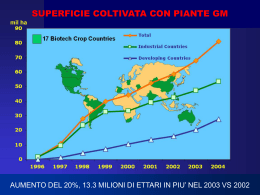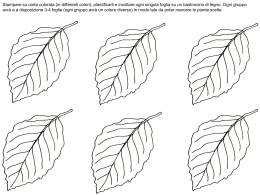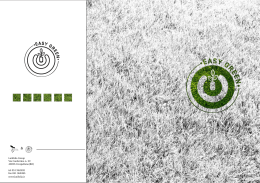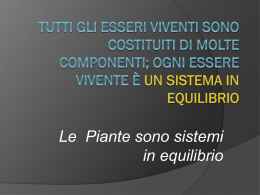FAB GRUPPO FLORA ALPINA BERGAMASCA CORSO DI BOTANICA 2013 I testi di questo opuscolo sono di Germano Federici (pag. 1÷3) Luca Mangili (pag. 4÷59) da pag. 4 sono tratti dal volume NATURA BERGAMASCA pubblicato nel 2004 dalla Provincia di Bergamo in collaborazione con il FAB edizioni Ferrari Editrice SOMMARIO INTRODUZIONE ALLA FLORA della Lombardia centro-orientale ............ 1 I BOSCHI RELITTI DELLA PIANURA ............................................................. 4 Le siepi ............................................................................................................... 5 Le piante esotiche ........................................................................................... 6 LE PRATERIE ARIDE............................................................................................. 7 GLI AMBIENTI UMIDI ........................................................................................ 8 I fontanili .......................................................................................................... 9 I COLTIVI .............................................................................................................. 10 Le piante infestanti ....................................................................................... 11 I BOSCHI TERMOFILI ...................................................................................... 12 I BOSCHI MESOFILI ......................................................................................... 14 Le querce ......................................................................................................... 15 Il castagno ...................................................................................................... 16 LE PRATERIE ARIDE........................................................................................... 18 Le specie mediterranee e steppiche ......................................................... 18 Le orchidee ..................................................................................................... 20 I PRATI FALCIABILI ......................................................................................... 21 I RONCHI............................................................................................................... 22 Le piante dei muri.......................................................................................... 23 I FIUMI .................................................................................................................. 24 I LAGHI SUBALPINI .......................................................................................... 25 LE FAGGETE .......................................................................................................... 27 I PRATI-PASCOLI ............................................................................................... 28 GLI AMBIENTI UMIDI ...................................................................................... 29 GLI ARBUSTETI .................................................................................................. 30 Le mughete ..................................................................................................... 32 LE PRATERIE NATURALI .................................................................................. 33 Le primule........................................................................................................ 34 LE VEGETAZIONI PIONIERE DEI MACERETI E DELLE ROCCE ........... 36 Le specie endemiche ..................................................................................... 37 Le specie vicarianti ....................................................................................... 39 LE PECCETE............................................................................................................ 40 Le conifere...................................................................................................... 42 I LARICETI E I RODORETI .............................................................................. 43 LE ALNETE E I MEGAFORBIETI..................................................................... 44 LE PRATERIE SEMINATURALI: I PASCOLI................................................ 45 LE PRATERIE NATURALI ACIDOFILE .......................................................... 47 Le genziane ..................................................................................................... 49 LAGHI E TORBIERE ............................................................................................ 50 Le piante insettivore .................................................................................... 51 LE VALLETTE NIVALI ........................................................................................ 53 Le specie artico-alpine ................................................................................. 54 LE VEGETAZIONI PIONIERE DEI MACERETI E DELLE ROCCE ........... 56 Le specie endemiche ..................................................................................... 57 La valle del Trobio ......................................................................................... 58 INTRODUZIONE ALLA FLORA DELLA LOMBARDIA CENTRO-ORIENTALE Dia 1: il corso introduce alla lettura della flora delle province di Bergamo e Brescia Dia 4-8: Il corso non riguarderà organismi come i funghi (che appartengono a un altro Regno della natura), i licheni (che sono un’associazione tra un fungo e un’alga), le alghe e i muschi. Questi ultimi due gruppi di organismi, pur facendo parte del Regno vegetale, non sono oggetto di trattazione in quanto richiedono studi e conoscenze specialistiche che esulano dal campo di competenze attuali del FAB Dia 9: Ci si occuperà di flora vascolare, comprendente “felci” (Pteridofite) e piante a seme (Spermatofite). Queste ultime si suddividono in Gimnosperme (comprendenti le “aghifoglie”, con seme non racchiuso in un frutto) e Angiosperme (con semi racchiusi in un frutto). Tale classificazione è filogenetica, ovvero rispecchia i rapporti di parentela emersi durante la storia della vita. Dia 10 Le piante vascolari sono caratterizzate dall’avere il corpo diviso in tre organi principali, radice, fusto e foglia collegati tra loro grazie a fasci di vasi che trasportano la linfa permettendo la nutrizione della pianta e lo svolgimento di tutte le funzioni vitali. I vasi si distinguono in legnosi (trasportano alle foglie la linfa grezza, costituita da acqua e sali minerali, assorbiti dalle radici) e cribrosi, che portano le sostante organiche sintetizzate dalle foglie a tutte le cellule vive del corpo. Dia 11 Di giorno la pianta respira (quindi assorbe ossigeno e produce biossido di carbonio) e, contemporaneamente, svolge attività sintetica (assimilando biossido di carbonio e liberando ossigeno). In condizioni normali prevale l’attività foto sintetica su quella respiratoria Dia 12 Di notte la pianta si limita a respirare e a svolgere altre attività metaboliche, esclusa la fotosintesi Dia 13-18 Le “felci” (propriamente dette Pteridofite) sono le piante che per prime hanno inventato organi e strutture citate. Comprendono i licopodi, le selaginelle, gli equiseti e le felci vere e proprie. Il loro ciclo vitale richiede acqua per la riproduzione sessuale, cosicchè sono organismi costretti a vivere in ambienti umidi, a meno che non rinuncino a tale forma di riproduzione Dia 19-21 Le più antiche piante a seme (Spermatofite) appartenevano al gruppo delle gimnosperme, e si sono svincolate dagli ambienti umidi grazie all’invenzione del seme, una struttura in cui l’embrione è circondato di materiali nutritizi indispensabili per consentire le prime fasi di vita conseguenti alla radicazione al suolo. Normalmente i semi sono dotati di meccanismi di dispersione passivi, legati ai moti del vento Dia 22-25 Le Angiosperme hanno inventato fiori e frutti. Spesso utilizzano gli animali sia per l’impollinazione (richiamandoli con colori, odori e sapori…) che per la dispersione dei semi. I frutti infatti aumentano la probabilità che un seme possa essere disperso lontano dalla pianta madre, grazie alle capacità di movimento degli animali. In tal modo viene notevolmente favorita la 1 colonizzazione di nuove aree. Dia 26-34 Le ragioni per occuparsi di botanica sono molteplici. Particolarmente importante l’obiettivo di conoscere il territorio che ci circonda per renderlo a misura d’uomo. La fortissima antropizzazione del territorio e un consumismo esasperato sono spesso causa e, insieme, conseguenza della perdita di identità personale a favore di un conformismo sociale ecologicamente distruttivo Dia 35-40 Occorre saper vedere il bello che esiste anche negli anfratti di una realtà artificiale profondamente trasformata. Un’aiuola, un selciato, un muretto possono rivelare il bisogno della vita di esprimersi assieme all’uomo. Dia 41-48 La biodiversità può essere mantenuta a un livello tale da salvaguardare la bellezza anche nelle città moderne, se si ha l’avvertenza di lasciarvi tasselli naturali connessi tra loro e con l’ambiente circostante. La riduzione della biodiversità si ha con la forte riduzione dei tasselli o con l’interruzione della connettività. Per questa ragione Milano, pur avendo una superficie quasi cinque volte maggiore di Bergamo, ospita poco più della metà della sua flora (540 contro le 930). Dia 49-54 Aumentando la superficie analizzata, aumenta anche la biodiversità, ma non in modo lineare. La provincia di Bergamo con 2700 km2 ospita 230 specie, quella di Brescia con 7500 km2 ne ospita 2800. Le due province condividono l’80% della flora complessiva. La diversità tra i due territori è legata a fattori climatici (la provincia di BG gode di maggior, Brescia di maggiori temperature grazie soprattutto alla presenza del Lago di Garda) e geologici. Dia 55 All’interno del territorio esiste anche una variazione di biodiversità lungo l’asse NordSud. Approssimativamente nei quadranti (aree di circa 36 km2 utilizzati nello studio del FAB) posti in pianura si hanno 400 specie, sui primi rilievi collinari circa 800, sulle prealpi 1000, sulle porzioni più settentrionali del territorio il numero scende a 600 o meno. Dia 56-59 La ragione sta nel fatto che procedendo verso Nord, ci si sposta su territori posti a quote progressivamente più elevate. Tra il punto più basso della pianura e la vetta dell’Adamello ci sono circa 3400 m di dislivello. Poiché la temperatura cala di 0,6°C ogni 100 m di quota, la differenza di temperatura tra i due punti è pari a circa 20°C. Alla scala terrestre, la diminuzione di 0,6°C si ha procedendo verso il polo N di circa 100 km. In proporzione, la salita alla vetta dell’Adamello equivale a percorrere 2800 km, dalla pianura padana fino alla penisola di Kola nel Mare Glaciale Artico Dia 60-75 Osservando una montagna sufficientemente alta, si vede come la vegetazione cambia con la quota, secondo fasce abbastanza regolari regolari. Procedendo nel nostro territorio dalla zona dei laghi e fino all’estremo limite delle foreste, assistiamo a continui cambiamenti nella vegetazione. Così dalla vegetazione di tipo mediterraneo osservabile intorno ai laghi prealpini, salendo progressivamente di quota, incontriamo boschi di querce e castagno, di faggio, di abete rosso (talora misto all’abete bianco) e infine di larice. A quota maggiore il bosco si apre e si mescola ad arbusteto a Pino mugo. Si individuano così delle fasce di vegetazione, ciascuna con la sua biodiversità, che hanno consentito la partizione dei versanti montuosi in piani vegetazionali (collinare, montano, alpino, nivale). 2 La quota raggiunta da ciascuna fascia di vegetazione dipende dall’esposizione del versante (a Nord resta più bassa) e alla collocazione della catena nell’arco alpino. In definitiva, risalendo un versante montuoso si incontrano le stesse fasce di vegetazione che suddividono l’emisfero boreale. E’ pertanto la diversità di ambienti che consente una grande biodiversità Dia 76 La biodiversità dei nostri territori è molto elevata anche se confrontata alla scala terrestre. Infatti dopo le zone tropicali e subtropicali, l’area del mediterraneo, comprendente quella alpina, si presenta come una singolarità. Nei nostri territori sono presenti più di 3000 entità botaniche Dia 77-90 Un secondo modo di classificare gli organismi, consiste nel definirne la distribuzione su scala mondiale. Della nostra flora fanno parte, tra le altre, specie cosmopolite (5%), articoalpine (3%), euroasiatiche (17%), europeo-montane (18%) evolutesi proprio sui monti continentali, stenomediterranee (0,8%). Importantissimo è il contingente di specie endemiche e stenoendemiche, di specie cioè che si trovano solo nell’area alpina o esclusivamente sul nostro territorio. Dia 91-98 La grande biodiversità del territorio è legata quindi alla sua storia geologica, che ha portato a climi diversi, a fasi di comunicazione con altri continenti e a fasi di isolamento che hanno favorito la comparsa di specie endemiche. I territori sono stati punto di convergenza e di transito di contingenti floristici provenienti dal circolo polare artico, dalla’Africa settentrionale e dalle steppe dell’Asia Dia 99-106 Un fenomeno recente che sta alterando la nostra flora, senza per ora ridurne la biodiversità, consiste nell’immigrazione di specie “aliene”, giunte dopo la scoperta dell’America (1482 d.C.) e di questi tempi, a causa della globalizzazione delle merci e delle persone, in misura massiccia. Queste specie sfruttano le aste fluviali, le vie di comunicazione ferroviarie e stradali, per penetrare profondamente nel territorio. Il loro ingresso viene notevolmente facilitato dall’incuria con cui vengono spesso realizzate le strutture necessarie alla vita sociale ed economica. 107-127 Un terzo modo di classificare le specie botaniche parte dalla loro forma biologica e, più esattamente, da come sono collocati sulla pianta gli organi perennanti, cioè quegli organi che garantiscono la sopravvivenza durante la cattiva stagione e la riproduzione. Si tratta di gemme per la produzione di fiori (riproduzione sessuale), per l’allungamento di organi necessari all’occupazione del suolo (stoloni, rizomi….) e alla riproduzione asessuale. La forma che le specie assumono è strettamente legata ai vincoli posti dai fattori fisici che caratterizzano l’ambiente (temperatura, umidità, vento, copertura nevosa….). Così, salendo di quota, gli alberi, che non potrebbero reggere un forte carico di neve senza subire danni, cedono il passo a forme arbustive prostrate (es Pino mugo, rododendri…)che superano facilmente anche gli inverni più nevosi. La classificazione delle piante in base alla forma biologica permette di comprendere alcune importanti caratteristiche di un ambiente anche senza avere altre informazioni su di esso. 3 I BOSCHI RELITTI DELLA PIANURA Alcune migliaia di anni fa una rigogliosa foresta si estendeva sulla maggior parte della nostra pianura, costituendone il più caratteristico paesaggio vegetale. Vi dominavano le querce (Quercus robur, Q. petraea) che indisturbate crescevano fino a raggiungere dimensioni maestose; sui suoli tendenzialmente asciutti le accompagnavano più frequentemente il carpino bianco (Carpinus betulus) e l’olmo (Ulmus minor), mentre laddove affioravano le acque di falda ed in prossimità degli alvei fluviali si infittiva la presenza di specie marcatamente igrofile, quali i pioppi (Populus nigra, P. canescens), i salici (Salix alba) e gli ontani (Alnus glutinosa). Vasti tratti con copertura arborea più o meno densa si alternavano sovente a radure ed acquitrini, formando un mosaico vegetazionale diversificato e straordinariamente ricco di specie. Fin dall’antichità più remota, con i primi dissodamenti, ebbe inizio la progressiva riduzione della foresta, proseguita più razionalmente durante la dominazione romana e protrattasi quasi ininterrottamente fino alla tarda età comunale; solo nell’alto medioevo, le ridotte necessità agricole di una popolazione meno numerosa ne consentirono una temporanea ripresa. Per tutto questo periodo, l’utilizzo della foresta fu comunque intenso: prelievo di legna, pascolo di ovini e suini, asportazione di foglia da utilizzare come strame o foraggio, raccolta di erbe commestibili e frutti selvatici, e soprattutto il continuo abbattimento degli esemplari arborei più maturi, ne alterarono l’equilibrio ecologico, determinandone un progressivo impoverimento. I boschi perdurarono più a lungo su alcune terre particolarmente ostili, come quelle sassose e poco fertili in prossimità del Serio, come testimoniato nei documenti catastali ottocenteschi; seppur con sorti diverse, sono giunti fin quasi ai nostri giorni anche quelli compresi entro alcune vaste proprietà: il grande Bosco di Brignano (circa 250 ha), antica riserva di caccia nobiliare, venne dissodato nei primi anni del secolo scorso, lasciando traccia solamente nelle carte topografiche dell’epoca; miglior fortuna ebbe quello dei Fontanili, poco a Sud di Spirano, che dopo aver fornito per secoli legname d’opera e da ardere, esiste ancora, seppur fortemente ridotto dagli oltre 80 ha dell’anteguerra ai 4 attuali. Oggi, boschi di una qualche consistenza permangono solo in aree marginali, non idonee all’agricoltura per conformazione e qualità del suolo, quali ripide scarpate e terrazze sassose, oppure presso alcuni fontanili e lanche fluviali. Sebbene assai inquinati da specie esotiche e, solitamente, destrutturati per il generale depauperamento dello strato arboreo, questi boschi costituiscono gli ultimi resti dell’antica foresta planiziale, della quale, come un archivio vivente, conservano preziose tracce nella loro composizione floristica; il numero delle specie presenti è ancora sorprendentemente elevato, anche se alcune popolazioni sono ormai ridottissime ed altre in progressiva rarefazione. La farnia (Quercus robur), il carpino bianco (Carpinus betulus), l’olmo (Ulmus minor), l’acero campestre (Acer campestre) ed altre latifoglie autoctone sono sempre presenti, anche se a prevalere sono ormai le invadenti robinie (Robinia pseudacacia); sotto la discontinua copertura arborea si sviluppa uno strato arbustivo abbastanza ricco, dove accanto ai più comuni sambuchi (Sambucus nigra), noccioli (Corylus avellana), fusaggini (Euonymus europaeus) e sanguinelli (Cornus sanguinea), compaiono più raramente i viburni (Viburnum lantana, V. opulus), lo spincervino (Rhamnus catharticus) ed il corniolo (Cornus mas). Ma è l’attenta osservazione del più umile strato erbaceo che rivela la presenza di specie rare o rarissime, la cui diffusione è sovente circoscritta ad aree limitate; tra le meno appari4 scenti vanno ricordate alcune Graminacee (Melica nutans, M. uniflora, Festuca heterophylla, Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum), Ciperacee (Carex pilosa, Carex sylvatica) e Giuncacee (Luzula pilosa, L. campestris), mentre decisamente più note e vistose sono alcune specie dal precoce sviluppo primaverile (Anemone nemorosa, Hepatica nobilis, Scilla bifolia, Erythronium denscanis, Galanthus nivalis, Leucojum vernum, Primula vulgaris, Vinca minor), che spesso segnalano la loro presenza con fioriture copiose, per nulla inferiori a quelle dei boschi collinari e montani. Le siepi Le strette fasce di vegetazione spontanea, prevalentemente arbustiva, che si sviluppano al bordo dei coltivi, sono state per secoli uno degli elementi fondamentali del paesaggio agricolo. Le siepi segnavano i confini delle proprietà, cingevano i campi a difesa dei raccolti dalle intrusioni degli animali al pascolo, frenavano la furia del vento, proteggevano il suolo dall’erosione, rinsaldavano le rive delle rogge, fornivano pali e legna da ardere oltre a frasche e frutti selvatici; per la loro riconosciuta utilità, non di rado erano minuziosamente descritte nei contratti agrari affinché fossero mantenute con cura. Oggi il loro valore è largamente misconosciuto. Considerate solo uno spreco di superficie produttiva ed un intralcio alla velocità delle lavorazioni meccaniche, sono state rimosse su vasti tratti della nostra pianura, ed anche quelle ancora esistenti vengono sovente danneggiate da arature e diserbi. Sebbene innumerevoli studi abbiano ormai dimostrato, su basi scientifiche, una maggiore produttività delle colture protette dalle siepi, il mondo agricolo stenta ancora a riconoscerne l’effettivo valore. Per il naturalista, invece, le siepi svolgono un’ insostituibile funzione ecologica, particolarmente nell’ambito di territori da molto tempo privati dell’originaria copertura boschiva, in quanto costituiscono l’ultimo rifugio per molte specie di piante e di animali che ebbero in passato maggiore diffusione. La siepe ripropone su scala ridotta la struttura e la complessità della fascia più esterna del bosco, concentrandole nella larghezza di alcuni metri, entro i quali alberi, arbusti , piante lianose ed erbacee convivono con una ricca comunità animale. Generalmente le siepi hanno origini molto antiche; la diretta derivazione dal bosco è ipotizzabile solo in pochi casi, particolarmente per qualche siepe situata lungo alcuni corsi d’acqua minori; la maggior parte è nata per disseminazione spontanea ai bordi dei campi, sulle strette fasce non interessate dalle lavorazioni, sui lunghi cumuli di sassi (rovari) accatastati pazientemente da generazioni di contadini per spietrarli, oppure sulle scarpate; non mancano, ovviamente, quelle di impianto artificiale. Il pregio floristico di una siepe, normalmente, è in diretta relazione con la sua età: quelle più antiche, formatesi quando l’ambiente circostante possedeva un elevato grado di naturalità, ospitano un buon numero di specie nemorali e, più in generale, conservano una maggiore diversità biologica. Le siepi svolgono, inoltre, l’importante funzione di corridoi ecologici, in quanto mettendo in contatto tra loro le residue aree boschive facilitano lo scambio genetico fra popolazioni altrimenti isolate, salvaguardandole così dal pericolo di un’estinzione in ambito locale. Non può essere dimenticato, infine, il loro valore puramente estetico: nell’ambito della pianura, la trama delle siepi costituisce quasi sempre l’unico elemento, in qualche misura naturale, che movimenta il paesaggio agrario, altrimenti piatto e monotono; il ripristino delle siepi su 5 vasta scala, è dunque un passaggio obbligato per rinaturalizzare ed abbellire il nostro territorio. Le piante esotiche Sul nostro territorio è presente un consistente numero di piante esotiche, provenienti da regioni anche lontanissime. La loro introduzione è avvenuta in epoche diverse e con varie modalità; talvolta è stata intenzionale, sovente del tutto accidentale. Se l’arrivo di alcune è recente e la loro presenza ancora poco significativa, altre si sono naturalizzate da così lungo tempo, e sono talmente comuni, da essere ormai entrate nella nostra quotidiana percezione del paesaggio, al punto da non costituire, agli occhi di un osservatore inesperto, elementi di disturbo. La loro diffusione è indice di degrado, in quanto difficilmente potrebbero espandersi all’interno di ambienti naturali integri; numerose sono entrate con prepotenza nelle siepi e nei boschi diradati, sottraendo spazio e nutrimento alle specie autoctone, grazie all’elevata capacità riproduttiva, alla sorprendente velocità di crescita ed all’assenza di parassiti specifici. E’ questo il caso della comunissima robinia (Robinia pseudacacia). Pianta originaria del Nordamerica, è una specie pioniera e bisognosa di luce, che cresce solitamente al margine della foresta, favorendone l’espansione. Introdotta in Europa a scopo ornamentale nel 1601, dopo un avvio stentato, si è diffusa grandemente nella pianura padana dalla fine del ‘700, trovando negli esausti boschi planiziali un ambiente ideale alla propria ecologia; in un’epoca bisognosa di legna, favorita da turni di ceduazione troppo ravvicinati, ha finito col prevalere sulle altre specie arboree, fino a formare consorzi quasi puri. La sua consistenza numerica tenderebbe tuttavia a scemare all’interno dei boschi non soggetti al taglio, lentamente sostituita dalla graduale ripresa di querce, carpini, olmi e aceri. Molto comune è anche l’ailanto (Ailanthus altissima), albero originario della Cina e dell’Asia sudorientale; importato in Europa nel 1751 a scopo ornamentale ed introdotto in Italia nel 1760 presso l’orto botanico di Padova, venne diffusamente coltivato nel secolo successivo, nel tentativo di sostituire il bombice del gelso, minacciato da alcune gravi malattie, poiché le sue foglie sono l’alimento esclusivo di un lepidottero saturnide (Samia cynthia) anch’esso in grado di produrre la seta; mentre l’allevamento del baco fallì miseramente, perché la seta ottenuta era di scarsa qualità, l’ailanto ebbe miglior fortuna, riuscendo spontaneamente a diffondersi un po’ ovunque. Anche il nostro platano (Platanus hybrida), ibrido fissato tra la specie del Mediterraneo sudorientale (Platanus orientalis) e quella americana (Platanus occidentalis), è stato diffuso a partire dal ‘700, grazie alla facilità con cui poteva essere riprodotto per via vegetativa; al contadino bastava tagliare un ramo con un deciso colpo di roncola ed infilarlo profondamente nel terreno umido della riva di un fosso per ottenere rapidamente una nuova pianta, operazione impossibile, ad esempio, con una quercia, riproducibile solo per seme e dall’accrescimento iniziale lentissimo. Se, in via ipotetica, tutte le robinie, gli ailanti ed i platani venissero abbattuti, scomparirebbe con loro la massima parte del patrimonio arboreo della pianura; questa eventualità indica in che misura i nostri paesaggi siano ormai inquinati dalle specie esotiche. Si consideri poi che, oltre alle poche citate, sono presenti anche altre piante arboree ed arbustive, ma soprattutto numerose specie erbacee, forse meno appariscenti ma con diffusione ancora più capillare; sono quasi 650 le specie esotiche ed avventizie ormai presenti in Italia, delle quali circa un terzo sono reperibili anche nella bergamasca, ed il loro numero è in continuo aumento. 6 Nessun ambiente ne è immune, perché la notevole adattabilità ecologica, unitamente alla grande rusticità, permette loro di colonizzare anche quelli particolarmente ostili, quali le aride massicciate ferroviarie, le scarpate stradali, le cave dismesse, le discariche ed i greti fluviali; la continua diffusione delle specie esotiche deve suonare come un campanello d’allarme, dimostrazione inequivocabile che le specie autoctone non sono più in grado di reagire di fronte all’intensa alterazione ambientale causata dall’uomo. Salvaguardare l’equilibrio ecologico e tutelare l’unicità dei nostri ambienti vegetazionali significa anche distinguere le piante estranee alla nostra flora e mettere in atto opportune strategie di contenimento. LE PRATERIE ARIDE Solo limitati lembi di pianura si sono rivelati talmente ostili alla messa a coltura da conservare, ancora oggi, preziosi relitti di vegetazione seminaturale. Lungo i corsi del Serio e del Brembo, i terrazzi più prossimi agli alvei sono costituiti da grossolane alluvioni ghiaiose, estremamente permeabili e ricoperte da un sottilissimo strato di terreno. Per loro natura sterili e inadatti a sostenere qualsiasi redditizia attività agricola, sono colonizzati da una vegetazione in apparenza povera e stentata, ma di grande interesse ecologico, perché vi appartengono specie ad essi fortemente legate e non reperibili altrove. Per sopperire all’elevata aridità del substrato, tutte hanno sviluppato apparati radicali molto estesi, in grado di assorbire rapidamente l’acqua piovana prima che percoli in profondità; inoltre, per conservare il prezioso liquido, le loro parti aree presentano numerosi accorgimenti, di natura sia fisiologica che morfologica, in grado di limitare il più possibile la traspirazione. Vi crescono numerose piante annuali, che concentrano il loro ciclo vitale nei mesi primaverili, favorite da una maggiore disponibilità di acqua; anche la specie più comune, il forasacco eretto (Bromus erectus), una robusta graminacea di media taglia, sebbene perenne, conclude velocemente il suo ciclo vegetativo entro l’inizio dell’estate, quando entra precocemente in dormienza; queste praterie aride, denominate brometi, assumono allora una tonalità spenta e monotona, che non rende giustizia della loro notevole ricchezza floristica, caratterizzata da un consistente gruppo di specie steppiche e mediterranee, qui rimaste accantonate dopo essere giunte sul nostro territorio in periodi per loro climaticamente più favorevoli (Achillea tomentosa, Chrysopogon gryllus, Fumana procumbens, Teucrium botrys, T. chamaedrys, Allium lusitanicum, Centaurea maculosa, C. bracteata, C. deusta, Blackstonia perfoliata, Eryngium campestre, Onobrychis arenaria). Oltre ad alcune orchidee (Orchis coriophora, Ophrys fuciflora, Orchi morio), sono osservabili con discreta frequenza numerose specie molto rare per la pianura, anche particolarmente attraenti, diffuse maggiormente negli ambienti aridi della collina ( Helianthemum oelandicum, H. nummularium, Inula montana, Teucrium montanum, Globularia punctata, Trifolium montanum); sulle ghiaie meno colonizzate, in assenza di concorrenza, è possibile imbattersi anche in alcune piante montane, fortunosamente giunte in pianura grazie al trasporto di semi operato dai fiumi (Biscutella laevigata, Saponaria ocymoides). La tarda primavera, tra maggio e giugno, quando i brometi sono nel massimo rigoglio vegetativo e si verifica il maggior numero di fioriture, è il periodo migliore per apprezzare l’unicità di questi ambienti, ormai scomparsi quasi ovunque, ma un tempo certamente più diffusi nell’alta pianura, come testimoniano i pochi esempi tuttora esistenti in località poste ad una certa di7 stanza dai fiumi. I brometi attuali rappresentano probabilmente una forma di vegetazione stabile, la cui evoluzione è bloccata dalla povertà del substrato; è anche possibile che, seppure frequentemente utilizzati in passato per il pascolo ovino e comunque impoveriti da un certo grado di disturbo antropico, conservino numerosi elementi delle praterie aride originarie, proprie delle aree più sterili anche anticamente sgombre dalla foresta. GLI AMBIENTI UMIDI Una volta rimossa la foresta, la regimentazione idrica ha costituito la tappa obbligata del plurisecolare processo di costruzione del paesaggio agrario, in quanto sia l’eccesso che la carenza di acqua condizionano negativamente lo svolgimento delle attività agricole. Gli acquitrini e le paludi ristagnanti nelle bassure, che il libero divagare dei fiumi e dei corsi d’acqua minori alimentava in occasione delle ricorrenti piene, rappresentavano un potente ostacolo alla messa a coltura delle terre. Ne era interessata soprattutto la bassa pianura al di sotto della linea delle risorgive, le cui acque confluivano nel mitico lago Gerundo, non un autentico bacino, bensì una vasta area facilmente soggetta ad allagarsi per periodi anche lunghi e che ancora in epoca storica si estendeva su alcune migliaia di ettari. Nelle aree depresse tra i coltivi, le macchie di carici (Carex sp.), cannucce (Phragmites australis) e mazze sorde (Typha latifolia), insieme a ontani (Alnus glutinosa) e salici (Salix alba, S. elaeagnos), testimoniavano l’invadenza e la vigoria di una vegetazione in equilibrio con l’ambiente, pronta ad espandersi anche sui suoli coltivati se non adeguatamente contenuta, da estirpare assolutamente; arginature dei fiumi e canali di sgrondo permisero di strappare nuova terra coltivabile alle paludi, considerate improduttive e malsane. Nel medesimo tempo, più a monte, nell’alta pianura asciutta, al fine di irrigare convenientemente le terre coltivate ed aumentarne la produttività, iniziava lo scavo di una capillare rete di rogge, dette seriole perché le loro acque provenivano principalmente dal Serio. Nel lungo periodo, le opere di bonifica idraulica hanno inciso sul paesaggio così fortemente da determinare sia la scomparsa pressochè totale delle zone umide che la completa regimentazione dei fiumi. Già duramente penalizzati, questi ecosistemi ricchissimi per lo straordinario numero di forme viventi che ospitano, si sono rivelati particolarmente sensibili anche all’inquinamento delle acque, come testimonia l’estinzione di numerose specie vegetali nel corso dell’ultimo secolo, la cui presenza nella nostra pianura era ancora documentata nelle flore ottocentesche (Salvinia natans, Utricularia vulgaris, Marsilea quadrifolia, ecc.) La vegetazione ripariale e acquatica è oggi assai scarsa lungo i fiumi Serio e Brembo, che presentano alvei caratterizzati da estesi ghiareti, particolarmente visibili nei mesi estivi quando la portata, già normalmente ridotta dai consistenti prelievi ad uso agricolo ed industriale, si riduce ad un’esile vena d’acqua; sconvolti ad ogni piena, ospitano una flora rusticissima ma effimera, caratteristica degli ambienti degradati e fortemente inquinata da specie avventizie di nessun pregio, comprendente alcuni poligoni (Poligonum persicaria, P. lapathifolium), la forbicina comune (Bidens frondosa), la nappola (Xanthium italicum) e la buddleja (Buddleja davidii), un arbusto di origine cinese con belle infiorescenze bianche o violacee. Lungo le rive di rogge e canali, è possibile imbattersi in consorzi vegetali di qualche interesse, 8 costituiti da alcune fra le più rustiche piante ripariali, anche se le periodiche operazioni di spurgo e sfalcio delle rive ne compromettono gravemente la durata. I migliori esempi attualmente esistenti sono costituiti da alcune lanche situate lungo i fiumi Adda e Oglio, al limite meridionale del territorio bergamasco; lungo questi rami fluviali morti, con lento scorrimento d’acqua oppure alimentati solo saltuariamente dalle piene e soggetti a progressivo interramento, in ragione del loro stadio evolutivo si sviluppa una vegetazione assai differenziata, dove accanto alle comunissime cannucce di palude (Phragmites australis) ed alle mazze sorde (Typha latifolia), crescono fitte compagini di carici (Carex pendula, C. riparia, C. acutiformis), fra le quali spiccano alcune piante particolarmente decorative, quali l’iris giallo (Iris pseudacorus), la salcerella (Lythrum salicaria), la mazza d’oro (Lysimachia vulgaris) od il raro giunco fiorito (Butomus umbellatus); se il processo di interramento giunge a termine, l’intera superficie delle lanche è destinata ad essere conquistata dal bosco, già annunciato dalle folte macchie arboree presenti ai loro bordi, costituite prevalentemente da salici, ontani e pioppi. Comprese nei parchi fluviali regionali e pertanto tutelate, le lanche rappresentano un’importante riserva di biodiversità, dalle quali può prendere avvio l’auspicabile recupero naturalistico delle fasce fluviali. I fontanili Sapiente esempio di utilizzo di una risorsa naturale, i fontanili devono la loro esistenza tanto alla particolare costituzione litologica della pianura quanto all’ingegno umano. Le piogge e le acque disperse dagli alvei dei fiumi vengono copiosamente assorbite dalle grossolane alluvioni del pedemonte, percolando in profondità ad alimentare le falde freatiche, corpi idrici sotterranei che scorrono lentamente verso valle ed affiorano spontaneamente al contatto con le argille ed i finissimi limi impermeabili della bassa pianura. Anticamente le acque sorgive impregnavano per larghi tratti i terreni circostanti, impaludandoli; la loro captazione ne agevolò il deflusso, consentendo ad un tempo il drenaggio delle acque in eccesso ed il loro utilizzo per fini irrigui. In area lombarda i fontanili sono documentati a partire dal XIV° secolo, ma probabilmente ne vennero realizzati già in epoca antecedente, forse nel periodo romano; presenti dunque da lungo tempo, sono tra i più caratteristici elementi del paesaggio planiziale. L’acqua sgorga in corrispondenza della testa, uno scavo più o meno profondo ed ampio che intercetta la falda, e la sua risalita può essere facilitata da una serie di tubi in ferro profondamente infissi nel terreno, oppure da anelli di cemento, accorgimenti moderni che hanno sostituito i primitivi tini in legno di quercia privi di fondo; defluisce quindi lungo l’asta, un canale che può raccogliere le acque provenienti da varie teste e le convoglia nella zona di utilizzo. Sia le teste che le aste devono essere periodicamente ripulite dalla vegetazione acquatica troppo invadente e spurgate dalle sabbie e dai sedimenti vari che rischiano di ostruirle. Le limpide acque dei fontanili, filtrate nel loro corso sotterraneo dalle ghiaie e dalle sabbie, venivano preferite a quelle derivate dai fiumi, sia per uso civile che agricolo, perché più pulite e meno fredde. Per la loro temperatura costante, compresa tra 10 e 14°C, trovavano un impiego particolarissimo nelle marcite, prati stabili realizzati con tecnica ingegnosa, grazie alla quale un velo d’acqua scorreva costantemente su una serie di superfici debolmente inclinate, favorendo la crescita dell’erba anche nel freddo inverno; potevano così realizzarsi anche 8 o 9 sfalci annuali, più del doppio rispetto ai 3 o 4 possibili negli altri prati. Nei fontanili più meridionali, regolarmente alimentati, favorita dal lento fluire delle acque 9 poco profonde, dalla temperatura costante e dalla buona illuminazione, si insedia una caratteristica comunità di piante acquatiche, sommerse o natanti, quali la sedanina d’acqua (Berula erecta), l’aromatico crescione (Nasturtium officinale), la veronica acquatica (Veronica anagallisaquatica), l’erba gamberaia (Callitriche obtusangola) ed il ranuncolo acquatico (Ranunculus tricophyllus), con fiori bianchi e foglie ridotte in sottili lacinie, mentre nelle anse riparate, dove la corrente è ancora più lenta, si raduna in compatti ammassi la piccola lenticchia d’acqua (Lemna minor); sulle rive, accanto a folti cespi di carici (Carex elata, C. acutiformis, Carex pendula), sono presenti l’iris giallo (Iris pseudacorus) e la salcerella (Lythrum salicaria), dai fiori vinosi. I fontanili più a monte, con lunghi periodi stagionali di secca, sono decisamente più poveri di vegetazione acquatica, ma intorno alle teste e nel primo tratto delle aste possiedono cortine arboree di buon pregio, talvolta veri e propri boschi, che conservano specie ormai scomparse dal restante territorio planiziale. Non meno ricca è la comunità animale: se la vegetazione arborea circostante è abbastanza folta, piccoli mammiferi, uccelli e rettili sono presenti in buon numero, mentre pesci e invertebrati acquatici, la cui vita è indissolubilmente legata alla qualità delle acque, concentrano la loro presenza in prossimità delle teste, più difficilmente raggiunte dall’inquinamento. L’utilità dei fontanili è oggi assai ridimensionata: il generale impoverimento delle falde dovuto ai forti emungimenti ne ha ridotto le portate, mentre i fabbisogni irrigui dell’agricoltura vengono soddisfatti con sistemi più pratici e tecnologici; accresciuta è invece la loro importanza ambientale, perché nella diffusa banalizzazione del paesaggio agricolo rappresentano un elemento indiscutibile di bellezza e un’inestimabile riserva di biodiversità. La nostra provincia conta oltre 170 fontanili, in parte ormai asciutti o degradati; sono una ricchezza da non perdere, una preziosa eredità del passato da conservare e valorizzare per il futuro. I COLTIVI Spazio agricolo per eccellenza, la pianura è coltivata pressochè ovunque, salvo le aree urbanizzate ed i ridottissimi lembi dove ancora permangono vegetazioni seminaturali. Con millenario lavoro, l’uomo l’ha completamente plasmata, trasformando gradualmente l’ambiente naturale in una distesa di coltivi, consorzi vegetali del tutto artificiali ed incapaci di sopravvivere senza assidue cure, che occupano i vasti spazi dove un tempo allignava la foresta. Nel quadro di questa radicale trasformazione, lo stesso paesaggio agrario ha subito, nel corso dei secoli, continui cambiamenti: l’introduzione di nuove piante, l’evolversi delle tecniche colturali, la disponibilità della forza lavoro e la realizzazione di un’adeguata rete irrigua, ma anche le dinamiche dei prezzi e dei contratti agrari, sono i fattori che, singolarmente o nel loro insieme, hanno determinato i mutamenti. Dall’antichità e fino all’inizio dell’età moderna, le necessità dell’autoconsumo, cui era destinata gran parte della produzione, nonchè il bisogno di tutelarsi dalle avversità climatiche, spingevano a differenziare le colture, così da garantire comunque una certa quota di raccolto. Tra i cereali si preferivano la segale, l’avena e l’orzo, ma trovavano largo spazio anche il miglio ed il panico, oggi praticamente scomparsi, favoriti dalla brevità del ciclo vegetativo e dalla resa abbondante; il frumento, coltura pregiata destinata alla vendita e con una resa piuttosto scarsa, occupava solo superfici modeste. La vite, allevata su sostegni vivi, era presente un po’ ovunque, insieme a vari fruttiferi; si 10 coltivavano anche il lino e la canapa, mentre nella fase di più fiorente produzione laniera si diffuse la redditizia coltura del guado, pianta tintoria da cui si estraeva un prezioso colorante azzurro. La campagna era molto diversa da quella odierna: i seminativi, recintati da siepi e filari, avevano dimensioni medio-piccole, e si alternavano a residui lembi boscati, prati stabili, pascoli ed a numerosi incolti, perché i suoli scarsamente concimati si esaurivano rapidamente e per ricostituirne la fertilità si ricorreva frequentemente a periodi di riposo. Nel ‘600 fece la sua timida comparsa il mais, che, vinte le resistenze iniziali, si diffuse sempre più a partire dal secolo successivo; negli stessi anni, con l’affermarsi della bachicoltura, iniziò anche la straordinaria diffusione del gelso, che giunse a contare centinaia di migliaia di piante, caratterizzando in modo preponderante il paesaggio agrario fino all’inizio del ‘900. Fino a questa soglia, l’utilizzo agricolo del territorio, pur comportando la drastica riduzione della vegetazione naturale, aveva, nel complesso, incrementato la varietà del paesaggio e conservato una notevole diversità biologica; la campagna era innanzitutto il luogo del lavoro, ma anche del quotidiano contatto con la natura. Nell’ultimo secolo, il tramonto della bachicoltura, la scarsa competitività delle produzioni locali nei confronti di quelle estere ed i rilevanti progressi tecnici, hanno determinato una svolta epocale. La meccanizzazione agricola sempre più accentuata, l’utilizzo su vasta scala dei prodotti chimici, nonché l’acquisizione di varietà sempre più resistenti e produttive, hanno spinto il mondo agricolo verso una specializzazione esasperata, che ha segnato in modo irreversibile il paesaggio. Le siepi, i filari ed i fossi, considerati tare produttive ed un intralcio alle lavorazioni meccaniche, sono stati eliminati in gran numero; i campi si sono ingranditi enormenemente e le semine si sono concentrate su pochissime specie, che si susseguono con monotonia, oppure si è passati alla monocoltura. Negli ultimi decenni, il paesaggio agricolo si è trasformato più che nei secoli precedenti; in larga misura privato degli elementi che da sempre l’hanno caratterizzato, ha perso tutta la sua bellezza; sorta di inerte substrato da sfruttare in vista dell’immediato ritorno economico, è diventato un “non paesaggio”. L’impoverimento biologico è proceduto di pari passo: ormai solo un limitato numero di specie vegetali e animali trovano possibilità di vita entro i coltivi oppure ai loro margini, e, paradossalmente, sono scomparse soprattutto le specie utili ed hanno resistito quelle nocive. Occorre riflettere sulla sostenibilità ecologica dell’attuale assetto produttivo agricolo e, nel suo interesse, ricreare la perduta biodiversità ambientale: al pari di tutti gli ecosistemi ben strutturati, risulterebbe più stabile ed equilibrato anche l’agroecosistema, frutto dell’interazione tra uomo e natura, strumento, ad un tempo, di una fondamentale attività produttiva e di salvaguardia ambientale. Le piante infestanti Ogni habitat, sia esso naturale o artificiale, possiede una sua flora caratteristica, costituita dalle specie che meglio si adattano alla sua ecologia. Non sfuggono a questa regola neppure i coltivi, dove numerose specie indesiderate crescono in concorrenza con le piante coltivate, sottraendo loro spazio, luce, acqua e nutrimento. Privi di una particolare valenza naturale, i consorzi delle erbe infestanti testimoniano il perenne dinamismo con cui la vegetazione, sia pure esotica, può conquistare nuove aree: in fondo, un coltivo appena lavorato non è altro che un ambiente ricco di opportunità, da colonizzare nel più breve tempo possibile. Il ciclo biologico delle infestanti è in sintonia con quello delle colture compagne, tanto da 11 potergli attribuire una particolare specializzazione; germinano solitamente nella medesima epoca e, favorite dalle laute concimazioni e dalle irrigazioni, completano rapidamente il loro sviluppo, arrivando a disperdere i semi con un certo anticipo sulla maturazione dei raccolti. La quantità di semi può essere molto elevata; una sola pianta di papavero o di giavone ne produce decine di migliaia, che in massima parte cadono sul terreno, in attesa di poter germinare, ma una certa quota passa nel raccolto, inquina la semente e, tramite questa, viene ulteriormente diffusa. Le specie perenni si propagano facilmente anche per via vegetativa, ogni qualvolta i loro rizomi vengono frantumati e dispersi dalle lavorazioni del terreno. Se non ostacolate, le infestanti possono arrecare alle colture danni ingenti, compromettendone sia a la resa, che la qualità; nel passato, causa l’elevata incidenza dei loro semi nei raccolti, si ottenevano con una certa frequenza farine nere, amare o addirittura tossiche, il cui utilizzo alimentare poteva risultare pericoloso. Per impedirne l’eccessiva propagazione, un tempo le infestanti venivano combattute attuando la rotazione delle colture, oppure eliminate mediante scerbature e zappature, faticose operazioni da ripetersi più volte; oggi sono contrastate da una sofisticata tecnica sementiera e dall’impiego generalizzato dei diserbanti chimici. Il numero delle specie infestanti si è ridotto; le più vulnerabili sono divenute estremamente rare o sono scomparse, ma le più resistenti, favorite anche dalla pratica della monocoltura, si ripresentano puntuali tutti gli anni, se possibile con diffusione ancora più ampia. Molte infestanti dei cereali, per la loro vistosità, sono certamente tra i fiori più noti. Da lungo tempo compagne dell’uomo, appartengono in gran parte al contingente delle archeofite; provenienti dalle steppe del vicino oriente, dove avvenne la domesticazione dei cereali, furono introdotte nelle nostre regioni in epoca molto antica. Gli appariscenti papaveri (Papaver rhoeas, Papaver apulum), l’aromatica camomilla (Matricaria chamomilla), la veccia dolce (Vicia sativa) ed il ranuncolo dei campi (Ranunculus arvensis) sono ancora molto diffusi, mentre il fiordaliso (Centaurea cyanus), dall’intenso colore azzurro, è sempre più raro. Quasi scomparse sono la speronella consolida (Consolida regalis), dalla vistosa spiga blu, e due geofite un tempo comunissime, il gladiolo delle messi (Gladiolus italicus) ed il cipollaccio dei campi (Gagea villosa), ormai presenti solo in qualche siepe. Nelle colture di mais e soia, le sole fioriture appariscenti sono quelle del cencio molle (Abutilon theophrasti) e delle campanelle (Convolvulus arvensis, Calystegia sepium), mentre assai meno accattivanti sono le Graminacee, spesso presenti massicciamente, quali la temibile sorghetta (Sorghum halepense), il giavone (Echinochloa crus-galli), il pabbio (Setaria viridis) e la sanguinella (Digitaria sanguinalis), insieme alla galinsoga (Galinsoga ciliata) una piccola composita dai minuscoli fiori bianchi, ed a varie specie appartenenti ai generi Amaranthus e Chenopodium; a prevalere nettamente è il contingente delle neofite, rappresentato soprattutto da piante originarie delle zone subtropicali americane e asiatiche, introdotte in epoca più o meno recente al seguito delle rispettive colture. Occorre infine ricordare che numerose infestanti crescono facilmente negli ambienti ruderali, al sicuro da arature e diserbi, dai quali muovono incessantemente verso i coltivi. I BOSCHI TERMOFILI Già nei mesi invernali, quando sulla pianura ristagnano il gelo e le nebbie ed alle quote superiori si accumula il manto nevoso, chiunque percorra un sentiero collinare ed osservi le precoci 12 fioriture che occhieggiano nel bosco, può percepire come imminente il risveglio della primavera. Protetti dai freddi venti settentrionali, assolati e caldi, i versanti meridionali delle colline e dei primi rilievi montuosi, godono infatti di condizioni climatiche particolarmente miti, anche nella stagione avversa; per contro, l’acclività dei pendii determina una generale scarsità di suolo, periodicamente dilavato dalle precipitazioni più intense, nonché il rapido deflusso delle stesse, con conseguente aridità. Li ricopre una vegetazione dal carattere submediterraneo, come ben evidenzia la consistente presenza di specie eliofile, termofile e xerofile, cioè amanti di stazioni luminose e idonee a sopportare sia temperature elevate che lunghi periodi di siccità. Nella copertura boschiva originaria predominava la rusticissima roverella (Quercus pubescens), associata al carpino nero (Ostrya carpinifolia) e talvolta alla rovere (Quercus petraea) ed al cerro (Quercus cerris) nelle stazioni con migliore disponibilità idrica, mentre nei siti più asciutti e rupestri si accompagnava al frugale orniello (Fraxinus ornus). Rimossi da tutte le località a morfologia più dolce, dotate di suoli migliori e idonee ad essere trasformate in prati e vigneti, questi boschi si sono mantenuti solo sulle pendici più ingrate, subendo anche l’intenso sfruttamento dell’uomo, che per secoli li ha governati a ceduo, impoverendoli e modificandone sensibilmente la composizione. Ad ogni taglio raso, favorito da una maggiore capacità pollonifera, il carpino nero si è avvantaggiato sulla roverella, così da divenire la specie dominante, mentre l’orniello, assai più resistente agli stress idrici, ha conservato pressochè inalterata la sua consistenza numerica; ne è derivata una cenosi denominata Orno-Ostrieto, attualmente la più diffusa tipologia di bosco termofilo. Non di rado degradati ad una discontinua boscaglia dai tagli troppo frequenti e dagli incendi, questi boschi raramente potevano raggiungere uno sviluppo maturo, ostacolati anche dalla povertà estrema del substrato; solo oggi, per la diminuita richiesta di legna ed il parziale abbandono di prati e dei vigneti, possono ricompattarsi, riguadagnare parte degli spazi perduti ed alcuni tratti della loro originale fisionomia. Meno alti e folti delle formazioni mesofile dei versanti freschi, i boschi termofili si caratterizzano per la ridotta densità della copertura arborea, una consistente presenza arbustiva ed un ricco strato erbaceo. Tra le ceppaie e frammisti alle basse macchie sempreverdi del pungitopo (Ruscus aculeatus), pregevoli per la ricchezza delle fioriture e l’abbondante fruttificazione, crescono diffusamente il corniolo (Cornus mas), il profumato ligustro (Ligustrum vulgare), il prugnolo (Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), il pero corvino (Amelanchier ovalis), il nocciolo (Corylus avellana) e l’emero (Coronilla emerus), mentre nei luoghi piu caldi ed asciutti spiccano le rosee infiorescenze piumose dello scotano (Cotinus coggyria), le cui foglie assumono una splendida tonalità arancio al sopraggiungere dell’autunno; molto comuni sono alcuni piccoli suffrutici, come il camedrio (Teucrium chamaedrys) ed il falso bosso (Polygala chamaebuxus), formanti bassi cespi compatti e ricoperti di fiori. Fra le specie erbacee, accanto a piante caratteristiche ma poco appariscenti come la delicata avena profumata (Hierochloe australis), una piccola graminacea dalla fioritura precoce, ve ne sono di più vistose ed assai note, quali la rosa di Natale (Helleborus niger), la bocca di lupo (Melittis melissophyllum), l’iris susinario (Iris graminea), l’astro bellissimo (Buphthalmum salicifolium), il ciclamino (Cyclamen purpurascens) e la peonia (Paeonia officinalis). Questa varietà, purtroppo, è compromessa nei boschi più pesantemente degradati, invasi dalla robinia (Robinia pseudoacacia) e dai rovi (Rubus ulmifolius), oppure soffocati dalla vitalba (Clematis vitalba), specie che si espandono in maniera abnorme in seguito al taglio, specialmente in 13 ambito collinare. I boschi termofili riescono ad insinuarsi abbastanza profondamente nelle valli, occupando le stazioni meglio esposte e riparate, sovente in sostituzione delle formazioni mesofile troppo intensamente sfruttate; comunque, verso i 900-1000 m, fra i carpini neri inizia ad insinuarsi sempre più frequentemente il faggio (Fagus sylvatica) e gradualmente la faggeta, nella sua variante termofila, diviene la cenosi dominante. I BOSCHI MESOFILI Sui suoli più evoluti e dotati di buona ritenuta idrica, particolarmente sui freschi ed ombrosi versanti esposti a settentrione, si afferma una copertura boschiva più ricca e meglio strutturata, costituita da specie mesofile, che prediligono una buona umidità, temperature moderate ed un’insolazione non troppo prolungata. Da molto tempo l’uomo ne ha alterato la composizione originaria, favorendo la capillare diffusione del castagno (Castanea sativa), soprattutto a spese della rovere (Quercus petraea); a lungo sfruttati per la produzione di legna e carbone, anche oggi questi boschi vengono governati a ceduo, ma il turno relativamente lungo consente loro di raggiungere uno sviluppo sufficientemente maturo. La rovere compare già al contatto con i boschi termofili, frammista alla roverella (Quercus pubescens) ed al carpino nero (Ostrya carpinifolia), dando vita a consorzi di transizione assai ricchi, perché vi confluiscono sia le specie degli ambienti caldi e secchi che quelle amanti del fresco; la sua presenza aumenta sui suoli più profondi, ma raramente riesce a prevalere sulle altre essenze arboree, perché l’entità dei suoi popolamenti è costantemente depauperata dagli abbattimenti cui va soggetta per l’elevata qualità del suo legno. Oltre al castagno, al carpino bianco (Carpinus betulus) ed al tiglio (Tilia cordata), l’accompagnano frequentemente l’acero di monte (Acer pseudoplatanus) ed il frassino (Fraxinus excelsior), specie maggiormente diffuse negli impluvi più umidi, mentre lo slanciato pioppo tremulo (Populus tremula), il ciliegio selvatico (Prunus avium) ed il vistoso maggiociondolo (Laburnum anaggyroides) sono piante pioniere dalla crescita veloce, che occupano prontamente le zone diradate dai tagli; alle basse quote, nelle schiarite, si incontra anche la robinia (Robinia pseudoacacia), ma la sua diffusione è solitamente ben contenuta dalla rapidità con cui il bosco si riforma. Il castagno sovente si è completamente sostituito alle altre specie, arrivando a costituire formazioni pure sui suoli più fertili e freschi, silicei o decalcificati, mentre dalle quote superiori discende sporadicamente il faggio (Fagus sylvatica), che insieme ad alcune specie microterme del sottobosco, quali il mirtillo (Vaccinium myrtillus), la lattuga montana (Prenanthes purpurea) o l’odoroso mezereo (Daphne mezereum), testimonia l’esistenza di peculiari condizioni di freschezza. Quando lo strato arboreo conserva una buona varietà, anche le componenti arbustiva ed erbacea sono ben sviluppate. Nel ricco strato arbustivo, accanto a specie più significative perchè maggiormente legate agli ambienti freschi (Frangula alnus, Euonymus europaeus, Viburnum opulus, Mespilus germanica, Rosa arvensis, Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum), alcune delle quali relativamente rare (Pyrus pyraster, Rosa gallica) o di origine esotica (Spiraea japonica), ne compaiono numerose assai comuni ed ampiamente diffuse anche in altre cenosi (Corylus avellana, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Ruscus aculeatus). Tra le specie erbacee più caratteristiche alcune spiccano per la straordinaria ricchezza delle lo14 ro precoci fioriture, che ammantano interi versanti già al limitare dell’inverno, quando le gemme degli alberi iniziano appena a gonfiarsi ed una sufficiente quantità di luce e calore giungono al suolo (Leucojum vernum, Hepatica nobilis, Erythronium dens-canis, Omphalodes verna, Anemone nemorosa), mentre più tardiva è la fioritura delle specie che prediligono la frescura o l’ombra densa (Pulmonaria officinalis, A. ranunculoides, Asarum europaeum, Cardamine bulbifera, Carex digitata, C. remota, Allium ursinum, Geranium nodosum, Aruncus dioicus). Più povere e meno caratterizzate risultano le formazioni pure di castagno, sia per l’uso di mantenere il sottobosco pulito per facilitare la raccolta dei frutti che per l’acidità del substrato; ad eccezione del brugo (Calluna vulgaris) e talvolta del mirtillo (Vaccinium myrtillus) la componente arbustiva è praticamente assente, ed anche il contingente di specie erbacee è assai limitato (Pteridium aqulinum, Melampyrum pratense, Luzula nivea, L. forsteri, Teucrium scorodonia, Veronica officinalis). Superiormente i boschi misti mesofili sfumano indistintamente nella faggeta, cenosi ancora più esigente in fatto di umidità atmosferica, ma sui suoli più imbevuti di acqua continuano a prevalere i consorzi di aceri e frassini (aceri-frassineti). Le querce Maestose e talvolta imponenti, da sempre le querce hanno colpito l’immaginazione dell’uomo, che fin dall’antichità gli ha attribuito una ricca simbologia, associandole alle maggiori divinità pagane e facendone l’emblema stesso della forza. Un tempo questi alberi dominavano le foreste di gran parte del nostro territorio, ed ancora oggi i querceti ne costituiscono la vegetazione climax, cioè la più ricca e complessa comunità vegetale compatibile con le condizioni ambientali, espressione finale di un processo di adattamento durato migliaia di anni. Le querce sono infatti giunte da noi circa 9.000 anni fa, dopo il termine dell’ultima glaciazione, provenienti dalle regioni europee più meridionali, dove erano state accantonate nei periodi freddi del Quaternario; successive fluttuazioni climatiche le hanno ora favorite ora penalizzate nei confronti di altre specie, ma da circa 7000 anni la loro presenza si è ormai stabilizzata negli areali attuali. La consistenza delle loro popolazioni ha subito una forte contrazione ad opera dell’uomo, che ha rimosso intere foreste, e con l’intenso utilizzo dei boschi superstiti favorisce la diffusione di piante concorrenti; alla rarefazione delle querce consegue un generale impoverimento strutturale e floristico dei nostri boschi, tanto che ormai, salvo rare eccezioni, i querceti rappresentano solo forme di vegetazione potenziali, la cui ricostituzione, ove possibile, necessita di tempi lunghi. Le nostre querce sono alberi d’alto fusto, a crescita lenta e molto longevi; monoiche, possiedono sia fiori maschili (in amenti) che femminili (in glomeruli) e producono caratteristici frutti (ghiande) parzialmente avvolti da un involucro (cupola); le foglie sono caduche, con un’inconfondibile forma obovata, ristretta alla base ed allargata all’apice, con alcuni lobi arrotondati per lato. Non sempre i caratteri morfologici permettono una chiara distinzione tra le specie, anche per la frequente presenza di ibridi, tanto che il grande Linneo ne raggruppò ben tre nella sola entità Quercus robur; tuttavia un decisivo elemento di discriminazione è costituito dalle peculiari esigenze ecologiche che le contraddistinguono, così che identificare le querce autoctone significa anche riconoscere i loro habitat particolari e le corrispondenti tipologie di bosco. 15 La farnia (Quercus robur), specie continentale resistente al freddo, predilige i suoli alluvionali profondi e freschi; anticamente dominante nelle foreste mesofile planiziali, mantiene tuttora ridotti polamenti nelle vallecole umide al piede dei colli. Si riconosce facilmente per le ghiande riunite a 2 o 3 su un lungo peduncolo e le foglie con base auricolata per via del picciolo brevissimo; fra le querce nostrane raggiunge le maggiori dimensioni ed è la più longeva, potendo vivere 500 – 1000 anni. La rovere (Quercus petraea), specie mesofila con distribuzione principale subatlantica, cresce preferibilmente in collina e nella fascia submontana, mal sopportando gli eccessi di umidità e le gelate tardive che si verificano nelle bassure; la sua diffusione è penalizzata dalla grande espansione del castagno, col quale condivide una predilezione per i suoli acidi. Rispetto alla farnia presenta ghiande prive di peduncolo e foglie con picciolo allungato, dimensioni leggermente ridotte e minore longevità. La roverella (Quercus pubescens), specie tipicamente termofila e xerofila, si adatta ai suoli più poveri e superficiali; predilige le stazioni soleggiate sui pendii calcarei, ma è indifferente alla natura chimica del substrato. Resistente al freddo, si spinge fin verso i 1000 m. Sui suoli più fertili raggiunge dimensioni ragguardevoli, ma generalmente, per la povertà estrema del substrato, ha un aspetto assai modesto. Meno longeva delle consorelle, come la rovere ha ghiande sessili e foglie con picciolo allungato, ma presenta una densa tomentosità bianco-giallastra che ricopre i giovani rami e la pagina inferiore delle foglie appena emesse, conferendo alla chioma la caratteristica tonalità verde chiaro. Il cerro (Quercus cerris) cresce frammisto alla roverella, ma solo nelle stazioni con suolo più profondo e tendenzialmente acido; non molto comune, si distingue nettamente per le cupole delle ghiande con lunghe squame e per le foglie più strette e con le stipole persistenti. Oltre alle specie autoctone brevemente descritte, in prossimità del Sebino, in località particolarmente riparate, anche in siti rupestri, cresce talvolta il leccio (Quercus ilex), essenza sempreverde schiettamente mediterranea, utilizzata in passato per rimboschire le pendici più ingrate ed ora parzialmente naturalizzata; infine, in qualche bosco collinare, ci si può imbattere in alcuni begli esemplari di quercia rossa (Quercus rubra), specie di origine nordamericana dalla crescita abbastanza rapida, con foglie a lobi acuminati e vivacemente colorate in autunno. Il castagno In una limpida giornata autunnale, quando le foglie ingiallite degli alberi già cominciano a cadere ma il freddo non si è ancora fatto pungente, inoltrarsi tranquillamente nel bosco alla ricerca delle castagne è sempre un’esperienza piacevole. Trovare l’albero giusto, sotto il quale fermarsi per raccogliere i frutti più grossi, non è difficile, perché il castagno (Castanea sativa) nei nostri boschi è molto comune, soprattutto in collina e nelle basse valli, dove sovente forma consorzi puri di notevole estensione, tanto da essere erroneamente ritenuto una delle piante autoctone di maggior successo. In effetti, la grande diffusione del castagno è dovuta principalmente all’azione diretta dell’uomo, e solo in minima parte alle potenzialità biologiche della specie. Presente nella nostra regione già nel Terziario, si estinse durante le glaciazioni, rifugiandosi in alcune zone dei Balcani, in Asia Minore e, forse, nell’Italia meridionale; reintrodotto dall’uomo in epoca molto antica, già nei secoli precedenti la conquista romana era stato diffuso un po’ ovunque, soprattutto a discapito dei querceti. Curiosamente, nelle sue linee essenziali, questa ipotesi coincide con quella degli autori 16 classici, per i quali il castagno era originario delle foreste del monte Timolo, presso Sardi, nell’attuale Turchia, da cui venne portato in Grecia e successivamente in Italia, dove i Romani lo diffusero ulteriormente verso Nord; il nome della pianta pare derivi dalla città di Kastanaia, nel Ponto, nella cui regione era particolarmente diffusa. Forse, il progressivo addolcirsi del clima avrebbe consentito al castagno di riconquistare spontaneamente il primitivo areale, ma l’intervento dell’uomo impresse un’intensità straordinaria ad un processo altrimenti destinato a compiersi in un arco temporale assai lungo. Certo è che, fin dai tempi più remoti, al castagno vennero riconosciute grande utilità ed importanza economica sia per il valore nutritivo dei suoi frutti che per la produzione di legna. Erano soprattutto le popolazioni montane, che la scarsa produzione cerealicola costringeva ad un’alimentazione povera e spesso insufficiente, ad integrare la propria dieta con le castagne, frutti provvidenziali grazie ai quali era possibile sfamarsi anche nei mesi invernali; per questo il castagno venne sistematicamente diffuso ovunque fosse possibile, anche in località al limite delle sue possibilità ecologiche, in sostituzione della vegetazione originaria. Le piante destinate alla fruttificazione venivano innestate, mantenute piuttosto rade e all’occorenza potate, in modo da assumere rapidamente una forma robusta e armoniosa ed iniziare quanto prima la produzione dei frutti, mentre la formazione del sottobosco veniva impedita per facilitarne la raccolta. Oggi, gli splendidi castagneti ad alto fusto che per secoli hanno caratterizzato le basse pendici delle nostre valli sono praticamente scomparsi, sia per la diminuita importanza economica dei frutti che per l’infierire di due gravissime malattie epidemiche. Il mal dell’inchiostro, originario probabilmente delle isole Azzorre, colpì i nostri castagneti già all’inizio dell’800, causando le prime falcidie, ma i danni maggiori sono dovuti al cancro corticale, proveniente dagli Stati Uniti e comparso in Italia nel 1938, in grado di diffondersi con estrema virulenza e portare a morte anche le piante di maggiori dimensioni. La trasformazione dei castagneti in cedui è stata l’unica risposta possibile, perché i polloni che si originano dopo i tagli possiedono di volta in volta una resistenza maggiore. Peraltro i cedui castanili per la produzione di legna erano già abbastanza diffusi anche nel passato, soprattutto in ambito collinare, dove fornivano l’ingente quantità di paleria necessaria ai vigneti; purtroppo molti cedui versano oggi in stato di abbandono e la loro conversione in fustaia sarebbe estremamente opportuna. Il castagno è una pianta moderatamente termofila, che richiede suoli abbastanza ricchi, acidi o decalcificati, con una buona disponibilità idrica; la sua diffusione è massima nella fascia collinare e submontana, dove ha sostituito quasi completamente i querceti mesofili, ed in parte anche le formazioni termofile sviluppatesi sui suoli più evoluti, ma nelle località più calde e meglio esposte si è spinto anche più in alto, a spese della faggeta. Un aspetto poco noto del castagneto è l’ampia diffusione che assunse in pianura nel periodo medievale. In un’epoca in cui i boschi erano ancora ampiamente presenti sul territorio, la loro conversione in castagneto rappresentò una conveniente forma di utilizzo prima di procedere al definitivo dissodamento; soprattutto i piccoli proprietari erano favorevoli al suo mantenimento, per il sicuro apporto alimentare che ne traevano. Negli atti notarili si fa menzione di appezzamenti con centinaia di “piedi” di castagno, la cui presenza era concentrata nell’alta pianura tra l’Adda e il Serio; ancora oggi, nei lembi boscati che persistono tra Bonate Sotto e Filago, se ne contano diversi esemplari. 17 LE PRATERIE ARIDE Sui bassi versanti della fascia montuosa più esterna e sui pendii collinari più caldi e asciutti, ovunque il suolo è particolarmente scarso e povero di sostanza organica, i boschi termofili tendono naturalmente a diradarsi, lasciando spazio a cenosi erbacee di notevole interesse. La loro primitiva estensione doveva essere assai modesta, limitata alle zone più ostili al bosco, ma il suo continuo degrado le ha favorite, consentendogli di occupare superfici più ampie, anche su suoli migliori; peraltro, dopo alcuni anni di abbandono, anche i prati da sfalcio, quando non vengono rapidamente invasi dai rovi o dagli arbusti, almeno inizialmente, mostrano la tendenza ad evolvere verso queste formazioni in vario grado adattate all’aridità. In generale la loro fisionomia ricorda quella dei brometi descritti per la pianura, ma per via dell’esposizione meridionale vanno soggette ad un più intenso riscaldamento e ad un’aridità ancora più accentuata; inoltre, dove più frequenti sono gli affioramenti rocciosi, la copertura erbacea risulta piuttosto discontinua e maggiore è la presenza delle specie montane. Sorta di crocevia naturale, vi crescono specie di varia provenienza, alcune delle quali raggiungono qui il limite del proprio areale, soggette a fasi di espansione o di regresso in funzione di tutta una serie di fattori naturali e antropici, dalle oscillazioni climatiche all’avanzata del bosco, dall’intensità del pascolo alla frequenza degli sfalci ed agli incendi; sono ben rappresentati gli elementi floristici centroeuropei, ma quelli di maggior bellezza o rarità hanno prevalentemente origine mediterranea o steppica. La massima copertura è data alcune graminacee, fra le quali sono particolarmente comuni il rusticissimo forasacco eretto (Bromus erectus) ed il più esigente paleo rupestre, (Brachypodium rupestre), maggiormente presente al margine delle formazioni boschive e sui suoli argillosi o debolmente acidi; specie di origine steppica come la barba d’oro (Chrysopogon gryllus), il paleo tardivo (Cleistogenes serotina) e l’inconfondibile lino delle fate (Stipa pennata) sono presenze preziose ma non altrettanto diffuse. Tra le specie di maggior valore, accanto a diverse orchidacee (Orchis morio, O. papilionacea, O. ustulata, Ophrys sphegodes, O. benacensis, O. apifera, Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea, Serapias vomeracea), vanno ricordate almeno Centaurea triumfetti, Centaurea bracteata, Inula montana, Scorzonera austriaca, Lactuca perennis, Campanula sibirica, Orlaya grandiflora, Linum tenuifolium, Helianthemum nummularium, Pulmonaria australis e Prunella laciniata, che insieme a numerose altre piante assai vistose susseguono le loro fioriture dalla primavera all’autunno inoltrato, indici del buon grado di naturalità che le praterie aride ancora detengono. Scarsamente produttive, in passato l’uomo le ha utilizzate solo marginalmente, raramente falciandole, più frequentemente destinandole al pascolo di qualche pecora o capra; nel caso di cenosi secondarie, l’azione antropica ha comunque svolto un ruolo positivo, evitandone l’incespugliamento e la riconquista da parte del bosco, dinamiche naturali innescate dalla cessazione di ogni forma di utilizzo. Ben lungi dall’essere poveri e degradati, per la particolare ricchezza floristica che li contraddistingue, i prati aridi sono meritevoli di tutela al pari di ambienti visivamente più attraenti, quali sono i boschi, le praterie d’altitudine o le zone umide; uno sfalcio tardivo ad anni alterni, oppure il pascolo leggero o saltuario, sono interventi poco onerosi e sufficienti ad assicurarne la continuità. Le specie mediterranee e steppiche 18 Potrà sorprendere, ma al pari delle comunità umane, anche quelle vegetali possiedono una loro storia, per certi aspetti non meno ricca di avvenimenti: ondate migratorie, conquiste e ritirate si sono succedute nel tempo, senza la convulsione che ha caratterizzato analoghe vicende umane, ma con esiti ancora duraturi. La nostra flora è costituita da specie provenienti da regioni diverse e assai lontane tra loro, giunte sul nostro territorio sull’onda dei mutamenti climatici che si sono susseguiti negli ultimi millenni. Sovente, piante che oggi sono accantonate in stazioni particolari o in ambiti geografici ristretti, hanno conosciuto in passato una diffusione più ampia, grazie a condizioni climatiche meglio corrispondenti alle loro esigenze vitali, e la loro presenza nell’attuale contesto vegetazionale permette di ricostruire le fasi del popolamento vegetale del nostro territorio. La bergamasca è parte integrante della regione floristica medioeuropea, ma, nonostante sia saldamente ancorata al sistema alpino e priva di qualsiasi connessione diretta con il mare, ospita un discreto contingente di piante di origine mediterranea. La loro risalita verso il Nord è stata favorita dal riscaldamento climatico verificatosi una prima volta tra 10.000 e 8.000 anni fa e, dopo un’oscillazione più fresca, nuovamente tra 7.000 e 5.000 anni fa, quando grazie a temperature medie più alte di pochi gradi rispetto a quelle attuali, i limiti superiori della vegetazione si innalzarono di alcune centinaia di metri sopra quelli odierni, consentendo a molte specie meridionali, ad esempio il leccio (Quercus ilex), di spingersi all’interno delle valli alpine e raggiungere l’apice della propria espansione; inoltre, una piovosità ridotta permise la penetrazione di specie orientali adattate all’aridità, provenienti dalle lontane steppe eurasiatiche con una migrazione di migliaia di chilometri. La vegetazione termoxerofila costituiva allora una fascia ben più profonda di quella attuale e orlava ininterrottamente il margine meridionale delle Alpi, direttamente collegata alle sue zone d’origine e continuamente arricchita dall’arrivo di nuove specie; in seguito, il generale raffreddamento del clima e l’aumento della piovosità l’hanno impoverita e isolata nelle sue sedi attuali, con una presenza maggiore nell’area compresa tra i laghi prealpini orientali. Le specie stenomediterranee, con diffusione strettamente limitata alle regioni costiere e comunque entro l’areale dell’olivo, sopravvivono oggi da noi in numero esiguo (Erica arborea, Orchis provincialis, Arum italicum, Sinapis arvensis), mentre le eurimediterranee, piante che riescono a spingersi più profondamente verso Nord fino al limite di coltivazione della vite, contano oltre un centinaio di specie, comprese alcune orchidee; poche le mediterraneo-montane, originarie dei rilievi montuosi meridionali (fra le quali Allium cirrhosum, Calamintha nepeta, Dianthus sylvestris, Geranium nodosum), ed alcune decine le steppiche, tutte appartenenti al gruppo delle sudeuropee-sudsiberiane (Achillea tomentosa, Allium lusitaniicum, Dictamnus albus, Campanula sibirica, Onobrychis arenaria, Artemisia alba, Fumana procumbens, ecc.). Le specie più comuni, in maggioranza eurimediterranee (Allium vineale, Ajuga chamaepytis, Crepis foetida, Petrorhagia prolifera, Dipsacus fullonum, Sambucus ebulus, Ballota nigra e molte altre) sono presenti anche in pianura, adattandosi senza difficoltà agli ambienti disturbati dall’uomo, che ha indirettamente contribuito alla loro diffusione nei coltivi e negli incolti, lungo i margini stradali e sui ruderi, ma quelle di maggior pregio si concentrano nei prati aridi e sui caldi pendii rupestri collinari e pedemontani. Ne sono ricchi soprattutto i versanti che si affacciano sul basso Sebino, favorevolmente esposti e riparati, soggetti all’influsso mitigatore della grande massa d’acqua, il cui carattere mediterraneo è più evidente quando il cielo azzurro intenso di una tersa giornata primaverile si riflette nelle profonde acque del lago ed il sole inonda di luce e calore le rocce sovrastanti. Vi si trovano anche piante estremamente rare, limitate a poche stazioni, come il terebinto (Pi19 stacia terebinthus), un arbusto dalle infiorescenze rossastre, il villucchio bicchierino (Convolvulus cantabrica), dai grandi fiori rosati, il guado (Isatis tinctoria), l’elegante lattuga rupestre (Lactuca perennis), la biscutella maggiore (Biscutella cichoriifolia), la ruta selvatica (Ruta graveolens) e la rarissima orchidea farfalla (Orchis papilionacea). Sono queste piante, e non gli olivi, gli oleandri ed i cipressi piantati dall’uomo, a raccontare i trascorsi climatici e vegetazionali della nostra terra; l’avanzata di nuove specie le ha costrette nei loro ambienti di rifugio, dove sopravvivono tenacemente da migliaia di anni, ma chissà che il riscaldamento in atto non offra loro una nuova opportunità per espandersi. Le orchidee Conosciute e apprezzate dai più solo per la straordinaria bellezza dei fiori, le orchidee occupano un posto del tutto speciale nel mondo delle piante, grazie alle sorprendenti strategie riproduttive che mettono in atto ed alla grande adattabilità ecologica, fattori a cui devono il loro successo evolutivo. Nel passato, in assenza di qualsiasi nozione scientifica, intorno a loro sono sorte le più disparate credenze; si riteneva, ad esempio, che vivessero solo nel folto delle giungle tropicali, che fossero estremamente rare, che in maggioranza fossero piante parassite o carnivore e gli si attribuivano portentosi effetti curativi. Come se non bastasse, diversi fra gli antichi autori ne attribuivano la nascita ad un inverosimile “potere seminale” ancora posseduto dagli animali morti, che trasmettevano le loro sembianze al fiore, spiegandone così la straordinaria somiglianza con alcuni insetti e perfino con il corpo umano. La verità, ovviamente, è un po’ diversa. Sono circa 25.000 le specie esistenti, diffuse maggiormente nelle zone tropicali e più limitatamente nelle regioni temperate e fredde; delle 153 specie italiane, quelle accertate per il territorio bergamasco sono attualmente 55. A differenza delle loro cugine tropicali epifite, che vivono sui rami degli alberi ed hanno fiori di dimensioni anche ragguardevoli, le nostre orchidee sono geofite, con radici e organi di riserva sotteranei e fiori decisamente più piccoli, ma con una varietà di forme e colori per nulla inferiore. Le troviamo negli ambienti più disparati, seppure con frequenza diversa: negli assolati prati aridi come nei pascoli d’altitudine, negli ombrosi boschi di latifoglie e in quelli di conifere, negli arbusteti e nelle zone umide, sui suoli silicei come su quelli carbonatici, dalla pianura fin sul crinale orobico. Se la famiglia, nel suo insieme, è molto adattabile, le singole specie sono estremamente esigenti: la loro distribuzione risulta indissolubilmente legata a precise condizioni di suolo, di umidità, di temperatura e di luce, nonchè alla presenza di specifici insetti impollinatori; per questo crescono solo negli ambienti più integri e dotati di una ricca biodiversità, mentre scompaiono inesorabilmente in tutte le situazioni di degrado. L’osservazione attenta dei loro fiori, oltre a rivelarne l’originalità, permette di riconoscerne i più importanti caratteri distintivi: l’esistenza di un solo piano di simmetria (zigomorfia), la particolare conformazione e colorazione di uno dei tre petali (labello), più grande e spesso prolungantesi nello sperone, gli stami ridotti da 6 (come di norma nelle Monocotiledoni) a 1 (solo il genere Cypripedium ne possiede 2), la saldatura dell’antera con lo stimma a costituire una sorta di colonnina (gimnostenio) ed i granuli di polline agglomerati in due masserelle collegate ad un organo viscoso (retinacolo); non è sempre presente il rostello, piccola protuberanza posta sul 20 gimnostenio per impedire il contatto tra antera e stimma e favorire la fecondazione incrociata, mentre solitamente si verifica la resupinazione, un movimento di torsione dell’ovario che avviene prima della fioritura per portare il labello in posizione inferiore. Una struttura così particolare serve a coinvolgere infallibilmente gli insetti pronubi; in natura è comune il caso di insetti che assumono sembianze vegetali per mimetizzarsi e difendersi dai loro predatori, più raramente avviene che le piante li imitino per trarli in inganno, sia pure senza causare loro alcun male. Le Oprhys sono le più raffinate: il loro labello riproduce le fattezze delle femmine di alcuni insetti, attraendone irresistibilmente i maschi, ingannati anche dall’emissione di aromi simili ai feromoni sessuali femminili; tentando l’accoppiamento il maschio urta il retinacolo, che si incolla sul suo capo con le masserelle di polline, le quali saranno poi depositate su un altro fiore. Le Ophrys sono agevolate dal fatto che i maschi s’involano con un certo anticipo sulle femmine; dunque sfruttano a proprio vantaggio questa sfasatura, ma la simulazione è talmente efficace che pur in presenza delle femmine i maschi sono maggiormente attratti dalle orchidee! Altre specie, come le appartenenti ai generi Orchis e Gymnadenia, si servono degli insetti che suggono il nettare dal fondo dello sperone, accessibile solo con una spirotromba adeguata; in questo caso il labello funge da pista di atterraggio. Se la fecondazione incrociata non è possibile, molte orchidee possono autofecondarsi, o addirittura produrre i semi senza fecondazione; per alcune, queste sono le più frequenti od esclusive modalità riproduttive. I semi, prodotti a migliaia e piccolissimi, sono facilmente disperdibili, ma costituiti dal solo embrione e privi di sostanze di riserva, possono germinare solo grazie al nutrimento fornito da funghi del genere Rhizoctonia. In seguito, quando la pianta inizia l’attività fotosintetica, la simbiosi può cessare, ma si mantiene tutta vita nelle orchidee prive di clorofilla; la crescita è comunqua assai lenta e la fioritura avviene solo dopo diversi anni. Osserviamole pure per la loro bellezza, ma ricordiamoci che, similmente alle orchidee che necessitano dell’intervento di altri organismi nelle fasi più importanti della loro vita, anche la nostra esistenza dipende da un’infinità di fattori naturali che troppo spesso trascuriamo. I PRATI FALCIABILI Le rigogliose praterie che ammantano i bassi versanti collinari e montani non hanno origine naturale. Estese sui pendii meno acclivi, dove si sono evoluti suoli discretamente profondi, ricchi di sostanza organica e sufficientemente umidi, sono state ottenute dall’uomo a spese della copertura boschiva originaria, con lo scopo di produrre il foraggio necessario all’alimentazione del bestiame. La composizione floristica dei primi prati doveva essere piuttosto scadente e simile a quella delle radure boschive, ma secoli di concimazioni con letame e di sfalci li hanno lentamente migliorati, fino alla formazione di cenosi più ricche e produttive, dove convivono stabilmente specie dalla notevole capacità vegetativa, in grado di accrescersi velocemente e sopportare il taglio periodico, ma assai esigenti, che necessitano di continue cure da parte dell’uomo. Falciati almeno due volte all’anno e regolarmente concimati, questi prati costituiscono un’associazione seminaturale assai caratteristica, l’Arrenatereto, che dal fondovalle risale fin verso gli 800 m, il cui nome è dovuto alla presenza costante di una robusta graminacea, l’avena altissima (Arrhenatherum elatius) ed alla quale partecipano numerose piante di diversa taglia, 21 ognuna delle quali occupa uno strato particolare. La massa erbosa del primo sfalcio si deve prevalentemente alle Graminacee, favorite dal loro precoce risveglio primaverile; oltre all’avena altissima, fra loro si contano numerose foraggere di gran pregio e dal notevole sviluppo vegetativo, come l’erba mazzolina (Dactylis glomerata), la fienarola dei prati (Poa pratensis), la fienarola comune (Poa trivialis) e il loglio perenne (Lolium perenne), che tendono a sovrastare il piccolo paleino odoroso (Anthoxanthum odoratum), cui il fieno deve il suo caratteristico aroma, e l’erba bambagiona (Holcus lanatus). Notevole importanza foraggera possiedono anche le leguminose, tutte assai appetite al bestiame; veramente comuni sono i trifogli (Trifolium pratense, T. repens), la cui presenza è più evidente dopo il primo taglio, ed il ginestrino (Lotus corniculatus), più rare la cicerchia dei prati (Lathyrus pratensis) e la veccia dolce (Vicia sativa). Insieme a queste specie ne crescono molte altre di minor valore, quali il soffione (Taraxacum officinale) ed il dente di leone comune (Leontodon hispidus), i millefoglie (Achillea millefolium, A. roseo-alba), la vistosa margherita dei prati (Leucanthemum vulgare) ed il fiordaliso nerastro (Centaurea nigrescens), tutte appartenenti alle Asteracee, il ranuncolo dei prati (Ranunculus acris), velenoso allo stato fresco ma il cui principio tossico si degrada con l’essicazione, il robusto spondilio (Heracleum spondylium) ed il tragoselino maggiore (Pimpinella major), entrambe appartenenti alle Ombrellifere, l’acetosa (Rumex acetosa), una poligonacea dal caratteristico sapore acidulo, un tempo consumata fresca in insalata; talune, come il fior di cuculo (Lychnis flos-cuculi), segnalano le zone più umide, mentre altre, come l’appariscente salvia dei prati (Salvia pratensis) prediligono quelle più secche; molte donano ricchissime fioriture, le cui tonalità prevalenti si susseguono con l’alternarsi delle stagioni. Se gli sfalci si diradano e la concimazione cessa, entrano nell’associazione specie meno esigenti, indicatrici di una minor disponibilità di elementi nutritivi; sui versanti meridionali compaiono Rhinanthus alectorolophus, Filipendula vulgaris, Pastinaca sativa, Daucus carota, Brachypodium rupestre e Bromus erectus, la cui presenza segnala una disponibilità idrica più ridotta e l’evoluzione verso le forme più ricche di brometo, mentre sui versanti esposti a settentrione, si assiste ad una rapida colonizzazione da parte del bosco. I RONCHI L’azione millenaria dell’uomo ha profondamente modificato il paesaggio; la vegetazione originaria è stata sostituita con prati e coltivi, ed anche l’aspetto fisico del territorio è stato trasformato, per renderlo più adatto alle esigenze delle colture. Se nella bassa pianura la difficoltà maggiore consisteva nel liberare i terreni dall’eccesso d’acqua, per la messa a coltura dei versanti collinari e montani occorreva addolcirne la pendenza, così che la terra faticosamente strappata al bosco non venisse rapidamente dilavata dalle piogge; in val Seriana si indicava con l’espressione s’drilà l’operazione di riporto della terra dalla base del pendio alla sua sommità. Il terrazzamento dei versanti permetteva di ricavare strisce di varia larghezza, più o meno pianeggianti o moderatamente inclinate, ma era un’ operazione estremamente onerosa, che richiedeva un grande dispendio di manodopera. Abbattuto il bosco occorreva estirpare ceppi e radici, da bruciare o asportare con tutta la ramaglia; quindi si ripuliva il terreno dalle pietre, accatastandole lungo i tracciati dei muri, che venivano eretti a secco ma con cura, seguendo la naturale morfologia del pendio; con l’innalzarsi dei muri si procedeva a stendere la terra, curando di formare uno strato sufficiente alle lavora22 zioni, e se quella disponibile in sito era troppo scarsa la si trasportava con le gerle dal fondovalle. Solo se la pendenza non era molto accentuata, bastava creare dei ciglioni erbosi, meno alti dei muri e di più semplice realizzazione. Tutte queste operazioni venivano compiute a forza di braccia, impiegando la roncola, la vanga e la zappa; il termine medievale roncare, letteralmente “tagliare con la ronca”, definiva l’insieme delle operazioni di ripulitura dalla vegetazione spontanea e di sistemazione del terreno, necessarie per avviare la coltivazione di un nuovo appezzamento, il ronco, termine infine usato per indicare i terrazzamenti a vigneto, realizzati su tutti i versanti collinari ben esposti. Nonostante la rimozione del bosco, con la creazione di nuovi habitat la biodiversità della collina si è incrementata, perché muri a secco, prati, vigneti e frutteti hanno offerto ricetto a nuove comunità vegetali e animali. Fra i filari di vite, sul terreno ben lavorato, periodicamente concimato e asciutto, crescono piante caratteristiche delle colture sarchiate, amanti della luce e del calore, a ciclo breve e sviluppo autunnale-primaverile (Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Veronica persica, Lamium purpureum, L. amplexicaule, Fumaria officinalis) o primaverile-estivo (Crepis capillaris, C. biennis, Solanum nigrum, S. luteum, Chenopodium album, Setaria spp., Amaranthus spp.), ma particolarmente caratteristiche di questo ambiente sono alcune piante geofite, perennanti grazie ai loro organi sotterranei, un tempo maggiormente diffuse, come l’aglio delle vigne (Allium vineale) e quello selvatico (Allium oleraceum), il cipollaccio (Leopoldia comosa), il muscari atlantico (Muscari atlanticum) ed il latte di gallina (Ornithogalum umbellatum), quasi tutte di origine mediterranea e favorite dalla buona esposizione dei versanti; anche le ripe erbose ospitano specie adattate alla secchezza del suolo ed amanti della luce, spesso assai appariscenti, come la salvia dei prati (Salvia pratensis), il geranio sanguigno (Geranium sanguineum), la silene ciondola e gli strigoli (Silene nutans, S. vulgaris ssp. vulgaris), il caglio zolfino (Galium verum), l’origano (Origanun vulgare), il raperonzolo (Campanula rapunculus), la salvastrella (Sanguisorba minor) e l’olmaria (Filipendula vulgaris). Degne di attenzione sono pure le piante che crescono sui muri, adattatesi alle particolari condizioni del loro ambiente e formanti comunità assai caratteristiche. Con la crisi dell’agricoltura collinare, verificatasi negli ultimi decenni, la superficie a vigneto si è più che dimezzata; molti ronchi sono stati convertiti a prato o abbandonati all’invasione della vegetazione naturale; muri e ciglioni vanno malinconicamente rovinando, ed uno dopo l’altro i terrazzi vengono conquistati da rovi e robinie, ma in qualche caso si è spontaneamente avviata la ricostituzione delle praterie aride e dei boschi termofili. Le piante dei muri I vecchi muri, accuratamente realizzati con la pietra locale per sostenere i terrazzamenti o per recintare le proprietà, rappresentano per le piante un ambiente assimilabile alle pareti rocciose; la scarsità di terriccio, la limitata disponibilità di acqua, l’esposizione e l’eventuale presenza di un legante sono i fattori che ne condizionano la colonizzazione, più facile a realizzarsi sui muri di contenimento, per il diretto contatto con il suolo. Le piante si insediano nelle fessure e negli interstizi che accolgono una piccola quantità di terriccio e dove l’umidità si mantiene più costante, formando associazioni cui partecipano specie assai caratteristiche, molte delle quali possiedono particolari adattamenti all’aridità. È questo il caso delle comuni borracine (Sedum album, S. dasyphyllum, S. sexangulare), provviste di foglie carnose in cui immagazzinare l’acqua, con stomi profondamente infossati e ri23 vestite da una cuticola impermeabile per ridurre la minimo la traspirazione. Le si ritrova facilmente sui muri più assolati insieme alla cedracca (Ceterach officinarum), una piccola felce insolitamente amante dei luoghi caldi e luminosi, con foglie coriacee che in caso di prolungata siccità si richiudono su se stesse, così che la delicata pagina superiore venga protetta da quella inferiore, coperta da numerose squame e da peli ghiandolari color ruggine. Altre felci di piccole dimensioni crescono frequentemente sui muri ombrosi, l’elegante erba rugginina (Asplenium trichomanes) e la ruta muraria (Asplenium ruta-muraria), sempre accompagnate dai cespetti della cimbalaria (Cymbalaria muralis), una scrofulariacea con foglioline lucide simili a quelle dell’edera e fiori graziosi che ricordano le bocche di leone, violacei con il labbro inferiore aranciato; dopo che le api hanno operato la fecondazione, i peduncoli fiorali cominciano ad incurvarsi, portando le capsule in formazione a contatto con il muro, in modo che una volta mature possano liberare i semi nelle sue anfrattuosità. L’erba vetriola (Parietaria giudaica) è diffusissima e si sviluppa dove più consistenti sono i depositi di terriccio, sovente alla base del muro, insieme a numerose piante ruderali che necessitano di un certo apporto di sostanze nutritive, come l’erba dei porri (Chelidonium majus), la fumaria (Fumaria officinalis), il grespino (Sonchus oleraceus), l’erba roberta (Geranium robertianum), il senecio comune (Senecio vulgaris), la verbena (Verbena officinalis) e l’ortica (Urtica dioica); persino il fico (Ficus carica) nasce spontaneamente fra le pietre dei muri, sviluppandosi spesso con una forma appressata, mortificato da continui tagli ma sempre vitale. Anche i muri danno asilo ad una flora esotica, nella quale ci si può imbattere più facilmente percorrendo una delle viuzze che contornano i colli cittadini, oppure alzando lo sguardo sulle imponenti mura venete: il cappero (Capparis spinosa) è originario dell’Asia Minore, mentre la vistosissima valeriana rossa (Centranthus ruber) e le note bocche di leone (Antirrhimun majus) sono specie mediterranee, introdotte per l’ornamento dei giardini ed in seguito spontaneizzatesi; uguale sorte ha avuto la cespica karwinskiana (Erigeron karwinskianus), un’asteracea originaria del Messico, con fiori simili alle pratoline. Grazie alle piante “coraggiose” che colonizzano i muri, in qualche modo la natura si è conquistata uno spazio sulle creazioni dell’uomo, capovolgendo, una volta tanto, l’esito di un confronto che troppo spesso la vede soccombere. I FIUMI Nel tratto che precede il loro sbocco in pianura, le aste fluviali hanno subito il radicale intervento dell’uomo: le zone periodicamente soggette alle esondazioni, da sempre di pertinenza dei fiumi, sono state ovunque colmate con materiali inerti, ricavandone aree verdi oppure spazi agricoli o edificabili, mentre gli alvei sono stati rettificati e ristretti entro arginature artificiali, causando la scomparsa, o quanto meno l’impoverimento, delle formazioni igrofile, già penalizzate dai forti prelievi idrici che, soprattutto nei mesi estivi, riducono le portate dei fiumi a livelli minimi. Non resta alcuna traccia dei folti boschi ripariali che un tempo orlavano gli alvei, spingendosi anche ad una certa distanza dai fiumi, sui suoli limosi e umidi del fondovalle; li costituivano il salice bianco (Salix alba), l’ontano nero (Alnus glutinosa), il frassino (Fraxinus excelsior), il pioppo nero (Populus nigra) e numerosi arbusti (Salix purpurea, S. elaeagnos, Frangula alnus, Cornus sanguinea, Viburnum opulus), tutte specie che affondano le radici nella falda più superficiale e sopportano senza difficoltà le temporanee sommersioni causate dalle piene maggiori. 24 Sui depositi ciottolosi e sabbiosi delle rive, appena al di sopra delle acque del fiume, che li raggiunge appena si ingrossa, si sviluppano popolamenti di salici arbustivi (Salix purpurea, S. elaeagnos), profondamente radicati e con rami estremamente flessibili per resistere alla forza delle acque, con una nutrita presenza di giovani piante di pioppo nero e salice bianco, cui si mischia sempre più frequentemente un grande arbusto originario della Cina, la buddleja (Buddleja davidii), dall’appariscente fioritura estiva violacea; parzialmente scalzate dalla furia delle piene più rovinose, queste specie pioniere ricolonizzano velocemente le rive, consolidandole nuovamente. Procedendo verso il greto si incontrano piante che in maggioranza non sono esclusive degli ambiti fluviali, entrando frequentemente anche negli ambienti più antropizzati; alcune sono perenni, molto diffuse quali la saponaria (Saponaria officinalis) o le artemisie (Artemisia vulgaris, A. verlotorum), oppure decisamente meno comuni, come l’elegante garofanino di Dodoneus (Epilobium dodonaei), formante cespugli bassi e compatti, con foglie lineari argentee e bei fiori rosei all’apice degli steli; in questa fascia, maggiormente disturbata delle precedenti, prevalgono comunque le piante a ciclo breve, biennali o annuali, fra cui la barbarea (Barbarea vulgaris) e la canapetta a foglie strette (Galeopsis angustifolia). Il greto vero e proprio, rimodellato ad ogni piena ma per buona parte dell’anno quasi privo di acqua, è un ambiente assolato ed arido in superficie, dove prosperano specie rusticissime dallo sviluppo rapido, in grado di formare popolamenti densissimi, quali la nappola (Xanthium italicum) ed i poligoni (Polygonum persicaria, P. lapathyfolium), ma dove è possibile anche l’insediamento di specie esotiche, come la balsamina ghiandolosa (Impatiens glandulifera), proveniente dall’Himalaya, o l’ormai diffusissimo senecio africano (Senecio inaequidens), facilmente riconoscibile per la prolungata fioritura gialla; le specie più amanti dell’acqua (Thyphoides arun- dinacea, Glyceria plicata, Polygonum hydropiper, Veronica beccabunga, Nasturtium officinale, Juncus effusus) si concentrano invece lungo gli stretti canali dove questa è sempre presente, nelle pozze e sui depositi fangosi costantemente umidi, in grado di rivegetare anche dopo essere state sommerse dai sedimenti trasportati dal fiume. Chi volesse conoscere la vegetazione ripariale e acquatica, tutto sommato può trovarne esempi migliori, anche se in scala ridotta, allontanandosi dagli ampi greti ciottolosi e cercando nelle vallecole e nelle limitate zone umide che ancora persistono al piede dei colli, lungo i modesti torrentelli ed i fossati che li drenano, ambienti più integri dove è possibile incontrare un gran numero di specie ormai rare o irreperibili sui nostri fiumi. I LAGHI SUBALPINI Per il repentino inabissarsi del fondale, la vegetazione lacustre è frammentaria o assente lungo le coste rocciose più scoscese del Sebino, mentre forma una cintura più ricca e complessa sulle rive limose in lieve declivio, per loro natura favorevoli al costituirsi di un’ampia fascia di interramento; soprattutto attorno ai piccoli bacini di Endine e di Gaiano si sviluppa rigogliosa, articolandosi in fasce concentriche in base alla profondità dell’acqua: a quella esterna più asciutta, succedono terreni sempre più inondati, fino alla zona centrale del lago, più profonda e non ancora occupata dalla vegetazione. In ogni fascia si ritrovano specie caratteristiche, specializzate a vivere in ambienti umidi, acquitrinosi od acquatici grazie a particolari adattamenti morfologici e strutturali. Le piante sommerse o natanti possiedono apparati radicali poco sviluppati e seguono le oscillazioni di livello delle acque grazie ai fusti flaccidi ed allungati, resi leggeri dalla ricchezza 25 di tessuti aeriferi che facilitano il galleggiamento e il movimento dei gas fino alle parti profonde; le foglie natanti hanno lamine espanse, con la pagina superiore protetta da cuticole e ricca di stomi, mentre quelle sommerse sono spesso divise in lacinie filiformi per non opporre resistenza al fluire delle acque, anche se lento. Le piante anfibie sono altrettanto ricche di tessuti aeriferi, ma possiedono apparati radicali robusti e fusti resistenti ed elastici, per sopportare il moto ondoso ed il vento; spesso formano densi cespi ed hanno foglie nastriformi di consistenza coriacea. Tutte affrontano un periodo di quiescenza invernale e sviluppano robusti rizomi o grosse gemme per immagazzinare abbondantemente le riserve da utilizzare alla ripresa vegetativa primaverile. Ad una certa distanza dalla riva, alla profondità di alcuni metri, si sviluppano basse praterie di alghe verdi che favoriscono l’accumulo di sedimenti e la colonizzazione da parte di nuove piante; le costituiscono specie appartenenti ai generi Nitella e Chara, simili nell’aspetto generale agli equiseti. In acque profonde da 1 a 4 m si afferma una comunità di piante sommerse, difficilmente osservabile dalla riva, cui partecipano il millefoglio d’acqua (Myriophillum spicatum), con foglie verticillate a 4 e divise in esili segmenti, il ceratofillo comune (Ceratophyllum demersum), i cui festoni privi di radici sono ancorati al fondo da esili germogli oppure vagano liberi nell’acqua, la coda di cavallo (Hippuris vulgaris) e, soprattutto, alcune specie di potamogeti, con fusti lunghi alcuni metri e foglie più o meno espanse (Potamogeton natans, P. crispus, P. lucens) o finemente laciniate (Potamogeton pusillus), tutte con fiori poco appariscenti. Dove la profondità dell’acqua si attenua compaiono frequentemente il ranuncolo acquatico (Ranunculus aquatilis) e la notissima ninfea (Nymphaea alba), che dal fondale fangoso innalza le foglie ed i candidi fiori galleggianti fino alla superficie dell’acqua. Approssimandosi ulteriormente alla riva, col diminuire della profondità divengono dominanti le piante anfibie, che mantengono costantemente immersa nell’acqua solo la parte basale. In questa fascia forma compagini fittissime la cannuccia d’acqua (Phragmites australis), così elevata da nascondere alla vista il retrostante specchio d’acqua; tra le specie che più frequentemente l’accompagnano sono da ricordare la mazzasorda (Typha latifolia), a tutti nota per le brune spighe vellutate, il coltellaccio eretto (Sparganium erectum) e la lisca palustre (Schoenoplectus palustris); nascoste tra queste si rinvengono facilmente la mazza d’oro (Lysimachia vulgaris), l’iris giallo (Iris pseudacorus), l’erba sega (Lycopus europaues), la menta acquatica (Mentha aquatica) e la scutellaria palustre (Scutellaria galericulata), mentre decisamente meno osservabile è il trifoglio fibrino (Menyanthes trifoliata), la cui fioritura impareggiabile è penalizzata dallo sfalcio annuale del canneto. Sulla riva ancora umida e di tanto in tanto soggetta a brevi sommersioni, trovano ampia diffusione le robuste carici (C. elata, C. acutiformis, C. pseudocyperus) che con i loro densi cespi producono in abbondanza materia organica e consolidano il suolo; più oltre, sulle aree dove oggi si estendono prati da sfalcio, strade, parcheggi ed abitazioni, si sviluppavano un tempo i boschi igrofili, con dominanza di ontani e salici nelle aree depresse più prossime all’acqua, mentre a distanza maggiore crescevano anche pioppi, olmi, frassini e farnie. Proprio il bosco rappresenta lo stadio finale verso cui evolve, in tempi più o meno lunghi, la vegetazione lacustre; le varie fasce avanzano progressivamente verso le zone più profonde, gradualmente colmate anche dal continuo apporto di detriti, così che bacini di modesta dimensione possono scomparire per interramento in tempi relativamente brevi. 26 LE FAGGETE Al di sopra dei boschi di querce e castagni, in ambito più decisamente montano, il faggio (Fagus sylvatica) diviene gradualmente la specie arborea dominante. Pianta dalle particolari esigenze ecologiche, meno tollerante delle altre specie mesofile, necessita di un clima fresco e piovoso, con precipitazioni regolarmente distribuite durante l'anno, costante umidità atmosferica e temperature non estreme, condizioni che ritrova facilmente sui nostri rilievi, caratterizzati da un clima suboceanico, con buona piovosità anche nei mesi estivi più caldi, nebbie frequenti ed inverni relativamente miti rispetto alle zone alpine più interne; predilige i suoli profondi, ricchi di humus e ben drenati, su substrato carbonatico, ma si adatta anche a quelli più poveri e tendenzialmente acidi, purchè non eccessivamente umidi o rocciosi. Specie gregaria per eccellenza, se indisturbato il faggio forma boschi puri di straordinaria bellezza, che un tempo ammantavano i versanti prealpini fino al limite della vegetazione arborea, salendo anche oltre i 1700 m nelle stazioni più favorite; le originarie fustaie sono state ovunque trasformate in cedui, ma nonostante l’intervento dell’uomo ne abbia modificato struttura e composizione, le faggete conservano ancora la loro peculiare fisionomia. Alle quote superiori e sui versanti più freschi, i faggi crescono ravvicinati, con tronchi agili e svettanti ramificati solo all’estremità, dove si concentrano le foglie; la chiusura dello strato arboreo è pressochè totale, lasciando filtrare solo una minima quantità di luce, mentre al suolo si accumula uno spesso strato di foglie morte. Nel sottobosco è quasi assente lo strato arbustivo, mentre compaiono diverse specie erbacee amanti dell’ombra e di una buona umidità, alcune abbastanza diffuse, come la barba di capra (Aruncus dioicus), la mercorella comune (Mercurialis perennis), le dentarie (Cardamine heptaphylla, C. enneaphyllos, C. pentaphyllos, C. kitaibelii), il raponzolo plumbeo (Phyteuma spicatum), l’erba fragolina (Sanicula europaea), l’uva di volpe (Paris quadrifolia), l’acetosella (Oxalis acetosella) e la velenosa actea (Actaea spicata). Negli impluvi molto umidi, al faggio subentrano il frassino (Fraxinus excelsior) e l’acero di monte (Acer pseudoplatanus), mentre nelle schiarite conseguenti ai tagli si diffondono temporaneamente il maggiociondolo (Laburnum anagyroides) e il salice stipolato (Salix appendiculata). Sui versanti soleggiati ed a quote più modeste, la faggeta presenta un carattere più termofilo: le piante sono più rade e meno elevate, frammiste a qualche carpino nero (Carpinus ostrya) e sorbo montano (Sorbus aria); una maggior quantità di luce e calore raggiungono il suolo e la lettiera di foglie si decompone più rapidamente. La presenza arbustiva è più consistente e vi crescono numerose specie erbacee comuni anche agli ostrieti ed ai querceti sottostanti, come l’anemone dei boschi (Anemone nemorosa), la fegatella (Hepatica nobilis), la rosa di Natale (Helleborus niger), il ciclamino (Cyclamen purpurascens), il geranio nodoso (Geranium nodosum), la lucertolina fetente (Aposeris foetida) ed alcune orchidee (Cephalanthera damasonium, Neottia nidus-avis, Listera ovata). Sulle creste ventose, sui pendii più ripidi e nei canaloni, il faggio assume spesso un portamento arbustivo, accompagnandosi più frequentemente al maggiociondolo alpino (Laburnum alpinum), alla betulla (Betula pendula), al sorbo montano (Sorbus aria) e ad alcuni salici (Salix appendiculata, Salix glabra). In ambito prealpino queste formazioni coincidono con il limite climatico della vegetazione arborea, mentre nelle valli più interne, il faggio si mischiava sempre più frequentemente con l’abete bianco (Abies alba) e col peccio (Picea excelsa), fino ad essere completamente sostituito dalle conifere; oggi, boschi misti dalla composizione equilibrata sono piuttosto rari, perché per lungo tempo la gestione forestale ha favorito la diffusione delle conifere, soprattutto del 27 peccio, a discapito della latifoglia. Le faggete occupano ancora notevoli superfici, ma la loro estensione originaria è stata notevolmente ridotta, sia per ampliare i pascoli d’altitudine che per ottenere prati da sfalcio nella fascia soprastante gli insediamenti e, conseguentemente, il passaggio alle cenosi erbacee avviene spesso in modo repentino; nel passato intensamente sfruttate per la produzione di legna e carbone, sovente sono inquinate o sostituite dal peccio anche alle quote inferiori, come avvenuto per il Bosco Faeto, sul versante settentrionale della Cima di Cavlera. La grande diffusione e l’importanza del faggio nei tempi passati sono indirettamente testimoniate proprio dai numerosi toponimi che ne sono derivati, come Fuipiano, (Bosco) Faeto, (Bosco) Fellongo, (Monte) Faeto, Faìt, Faietto, ecc., spesso ricorrenti e spettanti anche a località dove oggi la bella latifoglia è rara o scomparsa. I PRATI-PASCOLI Insediate su un territorio che il rigore del clima e la sfavorevole giacitura rendono largamente inadatto alla campicoltura, le popolazioni montane hanno trovato nell’allevamento bovino e nelle attività casearie connesse una preziosa fonte di sostentamento, e per disporre del foraggio necessario hanno sostituito ampi tratti di faggeta con i prati da sfalcio. Interi nuclei rurali devono la loro esistenza proprio alle vaste praterie che li circondano, ed anche la capillare diffusione di stalle e fienili, oggi spesso in stato di abbandono, testimonia la fondamentale importanza che i prati ebbero un tempo nell’economia montana; oggi il bosco riconquista ampie porzioni di territorio, ma fin oltre la metà del secolo scorso permaneva solo sui versanti più inospitali, mentre erano le regolari geometrie dei prati falciati, estese sui pendii meno acclivi e rimarcate da un reticolo di muretti e mulattiere, a connotare maggiormente il paesaggio. Le superfici disboscate furono dapprima utilizzate come pascolo, finchè le letamazioni ed i tagli ripetuti favorirono l’affermarsi di piante foraggere pregiate; l’intervento dell’uomo resta comunque indispensabile per il mantenimento delle praterie pingui, cenosi seminaturali che una volta abbandonate si impoveriscono rapidamente, fino ad essere invase da una vegetazione arbustiva che prelude al ritorno del bosco, processo oggi abbastanza frequente, perchè la diminuita importanza dell’allevamento bovino ha determinato una minore necessità di foraggio ed una ridotta disponibilità di letame. I prati da sfalcio montani si differenziano sensibilmente dagli arrenatereti delle quote inferiori, nonostante possiedano in comune un buon numero di specie; al progressivo innalzamento di quota corrispondono il graduale ingresso di specie decisamente montane e, soprattutto, un periodo vegetativo sempre più breve, tale da consentire un solo sfalcio, solitamente nella prima metà di luglio, tradizionalmente seguito dal pascolo. L’associazione prende il nome di Triseteto, per la costante presenza dell’avena bionda (Trisetum flavescens), una bella graminacea dalle spighette dorate e rilucenti a maturità, caratteristica di questi prati anche se non sempre dominante, scarsamente diffusa alle quote inferiori; alla medesima famiglia appartengono l’erba mazzolina (Dactylis glomerata), l’avena altissima (Arrhenatherum elatius), la coda di topo (Phleum pratense), il paleino odoroso (Anthoxanthum odoratum), i cappellini (Agrostis tenuis) e le festuche (Festuca rubra, F. pratensis), mentre fanno parte delle Leguminose i trifogli rossi (Trifolium pratense) e bianchi (T. repens, T. montanum) ed il ginestrino (Lotus corniculatus), tutte assai comuni ed ottime foraggere. 28 Entrano nella ricchissima e pluristratificata flora di queste praterie anche numerose piante dalle fioriture multicolori e di varia origine, che oltre a scandire l’alternarsi delle stagioni ne evidenziano alcuni aspetti particolari. Al risveglio primaverile, appena sciolte le ultime nevi, esplode ricchissima la fioritura bianco-violacea dei crochi (Crocus albiflorus), discesi dalle praterie d’altitudine, seguita a breve distanza dalle scille (Scilla bifolia), dai denti di cane (Erythronium dens-canis) e dai muscari (Muscari botryoides), presenze altrettanto copiose e indicatrici dell’antica copertura boschiva, che concludono precocemente il loro ciclo prima del rigoglioso sviluppo delle erbe di taglia maggiore. Primule (Primula elatior) e genziane (Gentiana kochiana) divengono più frequenti con l’innalzarsi della quota, mentre la serpentina (Polygonum bistorta) e la silene (Silene dioica) prediligono gli avvallamenti ed i versanti più umidi ed abbondantemente concimati, che segnalano con grandi macchie rosee; i velenosi ranuncoli (Ranunculus acris, R. bulbosus), la salvia dei prati (Salvia pratensis) e la vulneraria (Anthyllis vulneraria) crescono sui pendii asciutti e poco fertili, mentre la margherita dei prati (Leucanthemum vulgare), il millefoglio (Achillea millefolium) ed il cumino (Carum carvi) sono molto adattabili e si rinvengono un po’ ovunque. Narcisi (Narcissus poëticus) e botton d’oro (Trollius europaeus), sono specie peggioratrici della qualità del fieno, la cui presenza indica un decadimento del triseteto, dovuto ad una cura sempre meno intensa, anche se le loro fioriture, talvolta veramente copiose, sono tra le più apprezzate. Creste di gallo (Rhinanthus alectorolophus), vedovine (Knautia spp.), campanule (Campanula rotundifolia) e la centaurea nerastra (Centaurea nigrescens), abbondano nei mesi estivi, mentre la tardiva comparsa del colchico (Colchicum autumnale) chiude il ciclo delle fioriture. Se lo sfalcio cessa ed il pascolo diviene più intenso, specie alle quote più alte, con l’ingresso della poa alpina (Poa alpina) tendono a prevalere le graminacee di taglia minore, più resistenti al calpestio, sovente accompagnate da specie indicatrici di una certa acidità, come la tormentilla (Potentilla erecta). GLI AMBIENTI UMIDI Nonostante che il settore prealpino sia il più piovoso della provincia, con precipitazioni mediamente comprese tra 1600 e 2000 mm annui, l’acqua pare scomparire misteriosamente. I laghi, tanto numerosi sulla vicina dorsale orobica, sono quasi assenti, salvo un esiguo numero di piccoli bacini soggetti a prosciugarsi nei mesi estivi, ed anche nei ruscelli e nei torrenti, quando non restano malinconicamente asciutti, per gran parte dell’anno scorre solo un’esile vena d’acqua; soltanto al fondo dei principali solchi vallivi l’acqua sgorga copiosa da numerose sorgenti, alimentando costantemente i torrenti maggiori. L’estrema povertà di acque superficiali è dovuta alla natura carbonatica degli strati rocciosi che costituiscono i rilievi: le abbondanti precipitazioni vengono infatti rapidamente assorbite nelle fratture di calcari e dolomie e, una volta convogliate in profondità, vanno ad alimentare una circolazione di tipo sotterraneo. La vegetazione igrofila risulta pertanto poco sviluppata e frammentaria, concentrandosi essenzialmente lungo il reticolo idrografico principale e nelle ridotte zone umide di versante. Sulle rive ghiaiose dei torrenti e nelle vallecole ombrose, oltre ai comuni salici arbustivi (Salix elaeagnos, S. purpurea) si ritrova frequentemente anche l’ontano bianco (Alnus incana), mentre a breve distanza, su suoli umidi ricchi di humus, formano estese colonie il farfaraccio bianco (Petasites albus) e quello maggiore (Petasites hybridus), due Composite che sviluppano foglie enor29 mi dopo la precoce fioritura. A bassa quota, lungo i ruscelli oppure nei prati sempre umidi, si rinvengono comunemente alcuni giunchi (Juncus articulatus, J. effusus, J. conglomeratus) la beccabunga (Veronica beccabunga), la veronica acquatica (Veronica anagallis-aquatica), il cardo di palude (Cirsium palustre) ed alcune carici (Carex hirta, C. pallescens), più raramente la calta (Caltha palustris), una ranuncolacea dagli appariscenti fiori gialli, lo zigolo nero (Cyperus fuscus) ed il cardo giallastro (Cirsium oleraceum). Sempre a quote poco elevate, sui pendii costantemente intrisi dalle acque di modeste sorgenti, il giunco nero (Schoenus nigricans) forma popolamenti di una qualche estensione, assai caratteristici e riconoscibili anche da lontano per lo spento colore grigiastro dei suoi cespi; fra questi si rinvengono con facilità la taiola comune (Tofieldia calyculata), la parnassia (Parnassia palustris), l’erioforo a foglie larghe (Eriopphorum latifolium), dalle infruttesecenze costituite da bianchi pennacchi penduli, la carice glauca (Carex flacca) ed una piccola pianta insettivora, l’erba unta bianca (Pinguicula alpina); sovente queste piante restano inglobate nelle incrostazioni di travertino, originato dal carbonato disciolto nell’acqua, ed assumono dimensioni ridotte, mentre tutt’intorno crescono rigogliose la gramigna altissima (Molinia arundinacea) e quella liscia (Molinia coerulea). Meritano uno sguardo anche le pozze realizzate artificialmente per l’abbeverata del bestiame, spesso di origine antica e ben inserite nell’ambiente; collocate solitamente sul fondo di depressioni naturali ed impermeabilizzate da un sottile deposito argilloso, raccolgono le acque meteoriche ed ospitano, nell’insieme, una flora abbastanza ricca, anche se in ogni singola pozza e possibile rinvenire solo poche specie; oltre ai più diffusi giunchi e carici, vi crescono talvolta la mazza sorda (Typha latifolia), la mestolaccia (Alisma plantago-aquatica), la gamberaia (Callitriche palustris), la giunchina comune (Eleocharis palustris), il millefoglio d’acqua (Myriophyllum spicatum), la coda di topo ginocchiata (Alopecurus geniculatus), la rara mestolaccia lanceolata (Alisma lanceolata) e la lingua d’acqua (Potamogeton natans), che può arrivare ad invaderle completamente. Ai Piani di Valtorta si trova l’unica torbiera di dimensioni ragguardevoli, di inestimabile valore per il numero delle specie presenti (Phragmites australis, Equisetum palustre, E. variega- tum, Carex flava, C. flacca, C. hostiana, C. davalliana, C. panicea, C. lepidocarpa, C. fusca, Cirsium palustre, Pinguicula alpina, Mentha aquatica, Tofieldia calyculata, Eriophorum latifolium, Parnassia palustris, Blysmus compressus, Epilobium angustifolium, ecc.), comprese alcune orchidee sempre più rare per la scomparsa dei loro habitat (Dactylorhiza traunsteineri, Epipactis palustris, Herminium monorchis); si tratta di un biotopo prezioso e meritevole di tutela, la cui esistenza purtoppo è già compromessa da drenaggi e ripiene. GLI ARBUSTETI Oltre una certa quota, la crescita del bosco è inibita dall’inasprirsi del clima; al prolungarsi della stagione fredda corrisponde un sensibile accorciamento del periodo vegetativo, tanto che gli alberi non riescono più a svilupparsi. In ambito prealpino, pur con alcune variazioni locali, il limite climatico della faggeta corre mediamente attorno ai 1700 m nelle esposizioni più favorevoli ed un poco più in basso sui versanti più freddi; approssimandosi a questa quota gli alberi divengono via via più compatti, assumono un 30 portamento cespuglioso ed infine si diradano lasciando spazio ad una vegetazione arbustiva più resistente e frugale. Gli arbusteti trovano dunque la loro naturale collocazione nella fluttuante fascia di transizione tra il bosco e le praterie d’altitudine, più volte soggetta a discese o risalite al variare delle condizioni climatiche, fortemente ridotta dall’uomo o totalmente rimossa ovunque fosse conveniente ricavare dei pascoli e pertanto non sempre definibile nei suoi limiti originari; ma il loro sviluppo è notevole anche a quote meno elevate, sui versanti rocciosi, i crinali ed i macereti inadatti ad ospitare il bosco, così come nei canaloni percorsi dalle slavine, dove formano vegetazioni stabili, condizionate dalla natura fisica del substrato piuttosto che dal clima, mentre quando invadono i pascoli più bassi, le radure boschive o i prati abbandonati, rappresentano solo uno stadio della ricostituzione spontanea del bosco. Sui versanti meglio esposti, a quote dove la vegetazione mantiene un carattere termofilo, è frequente il pero corvino (Amelanchier ovalis), un arbusto di media taglia resistente alla siccità, dalla copiosa fioritura bianca che precede l’emissione delle foglie, da giovani così fortemente tomentose da far assumere una tonalità grigiastra all’intera pianta; nel medesimo ambiente, crescono anche l’emero (Coronilla emerus) ed il citiso a foglie sessili (Cytisus sessilifolius), due Leguminose a fiori gialli, il compatto ramno spinello (Rhamnus saxatilis) ed il cotognastro (Cotoneaster nebrodensis), dai frutti rosso vivo riuniti in mazzetti. Un po’ più in alto, nelle schiarite della faggeta e più diffusamente al suo limite superiore, in condizioni di maggior freschezza, subentrano cespuglieti igrofili costituiti dal salice stipolato (Salix appendiculata), un arbusto che può misurare alcuni metri, e dal più piccolo salice glabro (Salix glabra), ravvivati in giugno dalle macchie gialle del maggiociondolo alpino (Laburnum alpinum), fra i quali crescono la rosa pendulina (Rosa pendulina), priva di spine e con fiori vinosi, la lonicera alpina (Lonicera alpigena), dai frutti attraenti ma velenosi, rossi e appaiati come piccole ciliegie, il sorbo alpino (Sorbus chamaemespylus) e, dove si è accumulato uno spesso strato di suolo acido di origine organica, compaiono anche il rododendro ferrugineo (Rhododendron ferrugineum) ed il mirtillo (Vaccinium myrtillus); sono questi gli arbusteti più frequentemente rimossi per ampliare i pascoli, insieme alla fascia superiore della faggeta, così che oggi, in molte località, il trapasso dal bosco alla prateria avviene spesso in modo brusco. Sui detriti di falda stabilizzati, sulle frane ed i macereti a grossi blocchi, ma anche sui crinali rocciosi ed al limitare dei pascoli sassosi, ovunque il substrato calcareo-dolomitico affiori o sia ricoperto da un esile strato di suolo, specie se l’esposizione settentrionale assicura un innevamento prolungato, crescono bassi arbusteti a rododendro irsuto (Rhododendron hirsutum), distinguibile dal ferrugineo per le foglie ciliate, i fiori più chiari e la taglia minore; oltre al rusticissimo salice glabro ed al sorbo alpino, l’accompagnano sempre il ginepro nano (Juniperus nana) e l’erica (Erica carnea), insieme a specie meno comuni ma particolarmente attraenti, come il piccolo rododendro cistino (Rhodothamnus chamaecistus), dalla precoce fioritura rosa tenue, la dafne alpina (Daphne alpina), che cresce direttamente sulla roccia, ed il rossello alpino (Artostaphylos alpinus) le cui basse spalliere si notano più facilmente in autunno, quando le sue foglie assumono una vistosa colorazione rosso vivo. Le instabili colate detritiche al piede delle pareti rocciose vengono colonizzate dal pino mugo (Pinus mugo), i cui densi popolamenti sono un ambiente straordinario per la ricchezza floristica che ancora conservano. Infine, salendo di quota, negli arbusteti delle stazioni lungamente innevate, diviene sempre più consistente la presenza di alcuni salici nani (Salix reticulata, S. serpyllifolia, S. retusa), autentiche piante in miniatura che crescono completamente appressate al suolo; rusticissime, 31 entrano in varia misura nella composizione degli arbusteti più ricchi, e, grazie alla capacità di completare in tempi brevissimi il loro ciclo vegetativo, riescono a colonizzare le vallette nivali, estremi testimoni della vegetazione legnosa. Le mughete Specie pioniera dalla vitalità incontenibile, il mugo (Pinus mugo) supera indenne ogni avversità: resiste ai freddi più intensi ed alla siccità, sopporta gli innevamenti prolungati e di adatta ai suoli più poveri, riuscendo a crescere anche nelle spaccature delle rocce e sulle rupi; ma è al piede delle alte pareti calcareo-dolomitiche che forma i suoi popolamenti più estesi e caratteristici, scure compagini che tenacemente risalgono le biancheggianti falde detritiche, imbrigliandole e, ove possibile, preparandole ad accogliere una più ricca vegetazione. Il mugo può assumere portamento arboreo, ma sui nostri monti prevale la più comune forma arbustiva, alta fino a quattro metri, con numerosi rami ascendenti ed elastici, che reggono senza sforzo il peso della neve e si flettono prontamente al passaggio delle slavine; un apparato radicale robusto ed esteso lo ancora all’instabile substrato su cui cresce, sterile e permeabile, ma arricchito di humus dalla lenta decomposizione dei suoi aghi. Sovente la mugheta si presenta in formazione chiusa, quasi una foresta in miniatura, per larghi tratti impenetrabile e ancora sorprendentemente integra, perché sviluppandosi su substrati particolarmente ostili e per loro natura inadatti ad essere convertiti in pascoli, non ha subito consistenti alterazioni da parte dell’uomo, eccettuato il prelievo di legname nei pressi delle malghe; vi si ritrova una ricca varietà di piante, buona parte delle quali si rinvengono anche nelle cenosi legnose ed erbacee con cui si trova a contatto, ma con qualche tratto originale. Sopra la massa compatta dei mughi svettano alcuni larici (Larix decidua) e qualche peccio (Picea excelsa), spesso contorti o schiantati dalle slavine, frammisti alle macchie del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), cariche di frutti arancio sul finire dell’estate; qua e là compare il maggiociondolo alpino (Laburnum alpinum) e, sui versanti esposti a Nord, si rinviene anche la rara betulla pubescente (Betula pubescens). Al di sotto dei rami, nello strato basso arbustivo, sono diffusissimi il rododendro irsuto (Rhododendron hirsutum) ed il sorbo alpino (Sorbus chamaemespylus), mentre i detriti sono quasi completamente ricoperti da folti tappeti di ginepro nano (Juniperus nana), erica (Erica carnea) e camedrio alpino (Dryas octopetala), fra i quali si insinuano il mirtillo rosso (Vaccinium vitisidaea), un piccolo rovo (Rubus saxatilis), il rossello alpino (Arctostaphylos alpinus) e, negli avvallamenti più umidi, gli immancabili salici nani (Salix reticulata, S. retusa). Nello strato erbaceo si rinvengono comunemente alcuni endemiti (Primula glaucescens, Saxifraga hostii rahetica, Pedicularis adscendens, Carex austroalpina), accanto a specie interessanti ma poco diffuse (Lycopodium annotinum, Pyrola minor, P. rotundifolia) ed alla scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus), splendida orchidea ancora presente nelle mughete più inaccessibili, ormai rara o estinta in molte regioni alpine. Non condizionata dal clima, in presenza di substrati idonei, la mugheta può spingersi a quote relativamente basse, negli orizzonti propri delle latifoglie, come avviene sul versante settentrionale del Monte Secco, o nelle valli di Tede e del Varro, dove scende sotto i 900 m, mischiandosi al faggio (Fagus sylvatica), alla betulla (Betula pendula), al sorbo montano (Sorbus aria), al salice stipolato (Salix appendiculata) e perfino con specie termofile come il carpino nero (Ostrya carpinifolia) ed il pero corvino (Amelanchier ovalis), mentre nel sottobosco si ritrovano l’endemico citiso insubrico (Cytisus emeriflorus), il mughetto (Convallaria majalis) e la rosa di 32 natale (Helleborus niger). Sui substrati acidi della dorsale orobica, il mugo vegeta sui pendii detritici e sui dossi montonati, arrivando talvolta ad invadere i pascoli abbandonati, formando consorzi generalmente meno estesi, dove il rododendro ferrugineo (Rhododendron ferrugineum) il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e quello falso (Vaccinium gaultherioides) sostituiscono le specie basifile, ed al contingente endemico subentrano specie meno appariscenti (Hieracium sylvaticum, Astrantia minor, Majanthemum bifolium), largamente diffuse anche nella pecceta. LE PRATERIE NATURALI Chi, nel risalire le nostre valli prealpine, alzi lo sguardo sui versanti più ripidi, osserverà come già a bassa quota la copertura boschiva sia assente per larghi tratti, sostituita da praterie che paiono povere e monotone, specie al confronto con i prati pingui che verdeggiano sui pendii più dolci. In realtà, pur senza possedere il lussureggiante rigoglio vegetativo dei prati concimati, ad un’osservazione più attenta queste praterie si rivelano cenosi erbacee assai diversificate, floristicamente ricche e notevolmente estese in altitudine, condizionate dalla natura del suolo e dall’umidità piuttosto che dalla temperatura. Alcune hanno origine naturale, ma per lo più sono formazioni secondarie che hanno assunto carattere stabile, insediatesi sui pendii disboscati in epoche remote, dove l’erosione ha asportato il suolo forestale e la ricostituzione del bosco risulta bloccata. Nonostante l’entità delle precipitazioni sia tale da favorire lo sviluppo della faggeta, una marcata aridità caratterizza i ripidi versanti soleggiati, coperti da sottili suoli detritici, fortemente basici e privi di humus, sui quali si sviluppano basse praterie dove è sempre presente la sesleria (Sesleria varia), una piccola graminacea pioniera che si diffonde tramite sottili stoloni superficiali e, precocissima, vegeta già sul finire dell’inverno, quando produce le sue brevi spighe cerulee. Nelle stazioni più asciutte e sulle creste dove affiora la roccia, la sesleria è affiancata da piccole carici (Carex mucronata, Carex humilis) e dalla festuca alpestre (Festuca alpestris), robuste piante cespitose che si adattano ai suoli più ingrati, ma l’aspetto più appariscente del seslerieto è dato da una serie di piante assai vistose, fra cui varie Orchidacee (Gymnadenia conopsea, G. odoratissima, Orchis mascula, O. pallens, Anacamptis pyramidalis), Liliacee (Anthericum ramosum, Allium cirrhosum, A. ericetorum), alcuni bassi arbusti (Erica carnea, Cytisus emeriflorus, Chamaecytisus purpureus, Daphne cneorum, Polygala chamaebuxus) ed un buon numero di specie rare o endemiche (Carex baldensis, Euphorbia variabilis, Scabiosa graminifolia, Primula glaucescens, Aquilegia einseleana, Viola dubyana); infine, notevole è lo sviluppo estivo di alcune Ombrellifere (Laserpitium siler, L. nitidum, L. krapfii subsp. gaudinii), che rinverdiscono i pendii quando la sesleria e le carici cessano di vegetare. Sui versanti freschi, negli impluvi e sui suoli a tessitura più fine e tendenzialmente neutri, solitamente nelle zone a morfologia più dolce, una maggiore ritenzione idrica consente l’affermarsi di praterie ad erba alta, dominate da due Graminacee superanti abbondantemente il metro, (Molinia coerulea, Molinia arundinacea), fra le quali crescono specie assai caratteristiche (Aster amellus, Peucedanum oreoselinum, Thalictrum minus, Anthericum ramosum), comprese alcune indicatrici di una certa acidità (Potentilla erecta, Succisa pratensis, Serratula tinctoria). Assecondando la natura dei suoli, seslerieti e molinieti, si compenetrano in varia misura, così che 33 piante con esigenze ecologiche contrastanti convivono a breve distanza, ma anche in questi casi le due cenosi non entrano in competizione, perché il molinieto vegeta con un certo ritardo rispetto al seslerieto, offrendogli riparo quando entra in quiescenza. Adibite in passato al pascolo di pecore e capre e talvolta falciate, queste praterie venivano frequentemente incendiate nel periodo invernale, per contrastare l’incespugliamento, eliminare il consistente strato di vegetazione secca e favorire, anche in assenza di concimazione, un’abbondante crescita primaverile di erba tenera. In corrispondenza della faggeta, od al suo limite superiore, sui versanti più freschi, l’endemica carice sudalpina (Carex australpina), forma praterie igrofile cui partecipano diffusamente Horminum pyrenaicum, Anthyllis vulneraria subsp. baldensis, Stachys alopecurus, Primula glaucescens e la rara Scabiosa dubia. Ancora più in alto, oltre il limite del bosco, ritroviamo nuovamente la sesleria, stavolta accompagnata dalla carice verdeggiante (Carex sempervirens), con la quale forma una caratteristica associazione, il seslerio-sempervireto, ampiamente diffusa e ricca di specie pregiate (Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum, Linum alpinum, Pedicularis adscendes, Horminum pyrenaicum, Centaurea rhaetica, Globularia nudicaulis, Viola dubyana, Nigritella rhellicani); ma le praterie dall’aspetto più rigoglioso e, forse, più belle si sviluppano su alcuni ampi crinali e al fondo di conche calcaree dove si è formato un suolo profondo ed abbastanza ricco, probabilmente originatosi sotto una precedente copertura arbustiva; la sesleria e la carice verdeggiante vi crescono insieme alla festuca incurvata (Festuca curvula), ma l’aspetto più inconfondibile di queste praterie è dato dalle ricchissime fioriture dell’anemone narcissino (Anemone narcissiflora). Ormai decisamente in ambito alpino, lateralmente ai macereti e verso le creste, su pendii generalmente ripidi, si entra nel firmeto, associazione discontinua che deve il suo nome alla carice rigida (Carex firma), specie microterma di piccola taglia, resistentissima al gelo, all’aridità ed al vento, formante densi cuscinetti emisferici di un bel colore verde intenso; la sua comparsa avviene dopo che il pendio è gia stato parzialmente colonizzato da specie pioniere quali il camedrio alpino (Dryas octopetala) e la sassifraga verdeazzurra (Saxifraga caesia), sue abituali compagne, ma il gelo, le slavine e le forti piogge periodicamente la scalzano, costringendola a riconquistare faticosamente le posizioni perdute. Nelle località più fredde ed esposte, questo processo si ripete indefinitamente, ma sui versanti meno acclivi il firmeto può evolvere fino alla maturità: il prolungato accumulo delle foglie morte della carice causa un’ingente produzione di humus e la progressiva acidificazione del suolo, cui segue l’ingresso di specie più esigenti e l’affermazione di nuove comunità vegetali. Le primule Messaggere della primavera, le primule annunciano con i loro fiori la fine dei rigori invernali. Certamente non sono le uniche piante a vantare questa prerogativa, ma per la delicata bellezza, l’aspetto inconfondibile e la facilità con cui si fanno notare, possono senz’altro essere annoverate tra i fiori più conosciuti e amati. Il nome “Primula” (dal latino primus: primo) venne adottato da Linneo nel 1735, con evidente allusione alla precocità di queste piante, ma la sua origine è molto antica, trovandosi citato già nel Regimen Sanitatis, opera della celebre scuola medica salernitana, risalente al 1101, anche se esiste il dubbio che possa riferirsi alla comune pratolina (Bellis perennis). Andrea Mattioli (1500-1577), medico e botanico tra i più illustri della sua epoca, utilizzò per diverse primule il 34 termine Sanicula (dal latino sanare: guarire) oggi spettante ad un genere delle Ombrellifere, ma ancora più curiose sono le denominazioni ideate da Konrad Gesner (1516 – 1565), Artritica lunaria, e da Mathias de l’Obel (1538 - 1616), Paralitica alpina, entrambe riferite a Primula veris, che rivelano un improbabile utilizzo curativo di questa pianta, ritenuta capace di guarire reumatismi, artriti e paralisi, in particolare quelle della lingua, oltre che la balbuzie. Ridimensionate nel tempo le proprietà terapeutiche, dagli inizi del XIX° secolo gli studiosi si sono concentrati maggiormente sulla sistematica del genere, scoprendo continuamente nuove specie, tanto che dalle circa 300 note all’inizio del ‘900 si è passati ad oltre 600, spesso determinate attribuendo grande importanza a caratteri poco evidenti, come l’esatta definizione del tipo di pelosità; non senza ragione, Sandro Pignatti afferma, nella sua Flora d’Italia, che “in piante meno appariscenti, questa variabilità non sarebbe stata osservata, ed il numero delle specie descritte sarebbe stato ben minore”. Il maggior numero di specie è presente in Asia, nella regione himalayana, ma sulle catene montuose dell’emisfero boerale si ritrovano un po’ ovunque, mentre sono molto rare in quello australe. Le specie europee sono una quarantina e 25 quelle che crescono sul territorio italiano, dove si ritrovano in ogni ambiente, dai boschi e dalle siepi della pianura fino alle praterie ed alle creste rocciose d’alta quota: Primula palinuri cresce sulle rupi costiere del Tirreno meridionale, mentre Primula hirsuta è stata rinvenuta a 3570 m sul Lyskamm, nel gruppo del Monte Rosa. Nella bergamasca si contano 12 specie, sia a fiori gialli (4) che rosei (8), delle quali ben 3 endemiche, Primula glaucescens, Primula daonensis e Primula albenensis; particolarmente preziosa è l’ultima, scoperta solo in tempi recenti ed esclusiva del nostro territorio. Tutte le nostre primule sono piante erbacee perenni, provviste di radici fascicolate o di un robusto rizoma, con le foglie riunite in una rosetta basale e fiori con cinque petali parzialmente saldati in un tubo, raggruppati in ombrelle all’apice di uno scapo più o meno elevato, ad eccezione di Primula vulgaris che ne è priva. Un’osservazione poco attenta potrebbe ingenerare l’errore che le primule siano piante dioiche, in quanto i fiori portati da individui diversi sembrano possedere esclusivamente gli organi maschili o quelli femminili, intravedibili alla fauce, ma in realtà questo dimorfismo ingannatore è dovuto al curioso fenomeno dell’eterostilia, utile per impedire l’autofecondazione. Circa la metà delle piante sviluppa fiori con uno stilo lungo quanto il tubo corollino e sovrastante gli stami, mentre le rimanenti possiedono fiori con uno stilo breve e stami inseriti in prossimità della fauce. La fecondazione “legittima” è possibile solo tra fiori di diversa conformazione, cioè tra organi maschili e femminili posti alla stessa altezza, che stabiliscono il medesimo contatto con il corpo degli insetti impollinatori; nei fiori brevistili, per semplice caduta del polline sullo stimma, l’autofecondazione potrebbe ancora verificarsi, ma a scongiurare questa eventualità interviene la dimensione dei granuli pollinici, più grandi e adatti solo allo stimma dei fiori longistili. L’eterostilia venne scoperta e studiata nelle Primulacee, ma si manifesta in forma ancora più elaborata nelle Oxalidacee e nelle Lythracee, che presentano stili ed antere inseriti su tre livelli. Occorre infine ricordare che varie specie di primula si incrociano naturalmente con una certa facilità, producendo ibridi sia fertili che sterili, osservabili di tanto in tanto fra le consistenti popolazioni dei genitori; questa tendenza non è sfuggita ai floricultori, che l’hanno saputa utilizzare per ottenere un gran numero di varietà ornamentali. Nella nostra regione, tutte le primule a fiore rosa e, unica fra quelle gialle, l’orecchia d’orso (Primula auricula) sono protette; rispettiamo tuttavia anche le altre specie, forse più comuni ma non per questo meno attraenti, degne di essere considerate fra i più begli ornamenti 35 primaverili che la natura ha generosamente concesso alla nostra terra. LE VEGETAZIONI PIONIERE DEI MACERETI E DELLE ROCCE All’escursionista poco avvezzo a salire in alta quota, le piccole piante che schiudono i loro fiori sulle inospitali pareti rocciose o sui ripidi ghiaioni sembrano delicate e fragili, effimere affermazioni di bellezza in un ambiente severo e ostile alla vita; stupito, ne ammira il coraggio, ma in cuor suo pensa che presto soccomberanno, sepolte dai detriti oppure inaridite dal sole o dal primo gelo. Ma queste piante, in realtà, nulla hanno da temere, poichè grazie ad una vitalità eccezionale ed a particolarissimi adattamenti, superano con successo i continui stress cui sono sottoposte; inoltre, perfettamente adattate ai loro difficili ambienti, vi trovano un sicuro rifugio dalla forte competitività che si sviluppa nei pascoli, dove sarebbero rapidamente sopraffatte. Sui ghiaioni, l’instabilità del substrato è l’ostacolo principale da affrontare quotidianamente; vi crescono specie pioniere che hanno sviluppato una grande capacità vegetativa, in grado di rigenerarsi continuamente per sostituire di volta in volta le parti sommerse o schiacciate dal lento ma costante scivolamento dei detriti verso valle. Le piante sopravvivono all’inesorabile colata di pietra con modalità diverse, alcune lasciandosi trasportare, altre tentando di arrestarla: diverse ricoprono il ghiaione con un fitto intreccio di rami radicanti, verdi zattere galleggianti su un mare ostile, altre imbrigliano il pendio allineando i loro robusti cespi a formare vere e proprie barriere; molte insinuano i loro esili stoloni negli interstizi fra i detriti, quasi a rincorrerne i movimenti, emergendo qua e là con i germogli, altre ancora protendono forti ricacci verticali tra la coltre detritica. Per il resto, i ghiaioni si rivelano meno ostili di quanto sembri a prima vista. Lo strato più superficiale, grossolano e permeabile, è arido e povero, ma protegge dalla disidratazione il terriccio che si deposità in profondità, sufficientemente umido e ricco di nutrienti, cui le piante attingono con apparati radicali molto estesi, tanto che solo raramente soffrono per mancanza d’acqua, anche perchè le chiare rocce calcareo-dolomitiche riflettono efficacemente il calore solare e non raggiungono mai temperature eccessivamente alte. Le parti aeree, comunque, presentano adattamenti per ridurre la traspirazione e superare le forti escursioni termiche che si verificano ad alta quota, mentre la protezione dal gelo invernale è assicurata dal manto nevoso, a lungo persistente sui versanti settentrionali. I fiori, di norma, sono vivacemente colorati e abbastanza grandi rispetto alle dimensioni complessive della pianta, perchè nel breve ma intenso periodo di fioritura devono richiamare infallibilmente gli insetti impollinatori. I macereti sono colonizzati da comunità vegetali discontinue ma ricche di specie, talvolta poco appariscenti (Trisetum distichophyllum, Rumex scutatus), spesso assai vistose (Thlaspi ro- tundifolium, Linaria alpina, Gypsophila repens, Papaver rhaeticum, Cerastium carinthiacum, Hedysarum hedysaoides, Dryas octopetala, Saxifraga aizoides, S. sedoides, Hutchinsia alpina, Campanula cochleariifolia, ecc.), accanto alle quali sono presenti alcuni preziosi endemiti, (Achillea clavenae, Aquilegia einseleana, Viola dubyana, Allium insubricum, Linaria tonzigii, Galium montis-arerae, Moehringia concarenae). Alcune amano crescere tra i detriti instabili, altre riescono a svilupparsi solo dove il ghiaione è parzialmente assestato; formano associazioni durature sui pendii ancora attivi, continuamente alimentati dalla caduta di nuovi detriti, ed anche alle quote superiori, dove il clima è un 36 fattore limitante, mentre sui macereti più stabili, dolcemente inclinati e con un apporto detritico minimo, preparano l’ingresso delle specie più esigenti che vivono nelle praterie e negli arbusteti. Sulle rocce, le condizioni di vita sono decisamente estreme. Sulle pareti verticali e lungo le creste il suolo è praticamente assente, e solo all’interno di cavità e fratture si accumula una minima quantità di detrito fine e di humus, mentre l’umidità abbonda sulle rupi stillicidiose ma difetta sulle pareti più assolate, spesso totalmente asciutte. I versanti settentrionali restano ombrosi e freddi anche in estate, mentre quelli esposti a mezzogiorno sono luminosi e caldi; l’escursione termica giornaliera può essere molto ampia, ma è parzialmente attenuata dal calore che la roccia restituisce nelle fredde ore notturne. Vento e pioggia sferzano implacabili le piccole piante, mentre nel periodo invernale la copertura nevosa è praticamente assente, lasciandole esposte al gelo più intenso, anche se nelle giornate di sole la roccia assorbe una minima quantità di calore, riscaldandosi più dell’aria. Alghe endolitiche e licheni riescono a vivere sulle nude rocce, spingendosi anche al di sotto della dura superficie, ma le piante superiori necessitano di nicchie e fessure, sia pur impercettibili, dove insinuare le radici alla ricerca di acqua ed elementi nutritivi. Bisognose di protezione, molte crescono completamente aderenti alla roccia o sviluppano cuscinetti compattissimi, specie alle quote superiori; per limitare la traspirazione, possiedono foglie rivestite da cuticole ispessite o da una densa pelosità, mentre resistono al gelo grazie a particolari adattamenti fisiologici. Le specie che vivono sulle rocce formano associazioni rade ma durature, cui partecipano piante tra le più appariscenti della flora alpina (Potentilla nitida, Potentilla caulescens, Primula auricula, Globularia cordiifolia, Androsace helvetica, Bupleurum petraeum, Valeriana saxatilis, ecc.), fra cui un ricco contingente di endemiti (Saxifraga vandellii, S. presolanensis, Campanula rainerii, C. elatinoides, Physoplexis comosa, Telekia speciosissima, Primula albenensis, Minuartia grignenis, Moehringia dielsiana, Asplenium presolanense). Sia le piante delle rocce che quelle dei macereti calcareo-dolomitici neutralizzano l’eccesso di calcio mediante particolari processi metabolici, oppure espellendolo per via fogliare, così da formare una caratteristica incrostazione. La loro distribuzione riserva qualche sorpresa, poichè non tutte sono specie d’altitudine, prevalendo in esse l’adattamento edafico rispetto a quello climatico: alcune non sopportano i freddi intensi e si ritrovano soprattutto alle medie altitudini, mentre altre scendono a quote relativamente basse, purchè in stazioni fresche e ombrose. Le specie endemiche Al di là della bellezza dei paesaggi e dell’integrità degli ambienti, la flora di alcuni territori è veramente particolare, distinguendosi nettamente da quella di altre regioni per la presenza di specie esclusive, non rinvenibili altrove, neppure in località prossime aventi caratteristiche ambientali del tutto comparabili. Queste specie, definite endemiche (o endemiti) perché diffuse solo in territori assai circoscritti, sono più numerose nelle regioni floristicamente isolate: catene montuose, deserti, coste rocciose e isole, ospitano molte piante di antica origine e facilitano la differenziazione di nuove specie locali. Nelle isole Canarie, oltre un terzo delle specie (514 su circa 1400) sono endemiche, ma la loro frequenza è ancora più accentuata in Madagascar (65%) ed in Nuova Zelanda (72%), toc37 cando il valore massimo (82%) nelle remote isole Hawaii, sperdute nell’oceano Pacifico. Anche se non altrettanto ricche, le isole e le accidentate catene montuose sudeuropee ospitano un consistente gruppo di endemiti, tanto che la sola flora italiana ne conta circa 500 (approssimativamente l’8%), buona parte dei quali distribuiti nelle regioni alpine. Le Prealpi Lombarde ne sono particolarmente ricche: poste al margine meridionale del sistema alpino, sono sfuggite agli effetti distruttivi delle glaciazioni, che tuttavia le hanno ripetutamente isolate per lunghi periodi, durante i quali hanno offerto rifugio a numerose specie, consentendo ad alcune di sfuggire dall’estinzione e ad altre di differenziarsi dalle popolazioni originarie. I botanici chiamano paleoendemiti le specie antiche, ultimi residui della flora terziaria preglaciale, dai caratteri morfologici stabili, e neoendemiti quelle di più recente formazione, solitamente più variabili, ma questo criterio comporta numerose eccezioni, tanto che frequentemente i pareri discordano nell’attribuire una specie ad un gruppo anziché all’altro. Se è facile immaginare che, al verificarsi di mutamenti climatici drastici, alcune specie riescano a sopravvivere nelle località che meno ne hanno risentito, più complesso è capire come possono nascerne di nuove. Ogni specie cresce spontaneamente in un territorio più o meno esteso, definito areale, entro il quale i fattori ambientali, primo fra tutti il clima, soddisfano le sue peculiari esigenze ecologiche; al suo interno, le singole piante presentano in maggioranza caratteri uniformi, ma ognuna possiede un patrimonio genetico proprio, cui corrispondono minime diversità morfologiche. Tutt’altro che immutabili, le specie si adeguano continuamente all’ambiente: la sua modificazione in una parte dell’areale favorisce alcuni individui rispetto ad altri, tanto che i loro caratteri finiscono col prevalere nella popolazione locale; se l’originaria unità dell’areale viene nel contempo a spezzarsi, è possibile che le singole popolazioni prendano strade evolutive diverse, in futuro destinate a divergere sempre più. Un esempio classico è dato da quattro primule, tra loro molto simili, differenziatesi da un’antica progenitrice ed ora rinvenibili in areali ben distinti, corrispondenti a territori rimasti liberi dalle glaciazioni: Primula clusiana nelle Alpi Austriache e Bavaresi, P. wulfeniana sulle Alpi Carniche, P. spectabilis sulle Prealpi Venete e Lombarde orientali, mentre nel settore centrale cresce la nostra P. glaucescens. Non solo l’espansione dei ghiacciai, ma anche le fasi calde interglaciali hanno condizionato in modo determinante la distribuzione e l’evoluzione delle varie specie, sottoposte continuamente ad una dura concorrenza ed alla necessità di nuovi adattamenti; non a caso gli endemiti risultano maggiormente diffusi in ambienti come le rupi, i ghiaioni e le praterie magre, che richiedono una notevole specializzazione, ma che in cambio sono ecologicamente stabili e proteggono dall’intrusione delle piante più invasive. Ma la barriera ecologica costituita da questi ambienti agisce anche in senso opposto, impedendo alle specie che li popolano di espandersi all’esterno, ed è questo il principale motivo per cui vari endemiti crescono esclusivamente entro areali ridottissimi, anche se non si può escludere che le specie di nuova formazione riescano, in futuro, ad occupare territori più estesi. In ambito provinciale, per le ragioni sopra esposte, sono i rilievi carbonatici prealpini ad accogliere il maggior numero di endemiti, ospitandone complessivamente una settantina, provenienti in minima parte dalle Alpi occidentali (Corydalis lutea, Phyteuma scorzonerifolium, Fritillaria tubaeformis), ed in numero maggiore da quelle orientali (circa 30, compresi Carex balden- sis, Minuartia austriaca, Rhodothamnus chamaecistus, Potentilla nitida, Aquilegia einseleana, Physoplexis comosa e Saxifraga petraea); meglio rappresentativi sono gli endemiti insubrici, ori- ginatisi fra il lago di Como ed il Garda, presenti con una ventina di specie, alcune delle quali sono 38 fra le più belle della nostra flora (Campanula raineri, Silene elisabethae, Primula glaucescens, Allium insubricum, Telekia speciosissima, Campanula elatinoides, Viola dubyana e Saxifraga vandellii). Ma ancora più preziose sono 8 specie esclusive del nostro territorio o di poco sconfinanti, autentici gioielli che ne sanciscono l’originalità floristica, di seguito elencati in ordine di scoperta: Saxifraga presolanensis (raccolta nel 1894, ma descritta solo nel 1916), Minuartia grignensis (1922), Moehringia dielsiana (1925), Linaria tonzigii (1949), Galium montis-arerae (1957), Moehringia concarenae (1992), Primula albenensis (1993) e infine Asplenium presolanense (1998). Ogni anno numerosi botanici europei salgono i nostri monti per osservare queste specie, restando affascinati dall’enorme ricchezza di una flora che ha riservato nuove scoperte anche in tempi recentissimi; complesse vicende plurimillenarie ce l’hanno consegnata unica ed irripetibile, e forse, in un’epoca in cui l’uomo modifica pesantemente l’ambiente, dovremmo sentire maggiormente la responsabilità di questo patrimonio, per lasciarlo intatto alle generazioni future. Le specie vicarianti Certamente le piante non provano sentimenti, ma alcune specie sembrano manifestare fra loro una repulsione invincibile, tanto che, pur sviluppandosi ambienti simili, crescono sempre a debita distanza, quasi non si possano sopportare; questo fatto risulta ancora più sorprendente quando si considera che le specie in questione sono molto vicine sistematicamente ed assai somiglianti, al punto da essere facilmente confuse dai meno esperti. Immaginiamo di trovarci lungo il “Sentiero dei Fiori”, nello splendido tratto compreso tra la Val d’Arera e la Bocchetta di Corna Piana, in compagnia di un amico alle prime armi nel riconoscimento della flora alpina, armato di tanta buona volontà e di un manualetto fotografico che, purtroppo, illustri solo poche specie; giugno è alla fine e le fioriture sono già numerose. Ci siamo appena incamminati ed ecco, nel pascolo, dei bellissimi fiori blu: sono le inconfondibili genziane, ma quali? Basta una rapida occhiata al manualetto ed il nostro amico non ha alcun dubbio: “Gentiana kochiana!” sentenzia visibilmente soddisfatto; procediamo un poco e la nostra attenzione è richiamata da un bel cespo di primule, si sono proprio primule, dai fiori rosa, che spuntano lì nel macereto, appena sopra il sentiero “Qui, guarda! …Primula hirsuta….no, il colore è uguale ma le foglie non sono così …eccola …è proprio lei stavolta …Primula clusiana”. E queste strane rosette con le foglie nastriformi e tutte incrostate che crescono sulle rocce? Il nostro amico ormai si sente sicuro: “Vediamo ...... mi sembra che possa essere questa ...... Saxigrafa …… anzi …… Saxifraga paniculata. E questa piantina con i fiori bianchi è senzaltro Ranunculus glacialis. E’ più facile di quel che pensavo, imparo in fretta, non trovi?” A questo punto dovremo disilluderlo e spiegargli che …… All’interno del medesimo genere, esistono specie vicarianti che non si sovrappongono mai nella loro distribuzione, sia per motivi geografici che ecologici, nonostante crescano in ambienti apparentemente identici. Quando la vicarianza è di natura geografica, gli areali sono nettamente separati e, non di rado, talmente distanti da rendere impossibile una sovrapposizione; in questo caso l’ambiente di crescita può effettivamente corrispondere, e una specie vi sostituisce l’altra, svolgendovi un ruolo del tutto simile; P. clusiana è endemica delle Alpi Austriache e Bavaresi, ma possiede molti caratteri in comune con P. glaucescens, la pianta effettivamente osservata dal nostro amico. Diversa e più complessa è la vicarianza di tipo ecologico, solitamente dipendente da fattori edafici. Le praterie dei suoli calcareo-dolomitici differiscono sostanzialmente, nella loro composi39 zione floristica, dalle praterie dei suoli acidi, così come le associazioni delle rocce carbonatiche da quelle che colonizzano le rocce silicee: varie specie sono indifferenti alla natura chimica del substrato, ma altre manifestano al riguardo esigenze più precise. Molto semplicemente, ad un elevato tenore di calcio nel suolo corrisponde una maggiore concentrazione degli elementi minerali disciolti nella soluzione circolante, cioè nella fase acquosa da cui le piante traggono le sostanze nutritive; le specie calcicole tollerano soluzioni molto concentrate, potenzialmente dannose (l’eccesso di salinità può causare la morte della pianta), poichè sono in grado di rallentarne l’assorbimento e neutralizzarne gli eccessi, al contrario delle vulnerabili specie calcifughe, che non avendone le capacità necessitano di soluzioni più diluite. Se si considera la reazione chimica della soluzione circolante, comunemente espressa col simbolo pH, i suoli ricchi di calcio risultano costantemente basici (pH superiore a 7,4), mentre dove questo elemento è assente i suoli sono acidi (pH inferiore a 6,5); da qui l’uso comune di distinguere le piante basifile (calcicole) da quelle acidofile (calcifughe), i cui ambienti di crescia sono incompatibili. Naturalmente esistono anche piante neutrofile, che prediligono pH con valori intermedi, e piante indifferenti che tollerano ampie escursioni. Lungo il “Sentiero dei Fiori”, che si svolge in ambiente calcareo, è possibile osservare una grande varietà di specie basifile, ma il nostro amico ha erroneamente confuso Gentiana clusii con G. kochiana, Saxifraga hostii subsp. rhaetica con S. paniculata e Ranunculus alpestris con Ranunculus glacialis, piante acidofile presenti un po’ più a Nord, rispettivamente nei pascoli, sulle rocce e nei macereti silicei della dorsale orobica. Sono assai numerose le specie vicarianti che possiamo incontrare; saperle riconoscere facilita la comprensione delle particolarità floristiche del nostro territorio, in buona misura condizionate dalla natura dei suoli, soprattutto dove la composizione della roccia madre li influenza maggiormente. Talvolta la loro distribuzione può apparire capricciosa, in quanto suoli acidi si possono formare anche su substrati carbonatici, per l’accumulo di sostanza organica o per dilavamento, mentre rocce con minimo contenuto di calcio permettono la crescita di specie moderatamente basifile anche sui rilievi silicei, ma pure in questi casi le specie vicarianti rimangono fedeli indicatori della natura chimica del substrato. LE PECCETE Uno degli aspetti vegetazionali più facilmente osservabili sui nostri monti consiste nella transizione dai boschi di latifoglie a quelli di conifere, in origine coincidente col limite tra la fascia bioclimatica atlantica e quella boreale, passaggio che nella percezione comune segna in modo evidente il progressivo irrigidimento del clima che si verifica con l’innalzamento della quota. A seguito dell’intervento antropico, tuttavia, questa transizione ha perso gran parte del suo significato, poichè grazie a ripetuti rimboschimenti e ad una gestione forestale che le ha sempre favorite, le conifere scendono frequentemente negli orizzonti delle latifoglie, riuscendo a sostituirle completamente in numerose località. Una distribuzione altitudinale così ampia è resa possibile dalla grande adattabilità dell’abete rosso, o peccio, (Picea excelsa), pianta tipica delle grandi foreste boreali eurasiatiche, ma comune anche sulle Alpi; resistente alle basse temperature invernali ed ai geli primaverili, in grado di sopportare forti escursioni termiche e periodi di siccità, capace di svilupparsi anche sui suoli rocciosi e poveri; favorito da una notevole rapidità di crescita, soprattutto alle quote infe40 riori il peccio si avvantaggia sulle specie concorrenti, entrando in varia misura nelle faggete, specie in prossimità del loro limite superiore, ma normalmente costituisce boschi più o meno puri (peccete), floristicamente abbastanza differenziati nonostante l’apparente uniformità. In ambito montano, nell’orizzonte di pertinenza del faggio, all’incirca tra i 1000 ed i 1500 m di quota, il peccio è subentrato alla latifoglia, conquistando vasti spazi anche sui rilievi calcareo-dolomitici, dove originariamente la sua diffusione era solo sporadica. Le peccete di impianto artificiale, prive di qualsiasi legame con le condizioni ecologiche locali, si rivelano ambienti piuttosto poveri e dalla struttura estremamente semplificata: gli alberi, in maggioranza coetanei, crescono molto fitti, con lunghi tronchi diritti e spogli che solo all’estremita reggono un ciuffo di rami verdi, mentre al suolo, totalmente ombreggiato e coperto da uno spesso strato di aghi morti, il sottobosco è praticamente assente ed anche il novellame di abete rosso è molto scarso. Dove la sostituzione è avvenuta in modo più naturale e con gradualità, consentendo al faggio di mantenere una qualche presenza, la pecceta assume una struttura più articolata; la copertura arborea è meno chiusa e lascia filtrare una modesta quantità di luce, sufficiente perché un più ricco corteggio arbustivo ed erbaceo possa svilupparsi nel sottobosco, costituito per lo più da specie proprie della faggeta che evidenziano particolari condizioni di umidità e temperatura (Lonicera xylosteum, Corylus avellana, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Sanicula eu- ropea, Vinca minor, Cyclamen europaeum, Hepatica nobilis, Helleborus niger, Actaea spicata, Lathyrus vernus, Carex alba, Veronica urticifolia, Aposeris foetida, Hieracium sylvaticum, Saxifraga cuneifolia, ecc.) Assai caratteristiche sono le formazioni miste che il peccio costituisce con l’abete bianco (Abies alba), essenza che le esigenze ecologiche rendono in qualche misura assimilabile al faggio; queste cenosi si realizzano solitamente nelle convalli ombrose e umide, specie sui versanti settentrionali, dove sono più contenute le escursioni termiche, mal sopportate dall’abete; sporadico compare qualche sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), mentre nel sottobosco si rinvengono numerose specie amanti di un’elevata umidità, quali Homogyne alpina, Phegopteris polypodioides, Dryopteris dilata. Sui substrati silicei delle alte valli, in ambito subalpino, da 1600 a 1900 m, il peccio occupa diffusamente una fascia a lui climaticamente più congeniale, pur se la piovosità e la temperatura permangono troppo elevate per una piena affermazione della vegetazione boreale, cui si addice una maggiore continentalità; anche la ripidità eccessiva dei versanti e la presenza di vaste superfici detritiche, unitamente ai pascoli ottenuti per disboscamento, contribuiscono a creare ampie zone di discontinuità, che interrompono la regolarità della copertura boschiva. In questi consorzi il peccio vegeta più rado e con chiome maggiormente regolari, talvolta in formazioni pure, localmente mischiandosi all’abete bianco, ma più frequentemente accompagnandosi al larice (Larix decidua), specie alle quote superiori e nelle stazioni più asciutte; il grado di compenetrazione delle due conifere è particolarmente apprezzabile nell’autunno, quando, prima di cadere, gli aghi del larice assumono una luminosa tonalità giallo-oro che contrasta fortemente le scure sagome verdi del peccio. Il sorbo degli uccellatori è costantemente presente, ormai con portamento cespuglioso, mentre nel sottobosco, oltre ad alcune Graminacee (Calamagrostis villosa, Avenella flexuosa) si rinvengono la spigarola delle foreste (Melampyrum sylvaticum) e numerose Ericacee (Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitisidaea), accanto a vari arbusti (Sorbus chamaemespylus, Juniperus nana, Alnus viridis) che divengono sempre più frequenti approssimandosi al limite del bosco. 41 Le conifere Al massimo grado di evoluzione del mondo vegetale vi sono piante provviste di organi fiorali che si riproducono mediante semi; con un termine di origine greca, sono chiamate Fanerogame, cioè dalle “nozze evidenti”, in quanto sia il rilascio del polline che la formazione del frutto sono osservabili abbastanza facilmente. Vi appartengono le Angiosperme, che proteggono gli ovuli entro l’ovario, occupando un gradino più elevato delle Gimnosperme, piante più primitive, con gli ovuli nudi inseriti su foglie fruttifere che non si saldano a formare un ovario. Quest’ultima divisione comprende le Conifere (“portatrici di coni”); piante di origine antichissima, documentate da resti fossili risalenti al Carbonifero (da 350 a 280 milioni di anni fa), si stima che nel Giurassico (190-130 m. a.) ne esistessero 20.000 specie, ma da allora hanno conosciuto una continua decadenza, riducendosi alle circa 500 attuali. Molte si estinsero durante le glaciazioni, incapaci di adattarsi alle nuove condizioni climatiche, fatto che può sorprendere considerato che le nostre conifere crescono prevalentemente nella zona montuosa più fredda, ma in effetti, al pari delle latifoglie, anch’esse hanno ripopolato il nostro territorio dopo il termine dell’ultima glaciazione. Simili nel portamento, prive di fiori vistosi e con foglie poco o nulla differenziate: così le conifere appaiono al profano, che frequentemente le confonde, tanto che nel linguaggio comune vengono complessivamente denominate “pini”, errore rafforzato dall’uso abituale di chiamare “pinete” tutti i boschi di conifere, quali che siano le piante che vi crescono. Prevale, nei più, la percezione di alcuni caratteri ritenuti comuni, quali le foglie aghiformi e persistenti, i frutti consistenti in pigne (coni), la secrezione resinosa, le dimensioni ragguardevoli e la forma piramidale, ma questa omogeneità è solo apparente, poiché le 10 specie spontanee presenti sul nostro territorio appartengono a 6 generi che differiscono per caratteri importanti, grazie ai quali è possibile discriminarle con relativa facilità. Il larice (Larix decidua) è l’unica spogliante; presenta aghi brevi e riuniti in mazzetti e coni piccoli che, una volta aperti, persistono per vari anni sui rami. Pianta dalla chioma leggera, rusticissima, è diffusa soprattutto in ambito subalpino, ma sale anche a quote più elevate con esemplari isolati. Fra i pini, il cembro (Pinus cembra) si distingue per avere aghi raggruppati in fascetti di 5, lunghi e sottili; produce semi piuttosto grandi, molto appetiti da scoiattoli e nocciolaie che li ammassano in vari nascondigli per farne riserve invernali di cibo e, dimenticandone sempre alcuni, involontariamente li diffondono. Decisamente raro, conta solo poche stazioni in alta Val Brembana, dove cresce sporadico al limite del bosco e negli arbusteti. Il pino silvestre (Pinus sylvestris) possiede aghi appaiati, grossi e un po’ contorti, vagamente glauchi; la chioma è dapprima piramidale, ma col tempo diviene ampia e appiattita, mentre la corteccia è scagliosa e rossastra. Gli esemplari migliori ed i popolamenti più estesi crescono su alcuni antichi depositi morenici (pinete di Clusone e di Bossico), ma compare di tanto in tanto nei boschi misti della fascia montana e, a quota più modesta, sui più sterili versanti calcareodolomitici, dove si comporta da specie pioniera. Anche il mugo (Pinus mugo) presenta aghi appaiati, ma più brevi e di colore verde scuro; i coni sono ovoidali e piccoli, raggruppati a 2-5 e persistenti per anni. Si sviluppa in forma arbustiva, con numerosi rami ascendenti o prostrati, ma si incontrano anche esemplari con portamento arboreo; colonizza estesamente i macereti ed i pendii rocciosi, sovente formando popolamenti fittissimi. 42 L’abete rosso (Picea excelsa), così denominato per il colore della corteccia, è un grande albero dalla chioma piramidale, con aghi brevi e appuntiti, inseriti singolarmente tutt’intorno ai rami; i coni, sono pendenti e, dopo la dispersione dei semi, cadono interi al suolo. E’ la conifera più comune sul nostro territorio; forma boschi puri o in consociazione con altre specie, sia nella fascia montana, che in quella subalpina. L’abete bianco (Abies alba) si differenzia dal precedente per la corteccia grigio chiaro, gli aghi piatti e ottusi, scuri e lucidi di sopra e inferiormente argentei, disposti in due serie ai lati dei rametti; i coni sono eretti ed alla maturità si desquamano, lasciando sui rami solo l’asse centrale. Meno diffuso dell’abete rosso, più esigente riguardo ad umidità e temperatura, predilige le valli ombrose e fresche, nell’orizzonte del faggio. Il tasso (Taxus baccata) ha foglie aghiformi appiattite e tenere, più chiare di sotto, disposte in due serie come nell’abete bianco; dioico, gli individui femminili producono un frutto carnoso dal colore rosso vivo, l’arillo, che racchiude quasi completamente il seme; unica parte non velenosa dell’intera pianta, è assai gradito agli uccelli che, cibandosene, provvedono alla disseminazione. E’ un albero dall’accrescimento lento, sovente policormico, che raramente raggiunge dimensioni ragguardevoli; cresce nei boschi ombrosi, dalla bassa montagna fin verso i 1500 m. Il ginepro comune (Juniprus communis) è un arbusto medio-basso, spesso con portamento colonnare, dagli aghi brevi e pungenti, verticillati a 3; anch’esso dioico, non produce coni ma galbuli, frutti carnosi simili a bacche, assai aromatici, la cui maturazione avviene in 2-3 anni. Cresce nelle località asciutte e sassose, negli arbusteti e nei boschi radi, fino alla media montagna. Il ginepro nano (Juniperus nana) forma densi cespugli appressati al suolo ed ha foglie più brevi e molto ravvicinate; cresce comunemente a quote più elevate, salendo decisamente anche in ambito alpino. L’ultima specie, il ginepro sabino (Junipers sabina), si rinviene solo in alcune stazioni rupestri alla testata della Val Seriana; ha portamento prostrato e si distingue dai precedenti per avere piccole foglie squamiformi, opposte ed embricate su quattro file; presenta sia individui monoici che dioici e produce frutti velenosi. I LARICETI E I RODORETI Con i suoi rami leggeri e gli aghi sottili e teneri, il larice (Larix decidua) quasi non sembra in grado di resistere alle crudezze del clima alpino, eppure è la specie arborea che raggiunge le altitudini più elevate, come provano le piante contorte e nodose che crescono solitarie ben oltre il limite del bosco, più volte piegate e spezzate dall’infierire dei venti, dalla slavine e dal gelo, ma sempre incredibilmente vitali, così come gli esemplari nani che si incontrano lungo le creste, nelle spaccature delle rocce ed ovunque la natura dei luoghi offra loro un minimo riparo. Caso unico fra le nostre conifere, il larice si difende dai freddi intensi e prolungati con la perdita delle foglie, evitando così anche l’eccessivo appesantimento della neve; specie pioniera per nulla esigente, può sopportare grandi escursioni termiche e si adatta a qualsiasi suolo, colonizzando tanto i pascoli abbandonati quanto le pietraie e le frane. Se alle quote inferiori entra nella costituzione della pecceta, spesso preparandone la diffusione sui suoli più ingrati, salendo verso il limite della vegetazione arborea diviene la specie dominante, formando boschi aperti e luminosi caratterizzati dalla presenza di un ricco sottobosco, fino a quando, divenuti sempre più radi e ridotti gli alberi, rimane solo una compatta copertura arbustiva a rivestire i versanti; al confine tra le scure peccete ed i bassi arbusteti, il larice 43 trova dunque la sua naturale collocazione, preparando il graduale passaggio dalle une agli altri. Con l’ampliamento delle praterie d’altitudine a discapito della vegetazione originaria, l’uomo ha quasi totalmente rimosso questa fascia di transizione, ma ora che l’alpeggio estivo delle mandrie ha perduto d’importanza e le specie legnose riconquistano il terreno perduto, sia il bosco che gli arbusteti risalgono gradualmente di quota; dando prova di grande dinamismo, le formazioni pioniere che per prime invadono i pascoli arretrano dunque verso valle, progressivamente infiltrate dalla pecceta, mentre avanzano a monte, dove al raggiungimento del loro limite climatico formeranno coperture durevoli. Sui pendii rocciosi il larice cresce frequentemente col mugo (Pinus mugo), ravvivando la massa scura e compatta dei pini col verde tenero delle sue fronde, ancora più vivaci quando in autunno virano al giallo dorato; qualche betulla (Betula pendula, B. pubescens) ed il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) spuntano qua è là, insieme ad alcuni esemplari di peccio (Picea excelsa) dalla statura ridotta, mentre sotto i mughi compaiono frequentemente il ginepro nano (Juniperus nana), i mirtilli (Vaccinium myrtillus, V. gaultherioides, V. vitis-idaea), il brugo (Calluna vulgaris), dalla tardiva fioritura rosa, e l’astranzia minore (Astrantia minor), una piccola ombrellifera dai fiori bianchi; determinata dalla natura del substrato più che dai fattori climatici, questa cenosi si è conservata anche a quote relativamente basse, su pendii che non è stato conveniente trasformare in pascoli. Più in alto, dove il clima condiziona maggiormente la vegetazione, compagno abituale del larice è il rododendro ferrugineo (Rhododendron ferrugineum), in particolare sui versanti meno acclivi dai suoli più evoluti e ricchi di humus acido, meglio se esposti a settentrione, dove la persistente copertura nevosa lo protegge dall’intenso gelo invernale e dalla disidratazione. Arbusto sempreverde dalle foglie coriacee, verdi scure di sopra e caratteristicamente rugginose di sotto, il rododendro forma belle macchie basse e compatte, che nella breve estate alpina si ammantano di fiori rosa carico. Varie specie condividono lo stesso ambiente (Lonicera coerulea, Sorbus chamaemespylus, S. aucuparia, Potentilla erecta, Maianthemum bifolium, Lycopodium annotinum, Huperzia selago, Gentiana punctata, G. purpurea), ma la presenza pù consistente è quella dei mirtilli, tanto che prende il nome di Rodoro-vaccineto l’associazione che subentra al lariceto quando la conifera non ha più una presenza significativa; specie esclusive delle stazioni rivolte a Nord sono il raro licopodio alpino (Diphasium alpinum), piccola pianta a fatica osservabile sotto le fronde del rododendro, e la luzula di Sieber (Luzula sieberi), una giuncacea poco appariscente, mentre sui versanti meridionali, dove la neve si scioglie rapidamente, tende a prevalere il ginepro nano, più resistente del rododendro al gelo ed alla disidratazione grazie allo sviluppo appressato al suolo ed alle ridotte dimensioni delle sue foglie aghiformi. Gli arbusteti a rododendro ferrugineo, estesi su pendii idonei ad esere trasformati in pascolo, sono stati nel passato completamente distrutti; la loro ricostituzione risale a tempi recenti, ed in molte località è possibile osservarne di anno in anno la progressione sul terreno e l’arricchimento nella composizione floristica. LE ALNETE E I MEGAFORBIETI In corrispondenza della fascia di sviluppo del larice e degli arbusteti a rododendri e mirtilli, i più acclivi versanti esposti a nord sono rivestiti per larghi tratti da una boscaglia fitta e dall’aspetto sorprendentemente florido, l’alneta, che, precocissima, si riveste di tenere foglie 44 quando ancora le ultime nevi si stanno sciogliendo, portando il soffio della primavera là dove i rigori invernali sembrano indugiare più a lungo. La domina incontrastato l’ontano verde (Alnus viridis), un tenace arbusto alto 2-3 m, dal cui ceppo basale si dipartono numerosi rami ascendenti, talmente elastici da sopportare indenni il passaggio delle slavine e risollevarsi anche dopo essere rimasti sepolti nella neve per mesi. Pianta pioniera amante dei suoli silicei freschi, predilige gli impluvi dove un velo d’acqua scorre costantemente fra i detriti, stabilizzandoli con il fitto intreccio delle sue radici e conquistando gradualmente alla vegetazione anche i substrati più incoerenti, preservandoli dai continui smottamenti; lo si incontra più frequentemente fra i 1500 ed i 2000 m, ma la sua distribuzione altitudinale è assai ampia, poiché raggiunge quote più elevate grazie alla sua notevole resistenza al freddo, mentre scende decisamente più in basso lungo i greti dei torrenti ed i canaloni percorsi dalle valanghe. L’alneta costituisce un’associazione stabile, alla cui conservazione ha contribuito in modo rilevante la configurazione accidentata e spesso impervia delle località che occupa, del tutto inadatte ad essere trasformate in pascoli; ha carattere transitorio solo quando invade i pascoli abbandonati o si insinua nelle peccete diradate, creando le condizioni che favoriscono la ricostituzione del bosco. Fra gli ontani, oltre al sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) si rinviene anche qualche betulla (Betula pendula), mentre assai ricco e caratteristico è il sottobosco che si sviluppa sotto la densa copertura arbustiva, costituito da specie che necessitano di umidità abbondante (Peu- cedanum ostruthium, Adenostyles alliariae, Viola biflora, Saxifraga rotundifolia, Ranunculus platanifolius, Primula elatior, Polygonatum verticillatum, Thalictrum aquilegifolium, Lilium martagon, Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita alpina, Aconitum vulparia, Veratrum album), fra cui numerose felci (Athyrium distentifolium, Dryopteris dilatata, D. expansa, D. carthusiana, Phegopteris polypodioides) ed alcune piante frequenti anche nella pecceta (Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium). Non di rado, alla base dell’alneta o sui conoidi detritici fini sottostanti le pareti rocciose, dove le acque superficiali depositano in abbondanza il terriccio e le sostanze nutritive, le specie erbacee maggiori del sottobosco formano, da sole, una vegetazione dall’aspetto incredibilmente lussureggiante, il megaforbieto, caratterizzato da una stagionalità estremamente accentuata: durante l’estate, nel breve volgere di alcune settimane, i nudi detriti vengono completamente ricoperti dalle alte erbe, che rapidamente si sviluppano fino a raggiungere una taglia considerevole, fioriscono e si degradano al termine del loro ciclo; in questi contesti, dove è disponibile una maggior quantità di suolo e la pendenza è meno accentuata, compare frequentemente la salvastrella orobica (Sanguisorba dodecandra), una caratteristica rosacea dal delicato profumo, endemica delle Alpi Orobie. In condizioni di particolare frescura, le alte erbe scendono talvolta anche al bordo della pecceta, lungo i torrenti e nelle vallecole ombrose, peraltro conservando inalterata anche a quote più basse la rapidità del ciclo vegetativo. LE PRATERIE SEMINATURALI: I PASCOLI Alle soglie dell’alta montagna, ultimi spazi a misura d’uomo, i pascoli alpini sono frequentati da tempo immemorabile da mandrie e pastori; oggi il loro utilizzo si è ridotto, ma a testimoniare l’epoca in cui vennero più intensamente sfruttati rimangono un gran numero di baite, stalle 45 e recinti, sovente ridotti a ruderi ed ubicati anche nelle località più isolate. Già i cacciatori preistorici si spinsero oltre il limite del bosco, inseguendo cervi e camosci che, nella stagione estiva, risalivano i monti alla ricerca dei pascoli; divenuta la pastorizia un’importante fonte di sostentamento, fu dunque naturale condurre gli armenti sulle ricche praterie d’altitudine, all’epoca le più vaste disponibili ed in grado di nutrirli per alcuni mesi, lasciando alla nascente campicoltura i suoli più fertili ed accessibili delle basse quote; per il resto dell’anno, pecore e capre venivano portate nei boschi o negli incolti lungo i fiumi, dove più che l’erba brucavano foglie, giovani rami e frutti selvatici. Fin dall’inizio, l’allevamento transumante si configurò in stretti rapporti economici col fondovalle, consentendo l’inserimento delle terre alte nella dinamica produttiva; più tardi, in epoca medievale, fornì l’indispensabile materia prima all’industria laniera: nel periodo di maggior fioritura si stima in circa 100.000 capi il numero delle pecore allevate nella bergamasca, almeno la metà delle quali saliva stagionalmente ai pascoli alti. Aumentando il numero degli animali, si iniziò ad estendere il pascolo verso le quote inferiori, rimuovendo sia col fuoco che col taglio porzioni sempre più vaste di arbusteto e di bosco, ma fu a partire dal ‘500, con la crisi della produzione laniera, che l’allevamento transumante cambiò indirizzo, col prevalere del bestiame bovino e strutturandosi in organico collegamento con le cascine della pianura, dove venivano condotte a svernare le mandrie; risale a quest’epoca la nascita delle prime malghe dotate di strutture stabili, destinate al ricovero degli animali, dei loro custodi (bergamini) ed alla produzione casearia. Mentre le pecore venivano condotte sempre più lontano, sui monti della Valtellina e dei Grigioni, i pascoli furono ulteriormente estesi a discapito del bosco, spietrati, drenati e concimati; nel contempo iniziò la costruzione di baite, stalle, penzane e casere, poste a quote differenti in modo da assecondare la risalita delle mandrie col progredire della stagione: l’intera serie di baite basse (verso i 1400 – 1500 m), di mezzo ( a 1700 – 1800 m) e alte (a quote più elevate, anche oltre i 2100 m) esiste tuttora in varie località (Monte Zulino, Val di Gleno, Monte Agnone, Cardeto, Val Sedornia, ecc.). Alcune malghe erano proprietà di privati che le gestivano direttamente, ma in maggioranza appartenevano alle comunità valligiane e venivano concesse in affitto per periodi più o meno lunghi; l’affitto era regolato da capitolati minuziosi che fissavano norme per il buon uso dei fabbricati ed il miglioramento del pascolo, la cui resa veniva stimata in paghe, equivalenti alla superficie necessaria per alimentare un capo bovino adulto, oppure 5-6 pecore, per tutta la durata dell’alpeggio (da 80 a 90 giorni, all’incirca dalla metà di Giugno alle prime settimane di Settembre). Col tempo, lo sfruttamento degli pascoli si fece eccessivo, poiché gli affittuari li caricavano oltre le loro possibilità, cercando di trarne il massimo vantaggio immediato e, temendo il mancato rinnovo del contratto, ne trascuravano ogni cura; nei primi anni del ‘900, la capacità di carico degli alpeggi provinciali era stimata di poco superiore alle 15.300 paghe, ma per alimentare tutto il bestiame che vi saliva ne sarebbero occorse quasi 18.000; il sovraccarico determinò un notevole impoverimento dei pascoli e il progressivo accorciamento della durata dell’alpeggio, condizione protrattasi per alcuni decenni; oggi il loro sfruttamento si è fatto più razionale, ma la loro importanza economica è assai diminuita, tanto che i più disagevoli sono stati abbandonati, ed anche i migliori spesso non vengono caricati a sufficienza. Da lungo tempo, ormai, i pascoli sono delle cenosi seminaturali assai uniformi, la cui composizione floristica dipende essenzialmente dall’intensità dello sfruttamento cui sono sottoposti; anche nella fascia propria delle praterie, non è possibile ipotizzare quali associazioni erbacee ricoprissero originariamente i pianori o i versanti debolmente inclinati, in seguito destinati esclu46 sivamente al pascolo bovino, poichè la continua brucatura, il calpestio e le deiezioni degli animali hanno favorito ovunque poche specie più resistenti, cancellando ogni traccia della vegetazione precedente. Generale è la diffusione del cervino (Nardus stricta), una piccola graminacea facilmente riconoscibile per le spighe unilaterali, rifiutata dal bestiame per le sue foglie dure e pungenti, particolarmente resistente al calpestio ed in grado di crescere sia sui suoli compattati e asfittici che su quelli secchi o molto umidi; le sue foglie morte formano una spessa lettiera che si decompone molto lentamente e attraverso la quale solo poche piante riescono a crescere, tanto che può diventare la specie dominante nei pascoli eccessivamente caricati, formando basse praterie (nardeti) dallo spento colore grigiastro, a stento ravvivate dai piccoli fiori gialli della tormentilla (Potentilla erecta) e dal pallido azzurro di qualche campanula (Campanula barbata). Nei pascoli utilizzati più razionalmente, il nardo forma consorzi più ricchi e variati, mescolandosi senza prevalere con varie foraggere di pregio (Poa alpina, Phleum alpinum, Agrostis tenuis, Trifolium alpinum) ed accogliendo anche specie provenienti dalle vicine praterie naturali (Gentiana kochiana, G. punctata, G. purpurea, Crocus albiflorus, Campanula scheuchzeri, Crepis aurea, Leontodon helveticus, Arnica montana, Geum montanum, ecc.); le sue monotone estensioni si colorano allora di vivaci fioriture, assumendo forse l’aspetto più noto e familiare dei pascoli alpini. Nelle fasce spettanti al bosco ed agli arbusteti, con l’ingresso di rododendri e mirtilli, i pascoli abbandonati vengono rapidamente riconquistati dalla vegetazione spontanea, mentre alle quote superiori il cervino permane stabilmente, ostacolando il ricostituirsi delle cenosi originarie. Spesso, in prossimità delle stalle e nei recinti (barek), dove gli animali vengono più frequentemente radunati, il continuo accumulo di deiezioni arricchisce a dismisura il terreno di sostanze azotate, favorendo la crescita di una flora nitrofila assai caratteristica (Rumex alpinus, R. alpestris, Senecio cordatus, Aconitum napellus, Urtica dioica , Hypericum maculatum) rigogliosa e molto appariscente ma di nessun valore pabulare; autoconcimandosi con i propri resti, queste piante permangono lungamente anche nei pascoli abbandonati, testimoniandone l’antica frequentazione. LE PRATERIE NATURALI ACIDOFILE Per incontrare praterie autenticamente naturali, non condizionate dall’uomo ma in equilibrio col clima ed il suolo, occorre allontanarsi dai pascoli frequentati dalle mandrie e salire a quote più elevate, oppure inoltrarsi sui pendii più scoscesi. È proprio sui ripidi versanti esposti a mezzogiorno che si afferma il varieto, la cenosi erbacea più caratteristica ed estesa dell’intera catena orobica, costituita in assoluta prevalenza dalla Festuca scabriculmis subsp. luedii, una graminacea cespitosa dalle foglie sottili e morbidamente pendenti, un po’ glauche, nota ai pastori col nome di isega, appartenente al complesso gruppo della Festuca varia, dalla quale differisce per minimi particolari morfologici. Sui pendii acclivi il suolo è scarso e asciutto, sia per la veloce percolazione dell’acqua che per la forte insolazione, ed anche l’innevamento è assai breve; in queste condizioni, il varieto non forma una cotica compatta, ma assume un inconfondibile aspetto a ciglioni, ben noto agli escursionisti che, una volta abbandonato il sentiero, hanno provato a risalirlo di balza in balza, quasi come i gradini di una scala, accorgendosi troppo tardi che i grossi cuscini di festuca, oltre ad essere scivolosi e pungenti, spesso non offrono un appiglio sicuro; sono gli effetti combinati di gelo 47 e disgelo, talvolta accentuati dal sentieramento dovuto al pascolo, a conferire ai pendii la particolare disposizione a balze, riscontrabile ad alta quota anche in altre tipologie di prateria alpina. L’escursione altitudinale del varieto è molto ampia, poiché dai limiti della vegetazione forestale può spingersi oltre i 2700 m, fino alle creste più elevate; rappresenta un’associazione primaria in ambito alpino e, alle quote inferiori, sui pendii rupestri e sulle cenge dove forma coperture stabili di ridotta estensione, mentre è da considerarsi secondaria quando scende a sostituire gli arbusteti e i boschi di conifere rimossi dall’uomo. Non è possibile sapere se Festuca scabriculmis subsp. luedii abbia mai occupato le superfici subpianeggianti dove oggi si estendono i pascoli; attualmente non entra nella composizione dei nardeti, poiché non è in grado di resistere al calpestio del bestiame pesante, mentre forma estesi popolamenti sui versanti con pendenza elevata, accessibili solo a pecore e capre; più che il clima sono dunque le caratteristiche del substrato, in particolare l’acclività, a determinare le condizioni favorevoli all’affermazione del varieto. Nel passato, quando la pressione sui pascoli era insostenibile e si cercava in ogni modo di racimolare anche la minima quantità di foraggio, persino gli scoscesi pendii del varieto (segaboli) venivano occasionalmente falciati per ottenere il “fieno selvatico”. Non essendo un’associazione pioniera, il varieto si manifesta più compiutamente sui pendii ed i conoidi stabilizzati, raggiungendo una ricchezza floristica che contrasta con la sua apparente monotonia; alla festuca si accompagna frequentemente la carice verdeggiante (Carex sempervirens), mentre negli interstizi fra i cespi si sviluppano varie specie, talvolta assai appariscenti (Pulsatilla alpina subsp. apiifolia, Paradisea liliastrum, Pedicularis tuberosa, Centaurea nervosa, Hypochoeris uniflora, Laserpitium halleri, Bupleurum stellatum, Campanula barbata, Veronica fruticans, Geum montanum, Hieracium intybaceum, Silene rupestris, ecc.). Sui conoidi meno acclivi e dotati di maggiore umidità, al varieto subentra una vegetazione più esigente, costituita da specie ampiamente diffuse nei pascoli (Poa alpina, Phleum alpinum, Crepis aurea, Polygonum bistorta, Potentilla aurea, Ligusticum mutellina), mentre lungo le creste più esposte e sui pendii instabili la copertura della festuca diviene sempre più discontinua, lasciando infine spazio alle cenosi pioniere. Assai diversa è l’ecologia del curvuleto, associazione ampiamente diffusa sulle catene silicee alpine ma scarsamente rappresentato sulle nostre montagne, soprattutto per la mancanza di estese superfici subpianeggianti nella fascia altimetrica a lui più congeniale, al di sopra dei 2400 m; lo si ritrova a quote un poco inferiori in corrispondenza di dossi e lievi ondulazioni rivolte a Nord, su suoli superficiali molto acidi. L’associazione deve il suo nome alla carice ricurva (Carex curvula), una bassa ciperacea formante cespi compatti, circondati dalle guaine delle foglie morte; le sue esili foglie, costantemente parassitate da un fungo (Clathrospora elynae), si arricciano in punta e ingialliscono precocemente, già durante la fase di accrescimento, conferendo al curvuleto una spenta tonalità ocracea che pare anticipare l’autunno. Nelle stazioni a lungo innevate, il periodo utile per vegetare è estremamente breve; la propagazione avviene principalmente per via vegetativa, tramite l’emissione di nuovi ricacci, in quanto solo un minimo numero di piante riesce a fiorire ed a produrre semi; la copertura è solitamente abbastanza compatta, e, al di sotto dei cespi, le foglie morte costituiscono una spessa coltre che si decompone molto lentamente, ostacolando l’ingresso di altre specie. Ne deriva una notevole povertà floristica, tuttavia sufficiente a rimarcare alcuni aspetti particolari; oltre alle specie più comuni (Leontodon helveticus, Phyteuma hemisphericum, Hieracium glanduliferum, Senecio incanus subsp. carniolicus), la carice verdeggiante (Carex sempervirens) compare in prossimità dei pascoli, mentre la sesleria dei graniti (Oreochloa disticha) e 48 l’avena bronzea (Avenula versicolor) segnalano i dossi ventosi dove la neve permane più brevemente; i rosei cuscinetti della silene acaule (Silene acaulis) e la pediculare di Kerner (Pedicularis kerneri) crescono invece fra i detriti, quando la copertura della carice ricurva diviene più frammentaria. Le genziane Le piccole piante dai fiori blu intenso che punteggiano le praterie alpine sono le più note rappresentanti delle Genzianacee, famiglia cosmopolita comprendente 64 generi e circa 750 specie, diffuse per lo più nelle zone temperate e fredde dell’emisfero boreale, particolarmente nelle regioni montuose. Vi appartengono piante sia annuali che perenni, in massima parte erbacee, con foglie opposte e fiori emafroditi, solitamente a 5 petali, saldati a costituire un tubo e caratteristicamente contorti nei boccioli, così che ogni lobo è ricoperto dal precedente e si sovrappone a quello che segue; gli stami, in numero uguale ai lobi corollini, sono inseriti direttamente sul tubo, mentre lo stilo è unico ed il frutto consiste in una capsula. Il maggior numero di specie appartiene al genere Gentiana, che ne conta oltre 400, facilmente distinguibili per i fiori più o meno campanulati, relativamente grandi e dalla colorazione vivace; sia per la loro bellezza che per gli abituali ambienti di crescita sono tra le piante simbolo della flora alpina, apprezzate da escursionisti e studiosi, da lungo tempo conosciute soprattutto grazie alle loro proprietà terapeutiche. Plinio il Vecchio, uno dei più grandi eruditi dell’antichità, nel libro XXV° della Naturalis historia, racconta che fu il re illirico Genzio a scoprire le virtù curative di queste piante, in seguito chiamate genziane in suo onore; re sfortunato, inviso ai Romani per la sua alleanza con la Macedonia, venne sconfitto nel 168 a. C. ed esiliato a Gubbio, dove morì. Tutti gli antichi autori riconoscono alle genziane grande efficacia, sia preventiva che curativa, nei riguardi di molti disturbi, indicandone il più delle volte un uso appropriato, ma attribuendogli anche poteri del tutto fantasiosi: Avicenna le riteneva efficaci contro gli avvelenamenti più gravi, considerandole l’ultimo rimedio contro le punture degli scorpioni, mentre secondo altri possedevano virtù magiche in grado di guarire anche la peste; queste credenze, ancora in uso nel XVI° secolo, lasciano oggi sconcertati, ma, forse proprio per la grande considerazione di cui godevano, queste piante erano ritenute efficaci anche nelle situazioni più disperate. Piante preziose, dunque, tanto che la denominazione volgare Mettimborsa, oggi attribuita a Gentiana pneumonanthe, viene così interpretata dal Matthioli: “…avvenga che per le molte virtù sue sia degna come cosa pretiosa d’esser tenuta tra l’oro delle borse”. Oggi si riconoscono alle genziane proprietà febbrifughe, depurative, toniche, stomachiche, stimolanti, antifermentative e vermifughe, tanto che sono comunemente impiegate nella preparazione di medicinali e liquori; particolarmente apprezzata è l’azione sull’apparato digerente, per lo stimolo della secrezione gastrica. Queste proprietà sono dovute a numerosi principi amari (genziopicrina, genzioacaulina, genziamarina, genziina), percepibili fino all’incredibile diluizione di 1 a 12.000, usati anche per misurare l’amarezza di altre sostanze; sono presenti in tutte le specie, ma ne è particolarmente ricca la genziana maggiore (Gentiana lutea), una robusta pianta dai fiori gialli, alta fino ad 1,5 m, da sempre oggetto di raccolta da parte delle popolazione montane. Appartengono alla flora italiana 29 specie di genziane, diffuse sia sulle Alpi che lungo l’Appennino; Gentiana lutea cresce anche in Sardegna, nessuna in Sicilia. 49 Delle 15 specie rinvenibili sulle nostre montagne, solo una possiede fiori rosso-vinosi (Gentiana purpurea), due (la già citata Gentiana lutea e G. punctata) hanno fiori gialli punteggiati di bruno, e tutte le rimanenti blu; mentre il giallo è dovuto a pigmenti flavonici, sia il blu che il rosso sono determinati dagli antociani, il cui colore dipende dal pH del succo vacuolare che li contiene, virando al rosso quando è acido ed al blu se è neutro o basico. Ritroviamo le nostre genziane per lo più nelle praterie e negli arbusteti oltre il limite del bosco, ma entrano anche nelle zone detritiche d’alta quota e nei prati montani; alcune sono legate ai substrati calcareo-dolomitici (G. clusii, G. utricolosa, G. ciliata) altre a quelli silicei (G. kochiana, G. punctata, G. purpurea, G, brachyphylla). L’elegante Gentiana asclepiadea è la sola a crescere abitualmente anche nei boschi, mentre del tutto particolare è l’habitat di G. pneumonanthe, la più rara delle nostre genziane, che predilige i suoli acquitrinosi e acidi, scendendo anche al di sotto dei 300 m di quota. Tutte le genziane acauli hanno fiori blu: si tratta di 9 specie, non sempre riconoscibili facilmente, soprattutto quando, ad alta quota, assumono dimensioni estremamente ridotte; anche di giorno, se il tempo è freddo o nuvoloso, i loro fiori si richiudono, obbedendo ad uno stimolo regolato dall’abbassamento della temperatura. Diverse specie fioriscono assai precocemente, poco dopo la ripresa vegetativa, altre nei mesi estivi; solo la tardiva G. ciliata, l’unica con quattro petali, fiorisce prevalentemente in autunno. La raccolta delle genziane è vietata, trattandosi di piante protette; proprio la diminuita raccolta ha consentito alla genziana maggiore di diffondersi nuovamente sui nostri monti, dopo che per alcuni anni se n’era temuta la scomparsa. LAGHI E TORBIERE Fra i numerosi elementi che differenziano la dorsale orobica dall’antistante settore calcareo-dolomitico, l’abbondanza di acque superficiali è forse il più facilmente percepibile. Nonostante che l’entità delle precipitazioni sia lievemente inferiore, l’acqua non scompare velocemente in profondità ma scorre sulle impermeabili rocce silicee, si raccoglie in innumerevoli laghi di origine glaciale, imbeve i suoli acidi delle torbiere e confluisce copiosa negli spumeggianti torrenti che discendono dalle alte valli, costantemente presente anche nel reticolo idrografico minore; gli ambienti umidi sono pertanto ben rappresentati, pur se in alcuni casi la regimentazione delle acque ad uso idroelettrico e le opere di drenaggio effettuate per la miglioria dei pascoli ne hanno compromessa l’esistenza. Al margine delle sorgenti, fra i detriti sempre intrisi d’acqua, al piede delle rocce stillicidiose e nelle loro fessure, talvolta fra densi tappeti di muschi, sono assai comuni la graziosa sassifraga stellata (Saxifraga stellaris), dai delicati fiori bianchi, la gialla sassifraga autunnale (Saxifraga aizoides), le pinguicole (Pinguicula vulgaris, P. leptoceras, P. alpina) e due piccoli epilobi dai fiori rosei (Epilobium anagallidifolium, E. alsinifolium); alcune di queste specie crescono anche lungo i torrenti, sui tranquilli depositi ghiaiosi che le acque vorticose depositano negli slarghi dell’alveo, spesso insieme al billeri rotondifoglio (Cardamine asarifolia), una crucifera con fiori bianchi e foglie lucide e carnosette, diffusa quasi esclusivamente nel bacino brembano. Più ricca ed articolata è la vegetazione che si sviluppa lungo le rive dei laghi, caratterizzata da una marcata zonazione in relazione alla profondità dell’acqua, non sempre concentricamente ordinata per via dell’irregolarità dei fondali. 50 Caratterizzata da un notevole dinamismo, in tempi relativamente brevi questa vegetazione può occupare tutto lo specchio lacustre, specie se di dimensioni ridotte o poco profondo, determinandone la scomparsa per progressivo interramento; non pochi laghi minori sono così scomparsi negli ultimi decenni, trasformati in modesti pianori torbosi, ancora inondati di tanto in tanto, facilmente individuabili al fondo di conche o lievi depressioni e popolati da specie peculiari. Le piante autenticamente acquatiche sono veramente poche, mal adattandosi alle acque povere ed eccessivamente fredde dei laghi alpini, lungamente ricoperti dal ghiaccio: fra le più diffuse, la minuta gamberaia comune (Callitriche palustris) invade completamente alcuni minuscoli specchi d’acqua, insieme ai coltellacci (Sparganium minimum, S. angustifolium), dalle lunghe foglie nastriformi, mentre il ranuncolo a foglie capillari (Ranunculus tricophyllus subsp. eradicatus) è decisamente raro. In prossimità delle rive, su suoli ancora inondati, crescono la carice rostrata (Carex rostrata) ed i comunissimi eriofori (Eriophorum scheuchzeri ed E. vaginatum con una sola spiga, Eriophorum angustifolium con più spighe pendule), riconoscibili per i bianchi pennacchi cotonosi, talvolta formanti macchie assai estese, mentre nell’ampia fascia dove l’acqua imbeve il suolo senza più sommergerlo forma fitte colonie la carice fosca (Carex fusca), dalle spighe nerastre. Tutte queste piante profucono un’ingente quantità di sostanza organica, che alle temperature relativamente basse delle alte quote ed in ambiente acquitrinoso ed asfittico si decompone molto lentamente e solo in modo incompleto, accumulandosi anno dopo anno a costituire uno spesso strato di torba acida. È questo il regno degli sfagni (Sphagnum spp.), muschi provvisti di un esile fusticino e di rametti disposti in verticilli, simili a minuscole piantine, in grado di trattenere grandi quantità di acqua e di crescere indefinitamente sui propri resti, contribuendo all’ispessimento dello strato torboso; a Nord delle Alpi, favorita da una piovosità più elevata, la crescita defli sfagni è così intensa da portare alla formazione delle cosiddette “torbiere alte”, che si elevano sopra il livello dei terreni circostanti, ma nei nostri climi il loro sviluppo è più modesto, limitandosi a coprire estesamente le depressioni umide. Sulla soffice coltre di sfagno crescono la carice cenerina (Carex canescens) e la minuta carice stellare (Carex stellulata), così denominata per la particolarissima forma delle spighette mature, la pallida viola palustre (Viola palustris), la selaginella alpina (Selaginella selaginoides), una piccola licopodiacea, la rosea primula a foglie intere (Primula integrifolia), le drosere (Drosera rotundifolia e, rarissima, D. intermedia) e le pinguicole (P. vulgaris, P. leptoceras), piante “carnivore” che catturano minuscoli insetti; infine, a segnare la transizione verso le praterie umide, compaiono i densi cespi di tricoforo cespuglioso (Tricophorum caespitosum), dagli esili steli filiformi, i candidi fiori della parnassia (Parnassia palustris), il migliarino maggiore (Deschampsia caespitosa), una forte graminacea dalle foglie finemente striate e scabre, ed il cervino (Nardus stricta). Accanto alle specie più comuni, si rinvengono nelle torbiere anche piante molto rare, quali la cinquefoglia delle paludi (Potentilla palustris), il giuncastrello alpino (Triglochin palustris) ed il licopodio inondato (Lycopodiella inundata), ritrovato solo recentemente. Le piante insettivore Per crescere e riprodursi, ogni pianta deve assumere dall’ambiente esterno una serie di elementi nutritivi, alcuni in quantità elevata, altri in dosi minime, ma tutti ugualmente indispensabili, poiché ognuno svolge un ruolo particolare e insostituibile nella fisiologia delle piante, tan51 to che la loro vita non è possibile se uno solo viene a mancare. L’approvvigionamento di carbonio, idrogeno e ossigeno non costituisce mai un problema, in quanto l’anidride carbonica e l’acqua ne sono fonti inesauribili, ma il reperimento degli elementi minerali derivati dall’alterazione delle rocce, quali il fosforo, il potassio o il magnesio, dipende essenzialmente dalla dotazione del terreno. Del tutto particolare è il caso dell’azoto, che pur costituendo quasi l’80% dell’atmosfera non può essere assimilato tramite i normali scambi gassosi a livello fogliare. Le piante necessitano in grande quantità di questo elemento, indispensabile non solo per la formazione degli aminoacidi, singoli anelli di quelle lunghe catene che sono le proteine, ma anche della clorofilla, di vari enzimi ed altri composti organici di elevato valore biologico; normalmente viene assorbito dal terreno, come prodotto finale della decomposizione della sostanza organica ad opera di microrganismi e batteri, i quali, con una serie complessa di passaggi, scindono le proteine in singoli aminoacidi, liberano l’ammoniaca ed infine la trasformano nello ione nitrato, utilizzabile dalle piante. Pur se in misura esigua, le riserve azotate del terreno sono arricchite anche dall’attività di batteri che assimilano l’azoto atmosferico, rendendolo disponibile alla loro morte. Ma la fame di azoto è tale che alcune piante hanno “trovato” un modo più produttivo per sfruttarne l’ingente riserva contenuta nell’atmosfera, stabilendo una complessa simbiosi con alcuni batteri. Le Leguminose li ospitano frequentemente nelle loro radici, dove si riproducono in gran numero, determinando l’insorgere di caratteristici rigonfiamenti, detti tubercoli; questi iniziano a svilupparsi dopo la comparsa delle prime foglie, aumentano di numero e volume fino alla fioritura per essere infine riassorbiti dalla pianta. L’enzima che permette di fissare l’azoto, la nitrogenasi, si lega preferibilmente all’ossigeno, ma all’interno dei tubercoli, in ambiente praticamente anaerobico, può legarsi solamente alle molecole di azoto, fissandolo sotto forma di ammoniaca; questo meccanismo è reso ancora più efficace dalla presenza della leg-emoglobina, l’emoglobina dei legumi, un pigmento rosso che cattura eventuali molecole di ossigeno, così che la nitrogenasi non venga distratta dal suo prezioso compito. La perfetta simbiosi tra piante e batteri si sviluppa solo se il terreno è povero di azoto, con reciproco vantaggio per entrambi i contraenti; sono oltre 10.000 le specie vegetali che sviluppano simbiosi con organismi azotofissatori, in massima parte con batteri, ma anche con alghe azzurre. In ambienti molto acidi ed asfittici, quali le torbiere, dove l’attività degli organismi decompositori è fortemente inibita, procurarsi una sufficiente quantità di azoto resta comunque un difficile problema per le piante che vi crescono, specialmente se non sono capaci di costituire una simbiosi con gli organismi azotofissatori; per questo motivo alcune specie hanno sviluppato una singolare attitudine a compiere in proprio l’intero processo di demolizione della sostanza organica, il cui primo passo consiste ……… nel procurare la materia prima. Questa è costituita da piccoli insetti, catturati con sistemi semplici ma estremamente efficaci. Le drosere (Drosera rotundifolia, D. intermedia), possiedono foglioline riunite in rosetta e ricoperte da numerosi peli ghiandolari rossastri, i quali secernono all’apice un liquido appiccicoso e lucente, che attira piccoli insetti grazie al suo contenuto zuccherino; non appena un malcapitato vi resta invischiato, su di lui convergono anche i peli più lontani, stringendolo in una morsa senza scampo. A questo punto, il liquido appiccicoso si acidifica per la comparsa di un enzima in grado di digerire le parti molli dell’insetto, così che la foglia possa assorbirle; a digestione ultimata, i peli riacquistano la loro posizione normale, mentre i resti indigeriti vengono dispersi dalla pioggia o dal vento. 52 L’origine del nome Drosera si deve alle gocce che imperlano le foglioline e non si asciugano nemmeno nelle giornate più calde, tanto che le piccole piante sembrano sempre ricoperte di rugiada, droseros in greco; identico significato ha pure il meno usato nome volgare, rosolida, dal latino ros solis, “rugiada del sole”. Le pinguicole (Pinguicula alpina, P. vulgaris, P. leptoceras), piccole piante con fiori simili alle viole, hanno una rosetta di foglie ovali-lanceolate, di un bel verde tenero, superiormente ricoperte da ghiandole viscose, micidiali quanto la carta moschicida; quando un insetto vi rimane invischiato, stimolata dai suoi frenetici tentativi di fuga, la foglia si avvolge lentamente su se stessa, dai margini verso il centro, imprigionandolo completamente e digerendolo in 1-3 giorni, passati i quali torna a distendersi. Il genere deve il proprio nome dal latino pinguis, “grasso”, riferito alla consistenza un po’ carnosa delle foglie, mentre il nome volgare erba unta deriva dalla caratteristica vischiosità che le ricopre. Drosere e pinguicole sono diffuse nella zona montana, le prime solo nelle torbiere acide, le seconde anche sulle rocce stillicidiose, sui detriti e nei pascoli umidi; nell’800 Drosera rotundifolia era segnalata anche in pianura, insieme ad un’altra pianta carnivora, l’utricularia (Utricularia vulgaris), oggi scomparsa dal nostro territorio; pianta acquatica con bei fiori gialli, è priva di radici ed ha fusti fluttuanti e foglie finemente laciniate, munite di minuscole vescichette con un’apertura circondata da setole; le vescichette di norma sono sgonfie, ma quando un microrganismo acquatico ne urta le setole, si rigonfiano improvvisamente, risucchiandolo istantaneamente all’interno. La pianta non produce succhi digestivi, ma attende con pazienza che la sua vittima muoia e si decomponga per poterla assimilare; l’acqua viene quindi espulsa dalla vescichetta, che si predispone ad una nuova cattura. Le piante insettivore possono apparirci crudeli, ed incontrandole nelle nostre escursioni forse le osserveremo con una leggera inquetudine, ma non colpevolizziamole, poiché non hanno alcuna intenzionalità nei loro “comportamenti”, i quali non sono altro che un mirabile adattamento alla povertà del loro ambiente. LE VALLETTE NIVALI La neve, che per lunghi mesi imbianca le nostre montagne più elevate, costituisce per molte piante alpine un importante fattore di sopravvivenza. Anche nelle giornate più rigide, sotto la coltre nevosa si registrano temperature più sopportabili, tanto che solo raramente il suolo gela; oltre che dal freddo, foglie, gemme e germogli sono efficacemente protetti anche dalla disidratazione e, poiché almeno una minima quantità di luce filtra fino a loro, possono in qualche misura continuare la fotosintesi. In queste condizioni molte piante riducono al minimo la loro attività vegetativa senza mai interromperla completamente, preparandosi per una prorompente ripresa allo scioglimento della neve; tuttavia, nonostante i suoi benefici effetti, se persiste troppo a lungo, la copertura nevosa diviene un fattore limitante della vegetazione, in quanto il tempo a disposizione delle piante per svilupparsi, fiorire, maturare i frutti e disperdere i semi si riduce talmente che solo poche specie vi si adattano. Alle alte quote, negli avvallamenti e nelle conche dei pianori ondulati, specialmente sui versanti rivolti a settentrione, l’innevamento si protrae per almeno 8 mesi, ed in seguito il suolo rimane a lungo impregnato dalle fredde acque di fusione, che neppure le giornate di più intensa 53 insolazione riescono a riscaldare ed evaporare completamente; vi crescono piante che si sono adattate a temperature medie decisamente basse ed escursioni termiche limitate, poiché dopo aver lungamente usufruito della protezione del manto nevoso, trascorrendo comunque molti mesi con temperature di poco superiori allo zero, ricevono nei mesi estivi solo una modesta quantità di calore, dato che la maggior parte dell’irraggiamento solare serve per evaporare l’eccesso d’acqua nel suolo. Le piante delle vallette nivali costituiscono una vegetazione povera ma assai caratteristica, denominata tundra alpina per una certa affinità con quella delle estreme regioni settentrionali, cui l’accomunano l’estrema brevità della stagione vegetativa e la presenza di alcune specie a distribuzione artico-alpina. La pianta più caratteristica è il salice erbaceo (Salix herbacea), che, in cerca di protezione, sviluppa fusti sotterranei radicanti e spinge alla superficie del suolo solamente l’apice dei suoi brevi rami, recanti ognuno una coppia di tenere foglioline ovali e, di tanto in tanto, brevissime infiorescenze, che si aprono contemporaneamente all’emissione delle foglie o subito dopo; i semi, leggeri e provvisti del classico “piumino” vengono dispersi dal vento, ma questa specie si diffonde prevalentemente per via vegetativa, emettendo polloni che nella stagione estiva si allungano di pochi centimetri e, dopo una decina d’anni, alla morte del fusto principale divengono individui autonomi. Il salice erbaceo forma tappeti compatti ed estesi, contribuisce ad arricchire il suolo con i propri residui e crea condizioni ideali per l’insediamento di altre piante, quali la canapicchia alpina (Gnaphalium supinum), una minuscola piantina con sottili foglie tomentose ed infiorescenze che paiono la capocchia di uno spillo, la sibbaldia (Sibbaldia procumbens) e la ventaglina a cinque foglie (Alchemilla pentaphyllea), piccole Rosacee dal portamento strisciante, assai simili, provviste di insignificanti fiori verdastri; da sole, queste poche specie costituiscono la massa maggiore della vegetazione che ricopre il fondo delle conche nivali. Meno numerosa, ma senzaltro più appariscente è la bella margherita alpina (Leucanthemopsis alpina), che predilige le stazioni con detrito un po’ grossolano e copertura più discontinua, dove cresce con l’arenaria biflora (Arenaria biflora), la peverina a tre stimmi (Cerastium cerastioides), l’azzurra veronica alpina (Veronica alpina), la sassifraga androsacea (Saxifraga androsacea) e la soldanella della silice (Soldanella pusilla) che, precocissima, ancora prima che la neve sia completamente sciolta, schiude i suoi fiori violacei simili a piccole campane; talvolta compare qualche roseo cuscino di silene (Silene acaulis), mentre ai margini delle conche, su suoli un poco più ricchi, si afferma la più esigente motellina alpina (Ligusticum mutellina), una bassa ombrellifera che entra sovente nei pascoli. Dove il ristagno d’acqua è maggiore, su suoli moderatamente torbosi, prevale la carice puzzolente (Carex foetida) dalla densa infiorescenza ovale, accompagnata dal migliarino maggiore (Deschampsia caespitosa), una graminacea di grande sviluppo ed assai adattabile che, in questi contesti, assume un portamento estremamente ridotto. Se l’innevamento si prolunga oltre i 9 mesi, determinando condizioni ambientali proibitive per piante superiori, divengono dominatori incontrastati alcuni muschi del genere Polytrichum, già ben rappresentati nelle vegetazioni nivali più evolute; insieme a qualche epatica ed ai resistenti licheni, rimangono gli ultimi baluardi del mondo vegetale, soli rappresentanti della vita in un ostile mondo di gelo. Le specie artico-alpine 54 All’inizio di Giugno, la primavera alpina muove i suoi primi incerti passi. Il manto nevoso, già disciolto sui versanti più ripidi ed esposti, si assottiglia di giorno in giorno anche sui pianori e nelle conche, riducendosi infine a chiazze isolate, mentre sul suolo intriso d’acqua, dopo molti mesi riappare timidamente la vegetazione; fra i residui ingialliti e marcescenti dell’anno precedente si schiudono copiose le prime fioriture ed in breve tutto rinverdisce. Dopo un interminabile inverno, la vitalità delle piante alpine esplode prorompente, specie se paragonata alla gradualità con cui la primavera si manifesta alle quote più basse; proprio ora, calpestando l’ultima neve ed osservando i primi fiori intirizziti dal freddo, può nascere l’intuizione di una somiglianza tra l’ambiente alpino e quello artico, ed in effetti, esattamente nella stessa epoca, anche nelle regioni prossime al circolo polare la natura sta per iniziare la sua breve ma intensa stagione. Territori distanti fra loro migliaia di chilometri sono accomunati da una serie di fattori ambientali, quali la rigidità delle temperature e la lunga permanenza della copertura nevosa, che riducono a soli 2 - 4 mesi la stagione vegetativa. Nelle regioni artiche si verificano le condizioni più severe: le temperature raggiungono minimi decisamente estremi, ed anche in estate il suolo sgela solo in superficie, non oltre i primi 2 m, al di sotto dei quali il ghiaccio si conserva perennemente ed ostacola il drenaggio delle acque di fusione, così che nelle bassure si formano vasti acquitrini; per la scarsa presenza batterica il suolo è molto povero di sostanze nutritive assimilabili e l’aridita fisiologica è molto marcata, poiché le precipitazioni si verificano quasi esclusivamente in forma nevosa. Inoltre la lunga notte polare incombe per sei mesi all’anno, escludendo per tutto questo periodo qualsiasi possibilità di vita vegetale. Al confronto, sulle Alpi le piante affrontano minori difficolà: l’inclinazione dei versanti e la minore latitudine consentono un irraggiamento solare più intenso, le temperature sono mediamente più elevate, tanto che, riparate dalla coltre nevosa o negli anfratti delle pareti rocciose ben esposte, varie piante mantengono una minima attività vitale anche nella stagione invernale. Condizioni ambientali simili hanno indotto nelle piante i medesimi adattamenti, sia morfologici che fisiologici, quali forme di crescita ridotte, sviluppo di cuscinetti compatti, foglie piccole e coriacee, densa pelosità, cuticole ispessite, rapidità nel completare il ciclo biologico annuale ed un particolare metabolismo che permette di concentrare i succhi cellulari per evitarne il congelamento; inoltre, salvo rare eccezioni, sono tutte specie perenni, la cui vita non si esaurisce nell’arco di alcuni mesi, in modo da poter superare anche una stagione vegetativa particolarmente avversa e rimandare alla successiva la formazione di semi o propaguli, quali i bulbilli brodotti da Polygonum viviparum. In funzione della quota o della latitudine, collocandosi comunque tra le ultime formazioni forestali e la zona delle nevi perenni, le vegetazioni alpina ed artica manifestano esplicitamente l’affinità ambientale dei rispettivi territori, anche con la presenza di un nutrito numero di specie comuni. Sono le cosiddette piante artico-alpine, diffuse principalmente nelle zone artiche dell’emisfero boreale ed in minor misura sui maggiori rilievi europei, specialmente sulle Alpi; in Italia sono presenti con 124 specie, delle quali 54 crescono anche sugli Appennini. Nella bergamasca è possibile incontrarne 83, particolarmente lungo la dorsale orobica, mentre la loro presenza è più scarsa sui rilievi prealpini, più aperti all’influsso mitigatore della pianura; crescono nei macereti e sulle rocce, nelle praterie d’altitudine e nelle torbiere, talvolta formando popolazioni assai ricche, soprattutto dove non temono la concorrenza di altre specie; fra le tante, Ranunculus glacialis, Salix herbacea, Oxyria digyna, Saxifraga cotyledon, Cerastium 55 cerastioides, Minuartia sedoides, Sibbaldia procumbens, Loiseleuria procumbens ed Eriophorum scheuchzeri sono esclusive dei substrati silicei e acidi del settore orobico, mentre Anemone narcissiflora, Dryas octopetala e Salix reticulata prediligono i substrati carbonatici prealpini. Ma in quale modo queste piante hanno potuto raggiungere le nostre montagne? Come sono riuscite ad attraversare territori del tutto inadatti alle loro necessità vitali? La loro migrazione è dovuta alle glaciazioni quaternarie, che trasformarono l’Europa centrale in una gelida tundra, stretta in una morsa di ghiaccio, tra la grande calotta in espansione dalle regioni artiche e le lingue glaciali che scendevano dalle Alpi; quasi sospinte dai ghiacciai, vennero a contatto e si mischiarono specie in origine assai lontane, che alla ritirata delle masse glaciali le seguirono indifferentemente sia verso Nord che verso Sud, fino a raggiungere sedi diverse da quelle originarie; in maggioranza sono discese dalle regioni artiche fino alle Alpi, ma non mancano specie che hanno compiuto il percorso inverso, come Cerastium alpinum, Saxifraga stellaris ed alcune campanule. In modo indiretto, le glaciazioni hanno dunque favorito uno scambio floristico che ha parzialmente compensato la flora alpina dell’estinzione delle antiche specie terziarie, che non seppero a sopportare il peggioramento climatico e nemmeno migrare. LE VEGETAZIONI PIONIERE DEI MACERETI E DELLE ROCCE Le piante degli estremi ambienti silicei vivono in condizioni sostanzialmente simili a quelle dei macereti e delle rocce di natura carbonatica; nel breve capitolo a loro dedicato sono già state descritte le peculiari caratteristiche di tali ambienti e gli adattamenti cui le piante ricorrono per potervi sopravvivere. Naturalmente, un’importante elemento di diversità è rappresentato dalla composizione chimica del substrato, privo di calcio e pertanto idoneo ad ospitare solamente specie calcifughe (ossifile), ma alcune specie calcicole (basifile) compaiono sulle rocce della Formazione di Collio, costituite in minima parte da carbonati (fino al 3%) e più facilmente disgregabili. Le Alpi Orobie, mediamente più elevate di circa 500 m rispetto ai rilievi prealpini, non raggiungono quote proibitive per le piante superiori, ed è sufficiente salire una qualsiasi cima per scoprire una sorprendente varietà di specie, concentrate per lo più sui versanti meglio esposti; anche il Pizzo di Coca, che con i suoi 3052 m rappresenta la massima elevazione della catena, si colloca ampiamente entro i limiti altitudinali raggiungibili da gran numero di specie alpine. Oltre che alle condizioni climatiche generali, la vegetazione si mostra sensibile al microclima particolare delle singole stazioni, sul quale influiscono la conformazione del rilievo, l’esposizione dei pendii e la colorazione prevalentemente scura delle rocce, che facilita l’accumulo diurno di calore. Caratteristica delle rupi silicee è la piccola androsace di Vandelli (Androsace vandelli), una primulacea relativamente rara e comunque poco osservata per via della sua fioritura precoce, che già dalla metà di maggio ricopre letteralmente di candidi fiori i suoi compatti cuscinetti dalle minuscole foglie argentee; a quote non troppo elevate l’accompagnano sovente il raponzolo di Scheuchzer (Phyteuyma scheuchzeri), dalle globose infiorescenze violacee, la silene rupestre (Silene rupestris), l’asplenio settentrionale (Asplenium septentrionale), una modestissima felce dalle fronde lineari, la bella primula irsuta (Primula hirsuta), più frequente sulle rupi, mentre più rara è la vistosa sassifraga dei graniti (Saxifraga cotyledon), che produce una gran quantità di fiori bianchi in grandi pannocchie pendule. 56 Tutte queste specie possono spingersi assai in alto, a contatto con piante schiettamente alpine che solo raramente discendono dalle quote superiori; fra queste si contano numerose sassifraghe (Saxifraga exarata, S. bryoides, S. paniculata), alcune minuartie (Minuartia sedoides, M. verna, M. recurva) ed un piccolo gioiello dai fiori azzurri, il non ti scordar di me nano (Eritrichium nanum), che spesso colonizzano anche gli sfasciumi sommitali, insieme alla rosea pedicolare di Kerner (Pedicularis kerneri) ed alla cardamine a foglie di reseda (Cardamine resedifolia), mentre il raponzolo rupestre (Phyteuma hedraianthifolium), la minuta Draba dubia non abbandonano mai le pareti rocciose. Dove prevale la Formazione di Collio la ricchezza floristica è veramente notevole, poiché insieme alle specie ossifile crescono anche il camedrio alpino (Dryas octopetala) la saussurea cordata (Saussurea discolor), la potentilla lucente (Potentilla nitida) e la Minuartia rupestris, mentre sui macereti poco stabilizzati sono localmente frequenti la colombina gialla (Corydalis lutea), il caglio alpino (Galium anisophyllon), l’erba storna (Thlaspi rotundifolium), il giallo papavero alpino (Papaver rhaeticum), la gipsofila strisciante (Gypsophila repens), un vistoso doronico (Doronicum grandiflorum) dai grandi fiori gialli e la Linaria alpina, simile ad una piccola bocca di leone dai fiori violacei e con la fauce aranciata, spesso con popolamenti ricchissimi e tutte moderatamente basifile. I macereti a grossi blocchi, costituiti da dure rocce silicee, poco erodibili e pertanto scarsamente dotati di terriccio, sono frequentemente ravvivati dalla Cryptogramma crispa, una piccola felce con fronde sottilmente divise e di un bel verde vivo, e dallo sparviere vischioso (Hieracium intybaceum), una composita dai pallidi capolini gialli, mentre piuttosto raro è il cavolaccio lanoso (Adenostyles leucophylla), un’altra composita, dalle foglie biancastre e con infiorescenze rosee. Ad alta quota, sul detrito fine, oppure sullo sfatticcio originatosi nelle conche o sui versanti a debole inclinazione non soggetti a movimenti di scivolamento, in condizioni di innevamento prolungato e con buona dotazione idrica, si incontrano frequentemente i rosei cuscinetti dell’androsace dei ghiacciai (Androsace alpina), l’appariscente sassifraga a foglie opposte (Saxifraga oppositifolia) e quella di Séguier (Saxifraga seguieri), assai meno vistosa, l’erba camozzera (Ranunculus glacialis), l’acetosa soldanella (Oxyria digyna), l’endemica viola di Comolli (Viola comollia) e la margherita alpina (Leucanthemopsis alpina), piante generose che schiudono i loro fiori al cospetto delle nostre cime più elevate. Le specie endemiche Le Alpi Orobie, in qualche misura interessate dalle glaciazioni quaternarie e soggette ad un clima più rigido per la loro collocazione più interna, non hanno mai rappresentato un’area di rifugio paragonbabile alle più meridionali Prealpi. Le specie endemiche non mancano, ma si tratta per lo più di piante ampiamente diffuse sull’intera catena alpina (Androsace alpina, Minuartia rupestris, Pedicularis recutita, Phyteuma globulariifolium, Cirsium spinosissimum, Festuca scabriculmis ssp. luedii, Laserpitium halleri, Saxifraga seguieri, Viola thomasiana, ecc.), oppure limitate al solo settore occidentale (Achillea nana, Adenostyles leucophylla, Festuca acuminata) od orientale (Sempervivum wulfenii, Primula daonensis, Phyteuma hedraianthifolium, Corydalis lutea); queste specie, in maggioranza ossifile, non sono rare nei loro habitat, anche se per osservarne alcune occorre salire abbastanza in alto. Pur non essendone esclusiva, al nostro territorio è maggiormente legata l’androsace orobia (Androsace brevis), specie diffusa nel tratto più occidentale della catena orobica, tra il monte Fio57 raro ed il Legnone, ma che si spinge anche oltre il Lago di Como, nel Canton Ticino, dove il naturalista svizzero Oswald Heer la rinvenne per la prima volta sul monte Camoghè, nelle vicinanze di Bellinzona, nel 1833; questa bella primulacea cresce solo lungo le creste, nei detriti e nelle fenditure delle rocce, dove apre i suoi fiori rosei assai precocemente, spesso già alla fine di Maggio, sfuggendo così all’osservazione. Le specie endemiche esclusive delle Alpi Orobie sono solamente due: la viola di Comolli (Viola comollia) e la salvastrella orobica (Sanguisorba dodecandra). La diffusione della prima è limitata al settore centro-orientale della catena, dal Passo di Cigola al Monte Venerocolo, sia sul versante settentrionale che su quello meridionale, dove frequenta gli ambienti detritici d’alta quota; una stazione isolata esiste al Monte Legnone, all’estremità occidentale delle Orobie. Pianta inconfondibile per le piccole foglie tondeggianti e l’insolito viola-rosato dei suoi fiori, gialli alla fauce, che si schiudono tra Luglio e Agosto, fu scoperta nel 1832 da Giuseppe Filippo Massara, pavese, medico condotto a Montagna in Valtellina e valente naturalista, che la pubblicò nel 1834 dedicandola al botanico comasco Giuseppe Comolli. Pochi anni prima, nel 1829, lo stesso Massara aveva ritrovato in val d’Ambria una nuova sanguisorba, della quale spedì alcuni campioni a vari botanici, fra cui il prof. Giuseppe Moretti, dell’ateneo pavese, col risultato che questi, scorrettamente, la pubblicò nel 1833 attribuendosene la scoperta. La salvastrella orobica è una rosacea superante il metro d’altezza, con foglie pennate verdiglauche ed i fiori biancastri, raggruppati in spighe morbidamente pendenti e profumati, che si aprono tra Luglio e Agosto; esigente in fatto di umidità, cresce rigogliosa sui pendii detritici freschi, al margine delle alnete, lungo i torrenti, formando talvolta dense colonie, da 1000 e 2000 m di quota; anch’essa è presente su entrambi i versanti, dal Passo S. Marco a quello del Vò. La valle del Trobio Racchiusa tra le maggiori cime delle Orobie, l’alta valle Seriana custodisce ambienti alpini di grande bellezza; vette ardite e nevai, laghi cristallini e vasti campi detritici costituiscono lo scenario grandioso dove le specie pioniere affrontano incessantemente la lotta per l’esistenza. Sulla sinistra idrografica, la breve valle del Trobio, che dal bacino artificiale del Barbellino (1862 m) risale fino alla vetta del Gleno (2882 m), rappresenta il più completo esempio di ambiente periglaciale delle nostre montagne. Ancora oggi, la valle ospita tre distinti corpi glaciali, il maggiore dei quali è annidato nell’ampio circo compreso tra il Monte Gleno ed il Pizzo Tre Confini; nell’insieme la loro superficie supera di poco i 20 ha, ma ne misuravano oltre 100 attorno al 1830, al culmine della cosiddetta Piccola Età Glaciale, la fase di raffreddamento climatico che a partire dalla fine del ‘500 permise l’espansione dei ghiacciai alpini. In quell’epoca, gli attuali ghiacciai erano riuniti in un’unica massa e occupavano interamente la valle fin verso i 2300 m di quota; da allora, pur con brevi parentesi positive, il ghiacciaio si è continuamente ritirato, smembrandosi una prima volta nel 1942 e nuovamente nel 1970, liberando aree di grande interesse per il naturalista, che può osservarvi di anno in anno il graduale reinsediamento della vegetazione. Questa si manifesta in forma più ricca sull’antica morena frontale, colonizzata dalle prime piante oltre 150 anni fa; le specie presenti sono circa 50 e sui detriti fini e stabili il grado di copertura è già notevole, come evidenzia la buona diffusione di piante esigenti quali l’erba luc58 ciola dei ghiacciai (Luzula alpino-pilosa), la poa alpina (Poa alpina), l’agrostide di Schader (Agrostis schraderiana) il migliarino maggiore (Deschampsia caespitosa), il cardo spinosissimo (Cirsium spinosissimum), un piccolo trifoglio dal portamento prostrato (Trifolium thalii) e perfino un’orchidea (Coeloglossum viride), presente con qualche raro esemplare; ancora numerose sono le piante pulvinate, fra cui la silene a cuscinetto (Silene acaulis) e alcune sassifraghe (Saxifraga bryoides, S. paniculata), accanto alle quali si rinvengono anche la rodiola (Rhodiola rosea), l’aromatico genepì (Artemisia genepì), l’achillea nana (Achillea nana) ed il piccolo salice sermollino (Salix retusa). Poco a monte della morena, nelle aree della piana proglaciale colonizzate da circa un secolo, il numero delle specie si riduce quasi della metà, soprattutto per la scomparsa di quelle più esigenti, mentre tendono a prevalere quelle più decisamente pioniere, come l’androsace dei ghiacciai (Androsace alpina), la sassifraga brioide (Saxifraga bryiodes) e quella di Séguier (Saxifraga seguieri), la silene a cuscinetto (Silene acaulis), il papavero alpino (Papaver rhaeticum), l’acetosa soldanella (Oxyria digyna), il ranuncolo dei ghiacciai (Ranunculus glacialis) e la margherita alpina (Leucanthemopsis alpina); sui detriti, derivanti dalla disgregazione delle rocce della Formazione di Collio, crescono anche alcune specie calcicole, quali Silene quadridentata, Thlaspi rotundifolium, Arabis coerulea e Hutchinsia alpina. Il numero delle specie si riduce a poco più di una decina e la copertura vegetale diviene sempre più scarsa sulle aree liberate da pochi decenni; Androsace alpina, Saxifraga oppositifolia, Oxyria digyna, Ranunculus glacialis e Linaria alpina si spingono più avanti di tutte, con alcuni esemplari perfino in prossimità delle fronti glaciali. Nelle aree esterne alla cerchia morenica, nei macereti meglio esposti della Cima del Trobio, oltre alle specie più comuni si rinvengono anche lo spillone alpino (Armeria alpina), dalle globose infiorescenze rosate, il raro garofano dei ghiacciai (Dianthus glacialis) e l’endemica viola di Comolli (Viola comollia), mentre a quote inferiori si sviluppa la prateria a Festuca scabriculmis ssp. luedii, seppure in modo assai discontinuo; sui pianori del versante opposto occupa discrete superfici il curvuleto, mentre più in alto, sulle creste, è il regno incontrastato delle piante delle rocce e dei licheni. 59
Scaricare