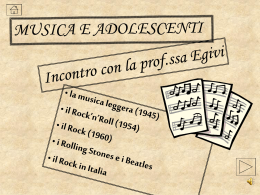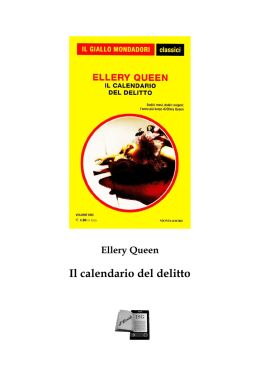leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it g LE TORPEDINI 17 Roxana Shirazi Slut! Confessioni di una groupie Dall’Iran della rivoluzione islamica ai camerini delle rockstar Traduzione di Elena Mascaro ISBN: 978-88-7615-587-1 Titolo originale: The Last Living Slut: Born in Iran, Bred Backstage © 2010 Roxana Shirazi Tutti i diritti riservati Originariamente pubblicato da HarperCollins Publishers I edizione italiana: settembre 2011 © 2011 Alberto Castelvecchi Editore Srl Via Isonzo, 34 00198 Roma Tel. 06.8412007 - fax 06.85865742 www.castelvecchieditore.com [email protected] Traduzione dall’inglese: Elena Mascaro Cover: Sandokan Studio Tutte le immagini, tranne dove specificato, provengono dalla collezione dell’autrice mn mn Per Tiger Per sempre Io sono l’amore che non osa pronunciare il suo nome LORD ALFRED DOUGLAS, Due amori op op INTRODUZIONE Stava lì, da sola, al crocevia ferroviario di San Clemente, California, un’esplosione di denim e di extension per capelli, con un portatile ammaccato tra le mani. Quella fu la prima volta che la vedemmo. Aveva preso il treno da Los Angeles per mostrarci il suo manoscritto. Noi eravamo prossimi alle date di scadenza dei nostri libri, così le dicemmo che aveva un’ora. Otto ore più tardi, qualche amico si era unito a noi e stavamo tutti seduti ubriachi in una cabina sulla spiaggia, ascoltando rapiti mentre Roxana Shirazi leggeva porzioni della storia che segue. Fu il miglior sabato notte da un po’ di tempo a quella parte. «Volete che smetta?», ci chiese nel suo contegnoso accento inglese. «Che altro hai?», le chiedemmo. «C’è il pezzo dove gli Avenged Sevenfold fanno pipì su di me». «Sì, per l’amor del cielo. Leggi quello». A quel tempo non era ancora un libro. Era una collezione di note dettagliate, articoli, istantanee e ritagli di giornale delle sue esperienze negli alberghi, sui tour bus e nel backstage mescolati a ricordi d’infanzia. E non solo ogni pezzo era avvincente e faceva luce sui trabocchetti del circo del rock’n’roll, 9 ma era raccontato con una voce eccezionale. La scrittura era muscolosa, elaborata e impenitente. Questa donna non era una vittima, ma faceva delle rock band le sue vittime e arrivava a spingerle all’stremo mettendole a disagio. Credeva nel mito del rock’n’roll e quando non era riuscita a trovare qualcuno che potesse dargli vita, aveva deciso di impersonarlo lei stessa. Fino a che non fece l’errore di innamorarsi di una rockstar. Tutto questo, unito alla sua sconvolgente maturità sessuale a Tehran nel mezzo della rivoluzione iraniana, ha dato forma a una storia che non avevamo mai sentito prima. Almeno non così. Dovevamo farla pubblicare. Mandammo qualche estratto scelto a parecchi editori e agenti. Dissero tutti che, dopo aver letto, non riuscivano a togliersi quelle immagini dalla testa. Però rifiutarono di mandare il libro in stampa. Come le rock band che la Shirazi aveva sedotto, dissero che il libro era fuori dalla loro zona di benessere. Era troppo. Così decidemmo di farlo uscire noi stessi. Slut! Confessioni di una groupie è una bellissima testimonianza di un’infanzia vissuta nella turbolenza politica a Tehran, un implacabile ritratto di una dislocazione culturale giovanile a Londra, avventure da backstage che fanno sembrare Sto con la band di Pamela DesBarres il diario di una suora, una favola ansiosa e spaventosa di amore bistrattato e brutale vendetta e il più avvincente resoconto di vita reale di depravazione femminile che avessimo mai letto. I rocker menzionati in questo libro potranno ancora avere le Polaroid, ma adesso voi avete le immagini. E sono indimenticabili, ve lo promettiamo. Neil Strauss e Anthony Bozza, Igniter Books 10 ALCUNE RIFLESSIONI SULLA PAROLA SLUT Volendo semplificare1, slut significa ‘individuo (anche se la parola si riferisce più comunemente alle femmine) che si intrattiene frequentemente in attività sessuali’2 con molti partner. Quando si descrive un maschio che si intrattiene frequentemente con molti partner, le parole spesso usate sono stallone, giocatore, arrapato, e così via, e molto difficilmente zoccola. Perché, un maschio che fa sesso frequentemente con molte partner riceve pacche sulle spalle, viene guardato con ammirazione perché sta sostenendo il ruolo che gli è stato assegnato come uomo. Viene visto come un passo verso lo sviluppo della mascolinità. È celebrato e incoraggiato. È l’equivalente delle marachelle di un bambino e dell’essere maliziosi. Con le femmine, invece, la disapprovazione è portata a livelli da stigmatizzazione. La ricerca da parte di una donna di piacere sessuale e di avventure sessuali è ancora vista come una caratteristica nega1. Per quanto vorrei scrivere di come il genere sia socialmente costruito – e di come i concetti di maschio e femmina siano semplicemente rappresentazioni che sono state propagate come verità e ci sono state inculcate dalla nascita – ho una storia da iniziare. 2. Vi prego di notare che il termine sesso indica sempre sesso consensuale. Qualsiasi atto sessuale che non sia consensuale non è sesso, è un atto di violenza. 11 tiva, che in qualche modo la rende un cattivo essere umano. Una femmina non è definita nei termini della sua umanità, ma nei termini della sua vita sessuale. Quindi, logicamente, godersi il sesso con diversi partner rende qualcuno una cattiva persona? Come può la vita sessuale di un individuo definirlo interamente come essere umano? Di sicuro gli esseri umani dovrebbero essere misurati in base alle loro qualità e attitudini: gentili, divertenti, pigri, espressivi, determinati, timidi, meschini, noiosi, prepotenti, spensierati e così via. Il sesso, anche se è solo un piccolo segmento della nostra esistenza, è ancora una bella e sensuale esperienza, e l’esplorazione della sessualità di una persona e le diversità sessuali dovrebbero essere celebrate e rispettate. In questo libro, io non mi vergogno di definirmi slut, ‘puttna’. Certo, qualcuno dirà che la parola puttana non può mai essere indipendente dai significati sociali e storici a cui è collegata e, essendo comunque contaminata dal suo senso negativo, bisognerebbe inventare un nuovo vocabolo per descrivere in modo positivo un individuo sessualmente attivo e dedito alla sperimentazione. Be’, forse è vero, ma in questo libro sono stata presuntuosa abbastanza da dare a me stessa l’autorità di cambiare il significato della parola slut. Amate il vostro corpo, amate la vostra sessualità, e cercate di capire che siete cattivi esseri umani solo se siete sgarbati, crudeli e se fate del male agli altri, e non a causa della vostra vita sessuale. Roxana Shirazi 12 Prologo gh Donington Park, Inghilterra 9 giugno «Roxana vuole farsi tutta la band», Tommy Lee dice a Nikki Sixx, indicandomi. Ancheggio in mezzo a loro, vestita di lino bianco e pizzo, gli occhi che luccicano di caldo miele liquido, la bocca socchiusa, il corpo che chiede una doppia penetrazione da queste due leggende del rock. «Mick morirebbe», mormoro, conscia della malattia ossea degenerativa di Mick Mars, ma assaporando i titoli che avrebbero accompagnato la notizia: Morte per sesso: ragazza uccide rock star durante la fornicazione. Il vizio del giorno di Vince Neil sono due bionde ossute, il tipo di donne i cui disordini alimentari sono solo l’ennesimo accessorio. È pomeriggio, piena estate, e siamo al coperto sotto al tubo intestinale delle luci fluorescenti nei camerini dei Mötley Crüe al Download Festival. Il fetore degli emo emana da ogni angolo mentre le piccole boy band bighellonano, con i loro occhi da panda e i capelli da ragazzine. Sono ragazzi elfo con le orecchie grandi, fieramente impiastricciati di matita nera, con angoscia e dolore e odio i miei genitori scarabocchiati sui loro top a strisce. Fingono distacco sui gradini 13 dei loro spogliatoi prefabbricati, come se non notassero la presenza esplosiva dei reali del rock Mötley Crüe. Bevo tè Earl Grey da una delicata tazza mentre Tommy Lee mi offre dello Jägermeister. Teenager vestite da cameriere chic anni Cinquanta lo guardano, Pollianne con gli occhioni spalancati. Sono insignificanti. Le scaccio via. Tommy butta fuori le ragazze che gli ho portato perché sembrano groupie: tutte avvolte in calze a rete strappate e vestiti sintetici. Con lui parlo in greco perché lui è per metà greco. È un bambino iperattivo col cuore grande sotto speed nel corpo di un uomo dinoccolato, magro e tatuato. Ha una dentatura prominente, e ha le rughe e una voce roca che sa di petrolio che mi scopa nella fica. Ma io voglio anche Nikki Sixx, il mio Elvis, dentro di me. «Sono una squirter», dico a Sixx. «Ci piace, vero, Tommy?», dice la sua voce, uno sdolcinato biascicare marinato in decenni di degenerazione distillata. Tommy mi porta nel suo camerino e chiude la porta mentre la sua guardia del corpo fuori si mette in posizione. Alza la musica techno di cui è così tanto innamorato a volumi da indurre la cancrena. «Non puoi mettere su Mott The Hoople invece?», lo supplico. «Questa è la musica per scoparti! Fuck yeah», dice Tommy, saltellando in giro come un bambino iperattivo. «Voglio vederti squirtare, Miss Bagnata!». È così autoritario, mi dà ordini con quel suo ruggito rauco. Io obbedisco e divarico le gambe sotto l’adorabile vestito di morbido cotone che mia mamma mi ha comprato. Non indosso mai mutandine. È un’abitudine che ho da quando ero ragazzina. Gli occhi di Tommy si illuminano come quelli di un ragazzo lupo. Apro la mia fica al massimo e uso un dildo per poter eiaculare sul pavimento di Tommy. «Nikki verrà?». Vorrei che fosse il 1983, quando erano la band più rozza del rock. Tommy, occhi ardenti, gioca con me e bacia il mio fiore. Sono così fottutamente eccitata. Voglio una doppia scopata con Tommy e Nikki. Vado a cercare Sixx. Nikki mi dice di essere paziente. Mi vuole per sé quando tornerà in Inghilterra. 14 15 Londra, Inghilterra Due mesi più tardi «Sembri così angelica», dice Nikki Sixx. «Posso essere una puttana più tardi in camera da letto se vuoi», rispondo. «Quindi tu e Livia siete un team?». La sua voce è nasale e intellettuale e scorre come sciroppo. Non riesco a credere di essere al telefono con Nikki Sixx. Sono una ragazza molto fortunata. «Sono affamato. Quando arrivate?», dice Nikki. «Presto… presto». «Venite in hotel. Vi aspetto. Sbrigatevi!». Il mio cuore è vivo, gonfio come una luna piena. Sto per cenare con Nikki Sixx. Piccola vecchia me: la ragazzina rifugiata iraniana con i baffi. La più grande sfigata a scuola, quella che ha perso la verginità a ventiquattro anni. Di colpo tutti gli altri – tutti i musicisti anonimi del Sunset Strip, quelli che una volta erano qualcuno, quelli che non lo saranno mai, quelli che mi hanno fottuto il cuore – non importano più. Non hanno significato. Nikki Sixx mi sta aspettando. Nel taxi che mi porta alla sua stanza, mi sento come se mi stesse scoppiando una coronaria. Livia cerca di calmarmi coi suoi modi infiorettati. Non è per niente turbata da tutto questo. Per lei Nikki Sixx potrebbe essere John Regolare del locale chiosco del pesce. Livia è una modella. È incantevole. Entrambe sembriamo star. Non troppo scollate, non troppo modeste. Luccicanti, pettinate, profumate e idratate. Lei, una bionda Marilyn, io, un’Ava Gardner corvina. Nikki sta aspettando nella lobby dell’hotel di St. Martins Lane. I suoi occhi felini, colore acquamarina, guardano obliqui come quelli di un giaguaro; capelli nerissimi e scalati ci ricadono sopra. Conosco un sacco di persone che darebbero un rene o un dito importante pur di essere in sua presenza. Sono sopraffatta. Cerco di essere civile e di non eiaculare spontaneamente mentre la mia femminilità si apre come un fiore di loto. Ci abbracciamo e baciamo e andiamo a cena. Mentre ci dirigiamo verso il ristorante, i miei capelli ondeggiano nel vento e nella pioggia tempestosa di Londra. Ascolto Nikki parlare della sua vita e lo guardo dare biglietti da cento dollari americani ad ogni senzatetto che incontriamo. Mi chiedo se sia uno spirito solitario e non più una leggenda degli eccessi del rock’n’roll: avendo commesso ogni genere di sporco ed esecrabile atto di degenerazione verso uomini e donne, e dopo essersi quasi ucciso due volte per overdose di eroina, cos’ha ora? Chi è? «È solo marketing. È business», insiste categorico sulla sua immagine. Il mio entusiasmo cala istantaneamente. «Avresti dovuto indossare scarpe basse. Quei tacchi ti faranno male ai piedi». Indica i miei splendenti tacchi a spillo di Pvc mentre entriamo nel ristorante Nobu, trendy e infestato di paparazzi. «Ok», mormoro delusa, barcollando senza mutandine sotto la mia minigonna. Livia mi guarda. È un sogno divenuto realtà: una sessualità da Lolita innocente, capelli biondi naturali che le ricadono sul viso, grandi occhi blu che sorridono a Nikki. Mi chiedo se lui faccia ancora sesso, o se sia tutto morto dentro di lui come un ricordo perso e intorpidito di una vita passata. Spero che lo faccia e spero che noi gli piacciamo, in questo modo potrò scoparmi anche Livia, il cui corpo di porcellana sono stata riluttante a toccare per paura di infrangerlo. 16 Mangio ostriche e massaggio le spalle di Nikki. «Voglio darmi al giardinaggio», dice con così tanto piacere che lo immagino mentre sogna a occhi aperti queste cose tutti i giorni seduto nella sua villa di Malibu, la solitaria icona rock. Cerco di unirmi alla conversazione ma non so un bel niente di giardinaggio. Invece parlo di quel che resta delle band hair rock degli anni Ottanta: Ratt, L.A. Guns, Faster Pussycat. Ma Nikki non sa nulla di quel che succede oggi nel mondo del rock vecchia scuola. Gli parlo della mia massima fantasia sessuale adolescenziale: essere penetrata contemporaneamente da lui e da Axl Rose. «Oh davvero?». I suoi occhi scintillano. «E dopo quello a quali fantasie sei passata?». «Ovviamente al porno», dico. Con nonchalance mi dice che gli piace starsene seduto a casa a masturbarsi. «Stupro per fare conoscenza», lo chiama. La sua voce è una nenia monotona. E comunque è in qualche modo interessante, come un buon giornale: pieno di informazioni e dettagli. Parliamo del suo desiderio di fare un viaggio nella mia patria, l’Iran, di spiritualità, e del tempo, e a quel punto si gira improvvisamente verso di me. Mi punta il mento davanti col fare inquisitorio di un insegnante e chiede: «Perché non hai un fidanzato?». Ingoio un pezzo del buffo pesce crudo che ha ordinato. Un sentimento spaventoso – che pensavo fosse evaporato dal cuore – di colpo mi monta nella testa. Non penso. Ingoio. Dico la verità. «Perché mi innamoro». 18 PARTE 1 CASA Capitolo gh 1 Io, mia mamma e mia nonna C’è la band. Una qualunque. Ci sono tre tipi con i capelli cotonati biondo acido e acceso e due chiome scure e ruggenti. Petto nudo, eye-liner, abiti di pelle, sudore, atteggiamento voglio-scoparti-baby. Chitarre e basso e batteria e testosterone da venticinquenni penetrano l’aria come in un porno hard-core. Fronteggiano il loro pubblico in adorazione, che li guarda dalla massa scura. Ci sono le giovani: un calderone gorgogliante di bianchi colli diafani forzati in abiti da tarda notte. Vestiti alla moda comprati a Camden un sabato pomeriggio, qualcuno sformato per nascondere il loro adipe giovanile. Hanno collant tigrati e capelli arruffati raccolti in code flaccide, matita nera che sottolinea i loro occhi da Red Bull e vodka. I seni delle ragazze, se non altro, sono sodi, tutti ciccia e pelle morbida. Il caldo emana aroma di detersivo dai loro abiti firmati nell’aria fetida, misto a birra e sudore. Bardate nel loro equipaggiamento emo, urlano le parole delle canzoni. Poi vanno a casa nelle loro camerette al sicuro in periferia, i muri tappezzati di poster e angoscia, i pavimenti coperti di lattine accartocciate di Red Bull. Giacciono lì, intimorite dalla notte. E poi ci sono le cacciatrici, predatrici nascoste negli angoli, magre e slanciate come gatti in calore. Corsetti stretti e 21 gonne con lo spacco, capelli ordinatamente disordinati. Occhi di zaffiro che ricordano quelli dei lupi, con le ciglia finte spruzzate di paillettes. Sono seducenti ma altezzose come una collana di perle, imbronciate con le sopracciglia arcuate. Vogliono il chitarrista solista, perché «lui è figo». Stanno su tacchi altissimi e le loro facce inespressive non mostrano alcuna emozione, ma i loro zigomi potrebbero tagliare il vetro. Pronte ad attaccare al ritmo delle loro strategie notturne, discusse, pianificate e dissezionate in toni sommessi sotto la luce itterica del bagno delle ragazze, fissando specchi coperti di segni di rossetto, fazzoletti di carta e bramando così intensamente da bruciare come lava. Ovviamente c’è sempre la mafia delle groupie più vecchie, il cui atteggiamento forzatamente tranquillo puzza comunque di desiderio rabbioso di avere della carne di rocker per la serata. Si aggirano abbattute e appesantite, impacchettate nei jeans. Hanno succhiato e masticato, fottuto e rovinato sulla strada verso tutti gli altri sleaze rocker degli anni Ottanta venuti dopo i Mötley Crüe. Hanno avuto veri appuntamenti con loro prima che si sposassero, che divorziassero e che si sposassero di nuovo. Hanno storie vere di cuori spezzati, ricordi sfocati e cicatrici per provarlo. I loro corpi giallognoli sono inondati di whiskey e sperma. La luce tremolante cattura i solchi sui loro visi. A quarant’anni e qualcosa sono disperate, arrabbiate, pronte a levare di mezzo le ragazze più giovani. Senza questo mondo, non sarebbero nulla. Questa è la loro identità. I ragazzi più vecchi sono sempre in prima fila, con i loro tatuaggi flaccidi e i discorsi banali sui bei vecchi tempi. Vogliono prendere la merda che li colpisce in faccia, in testa, qualunque cosa sia. Li allontana così tanto dalle loro piccolezze, dai cestini del pranzo dei bambini e dalle riunioni parenti-insegnati. I loro capelli una tempo lunghi si stanno violentemente ritirando. Ma li hanno visti tutti: i Pistols, i Sabbath, gli Sweet, tutto il resto. Hanno visto il sangue, la merda, i rasoi e gli aghi, il vomito, le belle pollastrelle. È meraviglioso, come le erezioni mattutine a quattordici anni e il bisogno degli adolescenti brufolosi di essere scopati che le accompagna. Sanno tutte le canzoni e cercano di essere a tutti i concerti. I soldi che spendono per vedere le band dovrebbero essere destinati al nutrimento dei loro figli, ma questa è la loro vita, il loro sangue, la loro unica felicità. Proprio come me. Perché il rock’n’roll è il mio gruppo 0. Quando tutti i tuoi pensieri e le tue emozioni sono consumati dal rock’n’roll e tutto quel che fai dipende dai movimenti di una rock band, allora la tua vita diventa come quella di un tossico. Il sangue che ti scorre nelle vene, il respiro che ti nasce in gola, le tue lacrime, i tuoi soldi, il tuo enorme amore, le tue onde celebrali, il tuo profumo, i tuoi orgasmi. Tutto. Tutto. Ma è un’illusione: l’amore che senti così appassionatamente, i legami d’amicizia, le infinite stanze d’hotel, il supporto emotivo che dai e prendi, il cibo che mangi, le urla gutturali di estasi, la gelosia, la sete. Lo sfinimento e il freddo e il caldo, i tacchi che ti consumano la pelle, i preservativi che usi e non usi, i test per le malattie trasmissibili sessualmente, le fauci serrate. È un picco, un nuovo regno, uno spazio in cui puoi entrare all’improvviso e senza consapevolezza. E può diventare il tuo battito cardiaco, permeare il tuo make-up genetico. Questo so. Quando succede, all’improvviso tutte le decisioni che prendi non sono interamente tue. E non sai come sia successo. Hai poco controllo sulle tue emozioni e sulle tue azioni. Ed è tutto a causa di una rock’n’roll band. Questa è la mia vita. 22 23 Capitolo gh 2 ERO UNA BAMBINA CHE SI CROGIOLAVA TRA SPARATORIE, gLEGGI ISLAMICHE, E SESSUALITÀg Sono nata in un ospedale militare a Tehran, Iran. Mia madre era un’attivista politica di ventiquattro anni che aveva scelto l’ospedale gestito da russi come consenso al socialismo, il movimento politico al quale si era allineata nella sua resistenza al regime dello Shah Mohammad Reza Pahlavi. Sono nata in una società totalitaria con poca libertà sociale e politica, dove solo lo Shah e l’élite dirigente beneficiavano delle ricchezze del Paese mentre le persone comuni non avevano accesso a cure ed educazione decorose. Appena la sua pancia si era gonfiata, mia madre aveva capito che sarei stata una bambina. Solo non sapeva quanto discola sarei diventata. Quando le acque le si erano rotte, la mia zia diciottenne l’aveva orgogliosamente accompagnata all’ospedale. Una volta dentro, mia madre imparò che la rinomata e impeccabile reputazione dell’ospedale era fasulla: era un’istituzione di crudeltà clinica. Mia madre rimase in travaglio per sedici ore – la mia testa era così grossa che non riusciva a venire fuori facilmente – ma usare medicinali per il travaglio era contro la politica dell’ospedale, non importa quale fosse la 25 situazione. Invece, le infermiere credevano nella disciplina, quindi prendevano mia madre a calci e pugni per farla spingere più forte. Le urlavano di darsi da fare. Un sottile velo di sangue avvampò sulle vene del collo bianco come il latte di mia madre. A un certo punto durante il travaglio, mia madre pensò di scappare via con me ancora dentro di lei. Ma prima che potesse farlo, svenne sul tavolo. Io venni alla luce nelle prime ore del mattino. Le infermiere mi portarono via in fretta per evitare il contatto fisico con mia madre, anche quello contro la politica dell’ospedale. La lasciarono da sola, sdraiata sul tavolo operatorio nella stanza vuota senza acqua per tre ore. Incapace di alzarsi, si ridusse a leccare le goccioline di sudore dal suo viso. Tutti i giorni per una settimana, le infermiere mi portavano da mia madre per cinque minuti di allattamento al seno, convinte che il loro regime militare fosse per il bene della paziente. Qualche settimana dopo la mia nascita, la mia zia diciottenne e mio zio furono arrestati, torturati e interrogati perché sospettati di essere attivisti contro lo Shah. Da quel giorno fino alla rivoluzione nel 1979, vari amici e membri della famiglia di mia madre furono costantemente arrestati a causa del loro credo politico e delle loro attività. Mia madre e io facemmo innumerevoli viaggi verso la famosa prigione di Evin di Tehran per vederli da dietro le sbarre. La mia prima casa da bambina apparteneva a mia nonna, Anneh. Fu lì, nel bel mezzo della rivoluzione iraniana e della conseguente guerra con l’Iraq, che rimasi circondata da amore puro e felicità, durante il terrore delle sparatorie della rivoluzione, la legge islamica e la mia iniziazione alla sessualità. 26 Capitolo gh 3 Avevo sei mesi quando andai in prigione con mia madre. Fu solo per ventiquattr’ore, ma fu abbastanza per impressionarla per molto tempo. Mia nonna, mia madre e io eravamo a casa quando la Savak, la polizia segreta dello Shah, butto giù la porta. Erano in quattro o cinque. Ero in braccio a mia madre mentre lei li guardava sfasciare tutto ciò che c’era in casa di mia nonna, cercando volantini, opuscoli, libri e ogni altro tipo di oggetto contro lo Shah che potesse provare che mia madre fosse un’attivista politica. Il viso di mia madre era bianco come un lenzuolo. Io urlavo mentre mia nonna pregava in un angolo. «Alzatevi. Venite con noi», l’uomo urlò a mia madre. Anche se lei obbedì, pretese di portare me, i miei pannolini e la mia bottiglia di latte. La portarono, con me in braccio, a una macchina che stava aspettando fuori e si sedettero al fianco di ognuna di noi mentre guidavano verso la prigione di Komiteh Moshtarak Zed-e-Kharaabkaari, usata dalla Savak per gli interrogatori. Una volta dentro, mia madre venne bendata e condotta lungo un corridoio, con me ancora in braccio. Quando le tolsero la benda, vide che si trovava in una piccola stanza. La lasciarono lì tutta la notte e lei mi guardò dormire mentre attendeva il suo destino. 27 La mattina dopo fu portata in una stanza per l’interrogatorio e io fui consegnata alle guardie. Era terrorizzata all’idea che potesse essere violentata, torturata e uccisa, e che non ci sarebbe stato più nessuno a prendersi cura di me e di mia nonna. Per fortuna chi la interrogò fu clemente. Chiese a mia madre delle sue attività politiche e di quelle di suo fratello. Dovette riuscire a convincerlo di non sapere nulla, perché improvvisamente le ringhiò di andare via. Lei mi strappò alle guardie, corse via e prese un taxi che ci riportò al sicuro a casa nostra. Vivevo un’esistenza da fiaba nelle strade polverose e asciugate dal sole di Narmak, un piccolo quartiere emergente della classe media inferiore nel nordest di Tehran. Giocavo giorno e notte nel vicolo di fronte alla vecchia casa di mia nonna. L’aria fuori era arida, e profumava di erba e di terra asciutta. D’estate, verso le cinque, dopo il riposo pomeridiano, gli adulti inzuppavano la terra inaridita di fronte alle loro porte con secchiate di acqua fredda e l’aria si inumidiva col profumo della terra bagnata dalla pioggia appena caduta. La casa aveva un ampio tetto. Durante le notti infuocate d’estate, come tutti nel quartiere, mia nonna, mia madre e io mettevamo i nostri materassi fuori e dormivamo sotto le stelle che riempivano il grezzo cielo persiano. Dormivamo in pasheh-band, una tenda di garza bianca che teneva gli insetti lontani. Era assicurata da chiodi fissati sul muretto che circondava il tetto. Nella notte, vedevo ciminiere come bocche sdentate nel buio e sentivo il ronzio dei mormorii del vicinato e delle loro risate vellutate che provenivano dai tetti. Nella nostra casa c’erano quattro spazi al piano terra sezionati come fossero stanze da un muro posizionato al centro. Appena dopo la porta d’ingresso c’era un piccolo atrio con null’altro che uno specchio decorato con foglie d’oro, un telefono e una credenza colma di biancheria, lenzuola e piumini accata- stati: questa era la nostra aerea di accoglienza. Appena dopo c’era una stanza con vetri fragili come biscotti e una porta di vetro che portava al giardino, le cornici delle finestre dipinte con la stessa vernice striata giallo-limone. Questa stanza era dove mia madre e io – e qualche volta mia zia e cugina – dormivano su soffici lenzuola di cotone e morbidi cuscini rosa che mia nonna aveva tenuto immacolati per anni. Dall’altro lato del muro c’era un soggiorno con una vecchia stufa sgangherata che sbuffava fumi puzzolenti. La stanza aveva porte scorrevoli che creavano uno spazio in cui la mia bisnonna dormiva la notte. Con le trecce nero corvino che le arrivavano alle ginocchia, sedeva in un angolo buio di quella stanza, assente a causa dell’Alzheimer, sempre vestita con un lungo camice bianco, una figura solitaria che fissava il vuoto. Ogni centimetro del piano di sotto era coperto di strati di spessi tappeti persiani, che sfumavano uno nell’altro come onde d’acqua colorata. Intricati ghirigori, fiori e riccioli esplodevano in una danza frenetica di turchesi elettrici, marroni profondi e rossi spudorati, ipnotizzandomi. Sedevo lì e cercavo di dare un senso ai loro disegni, ma alla fine mi arrendevo, preferivo unirmi a loro, sdraiarmici sopra, baciarli. Il secondo piano non era occupato. Aveva due stanze, una col balcone che si affacciava sul giardino, una vecchia cucina e un bagno in rovina. Gradini di pietra grigia portavano al piano terra, che era dove vivevamo. La porta d’ingresso era bassa ma pesante. Non era mai chiusa. Invece stava aperta per fare entrare il flusso costante di parenti e vicini che mangiavano, dormivano, spettegolavano, amavano, piangevano e ridevano con noi. Immediatamente alla sinistra della porta principale c’era un piccolo bagno con un tozzo gabinetto di porcellana e una doccia. Vicino ad esso c’era la fatiscente cucina dove mia nonna sedeva in mezzo a un palazzo fatto da pentole e padelle, che creavano il carnevale di piatti più inebrianti: ash-e reste, ghormeh sabzi, zereshk polo, sholeh zard e il mio preferito, koofteh 28 29 tabrizi, dalla città settentrionale di Tabriz, della quale la famiglia di mia madre era originaria. Il piatto consiste in un mucchio di carne tritata mischiata con noci tritate, dragoncello e zereshk (piccole bacche acide essiccate) e impastata in un grande polpettone rotondo con un uovo bollito inserito nel suo delizioso cuore dopo la cottura. La cucina dove mia nonna preparava aveva una cantina che sembrava una segreta sotterranea. Era un luogo di terrore, accessibile solo attraverso una botola di ferro nascosta sotto un tappeto. Un giorno la curiosità ebbe la meglio su di me, infilai le dita attraverso la grata della botola e la sollevai. Guardai dentro un buco nero senza fine. Scendendo l’unta scala di tela potevo sentire la presenza di mostri che mi stavano aspettando. L’aria fredda mi afferrò la testa e scivolò nelle orbite dei miei occhi spalancati mentre lottavo per vedere nel buio pesto. I miei piedi toccarono il pavimento e io stavo lì, tremando per il freddo e per la paura, terrore e repulsione mi nuotavano in gola e tra i polsi, mentre attendevo qualche indicibile orrore. Sapevo che dovevano esserci topi e scarafaggi che strisciavano ovunque, ma me ne stavo lì come uno spaventapasseri nel mio vestito leggero di cotone, lasciando che il brivido della paura mi desse una fantastica scossa nella pancia. Non osavo andare in giro nel caso andassi sbattere contro qualcosa, forse persino mio nonno morto (uno zio una volta mi disse che il suo corpo giaceva lì insieme alle carte ammuffite del passato). Dopo un minuto o due, quando non ne potevo più, risalii sulla scala, alla luce e al sole. La mia anima e il mio cuore si abbracciarono e si nutrirono del brivido che avevo provato. Quindi ogni volta che ne sentivo il bruciante desiderio, nei pomeriggi silenziosi, andavo in punta di piedi in cucina, sollevavo il pesante, freddo sportello di ferro, e scendevo giù per vedere oltre il mio mondo. A volte, in quei confini, sentivo un senso di sacro che mi elevava. Mia nonna mi richiamava sempre, ma nella mio mente ero lontana, pronta ad essere trasportata verso il lato oscuro. 30 Capitolo gh 4 TROVAVO RIFUGIO NEL SUO GREMBO, E IL PARADISO NELLA SUA PROTEZIONE g g Mia nonna sembrava una dea nella sua aura. Il suo istinto materno si estendeva a chiunque incontrasse. Il suo soprannome, Anneh, significa ‘madre’ nel dialetto persiano del Nord. I suoi polmoni erano tormentati da anni di asma e il suo cuore, gonfio d’amore incondizionato, regalava costantemente il suo affetto e il suo tempo alle persone della sua vita. Lavorava sempre duramente per assicurarsi che il banchetto di piatti che preparava con cura deliziasse tutti. Solare di natura, insaporiva la vita, ballando e ridendo sempre. Il piacere che traeva dalle più piccole cose – come scegliere le sfumature e il filato per confezionare vestiti – le dava pura gioia. «La mia casa è la casa di tutti», diceva, risplendendo d’orgoglio mentre serviva cene ai vari parenti e amici che ci facevano visita. Purtroppo, però, siccome la sua vista diminuiva, qualche volta commetteva piccoli errori in cucina, come aggiungere zucchero allo spezzatino quando invece intendeva usare il sale. E le pillole enormi e antiquate che il suo dottore le prescriveva per l’asma le inspessivano la pelle. Nel tempo vedevamo le sue vene, gonfie e blu, che nuotavano sotto la traslucida pelle bianca delle sue fragili mani, decorate da un anello di rubino donatole dai suoi bambini per la festa della mamma, di cui faceva tesoro. «Un giorno sarà tuo, mia principessa», diceva ogni volta che cercavo di giocarci. 31 Crediti fotografici gh Andres Lesauvage, pp. 7-8 Andres Lesauvage, p. 17 Gottfried Helnwein: Beautiful Victim, p. 24 Gottfried Helnwein: Sonntagskind, p. 78 Top Photo: Mad Pete, p. 150 Andres Lesauvage, p. 154 Mad Pete, p. 171 Mad Pete, p. 157 Archiesiceram.com, p. 202 Ella Studios, p. 369 379
Scarica