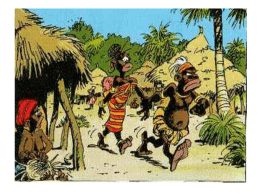casa lettrice malicuvata via vizzani, 41 – 40138 bologna [email protected] malicuvata.it progetto grafico: dogonreview.org impaginazione: giangi cavezzi illustrazioni: kain malcovich Autori Vari | Attraverso passaggi - annuario010 I edizione: gennaio 2011 ISBN 978-88-905441-1-8 licenza creative commons: attribuzione-non commerciale-non opere derivate 2.5 Italia. Attraverso passaggi | annuario010 AA. VV. francesco locane dario falconi simone rossi marco mazzucchelli alfio génitron jacopo nacci chiara reali marco montanaro elena marinelli marco visinoni fabrizio gabrielli jacopo cirillo marta casarini simona pinna manuela marceddu simone lisci ugo coppari gianni tetti lorenzo mari gabriele dadati sasha tsinski claudio morandini mattia piano antonio tirelli sig mustache kain malcovich casa lettrice malicuvata Sig Mustache | Tallinn-Helsinki | 2008 [attraverso passaggi racconti] Francesco Locane L’ultimo battito Un tuono coprì le sue ultime parole. «Cosa hai detto?» «Ho detto che il rumore del traffico si mescola meravigliosamente con questo temporale.» Stava seduto immobile vicino alla finestra e teneva il gatto nero in grembo. Un lampo rese ancora più scuro l’animale e fece risaltare il grigiore dei capelli dell’uomo, che continuava a guardare fuori, assorto. La sua mano destra si muoveva vicino alla bocca del felino, in un gioco che pareva potesse non avere mai fine. Il gatto fingeva di provare a morderlo, l’uomo spostava di qualche centimetro la mano, poi la riavvicinava e tutto ricominciava da capo. La pioggia batteva incessante da ore sulla Sesta Strada e su tutta New York, e sembrava che gli abitanti della metropoli fossero rimasti immobili, pietrificati dalla sorpresa di quel temporale: si muovevano solo le macchine e gli altri veicoli, ma parevano privi di conducenti. Merce si avvicinò alla finestra: il gatto lo guardò per capire le sue intenzioni. Poi, non considerato, balzò a terra con un suono sordo e zampettò via. «Mi manca Los Angeles» disse l’uomo. «Hai mai visto una tempesta del genere là?» 9 «Non ricordo. Ma credo che neanche New York, di recente, abbia assistito a qualcosa di simile.» «Dici?» «Sì» rispose esitando. «Ma in effetti questo non è altro che un temporale estivo, no?» Pronunciò queste parole e sorrise. Poi si rivolse verso la finestra, prese fiato e ricominciò a parlare. «Potrei stare delle ore ad ascoltare tutto questo. La pioggia sull’asfalto. I tuoni vicini e lontani.» «Puoi farlo.» «Sì.» «Sei ancora arrabbiato?» chiese Merce abbassando un po’ la voce. «Non credo, no.» L’uomo prese la mano di Merce per qualche secondo, la strinse tra le dita, come per saggiarne la consistenza, poi la lasciò. Merce gliela mise sulla spalla. In quel momento un altro lampo illuminò la stanza. «Sai a cosa pensavo? Che è strano che in cinquant’anni che abito da queste parti non mi sovvenga di un temporale così.» «Sono proprio cinquant’anni? Era il 1942?» L’uomo non considerò la domanda, e continuò. «Eppure è come se questo fosse il vero temporale a New York City. Ad averlo saputo, l’avrei registrato.» «Bastava consultare le previsioni del tempo» sussurrò Merce. Poi i due si guardarono negli occhi e risero. Un ulteriore tuono, la cui coda diventò un rombo di un autobus, seguito dallo squillo di un clacson, al quale se ne sovrapposero altri. Entrambi gli uomini erano assorbiti 10 dall’ascolto del vento, della pioggia e di tutti i suoni di Manhattan in quell’istante. L’acqua batteva sulle carrozzerie dei veicoli parcheggiati, sulle foglie degli alberi di Washington Square, sulle finestre dei palazzi. Ogni singola goccia dava il suo contributo. A questo pensava l’uomo. Si concentrò e sentì il sangue che gli pulsava nelle orecchie, un’eco lontana di quello che aveva percepito quando era entrato in quella camera per cercare il silenzio. E non l’aveva trovato. Da allora tutto era cambiato, per sempre. «Sono passati… Quarant’anni esatti!» esclamò. «Da cosa?» chiese Merce stupito. «Scusa» disse l’uomo ridendo. «Facevo i conti ad alta voce. La camera anecoica. E anche la prima esecuzione.» «Era questo periodo dell’anno?» «Sì. Mi viene in mente l’odore dei boschi intorno a Woodstock. Con tutta questa pioggia i funghi che non ci saranno, nei prossimi giorni» sussurrò. E si ricordò anche dell’emozione di vedere David al pianoforte che chiudeva il coperchio per iniziare a suonare. E il vociare del pubblico al terzo movimento, gli scricchiolii delle poltrone abbandonate da chi si alzava per lasciare la sala sbuffando. «Pioveva anche quel giorno?» chiese Merce. «Iniziò a piovere, sì. Non subito. Il rumore delle gocce sul tetto…» «Sarebbe bello fare una passeggiata da quelle parti, che ne dici? Uno di questi giorni…» «La mia gamba non me lo permette. Quest’acqua fa na- 11 scere i funghi e risveglia tutti i miei dolori, caro. Dovremo rinviare. E poi, ultimamente, quando vado per boschi scivolo, cado, lo sai… Un disastro.» «Perché non ci fermiamo lì un po’ per il tuo compleanno?» «Merce, Merce. Ci vuole quasi un mese. E poi dobbiamo andare a Francoforte da Walter e Stefan. Oppure alla nostra età possiamo permetterci di disattendere alle feste che organizzano per noi?» chiese l’uomo beffardo. L’altro scosse la testa. «Che organizzano per te» replicò. «Per me, come vuoi. Non ti hanno invitato?» domandò l’uomo sarcasticamente. «Sono in lista, chiederò di aggiungere al mio nome un “più uno”.» «Siamo vecchi, eh. Da quanto era che non tiravamo fuori il passato?» «Io dall’altro giorno.» «Ehi, con i giornalisti non vale.» «In tal caso, sì, hai ragione. Siamo vecchi.» Di nuovo i rumori si espansero nello spazio che le loro parole avevano momentaneamente occupato. L’uomo vide nettamente, in strada, un ramo scosso dal vento che perdeva le foglie, e non riuscì a trattenere un sottile senso di angoscia. Si accorse che aveva sospirato solo quando Merce glielo fece notare, chiedendogli cosa gli passasse per la mente. In quel momento un fulmine squarciò il cielo sopra New York. «Hai visto?» chiese eccitato l’uomo. Quella scarica era arrivata per caso, come tutto il resto, ma come sempre lui aveva colto l’occasione che gli veniva offerta da una 12 coincidenza. Non voleva parlare dei suoi pensieri di quel momento con il suo compagno. Non ora. «Sì. È stato incredibile, era netto, bellissimo.» «È una tempesta elettrica.» «Già, forse dovremmo staccare… Cosa si fa in questi casi?» «Niente. Si aspetta.» Era la sera di un giorno d’agosto. Nell’appartamento dove vivevano i due uomini permaneva un lieve odore delle verdure consumate in una cena precoce: in condizioni normali la luce del sole avrebbe ancora illuminato quelle stanze, la strada e tutta la città, ma il cielo era scuro a tal punto che sembrava che il mondo dovesse finire in quel preciso istante. Così pensavano i due, e lo stesso tanti altri, bloccati nei loro uffici e nelle loro case, costretti a fare i conti con qualcosa di imprevisto e più grande di loro, che nulla aveva a che fare con la chiusura non programmata delle fermate della metropolitana, un guasto improvviso all’ascensore, il cedimento di un albero che finiva per cadere sulla strada e spezzava il flusso del traffico, che pareva inarrestabile. L’uomo immaginò che, in quel momento, in molti dovevano essere come loro, fermi, affascinati e spaventati come lo erano stati gli antichi di fronte a fenomeni di quel tipo. Il timore dell’ignoto, dell’incontrollabile, dell’imprevedibile. Ma no, non aveva paura del caso, sapeva che la casualità era tutto. L’uomo si rese conto che Merce era ancora in piedi, dietro di lui, e premette appena la spalla sul suo ventre, come per sentirlo più vicino. Il calore del corpo lo fece stare meglio, ma per poco. 13 «John, che hai?» «Mi chiedo cosa ci sia, dopo.» «Dopo cosa?» «Dopo l’ultimo battito. O meglio, tra l’ultimo battito e la fine di tutto. Mi chiedo se in quel momento, in quello spazio, in quel tempo, ci sia qualcosa che si avvicini al silenzio.» Merce sospirò, girò intorno alla poltrona su cui l’uomo era seduto, si accomodò sul bracciolo e gli prese la mano. «Perché questi pensieri, ora?» «Non lo so. Capita. A te non succede mai?» «Sì, ma mi tornano in mente le tue parole, quando mi viene questa paura.» «Quali mie parole?» «Non le ricordi? Stai davvero diventando vecchio!» disse ridendo Merce. «Quali parole?» L’uomo, stavolta, era serio, e prese Merce alla sprovvista. Un altro fulmine li illuminò per un attimo, sorprendendo la nudità dei loro volti: si scaricò vicinissimo, tanto che il rombo del tuono che ne seguì fece tremare i vetri delle finestre. «Hai detto che la morte era un mistero la cui soluzione ti affascinava. Più o meno.» Ricordava di avere affermato qualcosa del genere, ma sentendolo da Merce era come se si trovasse di fronte a una foto che lo ritraeva in un posto e in un luogo indefiniti nello spazio e nel tempo. Le parole erano sue, ma dubitò di averle pronunciate davvero. In ogni caso non 15 sarebbe stato così sicuro nell’asserire cose del genere, alla soglia degli ottant’anni. Si sentiva sempre più fragile, più incerto e delicato. Mortale. All’improvviso la pioggia cominciò a diminuire di intensità, ma senza cessare del tutto. L’uomo se ne accorse, e rimase incantato nell’ascoltare il ritmo delle gocce diradarsi con estrema lentezza. Gli abitanti della metropoli tirarono un sospiro di sollievo e le loro occupazioni, gli orari, le telefonate da fare, gli appuntamenti che dovevano essere fissati, gli incontri di lavoro da preparare ripresero il loro posto, poco alla volta, nella vita di tutti. «Ti serve davvero quando pensi…» L’uomo lasciò la frase in sospeso, e si stupì di averlo fatto. Merce si avvicinò a lui e lo baciò sulla guancia. «Quando penso alla fine? Sì. Mi serve e ci penso. E penso che l’hai detta tu e che sono fortunato ad averti accanto da tanti anni.» «Tanti anni» disse l’uomo ridendo. «Non specifichiamo quanti, che per oggi abbiamo fatto i vecchi abbastanza.» Il rumore del traffico tornava a prevalere, dopo avere lasciato spazio al vento e alla pioggia, e crescevano i tremolii delle marmitte, lo stridore degli pneumatici, il soffuso rumore delle centinaia di passi che in quel momento riempivano l’aria del Village. «John, e tu?» «Io?» «Ti serve quella frase?» L’uomo sorrise. «Ti amo, Merce.» 16 «Anche io. Vado a fare una tisana.» «No, no, stai qua, ci penso io.» Il cielo era rimasto cupo, ma l’oscurità portata dalla tempesta era sfumata nella penombra del crepuscolo. La pioggia non smetteva di cadere, ma era solo pioggia. “Solo pioggia?” pensò Merce. Pioggia. Vento. Una macchina con il tubo di scarico rotto. L’autobus che frenava sbuffando. Il passaggio roboante e sommesso della metropolitana. Il gratticchiare del gatto su una libreria ormai di sua proprietà. Il tintinnare delle stoviglie in cucina. Il suo respiro. C’era tutto quello che ci doveva essere in quel momento. Merce Cunningham, ballerino e coreografo tra i più influenti del XX secolo, divise gran parte della sua vita professionale e affettiva con John Cage, vivendo nello stesso appartamento del Greenwich Village dal 1970. È morto il 26 luglio del 2009 a New York, a 90 anni. John Cage nacque nel settembre del 1912 a Los Angeles. Si trasferì a New York nel 1942. Dieci anni dopo ci fu la prima della famosissima opera 4’33’’, eseguita da David Tudor, pianista prediletto di Cage. Dopo avere attraversato diversi campi dell’arte, innovandoli e influenzandoli profondamente, Cage morì in un ospedale di New York il 12 agosto del 1992. La sera prima era stato colto in casa da un infarto, mentre preparava una tisana. 17 Marco Montanaro Come funzionano gli orologi La panca su cui stavano Ntonio e Gabriele era sistemata a qualche centimetro dal muro. Il locale un loculo, scavato a graffi nel fianco di un palazzo del centro storico. Niente volte a stella, soffitto tagliato di netto. Le pareti un tufo umido sbriciolato al tatto d’inverno. La cosa toglieva ulteriore aria al locale. Due luci al neon sopra il grande specchio; incollati nell’angolo in basso l’oleografia ingiallita di un Cristo dal cuore acceso e la foto in bianco e nero di una donna con espressione mascolina, coi contorni annacquati. Accanto allo specchio una porta a soffietto, lo stanzino: ad Augusto non serviva; spazzole, lozioni, forbici e gel stavano uno sull’altro sul ripiano o nel lavandino. Dalla panca Gabriele osservava le spalle di Augusto, una piega sotto il camice, e il riflesso del barbiere intento a rasare il mento del signore sulla sedia. Una volta, Gabriele piccolissimo, suo padre gli aveva spiegato che quelle sedie le fanno solo in Germania, così come i rasoi di Augusto che è il maestro più vecchio del paese. Poi per anni né Gabriele né suo padre erano tornati. Suo padre ammalato, Gabriele, cresciuto, voleva i capelli come quelli della tv o dei ragazzi più grandi. Augusto slacciò il telo dal collo del signore sulla sedia, sbattendolo piano per far cadere gli avanzi di capelli. 19 Gabriele portò la mano sulla fronte a stringere forte il ciuffo tra le dita. Si tranquillizzò, non era ancora il suo turno: toccava al signore grasso seduto accanto a lui sulla panca. Il signore teneva gli occhialini bassi sul naso e non aveva ancora interrotto la lettura da quando Gabriele e fratello erano entrati in bottega. La rivista di moto, Gabriele aveva intravisto anche delle donne, le tette però più grandi di quelle in tv. Comunque, il signore grasso aspettò che l’altro cliente si alzasse dalla sedia e pagasse, poi lasciò la rivista sul tavolino, raccolse gli occhialini con due dita e infine si alzò reggendosi i pantaloni con entrambe le mani. Nella bottega lo spazio venne meno di colpo mentre tutti e tre gli adulti erano in piedi. A Gabriele sembrò che il tempo rallentasse definitivamente. Il ragazzino si aspettava che il barbiere gli chiedesse almeno a che ora era accaduto. Dalle suore ci andavano dopo la scuola, per il pranzo e per i compiti. Il tragitto a piedi, prima degli infami: quando c’era Checco, in tre sul motore. Adesso no, la strada era una storia condivisa, inevitabile per i due fratelli, Ntonio, culo da oboe, venuto su presto e nero di lavoro, lo stampo di Angelo, il maggiore; Gabriele ancora bimbo, biondo di mamma, voce da clarino. Così li vedevi per strada, strumenti estranei per tratti e per fiato. Ntonio allora ci provava a fare il grande con Gabriele. Comunque era un gioco e Gabriele giocava – niente voglia di seguirlo quando insultava o faceva il pazzo, dalle suore. Di Ntonio salvava il ciuffo ossigenato o gli 20 orecchini, si è fratelli anche solo per brutta copia, imitazione. Ntonio portava un brillantino al lobo sinistro, e l’altro più su, anche se lo perdeva di continuo. Ma a Gabriele la mamma aveva detto no, che era ancora piccolo per quegli orpelli. Così si era accontentato del ciuffo canarino: a scuola lo prendevano in giro ma non importava. Dalle suore invece un ragazzino più piccolo gli aveva rivelato che l’avrebbe fatto, pure lui, doveva solo aspettare che gli crescessero i capelli. Fermavano sul marciapiede davanti alla chiesa, seduti randagi. Gabriele chiedeva l’ora, prima di entrare pensava al dopo, ancora strada, pallone, maglia di poliestere sudato. Il fratello allungava il polso destro – display digitale su cinturino elastico, plastica cinese – diceva una cosa senza forma, non si poteva pesare né sapere. Gabriele tornava per strada, al pallone, gli occhi chiusi. Ntonio diceva che non ne poteva più, delle suore, della scuola, quel giorno – l’ogni giorno dei ragazzini – avrebbe combinato un casino. L’educatore era giovane. A Gabriele stava simpatico perché non lo trattava male come gli altri adulti della comunità. A Ntonio capitava di essere messo in punizione o picchiato da questi o dalla superiora. Dall’istituto erano passati tutti i fratelli più grandi di Gabriele e Ntonio ma nessuno aveva fatto in tempo a conoscere quest’educatore più giovane. A Gabriele piaceva parlare di lui con la mamma, e la mamma s’illudeva che lui potesse fare qualcosa per il piccolo. Che non finisse come Checco o Aldino. Solo Angelo era riuscito a evi- 21 tare gli infami e questo era un segno di Dio, non ci fosse stato Angelo nessuno avrebbe potuto portare papà all’ospedale la prima volta che era caduto. Dalle suore un giorno Gabriele aveva messo il muso quando l’educatore aveva provato a spiegare l’orologio a un altro ragazzino: s’era venuto a sapere che pure lui capiva solo l’orario sul display del cellulare, ma pure questo, un tempo da niente, un tempo raccontato. Cos’è un’ora, un minuto, cos’è prima di Natale, cos’è dopo? Allora l’educatore aveva promesso che avrebbe insegnato anche a Gabriele, ma in segreto: i più grandi l’avrebbero preso in giro. Dal tempo agli acciacchi, Gabriele raccontò di suo padre, che stava male, che aveva il diabbeti e un’altra malattia che non sapeva dire. Ma perché la lancetta più piccola e sottile fosse così importante, perché non toccasse a quella più lunga segnare le ore visto com’era facile puntarla sul quadrante, questo no, proprio non gli entrava. E un quarto, o meno un quarto, formule magiche: lo mandavano in tilt, gli si arrossava il viso, sfuggiva ogni senso. A terrorizzarlo poi, il minuto esatto quando la lancetta è ferma tra due puntini, nello spazio vuoto in cui non sono indicati i numeri sul quadrante. Un agguato, la forma degli adulti. Si svegliò all’improvviso, era ancora buio, ma niente, non capiva manco dov’era. Si era addormentato sulla sedia davanti alla tv dopo la partita della Juve, sul letto la mamma russava e il papà stava seduto a fumare, l’asta delle flebo il nemico. Adesso sul letto non c’era nessuno, allora Gabriele si fece alla finestra. Nel cortile 22 di terra battuta e pozzanghere era ferma l’ambulanza con le luci accese, silenziosa: una lumaca. Uomini con giubbotti gialli sistemavano con calma qualcosa sul retro del mezzo. Poi la voce di Angelo, dai balconi la gente, il coro di supposizioni. Gli uomini coi giubbotti gialli chiusero gli sportelli sul retro del veicolo, e il lampeggiare della sirena fu un temporale privato nell’aria muta e notturna. Gabriele vide la sagoma della mamma spuntare dal portoncino del condominio. Ntonio l’accompagnava sottobraccio verso Angelo, più in là l’ambulanza partiva tra le palazzine grigie coi muri ritagliati dalle crepe. Nella stanza, Gabriele guardava l’orologio a muro, inseguiva un ticchettare di linee rette. «Nto’, ce ete la lumaca?» «Ce ccosa?» «La lumaca.» «Addò l’ha ntisu?» «Alla scola l’hannu dittu, la maestra.» «La lumaca… Un insetto è.» «Comu li formiculi?» «None, la lumaca ete longa, eti na speci di… aspe’, stannu quiddi piccinne e quiddi longhe, senza guscio. Tu quali vuoi sapere?» «Cce sacciu. Mi pensava che lo sapevi. Ma tu non lu sa.» «Lu sacciu, lu sacciu. Quantu sciamu alle suore ti faccio vedere. Prendiamo un libro e ti faccio vedere, se stanno i disegni. Mo lassimi stare ca no tti vogghiu ssentu. E càmina, ca facimu tardi.» 23 Fu Ntonio a portarlo dal barbiere quella mattina, sul motore di Checco. Checco, la mamma aveva detto che gli avrebbero dato un permesso, gli infami, sarebbe venuto. Comunque, Gabriele protestò per un po’. I capelli non li voleva tagliare da Augusto, i tagli nuovi non li sapeva fare. «La mamma ha detto che in chiesa no cci putimu sta così, culli capiddi mbrogliati» fu tutto quel che ebbe da dire Ntonio. Entrati nella bottega, li investì l’odore di dopobarba, misura sfasata di altre eleganze, altre asprezze: a quell’età si asciuga solo sulle basette o sul collo, e brucia. L’uomo grasso sulla panca si leccò più volte il pollice e l’indice per voltare pagina sulla rivista. Nello specchio c’erano il vecchio Augusto e il signore sulla sedia col mento imbiancato, rivolto in alto. Il barbiere osservò i due fratelli fissando lo sguardo nello specchio. «Buongiorno» disse con la mano pronta sul rasoio. 24 Simone Rossi benpartita Inizia con della musica. Comico o tragico, il nostro sarà uno di quei giochi in cui a un certo momento si ride verde. Ma che oggetto avranno insomma questi spettacoli? Nessuno. Piantate in mezzo a una piazza un lampione e metteteci intorno dei fiori, chiamate a raccolta il popolo e avrete una festa. Facile. Poi chiamiamo una liceale con i fianchi larghi e le facciamo leggere le note di regia di Rimbaud: Ho steso ghirlande da campanile a campanile. Ghirlande da finestra a finestra. Catene d’oro da stella a stella. E ballo. Perché danzo non si dice più, è più bello ballo, poi la liceale con i fianchi larghi se la porta via la sua amica timida tirando forte con la mano, vieni via, Margherita. L’impatto visivo è fondamentale: io tirerei dei fili da una finestra all’altra, sospesi a diverse altezze lungo tutta la strada. Possiamo appenderci panni bagnati e panni bagnati di verde, e campanelli, strisce di stoffa con sopra scritto: benpartita. Buona partenza, Marta: il tuo funerale sarà una roba grande. One. Two. Three. Four. 25 Io sono il capo quando non c’è il capo. Ogni tanto i servizi sociali funzionano e i nostri cittadini vogliono vedere dove vanno a finire i soldi delle tasse: in galera, finiscono in galera. I soldi dei buoni per redimere i ladroni: sarebbe bello se funzionasse sempre così. Da noi funziona così: oggi ho uno spacciatore di cocaina, un eroinomane e un pedofilo, e devo fare in modo che stendano i fili alla svelta, domani c’è un garage da puntellare e cercate di ricordarveli come se fossero tre figurine: i tre ladroni non avranno nomi. Il nostro oggetto saranno le carrucole: faremo scorrere lune di carta e diavolerie da film muto sopra il corpo di Marta portato in trionfo da quattro maggiordomi sui trampoli. La vestiremo normale, la lasceremo scalza e le infileremo, ebbene sì, una gerbera rossa tra i capelli. La gerbera è come una margherita, ma troppo grande. Il nome Gerbera è quello del naturalista tedesco Traugott Gerber, che vede le margherite giganti di Santiago del Cile e le chiama come il suo cognome: Traugott Margheritoni. Oltre che come graziose piante ornamentali dalla facile coltura, le specie del genere Gerbera vengono coltivate industrialmente per la produzione del fiore reciso. Marta. La produzione del fiore reciso. Il pedofilo non mi ha ancora raccontato nulla. Con il ragazzo parlo dei dischi solisti di Syd Barrett, sul serio, gli sballoni ascoltano veramente Syd Barrett: eh, il cappellaio matto, i pezzettini del domino che vengono giù come i palazzi, i materassi, i campanelli delle biciclette, lui sì che l’aveva capita. Wish you were here and you are here, in effetti, una scritta gigantesca sulle strisce 27 di stoffa e nei cartelloni dei supermercati a quattro piani con dentro tutto. Lo spacciatore faceva il commesso nel reparto articoli sportivi, ma non ci credeva nessuno: una volta ha messo un chilo e mezzo di bamba in una borsa da tennis e ha sparato contro la volante ai centotrenta sulla Ravegnana, e questa storia me l’ha già raccontata dieci volte. Ma non mi pagano mica per stare ad ascoltare: mi pagano per stare a guardare. Pagano anche i delinquenti, li trasformano in operai e gli danno sei euro all’ora (danno loro) per cinque ore al giorno (ore d’aria) per cinque giorni alla settimana, fanno (centocinquanta per quattro) seicento euro al mese, seicento euro al mese da spendere in sigarette e biglietti del treno e tempo perso dietro le sbarre, dietro le parentesi. Il pusher deve farsi altri vent’anni: fanno tipo cinquantamila euro che puoi tenerti da parte comodo comodo, poi ci compri una macchina usata e vai a sparare sulla Ravegnana. Il pusher è quello che lavora di più, il pedofilo fa il suo, Syd Barrett non fa un cazzo. Ci mettiamo cinque ore a stendere i fili per la benpartita di Marta: novanta euro smandibolati con il male nel collo e le pupille bruciate a forza di guardare in su, dove cazzo ho lasciato gli occhiali ieri sera? In ospedale, mi sa che i miei occhiali sono rimasti in ospedale. In galera quelli come me sono la feccia della feccia. C’è l’attenuante omosessuale in galera, e lei era una femmina. Sedici anni e una mamma puttana. Ho scritto una poesia per Marta. Si intitola Gerbera Kokanica. 28 Gerbera Kokanica è una specie del genere Gerbere, e Kokanica sembra la Kočani - si legge Cociàni - la fanfara serba, la Kočani Orkestar: al funerale di Marta ci voglio la Kočani Orkestar. E dei biscotti. E quattro trampolieri che la portino in trionfo tra le strisce di stoffa con sopra scritto benpartita. Vuole seimila euro più duemila di viaggio più vitto e alloggio per otto persone, la Kočani Orkestar. I trampolieri li devo ancora sentire. Non suonerà la Kočani e non farà bel tempo al funerale di Marta: è un sabato mattina idiota di marzo e piove e si spappola tutto, piove verticale e non suona nemmeno un campanello. Io lo so come si chiama questo strumento ingombrante: contrappasso, questa cazzo di pioggia di marzo è il contrappasso per il caldo di settembre, sei mesi, cinque anni fa: sono cinque anni e mezzo che ci siamo lasciati, Marta, ti volevo dire che ultimamente Francesco De Gregori è ovunque: qua la gente va veloce ed il tempo corre piano, come un treno dentro una galleria. Chissà se si chiama ancora becchino o se ha un nome più da muratore, in effetti sembra proprio un muratore. A lavorare si suda anche al freddo: il filmino con il flashback dell’addio di Marta è proiettato miniaturizzato nella goccia di sudore sul collo del becchino che sembra proprio un muratore, goccia di sudore, forse è pioggia. E invece sembra proprio che chiuderti dietro un muro faccia venire caldo, Marta: ti seppellisce sbuffando. Il treno si fermava sempre meno spesso, poi ha smesso. Fanno centoquattro gradi all’ombra e non c’è un cazzo 29 di niente da bere e nel negozio di scarpe c’è un piccione chiuso in una scatola con un torsolo di mela. I traversi lucidi dei binari sembrano le piastre di uno xylofono gigante e il tuo treno se ne va così, Marta, il tuo treno se ne va come per magia e invece se ne va sul serio, ciao treno, ciao Marta, avrei potuto dirti che i tuoi denti sembravano le piastre di uno xylofono e che le tue labbra grosse erano lì apposta per metterci la sordina, avrei potuto dirti che la tua bocca abbassava il volume della tua risata e io più che baciarti cercavo di strappare a morsi la sordina dei tuoi denti, ma la tua bocca a forma di custodia si è chiusa come per magia e invece si è chiusa sul serio, ciao bocca, ciao Marta, ciao Marta che ride. Tra Melbourne e Adelaide il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l’esistenza di Dio e non finiva mai, non finiva mai l’Australia verdissima. Chiedevi Quanto manca? appena mettevo in moto la macchina, era tipo una gag, con voce lamentosa e stanca chiedevi Quanto manca? e invece ci eravamo appena svegliati, avevamo fatto colazione seduti e una volta abbiamo addirittura preso il caffè al bar. Puoi cantarti le tue canzoncine facendo finta che dentro ci sia addirittura del blues. Puoi andare per strada, in televisione, su internet, dove ti viene meglio, dove ti pare, puoi avere anche venti o trenta persone che ti trovano bravo abbastanza da fidarsi, ma poi arriva il prossimo. Tu invece (noi invece) noi siamo talmente vicini che il prossimo sei sempre tu. Facile. Nessuno si approssima: aspettano il turno dietro la linea gialla che garantisce la nostra discrezione e sono ancora lì che aspettano. E sai perché sei sempre il prossimo? Perché le tue canzoncine mi 30 annoiano dopo due strofe. Sei bravo, eh, hai venti o trenta persone che te lo dicono, ma io dopo due strofe mi annoio. Non è colpa tua. Non è colpa mia. È che non mi piace il genere. Portami giù nel pozzo dove ti sei nascosta fino adesso, luna finta che non sei altro, ho smesso da un pezzo di fidarmi dei fusi orari e dei ritmi sonno/veglia, i ritmi circadiani, come nella canzone dove c’è quello che dorme di giorno e scrive di notte e all’improvviso la morosa di un altro gli regala una macchina da scrivere con sopra scritto Everest, la montagna, il superlativo di ever, il più ever di tutti, for Everest, e intanto si sveglia Hong Kong e si sveglia Taipei, compra quando sale, vendi quando scende, compra tanto sale, vedi quanto sei scemo? Vai a fare la spesa: abbiamo pasta e abbiamo sugo e ci manca tutto il resto, è finito anche il detersivo liquido per i panni, c’è gente adulta che non ha mai comprato un flacone di detersivo liquido per i panni in vita sua. Tu lo sai quanto costa un flacone di detersivo liquido? Marta lo sapeva. E la mia soglia d’attenzione è sempre stata bassissima. E infatti Marta l’ho lasciata io. Come no. Marta, se rubo le idee agli altri non è perché ho finito le mie: le idee non sono né come le sigarette né come le scatolette né come niente di quello che si consuma; Marta, le idee degli altri te le indicavo per stupircene insieme, per smontarle e poi smentirle e poi mentre sono lì che ti indico l’idea tu mi guardi il dito e finiamo a letto, Marta, certo che finiamo a letto. Ci finivamo, se non altro. 31 Ci finiremmo, se tu ti decidessi ad aprire la custodia dello xylofono. Ma la scatola da scarpe rimane chiusa, dentro c’è un piccione e un torsolo di mela e ci sono pure i buchi per far respirare il piccione: il piccione è vivo, di mela ce n’è ancora. Solo che non vola. E va bene che i piccioni più che altro cagano sulle automobili, ma dovranno pur volare anche loro, ogni tanto. Finisce con il piccione che diventa un colombo che diventa una colomba che si chiama Marta e non è per niente un uccello della pace: nel becco invece del ramoscello d’ulivo ha una gerbera. Gialla. Le piace cambiare. Le piaceva cambiare. Mi è dispiaciuto averla cambiata, amici. Amici. Amiche, devo dirvi una cosa. Aspettate, stanno suonando le campane e non si sente niente. Ecco. Eccoci. Amici: guardiamoci. Contiamoci. Non parlo con tutti: siamo in pochi e sappiamo riconoscerci. Volevo dirvi: baciamoci in bocca. Come in Russia. Come allo zoo di Berlino. Da oggi in poi: bacimbocca. A ogni buongiorno e a ogni buonanotte e a ogni arrivederci, rapido come un timbro. Senza lingua. Siamo in pochi e ci facciamo riconoscere. Diventeremo quelli dei saluti più intensi. Niente benefici. Solo baci. Ci riconosceranno. Vigorosi cenni di assenso. Diciamoci qui la regola: tutti sanno che tutti baciano tutti, ma i bacimbocca si danno di nascosto. Furtivo. Il 32 primo aggettivo che mi viene in mente se penso allo spettacolo del bacimbocca è furtivo. Eh, ma siamo timidi. Eh, ma sei paraculo. Ma anche no, i bacimbocca. Concesso: un bacimbocca può essere sostituito da un abbraccio lungo almeno quattro secondi (contare lentamente One. Two. Three. Four, come i batteristi con le spazzole). In generale, un abbraccio lungo almeno quattro secondi è un indicatore d’idoneità: se di solito ve lo date, siete già pronti per il bacimbocca. Eravate già pronti per il bacimbocca e non ve lo siete ancora dato, ci voleva uno che ve lo dicesse: ve lo sto dicendo: potete baciare la sposa. Ma con tutti? Anche i maschi con i maschi? Anche le femmine con i maschi brutti? Anche i maschi con i maschi? Sì. Non subito, ma sì. Piano piano, sì. Perché Marta è morta e io non ho nessuna voglia di ridere, nemmeno il contrappasso che sembra un contrabbasso, la gente muore sul serio e gli amori finiscono sul serio, e io è sul serio che vi dico che dovremmo proprio darci i bacimbocca, amici, copriamo con gli schiocchi i rintocchi di campane e campanelli, Marta è morta, baciamoci, Marta, gerbera Marta. 33 Dario Falconi Ci siamo amati fino al sempre degli amanti [Cronaca immaginaria degli ultimi minuti di vita del grande Edgardo Donato, autore della celebre canzone A media luz.] Buenos Aires, 15 febbraio 1963, ore 4:00 Casa di Edgardo Donato, camera da letto Amore mio, non riesco a dormire. La luce della notte mi fa paura. Questa penombra protesa nel nulla. Ti ricordi Rosita Quiroga e la sua interpretazione di Julián ed il maestro Enrique Delfino? Te lo ricordi il maestro Delfino? Quel giorno che prendendomi da parte mi disse Edgardo Donato, un giorno sarai il grande Edgardo Donato! Avevo ventitré anni e a ventitré anni il grande Enrique Delfino mi disse Edgardo Donato, un giorno sarai il grande Edgardo Donato. E avevo ventitré anni. E la musica e la radio. E il violino. Il mio violino. Ti ricordi amore mio? C’era allegria intorno e c’eri tu e c’era la prima volta in cui ti vidi ed era agosto. Un bandoneón insinuava una milonga morbida e dei tacchi rossi ansimavano promesse d’abbracci non fraterni. Ti ho amato non per come eri ma per come ostentavi quello che eri. Ci siamo amati fino al 35 sempre degli amanti. E ancora ti amo. E ancora è agosto. Questa vita insieme fu davvero bella? Se penso alle voci di Antonio Maida, Hugo de Carrel, Horacio Lagos, Lita Morales e Romeo Gavioli. El Gavio, mi sembra di sì. Te lo ricordi El Gavio? Oggi ho sessantacinque anni. Non sono vecchio. Dovrei essere felice. Sono il grande Edgardo Donato. Ho sessantacinque anni ed Enrique Delfino aveva ragione: sono il grande Edgardo Donato. Dovrei essere felice. Eppure amore mio, questa penombra protesa nel nulla, questo chiarore opaco che incanutisce la notte ed ossequia l’alba, che cede al languore vitreo d’un imminente ricominciare. Ecco, amore mio, questa penombra cupa mi spaventa, sembra che mi chieda qualcosa, che mi dica parole che non voglio più sentire. Mio padre che parla con mia madre, due italiani tristi, parole migranti. Il Conservatorio Franz Liszt di Montevideo. Dove sei piccolo Carlos? Davamo calci al pallone in un cortile. Lui un giorno mi disse Torno a casa, torno a Genova. Ma era triste Carlos quel giorno. Aveva la stessa faccia che ho io adesso. Il piccolo Carlos quel giorno era un uomo di sessantacinque anni in una camera da letto che parla a sua moglie delle proprie angosce. Amore mio, qual è la mia casa? Forse è a Torino? Dove ancora vive qualche zio che avrà dimenticato che esisto. O, piuttosto, è a Montevideo dove ho vissuto gli anni gloriosi della mia infanzia? Dove nel cortile dell’Accademia Liszt ho versato le mie prime lacrime stringendo forte le mani di Carlos che con il suo pianto bagnava i nostri pugni chiusi, avviandomi a quel mistero oltre il ballo che si chiama Tango? O è 36 Buenos Aires, la mia città? Qui sono nato. Qui ti ho conosciuto. Qui sono diventato il grande Edgardo Donato. Cosa diavolo sono? Questa opacità m’insulta. Io non resisto. Mi sento vibrare dentro la penombra. Cosa sono? Un italiano, un uruguaiano, un argentino? Chi sono? Ho provato tutta una fottutissima vita a fare di questa musica una carta d’identità. Rivalsa d’una generazione figlia di miserabili espiantati dall’Italia in una terra lontana. Cosa ne sarà di tutte queste inappartenenze quando precipiterà il frammento delle nostre voci nel gorgo della spietata penombra? Aníbal Troilo, Juan D’Arienzo, Carlos di Sarli, Osvaldo Pugliese, Francisco de Caro, Alfredo Gobbi, siamo tutti figli d’italiani nati in Argentina o in Uruguay, ma non siamo italiani; non siamo argentini; non siamo uruguaiani. Siamo tutti parenti di carcerati che parlavano il lunfardo per non farsi capire dai loro carcerieri. Abbiamo storie, sangue, lacrime, passioni. Ma non abbiamo una casa dove poter trattenere la nostalgia dei nostri sguardi. Il Tango, maledetto Tango. Ci siamo illusi di trovare l’identità nell’arte. Abbiamo coltivato il sogno dei grandi visionari. Una musica che fosse un pensiero, uno stile, un’essenza, una casa. Ci siamo convinti di poter vivere nel Tango. In quella sensualità esotica che è malinconia della fuga e vorace desiderio d’avvinghiarsi. Ci siamo sentiti parte di quel movimento estenuante, di quella disperante sonorità voluttuosa, di quel canto che è gioia del sopravvissuto. Amore mio, mi sembra tutto un incubo terribile. La nostra allegria era reale? Quei night, quei concerti, erano reali? Amore aiutami; è una notte troppo poco rassicurante per po- 37 tersi permettere di essere così poco chiara. L’opacità, la vedi? Un bagliore impercettibile che piega il buio solo per sondarne la consistenza. Ecco, questa penosa penombra mi sembra oggi la mia vita. Abbiamo voluto inseminare l’arte, fare l’amore con gli spartiti, procreare arrangiamenti. I nostri figli non sono nostri ma figli del loro tempo. Non ci somigliano. Loro sono argentini o uruguaiani ma non sono abitanti di Tango. Abbiamo creato un paese immaginario. L’arte non fa popolo. Aggrega le solitudini. Assottiglia le distanze. Ma non è terra, non è mare, non è porto, non è chiesa, non è casa. Ora ho capito perché Enrique Delfino, quando mi disse Edgardo Donato, un giorno sarai il grande Edgardo Donato, non sorrise. No, non sorrise. Aveva una specie di ghigno ma non era un sorriso. Avevo solo ventitré anni. Non potevo capire. Non volevo capire. Delfino sapeva che essere grandi significa essere infelici. Che l’allegria sarebbe stata solo una messinscena per far rilucere l’epilogo di questa istrionica penombra. Qualcuno disse che il Tango è un pensiero triste che si balla. Ma prima o dopo arriva la stanchezza ed il pensiero triste non fugge. Noi c’eravamo illusi di poter ballare in eterno. Amore mio, il tuo volto, le tue mani, i tuoi occhi, le tue gambe, i tuoi capelli, le tue caviglie, i tuoi tacchi rossi sono l’unica consistenza a cui io mi sento di appartenere. Tu sei la mia terra, il mio mare, il mio porto, la mia chiesa, la mia casa. Sei l’unica feritoia di cielo che ha oltrepassato la mia cortina plumbea. Mi manca il respiro, amore mio. Chissà se questo terrore improvviso non sia il preludio dell’oscurità definitiva? Allora che venga 38 questo buio totale a divorare le ore da cui ancora avrei voluto essere sfamato. Che arrivi e faccia presto il momento mai atteso e mai disatteso. Io muoio avendo già la percezione di cosa sia non appartenersi. Che istanti sublimi sono questi, amore mio. Tu mi guardi con gli occhi di sempre. Gli occhi della ragazza dai tacchi rossi. Ed era agosto ed un bandoneón insinuava una milonga morbida. Ci siamo amati fino al sempre degli amanti. E ancora ti amo. E ancora è agosto. Non piangere ragazza. Piangerai dopo e io voglio che tu lo faccia solo perché quando piangi diventi più bella e al mio funerale dovrai essere quella di sempre. Sì, perché io ti amo non per quello che sei ma per come ostenti quello che sei. Ora stringimi le mani. Più forte, così. Domani scriveranno molte cose. Diranno che il Tango era la mia vita, che stavo lavorando ad un nuovo progetto, che Edgardo Donato è un grande e che un grande ci ha lasciato troppo presto. Lasciali dire. Loro non sanno. L’arte, la musica, il Tango: era il mio destino, inevitabile. Era la mia penombra. La mia natura che s’incarnava in un violino attraverso un lamento di suoni intonati. Ma senza la tua luminosità io non avrei visto le corde, le note, gli spartiti. Sarei stato molto tempo prima quello che sarò tra poco. Cieco e senza voce. Grazie amore mio bellissimo per questa tua luminescenza. Grazie perché vedrò esaudito il desiderio d’ogni uomo. Morirò a casa. Morirò tra le tue braccia. Lentamente si spegne la penombra. Non vedrò più niente. Non sarò più a media luz. 39 Marco Mazzucchelli Ferox […] dove siamo finiti. Il Blaze sta guidando la macchina di suo padre, un’Audi familiare da complesse decine di migliaia di euro. Roba di lusso. Roba di pelle e di radica, massiccia come una barca. Costa così tanto che posso distendere le gambe come se fossi in sdraio sul balcone. Siamo con la macchina del padre del Blaze per fare la nostra bella figura. Perché il Blaze ha una Fiat Tipo che sta cadendo a pezzi, con una falsa elaborazione Abarth da 1500 euro, assemblata con pezzi e meccanica raccattati in mezza Lombardia. Perché io ho una Punto Sporting primo modello, milledue con marmitta e scarico, assetto, cerchi in lega, pneumatici ribassati, centralina modificata, pomello del cambio in carbonio, pedaliera in nichel e volante Momo. Perché tutti e due abbiamo gli adesivi Dunlop sulle minigonne. Perché a Milano questa roba non funziona più. Io e il Blaze ci rintaniamo nel traffico del centro dei nostri sabati pomeriggi provinciali a girare a 10 km orari, dietro massaie dirette ai centri commerciali e famiglie che vanno al lago con il cane che ci fissa dal lunotto posteriore, giriamo e giriamo le stesse vie battute dalle ragazze che mangiano il gelato e sculettano sul marciapiede, giriamo con i finestrini abbassati, impianto stereo a manetta che fa gon- 41 fiare l’abitacolo come una caramellosa bolla elastica. Dalle nostre parti ancora si voltano a guardarci e noi guardiamo loro girando attorno a quelle camminate sudate, le mani nelle mani, tette fresche, capelli lisci […] mentre barcollo entrando, finalmente mi ricordo delle medie scolate al pub e delle due latte di Löwenbräu da mezzo comprate in autogrill e tracannate durante il viaggio, bello steso e allungato nella macchina del padre del Blaze. Appena dentro mi rendo conto che dei […] stessa gente, stesso casino, magari meno orecchioni. La gentaglia guarda subito male i nostri capelli lunghi, i nostri jeans stretti. Io Tampa-style con maglia dei Morbid Angel, senza maniche e con la scritta extreme music for extreme people, il Blaze dei Deicide, con Gesù Cristo in bella mostra dopo un’autopsia a sfondo cannibalico. Signore e signori Noi siamo quelli che al sabato sera onoriamo il metal al Nautilus, Noi siamo quelli che quando sparano i pezzi vecchi di Metallica, Sepultura o Slayer ci mettiamo in mezzo alla pista a gambe larghe e li eseguiamo con perfezione chirurgica, suonando le nostre chitarre invisibili tutti assieme, ondeggiando ritualmente le lunghe chiome. Noi siamo quelli che vi infileranno un dildo d’acciaio su per il culo. Vediamo passare qua e là anche rastoni e snowboarders in versione “non c’è neve / non c’è erba, uccidetemi”, con i loro pantaloni da contadino dieci taglie più grandi e le loro magliette biafra, la facce piene di svariate profusioni di peli ispidi, cornucopie di baffi, basette, pizzetti e via dicendo. Niente a che vedere con i nostri menti perfettamente rasati, affilati e lisci come le lame delle 42 asce degli dei normanni. A ogni modo questo mi fa perlomeno sperare che più tardi il sound […] continuiamo arditi a falciare la gente qua e là ma sembra di navigare in mezzo a un mare di spettri, mi chiedo se […] è che qualcosa mi passa davanti gli occhi, una mina che lascia una scia di bianco sfavillante impressa sulle mie retine, sbava e spruzza giù dalla gonna corta e sbarazzina che ondeggia sfiorando le cosce in movimento, spruzzata dalle calze porno che le arrivano fin sopra il ginocchio, e da un top sbracciato che la fascia ma non la contiene, che asseconda il suo ondeggiare. A farle da cappello una capigliatura di ricci selvaggi e sparati, che ruotano su loro stessi fino a baciarle il collo e le spalle nude. Una bomba su due zampe. Mi ci vuole del tempo per rimettere insieme i pezzi del puzzle della sua apparizione. Mi ha turbato. Con il suo non gusto, con il suo essere sfrontata, con le sue cosce, mi ha turbato. Ma tutto finisce qui. È con il Blaze che partono due raglie chiusi nel cesso e due negroni appoggiati al bancone, mi porto due ciocche di capelli dietro le orecchie (il Blaze li ha legati in una coda) ed è come se nulla fosse successo. Scendiamo lo scalino e ci fermiamo poco più avanti, vicino al bar, a guardare le persone che […] e iniziamo […] ci guardano brutto perché se te ne resti muto in un angolo allora iniziano a pensare male, a dire che sfigato quello lì, che non gli passa niente per il cervello, che non ha i neuroni a posto. Gli dico di quando sono andato a Zurigo in treno, il mese scorso, che appena abbiamo superato la frontiera, ma il Blaze mi dice di smetterla con queste stronzate e al secondo giro ci tocca confrontarci 43 con due long island e rivedo quella esplosione di burro e miele che parla con […] «Ma Tu Sei Romana?» «Già, si sente vero?» fa con quegli occhi tondi e scuri che mi guardano per la prima volta. «Un po’.» «Non è vero, si sente tanto» e io già mi sono innamorato di quelle «e» e di quelle «a» così larghe e aperte, così puttane. «Non Così Tanto Dai.» «E invece sì» lo dice inclinando la testa verso una spalla. Alzo le spalle e lei sorride. Per quanto ne so il Blaze ormai è fuori dai giochi. Lei incomincia a parlare e me la ritrovo in un baleno addosso che mi urla nelle orecchie per coprire il boato della musica. Così addosso che la mano che ho sul petto le finisce tra le minne, minne che anche loro mi esplodono addosso e che lei non si ferma dallo strofinarmi contro, le schiaccia come se fossi il parabrezza insaponato di una Corvette. Mi accarezza un braccio, gioca con i peli e mi parla come se io fossi un’altra persona, […] oh regalo del cielo, mi dici che sei siciliana e che sei venuta a Milano dopo aver vissuto gli ultimi anni a Roma, perché sei modella di Dolce & Gabbana. «Ho appena compiuto diciott’anni, sono maggiorenne.» «Ho appena compiuto diciott’anni» mi ripete come un robot e poi lecca e succhia la cannuccia del suo drink a 2 centimetri dalla mia faccia, guardandomi dritta nelle palle degli occhi, con il suo profumo che mi schiaffeggia tra le gambe. Oh regalo del cielo, che cosa sta succedendo qua? Non voglio che scappi via, lo farai presto ma non voglio che sia così presto, e ti afferro, più forte, ti stringo a me e tu sei flessuosa e sorridente come una di quelle che si fanno pagare […] sono un produttore di un gruppo metal, che 44 siamo appena stati in Svezia per registrare e pubblicizzare il disco. La Scandinavia è La Mecca. Tu abbocchi a tutto quello che dico. Faccio l’uomo vissuto, il vecchio lupo di mare, e mi ci trovo bene in questo ruolo scafato, sfacciato faccia di merda. Ti carezzo il pezzo di schiena che il top lascia scoperto e arrivo fino al bordo delle mutande che sporge dal gonnellino, poi senza lasciare che dubbio mi passi per la testa, quando ti premi di nuovo contro ti coccolo la natica destra per qualche secondo e tutti quelli che passano non possono non notare il tuo burro straripante e le mie mani che lo suonano e adesso ti prendo la mano perché vorrei che mi toccassi proprio qui invece che […] «Sei molto simpatico», il calore del tuo fiato, un morbido fazzoletto di seta all’arancio […] mi parli e mi affondi sempre la bocca nell’orecchio e il movimento delle tue labbra mi stuzzica e massaggia e anch’io vorrei baciarti tutta, iniziando proprio da quel lembo di carne pastosa e sento i capelli sulla mia faccia e ancora il tuo profumo che mi si riversa addosso come burro fuso. Vorrei portarmelo addosso per il resto dei miei giorni, e domani, me lo prometto, girerò tutte le profumerie, farò diventar matte tutte le commesse perché snifferò tutti i campioncini finché non l’avrò trovato e poi passerò l’intera giornata steso a letto ad annusarmi le dita di te. Mi fai venire voglia di inventarmi mille cose da dirti solo per tenerti qui stretta ancora, perché sento che il collante che ci unisce sta facendo filamenti e sta perdendo presa, finiamo di girare in tondo abbracciati, e mi ti stacchi di dosso e così mi porti via il cuore. […] Perdo ogni speranza di baciarla, ci rinuncio. 45 Già pregustavo quella sensazione di quando una membrana si rompe e si arriva a un nuovo livello di conoscenza, quella sensazione di aver brecciato nelle sue difese, pronto a conoscerla, assaporarla, in quei momenti che precedono sempre il gusto del rossetto e delle labbra, la lingua e la saliva compressi in un baleno a cui aspiro più di ogni altra cosa. Quel frammento di tempo che non esiste davvero, non è quantificabile, quando capisci di essere in bilico nell’equilibrio instabile tra la consapevolezza di avercela fatta e l’indifesa sete di non averlo ancora fatto. Lo vedi nella patina dei suoi occhi che diventa un po’ più spessa e al glucosio e le palpebre si abbassano impercettibilmente, il suo viso sfoggia un’espressione mai stata così vulnerabile, lo capisci che ha detto sì e che non vede solo l’ora di provare. Tutto quello che viene dopo non regge il confronto, è quasi troppo facile. Inizio subito a pensare alla sua fica, al sapore che potrebbe avere, scoparla, come scoparla, scoparla ancora, quando rivedersi, e poi no stasera esco con gli amici, chi è che ti scrive sms alle tre di notte, è la Wind, è la Banca, è la Fnac, è l’Adecco e tutto va a incasinarsi in un turbinio di stronzate che girano a vuoto e davvero nulla hanno a che vedere con l’Assoluta Purezza di quell’attimo che non si riesce a comprendere e trattenere. […] «Lo Potrei Avere, Insomma?» Penso comunque alla sua fica, al sapore che potrebbe avere. «Guarda, io voglio essere schietta, perché mi piace essere sincera, così si evitano tanti grattacapi. Se si vuole essere amici io ci sto, ma niente di più. Cioè solo questo, cioè niente roba da scopare.» Scoparla. «Be’ Ti Ringra- 46 zio Di Questa Schiettezza Che Mi Regali E Anch’Io Non Posso Far Altro Che Dirti Che Io Ti Vorrei Scopare Qua Subito Per Terra Che Mi Piaci Perché Sei Bella Che Non Posso Dirti Che Mi Piaci Perché Sei Intelligente O Che Altro Sì Mi Sei Simpatica E Sei Anche Matura Per La Tua Età Ma Scoparti È Stata La Prima Cosa Che Mi È Passata Per La Testa Quando Ti Ho Vista Te Lo Devo Proprio Dire.» «Vedi è che.» «Oh Sabato Io Sono Ancora Qua A Milano In Un Altro Locale […] «No.» «È Vicino A Piazzale Lotto Più O Meno È Un Posto Oh! Non Aspettarti Niente Del Genere Eh! Non È Di Questo Tipo È Un Po’ Meno Curato Diciamo Come Locale.» «Ci vanno i punkabbestia vero, anche tu sei un po’ punkabbestia.» «Be’, Oddio...» E poi scoparla ancora. «Sì lo sei, un po’ lo sei.» «E Va Bene, Sì, Un Po’ Lo Sono» lo dico ma mica vado in giro a far vedere che ho il cane io. «E Cosa Facciamo Allora?» «Non lo so, io il numero te lo do. Non lo do a nessuno il mio numero, ma te mi stai simpatico.» È qua che inizio a sentire aria di fregatura. «Ma Scopare Niente Eh?» «Niente scopare.» […] «Sì dai, e magari se stasera riesci a recuperare qualcosa da fumare fammi sapere eh, ciao bello.» Allontanandosi camminando all’indietro si bacia la punta di dito indice e dito medio e me li mostra uniti, dalla parte dei polpastrelli, proprio dove lei ha […] io poi che le sigarette non le sopporto e ricordo di quando a dodici anni, quando ancora il Blaze non lo conoscevo e non avevo ancora comprato la mia prima chitarra elettrica a freccia, io e altri due amici ci siamo messi di impegno un inverno e un’estate interi per imparare a fumare, pieni pomeriggi in- 47 vernali in un parchetto di periferia, vicino a un discount dove compravamo le caramelle alla menta e la Milan Cola che assieme in bocca facevano così schifo che mi veniva la pelle d’oca. Poi sedevamo sugli schienali delle panchine immersi nel buio delle sei di sera di gennaio a fumare le Marlboro e le Chesterfield convinti di contribuire ad alimentare quella nebbia che spargeva fino a noi le luci dei lampioni della strada lontana. Non si vedeva niente, eravamo nella nostra bolla e il lontano rumore del traffico del rientro dei lavoratori ci arrivava filtrato, come se si trattasse di un’altra dimensione, un mondo che ancora non ci apparteneva e che non necessitavamo, non volevamo assolutamente. Mi ricordo che le mani ghiacciavano e tremavano. Poi arrivata l’estate andavamo alla stazione ferroviaria che l’avevano appena costruita proprio in mezzo ai campi, e con la bella stagione il più alto di noi tre ha iniziato a portarsi dietro il fratellino di otto anni. Prendevamo il sentiero che costeggiava la ferrovia col suo cancello verde, posavamo le biciclette nelle erbacce e ci sedavamo appoggiando la schiena al ferro rovente del cancelletto e tiravamo fuori i pacchetti che avevamo appena comprato in società. Il sole delle due ci fondeva la scatola cranica e le scapole, e quando fumavo due sigarette mi girava tutto e mi veniva la nausea e mi dicevo che quando sarei stato finalmente un fumatore serio non sarebbe più successo. Tutto intorno era giallo e bruciato dal sole, tutto secco e polveroso, solo ogni tanto spiccavano degli alberi verdi e freschi come delle macchie scure in un mare assolato e quando passavano i treni sferragliando noi gli mostra- 48 vamo il culo ancora non peloso a quelli con la fronte unta e spiattellata sui finestrini e i capelli sferzati dall’aria. Non ricordo di cosa parlavamo ai quei tempi, non mi ricordo neanche se parlavamo, magari di macchine e della Formula Uno, chi si ricorda perdìo, forse che volevamo crescere in fretta per guidare, come quelli più grandi, che venivano al bar anche loro e fumavano cinque sigarette assieme, messe in bocca a ventaglio, avevano soprannomi fighi come Lupo e Nazi, si allacciavano gli anfibi e dicevano che i colori delle stringhe volevano dire cose ben precise, tipo se eri stato dentro, se avevi pestato un poliziotto o un comunista. Se li lucidavano sempre, non ci cagavano di striscio, ci rivolgevano la parola solo se dovevano farci andare alla cassa a cambiargli i soldi, a stento tolleravano la nostra petulante presenza, con i nostri occhi indagatori, i nostri goffi corpi non ancora sviluppati, le nostre mezze frasi di ammirazione mista a rispetto e soggezione e sottomissione e servilismo e non so dire perché non ci abbiano mai pestato. Sniffavano il tabacco e scatarravano a terra come una squadra di baseball, così che iniziai a farlo pure io, avevano sempre lo scudetto dell’Italia sulla manica e il bomber anche in estate e qualche troietta dalla faccia devastata e il culo sudato che si portavano sul codino delle moto. Ogni tanto volevano entrare nel nostro cortile, sparivano per dei minuti e tornavano con quelle scrofe ancora 49 più sudate, la faccia congestionata, la bocca impastata da una gomma marcia e dall’alito di sperma, tornavano a strusciarglisi contro se giocavano ai videogiochi del bar, facevano saltini e applausini isterici, l’aria nel bar si faceva viziata, Lupo concentrato che alzava di scatto la spalla destra senza lasciare la mani da joystick e pulsanti, e senza staccare mai gli occhi dallo schermo diceva «e levami sta zinna dal braccio» […] in bocca il sapore marcio della sigaretta sotto i bagliori arancioni dei lampioni del parcheggio mentre vedo nell’auto dove sono appoggiato qualcuno preparare raglie su un cd Buddha Bar […] «Oh Hai Trovato Da Fumare?» «Coooosa?» «L’Hai Trovato Da Fumare Bellezza?» «Sììì… Ma sono riuscita solo a farmi offrire qualche tiro, da qualcuno» e così se ne’è andata in giro a tirar di bocca da perfetti sconosciuti, piccola puttanella. La gente che sale con lei in macchina, con chi cazzo se ne va in giro? Va a scopare con tutti quegli stronzi messi assieme? Poi qualcosa dentro di me si squarcia e si smembra. Inizia con un rombo immenso che mi cresce nelle orecchie – i muri delle vecchie fabbriche mi passano affianco impazziti e la strada sotto di me scorre a un palmo dalle punte dei miei piedi che si agitano per conto loro – ancora lì piegato sul compact disc, sbuffo della nube bianca sulla maglietta del Blaze, in faccia a Gesù morto crocefisso che mi guarda stupefatto […] il Blaze lecca la faccia a Gesù morto, sbavando sulla maglia […] ho paura […] trascino Sofia lungo il parcheggio, zampetta per starmi dietro, le stringo forte la mano, nell’altra stringo le chiavi dell’Audi del padre del Blaze. Penso alla sua fica, al 50 sapore che potrebbe avere. Non penso a niente. Apro la porta, Sofia si stende con le gambe fuori, sfila una caviglia dalle mutandine calate e spalanca le cosce. La sua fica non ha sapore. La sua fica non è niente. E scoparla è niente. Lei è niente e io non sono. Si alza, le cosce insudiciate, la sua fica insudicia il sedile. La sua fica adesso ha il mio niente. Mi pulisco con la sua bocca e nelle sue pupille esplose vedo riflessa l’insegna dell’Esselunga e il filare di lampioni e dietro il buio, la voragine, niente. Qualcuno passa, non dice niente. Passando tace. Non c’è niente da dire. […] mi giro a guardare il Blaze e quando lo guardo mi sembra che sta messo male, messo peggio di Gesù, stecchito, mummificato da millenni, un cadavere vero, straziato. Qualcuno, da qualche parte, ha riservato del dolore anche per lui. Ci metto un casino a tirarmi in piedi ed è come se dovessi imparare di nuovo a camminare, faccio due passi a respirare l’aria fresca e a schiarirmi le idee, mi si ricollegano gli occhi, la lacrimazione gli infonde nuova linfa, sbatto più volte le palpebre per irrorare i bulbi oculari, sento i capillari riattivarsi e riprendere a pompare sangue. Guardo l’orologio. Guardo le scale di casa. Vedo la serratura, l’ascensore, le scarpe da togliere, sfracellarmi sul letto. Questa è la luce disinfettata dell’ascensore, mi guardo nello specchio mentre i piani scorrono sulla mia schiena. Una vertebra ad ogni sobbalzo. Faccio fatica a focalizzare, non vedo niente. Il burro e il miele di Sofia sono stati insudiciati. Sofia non più da tenere stretta come una foto nel portafogli. Niente campioncini di profumo domani. Domani niente. Non più sapere se il numero 51 che mi ha dato è vero o falso. Niente “il numero da lei composto è inesistente”. Adesso nessun telefono che squilla, squilla e squilla. Adesso nessuno che chiama e chiama e chiama ancora e ancora. Adesso solo le cosce insudiciate di Sofia e le labbra sporche, col dorso della mano, Sofia se le pulisce. Sfracellarmi sul letto, inghiottito dal mio niente [e Sofia una notte di parecchi mesi più tardi, a mollo in una pozzanghera melmosa, l’ho chiamata. guardavo ebete i tergicristalli che spazzavano una pioggia lattescente ma che niente potevano contro il pesante appannarsi del mio fiato. il cellulare ha squillato e lei ha detto due volte “pronto?”, la seconda lievemente preoccupata. e poi io ho riattaccato.] 52 Jacopo Cirillo La storia aumentata del Passaggio a Nord Ovest La storia della scoperta del Passaggio a Nord Ovest è mediamente interessante, ma poi neanche tanto. Diciamocelo: ha delle potenzialità, ma i passaggi sono un po’ deboli, non ci sono picchi narrativi particolarmente rilevanti e i vari esploratori che hanno provato a farsi largo tra i ghiacci raccontano avventure perfettamente nella media, magari anche un po’ al di sotto. L’unico modo per farsela piacere è gonfiare i fatti, raccontarla in maniera iperbolica e integrare la verità con una verità aumentata – un po’ come quei codici nelle pubblicità che se fai la foto con il cellulare puoi vedere il video esclusivo. Ecco, questa è la storia aumentata della scoperta del Passaggio a Nord Ovest. Il Passaggio a Nord Ovest, che gli spagnoli insistono a chiamare Stretto di Anián per un loro vezzo linguistico, è una rotta che va dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico attraversando l’arcipelago artico del Canada. Dal 1500 ad oggi tutti gli stati del mondo, anche la Svizzera, il Lichtenstein e gli altri fortunelli che non sono bagnati dal mare da nessun lato, si sono accapigliati per tracciare il passaggio, segnarlo su una mappa e, alla fine, crearselo spaccando il ghiaccio. Sfruttando l’incredibile 53 scorciatoia, infatti, le navi risparmierebbero oltre 4000 km sulle rotte dall’Europa all’estremo oriente e non dovrebbero passare dal canale di Panamà. Ma alla fine non è tanto il tempo o la distanza: il fatto è che i vecchi marinai di quasi tutte le navi commerciali chiamano il Canada “Canadà”, con l’accento, e tendono a confondersi con il Panamà. Questa antipatica assonanza crea tanti di quei problemi che non raccontiamo neanche, tanto lo immaginate. Orbene, il Passaggio a Nord Ovest è una sfida irresistibile per intrepidi e coraggiosi lupi di mare. Tra tutti quelli che ci hanno provato, William Baffin merita una menzione d’onore. William Baffin era un bambino nato e cresciuto nei sobborghi di Londra che passava le giornate con altri teppistelli a scippare le vecchiette e tirare manciate di sabbia negli occhi ai bobbies urlando: ahahaaa, non mi avrai mai, maledetto potere costituito! Dopo molti anni in riformatorio, vivendo avventure che ispirarono Charles Dickens per le prime stesure di Oliver Twist e David Copperfield, nel 1612 si inventò la fasulla “Società per la Scoperta del Passaggio a Nord Ovest”, pensando: magari qualcuno ci casca, se poi scrivo tutte le parole con la maiuscola faccio anche la figura di quello che ha studiato. Purtroppo per lui, il malcapitato non conosceva il detto scrivere corsivo non significa scrivere corretto (e immagino non lo conosca più nessuno, ma questo solo perché l’Inghilterra vittoriana era molto gelosa dei propri detti popolari) e fu costretto dal capitano Robert Bylot 54 a guidare la spedizione della nave Discovery attraverso lo stretto di Hudson. Com’è, come non è, William Baffin scoprì di avere un grande talento nell’osservare gli istmi, immaginare passaggi dove non ci sono e calcolare quanto ghiaccio si spacca andando a una velocità media di 30 nodi. Con tutti i soldi che hanno speso i miei genitori per farmi studiare, pensò, ho finalmente scoperto la mia vocazione. Fondare la “Società per la Scoperta del Passaggio a Nord Ovest” è stata la cosa più intelligente che abbia mai fatto in tutta la vita. Non l’avesse mai detto. Nel viaggio successivo superò di 480 km il limite raggiunto dal suo predecessore John Davis, stabilendo un record che resistette 236 anni come il punto più a nord mai toccato in quel mare (circa la lat. 77° 45’N). Forte della sua inaspettata carriera lampo, Baffin tornò a Londra tutto tronfio, con un gilet nuovo e i pollici sotto le ascelle (provate a mettervi i pollici sotto le ascelle con i palmi delle mani rivolti verso l’altro e capirete con che spocchia William toccò la terraferma) ma, per un caso talmente incredibile da essere riportato in tutti i libri di storia, la giuria che doveva convalidare le scoperte e conferire onore al merito dell’esploratore era composta da due vecchie conoscenze di Baffin: l’unico poliziotto così poco reattivo da farsi effettivamente mettere fuori combattimento da una manciata di sabbia negli occhi e l’unica pensionata talmente disattenta da farsi derubare 55 da un moccioso con dei granelli di sabbia che gli uscivano dalle tasche (cfr. la turbolenta gioventù del ragazzo). Che beffa. Le scoperte di Baffin vennero messe in dubbio fino al 1818, anno in cui il capitano Ross se ne prese tutto il merito pretendendo di essere un suo lontano bisnipote, mentre in realtà era solo un mitomane, e il povero William morì per le ferite riportate durante una battaglia in una città di cui non sapeva né pronunciare, né scrivere correttamente il nome: Qeshm. Ma dopo la Q ci va sempre la U, pensava, e qui c’è una E. Qe confusione! e in quel momento lo trafissero con una baionetta dicendogli: mo’ studiati questa, secchione. La corsa alla scoperta del Passaggio a Nord Ovest però non conosce rimorsi e, vista la conclamata incapacità del capitano Ross, fu Sir John Franklin a prendersi sulle spalle tutta la spedizione. Equipaggiò due barche e partì alla volta di quella che gli abitanti del luogo avevano bonariamente chiamato, per sfregio, baia di Baffin. Non l’avesse mai fatto. I ghiacci gli si chiusero attorno, i vascelli intrappolati nel gelo invernale, scarsi razionamenti, poca acqua e aria di ammutinamento. Non sapendo bene che pesci pigliare, Sir Franklin decise di aspettare l’estate e il conseguente disgelo e, per passare il tempo, iniziò a mercanteggiare con gli indigeni per garantire cibo sufficiente a tutta la ciurma. Il capitano però era un gran taccagno e aveva i forzieri pieni solo di bigiotteria di scarsa qualità perché non si sa mai, hai visto come è andata a quel Cristóbal Colón che con qualche specchietto e una manciata di perline si è preso Cuba e San Salvador. 56 Per non saper né leggere né scrivere, Franklin accettò una partita di cibo scaduto conservato in contenitori metallici in cambio di un paio di orecchini con la clip (così non vi dovete fare il buco) e due specchi tascabili. Il metallo dei contenitori era piombo, i 143 membri della spedizione mangiarono per tutto l’inverno viveri scaduti e intossicati dal piombo e morirono di mal di pancia. Qualche anno fa alcuni esploratori, mentre ridevano a crepapelle davanti all’insegna “Baia di Baffin”, inciamparono su un oggetto contundente metallico che affiorava dal terreno e scoprirono il corpo di uno dei marinai perfettamente conservato nel ghiaccio vicino a un contenitore di piombo. Da qui ricostruirono fantasiosamente tutta questa storia. Solo nel 1906 il Passaggio a Nord Ovest fu davvero conquistato. Il merito è del vostro futuro idolo Roald Amundsen. Roald Amundsen era uno spendaccione norvegese con manie religiose – è grazie a lui e alle sue stimmate autoinflitte che da allora gli scialacquatori vengono apostrofati mani bucate – famoso per essere il bersaglio preferito dei creditori del villaggio. Roald era affetto da una strana cleptomania al contrario: non riusciva a non comprare qualsiasi cosa vedesse. Sua moglie aveva provato di tutto: tenerlo in casa, portarlo in supermercati poco forniti, impedirgli di maneggiare denaro, convincerlo a rubare, ma niente. Il suo ingegno era talmente fine che fu lui ad inventarsi i “pagherò”, solo che allora non venivano scritti su una cambiale ma detti a voce, e la riscossione era più difficoltosa. 57 Un bel giorno il buon Amundsen, mentre la moglie dormiva, decise di fare una piacevole passeggiata. Non l’avesse mai fatto. Girellando vicino al porto, gli capitò sotto gli occhi un peschereccio per aringhe di 47 tonnellate. Oh-oh. In pochi giorni raccattò un equipaggio promettendogli denaro se la spedizione fosse andata a buon fine, comprò la barca senza avere i soldi neanche per permettersi l’ancora e partì di tutta fretta per sfuggire ai creditori imbufaliti che si erano un po’ stufati dei suoi pagherò e pretendevano almeno che glieli mettesse per iscritto. In pochi mesi Roald riuscì incredibilmente a raggiungere il Passaggio a Nord Ovest e superarlo, mandò un telegramma a casa per raccontare l’impresa e decise, saggiamente, di rimanere al di là dell’Oceano, così, per sicurezza. Nel 1944, poi, una spedizione canadese riuscì a completare la traversata in una sola stagione ma è nel 2002 che bisogna ringraziare il vero eroe, colui che ha finalmente permesso di utilizzare il Passaggio a Nord Ovest per fini commerciali: il riscaldamento globale. Grazie al riscaldamento globale, infatti, il ghiaccio si è ridotto di circa trenta milioni di chilometri quadrati e ormai dal Passaggio a Nord Ovest ci passi anche in gommone. E pensate, il riscaldamento globale, non pago, ha aperto anche il Passaggio a Nord Est, ed era da secoli che nessuno ci riusciva. Ma questa è un’altra storia. 58 Chiara Reali Le pendu Ho risposto al telefono. Ho annuito mentre la voce all’altro capo del filo diceva, Albergo a cinque stelle, turisti inglesi, due bambini, ti aspetto tra un’ora. Ho appeso e l’aria era densa, ogni gesto mi costava fatica, ogni gesto lo osservavo con occhi da mosca e lo vedevo scomposto in migliaia di azioni e il movimento non riusciva a partire, frenato dall’incedere di tutti i sessanta minuti che zoppicando girano intorno alle sessanta tacche dorate dell’orologio. Rispondo al telefono una prima volta e la voce che non conosco dice mia madre, il suo nome; io: No, sono Giada; all’altro capo, silenzio, neanche un respiro, solo gatti che miagolano o un bambino che piange. Di nuovo il nome di mia madre seguito da un punto di domanda. Io, ancora: No, sono Giada. La voce si limita a dire: È morto. Ci pensi tu a dirlo alla mamma? Se vuoi te la passo. Ok. Ho salito le scale di corsa, ho aperto l’armadio e frugato i vestiti: qualcosa di comodo, qualcosa di elegante, qualco- 59 sa di comodo e di elegante, un abbigliamento adeguato, non sfigurare, non dare nell’occhio, essere libera nei movimenti. Sono arrivata all’appuntamento con qualche minuto di anticipo. Mi sono fermata all’angolo della strada e ho deciso di fumare una sigaretta guardando l’attesa lampeggiare sul display del telefono. Quando si accende una sigaretta il tempo che manca a volte dura un po’ meno, in stazione o alla fermata del tram, per esempio, al ristorante quando ancora si poteva fumare. Il tempo digitale scorre a scatti, non ha vie di mezzo, nessuna approssimazione; privilegia la precisione della misura alla sua rappresentazione, alla lancetta che stenta oscillando, al suo movimento continuo. La natura del tempo mi sfugge – tempo digitalizzato – perdo la concezione di infinito seguendo gli ottantaseimila e quattrocento momenti in cui è divisa la mia giornata. Infinito precario, infinito a tempo determinato, sono troppo giovane, sono troppo vecchia, sono troppo qualificata, sono troppo inesperta, è fidanzata o sposata? Ha intenzione di avere dei figli? Automunita? Dinamica? Crede nella nostra mission? Guarda al futuro? Guardo al passato, lo annuso. L’odore della casa, ricordo l’odore della casa. Scendo le scale e porgo il telefono a mia madre che dice, 60 Ero stata da lui domenica. Nina, cuma sté el to pà?, mi aveva chiesto, e io non capivo se era lucido o meno, dice. Non capivo, non sapevo più cosa dire… E poi cosa hai fatto? Sta bene, gli ho detto. Mio nonno morto in un lago di sangue sulla moquette di un negozio di scarpe. La donna è arrivata a piccoli passi veloci e stretti come la gonna che stava indossando, con un cenno mi ha salutata, mi ha allungato un pacco avvolto nel cellophane. Buon lavoro, mi ha detto, io ho ringraziato e tenendo il pacco in equilibrio sugli avambracci ho cercato di imitarle il sarcasmo ed è stato più facile di quanto pensassi, è bastato pensare al curriculum che ho presentato: maturità classica, laurea, ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato, conoscenze informatiche, disposta a viaggiare, disposta a tutto. Ho affondato le unghie nell’involucro di plastica: Alla prossima volta. Me ne sono andata. Mi sono accesa ancora una sigaretta. La cantina di funghi e castagne seccate al sole, i fucili e il cane e i fagiani e i pallini di piombo e il sorriso di soli due denti, ricordo. Mia madre mi dice, Quando andavo a trovarlo mi stupivo sempre di quanto si somigliassero: da giovani no, non così tanto, ma poi… e lo guardavo e pensavo, Adesso mio padre sarebbe così. 61 Te lo ricordi, il nonno? Me lo ricordo. Ricordo quando uscivamo col cane. Ricordo la sedia sulla quale sedeva. Mio nonno morto in un lago di sangue sulla moquette di un negozio di scarpe. Mi manca – non dice, lo agisce. Io resto, ascolto, aspetto. Lei mi ripete, Ero stata da lui domenica scorsa, Nina, cuma sté el to pà? Prende il telefono e chiama mio padre, mia zia, mia sorella, ripete le stesse le stesse le stesse parole, poi esce. Sedevo in braccio a mia madre, la ascoltavo raccontarmi della sua infanzia, socchiudevo gli occhi per rivederla bambina correre in mezzo alle foglie affilate del granoturco. Ma tu che lavoro fai, le chiedevo, Adesso che hai smesso di lavorare? E lei rispondeva, La casalinga, si lamentava: Non ci sono vacanze, non vengo pagata, i miei sforzi non sono riconosciuti, e io non capivo, cambiavo argomento. Mi dici di nuovo di quella volta che la mucca è scappata? Chiedevo, e lei ricominciava, mi sembrava di sentire la corda ruvida tra le mani, l’odore di fieno e di sterco, mi sembrava possibile che fosse stata bambina, avremmo potuto essere amiche, anch’io avrei potuto avere una mucca e portarla al guinzaglio. Ho risposto al telefono. Mia madre. Vai a prendere il pane. Sì. 63 Com’è andata? Bene. A che ora torni? Non lo so, mamma. Ci vediamo domani. Domani lavoro. A presto. Ciao. Le mani di solchi di terra, il calendario di Frate Indovino, le caramelle alle erbe, le sedie impagliate, il telefono appeso al muro e la Madonna trasparente di acqua santa, le mani della moglie affondate nelle tasche del grembiule, brava tusa, il maglione dei giorni di festa che mi pizzica il collo, ricordo. Resto in piedi, il movimento congelato. Cosa devo dire? Cosa devo fare? Cosa devo provare? Era l’ultima delle radici su quelle colline che ho imparato ad amare. Gli ho parlato di te, mi dice, Gli ho detto che vuoi andare a vivere lì, tornare. La mia collina è tutta nelle ombre che ancora si muovono vicino al pollaio e al lavatoio, accanto alla ruota ad acqua e giù, nella piazza. La mia collina è tutta nel cortile che non ha muri, steccati, recinti, solo un cancello con il chiavistello, Chiudi bene oppure entra il vento. Un muro c’è, ma si scavalca o ci si siede a mangiare l’uva americana e le bucce si possono pure sputare nell’orto, è concime. Un lato è delimitato dal fiume, si salta in un passo e se ti 64 tiri su i pantaloni, ti levi le scarpe, puoi camminarlo fino alla strada che è dove la collina finisce. Esce, la porta chiude fuori mia madre, io resto. Non parliamo mai della morte ma ho sempre capito: è una cosa di cui si deve avere paura. Un giorno ha deciso che era rimasta a casa abbastanza, è andata all’ufficio di collocamento e ha detto, Voglio un lavoro. Gli impiegati si sono messi a ridere, a dire, Alla sua età! Ma alla fine ha trovato un posto e un altro prima di questo, serve ai tavoli e si lamenta: non ci sono vacanze, non mi pagano abbastanza, i miei sforzi non sono riconosciuti. Ho appoggiato il pacchetto incellofanato sul sedile, lato passeggero, insieme alla borsa e alla giacca e al tuttocittà. Il giorno del mio ottavo compleanno ho accompagnato mia madre a dare l’esame di licenza media. Mentre passavamo su questo ponte, sul ponte che sto attraversando adesso, a ventiquattro anni, con una mano sul volante e una sulla plastica del pacco, mentre passavamo su questo ponte mi raccontava di quando era scappata di casa e si era nascosta nella cuccia del cane. Viveva con la mia bisnonna, che per me è una fotografia in bianco e nero incorniciata d’argento, e io guardavo fuori dal finestrino. Mi dici di nuovo di quella volta che la mucca è scappata? Dopo. 65 Allora l’ho aspettata in macchina, ho disegnato una mucca sul vetro appannato. Rispondo al telefono per la seconda volta e una voce che conosco dice il nome di mia madre. Io: No, sono Giada, C’è la mamma? dice la voce – è una voce che non mi piace e non mi è mai piaciuta. No, è uscita. Forse dovrei, penso; dico: Te lo ricordi? È morto. Silenzio. Inizio a parlare con questa voce che conosco che appartiene a una persona che non conosco, con la quale non ho mai parlato. Mia madre ha passato l’esame. Ti ricordi la gerla cos’è? Mi chiede, e io annuisco, io non capisco, La mucca, dov’è? Allora, ha iniziato, come a dire, C’era una volta, ogni mattina la tua bisnonna la riempiva e scendeva in città, a piedi, per vendere le uova e la verdura e la frutta, ogni mattina partiva alle quattro. Poi, un giorno – era una domenica e lei aveva il grembiule sopra il vestito buono e versava il vino agli uomini che giocavano a carte sotto il pergolato – un giorno le dicono, c’è un lavoro in un’altra città, un lavoro migliore, ma è una città lontana, non si può andare a piedi. Ti presto la bicicletta, dice qualcuno, ma lei non era mica capace di andare in bicicletta. Ha imparato lì dove hai imparato tu, nel cortile; ogni 66 mattina scendeva in città, a piedi, per vendere le uova e la verdura e la frutta e poi la sera saliva sulla bicicletta, imparava a pedalare e curvare e frenare e il tuo bisnonno la reggeva dai fianchi. La voce che non mi piace tace. Io vomito parole e ogni volta che la conversazione sta per spegnersi faccio domande per tenerla accesa, per non stare sola, per sentire una voce, anche la voce che non mi piace va bene. Mi reggo in equilibrio su un piede, poi su quell’altro, disegno spirali nere su un foglio e parlo e parlo. Ti faccio richiamare appena – Sì. Le devo dire qualcosa? No. Non smettere di parlare, non smettere di riempire il silenzio. Mi sono fermata a lato della strada, ho pigiato il bottone che fa lampeggiare le quattro frecce. Devo girare a destra, poi fino alla rotonda, poi ci sono i cartelli, ha detto la donna, noi le conferiamo la laurea di dottore in psicologia; ho girato a destra, poi fino alla rotonda, ho seguito i cartelli, ho parcheggiato. Stanza centodieci, ho chiesto, primo piano. Il pacchetto l’ho messo dentro la borsa, centouno, centodue, mi sono fermata, l’ho aperto, mi sono infilata il grembiule a strisce bianche e verdi, mi sono appuntata sul seno la targhetta di riconoscimento, ho bussato. Buona serata, ho salutato la coppia di turisti e ho salu- 67 tato i bambini, Fate i bravi con la baby sitter, e quando si è chiusa la porta sapevo già cosa fare: ho raccontato di quella volta che la mucca è scappata. Il funerale è dopodomani, dice mia madre. Io, seduta in poltrona, mi dondolo sui talloni, mi concentro sullo spazio bianco che c’è tra le righe. Penso: mio nonno morto in un lago di sangue sulla moquette di un negozio di scarpe. Mi è venuta in mente una cosa, mi dice, sorride: il sorriso lo sento prima, poi lo vedo quando alzo la testa dal libro e dico, Che cosa? La storia della spusìn, mi risponde, Te l’ho già raccontata? Non mi ricordo, mi sembra di no, le rispondo; apro il quaderno e prendo la penna: Racconta, la invito. Si siede in fondo al letto e socchiude gli occhi e poi dice: La chiamavano spusìn perché era vuncia, vuncissima. Io non capisco e chiedo, Perché? Mi spiega, Ma sì, è come un nomignolo all’incontrario, come il catòlich che era così comunista che gli hanno fatto i funerali civili per via del diritto canonico, così la spusìn era l’opposto di quello che dice il suo nome. Mi spiega dove abitava, la spusìn, due stanze, con il marito e i tre figli magri come dei cani; avevano sempre fame e mai niente da mangiare, dice, Poveri cristi, lui lavorava e lavorava ma non avevano niente. Poi si ferma, controlla. Stai scrivendo? Ci scrivi un libro sulla collina? Io rido e rispondo, mi piacerebbe, disegno la casa e la vite e il sentiero che scende alla roggia, la spusìn sulla soglia vestita di nero, le ombre diagonali che dividono il foglio a metà. 68 Quando scese scricchiolando il ballatoio di legno – aveva il pigiama verde che le avevano regalato a Natale e ne reggeva in vita i pantaloni un po’ troppo larghi, per la crescita –, lei dalla cucina contò i suoi passi, imbracciò la pagnotta nera – per questo odorava sempre di farina – e la grattò col coltello in scaglie tutte uguali che, ammollate nel latte, facevano la colazione. Stropicciando gli occhi la bambina si sedette e afferrò la tazza con entrambe le mani; se fai silenzio tra poco si sente la corriera che si arrampica lungo i tornanti, senti? Pulè, pulè, risero insieme, poi la bambina si fece seria. Ho fatto un sogno bellissimo, disse. Indossavo un vestito verde e nei capelli avevo nastri azzurri. Lei scosse la testa e, Impossibile, disse: i sogni sono bianchi e neri soltanto, a volte grigi o di seppia come le facce arrabbiate dei morti al cimitero, ma la bambina insistendo, I miei sono a colori, il nero è nero e il bianco è bianco, ma i ranuncoli, gialli, la strada di piccole pietre rosse e aguzze. Non ci credo, disse lei. Li colori al risveglio, ma la notte non c’è luce abbastanza. Non gli dava da mangiare, dice, ai figli, e nemmeno al marito, ma sempre si sentiva quel rumore: siamo a tavola adesso, con la matita mi sono raccolta i capelli, prende la forchetta e la sbatte nel piatto, tin, tin, tin. Come si può scrivere questo rumore? Penso ad alta voce. Non lo so, risponde. Mi sciolgo la crocchia e appunto, forchetta, piatto. Cos’era? Le chiedo. 69 Lei mi ferma con la mano aperta come per dire, con calma, pazienta, come a dirigere il traffico dei suoi pensieri e dei miei. Adesso ti spiego. Mia nonna tendeva l’orecchio e ascoltava, tin, tin, tin, dietro ai muri spessi. Diceva, La spusìn deve aver preso la Singer da cucire – indica la sala –, come la nostra – quando ero piccola mi sedevo per terra e schiacciavo il pedale coi pugni per fare girare la ruota – e invece, mi dice, salta fuori che era lei che si preparava la rusulada, l’uovo fresco sbattuto con lo zucchero, e se la mangiava golosa schioccando la lingua mentre i tre figli e il marito morivano di fame. La bambina mise il broncio, ma lei disse: Scendiamo al mercato, è martedì, prendiamo la corriera, pulè, pulè, e finse di guidare. Se c’è il sole ci mettiamo sul lago e salutiamo la mamma dall’altra parte. Vai a vestirti, brava. La bambina corse via. Andiamo, andiamo, gridò; gridò, Mercato! E alla fermata lei le strinse la mano perché non saltasse in mezzo alla strada, eccitata com’era. La senti che arriva? Fai sentire come fa la corriera, e la bambina: Pulè, pulè, e ridevano tutti. Lei si disse che forse era vero che i sogni, negli anni Cinquanta, erano gialli e rossi e degli altri colori; in fondo, tra tutte le donne, solo loro, canute, vestivano ancora di nero, le altre adesso avevano gonne e camicie sgargianti, non solo la Piera che i giovanotti le stavano dietro e la pizzicavano quando si chinava sul bancone 70 del bar, e lei rideva buttando indietro la testa e i riccioli biondi, ma anche le altre, quelle per bene – pulè, pulè, la corriera è arrivata. Raccontando si perde. I ricordi si richiamano l’uno con l’altro e io mi confondo, le chiedo: Per favore, una storia alla volta. Lei aggrotta la fronte e mi dice, Se non te le dico in questo modo, in questo momento, finisce che poi le dimentico tutte, e quando non ci sarò più chi ci sarà a raccontarle, ‘ste storie, che fine farà la casa di ieri che c’è sotto alla casa di oggi – mica era così, una volta, una volta era diversa, c’era il legno e l’uva di Santa Teresa che la coglievi e la mangiavi sporgendoti dalla finestra – che fine faranno la stalla e la tampa e il mattone nel letto, per riscaldarlo, la mia infanzia e il mio passato che è il tuo? Mia nonna le ha raccontate a mia madre, mia madre le ha raccontate a me e io a te le racconto. Va bene. Tu non avrai figli, dice, sospira: a qualcuno le devi raccontare lo stesso. Sita e sculta! Mi dice, Un giorno la spusìn va alla roggia a sciacquare i panni. Li strofina sui sassi piatti finché, all’improvviso, non sente un rumore come di un frutto che cade, proviene dal casolare. Apre la porta che cigola e vede la sedia per terra, il marito appeso alla trave. Inizia a gridare e si aggrappa, grassa di zucchero e uova, alle ginocchia magre di lui, e cade, sempre aggrappata, e poi si rialza e grida e gli prende i piedi e tira e tira e tira. 71 La trovano così, i vicini, che per salvarlo lo uccide, e c’è chi la consola e c’è chi ride di lei, nessuno le dice la verità – te la sto dicendo io adesso, a me l’ha detta la nonna, ma lei, la spusìn, non l’ha mai saputa. Sulla corriera, tornando dal mercato, la bambina appiccicata al finestrino salutava i passanti. La prese per mano, scendendo, e si incamminarono per la strada rossa di sassi aguzzi, pulè, pulè, una curva, un tornante, in fondo al quale videro uomini vestiti di nero. Intorno all’albero in mezzo al cortile qualcuno aveva disteso dei teli, una donna reggeva la spusìn che gridava il nome del figlio; come un’ombra cinese, l’appeso ondeggiava ed era un principe o un pupo o un salame, era insieme tutte le cose e nessuna. Lei strinse la bambina al grembo, sulla gonna ampia e nera, perché non vedesse: le chiese, dimmi ancora del sogno, la ascoltò elencarne i colori. Mio nonno morto in un lago di sangue sulla moquette di un negozio di scarpe mentre in palestra correvo stringendomi il seno che stava spuntando. Mia madre fuori dal vetro che piange e non riesce a chiamarmi e io corro, continuo a correre in tondo. Mio padre che parla con lei un linguaggio segreto e poi dice, tranquilla, il nonno sta male ma è in ospedale, lo stanno curando – mia madre che piange più forte. Mio nonno che non torna più a casa, neanch’io torno a casa, resto a dormire a casa di amici. Nessuno mi ha detto, È malato, nessuno mi ha detto che è morto, mio nonno 72 è partito e forse un giorno lo incontro in collina e gli chiedo, Ma allora? Perché sei scappato? Lui, piegato nell’orto che ci sente arrivare e si alza e sorride il sorriso a due denti soltanto, ricordo. 73 Alfio Génitron Fidarsi Il sabato pomeriggio nell’area del centro polifunzionale Le Vele sistemato nella prima cintura di Cagliari, nei territori di Quartu Sant’Elena e Quartucciu, le mamme spingono carrozzine, i papà carrelli pienissimi, i ragazzini mangiano gelati al pistacchio e quando hanno finito si rincorrono in galleria, quelli più grandi si baciano davanti alle vetrine dei negozi, poi ci sono i giochi coi gettoni per i più piccoli, esposizioni di quadri e ceramiche e legno lavorato a mano, a volte concerti e presentazioni di libri, balli di gruppo, spettacoli, tornei di Risiko e corsi di cucito. Da Roma hanno fatto sapere che doveva sorgere un ipermercato + centro commerciale + multisala cinematografica. E questo centro polifunzionale doveva sorgere alle porte di Cagliari, nei comuni di Q e Q. «A Cagliari no, ce ne sono già due» ha detto Flori. «Pensate a tutto voi?» «Sì.» «Da Roma vogliono solo un pezzo di terra.» «Anche il nostro partito ha detto pensate a tutto voi.» «Anche il nostro.» «Francesi e americani?» «Anche italiani. Perfino sardi.» «A noi non interessa chi costruisce.» 75 «Ho il nome per il progetto.» «Manca il piano del traffico.» «I parcheggi sono pochi.» «Pensate a chi dare in gestione i negozi.» «La direzione è dei repubblicani.» «Esistono ancora?» Il lavoro – sebbene in forma impiegatizia – l’ha deciso la terra: gli occupati di Q e Q sono stati scelti in base alla porzione di terreno concesso dai due comuni per la costruzione del centro polifunzionale Le Vele, chiamato così perché davanti all’ingresso principale ci sono tre vele di dieci metri quadrati l’una, che si incrociano e puntano verso il cielo, tenute su da tubi innocenti di quelli che quando tira vento si muovono appena; mentre le vele – secondo Fulco – soffiano solo quando c’è vento, e si sentono. «Da qui, invece, potete vedere il mare, seduti su questi tavolini si vede lo stagno, viale Poetto e poi il mare.» «Una bufera, un vento mai visto che si porta via tutto quanto trascinando vele e tubi fino allo stagno, o addirittura fino al mare, attraversando la strada e la spiaggia che separano lo stagno dal mare.» «Il mare, se ti prendi un caffè nel bar del centro polifunzionale, il mare lo puoi anche vedere, e se c’è vento vedi pure la schiuma che fanno le onde e sulle vetrate del bar si depositano delle minuscole goccioline che se ti avvicini sembrano cristalli di sale.» Nella rotonda hanno ricavato un parcheggio perché quelli del centro polifunzionale non bastano mai: 76 «Quanto deve stare?» «Credo un paio d’ore.» «Facciamo due ore?» «Facciamo due ore» risponde Fulco. «La metta dentro, la ricevuta, nel cruscotto. Non si sa mai.» Fulco la mette dentro, nel cruscotto. Non si sa mai. Esce dalla rotonda-parcheggio del centro polifunzionale e dove non c’è il marciapiedi è costretto fra le macchine in fila col motore acceso: non si capisce dove sia la coda della fila né la testa, parcheggi liberi ce ne sono dentro la rotonda, e anche fuori, per esempio questo è un parcheggio, e pure questo; Fulco non capisce, li guarda uno per uno incazzati come sono quando aprono lo sportello e in piedi vìsano davanti, macchine su macchine una dietro l’altra, che curvano oltre la multisala cinematografica e pare proseguano fino all’ingresso dell’ipermercato del centro polifunzionale. Fulco è diretto lì, all’ipermercato, deve fare un esperimento. Le luci dei parcheggi del centro polifunzionale Le Vele sono essenziali, il tanto che basta per aprire la portiera della macchina, scendere o salire. Se invece ti giri verso il complesso commerciale che ospita senza soluzione sia la galleria dei negozi che la multisala che l’ipermercato, è tutta un’esplosione di colori e suoni. Ormai la giornata si è scurita, ma da questa parte no: dalla parte del commercio, se ti giri e ti fermi, è ancora giorno. Fulco però non si ferma, ha soltanto due ore per l’esperimento, poi scade il parcheggio. Non gli serve nessun carrello, la porta girevole accompagna il suo ingresso e 77 dentro sono rumori di voci, canzoni, scontrini, carte di credito che sfregano, annunci di sconti e promozioni imperdibili, sirene, buste che si riempiono, carrelli che sbattono, pattinatrici vestite di rosso con gonne troppo corte e mariti che le seguono solo con gli occhi, le gonne, e col carrello della spesa manca poco che buttano giù l’enorme albero di Natale sistemato all’ingresso, pieno zeppo di palline, che quando rimbalzano fanno sempre lo stesso rumore, da quando Fulco era piccolo e ci giocava a tirarle sul muro le palline dell’albero di Natale, e sua madre s’incazzava: «Fulco, la vuoi finire?» gridava. E lui cercava di fare più piano, di lanciarle piano sul muro, ma il rumore era sempre quello, sempre lo stesso e la madre lo sentiva e si alzava dal letto e gli prendeva le palline e accompagnava Fulco in camera tirandoselo per un braccio: «Stai fermo, guarda la televisione o mettiti a fare i compiti, purché stai fermo.» «Ma io mi sto annoiando» rispondeva Fulco. «Ecco» diceva lei, «annoiati in silenzio.» La madre di Fulco, da quando Mariolino è morto cerca di nascondere la sua preoccupazione più grande, quella di essere sbattuta fuori dalla sua casa da un giorno all’altro. È vero, quella casa è sua, l’ha riscattata con i soldi che le hanno dato quando è morto il marito, ma a quanto pare, le ha detto Mariolino prima di iniziare lo sciopero della fame e morirci nel giro di una settimana, a quanto pare gliela possono togliere per pubbli- 78 ca utilità. E lei non lo capisce cosa sia pubblica utilità, non si capacita che possa esistere una pubblica utilità maggiore della casa: «Garantire una casa è pubblica utilità, non un centro polifunzionale» ha detto la mamma di Fulco alla radio. «Non mi dica che non c’è mai entrata?» «Mai entrata.» I piatti e la grancassa, una volta percossi, vibrano per poco. «Questa è Ionisation di Edgar Varése.» Fulco, al contrario della madre che la spesa la fa ogni giorno nelle botteghe vicino casa sua, compra il pane, un po’ di verdura, a volte la carne, il venerdì un pesce azzurro da fare bollito, Fulco la spesa la fa qua, nell’ipermercato del centro polifunzionale Le Vele, e compra tutto in offerta: una volta ha comprato cinque pacchi grandi di caffè che contenevano quattro confezioni da 200 grammi, e l’ultimo pacco l’ha dovuto buttare perché nel frattempo – dopo quasi un anno – era scaduto. Non beve molto caffè; se ne bevesse di più, non molto ma poco di più, non sarebbe scaduto. Si è detto questo, Fulco, mentre lasciava cadere l’ultimo pacco di caffè nel sacco dell’immondizia: «Se bevessi più caffè, non molto ma poco di più...» Se bevessi più caffè, Fulco se l’è ripetuto fino a trovare dentro quelle parole un tono di rimprovero quasi piacevole. Ma il caffè, con l’esperimento, non c’entra nulla. Per il suo esperimento Fulco ha scelto il dentifricio. Cammina fra gli scaffali e vede carrelli pienis- 79 simi e sente un vociare costante che non ha un nome – infatti, se ci fai caso, parlano in pochi mentre fanno la spesa e lo fanno a bassa voce. Fulco prende un tubetto di dentifricio per ogni marca, alla cassa ne conta undici e per la cassiera sembra una cosa normale; passa l’ultimo tubetto, totale, trentasette euro e dodici centesimi, la cassiera si raccoglie i capelli tenendo la forcina in bocca, gli occhiali sono sporchi, lo smalto sulle unghie è smangiato; Fulco le dà due banconote da venti, si apre la cassa, esce lo scontrino, lei appoggia lo scontrino e il resto e inizia ad afferrare le robe del cliente successivo. Con la sua busta di dentifrici, Fulco si sistema poco fuori le porte scorrevoli, vicino ai carrelli che le donne tirano fuori dalle guide e lasciano all’uomo il compito di spingerli per tutto il centro polifunzionale. Mi fermo qui – pensa Fulco. Mi piace. Mi fermo qui e aspetto di regalare la prima confezione di dentifricio: guardi signora – dirò – che io sono un gran consumatore di dentifricio. Sa quante volte mi lavo i denti in un giorno? Conosco tutti i segreti. Lei sa cos’è un dentifricio? Di cosa è fatto… Signora: di cosa è fatto un dentifricio? Ci mettiamo questa cosa nei denti, ogni giorno, chi più chi meno, senza nemmeno chiederci cosa ci sia dentro. Ci fidiamo: appena svegli, dopo pranzo, dopo cena, prima di uscire: strizziamo il tubetto sulle setole dello spazzolino e via di igiene orale. Io lo so cosa mettono dentro il dentifricio commerciale per pizzicare la lingua a quel modo, e anche per questo non lo uso più; da un’azienda siciliana mi faccio spedire un 80 prodotto che ha la stessa forma del dentifricio ma dentro, il sapore, è un’altra cosa. Molto più schifoso, però. «Salve signora, posso regalarle una confezione di dentifricio?» «No grazie.» «Non lo usa?» Non risponde, stringe il carrello e si tiene la borsetta con l’altra mano e punta dritta le porte scorrevoli; è sola, non ha un uomo accanto, forse ha avuto paura; forse, dovrei essere meno invadente – si dice Fulco – e strillare di meno, magari chiedere scusa invece di salutare: scusi signora e non salve signora, scusi se la disturbo signora, comprerà un dentifricio, oggi? glielo regalo. «Scusi signore.» «No grazie, non mi serve niente.» «...» «Grazie lo stesso.» «Prego.» Lo vedono assieme scrivere su di un taccuino davanti all’ingresso dell’ipermercato, lo vedono assieme e poi devono dirselo complici con gli occhi, quasi vicini; lo spingono assieme il carrello e quando Fulco alza la testa dai dati dell’esperimento si guardano di nuovo, lei, lui e Fulco, che senza parlare porge la scatola di dentifricio in direzione dei due: lei, lui, la scatola di dentifricio sulla mano di Fulco, e infine Fulco che sorride quando la mano di lei si allunga, prende la scatola e la butta dentro il carrello vuoto; la scatola, quando 81 sbatte sull’acciaio del carrello, fa un rumore piacevole, di cartone. Non si accorge Fulco che lui lo guarda, scarrella dieci metri e lo guarda, fino alle porte girevoli dell’ingresso. Fulco annota sul taccuino: il dono | dentifricio | uno su tre dopo dieci minuti | senza parole. Raccoglie la busta e si dirige verso il cinema. Ha ancora un’ora di parcheggio. E potrebbe incontrarla, e raccontarle dell’esperimento. O regalarle una scatola di dentifricio. [traduzione di Lautino Crippa] 82 Jacopo Nacci In merito alla terapia All’epoca la documentazione fotografica sul pianeta era già abbondante, fioriva in concomitanza con la Nuova Sensibilità: su centinaia di posizioni dello spazio dialogico dedicate al movimento di recupero si pubblicavano immagini sia della superficie dell’oceano e del mondo sommerso, sia di oggetti dalle più svariate fogge e funzioni, insieme a testi che ne ricostruivano la storia, spesso in un modo che appariva fin troppo evocativo e fantasioso anche a chi non avesse argomenti e conoscenze da opporre. Tuttavia, malgrado la mole di illustrazioni, quando entrammo nell’atmosfera mi resi conto che sin da bambino avevo immaginato un unico oceano indiviso e nessuna fotografia aveva mai realmente modificato la mia fantasia: era come se le fotografie ritraessero un altro luogo, un’altra cosa. Invece, una volta penetrati nel rosa profondo dell’alba, scorgemmo le montagne arse dal sole spiccare nell’aria e fummo in grado di vedere anche i fondali più prossimi alla superficie, i continenti di quel mondo, solo più velati d’azzurro dei nostri: aree verdi scuro e marroni, o grigie, ricoperte dalla sottile lastra dell’acqua. Scendemmo ancora, e quello che fino a un istante prima era stato il contorno del pianeta divenne il nostro orizzonte. 83 Ero curioso. Ravioli no, e non era contento. Nemmeno lui era mai stato là, ma durante il viaggio mi aveva confessato che al solo pensarci gli era sempre venuta una stretta allo stomaco. Notai che ero il solo a tenere i piedi sull’oblò principale: Ravioli si muoveva ai bordi, un rivolo di sudore gli colava sul volto pallido e contratto, guardava di sbieco la superficie marina coperta da grandi aree di nuvole rosa, a migliaia di sovrastature sotto di noi. Non erano tempi buoni, del resto oggi non è che siano migliorati, e ci si adattava a fare un po’ di tutto. Raramente fare tutto è piacevole. Per noi era la prima commissione, ma la Nuova Sensibilità era in crescita costante, era ormai chiaro che sarebbe diventata un affare vantaggioso. Ravioli se la cavava con i programmi di cartografia ed era uno studioso preparato, pensavo che una volta imparato come si faceva avremmo potuto licenziarci dall’agenzia e metterci in proprio, anche se lui nei giorni precedenti e durante il viaggio non aveva fatto altro che dirmi che, per quel che lo riguardava, avrebbe intascato i soldi e l’avrebbe chiusa lì; ma io pensavo a quei ricchi professionisti che riempivano i loro giardini imperiali di vestigia, facevano ricerche di scientificità improbabile sull’origine dei loro cognomi, sborsavano per il recupero dei reperti: me li immaginavo sedere sulle poltrone dei loro salotti come sovrani sul trono, circondati da sculture ossidate dall’acqua marina, protocomputer ricoperti da colonie di conchiglie e scheletri di mobilia preneostorica, e non riuscivo a non vederli come cancelli spalancati su immense riserve di denaro. 84 Quanto a ciò che si raccontava sugli squali e sulle loro facoltà ipnotiche, certo, non era rassicurante. Persino le loro dimensioni, che i più dicevano ridotte, meno che umane, contribuivano a generare un senso di anomalia. Però erano stati incontrati solo da una ventina di esploratori, e i recuperatori che si erano imbattuti in uno squalo si contavano sulle dita di una mano. Nessuno ne aveva mai catturato né fotografato uno, e chi ne parlava sembrava talmente sballato che i più suggerivano di non dar credito alla storia. Talmente sballato, pensai guardando Ravioli che fissava l’oblò, da provare con il suo stesso comportamento che qualcosa doveva aver necessariamente veduto. Questo non glielo dissi, a Ravioli. Né scacciai il pensiero, perché nello spazio i compagni ti servono freddi e le leggende ti fanno sopravvivere. Secondo le coordinate eravamo prossimi all’obiettivo. Individuammo la penisola, la spina gialla della catena montuosa si ergeva sulla superficie del mare per migliaia di stature. Riuscivamo a distinguere il confine tra i segni della civiltà e quelle che dovevano essere state le spiagge: potevo vedere le sabbie marroni trasformarsi gradualmente in regolari canali grigi ed edifici sommersi. Allora cominciammo a percorrere la lunga riviera dal basso in alto. Il sole era sorto quasi del tutto, entro poco tempo avremmo visto ogni cosa più chiaramente. Le coordinate indicavano che il reperto era a circa quaranta stature da noi. La navetta rallentò, calò di quota fino a una decina di stature dalla superficie e si fermò nell’aria. Mi assicurai il cavo e la bombola, srotolai la 85 scala di corda, afferrai il magnete e cominciai a scendere. Il faro del casco era acceso, ma una volta entrato in acqua mi resi conto che era vero ciò che si diceva: la flora marina emetteva una luminescenza che tendeva finemente all’azzurro e che, assieme al sole, conferiva all’acqua una trasparenza e un nitore da giorno pieno. Mi spinsi sul fondo, mi guardai attorno: il disco giallo proiettato sul continuum mi infastidiva più di quanto mi aiutasse, così spensi il faro. Il territorio attorno al reperto era stato evidentemente un parco, o qualcosa del genere: dal fondale emergevano scheletri di pietra che somigliavano ancora a panchine. Mi avvicinai a uno di essi e sfiorai lo schienale: da sotto la struttura uscì un banco di pesci trottola, che subito si dileguarono ruotando attorno all’occhio laterale. In fondo alla fila di panchine, a una dozzina di stature, il reperto era circondato da una giungla di alghe lunghe e sottili che ondeggiavano verso l’alto: sopra le punte si scorgeva solo una cunetta antracite, la sommità della sfera. Cominciai a penetrare la vegetazione. Quando il magnete iniziò a trascinarmi verso il reperto avvertii l’istinto di portare la mano destra alla pistola, ma non ne ebbi nemmeno il tempo: l’accelerazione mi fece piombare sulla grande sfera metallica, arte di un altro mondo; il suono sordo del magnete che si incollava alla sua superficie mi arrivò mediato dall’acqua e mi sembrò rimbombare ovunque. Incassato il colpo mi guardai attorno: in un mondo dove tutto ondeggia è anche difficile scorgere qualcosa, ma tutto sommato mi sembrò che tutto ondeggiasse come ondeggiava prima. 86 «Carica» dissi a Ravioli nel trasmettitore. Non ottenni risposta. Girai un’altra occhiata furtiva attorno. Tutto ondeggiava, silenzioso. «Ehi» fece l’auricolare gracchiando. «Dov’eri?» «Guardavo il sole dall’oblò laterale. Tiro su?» «Vai.» Sentii la catena tendersi, mi allontanai dal magnete facendo leva sul reperto con i piedi. «Ravioli.» «Sì?» «Quanto tempo abbiamo?» «Tre linee, direi.» «Rimango giù un altro po’.» Ravioli non rispose. La tensione della catena cominciò a estrarre la sfera dalla sua incrostazione millenaria; la vidi salire verso la superficie, farsi di nuovo tonda, giovane e bella sopra di me, resa leggera dalla forza trainante. Mi allontanai un poco dalla sua perpendicolare, poi risalii anch’io verso la superficie. Misi la testa fuori dall’acqua: sulla linea dell’orizzonte si alzava un sole ancora debole, ma di lì a un segmento l’atmosfera si sarebbe fatta invivibile. Cominciai a nuotare sul dorso, con bracciate ampie, guardando quel cielo rosa e azzurro che i miei avi avevano scrutato per centinaia di migliaia di anni. Poi mi immersi di nuovo. Il cavo che mi teneva legato alla navicella era lungo un centinaio di stature, così abbandonai la zona costiera e mi addentrai là dove era più densa la concentrazione di vestigia di quell’antica civiltà. Stavo 87 seguendo le strade di quella città sommersa quando mi accorsi, all’improvviso, che qualcosa fluttuava sotto di me, lungo il mio stesso percorso, a sei o sette stature da me, e in quello stesso istante mi resi conto, come accade talvolta nei sogni, che questo stava succedendo da un po’. Cercai di focalizzare lo sguardo, e ciò che vidi fu il cadavere di un essere impensabile. Sembrava scomposto, lacerato, ed era avvolto in un brandello d’impermeabile di plastica gialla; aveva la pancia rivolta in su, il volto rivolto verso di me, gli occhi vacui spalancati, ed era piccolo, come un ragazzino. Aveva la testa appuntita, con le branchie ai lati; aveva braccia, però incollate al busto per i polsi, e da lì le mani, o pinne molto simili a mani, si levavano lateralmente; aveva gambe, che però si univano all’altezza dei talloni, dando ai piedi la forma di una pinna di coda orizzontale, come quella di un cetaceo. La bocca era una mezzaluna rivolta in basso, e gli occhi erano subito sopra. Guardai la corrente muovere lievemente le branchie e la coda, contrarre ed espandere ritmicamente le sue membra, una, due volte, e a un tratto realizzai che quella cosa era viva e stava nuotando. Continuammo a fluttuare assieme, a poche stature di distanza. Credo sia durato almeno una linea. Ebbi la certezza che fosse una femmina, giovane, e in qualche modo bellissima. Non riuscivo a staccarmi; essere sopra di lei mi infondeva una sensazione sconosciuta di dolcezza e piacevole tensione. Fu allora che mi accorsi che ne stavo imitando i movimenti, che mi stavo lasciando andare, e che Ravioli mi stava chiamando. «Ehi. Eheei.» 88 «Sì. Sì, ci sono.» «Ti vuoi muovere? Tra un po’ qui l’aria sarà fuoco.» «Perdonami» dissi, «arrivo». Mi fermai. La creatura si fermò. Il suo sguardo non cambiava. Cominciai a nuotare verso la navetta. Prese a seguirmi, ma sempre a distanza. «Tira» dissi a Ravioli. Il cavo mi trascinò via, verso la scala di corda. Partimmo. Fuori dall’atmosfera Ravioli non sembrava ancora tranquillo. «Stare in nave con questo affare mi dà i brividi» disse guardando il reperto assicurato dalle funi elastiche, oltre la porta della stiva; poi si voltò verso di me «hai visto qualcosa là sotto, vero?». «Credo di sì» dissi. «Non voglio sapere nulla» disse Ravioli scuotendo la mano e distogliendo lo sguardo, «già se penso che veniamo da qui mi faccio schifo da solo». «Non devi sapere nulla» gli dissi io, e lo accarezzai sul capo. Per la prima volta, credo, pensai al fatto che era più giovane di me. Ora, voi dite che sembro normale: in perfetta salute mentale, dite, e questo vi lascia perplessi. Invece a me questo rassicura, ma non su di me, ché non ho dubbi su come sto, come non ne ha mia moglie: mi rassicura sugli altri, quelli che voi chiamate casi standard, insomma quelli che secondo voi hanno problemi. Mi rassicura perché so che in qualche modo loro sanno, il che è comunque meglio che non sapere; siete voi, piuttosto, 89 che non mi rassicurate, e non sapete. Sostanzialmente credo che mi sia stato sufficiente non sentirmi obbligato a pensare in termini di squali. È tutto qui. Credo che abbiate ora elementi sufficienti per trarre le vostre conclusioni in merito alla terapia. Io ve l’ho detto, state sbagliando tutto: fate domande, volete sapere, ma il punto è non farsi più domande: a quello serve l’angelo. Se gli altri sono malinconici, a quello serve l’angelo. Se ora sto bene e rido quando c’è il sole e pure se piove, a quello serve l’angelo. Quello che fate voi ora non serve, tanto meno a voi: dovreste smettere, dovreste essere felici. Posso andare? 90 Elena Marinelli Clementina Non ti piace? Lungo. A me piace, mi fa venire in mente i mandarini senza semi, a tutti piacciono i mandarini senza semi, tu ne andavi matta quando eri piccola. Clementina ha il naso piccolo e gli occhi azzurri, i riccioli neri sempre corti che le scendono sulla fronte e spesso mi guarda dormire al pomeriggio mentre mi dondolo sulla sedia del nonno in negozio, durante la pausa pranzo. Il suo è l’unico negozio che sta chiuso dalle 13 alle 15, perché il nonno non ha mai ceduto all’orario continuato, per principio. Come non ha mai ceduto agli yacht, per lo stesso principio: c’è un orario per tutto. In quello si mangia, dice e gli yacht non mi piacciono, ce le devo mettere io le barche nelle bottiglie, perciò decido io, o no? e si rivolgeva a Clementina prendendole delicatamente il mento e lei lo guardava e basta. Sui tavoli di legno del negozio e sulle mensole ci sono le bottiglie di vetro fatte apposta per tenere dentro i vascelli, le barche, i sottomarini, le pagode. Qualcuno ci mette anche gli yacht. Noi no. Il cartello diceva così da circa sei anni, era sistemato un po’ storto sulla finestra e rivolto con uno spigolo al mare. Era tenuto in un solo 91 punto da uno spillo con la capoccia nera di plastica, che finiva sul vetro con una ventosa. Ogni tanto questa si staccava, quando il sole sbatteva forte e asciugava la saliva del nonno attraverso il vetro. ‘Sta piccina non è che ci cresce muta? No, nonno, non ci cresce muta. Parlerà quando ne avrà voglia. Intanto ascolta, il che non è male per niente. A me sembra normale che parli poco, in generale, non è come gli altri bambini: se vivi con tua zia e tuo nonno non puoi essere come gli altri bambini. Lo sai anche se non te l’ha detto nessuno. Lo senti. Lo vedi. Lo ascolti. Ogni volta che ti guarda, Clementina ti sta dicendo di perdonarla, ti guarda e non dice, lo sa che vorremmo ci parlasse di più, allora chiede scusa, tutte le volte come se si sentisse già in colpa come un adulto. Non è normale che fissa. Sì che è normale nonno, ha paura che non ti svegli. Ma le dovrà passare ‘sta paura. Le passerà. Ma se comprassimo quelle cose che servono per attaccare le ventose? Quelle che hanno lo spray? Ma no, la mia saliva tiene. E poi irrimediabilmente la ventosa si stacca, cade a terra, io mi sveglio e Clementina è lì, tra le mie braccia, che mi guarda fisso. Si accoccola sempre e non me ne accorgo mai, sembra un gatto, si arrampica sui braccioli con una gamba alla volta e poi si poggia pianissimo con la testa sulla spalla o vicino al collo. Non è molto pesante, è ancora piccolina e parla poco. Ride spesso però e guarda le persone dormire, a volte ti accarezza la fronte, se la corrucci un 92 po’, col dito vuole sempre allargarti la rughina sulla fronte o quelle intorno all’occhio e mette a dormire le bambole nel suo letto mentre lei gioca con le bottiglie senza romperne mai una. Mentre dormo, ogni tanto Clementina mormora una ninna nanna facile, dice due cose e le ripete sempre, poi quando mi sveglio mi guarda fisso e so che vuole sentire una storia; a lei non piacciono le favole, vuole sentire le storie di Emma e di Teresa, sua madre, le mie, quelle del nonno e di Orazio, lo zio che ha il negozio di frutta e verdura cento metri più in là. Non le piace giocare fuori e il mare lo guarda spesso da lontano, sulla balaustra del lungomare, tra un buco di inferriata e l’altro oppure, al massimo, sul bagnasciuga quando è tardi e il sole si fa arancione come la sua maglia preferita. Quando vuole andare a casa, mi tira un lembo di camicia, se sono assorta mi chiama piano. Zia, ho fame. Cosa vuoi mangiare? Pane e pomodoro. E basta? Boh. Pane e pomodoro. Giulia cerca qualcosa sbuffando. Tiene in mano le scatole da buttare e scoperchia i cesti di vimini nel retro. Continua a cercare, prima nei cesti di sotto, poi in quelli di sopra; poi mescola i coperchi, non li chiude bene. E allora sbuffa. La guardo: io alla finestra a finire pane e pomodoro e lei lì a sudare. Giulia, che cerchi? Niente, niente, chiudi la porta che mi vedono da fuori. 93 Mi avvicino piano e guardo dentro. Non hai niente da fare? Sbircio. Non posso? No, che sbirci? Clementina dov’è? Gioca con le bottiglie. Vai. E dai ma’, che cerchi? Niente, non cerco niente. Vai. Ma è una roba per domani? Smettila. Ho capito, è per domani. Dove la porti domani Clementina? A mare, come al solito. E a giocare sull’altalena. Come al solito. Quando capirà che il funerale lei lo passa sull’altalena non le piaceranno più, le altalene. Ne abbiamo già parlato, ragazzina saccentella. Clementina in chiesa non ci viene. E io pensavo sempre: amen. Come si scrive yatch? Mmmm… y-a-t-c-h. Una sola c? Sì. E dove va la t? Prima della c. La prima volta che il nonno mise una nave in bottiglia era una zattera. Gli piacevano le cose difficili a quel tempo e la mano destra non gli tremava mai; ogni tanto la sinistra sì, ogni tanto, dice, la sinistra trema perché la destra non può, allora lei trema per tutte e due. La prima volta 94 ha messo una zattera nella bottiglia di vino rosso della cena della sera prima, pulita, tolta l’etichetta, strofinata via la colla, ci doveva mettere dentro qualcosa e non poteva permettersi modellini costosi o vele complicate. La cena era andata bene: in tavola c’era una pasta col pesce molto saporita, a parte le cozze, quelle non si sono riuscite a mangiare perché erano andate a male. La pasta era fatta in casa, cavatelli, poi pomodorini freschi e cicale, gamberi, gamberetti, gamberoni e calamari. Al nonno piacciono i crostacei: un giorno ha visto salpare una nave piena di giapponesi dal porto mentre mangiava almeno cinquanta gamberoni e senza problemi di stomaco. Era giovane, ma giura ancora oggi di farcela. Solo che non mi va. Fai bene, è che pensi di sentirti male. Clementina, non la ascoltare a questa. È invidiosa. Clementina ride, le piace sentire la storia della zattera in bottiglia, è uno dei modellini che le piacciono di più, quello con cui gioca più spesso e quello che il nonno lucida ogni mercoledì. Io non mi ci avvicino nemmeno, Giulia men che meno: noi due abbiamo il terrore di spaccare quel vetro anche solo passandoci vicino. Sarebbe come infilare due dita a fondo nei suoi occhi. Aveva assemblato la zattera pezzo su pezzo tutta la notte, dopo aver lavato i piatti, senza andare a dormire; aveva portato la nonna Emma a casa a piedi, si era fatto vedere da suo padre e poi si era nascosto per due minuti dietro il cespuglio accanto ai gerani, dove c’era buio per mandarle baci con la mano da lontano. La difficoltà più grande l’aveva incontrata verso mattina, per legare 95 insieme con il filo sottile tutti i blocchi di legno e metterci sopra la nonna, seduta a guardare verso il collo della bottiglia. Non c’era nessuna figura bruna al negozio dei pezzi, come lo chiamava lui, nemmeno una con un vestito celeste, perciò si accontentò di una castana coi capelli lisci e lunghi con un vestito ruggine. I capelli diventarono neri in mezz’ora, ma la faccia non era tagliata bene, non era quella lì, non aveva il sorriso accennato e gli occhi timidi, aveva le pupille troppo piccole e le iridi troppo chiare, non era la nonna Emma. Il nonno ci mette sempre almeno dieci minuti per pulire i colli di bottiglia perché sono stretti, le sue dita più grosse di quando era giovane e il pezzo di cotone liscio sul vetro va strisciato piano, per non farlo incrinare. I colli di bottiglia per definizione sono limitati, si stringono apposta per darti l’ebrezza della difficoltà, se non ci fossero loro, il nonno non sarebbe così soddisfatto, alla fine. Ci sono gli omini, nonno. Dove? Qui. Ci sono degli omini che corrono via dal collo di bottiglia, inciampano se non si mettono in fila indiana, si inciampano addosso perché lo spazio è troppo poco. Togli il tappo nonno. Perché? Poi ci va la polvere. Ma poi gli omini non respirano, si addormentano. Ma poi si svegliano, facciamo una sveglia per gli omini delle barche. La mettiamo sulla mensola. E se non si svegliano? 96 Certo che si svegliano. E se non si svegliano? La zattera quando ci gioca Clementina va sempre lenta; per fare tutto il tragitto della mensola, da casa fino al Capo del Mondo, come dice lei, ci mette almeno tutta la mattina e il dopo pranzo, alla riapertura delle quattro mancano solo pochi metri alla capitale vicino al mare. Prima di attraccare zattera e bottiglia, mima le manovre come le vede nel porto e si concentra, per quei minuti non ascolta più nessuno. Poi finisce, sta ferma un minuto a guardare il porto finto sulla mensola e corre via. Ma che c’ha ‘sta piccina? Niente, corre. Per tutta la stanza? Sì, nonno dai. Corre. Ma corre muta. Eh, sì, cosa deve dire quando corre? A questo punto corre via anche lui, di solito, guardandomi rivolto all’indietro. Con disapprovazione e sussurra: amen. Mentre corre, Clementina ogni tanto alza le mani a mimare un aereo, altre volte stringe un volante molto piccolo. Fa almeno dieci giri, a volte quindici, fa un po’ di rumore, poi sta ferma a lungo. Se le chiedi, ti dice che va sul deltaplano, non sull’aereo, gli aerei non le piacciono, non riesce a dire la parola aereo, si ferma alla a, e poi dice nono, è un deltaplano. La parola deltaplano le è venuta subito, la prima volta che l’ha visto su un volantino al parcheggio, c’era una 97 promozione per comprarne tre di colori diversi. Dito indice diretto e veloce e l’esultanza: deltaplano! Mamma mai. A dire mamma non ci prova nemmeno; se le chiedi di provare a dirtelo, magari prendendole il mento, come per creanza, lei sbadiglia e ritira la faccia oppure se ne va o si alza da tavola senza chiedere il permesso, prende il piatto pieno e il cuscino della sedia per andare a mangiare fuori e la violazione di quello spazio della parola non te la perdona facilmente. Eccola! Finalmente. Che ci fa nella cesta di vimini? Non lo so, stavo impazzendo. Non potevi metterne un’altra? Giulia si mette sempre la stessa camicia nera, a maniche lunghe ma larghe, con dei bottoni grandi, si raccoglie i capelli e si guarda a mala pena allo specchio, prima di uscire. La guardo che si veste, sempre di fretta, e poi la seguo in bagno e nell’altra stanza, mentre raccoglie le mie cose in giro sulla sedia e mi rimprovera il disordine. Passiamo davanti al nonno che sbuffa e sembra che russa, mentre si fa il nodo alla cravatta, dice sempre che non l’avrebbe messa questa volta, che luglio è infame, ormai l’estate è a luglio, ad agosto i camioncini del gelato potrebbero fare anche a meno di passare. Clementina è sempre arrabbiata e insofferente, non sta ferma per più di cinque minuti, non vuole le scarpe e si nasconde dovunque, sotto i tavoli e dietro le porte per non farsi trovare da me. La vesto come le pare, coi pantaloncini e non la pettino nemmeno, usciamo mano nella mano e almeno per qualche metro la sento sudata e 98 smaniosa, vorrebbe scivolarmi via ma lo sa: non è colpa mia se deve passare due ore su un’altalena arrugginita. Dondola e guarda dritto verso gli alberi del parco giochi comunale, alberi non proprio imponenti, potati male, lasciati crescere un po’ a caso davanti a un pezzo di lungomare. Riesce a stare sull’altalena per due ore esatte, prima che le scappi la pipì o abbia fame, riesce a spostare l’orario della merenda e non aver bisogno di nulla per due ore esatte. Guarda dritto verso il mare, vede onde enormi, e dentro la schiuma bambini biondi e altissimi che vanno in bicicletta sull’acqua pedalando velocissimi ma muovendosi lentissimi. Ogni tanto uno di loro urla, un altro frena col piede e fa il rumore dell’asfalto con la voce, altri ridono a crepapelle perché hanno sentito una barzelletta e nessuno affoga mai, conclude quando me lo racconta continuando a dondolare. La ruggine batte il tempo di due ore esatte, sulle giunture dell’altalena, rintocca ogni passaggio in basso e il piede di Clementina che si muove da solo. La ruggine è dura e scura, ogni anno di più, si espande ed è quasi arrivata alle maniglie; Clementina sul seggiolino ci sta sempre più stretta e io penso che dovrò inventarmi qualcosa, magari già l’anno prossimo, portarla da qualche parte, prendere la macchina, allacciarle la cintura e portarla a vedere i bambini biondi sull’acqua da qualche altra parte. Mi spiace per le sue cose che non vedrò mai. E Clementina sussurrava sempre: amen nascosta dietro la porta della sua stanza. 99 Ci dispiace per la dipartita, cari saluti e cordoglio. È di Marianna. Marianna chi? Marianna la prima moglie di Dante. Ah! Marianna. Zia cos’è cordoglio? È… è… è… è quando hai dispiacere per quel che è successo. Io non ce l’ho il cordo, cordo, cordo… No, tu no. Non è per tutti? No, Marianna lo dice a tutti noi. Tu non c’è bisogno. Com’è che si dice? Cordoglio, Clementina, ma è una parola difficile. Cordo. Cordo va bene? Quel giorno ho iniziato le parole difficili, il quaderno blu della mamma con le parole difficili. Scrivevo la data e dove le avevo sentite. La maggior parte delle parole difficili me le ha insegnate la zia e cordoglio è stata la prima. 11 luglio 1998, ho scritto, un puntino pieno, con la biro e accanto ho chiesto di scrivermi tutte le lettere in fila. Cordoglio. La seconda è stata mamma, senza maiuscola. Lo stesso giorno. Mamma l’ho detto dieci anni fa, a diciassette anni, la prima volta, da sola nel mio letto coi piedi al mare, mentre pensavo a tutt’altro. Marco m’aveva appena mollato per la mia amica riccia, ma non sentivo una tragedia insormontabile. Il primo che mi lasciava, le mie amiche preoccupate di allearsi contro Tiziana, la nostra amica riccia. Io no, io pensavo che in fondo non era così importante essere mollati. Avevo percezione 100 dei dolori grandi, io. Del cordoglio, che era l’unico dolore del cuore per me, del rimpianto, della privazione, le mie parole difficili erano queste, io non riuscivo a dire mamma, figurarsi se mi preoccupava Marco. Ero un po’ arrabbiata con Marco, sì, ho scritto mollata sul quaderno, ma l’ho cancellato quasi subito. Era naturale essere mollata, non era difficile. Nonostante tutto è stata la terza parola, l’indomani, il 12 luglio. Nonostantetutto, attaccato, pensavo fosse una parola unica, era nella frase Sta tranquilla, nonostantetutto e ho sentito la virgola col sospiro, ma non lo spazio. La quarta è stata Yatch, con la pronuncia tra parentesi, così come l’aveva scritto il nonno sotto dettatura della mamma. Io sapevo che era sbagliato, ma non l’ho mai detto. Il nonno pure lo sapeva, ma non l’ha mai corretto, Giulia non se n’è mai accorta, fino a quando la zia una mattina ha urlato: Ma è sbagliato! Da anni, te ne accorgi ora? Vabbè, ho capito, ma correggiamolo no? No. Ma perché? Ma posso scrivere come mi pare? Ma è sbagliato, è un cartello. Sta appeso fuori al vetro. Clementina, diglielo anche tu, mamma, diglielo anche tu. Io ridevo, insieme al nonno, Giulia non se ne preoccupava, stava facendo una cosa difficile coi numeri e il fisco, nella stanza di là, che è sempre stata la sua stanza. Io ogni tanto andavo lì e le arrivavo al petto e mi stendevo un po’ sulle sue gambe, prona, come un gatto, mi 101 accarezzava e andavo via. Giulia sa accarezzare. È una di quelle persone che fa le carezze giuste, ti fa sentire la sua mano per bene, non ha fretta anche se sta facendo altro, ti tocca a mani larghe la prima volta, subito per non farti scappare e poi comincia ad accarezzarti nel modo che ti serve e non è sempre uguale, dipende dal tocco di cui hai bisogno, lei lo sa che non sono tutti uguali. Il nonno è uno che conserva le cose come sono, per questo mette le navi nelle bottiglie, per smetterle di farle andare e venire. Una nave che parte non è detto che torni, potrebbe rompersi, naufragare, tornare morta. Una nave in bottiglia basta guardarla per sorridere. Io sono come lui, a me piace tenere le cose dentro le bottiglie, ci conservavo anche i soldi nelle bottiglie di vetro, le usavo come salvadanai, ci mettevo il tè al limone d’estate e il succo d’arancia. Il mio cassetto ha l’apertura di vetro, ci guardi dentro e ci sono io: il libro che sto leggendo, la musica che sto ascoltando, il braccialetto d’argento della mamma, le ventose del cartello del negozio quando non funzionano più, le lettere e le mail del papà, la foto con la zia a carnevale, una pallina di gomma bianca; ci metto una cosa ogni tanto, ogni cinque o sei mesi circa, devono essere cose di cui non mi posso liberare, nonostante tutto. Infilo dentro l’ultima arrivata e spingo le altre dietro, poi chiudo piano, non deve spaccarsi il vetro: dentro si vede tutto solo se stai attento più di qualche minuto per mettere a fuoco. Poi devo uscire dalla stanza, non posso stare lì dentro, ho bisogno che le cose si riequilibrino; mentre chiudo la porta dico sempre: amen. 102 Il prete dice quasi sempre così sia, ma non ci crede tanto. Guarda Clementina che ci sta capendo poco e non riesce a dirle niente che possa farla stare ferma. Clementina è seduta su un gradino col sole sulla faccia, ogni tanto lo guarda e strizza gli occhi, poi li riapre e dice non ci vedo più. Lo chiama il gioco dei ciechi e lo fa sempre quando è agitata e vuole l’attenzione di tutti. Non ricordo nient’altro. Ogni tanto ho paura di non ricordarmi nemmeno di mia mamma. La disegno oppure ripeto fitto fitto chi era e cosa faceva, come se fosse tutto quel che conta di lei. Inizio dalla data di nascita, cinque maggio, dico che è Toro, che le piacevano i mandarini e il melone, i capelli ricci neri e lunghi e gli occhi enormi, che le uscivano dalla faccia, quando sorrideva, e lei rideva spesso, nonostante tutto. Poi mi viene in mente il resto, faccio un sospiro di sollievo e mi tranquillizzo perché ho in mente il resto. Ogni tanto ho paura di non sapere più niente a parte quando è nata, io me la ricordo ma avevo due anni l’ultima volta che l’ho vista, non sono sicura di azzeccare i particolari e adesso mi rendo conto di quanto sono importanti i dettagli. Quelli delle navi in bottiglia, per esempio: l’attaccatura perfetta di un lato con l’altro, colla e pinzetta, perché non deve sbavare nulla oppure il nome sulla fiancata, l’ancora un po’ penzolante, il timone non troppo stretto, per farlo girare. Nonno lo sa, io lo so. Lui dice che quando i morti cominciano a diventare troppi, poi le loro facce si accavallano: è normale. Quelli di famiglia si somigliano perché ce li ricordiamo con la nostra mente e non abbiamo così tanta fantasia da me- 103 morizzare tutti i dettagli: è per questo che al cimitero ci vogliono le fotografie, ed è per questo che si fa una gran fatica a scegliere le fotografie per il cimitero, ci vogliono giorni e una gran concertazione, saranno le immagini del ricordo condiviso, i loculi sono tutti uguali, ma le facce no, i dettagli ficcati in eterno vengono scelti con attenzione sfinente, perché poi gli altri dettagli, quelli accantonati, si scordano, a un certo punto. Colleziono le cose per ricordarmi i dettagli, io, come il nonno con le barche, metto i puntini sui fatti per non perdere la memoria; io non li capisco quelli che vogliono dimenticare, davvero. Non hanno mai perso nessuno, quelli che lasciano andare i particolari. Amen non l’ho segnata subito, c’ho finito il quaderno. 104 Marco Visinoni La ballata del morto vivente Ho ancora qualche ricordo della mia vita reale. Di quand’ero vivo, intendo. Ricordo te. Non tutta te dettagli l’orlo del tuo vestito che solletica l’erba, la mia mano rovinata dal freddo, i tuoi piedi gettare scintille d’acqua sfregando l’un l’altro, come in cerca di una cura all’inverno. Il tuo volto mai. Per quanti sforzi compia è perso perso completamente, smarrito nella discarica infinita in fondo alla mia mente dove giace ogni ricordo d’infanzia il migliore amico, le feste di compleanno il primo bacio dato e ricevuto in obbedienza a un gioco crudele. Tutto perso. Appallottolato insieme al tuo viso e gettato con indifferenza verso il fondo. Nel ricordo gli ultimi dettagli di te mi raccontano che siamo in giardino, i tuoi occhi sfuocati oltre il recinto di legno, io seduto al tuo fianco sul divano a dondolo, regalo per te di un vicino mi guarda dicevi e io perso in altro che non torna e che ora non 105 avrebbe valore. Non più della tua confidenza. Il ricordo salta alla mia mano rovinata che copriva una fotografia che copriva un’area grande come una foglia, una fotografia di una città dove comprami un cappello le tue parole mentre ti inseguivo sotto la pioggia. È crudele come la memoria dia le cose importanti in pasto a dettagli che non contano. Sul dondolo la tua maschera sfuocata abbozzare un’espressione la tua mano a fuoco raccogliere la mia per condurla verso qualcosa che accadeva fuori, oltre le rose. Nevica soltanto intorno al pozzo dei rifiuti hai detto allora. Sotto la pioggia reale del presente, nel mio cappotto deturpato, stringo gli occhi e il girotondo di fiori bianchi mi aggredisce come espulso da un razzo. E come un razzo muore in fondo all’oceano, come l’estate non è mai esistita in questo buio fermo. Ora è sempre inverno, sempre nevica dappertutto. Cammino stringendomi più che posso nel cappotto logoro, oltre il cappotto un mondo ancora più consumato dove i vivi uccidono e i morti si nascondono. I vivi guidano automobili, bevono caffè da barattoli di cartone e si chiamano con nomi che mi suonano lontani. I morti sono involucri vuoti, si muovono incerti come me ma i loro occhi sono assenti, non conoscono parole e non rispondono, vogliono solo mangiare. Mangiare i vivi. Anch’io voglio mangiare, ma provo ribrezzo nel farlo. Mangio gatti randagi e topi abbastanza vecchi da lasciarsi afferrare. 106 Seduto in un rivolo da marciapiede soffio contro le mani a imitazione meccanica di un gesto passato, non ha più senso ora che il respiro da morto è più gelido del vento intorno. Pensare questo mi riporta un secondo ricordo, più breve e altrettanto pallido, quello della tua maschera sfuocata che piangeva in giardino piangevi lacrime bianche potavi le rose e senza voltarti mi hai domandato se i morti sarebbero arrivati fino a casa nostra. Ho sempre pensato di averti abbracciata alle spalle, ma il ricordo per quanto incerto colpisce reale e spietato, racconta di me che guardo altrove e rispondo una frase prosciugata. Racconta di te che ritorni alle rose, togliendo alla mia bocca il merito che non le spettava. I morti. Quand’ero ancora vivo la televisione li mostrava falciati da mezzi blindati ai semafori, uccisi a colpi di spranga e bastone sul marciapiede. Diceva di tenere sempre a portata di mano una pistola carica, perfino ai bambini era spiegato così. I morti erano maldestri, rumorosi. Suonavano il campanello delle case per farsi aprire, non provavano neanche a introdursi di nascosto. I vivi aprivano le porte con il fucile già all’altezza della fronte, scavavano in giardino trappole rudimentali nelle quali i morti rovinavano goffamente, in attesa di essere freddati. A me è andata diversamente, però, dev’essere per questo che sono diverso. Forse chi mi ha cambiato lo era già a sua volta. Non ho il coraggio di avvicinarmi a un vivo. Per ragioni che non capisco mi esprimo in modo comprensibile, 107 non grugnisco come gli altri, ma i miei movimenti sono rigidi e sarei ucciso prima ancora di provare a spiegare. Siamo rimasti in pochi, non si parla neanche più di epidemia ormai. Ho letto questo su un giornale che mi ha colpito in faccia stamattina, trascinato dal vento. Il livello di panico è al minimo. Di giorno siedo sotto un cavalcavia fingendomi un senzatetto, è l’unica possibilità per un morto vivente evoluto. Qualunque movimento mi tradirebbe. Mangio meno rispetto a quando ero vivo. Un gatto a settimana, non dimagrisco e non cedo. Speravo mi avrebbe indebolito al punto da distruggermi definitivamente, corrodere la mia mente e rendermi vuoto come gli altri, ma non c’è limite alla sopportazione della fame per un corpo defunto. Sono ancora lucido. Bevo neve sciolta in pozzanghere. La mia urina è verde acido, devo sempre stare attento a non farmi scoprire. Non defeco da mesi, come se il mio corpo liquefacesse il poco cibo che ingoio. Di notte cammino per quartieri bui dove poter essere scambiato per un drogato o un ubriaco. Non ho rapporti con nessuno. Gli altri morti mi camminano di fianco e per istinto capiscono che non sono commestibile, basta questo per non curarsi di me. Stento a considerarli la mia razza, come di certo non sono umano, non più. È bastato un attimo perché succedesse. Ricordo me sul divano, la pancia alla televisione risate preconfezionate, ho la testa spenta afferrare le spalle il whisky cadere di mano 108 ma non ricordo l’infrangersi del bicchiere a terra. Quando mi sono risvegliato ti avevo già uccisa, tra le mani un braccio scarnificato. Ti avevo già divorato il ventre. Il senso di colpa ultima scarica di umanità sono fuggito cercando di piangere ma non tutto è concesso, da morto. Nella fuga ho inciampato in ostacoli che mai avrei definito tali, scarpe dimenticate a terra, il gradino oltre la veranda. Continuavo a cadere, braccia e gambe pesanti e ogni volta lo sforzo immane di un nuovo rialzarsi. Non ansimavo, neanche questo è concesso, ma tutto era incerto e denso, i movimenti di un corpo marcio handicappato. È bastato un attimo. Eri morta, lo ero anch’io. Nel mio cappotto sudicio guardo il giornale che mi ha colpito in faccia, lo apro al centro e mentalmente cerco di risolvere il cruciverba del giorno. Mi piaceva, da vivo. Non ho una biro per scrivere e non so se riuscirei a usarla, la mia nuova condizione permette solo movimenti approssimativi. A volte mentre fingo di dormire qualcuno mi getta dei soldi, li abbandono a terra sperando cadano nelle mani di chi può entrare in un negozio senza farsi sparare in testa. Nevica sempre ed è sempre inverno, ma non provo freddo e non mi infastidisce restare seduto ai bordi alla strada, mentre il cappotto si fa nauseabondo per la mia putrefazione. La morte rende tolleranti al disagio. Certi giorni dalle finestre risuonano canzoni che non ricordo più, mi appoggio al muro e ascolto alla ricerca di un’immagine qualunque da afferrare e tenere stretta. 109 Non funziona ed è il solito pensiero che mi lacera, perché certi pensieri e non altri, una fotografia al posto del tuo volto, la nostra morte invece di una stanza d’albergo. Comprami un cappello, sussurro tra me, comprami un cappello, ma non è la tua voce e la tua voce quasi non ricordo. Non so perché non mi uccido. Definitivamente, intendo. Non ho speranze di guarigione e non vedo possibilità di rapporti con gli altri. Ma la linearità non fa parte della morte. Forse anche il mio cervello è avariato, l’istinto di sopravvivenza che muove il corpo dei miei simili mi divora i pensieri da dentro. Semplicemente non riesco a considerarla un’ipotesi, per quanto logica e corretta sia. Sono tornato a casa, ieri. Le sbarre alle finestre e il giardino abbandonato, le rose a cui tenevi non esistono più. Morte, come noi. Tre modi differenti di non vita, e nessuno a spiegarmi la differenza. Mi sono seduto sul divano a dondolo, i cuscini squarciati da qualcuno in cerca di soldi o altro. Ho pensato a te quel giorno. Ho appoggiato la mano sui resti graffiati del nostro adesivo, sono rimasto in attesa e un lampo nella testa mi ha illuminato. Ho perdonato chi mi ha reso così come qualcosa che era giusto fare, senza chiedersi perché. Ho chiuso gli occhi e ho immaginato di stringerti la mano, mentre la neve sorda mi abbracciava piano. 110 Fabrizio Gabrielli Faccio di quei passaggi, vè? e che vuoi farci, ho questo neo Non mi faccio abbracciare spesso, io. Diciamo che è per via di una sorta di paura. E che vuoi farci, ho questo neo. Il mio neo, uno dei, è grande e grosso e se ne sta sulla schiena, al centro. All’altezza del gancetto del reggiseno, m’ha detto una volta un medico dei nei, un dermatologo dell’Idi di Roma. Si dice un dermatologo anche se era donna, vè?, medica non si può: come verbo alla terza persona singolare tanto tanto, ma come sostantivo è una bruttura, la medica dei nei; lei sì che indossava il reggiseno, io invece mai fatto, nemmeno nelle fantasie più sconce. Che io poi ce l’ho avuta nelle orecchie più d’una volta, da ragazzino, una frase che diceva dobbiamo andare all’Idi di Roma, e misinterpretavo a Lidi di Roma: Ostia Fregene Maccarese, tipo, pensavo, e montavano subitanee preoccupazioni, dovrò cospargermi bene il neo di crema, riflettevo corrucciato, ero uno di quei bimbi che usano il verbo cospargere, un’infanzia difficile, la mia, uguale a tutte le altre solo in un aspetto, quello per il quale avere otto anni fa rima con ignorare l’omofonia. Il mio neo è una sorta di bottone dell’amicizia, qualcuno deve averlo premuto inavvertitamente mentre era- 113 vamo sul trenino per Fiumicino Scalo, ed ora niente, per quella sbadataggine trenìcola mi ritrovo interdetto agli abbracci. Proprio costretto a tirarmi indietro. Anzi, peggio: ad avvisare, a mettere in guardia, come Nanni Moretti in quella scena di Caro Diario, faccia attenzione ai nei, eh. Che a pensarci bene è un po’ come se prima di baciare mi prendessi la briga di illustrare i movimenti, dunque signorina, ora introdurrò la mia lingua nella sua cavità orale compiendo dei movimenti circolari da destra a sinistra, in senso antiorario: non è una gran bella abitudine, vè? Carlo m’aspetta al gate, trascino un trolley sovraccarico e lo scorgo con le braccia incrociate sotto la barba. Occhio al neo, quando m’abbracci: è la prima cosa che dico, forse non proprio la prima, sicuro avrò sciorinato un bellalà, oppure un ueh, le ròbe che fanno rumore nei momenti in cui ci si vede da lontano, mi ricordo mica, ora: però son sicuro che il passaggio successivo deve esser stato usciamo, che devo fumare. Non mi riesce di stare troppo distante dal tabacco, a me. Diciamo che è per via di una sorta di vizio. E che vuoi farci, ho questo neo. All’aeroporto di Cagliari, era quest’estate e sverginavo i miei approdi in Sardegna per le vie aeree, fumavo ancora cammelli blu, avevano quel nome anche di fronte al tabaccaio, dei cammelli blu, dicevo; perdevo un sacco di tempo a farmi capire, dicevan quasi sempre eh?, ed io ripetevo più lentamente, ma esplicitavo mica, spiegavo mica un pacchetto di camel blu. Cammelli. Blu. Ora tutto 114 il tempo di quel botta e risposta lo impiego ad elencare pueblo; rizlabluccòrte; filtriultraslìm. Non che sia meno criptica, come lingua. Epperò è un impiegare il tempo in maniera più fruttuosa, sembra. Con Carlo parliamo di lettere, potremmo discutere di argomenti meno fumosi, tipo perché è un po’ Simone ed un po’ Carlo, ma non importa: di romanzi ci vien meglio, è tutt’un citarci ed eccitarci con Cortázar e VilaMatas, avevo una discreta dipendenza da Vila-Matas, quest’estate, nel frattempo aspettiamo che un altro volo a basso costo rimbalzi sull’asfalto e nell’attesa fumare scrittura parlare: viene bene, e piglia bene, in fondo. Siamo gl’unici nell’androne che non indossino una paglietta, o una maglia fighetta, e non è che siamo in Sardegna per bere, ballare, trombare. Simone e Carlo m’hanno invitato per fare lo scrittore, tipo. Noialtri s’ha da fare le cose dei libri. simonia, stent’a dirlo I simoniaci, nella Divin Commedia, stanno al terzo anello, come i tifosi della squadra ospite a San Siro: in castigo per essersi macchiati dell’efferato reato di mercimonio di beni spirituali, gli tocca passare l’oltrevita a testa in giù, fuoco a lambirgli i piedi nudi. Simone Rossi non indossa le scarpe, non lo faccio da maggio, ti dice, ci sarebbero le infradito ma a piedi nudi si sta più comodi, l’asfalto che ti bacia la pelle dura dei talloni e l’ukulele sotto le dita, non c’è null’altro che ti serva. Io, che Simone abbia capito svariate ròbe più di 115 me son sicuro, e poi non è mica un segreto, si dice un po’ ovunque, dài che l’hai sentito pure tu, dallo Spazio Meme di Carpi al bar del Giambellino, che Simone sia un Mago. Se leggere pezzi di libri mentre qualcuno suona può essere considerata una mezzaspecie di produzione di beni spirituali, e regalarli ad orecchie fameliche è un po’ mercimoniare, noialtri sì, si è simoniaci, mi ci metto anch’io, che mi chiamo Fabrizio e questa sera voglio provare con un inedito, ho detto prima di iniziare, solo volevo accertarmi che non ci fossero tolfetani o allumieraschi in sala perché sapete, quando porto il katacrascio vicino casa mia non posso mai leggerlo, questo passo: c’è che mentre le scrivevo mi veniva di scimmiottare il dialetto di questi paesotti poco lontani da Civitavecchia, no?, ve l’ho detto già che vengo da Civitavecchia, vè?, dall’altra parte precisa precisa del mare, ed ecco, se stasera non ce ne sono, direi che ci provo. M’han dato fiducia, è strano perché non si dovrebbe dare mai fiducia ad uno che indossa una polo con il colletto rialzato, è quasi un assioma. E invece niente: c’ho provato, che io quando c’è modo di parlare in tolfetano vado in sollucchero, anzichenò, e pure il proprietario del locale, col gilet di pelle ed i baffi da easy rider, m’è sembrato abbia accennato un sorriso. In fondo alla serata al Dulcis, che a rigor di logica dovrebbe chiudere il festival ed invece è una sorta di gustosa anticipazione, ci stanno le Ichnusa ed i cannonau, i disegni estemporanei di Luca Congia, il mirto che devi assolutamente provare ed i romanzi che devi assolutamente leggere, c’è l’amicizia e il tirar tardi, sempre con 116 Vila-Matas, sempre con gli odradek che pigliano a girare impazziti per la stanza ed il tuo come si chiama?, il mio Lénghero, ha il corpo da nocciolina ed un mood pugnace, diciamolo a tutto l’internet, tumbleriamolo, quanto è figo tumblerare? Il lénghero mi guarda di traverso mentre m’addormento nel lettino della sorella di Carlo, dove ci son tanti insetti disegnati sulle coperte che quasi sembra d’essere in un coccinellòdromo. Allo Stentadì, ch’è la residenza autori, siamo tanti e belli. C’è l’elena, io la chiamo elenini ma sulla carta d’identità che ha lasciato per il cecchino c’è scritto Elena Marinelli (una volta ha letto Georgie Blues allo Zammù, Elenini, me ne sono innamorato, di quell’interpretazione, e non me la scordo più); sta studiando da elettrauto per cercare di mettere in moto una Centoventotto rossa sulla quale, con melliflua perizia, ha stipato le sue novelle preferite, incastrate a dovere, c’è da controllare filtro ed olio, poi nient’altro, solo brumbrum. Bicio col contrabbasso, perché noialtri non si prende più nemmeno il caffè, senza contrabbasso, dice simonerò, che mi sento sempre un po’ in colpa, se ripenso a Bicio, per avergli mandato a noia Rapper’s Delight ed il di lui bàssico giro: tun-tun-tun, suonalo ancora, Bicio, più aggressivo Bicio, la sugarhill gang potrebbe quasi querelarmi, se solo Bicio facesse la spia. E poi Elì. Migué. Carlopalì e Marialuì. Tutti lì, allo Stentadì, dò tra le tante cò decidià di fa così: abbeverarci ed abbreviarci. 117 Ci diamo da subito un’organizzazione che sembra d’essere in un collegio delle suore carmelitane scalze, ma senza collegio, senza suore e senza carmelitanesimo. Non ci resta che il girare decalzaturizzati: scalzi si prende l’acqua in frigo, scalzi si esce a fumare, scalzi si copia il codice dell’internet dalla bacheca e ci si abbraccia quando ci si incontra. Io no, però, che degl’abbracci ho paura, ho il bottone dell’amicizia spento, sapete. degli universali Ho sentito parlare per la prima volta degl’universali che pioveva tutto il cielo. Le professoresse che si davano il cambio sul ring, come cholitas ma meno agguerrite, erano una l’involucro dell’altra. Sintassi ce lo spiegava un truciolo riccioluto, una maschera del día de los muertos, ed era tutt’un magmatico sintagmare amalgami soggettoggettopredicato. Universali linguistici aveva i polpacci di Gigi Riva, il phisique du rôle di Margherita Hack ed una naturale predisposizione al soporifero. L’esempio di come si somiglino un po’ tutte le mamme del mondo sarà pure sputtanato ma è di sicura presa, diciamolo, una sorta di obolo preventivo, incassato il quale finisci per accettare pacificamente pure l’annichilimento d’una lezione di tre ore sul ruolo dei focus marker nelle lingue cuscitiche, che con tutto rispetto per gl’etiopi sono lingue un po’ del cazzo, le lingue cuscitiche. Una regola degli universali linguistici dice che se nel tuo modo di parlare distingui tra maschi e femmine, al- 118 lora nove su dieci che ti poni il problema di far capire se sono tanti maschi o poche femmine. Se una lingua ha genere, ha pure numero. Lo dice Greenwood, dei boschi verdi ci si deve fidare per forza, c’è il fascino orrorifico del mostruoso, nel verde, e pure nei boschi. Tanto più che pei boschi stai passandoci, l’ho già detto che il festival dei libri di Quartucciu si chiama Passaggi per il bosco, vè?, e allora tempo per riflettere ne hai mica: la fiducia deve tramutarsi in fede, cieca, incondizionata. A Cagliari, quando soffia il maestrale (il maestrale è maschio) di notte in spiaggia (spiaggia è femmina) non ci resisti troppo a lungo, neppure con la felpa col cappuccio. Il maestrale a Cagliari non ci riesce proprio ad essere singolare, se tira un giorno allora ne spirerà per altri due, è sempre dispari, il maestrale, e mai singolare: una ròba singolare, vè? Ed anche le spiagge, ecco, ce n’è mica solo una, di spiaggia a Cagliari, seguono una numerazione: spiaggia dodici è prima di spiaggia venticinque, che mi sembra pacifico, e su ognuna ti frusta il maestrale, tu stai capelli spettinati tutt’il tempo e non c’è troppa simpatia, in questo accadimento. Un universale linguistico che m’è venuto pensato a Cagliari, una sera di maestrale, è che in tutte le parole con una doppia zeta, magari pure tripla, c’è come una patina di cattiverìa, d’ostracismo congenito e gratuito: il caddozzo noialtri lo chiamiamo zozzone, facciam pure meglio dei sardi, ne infiliamo tre, di zeta: il caddozzozzone è quel camioncino ambulante che prepara i panini con le salsicce unte e bisunte tuttodì. Allo Stentadì, pa- 119 nini non se ne possono preparare, la cucina è bella ma di figura, non la si può mica utilizzare, ed allora se ti sale la fame l’unica è il caddozzo. Davanti al caddozzaro non c’è mio, tuo, suo, pur essendoci tu, lui, lei e pure lui, ed alla fine anche io. Un altro universale linguistico è che in tutte le lingue del mondo ci si piglia la briga di far capire all’altro che io sono io, tu sei tu e quello laggiù, quello che coi guanti di lattice infila le melanzane in mezzo al pane, bene, è lui. Facciamo così, mettiamo che tu mi racconti quello che ha combinato lui: io prima stento a crederci (allo Stentadì si fanno solo cose che c’entrano col nome, si stenta, si ostenta, si discute con gl’astanti), poi però lo scrivo, senza far nomi, che non sta bene parlar male degli astenti. “Enrique Vila-Matas un giorno finì che lo invitarono per davvero, ad un festival, lui non sapeva come arrivarci, mi dite dov’è il ponente?, chiese, gli dissero il ponente dov’è che stava e lui marciò, marciò in disciplinevole silenzio, finché non giunse a Limerick.” Non è importante che tutte le lingue si adeguino ad un certo universale linguistico affinché questo venga considerato tale, pontificava Greenwood, l’importante è che nessuna di queste lo contraddica. Che mi sembra un postulato tremendo, di quelli che ti mettono l’ansia sotto le unghie. Come dire l’eccezione invalida la regola. Mi son sempre chiesto come la prendano, gli undici titolari della regola, il sopraggiungere in punta di piedi del signor Eccezione: buongiorno sono Eccezione e secondo me siete assai bellini con le vostre divise da giuoco, però in campo 120 non potrete scendere mai, non siete davvero una squadra, ciao, me ne vado. Credo non bene, credo a sassate sul grugno, la piglierebbero: meriterebbe la lapidazione ogni volta, l’Eccezione. A me, mai passata per l’anticamera dell’ippotalamo, l’idea di andare in ferie dalle lettere, e dico ippotalamo perché è in quell’area del cervello che risiedono gli appetiti sessuali: non scrivere volendolo è come desiderare di non avere più un’erezione, una stramba preghiera invero. Conta poco che quattro scrittori sotto lo stesso tetto passino metà delle giornate a scrivere: l’importante è che nessuno si astenga dal farlo, solo così formerebbero un meraviglioso universale linguistico, e parlerebbero di loro in un’aula magna a romatré, mentre fuori piove tutto il cielo e gli studenti son intirizziti: magari si divertirebbero, quegli studenti, ultimo barlume d’interessantitudine prima di scivolare nel torbido fiume dei focus markers nelle lingue cuscitiche. Cosa c’entri Vila-Matas con Edoardo Lear e col suo limerick di Lucca stent’a dì, stent’a dirlo, cari i miei bolidi, sono le treqquaranta, la passione per le q doppie non s’è ancora sopita e a Stentadì dormon tutti. O quasi. Non io: troppo impegnato a non truccarmi da Eccezione, io. la morte sua, la marta mia C’è sempre una Marta, in letteratura: Marta, nei libri, è la morte sua. Bisognerebbe chiederlo al Visinoni, che con la morte s’impiastriccia le mani, non fa il becchino ma scrive i 121 noir e cita James Ellroy col suo tono di voce blues, quante volte una Marta è stata uccisa dentro una trama: ci dica, Visinoni, lei che di morte sembra saperne, mentre di Marte non lo so, non conosco la sua Weltanschauung sulle donne dei romanzi né tantomeno le sue conoscenze astronomiche. Una battuta apocalittica, vè? Da farti esclamare wow, ma anche no. Altre ròbe che sono la morte sua: i cardigan di cotone sulle t-shirt quand’è sera, le spillette sui cardigan, sbriciolu(na)glio letto sul contrabbasso e sull’ukulele, il dentifricio sullo spazzolino (prima sul tuo, e poi sul mio), la Nutella sul pane tagliato a tranci. La Nutella sulle scarpe: no. Buenas salenas cronopio cronopio sulle scarpe: sì. Il mirto nei bicchierini di carta: assolutamente. Il porceddu di domenica: vorrei ben vedere. Di Bolero costretto avevo sempre sentito parlare, sapevo ch’era una ròba simoniaca ma non ero mai stato presente al mercimonio di cotanto bene spirituale, ed è d’un fascino inquietante, Bolero costretto, come il rumore dei pattini sul parquet o l’irrequietezza dei piedi nudi mentre si legge, come i mignoli palmati o la posizione del riposo troppo simile a quella dell’eterno riposo. Chiara che arriva mentre sto leggendo al Canone Inverso quel pezzo su Vila-Matas che secondo me è easside, mica wesside, Chiara che cinque giorni prima le ho chiesto d’essere per sempre, Chiara che non si chiama Marta ma che con i libri e con le cose che faccio coi libri c’entra sempre: un’altra, la più meravigliosa, morte sua. 122 l’ultima parola è immaginazione (oppure zaccarsela alla pensc. oppure ancora: senso) Alberto Masala, che di cemento e strada ne ha visto e masticato tanto, e ne sa, c’è dell’abbardente nel bicchiere e l’ombra degli asciscini sui tetti delle case, Masala dice solo quattro regole, quattro, per onorare il contratto che hai con il tuo pubblico: cattura la sua attenzione, mantienila alta, fatti seguire, e poi trasmetti senso. Proprio così, dice, trasmetti senso. Quartucciu è un’appendice nervosa e farwèstica di Quartu Sant’Elena. Ha un senso, dopotutto: è una piccola Quartu, come l’Arena di Verona all’Italia in miniatura, io ci rimasi a bocca aperta davanti all’Arenuccia. Quella grande, quella vera: non mi ricordo. Per le strade di Quartucciu alle duemmezza del pomeriggio ci sono solo io, io e la canicola, con un occhio solo, l’altro è serrato, l’altro piange, sarà per la salsedine lo stress le cose che non vuoi vedere. In collera e senza collirio, con tutt’attorno un corollario di Corolla color corallo che corrono il rally, c’è che alle sei presentiamo il katacrascio e io c’ho di quelle madonne che nemmeno ad immaginarle. “Immaginazione è l’ultima parola, in quel libro di Henry Miller”, me lo dice Carlo ed io ci credo. Immagino, scioccamente e con faciloneria, che immaginazione sia l’ultima parola di Tropico del Cancro, ma mi sembra di ricordare anche che il libro non finisca con immaginazione, né che l’ultima frase sia immaginazione è l’ultima parola, dovrei ricontrollare. Anzi no, non posso: perché io Tropico del Cancro l’ho buttato dal balcone della casa di 123 mia nonna al paese, non è così pour parler, buttare è proprio le mot juste, era un periodo in cui odiavo particolarmente gli scrittori francesi ed in quella parentesi di antifrancesità decisi di farci cadere pure uno scodinzolìo di antiamericanità, Henry Miller m’era davvero andato a noia, era un tempo in cui andava a noia tutto, e la prassi era che prima io e te litigavamo selvaggiamente, poi tu volavi dritto dalla finestra. In quel periodo là, ecco, vociferavano parla col rap, lui. Avevo l’amaro in bocca, sempiternamente. [E comunque immaginazione era l’ultima parola che diceva Edgar Varése in un capitolo a lui dedicato su L’incubo ad aria condizionata di Miller, che non è un romanzo ma una raccolta di scritti sul viaggio in America che Miller compie dopo essere tornato dall’Europa, mi correggerà Carlo quando leggerà questo racconto, tempo dopo.] Il miele è dolce, di prassi. Se ci inzuppi i libri, però, in quel caso no: il miele si fa amaro, come la libreria che sta nel pieno dello struscio cagliaritano e dentro la quale la nike di Samotracia, in mezzo a tutte quelle sneakers e ai writer e all’hiphòppica lingua diventa Naic, è un attimo: dillo e basta, Just do it. A sentir parlare del katacrascio c’è pure Fabio. Fabio fa una musica che quante volte l’avrai sentito, c’è chi la definisce rumore. In ispagnuolo rumore si dice ruido e si pronuncia con l’accento sulla i, parola sdrucciola dal suono sdrucciolevole. Fabio si fa chiamare Rùido, con l’accento sulla u, se il rap ti va a genio e ne sai almeno un po’ sicuro che lo conosci. 124 Nell’anno del giubileo ho avuto l’onore di essere su un disco di Ruido, era la traccia quindici, si chiamava Qua si parla di relax e non era un pezzo malvagio, c’ero io col compare della mia crew e pure Moro, oltre alla Fit Prod. Tolgo mise che non mi si addicono, abdico ogni impegno come tipico nei giorni di relax, dicevo in quel pezzo, era il periodo in cui non m’andava a genio tantaròba, tra cui indossare mise che non mi si addicevano. Quando presentò Gli 8 comandamenti, la Fit Prod, s’organizzò un gran concerto a Cagliari: io non c’ero, però il giorno dopo Goppy mi chiamò dicendo “dovevi sentire, goppàre, abbiam cantato la tua strofa tutti insieme. Sembrava che fossi morto”, che doveva suonare come un gran tributo, credo, ed io così lo presi, in buona sostanza: mica m’incazzavo davvero sempre. Fabio, era l’ultimo giorno di Passaggi, ci ha invitati a Iglesias e noi ci siam giunti con le gambe stanche, a Iglesias c’è sempre una cedrata fresca e Loorto ad attenderti. Erano anni che non ci tornavo, a Loorto, ma dai subwoofer escon sempre suoni potenti, dentro quello studio; Ruido sui quattro quarti se la zacca alla pensc, è un motto nonsènsico ma funziona: ascolta Ruido sui quattro quarti in “4/4” e vedi se non ti scappa di zaccartela alla pensc un po’ pure a te, che non sai cosa significa. la(tra)ti dei cani là fuori Che tu ci creda o no, caro mio bolide d’un lettore, è l’onestà intellettuale che parla per me, avrei un fracco di ròbe da raccontarti, su Gianni Tetti; ma c’è un bel dia- 125 logo altrove su questo libèllo, perciò non ti rubo tempo prezioso. Prosegui, non titubare, si parla di calcio nel prossimo paragrafo. No, ho detto di calcio. Niente figa. com’un saliscendi, di tacco e di punta Con Carlo discutiamo ancora un po’ di lettere: potremmo snocciolare argomenti meno fumosi, tipo perché è un po’ Simone ed un po’ Carlo, o cosa ci sia di davvero imperdibile a Nebida, ma non importa, di romanzi ci vien meglio, di romanzi e di pallone. Una ròba che non t’aspetteresti mai è che Carlo tifa l’aèsseroma, che è un po’ l’appalesamento della veridicità vendìttica: l’aèsseroma sembrerebbe essere davvero quella cosa che ti fa sentire amici anche se non ci si conosce, e che ti fa sentir vicini anche quando si è lontani. Te lo dice con rabbioso rimpianto che giuocava al calcio, Carlo, laterale sinistro d’attacco, filiforme e nervoso come un Cristiano Ronaldo meno glam e più sudato, testa bassa e ginocchia appuntite, lunghe leve e pedalare sulla fascia, su e giù, un calcetto al terzino, un dribbling stretto, Carlo che però dentro ce la buttava mica mai, ti confessa. L’inno trasteverino, quello che ad un certo punto s’inerpica sulle alte vette della spocchiosità minacciosa intonando mo’ so dolori perché Roma ce sa fa: io non lo so se Carlo l’ha mai canticchiata, quella canzoncina, se la conosce. Provo a raccontargliela mentre attraversiamo lo stagno di Molentargius, ci sono fenicotteri ovunque, somigliano molto nella mia immaginazione alla mise che doveva avere Carlo quando scendeva in 126 campo, i fenicotteri. E immaginazione è l’ultima parola. E no: non la sapeva, la canzoncina in cui ad un tratto si gorgheggia e quanno che comincia la partita ogni tifosetta se fa ardita, tifa forzaroma a tutto spiano con la bandieretta ‘n mano perché c’ha er còre romano. Però amava i colpi di tacco, Carlo, ed i passaggi di punta, i tocchi di genio, quelli che non ti aspetti, quelli che sopraggiungono inattesi, come la scalinata per affacciarsi dalla laveria di Nebida, centinaia e centinaia di gradini scavati nella roccia che si tuffa nel mare azzurrèrrimo. Si scende? Si scende. La gravimetria è una scienza esatta, se non la conosci non è grave: è una branca della geofisica che si occupa di studiare i campi gravitazionali. Detto in soldoni, com’è che cade ogni cosa che per ineluttabile destino deve cadere. Intrufolarsi negl’interstizi dell’opificio come filoni di rame tout venant è tutt’un precipitare gravimetrico; dentro le laverie ci si arricchisce, lo facevano un tempo il piombo e l’argento, oggi è come se fossimo un po’ pagliuzze minerarie anche noi, risucchiati dal libeccio che t’accarezza la schiena e t’invita al volo, atavici richiami in tabarchino sussurrati dalle spiagge dell’isola di San Pietro. Scendere si scende, basta poggiare il tacco e lentamente adagiare la punta sul gradino, se t’arrischi in un punta punta punta finisce che ti esplodono i polpacci, bisogna saperci andare di fino, con la scalinata della laveria di Nebida. Che sembra un po’ come quando scrivi un libro, incespicare e discendere senza guardarti indietro, preci- 127 pitare con l’occhio fisso all’orizzonte, con un briciolo d’incoscienza stretto in pugno fin quando arrivi, stancamente ma arrivi, respiri il corbezzolo e tocchi le foglie del mirto, hai la pietra ruvida e calda sotto le gambe, e non sei che a metà del viaggio. Che poi dovrai pur risalirla, la china, tornarci, sui tuoi passi, capire se puoi permettertelo ancora, quel punta tacco punta, o se dovrai piuttosto limitarti ad un passaggio col piattone interno destro. È la teoria del saliscendi, del daje de tacco eddaje de punta. Io non lo so se a Isacco Newton era mai passato per la testa di mela bacata ch’aveva questo pensamento, però la gravità è anche quella che scende sui volti quando c’è da dirsi che poi alla fine ciao, prima di trasvolare altrove. E va bene gl’abbracci, le pacche, i ci si vede, però ecco gli addii: gli addii sono sempre un po’ come spingere un bottone in down. A Masua c’è un tramonto dietro il Pan di Zucchero che non vorresti mai doverlo raccontare. E dovrei esser triste, vorrei sul serio, ma non ci riesco. È che per via di quel bottone dell’amicizia in perenne stato off, sono interdetto anche alla malinconia. Che volete farci: ho questo neo. 128 Marta Casarini La vernice ecologica «Secondo me ce l’hai, dai. Tua mamma non fa i test della pipì?» «I test della pipì?!» «Sì, quelli che devi fare la pipì in un barattolo e poi portarla dal dottore e ti dice se sei malato o incinta.» «No, non li fa. Secondo me non ne abbiamo… perché non puoi usare un bicchiere?» «Perché lo devo chiudere, scemona, i bicchieri non hanno mica il coperchio.» «E perché lo devi chiudere?» «E perché perché perché… cos’hai, due anni?» «oooh! Cosa vuoi da me, cinno?» «Un contenitore.» «Non. Ce. L’ho, ti ho detto!» «Sì.» «No!» «Dai, vai a vedere. Così venerdì a quella stronza della maestra gliela faccio vedere io. Così la smette. Ho già tutto pronto, mi manca solo dove metterlo. Dai, ci vediamo domattina, è arrivato il pulmino. Mi raccomando, portamelo. Ciao.» Poi si bacia la punta dell’indice della mano destra, tutta piena di croste, ci soffia sopra e sale sul pulmino pullulante di sudore e cartelle. 129 Io e Fabio abbiamo fatto amicizia così, per le croste. Nessuno si sedeva mai vicino a lui, in mensa, perché aveva l’abitudine dei paragoni disgustosi. Appena la bidella svuotava la teglia gargantuesca del suo contenuto di penne al pomodoro, dal fondo del tavolo cominciava a sgranarsi un sommesso rosario di schifezze che si trasformavano in biglie sulle quali ognuno dei nostri compagni scivolava, procedendo a ruzzoloni verso un’inevitabile nausea collettiva. «Ecco il mostro pieno di viscere, ecco che nelle viscere rosse si incastrano grumi di muco, sembra basilico, ma è muco, ed ecco che la bidella Marisa rovescia tutte le budella sui piatti dei bambini che masticano l’intestino del mostro, mmmh che buono, e come sono belli mosci i suoi organi, belli viscidi di sangue!» Nessun piatto veniva privato della sua versione splatter: i filetti di merluzzo impanati diventavano piedi di gnomo imputriditi, il passato di carote cerume frullato, persino le fettine di pomodoro fresco, semplici e nude sul piatto di carta, agli occhi di Fabio parevano orrende escrescenze sanguinolente perdute in battaglia da due orchi litigiosi. Io ridevo. E mangiavo di tutto. Già allora propendevo per assecondare gli istinti, e il mio appetito da ippopotamo era talmente forte da resistere alle ondate di fantasia grandguignolesca del mio compagno di classe. Ero l’unica bambina a non storcere il naso davanti a un polpettone-infezione, alle verdure-suture e al panetesta mozzata di cane; ero l’unica a non essere pronta a strillare, alzando il braccino stretto in un golfino d’an- 130 gora rosa, “ce lo dico alla maestraaaaaaaa” non appena qualcuno mi tirava i capelli. Ed ero l’unica a non avere paura. Anche il giorno in cui mi avvicinai – il piatto pieno di minestrone-vomito di leone – e vidi per la prima volta da vicino le sue mani martoriate dalla psoriasi, non avevo paura. Prova ne siano le domande, e la voce, che vengono fuori solo quando non si teme niente. «Che cos’hai fatto lì?» «Dove?» «Nella mano.» «Niente.» Continuammo a sorbire il nostro vomito dai cucchiai opachi di vapore. «Ti fa male?» «No, ma a volte fa prurito.» «Ah. Anch’io avrei una crosta, lo sai?» «Dove?» «Sul ginocchio. Sono caduta dalla bici. Anche a me prude, perché non riesco mai a farla formare. Tu te le gratti?» «Sì.» «Anch’io.» Fabio smise di mangiare, poggiò il cucchiaio nel piatto e mi puntò gli occhi sulle ginocchia, sogghignando. «Io me le mangio.» 131 «Che cosa?» Il suo ghigno si allargò fino a raggiungere gli zigomi, la voce un sussurro di pregustazione dello scandalo: «Le croste.» «Ah sì. Anch’io! Ma il brutto è che mi piacciono solo quando sono belle dure, e non ho mai la pazienza di farle crescere, così devo accontentarmi di masticarle quando sono ancora un po’ molli, e non c’è gusto, perché da molli non sanno di niente. Sei fortunato, tu, che le hai sempre. Io posso mangiarle solo se mi faccio male.» Da allora, Fabio si legò a me come un koala all’eucalipto, un cucciolo di canguro al marsupio mammifero, un gattino alle coccole, una tenia all’intestino da infestare. Insieme parlavamo dei telefilm che ci piacevano, uno su tutti Willy, il principe di Bel-Air, e la sua ammirazione per me crebbe quando sotto il pino pelato del cortile gli snocciolai a memoria tutta la difficilissima sigla, senza sbagliare una parola. Giocavamo a creare collane con gli aghi irresinandoci le dita; insieme facevamo che io ero una piratessa assassina che scardinava le porte con la voce, e lui il pappagallo che viveva sulla mia spalla e ripeteva tutto quello che dicevo ma con voce ancora più forte, così scardinava anche le assi delle navi nemiche. Ritagliavamo le figure dai Topolini vecchi, e incollavamo la testa di Basettoni sopra il corpo di Paperino, le orecchie di Minnie sui piedi di Gastone, confon- 132 dendo attitudini e morfologie così come noi confondevamo i nostri limiti, conoscendoci mischiandoci. Ma, soprattutto, insieme odiavamo molto. Odiavamo le fighette in golfini d’angora rosa. Giravano tutte con i capelli legati in trecce o code di cavallo e proprio come i cavalli sculettavano al galoppo se chiamate alla lavagna e nitrivano a ogni battuta loffia della perfida maestra. Odiavamo stare seduti composti con le mani aperte sul banco, il gioco del silenzio, ritagliare le schede e appiccicarle al quaderno senza fare castroni con la colla, non poter ridere durante le lezioni e Simone, il capo della classe, otto anni, diciannove quadricipiti e un carnet di bionde che neanche un pub londinese. Simone, oltre ad aver vinto il Premio Calcolatrice come miglior studente di matematica della provincia, partecipava a un corso di karate, uno di judo e uno di organizzazione criminale e faceva della lotta agli sfigati la sua ragione di vita. Inutile dire che io, con la mia pancia alla Depardieu e i vestiti di pile, e Fabio, con la sua psoriasi e l’attitudine alla bizzarria, incarnavamo le vittime ideali. Ci copriva di insulti (neanche tanto originali, a dire la verità, tutta roba già sentita tipo cicciona e ritardato) e aizzava i compagni a fare lo stesso, tormentandoci con prese in giro e tirate di felpa e mutande. Capivamo che Simone e la sua ghenga non costituivano un vero peri- 133 colo perché a noi, di loro, non ce ne fregava niente. Non è che avessimo paura delle loro parole, né di ritrovarci emarginati durante il pranzo o la ricreazione. Anzi. Andavamo fieri del nostro essere scartati da bimbi che consideravamo cattivi, stupidi e noiosi nella loro incapacità di confondere il dovere con la fantasia. Quello che odiavamo in loro era il vuoto. Il loro essere tutti uguali. Il timore di sporcarsi, di parlare di storie, di riuscire a fare qualcosa di diverso da ciò che aveva ordinato la maestra. Quello che odiavamo era il loro voler fare di tutto per diventare uguali alla maestra. Quello che odiavamo, più di tutto, era la maestra. La maestra si chiamava Anna, e mai fu affidato un nome meno adatto a una persona. Anna ha un suono pannoso, che ti riempie la bocca di delizia candida. La maestra invece aveva una faccia segaligna di quelle che, se le guardi, sotto i denti ti si conficcano le schegge. Era così alta da sfiorare la porta con la testa, e come se la sua longitudine non fosse sufficiente, si cotonava i capelli, in modo da sembrare un severo cipresso ritto sul viale che porta al cimitero. Al grido di «se otto ore vi sembran poche / ci penso io a farvi lavorar», oltre ai compiti canonici da svolgere nel fine settimana, ci imbottiva di esercizi da fare durante l’intervallo. Se non li finivamo, erano guai. Li chiamava I Doveri. «Anche in Francia li chiamano così, bambini. I Doveri 134 in Francia li fanno tutti, e se non li fanno, le maestre possono decidere di non far fare mai più l’intervallo, a nessuno, anche a chi ha finito tutti i suoi Doveri. Capito, bambini? Questo solo in Francia. Voi siete fortunati a essere in Italia, ché i Doveri, se non vengono finiti, fanno del male solo a uno, e non a tutti. Siete contenti?» La maestra ce l’aveva con Fabio. Siccome nessuno, all’inizio della prima elementare, lo conosceva e l’aveva scelto come vicino di banco, lei aveva pensato di attaccarlo alla cattedra. Gli aveva fatto mettere la sedia a un lato del suo altare, perché diceva che così le era più comodo controllare quello che scriveva. In realtà, da lì era più facile dargli delle sberle sulla bocca. Con la mano piena di anelli. Anna era così: all’antica. Stronza sarebbe un termine più appropriato, e fu quello che adottammo subito Fabio e io, per riferirci all’albero malvagio che si cibava di ricreazione e decideva del nostro futuro. I giorni passavano uguali, a scuola. E uguali a casa. E Fabio, con i suoi arti pieni di pelle morta, mi era sempre più vicino. Fino al giorno della vernice ecologica. Era un giovedì pomeriggio, di novembre, e tutti avevamo il sussidiario aperto su una pagina di scienze pesante come cemento in umido. 135 La pioggia ticchettava contro i vetri luridi, il pino pelato scuoteva le sue rade chiome in una muta richiesta d’eutanasia clorofilliana, il pranzo a base di ossa di pescecane aveva piombato gli stomaci e le meningi di tutti, che ciondolavamo i capi alla ricerca di un gioco del silenzio che sfociasse in un sonnellino ristoratore. Anche la maestra sembrava leggere le varie fasi del processo di decomposizione dell’humus con particolare inedia. Fino a che, arrivati al punto del «o qui succede qualcosa o la scuola implode», scosse la sua testa paralizzata dalla lacca e disse: «Bambini, per venerdì prossimo avrete un Dovere particolare. Dovete presentare alla classe un progetto, come fanno in America. In America chi non presenta un progetto alla classe viene espulso. Voi siete fortunati a essere in Italia che non viene espulso nessuno ma solo punito con una nota, se non porta nessun progetto. Siete contenti?» Così cominciò la frenesia del progetto da presentare. Le fighette volevano costruire tutte una casa per le bambole con le scatole degli stuzzicadenti. Simone pensava di realizzare un vulcano che eruttava lava di gelatina (che banalità. Visto e rivisto. L’equivalente scientifico del cicciona). Io covavo il desiderio di presentare in diretta il rigurgito di un bolo di peli da parte del mio gatto Geremia, ma era solo un’idea fumosa, realizzabile forse solo con pratiche che violavano le normative europee sulla dignità degli animali domestici. 136 Fabio, invece, il progetto ce l’aveva già. Pronto, realizzato mesi prima. Non me ne aveva mai parlato perché, saltò poi fuori, si vergognava un po’ tanto era geniale. «Che cos’è?» «È una vernice.» «Mmh, come quelle che si trovano in ferramenta?» «No, è diversa. È una vernice ecologica. L’ho fatta con l’erba.» Aveva preparato una pappona vischiosa con muschio, trifogli, lattuga, resti di zucchine ripescati dal cestino dell’organico, fieno e una coda di ramarro. Aveva sminuzzato tutto rubando il frullatore a immersione di sua madre, dimenticandosi di ripulirlo e lasciandolo sul tavolo della cucina a sbavare sudiciume verde, procurandosi una punizione di due giorni senza budino. Ora, tutto ciò che mancava era un contenitore. La vernice era rimasta a decantare sul ripiano più alto del suo armadio per tre mesi. Adesso sobbolliva ed esalava un magma potente come metano e attendeva tra i miasmi il suo riscatto. «Si può usare per dipingere i mobili, le pareti, la puoi anche mettere sui vestiti e non va via. Non è tossica, senti che buon odore?» «Puah, che schifo, toglila, sa di cacca di mucca!» «È tutta naturale!» «E come la porterai a scuola?» «Infatti. Devi trovare il barattolo. Adesso prova a prenderne un po’ e a spalmarla sul tavolo.» 137 «Sul tavolo?! Fabio, tua mamma ti ammazza. Arrivi a un mese senza budino, minimo.» «E allora? Sai pensare solo al mangiare, te.» «Gnè.» «Dai, prova.» Ne spalmai una minuscola ditata sul tavolo, e rimasi stupefatta. Pensavo sarebbe scivolata via, liquida e molle come muco di un influenzato. Invece rimaneva appiccicata lì, densa e inamovibile come il catarro di un tisico. Provai a cancellarla passandoci sopra veloce il polpastrello. Niente. «È fantastica! Funziona!» «Sì» disse Fabio, e gli brillarono gli occhi di una luce infinita. Ora, quello che successe fu che io trovai il contenitore adatto. Sul ripiano più alto della dispensa scovai per caso un barattolo di Nutella mezzo pieno, che raggiunsi salendo su una sedia, spostando tre scatole di corn flakes e scavando dietro quindici pacchetti di caffè. Lo vuotai a cucchiaiate rimpinzandomi di molle crema, ripetendo a ogni piccolo morso di senso di colpa che era per una giusta causa. «Gliela faremo vedere, a quella stronza. Fabio è bravo gnam gnam e anch’io, e non è vero che non vale gnammmmniente. Gnamgnamgnamcerto, slurp, sarà un trionfo.» Poi portai il barattolo vuoto e ancora un po’ macchiato di marrone a casa del mio amico, e insieme lo riem- 138 pimmo di sbobba verdognola. Chiudemmo il coperchio zigrinato con forza da corsari, e attendemmo felici il venerdì. E poi le fighette presentarono le loro case di cartone. Simone fece eruttare una colata di ribes guadagnandosi l’eterno rispetto dei compagni e un assai poco invidiato bacio della maestra. Io alla fine lessi un racconto su come i ragni possono essere considerati nostri amici, considerata la loro golosità per le mosche, facendo arricciare venti narici all’unisono e applaudire in solitaria il mio leale amico. E Fabio tirò fuori dalla cartella il barattolo pieno di vernice ecologica. Lo prese con le mani arrossate, lo strinse e non dovette fare molta strada per portarlo fino alla cattedra. Gli bastava allungare le dita di dieci centimetri, non doveva percorrere tutta l’aula come avevo fatto io, sentendomi le gambe molli. Non doveva essere difficile. Ma sua mamma, quel giorno, gli aveva spalmato i palmi di NoMorePsoris, una crema americana che sedava il prurito. E proprio mentre il mio cuore, e il suo, sembravano essere gli unici rumori nell’aula, sembravano sovrastare i bisbiglii di scherno di Simone e le risatine cavalline delle fighette, e i pensieri e le paure e la solitudine e l’illusione, e i giochi insieme e i progetti e il suono ancora più forte degli anni che sarebbero venuti, e il 139 desiderio di come sarebbero dovuti essere, ecco che i battiti cessarono e un unico rumore invase ogni cosa. Di vetro che si rompeva, cadendo sul pavimento e di una sostanza vischiosa che si rovesciava, sulle piastrelle, indelebile. 140 [attraverso passaggi fotografi] Manuela Marceddu | Dodo | 2010 Simona Pinna | In viaggio | 2010 145 Simone Lisci | Verso il mare | 2010 [attraverso passaggi dialoghi] Dove siamo Sasha Tsinski | Quindi, dove siamo? Ugo Coppari | Al Bar Trieste, no?! ST | Non intendevo questo. Facevo riferimento al tuo nuovo video. In Limbo mobile sembra che tu voglia continuamente mettere in discussione la tua reale presenza in un determinato luogo. Sia il montaggio che lo stesso titolo sembrano volerci dire che quello in cui abitiamo è soltanto un limbo. Cosa stiamo aspettando? UC | Sinceramente non so cosa stiamo aspettando. Personalmente ho smesso di chiedermi tutte queste cose. Piuttosto cerco ordine e armonia. Si diceva che un artista debba sempre tenere il proprio salotto in ordine, sistemarlo e pulirlo quotidianamente, così quando arriva l’ospite, ovvero l’intuizione, questa sarà ben disposta a fermarsi. Ma questo non ha solo a che fare con la produzione artistica, ma anche con la vita di tutti quanti, di tutti i giorni. Pure le massaie. ST | E che c’entrano le massaie? UC | No, in realtà stavo pensando a un servizio che ho visto ieri su Rai2 - Costume e Società. Gli esperti, anche se 151 a dire il vero non so di cosa [dice ridendo e indicando la televisione che è in fondo al locale – NdR], consigliavano alle massaie come risparmiare sulla spesa. Dicevano che ad esempio al mercato il sabato e la domenica si può risparmiare fino al 30% sulla frutta e la verdura, perché ci sono le rimanenze. O che se il pesce fresco arriva in città il mercoledì, ecco che il giorno dopo già costerà qualche euro in meno. Massaie, è solo questione di tempo! Di saper aspettare! ST | Perché hai scelto proprio l’immagine del limbo? Forse perché come i bambini che abitavano questo luogo indefinito, noi siamo già morti e peraltro colpevoli? UC | Questa è una bella interpretazione. Sinceramente non ci avevo pensato. In fondo quello che dici è vero, siamo morti bambini e, cosa ancora più angosciante, siamo morti colpevoli. Si diceva che le anime morte bambine galleggino in questo limbo, e che non possano accedere al paradiso perché non avendo avuto il tempo e la possibilità di espiare i propri peccati nel proprio percorso di vita, sono rimaste macchiate per l’eternità. E tutto ciò ha dell’incredibile: come se venissi arrestato ancor prima di tentare una rapina. E magari solo perché avevo un passamontagna in auto. E se ti dico che in realtà faceva solo freddo? ST | Ho capito cosa intendi. E se ti dicessero che il freddo fosse un movente plausibile? 152 UC | Non sarebbe credibile, o forse sì. Comunque volevo raccontarti una cosa che mi è successa tempo fa. Ero chiuso in auto e stavo aspettando un mio amico, al riparo dal freddo. Potevo osservare i passanti senza che questi notassero la mia presenza. E vedevo che le persone adulte, quando non sanno di essere viste, si atteggiano come dei bambini, i cui movimenti sono molto meno spezzati. C’era un signore molto elegante, che avrà avuto una cinquantina d’anni e che aveva una scarpa slacciata. Si ostinava a camminare con la scarpa slacciata, a costo di non fermarsi e fare dei movimenti scomodi. Allacciarsi le scarpe ci fa ritornare bambini, in fondo: è un gesto elementare, tra i primi che impariamo: e che poi diventa meccanico. Allora questo signore si apparta in uno spazio buio, si guarda intorno, appoggia una scarpa su un muretto e si allaccia la scarpa. Poi si riaggiusta l’abito in maniera goffa e spontanea, come se fosse a casa sua. E quando ritorna nella zona illuminata, sul ciglio della strada dove aveva parcheggiato la propria auto, ecco che riprende la postura che aveva assunto precedentemente. Eretto e meccanico. E mi sono detto: È un gioco! Ma non sto parlando dei ruoli di Meyrowitz o di cose del genere. È che con gli occhi avevo tolto i vestiti a quell’uomo. E me lo immaginavo nudo, che si muoveva. E pensavo a quando magari faceva l’amore con la moglie o quando magari si masturbava, o quando magari giocava a tennis o che ne so io quando nuotava al mare. Me lo immaginavo sempre nudo e allora vedevo un bambino. Ma nel corpo di un adulto che era già morto: il disfacimento della carne intaccava anche lo spirito. 153 ST | Hai tempo per un’altra domanda? UC | Questioni di tempo, come dicevi prima. Mi dispiace ma devo proprio andare. Devo far revisionare l’auto, che mi è stata prestata da mio fratello. ST | Dimmi almeno i tuoi progetti futuri. UC | Tirare fuori qualcosa da questo limbo, e trovare i soldi per anestetizzarmi. 154 Doppia velocità Fabrizio Gabrielli | Zirriagga, tzilleri, pattadese. Frazziggu, chigno, ballocci. Greffa. Sette parole che non conoscevo, prima di leggere Gianni Tetti, significanti inediti per significati che pure avevo dentro. Defamiliarizzazione del familiare. Unheimlich puro. Nel leggerti s’ha come l’impressione di averle già viste e conosciute, quelle scene che racconta, eppure di non averle mai sentite, raccontate così. Come quando guardiamo un prato fiorito, diceva Lovecraft, e di punto in bianco ogni fiorellino di quel prato comincia ad intonare una nenia. Come sentirsi raccontare una favola rovesciata, e alla fine: niente. Dìcaci: quanto ti aiuta la Tua terra, la sua ancestralità spesso macchiettizzata, gl’afflati magici, a scolpire nel granito i personaggi e le epiche corali de I cani là fuori? Gianni Tetti | La mia terra mi aiuta, sempre. Anche a non sentirmi troppo solo mi aiuta. Come farei senza questa terra calda che non trema mai. Come farei senza sapere che appena torno a casa posso subito sentire l’odore del mare. E il vento in faccia. Non lo so come farei. 155 So però che l’ancestralità di cui parlo non è solo della mia terra, ma è dell’uomo. Ogni uomo ha un nucleo ancestrale nero come il petrolio. L’istinto, la rabbia, la voglia. E di questo parlo. Perché i sardi calpestano il futuro come gli altri e i miei personaggi ci vivono dentro a questi anni sottozero dove se non ringhi tanto peggio per te. E ho pensato che all’ultimo piano del palazzo di una multinazionale a New York, dove lavorano i pezzi grossi, si ringhia molto più che tra la gente di cui parlo io, che vive tutta sottoterra. E ho pensato che di tutto questo volevo parlarne. Di questo mondo dove tutti sono buoni e sono cattivi allo stesso tempo. Dove il più forte vince. Dove c’è sempre qualcuno più in alto di te. E così via. Quando scrivo voglio essere prima di tutto onesto, parlare di mondi che mi appartengono, creare personaggi che sono un po’ pezzi di me e un po’ pezzi di qualcos’altro, e onestamente i mondi che mi appartengono non sono tanto quelli ancestrali e misteriosi della Sardegna che tutti si immaginano, quanto quelli vuoti di periferie piene di asfalto o contorti del centro storico. E il bello è che siamo sempre in Sardegna e i luoghi che descrivo sono soprattutto rubati alla città dove sono nato: Sassari. Ed è qui che c’è l’ancestralità, quella senza patina, quella che può fare paura davvero, sensazioni che si costruiscono attraverso storie sentite in giro, mezze parole origliate per strada, sguardi sconosciuti presi ovunque ed esperienze personali. Prima guardo e ascolto o ricordo, poi prendo, poi metabolizzo, manipolo, violento, provando a dire la mia. 156 Alla magia non ci credo poi tanto. La magia è nelle parole della gente. E io credo alla gente che vuole qualcosa (che sia giusta o sbagliata non conta) e le prova tutte per ottenerla. È tutto umano, tutto sangue. Sono le credenze che ci piacciono tanto ad essere magiche, ma io non le vendo come vere queste credenze, le metto solo in bocca a chi ci crede, perché solo chi ci crede ne deve parlare e ne parla anche se il mondo tutto intorno gli dice che non c’è niente di vero. Ne parla perché se gli togli certe cose, ai miei personaggi non resta più nulla per vivere. I miei personaggi vivono di questo: i sogni, le illusioni, le piccole libertà che sono sempre troppo piccole e la vita che ogni tanto ricorda a tutti che è meglio non farsene troppe di illusioni. La mia Sardegna è questa: vento, odori, ricordi e cemento. [Gli facevo una domanda e lui mi rispondeva. Succedeva quasi un anno fa. Poi con Gianni ci siamo conosciuti, l’estate scorsa, eravamo a Quartucciu e abbiam fatto quelle cose che si fanno quando ci si conosce di domenica a Quartucciu: stringersi la mano, sedere allo stesso tavolo, mangiare il porceddu, eviscerare e sezionare questa domanda piuttosto che quella risposta. Io lo so, perché me l’ha detto Gianni, che all’inizio la domanda che gl’avevo posto per i modi verbosi di Malicuvata l’aveva lasciato interdetto. Piccato. Perché ero andato ad attingere al banale ruscello della sarditude. Ed infatti s’era curato subito di ricondurre il fluire del discorso, lui, con dighe pittate da slogan pieni d’animalità rabbiosa ed umanità barbarizzata, al placido lago – pur tuttavia oscuro – della 157 quotidianità. Oscura e sorprendente, piena di vento, odori, ricordi, e cemento. Ripigliamo da là, sotto invito di Carlo Palizzi. Come se non fosse passato tutto questo tempo. Come se non fosse stato tutto un dirci ròbe.] FG | Danilo Soscia, intervistandoti qualche tempo fa per l’internètte, s’è reso protagonista, suo malgrado, penso, d’un siparietto divertente invero. In due parole, per chi non avesse letto quell’interessante conversazione, mi prendo la briga di raccontare come è andata. Lui esordisce, con una brillante intuizione, più o meno così: una lettura superficiale farebbe dire che esiste un’affinità tra la tua scrittura e quella, per dire, di Aldo Nove, il feticismo delle merci, il vuoto cosmico e pneumatico che inficia la nostra capacità di discernimento e blablà, e poi un sacco d’altre ròbe interessanti, se non fosse che tu gli confessi candidamente di non aver letto una riga di Aldo Nove. Tempo fa mi ci sono imbattuto, io, in una poesia di Nove, si chiamava Sognando aa roma. Pacifico è che non abbia sortito l’effetto di rendere ai miei occhi Nove un to read sottolineabile a doppia vergata, anzi: avevo trovato quella sua nuance nazipop decisamente troppo nazipop, apprezzando piuttosto l’approfondimento tributatogli da Tiziano Scarpa (cosa che pur tuttavia non aveva sortito l’effetto di rendere Scarpa ai miei occhi un to read sottolineabile a doppia vergata), specie un passo in cui si spiegava in che modo la poesia di Aldo Nove mostrasse bene come il calcio sia diventato anche categoria interpretativa di tutto. C’è un elemento ricorrente nel tuo La medicina: i ricordi legati al Milan, all’album di figurine 158 Panini, al pallone autografato da Marco Van Basten. Al videogioco dei mondiali. Il calcio assume spesso e volentieri le fattezze di grimaldello interpretativo della società: l’amore incondizionato per la propria squadra, il tramandarsi una fede di padre in figlio, l’indissolubile suo esser legato a doppia mandata all’età delle passioni irrazionali, l’infanzia. E via discorrendo. Mi vien da chiederti, allora, se pure tu credi nella potenzialità metaforica del giuoco del calcio; quanto credi, giusto per rimanere in tema canilàfuori, contribuisca alla molossizzazione dell’essere umano (intesa come bestializzazione alla fine della fiera sterile, poiché votata ad un susseguente addomesticamento); e poi perché proprio il Milan. GT | Da piccolo volevo fare il calciatore. Come un sacco di bambini. Di sicuro come quasi tutti i miei amici. A parte uno che voleva fare l’avvocato. E ci è riuscito. E uno che voleva aggiustare materassi. Ma non ci è riuscito perché il negozio del padre è fallito. E poi c’era quello che si era fissato con la religione. E mio cugino, che voleva fare Terminator e uccidere tutti. Vabè, a parte questi gli altri volevano fare il calciatore. Io volevo fare il calciatore e quando facevo un gol esultavo come Fabrizio Ravanelli. Mi piacevano i calciatori lunghi e dinoccolati, tipo Faustino Asprilla, o Julio César Dely Valdés (quel centravanti del Cagliari pagato due lire e rivenduto a miliardi). E quindi, io che ero un ragazzino piccolo e sporco volevo giocare come quei giocatori alti e neri che toccavano la palla come se stes- 159 sero accarezzando un bambino appena nato e che quando calciavano quasi non facevano rumore. E in questo ero abbastanza originale, alla fine. Allora, lasciamo perdere Aldo Nove. Che non c’entra nulla. E pure Tiziano Scarpa. Che non c’entra neppure lui. E molliamo tutti quanti. Parliamo di pallone. Il pallone è di cuoio. Gira. Lo puoi calciare. Oppure lo prendi con le mani. Se lo prendi con le mani o sei un portiere o sei Maradona. Se sei Maradona, la tua mano è quella di Dio. E il tuo piede pure. Se sei un portiere, salvati se arriva Maradona. Il pallone non è una cosa seria, ma se la palla è dentro e tu mi dici che è fuori, io vengo lì, ovunque tu sia, vengo lì e ti spacco la faccia. Ecco. Volevo fare il calciatore ma anche lo scrittore. Però più il calciatore. Ma alla fine niente calcio. Perché comunque i sogni non si avverano mai. E non ci credere a chi dice il contrario. Uno che dice il contrario è il presidente del Milan. Ecco perché parlo del Milan e di Van Basten: perché il Milan era una squadra da sogno. E Van Basten era il cigno di Utrecht. E penso che per molte persone, avere un incontro con Van Basten o ricevere un pallone firmato da Van Basten, sia stato il momento più alto della loro vita. E che molte di queste persone credono nei sogni del presidente. E che il presidente ci crede meno degli altri. E adesso basta con questo presidente, perché neppure lui c’entra molto col calcio. Anche se sembra il contrario. E quindi il Milan. Ma ti faccio notare che in Adela si parla dell’Inter. E che ne Il dente si parla della Torres e del Cagliari. Il calcio è dappertutto. E tutti parlano di calcio. Chi non parla di calcio è un’élite. Voglio 160 parlare di esseri umani e voglio che siano verosimili, quindi i miei personaggi a volte parlano di calcio. Anche se hanno problemi più seri. Van Basten invece c’entra col calcio. Lui era un cigno. E Cruijff era il papero. Mi chiedo sempre come mai in Olanda paragonano i calciatori a grossi uccelli acquatici. Allora, mi immaginavo Van Basten, alto e sorridente, firmare il pallone al babbo di Giona. Giona è il protagonista de La medicina, il racconto a cui ti riferisci. Allora, il babbo di Giona è basso, ha un berrettino del Milan, un bomber preso dai cinesi, la sciarpa bianca, i jeans e le Nike, pulite pulite. Pulitissime. Nuove, sempre nuove devono essere, pensa il babbo di Giona. E insomma, Van basten sorride e firma palloni. Poi uno di questi arriva a Giona. Che se lo ricorda ancora. Perché il calcio può anche essere tutto, dove non c’è niente. E volevo fare il calciatore. Mi sarebbe piaciuto. Adesso no. Si suda troppo. Adesso guardo le partite, simpatizzo. Non per il Milan. E nulla. FG | Io le più balorde contraddizioni in termini, le forzature più clamorose che ho trovato nei meccanismi del calcio italiano le ho sempre viste vestite di rosso e nero, per questo te lo chiedevo: ne La medicina si avverte una storpiatura, un pizzico di inquietante fuoriposto, come l’ombra che ti fa sembrare biforcuta la coda del gatto nero sotto casa, come i capelli platino di Ibrahim Ba. Una cosa che mi faceva molto ridere, da ragazzino, era un siparietto di Giobbe Covatta che parlava d’un tifoso milanista razzista, xenofobo e decisamente pirla, in 161 preda a deliri esistenziali di fronte alla figurina Panini di Gullit: è un gran campione, si diceva. Epperò è negro. Epperò è un gran campione. Ad oltranza. Crescendo ho capito che son tante le cose del Milan che fanno sorridere, però amaramente, ché pur volendo c’è mica troppo da spanciarsi: Bertinotti che tifa per una squadra della quale odia il presidente, ad esempio, lo trovo discretamente avvilente. Ad esser buffi, invece, buffi e basta erano Dely Valdés col suo dente d’oro, a pensarci bene, o Asprilla con le sue capriole goffe. Che poi era di Panama City, Dely Valdés, ed in nazionale erano tre fratelli, come e peggio dei Derricks di Holly e Benji, per dire; ed era sempre sorridente, Dely Valdés, impressionante. Anche sulla foto del suo profilo di fèisbuc, guardalo: ride. Vai a capire se è felice sul serio. Conosco un macchinista che piazza le pizze al cinema per far ridere la gente in sala, mette su bobine comiche anche se soffre di depressione cronica ed è in cura dall’analista da una decina d’anni. Fèisbuc, la finzione, gl’infingimenti: quanto e come bazzichi, tu, la pagina della effe bianca su campo blu? Credi possa essere considerata la palestra d’infingimento definitiva, massimamente efficace? (Io la vedo così, ad esempio: ho scritto un paio di volte che ero in partenza per Reykjavik e ci son cascati quasi tutti, per quelli ero uno che viaggiava con frequenza da e per l’Islanda, per dire, ha funzionato il meccanismo della finzione.) E allora: quanta linfa vitale apportano, le reti sociali, se la apportano, ed in che modo, al tuo mestiere di scrivere? 162 GT | Facebook. Le reti sociali. Sono rimasto estraneo per un bel po’. E tutti mi dicevano non puoi, non puoi, devi entrare su FB. E quando ho scritto I cani là fuori allora ho pensato di entrare nella rete. Mia sorella Antea mi ha fatto il profilo. E adesso vado da solo. Ci sto abbastanza. Entro, poi faccio altro, mi faccio i cazzi miei ma ci sono e ogni tanto do uno sguardo. Ho ritrovato i miei compagni delle elementari e delle medie. E faccio amicizie impossibili, tipo gente con cui non parlerei mai, o con cui non condivido nulla, o scrittori famosi o attori. Diventiamo amici, perché magari ci siamo visti una volta da qualche parte, senza neppure parlare, o per motivi così. Diventiamo amici e basta, poi non abbiamo più contatti, nemmeno uno. Ma io guardo le foto. Leggo gli aggiornamenti. Ce n’è uno appassionato di motori che mette solo foto di macchine veloci e scrive cose tipo “ouuuuuuu” “spazialeeeeee” “lascia perdereeeee”. Scrive cose così, urlate. E un altro se la prende con tutti, è polemico. Quindi tu gli scrivi una cosa, e lui interpreta sempre male. Sempre. E quindi parte la polemica. E c’è uno che scrive strane minacce in inglese, ma non si capisce a chi. Scrive tipo “la fine è vicina”, “guardati le spalle”, “sono arrivato per punirti”. Una tipa invece mette le foto di lei nuda (e ha due tette enormi), e parla continuamente di come si farà i capelli o di come si tingerà le unghie. Uno parla solo di scacchi, un altro critica il governo (e fa bene), una tipa non si perde un rave party. E poi ci sono quelli che soffrono, e lo scrivono su internet quanto soffrono. E tu pensi, cazzo questo sta proprio soffrendo. Soffrono per amore, oppure 163 per il lavoro che non c’è, o per quello che c’è, contro il capo ufficio, contro la madre. Poi c’è quella che parla solo del suo cane. E quindi tutti difendono i cani. I cani su FB guai a chi li tocca. Se dici una cosa contro i cani ti tagliano la gola. E ce ne sono anche altri, ma adesso non mi vengono in mente. FG | Che poi magari mi sbaglio, ma non pensi anche tu ci sarebbe da contemplare una ridefinizione del concetto di amicizia? Voglio dire, Zuckerberg andrebbe citato in giudizio per appropriazione indebita di lessema. A me capita d’incontrare per la strada gente mai vista in precedenza che poi magari ci scambi due parole, oh, non ti trovi su niente, ma sai tipo gli antipodi? Eppure fieri ti ricordano siamo a-mi-ci su fèisbuc, ed il fatto che a quel contatto non corrisponda poi un’amicizia nella vita normale, una ròba universalmente accettata come amicizia in quella cosa universalmente riconosciuta come vita, ecco, mi fa venire la vocazione del lessicografo, a me. (Per inciso, la persona che facessi io il Garzanti metterei rappresentato vicino al lessema “amico” neppure li bazzica, i socialcòsi, come li chiama qualcuno.) Immergendoci più a fondo nel limbo dell’universalmente accettato come, spulciamo un po’ la tua visione del ruolo della scrittura. Volessimo cercare di categorizzarla, questa visione, ti sentiresti di ricondurla ad una delle categorie prefabbricate, non so, tipo “scrivere per me è un impegno sociale”, “scrivo per raccontare sic et simpliciter”, oppure mi ti spingi più in là e mi crei un’etica scrittoriale del tutto inedita? 164 GT | Una volta l’ho fatto anche io. E mi sono vergognato. Usavo FB da poco. Un certo entusiasmo nel perdere tutto quel tempo a cazzeggiare con gente. A un certo punto incontro per strada uno. E ci avevo chattato il giorno prima. E allora glielo dico: ciao, siamo amici su feisbuc. Il tipo ride, fa: ah sì, mi ricordo. Io penso che sono un coglione, e comunque gli dico questa cosa: comunque The piper at the gates of down è bestiale. In chat stavamo parlando dei Pink Foyd. Il tipo attacca a parlare dei Pink Floyd, di Syd Barret, e dei Camel, e della scena londinese del ‘65. Tutte cose interessanti. Ma me ne devo andare. E alla fine non ne avevo neppure voglia di parlare con quel tipo. Gli do una pacca sulla spalla e me ne vado. E mi sento ancora più coglione. E pure il tipo ha pensato che questo è un coglione. Io ho pensato che alla fine che cazzo le conosci a fare le persone su FB se poi quando le vedi in strada non le puoi nemmeno salutare. Vabè, l’ho fatto. Mai più. E quindi l’amicizia lo so cos’è. Ma faccio prima a dirti che io ho pochi amici. Loro a volte mi ricordano chi sono. Punto. Sono curioso di sapere come la pensi tu su questo fatto del ruolo della scrittura. Comunque per parlare della scrittura mi attacco al discorso sull’amicizia. Per scrivere devo ricordarmi chi sono. Ma chi sono davvero. E quindi ti dico la mia. Un po’ di tempo fa ti avrei detto che per me scrivere era come vomitare: doloroso ma liberatorio. Poi ho capito che mi piace essere letto. E allora scrivere è anche un fatto di egocentrismo. Di narcisismo. E poi ho capito che ci tengo a scrivere roba buona. 165 E quindi diventa quasi una questione di orgoglio. E siccome sono sardo tutti diranno che questo se l’aspettavano. Ma vabè. E quindi poi secondo me la scrittura è una cosa bella interessante che deve divertire formare e far pensare. Lo scrittore deve essere onesto. E onestà non vuol dire scrivere cose vere. L’onesta è la più grande qualità che può avere uno scrittore. Prima di tutto onesto con se stesso, bisogna guardarsi dentro e non avere paura. Io ci provo. Scrivo da quando ho imparato, cioè a cinque anni. E mi sembra di non aver mai fatto altro in vita mia. Scrivo perché voglio dire la mia. Scrivo perché ci tengo a me. FG | Guarda, ti faccio una confessione. Me l’avessi posta tu, questa domanda, lo so mica se t’avrei risposto. È che proprio m’innervosisco a sentirmi chiedere perché scrivi. È una domanda imbecille, inutile, pretestuosa. Chiediamo forse al pescivendolo il motivo per cui vende il pesce? Quello s’alza la mattina ed in testa c’ha un turbinio di ròbe: dove sistemare i merluzzi, come presentare le ombrine, quali spigole acquistare e quante cozze ormai irrimediabilmente avariate c’è da buttare nel cassonetto. Il pescivendolo sa che tutti i giorni dovrà impiastricciarsi la parannanza col sangue dei pesci. Non si chiede se sia il suo destino, o piuttosto il frutto d’un intestardimento. Sa solo che è tutto preso dall’attività di vendere il pesce, e certi giorni è felice, certi altri no. Non so se s’è capito, ma mi sta molto a cuore, il problema dei pescivendoli intesa come categoria sociale, ecco; non so se s’è capito che 166 era una metafora. Questo per spiegare i perché. Che poi ci sono i come. Come e al contempo al contrario di te, credo nella scrittura come strumento per ricordarmi chi (non) sono. Da un punto di vista, la storiella di Reykjavik è significativa: scrivo perché scrivere è l’unico mezzo che conosco, l’unico che mi è permesso maneggiare, per manipolare la realtà, per dare ad intendere che. Godo nell’intessere reticoli di finzione. Nel mettere e mettermi in discussione. Nell’instillare il germe del dubbio, dell’inadeguatezza. In me e negli altri. Quel fatto dell’egocentrismo, la vedo così, quell’ergersi al centro del mondo facendo leva sulla penna, è solo un modo meno doloroso per raccontarci quanto siamo emarginati. L’isola è un’isola solo se la vedi dal mare, quando ci sei sopra ti sembra una landa sterminata. E forte di quell’onnipotenza scrivi, sei l’ombelico del mondo, d’un mondo che non si lava mai l’ombelico. Scrivere per me è un gioco. Una sfida costante con il lettore. Non sono accomodante, nei confronti del lettore, non lo sono nemmeno con me stesso, figurati. E poi credo ci voglia un po’ di spocchia. E l’onestà di riconoscere che ce l’hai, quella spocchia, perché è quella che ti fa stare le ore intere con le braghe calate e la resa dei conti in tasca di fronte ad un’idea. Per come la vedo io, la scrittura è nomadismo, è perdersi ramingo per i meandri dell’insondabile, con la consapevolezza che per comprendere non c’è da far altro che riconoscere l’impossibilità di comprendere. 167 Solo dopo esser scesi a patti con quest’ineluttabilità, paradossalmente, inizi a comprendere. Però ecco, mi comprenderai, c’è da chiuderla, questa chiacchierata. Non sto qui a chiederti i prossimi progetti, consigli su libri da leggere o non leggere, né tantomeno perché un lettore dovrebbe scegliere proprio te, ché l’ho sempre trovata una domanda del cazzo, io, quest’ultima, quasi più stronza di perché scrivi. Allora faccio così, rubo l’idea alla Paris Review e ti chiedo di descriverci il posto in cui ti viene meglio scrivere. La stanza in cui lavori. Che magari capiamo una cosa in più su Gianni Tetti, una in più di quello che riusciamo a capire spulciando il tuo profilo su fèisbuc, s’intende. GT | E sì. In qualche modo la dobbiamo chiudere questa chiacchierata. E mi sono divertito. Allora, caro amico mio, per me scrivere non ha nessuna sacralità, e quindi dove sono sono e se ho voglia di scrivere scrivo. Con carta e penna o con il computer, non cambia molto. Comunque il posto dove mi viene meglio scrivere è il bagno. E adesso ti spiego come faccio: mi siedo sul cesso, metto il computer davanti a me e mi metto a scrivere. Il bagno è intimo, è silenzioso, il rumore dell’acqua è rilassante e tutte quelle mattonelle celesti mi aiutano a pensare. Nel bagno c’è la vasca e la lavatrice e una finestrella. Al bordo della finestrella metto il portacenere e ci appoggio la sigaretta. Lì scrivo, rileggo, riscrivo, insomma faccio le solite cose. E non è una bugia. È la verità. 168 Un’altra verità è che scrivo spesso a casa mia e che ho una stanza che fa da studio. Casa mia è al quarto piano di un palazzo che dà su una piazza. Nel mio studio ci scrivo a volte. Non sempre, solo a volte. Ci sono libri, un divano, un computer e fogli sparsi e cd. Le pareti del mio studio sono verdi. E nel mio studio c’è anche una cyclette mai usata e una panca per addominali mai usata. E ci sono perché qualcuno ha pensato che le potessi usare e me le ha regalate. E anche io, per qualche giorno avevo pensato che magari le uso, che così mi metto in forma. E invece niente ma sono in forma lo stesso. E c’è una finestra nel mio studio, da questa finestra si vede la piazza. E io guardo la gente che va e che viene, la guardo. Non è detto che questo mi ispiri qualcosa, comunque io lo faccio: guardo la gente dalla finestra dello studio. E nel mio studio c’è una poltrona gonfiabile che mi hanno regalato a Milano. La poltrona si sta sgonfiando piano piano e non so come fare per rigonfiarla. Perché è enorme e gonfiarla a fiato non fa. E poi scrivo quando sono in viaggio, scrivo in stazione, in treno, sulla nave, sull’aereo, in aeroporto. Scrivo in tutti questi posti qua, che sono posti di passaggio. E scrivo sulle panchine di tutti i posti. E una volta mi sono seduto alla fermata di un bus di Bologna. Ma non dovevo prendere il bus, è solo che non sapevo dove andare. E allora mi sono seduto là, e mi sono messo a scrivere. Mentre passavano sempre gli stessi due bus. La fermata si riempiva per qualche secondo, poi arrivava il bus e la fermata si svuotava. E nulla, io me ne stavo lì seduto a guardare la gente che saliva e scendeva. 169 E nulla, alla fine mi è piaciuto. E una volta ho sentito uno che li chiamava non-luoghi, e mi è piaciuto pure questo. Dimmi la verità, anche tu ci scrivi un sacco nei non-luoghi. FG | Io non lo so, fratello, come t’è venuto pensato che possa essere il tipo di persona che scrive nei non-luoghi. Epperò: bingo. Anche se per la precisione dovrei dirti che alla fine della fiera non posso davvero dire di scriverci, in quei non-posti là: ci afferro il bandolo della matassa, quello sì, che è più un non-scrivere, però, che è tutt’un’altra cosa. Perché invece poi c’ho la stanza del rammendo. Difficile, provo a spiegartelo meglio. Vedi, mi succede di questo. C’è che negli ultimi tempi mi è diventata una ròba d’una macchinosità incredibile, scrivere, sebbene quella macchinosità costituisca quasi una specie di metodo. Nel quale i non-luoghi hanno un ruolo centrale. Giro con una mazzetta di post-it gialli in tasca. Ho provato coi quadernini, ma niente: li perdo sempre. I post-it, invece, no; che sembra una cosa strana, eppure. Dicevamo, i non-luoghi. In treno: mi sento male, se scrivo. In aereo: pure. In macchina, mentre guido, mi pigliano invece certi raptus che mi devo fermare alle piazzole di sosta, tanto ho i post-it, penso. Infatti arrivo sempre in ritardo. E poi c’è il porto. Al porto ci capito spesso, è un reticolo di strade che non portano da nessuna parte e rotaie inutilizzate e cemento, il porto della città dove vivo, che potrebbe essere Tolone, Algeciras o Tangeri, a guardarla da mare, e invece è Civitavecchia. 170 Vado là, anche se non ho mica da imbarcarmi su nessuna nave, e piglio appunti. Anche a lavoro scarabocchio sui post-it, il posto dove lavoro io è pure quello un nonluogo, un luogo di tutti ma di nessuno, è un albergo e non sei mai davvero a casa, in albergo. Infatti come si dice: questa casa non è un albergo. Tutti quei post-it li appendo su un quadro che ho nello studio, è un quadro orrendo, una litografia d’un pellegrino che ho vinto per aver svolto il miglior tema sul Giubileo quando ero alle superiori, me l’ha consegnata Storace in persona, pensaté. Ad esser brutto è brutto, però i post-it sopra ci stanno che è una meraviglia. Lo studio, dicevamo, è la stanza del rammendo. Ogni tanto, come Concato con i fiori nelle domeniche bestiali, colgo un post-it dal prato appeso al muro. Poi un altro. Un altro ancora. Ne affianco una manciata nei quali intravedo una linearità di fondo. E lì imbastisco. Non saprei dirti se il mio vero atto di scrivere sia questo, la stesura finale, o quello precedente, il concepimento. Sono a due tempi, come i Garelli o la politica dell’Unione Europea. GT | Cazzo, cosa mi hai ricordato: il Garelli. Mio zio ci andava su un Garelli. Mio zio era riccio, era alto, parlava quasi sempre in sassarese e sapeva tutto di televisori, radio e motori. Vabò magari questo non c’entra un cazzo. E comunque mio zio tifava la Ferrari, Alain Prost. E poi adesso che ci penso, questa storia dello zio la metto in qualche racconto. Perché della scrittura penso anche un’altra cosa: che 171 non si butta via niente, come il maiale, come la balena. E che tutto torna, come nella vita… [Tutto torna, come nella vita. Il fatto è che saremmo andati avanti ad oltranza, nel dialogo, io e Gianni, però ad un certo punto dobbiamo interromperci, che ci piaccia o meno. Ce lo diciamo in chat di fèisbuc, il più non-luòghico dei non-luoghi. La tronchiamo qua, vè? chiedo io. Iea, mi risponde lui. Una ragazzetta ha appena messo sulla propria bacheca Good time degli Chic, è il due novembre del duemiladieci, stasera gioca il Milan. Piove, dice lui. Anche qui, rispondo io.] 172 Il tempo narrato Marta Casarini | Nel tuo romanzo Il libro nero del mondo sostieni: “Vivere la propria mania è anche uno dei due modi per salvarsi la vita. L’altro è traslocare in un sentimento solido e irrinunciabile”. Tu che strada hai scelto? Considereresti la scrittura una mania? Gabriele Dadati | Io ho scelto entrambe le cose. È il momento dell’esecuzione, giorno per giorno, che mi vede vacillare. Quanto lascio che la mia mania sia al comando delle operazioni? Non lo so. Quanto lascio che l’amore che provo sia l’orizzonte entro cui mi colloco? Non lo so. Entrambe le cose però cerco di perseguirle. La scrittura è una mania nella misura in cui in continuazione si fa in modo che nella nostra testa avvenga una “narrazione del mondo” che riempie di parole le cose che ci stanno attorno e ce le ri-racconta. 173 La musica è un linguaggio? Lorenzo Mari | Nel tuo romanzo Rapsodia su un solo tema, le riflessioni sulla musica e sulla letteratura s’intrecciano senza sosta, e sempre con estrema naturalezza. Danno luogo a incontri, scontri, contraddizioni, deviazioni, fusioni sinergiche, e, non ultimo, anche ad ampie considerazioni estetiche. Claudio Morandini | È vero. Molti dei compositori di cui racconto la vita in Rapsodia praticano la scrittura, oltre alla musica. Carl Thalberg si ostina da anni dietro un trattato sull’accordo di settima di dominante (e va bene, qui siamo dalle parti dello scherzo) ed è il curatore del trattato rimasto incompiuto dal suo compagno Ethan Prescott; questi è poco meno che un grafomane, un trascrittore di tutto ciò che gli accade; Dvoinikov stesso ha accarezzato più volte in passato di scrivere su questo e su quello – essenzialmente sul suo antenato musicista e anch’egli poligrafo Joseph Mathias Mayer… Dietro a questa intrusione della scrittura c’è ovviamente una necessità, quella mia di ricondurre comunque alla forma del romanzo, alla narrazione, una materia che sembra appartenere ad altri ambiti. Ma non è solo questo. Prescott, e anche Dvoinikov, almeno nelle intenzioni, si affidano alla scrittura per dire ciò che non possono dire 175 con la musica. Visto che la musica sembra parlare solo di se stessa, erigendo strutture di puri suoni, rifiutandosi a ogni contaminazione con la vita (Dvoinikov ne è convinto, Prescott sembra più possibilista riguardo a una semantica musicale), ecco che la scrittura, le parole vengono in soccorso. Danno a Prescott uno strumento con cui leggere la realtà, o almeno provare a metterci ordine; e a Dvoinikov, addirittura, garantiscono una libertà che la musica, più ossequiosa alle regole proprie e alle direttive altrui, sembra negare. Entrambi, da musicisti che sanno bene cosa la musica è e cosa non è, tengono ben separati i due mondi. È il romanzo – sono io, cioè – che mescola le carte, e tenta di contaminare musica e scrittura, non solo ispirandosi con una certa libertà a una delle forme meno rigide della musica – la rapsodia –, o a una certa idea di musica a programma, ma anche ripercorrendo i diversi modi possibili con cui la parola può “raccontare”, o “analizzare”, o “parafrasare” la musica. LM | Pare, tuttavia, che non sia più possibile fare questo attenendosi alla meta-letteratura che è stata tipica del “postmoderno classico”, se mi passi quest’ultima definizione, un po’ paradossale. Dove sono finiti gli scrittori che parlano di scrittori che parlano di scrittori o i personaggi che parlano di altri personaggi che parlano ecc.? Sono stati sommersi dalla quantità di narrazioni disponibili oggi (tanto che andremo incontro, secondo Douglas Coupland, alla de-narrazione)? Meglio rifugiarsi nelle note, e nel loro confronto con le parole? In 176 altre parole, il testo meta-letterario è ormai da considerarsi come un oggetto d’antiquariato? Non serve più? C’è ancora qualche speranza nella riflessione interdisciplinare? Quale? CM | Da questo punto di vista, anche Rapsodia su un solo tema appare come un oggetto di antiquariato – o meglio di modernariato. C’è sempre qualcuno che, dopo aver letto un mio romanzo, ne nota l’inattualità – il più delle volte, per fortuna, si tratta di un complimento. Non è un problema per me: come ho già detto altrove, mi sento appartenere al Novecento, per ragioni anagrafiche e sentimentali. Soprattutto appartengono al Novecento i miei personaggi, come Dvoinikov, che guarda con disincanto alla fine del mito dell’originalità (ma non è un problema così grave, visto che per lui la composizione è essenzialmente un lavoro di alto artigianato…), e Prescott, che vive invece con una certa spensieratezza in un ambiente postmoderno (ma la contaminazione con il basso, con la techno di DJ Kosmo, lo riempirà di angoscia e di stizza). Per loro la classica, classicissima struttura a matrioska (uno che racconta di un altro che racconta di un altro che…) è un modo accettabile di intendere non solo la loro arte, ma anche la loro vita. Nessuno dei due corre il rischio di cadere nella de-narrazione; non ne possono sospettare nemmeno il futuro concepimento. Si comportano come “personaggi”, e tendono a leggere se stessi come figure di romanzo – be’, d’accordo, sono davvero personaggi da romanzo. Prescott anzi sembra vedersi come una figura da sit- 177 com… In questo senso, il più compiaciuto dei due è Dvoinikov, che nel racconto della sua vita ritorna quasi proto-novecentesco, e scivola un paio di volte in un decadentismo fuori tempo massimo. Ma lo si perdona, perché per lui inventare la propria vita come la vita di un personaggio di letteratura è un modo per rivendicare un controllo su di sé e coltivare un orticello di libertà. Tornando alla questione della meta-letterarietà: ho la netta sensazione che ogni testo sia un meta-testo – io, almeno, leggo così ogni cosa che mi capiti sotto gli occhi, al di là del contenuto, come una riflessione sul linguaggio. Non rinuncio al piacere di seguire le avventure corse dalle parole, di indagare la componente “narrativa” del linguaggio. Tu dici che oggi il modello ormai “classico” di meta-letteratura postmoderna è in crisi – e io ti credo, non frequento molto la contemporaneità, seguo di malavoglia i trend editoriali. Che sia sopravvenuto un effetto di saturazione? Troppi scrittori hanno scritto di se stessi o di altri scrittori? Troppi si sono interrogati sulla natura della scrittura? Troppi scrittori in crisi (ora volo più basso), ridotti a macchietta, troppi complessi da pagina bianca? Oppure la meta-letteratura è diventata un giochino superficiale, un ricorso ludico a stilemi, a comodi cliché? O infine nessuno si interroga più sulla scrittura perché nessuno (ora esagero) padroneggia più la scrittura? O nessuno ha più nulla da chiedere alla letteratura, se non placido svago e qualche salto sulla sedia al momento giusto? Non posso rispondere a queste domande – ma è certo, per dirne una, che il Calvino che indagava le potenzia- 178 lità combinatorie del narrare non sembra aver lasciato tracce tangibili oggi, tra gli scaffali delle librerie. Anzi, da qualche anno si diffida di quel modello, e lo si fa con uno strano sollievo, come se ci si fosse finalmente liberati da un gran peso. E non parlo da calviniano tutto d’un pezzo, bada, perché c’è ben poco di calviniano nel mio modo di procedere, di accumulare pagine nel corso di anni, lasciando che si creino connessioni e si sviluppino percorsi. Mi manca insomma quel suo senso progettuale della struttura – ma amo il mio modo arruffato di procedere a tentoni. Però sto divagando. Mi chiedi se la musica possa soccorrere la letteratura nella riflessione su se stessa, attraverso il confronto tra le peculiarità e le differenze dei due linguaggi. Perché no, mi dico. A patto che con “musica” non si intenda semplicemente il mondo colorato di chi vive di musica, la ascolta, la produce, la esegue, la scrive – in tal caso la musica vale quanto, che so, l’architettura, il giardinaggio o qualunque altro microcosmo popolato di personaggi più o meno singolari. E a patto che non si parli di “musicalità” della lingua – questa è semplicemente la cara vecchia retorica dei classici, altro che musica. Ma una letteratura che si avvicina alla musica, ne “imita” le forme, ne esplora le strutture, e allo stesso tempo non si illude di trasformarsi in musica, perché procederà sempre con approssimazione, per analogie o per contrasti – ecco, una letteratura così può avere un qualche senso anche oggi, sarà una riflessione sui fondamenti e sui processi del linguaggio. La cosa può diventare intrigante se, come fanno certi compositori o teorici della 179 musica, si mette in dubbio che la musica possa essere considerata un linguaggio. Il bello è che non mi sono posto questi interrogativi mentre lavoravo a Rapsodia su un solo tema. Ho lasciato lievitare il romanzo, animato soprattutto dal piacere dell’invenzione, o della reinvenzione – anche se l’ho concluso oppresso da un senso crescente di angoscia. Soprattutto, ero spinto dal desiderio di condividere una appassionata familiarità con la musica. Le riflessioni teoriche sono venute dopo, e sono ancora in corso, come vedi. 180 Strumenti per Antonio Tirelli | Dimostrate di tenerci all’uso consapevole del linguaggio e di lavorare sulla forma dei vostri racconti. Chi ve lo fa fare? Non è più semplice assecondare il pubblico parlando come i concorrenti del Grande Fratello? Dario Falconi | Non so se sarebbe più semplice. Non c’ho mai provato. La risposta è celata nelle ragioni che muovono la mia indolente volontà di scrivere. La scrittura è il mio strumento di ribellione contro l’omologazione del pensiero. Attraverso il linguaggio c’è una domanda dilacerante di sottiglianza. Una sottesa ed estenuante richiesta di attenzione. Non arrendersi alla superficie ma inabissarsi. Il mio lettore ideale? Uno speleologo inarrendevole. Fabrizio Gabrielli | Sai come diceva, Cervantes, nel sedicesimo secolo? Ya que las comedias las paga el vulgo / es justo / hablarle necio / para darle gusto, che poi significa “visto che le commedie le paga il volgo, tutto sommato è giusto parlargli basso, se ciò gli arreca gusto”. Eppure questa bella domanda invero del Tirelli è fallace nei presupposti. Anzi, doppiamente fallace. In primis, perché spoglia il linguaggio utilizzato all’in- 181 terno della casa di reclusione telemediatica d’ogni afflato sperimentalricercatorio. Non si faccia l’errore, non lo si faccia mai, di credere – ingenuamente – che dietro i codici linguistici ruffiani, sboccacciati, turpiloquio-aholici e rasentanti la blasfemia mediasettiani (così da includere anche un certo politichese easy, dalla giacchetta marinara a Porto Cervo, per intenderci) non si celi un sottile arrovellamento, tanto faticoso e proficuo quanto snervante, pari a quello dello scrittore o sedicente tale. In secundis, perché verità vera è che, nel mio caso, ricercatezza formale, sperticante sperimentalismo e uso consapevole dello strumento lingua da una parte, e grettezza lessicale o espressiva dall’altra, non si autoescludono. Anzi, traggono reciprochevolmente linfa vitale. Vedi Katacrash (Prospettiva, Brain Gnu, 2010): i personaggi sono infottati con la doppia acca e per dialogare con se stessi e col mondo utilizzano la lingua che ci si aspetti utilizzino tre giovanotti infottati con la doppia acca. Non è allora possibile “elevare” quella lingua underground, con il suo slang, la sua lessicografia, la sua sintassi? Per dirla quasi con presunzione, non si può donarle dignità culturale e letteraria? Ce l’hanno fatta in Argentina col Lunfardo. Ce l’hanno fatta in Francia con certi argot. In Italia tutta una serie di penne, chenesò Nori o Benati, riprendono il filo quasi ininseguibile della lingua parlata. Allora si può, anzichenò. Detto questo, chiuderei con un rotondo “ma che cazzo ho detto?”. Sai, giusto per assecondare i palati meno fini. 182 [attraverso passaggi graphic designs] [attraverso passaggi d’appendice] Ethan Prescott Rafail Dvoinikov – Sonata per viola sola, 1951 [Carl Thalberg, che in Rapsodia su un solo tema (Manni, 2010) ha raccolto e pubblicato le numerose pagine di Ethan Prescott dedicate agli incontri con Rafail Dvoinikov, ha continuato a scoprire, tra le carte del suo compagno, appunti e minute sul compositore russo. Prescott era fatto così: scriveva ovunque, caparbiamente, con la vena di un poligrafo di altri tempi (o di un grafomane, dipende dai punti di vista), in attesa di riordinare il materiale magmatico che andava accumulando. Traduco per gli amici di Malicuvata un frammento inedito, uno dei tanti, incentrato su una Sonata di Dvoinikov creduta dispersa, mai incisa su disco e, per quel che ne so, mai eseguita in concerto. In questa pagina un tantino iperbolica Prescott torna su certi temi che gli sono cari, e sembra raccontare la musica come sede di profondi e misteriosi conflitti. Claudio Morandini.] La Sonata per viola sola è senz’altro una delle opere più stravaganti di Dvoinikov. Scritta di getto per un violista che non l’avrebbe mai eseguita in pubblico, sembra perseguire un’idea di sgradevolezza: nudità della melodia, idee tematiche di corto respiro strapazzate con ferocia, interruzioni e silenzi più lunghi e frequenti del sopportabile. Chi applaudirebbe con convinzione alla fine di una esecuzione di queste pagine scostanti? Il virtuosismo, che pure è richiesto, sembra occultarsi, negarsi, e 193 non cerca l’ammirazione, ma piuttosto lo sconcerto, o, se appena si è un po’ sensibili, il raccapriccio. Il primo tempo, un Allegretto il cui unico tema è giocato sulla cocciuta alternanza di un intervallo di quarta eccedente e uno di seconda maggiore, suona come un abbozzo, buttato lì con insofferenza. Ci viene da pensare che non lo vorremmo riascoltare mai più – come ci capita spesso, pensiamo che sarà più piacevole parlarne, piuttosto che ascoltarlo di nuovo. Eppure tra quei ghirigori impacciati sentiamo nascondersi un nucleo fascinoso di dolore, un grumo di spaventata bellezza – lo percepiamo risuonare leggerissimo nei silenzi, nel gioco traslucido degli armonici. È quella, la musica sottintesa delle vibrazioni e degli ipertoni, che vorremmo sentire, perché la intuiamo assai più bella e dolce di questa, reale, che ci strazia le orecchie e ci fa sbuffare. Il professionista riesce a distinguere con una certa consapevolezza la musica nascosta nelle altezze degli armonici, e ne resta turbato; agli altri, giunge comunque una qualche oscura impressione di un mondo negato, e la sensazione bruciante di non poter accedere a quel mondo. Dopo un Adagio che esplora le zone paludose del registro basso senza mai sollevarsi, il Presto finale è poco più di un raptus disperato, interrotto dalla fretta o dal disamore a metà di una frase: una trentina di secondi in tutto, in cui la melodia si contorce in spirali ascendenti di velocità spaventosa, che rendono impossibile a chiunque il mantenimento dell’intonazione. 194 Questa Sonata sta ben lontana dagli intendimenti della letteratura per viola sola, di solito concentrata su temi pensosi, malinconicamente severi, aristocraticamente sonnacchiosi – si pensi a Hindemith, a Vieuxtemps, a Reger, a Stravinsky, o a tutti quei minori sovietici che hanno fatto della viola la loro voce preferita. Quella di Dvoinikov non è una viola, ma un violino sgraziato o un violoncello scordato, che dal suo esilio urla e mugugna e protesta e di certo non si metterà mai a cantare. 195 [attraverso passaggi in ordine di apparizione] Sig Mustache non ci ha mandato il profilo. Francesco Locane è nato a Gorizia nel 1978 e dal 1996 vive a Bologna. È principalmente giornalista, autore e conduttore radiofonico, ma ha anche insegnato e si occupa di editoria. I suoi racconti sono stati pubblicati, tra gli altri, da Fernandel, Linus, Il Manifesto Libri e Mondadori. Kain Malcovich (Mirko Di Francescantonio – Lanciano 1980). Laureato all’Università Europea del Design, di giorno è pubblicitario, di notte fumettista. Disegna per riviste, webzine, libri, rockstar, da Carta Straccia a Toilet Comics, dalla copertina del Giuseppe Garibaldi di David Riondino alla mostra con Silver (Lupo Alberto), 5 anni fa a Milano. Nel 2008 pubblica il suo primo libro illustrato, NUMBers – un’equazione sociale. Fonda laripubblica.com, il non giornale di notizie al contrario, per poi chiuderla dopo un anno di esperimenti sulle speranze degli italiani. Crea e diffonde riviste inesistenti (Fumetti per minorenni ne è un esempio) per dimostrare che nel 2010 grazie al web siamo tutti famosi: i lettori 197 sono diventati tutti scrittori e nessuno è rimasto lettore: ora siamo tutti uguali. È finita. Marco Montanaro è nato nel 1982 e porta i baffi. Fa parte della redazione di inutile Opuscolo Letterario. Ha pubblicato una raccolta di racconti, Sono un ragazzo fortunato (Lupo, 2009) e un romanzo, La Passione (Untitl.Ed, 2010). Altri suoi racconti sono sparsi per il web e su carta. Da ultimo, La svastica sul petto è apparso nell’antologia Clandestina (Effequ, 2010). Quando può, smette di scrivere per molestare il suo pubblico, in pubblico. Il suo blog è malesangue.wordpress.com Simone Rossi, laureato in Semiotica a Bologna, è uno scrittore a cui piace suonare. Il suo primo libro si chiama La luna è girata strana (Zandegù, 2008). Il suo secondo libro si chiama sbriciolu(na)glio e gliel’ha pubblicato suo cugino. Scrive su Finzioni fin dal numero zero. Tuffa i biscotti nell’acqua. È presente nel volume Racconti di periferie e altri racconti (di periferie) (Malicuvata, 2010) con il racconto Abbandono Oblio Deserto. Ha un sito, come tutti: simone-rossi.it Dario Falconi nasce a Roma. Laureato in Lettere Moderne. Professore, drammaturgo, apprendista scrittore. Almeno questo dicono di lui. Il tutto è accaduto (se è accaduto) a sua insaputa. Un gran numero di racconti compaiono indisturbati su antologie e riviste. Utopsia 198 (Di Salvo editore, 2008) è stata la sua prima fatica letteraria completa. La seconda fatica letteraria completa è un romanzo e ha per titolo Patagonìa (Prospettiva, Brain Gnu, 2010). Marco Mazzucchelli, in gennaio. la nascita. la notte. la neve. l’infanzia. gli anni. la scuola. le suore. i preti. ogni mattina. lo zio. il bar. il vino rosso. gli ubriachi. di pomeriggio. il giro d’italia. la coppa del nonno. le sere. l’estate. i maggiolini. nascondino. dietro i muri. senza respiro. il mare. la montagna. i sentieri. i bergamaschi. poi il latino. la fisica. l’inglese. i concerti. i festival. l’europa. il politecnico. l’architettura. la prima scrittura. il servizio civile. il lavoro di merda. la russia. la mia metà. l’errore. il vivere assieme. mia figlia. le seconde scritture. la crisalide vuota. Jacopo Cirillo vive e lavora a Milano. Qualche anno fa ha co-fondato la rivista online Finzioni (finzionimagazine.it) che ormai è diventata un ometto. Nei ritagli di tempo lavora in Rizzoli, scrive su Wired.it e va in giro per osterie con il suo amico simone rossi a leggere storie come questa. Chiara Reali (Verbania, 1978) ha pubblicato diversi racconti su riviste e, con lo pseudonimo di Esther G., ha partecipato all’antologia edita da Minimum Fax Tu sei lei. Otto scrittrici italiane a cura di Giuseppe Genna. Il suo sito è yellowletters.wordpress.com 199 Alfio Gènitron è l’ideatore dell’omonima rivista di inventori. Tutti i suoi scritti sono tradotti in italiano da Lautino Crippa. Ha un sito internet nel quale periodicamente fa domande ai morti: alfiogenitron.wordpress.com Jacopo Nacci è nato nel 1975 e vive a Pesaro. Ha pubblicato il romanzo Tutti carini (Donzelli, 1997); è stato redattore del blog Il Resto della pesaresità; ha scritto recensioni per L’Indice e Satisfiction; è autore della serie Dreadlock!, in corso di pubblicazione sulla rivista Collettivomensa; è redattore del blog Yattaran. Elena Marinelli quando scrive è Osvaldo. O Teresa, dipende. Suonerebbe il contrabbasso, ma non riesce ad abbracciarlo. Fa delle gran ciambelle, sta sempre su internet e dicono sia piuttosto brava a leggere ad alta voce. Dorme sempre vicino alla porta. Il suo primo libro si chiama la centoventotto rossa. Abita qui: elenamarinelli.it Marco Visinoni è nato a Iseo nel 1981. Il suo primo romanzo ha per titolo Macabre danze di sagome bianche (Miraviglia, 2007); nel 2009 è seguita la raccolta di racconti Apocalypse Wow – Nove ballate dell’ultim’ora, selezionata da Unibook.com per la Fiera del libro di Torino 2009. Il racconto Paradise now è stato inserito nel volume Racconti di periferie e altri racconti (di periferie) (Malicuvata, 2010). Il suo sito internet è: marcovisinoni.it 200 Fabrizio Gabrielli (GBRFRZ81D14C773C) in un’Università aveva la matricola 208849/10, in un’altra la 57, e s’è laureato con 110/110 cum laude nella classe LM37. Ha pubblicato ISBN 978-88-7418-535-1 (202 pagine, nel 2008) e ISBN 978-88-7418-619-8 (180 pagine, nel 2009). Adora le IBU 100, il 4-3-3, i 4/4, il 26 luglio e le donne nate il 12 maggio del 1984. Marta Casarini è nata in luglio, ha scritto un libro che si chiama Nina Nihil giù per terra (Voras), alcuni racconti pubblicati in un paio di antologie, milioni di liste della spesa, qualche poesia, molte lettere importanti per persone che ha odiato e poche righe per quelle che ha amato. Consegna tutto in ritardo ma è simpatica lo stesso. Sasha Tsinski è ricercatore linguistico e reporter freelance. Ugo Coppari, presso Morlacchi Editore, ha pubblicato Bim bum bam! (2006), Nove anoressiche (2007) e Limbo mobile (2009). Attualmente vive e lavora a Perugia. Il suo sito internet è ugocoppari.com Gianni Tetti è nato a Sassari l’11 aprile, 1980. È laureato in Lingue e Letterature Straniere e lavora all’Università di Lettere e Filosofia di Sassari con un borsa di dottorato in Storia e Critica del Cinema. Si occupa di sceneggiatura, collaborando a vari progetti cinematografici e televisivi. Recentemente ha pubblicato il libro I cani là fuori (Neo Edizioni, 2010), scritto il lungometraggio 201 SaGràscia (regia di B. Angius, 2010) e diretto il documentario Un passo dietro l’altro (I.S.R.E., 2010). Suoi racconti sono presenti in numerose antologie e riviste italiane. Lorenzo Mari (Mantova, 1984) vive e lavora a Bologna. Nel 2009 ha pubblicato la raccolta poetica Minuta di Silenzio (L’Arcolaio, Forlì, 2009, prefazione di Luca Ariano); nello stesso anno, sue sillogi sono apparse in Pro/ Testo (Fara, Rimini, 2009) e nell’antologia a cura di Chiara de Luca Nella borsa del viandante (Fara, Rimini, 2009). Prima di approdare a Casa Lettrica Malicuvata, ha vissuto i fasti della rivista militante bolognese Tabard. Claudio Morandini è nato, vive e insegna ad Aosta. In passato ha scritto cicli di commedie per la radio e monologhi per il teatro. Prima del romanzo Rapsodia su un solo tema – Colloqui con Rafail Dvoinikov (Manni, 2010) ha pubblicato Nora e le ombre (Palomar, 2006) e Le larve (Pendragon, 2008). Il suo racconto Le dita fredde è stato incluso nell’antologia bilingue Santi – Lives of Modern Saints edita a Baltimora (Black Arrow Press, 2007). Fosca – Una novella valdostana si trova nell’antologia Nero Piemonte e Valle d’Aosta – Geografie del mistero pubblicata da Perrone nel 2010. Altri racconti sono apparsi su varie riviste. Sul blog Letteratitudine anima con Massimo Maugeri il “Dibattito su letteratura e musica”. Gabriele Dadati (Piacenza, 1982) ha pubblicato il libro di racconti Sorvegliato dai fantasmi (peQuod, 2006; nuova 202 edizione Barbera Editore, 2008), premio Dante Graziosi e finalista come Libro dell’anno per Fahrenheit di Radio 3 Rai, e il romanzo Il libro nero del mondo (Gaffi, 2009). Nel 2009 è stato scelto da Festivaletteratura di Mantova per rappresentare l’Italia nel progetto Scritture giovani. Scrive sul quotidiano Libertà, è tra gli autori di Booksweb.tv e si occupa di Laurana Editore. Antonio Tirelli nasce a Napoli nel 1979. Laureato in Scienze della Comunicazione, vive a Bologna lavorando in una libreria. La prima pubblicazione in cui appaiono i suoi disegni è l’antologia a fumetti Sherwood Comix. Immagini che producono azioni (Nicola Pesce editore, 2009). Nel 2010 ha illustrato il volume Racconti di periferie e altri racconti (di periferie) (Malicuvata, 2010). Suoi articoli su opifice.it e malicuvata.it 203 [indice] Sig Mustache Helsinki-Tallinn, 2008 5 [attraverso passaggi racconti] 7 Francesco Locane L’ultimo battito 9 Marco Montanaro Come funzionano gli orologi 19 Simone Rossi benpartita 25 Dario Falconi Ci siamo amati fino al sempre degli amanti 35 Marco Mazzucchelli Ferox 41 Jacopo Cirillo La storia aumentata del Passaggio a Nord-Ovest 53 Chiara Reali Le pendu 59 Alfio Gènitron Fidarsi 75 Jacopo Nacci In merito alla terapia 83 Elena Marinelli Clementina 91 Marco Visinoni La ballata del morto vivente 105 Fabrizio Gabrielli Faccio di quei passaggi, vè? 113 Marta Casarini La vernice ecologica 129 [attraverso passaggi fotografi] 141 Manuela Marceddu Dodo 143 Simona Pinna In viaggio 145 Simone Lisci Verso il mare 147 [attraverso passaggi dialoghi] 149 Sasha Tsinski | Ugo Coppari Dove siamo 151 Gianni Tetti | Fabrizio Gabrielli Doppia Velocità 155 Gabriele Dadati | Marta Casarini Il tempo narrato 173 Lorenzo Mari | Claudio Morandini La musica è un linguaggio? 175 Antonio Tirelli | Dario Falconi | Fabrizio Gabrielli Strumenti per 181 [attraverso passaggi graphic designs] 183 Mattia Piano Dodo 185 Mattia Piano In viaggio 187 Mattia Piano Verso il mare 189 [attraverso passaggi d’appendice] 191 Ethan Prescott Rafail Dvoinikov – Sonata per viola sola, 1951 193 [attraverso passaggi in ordine di apparizione] 197 [extra] i lettori di Malicuvata per Attraverso Passaggi Giovanni Curreli Marialuisa Fascì Spurio Davide Gianetti Lorenzo Mari Carlo Palizzi Carlo Schiavo Patrizia Sergio [malicuvata.it | [email protected]]
Scarica