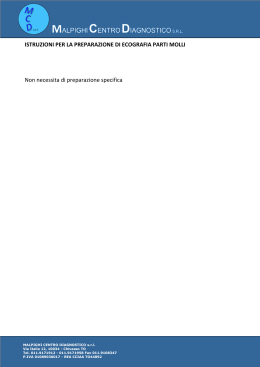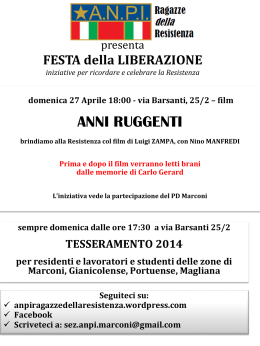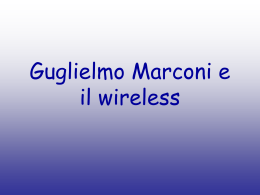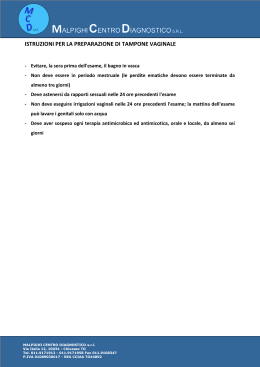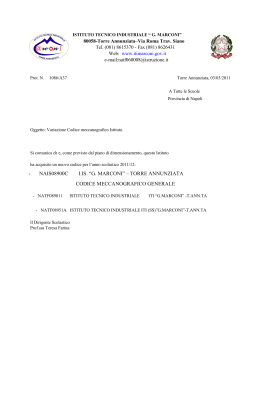STORIA, SCIENZA E SOCIETÀ STORIA, SCIENZA E SOCIETÀ Ricerche sulla scienza in Italia nell’età moderna e contemporanea Università di Bologna Dipartimento di Filosofia Centro Internazionale per la Storia delle Università e della Scienza “Bologna Studies in History of Science” Editor: Giuliano Pancaldi 1. Frederic L. Holmes, Eighteenth-century chemistry as an investigative enterprise, 1989, 144 pp. 2. John L. Heilbron, Weighing imponderables and other quantitative science around 1800, 1993, 337 pp. 3. Frederic L. Holmes, Between biology and medicine: The formation of intermediary metabolism, 1992, 114 pp. 4. Peter J. Bowler, Biology and social thought: 1850-1914, 95 pp. 5. I laboratori dell’università. Un incontro Bologna-Oxford, a cura di Anna Guagnini e Giuliano Pancaldi, 1996, 127 pp. 6. Robert Fox and Anna Guagnini, Laboratories, workshops, and sites. Concepts and practices of research in industrial Europe, 1800-1914, 1999, 214 pp. 7. Luigi Galvani International Workshop. Proceeedings, edited by Marco Bresadola and Giuliano Pancaldi, 1999, 215 pp. 8. The structure of knowledge: Classifications of science and learning since the Renaissance, edited by Tore Frängsmyr, 2001, 158 pp. 9. Electric bodies. Episodes in the history of medical electricity, edited by Paola Bertucci and Giuliano Pancaldi, 2001, 298 pp. 10. Natura, cultura, identità. Le università e l’identità europea, a cura di Giuliano Pancaldi, 2004, 213 pp. 11. Storia, scienza e società. Ricerche sulla scienza in Italia nell’età moderna e contemporanea, a cura di Paola Govoni, 2006, 304 pp. STORIA, SCIENZA E SOCIETÀ Ricerche sulla scienza in Italia nell’età moderna e contemporanea a cura di Paola Govoni Università di Bologna Dipartimento di Filosofia Centro Internazionale per la Storia delle Università e della Scienza 2006 In copertina: Giacomo Balla, “Lampada ad arco”, 1909-11, New York, Museum of Modern Art. Elaborazione grafica di Oriano Sportelli. Bologna Studies in History of Science, 11 Editor: Giuliano Pancaldi CIS - Dipartimento di Filosofia Università di Bologna Via Zamboni 38 40126 Bologna - I www.cis.unibo.it [email protected] Copyright © 2006 CIS, Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna ISBN: 978-88-900162-4-0 Indice Introduzione Paola Govoni 5 Pazienti e curatori nella pratica medica di Marcello Malpighi Marco Bresadola 17 Cure prodigiose e meraviglie elettrizzanti. Il duello filosofico tra l’abbé Nollet e Gianfrancesco Pivati Paola Bertucci 47 La rivoluzione chimica, i chimici italiani e i periodici scientifici di fine Settecento. Uno studio quantitativo Raffaella Seligardi 71 Consuetudine e privilegi. Il governo dell’innovazione nel Regno Lombardo-Veneto Christian Carletti 105 I significati della precisione. Per una storia socioculturale dell’astrofisica italiana Massimo Mazzotti 143 Dall’invenzione all’impresa. Marconi e la Wireless Telegraph Company Anna Guagnini 175 Lo sviluppo delle facoltà di medicina e chirurgia in Italia tra l’unità e la prima guerra mondiale Ariane Dröscher 213 Donne e scienza nelle università italiane, 1877-2005 Paola Govoni 239 Gli autori e le autrici 289 Indice dei nomi 291 INTRODUZIONE INTRODUZIONE / 5 Paola Govoni La raccolta di saggi che proponiamo in questo volume ha un doppio intento. Il primo è presentare i risultati di una ricerca su “Analisi quantitative della scienza e della tecnologia in Italia, 1745-1918” finanziata dal Miur.1 Il secondo obiettivo è offrire un’immagine delle ricerche in corso da parte dei ricercatori e delle ricercatrici che collaborano con il CIS, il Centro Internazionale per la Storia delle Università e della Scienza dell’Università di Bologna che, istituito nel 1991, compie in questi mesi quindici anni di vita.2 L’idea di avviare nuove analisi quantitative nel campo della storia della scienza nacque diversi anni fa dalla constatazione che, come in altri settori di ricerca, anche la pratica quotidiana degli storici della scienza stava subendo importanti modifiche con l’introduzione delle tecnologie informatiche che – ci si aspettava – avrebbero incoraggiato lo sviluppo di metodologie quantitative negli studi storici sulla scienza. La crescente disponibilità di testi scientifici del passato in formato digitale, un settore nel quale il CIS si è impegnato,3 e l’accesso sempre più frequente ai cataloghi in linea di manoscritti, strumenti scientifici e macchine conservati in biblioteche e musei sparsi in tutto il mondo, hanno modificato il rapporto degli storici della scienza con le fonti, consentendo una diversa fruizione di queste importanti risorse. 1. Il progetto nazionale, coordinato da Mauro Di Giandomenico, era intitolato: “Metodologie innovative per il trattamento informatico di temi e problemi di storia della scienza tra Settecento e Novecento”. 2. Il CIS fu inaugurato nell’autunno del 1991 con un convegno internazionale i cui atti sono stati pubblicati in G. Pancaldi (a cura di), Le università e le scienze. Universities and the sciences, Martello, Milano, 1993. 3. Si tratta dei Bologna Science Classics Online (2000-), l’edizione elettronica di alcuni classici della scienza. Attualmente comprende le seguenti opere: Anothomia (1316 c.) di Mondino de’ Liuzzi, a cura di Piero Giorgi; Miscellanea (1732) di Laura Bassi, a cura di Marta Cavazza; Il newtonianismo per le dame (1737) di Francesco Algarotti, a cura di Massimo Mazzotti; e De viribus electricitatis (1791) di Luigi Galvani, a cura di Marco Bresadola. 6 / INTRODUZIONE D’altra parte, l’esigenza di collegare gli studi di storia della scienza che si conducevano a Bologna con le ricerche in corso nella comunità internazionale degli storici della scienza era anch’essa ben avvertita quando il CIS nacque. Il nuovo Centro, infatti, poteva contare sull’esperienza della International Summer School in History of Science, fondata nel 1988 a Bologna.4 Da allora la Scuola tiene i suoi corsi ogni due anni a turno nelle quattro città promotrici e ha coinvolto alcune centinaia di giovani studiosi provenienti da decine di paesi. A partire dal 1989 le lezioni più importanti tenute presso la Scuola sono state pubblicate nella collana dei Bologna Studies in History of Science, che conta oggi undici volumi. Mettere a disposizione dei giovani storici della scienza attirati dalla Summer School e dal CIS le nuove risorse digitali è stato uno dei primi obiettivi del Centro. Alle pubblicazioni e ai convegni specialistici 5 si affiancò quindi una serie di iniziative nel campo degli strumenti digitali al servizio degli storici. Il primo di quei progetti fu il completamento di una base di dati bibliografica – denominata Boscientia e cominciata già nel corso degli anni Ottanta – che censiva 9.000 classici della scienza da Copernico ad Einstein presenti nelle biblioteche di Bologna.6 A quella prima base di dati seguì presto un Archivio iconografico relativo a materiali e luoghi significativi per la storia della scienza conservati all’Università di Bologna.7 Negli stessi anni fu completata la catalogazione dell’intero patrimonio bibliografico rilevante per la storia della scienza conservato in città – il catalogo, denominato Biblioteca di Storia della Scienza, è ricco di circa 20.000 titoli 8 – nonché una serie di iniziative organizzate in occasione delle prime edizioni della Settimana della cultura scientifica e tecnologica promossa dal Ministero dell’università. 4. Per iniziativa di Giuliano Pancaldi, John Heilbron (Berkeley) e Tore Frängsmyr (Uppsala), cui si aggiunse nel 1992 Dominique Pestre (Parigi). L’occasione per la creazione della Scuola furono le celebrazioni per il nono centenario dell’Università di Bologna, promosse dal rettore Fabio Roversi Monaco. 5. I primi due libri della collana Bologna Studies in History of Science, furono F. L. Holmes, Eighteenth-century chemistry as an investigative enterprise, BSHS, 1, CIS, Bologna, 1989 e J. L. Heilbron, Weighing imponderables and other quantitative science around 1800, BSHS, 2, CIS, Bologna, 1993. L’elenco completo dei titoli della collana si trova nella terza di copertina del presente volume. 6. Boscientia fu realizzata con il sostegno della Soprintendenza ai Beni Librari dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. 7. L’Archivio Iconografico fu completato nell’ambito del Progetto Finalizzato Beni Culturali del CNR. 8. Consultabile all’indirizzo: http://opac2ns.cib.unibo.it/cgi-opac/startopac/formgo? language=ITALIANO&s_class=Dewey&nature=Tutte&action=find&browse=Titolo&libr=Tutte INTRODUZIONE / 7 Dal 1993 al 2000, infine, fu pubblicata la newsletter del CIS in lingua inglese – Universitas – che nel 1995 fu tra le prime riviste prodotte in Italia disponibili anche online.9 Negli stessi anni, è noto, l’intera comunità italiana degli storici della scienza si stava aprendo all’uso delle nuove tecnologie informatiche.10 Eppure, a giudicare dalle monografie e dalle ricerche presentate nell’ambito delle principali società di storia della scienza, nazionali e internazionali, fino ad ora l’uso dei nuovi strumenti non sembra aver generato novità importanti sul fronte dei contenuti. La produzione degli storici della scienza continua a essere caratterizzata da monografie e articoli firmati perlopiù da singoli studiosi, anziché da squadre di ricercatori, magari di più paesi, che potrebbero avvalersi delle nuove tecnologie di comunicazione, e raramente vengono affrontate le tematiche quantitative e comparate che i nuovi strumenti digitali potrebbero incoraggiare. Anche l’indirizzo di studi ispirato dalla linguistica computazionale, nonostante alcuni importanti contributi recenti,11 non sembra essersi diffuso nella comunità internazionale degli storici della scienza con il ritmo che era lecito attendersi. Le ricerche qui presentate muovono dalla consapevolezza delle potenzialità racchiuse nelle nuove tecnologie digitali e, insieme, affondano le loro radici in metodologie e temi di ricerca già consolidati. Alcuni 9. Tutte le banche dati e i progetti citati sono disponibili sul sito del CIS, all’indirizzo: www.cis.unibo.it 10. Si segnalano in particolare le seguenti istituzioni e iniziative: Seminario di storia della scienza di Bari (http://www.ssscienza.uniba.it/index.htm); il Gruppo nazionale di fondamenti e storia della chimica (http://www.filosofia.unibo.it/gnfsc/Gnfsc.htm); la Società italiana di meccanica celeste e astronomica (http://mat-1.mat.uniroma2.it/ simca/home.html ); il Museo e istituto di storia della scienza di Firenze (http:// www.imss.firenze.it/indice.html); a Bologna la Fondazione Gugliemo Marconi (http://www.fgm.it/site/index.php), il CIS (http://www.cis.unibo.it/), e il Centro interdisciplinare di epistemologia e storia della scienza “Federigo Enriques” (http:// www.ciress.unibo.it/); il Centro di studi Lazzaro Spallanzani a Reggio Emilia (http:// www.spallanzani.it/); il Pavia Project Physics del gruppo di Storia e didattica dell’Università di Pavia (http://ppp.unipv.it/PagesIT/pppit.htm); il Centro interdipartimentale di ricerca in storia e filosofia delle scienze (CIRSFIS) a Padova (http:// www.scienze.unipd.it/cirsfis/); l’Osservatorio astronomico e museo di Brera a Milano (http://albinoni.brera.unimi.it/), PRISTEM, il “Progetto RI cerche SToriche E Metodologiche presso l’Università Bocconi a Milano (http://www.unibocconi.it/ index.php?proc_id=11&nav_level1=4&nav_level2=21&nav_level3=101&documento=1827 &procedura=0&sub_action=0&sub_param=&sub_function_title=); la Società italiana di storia della matematica con sede a Torino (http://www.dm.unito.it/sism/). 11. Si vedano per esempio L. Dibattista, J.-M. Charcot e la lingua della neurologia, Cacucci, Bari, 2003, e D. Buzzetti, G. Pancaldi, H. Short (eds.), Augmenting Comprehension: Digital Tools and the History of Ideas, Office for humanities communication, London, 2004. 8 / INTRODUZIONE dei saggi che presentiamo affrontano direttamente il tema degli indicatori quantitativi della produzione scientifica, secondo una prospettiva d’indagine che ha avuto una certa fortuna tra gli storici della scienza fin dalla pubblicazione delle ricerche di Dereck de Solla Price nei primi anni Sessanta.12 Ma qual è dunque il filo che lega insieme ricerche che, come si vedrà, affrontano campi d’indagine diversi come la storia della medicina, della filosofia naturale, della chimica, dell’astrofisica, della tecnologia e delle istituzioni scientifiche in un lungo arco di tempo? Ciò che accomuna gli autori e le autrici di questo libro, come suggerisce il titolo, è la convinzione che la scienza e le comunità di esperti che la producono debbano essere studiate tenendo conto dei contesti – nazionali e internazionali – in cui quelle comunità sono immerse. Si considerino, per esempio, le relazioni mediante le quali si costruisce una carriera scientifica di successo, come quella di Marcello Malpighi cui è dedicato il saggio di Marco Bresadola. Bresadola considera l’attività del fondatore dell’anatomia microscopica all’interno di una variegata rete di rapporti con pazienti e colleghi di diverse regioni italiane ed europee. Al centro dell’attenzione sono i consulti di Malpighi. Fonti di grande interesse finora poco studiate dagli storici, i consulti malpighiani sono in parte ancora inediti. Qui se ne pubblicano due, conservati nella Biblioteca Universitaria di Bologna, per offrire ai lettori uno spaccato della pratica medica del Seicento con informazioni che riguardano non solo il decorso delle malattie e le cure tentate, ma anche le abitudini di vita dei pazienti, la loro condizione sociale, i rapporti con i curatori. Uno studio analitico e quantitativo dei consulti di Malpi12. Per una bibliografia degli studi quantitativi sulla storia della scienza, fino agli anni Settanta si veda R. Hahn, A bibliography of quantitative studies on science and its history, Office for History of Science, Univ. of California, Berkeley, 1980. Per la letteratura disponibile in questo particolare campo di studi si vedano, per esempio: D. Edge, “Quantitative measures of communication in science: A critical review”, in History of Science, 17, 1979, pp. 102-134; M. J. Nye, “Scientific decline: Is quantitative evaluation enough?”, in Isis, 75, 1984, pp. 697-708; A. F. J. van Raan (ed.), Handbook of Quantitative Studies of Science and Technology, North-Holland, Amsterdam, 1988; S. I. Doroshenko, S. D. Haitun, “Quantitative studies of science: A bibliography of Soviet publications”, in Scientometrics: International Journal for all Quantitative Aspects of the Science of Science and Science Policy, 15,1989, pp. 139-154; K. H. Jarausch, K. A. Hardy, Quantitative methods for historians: A guide to research, data, and statistics, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1991; H. F. Moed, W. Glänzel, U. Schmoch (eds.), Handbook of Quantitative Science and Technology Research: The Use of Publication and Patent Statistics in Studies of S&T Systems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2004; P. Hudson, History by Numbers: An Introduction to Quantitative Approaches, H. Arnold, London, 2000. INTRODUZIONE / 9 ghi si dimostra utile, oltre che per le informazioni che ci dà sulla storia della medicina e sulle strategie di carriera dell’anatomista bolognese, per la ricostruzione della ragnatela di rapporti che intercorrevano tra medici e pazienti appartenenti alle élite dell’epoca. Spesso si trattava di malati, e di colleghi, che Malpighi assecondava con pazienza e con largo dispendio di tempo ed energie allo scopo di promuovere la propria immagine e i propri interessi in un circuito – geografico, sociale e politico – sempre più esteso. Questo studio dell’attività professionale di Malpighi è uno dei primi risultati di un nuovo progetto di ricerca che Marco Bresadola, da tempo impegnato in ricerche sui confini tra medicina e filosofia naturale,13 sta svolgendo su Marcello Malpighi e sul ruolo della medicina nella società e nella cultura italiana della prima età moderna. Il saggio di Paola Bertucci considera invece le relazioni intellettuali e scientifiche tra “centro” e “periferia” nella comunità degli studiosi di elettricità dell’Europa del Settecento. Le vicende narrate si concentrano nel 1749 tra Venezia, Padova, Bologna e Parigi. Oggetto della contesa sono i “tubi medicati”, un’invenzione di Gianfrancesco Pivati che sembrava promettere cure miracolose grazie all’elettricità, un campo di fenomeni alla moda tra i filosofi naturali e i frequentatori di salotti del tempo. L’idea dei tubi medicati era venuta a Pivati mentre conduceva degli esperimenti sulle piante che, attraversate dall’elettricità, sembravano emanare particolari profumi. Pivati si era convinto che, strofinando dei tubi di vetro sigillati contenenti le sostanze medicamentose, sarebbe stato possibile curare i malati facendo loro respirare gli effluvi rilasciati con il nuovo metodo senza ingerire le sostanze stesse. Per sottoporre la nuova terapia elettrica al vaglio della filosofia sperimentale si fece avanti Jean Antoine Nollet, celebrato dagli esperti di elettricità e dai frequentatori dei salotti parigini. Se Nollet avesse sancito il buon funzionamento dei tubi medicati, Pivati, sostenuto dall’Accademia delle scienze di Bologna, sarebbe entrato nel novero dei filosofi naturali dell’epoca. Nollet, dal canto suo, si lasciò coinvolgere volentieri nella vicenda, pronto ad allargare anche a sud delle Alpi la fama di studioso 13. M. Bresadola, G. Pancaldi, (eds.), Luigi Galvani International Workshop, Bologna Studies in History of Science No. 7, CIS, Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna, Bologna, 1999; M. Bresadola, Una università “riformata”. Scienza e medicina a Ferrara alla fine del Settecento, Ferrara, 2003; Id., con M. Piccolino, Rane, torpedini e scintille. Galvani, Volta e l’elettricità animale, Bollati Boringhieri, Torino, 2003; A. Vallisnieri, Quaderni di osservazioni, II, a cura di Marco Bresadola, Olschki, Firenze, in corso di stampa. 10 / INTRODUZIONE imparziale, capace di far emergere la “verità” in mezzo alle controversie più complesse, come fin dall’inizio era apparsa la questione dei tubi medicati. Attraverso un confronto tra documentazione a stampa e un ricco materiale inedito, Paola Bertucci – che ha terminato di recente un libro sul viaggio di Nollet in Italia 14 – mette in luce il ruolo decisivo svolto dalla diplomazia delle accademie nell’arbitrare la controversia medico-scientifica generata dalle pretese di Pivati. Anche il saggio di Raffaella Seligardi considera una rete di relazioni internazionali, ricostruita attraverso lo studio di alcuni giornali scientifici della fine del Settecento. Analizzando i periodici di chimica italiani e francesi, Raffaella Seligardi mette in luce nuovi aspetti del dibattito prodottosi tra Francia e Italia in merito alla cosiddetta rivoluzione chimica. Analogamente a quanto si verificava in Germania, anche i periodici scientifici pubblicati a sud delle Alpi offrirono uno spazio importante al dibattito sulla nuova chimica. L’analisi quantitativa dei giornali si rivela utile per una migliore comprensione di quel dibatto e pone in evidenza la circolazione europea dei risultati delle ricerche di alcuni chimici italiani, a lungo ritenuti secondari nella vicenda. I dati presentati confermano, da un lato, che le ricerche chimiche sui fluidi imponderabili e le arie furono centrali per la rivoluzione chimica e, dall’altro, ci ricordano che la chimica di sali, terre e metalli continuava ad essere la base consolidata della disciplina. I risultati conseguiti con un approccio quantitativo a questo tema particolare, al quale Raffaella Seligardi ha già dedicato uno studio importante,15 inducono l’autrice a suggerire l’opportunità di condurre uno spoglio sistematico dei periodici scientifici del Settecento ai fini di una soggettazione standardizzata dei contenuti. Un simile progetto, nel quale dovrebbe naturalmente essere coinvolto un nutrito gruppo di ricercatori, offrirebbe alla comunità internazionale degli storici della scienza uno strumento di straordinario interesse. Christian Carletti si occupa invece di innovazione tecnologica nel Lombardo-Veneto di metà Ottocento. Dopo avere richiamato la legislazione che disciplinava il sistema dei privilegi sotto la dominazione austriaca, il saggio si concentra sul ruolo svolto dalle accademie come 14. P. Bertucci, Viaggio nel paese delle meraviglie. Scienza e curiosità nell’Italia del Settecento, Bollati Boringhieri, Torino, in corso di stampa. Inoltre, Id., G. Pancaldi (eds.), Electric bodies. Episodes in the history of medical electricity, Bologna Studies in History of Science No. 9, CIS, Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna, Bologna, 2001. 15. R. Seligardi, Lavoisier in Italia. La comunità scientifica italiana e la rivoluzione chimica, Olschki, Firenze, 2002. INTRODUZIONE / 11 mediatrici tra le ambizioni degli inventori locali e le esigenze del governo centrale. In quel contesto si inserisce la figura di Bartolomeo Avesani, tecnologo e inventore le cui carte sono state riscoperte da Christian Carletti negli archivi veronesi. Di famiglia nobile, Avesani aveva rinunciato alla carriera cui era stato destinato per assecondare la sua passione per la meccanica, un interesse che coltivò da autodidatta frequentando fin da giovanissimo le officine e gli artigiani della città. Attraverso la partecipazione ai concorsi indetti dall’Accademia di agricoltura commercio ed arti di Verona, ma ben presto anche a quelli promossi dall’Istituto Lombardo e dall’Istituto Veneto, Avesani conquistò una fama nazionale. Nel 1813 ottenne dall’Istituto Reale di scienze lettere e arti di Milano una prima medaglia d’argento per le innovazioni introdotte in una macchina tessile. Da allora prese a innovare decine di dispositivi, compresa una particolare macchina idraulica per i pozzi, un nuovo fuso da filatoio, una macchina per la lavorazione del filo d’acciaio, un’altra per la fabbricazione delle viti, dei nuovi modelli di argano, un apparato per la movimentazione della terra su lunghe distanze, una per la costruzione di ruote dentate e molto altro ancora. Grazie alla pubblicità ottenuta mediante i concorsi e la pubblicazione dei progetti negli atti delle accademie, al laboratorio di Avesani arrivarono commesse da molte parti dell’Italia settentrionale. Christian Carletti sta scrivendo la tesi di dottorato sul poco frequentato mondo di inventori e costruttori di macchine attivi tra Veneto e Lombardia prima dell’unità,16 una realtà che, a quanto pare, per investimenti e innovazione competeva più di altre realtà italiane con gli sviluppi che si stavano producendo a nord delle Alpi. Nella ricostruzione di Carletti il successo di Avesani doveva molto, oltre che al tessuto di artigiani e macchinisti su cui poteva contare, alla lucidità con cui sapeva battere le strade – politiche e accademiche, oltre che tecnologiche – che gli consentivano di promuovere le sue invenzioni e di mettere a frutto i brevetti ottenuti. Anche Massimo Mazzotti si occupa di istituzioni, con riferimento alla nascita di un nuovo campo disciplinare: l’astrofisica. Mazzotti considera in particolare le politiche del Vaticano dopo l’unità italiana ed esamina l’attività di Angelo Secchi, gesuita e astronomo a capo dell’osservatorio vaticano tra il 1849 e il 1878. Mazzotti mostra come la realizzazio16. C. Carletti, Strumenti, fabbriche e laboratori a metà Ottocento: la scienza elettrica di Francesco Zantedeschi, Tesi di Dottorato in Storia della Scienza, Università di Bari. Con Giampietro Berti, Carletti sta curando la pubblicazione dell’inventario degli strumenti del gabinetto fisico dell’Università di Padova nel 1849. 12 / INTRODUZIONE ne di ricerche pionieristiche nel settore dell’astrofisica e della meteorologia nella Roma pontificia possa essere ricondotta alla volontà di controllo territoriale da parte del Vaticano e, insieme, alla battaglia da questi ingaggiata contro ateismo e materialismo in un momento particolare dei rapporti tra Italia e Vaticano. In quel contesto – in cui esigenze della politica, nuovi programmi di ricerca e il perseguimento di piani d’innovazione tecnologica si intrecciavano – si produsse il processo che doveva portare al trasferimento della organizzazione del lavoro propria degli osservatori astronomici vaticani nel più vasto ambito delle istituzioni di ricerca della giovane nazione. Il passaggio fu caratterizzato da un’operazione di reinterpretazione e riutilizzazione mirata di risorse, materiali e simboliche, grazie alla quale concetti e pratiche osservative messe a punto nello stato pontificio furono utilizzate a sostegno del processo di unificazione del paese. L’Osservatorio del Collegio Romano non sopravvisse a lungo alla conquista italiana di Roma. Eppure, il regime di osservazioni astronomiche sviluppato in quell’osservatorio fu adottato con entusiasmo dalla nuova rete nazionale degli osservatori italiani. Ma perché dunque si optò per quel tipo di organizzazione, che portava con sé un’immagine dell’universo unificato coltivata da Secchi, piuttosto che un’immagine laica o addirittura materialistica in linea con le tendenze filosofiche predominanti nella cultura italiana del periodo? Nel rispondere a questa domanda Mazzotti, impegnato da tempo in ricerche sulla dimensione sociale della matematica italiana tra Sette e Ottocento – tema sul quale ha ultimato di recente un volume, centrato sulla figura di Maria Gaetana Agnesi 17 – mette in luce nuovi aspetti dei rapporti tra la giovane nazione e il Vaticano. Con il saggio di Anna Guagnini l’attenzione torna sull’innovazione tecnologica e il suo sfruttamento commerciale, attraverso il caso esemplare della Wireless Telegraph Company fondata da Guglielmo Marconi. Da tempo impegnata in questo settore d’indagine,18 Anna Guagnini affronta qui gli esordi della società di Marconi, inventore e imprenditore, vincitore nel 1909 del premio Nobel per la fisica. Nel processo di sviluppo di un’impresa che ha per obiettivo il lancio di una nuova tecnologia, la fase del decollo è la più rischiosa, oggi come in 17. M. Mazzotti, Another Enlightenment: The World of Maria Gaetana Agnesi, Johns Hopkins University Press, Baltimore, in corso di stampa. 18. Tra i lavori più recenti si veda: A. Guagnini, “Patent Agents, Legal Advisers and Guglielmo Marconi’s Breakthrough in Wireless Telegraphy”, in A. Guagnini, I. Inkster, (eds.), Patents in History, in History of Technology, numero speciale, 24, 2002, pp. 171-202. INTRODUZIONE / 13 passato. I primi passi della Wireless Telegraph Company non fanno eccezione. L’obiettivo di Anna Guagnini, che si concentra sugli anni tra il 1896 e il 1899, è di ricostruire in dettaglio gli obiettivi e la vita quotidiana della nuova impresa attraverso una straordinaria documentazione d’archivio, compresa quella depositata recentemente presso la Bodleyan Library di Oxford. Nella ricostruzione di Anna Guagnini la contabilità minuta relativa a dimostrazioni ed esperimenti, brevetti, spese legali e di rappresentanza rivela in modo esemplare la difficoltà di separare le molte dimensioni di un’impresa come quella di Marconi, in cui ricerca tecnologica e successo commerciale erano coltivate con uguale ambizione. Il saggio di Ariane Dröscher propone un approccio quantitativo a un capitolo trascurato della storia delle istituzioni scientifiche in Italia. Si tratta di uno studio di lungo periodo in un settore che l’autrice ha già coltivato con successo.19 Qui Ariane Dröscher esplora le facoltà di chirurgia e medicina in Italia dall’unità alla Prima guerra mondiale, analizzando in dettaglio le cattedre e gli stabilimenti annessi: laboratori, cliniche e musei. Ponendo a confronto la realtà dei diversi atenei, il saggio evidenzia alcuni dei nodi non risolti dell’università italiana del tempo. All’indomani dell’unità il Ministero della pubblica istruzione si trovò a spartire i pochi fondi destinati all’istruzione superiore tra ventidue università. Nel contesto europeo, quel numero era del tutto sproporzionato rispetto al numero degli studenti universitari: tra il 1860 e il 1900 in Italia c’era un’università ogni 1,4 milioni di abitanti, mentre paesi come la Germania e la Francia disponevano di un’università ogni 2,5 milioni di abitanti e l’Inghilterra una ogni 4,1. Nella consapevolezza dell’anomalia – e considerato che, nonostante l’alto numero di atenei disseminati nel territorio, la percentuale di popolazione italiana con una laurea era all’epoca tra le più basse d’Europa – fin dai tempi del ministro Matteucci si era tentato di chiudere le università più piccole a favore delle maggiori. L’intento razionalizzatore, tuttavia, non riuscì mai a imporsi a causa delle forti pressioni che provenivano da docenti e autorità locali. Nel saggio lo sviluppo delle cattedre mediche è messo a confronto con quello delle cattedre delle facoltà di scienze, un’operazione 19. A. Dröscher, Le facoltà medico-chirurgiche italiane (1860-1915). Repertorio delle cattedre e degli stabilimenti annessi, dei docenti, dei liberi docenti e di tutto il personale scientifico, Studi del Centro interuniversitario per la storia delle università italiane, 4, CLUEB, Bologna, 2002. Dell’autrice, si segnala anche Die Zellbiologie in Italien im 19. Jahrhundert, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Halle, 1996. 14 / INTRODUZIONE che permette di smentire il luogo comune che vorrebbe queste ultime più deboli rispetto alle facoltà mediche. L’analisi proposta da Ariane Dröscher consente inoltre di illustrare abitudini e stili di lavoro dei docenti universitari italiani, che la storiografia ha trattato prevalentemente a livello individuale trascurando i tratti comuni di un gruppo di esperti che svolse comunque un ruolo centrale nei tentativi volti a riconquistare alla ricerca italiana un posto dignitoso nel contesto europeo. Dell’istruzione scientifica superiore si occupa anche Paola Govoni, che nel suo saggio esamina un fenomeno particolare: la crescita nel numero delle studentesse nelle università italiane nel corso di più di un secolo. L’indagine prende il via dal 1877, l’anno in cui fu conferita la prima laurea a una donna nella storia dell’Italia unita, e arriva fino al 2005, quando anche nel settore dei dottorati di ricerca le donne hanno superato quantitativamente gli uomini. I dati esaminati consentono di individuare alcune tendenze significative nei rapporti tra donne e scienza nella storia delle università italiane. Nel periodo che va dal 1877 al 1900, per esempio, quando le donne che ottennero una laurea erano ancora poche, una su tre conseguì una laurea in scienze o in medicina. La presenza delle donne nelle facoltà scientifiche e mediche culminò nell’anno accademico 1923-24, quando il loro numero raggiunse il picco più alto di quasi tutta la prima metà del Novecento. Gli anni immediatamente successivi videro crescere il numero complessivo delle studentesse universitarie, ma calare in modo consistente quello delle iscritte alle facoltà scientifiche, che aumentarono di nuovo in misura rilevante alla fine degli anni Trenta. I rapporti tra donne e istruzione scientifica superiore si mantennero buoni fino agli anni Cinquanta, per poi peggiorare drasticamente tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, quando si produsse il balzo definitivo verso la parità numerica tra gli uomini e le donne iscritte agli atenei italiani, raggiunta nel 1990-91. A giudicare dai dati di questo studio, che fornisce anche un profilo prosopografico delle prime 72 laureate in scienze e medicina nell’Italia unita, l’accesso delle donne all’università ha assunto nel corso del Novecento le proporzioni di una straordinaria conquista sociale. Si tratta forse del più importante – e meno perseguito – tra i successi di cui può vantarsi l’università italiana nell’ultimo secolo e mezzo. L’analisi mostra che le donne sono state l’attore sociale più dinamico e insieme il più sensibile alle sinergie particolari – favorevoli o contrarie all’istruzione scientifica –, che si sono prodotte in quell’arco di tempo. I risultati presentati sono i primi di una ricerca più ampia volta a rico- INTRODUZIONE / 15 struire i rapporti tra donne, scienza e tecnologia dall’unità al decollo industriale del secondo dopoguerra, concepiti come un indicatore importante e spesso trascurato dei legami tra istruzione e sviluppo. Come i lettori e le lettrici potranno verificare, la varietà dei temi trattati e dei punti di vista adottati sono le principali caratteristiche – per chi scrive, la vera ricchezza – di questo volume. Una varietà e una libertà che si respirano anche al CIS, un laboratorio di storia della scienza, piccolo ma dinamico e con tanti occhi puntati sulle ricerche in corso in molte parti del mondo. Prima di lasciare la parola alle vicende che sono state qui brevemente introdotte, è giusto dare spazio ai ringraziamenti. È stato un piacere lavorare con i colleghi e le colleghe che si sono impegnati nella realizzazione di questo volume. Lo stesso piacere che molti di noi provano quotidianamente incontrando al CIS amici o studiosi italiani e stranieri di passaggio cui raccontare le scoperte fatte durante l’ultima spedizione in qualche archivio lontano, l’esperienza maturata in occasione dell’ultimo congresso cui abbiamo partecipato o, ancora, depositando sul tavolo comune la copia di una pubblicazione recente. Chi si occupa di storia, scienza e società sa bene quanto siano importanti queste consuetudini. 16 / INTRODUZIONE PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 17 PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MARCELLO MALPIGHI Marco Bresadola Introduzione Marcello Malpighi (1628-1694), noto come il fondatore dell’anatomia microscopica, è una figura di spicco della scienza del Seicento, alla quale fornì contributi fondamentali come la scoperta dei capillari sanguigni e dei globuli rossi, lo studio dei recettori sensoriali e della secrezione ghiandolare, le esperienze sulla generazione animale, le ricerche entomologiche e di anatomia vegetale. Oltre a essere uno dei massimi esponenti della tradizione galileiana e meccanicista nello studio del vivente, a partire dal 1669 Malpighi fu membro della Royal Society e fornì un prezioso contributo alla circolazione delle idee tra Italia e Inghilterra, in un periodo di formazione e diffusione della nuova filosofia sperimentale di marca baconiana.1 L’adesione di Malpighi alle posizioni epistemologiche dei “moderni”, che intendevano rifondare la medicina sulla base del metodo sperimentale e della filosofia meccanica, risultò evidente ai contemporanei fin dalla pubblicazione della sua prima importante opera, il De pulmonibus, apparsa nel 1661. Negli anni immediatamente successivi, durante la sua permanenza all’Università di Messina, Malpighi rimase coinvolto in un’aspra polemica con alcuni colleghi, che lo accusavano di insegnare teorie in contrasto con la tradizione aristotelica e galenica. Ringrazio Michelangelo Ferraro, Benedino Gemelli e Paola Govoni per aver letto una versione preliminare di questo saggio, fornendomi preziosi commenti e suggerimenti utili al suo miglioramento. 1. Su Malpighi restano fondamentali gli studi di Belloni e Adelmann. Tra gli altri, l’introduzione di L. Belloni a M. Malpighi, Opere scelte, Utet, Torino, 1967, pp. 9-68; H. B. Adelmann, Marcello Malpighi and the evolution of embriology, 5 v., Cornell University Press, Ithaca (NY), 1966. Studi più recenti includono W. Bernardi, Marcello Malpighi, in W. Tega (a cura di), Storia illustrata di Bologna, v. 6, Aiep, Milano, 1987, pp. 161-180; D. Bertoloni Meli (ed.), Marcello Malpighi, anatomist and physician, Olschki, Firenze, 1997. 18 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI Ritornato nel 1666 a Bologna, la sua città natale, per insegnare medicina pratica, Malpighi divenne protagonista di un nuovo scontro, questa volta con Giovanni Gerolamo Sbaraglia e altri professori dello Studio felsineo. Questi negavano che le scoperte anatomiche e fisiologiche più recenti, incluse naturalmente quelle di Malpighi, potessero essere di qualche utilità per il progresso degli studi medici. Fu in quella occasione che Malpighi, in riferimento ai continui attacchi subiti, scrisse: “Io però in questa desolazione mi vedo altamente esaltato da’ miei nemici; poiché per abbattere le mie cosette tentano di porre a terra tutta la medicina razionale, e l’anatomia, quasi che io sia medesimato con queste così nobili facoltà.”2 Le continue e accese polemiche che coinvolsero Malpighi, e con lui molti altri medici e filosofi naturali dell’epoca, avevano origine nella crisi della filosofia aristotelica e della tradizione galenica, su cui si era retta la medicina dotta fin dal medioevo.3 L’idea malpighiana di fondare la medicina sulla filosofia meccanica e sulla ricerca anatomica era soltanto una delle proposte in campo e si scontrava sia con i difensori della tradizione, sia con coloro che insistevano piuttosto sulla necessità di affidarsi all’osservazione clinica e alla ricerca terapeutica. La posizione di Malpighi, secondo cui l’anatomia “porta vantaggio alla più soda medicina, mostrando l’origine e la sede de mali, le loro cause e il modo di generarsi, dalle quali si cavano le indicazioni per scegliere li rimedii”,4 era contestata da chi faceva notare come i moderni, nonostante le loro scoperte anatomiche e fisiologiche, non avessero in alcun modo promosso la conoscenza delle malattie né migliorato gli strumenti di cura. Se la dottrina degli umori e dei temperamenti di matrice galenica risultava ormai screditata agli occhi di gran parte dei membri della professione, la pratica medica continuava a basarsi su concetti e rimedi tradizionali, ai quali ricorrevano tanto Malpighi e i moderni, quanto i loro avversari. 2. Lettera di M. Malpighi a R. Marescotti, Bologna 1689, in H. B. Adelmann (ed.), The correspondence of Marcello Malpighi, Cornell University Press, Ithaca (NY), 1975, v. 4, pp. 1560-61. Sulla disputa tra Malpighi e i galenisti messinesi, si veda Adelmann, Marcello Malpighi cit., I, pp. 269-90; sulla polemica tra Malpighi e il gruppo di Sbaraglia si veda ibid., pp. 533-555; M. Cavazza, The uselessness of anatomy: Mini and Sbaraglia versus Malpighi, in Bertoloni Meli (ed.), Marcello Malpighi anatomist and physician cit., pp. 129-145. 3. Su questo tema si veda R. French, Medicine before science. The rational and learned doctor from the Middle Ages to the Enlightenment, Cambridge University Press, Cambridge, 2003. 4. Malpighi, Opere scelte cit., pag. 536. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 19 Il carattere conservativo e tradizionale dell’approccio terapeutico malpighiano è stato rilevato da diversi storici, per i quali gli esponenti della iatromeccanica, compreso Malpighi, ricoprirono un ruolo importante nel rinnovamento culturale del Seicento, senza tuttavia riuscire a unificare, nella loro opera, filosofia naturale e medicina.5 Questa interpretazione, che assegna un ruolo marginale alla medicina pratica nella rivoluzione scientifica, è stata di recente messa in discussione. Domenico Bertoloni Meli, ad esempio, ha invitato a riconsiderare il rapporto tra ricerca anatomica e pratica medica nell’opera di Malpighi, rivolgendo l’attenzione a fonti finora trascurate quali i testi delle lezioni universitarie, i resoconti autoptici e i consulti medici dello studioso bolognese.6 Malpighi, infatti, fu professore di medicina pratica all’Università di Bologna per più di vent’anni ed esercitò un’intensa attività di medico curante e consulente in molti stati italiani. La professione medica rappresentava una parte significativa della sua carriera e contribuì senza dubbio a renderlo famoso, tanto da fargli ottenere, nel 1691, la nomina ad archiatra pontificio di Innocenzo XII, uno degli incarichi più prestigiosi della medicina dell’epoca. Tra le fonti della pratica medica di Malpighi, Bertoloni Meli attribuisce particolare importanza ai consulti, pareri scritti in risposta a richieste riguardanti specifiche malattie e i relativi rimedi. La loro analisi consente di ricostruire il modo in cui era praticata la medicina meccanicistica, ma anche di comprendere se questa costituiva una reale alternativa ad approcci alla cura più tradizionali. Lo studio dei consulti può aiutare a chiarire lo statuto delle scoperte anatomiche di Malpighi e gettare nuova luce sul ruolo della iatromeccanica nella medicina d’età moderna.7 5. Si veda, ad esempio, A. Guerrini, The varieties of mechanical medicine: Borelli, Malpighi, Bellini, and Pitcairne, in Bertoloni Meli (ed.), Marcello Malpighi anatomist and physician cit., pp. 111-128; in particolare dove si afferma che “Medicine and natural philosophy remained two distinct careers for him [Malpighi], as they were for many other physicianvirtuosi”, ibid., p. 119. Per un giudizio analogo su Francesco Redi, si vedano l’introduzione di C. Doni a F. Redi, Consulti medici, Centro editoriale toscano, Firenze, 1985, p. 17 e B. Basile, L’invenzione del vero, Salerno editrice, Roma, 1987, pp. 90-91. Su Giambattista Morgagni, si veda l’introduzione di E. Benassi in G. Morgagni, Consulti medici, Cappelli, Bologna, 1935, pp. xx-xxi. 6. D. Bertoloni Meli, “The archive and consulti of Marcello Malpighi: Some preliminary reflections”, in M. Hunter (ed.), Archives of the scientific revolution, The Boydell Press, Woodbridge, 1998, pp. 109-120; Id., Francesco Redi e Marcello Malpighi: ricerca anatomica e pratica medica, in W. Bernardi e L. Guerrini (a cura di), Francesco Redi, un protagonista della scienza moderna, Olschki, Firenze, 1999, pp. 73-86. 7. Ibid., pp. 112-113. 20 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI Accanto a chi, come Bertoloni Meli, ha suggerito un approccio ai consulti che favorisce l’analisi del contenuto intellettuale dei documenti, vi sono altri studiosi che li hanno invece esaminati da un punto di vista testuale, privilegiando gli aspetti linguistici e stilistici. Ma i consulti si prestano anche a un’indagine di tipo sociale, capace di mettere a fuoco l’identità dei pazienti e utile a ricostruire i rapporti tra i diversi attori coinvolti nella pratica consultiva. Sarà questo l’approccio adottato nelle pagine che seguono. Quando Malpighi redigeva un consulto, infatti, doveva fare i conti non solo con la malattia, ma anche con le aspettative del malato, dei suoi parenti e con la presenza sulla scena terapeutica di altri curatori. Si creava così una complessa rete di rapporti sociali, animata da una molteplicità di soggetti con ruoli e atteggiamenti differenti. L’analisi di questi aspetti, che con tutta probabilità hanno avuto un’influenza sullo stile e sul contenuto dei consulti di Malpighi, fornisce indicazioni preziose sulle motivazioni che spingevano lo studioso bolognese, così come molti altri medici dell’epoca, a dedicarsi alla pratica consultiva. In generale, l’operazione aiuta a chiarire alcuni atteggiamenti tipici dei membri della professione medica dell’epoca, il rapporto tra curatori e pazienti e lo statuto della medicina d’età moderna. Mentre nel caso particolare di Malpighi i consulti si rivelano utili alla comprensione del ruolo avuto dalla pratica medica nella costruzione dell’identità e della carriera dello studioso bolognese. In questo saggio si propone dunque un’indagine di natura sociale con l’intento di far emergere quel mondo ricco e variegato di curatori e di pazienti, spesso in ombra nelle ricostruzioni storiografiche, con cui Malpighi ebbe a che fare nel corso della sua attività professionale.8 Lo studio, che presenta dati ancora parziali, è parte di un progetto più ampio e tuttora in corso finalizzato sia a una migliore comprensione della natura, delle forme e delle funzioni della pratica del consulto, intesa come mezzo di comunicazione e mediazione di relazioni sociali, sia a una comprensione dell’attività medica di Malpighi in rapporto alla sua opera scientifica e nel contesto della medicina dell’epoca. In appendice al saggio si è deciso di pubblicare due documenti inediti, non soltanto per contribuire agli studi specialistici su Malpighi, 8. Per un approccio simile, ma applicato ai consulti di Antonio Vallisneri, si veda l’Introduzione di B. Gemelli in A. Vallisneri, Consulti medici, a cura di B. Gemelli, Olschki, Firenze, 2006. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 21 ma anche per offrire ai lettori uno spaccato concreto del contesto quotidiano della pratica medica d’età moderna. Si tratta di due richieste di consulto indirizzate allo studioso bolognese, un genere di documento che, spesso trascurato dagli storici, si dimostra in realtà di particolare interesse. È dalle richieste di consulto, infatti, che possiamo ricostruire l’identità dei pazienti, uomini e donne, ed esplorare le diverse motivazioni di coloro che si rivolgevano a Malpighi per un parere, fosse il paziente stesso o altri medici. I consulti di Malpighi: un’analisi quantitativa Per certi aspetti i consulti di Malpighi sono assimilabili ai consilia, un genere della letteratura medica sviluppatosi nel nord dell’Italia durante il medioevo. I consilia erano resoconti scritti, riguardanti un caso specifico e contenenti la prescrizione del trattamento cui si intendeva sottoporre il paziente: all’esame del caso, che solitamente consisteva in una descrizione del malato (età, sesso, costituzione o “temperamento”, abitudini di vita), nell’elenco dei sintomi e nell’eziologia della malattia, seguivano l’indicazione del “regime” da tenere durante la cura e i rimedi da somministrare. In modo del tutto simile a quanto avveniva per la stesura di certi atti legali, i consilia implicavano il parere esperto di uno o più medici dietro richiesta del malato stesso, di un suo conoscente o di un altro curatore. Il parere era in genere redatto in seguito a una visita al paziente o a una consultazione tra colleghi. Nati originariamente come risposta a una richiesta individuale, i consilia vennero presto raccolti in collezioni di casi e diffusi come strumento utile ai medici, al punto da costituire uno dei principali generi letterari della medicina d’età moderna.9 Anche i consulti malpighiani, così come i consilia, erano pareri scritti relativi a casi individuali, in cui si discuteva la causa della malattia e si consigliava il trattamento opportuno. Tuttavia, essi riguardavano pazienti che Malpighi non aveva avuto la possibilità di visitare personalmente e sembrano per questo assomigliare ai consilia in absentia, un ge9. D. P. Lockwood, Ugo Benzi: Medieval philosopher and physician, 1376-1439, The University of Chicago Press, Chicago, 1951, p. 47; J. Agrimi, C. Crisciani, Les consilia medicaux, Brepols, Turnhout, 1994. Sui vari generi nella medicina pratica d’età moderna si veda G. Pomata, Praxis Historialis: The uses of Historia in early modern medicine, in G. Pomata, N. G. Siraisi (eds.), Historia. Empiricism and erudition in early modern Europe, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 2005, pp. 105-146. 22 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI nere esistente già in epoca medioevale.10 La presentazione del paziente, l’elenco dei sintomi e il decorso della malattia non si trovavano nel consulto di Malpighi, ma erano riportati nella lettera in cui si chiedeva il suo parere, oppure in una o più relazioni accluse. I consulti malpighiani sono dunque risposte a lettere di corrispondenti e, assieme a queste ultime, fanno parte a pieno titolo dell’epistolario del medico bolognese.11 Malpighi era solito conservare una copia dei consulti spediti, come casistica utile allo svolgimento della propria attività consultiva e professionale. Tuttavia, si rifiutò sempre di pubblicare quei documenti, giudicandoli imperfetti e non adatti alla stampa. Nonostante avesse proibito perfino ai propri allievi di pubblicare quelle carte, anche dopo la sua morte, nel corso del Settecento almeno una parte delle copie dei consulti fu stampata in diverse edizioni.12 Anche Giambattista Morgagni raccolse e copiò molti dei consulti malpighiani in vista di una loro pubblicazione, senza tuttavia portare a compimento il lavoro, che ha visto la luce soltanto una ventina d’anni fa.13 Un gruppo nutrito di copie autografe di consulti è conservato presso la Biblioteca Universitaria di Bologna e fa parte della collezione di manoscritti malpighiani ritrovata da Gaetano Atti nel 1830 a Crevalcore, il paese natio di Malpighi. Atti individuò 217 consulti e li raccolse in due volumi, ordinandoli in base alla data, alla lingua di redazione (italiano o latino) e alla presenza o meno delle lettere di richiesta.14 Questi consulti, e le relative richieste, sono quasi sempre datati e in molti casi consentono di individuare l’identità del richiedente, quella del paziente e il luogo geografico di provenienza delle richieste. Per queste ragioni e per il fatto che non hanno subito interventi redazionali successivi, come avvenuto invece nel caso di quelli sistemati da Morgagni, essi sono sta10. Lockwood, Ugo Benzi cit., pp. 93-94. 11. La maggior parte dei consulti di Malpighi non è stata tuttavia pubblicata nella corrispondenza curata da Adelmann: Bertoloni Meli, The archive and consulti of Marcello Malpighi cit., pp. 113-117. 12. Ibid., n. 9, p. 112. 13. I consulti malpighiani collazionati da Morgagni sono conservati all’Accademia delle Scienze di Bologna e sono stati pubblicati in G. Plessi, R. A. Bernabeo (a cura di), Consulti di Marcello Malpighi, 1675-1694, 3 v., Istituto per la Storia dell’Università di Bologna, Bologna, 1988-1992. Una raccolta di consulti di Malpighi è stata pubblicata anche da Belloni in Malpighi, Opere scelte cit., pp. 451-490. 14. Ms. 2085, voll. IV e V, Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB). Si veda G. Atti, Notizie edite ed inedite della vita e delle opere di Marcello Malpighi e di Lorenzo Bellini, Tipografia Governativa alla Volpe, Bologna, 1847, pp. 480-81, dove sono indicati 4 consulti in più, ma il riscontro diretto sui manoscritti dà come risultato il numero di 217. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 23 ti scelti qui per condurre l’analisi di alcuni aspetti sociali della pratica medica di Malpighi.15 L’attività di Malpighi come medico e consulente ebbe inizio almeno dalla fine degli anni Cinquanta del XVII secolo. Nel 1661, ad esempio, Malpighi rispose a una richiesta di Giovanni Alfonso Borelli, che lo aveva interpellato per un consulto sulle condizioni di salute della moglie di un conoscente comune.16 Tuttavia, i più antichi consulti malpighiani conservati sono datati intorno alla metà degli anni Settanta, quando Malpighi era ormai affermato sia come anatomico, sia come medico.17 I 217 consulti qui analizzati coprono invece il periodo che va dal 1681 al 1694, anno della morte dello studioso bolognese (Fig. 1). 1. Distribuzione temporale dei consulti malpighiani. Fonte dei dati: ms. 2085, voll. IV e V, Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB). Come si vede nel grafico in figura 1, non risultano disparità rilevanti nel numero dei consulti redatti annualmente da Malpighi nel periodo in questione (1681-1694), anche se il numero tende a crescere intorno al 15. Gran parte dei consulti autografi conservati presso la BUB si ritrova in copia nella collezione ordinata da Morgagni, ma senza le relative lettere di richiesta, mentre un certo numero è stato anche inserito da Adelmann nell’edizione della corrispondenza di Malpighi. 16. Lettere di Borelli a Malpighi, Firenze, 14 e 21 ottobre 1661, in The correspondence cit., I, lett. nn. 46 e 47. 17. È possibile che i consulti degli anni precedenti, così come gli strumenti e la maggior parte delle carte di Malpighi, siano andati distrutti nell’incendio avvenuto nel 1684 nella sua villa a Corticella, vicino a Bologna. 24 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI 1685 per poi attestarsi tra 16 e 20 consulti l’anno (con un picco significativo nel 1688).18 L’impressione che si ricava da questi dati, che sono comunque parziali poiché non tengono conto di tutti i consulti malpighiani, è che nel corso degli anni Ottanta del Seicento Malpighi consolidò la sua fama come medico ampliando considerevolmente la rete sociale cui prestò la sua attività professionale. Nel 1681 Malpighi era a Bologna, dove insegnava medicina pratica all’università e dove rimase fino al termine del 1691, quando si trasferì a Roma. Le richieste di pareri medici gli giungevano da tutti gli stati italiani: dal Ducato di Modena come dalla Repubblica di Lucca, da Venezia come dalla Sicilia, dove peraltro aveva lavorato qualche anno, dal 1662 al 1666, come professore di medicina dell’Università di Messina. Dopo il trasferimento a Roma, crebbero i consulti di Malpighi indirizzati al Ducato di Toscana e ad altre città del centro Italia come Perugia. Ma Malpighi era interpellato anche dai paesi d’oltralpe. Nel 1686, ad esempio, redasse un consulto per un religioso di Malta, mentre nel 1693 gli fu richiesto un parere sulla salute di un nobile tedesco.19 La maggior parte dei consulti malpighiani riguardavano però pazienti residenti nello Stato della Chiesa, specialmente nelle città pontificie della Romagna e della costa adriatica come Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena e Senigallia. Questo dato si spiega in gran parte con ragioni di natura politica e professionale. In genere i consulti erano chiesti per pazienti illustri o, in ogni caso, per personaggi di un certo rilievo locale. Il fatto che la maggior parte delle richieste provenisse a Malpighi dallo Stato della Chiesa suggerisce che chi chiedeva il consulto si rivolgeva anzitutto ai medici più in vista di quello stato. Malpighi era senza dubbio uno di quei medici e i ruoli che ricoprì, quello di professore a Bologna e di archiatra pontificio a Roma, costituivano un solido legame tra lui e lo stato e, di riflesso, tra lui e personaggi politicamente e socialmente importanti al suo interno. Inoltre, parecchi dei medici che interpellavano Malpighi come consulente avevano studiato a Bologna, l’università nella quale, come si è 18. Questi dati andrebbero ulteriormente elaborati tenendo conto di tutti i consulti malpighiani. Da un confronto tra i consulti conservati presso la Biblioteca Universitaria di Bologna e quelli sistemati da Morgagni, Adelmann stabilisce che nel 1685, ad esempio, Malpighi redasse almeno 25 consulti e nel 1691 più di 40. Adelmann, Marcello Malpighi cit., I, pp. 491 n. 2, 608 n. 11. 19. Ms. 2085, v. V, BUB. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 25 detto, Malpighi era professore di medicina pratica dal 1666. Questo dato suggerisce, da un lato, che l’attività di consulenza si costruiva almeno in parte attraverso legami personali tra i curatori (oltre che tra i curatori e i pazienti), come quelli esistenti tra maestro e allievo. Dall’altro lato, il fatto che molti medici laureati a Bologna risiedessero in città dello Stato della Chiesa, conferma che la professione medica in età moderna era piuttosto statica e che i laureati tendevano a trovare un’occupazione all’interno dei confini nazionali. Infine, la gran parte delle richieste di consulto provenivano da città o comunque da centri urbani di una qualche rilevanza, a conferma che la professione medica era ancora un’occupazione praticata prevalentemente nelle città e che i medici raramente risiedevano in zone rurali. Un altro elemento contribuisce a spiegare la distribuzione geografica dell’attività di Malpighi come consulente. In genere i consulti erano richiesti per malattie croniche o di lunga durata, piuttosto che per disturbi acuti che imponevano invece l’intervento urgente e immediato di un curatore vicino. Tuttavia, la vicinanza del medico consulente al paziente, o comunque la relativa brevità dei tempi di comunicazione, erano ritenuti aspetti importanti anche nella scelta del consulente. Questo può spiegare l’aumento delle richieste di consulto provenienti da città dell’Italia centrale dopo il trasferimento di Malpighi da Bologna a Roma. Si è detto come molti dei consulti malpighiani fossero destinati a pazienti illustri. In effetti, dei circa 180 consulti di cui è possibile individuare con sicurezza lo status sociale del malato, il 75% (135 consulti) riguardava pazienti nobili, seguiti a distanza dai religiosi, mentre erano in numero decisamente inferiore i cavalieri e i mercanti (Fig. 2). Supponendo che tutti gli altri consulti fossero diretti a persone non titolate, circa i due terzi dei pazienti appartenevano in ogni caso alla nobiltà o alle gerarchie ecclesiastiche.20 Il dato sociale che emerge da un’analisi quantitativa della pratica consultiva di Malpighi dimostra dunque una certa continuità con quanto succedeva fin dal medioevo e conferma il carattere rigido e gerarchico della organizzazione sanitaria in età moderna. I medici, ai vertici di quella gerarchia, offrivano le loro prestazioni prevalentemente ai mem20. Una simile proporzione è riscontrabile nei consulti di Ugo Benzi. Lockwood, Ugo Benzi cit., p. 117. 26 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI 2. Status sociale dei pazienti nei consulti malpighiani. Fonte: ms. 2085, voll. IV e V, BUB. bri delle élite sociali, lasciando la cura dei pazienti meno abbienti ai curatori di rango inferiore.21 Tra i criteri che distinguevano i medici dagli altri curatori, infatti, non vi era solo il possesso di un titolo universitario e la prerogativa di prescrivere un regime di vita e di somministrare farmaci per bocca, ma anche il rango sociale dei pazienti che avevano in cura. Poteva capitare che i medici, anche i più famosi, si dedicassero alla cura di servitori o persone che svolgevano mestieri manuali, ma ciò avveniva in ogni caso entro una cornice sociale ben definita, ad esempio all’interno di strutture ospedaliere o dietro richieste specifiche di colleghi o patroni, oppure come realizzazione dell’ideale caritatevole legato all’autopromozione professionale. Ma l’acquisizione di una clientela importante, e soprattutto facoltosa, rimaneva una delle principali aspirazioni di molti medici del Seicento.22 Anche per quanto concerne il sesso dei pazienti, l’attività di consulente di Malpighi non sembra fare eccezione rispetto alla tradizione dei consilia. Il numero degli uomini è circa il doppio di quello delle donne che, con pochissime eccezioni, erano nobili o monache (Fig. 3). 21. Agrimi, Crisciani, Les consilia cit., pp. 99-100. 22. D. Gentilcore, The organisation of medical practice in Malpighi’s Italy, in Bertoloni Meli (ed.), Marcello Malpighi anatomist and physician cit., pp. 75-110. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 27 3. Rapporto tra pazienti maschi e femmine nei consulti malpighiani. Fonte: ms. 2085, voll. IV e V, BUB. Se per un malato avere un titolo o comunque un ruolo sociale elevato era una condizione favorevole per ottenere un consulto, per una malata ciò era praticamente indispensabile, identificate com’erano le donne attraverso la parentela con un uomo illustre o l’appartenenza a un convento.23 Il minor numero di pazienti donne rispetto agli uomini nei consulti malpighiani si spiega anche ricordando che all’epoca i medici lasciavano spesso la cura delle donne, soprattutto quelle di condizione non elevata, ad altri curatori come le levatrici.24 I consulti di Malpighi relativi a pazienti donne sono comunque di particolare interesse, sia perché, in ogni caso, il loro numero non è affatto trascurabile, sia perché possono dirci molto sul trattamento del corpo femminile nella medicina del periodo. I bambini, così come le donne, erano oggetto di consulto soltanto in casi particolari e grazie a legami familiari con personaggi altolocati. Nei consulti malpighiani nei quali è specificata l’età del paziente, risultano solo due bambini sotto i 10 anni, mentre l’età media dei pazienti maschi adulti è di 46 anni e quella delle pazienti di 41. 23. Agrimi, Crisciani, Les consilia cit., p. 100. 24. Sul mondo delle donne curatrici in età moderna e, in particolare, sulle levatrici, si vedano C. Pancino, Il bambino e l’acqua sporca. Storia dell’assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche (secoli XVI-XIX), Angeli, Milano, 1984; E. Brooke, Women healers through history, Women’s Press, London, 1993; H. Marland (ed.), The art of midwifery. Early modern midwives in Europe, Routledge, London and New York, 1993. 28 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI I dati riguardanti l’età, assieme a quelli considerati in precedenza, aiutano a stendere un identikit abbastanza preciso del paziente-tipo nei consulti di Malpighi: si trattava di una persona di estrazione sociale elevata, nella maggior parte dei casi un uomo in età adulta o avanzata, abitante in una città o in un centro urbano. Questo profilo corrisponde nella sostanza a quanto già sappiamo della clientela dei medici d’età moderna, soprattutto quando si è indagato nell’attività di personaggi appartenenti all’élite della categoria, professori universitari o medici di corte.25 Ma l’analisi quantitativa fin qui condotta non dice ancora nulla circa le motivazioni alla base di questa pratica, il tipo di rapporto esistente tra medico e paziente e tra Malpighi e quei colleghi che a lui si rivolgevano con la richiesta di un consulto. Malpighi e i medici Tra i diversi modi possibili di classificare i consulti vi sono le differenti circostanze della loro redazione, la finalità per cui erano redatti, la tipologia sociale del richiedente e la natura della relazione terapeutica esistente tra medico e paziente.26 Come si è detto, i consulti di Malpighi erano dei consilia in absentia, scritti per pazienti che Malpighi non aveva la possibilità di visitare di persona. Ora cercheremo di capire chi e per quali ragioni richiedeva il consulto a Malpighi e che cosa spingeva lo studioso a dedicare tanto tempo a questa attività. Tipicamente Malpighi era interpellato dal medico che aveva in cura il paziente, da un parente o conoscente del paziente, oppure ancora dal paziente stesso. Uno dei più antichi consulti conservati alla Biblioteca Universitaria di Bologna riguarda una monaca modenese quarantacinquenne, Suor Palma Celeste Tassoni. Nell’aprile del 1682, Malpighi fu consultato da due medici, Annibale Cervi e Giovanni Battista Grandi, perché da dodici anni la monaca soffriva di vari disturbi che non le consentivano di alzarsi dal letto e che il suo medico curante, Giovanni Manzini, aveva tentato invano di guarire. Morto Manzini, era stato il nipote, Annibale 25. Per una visione d’insieme della medicina d’età moderna, si veda il saggio di Andrew Wear in L. I. Conrad [et al.], The Western medical tradition, 800 BC to AD 1800, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 215-370. 26. Lockwood, Ugo Benzi cit., pp. 90-113. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 29 Cervi, a ereditare il caso di Suor Celeste insieme al resto della clientela. Nemmeno Cervi, tuttavia, aveva avuto fortuna nell’individuare la cura giusta e la monaca continuava ad avere febbre, palpitazioni e altri seri incomodi. Cervi si decise allora a chiedere un consulto a un collega modenese, Giovanni Battista Grandi, con il quale concordò una nuova cura che, ancora una volta, non ebbe l’effetto sperato. Scriveva infatti Cervi a Malpighi: Ma già che il signore mio collega ed io non abbiammo per anco potuto conseguire conforme il nostro desiderio il fine preteso, perciò soggettiamo le nostre operazioni all’ochio di chi meglio vede, ed al parere di chi più sa, acciò dalla loro prudenza, e sapere ci sia additata la via regia, e più sicura di servire con miglior fortuna chi tanto merita.27 Ci si aspettava dunque di ottenere da Malpighi preziose indicazioni terapeutiche, possibili grazie alla maggiore capacità di “vedere” e al maggiore “sapere” del famoso professore. Il fatto che Cervi attribuisse a Malpighi un occhio più acuto del proprio – sebbene il medico bolognese non avesse mai visto la paziente – si spiega naturalmente con il particolare significato che operazioni come “vedere” e “osservare” assumevano nel contesto della medicina dell’epoca. Per il medico osservare significava elaborare una storia dei sintomi patologici e delle condizioni del paziente (temperamento, stile di vita e così via), sulla cui base costruire poi l’eziologia della malattia: non era dunque necessario che un medico esaminasse personalmente il paziente se poteva disporre della storia della sua malattia. Ciò che i richiedenti trasmettevano a Malpighi era per l’appunto quella storia (e in molti casi anche le cure già effettuate), convinti che le conoscenze teoriche – il sapere – e l’esperienza pratica – il vedere – del medico bolognese fossero tali da consentirgli di esprimere un parere esperto sulla causa dei disturbi e sui loro possibili rimedi, anche senza vedere il malato.28 La decisione di un medico di chiedere un consulto a un collega può ai nostri occhi apparire rischiosa per la sua reputazione: si trattava, in sostanza, di dichiarare la propria impotenza a guarire il malato. Tuttavia, il grande numero di consulti chiesti a Malpighi da medici di ogni 27. Ms. 2085, v. IV, cc. 45-51 (cit. a c. 51), BUB. Consulti di Marcello Malpighi cit., II, p. 14. 28. Naturalmente se la storia trasmessa non era giudicata soddisfacente da Malpighi (ma ciò accadeva raramente), egli si rifiutava di fornire il consulto o richiedeva un supplemento di informazioni. Sul rapporto tra osservazione e storia nella medicina e nella scienza d’età moderna si veda G. Pomata, “‘Observatio’ ovvero ‘historia’. Note su empirismo e storia in età moderna”, in Quaderni storici, 31, 1996, pp. 173-198; Pomata, Siraisi (eds.), Historia, cit. 30 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI parte d’Italia, oltre alla diffusione di questo genere letterario nella medicina seicentesca, suggeriscono un’altra lettura del fenomeno. A certe condizioni ottenere un consulto poteva costituire un elemento di prestigio professionale e una carta vincente che il medico era in seguito in grado di giocare nel mercato dell’offerta sanitaria. La carta, com’è ovvio, era tanto più preziosa quanto più il consulente era famoso all’interno della comunità medica e nel più vasto contesto sociale e politico. Malpighi, professore di medicina pratica in un’università prestigiosa, socio di accademie scientifiche e autore di importanti testi medici, era molto noto e certamente lo era diventato ancora di più dopo la nomina ad archiatra pontificio. I suoi titoli esercitavano una sicura presa sui medici e anche su molti pazienti, sia che appartenessero a classi sociali elevate (e questo era il caso, come si è detto, della maggioranza dei pazienti per i quali Malpighi redigeva consulti), sia che non vi appartenessero (e in questo caso poteva essere il medico a spiegare al paziente quanto fosse privilegiato a ricevere un tale consulto). Accadeva anche, come vedremo, che fossero invece gli stessi pazienti a pretendere che il loro medico si consultasse con Malpighi. Come mostra il caso di Suor Celeste, la decisione di rivolgersi a Malpighi poteva avvenire dopo aver coinvolto altri medici, come ultimo tentativo terapeutico. Nell’ottobre del 1689 il medico Angelo Rambaldi di Novellara, una piccola località vicino a Reggio nel Ducato di Modena, scrisse a Malpighi in relazione alla malattia del tenente colonnello Carlo Pradella (o Predelli), affetto da disturbi alla vescica. Rambaldi era stato a sua volta interpellato assieme a un altro medico, Prospero Marmiroli di Reggio, da coloro che avevano in cura il militare per fornire un consulto circa la presenza o meno di una “pietra” (un calcolo) nella vescica del paziente. Esclusa questa causa, i due avevano prescritto una nuova terapia, che tuttavia si era rivelata inefficace. Rambaldi si rivolgeva dunque a Malpighi, attendendosi dalla sua “impareggiabile peritia” l’indicazione dei rimedi necessari a guarire il colonnello.29 Un mese e mezzo dopo questa prima lettera, anche l’altro consulente inizialmente coinvolto, Marmiroli, scrisse a Malpighi una relazione sulla malattia di Pradella, diversa nello stile da quella di Rambaldi, ma simi- 29. Ms. 2085, v. V, cc. 408-409, BUB; pubbl. come Lettera di A. Rambaldi a Malpighi, Novellara, 17 ottobre 1689, in The correspondence cit., IV, lett. n. 782. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 31 le nel contenuto, chiedendo anch’egli lumi sulla terapia da adottare in quel difficile caso.30 Malpighi rispose ai due medici con un consulto datato primo dicembre 1689, nel quale giudicava il caso “tanto difficile” e, com’era suo costume e come prescrivevano le convenzioni del genere, si rimetteva “alla somma prudenza” dei medici curanti.31 Il caso, in effetti, si rivelò al di sopra delle capacità terapeutiche di Malpighi e le condizioni del paziente continuarono a peggiorare nei mesi successivi fino sua alla morte, avvenuta il 20 aprile 1690. Malpighi fu informato della morte del colonnello da una lettera di Marmiroli, nella quale era riportata anche l’autopsia del paziente che peraltro non aveva confermato, per stessa ammissione dello scrivente, la diagnosi di calcolo formulata a suo tempo. La lettera fu consegnata a Malpighi da un nipote del defunto, che voleva ringraziare di persona il medico bolognese per l’assistenza prestata al parente e cogliere l’occasione per “domandargli consiglio di certi suoi mali che patisse, che lui stesso esponerà, come d’altri di suoi congiunti”.32 Il caso del colonnello Pradella è interessante da molti punti di vista. In primo luogo, il resoconto fatto dal medico reggiano dell’autopsia del paziente conferma che nella seconda metà del Seicento questa pratica aveva ormai perso i connotati di un evento eccezionale, legato a situazioni particolari come gli accertamenti medico-legali, le pratiche relative ai processi di beatificazione e santificazione o l’individuazione delle cause di morte di personaggi di assoluto rilievo (e non era certamente questo il caso del colonnello Pradella). Lo stesso Malpighi fu chiamato a eseguire diverse autopsie, sia su pazienti propri sia di altri medici.33 In secondo luogo, il caso Pradella rivela particolari significativi dell’attività consultiva di Malpighi. Egli seguì l’evolversi della malattia per parecchi mesi attraverso la corrispondenza con i medici curanti; la sua attività consultiva, in questo come in molti altri casi, richiedeva dunque un impegno duraturo e interventi ripetuti. Inoltre, accadeva di frequente che uno stesso medico si rivolgesse a Malpighi per più di un 30. Ms. 2085, v. V, cc. 402-405, BUB, pubbl. nell’appendice documentaria alla fine del saggio. 31. Ibid., cc. 412-413; pubbl. in Consulti di Marcello Malpighi cit., I, pp. 206-208. 32. Ibid., cc. 406-407, 414; pubbl. in The correspondence cit., IV, lett. n. 824. Si veda anche ibid., lett. n. 808. 33. L. Munster, Marcello Malpighi: “Anatomica sive in cadaveribuis sectis observationes”, in Celebrazioni malpighiane. Discorsi e scritti, Azzoguidi, Bologna, 1966, pp. 170-228; Malpighi, Opere scelte cit., pp. 413-448. 32 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI paziente: una volta stabilito, il rapporto con il consulente tendeva a conservarsi e rafforzarsi nel tempo. Si creava così tra Malpighi e i colleghi operanti nei diversi stati italiani una rete di relazioni che contribuiva, allo stesso tempo, ad accrescere la fama del medico bolognese e, a livello locale, a consolidare il prestigio dei medici che gli si rivolgevano. Da questa rete erano esclusi, a quanto risulta dai documenti, altri curatori che non fossero medici, come i chirurghi, gli speziali e le donne curatrici. I medici che interpellavano Malpighi per consulto occupavano posizioni diverse nella gerarchia professionale dell’epoca. Si poteva trattare del semplice medico che si guadagnava da vivere con l’attività pratica, così come del professore universitario con ruoli di vertice negli organismi sanitari di una città o di uno stato.34 Quel mondo, a un primo sguardo superficiale, può apparire tutto sommato omogeneo, senza differenze significative nelle indicazioni diagnostiche e terapeutiche tra un medico e l’altro o tra medici e curatori diversi. Tuttavia, se si indaga più da vicino nell’attività di consulenza di Malpighi e in quella di altri medici dell’epoca, il quadro si fa via via più complesso ed emergono posizioni tutt’altro che simili circa il modo di affrontare le malattie e mettere a punto le cure. Nel 1684, ad esempio, Lorenzo Bellini chiese a Malpighi consiglio sulla salute del fratello maggiore, curato a Napoli prima da Leonardo di Capua e Tommaso Cornelio e poi da medici “d’altra fazione”. Al paziente erano stati somministrati rimedi diversi secondo il “capriccio” di chi lo aveva in cura, tutti risultati inefficaci se non addirittura dannosi. Il fratello di Bellini si trovava così “aggiustato pel dì delle feste” al punto da rischiare di morire.35 Quello stesso anno Malpighi si rifiutò di commentare un consulto trasmessogli dal medico ferrarese Leonardo Mezzogori: anche in questo caso emergeva una profonda differenza di vedute diagnostiche e terapeutiche, che indusse Malpighi a esprimersi con un tono molto cauto e a rispondere che sul caso in questione “non devo, né posso motivare cosa alcuna”.36 34. Capire se e in che modo questa diversità di ruolo sociale dei medici si rifletteva nello stile e nel linguaggio utilizzati nelle lettere di richiesta e nelle risposte/consulti di Malpighi è oggetto di analisi nel progetto di ricerca in corso, così come pure l’indagine di eventuali approcci diversi alla malattia e alla cura adottati dai medici che interpellavano Malpighi. 35. The correspondence cit., III, lett. nn. 466 e 467. 36. Ms. 2085, v. V, cc. 259-260, BUB; pubbl. in The correspondence cit., III, lett. n. 445. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 33 Nella sua attività medica lo studioso bolognese si fece portavoce di un particolare approccio alla malattia e alla cura che, come sostenne l’allievo Antonio Vallisneri a inizio Settecento, fece scuola in ambienti come Bologna, ma non piacque in altri: “Sappia pure – scriveva Vallisneri al suo corrispondente al fine di difendere la pubblicazione dei consulti di Malpighi – che la pratica de’ bolognesi appresso certi satrapi è detestata, e dicono appunto che il Malpighi gli ha guasti tutti, [...] onde è giusto che ci difendiamo, la pubblichiamo e facciamo vedere quanto sia savia, utile, fondata”.37 Una rilettura dei consulti, dunque, consente di gettare nuova luce non solo sulla pratica medica di Malpighi e sul rapporto tra questa e la sua concezione meccanicistica e “razionale” della medicina, ma anche sui diversi approcci alla malattia e alla cura che si disputavano il campo in età moderna. Malpighi e i pazienti La pratica consultiva costituiva naturalmente una fonte di potenziali conflitti tra i membri della professione medica, perché il confronto tra i diversi approcci terapeutici poteva influenzare il mercato della domanda di cura. Nella sua attività di consulente Malpighi sembra seguire una serie di regole di comportamento, indipendenti dalla persona che l’aveva interpellato e finalizzate a evitare conflitti con gli altri medici. Una di queste regole, come abbiamo visto, era di concludere il consulto dichiarando di volersi comunque affidare al giudizio dei medici curanti per la decisione finale sulla terapia. Un’altra era di evitare di contraddire apertamente le indicazioni diagnostiche e terapeutiche degli altri medici anche quando, come nel caso sopra citato del consulto trasmessogli da Mezzogori, le divergenze di vedute erano profonde. Queste formule retoriche, che si accompagnavano a uno stile di scrittura sempre ispirato a grande cautela e modestia, appartenevano evidentemente a un codice di comportamento adottato da Malpighi e dagli altri autori di consulti dell’epoca, una sorta di deontologia professionale per 37. Lettera di A. Vallisneri a V. A. Pigozzi, Padova, 1 maggio 1713, in A. Vallisneri, Epistolario, a cura di D. Generali, v. 2, Angeli, Milano, 1998, p. 303. B. Gemelli, “Entre l’artifice et la pertinence: la composition des consultations médicales de Antonio Vallisneri”, in Medicina & Storia, 9, 2005, pp. 35-60. 34 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI certi versi simili all’ethos della ricerca che guidava la comunità dei filosofi naturali del Seicento.38 A ogni occasione il consulto metteva potenzialmente in discussione non solo i rapporti tra i membri della professione medica, ma anche i rapporti tra questi e i pazienti. Il parere esperto faceva breccia nello spazio fiduciario e tendenzialmente esclusivo in cui si muovevano il malato e il suo curatore, mettendo a rischio equilibri consolidati. A questo proposito occorre tenere presente che in età moderna il rapporto tra curatore e paziente era meno squilibrato dalla parte del curatore di quanto non sia stato in seguito, dopo lo sviluppo della medicina “scientifica” ottocentesca. In molti casi, infatti, era il paziente che occupava una posizione di forza nella relazione terapeutica.39 Uno dei mezzi che il paziente aveva a sua disposizione per farsi valere era naturalmente quello di pretendere l’intervento di più medici, incaricando il proprio medico di rivolgersi a un altro esperto, oppure rivolgendosi personalmente a un consulente. Dietro la maggior parte delle richieste di consulto ricevute da Malpighi, infatti, anche quando formalmente era un medico a scrivere, vi era in realtà la volontà del paziente. Talvolta era invece il paziente a prendere in mano la penna e a interpellare direttamente Malpighi, come nel caso di un signore faentino, Giulio Cesare Naldi, che nel 1683 scrisse: [...] e non ho voluto che il mio signore medico scriva a vostra signoria illustrissima sopra a ciò perché proponendomi un decotto, che parmi non mi si convengha, ad effetto non li rapresenti diversamente di quello gli ho descritto, ho voluto esere io che scriva.40 Questa richiesta di consulto è particolarmente interessante, poiché testimonia quanto potessero essere complessi i rapporti tra curatori e pazienti in questo periodo. Naldi decise di rivolgersi a Malpighi in prima persona non solo perché riteneva che il proprio medico avesse sbagliato diagnosi e cura, ma addirittura perché non si fidava di ciò che il suo medico avrebbe riferito al consulente. Il rapporto fiduciario tra medico e paziente era evidentemente venuto meno, un fatto che si ri38. S. Shapin, A social history of truth, The University of Chicago Press, Chicago, 1994. 39. G. Pomata, La promessa di guarigione. Malati e curatori in antico regime, Laterza, RomaBari, 1994. 40. Ms. 2085, v. V, cc. 241-243, BUB; pubbl. in The correspondence cit., II, lett. n. 420 e in Consulti di Marcello Malpighi cit., I, pp. 62-63. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 35 flette nella risposta di Malpighi, come sempre cauta e non poco imbarazzata. Malpighi dapprima insistette sulla difficoltà di determinare la causa dei disturbi di Naldi, quasi a giustificare l’operato del collega; poi rimandò al medico curante l’individuazione dei segni patologici; infine si scusò di non potersi dilungare sul caso in quanto si trattava di disturbi che lui stesso provava, “onde mi affliggo sentendo simili storie”, quasi a volersi spogliare delle vesti di medico: non per confortare il paziente (come invece era solito fare ad esempio Redi), bensì per liquidarlo.41 Quello di Naldi è un caso limite nell’attività di consulenza di Malpighi. La maggior parte dei pazienti che si rivolgevano direttamente al medico bolognese non metteva così apertamente in discussione l’operato del proprio curatore e il rapporto fiduciario esistente. Ciò che ricercavano da Malpighi era un altro parere esperto sulla loro malattia e soprattutto indicazioni terapeutiche più efficaci dei rimedi presi fino a quel momento. Come scrisse un paziente di Gubbio: Io che vivo in sì calamitoso stato, sentendo il glorioso grido del merito impareggiabile dell’Eccellentissimo Signore Dottore Malpighi, e quanto sia di profitto al genere humano, sono con tutto lo spirito a supplicare Sua Signoria Ecellentissima a farmi l’honore di espormi i suoi sensi circa il mio suddetto male, e prescrivermi un’esatta purga per sradicare affatto questo mio contumacissimo male, e con tanta fede et ansietà indicibile attendo le sue pregiatissime grazie, dalle quali ho così ferma fede di riaquistare una perfetta salute, che piacendo a S.D.M. mediante le sue prudentissime direttioni impiegherò la mia vita in pregare il Signore Iddio per la conservatione del mio liberatore.42 Per il malato, interpellare il medico famoso, personalmente o attraverso intermediari, costituiva già di per sé un atto terapeutico, indipendentemente dal contenuto del consulto: “il suo solo nome è stato bastante a riempire di speranza l’ammalato”, scriveva a Malpighi il fratello di un paziente.43 A queste richieste Malpighi rispondeva adottando il codice di comportamento di cui si è detto e mostrando spesso un 41. Consulti di Marcello Malpighi cit., I, p. 64. Sullo stile di Redi si veda Basile, L’invenzione cit., p. 119. 42. Ms. 2085, v. V, cc. 380-81, BUB; pubbl. nell’appendice documentaria alla fine del saggio. 43. Lettera di Borghese a Malpighi, Roma, 6 aprile 1685, in The Correspondence cit., II, lett. n. 508. Si veda Gemelli, Le langage de la maladie dans la correspondance de Antonio Vallisneri, in corso di pubbl. negli Atti del “Colloque international Maladie en lettres/ Krankheit in Briefen (17-20e siècle/ 17.-20 Jh.), 26-28 juin 2003 - Université de Lausanne”, a cura di V. Barras e M. Dinges. 36 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI atteggiamento quasi di ritrosia nei confronti dell’interlocutore. “Per il solo motivo d’obedire a i comandamenti di Vostra Signoria Illustrissima, ho preso la penna, non essendo il dovere, ch’io entri a giudicare le determinationi di quei, che sono maestri nell’arte”: così esordiva Malpighi nella risposta a un marchese che gli chiedeva consiglio per il trattamento dell’infertilità sua e della moglie.44 Sembra a questo punto lecito chiedersi: che cosa spingeva Malpighi a rispondere alle richieste provenienti dai pazienti, giacché ciò poteva creare tensioni con i colleghi? Più in generale, quali erano le motivazioni alla base della sua attività di consulente? Senza dubbio la pratica del consulto era un segno di distinzione all’interno della professione medica del periodo, come potevano esserlo una lettura universitaria o un incarico istituzionale in campo sanitario: chi redigeva consulti era identificato dai colleghi, e da un certo pubblico, come membro dell’élite professionale. Naturalmente tale pratica poteva anche essere fonte di guadagno, come suggerisce l’esempio del duca di San Severino, che si rivolse a Malpighi per consiglio assicurandogli “che sarà riconosciuto da me come merita”.45 L’attività di consulente, in ogni caso, costituiva soprattutto un mezzo per entrare in contatto o rinforzare i rapporti con l’ambiente sociale e politico delle élite cittadine, dal quale dipendevano le fortune dei medici come Malpighi. Si è detto che le richieste di consulto a Malpighi potevano provenire da un medico, dal paziente o da un parente o conoscente di quest’ultimo e che la maggior parte dei malati oggetto di consulto appartenevano alle classi sociali più elevate. Quando erano i pazienti o i loro congiunti a interpellare direttamente Malpighi, l’appartenere alla nobiltà o alle gerarchie ecclesiastiche sembra essere stata una condizione necessaria e sufficiente. Nel 1685, ad esempio, Marcantonio Borghese si rivolse a Malpighi per chiedere un consulto sulla malattia del fratello ventunenne.46 Appartenente a una delle famiglie nobili più importanti dello Stato della Chiesa, Borghese era nipote del cardinale Girolamo Boncompagni, che 44. Lettera di Malpighi a ignoto, Ronchi di Corticella, 16 giugno 1682, in The correspondence cit., II, lett. n. 407. 45. Lettera del duca di Sanseverino a Malpighi, Foligno, 16 ottobre 1685, in The correspondence cit., III, lett. n. 537. Questo importante aspetto dell’attività di Malpighi sarà indagato a fondo in una prossima fase della ricerca. 46. Ms. 2085, v. IV, cc. 250-51, BUB; pubbl. in Consulti di Marcello Malpighi cit., II, pp. 279-81 e in The correspondence cit., III, lett. n. 502. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 37 era stato arcivescovo di Bologna fino alla morte, avvenuta nel gennaio del 1684. Malpighi era stato uno dei medici curanti del cardinale e aveva forse partecipato anche all’autopsia del prelato, riferendone i risultati al medico della famiglia Borghese e poi anche al principe, suo nipote.47 Malpighi continuò a fungere da consulente per la salute dei membri della famiglia nobiliare romana anche negli anni successivi, stabilendo con Marcantonio Borghese un rapporto epistolare duraturo che, nel corso del tempo, si allargò a questioni letterarie, scientifiche e politiche. Nel 1690, ad esempio, Malpighi gli chiese di adoperarsi in suo favore nella vicenda della riforma dello Studio bolognese.48 Anche molti alti prelati si rivolgevano a Malpighi per ricevere consiglio medico, in modo diretto o attraverso intermediari. Nel 1686, ad esempio, Malpighi scrisse un consulto per l’arcivescovo di Ravenna Fabio Guiniggi, che l’aveva interpellato attraverso l’amico Silvestro Bonfiglioli perché esprimesse il suo giudizio sulla propria malattia e sulla validità dei rimedi prescritti da un altro medico.49 L’anno successivo Guiniggi richiese a Malpighi un consulto per un nobile lucchese suo amico, fungendo quindi da intermediario tra il paziente e il consulente. Molti altri vescovi e cardinali di varie città italiane compaiono nei consulti malpighiani, così come i membri di alcune delle famiglie nobili più importanti dell’epoca, tra cui gli Aldrovandi, i Malvasia, i Tanari, i Malvezzi, gli Zambeccari di Bologna, gli Strozzi di Ferrara, i Raggi e i Pallavicini di Genova, i Borromeo di Milano, i Panphili e i Colonna di Roma, i Savoia (ma l’elenco potrebbe essere molto più lungo). Nel 1688 e poi nuovamente nel 1693, Malpighi fu interpellato anche dal medico del re di Polonia per la malattia di sua maestà e della consorte. Se ai nomi dei pazienti oggetto di consulto aggiungiamo quelli degli uomini e delle donne che Malpighi curava personalmente, a cominciare dal pontefice Antonio Pignatelli di cui era stato medico ai tempi della permanenza bolognese del religioso come cardinale legato, ci ritroviamo all’interno di una rete di rapporti che riconducono direttamente al potere dominante in Italia e, in particolare, nello Stato della Chiesa, nella seconda metà del Seicento. 47. Ibid., nn. 433, 434, 437. 48. Adelmann, Marcello Malpighi cit., I, pp. 62-63. 49. Ms. 2085, v. V, cc. 83-88, BUB; pubbl. in Consulti di Marcello Malpighi cit., II, pp. 302308 e in The correspondence, cit., III, lett. nn. 574, 576. 38 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI Conclusione I medici e i pazienti cercavano il consiglio professionale di Malpighi perché lo consideravano un grande medico pratico, “l’Esculapio del nostro secolo”, il cui “solo tocco della mano, una sola occhiata” o anche un parere scritto e a distanza erano capaci di guarire i malati.50 Era effettivamente così? La fama di Malpighi come medico derivava da un approccio particolare alla diagnosi e alla terapia che si era rivelato più efficace di altri, oppure era costruita piuttosto sui meriti accademici e sulla notorietà conquistata grazie alle ricerche anatomiche e filosofico-naturali? Lo studio in corso dei consulti malpighiani potrà contribuire a rispondere a questa domanda e a comprendere meglio i rapporti tra teoria e pratica medica in un autore come Malpighi e, più in generale, nella medicina di età moderna. A questa questione se ne collega un’altra, relativa alle motivazioni che muovevano Malpighi nel campo della pratica e al rapporto tra medicina e potere. In diverse occasioni il medico bolognese si lamentò della quantità di tempo ed energie che era costretto a dedicare a questa attività, un impegno che lo costringeva a sacrificare il lavoro di ricerca e che talvolta sentiva come una vera e propria schiavitù.51 Per esempio, nella risposta a una lettera polemica di Sbaraglia “contro gli studi dei medici moderni”, pubblicata nel 1689, Malpighi replicò all’affermazione che vi erano molti medici “bramosi di medicare” con queste parole: Quelli, poi, li quali nel presente secolo attendono alle tre anatomie proposte dall’autore, non so se siano bramosi di medicare; poiché simili curiosi, nauseati dal tedio della pratica e spaventati dalla vastità dell’arte, si applicano per genio alla coltura di questa parte, la quale, richiedendo libertà, quiete d’animo e ozio, non permette l’atto pratico così frequente di medicare: ed io stesso per lo spazio di vent’anni mi sono assentato dalla città, vivendo in villa gran parte dell’anno.52 Malpighi si identificava con quei “curiosi, nauseati dal tedio della pratica e spaventati dalla vastità dell’arte,” che preferivano dedicarsi alla ricerca anatomica e allo studio della filosofia naturale. Tuttavia, 50. Lettera di G. Grandi a Malpighi, [Venezia, 1 maggio 1684], in The correspondence cit., III, lett. n. 454. 51. Adelmann, Marcello Malpighi cit., I, p. 379. 52. Malpighi, Opere scelte cit., p. 506. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 39 si guardava bene dal rifiutarsi di curare i pazienti o di rispondere a richieste di consulto che gli giungevano continuamente, come abbiamo visto, da ogni parte d’Italia e d’Europa. D’altra parte, egli si lamentava dell’impegno profuso nella pratica medica soprattutto con gli studiosi di filosofia naturale e i membri della repubblica letteraria dell’epoca, spesso per giustificare ritardi nell’attività di ricerca o presunte mancanze nei propri lavori scientifici, mentre si guardava bene da qualunque lamentela con i colleghi medici o con i pazienti. La pratica medica era qualcosa che Malpighi, almeno a parole, non sembrava amare particolarmente; ma in realtà essa costituiva una parte essenziale della sua attività, che gli consentiva di tessere una vasta rete di rapporti, sia con gli altri medici sia con personaggi di rilievo della società e della politica del tempo, permettendogli così di promuovere la propria condizione professionale e, non ultimo, i suoi studi scientifici. Come abbiamo visto, la maggior parte dei pazienti con cui Malpighi entrava in contatto attraverso l’attività di consulenza, apparteneva alle élite laiche e religiose dello Stato della Chiesa e degli altri stati dell’epoca. Il rapporto tra Malpighi e questi pazienti sembra possedere alcuni caratteri della relazione di patronage che ebbe un ruolo così importante nella medicina e nella scienza d’età moderna: tra questi, l’importanza dei favori del patrono per il successo professionale del medico o del filosofo naturale. Tuttavia, nel caso di Malpighi la relazione di patronage non ha quel carattere di esclusività di rapporto tra patrono e protetto che vigeva negli ambienti di corte. La sua clientela non apparteneva a un unico centro di potere, ma era rappresentativa di diverse realtà locali e nazionali, sebbene collegate tra loro. Anche dopo essere divenuto archiatra pontificio, Malpighi non servì solamente il papa o la sua corte, ma continuò a svolgere un’attività medica e consultiva ampia nei numeri e diversificata nei soggetti. Da questa attività emerge la figura di un medico non più legato a contesti prevalentemente locali, ma semmai capace di promuovere la propria posizione e i propri interessi a un livello molto più esteso, grazie a una vasta rete di relazioni sociali e politiche con le classi dominanti, pronte a ricambiare i servigi ricevuti dal medico con denaro e favori professionali. Il rapporto tra Malpighi e il potere sembra dunque configurarsi più in senso orizzontale che verticale, come invece accadeva tradizional- 40 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI mente nelle società cortigiane: una realtà suffragata da documenti importanti come i consulti, che aprono nuove prospettive nello studio dell’identità del medico in questo periodo e nell’indagine del ruolo della medicina nella società e nella cultura verso la fine dell’età moderna. DOCUMENTI Di seguito sono pubblicate due richieste di consulto a Malpighi, entrambe risalenti al 1689, conservate alla Biblioteca Universitaria di Bologna, ms. 2085, vol. V. La prima è scritta da un signore di Gubbio di cui non si conosce l’identità, ma che sembra un personaggio altolocato (a lui Malpighi si rivolge come “nobile signor paziente”). Alla richiesta di consulto fa seguito una relazione, scritta dallo stesso paziente, sulle condizioni della sua salute e la storia della malattia. Questo documento risulta inedito, mentre il consulto di Malpighi è stato pubblicato in Consulti di Marcello Malpighi, 1675-1694, cit., I, pp. 169-170. Come in molti altri casi, la raccolta dei consulti malpighiani curata da Morgagni e pubblicata nel 1988 da Giuseppe Plessi e Raffaele Bernabeo, comprende dunque il consulto di Malpighi ma non la relativa richiesta, che pure è un documento fondamentale, come si è visto, per uno studio dell’attività medica di Malpighi e per comprendere il contesto sociale della medicina dell’epoca. Anche la seconda richiesta di consulto è inedita. In questo caso l’autore non è il paziente, ma il medico curante, Prospero Marmiroli di Reggio Emilia. Come nel caso precedente, nell’edizione moderna dei consulti malpighiani è inserito solo il consulto di Malpighi (Consulti di Marcello Malpighi, 1675-1694, cit., I, pp. 206-208). Altri documenti relativi a questo caso sono pubblicati nella corrispondenza malpighiana (The correspondence of Marcello Malpighi, cit., IV, lett. nn. 782, 808, 824), nella quale, tuttavia, non è stata inserita la richiesta di Marmiroli in quanto il curatore, Howard Adelmann, non ha ritenuto che appartenesse al genere epistolare.53 Nella trascrizione del testo si è seguito un criterio conservativo, con il rispetto della punteggiatura, delle forme e delle grafie originali. Si sono 53. Bertoloni Meli (ed.), The archive and consulti of Marcello Malpighi cit., p. 113. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 41 invece modernizzate maiuscole e minuscole, accenti e apostrofi, l’uso dell’h nelle forme del verbo avere.54 Un paziente scrive a Marcello Malpighi * L’anno 1687 il Signore dottore Alessandro Coccia Primo medico di questa città, mi favorì di purgarmi, e doppo mi fece prender per alcune settimane il vetriolo di Marte per tor via l’ostruttioni da gl’hippocondri e nel fine mi fece pigliare il Magisterio di [...] con suoi brodi proportionati, ma però mi sono scordato conferirli l’indispositione della gonorrea, che ho scrupolo non averla confessata, non sapendo se possa pregiudicare alla cura. In questa purga, e doppo mi sono sentito assai sollevato, ma da molti mesi sono travagliato spesse volte da debolezze di testa con qualche leggiera palpitatione. Al presente mi ritrovo con flati ne gl’hippocondri, che mi fanno tensione, vellicationi, tremori, e qualche mite palpitatione di cuore, mi sento una smania interna, e più me l’accresce l’apprensione d’un male pericolosissimo, mi soggiunge ancora un impedimento al vedere fisso, al scrivere, e leggere (tutt’effetto, credo della mia fissa apprensione) et anco evaporationi alla testa, con regurgito alle volte di matterie accide allo stomaco, quasi sempre doppo il cibo, e nel pranzare alle volte m’impedisce il bevere. Io che vivo in sì calamitoso stato, sentendo il glorioso grido del merito impareggiabile dell’Eccellentissimo Signore Dottore Malpighi, e quanto sia di profitto al genere humano, sono con tutto lo spirito a supplicare Sua Signoria Ecellentissima a farmi l’honore di espormi i suoi sensi circa il mio suddetto male,55 e prescrivermi un’esatta purga per sradicare affatto questo mio contumacissimo male, e con tanta fede et ansietà indicibile attendo le sue pregiatissime grazie, dalle quali ho così ferma fede di riaquistare una perfetta salute, che piacendo a S.D.M. mediante le sue prudentissime56 direttioni impiegherò la mia vita in pregare il 54. I criteri di trascrizione qui adottati seguono quelli elaborati dall’Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Vallisneri. Si veda A. Vallisneri, Quaderni di osservazioni, I, a cura di C. Pennuto, Olschki, Firenze, 2004, pp. lxxxv-lxxxviii. * Ms. 2085, v. V, cc. 380-81, 384-85, BUB. 55. “farmi l’honore di espormi i suoi sensi circa il mio suddetto male”. Nel ms. questa frase è stata aggiunta successivamente. 56. prudentissime. Nel ms. si legge “prandettissime”. 42 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI Signore Iddio per la conservatione del mio liberatore. Quam Deus etc. Io N.N. ritrovandomi nell’età d’anni 43 con temperamento caldo, e secco rimesso, d’habito mediocre carnoso, di colore rubicondo fosco, di capelli negri, e nel fine alquanto crespi. Nell’anno 22 di mia età trascorsi in un errore giovanile con una donna, per il di cui comercio aquistai una gonorrea, che mi tenne appresso 15 mesi, non ostante le purghe fattemi dal Signore medico in Roma, e perché vedevo la contumacia, discorsi con un medico, che mi consigliò a prendere per cinque mattine una chiara d’ovo con sugo di limoni sbattuti assieme, né da ciò ricevei sollievo, anzi precipitai all’improviso una notte delle dette cinque mattine in una tormentosa palpitatione di cuore, che parevami morire suffocato; subito furono chiamati i primi Signori medici di Roma, che mi prescrissero una purga col cavar sangue dal piede, e da questa purga ne ricevei sollievo, solo due volte il mese mi toccava detta palpitatione, ma mite. Tre mesi doppo il principio della palpitatione, discorrendo con un gentilhuomo mio amico, vicino di camera, di questa mia palpitatione mi disse ancor lui patirne, ma in verità era differente dalla mia; accadé che detto signore una mattina fu ritrovato morto in camera, io appresi tal morte, oltre al vincolo dell’amicitia, che mi produsse dolore, ch’ancor’io dovevo morire per tal male, e così fu la forte apprensione, che sin hora la conservo, et hallora in me s’augumentò il male col pormi in pessimo stato; sì che i signori medici mi dissero esser il mio male hippocondriaco, e per ciò mi fecero una lunga purga, doppo l’acciaro in diversi modi, et in fine li bagni, ne quali restai libero dalla gonorrea, e perché vedevano ancora il male contumace, mi prescrissero la mutatione dell’aria; ritornato in Gubbio mia patria ho provata la palpitatione intermittente più assai del solito, cioè una volta in due mesi, e quando due volte il mese, e questa mi viene circa le sette hore della notte per il più nella digestione, ma con il vomito di qualche portione di cibo, e di matterie aquose acide, né resto sollevato. Un medico scrive a Marcello Malpighi * Il Signor Tenente Colonello Pradella d’età di 55 anni, di statura alta, di corpo gracile, di temperatura bilioso, pocco regolato a tempi passati * Ms. 2085, v. V, cc. 402-405, BUB. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 43 in sex rebus non naturalibus, sono 25 anni da che patisce nell’urina, non ha però mai havuto calculo, né dolore nefritico, né arenne entro l’urina. Ha avuto caruncule nell’uretra, ha patito scolatione di seme etc. Sarano 12 anni che patì, come riferisce nell’istesso modo il male d’urina, come la presente ne è molestato, e fu medicato con solutivi, con alteranti, e con decotto di china, e ne restò molto solevato. Al presente quasi sarà un anno nel quale più del suo solito è travagliato, et è, che ha l’incommodo d’urinare più, e più volte ad ogni hora, ha il dolore nell’urinare con ardore entro l’uretra, non però sempre, et anche di quando in quando entro la vesica. Esce l’urina alle volte a fontana al peso di tre e più onze per volta, in questi giorni ne anche al peso d’un onza per volta, alcune pocche volte da pocco tempo in qua esce a gosie a gosie, alcune altre volte pare, che non possa uscire, non si è però mai restata d’uscire. Non sente dolore doppo haver urinato alla gianda; da pocchi giorni sono lo sente però quasi per tutta l’uretra quando ha fornito d’urinare. Pare che urini meglio levato dal letto, che coricato, da pocchi giorni sono alcune volte meglio in letto, che coricato. L’urina che fa è torbida di colore ceneritro, che restando nel bicchiere deponne al fondo una materia crassa di colore cineritro, quale come colla s’ataca al bichiere nel fondo, et a forza solo si staca; più ne depongono di questa materia le urine della note, che quelle del giorno; anzi che quelle del giorno in particolare la mattina sono manco torbide, e la materia, che depongono più tardi la depongono, e non è tanto aglutinata anzi come gelatina in vari pezzetti divisa. Attribuisce questi effetti perché piglia nella mattina qualche alterante, al presente siero di capra destilato con cicoracei al peso di otto onze, e sarano da duoi giorni, che con questo s’è accompagnato un poco di croco di Marte astringente; ma se nella sera piglierà il detto siero, pure nella note averà l’urina più torbida della mattina, e che deponne più glutinoso. Non solo deponne detta materia glutinosa, ma anche attorno al bicchiere lascia una materia viscida come un vello. Alcune volte s’oservano nell’urina, subitto, che è uscita, certi filamenti longhi, e crassetti, che poi anche essi restando l’urina nel bichiere si deponganno al fondo, e s’aglutinano con l’altra materia. Alcune volte s’è osservato nell’urina qualche segno di sangue, cioè che l’urina è venuta rosa, e alcune volte ha avuto seco qualche piccolo grumetto di sangue. 44 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI La materia come dissi che si deponne è glutinosa, e quella, che da un bicchiere d’urina, che sia capace di 18 onze d’urina, che si deponne sarà nel fondo del bicchiere, il quale è più angusto della cima, sarà dico all’altezza di un detto per traverso, e molte volte meno. L’urina quando ha deposto resta come lesivio men torbido. Non eccede in quantità l’urina a quello che beve, e se eccede pocco eccede. Non s’è mai osservata con detta materia glutinosa accompagnata portione calculosa, o sabulosa. Gli pare però da pocchi giorni sono nell’anettarsi doppo urinato di sentire restato alla punta della gianda qualche cosa di ruvido come granello d’arena. Doppo le aque di Grafagnana, e quelle della Brandola prese nella staggione passata, si sentì meglio, ma non durò molto questo suo meglio, et in quel tempo che beveva le aque le urine o che deponevanno pocca materia (erano però copiose a causa delle aque, et erano anche torbide abbenché meno torbide) e quella non era glutinosa, che si attacasse al bichiere, o che non deponevano cosa alcuna. Ha pure al presente due caroncule una nel mezzo dell’uretra, e l’altra vicino al colo della vescica, che però lasciano entrare una piccola candeletta di cera. Sono pocchi giorni, che quasi dal continuo è molestato da dolore con brusiore nel sito delle dette caroncole. Patisse anche alcune volte dolore gravativo alli reni, et urente, che 57 lo molesta, e si fa sentire nel cavalcare in maniera come dice pare che siano cani, che gli mordano le reni, e nel tosire pare che sia una ferita in quel luoco, che lo tormenti; non pensa però molto al detto senso molesto, perché pocche volte lo travaglia. Non può stare coricato al presente nel latto sinistro che non senta dolore corrispondente alla vesica, e riferisce in questo modo anche si sentisse 12 anni sono quando fu travagliato come dissi nel modo istesso col quale hora si sente afflitto, e nella purga si liberò da quello incommodo. Ha l’hipocondrio sinistro, che al tatto non è tanto trattabile come il destro, e postavi sopra la mano si sente in quello il polso gagliardo dell’arteria. E’ più grasile del suo solito, sino al presente però caminava senza incommodo, andava in sedia, a cavalo con l’incomodo solo nelli reni, come s’è detto, batte il piede per terra senza alcuno incomodo alla vesi57. che. Nel ms. si legge “che che”. PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI / 45 ca, non ha febre, non patisse sette, né inapetenza, né vigilie, se non fossero gl’incomodi dell’urina, non ha respiro offeso, ha il corpo pocco obediente, vive al presente regolatamente. Ricercarebbe dalla virtù singolare del Signor Marcello rimedio a questi suoi mali et io ne ho fatta questa rozza descritione volontieri a lei, sì perché sono certo di dovere imparare molto mentre lei s’applicherà a questi mali, come anche perché con questa occasione dedicandomi tutto per suo spero nella sua bontà, che sia per accettarmi quale desidero sempre di essere Di Vostra Signoria Mio Signore Reggio li 28 novembre 1689 Humilissimo devotissimo et obbligatissimo servitore Prospero Marmiroli 46 / PAZIENTI E CURATORI NELLA PRATICA MEDICA DI MALPIGHI CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 47 CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI. IL DUELLO FILOSOFICO TRA L’ABBÉ NOLLET E GIANFRANCESCO PIVATI Paola Bertucci Introduzione Questo saggio analizza una controversia e la sua “doppia vita”: quella che emerge da documenti ufficiali, affidata alle pagine a stampa di libri e periodici, e quella non ufficiale, di cui si propone qui una ricostruzione basata in gran parte sull’esame di materiale manoscritto inedito. La controversia, che culminò nel 1749, aveva per oggetto i “tubi medicati”, un’invenzione che sembrava promettere guarigioni miracolose sfruttando la moda del secolo: l’elettricità. I protagonisti della vicenda furono apparentemente due, l’inventore dei tubi, Gianfrancesco Pivati, e la massima autorità nel campo dell’elettricità, Jean Antoine Nollet. A un esame più attento dei documenti, tuttavia, emergono molti altri personaggi il cui ruolo non può dirsi secondario. La ricostruzione di questa vicenda e il confronto tra i documenti a stampa e quelli inediti consente un’analisi di alcuni topoi della cultura scientifica nell’età dell’Illuminismo: il dibattito sulle norme per la certificazione dei risultati sperimentali, il ruolo della “diplomazia accademica” nell’arbitrare le controversie, lo status ambiguo della cultura della meraviglia e della curiosità nel Settecento.1 Gianfrancesco Pivati, l’editoria e la medicina elettrica La Repubblica delle lettere era l’essenza dell’Illuminismo. Per i cittadini e le cittadine di quella repubblica ideale, soprattutto se residenti 1. La relazione tra filosofia sperimentale e cultura della curiosità è il filo conduttore di una mia monografia sul viaggio di Nollet in Italia, P. Bertucci, Viaggio nel paese delle meraviglie. Scienza e curiosità nell’Italia del Settecento, Bollati Boringhieri, Torino, in corso di stampa. 48 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI lontano dai grandi centri, pubblicare era il mezzo più efficace di partecipare alla vita culturale. L’importanza della “sfera pubblica” e dei suoi risvolti economici era ben presente a uno dei protagonisti della nostra storia, Gianfrancesco Pivati.2 All’epoca della controversia, negli anni tra il 1746 e il 1749, Pivati lavorava come revisore per la Repubblica veneziana ed era anche Sovrintendente alle stampe, una posizione che venne reintrodotta nel 1730 dopo circa un secolo in cui era rimasta vacante. Grazie a questo ruolo, Pivati ebbe l’opportunità di tessere relazioni con importanti esponenti del mondo dell’editoria veneziana. Nella prima metà del secolo, grazie anche agli investimenti di un gruppo eterogeneo di “capitalisti” che finanziavano le tipografie e grazie alla domanda proveniente da un pubblico crescente, l’editoria veneziana si era rivelata un’impresa redditizia.3 Già nel 1725 i Riformatori dello Studio di Padova, un corpo di magistrati che emetteva leggi sia sull’università sia sul commercio librario, riconobbero che la stampa era “fra l’arti principali che accrescono splendore et utile alla Dominante”.4 Prima della reintroduzione della posizione del Sovrintendente, i Riformatori intervenivano in materie riguardanti l’editoria soltanto su richiesta. Il Sovrintendente, al contrario, era l’espressione del rinnovato interesse della Repubblica per il mondo della carta stampata: egli doveva ispezionare le tipografie, controllare che tutti i processi di stampa avvenissero nel rispetto delle leggi veneziane e farsi portavoce dei bisogni degli stampatori. Come Sovrintendente alle Stampe, Pivati ebbe modo di conoscere in profondità il mondo di tipografi, librai e stampatori così come le aspettative dei lettori. Diven2. Sul concetto di sfera pubblica si veda J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari, 2000 (1° ed. orig. 1962). Si vedano inoltre, R. Darnton, The business of Enlightenment. A publishing history of the Encyclopédie 1775-1800, Belknap-Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1979. Per un’analisi recente del rapporto tra centro e periferia nella Repubblica delle lettere si vedano l’introduzione e i saggi di P. Findlen, L. Roberts, L. Koerner, W. Clark, in W. Clark, J. Golinski, S. Schaffer (eds.), The sciences in enlightened Europe, Chicago University Press, Chicago, 1999. 3. Sull’editoria veneziana, M. Infelise, L’editoria veneziana nel ‘700, Angeli, Milano, 1991; M. Berengo (a cura di), Giornali veneziani del Settecento, Feltrinelli, Milano, 1962; Id., La società veneta alla fine del Settecento: ricerche storiche Sansoni, Firenze, 1956; B. Dooley, Science, politics and society in eighteenth-century Italy. The Giornale de’ letterati and its world, Garland, New York, 1991. Per i rapporti tra editoria e diffusione del sapere scientifico, P. Govoni, Un pubblico per la scienza. La divulgazione scientifica nell’Italia in formazione, Carocci, Roma, 2002. 4. Archivio di Stato, Venezia, Riformatori, f. 10, cc. 157-63, citato in Infelise, L’editoria veneziana nel ‘700, cit. , p. 41. Sui tentativi di riforma nella Repubblica di Venezia, si veda B. Dooley, “Il patriziato veneziano e l’attività accademica”, in G. Araldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), Storia della cultura veneta, Il Settecento, v. 5/I, Neri Pozzi, Vicenza, 1985. CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 49 ne quindi presto consapevole della crescente popolarità dei dizionari che, a metà Settecento, erano molto richiesti da un pubblico desideroso di sfoggiare qualche costoso volume nella biblioteca di casa e di poter appagare la propria curiosità su argomenti disparati, dalla storia sacra e profana all’“arte di pettinarsi”.5 Il Senato veneziano conferiva privilegi per proteggere i tipografi che si avventuravano nella pubblicazione di opere costose.6 Nel 1744 lo stampatore veneziano Stefano Monti, stimolato da un gruppo di investitori, decise di commissionare la compilazione di un dizionario sul commercio basato sulla traduzione di quelli di Jacques Savary e Noël Chomel.7 La scelta di Monti ricadde su Pivati che poteva contare sulla collaborazione di autorevoli eruditi – tra cui Ludovico Muratori – e su un certo numero di traduttori. Ma l’impresa congiunta di stampatori e investitori non ebbe successo: il progetto si arenò l’anno successivo con la pubblicazione del terzo volume. Pivati, in ogni caso, si rese conto che l’insuccesso collettivo poteva trasformarsi in un vantaggio personale. Poiché Monti non intendeva proseguire il lavoro, persuase un altro stampatore veneziano, Gasparo Baseggio, ad affidargli la compilazione di un nuovo dizionario che avrebbe messo insieme la storia sacra con le nuove scoperte scientifiche fatte nelle più importanti accademie europee.8 L’interesse di Pivati per la filosofia sperimentale non era una novità. Nel 1738 aveva presentato ai Riformatori dello Studio di Padova le sue Riflessioni sopra lo stato presente dello Studio di Padova, un programma di riorganizzazione del sistema universitario che testimoniava il suo coinvolgimento nei tentativi di rinnovamento della cultura veneta.9 Convinto che la filosofia sperimentale fosse la disciplina “più utile e la più necessaria da istituirsi”,10 Pivati proponeva una riduzione del numero 5. R. Yeo, Encyclopaedic visions: Scientific dictionaries and Enlightenment culture, Cambridge University Press, Cambridge, 2001. 6. Infelise, L’editoria veneziana nel ‘700, cit., p. 51. 7. J. Savary, Dictionnaire universel de commerce Paris, 1723; N. Chomel, Dictionnaire Oeconomique Lyon, 1709. 8. L’editore ufficiale del dizionario di Pivati era Sebastiano Milocco. Sulle vicissitudini del dizionario e su Pivati poligrafo, si vedano M. Infelise, “Enciclopedie e pubblico a Venezia a metà Settecento: G. F. Pivati e i suoi dizionari”, Studi Settecenteschi, 16, 1996, pp. 161-190 e S. Garofalo, L’enciclopedismo italiano: Gianfrancesco Pivati, Longo, Ravenna, 1980. 9. G. Pivati, Della Elettricità Medica Lettera a Celebre Signore Francesco Maria Zanotti, Lucca, 1747, p. xi. 10. P. Dal Negro, “L’Università”, in Araldi, Pastore Stocchi (a cura di), Storia della cultura veneta, Il Settecento, cit., pp. 64-5. 50 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI delle cattedre esistenti, in modo da aumentare in proporzione gli insegnamenti scientifici. Ciò nonostante, il suo ambizioso progetto di un Nuovo Dizionario Scientifico e Curioso Sacro-Profano non mancò di suscitare il sarcasmo di Pietro Ercole Gherardi, segretario del duca di Modena a Venezia.11 Gherardi, che aveva rifiutato di essere coinvolto nel progetto originario di Monti, confessò a Muratori: Questi [Pivati], a quel che mi vien detto, prenderà dal Furetière, dal Martinière, dal Savary, dal Chomel, dal Moreri ora una notizia ed ora un’altra, e con molti pezzi degli scrittori suddetti cuciti insieme, farà l’abito suo di Trufaldino, ovvero volterà nella padella la frittata.12 Il duro giudizio su Pivati non era evidentemente condiviso dalla commissione speciale dell’Università di Padova – di cui erano membri sia l’anatomista Giambattista Morgagni sia il professore di filosofia sperimentale Giovanni Poleni – che difese l’originalità del dizionario dall’accusa di plagio rivoltagli da Monti.13 Durante i cinque anni in cui lavorò al dizionario, Pivati consolidò relazioni con il mondo dell’aristocrazia veneziana e con medici, avvocati, esponenti del clero e del mondo accademico, che divennero sottoscrittori dell’opera. Ma per non incorrere nei rischi di cui era consapevole, prima di portare a termine il lavoro decise di cercare il sostegno e la protezione di istituzioni scientifiche oltre i confini della Serenissima, in particolare presso l’Istituto delle Scienze di Bologna. I contatti tra l’Istituto e Pivati iniziarono il 13 agosto 1746 con l’invio al segretario, Francesco Maria Zanotti, di due copie del primo volume del dizionario, una per lo stesso Zanotti, l’altra per la biblioteca dell’Istituto. Nella lettera che accompagnava i volumi Pivati faceva riferimento alle sue relazioni con Morgagni e Poleni e pregava Zanotti di tenerlo aggiornato sulle attività sperimentali dei membri dell’Istituto, per poterne poi scrivere nella sua opera.14 Regalo e lettera ottennero l’effetto sperato e Pivati fu eletto membro dell’Istituto pochi mesi più tardi, il primo dicembre 1746. 11. G. Pivati, Nuovo Dizionario Scientifico e Curioso Sacro-Profano, Venezia, 1746-1751. 12. Gherardi a Muratori (23 Ottobre 1745), in Edizione nazionale del carteggio di L. A. Muratori, v. 20, G. Pugliese (a cura di), Carteggio con Pietro E. Gherardi, Olschki, Firenze, 1982, p. 277. 13. Infelise, L’editoria veneziana nel ‘700, cit., pp. 58-9. 14. Archivio dell’Accademia delle Scienze di Bologna (AASB), “Antica Accademia”, Tit. III, Lettere Ricevute: Pivati a Zanotti, 13 Agosto 1746. CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 51 I tubi medicati Fu mentre lavorava al dizionario che Pivati ebbe l’idea dei tubi medicati. Come nel caso di altri eruditi del tempo, anch’egli si dilettava di elettricità.15 La corrispondenza dei letterati testimonia la diffusa curiosità verso gli esperimenti elettrici negli stati a sud delle Alpi: le serate elettriche offrivano situazioni spesso esilaranti e costituivano divertenti occasioni di socialità: fatto il buio in sala, i gentiluomini e le gentildonne elettrizzati cominciavano a “scintillare dalla faccia, naso, lingua, braccia, mani e gambe”, accendevano “col dito la candela ammorzata [e] l’acquavita”, facevano “lampeggiare la spada nuda e dalla sua punta farne uscire la fiamma”, “attraere e ripulsare [sic] le foglie d’oro a foggia di vaga fontana”, “elettrizzar l’acqua e il fuoco, e la terra da fiori”.16 I nuovi esperimenti elettrici, provenienti soprattutto dalla Germania, venivano ripetuti e discussi nella Penisola. Verso la fine del 1746 Gherardi raccontò di aver provato il “fenomeno del polso”, l’esperimento concepito dal professore tedesco Georg Matthias Bose che sembrava indicare che l’elettrizzazione producesse effetti fisiologici misurabili: collegato ad una macchina elettrica, Gherardi registrò un aumento della pulsazione da 65 a 76 battiti al minuto.17 Pivati conosceva il repertorio degli esperimenti elettrici più famosi e aveva letto le numerose pubblicazioni che erano apparse in Europa negli anni precedenti, come dimostra la ricca voce “elettricità” nel suo dizionario.18 Ma soprattutto sapeva che all’Università di Padova Poleni e Morgagni stavano lavorando “per vedere se così belle scoperte ridurre si possano di nuovo vantaggio o alla pirotecnia, o a quello ch’è più da sperarsi, alla Medicina”.19 Passare dal “mirabile, cioè quello che può bastare alla curiosità” agli effetti terapeutici del “fuoco elettrico” lo avrebbe quindi posto tra i 15. Pivati, Lettera, cit., p. xiv. Sull’elettricità nel XVIII secolo, si vedano G. Pancaldi, Volta. Science and culture in the age of Enlightenment, Princeton University Press, Princeton, 2003; M. Piccolino, M. Bresadola, Rane, Torpedini e scintille. Galvani, Volta, e l’elettricità animale, Bollati Boringhieri, Torino, 2003; P. Bertucci, “Sparking Controversy. Jean Antoine Nollet and medical electricity south of the Alps”, in Nuncius, 20, 2005, pp. 153-87. Per una storia generale dell’elettricità rimando al classico, J. L. Heilbron, Electricity in the 17th and 18th century. A study of early modern physics, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1979 (nuova ed. Dover, New York, 1999). 16. Gherardi a Muratori, 24 Dicembre 1746, in Carteggio Muratori-Gherardi cit., p. 348. 17. Ibid., p. 349. 18. Pivati, Nuovo Dizionario cit., pp. 499-503. 19. Ibid., p. 503. 52 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI pionieri della più promettente applicazione della nuova scienza: la medicina elettrica.20 Tra il 1746 e il 1747, Pivati si impegnò in un’attività sperimentale sistematica, che consisteva nell’estrarre scintille da corpi diversi, provenienti dal mondo minerale e vegetale e suggerì che il colore delle scintille elettriche potesse variare a seconda della sostanza da cui venivano estratte: Osservai, per esempio, che elettrizzando un vaso di fiori, al toccare il vaso stesso, la terra, le foglie, i fiori, tutto tramanda luce e cagiona sensazione differente, secondo che la pianta abbonda più di sali, di zolfo, di olio &c.21 Lo studio dell’elettricità poteva essere utile, dunque, per l’analisi chimica dei materiali. Il richiamo alla chimica non poteva non attirare l’attenzione dei membri dell’Istituto delle Scienze di Bologna, il cui interesse per questa disciplina risaliva alla fondazione dell’Istituto nel 1711. Il fondatore, Luigi Ferdinando Marsili, nel suo programma di un’istituzione che ricalcasse il modello della Royal Society e dell’Académie Royale des Sciences, aveva fatto notare che lo studio della “natura dei fluidi”, di pertinenza della chimica, non era “né praticata, né conosciuta” a Bologna. Osservava anche che l’aver trascurato questo argomento aveva reso la ricerca medica locale sterile, specialmente a confronto con la “gloriosa memoria” del medico bolognese Marcello Malpighi, il cui lavoro era stato l’ultimo ad eccitare l’“applauso delle nazioni straniere”.22 L’allarme di Marsili portò alla creazione di una cattedra di chimica presso l’Istituto (1714) e più di vent’anni più tardi, nel 1737, nell’istituzione della prima cattedra di chimica in una università a sud delle Alpi, assegnata a Iacopo Bartolomeo Beccari. Allievo di Giambattista Morgagni, Beccari ebbe un ruolo di primo piano nello stabilire i programmi e le attività sperimentali dell’Istituto. Oltre al suo lavoro sul glutine, che lo rese famoso a livello internazionale, Beccari faceva ricerca sulle proprietà chimico-fisiche dei fosfori e 20. Pivati, Lettera cit., p. xiv. Sulla medicina elettrica in Italia, Piccolino, Bresadola, Rane, torpedini e scintille, cit.; P. Bertucci, “The electrical body of knowledge: Medical electricity and experimental philosophy”, in P. Bertucci, G. Pancaldi (eds.), Electric bodies. Episodes in the history of medical electricity, Bologna Studies in the History of Science, 9, CIS, University of Bologna, Bologna, 2001, pp. 43-68. 21. Pivati, Lettera cit., p. xiv. 22. L. F. Marsili, Parallelo dello Stato Moderno della Università di Bologna con l‘altre al di là de‘ Monti (mss, 1709), pubblicato in A. Angelini (a cura di), L’Istituto delle Scienze e l‘Accademia, Anatomie Accademiche, v. 3, Il mulino, Bologna, 1987, pp. 463-521, a p. 468. Per i rapporti tra l’Istituto delle Scienze e l’Università di Bologna si veda anche M. Cavazza, Settecento Inquieto, Il mulino, Bologna, 1990. CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 53 sulla virtù elettrica. Il suo interesse per l’elettricità, di lunga data anche se poco sistematico, risaliva al 1703, quando aveva scritto una memoria sull’argomento. Non sorprende quindi che egli salutasse con favore il lavoro di Pivati.23 Secondo il racconto di Pivati, i tubi medicati nacquero nel corso di esperimenti sull’elettrizzazione delle piante. Mentre provocava l’emissione di un flusso continuo di scintille da un fiore e dirigendo la corrente scintillante verso una delle narici, Pivati aveva avvertito “un gentilissimo effluvio odoroso del fiore, unito ad un odore di nitro, [che] per qualche ora mi cagionò una specie di raffreddore, o per meglio dire di otturamento de’ vasi in quella parte del naso.”24 Questo risultato gli suggerì che gli effluvi elettrici potessero trascinare fuori dai corpi le sostanze odorose e che, similmente, essi potessero trasportare all’interno del corpo umano le proprietà curative di sostanze medicamentose. Così, Pivati riempì il solito tubo di vetro della macchina elettrica con medicine specifiche, convinto che esse potessero produrre gli effetti desiderati senza essere ingerite, ma assorbite dai pazienti attraverso la semplice respirazione: Mi sono lusingato di più, perché mi sono ideato un effetto sovente impossibile all’arte medica, ch’è quello d’introdurre nelle parti più interne del corpo umano un medicamento topico, il quale, o urtando disgombrar possa qualche impedimento ne’ canali, o scorrendo arrivi a consolidare, detergere, imbalsamare, o altro, qualche parte, a cui non è permesso all’arte di giungere per sola ingestione etc.25 Dopo aver letto dei tubi medicati, anche Giambattista Bianchi, protomedico, professore di anatomia presso l’Università di Torino e membro dell’Istituto delle Scienze dal 1722, si dedicò a sperimentazioni sulle cure elettriche, iniziando uno scambio epistolare con Pivati. Bianchi elaborò delle variazioni sul tema delle intonacature, specializzandosi nelle “purghe elettriche”: invece di mettere le sostanze medicamentose all’interno dei cilindri di vetro, chiedeva ai pazienti di reggere in mano i purganti mentre un operatore procedeva con l’elettrizzazione. In questo modo, secondo il medico torinese, il potere purgativo delle sostanze si diffondeva nell’aria insieme agli effluvi elettrici e al paziente sarebbe 23. Su Beccari, si veda M. Crespi, A. Gaudiano, “Beccari, Iacopo Bartolomeo” in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 7, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1965, pp. 432-435. Beccari fu eletto membro della Royal Society di Londra nel 1728. 24. Pivati, Lettera cit., p. xvi. 25. Ibid., p. xxv. 54 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI bastato respirare per beneficiare degli effetti sperati. “Piacemi grandemente quella maniera di purgarsi senza prendere per bocca medicamento alcuno, che suole spesso indurre spiacevoli sconcerti di stomaco, o d’intestino”, dichiarava Flaminio Scarselli a Laura Bassi.26 La notizia delle cure di Pivati e di Bianchi si diffuse per tutta la Penisola e numerosi elettrizzatori si impegnarono a ripetere gli esperimenti sia con tubi semplici sia con quelli medicati. La possibilità di un uso terapeutico dell’elettricità aveva modificato lo status della nuova scienza, elevandola da intrattenimento salottiero a ricerca di punta. Il ruolo dell’Istituto delle Scienze di Bologna Quando ricevette da Pivati la descrizione delle cure eseguite con i tubi medicati, il segretario dell’Istituto delle Scienze di Bologna non riuscì a contenere l’entusiasmo. Quale novità nelle nostre esperienze sull’elettricità! Che giustezza! Che successo! [...] Le abbiamo dimostrate in tal modo, che non ci sembra di azzardare, e quanto a me, credo che abbiamo superato tutti in fatto d’elettricità.27 La convinzione che sotto l’egida dell’Istituto si fosse realizzata una scoperta che avrebbe lasciato un segno nella storia dell’arte medica ebbe un effetto notevole sulla reazione di Zanotti agli esperimenti di Pivati. Nonostante fosse consapevole che la certificazione dell’affidabilità dei tubi medicati necessitava di ulteriori prove, Zanotti fece sì che la lettera di Pivati venisse pubblicata a Bologna, anche se con la falsa indicazione di Lucca.28 Secondo lo stampatore anonimo – sotto le cui mentite spoglie molto probabilmente si nascondeva lo stesso Zanotti – grazie ai tubi medicati l’ “Elettricità, quantunque sia stata già trattata da altri, tuttavia si può dir nuova, uscendo ora fuori con un pregio, che ella non aveva ancora avuto, e ciò è di recare un meraviglioso accrescimento alla Medicina, e porgere un pronto e facil rimedio a moltissimi incomodi della salute.” Per questo motivo si era trasformata in una “nuova scienza”, che richiedeva pubblicità immediata.29 26. Flaminio Scarselli a Laura Bassi (26 Febbraio 1749), in Lettere inedite alla celebre Laura Bassi, Cenerelli, Bologna, 1885, p. 119. 27. Bibliothèque Publique Universitaire, Genève, Collection Jallabert, Correspondance, SHAG 242, f. 186 (Zanotti a Jallabert, 1 luglio 1748). 28. Ibid., f. 186 bis. 29. Pivati, Lettera cit., p. vi. CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 55 I membri dell’Istituto videro nei tubi di Pivati l’opportunità di rilanciare la scienza italiana nel panorama internazionale, come espressamente dichiarato da Zanotti a Francesco Algarotti: “se i fatti son veri, il veneziano ha superato tutti cotesti vostri inglesi, francesi e tedeschi”.30 Sfruttando la rete di corrispondenti stranieri dell’Istituto, i membri si impegnarono a pubblicizzare i tubi medicati all’estero. Scrivendo a Nollet, Zanotti si vantò del successo del lavoro di Pivati, che “ha reso l’Italia elettrica”,31 mentre Beccari inviò un resoconto delle cure elettriche a René Réaumur il quale, all’inizio del 1748, lo lesse durante una seduta dell’ Académie des Sciences.32 Successivamente Zanotti scrisse anche a Jean Jallabert a Ginevra e comunicò all’Académie des Sciences l’avvenuta pubblicazione dell’Elettricità Medica di Pivati.33 Guidato dall’entusiasmo non meno che dall’ambizione, Zanotti censurò ogni opposizione ai tubi medicati. In quanto Segretario dell’Istituto delle Scienze, egli aveva un controllo assoluto dei De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituti atque Academiae Commentarii, essendo libero di scegliere le memorie da pubblicare e di scrivere i commentari che introducevano il volume.34 Zanotti esercitò in pieno questi poteri quando si trattò di ufficializzare la reazione dell’Istituto agli esperimenti di Pivati. Nel dicembre del 1747 Goffredo Bonzi, lettore di medicina, aveva presentato ai membri dell’Istituto delle Scienze un resoconto dei suoi tentativi di ripetere gli esperimenti con tubi di vetro inviati da Pivati da Venezia.35 Bonzi aveva contestato con fermezza le conclusioni di Pivati, 30. F. Algarotti, Opere, v. 12, Venezia, 1794, p. 259. M. Mazzotti, “Newton for Ladies: Gentility, gender and radical culture”, in British Journal for the History of Science, 37, 2004, pp. 119-146. 31. AASB,”Antica Accademia”, Minute scritte durante il segretariato Zanotti, MZ, Tit. III, n. 235: 2 Marzo 1749. 32. Archives de l’Académie des Sciences, Paris (AASP), Procès Verbaux, Tome 67 (1748), ff. 26-27. 33. Bibliothèque Publique Universitaire Genève, Collection Jallabert, Correspondance, SHAG 242, ff. 185-87 : Zanotti a Jallabert, 1 luglio 1748; Archives de l’Académie des Sciences Paris (AASP), Procès Verbaux, Tome 67 (Septembre 1748), f. 425. 34. Ufficialmente la selezione doveva essere fatta da una commissione apposita ma, di fatto, era il Segretario a decidere. AASB, Tit. IV, Lezioni e carte diverse, fasc. XI, Notizie e giudizi sulle dissertazioni. 35. La memoria di Bonzi, che non è sopravvissuta, era intitolata Sopra la medicatura elettrica e fu letta all’Accademia delle Scienze di Bologna il 7 dicembre 1747, come risulta da AASB, Registro Atti, pubblicato in Angelini (a cura di), Istituto delle Scienze, cit., p. 337. Riferimenti al contenuto della memoria si trovano nelle lettere di Zanotti a Morgagni, in G. Rocchi (a cura di), Carteggio tra Giambattista Morgagni e Francesco M. Zanotti, Bologna, 1875, pp. 349-51. 56 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI negando che l’elettrizzazione potesse far evaporare le sostanze odorose attraverso tubi di vetro sigillati e respingendo la possibilità che i tubi medicati potessero avere una qualsiasi efficacia terapeutica. Zanotti etichettò Bonzi come uno di coloro che “per una naturale inclinazione a disprezzare i nuovi intenti [...] non temono di spacciar per ridicole le esperienze del signor Pivati”, e nella prefazione non fece alcuna menzione delle sue prove, rifiutandosi di pubblicare la sua memoria.36 Esaltò invece le scoperte del padovano che “commossero l’Italia intera”.37 Convinto che “grande accrescimento avrebbe dato alla scienza de’ medici la curiosità di un fisico”, Zanotti coinvolse nella controversa questione Giuseppe Veratti. 38 Sposato alla più celebre Laura Bassi, Veratti era lettore di anatomia all’università e membro dell’Istituto delle Scienze.39 Nei mesi seguenti si impegnò in una serie di esperimenti, spesso condotti in presenza di Beccari e Zanotti, i cui risultati furono esposti in una nuova pubblicazione promossa dall’Istituto e dedicata al Senato bolognese: le Osservazioni fisico-mediche intorno alla elettricità, pubblicate a Bologna nel 1748. Dato l’incondizionato sostegno di Zanotti ai tubi medicati, non era facile per Veratti dar voce alle proprie perplessità. Si limitò quindi a sottolineare che per mancanza di tempo non era riuscito a ripetere gli esperimenti fino ad esserne completamente soddisfatto. Nonostante dichiarasse di essere stato “costretto a pubblicare queste poche osservazioni da me fatte intorno alla Elettricità” dai “replicati impulsi, ed autorevoli consigli di più persone sagge”, Veratti era ansioso quanto Zanotti di attribuirsi dei meriti nel campo della medicina elettrica.40 Flaminio Scarselli, segretario dell’ambasciatore bolognese presso la corte pontificia, aveva raccomandato a Laura Bassi di non aspettare troppo a pubblicare i risultati sperimentali, in quanto “la materia quanto è bella, altrettanto 36. Zanotti a Morgagni (12 dicembre 1747), ibid., p. 351 37. “De electricitate medica”, De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituti atque Academiae Commentarii (d’ora in poi Commentarii), 1755, III: 83-87, p. 85 38. Zanotti a Morgagni, 5 settembre 1747, in Rocchi (a cura di), Carteggio tra Giambattista Morgagni e Francesco M. Zanotti, cit., p. 343. 39. Sul matrimonio Bassi-Veratti, si vedano B. Ceranski, Und Sie fürchet sich vor niemanden. Über die Physikerin Laura Bassi (1711-1778), CampusVerlag, Frankfurt-New York, 1996, pp. 89-95; P. Findlen, “Science as a career in Enlightenment Italy. The strategies of Laura Bassi”, in Isis, 84, 1993, pp. 440-469; M. Cavazza, “Between modesty and spectacle: Women and science in eighteenth-century Italy”, in P. Findlen, C. M. Sama (eds.), Italy’s eighteenth century. Gender and culture in the age of Grand Tour, in corso di stampa. 40. G. Veratti, Osservazioni Fisico-Mediche intorno all’Elettricità dedicate all’Illustrissimo, ed eccelso Senato di Bologna, Bologna, 1748, p. i. CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 57 lusinga la curiosità, e la diligenza de’ Filosofi, e de’ Medici, onde il ritardo porta pericolo di essere prevenuto”.41 Il libro di Veratti fu promosso dall’Istituto in Italia e all’estero e fu tradotto in francese nel 1750. Facendo proprio il sostegno dell’Istituto alla medicina elettrica, anche Laura Bassi si impegnò in un’intensa promozione del libro del marito, inviando diverse copie a Scarselli perché le distribuisse a cardinali, altri filosofi e librai nell’Italia meridionale e, soprattutto, al Papa.42 In Italia, tuttavia, le cure elettriche non riscuotevano unanime consenso. Scipione Maffei, l’erudito veronese che si dilettava di elettricità e possedeva una costosa macchina elettrica, scrisse a Zanotti che a Venezia le “storie di Pivati” venivano “credute o false, o grandemente esagerate”.43 Perfino le più celebri cure professate da Pivati non avevano superato l’esame attento dei colleghi. Mi vien detto che, incontrato casualmente a Venezia il vescovo Donadoni di Sebenico da un suo conoscente, non con altro se non che con un sorriso accompagnato da qualche crollamento di capo rispose a chi si congratulava di vederlo oramai libero della lunga podagra e chiragra patita.44 Quando Maffei si recò da Pivati per vedere i famosi esperimenti, trovò che “la sua macchina è così imperfetta, che con essa nulla, né pur di triviale poté egli farmi vedere in tutta una mattina.”45 Nel mondo degli eruditi e dei dotti la reputazione di Pivati come elettrizzatore andava insieme a quella di poligrafo: Se lo traslatamento del Dizionario scientifico riesce uno spiacevole guazzabuglio, si scopriranno per avventura, per imposture e visioni di fantasia pregiudicata, i racconti delle guarigioni decantate nelle consapute due letteruzze Pivati e Griselini intorno l’elettricità medica.46 41. Scarselli a Bassi (30 novembre 1748), in Lettere inedite alla celebre Laura Bassi, cit., p. 115. 42. Findlen, “Science as a Career”, cit. Sul laboratorio di Laura Bassi e Giuseppe Veratti, M. Cavazza, “Laura Bassi e il suo Gabinetto di Fisica Sperimentale: realtà e mito”, in Nuncius, 10, 1995, pp. 715-753. 43. Maffei a Zanotti, 14 febbraio 1749, in S. Maffei, Epistolario: 1700-1755, v. 2, Giuffré, Milano, 1955, p. 1239. Sulla cultura scientifica di Maffei e il suo entourage culturale, I. Dal Prete, Scienza e società nella terraferma veneta. Il caso veronese, in corso di stampa. 44. Gherardi a Muratori, 18 novembre 17, in Carteggio Muratori-Gherardi cit., p. 405. 45. Maffei a Zanotti (14 febbraio 1749), in Maffei, Epistolario, cit., p. 1239. 46. Gherardi a Muratori (18 novembre 1747), in Carteggio Muratori-Gherardi, cit., p. 405. La macchina elettrica di Maffei è menzionata in una lettera del 16 aprile 1747 a Giovanni Poleni: Maffei, Epistolario, cit., p. 1178. 58 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI Scrivendo nel 1747 a Muratori, Gherardi citò gli esperimenti di Bonzi con i tubi inviati da Venezia, spiegando che a Bologna “gli elettrici tubi intonacati spediti all’accademia bolognese han fatto l’effetto che ai defunti produce l’incenso”.47 Evidentemente non era ancora a conoscenza dell’operazione di censura che Zanotti avrebbe operato su Bonzi. Nel frattempo le fortune di Pivati crescevano. Nei vari stati italiani era considerato colui che aveva concepito per primo l’idea di applicare l’elettricità all’arte medica e all’inizio del 1749 il Senato veneziano gli conferì un privilegio per le sue Riflessioni fisiche sulla medicina elettrica, un lavoro ambizioso che celebrava la sua priorità nell’invenzione della “medicina elettrica”. Nonostante lo scetticismo di Maffei, di Gherardi, di Bonzi e, come vedremo, anche di Nollet e di altri elettrizzatori europei, Pivati trovava un altro sostenitore nel professore di fisica sperimentale Johann Heinrich Winkler che, di fronte ad un pubblico di oltre quattrocento persone, tra i quali si trovavano rappresentanti del governo, comunicò di essere riuscito a ripetere a Lipsia gli esperimenti con i tubi medicati.48 Nollet e le cure dei paralitici Se negli stati italiani il resoconto di Winkler consolidò l’immagine di Pivati come “inventore” della medicina elettrica, a Parigi suscitò invece reazioni piccate: “Se [Winkler] non ha intenzione di ingannare gli altri, credo che non se n’abbia troppo a male di ingannare se stesso”.49 Un mese prima del suo viaggio in Italia, Nollet scrisse a Jallabert senza far mistero di ciò che pensava dei tubi medicati e della trasmissione degli odori per mezzo dell’elettricità.50 La sua irritata impazienza risultava dalle numerose controversie nelle quali era stato coinvolto a partire dal 1746, quando gli esperimenti di Petrus Musschenbroek con la bottiglia di Leida divennero l’elettrizzante novità del tempo. Nollet fu 47. Gherardi a Muratori (18 novembre 1747), in Pugliese, Carteggio Muratori-Gherardi, cit., p. 405. 48. “An account of Professor Winkler’s experiments relating to odours passing through electrised globes and tubes”, in Philosophical Transactions of the Royal Society, 47, 1751, pp. 231-241. 49. Nollet a Jallabert (22 marzo 1749), in I. Benguigui, Théories électriques du XVIIIe siècle. Correspondance entre l’abbé Nollet (1700-1770) et le physicien genevois Jean Jallabert (17121768), Georg, Genève, 1984 (in seguito Correspondance Nollet-Jallabert), p. 173. 50. Nollet a Jallabert (gennaio 1749), in ibid., pp. 166-69. CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 59 tra i primi ad eseguire esperimenti sugli effetti degli shock elettrici su arti paralizzati. I risultati degli esperimenti condotti su un gruppo di paralitici, tuttavia, gli apparvero “ troppo incerti per meritare che li si annunci”: mentre i pazienti avvertivano qualche dolore e, nel corso delle notti successive, anche un po’ di prurito nelle parti sottoposte ad elettrizzazione, la varietà delle loro risposte non consentiva di ritenere conclusive le prove condotte. 51 Sebbene inizialmente la reazione di Nollet alle applicazioni mediche dell’elettricità fosse tutt’altro che entusiastica, i suoi esperimenti sui paralitici suscitarono la dura reazione di Antoine Louis, un chirurgo parigino. Louis vantava una certa autorevolezza in materia: nel 1747 era stato ammesso all’Académie Royale de Chirurgie proprio grazie a un lavoro sulle paralisi.52 Nelle sue Osservazioni sull’elettricità, pubblicate a Parigi nel 1747, Louis rese pubblici i risultati degli esperimenti che aveva condotto, sostenendo che l’elettrizzazione aveva pericolosi effetti secondari e che coloro che si divertivano a usare il proprio corpo negli esperimenti elettrici si esponevano a gravi rischi. Ma le obiezioni di Louis non scoraggiarono Nollet. In risposta a quell’attacco, l’abbé comunicò ai membri dell’Académie des Sciences la guarigione di un paralitico operata da Jallabert a Ginevra.53 Consapevole del fatto che il clamore sollevato dalle cure elettriche, nonostante le – o forse grazie alle – controversie, aveva aumentato l’interesse del pubblico nei confronti dell’elettricità, Nollet scriveva a Jallabert, con malcelata soddisfazione: “è per voi che l’elettricità ha cominciato a vendersi davvero velocemente.” 54 Preoccupazioni economiche e desiderio di riconoscimento sociale erano caratteristiche tipiche dell’impresa filosofica di Nollet. La sua autorevolezza nel campo della filosofia sperimentale era cresciuta grazie al suo lavoro di costruttore e inventore di strumenti, non meno che alla sua abilità di comunicatore della filosofia naturale al pubblico dei non esperti, oltre che alla protezione del suo maestro Réaumur. I costosi gabinetti di fisica prodotti dal suo atelier erano acquistati da istituzioni accademiche o da ricchi contemporanei come Voltaire che, spendendo la ragguardevole somma di 10.000 livres per un gabinetto com51. J. A . Nollet, “Observations sur quelques nouveaux phénomènes d’Electricité”, in Mémoires de l’Académie des Sciences de Paris pour l’année 1746, 1751, p. 19. 52. A. Louis, Observations sur l’électricité, Paris, 1747, p. xx. 53. AASP, Procès Verbaux, Tome 67 (1748), ff. 43-44 (3 febbraio 1748). 54. Nollet a Jallabert (17 marzo 1748), in Correspondance Nollet-Jallabert, cit., p.161. 60 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI pleto, aveva confessato a un corrispondente: “l’Abbé Nollet mi rovina”.55 Il fascino che la nuova scienza esercitava sulle classi elevate aveva creato una crescente richiesta di dimostrazioni sperimentali che Nollet sapeva abilmente soddisfare. Nel 1744 anche il re lo aveva invitato a risiedere a Versailles per dare lezioni di fisica al Delfino di Francia tre volte la settimana. I suoi esperimenti e i suoi strumenti deliziarono anche la famiglia reale e gli altri residenti a corte: La regina e le principesse hanno visto i miei esperimenti con piacere e molte volte, tutto questo bisogno mi è valso una bella scatola d’oro, qualche libro [...] 4000 # di gratificazione e una pensione annuale di 1000 # sulla cassa del Signor Delfino.56 Ma già nel 1739, poco dopo la nomina di adjoint méchanicien per l’Académie des Sciences, il re di Sardegna aveva invitato Nollet a Torino, affidandogli il compito di dare lezioni di fisica al primogenito, il duca di Savoia. Nollet si era fermato nella capitale piemontese per sei mesi durante i quali ebbe modo di tessere utili relazioni con i professori dell’università locale. Questi gli commissionarono un intero gabinetto di fisica, che fu pagato dal re. Dieci anni dopo, quando tornò in Italia, l’abbé fu soddisfatto di trovare il gabinetto ancora in buono stato.57 Alla fine del 1746, dunque, assolti gli obblighi didattici a corte, Nollet decise di affidare il laboratorio per la costruzione degli strumenti a un suo cugino e si dedicò ad un programma di riordino degli esperimenti elettrici.58 La sua prima pubblicazione sull’argomento, l’Essai sur l’électricité des corps, pubblicato a Parigi nel 1746, proponeva la prima teoria sistematica sulle cause dei fenomeni elettrici.59 Presentando questa teoria a un 55. Citato in J. F. Gauvin, “An Eighteenth-Century Entrepreneur”, in Bulletin of the Scientific Instrument Society, 57, 1998, p. 23. Su Nollet, si veda L. Pyenson, J.-F. Gauvin (eds.), The Art of Teaching Physics. The eighteenth-century demonstration apparatus of Jean Antoine Nollet, Les éditions du Septentrion, Sillery, Quebec, 2002. 56. Nollet a Jallabert (giugno 1744), in Correspondance Nollet-Jallabert cit., pp. 115-117. 57. Bibliothèque Municipale de Soisson, Soisson. J. A. Nollet, Journal du Voyage de Piedmont et d‘Italie, mss. 150, f. 11 (14 maggio 1749). 58. Nollet a Jallabert (4 dicembre 1746), in Correspondance Nollet-Jallabert cit., p. 145 e p. 147. 59. Sulla teoria elettrica di Nollet, Heilbron, Electricity in the 17th and 18th century, cit., pp. 280-289. Sulla carriera di Nollet da artigiano a savant, si vedano A. Turner, “Sciences, arts and improvement. Jan Antoine Nollet, from Craftsman to Savant ”, in Pyenson, Gauvin (eds.), The art of teaching physics, cit., pp. 29-47 e J. F. Gauvin, “Eighteenth-century entrepreneur. Excerpts from the correspondence between Jean Antoine Nollet, EtienneFrançois Dutour, and Jean Jallabert, 1739-1768”, ibid., pp. 47-69. CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 61 pubblico di curiosi non esperti, Nollet mise a frutto il prestigio di cui godeva presso le classi più elevate. Gli spettatori aristocratici delle sue dimostrazioni pubbliche fungevano da giudici nel “tribunale in cui non sarò mai condannato se si va alla maggioranza dei voti; ciò che sostengo qui, l’ho fatto vedere nelle mie lezioni pubbliche a più di seicento testimoni”.60 Nel frattempo, tuttavia, elettrizzatori con poca esperienza continuavano a proporre nuove teorie sull’elettricità, rendendo pubblici esperimenti e presunte scoperte attraverso la stampa popolare. Nollet era piuttosto preoccupato dalla perdita di credibilità che il proliferare di questi elettrizzatori stava provocando: “troppo fertile di meraviglie” se trattata da non-esperti, l’elettricità stava generando “un certo disprezzo per la fisica” che andava assolutamente contrastato.61 Con l’intenzione di contenere la moltiplicazione di teorie non controllate sulla natura della materia elettrica, nel 1748 Nollet propose ai membri dell’Académie des Sciences la costituzione di una commissione speciale che si sarebbe incaricata di una “revisione generale” di tutti gli esperimenti elettrici. Il progetto, che prevedeva l’esecuzione di tutti gli esperimenti a casa di Nollet e l’impiego dei suoi strumenti, fu accettato dall’istituzione francese e Nollet fu incluso tra i membri della commissione.62 La medicina elettrica rientrava nel programma di riordino proposto da Nollet. Richiedendo insieme abilità sperimentali e competenze in campo medico, essa identificava un’area di intersezione tra fisica e medicina che, tuttavia, veniva spesso ignorata sia da medici sia da fisici di riconosciuta autorevolezza, mentre era altrettanto spesso frequentata da elettrizzatori improvvisati.63 Nollet aveva intenzione di vagliare le controverse virtù curative dell’elettricità con i metodi della filosofia sperimentale. All’inizio del 1748, quando ricevette il resoconto di Jallabert sulla cura del paralitico di Ginevra, Nollet ottenne l’autorizzazione del ministro della guerra, il conte d’Argenson, a riprendere i test sugli effetti del60. J. A. Nollet, Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques, Paris 1749, p. 14. 61. Ibid., p. 342. 62. AASP, Procès Verbaux, Tome 67 (1748), ff. 486-487. Sull’Académie des Sciences e il suo ruolo nel formare l’immagine degli intellettuali francesi, si veda R. Hahn, The anatomy of a scientific institution: The Paris Academy of Sciences, 1666-1803, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1971. 63. Bertucci, “The electrical body of knowledge”, cit. 62 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI l’elettricità nell’Hôpital des Invalides. Grazie all’intercessione del ministro, l’abbé iniziò una collaborazione con il medico Munier e con il capo chirurgo Bouquot al fine di studiare gli effetti dell’elettricità su tre paralitici. Una delle stanze dell’ospedale fu allestita per eseguire gli esperimenti. Seguendo le indicazioni di Jallabert, Nollet e i suoi collaboratori sistemarono i tre pazienti su sostegni isolanti e li collegarono alla macchina elettrica.64 Per due ore al mattino e altrettante il pomeriggio, gli operatori fecero scoccare scintille dagli arti paralizzati. Dopo cinquanta giorni di queste prove, Nollet, Morand e Bouquot dovettero concludere che gli effetti dell’elettrizzazione erano temporanei e che i movimenti che essa induceva negli arti paralizzati erano sempre e soltanto involontari.65 Gli esperimenti condotti sui paralitici offrirono a Nollet l’opportunità di presentarsi al pubblico come arbitro esperto e affidabile nei casi di controversie relative alla medicina elettrica. A tre settimane dall’inizio delle prove, quando il ministro della guerra e un “grande numero di gente di distinzione” si erano raccolti per assistere agli esperimenti medico-elettrici, egli aveva espresso la speranza di vedere risultati più incoraggianti, dal momento che le prove eseguite non lasciavano dubbi quanto alla provvisorietà degli effetti dell’elettrizzazione. Ciò nondimeno, a garanzia di imparzialità la dimostrazione pubblica cominciò con la lettura del resoconto di Jallabert sulla cura del paralitico di Ginevra.66 Contrattazioni filosofiche Come inviato della corte francese e rappresentante dell’autorevole Académie des Sciences, Nollet interagì attivamente con la comunità intellettuale della Penisola, sia in contesto accademico sia in ambito salottiero.67 Mostrandosi desideroso di eseguire i controversi esperimenti insieme ai suoi rivali, l’abbé si era costruito una fama di studioso 64. Nollet a Jallabert (17 marzo 1748), in Correspondance Nollet-Jallabert, cit., pp. 160-163. 65. Morand & Nollet, “Expériences de l’Electricité appliqué a des Paralitiques”, Mémoires de l’Académie des Sciences de Paris pour l’année 1749, 1753, pp. 29-38. 66. Nollet a Jallabert (1 maggio 1748), in Correspondence Nollet-Jallabert, cit., p. 165. 67. Su questi aspetti del viaggio di Nollet, si veda P. Bertucci, “Back from Wonderland: Jean Antoine Nollet’s Italian Tour”, in R. Evans, A. Marr (eds.), Curiosity and Wonder from the Renaissance to the Enlightenment, Ashgate, Aldeshot, 2006, pp. 193-211. CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 63 imparziale e capace di rendere i suoi giudizi accettabili anche dagli avversari: il duello filosofico sarebbe stato vinto dalla “verità”, non da una delle due parti che si erano sfidate. D’altra parte, la strategia del duello filosofico era familiare a Nollet. Nelle sue Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques pubblicata a Parigi nel 1749, pochi mesi prima di intraprendere il viaggio in Italia, l’abbé aveva messo in scena quattro “duelli filosofici” con altrettanti autori che avevano criticato il suo lavoro. Lo stile bellicoso delle Recherches era piaciuto al recensore del Journal des Trévoux, che ne aveva lodato i “sentimenti che dovrebbero essere presi come esempi per tutte le dispute letterarie”: Ci si può armare per la verità, si può lottare fino ad un certo punto; ma dopo la battaglia, ci si deve comportare come i nostri guerrieri durante l’armistizio: essi si guardano, si mettono in guardia, si stimano, si dicono reciprocamente: adesso prendete posto alla tavola degli alleati (Eneide, VIII, 174) 68 L’immagine del filosofo interessato esclusivamente al trionfo della verità da imporre con le armi della ragione, fu ampiamente utilizzata da Nollet durante il suo viaggio. In un primo momento, sia i sostenitori sia i rivali dei tubi medicati lo riconobbero come arbitro autorevole. Fallita la “testimonianza virtuale”,69 gli esperimenti di Pivati avevano bisogno dell’approvazione di un personaggio prestigioso come Nollet per guadagnarsi credito di là delle Alpi. Gli elettrizzatori italiani erano consapevoli delle opportunità che la sua visita avrebbe potuto fornire in termini di reputazione a livello internazionale: [Bianchi] vuole che ci mettiamo sulla parata, perché convinto sia (come pare da quello che ha veduto dal Sig. Bianchi cominci a persuadersi) questo distintissimo fisico, verrà con noi tutta la Francia, e l’Inghilterra.70 Nollet dal canto suo era interessato a guadagnarsi i favori della comunità colta a sud delle Alpi per allargare i confini delle sue attività e del suo prestigio: il viaggio attraverso le capitali italiane della cultura 68. [anon.], “Article XLIII. Essai sur l’Electricité des Corps, par M. l’Abbé Nollet”, Journal des Trévoux, 1751, II: 864-875, p. 874-875, originale latino nel testo. 69. Sul concetto di “testimonianza virtuale”, si veda S. Shapin, S. Schaffer, Leviathan and the air-pump. Hobbes, Boyle and the experimental life, Princeton University Press, Princeton, 1989, cap. 2. 70. Biblioteca Comunale Archiginnasio, Bologna, Collezione. Autografi, Pivati a Veratti (luglio 1749), f. 15001. 64 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI gli offriva l’opportunità di stabilire relazioni importanti con cultori e professionisti della filosofia sperimentale. Al fine di presentarsi come arbitro imparziale e per mantenere la credibilità che persino i suoi avversari gli accordavano, mostrava dunque di non avere alcun pregiudizio nei confronti dei “prodigi” italiani, nascondendo ciò che aveva rivelato invece a Jallabert prima della partenza: “noi siamo inclini a credere che i fatti d’Italia siano per lo meno esagerati”.71 Prima di lasciare Parigi, gli elettrizzatori italiani con cui Nollet era in corrispondenza lo avevano informato dei loro vani tentativi di far passare gli odori attraverso tubi di vetro sigillati.72 Giambattista Bianchi, però, gli aveva inviato un giornale con numerose descrizioni di cure e purghe elettriche eseguite seguendo le indicazioni di Pivati e gli aveva descritto gli esperimenti che Veratti stava eseguendo a Bologna.73 Nollet si rese così conto che Pivati non era un dilettante isolato. Un anno prima del suo viaggio, Nollet si era rivolto a Jallabert per risolvere un’importante lacuna rispetto a Bianchi, Pivati e Veratti: “non sono membro dell’Istituto di Bologna e non potete dubitare del fatto che sarei molto onorato di esserlo”,74 aveva scritto al professore ginevrino nel maggio del 1748. L’invito a sostenere la candidatura fu raccolto da Jallabert, che era membro dell’Istituto e che raccomandò l’abbé a Zanotti: Nollet fu eletto pochi mesi più tardi. Le manovre dell’abbé non erano dettate soltanto da ambizione personale, ma anche dall’interesse dell’Académie des Sciences ad allargare la rete di corrispondenti stranieri e il pubblico per i Mémoires. Durante i nove mesi che trascorse negli stati italiani, Nollet agì come un abile mercante dei prodotti culturali dell’Académie: trovò sette nuovi corrispondenti stranieri e riuscì a fare adottare i Mémoires da diverse istituzioni scientifiche italiane.75 Arrivato a Bologna, Nollet si guardò bene dal dare l’impressione di voler giudicare le attività di ricerca dell’Istituto. Se nel resoconto a stampa dichiarava: “uno dei più forti [motivi che mi fecero intraprendere il viaggio in Italia] fu il desiderio di veder accadere, nelle mani di coloro che avevano detto di esserci riusciti, questi fenomeni elettrici”,76 nella 71. 72. 73. 74. 75. 76. Nollet a Jallabert (22 marzo 1749), in Correspondance Nollet-Jallabert, cit., p. 174. AASP, Procès Verbaux, Tome 67 (1748), ff. 18-26. Ibid., ff. 15-18. Nollet a Jallabert, 1 maggio 1748, in Correspondence Nollet-Jallabert, cit., p. 165. Bertucci, “Back from Wonderland”, cit. Nollet, “Extract”, cit., p. 374 CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 65 corrispondenza privata con Zanotti sosteneva invece: “l’elettricità, ve lo garantisco, è l’ultimo dei motivi che mi hanno portato a Bologna”.77 Per parte loro, i membri dell’Istituto, e specialmente Zanotti, ricevettero l’abbé come il rappresentante di un’importante istituzione straniera e come un prestigioso membro straniero dell’Istituto. Il vice-legato fece in modo che Nollet avesse una carrozza e un lacchè per tutto il tempo del suo soggiorno, mentre Laura Bassi e Giuseppe Veratti lo invitarono nella loro casa per discutere di filosofia sperimentale e dei tubi medicati. Contrariamente a quanto era accaduto a Venezia, la visita di Nollet a Bologna non assunse le caratteristiche di un duello filosofico. Invece di gettare il guanto e mettere in scena il suo disaccordo, Nollet durante gli incontri con Bassi e Veratti si presentò come un modello di buone maniere. Il suo savoir faire gli valse le simpatie dei coniugi bolognesi che lodarono la sua amabilità e i suoi modi raffinati. Negli anni successivi Nollet inviò diverse lettere alla filosofessa di Bologna e le dedicò anche una delle sue Lettres sur l’Electricité che pubblicherà a Parigi nel 1753. Inoltre, Zanotti acconsentì a diventare corrispondente straniero per l’Académie, mentre l’Istituto si impegnò a ricevere regolarmente i Mémoires.78 Sulla via del ritorno in Francia, in una lettera a Zanotti, Nollet riconobbe l’amicizia e la cordialità che i membri dell’Istituto gli avevano accordato, “qualità rare tra uomini che fanno la stessa carriera” .79 Le buone relazioni che Nollet era stato in grado di tessere con l’Istituto bolognese erano anche ottime credenziali per il suo incontro con il Papa che, desideroso di avere le sue impressioni sul suo soggiorno a Bologna, gli concesse un’udienza privata.80 La visita a Benedetto XIV segnò un inaspettato punto di svolta nella controversia. Il Papa era desideroso di conoscere le opinioni di un filosofo tanto celebre a proposito delle scoperte che l’istituzione bolognese, di cui era protettore, sosteneva con tanto vigore. Benedetto XIV era irritato per il troppo rapido sostegno che l’Istituto aveva accordato ai tubi medicati e alla medicina elettrica in generale. Pochi anni dopo avrebbe rivelato il fastidio che provava per quella che giudicava nient’altro 77. BCAB, Lettere di vari a Zanotti (Nollet a Zanotti, 29 ottobre 1749), B 160, f. 38. 78. BCAB, Lettere di vari a Zanotti (Nollet a Zanotti, 11 maggio 1750), B 160, f. 45. ASP, Procès Verbaux, Tome 69 (1750), 27 marzo 1750, f. 187 79. BCAB, Lettere di vari a Zanotti (Nollet a Zanotti, 6 settembre 1749), B 160, f. 37. 80. Nollet, Journal, cit., f. 149v. 66 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI che un’ossessione: in ogni udienza de’ Ministri di Principi, in ogni Posta che venga o di qua, o di là da monti, noi siamo elettrizzati, e non proviamo altro effetto, che quello di sentirci acceso il sangue, ingombrata la testa, e mossa la bile.81 Il medico del Papa rivelò a Nollet che la frettolosa pubblicazione del lavoro di Veratti aveva reso Benedetto XIV furioso.82 L’atteggiamento del pontefice nei confronti della medicina elettrica spostò l’ago della bilancia a favore di Nollet, ma allo stesso tempo costrinse l’abbé a un ulteriore sforzo diplomatico nella presentazione al pubblico dei suoi incontri con gli elettrizzatori italiani. Il pontefice era il protettore dell’Istituto delle Scienze ed era interesse dell’Académie des Sciences mantenere buone relazioni con l’istituzione bolognese. Era quindi necessaria molta prudenza nel rendere pubblico il ruolo dell’Istituto nell’affaire Pivati. In seguito all’incontro con il papa, l’atteggiamento di Nollet divenne più morbido. Nonostante ritenesse che “non c’è altro che l’immaginazione da purgare qui”, Nollet raccomandava a Jallabert (al quale aveva inviato qualche resoconto degli incontri con gli italiani) di non divulgare le sue opinioni fino a quando non fosse tornato a Parigi: si era infatti reso conto che “a Bologna gli spiriti sono divisi”83 e che i membri dell’Istituto si erano pentiti “di essersi spinti tanto avanti […] in futuro si propongono di essere molto più prudenti”.84 Nel maggio 1750, rientrato a Parigi, Nollet inviò a Zanotti la parte della memoria che stava per consegnare all’Académie des Sciences in cui descriveva la sua visita a Bologna e le sue discussioni con Veratti sui tubi medicati. Dichiarandosi pronto ad apportare tutte le modifiche che Veratti ritenesse necessarie, Nollet taceva di aver già inviato la memoria alla Royal Society di Londra, dove era stata letta due mesi prima, il 29 marzo 1750.85 Non vi era nulla di potenzialmente offensivo per l’Istituto in quella parte del resoconto: Veratti era descritto come un “uomo colto, saggio e candido”, le cui guarigioni non erano “tali da darmi dif- 81. F. X. Kraus, Briefe Benedictus XIV an den Canonicus Pier Francesco Peggi in Bologna, J.C. Mohr, Freiburg, Tubingen, 1884, p. 119. 82. Nollet a Jallabert (22 agosto 1749), in Correspondance Nollet-Jallabert, cit., pp. 177-178. 83. Ivi. 84. Ibid., p. 179. 85. BCAB, Lettere di vari a Zanotti (11 maggio 1750), B 160, f. 45. Royal Society Library, London. Journal Book, 1750, ff. 278-286. CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 67 ficoltà a credervi”.86 Veratti, tuttavia, trovò un certo numero di inesattezze e, qualche giorno più tardi, preparò una bozza con le correzioni da inviare a Parigi.87 Questa bozza è conservata nella Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, ma non vi è alcuna evidenza che l’abbé abbia mai ricevuto la versione definitiva. In ogni caso, quelle correzioni non furono mai incorporate nella versione finale della memoria. D’altro canto, la lettera di Veratti nasceva comunque in ritardo: la Royal Society, infatti, avrebbe pubblicato la versione che Nollet aveva inviato a Londra prima di chiedere il parere del medico bolognese. Probabilmente Nollet ignorò deliberatamente le correzioni di Veratti, oppure la lettera non lo raggiunse mai, forse per un atto di censura – o di autocensura – imposto a Veratti. Se fosse possibile sostenere con più evidenza documentale una delle due possibilità, concluderei sottolineando, rispettivamente, la spavalda consapevolezza di Nollet di aver vinto il duello filosofico, o la discreta resa dei membri dell’Istituto. In ogni caso, dai dati disponibili si può dedurre che il silenzio sul ruolo dell’Istituto nella promozione dei tubi medicati fu per entrambe le parti un ottimo compromesso per porre fine alla controversia: i membri dell’istituzione bolognese avrebbero preservato la propria reputazione scientifica sulla scena internazionale, Nollet dal canto suo avrebbe mantenuto buone relazioni con l’Istituto e il suo potente protettore, Benedetto XIV. Dopo aver ricevuto l’estratto di Nollet, Zanotti preparò una lettera ufficiale in cui rendeva noto che l’atteggiamento dell’Istituto nei confronti dei tubi medicati era cambiato: qui non si parla quasi più della elettricità, o sia medica, o sia di qualsivoglia genere. Il Mondo si stanca di parlar lungamente della medesima cosa.88 Il compromesso risultava accettabile anche a Nollet che avrebbe potuto vantarsi della sua vittoria senza offendere l’Istituto o il suo protettore. Nessun riferimento all’appartenenza di Bianchi o Pivati all’Istituto sarebbe apparsa nella versione pubblicata della controversia, atto 86. Nollet, “Extract”, cit., p. 390. 87. BCAB, Mss Laura Bassi, Cart. 1, fasc. 2, non catalogato. 88. AASB, “Antica Accademia”, Tit. III, Minute scritte durante il segretariato Zanotti: Lettera scritta in nome dell‘Accademia al Sig. abate Nollet, 19 dicembre 1750. In una lettera a Veratti del 10 luglio 1751, Pivati si lamentava dello scarso interesse del medico bolognese per i tubi medicati: BCAB, Collezione autografi, LVI, f.15004. 68 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI finale di una lunga serie di negoziazioni tra interessi individuali e collettivi. Conclusione Come in una miniatura, la microstoria dei tubi medicati racchiude in sé caratteristiche significative della filosofia sperimentale nell’età dell’Illuminismo. Durante la controversia furono diverse le questioni in gioco: problemi concernenti l’autorevolezza e l’imparzialità, tensioni emergenti dall’assenza di norme condivise per la ripetizione e la certificazione dei risultati sperimentali, la relazione tra la filosofia naturale e le contingenze locali.89 In un tempo in cui i filosofi naturali erano impegnati a negoziare gli standard per la certificazione dei risultati delle pratiche sperimentali, il duello filosofico sui tubi medicati acquistò un significato che impedì all’episodio di essere archiviato troppo in fretta. Nollet continuò a fare riferimento alla controversia nei testi che pubblicò successivamente e, circa venti anni più tardi, Joseph Priestley ricordava ancora la controversia nel suo History and Present State of Electricity (Londra, 1767). Com’è noto, Priestley sosteneva l’idea di un progresso scientifico lineare e il suo ricorso alla storia aveva come scopo quello di mettere in evidenza la “nascita e il progresso” della filosofia sperimentale. Dunque, ricordare un episodio che non era più sulle labbra di tutti significava offrire ai lettori un’utile lezione metodologica.90 Mi sono dato una regola, e credo di avervi costantemente aderito, di non prendere nota degli errori, dei fraintendimenti e degli alterchi degli elettrizzatori; eccetto quando mi rendevo conto che la conoscenza di essi sarebbe stata utile ai loro successori. Tutte le dispute che non hanno contribuito in nessun modo alla scoperta della verità, le consegnerei volentieri all’oblio eterno.91 Il racconto delle controversie del passato aveva lo scopo di codificare le pratiche sperimentali legittime e di distinguerle da quelle erronee.92 89. Sul tema della contingenza si veda Pancaldi, Volta. Science and culture in the age of Enlightenment, cit., cap. 9. 90. J. Priestley, History and Present State of Electricity, London, 1767, p. i. 91. Ibid., p. x. 92. Sul tema si veda R. Porter, Enlightenment. Britain and the Creation of the Modern World, The Penguin Press, London, 2000, in part. il cap. 10. CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI / 69 Lo stesso Nollet, con le sue narrazioni di duelli filosofici dai quali emergeva immancabilmente vincitore, aveva adottato questo particolare uso della storia. Nel suo racconto la costellazione di interazioni tra le parti coinvolte scompariva per lasciar spazio al trionfo di un verità auto-evidente e super partes. Gli stessi protagonisti, d’altra parte, erano consapevoli di tutte le altre dinamiche, essenziali per l’accreditamento delle scoperte, per la costruzione delle carriere e per l’arbitraggio delle controversie. Come si è visto, in questo intreccio di interazioni le istituzioni accademiche giocavano un ruolo cruciale. Entusiasmato dalle scoperte di Pivati, ma consapevole che i risultati di un solo sperimentatore non avrebbero ottenuto l’attenzione che si era augurato per i tubi medicati, Zanotti agì in nome dell’Istituto delle Scienze per promuovere l’invenzione all’estero. I rapporti esistenti tra i membri dell’Istituto e quelli dell’Académie des Sciences avevano così permesso agli esperimenti di Pivati di essere ritenuti meritevoli di verifiche, piuttosto che liquidati come le fantasie di un ciarlatano. La mediazione dell’Istituto delle Scienze di Bologna garantiva ai tubi medicati una certificazione senza che Pivati dovesse negoziare personalmente la propria autorevolezza. In cambio, la nuova invenzione “certificata” avrebbe aumentato il prestigio dell’Istituto e dimostrato a Benedetto XIV che i suoi sostanziosi investimenti avevano dato dei frutti. Questo universo di relazioni fu rimosso nei resoconti pubblici della controversia che incoronarono Nollet, arbitro imparziale e disinteressato fautore della verità, come vincitore su Pivati, abbagliato dall’“amore del meraviglioso”. La battaglia di Nollet, liberata nella versione ufficiale di tutti quegli elementi che la riconducevano a episodio locale e marginale, diventava così un esempio normativo di condotta sperimentale appropriata da parte del filosofo naturale. Precedenti analisi di questa controversia hanno interpretato il viaggio di Nollet come un “exercise on the political geography of calibration”, o come un momento in cui i protocolli della filosofia sperimentale furono estesi (da Nollet) alla medicina elettrica, contro gli “Italiani” difensori invece di metodi legati alla storia naturale.93 93. S. Schaffer, “Self-evidence” in J. Chandler, (ed.), Questions of evidence: Proof, practice and persuasion across the disciplines, Chicago University Press, Chicago, 1994, pp. 5691; L. Roberts, “Heterogeneous purposes and the protocols of experiment, or How tracing the history of amber can shed light on the medical electricity”, in Bertucci, Pancaldi (eds.), Electric bodies, cit., pp. 17-41. 70 / CURE PRODIGIOSE E MERAVIGLIE ELETTRIZZANTI Se queste analisi sottolineano processi e dinamiche che indubbiamente caratterizzarono la filosofia sperimentale e in particolare le ricerche elettriche negli anni della controversia, esse la esaminano però dal punto di vista offerto dal “vincitore”, ignorando il significato delle interazioni tra Nollet e coloro che successivamente egli descrisse come suoi rivali. Mettendo in luce il contesto italiano, questo studio ha proposto un cambio di prospettiva che enfatizza la reciprocità degli scambi tra Nollet e la comunità filosofica a sud delle Alpi. Questa reciprocità, caratterizzata dal fatto che i protagonisti partecipavano ad una stessa vita culturale, non riesce ad essere spiegata sulla sola base dei loro diversi approcci allo studio del mondo naturale, argomento che questo studio ha comunque messo in discussione. Durante il suo viaggio Nollet cercò consenso piuttosto che conflitto. Mentre nel presentare i suoi esperimenti con i tubi medicati al pubblico, insisteva sull’effettiva esecuzione degli esperimenti e si presentava come un filosofo disinteressato che combatteva in nome della verità, la sua visita nelle capitali culturali della Penisola fu caratterizzata dai suoi tentativi di tessere relazioni con filosofi e dilettanti locali. Sulla base dei dati raccolti, il duello filosofico appare più una creazione letteraria che non la reale preoccupazione di Nollet in viaggio a sud delle Alpi. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 71 LA RIVOLUZIONE CHIMICA, I CHIMICI ITALIANI E I PERIODICI SCIENTIFICI DI FINE SETTECENTO: UNO STUDIO QUANTITATIVO Raffaella Seligardi Introduzione Alla fine del XVIII secolo, analogamente a quanto si verificò in Germania, i periodici scientifici pubblicati a sud delle Alpi offrirono spesso spazi al dibattito sulla cosiddetta rivoluzione chimica, contribuendo in modo rilevante alla formazione di una comunità italiana di esperti.1 D’altro canto, i giornali scientifici europei, in particolare francesi, ospitarono di frequente gli scritti di chimici italiani e sono dunque una fonte altrettanto preziosa per indagare l’impatto che le loro ricerche e idee ebbero tra i colleghi d’oltralpe. Meglio di quanto non fossero in grado di fare le traduzioni di opere monografiche, i giornali consentivano una rapida diffusione di notizie aggiornate e, in particolare nelle recensioni, agli studiosi era concesso di esprimere commenti o critiche in modo più libero di quanto non potessero fare, per esempio, nella prefazione a una monografia in traduzione. Nella prima parte di questo saggio proporrò un’analisi quantitativa degli articoli pubblicati in alcuni giornali italiani, al fine di verificare l’entità della presenza del dibattito sulla nuova chimica nel contesto scientifico della Penisola. Nella seconda parte del saggio, invece, l’analisi quantitativa verterà sulla presenza di autori italiani in alcuni giornali francesi, nella convinzione che ciò sia un indicatore utile a individuare la dimensione del contributo italiano al dibattito internazionale sulla nuova chimica. Limiterò l’esame ai due principali periodici scientifici italiani, entrambi pubblicati in Lombardia: gli Opuscoli scelti, pubblicati a Milano, e gli 1. Circa il caso della Germania, si veda K. Hufbauer, The formation of the German chemical community (1720-1795), University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1982; circa l’Italia, si veda R. Seligardi, Lavoisier in Italia. La comunità scientifica italiana e la rivoluzione chimica, Olschki, Firenze, 2002. 72 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA Annali di Chimica, pubblicati a Pavia. Il primo periodico presenta notevoli analogie con un altro periodico che esaminerò, il Journal de Physique. Gli Annali di Chimica, invece, l’unico giornale scientifico italiano dedicato specificatamente alla chimica, furono pensati sul modello di un altro giornale francese, pure qui preso in esame, le Annales de Chimie. Prima di procedere, tuttavia, sono necessari alcuni chiarimenti metodologici. Per quanto concerne lo studio dei periodici italiani, ho incluso nel campione analizzato tutti gli articoli su temi attinenti la cosiddetta nuova chimica e che trattano di arie, acidi, affinità, combustione e/o calcinazione, calore, flogisto e fluidi imponderabili in generale, natura dell’acqua e nomenclatura.2 Naturalmente, non è sempre facile decidere quando un articolo è “rilevante” perché, com’è ovvio, il giudizio dello storico non può che avvenire a posteriori. Ho ritenuto dunque utile applicare a questo contesto della ricerca l’approccio prudente che di recente Robert Fox ha suggerito di usare quando ci si occupa di “esperimenti cruciali”: come storici dobbiamo essere consapevoli che molti degli esperimenti che oggi definiamo cruciali, non necessariamente lo erano agli occhi dei contemporanei.3 In effetti, argomenti ritenuti oggi dagli storici della scienza di grande rilevanza nel contesto di quella che chiamiamo rivoluzione chimica, come la scoperta della natura composta dell’acqua o la teoria dell’acidità basata sull’ossigeno, agli occhi di un chimico di fine Settecento potevano essere in realtà del tutto secondari.4 Per queste ragioni, tra gli articoli considerati “rilevanti” per la chimica di fine Settecento ai fini di questo studio, ho deciso di includere anche quelli concernenti l’analisi chimica di sostanze organiche vegetali e animali, la scoperta di nuovi metalli e o terre, la mineralogia, la fisiologia e la farmacia, che pure costituivano parte importante del dominio della chimica di fine Settecento. Un secondo criterio adottato riguarda la classificazione per temi. Talvolta, com’è ovvio, lo stesso articolo può trattare più argomenti, tutti significativi ai fini di questa ricerca. In quei casi l’articolo è stato classi2. La scelta è dettata dalle conclusioni raggiunte dalla storiografia sulla rivoluzione chimica, che ha indicato nei temi elencati i principali oggetti di dibattito. Si veda in part. P. Bret, “Trois décennies d’études lavoisiennes. Supplément aux bibliographies de Duveen”, in Revue d’histoire des sciences, 48, 1995, pp. 169-205. 3. R. Fox, “What was ‘crucial’ about Rumford’s experiments on the nature of heat?”, in Atti dell’ XI Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, a cura di L. Cerruti e F. Turco, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Roma, 2006, pp. 415-425. 4. Seligardi, Lavoisier in Italia, cit., pp. 354-355. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 73 ficato nella categoria cui dedica quantitativamente più spazio. Questo per quanto concerne i periodici italiani; per quelli francesi, invece, ho preso in esame tutti gli autori italiani pubblicati. Infine, ho scelto di non classificare in modo netto gli autori o gli articoli come pro o contro la nuova chimica. Numerosi studi hanno dimostrato che durante una “rivoluzione scientifica” non esistono posizioni nette e spesso si riscontrano tante interpretazioni dei risultati sperimentali quanti sono gli scienziati coinvolti. La nuova chimica nei periodici scientifici italiani: gli Opuscoli scelti Il periodico scientifico italiano più importante nell’ultimo quarto del Settecento fu la Scelta di opuscoli interessanti tradotti da varie lingue, curato da Carlo Amoretti e Francesco Soave, un mensile che iniziò le sue pubblicazioni a Milano nel 1775.5 Dal 1778 al 1803 il titolo del periodico cambiò in Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti e la cadenza divenne bimestrale. Dal 1804 la testata cambiò nuovamente titolo in Nuova scelta di opuscoli interessanti sulle scienze e sulle arti (tra il 1775 e il 1807 furono pubblicati 59 volumi). Oltre a presentare ai lettori di lingua italiana articoli pubblicati in Francia, Inghilterra e Germania, il giornale dava naturalmente spazio anche agli articoli originali di scienziati italiani. Gli 85 articoli non italiani presi in esame avevano la seguente provenienza geografica: il 30% arrivava dalla Francia, il 21% dalle isole britanniche, l’11% dall’area linguistica tedesca, il 7% dal Belgio-Olanda e il 6% dalla Svezia. Durante i primi anni di vita la Scelta di opuscoli interessanti pubblicò pochi articoli di autori italiani, prevalentemente traduzioni di memorie presentate all’estero o riassunti di libri, anche questi talvolta pubblicati all’estero, come nel caso di alcune opere di Felice Fontana.6 La maggior 5. Sui periodici scientifici italiani nel Settecento, F. Arato, “Carlo Amoretti e il giornalismo scientifico nella Milano di fine Settecento”, in Annali della Fondazione Luigi Einaudi, 21, 1987, pp. 175-220; P. Delpiano, “I periodici scientifici nel Nord Italia alla fine del Settecento”, in Studi storici, 30, 2, 1989, pp. 457-482; Id., “La divulgazione tecnico-scientifica nei periodici piemontesi del Settecento”, in G. Barsanti, V. Becagli, R. Pasta (a cura di), La politica della scienza: Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento, Olschki, Firenze, 1996, pp. 345-365. 6. P. K. Knoefel, Felice Fontana, life and works, Temi, Trento, 1984. In part. sulle ricerche chimiche di Fontana, si veda F. Abbri, Science de l’air. Studi su Felice Fontana, Brenner, Cosenza, 1991. 74 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA parte degli articoli erano traduzioni di memorie apparse sul Journal de Physique o sulle Philosophical Transactions della Royal Society. Per quanto concerne invece i temi, il più dibattuto era lo studio dei gas, con 36 titoli: il 24,48% dei 147 articoli considerati rilevanti ai fini di questo studio (Fig. 1). La punta massima di articoli relativi alle arie si ebbe tra il 1776 (4 articoli) e il 1777 (9 articoli). Questi picchi si spiegano con la scoperta dell’aria infiammabile delle paludi (il metano) da parte di Alessandro Volta e con le riflessioni sulle ricerche di Fontana sull’aria fissa pubblicate a Parigi nel 1776, lo stesso anno in cui fu pubblicata la dissertazione di Lavoisier sul principio ossigino come causa dell’aumento di peso dei metalli calcinati.7 Se a questo dato aggiungiamo i 7 articoli sulla vegetazione e i 5 sulla respirazione, nonché gli altri 5 sulla combustione e/o calcinazione, la percentuale di articoli sulle arie arriva al 36%: un dato che conferma come la chimica dei gas in tutti i suoi aspetti, fisiologici e non, fosse davvero il campo di ricerca più proficuo e degno di interesse nell’ultimo quarto del Settecento, perché le arie, con la loro capacità di “fissarsi”, cioè di combinarsi chimicamente, rappresentavano una novità assoluta nella storia di questa disciplina. Quantitativamente inferiore, ma in ogni caso rilevante, fu la trattazione dei sali, con 15 articoli, il 10,2% del totale. Se a questi si aggiunge il numero degli articoli sugli acidi (12),8 si arriva al 18,3%: un dato, questo, che sembra confermare quanto affermato da Frederic L. Holmes a proposito della chimica dei sali come la parte più sviluppata e matura della chimica del Settecento.9 Circa il dibattito sulla natura dell’acqua – altra grande novità negli studi di chimica dell’ultimo quarto del Settecento –, se ne trova traccia in 10 articoli: un articolo l’anno tra il 1781 e il 1785, nel 1792 e nel 1794, e 3 articoli nel 1789. Prima del 1783, data della scoperta della natura composta dell’acqua, gli articoli vertevano sulla sua convertibilità in 7. A. L. Lavoisier, “Dissertazione ove dimostrasi, che il principio il qual combinasi coi metalli durante la lor calcinazione, e n’accresce il peso, non è altro che l’aria atmosferica la più pura”, in Scelta di opuscoli interessanti, 16, 1776, pp. 25-39; originale: “Mémoire sur la nature du principe qui se combine avec les métaux pendant leur calcination, & qui en augmente le poids”, in Observations sur la Physique, 5, maggio 1775, pp. 429 e ss. 8. Ricordo che nella terminologia chimica settecentesca anche gli acidi rientravano nella categoria dei sali. 9. F. L. Holmes, Eighteenth-century chemistry as an investigative enterprise, Office for History of Science and Technology, University of California, Berkeley, 1989. 1. Distribuzione degli argomenti negli Opuscoli scelti, 1772 –1807. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 75 76 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA terra, mentre negli anni successivi il problema posto era se l’acqua fosse un elemento o un composto. Un accenno alla natura composta dell’acqua comparve per la prima volta sugli Opuscoli scelti nel 1783.10 L’anno successivo fu pubblicata una lettera di Jean Magellan a Carlo Lodovico Morozzo,11 nella quale il portoghese riferiva le opinioni di James Watt, Joseph Priestley e Richard Kirwan. Secondo Watt, l’acqua era composta da aria deflogisticata + flogisto, essendo l’aria deflogisticata composta a sua volta da acqua + fuoco elementare che aveva perso flogisto. Priestley e Kirwan, invece, seguivano l’ipotesi dell’identità tra aria infiammabile (idrogeno) e flogisto. In una nota, i curatori degli Opuscoli scelti scrissero: Dalle ulteriori osservazioni sembra doversi inferire, che l’acqua sia la base delle arie tutte; che combinata col flogisto dia aria infiammabile; e combinata col calore o fuoco elementare dia aria deflogisticata. In questa ipotesi se uniscansi queste due arie il flogisto della prima s’attacca al calore della seconda per una maggiore affinità; e l’acqua, non essendo più tenuta in istato di dissoluzione, precipita sulle pareti, o sul fondo del vaso. Così colle due arie formasi l’acqua per analisi, e non per sintesi, come altri immaginano.12 I curatori del periodico usavano il tipico argomento degli antilavoisieriani, che rifiutavano di considerare l’acqua un composto. É a questo punto che sugli Opuscoli scelti prese il via il dibattito sulla natura dell’acqua, con posizioni prevalentemente in linea con quelle dei curatori. Nel 1787 la pubblicazione della Méthode de nomenclature chimique13 fu ignorata, ma l’anno successivo la nuova nomenclatura era adottata in un articolo del barone di Puymaurin.14 In quella occasione i curatori del giornale si limitarono a spiegare la differenza tra le desinenze “-oso” e “-ico” introdotte per la nomenclatura degli acidi. Nel 1789, finalmente, comparve la traduzione dell’estratto della Méthode per le Observations sur la physique di Jean Claude de la Métherie,15 accompa10. Opuscoli Scelti, v. 6, 1783, nota a p. 378. 11. J. Magellan, Lettera a Morozzo [11 maggio 1784], in Opuscoli Scelti, 7, 1784, pp. 210-212. 12. Ibid., nota a p. 211. 13. L. B. Guyton de Morveau, A. L. Lavoisier, C. L. Berthollet, A. F. Fourcroy, Méthode de nomenclature chimique [...] On y a joint un nouveau Système de Caractères Chimiques, adaptés à cette Nomenclature, par MM. Hassenfratz & Adet, Cuchet, Paris, 1787. 14. J. P. C. de Marcassus, barone di Puymaurin, “Dell’acido fluorico o spatico […]”, in Opuscoli Scelti, 11, 1788, pp. 410-422. 15. J. C. de la Métherie, “Extrait de la Méthode de la Nomenclature chimique”, in Observations sur la Physique, 31, settembre 1787, pp. 210-219. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 77 gnata da una nota dei curatori degli Opuscoli scelti: Quando fu pubblicato il nuovo metodo di Nomenclatura chimica udimmo e leggemmo che generalmente era riprovato, sicché non solo varj illustri Chimici ne dimostrarono l’inutilità, lo svantaggio, e la poca aggiustatezza de’ termini; ma varie Accademie pur si proposero di non mai adottarla negli scritti che sarebbono per pubblicarsi ne’ loro Atti, o Memorie. Quindi credemmo allora inutile di farla conoscere. Ma veggendo in seguito, che non solo co’ termini della nuova Nomenclatura esprimeansi i loro Autori, ma eziandio che molti altri affettavano di secondare, direm così, la moda; abbiam creduto opportuno d’inserire nella nostra raccolta l’estratto di questo nuovo Dizionario fatto dal sig. de la Métherie pel Giornale di Fisica, giacché sovente ci avviene di tradurre degli scritti di coloro che ne parlano il linguaggio.16 Gli altri articoli qui presi in esame e pubblicati nel 1789 sono di autori stranieri: uno di Louis Le Fèvre de Gineau che esponeva la teoria di Lavoisier sull’acidità e sulla natura composta dell’acqua utilizzando la nuova nomenclatura,17 e uno di Priestley che, com’è noto, confutava invece tutta quanta la nuova dottrina.18 Con la pubblicazione di queste due memorie, i curatori intendevano evidentemente offrire ai loro lettori la possibilità di scegliere se accettare o no la nuova nomenclatura.19 Tuttavia, come si è detto, essi si erano dichiarati fin dal 1784 per la natura semplice dell’acqua e ora, in realtà, si appellavano all’autorità di Priestley per controbattere la nuova chimica. Intanto, nella sezione dedicata alle “Novelle letterarie”, il Traité élémentaire de chimie di Lavoisier, uscito quello stesso anno, 20 era liquidato in poche righe.21 Tra gli studiosi non italiani Joseph Priestley fu senz’altro il più presente negli Opuscoli scelti: 12 articoli tra il 1775 e il 1792 (con un picco di 6 articoli tra il 1775 e il 1778). Di Lavoisier furono pubblicate solo 5 16. “Metodo di nomenclatura chimica […] estratto dal Sig. de la Métherie”, in Opuscoli Scelti, 12, 1789, pp. 11-20, nota a p. 11. 17. L. Le Fèvre de Gineau, “Memoria in cui rendesi conto delle sperienze fatte pubblicamente in quest’istesso Collegio [Collège Royale] nel mese di Maggio, Giugno e Luglio dell’istess’anno [1788], sulla composizione, e scomposizione dell’acqua”, ibid., 12, 1789, pp. 73-84. 18. J. Priestley, “Sperienze ed osservazioni relative ai principj dell’acidità, alla composizione dell’acqua, e al flogisto, cavate dalle Transazioni Filosofiche”, ibid., 12, 1789, pp. 85-93. L’articolo era pubblicato con una lettera di Priestley a de la Métherie sullo stesso argomento. Id., “Lettera a de la Métherie sulla combustione dell’aria infiammabile e dell’aria pura”, ibid., pp. 93-94. 19. Ibid., 12, 1789, nota a p. 73. 20. A. L. Lavoisier, Traité élémentaire de chimie: présenté dans un ordre nouveau et d’après les découvertes modernes, Cuchet, Paris, 1789. 21. Opuscoli scelti, 12, 1789, p. 44 a fine volume. 78 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA memorie e 2 recensioni, mentre più rilevante fu la presenza di Jan Ingen Housz (7 articoli). Se Lavoisier era percepito dai curatori degli Opuscoli scelti come uno dei chimici più importanti dell’epoca, in realtà l’autorità indiscussa, in particolare per la chimica dei gas, era ritenuta senz’altro Priestley. I dati quantitativi testimoniano inoltre dell’interesse per Ingen Housz, un autore che forse meriterebbe una maggiore attenzione da parte degli storici: i suoi scritti sulla vegetazione e sui gas assorbiti e liberati dalle piante, fondamentali per la storia degli studi sulla fotosintesi, infatti, si inseriscono a pieno titolo nella storia della chimica. Tra il 1777 ed il 1784, l’autore italiano più presente nelle pagine del periodico fu Alessandro Volta, con 8 articoli: erano quelli gli anni delle ricerche sulle arie infiammabili, sul calore, sulla natura dell’acqua e della costruzione di strumenti come le pistole elettriche e gli eudiometri ad aria infiallabile.22 Seguiva, tra il 1776 e il 1783, Felice Fontana, con 4 articoli, infine, tra il 1780 ed il 1803, Luigi Valentino Brugnatelli, con 5 articoli. Volta e Fontana, ognuno a proprio modo, erano flogististi, mentre Brugnatelli era un lavoisieriano che aveva portato alle estreme conseguenze i principi teorici ispiratori della rivoluzione chimica e della relativa nomenclatura, arrivando a proporre un suo sistema, alternativo a quello dei francesi. La sua presenza nelle pagine degli Opuscoli scelti rafforzava dunque l’atteggiamento critico del giornale nei confronti della nuova chimica. Dopo il 1795 negli Opuscoli scelti la frequenza di articoli sulla nuova chimica calò considerevolmente e, analogamente a ciò che vedremo accadere per il Journal de physique, la concorrenza di altri giornali cominciò a farsi sentire. Nel 1788, infatti, Brugnatelli aveva fondato la Biblioteca fisica d’Europa (ne furono pubblicati 20 volumi fino al 1791); tra il 1792 e il 1796 pubblicò il Giornale fisico medico ma, soprattutto, nel 1790 Brugnatelli iniziò la pubblicazione degli Annali di chimica. 22. F. Bevilacqua, L. Fregonese, (a cura di), Nuova voltiana. Studies on Volta and his times, Hoepli, Milano, 2, 2000; G. Pancaldi, Volta: Science and Culture in the Age of Enlightenment, Princeton University Press, Princeton, 2003. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 79 Gli Annali di chimica L’impresa editoriale più importante di Brugnatelli fu la pubblicazione, dal 1790, degli Annali di chimica ovvero Raccolta di memorie sulle scienze, arti e manifatture ad essa relative. Il periodico – di cui si pubblicarono, con periodicità variabile, 22 volumi fino 1805 –, nacque sul modello delle Annales de Chimie (1789) di Lavoisier e dei Chemische Annalen (1784) di Lorenz Crell. Negli Annali di chimica si pubblicavano recensioni, numerosi articoli di autori italiani, traduzioni di memorie comparse sul Journal de Physique, traduzioni ed estratti di corrispondenza dal giornale di Crell, memorie provenienti dall’Inghilterra e, a partire dal 1797, estratti dalle Annales de Chimie. Lo scopo degli Annali era di aggiornare la comunità scientifica italiana in merito alle nuove scoperte e agli sviluppi della disciplina, con un’attenzione particolare alle applicazioni industriali e alle scoperte di nuovi elementi e di farmaci. Pur dichiarandosi lavoisieriano, nella prefazione al primo volume Brugnatelli esprimeva l’intento di pubblicare articoli sia pro sia contro la nuova chimica: un proposito, questo, che non avrebbe mantenuto a lungo.23 Quando nacquero gli Annali di Chimica la grande stagione della scoperta di nuovi gas e della sistematizzazione che ne aveva dato Priestley era trascorsa; nonostante questo, l’argomento principale trattato dal giornale furono gli studi sulle arie, con 15 articoli dei 127 qui considerati e pubblicati tra il 1790 ed il 1805 (11,8%). Il maggior numero di articoli (4) fu pubblicato nel 1798, quando Brugnatelli intervenne in prima persona a proposito delle definizioni di azoto e termossigeno (Fig. 2).24 Nel primo volume furono pubblicati, tra gli altri, un articolo di Carradori, critico nei confronti dell’esperimento di Paets van Troostwijk e Deiman, che avevano decomposto l’acqua per mezzo della scintilla elettrica;25 uno di Giobert, di tipo applicativo;26 parte di un articolo di Volta 23. “Prefazione”, in Annali di chimica, 1, 1790, p. IX. 24. Per una discussione della teoria chimica di Brugnatelli si veda Seligardi, Lavoisier in Italia, cit., pp. 76-81. 25. G. Carradori, “Riflessioni sull’esperienza dei signori Paets van Troostwyk [sic], e Deiman Sulla decomposizione dell’acqua in aria infiammabile e deflogisticata, comunicate per lettera ad un suo Amico [Giovanni Fabbroni]”, in Annali di Chimica, 1, 1790, pp. 118. Sui chimici olandesi, L. Roberts, “The Dutch meet the ‘new’ chemistry”, in B. Bensaude-Vincent, F. Abbri (eds.), Lavoisier in European context: Negotiating a new language for chemistry, Science History Publications, Canton (MA), 1995, pp. 87-112; H. A. M. Snelders, “The new chemistry in the Netherlands”, in Osiris, 4, 1988, pp. 121-145. 26. G. A. Giobert, “Sopra la produzione di un olio nella distillazione del gas muriatico 2. Distribuzione degli argomenti negli Annali di chimica, 1790-1805. 80 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 81 sull’eudiometro,27 un articolo dello stesso Brugnatelli28 e parte della Litologia vesuviana di Giuseppe Gioeni, completata nei volumi successivi.29 Furono inoltre tradotte dal Journal de Physique alcune notizie relative alla pretesa scoperta di nuovi regoli metallici da parte di Matteo Tondi e Anton von Ruprecht.30 Nel 1791 furono pubblicate sia la lettera a Lavoisier in cui Joseph Black si dichiarava finalmente a favore del nuovo sistema di chimica,31 sia una a Brugnatelli di Crell, nella quale si rendeva conto del dibattito in corso in Germania su quei medesimi temi.32 Nel 1793 furono pubblicati un articolo di Giuseppe Olivi33 e uno di Giobert,34 entrambi lavoisieriani; ma anche una memoria di Gioacchino Carradori che, pur impiegando parzialmente la nuova nomenclatura, si dichiarava seguace della teoria del calore di Adair Crawford e riteneva quindi valida l’esistenza del flogisto.35 Nel 1794 comparve sugli Annali di Chimica il primo articolo del farmacista belga Jan Baptiste Van Mons,36 che ebbe un ruolo importante per la diffusione a nord delle Alpi della nomenclatura riformata di Brugnatelli e, più in generale, della chimica italiana. Tuttavia, gli argomenti più spesso affrontati nei tre volumi pubblicati nel 1794 furono il diossigenato, ed altri argomenti chimici [Lettera a Brugnatelli, Torino, 5 agosto 1790]”, in Annali di Chimica, 1, 1790, pp. 19-27. 27. A. Volta, “Descrizione dell’eudiometro ad aria infiammabile […]”, ibid., 1, 1790, pp. 171-231; 2, 1791, pp. 161-286; 3, 1791, pp. 36-45. 28. L. V. Brugnatelli, “Riflessioni sull’acido marino ossigenato usato come fotometro [...]”, ibid., 1, 1790, pp. 232-242. 29. G. Gioeni, “Saggio di litologia del Vesuvio”, ibid., 1, 1790, pp. 243-267; ibid., 2, 1791, pp. 33-160; ibid., 3, 1791, pp. 161-264. 30. L. Crell, “Estratto d’una lettera del medesimo al sig. de la Métherie Sopra i regoli metallici ottenuti dalla terra calcare, dalla magnesia, dalla terra selciosa, e dal sal sedativo [Helmstadt, 5 agosto 1790]”, ibid., 1, 1790, pp. 75-77; “Notizia comunicata dal sig. Jacquin figlio a Brugnatelli Sopra i pretesi nuovi regoli metallici”, ibid., 1, 1790, p. 170. 31. J. Black, “Estratto di lettera a Lavoisier”, ibid., 2, 1791, pp. 23-26. La lettera originale di Black a Lavoisier è datata 24 ottobre 1790. Si veda A. L. Lavoisier, Oeuvres de Lavoisier. Correspondance, 6. 1789-1791, a cura di P. Bret, Blanchard, Paris, 1997, pp. 185-188. 32. L. Crell, “Estratto di lettera […] al Sig. Brugnatelli sulla decomposizione dell’alcali volatile, ec. [Helmstadt, 28 agosto 1791]”, in Annali di Chimica, 3, 1791, pp. 46-47. Sui chimici tedeschi si veda Hufbauer, The formation of the German Chemical Community, cit., Appendix 1: Biographical profiles. 33. G. Olivi, “Ricerche chimiche intorno alla cagione della colorazione in rosso delle croste de’ Granchj e Gamberi”, in Annali di Chimica, 4, 1793, pp. 100-106. 34. G. A. Giobert, Lettera a Brugnatelli [Torino, 16 gennaio 1793], ibid., 4, 1793, pp. 107-109. 35. G. Carradori, “Della polvere fulminante”, ibid., 4, 1793, p. 152, nota 1. 36. J. B. Van Mons, “Esperimenti sulla presenza dell’ossigeno nell’ossido rosso di mercurio preparato per l’ossidazione spontanea e ripristinato prima d’essere raffreddato”, ibid., 5, 1794, pp. 21-27. 82 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA battito sulla scintillazione dell’acciarino nel vuoto,37 e quello sulla natura dell’acqua, che continuò a trovare spazio anche nel 1795. Quello stesso anno furono resi noti i risultati sperimentali di J. F. A. Göttling, che dichiarava di essere riuscito a bruciare fosforo in azoto puro.38 Sulle pagine degli Annali di Chimica il dibattito sulla combustione del fosforo proseguì fino al 1797 ma, riguardo alla nomenclatura, continuò almeno fino al 1802. L’importanza data da Brugnatelli alla nuova chimica e alla nomenclatura riformata trovano conferma nei 16 articoli dedicati a questi temi (12,5% del totale). In particolare, dopo la pubblicazione del suo Prospetto di riforma alla Nuova Nomenclatura Chimica,39 Brugnatelli si preoccupò di rendere note le reazioni, in Italia e all’estero, alla sua proposta.40 Convinto dei vantaggi del suo sistema, Brugnatelli annunciò che tutte le memorie pubblicate sugli Annali di chimica avrebbero adottato i nomi riformati.41 A tale scopo, pubblicò anche la Sinonimia e il Vocabolario della sua nuova nomenclatura, inserendo sia i nomi della nuova nomenclatura francese, sia quelli della chimica precedente alla riforma della nomenclatura tra i nomi antichi.42 Inoltre, per meglio far comprendere le ragioni scientifiche della sua riforma, Brugnatelli ripubblicò i capitoli sul calore e sulla luce tratti dai suoi Elementi di chimica,43 37. Seligardi, Lavoisier in Italia, cit., pp. 287-307. 38. M. Beretta, “Luigi Valentino Brugnatelli e la chimica in Italia alla fine del Settecento”, in Storia in Lombardia, 2, 1988, pp. 3-31; Id., “Gli scienziati italiani e la rivoluzione chimica”, in Nuncius, 2, 1989, pp. 119-145; F. Abbri, “Spallanzani e la diffusione delle teorie chimiche di Lavoisier in Italia”, in G. Montalenti, P. Rossi (a cura di), Lazzaro Spallanzani e la biologia del ‘700, Olschki, Firenze, 1983, pp. 121-135; Id., “Spallanzani e la ‘chimica nuova’”, in F. Capuano, P. Manzini, (a cura di), La “mal-aria” di Lazzaro Spallanzani e la respirabilità dell’aria nel Settecento, Olschki, Firenze, 1996, pp. 3-15; Seligardi, Lavoisier in Italia, cit., pp. 269-285. 39. L. V. Brugnatelli, “Prospetto di riforma della nuova nomenclatura chimica proposta dai sigg. Morveau, Lavoisier, Berthollet, e Fourcroy”, in Annali di Chimica, 8, 1795, pp. 149-173. 40. L. V. Brugnatelli, “Avvertimento [Pavia, 19 agosto 1795]”, ibid., 9, 1795, 6 pp. n.n. in apertura di vol. 41. Solo nel caso di una memoria di Giobert su dei nuovi esperimenti sulla combustione del fosforo, Brugnatelli mise i nomi riformati tra parentesi, lasciando la nomenclatura francese nel testo, in rispetto delle idee di Giobert che si opponeva ai risultati di Göttling. G. A. Giobert, “Lettera sopra diverse nuove sperienze di chimica”, ibid., 11, 1796, pp. 265-269. 42. L. V. Brugnatelli, “Sinonimia antica e nuova riformata disposta per ordine Alfabetico”, ibid., 10, 1795, pp. 1-30; Id., “Vocabolario della nuova nomenclatura chimica riformata e accresciuta”, ibid., 10, 1795, pp. 31-118 [la numerazione delle pagine riparte da 1 dopo la p. 187 del volume]. 43. L. V. Brugnatelli, Elementi di chimica appoggiati alle più recenti scoperte chimiche e farmaceutiche, Baldassarre Comino, Pavia, 1795-1798, 3 voll. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 83 nonché un articolo riguardante i diversi tipi di combustione.44 Negli Annali di chimica, rispetto agli Opuscoli scelti colpisce l’abbondanza di articoli sui fluidi imponderabili: si tratta di 15 articoli, lo stesso numero di quelli dedicati alle arie. Di questi, 3 furono pubblicati nel 1795 e 5, relativi all’elettricità animale e all’elettrochimica, nel 1802. Brugnatelli, infatti, diede molto spazio nel periodico alla sua teoria termossigena e agli studi sul fluido elettrico, in particolare in concomitanza con la scoperta della pila e durante la collaborazione con Volta.45 Nel 1796 Van Mons iniziò la collaborazione con gli Annali.46 Il farmacista di Bruxelles, dal 1792 collaboratore delle Annales de Chimie, inviava regolarmente a Brugnatelli le ultime novità dalla Germania e da Parigi. Nel 1797 Brugnatelli pubblicò i risultati degli esperimenti di Fourcroy e Vauquelin che smentivano definitivamente le conclusioni di Göttling.47 Brugnatelli riconobbe l’errore commesso,48 tuttavia tradusse la memoria dei due francesi utilizzando la sua nomenclatura riformata, ribadendo ancora una volta l’inadeguatezza del nome “azoto”. Nel frattempo per quello stesso gas adottò senza riserve il termine “septone”, come proposto dallo statunitense Winthrop Saltonstall.49 Nel 1798 comparvero ben 12 articoli sperimentali di Brugnatelli.50 Il calo di credibilità subito dopo la pubblicazione dei risultati di Göttling 44. L. V. Brugnatelli, “Memoria sopra il calorico”, in Annali di Chimica, 9, 1795, pp. 238-270; Id., “Memoria sulla luce”, ibid., pp. 291-301; Id., “Intorno alle diverse specie di combustioni”, ibid., 11, 1796, pp. 41-47. 45. Pancaldi, Volta: Science and Culture in the Age of Enlightenment, cit. 46. J. B. Van Mons, “Sopra diversi nuovi argomenti di chimica [Bruxelles, 30 marzo 1796]”, in Annali di Chimica, 12, 1796, pp. 218-220. 47. A. F. Fourcroy, N. Vauquelin, “Esame delle esperienze fatte in Germania sulla pretesa combustione nel gas fossigeno, o azotico e dei risultati che se ne sono derivati […]”, ibid., 13, 1797, pp. 3-34. 48. A. F. Fourcroy, N. Vauquelin, “Esame delle esperienze fatte in Germania […]”, cit ., nota a p. 3. 49. Recensione a “Wintrop [sic] Saltonstall, Dissertazione inaugurale sulla storia chimica del septone (dell’azoto de’ francesi), Nuova York, 1796”, in Annali di Chimica, 14, 1797, p. 266. 50. L. V. Brugnatelli, “Nuove osservazioni sopra la maniera di produrre strepitose fulminazioni con varie sostanze per mezzo del fosforo”, ibid., 15, 1798, pp. 79-88; Id., “Osservazioni sopra l’ossisaccarico considerato come reagente chimico”, ibid., pp. 108110; Id., “Apparecchio comodissimo per ottenere in grande, e con poca spesa l’acqua saturata di ossicarbonico, e di varie altre specie di acque minerali”, ibid., pp. 111-115; Id., “Osservazioni sopra l’oro fulminante”, ibid., pp. 116-119; Id., “Delle acque minerali [estratto dal 3° volume degli Elementi di chimica]”, ibid., 17, 1798, pp. 19-83; Id., “Dell’ammoniuro di cobalto”, ibid., pp. 89-104; Id, “Osservazioni intorno alla formazione degli eteri”, ibid., pp. 139-141; Id., “Osservazioni sopra l’albumina”, ibid., pp. 142-144; Id., “Osservazioni sopra l’ammoniuro di mercurio e di zinco”, ibid., pp. 160-164; Id., “Maniera di ottenere il mercurio dolce senza mercurio corrosivo e di una forza medica costante comunicata all’Accademia di Mantova”, ibid., pp. 214-218. 84 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA lo aveva spinto a recuperare terreno sperimentando nuovi strumenti e nuovi reagenti, studiando in dettaglio fenomeni fino a quel momento ritenuti marginali, ricercando nel settore delle applicazioni della chimica. Lo sforzo, come vedremo, non fu vano: saranno proprio queste memorie a essere scelte per la pubblicazione nelle Annales de Chimie. Nel volume del 1800 trovarono spazio la scoperta della pila e l’uso fattone per la decomposizione dell’acqua da William Nicholson e Anthony Carlisle e alcune altre esperienze di elettrochimica di Volta.51 Le nuove proprietà chimiche del fluido elettrico indussero Brugnatelli, ancora una volta, a un ripensamento della nomenclatura che lo studioso presentò ora ai suoi lettori in una grande tavola allegata al volume.52 L’analisi quantitativa degli Annali di chimica consente di cogliere la progressiva maturazione e convinzione del chimico pavese della validità delle innovazioni lavoisieriane, ma anche della loro incompletezza. Dei 127 articoli qui considerati, 32 erano di Brugnatelli (25,19%), 20 di Carradori (15,74%) e 9 di Van Mons (7%). I dati quantitativi confermano l’uso strumentale che Brugnatelli fece della rivista: Carradori, infatti, era critico nei confronti della teoria del calorico di Lavoisier 53, mentre Van Mons sosteneva apertamente la teoria del termossigeno di Brugnatelli. La presenza italiana nei periodici scientifici francesi: le Observations sur la physique Le Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle, et sur les arts furono pubblicate ogni mese a Parigi dal 1771. Inizialmente il solo curatore fu l’abate Jean Baptiste François Rozier cui si affiancarono, tra il 1780 ed il 1785, Jean André Mongez e, dal 1785, Jean Claude de la Métherie.54 Il periodico, conosciuto negli ambienti scientifici come Journal de physique, o semplicemente come “il giornale di Rozier”, ebbe una buo51. A. Volta, “Lettera a Brugnatelli Sopra alcuni fenomeni chimici ottenuti col nuovo apparecchio elettrico”, ibid., 18, 1800, pp. 3-23. 52. L. V. Brugnatelli, “Osservazioni chimiche sopra l’ossielettrico”, ibid., 18, 1800, pp. 136-152; Id, “Avvertimento Sopra la Nomenclatura Chimica moderna con una Tavola”, ibid., pp. 192-197; Id., “Sinonimia delle nomenclature chimiche moderne”, ibid., tav. f. t. 53. G. Carradori, Scritti sull’elettricità animale, a cura di W. Bernardi, Società di Storia Patria, Prato, 1989. 54. E. W. J. Neave, “Chemistry in Rozier’s Journal”, in Annals of Science, 6, 1948-1950, p. 417. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 85 na diffusione in Europa grazie alla rapidità con cui informava i lettori circa le ultime novità scientifiche.55 Inizialmente, il periodico pubblicò vari articoli sull’analisi e la classificazione di terre, sali, acidi, cristalli, insieme a studi sulle acque minerali.56 Dal 1772 si svilupparono due linee principali di ricerca. La prima prese il via con la controversia tra la teoria della causticità basata sull’acidum pingue, di Johann Friedrich Meyer, e quella basata sull’aria fissa, di Joseph Black.57 L’altro importante filone di ricerca fu quello sulle arie, iniziato dopo la presentazione delle scoperte di Joseph Priestley alla Royal Society nel marzo 1772. Nel 1774 Lavoisier pubblicò i suoi Opuscules physiques et chimiques,58 e il dibattito si spostò sulla calcinazione e sull’aria deflogisticata, sulle varie arie e sui tentativi di chiarire la natura del flogisto. Negli anni immediatamente successivi, inoltre, comparvero alcune ricerche sull’eudiometria. Dei 420 articoli e recensioni delle Observations sur la physique scelti come rilevanti ai fini di questo studio e comparsi in 51 volumi tra il 1771 ed il 1800, 88 trattavano di arie (20,95%). Il picco si ebbe nel 1773, con 10 articoli, spesso relativi alla natura dell’aria fissa, in linea con le ricerche di Meyer e di Black e con gli studi di Priestley. Gli articoli sulle arie furono numerosi anche nel 1777 (7 articoli, soprattutto sull’aria infiammabile), nel 1783 (7 articoli) e nel 1785 (6 articoli). Ricordo che nel 1777 le ricerche di Volta sull’aria infiammabile delle paludi erano ormai note in tutta Europa; mentre per quanto concerne il 1783 e il 1785, gli studi sui gas si possono mettere in relazione al dibattito sull’acqua, la cui natura composta venne scoperta proprio nel 1783. Di questo tema si parla in 36 articoli (8,57%), di cui 8 pubblicati nel 1786 (Fig. 3).59 55. E. W. J. Neave, “Chemistry in Rozier’s Journal”, cit., p. 419. I Mémoirs dell’Accademia delle Scienze di Parigi venivano pubblicati con un ritardo medio di tre anni dalla lettura. 56. Per un’analisi dettagliata per argomenti, si veda E. W. J. Neave, “Chemistry in Rozier’s Journal”, in Annals of Science, 6, 1948-1950, pp. 416-421; ibid., 7, 1951, pp. 101-106, pp. 144-148, pp. 284-299, pp. 393-400; ibid., 8, 1952, pp. 28-45. 57. F. Abbri, Le terre, l’acqua, le arie. La rivoluzione chimica del Settecento, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 127-130. 58. A. L. Lavoisier, Opuscules physiques et chimiques, Durand-Didot-Esprit, Paris, 1774; Id., Opuscoli fisici e chimici, a cura di M. Ciardi e M. Taddia, Bononia University Press, Bologna, 2005. 59. P. A. Adet, “Lettre à Ingen-Housz sur la decomposition de l’eau”, in Observations sur la Physique, 28, 1786, pp. 436-441; J. C. de la Métherie, “Réflexions sur la lettre précédente”, ibid., pp. 442-446; C. L. Berthollet, “Lettre à de la Métherie sur la composition de l’eau [17 luglio 1786]”, in Observations sur la Physique, 29, 1786, pp. 138-139; J. C. de la Méherie, “Réflexions sur la lettre précédente”, ibid., pp. 140-142; J. H. Hassenfratz, 3. Distribuzione degli argomenti nel Journal de Physique, 1771-1800. 86 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 87 Dal 1787 la controversia sulle nuove scoperte chimiche si arricchì delle numerose polemiche sulla nomenclatura. I lavoisieriani si rifiutarono di mettere in discussione la validità del loro sistema, intervenendo solo in risposta alle critiche più serie. D’altra parte, nel 1789 Lavoisier e i suoi collaboratori avevano iniziato la pubblicazione delle Annales de Chimie, dove le loro scoperte e il consolidamento progressivo della nuova chimica avevano trovato un loro spazio prestigioso. Dal 1786 nel primo numero di ogni anno Jean Claude de la Métherie pubblicò un “Discours préliminaire” in cui riassumeva le scoperte fatte nei dodici mesi trascorsi. Jean Claude de la Métherie era fermamente contrario alla nuova chimica e, grazie ai suoi privilegi di curatore, non perdeva occasione per esporre le sue critiche.60 Nel gennaio 1788 comparve un articolo in cui il traduttore utilizzava i nomi della nuova nomenclatura61 e de la Métherie inserì una nota in cui esprimeva l’intenzione di lasciare invece ogni autore libero di usare la terminologia preferita, ma non mantenne il proposito. Nell’ottobre 1788 de la Métherie scrisse che avrebbe inserito i nomi nuovi nel testo, ma li avrebbe fatti seguire tra parentesi da quelli vecchi, rispondendo così alle lamentele di numerosi lettori.62 Insieme agli attacchi alla nuova chimica contenuti nei “Discourses préliminaires”, de la Métherie si preoccupò di inserire varie lettere analogamente contrarie,63 oltre che dettagliati articoli critici (10 degli 11 articoli totali tra il 1789 e il 1790).64 “Lettre à de la Métherie sur la calcination des métaux dans l’air pur, et la décomposition de l’eau”, ibid., pp. 305-306; la risposta di J. C. de la Métherie si trova ibid., pp. 306-308. 60. M. Crosland, In the shadow of Lavoisier, The Annales de chimie and the establishment of a new science, Alden, Oxford, 1994, pp. 137-151. 61. S. F. Hermbstaedt, “Sur l’acide des pommes ou vinaigre imparfait”, in Observations sur la Physique, vol. 32, gennaio 1788, pp. 57-61. 62. Ibid., 33, ottobre 1788, nota a p. 303. 63. “Extrait de différentes lettres sur la nouvelle Théorie & la nouvelle Nomenclature”, ibid., 35, 1789, pp. 75-76. 64. J. M. de Aréjula, “Réflexions sur la nouvelle nomenclature chimique pour servir d’introduction à la traduction espagnole de cette Nomenclature”, ibid., 33, ottobre 1788, pp. 262-286; E. C. Marivetz, “Lettre à de la Métherie sur la Nomenclature chimique [10 novembre 1787]”, ibid., 32, gennaio 1788, pp. 61-63; B. G. Sage, “Analyse du Spath pesant aëré”, ibid., 32, aprile 1788, pp. 256-260; Id., “Deuxième lettre sur la nouvelle nomenclature”, ibid., 34, gennaio 1789, pp. 66-67; Id., “Troisième lettre sur la nouvelle nomenclature”, ibid., 34, febbraio 1788, pp. 138-142; C. Opoix, “Sur la nouvelle théorie”, ibid., 34, gennaio 1789, pp. 76-78; J. A. de Luc, “Sur la nature de l’Eau, du Phlogistique, des Acides et des Airs”, ibid., 36, febbraio 1790, pp. 144-154; Id., “Sur la chaleur, la Liquéfaction et l’Evaporation”, ibid., 36, marzo 1790, pp. 193-207; Id., “Sur les Vapeurs, les Fluides aériformes et l’Air atmosphérique”, ibid., 36, aprile 1790, pp. 276-290. 88 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA Anche i fluidi imponderabili trovarono ampio spazio nelle pagine del giornale (41 articoli, il 9,76% del totale). In particolare, si diede rilevanza al dibattito sull’esistenza o meno del flogisto e sulla natura del calore. Ben 13 di quei 41 articoli comparvero tra il 1788 e il 1790, gli anni più intensi del dibattito sul flogisto in Francia. Inoltre, si pubblicarono anche articoli sulla natura e sugli effetti della luce e dell’elettricità. Infine, anche i 39 articoli sugli acidi (9,28% del totale) 65 erano in linea con le convinzioni di de la Métherie: nemmeno la teoria dell’acidità lavoisieriana basata sull’ossigeno era accettata dal curatore. Gli articoli su temi riconducibili dagli storici alla rivoluzione chimica subirono un crollo quasi verticale tra il 1790 e il 1793, per risalire nel 1799 e calare di nuovo nel 1800 (Fig. 4). Questo calo di interesse si spiega con la concorrenza delle Annales de Chimie e con l’ostinazione dimostrata da de la Métherie nel difendere l’esistenza del flogisto. Dal 1789 anche la qualità degli articoli di chimica pubblicati nelle Observations cominciò a diminuire. Gli autori più assidui divennero Balthazar Georges Sage e Jean André de Luc, antilavoisieriani e interessati alla mineralogia e alla teoria della terra, piuttosto che ai temi teorico-sperimentali dei chimici. Gli articoli provenienti da altri paesi europei arrivavano in particolare dalla Germania e trattavano spesso di metallurgia e mineralogia: in molti casi si trattava di estratti dai Chemische Annalen di Crell. Nel 1794 le Observations divennero il Journal de physique, de chimie et d’histoire naturelle et des arts e lo storico Maurice Crosland ha evidenziato come la parola chimie appaia esplicitamente nel titolo di questa testata per la prima volta, probabilmente perché proprio nel 1794 le “rivali” Annales de chimie sospesero la pubblicazione (fino al 1797).66 In realtà anche il Journal de Physique non uscì negli anni tra il 1795 e il 1797, subendo le stesse limitazioni alla libertà di stampa che avevano colpito la testata rivale. Tra il 1771 ed il 1800 la presenza italiana nel Journal de Physique conta 33 autori, per un totale di 73 tra articoli e recensioni, corrispondenti al 17,38% dei 420 articoli presi qui in esame. Una presenza di tutto rispetto se si considera che, com’è ovvio, la presenza più importante era quella francese (50% degli articoli), seguita da quella di Gran Bretagna e Irlan65. Di questi 7 furono pubblicati nel 1786 (spesso provenienti dal giornale di Crell) e 6 nel 1790 (in particolare sull’acido nitroso e sull’acido marino deflogisticato. 66. Crosland, In the shadow of Lavoisier, cit., p. 142. 4. Presenza nel Journal de chimie di temi rivelanti nel contesto della “rivoluzione chimica”, 1771-1800. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 89 90 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA Gran Bretagna e Irlanda Francia Germania e Austria Svizzera Belgio e Olanda Svezia Altro 5. Distribuzione geografica dei contributi pubblicati sul Journal de Physique, 1771-1800. Nel grafico non è rappresentata l’Italia poiché, come precisato all’inizio, tutti gli italiani pubblicati sul giornale sono stati presi in esame. Per avere un quadro più realistico della geografia dei collaboratori al Journal de Physique è necessario eliminare dal totale il dato relativo agli italiani, che altrimenti risulterebbero sovra rappresentati rispetto agli autori di altri paesi. da (15%), Germania e Austria (11%), cui seguivano Belgio, Olanda, Svizzera e Svezia (Fig. 5). L’analisi quantitativa degli argomenti degli articoli pubblicati dagli italiani o dei libri italiani recensiti è di pochi punti superiore alle percentuali relative agli ambiti di interesse del giornale in generale; quelli sulle arie dominano in assoluto, arrivando a 17 (23,28% a fronte di un 20,95% del totale del Journal), seguiti da quelli sui fluidi imponderabili che sono 9 (12,32%, a fronte di un 9,36% del totale del Journal), mentre quelli sulla chimica dei sali, che sono 7, rappresentano il 9,58% (a fronte del 7,14% del totale del Journal). Gli studi sulla natura dell’acqua, che sono 5, sono invece in percentuale inferiore (6, 84% a fronte dell’8,57% del totale del Journal). Come già detto, nei primi anni Settanta del Settecento la rivista pubblicò soprattutto articoli riguardanti lo studio delle nuove arie. Per esempio, nel 1772, accanto alle memorie di Macquer, Cadet, Lavoisier e Brisson sulla combustione del diamante,67 apparve anche quella di Gio67. P. J. Macquer, L. Cadet, A. L. Lavoisier, “Resultat de quelques expériences faites sur le diamant [29 aprile 1772]”, in Introduction aux Observations sur la Physique, 2, maggio 1772, pp. 108-111; L. Cadet, “Expériences et observations chimiques sur le diamant”, ibid., 2, settembre 1772, pp. 401-408; “Mémoire lu par M. Macquer, à la Séance publique LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 91 vanni Francesco Cigna sulla causa di morte degli animali in un recipiente chiuso.68 Nell’ottobre del 1775 Rozier pubblicò le ricerche sull’aria fissa di Felice Fontana 69 e una lettera di Landriani, dove il milanese descriveva il suo nuovo eudiometro.70 Anche i libri di autori italiani di cui si diede notizia tra il 1776 ed il 1778 riguardavano le arie: uno di Nicola Andria,71 uno di Fontana72 e la traduzione in lingua francese delle lettere di Volta sull’aria infiammabile delle paludi.73 Sul Journal de Physique le ricerche di Volta non furono soltanto oggetto di una recensione nella sezione “Novelle letterarie”, ma anche di un “Précis” più dettagliato nei numeri di febbraio e marzo 1778.74 Inoltre, furono pubblicate le due famose lettere di Volta a Priestley e una di Senebier a Volta sulla combustione dell’“aria infiammabile” e sull’eudiometria.75 Sempre verso la fine degli anni 1770, si rinnovò l’interesse di Rozier per gli studi italiani sulla fisiologia della respirazione. Fu così pubblicata una lunga memoria del medico napoletano Michele Troja sugli animali soffocati 76 e uno studio di Pietro Moscati sul sangue e sul calore animale.77 de l’Académie Royale des Sciences, le 14 Septembre 1772, sur des expériences faites en commun, au foyer des grands verres ardens de Tschirnausen, par MM. Cadet, Brisson & Lavoisier”, ibid., 2, dicembre 1772, pp. 612-616. 68. G. F. Cigna, “Dissertations sur les causes de l’extinction de la lumière d’une Bougie, & de la mort des Animaux renfermés dans un espace plein d’air”, ibid., 2, maggio 1772, [pubbl. 1777], pp. 84-105. 69. F. Fontana, “Recherches optiques sur l’air fixe”, ibid., 6, ottobre 1775, pp. 280-289. 70. M. Landriani, “Lettre à l’Auteur de ce Recueil”, ibid., 6, ottobre 1775, pp. 315-316. 71. N. Andria, “Lettera sull’aria fissa”, ibid., 8, novembre 1776, p. 416. 72. F. Fontana, “Recherches physiques sur la nature de l’air nitreux et de l’air dephlogistiqué”, ibid., 9, gennaio 1777, p. 75. 73. A. Volta, Lettere sull’aria infiammabile nativa delle paludi, recensione alle traduzioni francesi di Treitz, Strasbourg, e di Ruault, Paris, con note, ibid., 11, gennaio 1778, p. 89. 74. “Précis des Lettres de M. Alexandre Volta sur l’Air inflammable des Marais”, ibid., 11, febbraio 1778, pp. 152-158; ibid., marzo 1778, pp. 219-229. 75. A. Volta, “Sur l’inflammation de l’Air inflammable mêlé à l’Air commun dans des vaisseaux fermés, et sur les Phénomènes que presentent sa décomposition et la diminution qu’il produit dans l’Air respirable, avec lequel on le mêle”, ibid., 12, novembre 1778, pp. 356-373; Id., “Deuxième lettre à Priestley […]”, ibid., 13, aprile 1779, pp. 278-303; J. Senebier, “Lettre à M. Volta”, ibid., pp. 303-306. Su questi temi, si veda R. Seligardi, “Volta and the synthesis of water: Some reasons for a missed discovery”, in Nuova Voltiana. Studies on Volta and his Times, cit., pp. 33-48. 76. M. Troja, “Mémoire sur la mort des animaux suffoqués par la vapeur du charbon, allumé, et sur les moyens pour les rappeler à la vie”, in Observations sur la Physique, 11, febbraio 1778, pp. 173-183; ibid., marzo 1778, pp. 212-219; ibid., aprile 1778, pp. 297-311; ibid., giugno 1778, pp. 469-493. 77. P. Moscati, “Nouvelles expériences et observations sur le sang et l’origine de la chaleur animale”, ibid., 11, maggio 1778, pp. 389-400. 92 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA Inoltre, comparvero due importanti studi di Felice Fontana sugli acidi organici78 e sugli alcali, in cui Fontana stabiliva che l’acido nitroso era composto di aria deflogisticata e flogisto e suggeriva un metodo nuovo per determinare il peso assoluto delle arie “artificiali”.79 Rozier pubblicò anche gli studi di Fontana sulla presunta conversione dell’acqua in terra, in cui Fontana confermava quanto già stabilito da Lavoisier, cioè che la terra derivava dal vetro del recipiente usato nell’esperimento.80 Fu pubblicato anche uno studio sull’aria estratta da diverse acque tra cui quella della Senna,81 esperimenti fatti a Parigi da Fontana sotto la direzione di Ingen Housz. Inoltre, Rozier pubblicò la lettera di Fontana a Priestley in cui l’italiano descriveva il suo eudiometro.82 Il Journal pubblicò inoltre la memoria letta da Fontana alla Royal Society l’11 maggio 1779 dove si mettevano a confronto le teorie di Priestley e di Scheele sull’aria infiammabile e si raccontavano le conseguenze derivanti all’autore in seguito alla respirazione di questa aria.83 Il nome italiano più presente nelle pagine del Journal fu dunque quello di Felice Fontana, con 15 articoli pubblicati tra il 1775 e il 1788. Seguiva Morozzo con 5 articoli e Brugnatelli, Giobert, Landriani e Vaccà Berlinghieri con 4 articoli ciascuno. Inoltre, nel decennio 1775-1785, 4 interventi furono dedicati al lavoro di Marsilio Landriani. Dapprima Rozier pubblicò una lettera di Priestley a Landriani, relativa alle sue ricerche sulla vegetazione e sull’emissione di ossigeno dalla “materia verde”.84 Nel giugno del 1782 furono recensiti gli Opuscoli fisico-chimici di Landriani, evidenziando come il milanese ritenesse l’acido dell’aria fissa quell’acido universale da tempo ricercato dai chimici.85 A tale proposito, nel volume successivo fu pubblicata una memoria in cui Landriani 78. F. Fontana, “Sur la nature de l’acide des Animaux, des Végétaux & des Substances gommeuses et résineuses, et sur la nature de l’acide des Fourmis, & de quelques autres Substances animales”, ibid., 12, luglio 1778, pp. 64-75; ibid., settembre 1778, pp. 169-189. 79. F. Fontana, “Expériences sur l’Alkali fixe végétal, & sur l’Alkali minéral”, ibid., 12, novembre 1778, pp. 376-391; in part. p. 388. 80. F. Fontana, “Mémoir sur la conversion de l’eau en terre”, ibid., 13, marzo 1779, pp. 161-178; Id., “Extrait d’une lettre de M. Fontana à M. Gibelin sur la conversion de l’eau en terre”, ibid., 19, 1782, pp. 396-398. 81. F. Fontana, “Lettre à Priestley [9 febbraio 1779]”, ibid., 13, maggio 1779, pp. 374379. 82. F. Fontana, “Suite de la lettre à Priestley”, ibid., 15, gennaio 1780, pp. 30-35. 83. F. Fontana, “Mémoir sur l’Air inflammable”, ibid., 15, 1780, pp. 99-111. 84. J. Priestley, “Extrait d’une lettre […] à D. Marsiglio [sic] Landriani”, ibid., 13, febbraio 1779, pp. 128-129. 85. M. Landriani, Opuscoli fisico-chimici, Pirola, Milano, 1781, ibid., 19, 1782, p. 489. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 93 sosteneva la possibilità della conversione di tutti gli acidi in uno solo.86 Nel 1785 comparve una memoria di Landriani sul calore latente87 e una sulla decomposizione dell’alcool, studi che lo portarono a ribadire la teoria dell’esistenza dell’acido universale. In questa memoria, Landriani scriveva di aver decomposto l’alcool non facendolo reagire con gli acidi, ma per mezzo di una canna rovente, ottenendo aria infiammabile mescolata ad aria fissa; ne concludeva che la parte flogistica dell’alcool si trasformava in aria infiammabile.88 Questa memoria di Landriani si inseriva in un volume del Journal dedicato alla natura dell’acqua; accanto alla memoria del milanese, infatti, comparivano molti altri studi, come per esempio quelli di Priestley e Cavendish,89 un estratto della memoria di Ferdinando Giorgi e Gaetano Cioni90 e una di Fontana.91 Giorgi e Cioni avevano ripetuto l’esperimento analitico di Lavoisier e Meusnier, ma non avevano ottenuto né idrogeno né ossigeno: usando un calore esiguo, rispetto al forte calore impiegato dai francesi, avevano ottenuto un’aria intermedia, tra la deflogisticata e l’atmosferica. Fontana, invece, era riuscito ad ottenere aria infiammabile, ma le conclusioni cui giungeva con il suo esperimento erano tutte contrarie a Lavoisier.92 Inoltre, l’anno successivo, il Journal pubblicò la recensione al Saggio di Giorgi sulla decomposizione dell’acqua.93 Per quanto riguarda la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, furono pubblicate diverse memorie di autori italiani sulla mineralogia e sull’analisi delle acque minerali. Tuttavia, nel 1789 si diede spazio nuovamente a due teorie del calore che confutavano quella di Lavoisier: una di Carradori, in linea con le posizioni di Crawford,94 l’altra di 86. M. Landriani, “Essai sur la conversion de tous les acides en un seul”, ibid., 20, agosto 1782, pp. 106-112. 87. M. Landriani, “Dissertation sur la chaleur latente […]”, ibid., 26, febbraio 1785, pp. 88-100; ibid., marzo 1785, pp. 197-207. 88. M. Landriani, “Sur la décomposition de l’Esprit de vin & de l’Alkali volatil [estratto di lettera, Milano, 8 agosto 1785]”, ibid., 27, luglio 1785, pp. 63-64. 89. H. Cavendish, “Expériences sur l’Air [letta alla Royal Society il 2 giugno 1785]”, ibid., 27, agosto 1785, pp. 107-116; J. Priestley, “Expériences et observations relatives à l’air et à l’eau [letta alla Royal Society il 4 febbraio 1785]”, ibid., settembre 1785, pp. 167-188. 90. F. Giorgi e G. Cioni, “Extrait des observations Sur l’Analyse que MM. Meusnier et Lavoisier ont faite de l’eau en 1784”, ibid., 27, luglio 1785, pp. 56-60. 91. F. Fontana, “Extrait d’expériences faites sur la décomposition de l’eau”, ibid., 27, settembre 1785, pp. 288-289. 92. Abbri, Le terre, l’acqua, le arie, cit., pp. 317-318. 93. F. Giorgi, “Saggio di naturali esperienze sopra la decomposizione dell’acqua”, in Observations sur la Physique, 28, marzo 1786, p. 232. 94. “Extrait d’un ouvrage qui a pour titre La Theoria [sic] del Calore, en deux volumes”, ibid., 34, aprile 1789, pp. 271-274. 94 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA Leopoldo Vaccà Berlinghieri, contrario a Crawford ma anche a Lavoisier.95 Di Vaccà Berlinghieri, che confutava da un punto di vista fisico tutta la calorimetria di Lavoisier,96 furono pubblicate le memorie sul calore,97 sul flogisto98 e le risposte alle obiezioni mossegli da Hassenfratz nel terzo volume delle Annales.99 Il volume era dunque tutto volto a criticare la nuova chimica: delle 4 pubblicazioni di Vaccà Berlinghieri pubblicate dal giornale, 3 apparvero nel 1789. In particolare dal 1780 il Journal pubblicò numerose memorie di membri dell’Accademia torinese spesso tratte dai Mélanges (poi Mémoirs) dell’Accademia torinese. Si tratta di 20 titoli, il 27,3% del totale degli articoli italiani, in particolare di Morozzo, Saluzzo e Giobert, sulle acque minerali, sui sali, la mineralogia e sulle arie e la respirazione.100 Ricordo che i piemontesi, a esclusione di Giobert, erano tutti flogististi e la loro presenza nelle pagine del Journal si spiega con la politica editoriale di de la Métherie esposta precedentemente (Tab. 1). Per quanto concerne Giobert, la sua prima memoria pubblicata nel Journal, nel 1790, fu quella sulla fosforescenza, dove l’autore seguiva ancora la vecchia nomenclatura.101 In seguito fu recensita e poi data in estratto una sua memoria sull’analisi delle acque di Valdieri,102 in cui 95. Recensione a L. Vaccà Berlinghieri, Esame della teoria del calore di Crawford con qualche nuova congettura sulla stessa materia, ibid., 35, luglio 1789, pp. 77-78. 96. Abbri, Le terre, l’acqua, le arie, cit., pp. 341-342. 97. L. Vaccà Berlinghieri, “Mémoir sur la chaleur”, in Observations sur la Physique, 35, agosto 1789, pp. 113-121. 98. L. Vaccà Berlinghieri, “Mémoir sur la nature du feu et du phlogistique”, ibid., 35, dicembre 1789, pp. 433-441. 99. J. H. Hassenfratz, “Observations relatives à un Mémoir de M. Berlinghieri”, in Annales de Chimie, 3, 1789, pp. 262-265; L. Vaccà Berlinghieri, “Réponse aux observations de M. Hassenfratz”, in Observations sur la Physique, 36, gennaio 1790, pp. 58-61. 100. Sugli scienziati piemontesi, G. Pedrocco, “Scienziati piemontesi nell’evoluzione chimica settecentesca”, in G. C. Calcagno, V. Pallotti, G. Pedrocco, (a cura di) Scienze e tecnologie in Europa nell’età moderna, CLUEB, Bologna, 1979, pp. 15-83; F. Abbri, “De utilitate chemiae in oeconomia reipublicae. La rivoluzione chimica nel Piemonte dell’Antico Regime”, in Studi storici, 30, 2, 1989, pp. 401-433; M. Ciardi, L’atomo fantasma. Genesi storica dell’ipotesi di Avogadro, Olschki, Firenze,1995; B. Maffiodo, I borghesi taumaturghi. Medici, cultura scientifica e società in Piemonte fra crisi dell’Antico Regime ed età napoleonica, Olschki, Firenze, 1996; M. Ciardi, “Medicina, tecnologia civile e militare, filosofia naturale. L’insegnamento della fisica nel Regno di Sardegna”, in Studi settecenteschi, 18, 1998, pp. 217-247; Id., “Dialoghi tra filosofi naturali. Spallanzani, l’Accademia delle Scienze di Torino e la scienza sabauda”, in W. Bernardi, P. Manzini (a cura di), Il cerchio della vita, Olschki, Firenze, 1999, pp. 203-235. 101. G. A. Giobert, “Observations physiques sur le phosphorisme du tartre vitriolé [4 gennaio 1789]”, in Observations sur la physique, 36, aprile 1790, pp. 256-262. 102. Recensione a G. A. Giobert, Des eaux sulphureuses et thermales de Vaudier, in Journal de Physique, 2 [45], novembre 1794, p. 403; Id., “Des eaux sulfureuses et thermales de Vaudier”, ibid., 4 [47], 1798, pp. 197-201. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 95 Giovanni Francesco Cigna Arie Acque Acidi Combustione Respirazione Altro minerali 1 Vittorio Amedeo Gioannetti 2 Giuseppe Angelo Saluzzo 1 Carlo Lodovico Morozzo 3 Giuseppe Maria Urbano Fontana 1 1 1 Costanzo Benedetto Bonvicino Gioacchino Bonaventura Argentero, marchese di Brezé 1 1 1 1 Carlo Antonio Napione 1 Giovanni Antonio Giobert 2 Carlo Giulio e Francesco Rossi 1 2 Tabella 1. Membri dell’Accademia delle Scienze di Torino con articoli pubblicati sul Journal de Physique. Giobert descriveva il proprio eudiometro a fosforo, criticato tuttavia dal “Redacteur” perché non assorbiva completamente l’ossigeno contenuto nel campione da analizzare. Inoltre, fu recensita la traduzione italiana della versione francese dell’opera di Poerner sull’arte tintoria alla quale Giobert aveva aggiunto delle note.103 Da quanto si è visto, fino alla metà degli anni Ottanta Felice Fontana fu percepito in Francia come il più autorevole chimico italiano, un’autorità a livello internazionale e per questa ragione fu spesso presente nel giornale. Circa altri autori, invece, la loro pubblicazione appare dipendere soprattutto dagli interessi dei curatori: si scelsero infatti prevalentemente autori in grado di appoggiare la campagna contro la nuova chimica condotta da de la Métherie. Morozzo era e rimase un flogistista e diede importanti contributi agli studi sulle arie dal punto di vista teorico in linea con le convinzioni del curatore, mentre Vaccà Berlinghieri aveva condotto uno studio sul calore alternativo alla teoria lavoisieriana del calorico. Landriani manteneva una fitta corrispondenza con vari scienziati in tutta Europa, utile al giornale per aggiornare i lettori circa quanto accadeva fuori di Francia. Brugnatelli e Giobert erano invece autori di ricerche di contenuto sperimentale e applicativo. 103. Recensione a K. W. Poerner, Istruzioni intorno all’arte tintoria, particolarmente delle lane, accresciuta con annotazioni di Desmarets, Berthollet e Giobert, Torino, 1796, ibid., 2 (45), novembre 1794, p. 403 (originale: K. W. Pörner, Chymische Versuche und Bemerkungen zum Nutzen der Farbekunst, Leipzig, 1772, 3 v.). 96 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA In generale, il Journal recensì 15 opere di autori italiani (le recensioni sono il 20,54% della presenza italiana). Tra le recensioni e le memorie pubblicate negli anni 1788 e 1789 ci fu un discreto intervento di italiani (7 presenze in entrambi gli anni, cioè il 19% del totale degli italiani); questi lavori non mettevano in discussione il vecchio sistema di chimica e a volte lo difendevano esplicitamente. Il caso di de la Métherie presenta dunque forti analogie con quello di Brugnatelli: dopo un primo periodo in cui si era lasciato spazio sia a posizioni a favore sia a quelle contrarie alla nuova teoria chimica, le successive scelte editoriali risentirono fortemente delle convinzioni dei curatori. Gli italiani e le Annales de Chimie Le Annales de chimie ou recueil de mémoires concernant la Chimie et les Arts qui en dépendent furono fondate da Lavoisier e dai suoi collaboratori nel 1789, con lo scopo di diffondere il proprio lavoro innovativo in chimica, ma con un occhio rivolto anche alla farmacia, grazie alla presenza nella redazione di Antoine François Fourcroy.104 La prima serie, quella che qui più ci interessa, fu pubblicata con cadenza mensile dal 1789 al 1804, con una interruzione tra il 1794 e il 1797 causata delle limitazioni alla libertà di stampa imposte dalla rivoluzione.105 Tra il 1789 ed il 1802 furono pubblicati 44 volumi delle Annales nei quali gli articoli considerati rilevanti ai fini di questa ricerca furono soltanto 68, una media di 1,54 per volume. Questa media, così bassa se confrontata con quella del Journal de Physique (8,23 articoli per volume), si spiega con la politica editoriale delle Annales, nate per consolidare l’autorità della nuova chimica, non certo per farne oggetto di dibattito. Ben 13 articoli dei 68 scelti (il 19,11%) sono di argomenti difficilmente classificabili secondo le categorie fin qui adottate. Se a queste si aggiun104. La redazione era originariamente composta da L. B. Guyton de Morveau, A. L. Lavoisier, G. Monge, C. L. Berthollet, A. F. de Fourcroy, P. F. Barone di Dietrich, J. H. Hassenfratz, P. A. Adet. Sul giornale si veda S. Court, “The Annales de Chimie, 1789-1815”, in Ambix, 19, 2, 1972, pp. 113-128; in part. sulla farmacia, si veda S. Court, W. A. Smeaton, “Fourcroy and the Journal de la Société des Pharmaciens de Paris”, ibid., 26, 1, 1979, pp. 39-55; J. Simon, “The chemical revolution and pharmacy: a disciplinary perspective”, ibid., 45, 1, 1998, pp. 1-13. 105. Crosland, In the shadow of Lavoisier, cit. in part. per quanto riguarda le Annales, pp. 152-179. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 97 gono le memorie strettamente applicative e quelle sugli strumenti, si arriva al 25% degli articoli totali qui considerati. Un dato che conferma come i fondamenti teorici della nuova chimica fossero ormai dati per certi e si fosse dunque giunti, per usare il gergo degli storici, a una fase di scienza normale, non più da discutere e mettere in discussione, ma da esplorare in ogni direzione (Fig. 6). Nei primissimi anni di vita delle Annales, le notizie concernenti la ricerca chimica svolta in Italia erano riportate indirettamente, tramite gli estratti che Crell dava dei periodici di Brugnatelli; successivamente si cominciarono a pubblicare estratti dai Mémoirs dell’Accademia di Torino e dalle Memorie della Società Italiana,106 ma solo relative agli argomenti strettamente chimici. Infine, le Annales iniziarono a pubblicare estratti dagli Annali di Chimica di Brugnatelli. Si ha dunque una prevedibile prevalenza di articoli di autori francesi (39%), seguiti da quelli di Germania-Austria (23%) e Belgio-Olanda (19%). Per quanto riguarda gli italiani, ho contato 13 autori, per un totale di 38 articoli, il 55,88% del totale (Fig. 7). Questo dato importante si spiega con le due polemiche (quella sui nuovi metalli e quella sulla combustione del fosforo) che, come vedremo, trovarono spazio sulle Annales e di cui furono protagonisti alcuni chimici italiani. Nel 1791 fu pubblicato l’estratto di un articolo congiunto di Matteo Tondi107 e Anton Ruprecht, dagli Annalen di Crell, in cui si esponeva un procedimento per ridurre i minerali di tungsteno e molibdeno,108 cui faceva seguito una lettera di un Andrea o Antonio Savaresi che contestava il procedimento.109 La controversia scoppiò in maggio: gli allievi di Tondi e Ruprecht esposero i nuovi risultati dei loro maestri, i quali dichiaravano di aver estratto nuovi metalli da alcune terre non ancora decomposte.110 Avevano anche dato loro un nome: dalla barite avevano estratto il borbonium; dalla magnesia l’austrum, dalla calce il parthenium, 106. Memorie di matematica e fisica della Società Italiana, edite dal 1782, cadenza biennale, curate da Anton Maria Lorgna. 107. Abbri, “La chimica italiana dalle origini ad Avogadro”, cit., pp. 405-406; Id., “Filosofia chimica e Scienza naturale nel Meridione”, in P. Nastasi (a cura di), Atti del convegno Il Meridione e le scienze (secoli XVI-XIX), Palermo, 14-16 maggio 1985, Palermo, 1986, pag. 121. 108. “Procédé de MM. Ruprecht & Tondy [sic], pour réduire les Mines de Tungstène & de Molybdène”, in Annales de Chimie, 8, 1791, pp. 3-9 109. A. M. Savaresi, “Lettre à M. Fourcroy [Schemnitz, 26 novembre 1790]”, ibid., 8, 1791, pp. 9-16. 110. Estratto di una lettera di Microszewski e Bienkowski da Schemnitz, ibid., 9, 1791, pp. 51-53. 6. Gli argomenti trattati nelle Annales de Chimie, 1789-1804. 98 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 99 Gran Bretagna e Irlanda Francia Germania e Austria Belgio e Olanda Altro 7. Provenienza geografica dei contributi alle Annales de Chimie, 1789-1802. Analogamente a quanto precisato prima circa il Journal de Physique, il dato significativo sulla geografia dei contributi relativi alla rivoluzione chimica richiede lo scorporamento degli italiani. dall’allumina l’apulum e dall’acido boracico il bornium. I nomi erano un omaggio ai paesi d’origine dei due scienziati, ma anche al maestro di Ruprecht, Ignaz von Born. Gli esperimenti erano stati rifatti anche davanti ai savants della capitale austriaca e confermati dagli allievi di Tondi e Ruprecht. Il dibattito vide coinvolti Martin Heinrich Klaproth, Nicolas Joseph Jaquin e il collega di Tondi, Savaresi, e si concluse con la smentita della pretesa scoperta: i nuovi metalli erano in realtà composti di siderite (fosfuro di ferro). Le pubblicazioni, consistenti in memorie e lettere, relative alla vicenda furono 8, pubblicate in 4 diversi volumi del 1791, un fatto che spiega l’alto numero – ben 10 – di articoli sui metalli, il 14,7% del totale. L’ampio spazio concesso a questa vicenda dalle Annales, rispetto al Journal de Physique 111 o gli Annali di Brugnatelli, si spiega con le necessità della redazione di raccogliere molto materiale dalle varie branche della disciplina, quindi anche dalla mineralogia. Inoltre, l’esito di questa piccola controversia era utile per ribadire la correttezza del metodo lavoisieriano di analisi dei composti, che andava applicato con rigore e cautela, ciò che Tondi e Ruprecht non avevano fatto. Il chimico italiano più citato del 1791 sulle pagine delle Annales fu Giovanni Antonio Giobert che, proprio in quell’anno, iniziò a pubblica111. F. Tihavsky, “Mémoir sur les métaux retirés des différentes terres”, in Observations sur la Physique, 38, febbraio 1791, pp. 208-225. 100 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA re articoli originali e, dall’anno successivo, divenne un collaboratore assiduo delle Annales, fornendo anche gli estratti dagli Annali di Brugnatelli e non mancando di criticare gli articoli di Carradori là pubblicati. Come già ricordato, dal 1794 al 1797 le Annales furono costrette a sospendere la pubblicazione; pertanto, nei primi volumi del 1797 ci si preoccupò di dare notizia degli eventi più rilevanti avvenuti in campo scientifico durante i tre anni di forzato silenzio. Nel 1797 un nuovo corrispondente dall’Italia fu Gian Battista Venturi,112 che curò per le Annales anche gli estratti dalle Philosophical Transactions della Royal Society.113 Il volume del 1797 fu dedicato alla polemica sulla combustione del fosforo generata dagli esperimenti di Göttling. Si pubblicarono l’esame sperimentale di Fourcroy e Vauquelin114 e una lettera di Van Mons a Brugnatelli, tradotta da Venturi,115 il quale aggiunse una sua nota nella quale faceva l’apologia della nuova chimica e del metodo dei francesi, difendeva la teoria dell’acidità basata sull’ossigeno e, infine, annunciava l’opera di Spallanzani relativa alla questione del fosforo.116 Venturi poi dava un estratto di questa opera.117 In seguito, le Annales tradurranno anche le obiezioni contro Spallanzani formulate da Carradori.118 Le osservazioni di Brugnatelli in merito alla questione della combustione del fosforo non arrivarono alle Annales tramite Venturi (amico e conterraneo di Spallanzani, avverso a Brugnatelli), bensì grazie a Van 112. G. B. Venturi, Autobiografia. Carteggi del periodo elvetico (1801-1803), a cura di W. Spaggiari, Studium Parmense, Parma, 1984. 113. La notizia della collaborazione di Venturi fu annunciata in Annales de Chimie, 22, 1797, nota a p. 228. 114. A. F. Fourcroy, N. Vauquelin, “Examen des éxpériences faites en Allemagne sur la prétendue combustion dans le gaz azote etc., et des résultats qu’on en a tirés”, ibid., 21, an 5, 1797, pp. 189-220. 115. J. B. Van Mons, “Observations nouvelles sur la propriété d’entretenir la combustion que Goettling, professeur à Jena, prétend trouver dans le Gaz azote”, ibid., 22, an 5, 1797, pp. 221-227. 116. [G. B. Venturi], “Addiction du Traducteur”, ibid., 21, an 5, 1797, pp. 228-230; L. Spallanzani, Chimico esame degli esperimenti del Sig. Gottling Professore a Jena sopra la luce del fosforo di Kunkel osservata nell’aria comune, ed in diversi fluidi aeriformi permanenti, nella qual occasione si esaminano altri fosfori posti dentro ai medesimi fluidi, e si cerca se la luce solare guasti il gaz ossigeno, siccome pretende questo Chimico, Società Tipografica, Modena, 1796. 117. L. Spallanzani, “Examen chimique des expériences de M. Goettling sur la lumière du Phosphore dans les différens gaz, etc”, in Annales de Chimie, 22, an 5, 1797, pp. 246-257. 118. G. Carradori, “Objections contre l’opinion du Profes.r Spallanzani, sur la cause du luisant des Phosphores naturels, communiquées à Mr. Jean Fabbroni [… Prato, 5 aprile 1797]”, ibid., 24, an 6, 1797, pp. 216-225. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 101 Mons.119 Nonostante il belga condividesse in parte la nomenclatura di Brugnatelli, tradusse la memoria utilizzando la nomenclatura francese ufficiale e delegando la spiegazione di quella riformata alle note.120 Infine, nel 1798 Guyton de Morveau pubblicò una disamina delle varie proposte e critiche alla nuova nomenclatura provenienti da Stephen Dickson, Juan Manuel Aréjula, e Brugnatelli.121 Circa quest’ultimo, Guyton scrisse che la denominazione “termossigeno” serviva solo ad allungare inutilmente il nome ossigeno, sottolineando allo stesso tempo le difficoltà insite nell’istituire una scala delle proporzioni di calorico con cui l’ossigeno si univa nei differenti stati e nell’indicarne le variazioni attraverso dei coefficienti.122 Nonostante le diverse posizioni circa l’uso della nomenclatura, i curatori delle Annales pubblicarono numerose memorie sperimentali di Brugnatelli, riconoscendo la qualità delle sue ricerche.123 Anche i primi due volumi degli Elementi di chimica di Brugnatelli ricevettero una recensione favorevole: d’altra parte, dopo la conclusione della questione del fosforo,124 Brugnatelli si era “ravveduto” e aveva adottato in parte la nuova terminologia. Gli articoli sulla nomenclatura furono 7 (il 10,29%), così come quelli sulla combustione. Come si è visto, questi argomenti erano strettamente attinenti le polemiche sul fosforo e sommando i due dati si arriva al 20,58%, a testimonianza della grande attenzione dedicata alla questione. Riassumendo, i nomi italiani più presenti nelle pagine delle Annales furono quelli di Brugnatelli, con 8 pubblicazioni e di Giobert, con 7, seguiti da Carradori, con 5. Tra gli argomenti trattati dagli scienziati italiani, 5 articoli su 7 parlavano di combustione e/o calcinazione, mentre 6 su 10 riguardavano i metalli. Ben 10 articoli su 13 erano relativi ad argomenti vari, non facilmente classificabili tra quelli classici della rivoluzione chimica. La presenza italiana registra un picco nel 1791, con 8 articoli (di cui 3 di Giobert e 3 di Savaresi), nel 1797 gli articoli pubblicati furono 7 (di 6 autori diversi che affrontavano il caso Göttling) e 119. L. V. Brugnatelli, “Observations sur le Phosphore”, ibid., 24, an 6, 1797, pp. 57-77. 120. Ibid., nota a p. 59. 121. L. B. Guyton de Morveau, “Examen de quelques critiques de la nomenclature des chimistes français”, in Annales de Chimie, 25, an 6, 1798, pp. 205-215. 122. Guyton de Morveau, “Examen de quelques critiques […]”, cit., p. 211. 123. Generalmente, però, i termini di Brugnatelli erano tradotti in lingua francese, seguendo la nomenclatura ufficiale. 124. Annales de Chimie, 27, an 6, 1798, pp. 110-112. 102 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA 6 nel 1798 (5 del solo Brugnatelli). Questi picchi si spiegano con la polemica del 1791 sui regoli metallici e con la necessità di recuperare gli anni in cui la pubblicazione era stata sospesa nel 1797, inserendo qui anche la questione del fosforo. Lo stesso vale in generale circa l’andamento degli articoli qui considerati rilevanti sulle Annales: si hanno 13 articoli nel 1791 e 11 nel 1797 (Fig. 8). 8. Numero degli articoli rilevanti nel contesto della nuova chimica pubblicati sugli Annales de Chimie, 1789-1802. Dal 1797 Van Mons, che collaborava con il giornale dal 1792, era divenuto a pieno titolo membro della redazione, ma dal 1798 si occupò solo degli estratti di Crell, lasciando quelli degli Annali di Brugnatelli al medico e botanico Henri Tollard. Nel 1801 Van Mons lasciò le Annales per fondare il Journal de Chimie et de Physique, che uscì in sei volumi, fino al 1804.125 A parere di Crosland la ragione principale di questo abbandono è da ricercare nel rifiuto alla proposta di Van Mons di pubblicare un supplemento mensile alle Annales.126 A mio avviso, invece, il motivo principale – secondario, tuttavia, per Crosland – fu che Van Mons 125. Il titolo del primo volume era Journal de Chimie pour servir de complément aux Annales de Chimie et autres Ouvrages périodiques français de cette science; poi il titolo divenne Journal de Chimie et de physique ou Recueil périodique des découvertes dans les sciences chimiques et physiques tant en France que chez l’étranger. 126. Crosland, In the shadow of Lavoisier, cit., pp. 90-91. LA RIVOLUZIONE CHIMICA / 103 era ora molto più vicino alla teoria termossigena e alla conseguente riforma della nomenclatura di Brugnatelli, incarnando dunque un elemento dissonante in seno alla coterie lavoisieriana, proprio in un periodo in cui le polemiche sulla nuova chimica si stavano attenuando. In ogni caso, Van Mons continuò a fornire alle Annales notizie e traduzioni del lavoro dell’amico pavese, come ad esempio il suo articolo sulla scoperta dell’acido cobaltico.127 La traduzione di questa memoria comparve anche sul Journal de Physique, con una nota di de la Métherie che ne confermava i risultati sperimentali;128 ma sulle Annales essa fu criticata da Darracq,129 che dichiarò il preteso acido scoperto da Brugnatelli essere in realtà arseniato di cobalto disciolto in un eccesso d’acido.130 L’analisi della presenza italiana sulle Annales de chimie fa emergere un quadro diverso rispetto a quello offerto dal Journal de physique: nelle Annales le posizioni degli italiani non sembrano essere state strumentalizzate ai fini della politica del giornale come invece era accaduto nel caso di de la Métherie. Certo, le proposte teoriche e relative alla nomenclatura di Brugnatelli furono osteggiate, ma grazie a Van Mons, Crell, Giobert e Venturi gli italiani trovarono anche nelle Annales un trampolino per l’Europa. Ovviamente, sia Giobert sia Venturi, poiché seguaci della nuova chimica, fungevano da filtro del flusso di notizie provenienti dall’Italia verso la Francia. In questo modo, pochissimi antilavoisieriani trovarono uno spazio nelle Annales, al contrario di quanto accadde invece nel Journal de Physique. Tuttavia, il dibattito sui nuovi regoli metallici e quello sul fosforo dimostrano che queste polemiche ebbero una risonanza europea e che non lasciarono indifferenti i francesi. 127. L. V. Brugnatelli, “Mémoire sur l’ammoniure de cobalt, et sur un acide contenu dans l’oxide gris de ce metal, connu sous le nom de saffre”, in Annales de Chimie, 33, an 8, 1800, pp. 113-124. 128. L. V. Brugnatelli, “De l’acide cobaltique”, in Journal de Physique, 50, Ventose an 8, 1800, pp. 233-235 [estratto dalle Annales de Chimie]. 129. Darracq, “Mémoire sur une nouvelle combinaison reconnue dans le saffre, et que le cit. Brugnatelli a prise pour de l’acide cobaltique”, in Annales de Chimie, 41, an 10, 1802, pp. 66-76. 130. Darracq, “Mémoire sur une nouvelle combinaison […]”, cit., p. 75. Brugnatelli replicò a queste critiche in Annali di Chimica, 19, 1802, pp. 89-94. 104 / LA RIVOLUZIONE CHIMICA Conclusione Nel caso qui preso in esame, i dati quantitativi si sono rivelati utili per una migliore comprensione della presenza del dibatto sulla cosiddetta nuova chimica nei giornali italiani, così come della circolazione a nord delle Alpi dei risultati delle ricerche di alcuni chimici della Penisola. Si scopre così, per esempio, che personaggi solitamente dipinti come secondari nella storia della chimica, come Carradori o Brugnatelli, erano in realtà presi molto sul serio a Parigi: si è visto che Carradori e Brugnatelli ebbero una presenza importante in un giornale come le Annales de Chimie. I dati raccolti, inoltre, mentre confermano ancora una volta l’importanza di Priestley e Fontana sulla scena della chimica europea, fanno emergere, da un lato, come le ricerche sui fluidi imponderabili e gli studi sulle arie fossero elementi centrali della cosiddetta rivoluzione chimica, dall’altro, che la chimica riguardante l’analisi di sali, terre e metalli costituiva la base consolidata della disciplina. In questa sede, com’è ovvio, non si sono potuti analizzare tutti gli articoli pubblicati sui periodici presi in esame e i risultati riportati si basano dunque su una selezione, motivata dai criteri esposti in apertura. Tuttavia, l’analisi quantitativa applicata ai periodici si è confermata uno strumento utile allo studio dell’evoluzione del pensiero del singolo filosofo naturale, così come di un’intera comunità, e dei cambiamenti intervenuti all’interno di una disciplina e dei canali della comunicazione scientifica. Questo studio sembra confermare la necessità di uno spoglio dei periodici scientifici del Settecento e dell’Ottocento, magari indicizzati secondo i criteri della Classificazione Decimale Universale (CDU), un’operazione utile per disporre di una soggettazione standardizzata dei contenuti. Questa, affiancata a un indice degli autori, costituirebbe per gli storici della scienza interessati a ricostruire le reti di comunicazione nazionali e internazionali tra scienziati, uno strumento di straordinaria efficacia. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 105 CONSUETUDINI E PRIVILEGI. IL GOVERNO DELL’INNOVAZIONE NEL REGNO LOMBARDO-VENETO Christian Carletti Introduzione Nella Prefazione del 1839 al primo volume del Politecnico, Carlo Cattaneo annunciava l’intenzione di avviare una pubblicazione che rendesse conto delle cognizioni della scienza che più direttamente interessavano “il campo della Pratica”.1 In particolare si sarebbe trattato delle “Arti produttive e salutari”, strettamente legate alle scienze matematiche e fisiche, ma anche di quelle “sociali e mentali” senza trascurare le “Arti Belle”.2 Lo scopo era di far fronte a quel “bisogno di promuovere […] ogni maniera d’industrie” che appariva “ormai troppo manifesto”.3 Nuovi stimoli non mancavano: l’ordinamento che nel 1838 aveva riformato l’Istituto di Scienze, Lettere e Arti scindendolo nei due poli dell’Istituto Lombardo, con sede a Milano, e dell’Istituto Veneto, con sede a Venezia, e l’autorizzazione del governo all’avvio di due scuole tecniche nelle due città, apparivano a Cattaneo “deboli segni”, che tuttavia incoraggiavano “quello spirito industriale che da qualche tempo si occupa 1. L. Ambrosoli (a cura di), Carlo Cattaneo. Il Politecnico, 1839-1844, Bollati Boringhieri, Torino, 1989, v. 1, p. 7. Della vasta bibliografia su Carlo Cattaneo segnalo, tra gli studi più recenti, G. Armani, Gli scritti su Carlo Cattaneo: bibliografia 1836-2001, Casagrande Editore, Lugano, 2001; L. Cafagna, N. Crepax, Atti di intelligenza e sviluppo economico. Saggi per il bicentenario della nascita di Carlo Cattaneo, Il Mulino, Bologna, 2001; L. Colucci, Carlo Cattaneo nella storiografia: studi su Risorgimento e federalismo dal 1869 al 2002, Giuffrè, Milano, 2004; M. C. Fugazza, “Cattaneo e il mondo imprenditoriale milanese prima del 1848”, in Studi Storici, 43, 2, 2002, pp. 1029-1064; C. G. Lacaita, R. Gobbo, A. Turiel (a cura di), La biblioteca di Carlo Cattaneo, Casagrande Editore, Bellinzona, 2003; C. G. Lacaita, R. Gobbo, E. R. Laforgia, M. Priano (a cura di), “Il Politecnico” di Carlo Cattaneo. La vicenda editoriale, i collaboratori, gli indici, Casagrande Editore, Milano-Lugano, 2005. 2. Ibid., pp. 8-9. 3. Ibid., p. 10. 106 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI a propagare l’uso dei combustibili fossili, i più nuovi metodi d’illuminazione, e i primi abbozzi di studj sulle strade ferrate”.4 Un paio d’anni dopo, sempre a Milano, anche il fisico e imprenditore Alessandro Majocchi stendeva il Proemio al primo volume di un altro, nuovo periodico: gli Annali di Fisica, Chimica e Matematiche. L’obbiettivo, nelle dichiarazioni del curatore, era mettere a disposizione dei lettori un giornale che raccogliesse i principali studi di autori italiani in ambito scientifico, tentando di arginare l’inclinazione di molti professori a preferire le pubblicazioni su riviste francesi, che avevano naturalmente il pregio di garantire una più ampia circolazione.5 Per altro verso, tuttavia, gli Annali volevano essere uno strumento per “i direttori [...] e i sovrintendenti alle officine delle arti, i manifattori, i meccanici, e qualunque artefice, la cui professione è in qualsiasi modo subordinata alle scienze chimiche e fisiche”.6 Questi avrebbero trovato negli Annali “un mezzo facile per apprendere quelle cognizioni atte a dare un nuovo perfezionamento ai loro processi ed ai loro prodotti, e ad attivare nuove fabbriche e nuovi rami d’industria.”7 Sia il Politecnico sia gli Annali di Fisica, Chimica e Matematiche erano dunque iniziative che manifestavano una sensibilità crescente nei confronti dei problemi legati allo sviluppo delle attività produttive. In particolare, cresceva l’attenzione verso le invenzioni in campo tecnico. Il Politecnico dava spazio ad annunci sulla messa a punto di nuovi metodi di lavorazione e nuove macchine, oppure rendicontava circa la distribuzione di premi per scoperte recenti. Similmente, in appendice agli Annali di Majocchi, era pubblicato un Bullettino dell’industria meccanica e chimica che mirava a raggiungere il pubblico dei piccoli imprenditori con notizie sulla costruzione di telai, l’installazione di impianti per l’estrazione del ferro o del carbone, fino alle più recenti tecniche galvanoplastiche. 4. Ivi. Sull’Istituto Veneto, si vedano G. Gullino, L’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti: dalla rifondazione alla seconda guerra mondiale (1838-1946), Istituto Veneto di scienze, lettere e arti, Venezia, 1996; Id., La nascita dell’Istituto Veneto e la sua attività sino al termine della dominazione austriaca, in Ingegneria e politica nell’Italia dell’Ottocento: Pietro Paleocapa, Venezia, Stamperia di Venezia, 1990, pp. 67-87. 5. Sul tema si veda il saggio di Raffaella Seligardi in questo libro. 6. G. A. Majocchi, “Proemio”, in Annali di Fisica, Chimica e Matematiche, v. 1, 1841, pp. 3-11, citazione p. 5; corsivi dell’autore. Sugli Annali di Majocchi, si veda C. G. Lacaita, Un’organizzazione della cultura e tecnica italiana nell’età del Risorgimento: Gio. Alessandro Majocchi e gli Annali di fisica, chimica e matematiche, in M. L. Betri, D. Bigazzi (a cura di), Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta, Angeli, Milano, 1996, v. 2, pp. 198-218. 7. Ivi. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 107 Per Cattaneo e Majocchi l’attenzione alle attività di innovazione tecnica era ancorata all’idea di “progresso” e a quella del conseguente, necessario connubio tra le scienze teoriche e la tecnica. Va in ogni caso evidenziato che dalle pagine delle loro riviste emergeva anche l’analisi critica di una situazione economica poco felice, così come l’intento di sopperire alla carenza di intraprendenza nel campo dell’industria mediante l’informazione sulle possibilità di sviluppo. Ora, come vedremo, sia l’esigenza di chiarire che cosa dovesse intendersi per innovazione in ambito industriale, sia la necessità di mantenere efficiente un sistema d’informazione al riguardo muovevano di pari passo con gli intenti normativi del governo del Regno LombardoVeneto in quegli stessi anni. “Scoperta” – recitava il regolamento sui privilegi approvato nel 1820 – doveva essere considerato “ogni nuovo ritrovato d’una maniera di procedere in operazioni d’industria, che sia stata bensì usata anticamente, ma poi del tutto perduta, o che in oggi adoperata nell’Estero, sia però sconosciuta nel nostro Stato”.8 “Invenzione”, invece, era da intendersi “la produzione di un nuovo oggetto ottenuto con nuovi mezzi, o d’un nuovo oggetto ottenuto con mezzi cogniti, o d’un oggetto cognito ottenuto coll’uso di mezzi differenti da quelli finora adoperati per conseguire lo scopo rispettivo”.9 Per “miglioramento o cambiamento” si intendeva, invece, “ogni aggiunta di qualche apposito meccanismo, metodo o processo d’operazione in un oggetto già precedentemente noto, o privilegiato dalla quale ne ridondi una maggiore perfezione, ovvero un vantaggio economico, sia per l’oggetto che ne forma la scoperta, sia nel modo di ottenerlo”.10 Infine, secondo la legislazione, “per nuovi devono considerarsi le scoperte, le invenzioni, i miglioramenti che non sono conosciuti nello Stato, né per pratica esistente de’ medesimi, né per descrizione contenuta in qualche opera alle Stampe.”11 Si trattava di definizioni generiche che, come nel caso degli annunci pubblicati sul Bullettino di Majocchi, si rivolgevano non solo agli inge8. “Patente Sovrana sulla concessione dei privilegi esclusivi per le scoperte, le invenzioni, ed i miglioramenti in ogni ramo d’industria”, in Collezioni di leggi e di regolamenti pubblicati dall’Imperial Regio Governo delle province venete, tomo 1, 1821, pp. 12-59. Citazione p. 39. Corsivi nel testo. 9. Ivi. 10. Ivi. 11. Ivi. Sul concetto di invenzione rinvio a K. J. Dood, “Pursuing the Essence of Inventions: Reissuing Patents in the 19th Century”, in Technology and Culture, 32, 1991, pp. 9991017; P. O. Long, “Invention, Authorship, Intellectual Property, and the Origin of Patents: Notes toward a Conceptual History”, in Technology and Culture, 32, 1991, pp. 846-884. 108 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI gneri, ma anche a meccanici e artigiani interessati a un sistema che, attraverso il pagamento di una tassa, avrebbe garantito loro il diritto di proprietà su un oggetto nuovo, fosse una macchina o un composto da impiegarsi nella colorazione della seta. Di tale privilegio gli inventori avrebbero potuto disporre in modo esclusivo, usufruendone per un periodo massimo di 15 anni, lasso di tempo durante il quale erano tenuti a riprodurre a scopi di vendita o a impiegare in un processo di produzione l’oggetto stesso. In questo contesto, cresceva dunque l’esigenza di mantenersi aggiornati su oggetti e autori privilegiati. Del resto, era il governo stesso che, per prevenire la reiterazione di scoperte già fatte e limitare i casi di contraffazione, ordinava che l’assegnazione di nuovi privilegi fosse comunicata sulle gazzette locali. Con questo scopo si impiegavano, ad esempio, la Gazzetta di Milano e la Gazzetta privilegiata di Venezia che davano di volta in volta notizia dei privilegi concessi. Inoltre, a partire dagli anni Trenta, in appendice a periodici come le Collezioni delle leggi, istruzioni e disposizioni di massima pubblicate o diramate dalle province venete,12 iniziarono a essere redatti anche elenchi completi che riassumevano schematicamente i privilegi accordati in un certo anno, la durata prevista e il loro stato, la revoca, il rinnovo e così via. Accanto a ingegneri e artigiani, che rappresentavano solo una parte del potenziale pubblico dei giornali di cui stiamo parlando, c’erano poi le grandi manifatture attive in Lombardia, come le filande da seta, la raffineria Azimonti, la fabbrica di ceramiche Richard, le fucine di Giuseppe Badoni e l’officina meccanica Ragazzoni.13 Proprietari, dirigenti e tecnici di quelle manifatture formavano un pubblico differente, ma non estraneo al bisogno di organi di informazione che assolvessero il 12. Collezione delle leggi, istruzioni e disposizioni di massima pubblicate e diramate nelle province venete in oggetti di amministrazione politica, camerale e giudiziaria (divisa in due parti), Milano, 1827-1839. 13. L. Magrini, “Sul non doversi separare la teoria e la pratica nel cercare i progressi dell’industria”, in Giornale dell’I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere e Arti e Biblioteca Italiana, IX, 1856, pp. 355-383; nel saggio si fa riferimento a molte delle fabbriche più attive in Lombardia. Per un’analisi aggiornata si veda S. Licini, Imprenditori in Lombardia tra prima e seconda industrializzazione, in Cafagna, Crepax, Atti di intelligenza e sviluppo economico, cit. Sull’iniziativa economica nella Lombardia e nel Veneto austriaci, si vedano G. Bigatti, La città operosa. Milano nell’Ottocento, Angeli, Milano, 2000; J. Cohen, G. Federico, The Growth of the Italian Economy, 1820-1960, Cambridge University Press, New York, 2001, pp. 1-29; R. Giusti, Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale, Mantova, Accademia virgiliana, 1977; A. Lazzarini, Trasformazioni dell’agricoltura e istruzione agraria nel Veneto, in G. Biagioli, R. Pazzagli, Agricoltura come manifattura, Olschki, Firenze, 2004; M. Psalidopoulos, M. E. Mata, Economic Thought and Policy in Less Developed Europe:19th Century, Routledge, New York and London, 2001. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 109 compito di comunicare quando un privilegio era decaduto o scaduto, se era giunto il momento di usufruirne senza incorrere in denunce per abuso, oppure se i dettagli di una macchina, in precedenza privilegiata, erano divenuti noti rendendo possibile l’utilizzo dei disegni per riprodurla. La legislazione austriaca cercava di agevolare con crescente risolutezza l’impiego di oggetti ex-privilegiati. Con il decreto del 1852 era introdotta una serie di articoli volti a tutelare la possibilità di fruire dei privilegi scaduti, il più importante dei quali era l’imposizione della pubblicazione, dopo il decorso, delle descrizioni dettagliate e dei progetti. Non essendo organi ufficialmente delegati né specializzati allo scopo, giornali come quelli di Majocchi o di Cattaneo non rendicontavano in modo sistematico sui privilegi concessi nel Lombardo-Veneto o nell’Impero d’Austria. Tuttavia, mediante esposizioni critiche curate da esperti del settore, cercavano di sopperire alla necessità di dare notizie anche su invenzioni e scoperte di rilievo effettuate all’estero. Si mirava dunque a offrire un punto di osservazione privilegiato in cui gli stimoli a cercare – anche oltre confine – spunti innovativi fossero alimentati da una solida conoscenza del contesto locale. Qui si sono citati il Politecnico e gli Annali di Fisica, Chimica e Matematiche, ma andrebbero elencati anche il Giornale agrario Lombardo-Veneto, gli Annali universali di statistica, il Giornale dell’ingegnere, architetto ed agronomo, la Biblioteca Italiana. 14 Queste e altre pubblicazioni, seppur in modo parziale, tentavano di assolvere una funzione che, pur non regolamentata dal governo, era da esso promossa e sostenuta e risultava coerente con l’evoluzione degli interventi legislativi in materia di privilegi varati a livello statale. Lo studio della legislazione, che ebbe le sue tappe fondamentali nei decreti del 1820, del 1832 e del 1852, è uno degli elementi che possono contribuire a gettare luce sulle attività di innovazione nel Regno Lombardo-Veneto e me ne occuperò nella prima parte di questo saggio. Si trattava tuttavia di provvedimenti centralizzati, che si rivolgevano a zone dell’Impero austriaco estremamente diversificate e che per questo non sempre andarono incontro in modo adeguato alle esigenze locali. Se è vero, infatti, per quanto concerne il caso del Regno Lombardo14. Per una rassegna della stampa periodica economica lombarda nell’Ottocento si veda F. Della Peruta, E. Cantarella, Bibliografia dei periodici economici lombardi 1815-1914, Angeli, Milano, 2005; si veda inoltre il classico M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Einaudi, Torino, 1980. 110 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI Veneto, che le aspirazioni di alcune élite intellettuali potevano riconoscersi in quella legislazione, è altrettanto certo che, qualora si scelga di analizzare pratiche radicate in specifici contesti sociali, emergono aspetti contraddittori. In particolare, mettendo a confronto la realtà di zone diverse del Lombardo-Veneto, in alcuni casi meno vivaci di altre, si rileva che alcuni degli elementi innovativi introdotti dalle leggi sui privilegi tardarono ad essere accettati e a fatica si amalgamarono con il substrato socio-economico presente. Nella seconda e terza parte di questo saggio considererò alcuni degli aspetti che ponevano le norme varate in tacito conflitto con un ambiente, quello delle accademie, in cui l’invenzione di macchine tardò ad adottare criteri di segretezza, così come ad emanciparsi dalle prassi molto tradizionali di verifica ed esame. Ambizioni queste che erano invece centrali per l’aspirazione del governo austriaco a diffondere un sistema dei privilegi di impianto “semi-liberista”, che fosse cioè regolamentato nei suoi aspetti generali, ma nel contempo aperto alle richieste del mercato e dell’industria. L’ultima parte di questo lavoro, infine, è dedicata all’analisi del caso dell’artigiano-ingegnere Bartolomeo Avesani. Scendendo nei dettagli delle sue invenzioni e prendendo in considerazione i rapporti prodotti dalle commissioni incaricate di testarle, è possibile intravedere, per esempio, i canoni d’efficienza meccanica cui bisognava conformarsi perché fosse riconosciuto il valore commerciale di una macchina. Inoltre, saranno ripercorse le tappe che portarono Avesani ad emergere come inventore: la sua carriera professionale offre un esempio dei network istituzionali in cui si imbatteva chi ambiva a consolidare la propria fama e a procurarsi un pubblico di potenziali acquirenti. La legislazione, 1820- 1852 L’occupazione napoleonica dell’Italia aveva portato a una sostanziale estensione della legislazione francese sui privilegi alla Penisola. I decreti emanati nel 1805 nel Ducato di Parma e Piacenza, nel 1806 nel Regno d’Italia e nel 1810 nel Regno delle Due Sicilie reiteravano la legge francese del 7 gennaio 1791.15 15. M. Vasta, L. Dolza, Tra diffusione e tutela: i paradossi dell’attività innovativa, in V. Marchis (a cura di), Conoscenze scientifiche e trasferimento tecnologico, Einaudi, Torino, 1995, p. 102. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 111 Dopo la Restaurazione, il primo intervento in materia di privilegi a interessare l’Italia fu la Patente Sovrana sulla concessione dei privilegi esclusivi, varata su iniziativa del governo di Vienna nel 1820 e avente validità nel Regno Lombardo-Veneto, oltre che in tutte le province dell’Impero d’Austria. Nel Regno di Sardegna una legge sulle Regie Patenti fu invece approvata nel 1826 e rimase pressoché invariata fino alle leggi sulle privative per invenzioni e scoperte industriali del 1855.16 Per altri interventi di qualche rilievo nel resto d’Italia bisogna far riferimento all’Editto Sovrano del 1833 nel Ducato di Parma, all’editto Sulle dichiarazioni di proprietà per le nuove invenzioni e scoperte in fatto di arti e di agricoltura emanato lo stesso anno nello Stato Pontificio e, solo molto più tardi, all’editto del 1854 volto a regolamentare l’applicazione dei privilegi nel Ducato di Modena. Il decreto napoleonico del 24 giugno 1806, portante il Regolamento sulla proprietà degli Autori di invenzioni e scoperte d’industria, aveva introdotto nel Regno d’Italia il concetto secondo cui ogni scoperta o nuova invenzione è proprietà del suo autore. Com’è stato sottolineato, il riconoscimento di un naturale diritto di proprietà traccia una linea di demarcazione tra il privilège di antico regime, inteso come favore concesso dal sovrano, e il moderno brevet d’invention.17 Ma è vero anche che la distinzione rimase a lungo confusa e tardò ad affermarsi, tanto che nel Lombardo-Veneto preunitario l’innovazione tecnica continuò a essere sostanzialmente regolamentata da un sistema di privilegi.18 Nonostante ciò, la Patente Sovrana del 1820, emanata in seguito all’abrogazione del decreto napoleonico del 1806, tendeva a conservare sul piano legale il diritto di proprietà. Per quanto il testo di questa pri16. Sul sistema dei privilegi nel Piemonte preunitario e per un elenco delle fonti per lo studio dei brevetti in generale si veda V. Marchis, L. Dolza, M. Vasta, I privilegi industriali come specchio dell’innovazione nel Piemonte preunitario, La Rosa, Torino, 1992. Vanno inoltre segnalati M. Ciardi, La fine dei privilegi: scienze fisiche, tecnologia e istituzioni scientifiche sabaude nel Risorgimento, Olschki, Firenze, 1999 e A. Ferraresi, Stato, scienza, amministrazione, saperi. La formazione degli ingegneri in Piemonte dall’antico regime all’unità d’Italia, Il Mulino, Bologna, 2004. 17. Vasta, Dolza, Tra diffusione e tutela, cit., p. 94. 18. Si veda la voce “privilegio” in V. Guazzo, Enciclopedia degli affari ossia Guida Universale per la cognizione e conformazione di qualunque atto per lo sviluppo di qualsiasi affare tanto tra privati come avanti qualunque Autorità od Ufficio, Crescini, Padova, 1853. Si veda inoltre C. M. Belfanti (a cura di), Tecnici, empiristi, visionari: un secolo di innovazione nell’economia bresciana attraverso i brevetti 1861-1960, Grafo, Brescia, 2002; Id., “Guilds, Patents and the Circulation of Technical Knowledge. Northern Italy during the Early Modern Age”, in Technology and Culture, 45, 3, 2004, pp. 569-89. 112 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI ma legge non fosse sempre esplicito in proposito, era chiaro che il privilegiato poteva considerarsi il possessore del prodotto che aveva presentato: gli era infatti consentito di “disporre anche del privilegio stesso, trasmetterlo ad altri mediante vendita, locazione, od altro qualunque siasi modo di alienazione.”19 Un ulteriore elemento di continuità tra il decreto del 1806 e la legge austriaca del 1820 è l’assenza di un apparato normativo volto a regolamentare il controllo sull’efficienza delle nuove invenzioni. Nella Francia di ancien régime la verifica dell’utilità di un’invenzione era un momento chiave nell’iter per la concessione di un privilegio. Dal 1699, infatti, l’Accademia delle Scienze di Parigi era stata incaricata di certificare che le macchine per le quali era presentata richiesta di privilegio fossero realmente nuove ed utili e per quasi tutto il Settecento l’ottenimento di un privilegio rimase subordinato a tale condizione.20 Un mutamento era venuto solo verso la fine del secolo ed emerse da quello stesso dibattito che aveva dato origine alla già citata legge del 7 gennaio 1791. In quell’occasione il Chevalier de Boufflers, incaricato dal Comitato per l’Agricoltura e il Commercio di affrontare la questione dei privilegi, evidenziò come il giudizio sulle prestazioni di una macchina fosse sovente fallace e propose, di conseguenza, la completa eliminazione di ogni prassi di giudizio.21 L’iniziativa ebbe applicazione pressoché immediata e fu estesa alle province italiane. Nel Regolamento per l’esecuzione del Decreto 24 Giugno 1806 si legge che le patenti di invenzione “saranno accordate senza esame preliminare [...] a chiunque vorrà eseguire o far eseguire nel Regno oggetti d’industria fino allora sconosciuti.” 22 Ed è di seguito chiarito che il governo, “nell’accordare una patente d’invenzione senza esame preliminare, non intende garantire in alcun modo né la priorità, né il merito, né il successo d’un’invenzione.” 23 Una precisazione, quest’ultima, di particolare rilievo in quanto spiega come al riconoscimento del diritto di un autore alla proprietà della sua scoperta e alla soppressione di un sistema di giudizio fosse associata una diminuzio19. “Patente Sovrana sulla concessione dei privilegi esclusivi”, cit., p. 25. 20. R. Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution, University of California Press, Berkeley, 1971, p. 23. 21. Ibid., p. 188. 22. “Regolamento per l’esecuzione del Decreto 24 Giugno 1806 sulla proprietà degli Autori d’invenzioni e scoperte in ogni genere d’industria”, in Giornale Italiano, 186, 5 Luglio 1806, p. 747. 23. Ivi. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 113 ne della volontà di controllo sui processi di innovazione da parte del governo.24 D’altro canto, sebbene sorretto da un impianto che oggi definiremmo forse di impronta liberista, il decreto del 1806 prevedeva casi specifici, quali quello in cui l’autore presentasse oggetti di interesse per la salute o la sicurezza pubblica, per cui un esame preliminare sarebbe stato ancora indispensabile. Inoltre, nell’eventualità che l’invenzione o la scoperta fosse “di una utilità generale, ma d’una esecuzione troppo semplice o d’una imitazione troppo facile per istabilirne una commerciale speculazione”,25 all’inventore stesso era concesso di entrare in trattativa con il governo. Rivolgendosi al Ministro dell’interno, grazie alla mediazione delle Prefetture, egli avrebbe ottenuto la possibilità di dimostrare i vantaggi che recava l’oggetto proposto e, una volta comprovata l’utilità, avrebbe avuto il diritto a ricompense in denaro cui erano destinati alcuni fondi per l’incoraggiamento dell’industria. La considerazione di casi in cui una verifica rimaneva comunque necessaria, così come l’esistenza stessa di fondi per l’industria alimentati dalla tassazione imposta agli inventori, e non da ultimo il complesso di articoli con cui il decreto si proponeva di arginare e punire gli abusi, erano evidentemente i residui dell’inclinazione del governo a conservare nonostante tutto alcuni margini di controllo. L’entrata in vigore della Patente Sovrana del 1820 portò a un ulteriore affievolimento di questa tendenza. Secondo il testo della legge, chi ambiva a ottenere un privilegio esclusivo per qualche scoperta o invenzione era tenuto a presentare presso il Capitanato Circolare del luogo di residenza una descrizione sigillata. Tale descrizione, contenente i dettagli dell’oggetto in questione, avrebbe dovuto rispettare i consueti canoni di chiarezza espositiva ed escludere qualsiasi tentativo di occultamento. Ad essa era inoltre possibile aggiungere “disegni o modelli” e tuttavia, si legge, “questi non saranno assolutamente indispensabili, 24. Sulla politica economica dell’Austria in Lombardia si veda in particolare R. Pichler, L’economia Lombarda e l’Austria. Politica commerciale e sviluppo industriale 1815-1859, Angeli, Milano, 2001. Un approccio più attento ai processi di innovazione in campo tecnico è, ad esempio, quello di A. Bernardello, “Imprese ferroviarie e speculazione di borsa nel Lombardo-Veneto e in Austria (1836-1847)”, in Storia in Lombardia, 10, 1991, 2, pp. 352; Id., La prima ferrovia tra Venezia e Milano: storia della imperial-regia privilegiata strada ferrata ferdinandea lombardo-veneta, 1835-1852, Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 1996. 25. “Decreto portante il regolamento sulla proprietà degli Autori d’invenzioni e scoperte d’industria”, in Giornale italiano, 185, 4 Luglio 1806, p. 543. 114 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI qualora si possa con la sola descrizione [...] far bastantemente conoscere l’oggetto di cui si tratta.”26 A tergo del plico sigillato l’autore avrebbe riassunto in un’annotazione di poche righe le caratteristiche dell’oggetto per il quale richiedeva la concessione di un privilegio. Il plico sarebbe stato in seguito spedito al governo che, sulla base di questa annotazione, avrebbe considerato se l’oggetto potesse essere dannoso o contrario alle leggi dello stato. Successivamente, la richiesta giungeva alla Camera Aulica di Commercio di Vienna, unico organo addetto alla valutazione complessiva dell’invenzione presentata, ma la cui attività si limitava di fatto al compito burocratico di redigere il privilegio secondo la formula prevista, inviandolo all’autore e ordinandone la pubblicazione.27 Di fatto, la procedura per l’ottenimento di un privilegio andava viavia semplificandosi. In particolare, se si tiene conto delle difficoltà che implica la descrizione di una macchina per l’industria senza l’ausilio di disegni, diviene immediatamente chiaro come andasse scemando la volontà di accertare che le invenzioni rispondessero ai canoni richiesti dalle esigenze di impiego. Ne è una conferma, nel 1832, l’entrata in vigore di una legge sui privilegi che porta all’abrogazione della Patente Sovrana del 1820. Aggiunte di poco rilievo riguardavano l’esclusione di commestibili, bevande e medicinali dagli oggetti per i quali era possibile ottenere privilegio esclusivo. Un nuovo articolo introduceva la possibilità, fino ad allora negata, di inoltrare richieste per oggetti già in precedenza privilegiati all’estero, mentre altre specifiche, assenti nel testo del 1820, concernevano l’esercizio di privilegi a firma diversa da quella del proprietario e la risoluzione di controversie circa il diritto di proprietà.28 Una novità di particolare interesse va invece rilevata nell’iter che portava alla concessione. Nella legge del 1832 il ruolo della Camera Aulica di Commercio, che secondo la legge del 1820, perlomeno for- 26. “Patente Sovrana sulla concessione dei privilegi esclusivi”, cit., p. 17. 27. Ibid., paragrafi 5-9, pp. 19-23. 28. “Patente Sovrana 31 marzo 1832 portante la nuova legge relativa alla concessione di Privilegj esclusivi per nuove scoperte, invenzioni o miglioramenti in qualsivoglia ramo d’industria”, in Collezioni di leggi e di regolamenti pubblicati dall’Imperial Regio Governo delle province venete, tomo 2, 1832, pp. 99-125. Sull’esclusione di commestibili, bevande e medicinali e sulle richieste per oggetti privilegiati all’estero si veda il § 2, p. 100; sull’esercizio di privilegi sotto firma diversa da quella del proprietario si veda il § 24, p. 111; le norme da applicare nei casi di controversia o abuso sono descritte nel Titolo VI, paragrafi 25-30, pp. 111-115. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 115 malmente, era l’organo delegato all’esame dell’oggetto presentato da un autore, viene quasi completamente soppresso. Dal 1832 a essa compete solamente la trattazione di eventuali ricorsi, mentre passa al governo l’onere di ricevere le descrizioni sigillate degli oggetti per cui è inoltrata richiesta di privilegio. Il governo d’altro canto non è tenuto a nessuna ispezione: ad esso spetta solamente il compito di verificare l’avvenuto versamento delle tasse e l’emissione del privilegio. È specificato, infatti, che “il governo non entrerà punto in esame circa la novità o l’utilità dell’invenzione, della scoperta o del miglioramento, ma soltanto riconoscerà se l’oggetto nel ricorso indicato sia per avventura sotto qualche pubblica vista pernicioso o contrario alle leggi”.29 Al governo competeva soltanto la compilazione del modulo di concessione, la consegna al privilegiato e la stesura di una copia per la pubblicazione nelle gazzette incaricate e presso il Distretto in cui risiedeva l’autore. Per quanto riguardava poi le descrizioni sigillate, queste potevano essere sì aperte presso il governo, ma solo “dopo [che sia stato] rilasciato e pubblicato il privilegio” e solo a condizione “che il ricorrente non abbia espressamente domandato il segreto”.30 In quest’ultimo caso, “le descrizioni verranno durante il periodo del privilegio custodite sigillate”.31 Con la legge del 1832 veniva così meno in modo pressoché totale l’interesse dello stato austriaco a mantenere attivo un sistema di controllo sulle invenzioni. Tale era il risultato da un lato della propensione a lasciare che fosse il mercato, o le azioni (legali o d’altra natura) tra gli interessati, a decidere della maggiore o minore utilità di determinati prodotti per l’industria, e dall’altro lato della quasi completa ritrosia del governo stesso a investire capitali per sostenere gli inventori. Per quanto concerne quest’ultimo punto, è da notare che il sistema dei privilegi andava evolvendo verso una semplice procedura di tassazione in cui il ruolo dell’amministrazione era di mettere a disposizione dell’autore la garanzia di poter usare la propria scoperta prima di altri, che l’autore stesso poteva scegliere di “acquistare” mediante il pagamento di somme prestabilite. Lo scopo della legislazione, dunque, non era più la verifica dell’efficacia dell’invenzione: si puntava piuttosto a tutelare i diritti dell’inven29. Ibid., p. 103. 30. Ibid., pp. 103-104. 31. Ibid., p. 104. 116 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI tore a porre in opera la propria scoperta. Al privilegiato, infatti, oltre al possesso del suo prodotto, era accordata l’autorizzazione “ad erigere tutti i laboratorj, ed a prendere in opera tutti gli operaj che crede necessarj a porre nella maggiore attività l’oggetto del suo privilegio, ed a darvi l’estensione che gli aggrada nella più ampia maniera. Egli può erigere [...] stabilimenti e magazzini per la fabbrica e per lo smercio dell’oggetto privilegiato, autorizzare altre persone a porre in pratica il suo ritrovato all’ombra del privilegio medesimo; assumere socj a suo talento per portarne a qualunque grado d’incremento l’uso e l’applicazione [...]”.32 Accanto al privilegio del singolo, del resto, il governo mirava anche a incentivare la competizione, pertanto la legge del 1832 prevedeva il decadimento dei diritti acquisiti al momento della concessione nel caso in cui il privilegiato avesse lasciato trascorrere “un anno intiero dal giorno della concessione del privilegio senza cominciare a porre in pratica la sua invenzione, la sua scoperta o il suo miglioramento”.33 Ciò avrebbe impedito che l’emissione di privilegi esclusivi finisse per limitare l’iniziativa di altri imprenditori con a disposizione un capitale sufficiente per l’avvio di attività. Nella stessa prospettiva va considerata l’istituzione di un registro, tenuto presso la Camera Aulica di Commercio di Vienna e aperto alla pubblica consultazione, al fine di dare a chiunque l’opportunità “di conoscere con piena certezza i privilegi precedentemente conceduti”.34 In tale registro “si noteranno tutti i privilegi nel modo con cui vengono accordati, e coll’indicazione delle persone che gli ottennero e del loro domicilio, delle epoche della concessione del certificato ufficiale, del privilegio originale e della sua durata”.35 Accanto a esigenze di segretezza, che andavano in ogni caso tutelate, si faceva sempre più manifesto il bisogno di far conoscere, almeno per sommi capi, a quale livello fosse giunta l’innovazione tecnica nei diversi rami d’industria. L’obbligo di dare avviso sulle gazzette locali del conferimento dei privilegi assolveva dunque a pieno questa funzione e instaurava, nella volontà del legislatore, un meccanismo di controllo reciproco tra gli interessati. Non è difficile immaginare come i commercianti locali, saputo attraverso i giornali di una nuova scoperta messa a 32. 33. 34. 35. Ibid., pp. 104-105. Ibid., p. 109. Ibid., p. 110. Ivi. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 117 punto dai loro concorrenti, avrebbero cercato di seguirne le vicende e non avrebbero tardato a segnalare l’eventuale inattività della fabbrica di un privilegiato tentando di appropriarsi a loro volta dei diritti a quella concessi. L’ultima legge sui privilegi che interessò il Lombardo-Veneto durate il periodo della dominazione austriaca è del 1852. Più complesso ed esteso dei precedenti, il nuovo decreto mostrava in particolare due elementi innovativi e di interesse, sintomatici di una crescente vitalità del sistema. Il primo è l’istituzione dell’Imperial Regio Archivio dei privilegi, con sede a Vienna, il cui compito era la custodia di tutte le descrizioni complete degli oggetti privilegiati, il mantenimento di un registro dei nomi, di un registro delle materie, nonché di un registro principale che doveva rispondere a più rigidi criteri di completezza e nel quale dovevano essere descritti tutti i privilegi stati conferiti [sic] dal giorno in cui entrerà in vigore la Legge portata dalla Sovrana Patente sui privilegi del 15 agosto 1852, la data del conferimento, il nome ed il domicilio di chi ottenne un privilegio, o di chi rappresenta quest’ultimo, l’oggetto privilegiato, la data del privilegio, l’eventuale domanda del segreto, tutte le circostanze riguardanti l’esercizio, il trasferimento, il prolungamento o l’estinzione del privilegio, e finalmente il numero del fascicolo nel quale si custodiscono la descrizione e gli altri allegati della rispettiva istanza, non che i successivi documenti che hanno relazione col privilegio.36 Inoltre, all’Archivio competeva la compilazione mensile di un rapporto concernente le variazioni avvenute riguardo “lo stato dei privilegi per nuove concessioni, prolungamenti, mutazioni di possesso e cessazioni della loro validità”.37 Tale prospetto sarebbe stato consegnato al Ministero del commercio e dell’industria che si sarebbe occupato di trasmetterne copia ad ogni provincia dell’Impero e di ordinarne la pubblicazione. Il secondo elemento di novità nella legge del 1852 era l’aumentato interesse nei confronti delle descrizioni in cui il richiedente presenta nei dettagli l’oggetto. Rimane valida la norma che vieta, prima della concessione del privilegio, qualsiasi “investigazione di sorta sulla no36. “Patente Imperiale 15 agosto 1852 con cui si emana una nuova Legge sui privilegi a tutela di nuove scoperte, invenzioni e miglioramenti nei rami d’industria”, in Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia, II, 1852, pp. 942-986. Citazione p. 968. 37. Ibid., p. 953. 118 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI vità od utilità della scoperta, invenzione o miglioramento indicato”,38 così come rimane facoltativa l’inclusione nella domanda di disegni o modelli descrittivi. Tuttavia, la legge pone l’accento sul fatto che i rapporti devono essere resi nel modo più chiaro e intelligibile possibile, con particolare riguardo ai mezzi impiegati e soprattutto devono fornire a qualsiasi perito in un determinato ramo d’industria le indicazioni adeguate per la riproduzione dell’oggetto in questione. Nella legislazione del 1852 la questione della riproducibilità di un’invenzione diviene di fondamentale importanza. L’istituzione dell’Archivio dei privilegi, così come il tentativo di rendere il più possibile realistiche le descrizioni dettagliate, rinviano all’esigenza che si andava facendo sempre più marcata di tutelare non solo i diritti del privilegiato, ma anche quelli di artigiani e commercianti che, una volta decorso il termine massimo di 15 anni in cui un privilegio per una nuova invenzione poteva essere concesso a terzi, ne avrebbero potuto disporre liberamente. Dal 1852, i dettagli degli oggetti dei quali era scaduto il privilegio cominciarono ad essere regolarmente pubblicati. Di qui il divieto di “occultare cosa alcuna sia nei mezzi, sia nel modo di applicarli”, così come di “indicare mezzi più costosi o non atti a produrre il medesimo effetto”,39 nonché l’esigenza di un’accuratezza nella descrizione “tale che, quando essa vien portata a pubblica notizia dopo la scadenza del privilegio, sia possibile ad ogni uomo d’arte di riprodurla”.40 In questo contesto l’Archivio dei privilegi diventava anche l’organo delegato a fornire assistenza, un vero e proprio ufficio aperto al pubblico, dove ci si recava per ottenere informazioni su determinati incartamenti, per conoscere a quali limiti un privilegio era soggetto, ma anche per confrontare le proprie invenzioni con quelli altrui, ammesso che queste ultime non fossero coperte da segretezza. Secondo la legge del 1852, infatti, è libero a chiunque di chiedere all’Archivio dei privilegi schiarimenti a voce od in iscritto riguardo ai privilegi concessi, e anche a ispezionare a tal uopo in persona il registro. Così pure ognuno potrà vedere le descrizioni ivi conservate cogli allegati di cui non si abbia richiesto il segreto o che provengano da privilegi non più validi, e finalmente di prendere copia da sé o col mezzo di altri a propria spesa di singole parti di tali privilegi dal registro o da quei privilegi che non si devono tenere segreti.41 38. 39. 40. 41. Ibid., p. 948. Ibid., p. 947. Ibid., p. 945. Ibid., p. 953. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 119 Vale la pena di segnalare anche la presenza nel regolamento per l’attuazione del decreto di ben quattordici articoli volti a definire la prassi da seguire in casi di controversia. Questi rendono indirettamente conto della quantità di abusi cui il sistema andava soggetto e di quale sorta essi fossero. Si trattava in particolare, com’è facile intuire, di contraffazioni, molte delle quali avevano origine dentro la stessa fabbrica del privilegiato, come rivela la considerazione di “circostanza aggravante” nel caso in cui il colpevole si trovasse “al servizio del privilegiato, od abusando della fiducia in lui riposta, si fosse prevalso della cognizione della fatta scoperta, invenzione o miglioramento per commettere la violazione del privilegio”.42 Sempre più frequenti erano le occasioni in cui un inventore denunciava l’utilizzo da parte di terzi di macchine troppo simili a quella da lui messa a punto. La procedura, presentato il ricorso alle autorità competenti, prevedeva la possibilità per le parti in causa di accordarsi autonomamente sull’indennizzo e sull’eventuale cessione degli oggetti in questione. Tuttavia, nei casi di meno facile soluzione era previsto l’intervento di un’altra figura, quella del perito il quale, sotto giuramento, era il solo a poter ricorrere alle descrizioni originarie presentate in occasione della richiesta del privilegio. Ciò che poteva seguirne, oltre al sequestro e alla confisca dei materiali in esame, era la condanna a pene pecuniarie commisurate al danno arrecato, ma anche l’arresto e la reclusione.43 La dimensione locale dell’innovazione Nel paragrafo precedente ho analizzato la struttura di un sistema legislativo che si sviluppò per assecondare le esigenze crescenti di un settore, quello dei privilegi, che nel corso dell’Ottocento vide una forte espansione. Sono emersi, da un lato, i provvedimenti attraverso cui erano regolamentate le prassi per richieste e concessioni ed è stato possibile evidenziare l’istituzione di strutture, come l’Archivio dei Privilegi, nate per rispondere ad esigenze di gestione e informazione. Inoltre, si sono individuate disposizioni, quali l’obbligo di fruire effettivamente del 42. Ibid., p. 974. 43. Si vedano le Sezioni VI e VII, pp. 972-978, della già citata “Patente Imperiale 15 Agosto 1852”. 120 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI privilegio – pena il decadimento –, o la rigorosa regolamentazione delle controversie per i casi di uso illecito di un’invenzione, che pur disciplinando il sistema contribuivano allo stesso tempo a imprimergli una maggiore dinamicità. L’analisi della legislazione ha inoltre permesso di intravedere i principi che la ispiravano. In particolare, la scelta di un progressivo allentamento dei meccanismi di controllo sull’utilità delle nuove scoperte e, più tardi, la severa tutela dei diritti a usufruire dei privilegi scaduti o decaduti, manifestavano la convinzione del governo di assecondare il carattere concorrenziale di un mercato sempre più aperto. Infatti, rinunciando alle procedure di verifica e concedendo privilegi per ogni invenzione, si offriva all’autore l’opportunità di mettere il proprio prodotto al vaglio di qualsiasi potenziale acquirente. Inoltre, garantendo l’uso dei privilegi scaduti si assicurava la commercializzazione e la diffusione di ogni macchina di effettivo interesse. Più controverso rimaneva il problema della descrizione degli oggetti di privilegio. Come abbiamo visto, la legge del 1820 dava poca importanza ai progetti e si mostrava, da questo punto di vista, permissiva nei confronti degli inventori. In quel periodo la descrizione dell’invenzione era infatti considerata dal legislatore come una prassi obsoleta che era stata necessaria in passato, quando ancora si riteneva opportuno analizzare la scoperta prima di consentirne l’impiego, ma che non serviva più in un sistema che puntava a una autoregolamentazione imposta dalle esigenze del mercato. Con la legge del 1852, tuttavia, la questione delle descrizioni tornava in primo piano. Era divenuto evidente che, per raggiungere una reale efficacia, il sistema dei privilegi doveva da un lato proteggere l’originalità di un’invenzione, dall’altro consentirne la diffusione una volta che il privilegio fosse scaduto. Ma in assenza di disegni dettagliati risultava difficile rispondere a quest’ultima esigenza; per questa ragione il decreto del 1852 imponeva una minore flessibilità e tornava ad esigere dagli autori illustrazioni meticolose che garantissero, in primo luogo dalla data di scadenza, una reale fruibilità dell’oggetto ex-privilegiato. Vi era stata dunque l’abolizione e poi, in un contesto mutato, la reintegrazione dell’obbligo di fornire i progetti delle invenzioni. Ripensamenti come questi mostrano alcune delle incertezze di un sistema dei privilegi che, non ancora ben definito, doveva rispondere a fluttuazioni economiche e tenere conto di variabili come la maggiore o minore adesione degli autori al sistema stesso. Nel contempo, però, la disponibili- CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 121 tà ad adattarsi a esigenze mutevoli e a ripensare di volta in volta i meccanismi di questo complesso apparato per il controllo e l’incentivazione dello sviluppo tecnico, erano anche un sintomo del deciso interesse del governo di Vienna nei confronti del sistema dei privilegi. Resta da chiedersi se questo interesse bastò a fronteggiare le resistenze che in contesti specifici, come quello del Lombardo-Veneto, erano generate dalla fedeltà a modelli innovativi consolidati e strutturati a misura di un particolare contesto economico e istituzionale. Scendendo nei dettagli, pare che questa domanda debba avere una risposta negativa; nel Lombardo-Veneto furono infatti molteplici i fattori che ostacolarono la diffusione dei privilegi. Un primo elemento va individuato a livello della struttura economica prevalente nella regione. Sebbene fosse la più ricca area della penisola, nei decenni centrali dell’Ottocento il Lombardo-Veneto era ancora dominato da un’economia di tipo preindustriale, quasi totalmente dipendente dalla lavorazione della seta e della lana e pressoché estraneo all’applicazione di nuove fonti di energia, all’utilizzazione massiccia del ferro, così come al processo di meccanizzazione su larga scala in corso invece in altri paesi europei. 44 Le cause del ritardo, in particolare nei confronti del modello britannico, sono attribuite dagli storici a fattori sociali come l’elevato tasso di analfabetismo e il basso reddito procapite, ma soprattutto alla mancanza di carbone, che frenò la diffusione del vapore.45 Una incidenza particolare ebbe però la diffusione della piccola azienda a conduzione familiare. Com’è stato osservato, erano solo una minoranza i lavoratori impiegati in un opificio per l’intero anno, mentre per gli altri erano i tempi e i ritmi dell’attività agricola che determinavano il parziale impiego nel 44. Sul permanere nell’Italia divisa di una struttura economica di tipo preindustriale si veda N. Crepas, Le premesse dell’industrializzazione, in F. Amatori, D. Bigazzi, R. Giannetti, L. Segreto (a cura di), Storia d’Italia. L’Industria, Einaudi, Torino, 1999, pp. 87-177. Sul Lombardo-Veneto si vedano in particolare le pp. 153-166. Si rimanda inoltre a A. M. Banti, Terra e denaro: una borghesia padana dell’Ottocento, Marsilio, Venezia, 1989; M. Berengo, L’agricoltura veneta dalla caduta della repubblica all’Unità, Banca Commerciale Italiana, Milano, 1963. A. Colli, Alle radici del «modello lombardo». Agricoltura, manifattura industria tra Ottocento e Novecento, in Cafagna, Crepax, Atti di intelligenza, cit., pp. 193-241; L. Cafagna, Dualismo e sviluppo nella storia d’Italia, Marsilio, Venezia, 1989, in particolare si veda il Capitolo I “La Lombardia nucleo originale dello sviluppo economico italiano”, pp. 3-179; N. Crepax, Tradizione lombarda, industria tessile e sviluppo economico, in Cafagna, Crepax, Atti di intelligenza, cit., pp. 243-283; Pichler, L’economia Lombarda e l’Austria, cit., pp. 21-26; S. Zaninelli (a cura di), Storia dell’Industria Lombarda, v. 1, Il Polifilo, Milano, 1988. 45. Su questo tema si rimanda a C. Bardini, Senza carbone nell’età del vapore: gli inizi dell’industrializzazione italiana, Mondadori, Milano, 1998. 122 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI settore secondario, e questo significava per l’industria un preciso condizionamento nel modello di sviluppo.46 Dal nostro punto di vista, è interessante osservare che in un’area in cui l’industria cresceva in simbiosi con le esigenze di un’economia rurale di tipo domestico, e in un contesto in cui i rapporti di produzione rimanevano saldamente ancorati alla terra piuttosto che alle macchine, una legislazione sui privilegi mirante a regolare la competizione tra i proprietari di fabbriche e officine era inservibile o perlomeno di difficile attuazione. Uno dei maggiori ostacoli contro cui cozzava la spinta riformatrice promossa dal governo austriaco fu proprio l’organizzazione istituzionale che faceva da sfondo ad un’economia fondata sull’agricoltura. Mi riferisco in particolare alle accademie agrarie che, ancora a metà Ottocento, si trovavano disseminate in gran parte del territorio del Lombardo-Veneto. Sorte nella maggior parte dei casi durante la seconda metà del Settecento, fornirono per lungo tempo un aiuto concreto a contadini, artigiani e commercianti.47 A chi vi si rivolgeva, le accademie garantivano assistenza per la soluzione di problemi burocratici e legali. Inoltre, fungevano da cassa di risonanza alle esigenze che i ceti lavoratori andavano di volta in volta manifestando a livello locale. Infine, arruolavano anche esperti e promuovevano studi per rispondere a casi specifici: è sufficiente scorrere gli annali pubblicati negli anni Cinquanta dall’Accademia di Vicenza, di Bergamo o di Verona per avere un’idea di quanto si fece per affrontare, ad esempio, i danni che la pebrina, una malattia epidemica del baco diffusa nell’area del Mediterraneo, stava arrecando alla produzione della seta.48 La vicinanza ai settori produttivi, l’intraprendenza e i margini di autonomia di cui godevano, facevano delle accademie agrarie un elemento di riferimento importante. Ma le accademie costituivano allo stesso tempo il maggiore ostacolo alla diffusione della figura di quell’imprenditore, indipendente e intento a perseguire strategie innovative originali e redditizie, che era l’ideale cui si ispiravano le leggi sui privilegi. 46. Crepax, Le premesse dell’industrializzazione, cit., p. 158. 47. P. Del Negro, La politica di Venezia e le accademie di agricoltura, in G. Barsanti, V. Becagli, R. Pasta (a cura di), La politica della scienza: Toscana e stati italiani nel tardo Settecento, Olschki, Firenze, 1996, pp. 451-489. 48. Sull’argomento si veda B. Caizzi, “La crisi economica del Lombardo-Veneto nel decennio 1850-1859”, in Nuova Rivista Storica, v. 42, 1958, pp. 205-222; per una prospettiva più ampia si rinvia a G. Federico, Il filo d’oro. L’industria mondiale della seta dalla Restaurazione alla Grande crisi, Marsilio, Venezia, 1994. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 123 Le accademie e i concorsi Tra le attività che si svolgevano con regolarità nello spazio accademico vi era l’esame di macchine agricole e per l’industria. A provare la macchina erano commissioni di periti, scelti perlopiù tra i soci dell’istituto, anche se, nel caso di invenzioni di particolare interesse, si poteva ricorrere a esperti provenienti dall’esterno. I periti avrebbero compiuto l’analisi e steso un rapporto, con particolare riguardo per l’efficienza e la possibilità d’impiego della macchina in esame. L’accademia metteva a disposizione le competenze, un filtro attraverso cui l’abilità pratica dei costruttori approdava alla formalità di una descrizione tecnica che, a sua volta, poteva essere pubblicata o impugnata dall’autore come attestato del valore dei propri prodotti.49 Le commissioni e il lavoro che svolgevano rappresentavano dunque il mezzo di trasferimento da una conoscenza pragmatica sui metodi di produzione a un sapere sulle tecniche in grado di dimostrare il reale potenziale innovativo di un’invenzione. La via istituzionale per questo salto qualitativo, che portava dall’abilità manuale verso un sapere sistematico e razionale, erano i “Concorsi per invenzioni e nuove scoperte”. Indetti periodicamente dalle accademie sulla base di regolamenti interni, i concorsi erano solitamente disciplinati da dettami molto generici e non puntavano alla soluzione di un problema concreto, pertanto avevano l’effetto di attirare macchine e invenzioni di ogni genere (attrezzature agricole, filatoi, argani ecc.).50 Prassi consolidata fin dal periodo della Repubblica di Venezia, quella dei concorsi era una strategia che si era dimostrata utile per la promozione dello sviluppo nel settore agricolo. Dopo l’invasione napoleonica quella consuetudine non era caduta in disuso, tuttavia il governo francese aveva cercato di contenere o perlomeno irreggimentare l’autonomia delle accademie, trasformando i concorsi in uno strumento del piano di sviluppo centralizzato tipicamente napoleonico. 49. Si veda ad esempio il caso di Bartolomeo Avesani nel paragrafo successivo: l’utilità di una sua macchina a vapore era stata dimostrata dall’Accademia di Verona e i dettagli pubblicati nel v. 13 degli Atti dell’Accademia stessa. Della macchina a vapore del signor Bartolomeo Avesani ingegnere meccanico, in Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, v. XIII, 1831. 50. Tale varietà è significativamente descritta negli Atti dei concorsi indetti dall’Istituto Lombardo in cui, accanto ai più semplici utensili agricoli, compaiono macchine destinate all’industria tessile e strumenti scientifici. Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni de’ premj d’industria fatte in Milano e in Venezia dall’anno 1806 in avanti, vv. 1-8. 124 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI Nei primi anni dell’Ottocento, per esempio, il governo appena insediato aveva affrontato il problema di una troppo scarsa produzione di “zucchero d’uva” attraverso un concorso per l’invenzione di nuovi metodi di lavorazione. Mediante la concessione di premi, si puntava a ottenere informazioni circa le aziende più produttive e le migliori strategie impiegate, per poterle in seguito imporre a livello generale negli anni successivi. Il problema non giunse però a una rapida soluzione: ancora nel 1810, il ministro dell’interno Vaccari inviava a tutte le prefetture la richiesta di “far sapere al governo chi avesse fatto qualsiasi progresso in questa direzione”.51 Nonostante il ruolo mediatore assolto dalle istituzioni locali continuasse ad essere importante, accentrare divenne un obbiettivo da perseguire e nel 1805 il governo aveva stabilito che nel giorno 15 del mese di agosto di ciascun anno avvenire si sarebbero distribuiti dei premj a quei sudditi italiani che avessero fatte utili scoperte nell’agricoltura e nelle arti meccaniche, o che avessero inventati, perfezionati o trasportati nel Regno nuovi rami d’industria, nuove sorgenti di prosperità; che i premi consisterebbero in corone d’alloro ed in medaglie d’oro ed argento, sulle quali sarebbe impressa da una parte un’iscrizione che ricordasse l’oggetto che avesse ottenuto il premio ed il nome del premiato; che le corone e le medaglie sarebbero distribuite dal Ministro dell’Interno alla presenza di tutti i Ministri e di tutte le autorità nazionali e locali che si trovassero unite in Milano, e di tutti i membri dell’Istituto nazionale.52 Il concorso, già impiegato presso le accademie minori, continuava così a costituire un valido incentivo all’imprenditoria ma ora, elevato ad evento fastoso da onorare nella capitale della regione, assumeva anche una funzione celebrativa. Attraverso l’assegnazione di corone d’alloro e medaglie e alla presenza di tutti i ministri riuniti a Milano, il governo intendeva rendere pubblica e manifesta la propria operosità e gratificare i cittadini che con il loro ingegno avevano contribuito al progresso economico dello stato. Le Distribuzioni dei premj d’industria continuarono fino al 1814, quando furono interrotte dalla guerra. L’anno successivo Francesco I costituì il Regno Lombardo-Veneto affidandone la gestione amministrativa ai due governi di Milano e Venezia e nel 1816 i concorsi ripresero senza una sostanziale soluzione di continuità, ma si tennero separatamente 51. Il Ministro dell’Interno alle Prefetture, Milano, 10 Ottobre 1810 - Circolare 21580, Archivio di Stato di Verona, Dipartimento dell’Adige - Prefettura, Busta 37. 52. Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni de’ premj d’industria, cit., v. 4, p. 109. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 125 in entrambe le città. In seguito, con due decreti emanati nel 1817 e nel 1818, fu stabilito che la distribuzione dei premi dovesse tenersi alternativamente un anno a Milano e l’altro a Venezia, mantenendo validità per tutto il territorio del Regno. La data fissata era il 4 ottobre, giorno dell’onomastico dell’Imperatore.53 Circa i premi sarebbero consistiti, “come per lo avanti, in medaglie d’oro, in medaglie d’argento ed in menzioni onorevoli”.54 Gli aspiranti avrebbero dovuto presentare alle Regie delegazioni provinciali la domanda accompagnata “da un saggio delle invenzioni, dei perfezionamenti e delle introduzioni da essi fatte, o da una descrizione o da un disegno abbastanza precisi e specificati per darne sufficiente cognizione”.55 Entro il primo giorno d’agosto ogni delegazione provinciale doveva nominare una commissione di cinque esperti scelti “tra i professori di fisica, di storia naturale o di tecnologia ne’ licei, e tra i membri delle società agrarie e di arti che esistono nelle province, ad oggetto di esaminare le scoperte o introduzioni che fossero state notificate, e di portar opinioni sugli oggetti insinuati pel concorso a premio”.56 Nel caso in cui l’oggetto a concorso non potesse essere presentato, per esempio a causa delle dimensioni, la commissione doveva “recarsi a vederlo sul luogo, o deputare qualcuno de’ suoi membri a farne l’esame e il rapporto” e, una volta esaminata l’invenzione, il processo verbale doveva essere inviato all’Imperial Regio Istituto di Scienze, Lettere ed Arti per il pronunciamento del giudizio definitivo.57 I risultati sarebbero stati in seguito pubblicati e i modelli esposti al pubblico per dieci giorni nelle sale destinate alla distribuzione dei premi. Ovviamente, chi avesse presentato macchine per cui era stato chiesto il privilegio non era obbligato a rendere pubblica la propria invenzione, ma di fronte alla commissione era tenuto a seguire la prassi del concorso, cioè a mostrare in ogni caso la macchina e a comprovarne l’utilità (Tab. 1). L’I.R. Istituto di Scienze, Lettere e Arti rimase l’istituzione di riferimento per la distribuzione dei premi d’industria e rappresentò fino all’unità un modello non solo per le accademie già presenti sul territorio, ma anche per le attività di nuovi centri. Tra questi è la Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri di Milano che, nel 1841, anno della sua 53. 54. 55. 56. 57. Ibid., p. 111. Ivi. Ivi. Ivi. Ivi. 126 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI Anni Luogo 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1815 1816 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 Milano Milano Milano Milano Milano Milano Milano Milano Milano Venezia Milano Venezia Milano Venezia Milano Venezia Milano Venezia Milano Venezia Milano medaglie d’oro medaglie d’argento menzioni onorevoli 1 3 5 5 4 5 3 3 3 3 2 4 4 5 5 4 5 6 5 4 5 N. 84 8 9 12 9 11 21 14 13 18 12 10 16 15 19 31 19 37 20 36 27 37 N. 394 – 11 16 6 12 21 25 12 13 13 10 20 19 8 14 21 28 16 30 12 21 N. 328 Tabella 1. Prospetto dei premi d’industria assegnati dal 1806 al 1826. Fonte: Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni de’ premj d’industria fatte in Milano e in Venezia dall’anno 1806 in avanti, v. IV, tomo II, 1826, p. 121. fondazione, programmava un piano per premi d’incoraggiamento finalizzati a promuovere le attività produttive.58 Anche in questo caso, si trattava di un’iniziativa patrocinata dal governo che prevedeva la nomina di commissioni per l’esame degli oggetti presentati e la distribuzione di medaglie. Le prime due commissioni elette, una per le arti meccaniche e una per la chimica, erano per lo più costituite da scienziati e tecnici già membri dell’Istituto Lombardo o con incarichi di docenza presso i licei milanesi. In seguito, tuttavia, al fine di bilanciare la preparazione quasi esclusivamente scientifica di quei periti, vennero istituite la Commissione 58. C. G. Lacaita, L’intelligenza produttiva. Imprenditori, tecnici e operai nella Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri di Milano (1838-1988), Electa, Milano, 1990, pp. 27-28. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 127 per il miglioramento dei rami d’industria dipendenti dal commercio e la Commissione per i rami d’industria dipendenti dall’agricoltura. Nel suo studio sulla Società d’Incoraggiamento di Milano, Carlo G. Lacaita elenca i nuovi membri: per il settore agricolo erano stati chiamati proprietari terrieri, generalmente appartenenti alla nobiltà. Tra i periti per l’industria erano invece presenti Domenico Buzzoni, direttore della filatura Buzzoni, Sperati e soci; Pietro Borella e Giovanni Lamberti, proprietari di due setifici; Leopoldo Pressyl, direttore della manifattura laniera Francesco Carlo e Leopoldo Pressyl; e infine lo zuccheriere Pietro Calderara, i mercanti Giuseppe Negri e Felice Quinterio, il negoziante di formaggi Ambrogio Campiglio e il professore Francesco Viganò, quest’ultimo in qualità di segretario della commissione.59 Con l’introduzione tra i periti di imprenditori dotati di esperienza sul campo, la Società d’Incoraggiamento di Milano mostrava fin dall’inizio le ambizioni di rinnovamento che la guidavano. In particolare, si volevano mettere a disposizione competenze pratiche, suscitare l’interesse degli uomini d’affari e infine modificare una consuetudine in cui spettava solo a tecnici, fisici ed economisti il giudizio sulle scoperte. Ciò che sembra importante evidenziare qui è che, una volta trasferita dalle piccole accademie agrarie a grandi istituti quali la Società d’Incoraggiamento di Milano e l’I.R. Istituto di Scienze, Lettere e Arti, la distribuzione dei premi accentuava il suo carattere encomiastico per diventare una cerimonia di riconoscimento in cui lo stimolo all’intraprendenza era costituito dall’esaltazione pubblica dei progressi ottenuti in campo tecnico. D’altro canto, il grande evento annuale della premiazione coinvolgeva, oltre ai giudici degli Istituti di Scienze, anche le Regie delegazioni e si diramava fino alle periferie della regione, impegnando i membri delle società agrarie provinciali che, a loro volta, erano a contatto diretto con gli inventori locali. Nel caso dei concorsi della Società d’Incoraggiamento di Milano poi, si puntava ad attirare l’interesse dei commercianti, dei negozianti e degli imprenditori stranieri. Se si tiene infine conto che dalla presentazione della domanda all’esposizione finale trascorrevano alcuni mesi, appare evidente che i concorsi avevano l’effetto di coinvolgere, per un lungo periodo, un’ampia parte dei settori produttivi della società. Indirettamente, orientando questi settori in modo 59. Ibid., p. 29. 128 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI univoco e verso progetti condivisi, si otteneva l’effetto di aumentare la possibilità di controllo. I benefici offerti dai concorsi banditi dalle piccole accademie sembravano dunque moltiplicarsi nella traslazione a un sistema di stato. Tuttavia, erano importate anche prassi che non si conciliavano con la spinta riformatrice promossa attraverso la legislazione sui privilegi. La concessione della medaglia e il riconoscimento per un impegno civile e di pubblica utilità, che erano gli obiettivi ultimi dei concorsi, rimandavano a una concezione “illuminata” dell’intraprendenza tecnica in cui il potere del miglioramento si manifestava solo qualora fosse stato “donato” alla società. Nobili industriosi e ingegneri aristocratici erano stati per lungo tempo i protagonisti di questo sistema e i concorsi indetti dagli Istituti Lombardo e Veneto preservavano il loro ruolo. Dall’altra parte, invece, stava un sistema dei privilegi in cui l’inventiva era una forza che il singolo poteva dispiegare a proprio vantaggio: lo stato non gli metteva a disposizioni beni, ma dei diritti che l’inventore avrebbe dovuto acquistare per fruirne e che, ottenuti, avrebbe impiegato per incrementare la propria personale ricchezza. Si consideri inoltre che nelle commissioni dei concorsi erano presenti fisici e artigiani incaricati di analizzare e testare l’invenzione e, attraverso una verifica empirica, dimostrarne l’effettiva utilità; questo mentre invece le leggi sui privilegi del 1820, del 1832 e del 1852 puntavano ad abolire quel sistema. È in questo contesto che si trovò a operare Bartolomeo Avesani. L’ingegnere meccanico Bartolomeo Avesani Bartolomeo Avesani era nato a Verona nel 1792 in una ricca famiglia di commercianti di seta. Morto il padre quando aveva solo otto anni, fu avviato agli studi dallo zio paterno, l’abate Gioachino Avesani, che godeva di buona fama come intellettuale e che per il nipote avrebbe voluto una carriera nel campo delle lettere.60 Anche le aspettative nutrite 60. Durante i primi decenni dell’Ottocento Gioachino Avesani fu uno dei personaggi più in vista della città di Verona, ricoprì incarichi politici e di insegnamento; come studioso, fu in particolare noto per un compendio dell’Orlando Furioso utilizzato per l’insegnamento nei collegi (L. Ariosto, Orlando furioso di M. Lodovico Ariosto conservato nella sua epica integrità e recato ad uso della studiosa gioventù dall’abate Gioachino Avesani, Bianconi, Venezia, 1823). CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 129 dalla madre, Maddalena Barisani, erano notevoli. Appartenente a una famiglia aristocratica di Castelfranco, Maddalena Barisani aveva un fratello tra i membri del senato milanese, che ci si aspettava avrebbe aiutato Bartolomeo a conquistare una solida posizione.61 Bartolomeo Avesani, tuttavia, una volta terminati gli studi superiori presso il Collegio di San Sebastiano a Verona rifiutò gli aiuti e i consigli della famiglia per intraprendere la difficile carriera di inventore e dedicarsi alla progettazione e alla costruzione di macchine.62 La scelta ebbe delle conseguenze nella vita di Avesani perchè gli alienò i favori di parenti influenti e il loro sostegno economico, costringendolo a ristrettezze cui non era abituato.63 D’altra parte, Avesani non poteva aspettarsi dalla famiglia l’approvazione per un mestiere nella sostanza manuale e che richiedeva le abilità dell’artigiano piuttosto che quelle del prelato, del letterato o del politico. Nell’Elogio commemorativo scritto nel 1847, Antonio Radice restituisce l’immagine di questo conflitto familiare attraverso il ricordo dello zio abate che “sgridava sovente e biasimava altamente l’istinto del nipote” e lamentava “che volesse far professione d’un’arte vile senza accordare che la meccanica fosse neppur un’arte”.64 Avesani, in effetti, mancava di una formazione adeguata anche per fare l’inventore. Nonostante i buoni risultati ottenuti presso il collegio, si avvicinò alla meccanica privo di cognizioni teoriche “poiché incolto d’ogni studio sulla statica, sulla dinamica e sulla geometria descrittiva.”65 Le nozioni elementari di disegno le aveva imparate frequentando le officine e le abilità manuali gli derivavano dall’osservazione del lavoro dei maestri d’arte locali.66 Circa la qualifica di “ingegnere”, in mancanza di notizie certe, è lecito supporre che gli fosse stata attribuita ad honorem per i successi otte61. Avesani Bartolammeo, Autografoteca Scolari, b. 258, Biblioteca Civica di Verona. 62. Sulla biografia di Bartolomeo Avesani si vedano A. Radice, “Elogio dell’ingegnere meccanico Bartolomeo Avesani”, in Memorie dell’Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona, v. XXI, 1846, pp. 270-319 e la breve nota biografica in Avesani Bartolammeo, Autografoteca Scolari, b. 258, Biblioteca Civica di Verona. Si veda anche Ms Avesani Ingegnere Bartolommeo, in Libro dei Meriti, Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona. 63. Alle difficili condizioni economiche cui dovette far fronte Bartolomeo Avesani si fa spesso riferimento in Radice, “Elogio dell’ingegnere meccanico Bartolomeo Avesani”, cit., p. 273, p. 300 e p. 312. 64. Ibid., p. 289. 65. Ibid., p. 290. 66. Ivi. 130 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI nuti nel corso di una lunga carriera come inventore, piuttosto che attraverso un regolare curricolo formativo. Ad alimentare tale dubbio è il fatto che, perlomeno fino alla metà degli anni Venti dell’Ottocento, nei documenti ufficiali per l’assegnazione di riconoscimenti e medaglie Avesani è definito “meccanico”, mai ingegnere.67 Sappiamo inoltre che Avesani si spostava di frequente per eseguire lavori che gli venivano commissionati, ma solo per brevi periodi, durante i quali mantenne sempre la propria residenza a Verona, dove mancava una scuola per la preparazione di ingegneri.68 L’unico significativo periodo trascorso fuori città risale alla fine degli anni Venti, quando si trasferì per alcuni anni a Venezia per raggiungere Anna Zucchi, che sarebbe divenuta la sua seconda moglie. Ma a quel tempo Avesani aveva ormai superato i trent’anni e sembra improbabile che, già noto nel mondo degli inventori, abbia frequentato una scuola per ingegneri. L’istituzione che più si interessava al lavoro di artigiani e inventori a Verona quando Avesani cominciò la propria attività era l’Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti. É a quell’Accademia che nel 1812 Avesani si rivolse per ottenere assistenza.69 Aveva di recente messo a punto un modello in scala di una macchina per la lavorazione della seta che voleva mandare a Milano per partecipare all’annuale Concorso per la distribuzione de’ premj d’industria. Grazie alla mediazione dell’Accademia, Avesani fu introdotto alla regolare procedura di registrazione presso la Prefettura e il suo modello fu spedito al Ministro dell’interno. Sfortunatamente la macchina arrivò in ritardo e il nome di Avesani non comparve tra i partecipanti al concorso di quell’anno. Tuttavia la regolarità dell’iscrizione e il fatto che il ritardo era dovuto a cause accidentali, bastarono a far ottenere ad Avesani l’esonero dal servizio militare, ricompensa prevista per tutti i giovani che avessero meritato un premio per nuove invenzioni.70 67. Si veda ad esempio Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni de’ premj d’industria, cit., v. II, 1815-1819, p. 98 e p. 153. 68. Sulla scuole per ingegneri e sulla formazione degli ingegneri nel Veneto durante l’Ottocento si veda M. Minesso, Tecnici e modernizzazione nel Veneto. La scuola dell’Università di Padova e la professione dell’ingegnere (1806-1915), Trieste, Lint, 1992, in particolare il cap. 1: L’origine di una nuova figura professionale. Si veda inoltre G. C. Calcagno, La figura dell’ingegnere tra Sette e Ottocento, in Ingegneria e politica nell’Italia dell’Ottocento: Pietro Paleocapa, cit., pp. 463-476. 69. Sull’Accademia di Verona, si veda C. Vanzetti, L’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona, 1768-1989, Grafiche Fiorini, Verona, 1990. 70. Radice, “Elogio dell’ingegnere meccanico Bartolomeo Avesani”, cit., p. 291. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 131 L’anno successivo Avesani ripresentò all’Istituto Reale di Scienze Lettere e Arti di Milano il modello in scala della sua macchina tessile. Secondo il rapporto della commissione esaminatrice, questo nuovo tipo di filatoio rendeva “non senza economia di fatica e di tempo simultanee tre operazioni ottenute dinanzi disgiuntamente, vale a dire di filare le bave, di addoppiarle, e di torcerle”.71 L’invenzione era stata pertanto giudicata di sicuro interesse e presso l’Archivio di stato di Verona è conservato l’attestato con cui, il 18 agosto 1813, si diede avviso ad Avesani che il giorno 14 di quel mese la sua macchina, analizzata presso l’I.R. Istituto di Milano, era stata premiata con una medaglia d’argento durante la Distribuzione de’ premj d’industria.72 La commissione dei giudici che si era espressa in modo positivo sul modello aveva però mantenuto il riserbo sulla reale efficacia operativa della macchina. Si era infatti osservato che solo verificando il funzionamento di un modello in scala reale sarebbe stato possibile valutare adeguatamente i fenomeni di attrito e il risparmio di energia ottenibile.73 Stimolato forse da queste considerazioni, Avesani continuò a lavorare alla sua invenzione e negli anni seguenti vi apportò notevoli miglioramenti. Così, al Concorso per la distribuzione de’ premj d’industria che si tenne nel 1816 a Venezia, egli presentò un prototipo di filatoio in scala reale che, secondo il parere dei giudici, “delle sei operazioni necessarie per ridurre la seta da cucire fino al punto di colorirsi, cinque ne eseguisce da sé sola ad un tratto”.74 Questa volta Avesani riuscì a soddisfare in toto i canoni di originalità ed efficienza richiesti dall’Istituto con un’invenzione “di cui la simile non esiste” e che facilitava la lavorazione delle sete “con grande risparmio di spesa e di tempo”: per queste ragioni se ne auspicava l’impiego e veniva conferita ad Avesani la medaglia d’oro.75 Dopo questi primi risultati, i successi di Avesani presso gli annuali Concorsi per premj d’industria si susseguirono senza soluzione di continuità. Nel 1817 ottenne tre medaglie d’argento per l’invenzione di un nuovo fuso da filatoio, una macchina per la lavorazione del filo 71. Ibid., p. 292. Si veda anche Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni de’ premj d’industria, cit., v. II, 1815-1819, p. 98. 72. Prefetto dell’Adige. 18 Agosto 1813, n. 24449, Archivio di Stato di Verona: Prefettura del Dipartimento dell’Adige – Busta 36. 73. Radice, “Elogio dell’ingegnere meccanico Bartolomeo Avesani”, cit., pp. 292-293. 74. Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni de’ premj d’industria, cit., v. II, 18151819, pp. 98-99. 75. Ibid., p. 99. 132 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI d’acciaio e una per la fabbricazione delle viti.76 Nel 1819 presentò al concorso, che quell’anno si tenne a Venezia, un campione di manicotto di ottone generalmente impiegato nelle pompe antincendio. Le novità dei manicotti di Avesani erano nella maestria con cui erano stati costruiti e, come risulta chiaro dal rapporto della commissione, nel fatto che “erano tutti tra loro eguali perfettamente nelle rispettive specie, e combaciantisi ciascuno con tutti gli altri”.77 In un periodo in cui la produzione seriale era ancora agli albori, la capacità di produrre oggetti identici era tenuta in grande considerazione, soprattutto quando si trattava di apparati che potevano essere impiegati dallo stato su larga scala. Questo procurò ad Avesani una medaglia d’argento. Avrebbe meritato l’onorificenza più alta se, come aveva osservato la commissione, avesse presentato anche la macchina usata per la fabbricazione dei tubi.78 Negli anni successivi Avesani fu premiato per alcuni nuovi modelli di argano, un apparato per la movimentazione della terra o dell’acqua su lunghe distanze, una macchina per la costruzione di ruote dentate e altro ancora. I Concorsi per premj d’industria erano divenuti per Avesani una sorta di fiera espositiva delle sue invenzioni dove i riconoscimenti e la fama alimentavano le richieste dei clienti. Nel suo laboratorio, perfezionato nel corso del tempo, cominciò a ricevere molte richieste, non solo di privati, ma spesso anche da enti pubblici veronesi e di città limitrofe. In particolare, gli procurò molto lavoro una macchina idraulica da applicare ai pozzi che conosciamo attraverso un preventivo di spesa preparato da Avesani e che fu installata negli ospedali militari di Verona e di Vicenza. 79 L’apice della carriera di Avesani fu raggiunto nel 1830, quando l’inventore si rivolse all’Accademia di Verona perché fosse presa in esame una macchina a vapore di sua invenzione.80 La macchina, costruita sul modello delle macchine a vapore tradizionali, era in grado di sviluppare una forza di “circa tre Cavalli” ed era stata progettata per resistere a 76. Ibid., pp. 153-155. 77. Ibid., pp. 246 78. Ivi. 79. Preventivo della spesa occorrente per la costruzione ed attivazione di una Macchina Idraulica della Fabbrica dell’Ingegnere Meccanico Bartolomeo Avesani in Verona, da porsi in opera nel Pozzo dell’Ospital Militare di Vicenza in S. Maria nuova, in Batolammeo Avesani, Autografoteca Scolari b. 258 – Biblioteca Civica di Verona. 80. Lettera di Bartolomeo Avesani, 21 maggio 1830 – Archivio dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Verona. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 133 temperature e pressioni molto elevate. 81 Ma la sua originalità era in un sistema di valvole attraverso cui Avesani aveva cercato di rimediare ai rischi di scoppio, che all’epoca erano notoriamente frequenti e costituivano uno dei problemi di più difficile soluzione. La commissione nominata dall’Accademia sottopose la macchina a un’analisi minuziosa: si considerò anzitutto la bontà dei materiali di costruzione, poi si riempì la caldaia e se ne misurò la portata (200 litri d’acqua); infine, acceso il fuoco, si alimentò la macchina a legna (6 chilogrammi) e fu cronometrato il tempo impiegato per portare l’acqua ad ebollizione (35 minuti).82 Stabilita la quantità di lavoro generato e il dispendio di energia, venne considerato nei dettagli anche il sistema di circolazione dell’aria e di combustione e, infine, il sistema di sicurezza garantito dalle valvole meccaniche di Avesani.83 I risultati erano nel complesso superiori alle aspettative, tanto che l’inventore veronese fu premiato con una medaglia d’oro e nominato socio onorario dell’Accademia.84 Inoltre, si ordinò che il rapporto dell’analisi e i disegni della macchina fossero stampati in un volume separato delle Memorie pubblicate dall’Accademia (Fig. 1).85 L’anno successivo la stessa macchina fu presentata al Concorso per premj d’industria presso l’I. R. Istituto di Scienze di Milano che confermò l’analisi della commissione dei periti veronesi e premiò Avesani con l’ennesima medaglia d’oro. 86 Grazie alla importante circolazione delle notizie concernenti la nuova macchina assicurata dalle Memorie dell’Accademia, numerose commesse presero ad arrivare al laboratorio di Avesani. A confermare l’efficacia dell’iniziativa commerciale è una lettera senza data, ma certamente degli anni Trenta, conservata presso la Biblioteca Civica di Verona. Si tratta di una proposta di contratto con cui “l’Amministrazione della 81. Ivi. Si apprende in Radice, “Elogio dell’ingegnere meccanico Bartolomeo Avesani”, cit. p. 303, che, sebbene fossero note e oggetto di studio anche in Italia le continue evoluzioni della macchina a vapore, in particolare l’applicazione alla navigazione, il modello di macchina su cui Avesani cominciava a lavorare in quegli anni era quello “elementare” messo a punto da James Watt. 82. Della macchina a vapore, cit., p. 6. 83. Ibid., pp. 7-8. 84. Ms Avesani Ingegnere Bartolommeo, in Libro dei Meriti, Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona, dove si legge: “Eletto [socio] il giorno 8 gennaio 1831 sopra rapporto d’apposita commissione incaricata di esaminare la sua macchina a vapore, ottenne la medaglia d’oro di maggiore grandezza per la detta macchina.” 85. Della macchina a vapore, cit. 86. Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni de’ premj d’industria, cit., v. 5, 18271832, p. 413. 134 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI 1. Bartolomeo Avesani, Sezioni verticali della macchina a vapore in Memorie dell’Accademia di d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona, v. XIII, 1831. (Biblioteca della Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona). CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 135 Società Privilegiata di Battelli di Milano” chiedeva ad Avesani la fabbricazione di una macchina a vapore da impiegare sul battello del Lago di Garda. Nel testo sono indicati tutti i dettagli tecnici che il costruttore avrebbe dovuto soddisfare, ma fin dall’inizio è chiarito che la Società intendeva “mettere ad effetto la nuova Caldaja d’invenzione dell’Ingegnere Meccanico Bartolomeo Avesani, che si compone di legno con particolare processo come già venne pubblicato [...]”.87 Il riferimento è al rapporto prodotto dalla commissione di Verona ed è certo che la pubblicazione di cui si parla è quella delle Memorie dell’Accademia.88 Si tratta forse di dettagli, ma resta il fatto che, a quanto pare, i soci di una ditta di costruzione di battelli erano a conoscenza del lavoro di un inventore attraverso una pubblicazione accademica. Un elemento che conferma, da un lato, quanto fosse importante per Avesani così come per ogni altro inventore far conoscere i propri lavori ed essere accreditato presso un’accademia, dall’altro la fruizione degli atti e delle memorie presso un pubblico non solo di studiosi e tecnici, ma anche di imprenditori. Dopo la messa a punto della macchina a vapore, in effetti, Avesani non fu più solo un inventore, ma cominciò ad essere tenuto in considerazione come perito di macchine per l’industria. Nel 1832, infatti, fu chiamato presso l’Accademia di Verona per prendere parte a una commissione incaricata di valutare l’utilità di un nuovo maglio da sabbia e nel 1837 e nel 1838 fu il giudice di altre invenzioni.89 In quel periodo fu anche eletto socio corrispondente dell’Istituto Veneto e della Società Agraria di Perugia,90 mentre nel frattempo aveva accettato un prestigioso incarico offerto dall’Amministrazione di Verona che necessitava dell’assistenza di un tecnico per la progettazione e l’esecuzione di alcuni lavori di fortificazione.91 Nonostante i nuovi impegni procuratigli dalla fama raggiunta, Avesani continuò a migliorare la macchina a vapore di sua invenzione fino ad applicarla alla filatura della seta, attraverso un sistema che consentiva di sfruttare il vapore come forza motrice e nel contempo di impiegare l’acqua della caldaia per il processo di lavorazione. 87. “Lettera dalla Privilegiata Società di Battelli a Vapore in Milano”, in Avesani Bartolammeo, Autografoteca Scolari, b. 258, Biblioteca Civica di Verona. 88. Della macchina a vapore, cit., p. 5. 89. Ms Avesani Ingegnere Bartolommeo, in Libro dei Meriti, Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona. 90. Bartolammeo Avesani, Autografoteca Scolari b. 258 – Biblioteca Civica di Verona. 91. Radice, “Elogio dell’ingegnere meccanico Bartolomeo Avesani”, cit., p. 306. 136 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI Nel 1843 Avesani chiese all’Accademia di Verona di produrre un’analisi sulla macchina, questa volta mosso dalla precisa intenzione di presentare il rapporto alla Quinta riunione degli scienziati italiani che quell’anno si sarebbe tenuta a Lucca.92 Della commissione facevano parte Giuseppe Zamboni, fisico noto per l’invenzione della pila a secco e eletto a rappresentare l’Accademia di Verona al Congresso; Pietro Maggi, anch’egli impegnato nel campo della fisica dell’elettricità; Nicola Mazza, proprietario di una manifattura tessile; infine i soci dell’Accademia Giuseppe Beretta e Angelo Cominzoni. Erano questi gli esponenti di spicco scelti per dare prova al Congresso dell’impegno di una città, Verona, che, pur non essendo intorno alla metà dell’Ottocento un centro particolarmente vitale né dal punto di vista scientifico né da quello dell’attività industriale, si muoveva con iniziative proprie grazie al lavoro dell’Accademia. Il rapporto redatto dalla commissione era solitamente preceduto da una descrizione dettagliata dell’invenzione, volta a esporne gli elementi di novità. Per quanto concerne la macchina progettata e costruita da Avesani, essa aveva il pregio particolare di utilizzare il vapore, come già accennato, oltre che come motore “il quale fa girare li aspi”, anche per produrre l’acqua calda necessaria per la filatura dei bozzoli, con in più un sistema per il ricircolo dell’acqua calda residua.93 Il vero elemento di innovazione era dunque nel fatto che attraverso il movimento impresso a uno stantuffo dal vapore generato da una caldaia, la macchina non solo consentiva di imprimere una regolarità al volgere degli aspi e metteva a disposizione acqua calda per la filatura, ma garantiva il ricircolo: alla fine del processo, infatti, l’acqua “anziché cader gettata, per alcuni forellini aperti nella caldaja scola e raccogliesi in un condotto ove è assorbita da una tromba aspirante, e ritorna con quell’avanzo di temperatura che tuttavia le rimane al 92. Ms Avesani Ingegnere Bartolommeo, in Libro dei Meriti, Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona. Sui Congressi degli scienziati italiani si rinvia a G. Pancaldi (a cura di), I congressi degli scienziati italiani nell’età del positivismo, Clueb, Bologna, 1983; C. G. Lacaita, “I congressi degli scienziati italiani nella storia del Risorgimento”, in Il Risorgimento, 3, 2001, pp. 7-18; C. Fiuman, I congressi degli scienziati e la cultura agronomica, in Biagioli, Pazzagli, Agricoltura come manifattura, cit., pp. 203-251. 93. “Nuova filanda a vapore; rapporto fatto all’Accademia di Agricoltura, Arti e Commercio di Verona, dai signori Zamboni abate Giuseppe, Mazza abate Nicola, Maggi dottor Pietro, Beretta Giuseppe, e Cominzoni dottor Angelo, ed opinione esternata dal dott. Gera al Congresso degli Scienziati avvenuto in Lucca”, in Giornale agrario lombardo veneto, v. 1, 1844, p. 47. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 137 grande ricettacolo dell’acqua bollente, donde ne è uscita”, non prima di essere stata anche filtrata dalle impurità attraverso “un doppio e fitto setaccio”. 94 Secondo le prove ordinate dall’Accademia, il sistema di ricircolo dell’acqua riscaldata diminuiva la dispersione del calore al punto da ridurre di due terzi, rispetto ai filatori comuni, il consumo della legna impiegata come combustibile e vi erano buoni motivi per “doversene attendere in pratica una più sottile riduzione”.95 Oltre a ciò la commissione metteva in evidenza il poco spazio occupato dalla macchina, la regolarità che il meccanismo messo appunto da Avesani riusciva a imprimere al filatoio e, non ultimo, l’abilità con cui l’inventore, “esclusa ogni maniera di ruote dentate, col porre in loro vece manovelle o correggie”, era riuscito a fornire notevoli garanzie in fatto di controllo dei fenomeni di logoramento.96 La commissione aveva presentato anche una valutazione delle capacità produttive della macchina. Il moto che lo stantuffo mosso dal vapore della caldaia trasmetteva agli aspi garantiva un importante risparmio di personale, in quanto diveniva inutile la presenza della “menatrice”, la persona (solitamente una donna) addetta all’avvolgimento del filo sulla matassa. Grazie al meccanismo che muove il filatoio, si legge sul rapporto, “non è punto d’uopo di mano che aggiri l’aspo e la filatrice basta sola agli altri servigj altrove prestati dalla menatrice”.97 La filatrice “col sol premere di un piede [può] allentare quanto bisogna, ed arrestare eziandio a sua posa il movimento dell’aspo, [e] con esso quello dello zeto [...] senza punto scomporsi dall’atto del suo sedere”.98 Infine i periti dell’Accademia, che avevano provato la macchina con l’ausilio di due filatrici impiegate presso la manifattura tessile diretta da Nicola Mazza, confermavano la qualità del prodotto lavorato: una seta “per nulla inferiore a quella delle migliori filande, sia per sottigliezza ed eguaglianza, sia per morbidezza e lustro del filo”.99 Questo, a parere della commissione, faceva dell’invenzione progettata da Avesani una macchina degna di suscitare attenzione, di cui si auspicava 94. 95. 96. 97. 98. 99. Ibid., p. 49. Ibid., p. 50. Ivi. Ibid., p. 48. Ivi. Ibid., p. 50. 138 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI l’impiego effettivo e per questo premiata dall’Accademia di Verona con una medaglia d’oro.100 Tuttavia al congresso di Lucca, ove fu inviato il solo rapporto prodotto dall’Accademia e non il modello della macchina, il giudizio fu piuttosto negativo. Furono infatti sollevati molti dubbi sia sulla possibilità di utilizzare acqua riciclata per sciogliere la gomma dei bozzoli, sia sul presunto risparmio di combustibile e, infine, anche sull’effettiva novità dell’invenzione. In particolare Luigi Pacinotti, “pur protestandosi mancante di osservazioni pratiche e partendosi dai soli principi teorici”, osservava che una qualsiasi macchina a vapore avrebbe generato una forza eccessiva, certamente superiore a quella necessaria nelle filande. Inoltre Pacinotti osservava che il sistema adottato da Avesani richiedeva lunghi tratti di tubi in rame: questi, proprio per la loro lunghezza, avrebbero provocato una dispersione di calore ed era pertanto da dubitare che la macchina fosse realmente vantaggiosa. A Lucca seguirono altri interventi, tra cui quello dell’ingegnere Tommaso Cini secondo cui “il frutto del capitale impiegato in una macchina a vapore, più il costo del combustibile necessario a tenerla in moto, sono per le comuni filande di seta [...] sempre più gravi della spesa necessaria a farle agire con forza animale”.101 Pur accettando tali obiezioni, il conte Luigi Serristori di Firenze suggeriva che la descrizione della macchina fosse pubblicata su qualche giornale dell’Italia meridionale, al fine di diffondere le notizie dei progressi che si andavano facendo in questo settore.102 A concludere la discussione era però il presidente della commissione Gherardo Freschi, membro dell’Accademia Agraria di Udine, che richiamava i colleghi a non lasciarsi andare ad inutili supposizioni: prima di aver visto la macchina e averne studiato il funzionamento non sarebbe stato possibile stendere alcun giudizio. Pertanto si invitava a “procurare alla Sezione agronomica in questo o nel futuro anno un modello o disegno della macchina, per poterne coscienziosamente ragionare”.103 100. Avesani Ingegnere Bartolommeo, in Libro dei Meriti, Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona. 101. Atti della Quinta Riunione degli Scienziati Italiani tenuta in Lucca nel settembre del 1843, Tipografia Giusti, Lucca, 1844, p. 79. 102. Ibid., p. 78. 103. Ibid., p. 78. CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 139 Conclusione Il caso di Avesani, che si è scelto di esaminare in qualche dettaglio, è l’esempio di un inventore la cui crescita professionale si basa sul tradizionale modello di sviluppo tecnico promosso da accademie minori, come quella di Verona, in concomitanza con grandi istituti quali l’Istituto Lombardo e l’Istituto Veneto. Il cuore di quel sistema, come si è visto, era la riunione dei periti per l’analisi della macchina e l’applicazione di una prassi pressoché identica, sia che si trattasse del Concorso per premj d’industria, sia che fosse l’ “adunanza” di un’accademia minore oppure il Congresso degli scienziati italiani. A conclusione di questo lavoro, vale dunque la pena sottolineare i due significati principali che questo tipo di riunioni sembrano assumere nel Lombardo-Veneto nel periodo 1820-1850. Un primo ordine di considerazioni riguarda l’approccio tecnico-pratico all’oggetto d’innovazione. Com’è emerso dal caso di Bartolomeo Avesani, la commissione eletta per provare una nuova invenzione aveva il compito di valutare su un piano generale l’originalità della macchina, la sua capacità di migliorare tecnologie preesistenti e l’efficienza. Inoltre, i rapporti redatti durante l’esame descrivevano la qualità dei materiali, si soffermavano sui dettagli tecnici di funzionamento, presentavano misurazioni dei consumi e della capacità di produrre un risparmio energetico, esponevano valutazioni sulla resistenza all’usura e così via. La presenza della macchina era condizione essenziale per la stesura di un giudizio: nel 1813 l’efficienza del filatoio di Avesani fu confermata solo quando l’inventore presentò a concorso un modello in scala reale della macchina. Analogamente, i manicotti per le pompe antincendio che Avesani aveva costruito nel 1819 non erano stati premiati con la medaglia d’oro perchè l’autore non aveva fornito la macchina impiegata per la fabbricazione. Anche al Congresso di Lucca il presidente della commissione aveva esortato Avesani a inviare un modello della macchina, senza la quale non si sarebbe potuta azzardare alcuna opinione. Tali criteri instauravano meccanismi di controllo basati sulla convinzione che fosse necessario dimostrare molto concretamente l’utilità delle macchine. La legislazione sui privilegi approntata dal governo austriaco, come si è avuto modo di vedere, non prevedeva queste prassi: l’inventore non era vincolato a sottoporre la propria invenzione ad alcuna analisi e 140 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI doveva, al più, sottostare all’onere di consegnare i disegni che sarebbero stati mantenuti segreti per tutta la durata del privilegio. Per un inventore, la procedura adottata dal sistema dei privilegi era dunque meno impegnativa rispetto a quella delle accademie, perchè non prevedeva prassi di verifica; inoltre era più vantaggiosa, in quanto tutelava un diritto di proprietà sulle scoperte e garantiva all’autore l’uso esclusivo delle macchine privilegiate. Nonostante ciò, Avesani non aderì al sistema dei privilegi e preferì costruire la sua carriera muovendosi tra le più intricate procedure tradizionali mantenute vive dalle accademie. Una riflessione su tale scelta porta al secondo ordine di considerazioni sulla proficuità del sistema delle accademie e dei concorsi e sulle ragioni che contribuirono a mantenerlo attivo. Va anzitutto considerato che le leggi sui privilegi avevano come referente principale il pubblico degli imprenditori più attivi nell’Impero d’Austria e puntavano a coinvolgere le grandi manifatture che ruotavano intorno allo snodo commerciale viennese. Nel Lombardo-Veneto, la forma più diffusa di iniziativa imprenditoriale era invece quella della piccola officina artigiana di cui è rappresentativo il caso di Bartolomeo Avesani. I proprietari, che la gestivano privatamente o con l’ausilio di pochi dipendenti, di rado giungevano ad accumulare capitali sufficienti da investire nella richiesta di un privilegio. Indubbiamente questa situazione costringeva gli artigiani a circoscrivere le proprie ambizioni al mercato locale e li spingeva perciò verso le accademie, allontanando nello stesso tempo la prospettiva dei privilegi. L’accademia esercitava dunque sui piccoli imprenditori un’attrazione molto forte: la riunione per l’analisi di una macchina non era solo il momento di un giudizio tecnico, ma anche l’occasione per l’inventore di guadagnare fama e prestigio attraverso l’assegnazione di una medaglia. Inoltre, in modo ben diverso rispetto all’anonimità della procedura burocratica per l’ottenimento di un privilegio, il concorso era un momento di aggregazione sociale. Là l’inventore aveva l’occasione di incontrare fisici e tecnici, guadagnarsi la loro stima ed eventualmente ottenere la candidatura a socio di un’accademia: proprio per quella via Avesani aveva iniziato la sua carriera di perito nel collaudo di macchine. Inoltre, la partecipazione ai concorsi aveva evidenti risvolti economici: dava infatti all’autore la possibilità di rendere pubbliche le proprie invenzioni, ad esempio attraverso la Collezione degli atti per la distribuzione de’ premj d’industria. Avesani, in particolare, era interessato a pubblicare le sue invenzioni piuttosto che a mantenerle segrete e le of- CONSUETUDINI E PRIVILEGI / 141 ferte di lavoro, giunte dopo l’edizione del rapporto sulla sua macchina a vapore nelle Memorie dell’Accademia di Verona, mostrano che il sistema cui Avesani prestava fiducia era efficiente e funzionale. L’ostacolo maggiore alla diffusione dei privilegi nel Lombardo-Veneto fu probabilmente la proficuità del sistema delle accademie e dei concorsi e il fatto che esso godeva di credibilità sia presso gli inventori come Avesani, che intendevano mostrare le loro macchine, sia presso i clienti eventualmente interessati all’acquisto. È inoltre da considerare che quel tessuto di accademie e concorsi era difficile da smantellare perché saldamente radicato in un contesto sociale in cui il riconoscimento pubblico e l’accreditamento dispensati da quelle istituzioni erano tenuti in grande considerazione. 142 / CONSUETUDINI E PRIVILEGI I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 143 I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE. PER UNA STORIA SOCIOCULTURALE DELL’ASTROFISICA ITALIANA Massimo Mazzotti “Oh Secchi! Guarda l’aurora boreale. È la Comune di Parigi che arriva!”. Una voce proveniente dalla strada, mentre il gesuita Angelo Secchi osserva il fenomeno, rosso intenso, dal tetto della chiesa di Sant’Ignazio (6 febbraio 1872).1 Introduzione In questo saggio si vuole mettere a fuoco l’emergere di nuove pratiche scientifiche presso l’Osservatorio del Collegio Romano verso la metà dell’Ottocento evidenziandone il significato sociale e culturale. Nella prima e seconda sezione del saggio si chiarisce che la presenza di ricerche pionieristiche in campo astrofisico e meteorologico nella Roma pontificia fu un fenomeno tutt’altro che casuale. L’interesse per questi ambiti di ricerca, infatti, va collegato ad una precisa politica di accentramento e controllo territoriale, nonché alla battaglia culturale ingaggiata dal governo romano contro ateismo e materialismo. Nella terza parte del saggio è presa in esame la trasformazione di questa tradizione scientifica locale in un programma di ricerca nazionale, emblematico della nuova scienza italiana. Questo processo di trasferimento tecnico-scientifico è qui caratterizzato come un’operazione di reinterpretazione e utilizzo mirato di risorse materiali e simboliche grazie alla quale i concetti e le pratiche osservative sviluppate nel contesto romano poterono essere mobilitati in supporto del processo di unificazione della giovane nazione italiana. Ringrazio David Aubin, Charlotte Bigg, Otto Sibum e i partecipanti al workshop presso il Max-Planck Institut di Berlino (2003) per i commenti espressi in merito a una versione precedente del presente saggio. Sono grato anche a Ileana Chinnici (Osservatorio di Palermo), Laura Gasparini (Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia), Agnese Mandrino (Osservatorio di Brera) e Luisa Pigatto (Osservatorio di Padova) per la gentile collaborazione. 1. Lettera di Secchi a Denza, 7 febbraio 1872, in M. C. Beltrano, (a cura di), Presenze scientifiche illustri al Collegio Romano, UCEA, Roma, 2001, p. 34. 144 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE Le macchine del papa Negli anni Cinquanta e Sessanta dell’Ottocento, l’Osservatorio del Collegio Romano, gestito dai gesuiti, fu la sede dell’elaborazione e della standardizzazione di tecniche all’avanguardia nella disciplina emergente dell’astronomia fisica o, come sarà chiamata in seguito, astrofisica. Può sorprendere che il governo pontificio, noto per la sua politica culturale reazionaria, favorisse ricerche scientifiche di questo tipo. In effetti, papa Pio IX aveva esplicitamente condannato gran parte dei valori e delle correnti di pensiero associati alla modernità, inclusi la libertà di parola, la democrazia, il liberalismo, il socialismo e la separazione tra stato e chiesa. Il suo Sillabo (1864) è una tipica espressione dell’antimodernismo viscerale diffuso a Roma negli anni immediatamente precedenti l’occupazione della città e la sua annessione al Regno d’Italia. Non si deve desumere, tuttavia, che la chiesa cattolica si opponesse alla scienza e alla tecnologia moderne tout court. Al contrario: durante gli ultimi anni del suo potere temporale, il governo pontificio incoraggiò alcuni progetti di innovazione tecnico-scientifica assai significativi. I successi di questo breve periodo di riforme furono immortalati in una serie di stampe celebrative: un chiaro messaggio rivolto al governo italiano, le cui pretese sulla città eterna erano spesso legittimate in contrapposizione all’oscurantismo scientifico della chiesa. Nella sua lotta contro la nazione italiana, il governo pontificio era pronto a mobilitare ogni risorsa culturale disponibile. Se l’archeologia cristiana rappresenta la manifestazione più evidente di questa strategia, altre discipline scientifiche, come l’astronomia, e vari sistemi tecnologici, come le ferrovie e la telegrafia, furono attivamente supportati e mobilitati durante il pontificato di Pio IX (1846-1878), l’ultimo dei papare. Il pontefice stesso non era estraneo alle scienze sperimentali, avendo completato i suoi studi collegiali con una competente dissertazione sulla costruzione e l’uso dei telescopi.2 2. Pio IX, “Syllabus Errorum”, in Enchiridion delle Encicliche, v. 2, EDB, Bologna, 1996, pp. 521-545. Le stampe si trovano in P. Cacchiatelli, G. Cleter, Le scienze e le arti sotto il pontificato di Pio IX, Tip. Forense, Roma, 1860-1863; ristampato nel 1863-67 e nel 18701874. Sugli studi del pontefice, si veda G. M. Mastai Ferretti [Pio IX], Le macchine ottiche. Esercizio fisico-matematico, Allegrini, Firenze, 1809 e P. Pizzamiglio, G. Tabarroni, Pio IX e le macchine ottiche, Clueb, Roma, 1981. Su Pio IX, si veda G. Martina, Pio IX, 3 v., Edizioni Studium, Roma, 1973-1991. Sulla politica della scienza durante il pontificato di Pio IX si veda anche M. Mazzotti, “For science and for the Pope-King: Writing the history of the exact sciences in nineteenth-century Rome”, in British Journal for the History of Science, 33, 2000, pp. 257-282. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 145 Tra le scienze, l’astronomia giocò dunque un ruolo di rilievo nella politica culturale dello stato pontificio. Nel periodo immediatamente successivo ai moti rivoluzionari del 1848-49 gli astronomi pontifici avevano cominciato a dedicarsi prevalentemente alle ricerche di astrofisica, rompendo così con la tradizione precedente imperniata sull’astronomia di posizione. La nuova importanza attribuita alla dimensione fisica dell’astronomia segnò un mutamento concettuale, nonché un radicale cambiamento di pratiche e tecnologie. Questa rivoluzione fu guidata dal principale osservatorio pontificio, quello del Collegio Romano, e più specificamente dal suo direttore, il gesuita Angelo Secchi (1818-1878). Fisico sperimentale per formazione, Secchi era stato costretto ad abbandonare Roma nel 1848 e a portare a termine gli studi presso il collegio gesuita di Stonyhurst, nel Lancashire. Secchi cominciò la sua carriera scientifica insegnando fisica sperimentale al collegio gesuita di Georgetown, vicino Washington, dove pubblicò i suoi primi studi sulla misurazione della resistenza elettrica e l’applicazione dell’elettricità alla telegrafia. Il suo interesse per l’astronomia e la meteorologia nacque in questo periodo, durante la collaborazione con padre James Curley (1796-1889), il direttore dell’osservatorio gesuita di Georgetown, e con il capitano Matthew Fontaine Maury (1806-1873), un ufficiale della marina americana noto per i suoi studi di meteorologia e oceanografia. Verso la fine del 1849, l’ordine regnava nuovamente in Europa continentale e ai gesuiti fu concesso di tornare alle istituzioni d’origine. A Secchi fu offerta una cattedra universitaria al Collegio Romano e la direzione del prestigioso osservatorio, carica che mantenne fino alla sua morte, avvenuta nel 1878. Nel corso di questo lungo e travagliato periodo, Secchi e i suoi collaboratori poterono sempre contare sulla fiducia e la protezione di Pio IX.3 Fu proprio l’interessamento personale del pontefice e una serie di donazioni private, che permisero al giovane Secchi di rinnovare completamente l’osservatorio in meno di un anno dalla sua nomina a di3. Per i dati biografici e le pubblicazioni si vedano J. Pohle, P. Angelo Secchi, ein Lebens und Kulturbild, Bachem, Colonia, 1883; C. Bricarelli, “Della vita e delle opere del P. Angelo Secchi”, in Memorie della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei, 4, 1888, pp. 41-105 e G. Abetti, Padre Angelo Secchi, il pioniere dell’astrofisica, Agnelli, Milano, 1928. Si veda inoltre, I. Chinnici, W. Gramatowski, “Le carte di Angelo Secchi S. J. (1818-1878) conservate presso la Pontificia Università Gregoriana. Un inventario inedito rivisitato”, in Nuncius, 16, 2001, pp. 571-627. 146 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE 1. L’equatoriale di Merz dell’Osservatorio del Collegio Romano in Angelo Secchi, L’astronomia in Roma nel pontificato di Pio IX, Tip. Della Pace, Roma, 1877, tav. V. (Collezione privata). rettore. Furono acquistati numerosi strumenti nuovi, tra i quali un equatoriale Merz di 24,5 cm di apertura e 430 cm di distanza focale: il telescopio più grande in Italia al momento dell’acquisto, nel 1853 (Fig. 1). Il pontefice favorì inoltre l’acquisizione di nuovi strumenti per l’osservatorio universitario del Campidoglio, la cui direzione fu affidata nel 1865 a Lorenzo Respighi (1824-1889), devoto cattedratico proveniente da Bologna, che aveva svolto ricerche all’avanguardia in campo spettroscopico e si era rifiutato di prestare giuramento al re d’Italia.4 Per il suo nuovo osservatorio, Secchi scelse una posizione estremamente simbolica: il tetto della chiesa di Sant’Ignazio presso il Collegio Romano (Fig. 2). Gli strumenti furono collocati sopra enormi pilastri che nel progetto originale avrebbero dovuto sorreggere una cupola di diciotto metri di diametro, mai edificata. Al posto di una sola cupola Secchi ne fece erigere tre, apribili e in metallo e legno, entro cui furono collocati telescopi e macchinari elettrici. Oltre alla cupola per l’equatoriale di Merz, l’osservatorio aveva una cupola per il circolo meridiano 4. A. Secchi, L’astronomia in Roma nel pontificato di Pio IX, Tip. della Pace, Roma, 1877; Pizzamiglio, Tabarroni, Pio IX e le macchine ottiche, cit.; G. Ferrari, Lorenzo Respighi: suo elogio nell’anniversario della morte, Cuggiani, Roma, 1891. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 147 2. L’Osservatorio del Collegio Romano negli anni Sessanta dell’Ottocento in Angelo Secchi, L’astronomia in Roma nel pontificato di Pio IX, cit., tav. III. (Collezione privata). di Ertel e una per il rifrattore di Cauchoix (di 16,3 cm di apertura), quest’ultimo da utilizzarsi esclusivamente per l’osservazione solare. L’osservatorio includeva anche una sezione meteorologica e, nel 1858, nelle sale attigue divenne operativo il primo osservatorio magnetico in Italia, per lo studio del magnetismo terrestre in relazione all’attività solare. Con la nomina di Secchi a direttore del servizio meteorologico pontificio, l’osservatorio divenne anche il centro di una rete telegrafica di stazioni meteorologiche sparse da un capo all’altro dei territori pontifici. Il servizio era indirizzato a diverse istituzioni pontificie e Secchi elaborò il progetto per il coordinamento delle osservazioni meteorologiche in stretta collaborazione con il ministero del commercio e la marina militare. I dati raccolti dall’osservatorio e dalla rete di stazioni a esso collegate cominciarono a essere pubblicati regolarmente in un bollettino – il Bullettino Metereologico dell’Osservatorio del Collegio Romano – in cui le osservazioni astronomiche, meteorologiche e magnetiche erano presentate insieme, formulate in una prospettiva fisica unitaria. La stessa pianta dell’osservatorio di Secchi rispecchiava efficacemente il nuovo ordine dell’astronomia fisica, con le sezioni magnetiche, elettriche e meteorologiche a circondare e integrare la grande cupola dell’equatoriale di 148 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE Merz, essa stessa ricolma di strumenti spettroscopici per l’osservazione del sole e delle stelle.5 Il passaggio di Secchi dall’astronomia di posizione all’astrofisica e alla meteorologia avvenne in un periodo di mutamenti sociali radicali per lo stato pontificio e per l’Italia. Tra le altre cose, i moti del 1848-49 avevano dato origine a un esperimento repubblicano nella stessa città del papa: la Repubblica Romana, schiacciata solo grazie all’intervento militare francese. Con la restaurazione del governo pontificio cominciò una fase di importanti mutamenti politici e amministrativi, atti a rafforzarne il potere temporale e spirituale. Si implementarono, ad esempio, nuove forme di disciplina religiosa nelle istituzioni ecclesiastiche e tra i sacerdoti secolari si istituì un sistema centralizzato di formazione religiosa, inoltre, si rafforzò la gerarchia episcopale a livello mondiale, soprattutto nei paesi protestanti. Nel 1870 la proclamazione del dogma dell’infallibilità del papa rientra chiaramente in questa strategia di centralizzazione. Il nuovo dogma consentì alla curia romana di disciplinare più efficacemente i ranghi della chiesa cattolica in tutto il mondo, trasformandola in un’istituzione più compatta, uniforme e controllabile di quanto non fosse stata sino allora. Questa operazione di disciplinamento era giudicata necessaria per guidare la chiesa in un ambiente sociale e culturale in rapido cambiamento, caratterizzato da potenti forze separatiste e nazionaliste.6 Per quanto concerne il controllo del territorio pontificio, il governo ridusse le tradizionali autonomie locali nel tentativo di rafforzare il potere centrale. Allo stesso tempo i romani impararono a scandire il mezzogiorno con il colpo di cannone di Castel Sant’Angelo, sede delle famigerate carceri papali. Le guardie svizzere furono addestrate a sparare con precisione al segnale ottico mandato dall’osservatorio di Sec5. Il rifrattore di Cauchoix accompagnò Secchi durante la spedizione pontificia in Spagna per l’eclissi del 1860. In quell’occasione, il confronto tra le fotografie ottenute da Secchi e quelle di Warren De La Rue dimostrò che le protuberanze solari non erano un’illusione ottica, ma un fenomeno realmente appartenente al sole. Si veda W. De La Rue, “Comparison of Mr. De La Rue’s and Padre Secchi’s eclipse photographs”, in Proceedings of the Royal Society of London, 13, 1863-1864, pp. 442-444. Sulla strumentazione magnetica di Secchi, si veda A. Secchi, Descrizione dell’osservatorio magnetico del Collegio Romano e sunto delle osservazioni fatte nel 1859 e 1860, Tip. delle Belle Arti, Roma, 1860. 6. P. Gavazzi, “Pio IX e la riforma degli ordini religiosi (1846-1857)”, in Atti del II convegno di ricerca storica sulla figura e sull’opera di papa Pio IX, Centro Studi Pio IX, Senigallia, 1977, pp. 203-242; A. Polverari, Vita di Pio IX, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, v. 2, 1986-88, p. 97; G. Martina, Pio IX, cit., v. 1, pp. 463-465 e v. 2, pp. 693-698; C. Fiorentino, La questione romana intorno al 1870, Archivio Guido Izzi, Roma, 1997, pp. 45-113. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 149 chi: era stato il pontefice in persona a suggerire quella innovazione, cui era seguita la sincronizzazione di tutti gli orologi del Regno con l’ora meridiana romana. Il controllo esercitato da Secchi sul tempo dei romani divenne così ampio da includere la supervisione di tutti gli orologi solari dello stato. La standardizzazione del tempo a livello nazionale rispondeva ad una duplice necessità. Da essa dipendeva infatti il funzionamento delle nuove infrastrutture pontificie, prima tra tutte il sistema ferroviario. Ma l’abitudine all’uso del tempo standard era anche necessaria per l’applicazione del nuovo regime osservativo instaurato da Secchi, che si fondava sulla raccolta sincronizzata di dati. Similmente, la rete di linee telegrafiche che si sviluppò sul territorio pontificio durante gli anni Cinquanta dell’Ottocento, doveva servire a molteplici scopi. Secchi supervisionò l’installazione delle macchine telegrafiche e la stesura dei cavi: sin dall’inizio funzionarono sia come sistema di comunicazione al servizio del governo, sia come sistema per connettere le macchine per la registrazione automatica dei dati nelle stazioni dipendenti dall’osservatorio. Inoltre, i cavi telegrafici potevano fungere essi stessi da strumenti scientifici. La prima linea telegrafica pontificia collegava i palazzi vaticani al porto di Anzio e alla residenza papale di Castel Gandolfo. Il duplice impiego di questa linea come sistema di comunicazione chiave per il governo e strumento scientifico per lo studio del magnetismo terrestre mostra chiaramente la natura eterogenea della pratica scientifica di Secchi e il livello di controllo da lui esercitato sulle infrastrutture tecnologiche pontificie.7 L’enfasi sui temi della comunicazione e del controllo fu anche all’origine della produzione di un gran numero di dati statistici sulle condizioni dello stato pontificio, a partire dal censimento generale del 1853. Le notevoli perdite territoriali del 1859-60 non fecero che accelerare processi di questo genere. Con il confine dei territori papali ormai fissato a 30 chilometri da Roma, la sopravvivenza della città eterna dipendeva essenzialmente dalla sua integrazione con le infrastrutture e le economie delle regioni italiane limitrofe. Il governo pontificio programmò quindi ulteriori investimenti strategici per ferrovie, linee tele7. A. Secchi, Memoria sulla relazione de’ fenomeni meteorologici colle variazioni del magnetismo terrestre, Tip. delle Belle Arti, Roma, 1864, p. 16. Secchi utilizzò inoltre le linee telegrafiche per “osservare” le stelle cadenti. Si veda la lettera scritta da Secchi a Schiaparelli datata 13 agosto 1866, in L. Buffoni, A. Manara, P. Tucci (a cura di), G. V. Schiaparelli, A. Secchi. Corrispondenza, 1861-1878, Artes, Milano, 1991, p. 63. 150 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE grafiche e ponti sospesi, favorendo anche la creazione di nuove banche commerciali e società di capitali. Il dodicesimo anno del pontificato di Pio IX fu celebrato, appropriatamente, con il conio di una medaglia che rappresentava su un lato il pontefice e sull’altro una locomotiva in piena corsa.8 L’osservatorio di Secchi fu un luogo chiave per questo estremo tentativo di modernizzazione dello stato pontificio. Principale consigliere del pontefice in campo scientifico, Secchi dedicò buona parte del suo tempo a sovrintendere, con i suoi assistenti, operazioni apparentemente distanti dalle pratiche osservative: triangolazioni cartografiche ad esempio, ma anche progettazione e installazione di linee telegrafiche, reti idriche e fari per la navigazione costiera. In realtà, come abbiamo visto nel caso delle linee telegrafiche, il regime osservativo instaurato da Secchi era fin dall’inizio congruente con il progetto di modernizzazione dello stato: ne era anzi una condizione essenziale. In altre parole, le pratiche sperimentali e la disciplina osservativa forgiate nell’osservatorio di Secchi erano certamente indirizzate allo studio della fisica terrestre e di quella celeste, ma rendevano al tempo stesso possibile l’implementazione di importanti riforme socio-tecniche. L’Osservatorio del Collegio Romano fu quindi il luogo di incontro privilegiato tra le necessità impellenti dello stato e le nuove pratiche di osservazione della nascente comunità astrofisica. La relazione tra il regime osservativo di Secchi e i bisogni dello stato divenne così stretta che i confini dell’osservatorio di Secchi arriveranno a coincidere con quelli dello stesso stato pontificio: abbiamo visto come le nuove infrastrutture progettate da Secchi potessero trasformarsi in strumenti scientifici al servizio dell’osservatorio.9 Lo studio delle macchine disegnate per l’osservatorio di Secchi offre ulteriori indizi sulla correlazione tra pratiche osservative e lotta dello stato pontificio per la sopravvivenza. 8. L’iscrizione sulla medaglia recita: “Providentia P(ontificis) M(aximis) / Ferrea Via Romam Provinciis Jvngi Curavit.” Si vedano, Pizzamiglio, Tabarroni, Pio IX e le macchine ottiche, cit., p. 13 e M. Caravale e A. Caracciolo, Lo stato pontificio da Martino V a Pio IX, Utet, Torino, 1978, pp. 667-740. 9. A. Secchi, Misura della base trigonometrica eseguita sulla via Appia per ordine del governo pontificio nel 1854-55, Tip. della Rev. Camera Apostolica, Roma, 1858. Per una storia culturale dei regimi osservativi ottocenteschi, si veda S. Schaffer, “Astronomers mark time: Discipline and the personal equation”, in Science in Context, 2, 1988, pp. 115-145. Sul rapporto tra laboratorio e nazione nell’Ottocento, si veda anche B. Latour, The Pasteurization of France, Harvard University Press, Cambridge MA, 1988. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 151 Secchi progettò personalmente numerosi strumenti, dagli spettroscopi ai barometri, il più famoso dei quali è il meteorografo per la registrazione automatica dei parametri meteorologici (1858). Questa macchina imponente fu messa a punto in collaborazione con la società romana Brassart, nota per la costruzione di strumenti di precisione. La macchina doveva registrare e organizzare il flusso costante di informazioni raccolte dalla rete di stazioni sparse sul territorio pontificio al fine di facilitare lo studio del tempo meteorologico, che per Secchi era di per sé una “macchina immensa”. La registrazione dei dati poteva avvenire a notevole distanza dallo strumento perché Secchi aveva integrato tecnologie meccaniche e elettriche, avvalendosi della propria esperienza nella trasmissione telegrafica. Ma questo notevole strumento doveva anche servire per rompere l’isolamento diplomatico e culturale dello stato pontificio. Pio IX, infatti, donò 20.000 franchi per completare un modello elegantemente rifinito da inviare all’esposizione universale di Parigi del 1867 (si tenga presente che un buon stipendio annuo di un impiegato statale a Roma ammontava a 1.500 franchi circa). Lo strumento vinse il Grand Prix e Secchi fu insignito della legion d’onore, causando visibile irritazione tra i rappresentanti italiani.10 Il design del meteorografo incarnava aspetti importanti della pratica scientifica di Secchi. Sul tetto della chiesa di Sant’Ignazio gli astronomi pontifici raccoglievano, elaboravano e pubblicavano una quantità senza precedenti di dati astronomici, meteorologici e magnetici. I dati erano prodotti da una rete capillare di stazioni in cui operavano pochi ma affidabili collaboratori. La capacità di coordinare le attività di misurazione con gruppi di collaboratori operanti a distanza fu decisiva per l’implementazione della nuova pratica e richiese la soluzione di notevoli problemi di addestramento, standardizzazione e fiducia. La rete di osservazione di Secchi includeva confratelli gesuiti, ma anche impiegati statali, ingegneri pontifici e ecclesiastici appartenenti a vari ordini. Non tutti risposero in modo adeguato: se i telegrafisti erano particolarmente efficienti nel fornire a Secchi informazioni utili, certi ordini religiosi incaricati della raccolta di dati meteorologici sembravano molto meno entusiasti del suo regime osservativo, che egli stesso descriveva 10. A. Secchi, Descrizione del meteorografo dell’osservatorio del Collegio Romano, Tip. delle Belle Arti, Roma, 1870, p. 8. Paolo Brenni ha restaurato uno dei meteorografi di Secchi per l’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze. P. Brenni, “Il meteorografo di padre Angelo Secchi”, in Nuncius, 8, 1993, pp. 197-247. 152 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE come ispirato allo “spirito tedesco” e quindi basato sulla “paziente osservazione e materiale ripetizione della stessa cosa milioni di volte”. A dire il vero, anche alcuni studenti di Secchi mostrarono una scarsa inclinazione per i suoi metodi, una reazione che il padre gesuita attribuiva invariabilmente a una carenza morale, a “mancanza di carattere”. Al contrario, la registrazione automatica e il confronto meccanizzato dei dati effettuati dal meteorografo offrivano il modello migliore della disciplina che, secondo Secchi, avrebbe regolato le pratiche osservative nel prossimo futuro.11 Il meteorografo di Secchi non conteneva alcun componente essenzialmente nuovo ma, come la maggior parte dei suoi strumenti spettroscopici e meteorologici, era progettato per evidenziare eventuali relazioni tra diversi tipi di fenomeni al momento stesso della loro misurazione. In altre parole, questo strumento registrava e visualizzava contemporaneamente numerosi parametri – ad esempio temperatura, pressione, o l’intensità del campo magnetico – offrendo allo sguardo del ricercatore una mappa di relazioni che poteva suggerire, in alcuni casi, l’esistenza di nessi tra fenomeni apparentemente non correlati. In tal modo il meteorografo divenne emblematico del regime osservativo di Secchi, che era basato proprio sulla costruzione di relazioni tra i fenomeni astronomici, meteorologici e magnetici. Si noti anche che il meteorografo forniva i dati in forma visiva, attraverso grafici piuttosto che tavole numeriche. Secondo Secchi, questa scelta avrebbe facilitato l’individuazione di relazioni e influenze tra fenomeni di diverso tipo. La superiorità intrinseca delle rappresentazioni visive dei fenomeni rispetto a quelle numeriche era una convinzione che caratterizzava le pratiche osservative di Secchi rispetto a quelle di altri astronomi contemporanei e derivava da una sua più generale fiducia nella priorità euristica ed epistemologica del visivo sopra l’astratto e il matematico.12 Fu proprio nel tentativo di meccanizzare la registrazione delle informazioni visive che Secchi cominciò a studiare l’errore dell’operatore nell’osservazione astronomica, fiducioso che in futuro il fattore umano 11. Sugli studenti indisciplinati si veda la lettera di Secchi a Schiaparelli, 30 giugno 1868, in Buffoni, Manara, Tucci (a cura di), G. V. Schiaparelli, A. Secchi. Corrispondenza, cit., pp. 176-177, citazione da p. 177. Sui monaci indisciplinati si veda la lettera di Secchi a Denza, 22 febbraio 1876, in Feltrano, (a cura di), Presenze scientifiche illustri, cit., pp. 35-36. 12. Per un caso di studio sui significati sociali e culturali della opposizione tra cognizione visiva e forme di cognizione basate su procedure algoritmiche, si veda M. Mazzotti, “The geometers of God: Mathematics and reaction in the Kingdom of Naples”, in Isis, 87, 1998, pp. 678-701. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 153 potesse essere eliminato totalmente grazie all’integrazione di tecnologie fotografiche e elettriche. Nel 1851 Secchi aveva cominciato a sperimentare con il collodio, scattando fotografie della luna, dei pianeti e del sole. Nutriva grandi speranze nel progresso della fotografia come mezzo di registrazione oggettiva. In attesa dell’osservatore non umano perfetto, però, ci si doveva accontentare dei mezzi a disposizione, vale a dire una disciplina rigida e la standardizzazione delle tecniche di rappresentazione. Di qui l’impegno straordinario di Secchi e dei suoi collaboratori per la produzione di tavole a colori estremamente dettagliate rappresentanti i fenomeni celesti, soprattutto la superficie e le protuberanze solari. La precisione di quelle tavole divenne presto una caratteristica distintiva dell’attività dell’Osservatorio del Collegio Romano.13 Il meteorografo, infine, incarnava la dimensione universale dell’attività scientifica pontificia. L’osservatorio di Secchi non era solo al centro di una rete telegrafica che collegava le stazioni meteorologiche sparse da un capo all’altro degli stati della chiesa, ma era anche al centro della rete mondiale di osservatori e stazioni meteorologiche gestite dalla Compagnia di Gesù. Questi osservatori ospitarono ben presto esemplari del meteorografo di Secchi, la cui presenza si spinse così fino a Shanghai, L’Avana, Manila e Washington. La portata dell’attività di questa rete di strumenti era quindi globale, come dimostrano i risultati della ricerca gesuita sul magnetismo terrestre o gli studi sismologici che avrebbero portato nel nuovo secolo la visione cattolica della ricerca scientifica tipica di Secchi e dei suoi collaboratori. Il meteorografo era dunque anche emblema della dimensione globale della ricerca scientifica pontificia, una ricerca che ambiva a rispec13. Sull’importanza della rappresentazione dei dati in forma visiva si veda A. Secchi, Descrizione dell’osservatorio magnetico del Collegio Romano e sunto delle osservazioni fatte nel 1859 e 1860, Tip. Delle Belle Arti, Roma, 1860, p. 7. Sullo stesso tema si veda la controversia tra Secchi e Rudolphe Radau (Brenni, “Il meteorografo di padre Angelo Secchi”, cit., pp. 225-229); e la convinzione di Secchi che nessuna teoria fisica può essere fondata solo sull’analisi (A. Secchi, L’Unità delle forze fisiche: saggio di filosofia naturale, 2 v., Treves, Milano, [1864] 1874). Sulla completa meccanizzazione dell’osservazione si veda la lettera di Secchi a Schiaparelli, 8 gennaio 1868, in Buffoni, Manara, Tucci (a cura di), G. V. Schiaparelli, A. Secchi. Corrispondenza cit., p. 166. Sulle tecniche e gli strumenti fotografici di Secchi, si vedano A. Secchi, Fotografie lunari e degli altri corpi celesti, Tip. delle Belle Arti, Roma, 1859; Id., Relazione delle osservazioni fatte in Spagna durante l’eclisse totale del 18 luglio 1860, Tip. delle Belle Arti, Roma, 1860 e L. Gasparini, “Padre Angelo Secchi e l’applicazione della fotografia nelle osservazioni astronomiche”, in Fotologia, 12, 1992, pp. 35-47. Si veda inoltre P. Becchetti, La fotografia in Roma dalle origini al 1915, Colombo, Roma, 1983. 154 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE chiare la missione universale della Chiesa. In tal senso contribuiva a rafforzare l’immagine di Roma come città sopranazionale e quindi essenzialmente non-italiana.14 L’universo unificato Gli aspetti salienti della pratica scientifica di Secchi che abbiamo cercato di delineare nelle pagine precedenti erano radicati in una particolare concezione della realtà fisica. Nelle stanze sul tetto di Sant’Ignazio, come si è detto, non c’era più spazio per la tradizionale astronomia di posizione. Lo studio dei corpi celesti, e del sole in particolare, era significativo e degno di approfondimento solo in quanto poteva favorire la comprensione delle relazioni fisiche tra le varie componenti del creato. È in questa prospettiva dunque che, verso il 1850, Secchi cominciò ad applicare la propria esperienza nella misurazione delle correnti elettriche all’analisi delle proprietà fisiche del sole. Da qui allo studio su larga scala delle variazioni magnetiche fino al lavoro di classificazione degli spettri stellari, Secchi continuerà a colmare il divario tra cieli e terra per mezzo della sua strumentazione elettrica, magnetica e spettroscopica. Nell’osservatorio di Secchi anche la pratica tradizionale dell’osservazione ottica muta di significato, consacrata com’è principalmente allo studio morfologico di fenomeni come le protuberanze solari, da mettere in relazione a specifiche proprietà fisiche dei corpi celesti e quindi, da ultimo, al rafforzamento del quadro generale di un universo unificato.15 La natura eterogenea delle pratiche osservative di Secchi e la loro sistematica commistione di fisica celeste e terrestre riflettevano una concezione dell’universo come essenzialmente omogeneo e intelligibile nei soli termini di materia e moto. Secchi aveva derivato questa immagine meccanicistica della realtà fisica da correnti sperimentali e filosofiche preesistenti all’interno della cultura cattolica. Anche nella sua difesa del dogma religioso sulla base dell’adesione a una metafisica rigorosa14. M. Sanchez Navarro-Neumann, “Os Jesuitas e a sismologia”, in Broteria, 24, 1937, pp. 141-151; A. Udías, W. Stauder, “The Jesuit contribution to seismology”, in Seismological Research Letters, 67, 1996, pp. 10-19. 15. Sulle prime ricerche di Secchi, si veda A. Secchi, Ricerche di reometria elettrica, Tip. delle Belle Arti, Roma, 1850; Id., Sul modo di valutare la forza del raggiamento solare, Tip. delle Belle Arti, Roma, 1851. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 155 mente dualistica, Secchi riprendeva una strategia apologetica ben collaudata. Agli inizi dell’Ottocento si era assistito a vari tentativi di integrazione dei recenti sviluppi delle scienze, soprattutto la fisica, con l’apologia della religione cattolica e la difesa del dogma teologico. A Roma l’Accademia dei Nuovi Lincei (1801), la cattedra di Fisica Sacra dell’Università La Sapienza (1816) e la Scuola di Applicazione per gli ingegneri (1817) furono istituzioni create proprio per sostenere un rinnovamento degli studi scientifici in linea con la restaurazione della fede religiosa e dell’ordine sociale. Gli ecclesiastici più favorevoli allo studio delle scienze moderne cercavano così di mostrare che la scienza ha la capacità di spiegare l’armonia superiore del creato senza condurre necessariamente all’adozione di dottrine materialistiche. L’obiettivo primario dello scienziato cattolico doveva essere dunque quello di rompere l’infausta alleanza tra ricerca sperimentale e filosofia atea, reagendo così all’abuso della scienza che si attribuiva all’Illuminismo. La battaglia anti-illuminista si affiancava comunque al pieno riconoscimento del valore pratico della scienza moderna e della tecnologia, di cui era anche riconosciuto il ruolo nello sconfiggere la metafisica scolastica e la superstizione. A partire dagli anni Venti dell’Ottocento questa strategia culturale, detta “concordista”, fu ulteriormente sviluppata ed elaborata, soprattutto da studiosi gesuiti. Nel 1824 il pontefice aveva restituito il Collegio Romano alla Compagnia, nel tentativo di favorire la rinascita della autorevole tradizione scientifica gesuita. Negli stessi anni le opere di Galileo furono tolte dall’Indice dei libri proibiti, mentre con la bolla Quod divina sapientia si offriva la piena legittimazione teologica alla ricerca sperimentale. Questa rinnovata alleanza tra religione e scienza si fondava sui principi di un mitico sperimentalismo galileiano: il nemico non era la scienza in quanto tale, bensì il meccanicismo materialistico e il determinismo matematico.16 16. Per l’iniziale approccio concordista, si veda S. Proja, “Cenni intorno alla cattedra di fisica sacra dell’archiginnasio romano”, in Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti, 74, 1837, p. 108. Per l’approccio gesuita, si veda E. Vasco, Il Ratio studiorum adattato ai nostri tempi, 2 v., Civiltà Cattolica, Roma, 1851. Sulle basi filosofiche e metafisiche della pratica scientifica di Secchi e le loro radici nella cultura cattolica, si veda P. Redondi, “Cultura e scienza dall’illuminismo al positivismo”, in G. Micheli (a cura di), Storia d’Italia, Annali 3, Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi, Einaudi, Torino, 1980, pp. 797-811. Si veda inoltre, P. Redondi, “Physique et apologetique. Le Cosmos de l’abbé Moigno et de Marc Seguin” in History and Technology, 6, 1988, pp. 203-225. 156 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE Un tipico rappresentante di questo movimento fu il gesuita Giovan Battista Pianciani (1786-1862), insegnante e compagno di esilio di Secchi. Sin dagli anni Venti Pianciani aveva sostenuto che la ricerca in campo elettrico e magnetico poteva condurre alla scoperta di un ordine e di un’unità profondi al di là della varietà dei fenomeni fisici. Nei suoi numerosi studi sulla chimica e l’elettricità Pianciani rifiutava la nozione di “fluido elettrico” e i modelli fisico-matematici ad essa correlati a favore di un modello cosiddetto dinamista. In questo modello i processi naturali erano spiegati in termini di agenti correlati in grado di trasformarsi l’uno nell’altro, come il calore e il moto, le forze elettriche e quelle magnetiche. Questo atomismo e dinamismo gesuita si sviluppò in opposizione alla contemporanea rinascita neo-scolastica dell’ilomorfismo e affondava le proprie radici in una visione agostiniana della causa prima come fondamento di tutti i fenomeni naturali.17 Secchi, uno degli scienziati ecclesiastici più autorevoli della sua epoca, contribuì in maniera sostanziale al successo di questo sperimentalismo spiritualistico. Il suo manifesto filosofico, un libro del 1864 sull’unità delle forze fisiche, era stato scritto per infondere nuova vita nell’insegnamento della fisica a Roma, ma incontrò un ben più ampio successo, come indicato dalle traduzioni in francese e tedesco. In questo saggio le leggi fisiche e la struttura della materia vengono presentate nel contesto di una rappresentazione unitaria dei fenomeni, alla cui base si trova il movimento molecolare. Secchi criticava l’interpretazione realista della forza, la nozione di forza agente a distanza e quella dei vari fluidi materiali. Ispirato, invece, dalla teoria meccanica del calore, Secchi introdusse l’etere come mezzo materiale (ma imponderabile) per tutte le trasformazioni fisiche. Poteva così concludere che tutte le forze naturali sono semplicemente forme diverse del moto della materia ponderabile e imponderabile. In futuro, secondo Secchi, si sarebbe potuto arrivare a dimostrare che la stessa materia ponderabile è costituita soltanto da vortici di etere.18 17. Si veda G. B. Pianciani, Istituzioni fisico-chimiche, Puccinelli, Roma, 1833-34. 18. A. Secchi, L’unità delle forze fisiche (ed. in lingua francese, L’unité des forces physiques, essai de philosophie naturelle, Savy, Paris, 1869; e Die Einheit der Naturkräfte, ein Beitrag zur Naturphilosophie, Frohberg, Leipzig, 1876). Si veda inoltre, Id. Lettera su di un problema cosmologico Tip. Marini, Roma, 1862. Importanti risorse per la fisica sperimentale di Secchi furono alcuni lavori di fisici italiani della prima metà del secolo, come Macedonio Melloni (1798-1854), che aveva approfondito l’analogia tra luce e calore, e Ambrogio Fusinieri (1775-1849), il cui approccio fenomenico e anti-materialistico era divenuto estremamente autorevole nel periodo della Restaurazione. Si vedano, M. Melloni, Mémoire sur I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 157 L’unione tra la metafisica dualistica e ciò che Secchi chiamava un “sano sperimentalismo” trovò piena espressione nella pratica dell’osservatorio pontificio. Il legame tra la nuova fisica dinamista e le scienze osservative era evidente agli occhi di Secchi: l’astronomia tradizionale non era in grado di spiegare un numero crescente di fenomeni celesti proprio perché ignorava la teoria dell’universo unificato e il suo rapporto con le tecniche spettroscopiche. A loro volta, il programma di ricerca dell’astrofisica e le sue tecniche di osservazione potevano fornire il necessario sostegno empirico alla filosofia naturale di Secchi, risultando vitali per il suo progetto più ampio di ridurre tutte le leggi fisico-chimiche a due soli fattori: materia e moto. Considerato questo sfondo di presupposti e aspettative è facile capire il motivo per cui la notizia delle scoperte di Gustav Kirchhoff nel campo dell’analisi spettrale (1859) e la sua mappa dello spettro solare suscitarono il massimo interesse a Roma, al contrario di quanto avvenne in altri importanti osservatori italiani ed europei. In realtà, la competenza in campo spettroscopico non era appannaggio esclusivo degli osservatori romani. Già nel 1860, a Firenze, Giovan Battista Donati (18261873) e il costruttore di strumenti Giovan Battista Amici (1786-1863) avevano sviluppato uno spettroscopio a fenditura con collimatore (quello che di lì a poco sarebbe diventato lo spettroscopio standard), che usarono per lo studio e la classificazione di alcune stelle. La correlazione individuata da Donati tra gli spettri stellari e i relativi colori fu certamente uno dei punti di partenza della ricerca spettroscopica di Secchi. Donati, tuttavia, lavorava ancora in un contesto pratico-teorico tradizionale: non utilizzava gli strumenti spettroscopici per analizzare la struttura fisica dei corpi celesti, bensì per calcolarne la posizione. L’approccio di Donati alle tecniche spettroscopiche, a cui riservava comunque un ruolo marginale nell’economia complessiva delle scienze osservative, era chiaramente alla base del suo scetticismo circa l’introduzione della spettroscopia negli “osservatori di prim’ordine”. Era questo atteggiamento che distingueva Donati e altri pionieri delle tecniche spettroscopiche da Secchi e dai suoi giovani seguaci italiani, come Pietro l’identitè des diverses radiations lumineuses, calorifiques et chimiques vibrées par le soleil et les sources terrestres, Ramboz, Ginevra, 1842; A. Fusinieri, Memorie sperimentali di meccanica molecolare, Sicca, Padova, 1844; Id., Memorie sopra la luce, il calorico, la elettricità, il magnetismo, l’elettro-magnetismo ed altri oggetti, Sicca, Padova, 1846. Su Fusinieri, ma anche su Secchi, si veda Redondi, “Cultura e scienza dall’illuminismo al positivismo”, cit., pp. 721-729. 158 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE Tacchini, futuro presidente della Società degli Spettroscopisti Italiani, e dal padre barnabita Francesco Denza (1834-1894), astrofisico e futuro direttore della Società Meteorologica Italiana.19 Al corrente del lavoro di Donati sulle stelle e in possesso di uno spettroscopio Hofmann a visione diretta – un dono di Jules Janssen (18241907) – Secchi iniziò lo studio degli spettri stellari nel 1862, studio che ricollegò immediatamente a quello della costituzione della materia dei corpi celesti e alla soluzione di “importanti questioni cosmiche”. Secchi commissionò poi a Hofmann e Merz la produzione di spettroscopi speciali a prisma multiplo che consentivano la visione simultanea di numerosi spettri stellari. È con questi strumenti che intraprese la sua nota classificazione stellare, completata nel 1867 e che comprendeva oltre quattromila stelle suddivise in quattro classi spettrali.20 È importante notare che Secchi considerava il proprio meccanicismo e il tentativo di ridurre tutti i fenomeni a materia e moto, in completo disaccordo con prospettive di tipo determinista e materialista. Attribuire alla materia capacità auto organizzative, infatti, era per Secchi un’ipotesi che oltrepassava i limiti della conoscenza scientifica. Contro la “necessità materiale e matematica” Secchi difendeva invece la natura con19. Sulle prime analisi spettrali e la strumentazione spettroscopica, si vedano J. Bennett, The celebrated phenomena of colours, Whipple Museum, Cambridge, [1984]; e J. B. Hearnshaw, The analysis of starlight: One hundred and fifty years of astronomical spectroscopy, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, pp. 51-103. Sulla nascita della “nuova astronomia”, si vedano A. J. Meadows, Early Solar Physics, Pergamon Press, Oxford, 1970, pp. 20-82 e K. Hufbauer, Exploring the Sun: Solar science since Galileo, The Johns Hopkins University Press, Baltimora, 1991, pp. 42-65. Sugli inizi della spettroscopia in Italia si vedano inoltre, G. B. Donati, Intorno alle strie degli spettri stellari, Tip. Galileiana, Firenze, [1860]; e I. Chinnici, “19th century spectroscopic instruments in Italian astronomical observatories”, in Nuncius, 15, 2000, pp. 671-680. Su Amici si vedano, E. Proverbio, P. Tucci, “Giovanni Battista Amici costruttore di telescopi e cannocchiali acromatici”, in Physis, 30, 1993, pp. 145-175 e A. Meschiari, “Corrispondenza di Giovanni Battista Amici con Carlo Matteucci e Angelo Secchi”, in Nuncius, 14, 1999, pp. 233-261. Su Denza, si veda G. Boffito, Scrittori barnabiti, v. 1, Olschki, Firenze, 1933, pp. 606-638. 20. Sulle divergenze tra Donati e Secchi, si veda Memorie della Società degli Spettroscopisti Italiani, v. 1, 1872, pp. 54-56. Sul viaggio di Janssen a Roma, si veda D. Aubin, “Orchestrating observatory, laboratory, and field: Jules Janssen, the spectroscope and travel”, in Nuncius, 17, 2002, pp. 615-633. Sulla spettroscopia stellare di Secchi e il suo iniziale sistema di classificazione, si vedano, A. Secchi, “Sugli spettri prismatici della luce de’ corpi celesti”, in Memorie dell’Osservatorio del Collegio Romano. Nuova serie, v. 2, 1860-63, pp. 121128; Id., Le scoperte spettroscopiche in ordine alla ricerca della natura de’ corpi celesti, Tip. delle Belle Arti, Roma, 1865; Id., Catalogo delle stelle di cui si è determinato lo spettro luminoso all’Osservatorio del Collegio Romano, Gauthiers-Villars, Parigi, 1867; Id., “Sugli spettri prismatici delle stelle fisse”, in Memorie della Società Italiana delle Scienze. Serie terza, 1, 1867, pp. 71-78; Id., “Sugli spettri prismatici delle stelle fisse. Memoria II”, in Memorie della Società Italiana delle Science. Serie terza, 2, 1869, pp. 73-133. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 159 tingente delle leggi fisiche, in pieno accordo, in questo, con il pensiero di John Tyndall (1820-1901), la cui opera è spesso citata negli scritti teorici del gesuita. Il riduzionismo di Secchi, secondo il quale fenomeni come il calore, la luce, l’elettricità, il magnetismo, la chimica e persino la gravitazione, avrebbero dovuto essere interpretati come movimento di molecole e etere, non segnava certo il trionfo della materia sullo spirito. Al contrario: il funzionamento mirabilmente semplice della macchina dell’universo ne svelava la natura teleologica, indirizzando l’osservatore verso una sfera spirituale superiore, una mente ordinatrice, un principio direttivo. Tra la materia e la vita, ragionava Secchi, vi è una frattura profonda, incolmabile, che divide l’universo materiale e la struttura della “grande rete degli esseri”, che il gesuita estendeva alla vita extraterrestre e a esseri che potrebbero essere “immensamente più capaci di noi”. In definitiva, le leggi fisiche esistenti dipendono dall’infinita libertà del creatore. La continua trasformazione delle forze fisiche l’una nell’altra rende necessario postulare l’atto della creazione, inteso come la primordiale trasmissione del moto da Dio alla materia inerte. In questa prospettiva, le leggi sperimentali della conservazione dell’energia possono quindi essere interpretate come un segno dell’azione soprannaturale continua nel mondo fisico.21 Le teorie atomistiche e dinamiste di Secchi incontrarono la resistenza di ampi settori della cultura cattolica. In particolare il suo saggio sull’unità delle forze fisiche, una difesa della nuova fisica e della nuova astronomia, originò un intenso dibattito che coinvolse numerosi filosofi e teologi. La prospettiva teorica e le pratiche osservative di Secchi furono criticate soprattutto dai filosofi di indirizzo neoscolastico, i quali accusarono il gesuita di puro e semplice materialismo e gradualmente, a partire dal 1870, riuscirono a isolare l’osservatorio pontificio e il suo direttore. La dottrina neoscolastica dell’ilomorfismo stava certamente guadagnando il favore delle istituzioni culturali cattoliche di tutto il mondo e la bolla papale Aeternis Patris (1879) ne sancirà ufficialmente l’egemonia. Non sorprende quindi che Secchi si sia sentito circondato da nemici nei suoi ultimi anni. Tra questi egli contava non solo politici e intellettuali italiani di tendenze anticlericali, ma anche colleghi romani e con21. Si veda, A. Secchi, “La grandezza del creato”, due lezioni pubblicate postume in Id., Lezioni elementari di fisica terrestre, Loescher, Torino-Roma, 1879, pp. 183-218. 160 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE fratelli gesuiti, come Giovanni Maria Cornoldi (1822-1892), e i direttori del periodico gesuita Civiltà Cattolica, apertamente schierati su posizioni neoscolastiche. L’isolamento di Secchi assunse una sorprendente dimensione anche fisica nel 1873 quando, in seguito alle pressioni esercitate dai ministri Quintino Sella e Ruggero Bonghi, le autorità italiane confiscarono il Collegio Romano e espulsero i gesuiti. Soltanto Secchi e i suoi assistenti, grazie alla loro reputazione internazionale, non furono allontanati dall’osservatorio sul tetto della chiesa. Essi continuarono così a vivere e lavorare in questo bizzarro stato di sospensione fino al 1879 quando, con la morte di Secchi, anche l’osservatorio fu confiscato dal governo italiano.22 La caduta dello stato pontificio come entità territoriale nel 1870 aveva determinato il rapido isolamento di Secchi nella cultura scientifica cattolica e la perdita di rilevanza del suo regime osservativo. Nelle nuove condizioni politiche e istituzionali venutesi a delineare, le pratiche sperimentali di Secchi risultavano meno significative per la Santa Sede della pura e semplice ortodossia teologica. La filosofia neoscolastica stava diventando rapidamente il cemento della rinnovata cultura cattolica nel mondo, limitando in tal modo la molteplicità delle posizioni teoretiche che avevano caratterizzato la ricerca scientifica svolta dal Collegio Romano nel corso dei decenni precedenti. Ma se una chiesa senza stato aveva perso interesse per il regime osservativo di Secchi, nuove entità nazionali cominciarono invece a tradurlo e ad appropriarsene: prima tra tutte la giovane nazione italiana. 22. G. Martina, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, 1814-1983, Morcelliana, Brescia, 2003, pp. 47-71. Sulla neoscolastica, si vedano, A. Masnovo, Il neo-tomismo in Italia, Soc. Ed. Vita e Pensiero, Milano, 1923; A. Piolanti, Pio IX e la rinascita del tomismo, Libreria Vaticana, Città del Vaticano, 1974; A. Piolanti, L’Accademia di Religione Cattolica. Profilo della sua storia e del suo tomismo, Libreria Vaticana, Città del Vaticano, 1977. Su Cornoldi, si vedano G. M. Cornoldi, I sistemi meccanico e dinamico circa la costituzione delle sostanze corporee, considerazioni rispetto alle scienze fisiche, Tip. Piacentini e Franchini, Verona, 1864; L. Malusa, Neotomismo e intransigentismo cattolico, IPL, Milano, 1989. Si veda inoltre la documentazione relativa alla controversia tra Secchi e il domenicano Vincenzo Nardini in A. Secchi, Intorno alla soluzione di un problema fisico-cosmologico, Morini, Roma, 1862; V. Nardini, Risposta alla lettera del P. Angelo Secchi intorno alla soluzione di un problema fisico-cosmologico, Cesarelli, Roma, 1862. Sulla confisca del Collegio Romano, si veda R. Bonghi, Collegio Romano. La Biblioteca Vittorio Emanuele e i musei. Discorso inaugurale, Tip. Barbera, Roma, 1876. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 161 Un’astrofisica italiana Tra il 1850 e il 1870 l’universo unificato di Secchi fornì alla cultura scientifica pontificia un paradigma assai efficace, che poteva essere utilizzato per sostenere sia l’innovazione tecnico-scientifica, sia il dialogo con i settori più vivaci della ricerca fisica e astronomica internazionale. Allo stesso tempo il regime osservativo implementato da Secchi permise la trasformazione degli osservatori pontifici in luoghi per l’elaborazione e l’applicazione di tecniche ritenute fondamentali per la riforma dello stato. L’integrità del dogma religioso era salvaguardata con l’adozione di un rigido dualismo metafisico che lo poneva oltre il limite di una legittima analisi scientifica. Il riconoscimento di questi molteplici significati della pratica sperimentale di Secchi può aiutarci a capire l’apparente paradosso di una cultura in cui politica ultraconservatrice e teologia tradizionalista potevano convivere con ambiziosi programmi di modernizzazione tecnicoscientifica. Erano quelli gli anni in cui si assistette all’unificazione politica italiana e all’occupazione e alla proclamazione di Roma capitale. La politica italiana del decennio 1860-1870 fu caratterizzata dalla “questione romana”: la città eterna era un simbolo che le élite liberali della nuova nazione non potevano permettersi di lasciare in mano alla chiesa. In gioco non c’era soltanto lo status amministrativo della città, ma la ridefinizione del rapporto tra stato e chiesa, tra ragione e fede. Da qui lo spirito spiccatamente anticlericale del Risorgimento italiano e i suoi toni radicali, caratterizzati dalla percezione che la chiesa cattolica costituisse una minaccia mortale per uno sviluppo “moderno” della nazione. Non sorprende pertanto che l’ultimo periodo risorgimentale sia coinciso con l’apice del positivismo italiano, una prospettiva utilizzata dalle élite liberali per inquadrare i problemi sociali e economici della nuova nazione e per individuarne le possibili soluzioni. In particolare, le élite anticlericali e liberali rappresentate dai primi governi nazionali ritenevano che il progresso tecnico e scientifico fosse una condizione necessaria sia per il successo del processo di costruzione nazionale, sia per l’ammissione dell’Italia nella cerchia delle massime potenze mondiali. Le ambizioni imperialistiche italiane divennero presto materia di discussione per i governi europei e di lì a poco la nuova nazione avrebbe cominciato la propria avventura coloniale su scala ridotta. Allo stesso 162 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE tempo, però, con una guerra civile in atto nel Mezzogiorno e una popolazione che, nella grande maggioranza, era analfabeta e non parlava la lingua italiana, le élite liberali avevano un urgente bisogno di consolidare l’ordine sociale nel paese tramite l’implementazione di processi di controllo, accentramento e istruzione popolare. Tutte le scienze furono mobilitate a supporto di questo sforzo per l’unificazione e in particolare quelle naturali e matematiche, che furono presto oggetto di un programma divulgativo di straordinaria portata e complessità, mai più ripetutosi in quelle dimensioni nella storia della penisola. Come dichiarò il primo ministro Quintino Sella, nella Roma finalmente “italiana”, l’universalismo religioso della Chiesa doveva essere sostituito al più presto dall’universalismo laico della scienza moderna.23 L’opportunità di un coinvolgimento governativo diretto nella ricerca astronomica fu offerta dall’organizzazione della spedizione in Sicilia per osservare l’eclissi del dicembre 1870. In tutta Europa la nascita dell’astrofisica come disciplina scientifica durante gli anni Sessanta e Settanta dell’Ottocento fu contrassegnata da una serie di spedizioni per l’osservazione delle eclissi, il cui scopo principale era quello di verificare le ipotesi correnti sulla natura fisica dei fenomeni solari. Allo stesso tempo queste spedizioni, spesso supportate militarmente e caratterizzate da forti toni nazionalistici, erano parte integrante delle strategie imperialistiche delle potenze coloniali occidentali. Nel caso italiano la nascita di una comunità astrofisica di spicco e le sue prime spedizioni scientifiche furono elementi costitutivi non tanto di una politica coloniale – ancora in fieri – quanto dello stesso processo di costruzione nazionale.24 23. Q. Sella, “Discorso al Parlamento del 14 marzo 1881”, in Id., Discorsi parlamentari, v. 1, Tip. Della Camera dei Deputati, Roma, 1887-1890, pp. 273-311; J. Davis, Conflict and control: Law and order in nineteenth-century Italy, Macmillan, Londra, 1988; G. Quazza, L’utopia di Quintino Sella. La politica della scienza, ISRI, Torino, 1992; G. A. Caracciolo, Roma capitale, Editori Riuniti, Roma, 1999; G. Martina, “Roma dal 20 settembre 1870 all’11 febbraio 1929”, in Storia d’Italia, Annali 16, Roma, la città del papa, Einaudi, Torino, 2000, pp. 1059-1100. Sul ruolo degli scienziati e in particolare dei matematici agli inizi della vita politica italiana, si veda U. Bottazzini, Va’ pensiero. Immagini della matematica nell’Italia dell’Ottocento, Mulino, Bologna, 1994. I valori del liberalismo politico, dell’anticlericalismo e del positivismo furono divulgati tra la borghesia italiana da collane di successo quali la Biblioteca del popolo (Sonzogno, Milano) e La scienza del popolo (Treves, Milano). Sulla divulgazione scientifica nel periodo in esame, P. Govoni, Un pubblico per la scienza. La divulgazione scientifica nell’Italia in formazione, Carocci, Roma, 2002. 24. Sui rapporti tra spedizioni astrofisiche e politiche coloniali, si veda A. SoojungKim Pang, Empire and the Sun, Stanford University Press, Stanford, 2002. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 163 La spedizione italiana del 1870 fu organizzata intorno alla figura e all’attività di Angelo Secchi, sebbene per ovvie ragioni non poté essergli conferito alcun ruolo ufficiale. Alla spedizione parteciparono sia tecnici e fotografi, sia astronomi provenienti da Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Furono invitati anche alcuni fisici sperimentali, come Pietro Blaserna (1836-1918), promotore di una nuova pratica di laboratorio centralizzata e coordinata nelle università italiane, sulla base del modello tedesco.25 Materiali e strumenti furono caricati da vari porti italiani sulla nave da guerra Plebiscito e trasportati in Sicilia. Nel frattempo, in Calabria, ingegneri militari e topografi in contatto telegrafico costante con gli organizzatori della spedizione, prendevano posizione lungo la linea ferroviaria per definire il limite esatto della zona di eclissi totale. Il programma scientifico prevedeva osservazioni visive e spettroscopiche della corona e delle protuberanze solari, con Secchi responsabile della sezione fotografica. La raccolta di dati fu più limitata del previsto, soprattutto a causa del maltempo persistente. Si osservò la linea di emissione nello spettro della corona vista da William Harkness l’anno precedente, ma la sua posizione non poté essere misurata accuratamente. Negli spettri delle protuberanze furono osservate le linee dell’idrogeno e dell’elio e nella corona fu misurata una forte polarizzazione.26 Il significato della spedizione, tuttavia, andò ben oltre questi risultati: si trattava della prima spedizione scientifica dell’Italia unita, il debutto sulla scena scientifica internazionale della nuova nazione. Quando una spedizione britannica guidata da Norman Lockyer (1836-1920) montò le tende vicino agli italiani, questi poterono annunciare a Roma con orgoglio di essere stati “con quei distinti signori in amichevoli e 25. P. Blaserna, “Sullo stato attuale delle scienze fisiche in Italia e su alcune macchine di fisica”, in L’Italia alla Esposizione Universale di Parigi nel 1867: rassegna critica descrittiva illustrata, Racon-Le Monnier, Parigi-Firenze, 1868, pp. 70-74. Sulla riorganizzazione della fisica sperimentale nell’Italia post-unitaria e i modelli francese e tedesco, si veda B. Reeves, “Le tradizioni di ricerca della fisica italiana nel tardo diciannovesimo secolo”, in V. Ancarani (a cura di), La scienza accademica nell’Italia post-unitaria, Angeli, Milano, 1989, pp. 53-112. 26. G. Cacciatore (a cura di), Rapporti sulle osservazioni dell’eclisse totale di sole del dicembre 1870 eseguite in Sicilia dalla commissione italiana, pubblicati a spese del Regio Governo, Stab. Tip. Lao, Palermo, 1872; A. Secchi, “Progresso delle cognizioni solari ottenuto in occasione dell’eclisse solare del 22 dicembre 1870”, in Atti dell’Accademia Pontificia de’ Nuovi Lincei, 24, 1871-72, pp. 1-15; P. Tacchini, Eclissi totali di sole del dicembre 1870, del maggio 1882 e 1883, e dell’agosto 1886 e 1887. Relazioni e note, Botta, Roma, 1888, pp. 233-236; I. Chinnici, “Eclissi totali di sole 1860-1870: la nascita della fisica solare”, in Giornale di astronomia, 1, 2000, pp. 40-45. 164 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE cordiali rapporti quali convengonsi fra cittadini di culte e libere nazioni”. In contatto telegrafico costante con il governo, i leader della spedizione comunicarono inoltre che il giorno dell’eclissi “la bandiera nazionale sventolava sugli spaldi del castello d’Augusta [base della spedizione italiana]”. L’antico castello borbonico, simbolo di tirannia, era stato così trasformato in “luogo di scienza” per “l’onore nazionale e il progresso della civiltà”.27 Il giorno seguente, le autorità locali organizzarono banchetti in varie città siciliane per festeggiare le spedizioni italiana, britannica e americana, quest’ultima organizzata e diretta da Benjamin Peirce, professore di astronomia e matematica ad Harvard. Apparizione della scienza italiana sulla scena internazionale dunque, ma non solo. Nelle intenzioni degli organizzatori e promotori, grazie a questa spedizione – fortemente militarizzata – il nuovo spirito scientifico nazionale aveva raggiunto la Sicilia, la più ribelle tra le regioni italiane. L’isola era ancora gestita da potenti élite locali e Palermo era stata teatro di una preoccupante insurrezione anti-unitaria soltanto quattro anni prima. La spedizione si era spinta quindi ai confini estremi della nazione, dove la legittimazione del governo e della monarchia sabauda erano ancora oggetto di un’aperta contestazione. Gli scienziati erano sbarcati su quest’isola ribelle con i loro cronografi, i loro telescopi e le loro bandiere italiane, portando la luce della scienza e l’ora esatta nazionale. Nell’ambito di questa impresa civilizzatrice la spedizione aveva anche raggiunto un ulteriore obiettivo: quello di stabilire contatti più solidi con gli scienziati meridionali e di rilanciare l’osservatorio di Palermo – un tempo guidato da Giuseppe Piazzi – nel contesto del nuovo sistema di ricerca nazionale. La spedizione del 1870 segnò l’inizio della riorganizzazione e della standardizzazione ufficiale della pratica degli osservatori in tutta la comunità astronomica italiana. Per la prima volta professionisti provenienti da una decina di piccoli e medi osservatori sparsi per la Penisola si erano riuniti e avevano lavorato fianco a fianco sotto il tricolore nell’intento di dare vita a una scienza “italiana”. In realtà, il tempo nuvoloso non fu né l’unico né il maggiore dei problemi che la spedizione dovette affrontare. Ben più gravi, sebbene meno enfatizzate nei resoconti ufficiali, furono proprio le difficoltà incontrate dagli astronomi nel coordinare il loro lavoro come frutto di un coeso e unico gruppo di ricerca. 27. Citazioni tratte da Cacciatore (a cura di), Rapporti sulle osservazioni dell’eclisse totale, cit., pp. 7-9. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 165 Fu presto chiaro che nei due osservatori provvisori allestiti in Sicilia dalla spedizione, gli astronomi, assistiti dagli ufficiali della Plebiscito, non stavano producendo osservazioni e rilevando dati in modo efficace. Questo avveniva nonostante il fatto che, sotto la guida di Secchi, scienziati e tecnici si fossero riuniti con grande anticipo per discutere priorità e tecniche, testare e scegliere i cronometri, scambiare e tarare gli strumenti. In particolare, si fecero sforzi notevoli per standardizzare le tecniche per la rappresentazione e la misurazione dei fenomeni solari. Gli scienziati italiani dovevano trovare con urgenza risposte comuni a domande di questo tipo: Quali tecniche si devono usare per disegnare la superficie solare? Quali termini si devono usare per descriverla? Come classificare le protuberanze ed altri fenomeni simili? A questo scopo, nelle settimane precedenti l’eclissi, si svolse una serie di micro-processi di standardizzazione delle pratiche e di taratura della strumentazione. Pietro Tacchini e Giuseppe Lorenzoni (1843-1914), per esempio, trascorsero intere giornate a disegnare le protuberanze solari come apparivano con il sole pieno, alternandosi a un equatoriale di Merz. Decisero di disegnare la stessa protuberanza sullo stesso foglio ma con colori diversi, in modo da poter notare “analogie e differenze” tra i loro stili. Questo esercizio continuò finché i due non convennero che gli “stili” erano diventati sufficientemente simili da rendere attendibili le loro future rappresentazioni dell’eclissi. In generale, Secchi e i suoi nuovi colleghi rimasero sorpresi dalle differenze riscontrate nelle descrizioni e nelle rappresentazioni ottenute osservando gli stessi fenomeni con gli stessi strumenti: disegnavano in modo diverso, parlavano in modo diverso e i legami di fiducia che li univano erano pericolosamente deboli. Un episodio in particolare appare emblematico del clima che caratterizzò la spedizione. Secchi si mostrò presto convinto che la scarsa qualità delle sue fotografie fosse dovuta solo in parte alla presenza di nubi. Sospettava piuttosto che gli assistenti assegnategli fossero stati troppo lenti nell’obbedire ai suoi ordini e che il fotografo avesse modificato certe sostanze chimiche senza informarlo. Episodi, questi, che non avrebbero potuto certo verificarsi nella collaudata routine su cui si fondava il regime osservativo dell’Osservatorio del Collegio Romano: la scienza italiana, così come gli italiani, era ancora da farsi.28 28. Su Tacchini e Lorenzoni, ibid., pp. 101-102. Per le rimostranze di Secchi, ibid., p. 21. Sulle questioni socio-tecniche legate all’affidabilità dell’osservatore in astronomia, 166 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE La standardizzazione delle pratiche osservative continuò ben oltre la spedizione: per tutto l’anno 1871 Tacchini a Palermo e Secchi a Roma coordinarono il loro monitoraggio del lembo solare. Poco dopo, si unirono a questo programma anche gli osservatori di Padova e Napoli, facendo uso degli strumenti spettroscopici acquisiti in occasione della spedizione del 1870. Verso la fine del 1871, Secchi e Tacchini annunciarono la creazione di una società che avrebbe implementato il regime osservativo di Secchi a livello nazionale. La Società degli Spettroscopisti Italiani diede così inizio alla propria attività sotto la direzione di Tacchini e con la partecipazione di cinque osservatori nazionali. Furono invitati ad offrire il loro contributo anche fisici e chimici interessati alle tecniche spettrografiche. In linea con le precedenti ricerche di Secchi, la società avrebbe concentrato le proprie attività nello studio dei legami profondi tra fisica solare e fisica terrestre. L’analisi morfologica e spettroscopica del sole aveva quindi come scopo primario lo studio della costituzione fisica della stella e l’individuazione degli effetti dell’attività solare sulla terra.29 Le Memorie della società, pubblicate a cura di Tacchini a partire dal 1872, furono la prima rivista interamente dedicata all’astrofisica ad apparire sulla scena internazionale. La rivista si presentò agli studiosi come il luogo privilegiato per la standardizzazione delle tecniche di misurazione e di rappresentazione da usarsi in astrofisica. Scorrendone le pagine si riscontra un rapido passaggio da stili descrittivi caratterizzati da rappresentazioni e terminologie idiosincratiche, a forme di espressione più distaccate, impersonali e oggettive. Questo processo è ben visibile, ad esempio, nella rappresentazione del lembo solare, accuratamente monitorato e disegnato da vari membri della società su base giornaliera. Da principio furono pubblicati tutti i disegni del lembo solare relativi allo stesso giorno, accompagnati dall’indicazione dell’osservatorio di provenienza. Già nel secondo anno di vita della rivista questa congerie di rappresentazioni venne sostituita da un foglio mensile in cui a ogni giorno corrisponde un’unica rappresentazione. I disegni erano selezioS. Schaffer, “On astronomical drawing”, in C. Jones, P. Galison (eds.), Picturing science, producing art, Routledge, London, 1998, pp. 441-474. 29. P. Tacchini, “Sulla nuova società degli spettroscopisti italiani”, in Memorie della società degli spettroscopisti italiani, 1, 1872, pp. 3-6. Secchi e Tacchini difesero il legame tra fisica solare e terrestre contro le argomentazioni di Hervé Faye in una lunga appendice al secondo volume delle Memorie (1873). I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 167 nati e ritagliati dalle relazioni dei diversi osservatori, ma le tracce di questo processo di collage non sono visibili e ogni riferimento alla provenienza delle singole immagini è eliminato. L’effetto finale è notevole: per ogni dato giorno il lembo solare ha ora una forma unica e quindi oggettiva. La riorganizzazione interna del settore astrofisico delle Memorie fu accompagnata da vari processi di disciplinamento e professionalizzazione. Istruttivo in tal senso risulta il confronto tra i resoconti del 1870 sull’eclissi solare e gli articoli apparsi in seguito. I primi includevano le osservazioni di una schiera di entusiasti astronomi non professionisti: aristocratici come il principe di Lampedusa, presidi di scuole e collegi, parroci, ufficiali di marina. Gli organizzatori della spedizione ufficiale avevano infatti deciso di pubblicare, o almeno citare, molti dei resoconti che avevano ricevuto dagli astronomi dilettanti che avevano osservato l’eclissi. Possiamo così leggere le impressioni di distinte signore che, a quanto pare, erano considerate particolarmente adatte a commentare il cambiamento dei colori dello spettro man mano che l’eclissi si avvicinava alla totalità. “Lo spettacolo era sublime, degno dell’Eterno Fattore!”, fu il commento di una certa signora Angela Vanneschi, che si dichiarò inoltre piena “di meraviglia e rispetto per la scienza e gli scienziati”. Come lei, molti tra i dilettanti e gli astronomi professionisti fecero riferimento al carattere soprannaturale dello spettacolo. Questo tema è invece assente dalla prosa asciutta di padre Secchi, la cui strategia apologetica, come abbiamo visto, ha poco a che fare con la teologia naturale.30 A un paio d’anni dalla spedizione siciliana è già impensabile che astronomi dilettanti possano vedere le loro relazioni pubblicate nelle Memorie. A differenza di quanto avvenne in altri paesi europei, i nuovi esperti italiani di astronomia fisica tracciarono infatti confini precisi e rigidi per il loro gruppo. Gli autori pubblicati includevano solo i membri della società, specialmente Secchi e Tacchini, e un numero esiguo di corrispondenti presso osservatori italiani e stranieri. La questione della demarcazione professionale emerge chiaramente nel giudizio di Tacchini circa un articolo inglese che prospettava la possibilità di utilizzare piccoli telescopi nell’osservazione della cromosfera e delle protuberanze 30. Citazioni tratte da G. Cacciatore (a cura di), Rapporti sulle osservazioni dell’eclisse totale, cit., p. 208. Sul principe di Lampedusa si veda I. Chinnici, “Gli strumenti del Gattopardo”, in Giornale di Astronomia, 1, 1997, pp. 24-29. 168 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE solari. Tacchini commentò ironicamente l’utilizzo di telescopi portatili in questo campo, sottolineando la sostanziale differenza qualitativa tra le osservazioni del dilettante e quelle del professionista, il solo che possa propriamente “vedere” i fenomeni celesti. Allo stesso tempo, la nuova comunità di specialisti della fisica solare doveva demarcare e difendere la diffusione delle proprie pratiche rispetto a quelle proprie di gruppi preesistenti, primi tra tutti gli astronomi tradizionali. Contro l’opinione di colleghi più prudenti come Donati, Secchi e Tacchini insistettero sulla necessità di dotare le grandi cupole degli osservatori italiani di strumenti spettroscopici e, se necessario, modificare i telescopi tradizionali per facilitare l’osservazione spettroscopica.31 Una nuova comunità si legittima anche attraverso la ricostruzione delle proprie radici e così, nel primo numero delle Memorie, Tacchini traccia la genealogia della spettroscopia italiana, facendola risalire ai lavori di Secchi e Respighi e descrivendone la successiva diffusione negli osservatori di Padova, Napoli e Palermo in occasione della spedizione per l’osservazione dell’eclissi del 1870. Proclamando il ruolo centrale della spettroscopia nell’astronomia moderna, Tacchini concludeva chiedendo una suddivisione più razionale del lavoro tra gli osservatori, in particolar modo in quelle aree di ricerca che richiedevano osservazioni spettroscopiche continue e coordinate. Negli anni immediatamente successivi il compito di disegnare una mappa nazionale del lembo solare fu abilmente utilizzato da Tacchini come mezzo per implementare il regime osservativo di Secchi negli osservatori nazionali che avevano aderito al progetto. A essi Tacchini fornì una serie di istruzioni estremamente dettagliate, dal metodo corretto per rappresentare le macchie solari, alla larghezza standard della fenditura dello spettroscopio nell’osservazione delle protuberanze, fino al tipo di carta e matita da usare per disegnarle.32 In conclusione, l’organizzazione della spedizione del 1870 e la costituzione della Società degli Spettroscopisti Italiani diedero l’opportunità a una nuova generazione di astronomi guidati da Tacchini e Denza di attirare risorse verso la ricerca astrofisica e meteorologica, collocan31. P. Tacchini, “Sulla precedente memoria del prof. Lorenzoni”, in Memorie della Società degli Spettroscopisti Italiani, 2, 1873, p. 43. 32. P. Tacchini, “Sulla nuova Società di Spettroscopisti Italiani” in Memorie della Società degli Spettroscopisti Italiani, 1, 1872, pp. 3-6; Id., “Protuberanze solari osservate contemporaneamente a Palermo, Roma e Padova nel luglio e agosto 1871”, in Memorie della Società degli Spettroscopisti Italiani, 1, 1872, pp. 25-32. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 169 do queste discipline al centro della nascente astronomia italiana. L’universo unificato di Secchi e il suo regime osservativo divennero così risorse fondamentali per Tacchini e i suoi colleghi, in quanto permisero loro di collegare le nuove pratiche scientifiche al più ampio progetto di costruzione della nuova nazione e del suo sistema di ricerca. La mancanza di un osservatorio nazionale centrale rese pressante per la comunità astronomica italiana la propria riorganizzazione, sollevando questioni molto importanti circa la standardizzazione e il coordinamento delle pratiche osservative. Allo stesso tempo, questa situazione decentrata, anomala nel panorama europeo, diede alla nuova disciplina la possibilità di trovare un immediato riconoscimento istituzionale. In Italia, infatti, l’adozione di un programma di ricerca astrofisico da parte degli osservatori esistenti incontrò un’opposizione assai poco strutturata. Questa debole resistenza, di natura sia pratica sia teorica, e il costo relativamente basso della strumentazione spettroscopica, furono due fattori che favorirono l’adozione del regime osservativo di Secchi e la sua trasformazione in un modello di lavoro per i giovani astronomi italiani. Tacchini svolse un ruolo chiave nella mediazione tra Secchi, la comunità astronomica e il governo italiano. Le sue richieste di finanziamenti per la ricerca astrofisica furono accolte favorevolmente dall’allora ministro della pubblica istruzione Quintino Sella, uno scienziato che, come molti altri in quegli anni, si era votato alla politica. Il governo era attento alle questioni tecniche e scientifiche, certamente sensibile all’immagine internazionale del paese e impegnato in numerosi processi di centralizzazione e standardizzazione.33 Inoltre, è significativo il fatto che, dopo la morte di Secchi, avvenuta nel 1878, la direzione dell’Osservatorio del Collegio Romano fu affidata dal governo proprio a Tacchini il quale, un anno dopo, all’apice della sua carriera politica e scientifica, avrebbe assunto anche la direzione del Reale Ufficio Centrale di Meteorologia, che unificava e coordinava le reti meteorologiche e sismologiche nazionali. La continuità con il regime osservativo di Secchi è ulteriormente evidenziata dal fatto che Tacchini scelse di affidare la costruzione dei nuovi strumenti meteoro33. I. Chinnici, “Nascita e sviluppo dell’astrofisica in Italia nella seconda metà dell’Ottocento”, relazione presentata al XVIII congresso di storia della fisica e dell’astronomia, Como, 1998; G. Foderà Serio, “Dalla Società degli Spettroscopisti Italiani alla Società Astronomica Italiana”, in F. Bònoli (a cura di), L’astronomia in Italia, Arte Tipografica, Napoli, 1998, pp. 21-48. 170 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE logici e sismologici italiani ai Brassart, gli specialisti nella costruzione di strumentazione scientifica che sino ad allora avevano lavorato per Secchi. Nel frattempo, Tacchini aveva anche messo a punto un progetto di riforma nazionale per la coordinazione e la ridistribuzione dei compiti e dei finanziamenti tra tutti gli osservatori nazionali, che ricevette il benestare del governo nel 1876.34 Eppure, per qualche mese, il governo italiano aveva preso in considerazione la possibilità di reclutare lo stesso Secchi come guida della nuova astronomia italiana. Il matematico e politico liberale, nonché fondatore e direttore del Politecnico di Milano, Francesco Brioschi (18241897) aveva contattato Secchi, con discrezione, subito dopo l’occupazione di Roma nel settembre 1870. Le trattative segrete continuarono durante tutta la spedizione in Sicilia del 1870. Secchi, al quale fu offerta la cattedra di astrofisica presso la nuova università di Roma, inizialmente accettò, a condizione che i vincoli sull’insegnamento e la ricerca dei gesuiti fossero aboliti e che la cattedra fosse denominata “astrofisica e meteorologia”. Il governo, tuttavia, non si discostò dalla propria linea anticlericale e le istituzioni gesuitiche non furono risparmiate. Verso la fine del novembre 1870, nel bel mezzo della spedizione per l’eclissi, le trattative si bloccarono e Secchi si rifiutò di dialogare ulteriormente con le autorità italiane. Visto il fallimento nell’attirare Secchi dalla parte dei liberali che credevano nel “progresso” e in uno sviluppo nazionale di tipo “moderno”, e anche in considerazione dell’affermazione di Tacchini come suo autorevole erede, il governo italiano cominciò a togliere – letteralmente, come si è visto prima – il terreno da sotto i piedi dell’astronomo gesuita. Secchi fu escluso anche dalle successive imprese nazionali, come per esempio la spedizione italiana in India per l’osservazione del transito di Venere (1874): in quella occasione l’affiliazione di Secchi al gruppo italiano (guidato da Tacchini) non fu ritenuta possibile. Anche la presenza del gesuita come rappresentante della Santa Sede suscitava ormai rimostranze formali da parte italiana, come nel caso della sua partecipazione ai lavori della Commission Internationale du Mètre di Parigi del 1872. 34. Sull’estrema centralizzazione e uniformità del sistema universitario italiano rispetto a quello francese e tedesco, si vedano B. Clark, Academic power in Italy. Bureaucracy and oligarchy in a national university system, Chicago University Press, Chicago, 1977 e P. Giglioli, Baroni e burocrati: il ceto accademico italiano, Mulino, Bologna, 1979. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 171 D’altra parte, l’inclusione di Secchi nel pantheon della scienza italiana rimase problematica ben oltre la sua morte, come dimostra la storia di un monumento commemorativo che fu progettato ma mai ultimato. Come scrisse una mano ottocentesca sul frontespizio di una copia de L’unità delle forze fisiche nella biblioteca dell’università di Padova: “una grande mente, peccato che sia un prete”.35 Conclusione Sebbene l’Osservatorio del Collegio Romano non sia sopravvissuto a lungo alla conquista italiana di Roma, il suo regime osservativo fu adottato con entusiasmo dalla rete degli osservatori italiani nazionalizzati. Secchi, fedele al pontefice fino alla fine e dal 1870 leader degli scienziati cattolici legittimisti, non svolse alcun ruolo ufficiale nel sistema italiano della ricerca. Nonostante questo, le sue pratiche osservative e la sua prospettiva teorica divennero ugualmente risorse preziose per la comunità astrofisica italiana emergente. Le ragioni di questo successo, come abbiamo visto, sono da ricercarsi, da un lato, nelle particolari condizioni sociali e tecniche dell’astronomia nell’Italia post-unitaria e soprattutto nella sua struttura decentralizzata, dall’altro lato, nella natura eterogenea della pratica di Secchi, che si prestava a sostenere le più generali priorità nazionali del controllo e della standardizzazione. Ci si potrebbe chiedere, però, perché l’universo unificato di Secchi sia stato tradotto in un programma di ricerca nazionale nonostante le sue esplicite basi metafisiche. Ovvero, perché si optasse per l’universo unificato di Secchi, invece che per una qualche sua versione materialistica, più in linea con la cultura radicale del Risorgimento e con le tendenze filosofiche predominanti nella cultura scientifica italiana del periodo. Si può tentare di fornire una risposta partendo dalla constatazione che sul finire del secolo le dottrine razionaliste e materialiste che avevano alimentato buona parte della cultura risorgimentale cominciano a perdere terreno. La stagione positivista volgeva al termine e insieme 35. G. Castellani, “Nomina e rinunzia del P. Angelo Secchi a professore di astrofisica nell’Università di Roma”, in Civiltà Cattolica, 95, 1944, pp. 39-46, 159-169, 170-179; R. Finzi, “Il mancato monumento scientifico al Padre Angelo Secchi”, in Atti e memorie della deputazione di storia patria per le antiche province modenesi, 6, 1971, pp. 137-147. 172 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE a essa la previsione ottimistica di un rapido sviluppo sociale e economico dell’intera nazione. Mentre l’anticlericalismo rimaneva forte tra le élite italiane, il dogma religioso non appariva più come il nemico principale del nuovo ordine liberale e illuminato. Con l’aumento delle rivolte per il pane e delle manifestazioni socialiste, la questione sociale andò rapidamente ad affiancarsi alla questione romana, al centro del dibattito politico. Gli eventi drammatici della Comune di Parigi sembrarono confermare che le difficoltà per le élite liberali giungevano ormai da altre direzioni. La svolta autoritaria del governo italiano e la reazione repressiva al malcontento popolare sarebbero diventate sempre più evidenti nel corso degli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento.36 Lungi dal rappresentare un ostacolo alla sua adozione, le radici antimaterialiste e spiritualiste dell’universo unificato di Secchi ne accrebbero invece il fascino nell’Italia di fin de siècle. I gesuiti in tonaca nera potevano anche essere fuori moda, ma le sorti del meccanicismo spiritualista di Secchi erano certamente in ascesa e non solo in astronomia. L’approccio anti-materialistico alla pratica scientifica trovò, infatti, un pubblico molto ricettivo in ampi settori della borghesia italiana, i cui orientamenti politici stavano assumendo toni sempre più conservatori. La fusione tra “sano sperimentalismo” e rigido dualismo metafisico propugnata da Secchi avrebbe goduto un successo duraturo nella scienza italiana. Sfrondato delle connotazioni clericali, il suo approccio poteva essere infatti utilizzato per legittimare la pratica sperimentale, l’innovazione tecnico-scientifica e lo sviluppo economico subordinandoli nello stesso tempo a una sfera superiore di valori spirituali e obiettivi nazionali indiscutibili. Certo l’orizzonte metafisico delle élite italiane di fine secolo non era più quello del dogma cattolico. Si stava affermando, piuttosto, un discorso nazionalistico centrato sulla rilettura idealistica dell’eredità classica e strutturato intorno a miti pervasivi quale quello della madrepa36. Si considerino le significative tendenze materialistiche presenti in medicina, biologia e nelle scienze naturali e il successo della “psicologia scientifica” negli anni settanta e ottanta dell’Ottocento (si veda, ad esempio, G. Sergi, L’origine dei fenomeni psichici e la loro significazione biologica, Dumolard, Milano, 1885). È interessante rilevare che Bonghi appoggiò il progetto di Tacchini nel 1876 rifiutando invece di promuovere la psicologia scientifica di Sergi. Degno di nota è anche l’evidente cambiamento di tono tra le pubblicazioni della collana La scienza del popolo e quelle della Biblioteca utile, entrambe pubblicate da Treves a Milano. Quest’ultima collana, molto meno radicale della prima, ristamperà L’unità delle forze fisiche di Secchi nel 1874. I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE / 173 tria redenta e della sua missione. È questa la matrice culturale che permea il processo di riorganizzazione del lavoro tecnico-scientifico nei laboratori e negli osservatori di fine secolo. In questo contesto le pratiche e i metodi osservativi elaborati da Secchi nella Roma papale potevano quindi produrre e dare senso a valori scientifici – la precisione, ad esempio – la cui diffusione era ritenuta fondamentale per la costruzione della nazione e la realizzazione del suo destino spirituale.37 37. Sulla fortuna dello sperimentalismo di Secchi, si veda Redondi, “Cultura e scienza”, cit. Sul clima culturale di fine secolo e la crisi della cultura positivista, si veda G. Pancaldi, Darwin in Italy. Science across cultural frontiers, Indiana University Press, Bloomington, 1991, pp. 152-169. Sulla costruzione del discorso sui “valori spirituali” nell’Italia di fine secolo, F. Jesi, Cultura di destra, Garzanti, Milano, 1993. 174 / I SIGNIFICATI DELLA PRECISIONE DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 175 DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA. MARCONI E LA WIRELESS TELEGRAPH & SIGNAL COMPANY* Anna Guagnini Introduzione Nei resoconti del processo di sviluppo di imprese che hanno per obiettivo il lancio di una nuova tecnologia, il passaggio dall’invenzione al decollo imprenditoriale costituisce una delle fasi più affascinanti, ma anche più difficili da ricostruire. Il percorso che ha portato pionieri quali Elmer Sperry, Elihu Thompson e Thomas Edison ad impegnarsi in prima persona nello sviluppo commerciale delle proprie invenzioni è stato oggetto di studi esemplari da parte di Thomas Hughes, Bernard Carlson e Robert Friedel, per rimanere nel settore dell’industria elettrica.1 Le loro indagini hanno contribuito a mettere in evidenza non solo la complessità dei rapporti di collaborazione tra attori che con ruoli differenti hanno contribuito allo sviluppo di nuove tecnologie dallo stadio embrionale a quello maturo, ma anche la dimensione imprenditoriale di questo processo. Tuttavia, quelle indagini mostrano anche quanto sia difficile fornire un quadro preciso di come un inventore riesca a portare avanti il proprio progetto fino al punto in cui viene rilevato da una struttura imprenditoriale ben definita; non mi riferisco tanto allo sviluppo degli aspetti tecnologici dell’invenzione, quanto piuttosto a quelli economici e organizzativi. La mancanza di dati precisi costituisce uno dei problemi maggiori; altrettanto difficile è quantificare forme di contributo essenzialmente qualitative, quali ad esempio le collabo* La Wireless Telegraph & Signal Company nel 1900 modificò la ragione sociale divenendo la Marconi’s Wireless Telegraph Company. Dato che questo studio riguarda esclusivamente il periodo anteriore al 1900, si è mantenuta la denominazione della fase iniziale. 1. T. P. Hughes, Elmer Sperry. Inventor and engineer, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1971; W. B. Carlson, Innovation as a social process. Elihu Thomson and the rise of General Electric, 1870-1900, Cambridge University Press, Cambridge, 1991; P. Israel, Edison. A life of invention, John Wiley & Sons, New York, 1998. 176 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA razioni, che pure costituiscono fattori cruciali nello sviluppo di una nuova tecnologia. La formazione della Wireless Telegraph & Signal Co. costituisce un caso esemplare per lo studio del processo di formazione di una società creata specificamente allo scopo di sfruttare e sviluppare commercialmente una invenzione radicalmente innovativa. La storia della società, che nel 1900 modificò la ragione sociale in Marconi’s Wireless Telegraph Co., è stata oggetto di alcuni studi, per altro non recenti: il libro di W. R. Maclaurin (non dedicato specificamente a questa società) venne pubblicato nel 1949, mentre il libro di W. J. Baker (che per quanto accurato è di carattere essenzialmente descrittivo), risale al 1970;2 in entrambi i casi però la fase antecedente la costituzione della società è descritta in modo sommario. Più dettagliata, ma ancora con molte lacune, è la ricostruzione fornita da Hugh G. J. Aitken,3 mentre le numerose biografie di Marconi, in cui l’interesse per l’inventore prevale sulla analisi della società, ne forniscono ricostruzioni storiche quanto meno approssimative.4 Come per altri casi, anche in questo una ricostruzione accurata si scontra con la difficoltà nel reperire informazioni sui costi e le modalità di finanziamento dell’attività condotta precedentemente alla creazione della società. Sicuramente sarà possibile acquisire nuovi dati, anche a seguito del riordinamento dell’Archivio della Marconi Wireless Telegraph Co.5 Tuttavia, difficilmente si riuscirà ad ottenere un quadro preciso di quali e quante siano state le spese incorse nel passaggio dall’invenzione alla costituzione di un’impresa. Rimane però possibile adottare una via indiretta allo studio di questo problema, cioè individuare e mettere in evidenza alcune delle voci più significative tra costi ed investimenti e fornire indicatori che suggeriscano una stima approssimativa di quale possa esserne stata l’entità. È questa la via che ho adottato. 2. W. R. Maclaurin, Invention and innovation in the radio industry, Macmillan, New York, 1949; W. J. Baker, A history of the Marconi Company, Methuen & Co., Londra, 1970. 3. H. G. J Aitken, Syntony and spark, John Wiley & Sons, New York, 1976. 4. Mi riferisco a biografie quali O. Dunlap, Marconi. The man and his wireless, Macmillan, New York, 1937; W. P. Jolly, Marconi, Stein & Day, New York, 1972 e G. Masini, Marconi, UTET, Torino, 1975. Anche la biografia di D. Marconi, My father Marconi, F. Muller, Londra, 1962 (trad. it. Marconi, mio padre, Frassinelli, Milano, 1993), che rimane comunque la migliore da un punto di vista narrativo, risente del mancato ricorso a documentazione primaria per quanto riguarda la storia della società. 5. Di recente l’Archivio della Marconi Wireless Telegraph Company è stato depositato presso la Bodleian Library dell’Università di Oxford e ne è in corso una accurata ricatalogazione. I documenti a cui si fa riferimento di seguito sono indicati usando i codici del vecchio Catalogo; il nuovo ordinamento consentirà in ogni caso di identificare i documenti anche sulla base del loro precedente codice. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 177 L’impostazione delle osservazioni che seguono è prevalentemente tematica, non cercherò quindi di ricostruire le vicende in ordine cronologico (anche se ciò determinerà inevitabili ripetizioni), ma piuttosto di esaminare quali sono stati in quel breve periodo i settori in cui si sono concentrate le spese e quelli che hanno aumentato il valore dell’invenzione. I settori sono: spese brevettuali, di consulenza e legali, dimostrazioni ed esperimenti (e pubblicità) e finanziamento della società. Per quanto la ricostruzione non sia dettagliata, questo tipo di analisi offre in ogni caso una prospettiva nuova da cui esaminare le vicende relative alla fase del decollo. Gli elementi che ne emergono consentono in particolare di ricostruire con maggior precisione il ruolo degli attori principali di questa vicenda, i loro obiettivi e le loro strategie. È stato osservato più volte che quando Marconi decise di recarsi a Londra lo fece perchè non solo era profondamente convinto della validità della sua invenzione, ma era altrettanto deciso a ricavarne un guadagno. Il suo obiettivo era di ottenere un brevetto, venderlo e tornare in Italia con i proventi. Questo piano d’azione aveva ricevuto l’approvazione del padre Giuseppe che, dopo aver manifestato preoccupazione per il futuro di quel giovane totalmente assorto in progetti strani e apparentemente improduttivi, aveva finito per riconoscere il valore potenziale dell’invenzione a cui era approdato. Come ha dimostrato Barbara Valotti, la convinzione che il valore commerciale dell’invenzione dipendesse dal brevetto era solidamente radicata nella mente di Marconi ben prima della sua partenza per Londra. Nei mesi precedenti il viaggio, sia lui sia la madre, Annie Jameson, si rivolsero ai parenti irlandesi di quest’ultima per consigli ed è probabile che siano stati loro a suggerire di registrare la prima domanda di brevetto in Gran Bretagna. Era facile immaginare, infatti, che un certificato di proprietà intellettuale ottenuto in quel paese avrebbe dato all’inventore accesso a un mercato molto più recettivo e potenzialmente remunerativo di quanto potesse aspettarsi in Italia – posto, naturalmente, che si riuscisse a trasformare il dispositivo in un sistema pratico di comunicazione.6 L’importanza del sostegno fornito a Marconi dalla numerosa rete di parenti irlandesi è stata ampiamente riconosciuta dallo stesso invento6. B. Valotti, La formazione di Guglielmo Marconi, Tesi di laurea, Università di Bologna, 1995; Id., “The roots of invention: New sources on young Marconi”, in Universitas, 7, 1995, pp. 1-5; Id., “Oltre il mito dell’autodidatta. Le origini e la formazione di Guglielmo Marconi”, in G. Falciasecca, B. Valotti (a cura di), Guglielmo Marconi. Genio, storia e modernità, Editoriale G. Mondadori, Milano, 2003, pp. 10-27. 178 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA re come dai suoi biografi e dagli storici che si sono occupati delle vicende della Marconi Wireless Telegraph Co. Il contributo del cugino Henry Jameson Davis in particolare è stato ripetutamente – e giustamente – sottolineato. Quanto rimane da chiarire è in che misura quel sostegno abbia inciso sulla direzione di sviluppo dell’invenzione; in altri termini, quanto i rapporti con i parenti inglesi, oltre che quelli avviati con enti pubblici e privati inglesi, abbiano contribuito a ridefinire il programma iniziale di Marconi. Nelle pagine che seguono si tornerà inevitabilmente su questi temi; l’approfondimento degli aspetti economici della fase di transizione e delle iniziative che precedettero la creazione della società sarà un’occasione per esaminare come venne condotta la ricerca di un mercato per il nuovo metodo di comunicazione, quali posizioni emersero nel corso di quel processo e in quale contesto si svolse l’attività di sperimentazione che portò a progressi tecnologici notevoli. Il brevetto Le riforme della legge sulla proprietà intellettuale adottate in Gran Bretagna nel 1852 e nel 1883 portarono non solo ad una notevole semplificazione delle procedure per la domanda e l’ottenimento di brevetti, ma anche una altrettanto notevole riduzione dei costi. In base alle norme in vigore nell’ultimo decennio dell’Ottocento, per ottenere un brevetto un inventore poteva presentare una domanda provvisoria, il cui costo era di 1 sterlina, a cui doveva far seguito entro nove mesi una domanda definitiva per cui venivano richieste 3 sterline (l’inventore poteva anche presentare direttamente la domanda definitiva, evitando la provvisoria, ma ciò avveniva con minor frequenza). Molto più alto, invece, era il costo per il rinnovo dei brevetti, la cui validità si poteva estendere fino a 14 anni: in quel caso l’importo da pagare ammontava a circa 100 sterline.7 Le procedure formali costituivano però il capitolo meno oneroso nell’economia complessiva della richiesta di un brevetto. In teoria, qua7. W. Martin, The English patent system, Temple Primers, Londra, 1904. Per la legislazione inglese relativa ai brevetti e precedente al 1852 rimando a C. MacLeod, Inventing the industrial revolution: The English patent system, 1660-1800, Cambridge University Press, Cambridge, 1988 e H. I. Dutton, The patent system and inventive activity during the industrial revolution, 1750-1852, Manchester University Press, Manchester, 1984. Una sintesi degli sviluppi successivi è offerta da K. Boehm e A. Silberston, The British patent system, Cambridge University Press, Cambridge, 1967. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 179 lunque inventore poteva preparare da solo la propria specificazione, utilizzando i moltissimi manuali pubblicati soprattutto dopo la riforma del 1852. Tuttavia anche le persone più competenti sul piano tecnico/scientifico e dotate di esperienza in campo industriale, se ritenevano che la propria invenzione avesse qualche valore, non potevano fare a meno dell’assistenza di agenti di brevetti. Per evitare di cadere in errori che invalidassero il brevetto, ne riducessero la portata (e quindi il valore commerciale) o lo esponessero al rischio di contestazioni era necessario condurre le ricerche preliminari alla presentazione della domanda con accuratezza e formulare le specificazioni in modo corretto sul piano legale e procedurale; e per ottenere quel risultato occorrevano conoscenze pratiche e teoriche di tipo professionale. Di fatto, nel 1894 solo il 25% dei brevetti fu richiesto da persone che non fossero ricorse all’assistenza di agenti di brevetti.8 Henry Jameson Davis, figlio di una sorella di Annie Jameson, era ben informato a questo proposito. Dopo aver lavorato come ingegnere nel settore dell’industria molitoria, nel 1892 era passato alla libera professione aprendo un ufficio di consulenza in Mark Lane, non lontano dalla sede delle due maggiori associazioni londinesi per il commercio dei cereali. Non solo la sua attività lo aveva portato a trattare licenze e acquisti di brevetti, ma al suo attivo aveva lui stesso due brevetti di macchine per la rimozione di impurità dal grano e da altri cereali nella fase precedente alla macinatura.9 Ben sapendo quanto fosse importante la correttezza formale oltre che la precisione tecnica del testo di un brevetto, Davis si era rivolto in quella occasione ad uno degli agenti più qualificati tra quelli operanti a Londra, la ditta Carpmael & Co. Fu così che a quello stesso studio si rivolse il cugino italiano quando, nella prima settimana di marzo del 1896, avviò le pratiche per ottenere il riconoscimento della propria invenzione. La domanda, dal titolo “Improvements in telegraphy and in apparatus thereof” (N. 5028), fu registrata il 5 marzo 1896.10 8. Special report from the Select Committee on the Patent Agents Bill, Together with the Proceedings of the Committee. Minutes of Evidence, Appendix and Index, HMSO, Londra, 1894. Secondo il presidente del Chartered Institute of Patent Agents, nel 1897 la percentuale era scesa a 15%. W. Lloyd Wise, “The present position of the profession”, in Transactions of the Chartered Institute of Patent Agents, 12, 1893-4, pp. 97-112. 9. I brevetti, di cui era titolare con altri colleghi, erano “Improvements in purifiers employed in milling” (N° 1200, 1889) e “On improvements in purifiers employed in milling” (N° 8488, 1891). 10. Lettera di Carpmael & Co. a Marconi, 19 marzo 1896, Marconi Archive, (Bodleian Library, Oxford; di seguito Marc. Arc.), His 208. Per una analisi dettagliata del processo 180 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA Il conto inviato da Carpmael per la consulenza nella preparazione della domanda provvisoria e la sua presentazione al Patent Office di Londra ammontò a 4,5 sterline. La preparazione di una domanda provvisoria, nel caso di un brevetto che non presentasse particolari problemi in quanto alla complessità del contenuto e ai diritti richiesti (esclusi i disegni), costava mediamente 4 sterline; la parcella di Carpmael rientrava dunque nella norma. Come termine di paragone, per una visita medica a domicilio in quel periodo si chiedevano, a seconda della difficoltà del caso, da 2 fino a 10 sterline; la paga settimanale di un operaio non qualificato era di poco superiore a 1 sterlina, 2 quella di un operaio specializzato. Anche il passo successivo, cioè l’assistenza nella preparazione di una domanda definitiva dello stesso genere “di routine”, sarebbe costata circa 4 sterline. Il sistema proposto da Marconi, però, non era, come suggerito dal titolo adottato per il brevetto, un semplice miglioramento di metodi di comunicazione telegrafica già esistenti. Sulla base di suggerimenti ricevuti dalle persone a cui aveva comunicato la propria invenzione, dell’interesse che stava suscitando da parte di enti governativi e probabilmente anche delle esperienze che stava conducendo in collaborazione con William Preece e i tecnici del General Post Office (come vedremo), Marconi decise di abbandonare la domanda provvisoria già registrata e di presentarne una nuova e più accurata. Il documento, dal titolo “Improvements in transmitting electrical impulses and signals, and in apparatus therefor” (N. 12.039), venne depositato presso il Patent Office il 2 giugno 1896. I nove mesi che intercorrevano tra la domanda provvisoria e quella definitiva avevano lo scopo di consentire al richiedente di perfezionare la descrizione dell’invenzione sulla base di nuovi esperimenti, a condizione che la descrizione finale non modificasse sostanzialmente le caratteristiche dell’invenzione stessa così come era stata descritta nella domanda provvisoria. Nell’autunno del 1896 Marconi si apprestò a preparare la versione finale, integrando nel testo i miglioramenti che erano stati sperimentati nel corso delle prove condotte a Londra e Salisbury, su cui tornerò di seguito. Fu appunto quando dovette affrontare questo compito che Marconi si rese conto della difficoltà di ottemperare alle regole e produrre una specificazione che fosse corretta e al temche si concluse con l’assegnazione del brevetto, si veda A. Guagnini, “Patent agents, legal advisers and Guglielmo Marconi’s breakthrough in wireless telegraphy”, History of Technology, 24, 2002, pp. 171-201. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 181 po stesso gli consentisse di estendere al massimo l’ampiezza delle rivendicazioni. Va tenuto conto anche del fatto che proprio in quel periodo, dopo il primo annuncio pubblico della sua invenzione da parte di William Preece, le reazioni erano state tali da indurlo a ritenere che il brevetto avrebbe incontrato una agguerrita opposizione e che ogni imprecisione del testo sarebbe stata sfruttata per invalidarlo. Le critiche più immediate e vigorose erano provenute dalla comunità scientifica inglese, in particolare da Oliver Lodge e da altri fisici sperimentali di scuola maxwelliana, che avevano accusato il giovane inventore italiano di aver utilizzato tecniche e strumenti di laboratorio perfezionati ed usati per ricerche sperimentali sull’elettromagnetismo. Ma Marconi, nei colloqui avuti con Preece e con i tecnici del GPO e militari, si era reso conto del fatto che contestazioni relative alla priorità nell’uso di dispositivi per la trasmissione senza fili avrebbero potuto provenire anche da altri fronti.11 Per premunirsi contro il pericolo di azioni volte a invalidare il brevetto, Marconi fece quanto era di norma per le invenzioni che si ritenevano più promettenti; ricorse cioè alla consulenza di avvocati specializzati in materia di brevetti, con competenze e conoscenze sia nel settore scientifico e tecnico, sia in quello legale. Si trattava di professionisti la cui esperienza – e la cui fama – era maturata nel corso delle aspre battaglie legali che si stavano conducendo in quel periodo, soprattutto (anche se non esclusivamente) per il controllo di settori industriali in rapido sviluppo come quello elettrico e chimico. Per quanto concerne in particolare il settore elettrico, processi quali quelli intentati alla fine del decennio precedente dalla Edison & Swan United Electric Light Co. per il controllo del brevetto sulle lampadine a incandescenza, in particolare contro Woodhouse & Rowson prima e Holland poi, e con cui la United Telephone Co. si oppose alle società che avevano tentato di inserirsi nel mercato della telefonia, non solo avevano coinvolto i più affermati avvocati e consulenti legali di quel tempo, ma avevano favorito anche lo svilupparsi di competenze di carattere altamente specialistico. Anche nella scelta dei consulenti legali, come in quella degli agenti di brevetti, Marconi non badò a spese e attinse da quanto di meglio offriva il mercato. Il termine per la consegna del brevetto era il 2 marzo 1897. 11. Lettera di Marconi a Preece, 13 dicembre 1896, Preece Collection, MSS 022/11/71, IEE Archive, Londra (di seguito IEE Arc.). Nota manoscritta inviata a Preece da Marconi per la conferenza di Toynbee Hall, dicembre 1896, Baker Collection, NAEST 032/8, IEE Arc. 182 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA Inizialmente, nel dicembre del 1896, Marconi si rivolse a John Cameron Graham. Ingegnere elettrico di formazione, dopo aver lavorato per alcuni anni in ambito industriale Graham aveva intrapreso l’iter di studi e praticantato che dava accesso alla professione legale ed era considerato uno degli avvocati più qualificati nel campo dell’industria elettrica.12 La bozza della domanda venne quindi esaminata da Graham, ma anche il parere di questo esperto non fu ritenuto sufficiente. Prima di consegnare il testo finale, infatti, Marconi chiese e ottenne la consulenza della persona considerata come il maggior esperto scientifico/legale tra quelli operanti nelle corti di giustizia londinesi, John Fletcher Moulton. I titoli di studio e il profilo scientifico di Moulton erano decisamente eccezionali: ottenuto il titolo di Bachelor of Arts presso lo University College di Londra, aveva poi superato l’esame del Tripos presso l’Università di Cambridge con il massimo dei voti. Prima di avviarsi alla professione di avvocato era stato Fellow di Christ College (Cambridge) e, grazie alle ricerche sulle scariche elettriche nei gas rarefatti che aveva condotto in quel periodo, era stato nominato Fellow della Royal Society. La reputazione che si era guadagnato come studente e ricercatore in campo scientifico venne ben presto confermata nella nuova professione: nell’ultimo decennio dell’Ottocento Moulton fu uno dei protagonisti delle battaglie che vennero condotte nel foro londinese, soprattutto dei procedimenti legali che riguardavano il settore industriale.13 Il testo del brevetto di Marconi che venne consegnato al Patent Office il 2 marzo 1897, a poche ore dalla scadenza dei nove mesi prescritti, era dunque il prodotto di un lavoro di revisione che aveva coinvolto ben tre esperti: Carpmael, Graham e Moulton.14 Senza nulla togliere al valore dell’invenzione, non vi sono dubbi che grazie al contributo di que12. Who was Who, 1929-1940; Membership Forms of Applications of Admission to the Society of Telegraph Engineers, v. 7a (1890-91), IEE Arc. Il nome di Graham fu suggerito a Marconi da Preece in una lettera inviata il 5 gennaio 1897, Marc. Arc., His 63. 13. Su Moulton, che nel 1906 venne eletto Lord Justice, si veda H.F. Moulton, The life of Lord Moulton, Nisbet & Co., Londra, 1922. 14. Una ricostruzione dei passaggi attraverso cui il testo venne redatto è offerta dallo stesso Marconi in “Observations on Dr. J. A. Fleming’s Report on Marconi’s Patent No. 12039 of 1896”, Nota dattiloscritta, 6 novembre 1899; Marc. Arc., His 208; e da Edward Carpmael, “Extracts from opinion of Messrs Carpmael & Co”, Nota dattiloscritta in data 15 febbraio 1900; Marc. Arc., His 208. Furono Graham e Moulton, oltre che Carpmael, gli esperti a cui Marconi si rivolse per ottenere i pareri che di norma erano allegati a un brevetto all’atto della sua vendita. I loro certificati vennero infatti allegati alla documentazione relativa all’atto di costituzione della Marconi’s Wireless Telegraph Co., unitamente ad un quarto certificato redatto da F. H. Bowman, ingegnere consulente del General Post Office. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 183 sti consulenti il testo del brevetto fu formulato in modo ineccepibile sul piano legale e tecnico e tale da assicurarne un altissimo valore commerciale. Come venne osservato con malcelata acrimonia dalla stampa specializzata contemporanea, la specificazione era un “modello di perspicacia”:15 nonostante la straordinaria ampiezza delle rivendicazioni il documento offriva infatti ben pochi appigli a chi intendesse contestarne la validità. Ma tutto ciò ebbe un prezzo che non dovette essere indifferente. La maggior parte delle consulenze venne pagata personalmente da Marconi e, con l’eccezione di alcune delle prestazioni di Graham, che vennero pagate tramite lo studio di avvocati Morten, Cutler & Co. e quindi registrate nell’elenco delle spese presentato all’inventore (su cui si tornerà di seguito a proposito dei costi legali), non ne rimane documentazione.16 La relazione che lo studio legale fornì a Marconi indica che Graham fu pagato 5 sterline e 15 scellini per consultazioni di carattere tecnico, e una sterlina e 6 scellini per quelle di carattere amministrativo/legale, ma non vi sono informazioni su quanto richiedesse per pareri relativi alla formulazione di brevetti, né di quante volte Marconi sia ricorso al suo intervento. Sappiamo però che venne interpellato frequentemente, non solo per questioni di brevetti ma anche, come si vedrà, nel corso delle trattative per la creazione della società. Anche per quanto riguarda Moulton la documentazione è carente, ma non è difficile immaginare che le sue parcelle corrispondessero alla reputazione di cui godeva. Che il prezzo pagato per il lavoro svolto da quegli esperti fosse stato alto lo ammise lo stesso Marconi, ma sia lui sia i dirigenti della Marconi’s Wireless Telegraph Co. dovettero anche essere ben consapevoli dell’importanza del loro contributo: Carpmael & Co. rimasero per anni gli agenti di brevetti della società e la collaborazione di Graham e Moulton fu richiesta in altre occasioni, in particolare per il famoso brevetto N. 7777 del 1900 relativo alla sintonia, sulla cui validità si sarebbe dovuta basare la possibilità di mantenere il controllo tecnologico e imprenditoriale del nuovo metodo di comunicazione.17 15. “Notes”, in The Electrician, 39, 1897, p. 665. 16. Morten, Cutler & Co., “Sale of Patent”, (25 gennaio/24 luglio 1897), p. 6. Marc. Arc., His 43. 17. Alla stesura del testo del brevetto N. 7777 collaborarono Moulton, Graham e J. A. Fleming. Moulton e Graham furono consultati ancora nel 1901 in relazione alla validità del brevetto di Ferdinand Braun (Lettera di J. A. Fleming a Marconi, 20 febbraio 1901; Mar. Arc., His 248). Sempre nel 1901 a Moulton fu affidato il compito di esaminare il testo del brevetto 7777 prima che fosse consegnato al Patent Office (Lettera di J. A. Fleming a Marconi, 17 febbraio 1901; Marc. Arc., His 208). E nel 1904, quando la Marconi Wireless 184 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA Il capitolo spese per quanto riguarda il primo brevetto non termina a questo punto. Un’altra voce, e probabilmente la più costosa, riguardò infatti le domande di brevetto che vennero presentate in altri paesi per ottenervi analoga protezione legale. Le leggi sulla proprietà intellettuale e le regole per la formulazione delle richieste di brevetto erano non solo notevolmente differenti, ma la stessa definizione di che cosa costituiva l’oggetto della domanda variava da un paese all’altro; la preparazione del testo del brevetto e l’ordine temporale nella presentazione delle domande dovevano tenere conto di tali differenze. Le richieste di brevetto per la Germania e gli Stati Uniti, ad esempio, dovevano essere inoltrate prima che i contenuti della domanda presentata in Inghilterra divenissero pubblici, il che avveniva dopo la accettazione del brevetto da parte del Patent Office di Londra. A quel punto, infatti, il testo del brevetto inglese sarebbe stato considerato come una pubblicazione e avrebbe potuto invalidare le domande presentate in altri paesi, anche se a presentarle era lo stesso firmatario del brevetto originale. Anche in questo caso, se il valore presunto dell’invenzione era alto, era pressoché inevitabile che si ricorresse all’assistenza di agenti, scegliendoli preferibilmente tra coloro che avevano maggior esperienza in quel genere di pratiche. Senza la loro assistenza sarebbe stato pressoché impossibile riuscire a presentare le domande in altri paesi evitando di incorrere in errori procedurali che non solo avrebbero rischiato di comprometterne la validità, ma avrebbero potuto danneggiare lo stesso brevetto inglese. Forse Davis non aveva considerato questo aspetto nel momento in cui, per i propri brevetti, aveva deciso di affidarsi alla ditta Carpmael & Co. Di fatto la scelta si rivelò ideale per Marconi perché quella era una delle ditte di maggior esperienza per quanto riguardava le pratiche per il conseguimento di brevetti a livello internazionale.18 Già nell’aprile del 1896 Marconi aveva chiesto a Carpmael informazioni sulle procedure e sui costi per ottenere brevetti in altri paesi europei ed extra-europei. Sulla base delle indicazioni ricevute comunicò Telegraph Co. intentò un procedimento legale contro De Forest e la sua società per violazione di brevetto, a Moulton fu chiesto di preparare una relazione da affidare agli avvocati americani di Marconi (J. F. Moulton, Nota dattiloscritta senza titolo relativa alla relazione di Betts, Betts, Sheffield & Betts, New York; Marc. Arc., His 181). 18. Edward Carpmael (senior partner della ditta) e suo fratello Alfred (di professione avvocato) erano autori di Carpmael’s Patent Laws of the World (W. Clowes & Sons, Londra, 1885), il più importante testo su questo argomento, più volte aggiornato e ripubblicato negli anni successivi e poi ripreso come annuario dal Chartered Institute of Patent Agents con il titolo Patent Laws of the World and Patent and Trade Mark Laws of the World. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 185 al padre che la spesa sarebbe ammontata a 300 sterline.19 Non si trattava certo di una stima per eccesso, ma come tale fu probabilmente considerata dal genitore; di conseguenza Marconi dovette ridurre il numero dei paesi in cui presentare le domande. Il mese successivo il giovane inventore scrisse di nuovo al padre, questa volta chiedendogli 190 sterline e specificando che sarebbero servite per ottenere brevetti esteri. Nel periodo da maggio a settembre 1896 quest’ultimo inviò effettivamente tre bonifici da 100 sterline ciascuno, ma per le dimostrazioni oltre che per i brevetti.20 L’abbandono della domanda provvisoria rinviò i termini per la presentazione delle domande in altri paesi; tali procedure potevano infatti venir avviate solo dopo che la domanda provvisoria era stata registrata presso il Patent Office inglese e quando il testo finale era ormai definito. Tuttavia nel novembre del 1896, quando la questione tornò a presentarsi, Marconi chiese a Carpmael un nuovo preventivo per ottenere brevetti in nove paesi: Francia, Germania, Austria, Stati Uniti, Russia, Ungheria, Spagna, Italia e India.21 Le domande vennero presentate nelle settimane successive, come Marconi si premurò di comunicare al padre in una lettera del 8 gennaio 1897. Tuttavia in quella occasione non mancò di sottolineare che dall’elenco rimanevano esclusi altri paesi, in particolare Belgio, Svizzera, Portogallo, Danimarca e Brasile e che sarebbe stata sua intenzione di far domanda anche in quei paesi, se e quando avesse avuto il denaro necessario.22 Dimostrazioni ed esperimenti L’assistenza fornita da Davis al giovane cugino italiano (Davis aveva allora 42 anni e Marconi solo 22) andò ben al di là dei consigli relativi al brevetto. Già nei primi mesi del 1896 Davis era attivamente impegnato nel promuovere l’invenzione e il suo ufficio di Mark Lane, come pure l’abitazione londinese di Marconi, divenne la base per una intensa attività di contatti, incontri e dimostrazioni del funzionamento del nuovo 19. Lettera di Marconi al padre, 8 aprile 1896, Henry Willard Lende Collection (di seguito Lende Coll.); “Note spese di Giuseppe Marconi”, Archivio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma (di seguito Arc. Lincei), Carte Marconi, Scatola 39, Gruppo A, Fasc. 5. 20. Lettera di Marconi al padre, 6 maggio 1896, Lende Coll. 21. Lettera di Marconi a Carpmael, 8 novembre 1896, Marc. Arc., His 10. 22. Lettera di Marconi al padre, 9 gennaio 1897, Lende Coll. 186 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA metodo di comunicazione. Queste prime dimostrazioni furono essenzialmente di carattere privato, rivolte a persone che Davis, con l’aiuto di altri parenti, contattò tra conoscenti e colleghi; lo scopo era di divulgare informazioni sul nuovo sistema di comunicazioni e di individuare potenziali acquirenti del brevetto. Ad assistere a quelle prove di trasmissione furono ingegneri, principalmente liberi professionisti individuati soprattutto tra quanti operavano nel campo dell’ingegneria elettrica, e persone la cui attività gravitava attorno al commercio di grano e cereali, il settore in cui Davis stesso lavorava. Per quanto concerne questo secondo fronte, l’ufficio di Mark Lane, come si è detto, era strategicamente situato a poca distanza dagli uffici delle due maggiori associazioni londinesi di commercio di cereali, il Baltic Exchange e il London Corn Exchange;23 probabilmente alcune dimostrazioni furono realizzate anche presso le sedi di queste associazioni.24 L’attività promozionale fu altamente dispendiosa dal punto di vista del tempo ad esse dedicato, non solo da Marconi ma anche da Davis. Oltre al ruolo di consulente quest’ultimo si trovò infatti a svolgere spesso anche quello di assistente del cugino, dato che le dimostrazioni richiedevano l’intervento di almeno due persone e Marconi non poteva permettersi di affidare una parte delle sue apparecchiature ad estranei prima di aver ottenuto il brevetto. Tuttavia le prime dimostrazioni non furono impegnative da un punto di vista tecnico e neppure da quello dei costi. L’apparato utilizzato era sostanzialmente quello che era stato portato da Bologna; le parti che si erano danneggiate nel corso del trasporto dall’Italia furono riparate e le modifiche apportate consistettero essenzialmente nella sostituzione di alcune componenti con altre di miglior qualità acquistate o ordinate (su consiglio e con l’assistenza di Davis) presso costruttori di strumenti scientifici londinesi. Ben presto però le spese cominciarono ad aumentare. Le dimostrazioni private proseguirono anche nei mesi successivi, tuttavia già nella primavera del 1896 Marconi, sempre grazie ai propri parenti irlandesi residenti a Londra, avviò contatti con enti pubblici, il General Post Office (di se- 23. Gli uffici del London Corn Exchange erano proprio in Mark Lane e quelli del Baltic Exchange (South Sea House) si trovavano in una via adiacente, Threadneedle Street. 24. A. R. Tattersall, nel suo necrologio di Davis, ricorda lo scalpore suscitato dal racconto di una prova condotta da Marconi e da Davis presso la sede del Baltic Exchange in presenza dei membri di quella associazione. Necrologio di H. J. Davis, The Miller, gennaio 1937; copia in Marc. Arc., His 247. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 187 guito GPO) e il War Office. Dapprima, su suggerimento di un altro cugino, Ernest Burns, luogotenente del Genio Militare, Marconi comunicò la propria invenzione al maggiore George Anderson Carr, un ingegnere militare che insegnava elettrotecnica alla School of Military Engineering di Chatham e alla School of Submarine Mining di Gillingham. Carr gli riferì che difficilmente l’esercito avrebbe accettato di acquistare un’invenzione per cui era già stato richiesto un brevetto e gli consigliò di rivolgersi al GPO. Marconi non perse tempo e nel giro di pochi giorni riuscì a procurarsi (probabilmente grazie a Davis) una lettera di presentazione che gli consentì di ottenere un appuntamento con Preece, il potente Engineer-in-Chief ed Electrician dell’ente governativo responsabile delle comunicazioni.25 L’incontro avvenne alla fine di marzo e quanto il giovane inventore italiano mostrò a Preece bastò a convincerlo che valeva la pena esaminare attentamente l’invenzione. Da quel momento il giovane inventore italiano si trovò a fronteggiare una situazione comune a molti dei promotori di nuove tecnologie e non solo nel settore delle comunicazioni. Le dimostrazioni divennero pubbliche, sempre più impegnative e si trasformarono gradualmente in ambiti di sperimentazione in cui gli apparati di trasmissione e ricezione venivano modificati e nuove soluzioni erano adottate al fine di migliorare il funzionamento del sistema. A partire da quel momento le dimostrazioni, realizzate in condizioni simili a quelle operative, divennero sia “vetrine” commerciali, sia opportunità di ricerca e di conduzione di esperimenti. Entrambe queste attività, sia la dimostrazione a scopo commerciale sia la ricerca, si dimostrarono necessarie per il conseguimento dell’obbiettivo che Marconi si era preposto; ma il loro costo, che non era stato previsto inizialmente, divenne sempre più alto. Quando Marconi lo informò della propria invenzione, Preece, avendo ben presente il genere di situazioni a cui avrebbe potuto venir applicata, gli offrì la possibilità di organizzare delle prove presso la sede del GPO. La natura del supporto offerto da Preece fu però stabilita in termini espliciti già nel corso dei primi incontri: l’ente governativo inglese avrebbe offerto la disponibilità dei locali e del proprio personale tecnico e avrebbe acconsentito all’utilizzazione delle proprie officine per modificare o aggiustare le attrezzature necessarie alle prove, ma non avrebbe contribuito direttamente ai costi delle prove o alla produzione 25. Lettera di Marconi al padre, 1 aprile 1896, Lende Coll. 188 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA delle attrezzature utilizzate nel corso delle stesse.26 I preparativi per la realizzazione delle prove iniziarono subito: a partire dalla fine di aprile i due cugini avevano avviato contatti con varie ditte londinesi, tra cui Elliott Brothers, Consolidated Telephone Construction & Maintenance Co. e Siemens, per ottenere preventivi e ordinare strumenti, in particolare campanelli elettrici e relais.27 Già all’inizio di maggio il giovane inventore aveva scritto al padre chiedendogli di inviare 100 sterline per pagare gli strumenti che aveva ordinato in preparazione di quegli esperimenti: fu questo bonifico che portò a 300 sterline la quota inviata per brevetti e sperimentazione da Giuseppe Marconi nel 1896.28 Al loro acquisto contribuì anche Davis, che stimò in circa 50 sterline la propria spesa per gli strumenti utilizzati nel corso delle dimostrazioni condotte nei primi mesi del 1896.29 La prima serie di dimostrazioni fu condotta presso la sede londinese del GPO, in St. Martin Le Grand, nell’ultima settimana di luglio del 1896. Preece,30 uno degli esperti più in vista (e anche più controversi) nel settore dell’industria elettrica inglese, da anni era impegnato, con l’assistenza dei tecnici del GPO, nella sperimentazione di un proprio metodo di comunicazione senza fili, concettualmente del tutto diverso da quello utilizzato da Marconi.31 Tuttavia, nonostante ripetuti tentativi, Preece non era riuscito a trasformarlo in un sistema in grado di risolvere il problema per cui era stato ideato: la comunicazione tra stazioni poste a distanza ravvicinata, ma tra cui fosse difficoltoso mantenere un 26. In risposta a una lettera del padre, che aveva frainteso la disponibilità del Post Office a sostenere i costi delle prove, Marconi precisò i termini dell’accordo: “non avendomi il direttore dei telegrafi offerto di far eseguire a sue spese le prove del mio sistema, ma solo di prestarmi l’uso dei locali per gli esperimenti che avrei creduto di fare, come pure di farmi aiutare in qualche modo dal personale telegrafico, per cui le spese più grandi, cioè il costo delle macchine e delle privative rimarrebbero a mio carico.” Lettera di Marconi al padre, Londra, 8 aprile 1896, Lende Coll. 27. Lettere di Davis a Marconi, 25-30 aprile e 15 giugno 1896, Marc. Arc., His 77. 28. Lettera di Marconi al padre, 6 maggio 1896, Lende Coll. La somma gli fu recapitata qualche giorno più tardi. 29. Lettera di Davis a Marconi, 27 settembre 1912, Marc. Arc., His 247. 30. Su Preece si vedano E. C. Baker, Sir William Preece FRS, Victorian engineer extraordinary, Hutchinson & Co., Londra, 1976) e B. Hunt, “‘Practice vs. theory’. The British electrical debate, 1888-1891”, in Isis, 74, 1983, pp. 341-55. 31. Si trattava di un sistema basato su fenomeni di induzione elettromagnetica, a cui Preece era pervenuto sulla base dell’osservazione di interferenze tra linee telefoniche. Così come era stato ideato e impostato, si trattava di una estensione dei metodi in uso di comunicazione via fili più che di una alternativa a tale sistema. Preece stesso descrisse i suoi esperimenti di “telegrafia induttiva” in una serie di articoli pubblicati sulla stampa scientifica dell’epoca. Si veda in particolare W. Preece, “Signalling through space”, in Journal of the Society of Arts, 42, 1893-4, pp. 274-280. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 189 collegamento via filo. Ne era un caso tipico la comunicazione tra stazioni costiere e battelli-faro o fari costruiti su isole difficilmente accessibili in quanto situate in tratti di mare soggetti a frequenti mareggiate o forti correnti. Di questo problema, e in generale della creazione di una rete di collegamento tra i fari posti a protezione della navigazione lungo le coste inglesi, si erano occupate a partire dal 1892 ben cinque commissioni parlamentari.32 Preece era bene informato sull’attività di queste commissioni perché l’ingegnere capo del GPO ne era membro permanente. Le prime prove condotte da Marconi a Londra, presso la sede del GPO, ebbero essenzialmente lo scopo di verificare (da parte dei funzionari di quell’ente) se il sistema funzionasse effettivamente, sia in condizioni da laboratorio sia per distanze di poche decine di metri. Più impegnative furono le prove condotte nella prima metà di settembre presso Salisbury. Anche in quel caso si trattava di dimostrazioni realizzate per il GPO, ma vi assistettero oltre ai tecnici di quell’ente anche osservatori militari inviati dal War Office e dalla Royal Navy. Poco dopo essersi messo in contatto con Preece, Marconi aveva infatti comunicato la propria invenzione al War Office33 e vi erano già stati due incontri: una visita da parte di Charles Penrose, maggiore dei Royal Engineers il 18 di giugno 1896 presso l’abitazione di Marconi, durante la quale quest’ultimo dimostrò il funzionamento del proprio sistema di comunicazione, a cui fece seguito alla fine di agosto una dimostrazione che Marconi fu invitato a tenere presso gli uffici londinesi del War Office.34 L’obiettivo del secondo ciclo di esperimenti fu di accertare a quale distanza fosse possibile trasmettere segnali, sia mediante uso di riflettori sia con “conduttori verticali”, lontano da linee telegrafiche e telefoniche, da reti di distribuzione dell’elettricità e da altre strutture urbane che potessero causare interferenze. Le prove, a cui assistettero anche osservatori militari, si protrassero per due settimane. Durante quel pe32. First Report of the Royal Commission appointed to inquire and report what lighthouses and light-vessels it is desirable to connect with the telegraphic system of the United Kingdom by electrical communication, HMSO, Londra, 1893 [C.-6844]. L’ultimo dei rapporti, su cui si tornerà di seguito, fu pubblicato nel 1897. 33. Lettera di Marconi al Principal Secretary del War Office, 20 maggio 1896, Public Record Office, Londra (di seguito PRO), WO 32/8594. Rapporto inviato dal Maggiore C. Penrose, Assistant Inspector of Submarine Defences, al War Office, 20 giugno 1896, PRO, WO 32/8594. 34. Rapporto di Penrose a W. H. Turner, del War Office, 1 settembre 1896, PRO, ADM 111/567. Alle prove assistettero, oltre a Penrose, il Maggiore Carr (che Marconi aveva già incontrato privatamente) e Henry B. Jackson per la Royal Navy. 190 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA riodo Marconi si valse dell’assistenza di Harry R. Kempe, uno dei più validi e stretti collaboratori di Preece e 1st Principal Technical Officer del GPO,35 J. B. Chapman (Principal Technical Officer) e altri due Royal Engineers, uno dei quali, George Kemp, sarebbe diventato in seguito uno dei primi e più fidati assistenti di Marconi.36 Senza dubbio i benefici ottenuti da quella collaborazione, che proseguì durante i mesi invernali presso la sede del GPO, furono notevoli. Con il loro aiuto Marconi migliorò e rese più efficace la disposizione delle varie parti del sistema e introdusse nuovi dispositivi che, pur non modificandone la struttura di fondo, nel loro complesso produssero un sensibile aumento della distanza e della qualità della trasmissione.37 Il risultato di quelle prove procurò a Marconi, per tramite di Preece, l’attenzione della Royal Commission on Electrical Communication with Lighthouses and Light-vessels. Nel rapporto finale – il quinto – pubblicato nel settembre del 1897, la commissione suggerì che il sistema di Marconi poteva essere considerato un’alternativa nei casi in cui la soluzione via cavo telefonico e quella induttiva si fossero dimostrate insoddisfacenti, in particolare per la comunicazione con navi faro situate in tratti di mare dai fondali profondi e rocciosi. Il rapporto preannunciava anche la realizzazione di esperimenti per accertare la validità del nuovo metodo.38 Una raccomandazione del genere non poteva che incoraggiare le speranze di Marconi circa la possibilità di vendita della sua invenzione. Tuttavia, da un punto di vista delle attrezzature, i costi continuavano ad gravare sulle spalle sue e dei suoi famigliari e parte dei 35. A questo tecnico in particolare, per la sua notevole esperienza e competenza, Preece aveva affidato la realizzazione dei propri esperimenti di telegrafia induttiva. Membro del Institution of Electrical Engineers (oltre che degli Institutions of Civil e Mechanical Engineers), Kempe era anche l’autore di due testi di elettrotecnica tra i più usati dagli ingegneri telegrafici inglesi di quel periodo, A handbook of electrical testing (E. & F.N. Spon, Londra, 1876) e Engineer’s Year Book (Londra, 1894). R. Appleyard The history of the IEE, IEE, Londra, 1939, pp. 43-4; necrologio in The engineer, 159, 1935, p. 401. 36. Oltre a Kempe e Kemp, gli altri tecnici del GPO specificamente ricordati da Marconi per il contributo dato durante quelle prove furono John Gavey, M. Cooper, J. E. Taylor. Documento manoscritto di Marconi, Marc. Arc., His 62. 37. Come li descrisse Marconi, questi miglioramenti consistettero principalmente nell’uso di relais più sensibili, martelletti più rapidi e disposizioni migliori e più compatte delle varie parti di trasmettitori e ricevitori. Guglielmo Marconi, Brief story of my life (ristampa, in versione narrativa, della testimonianza resa da Marconi nel corso del procedimento legale contro la National Electric Signalling Co., Eastern District of New York Court, giugno 1913 e pubblicata nella rivista American Marconigraph a partire dal luglio 1913), Mar. Arc., His 38. 38. Fifth and Final Report, Royal Commission on electrical communication with lighthouses and light-vessels, HMSO, Londra, 1897 [C.-8675], p. 6. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 191 soldi inviati a Marconi dal padre Giuseppe nell’estate del 1897 era stato destinato specificamente a sostenere le spese di quelle prove. Una nuova serie di prove fu condotta dal 15 al 24 marzo, ancora nei pressi di Salisbury. Durante quegli esperimenti Marconi venne assistito da tre tecnici del GPO, tra cui George Kemp. Anche a quelle prove partecipò in qualità di osservatore per conto della Royal Navy Henry B. Jackson, Capitano e Comandante della Scuola Navale di Torpediniere HMS Defiance, da tempo impegnato in ricerche su di un sistema di telegrafia senza fili simile a quello di Marconi.39 Nel corso del secondo ciclo di esperimenti a Salisbury l’attenzione si spostò definitivamente sull’uso di conduttori elevati. Per ottenere una maggior altezza furono fatti costruire appositamente ed utilizzati due palloni aerostatici di due metri di diametro, avvolti da una sottile lamina di stagno; quando le condizioni del tempo impedirono l’uso dei palloni, vennero costruiti degli aquiloni. Anche in quel caso attrezzature e trasporti furono pagati da Marconi. I risultati ottenuti nel corso dei nuovi esperimenti furono sorpredenti: da una distanza di trasmissione di poco più di un chilometro ottenuta nel settembre precedente, si passò a 11 chilometri. Il parere degli esperti che parteciparono ai due cicli di prove condotte presso Salisbury, sia i tecnici del GPO sia quelli militari, furono positivi. Pur riconoscendo che i dispositivi utilizzati da Marconi erano ancora notevolmente rozzi e che molto restava da fare per ottenere un sistema sufficientemente affidabile, i rapporti stilati separatamente da Kempe, Penrose e Jackson concordavano sulla fattibilità del metodo e sull’opportunità di proseguire gli esperimenti.40 Più ambigua invece fu la posizione di Preece. Da un lato i commenti che espresse nella corrispondenza privata con i dirigenti del GPO furono scettici. Nella lettera di accompagnamento del rapporto di Kempe dichiarò infatti che a suo parere tale relazione era “molto interessante ma non incoraggiante” e di ritenere che il proprio sistema di telegrafia induttiva fosse “più eco39. Su Jackson, le sue ricerche e i rapporti con Marconi, si veda in particolare R. F. Pocock, G. R. M. Garratt, The origins of maritime radio. The story of the introduction of wireless telegraphy in the Royal Navy between 1896 and 1900, Science Museum, HMSO, Londra, 1972 e R. F. Pocock, The early British radio industry, Manchester University Press, Manchester, 1988. 40. “Signalling across space by Marconi’s aystem. Report by Mr. H. R. Kempe of Engineer in Chief’s Office”, 15 settembre 1896, IEE Arc., Special Collection, MSS 22/101/106; C. Penrose, “Report on Signor Marconi’s invention”, 1 settembre 1896, PRO, ADM 111/ 567. “Report of 16th September 1896 (G. 4082) from Captain Jackson, H.M.S. ‘Defiance’, to the Commander-in-Chief, Devonport”, in Admiralty Correspondence relating to Signor Marconi’s system of wireless telegraphy, HMSO, Londra, 1899, pp. 1-3. 192 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA nomico e pratico”.41 Dall’altro, nelle sue dichiarazioni pubbliche, l’ingegnere capo del GPO ostentò non solo una notevole fiducia a livello personale nel nuovo sistema, ma anche l’impegno a promuoverlo da parte dell’ente di cui era dipendente: durante una conferenza che tenne nel dicembre del 1896 a Londra in cui annunciò ufficialmente per la prima volta il risultato degli esperimenti di Salisbury (quegli stessi esperimenti che aveva descritto privatamente come non incoraggianti), affermò che il GPO “aveva deciso di non risparmiare spese per gli esperimenti con l’apparato [di Marconi]” e che nuove prove erano imminenti. La comunicazione ebbe ampia eco nella stampa contemporanea e così pure la notizia che gli esperimenti sarebbero stati condotti con il supporto del GPO.42 Quegli esperimenti vennero effettivamente realizzati: le prove si tennero nella prima metà del maggio successivo attraverso il Canale di Bristol, tra Lavernock Point, presso Penarth, l’isola di Flat Holm e Brean Down, presso Weston-super-mare, e furono decisamente più importanti e impegnative delle precedenti. Le distanze su cui ci si proponeva di verificare il funzionamento dei due metodi erano di 3,3 miglia (5,3 chilometri) nel primo tratto, e di 8,7 miglia (14 chilometri) tra le stazioni poste sui versanti opposti del canale e cioè Lavernock Point e Brean Down.43 Tuttavia, le 600 sterline che servirono a finanziare quelle prove non vennero stanziate dal GPO, ma dal Board of Trade, l’ente governativo per conto del quale la Royal Commission aveva svolto le proprie indagini.44 Si trattava infatti delle prove preannunciate nel rapporto finale di quella commissione, la cui gestione era stata affidata al GPO. Inoltre quella quota doveva servire a pagare non solo le spese per gli 41. Lettera di Preece a Lamb, 20 settembre 1896, allegata al rapporto di Kempe, IEE Arc., Special Collection, MSS 22, 100-276. 42. L’affermazione fu riportata non solo su riviste specializzate come The electrical engineer (18 dicembre 1896, p. 681), ma anche su The Daily Chronicle, (14 dicembre 1896) e in un articolo apparso sulla rivista del GPO. Si veda “Telegraphing without wires”, in St Martin’s Le Grand, 7 gennaio 1897, pp. 80-81. 43. La scelta della località non fu casuale: nel 1892 in quello stesso luogo Preece aveva già organizzato degli esperimenti di telegrafia induttiva. A Lavernock Point (presso Penarth) e sull’isola di Flat Holm vi erano due fortezze militari, a protezione del canale di Bristol. Nel 1896 il War Department posò un cavo per la comunicazione tra le due fortezze, ma la soluzione non era ideale a causa del traffico intenso e dei frequenti ancoraggi; infatti dopo poco il cavo si spezzò. Nel 1898 il cavo fu sostituito dal sistema induttivo di Preece. Si veda Preece, “Aetheric Telegraphy”, in Journal of the Society of Arts, 47, 1897, p. 520. 44. R. F. Pocock, “Marconi’s radio trials at Lavernock”, Papers presented at the Fifth IEE Meeting of the History of Electrical Engineering, 1977 (N.6, pp.1-5), p. 2. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 193 esperimenti di Marconi, ma anche le prove che Preece intendeva condurre – e che di fatto realizzò – con il proprio sistema di telegrafia induttiva. Di fatto, queste ultime dovettero assorbire la maggior parte dello stanziamento, se è vero quanto Marconi riferì in una lettera all’ambasciatore italiano a Londra, Annibale Ferrero, in cui lo informò della decisione del Governo inglese di spendere 200 sterline per esperimenti da condurre presso Cardiff.45 Le dichiarazioni di Preece per quanto riguarda il sostegno finanziario del GPO produssero critiche che continuarono negli anni da parte degli avversari di Marconi. Ancora nel 1906 Silvanus Thompson, professore di ingegneria elettrica al Finsbury College di Londra, denunciò in una lettera a The Times che 5.000 sterline di denaro pubblico erano state spese per promuovere una tecnologia di cui aveva beneficiato un’impresa privata. Marconi più volte contestò queste affermazioni46 e lo stesso Preece smentì privatamente quanto aveva dichiarato in pubblico: in una lettera a Lodge, che lo rimproverava di aver devoluto fondi pubblici al finanziamento di un sistema proposto da uno straniero, Preece affermò che Marconi “non aveva mai ricevuto un solo penny da noi” e che era stata la stampa a diffondere al riguardo notizie scorrette.47 In effetti, non risulta che il GPO si sia comportato diversamente da quanto il suo ingegnere capo aveva dichiarato inizialmente e cioè si era limitato a fornire l’assistenza dei propri tecnici. Non si trattò in ogni caso di un contributo da poco, non solo da un punto di vista tecnico e qualitativo e neppure da un punto di vista strettamente monetario: se si fosse conteggiato quanto era costata tale assistenza in termini di orelavoro di alcuni dei propri tecnici più qualificati e la disponibilità del proprio laboratorio, l’investimento da parte del GPO era stato cospicuo, ma la spesa si sarebbe probabilmente fermata al di sotto delle 500 sterline. Va anche tenuto presente che grazie a quella collaborazione l’ente governativo inglese aveva ottenuto informazioni preziose su di un sistema protetto da un brevetto. 45. Lettera di Marconi a A. Ferrero, 20 dicembre 1896. Ambasciata a Londra, Corrispondenza in arrivo novembre-dicembre 1896, Busta 184, fascicolo 2, Ministero degli Affari Esteri, Roma. 46. “Wireless telegraphy, 1895-1919. Some personal experiences of its inception, development and achievements. By G. Marconi”, Capitolo 3, pp.10-11; dattiloscritto, a cura di L. de Sousa, segretario privato di Marconi, Marc. Arc., His 10. 47. Lettera di Preece a O. Lodge, 15 marzo 1898; University College Archive, Lodge Collection, MS ADD 89/86. 194 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA Altri segnali di interesse Restava ancora moltissima strada da fare. Marconi doveva ancora dimostrare l’efficienza e la affidabilità del suo sistema nelle condizioni in cui avrebbe dovuto venir utilizzato normalmente. Tuttavia in poco più di un anno la qualità e la distanza delle trasmissioni erano state migliorate in modo straordinario e di pari passo si era accresciuto il valore commerciale dell’invenzione. Quale poteva essere tale valore? Per quanto riguarda il settore civile, nel rapporto finale della Royal Commission on Electrical Communication with Lighthouses and Light-vessels si era indicato in 10.060 sterline il preventivo per il collegamento di 5 navi faro del tipo sopra indicato con la costa, cioè circa 2.000 sterline per impianto.48 Il preventivo si riferiva ovviamente a collegamenti da stabilirsi con il metodo tradizionale, via cavo telefonico, ma indicava il prezzo che il governo inglese sarebbe stato disposto a pagare per qualsiasi metodo alternativo altrettanto efficace e la cui manutenzione risultasse meno costosa. I risultati conseguiti nel corso delle dimostrazioni di Bristol non lasciavano dubbi: la distanza di trasmissione raggiunta in quella occasione dal sistema di Marconi era stata di più di 14 chilometri. A quel punto Preece abbandonò le esitazioni che lo avevano mantenuto in posizione d’attesa e nel rapporto che inviò al Segretario del GPO alla metà di luglio suggerì di offrire 10.000 sterline per l’acquisto del brevetto, posto che nel frattempo gli uffici governativi competenti si fossero pronunciati a favore della sua validità.49 Nel frattempo erano cominciate a pervenire a Marconi richieste di informazioni da parte di altri enti, sia pubblici sia privati. Dimostrazioni erano state offerte agli addetti dell’Ambasciata Austro-Ungarica a Londra;50 ancora più interessante era stato il segnale di interesse da parte della società di assicurazioni Lloyds di Londra che tramite il suo segretario, Henry Hozier, si era messa in contatto con gli avvocati di Marconi, lo studio legale Morten Cutler & Co., per ottenere informazioni sul nuovo sistema di comunicazioni.51 All’inizio di gennaio Marconi 48. Fifth and Final Report, Royal Commission on electrical communication, p. 12. 49. Lettera di Preece a J.C. Lamb, Segretario del GPO, 15 luglio 1897; IEE Arc., NA 13/9. 50. Lettera di Marconi al padre, 9 gennaio 1897, Lende Coll. 51. Un incontro tra Morten e Hozier è registrato alla data 1 marzo 1897 nel documento Morten Cutler & Co., “Sale of Patent”, cit., p. 6. Hozier da anni stava promuovendo la creazione di una rete privata di stazioni di segnalazione lungo le coste inglesi, di proprietà della Lloyds e gestita da quella stessa società. D. E. W. Gibb, Lloyd’s of London. A study in individualism, Macmillan & Co., Londra, 1957. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 195 aveva ristabilito i contatti con l’ambasciatore italiano a Londra, il generale Ferrero, lo aveva incontrato e gli aveva mostrato il funzionamento del suo metodo di trasmissione presso i locali del GPO.52 Ferrero, che durante il primo incontro con il giovane inventore nel marzo del 1896 si era limitato a fornire consigli generici, questa volta si impegnò a comunicare i risultati degli esperimenti che Marconi stava conducendo alle autorità italiane. Rimaneva intanto forte l’interesse da parte degli enti militari inglesi e, in particolare, della Royal Navy. Già nel rapporto inviato ai suoi superiori nel settembre del 1896, dopo aver assistito al primo ciclo di prove presso Salisbury, Jackson riferì di aver discusso con Marconi il prezzo che quest’ultimo avrebbe chiesto per effettuare delle prove per conto dell’Ammiragliato. Marconi aveva avanzato la proposta di un compenso mensile di 25 sterline (più una quota da stabilire in base al successo degli esperimenti) e circa 300 sterline per il primo apparecchio completo che avrebbe fornito; i successivi, secondo Jackson, avrebbero avuto un prezzo inferiore a seconda della quantità dell’ordinazione. Il rapporto, estremamente dettagliato nella descrizione tecnica, indicava chiaramente che per parte sua Jackson non solo riteneva il sistema valido, ma era decisamente favorevole all’avvio di tali prove.53 Ancora più positivi furono i commenti contenuti nel rapporto inviato dopo il secondo ciclo di prove a Salisbury e quelle di Bristol, tanto da indurre il War Office ad accogliere la proposta di Jackson e scrivere a Marconi chiedendo la sua disponibilità a condurre delle prove di carattere particolare e il prezzo che avrebbe richiesto.54 Ma quelle prove non si tennero ed è possibile che sia stato lo stesso Marconi a lasciar cadere l’offerta.55 In ogni caso, dal momento che già un ente governativo, il GPO, 52. Lettera di Marconi a padre, 9 gennaio 1897, Lende Coll. Marconi aveva già incontrato Ferrero poco dopo il suo arrivo a Londra, ma in quella occasione l’ambasciatore lo aveva invitato ad assicurarsi il brevetto prima di comunicare il contenuto dell’invenzione al governo italiano, sul cui appoggio a suo parere non ci sarebbe stato comunque molto da sperare. Lettera di Marconi a padre, 4 febbraio 1896 (trascrizione dell’originale), Arc. Lincei, Carte Marconi, Scat. 37. 53. “Report of 16 September 1896 from Captain Jackson to the Commander in Chief, Devonport”, Admiralty Correspondence relating to Signor Marconi’s system of wireless telegraphy, HMSO, Londra, 1899, p. 2. 54. Lettera dell’Inspector General of Ordnance, War Office, a Marconi, 17 September 1896; Marc. Arc., His 77. 55. Questa è l’ipotesi, non improbabile, suggerita da Aitken. Le prove sarebbero state nell’invio di segnali tra una trasmittente costiera e due ricevitori indipendenti, entrambi chiusi in scatole di acciaio e posti su di una nave a un miglio di distanza. Ciò avrebbe richiesto una capacità selettiva che gli apparecchi utilizzati da Marconi in quel periodo non erano in grado di fornire. Aitken, Syntony and spark, cit., p. 216. 196 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA aveva in corso contatti con l’inventore italiano, a questo ente fu demandata la gestione di ulteriori prove e, se lo avesse ritenuto opportuno, anche la conduzione delle trattative per l’acquisto di apparecchi o l’uso del brevetto. Non si trattò di una soluzione gradita ai militari, che in più occasioni cercarono di far pressione sul GPO per arrivare ad un accordo che consentisse loro l’uso del metodo che Marconi stava sperimentando. Fu solo nell’estate del 1899 che la Royal Navy riuscì a negoziare con la Marconi Wireless Telegraph Company una serie di prove che risultarono poi nell’acquisto di apparecchi e nel pagamento di royalties per l’uso degli stessi.56 Nel frattempo, già nell’estate del 1897 prove su grande scala furono organizzate per invito del Ministero della marina italiana. Dopo aver tenuto delle dimostrazioni a Roma, presso la sede del ministero, in presenza del re e della regina oltre che di rappresentanze governative e scientifiche, Marconi fu invitato a condurre delle altre prove, più impegnative da un punto di vista tecnico, a La Spezia: prima a terra, dal 10 al 13 luglio, e nei giorni successivi, dal 14 al 18, con un ricevitore installato su un rimorchiatore e poi su una corazzata. Questa fu la prima opportunità offerta a Marconi di sperimentare il funzionamento del suo sistema di comunicazione su mare e con una delle stazioni in movimento, oltre che di verificare se le strutture metalliche delle navi ostacolassero le comunicazioni.57 Gli apparecchi utilizzati per le dimostrazioni vennero inviati dall’Inghilterra e vi ritornarono a conclusione delle prove; la Marina Italiana, per parte sua, oltre a mettere a disposizione le proprie strutture e l’assistenza del personale tecnico, pagò a Marconi un contributo, a titolo di rimborso spese, di 3.000 lire, equivalenti a circa 113 sterline.58 Tenendo conto delle informazioni che l’ente militare ottenne dalle dimostrazioni tenutesi a La Spezia e che in quell’occasione il governo italiano ottenne da Marconi l’uso senza pagamento del brevetto, lo si potrebbe definire un investimento altamente remunerativo. Per parte sua, Marconi ne ricavò l’opportunità di condurre importanti esperimenti che richiedevano l’uso di mezzi altri- 56. Sui rapporti tra la Royal Navy e Marconi si vedano Pocock, Garratt, The origins of maritime radio, cit. e Pocock, The early British radio industry, cit. 57. A. della Riccia, Gli apparecchi del Marconi e le esperienze alla Spezia, Tipografia E. Voghera, Roma, 1897 (estratto da Rivista d’Artiglieria e Genio, 8, 1897) 58. Nota manoscritta di Marconi, Spezia 17 luglio 1897, Marc. Arc., His 20. In una lettera inviata al padre da Roma, Marconi riferì dell’offerta da parte del governo italiano di pagare 60 lire italiane al giorno, più le spese di viaggio e di sussistenza. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 197 menti molto costosi da affittare e la pubblicità derivante dal realizzare tali esperimenti con il patrocinio di un ente governativo che fungeva da “garante”. Pubblicità Se importante fu il contributo dei tecnici del GPO, almeno altrettanto importante fu la credibilità e la visibilità che Marconi ricavò da quella collaborazione. La notizia che un nuovo metodo di comunicazione senza fili era in corso di sperimentazione sotto l’egida di un istituto importante quale il GPO (e poi della Marina Italiana) apparve come una convalida, per quanto indiretta, dell’efficacia del metodo e ciò attirò su Marconi l’attenzione della stampa, specializzata e non. Anche se difficile da quantificare, senza dubbio il beneficio che Marconi ne trasse in termini di promozione della propria invenzione fu grandissimo. Non è necessario sottolineare che la pubblicità fu un fattore fondamentale, non solo nella fase di decollo della nuova tecnologia, ma anche nelle fasi successive e che Marconi si dimostrò sempre estremamente abile nello sfruttare le opportunità offerte dall’interesse straordinario del pubblico per la sua invenzione.59 Mentre il primo annuncio ufficiale delle prove da parte di Preece, nel corso della riunione annuale della British Society for the Advancement of Science (tenutosi a Liverpool nel settembre del 1896) suscitò interesse soprattutto tra gli esperti,60 ben diverso fu l’impatto della conferenza che lo stesso Preece tenne in dicembre a Londra a Toynbee Hall e durante la quale Marconi fece la sua prima apparizione pubblica.61 Fu quella l’occasione in cui l’ingegnere capo del GPO annunciò il supporto di quell’ente alla sperimentazione del nuovo metodo di telegrafia senza fili. Come nel caso recente della telefonia, anche in quello della telegrafia senza fili l’attenzione fu catalizzata dal carattere “magico” dell’invenzione. L’enfasi sull’eccentricità dell’autore, alimentata da in59. Quell’interesse fu tanto più vitale alla sopravvivenza della società in quanto i bilanci della Wireless Telegraph and Signal Co. rimasero negativi per i primi tre anni e si fu in grado di pagare i primi dividendi agli azionisti solo nel 1911. La società superò quel periodo critico tramite successive ricapitalizzazioni basate sul successo degli esperimenti via via realizzati (esperimenti a cui la stampa fece da efficacissima cassa di risonanza) e sulle aspettative che essi generarono. 60. La comunicazione fu riportata in The Times (22 settembre 1896, p. 8) e in The Electrical Engineer (25 settembre 1896, p. 337). 61. “Wireless telegraphy”, in The Electrical Engineer, 18 dicembre 1896, p. 681. 198 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA terviste e articoli su quotidiani e riviste destinate al grande pubblico che lo descrivevano come un giovane outsider straniero, contribuì ad accrescerla.62 Ma l’interesse per Marconi e per il nuovo metodo di comunicazione si accese anche in altri settori di pubblico. Il 4 giugno 1897 la conferenza di Preece al Royal Institution dal titolo Signalling through space without wires, anche in questo caso con la partecipazione di Marconi, fu salutata da un applauso “un po’ più caloroso di quello solito ben educato offerto dalla platea della Royal Institution”, tra cui si trovavano Lord e Lady Kelvin, Lord Rosse, William Ramsay, William Grylls Adams, John A. Fleming e Silvanus P. Thompson.63 In quella occasione, come osservò l’editorialista di The Electrician, “la sala delle conferenze […] era piena fino al limite del disagio, se non del pericolo”.64 La conferenza venne ripetuta pochi giorni più tardi, con successo altrettanto straordinario, sia in un ambito più popolare, a Myddelton Hall, Islington,65 sia in quello altamente prestigioso della Royal Society.66 I commenti di alcuni settori della stampa specializzata non furono unanimemente favorevoli al sistema e in alcuni casi furono decisamente critici, specialmente da parte dell’autorevole rivista The Electrician. Tuttavia anche la pubblicità negativa è pur sempre pubblicità e il fatto che il metodo di telegrafia senza fili di Marconi stesse diventando un argomento di controversia tra i più qualificati esponenti del mondo dell’ingegneria elettrotecnica inglese contribuì a rendere più vivo l’interesse del pubblico. Quello che contò maggiormente fu l’attenzione di settori particolari di pubblico, come ad esempio le comunità e le associazioni che da anni sollecitavano il governo a migliorare il sistema di comunicazione e di sicurezza lungo le coste inglesi: autorità locali, camere di commercio delle città costiere, compagnie di navigazione. Le notizie relative alle dimostrazioni del nuovo metodo di comunicazione senza fili vennero infatti utilizzate come strumenti di pressione per indurre il governo ad agire. In un paese in cui le notizie di incidenti navali, con perdite di vite e di beni commerciali, apparivano quasi quotidianemente nelle cronache nazionali e locali, questa pressione ebbe un peso notevole. Ai promotori di quella campagna non interessava quale me62. Si veda ad esempio H. J. W. Dam, “The new telegraphy. Interview with Signor Marconi”, in Strand Magazine, 8, 1897, pp. 273- 280. 63. The Electrical Engineer, 11 giugno 1897, p. 739 e The Electrician, 39, 1897, pp. 216-218. 64. “Notes”, in The Electrician, 39, 1897, p. 207. 65. The Times, 11 giugno 1897, p. 6. 66. “Notes”, in The Electrician, 39, 1897, p. 239. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 199 todo venisse adottato, ma fin tanto che non vi fossero stati altri metodi ugualmente promettenti il beneficiario di questa pressione indiretta rimase Marconi. Costi legali Brevetti e dimostrazioni non esauriscono il capitolo spese del periodo 1896-7: i costi legali costituirono un’altra delle voci importanti nell’economia della fase pre-societaria. Nei primi mesi del 1897 le intenzioni di Marconi non erano mutate: ottenere il brevetto e venderlo. A incoraggiarlo in questa direzione erano soprattutto i rapporti stabiliti col Post Office e le istituzioni militari; tuttavia tale interesse non si era ancora materializzato in un’offerta. Per contro, due offerte di acquisto del brevetto vennero dal settore privato. La prima domanda risaliva al marzo del 1896, quando Marconi aveva appena presentato la prima domanda di brevetto, poi abbandonata. Frank Wynne e David Urqhuart, due ingegneri elettrici soci della ditta di consulenti Urquhart & Small (e conoscenti di altri parenti irlandesi di Annie Jameson, i Robertson) gli proposero di costituire una piccola società con un capitale di 2.400 sterline allo scopo di acquistare l’invenzione. I due ingegneri si sarebbero impegnati a reperire 500 sterline in contanti per avviare l’impresa, proseguire gli esperimenti e commercializzare il brevetto; in cambio della sua cessione l’inventore non avrebbe ricevuto un pagamento in contanti, ma gli sarebbero state assegnate 1.400 azioni, di cui 400 avrebbero dovuto essere trasferite a Wynne e Urqhuart.67 Questa prima proposta non fu accolta: Davis fece presente al cugino che se avesse accettato l’offerta non avrebbe avuto il controllo né della società né dell’invenzione; di conseguenza avrebbe dovuto adeguarsi alle decisioni della maggioranza degli azionisti oppure acquistare almeno altre 300 azioni di tasca propria.68 Preece, a cui Marconi si era rivolto per un parere, aveva inoltre osservato che il capitale proposto per avviare l’impresa non sarebbe stato sufficiente a realizzare i miglio67. Dattiloscritto non datato su carta intestata della ditta Urquhart & Small, Consulting Engineers indirizzato a Marconi, Marc. Arc., His 44. I termini della proposta furono riassunti da Marconi in due lettere inviate al padre in data 11 marzo e 21 marzo 1896, Lende Coll. 68. Le trattative sono descritte da Marconi nelle lettere inviate al padre in data 11 marzo, 21 marzo e 1 aprile 1896, Lende Coll. 200 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA ramenti necessari a rendere il metodo commercialmente valido. Oltre al parere dei parenti e di Preece, Marconi chiese anche quello di altri esperti e la corrispondenza col padre indica che non furono certo persone di secondo piano quelle a cui si rivolse: l’avvocato interpellato a proposito della proposta di Wynne e Urqhart fu Sir Frederick Bramwell. Fellow della Royal Society e membro sia dell’Institution of Civil Engineers sia dell’Institution of Electrical Engineers, Bramwell era uno dei maggiori consulenti nel settore dell’industria elettrica del tempo. L’identificazione non è del tutto chiara dato che il giovane inventore italiano, poco informato sul gotha di quel settore, nella corrispondenza con il padre si riferì a Lord Bramble.69 Frederick Bramwell, il cui umorismo era proverbiale, avrebbe sicuramente apprezzato l’involontaria ironia dell’errore che lo trasformava in un cespuglio di rovi. Dopo tutto fu lui, quando venne nominato Fellow della Royal Society, a commentare che la sigla FRS poteva essere interpretata come “Fees Rised Since”. Non è dato sapere se Marconi ottenne effettivamente questa consulenza, ma se la ottenne ebbe certo un prezzo rilevante – da FRS, appunto. La seconda proposta venne avanzata nel gennaio del 1897 da non meglio identificati “Messrs. Sheridan” per conto di una società a nome British Syndicate Ltd.70 Questa volta però le trattative non vennero condotte direttamente da Marconi e da Davis, ma dallo studio legale a cui si è già fatto riferimento in precedenza, Morten Cutler & Co., incaricato a questo scopo dallo stesso Marconi. Tuttavia anche quella proposta fu presto abbandonata, questa volta da parte degli offerenti. Marconi in quel periodo era impegnato nella preparazione degli esperimenti di Salisbury e continuava ad avere grande fiducia nella possibilità che il GPO potesse acquistare la sua invenzione. Di tutt’altro parere era però Davis, che già aveva cominciato a esplorare la possibilità di farsi lui stesso promotore di una società per lo sviluppo e la commercializzazione dell’invenzione del cugino. Non appena Sheridan ritirò l’offerta, Davis lanciò la propria proposta di creazione di una società. Morten, Cutler & Co passarono quindi direttamente ad occuparsi delle nuove trattative che vedevano Davis nella veste di capofila di un gruppo di 69. Lettera di Marconi al padre, 8 aprile 1896, Lende Coll. 70. Morten, Cutler & Co., “Sale of Patent”, cit., p. 1, 27 febbraio 1897. Non è chiaro se Messrs Sheridan siano gli stessi “due signori Americani”a cui Marconi fa riferimento in una lettera al padre del 9 gennaio 1897 (Lende Coll.) e che avrebbero dichiarato di voler acquistare il brevetto per gli Stati Uniti, offrendo 10.000 sterline (4.000 sterline subito e il resto quando il brevetto fosse stato accettato dal Patent Office americano). DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 201 potenziali azionisti e che si conclusero in luglio con la costituzione della Wireless Telegraph and Signal Co. Ma anche il ricorso a questo studio legale non fu considerato sufficiente. Marconi aveva già avviato in gennaio contatti con un altro avvocato, R. Owen, dello studio londinese Faithful & Owen, specializzato nella legislazione relativa a brevetti e proprietà intellettuale.71 Non ritenendo sufficiente o del tutto imparziale il parere di Morten, Cutler & Co., a cui si era rivolto probabilmente su consiglio di Davis, Marconi continuò a valersi della consulenza di Owen anche durante le trattative che si conclusero con la creazione della Wireless Telegraph & Signal Co.72 Lo studio legale Morten Cutler & Co. mantenne un accuratissimo resoconto degli incontri e delle trattative per tutto il periodo fino alla costituzione della società e quando si chiuse la partita, il 24 luglio del 1897, il conto ammontava a 95 sterline e 17 scellini.73 Per quanto riguarda Owen, che venne pagato direttamente da Marconi, non ci sono documenti che attestino l’importo del suo compenso. Chi fu l’imprenditore? Nel calcolare i costi del passaggio dall’invenzione all’impresa una voce fondamentale è costituita dal tempo che a questo processo può dedicare l’autore. Nel caso di Marconi, sia prima del trasferimento a Londra sia nei mesi successivi, l’inventore vi lavorò a tempo pieno. É vero che le aspettative del padre, da cui dipendeva economicamente, esercitavano su di lui una forte pressione morale e che le richieste di denaro dovevano essere ogni volta attentamente giustificate e negoziate, ma il sostegno paterno garantì la copertura delle spese di alloggio e sussistenza – non solo di Marconi, ma anche della madre Annie che con lui si era trasferita a Londra per aiutarlo ed assisterlo.74 La nota spese compilata da Giuseppe Marconi fornisce un quadro dettagliato del denaro dato al giovane inventore al momento della sua partenza e di quello inviato successivamente: 71. Copia della lettera di Agnes Jameson a Owen, 26 gennaio 1897, Marc.Arc., His 31. 72. Morten Cutler & Co., “Sale of Patent”, cit., pp. 21-25. Lettere di Marconi al padre, 9 e 19 aprile 1897, Lende Coll. 73. Morten Cutler & Co., “Sale of Patent”, cit., p. 26. 74. Tra i compiti di Annie Jameson Marconi vi era anche quello di correggere la corrispondenza in inglese del figlio, il cui inglese scritto, soprattutto quello formale, era piuttosto vacillante. 202 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA Denaro ricevuto dal padre, 1896-1897: 1896: Sterline: 619,72 Lire italiane 16.812,35 1897: » 268,17 » » 6.287,50 Totale: » 887,89 » » 23.099,85 Fonte: “Note spese di Giuseppe Marconi”, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, Carte Marconi, Scatola 39 Gruppo A, Fasc. 5. Il totale indicato da Giuseppe Marconi in questo documento ammonta a 26.564,15 lire italiane (e cioè 1.077 sterline), in quanto include anche il denaro inviato per le spese di mantenimento della moglie Annie. A termine di paragone, in Inghilterra in quel periodo lo stipendio di un funzionario amministrativo comunale di livello medio-alto e quello di un preside di scuola tecnica ammontava a circa 500 sterline annue; quello di un professore universitario era di 1.000-1.200 sterline annue. Attorno a 1.500 sterline, sempre su base annua, era lo stipendio di Preece e Kempe, che vantava circa 25 anni di anzianità, riceveva circa 500 sterline;75 150 sterline (spese escluse) fu la paga annuale di George Kemp, il tecnico quarantenne del GPO che venne assunto come assistente da Marconi nel 1897. Occorre tener presente che la quota del 1896, e cioè 619 sterline e 72 scellini comprendeva anche i tre bonifici di 100 sterline ciascuno effettuati nei giorni 9 maggio, 11 agosto e 2 settembre. Si trattava del denaro che Marconi aveva ottenuto dal padre per poter procedere con esperimenti e brevetti. Come si è già osservato in precedenza, era una somma inferiore a quella che il giovane inventore aveva indicato inizialmente come necessaria a coprire tutte le spese previste, dato che i brevetti da soli avrebbero richiesto almeno 190 sterline (secondo la stima più bassa, che comprendeva un numero limitato di paesi). Più volte è stato osservato che il sostegno famigliare costituì una risorsa essenziale per il successo dell’impresa avviata da Marconi; lo hanno sottolineato pressochè tutti gli studiosi che ne hanno analizzato la storia e lo ha più volte ripetuto lo stesso Marconi. Che tale sostegno sia stato fondamentale è innegabile; eppure, per quanto significative, le somme inviate da Bologna non poterono coprire che le spese vive e più immediate. L’autofinanziamento su base familiare avrebbero potuto bastare se Marconi si fosse attenuto strettamente al progetto iniziale, quello cioè di ottenere un brevetto in Inghilterra e di venderlo il più presto possibile. Ma quella fonte non era certo sufficiente a coprire i costi di un progetto che 75. Gli stipendi di funzionari pubblici sono pubblicati nei volumi annuali di Whitakers’s Almanack. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 203 stava crescendo in dimensioni e prospettive; non sarebbe bastata nè a sostenere le spese di sperimentazione e dimostrazione, nè quelle occorrenti per ottenere brevetti in altri paesi. La necessità di cercare altre fonti di finanziamento è un argomento ricorrente nella corrispondenza di Marconi con il padre. Già nel corso delle trattative con Wynne e Urqhuart Marconi, su suggerimento di Davis, aveva manifestato il proprio interesse a mantenere il controllo del brevetto fino alla realizzazione di quei miglioramenti che riteneva necessari per riuscire a vendere il nuovo metodo di comunicazione nelle condizioni a lui più favorevoli, cioè quando fosse stato in grado di dimostrare che si trattatava di un metodo affidabile e in grado di trasmettere a distanze utili. Ovviamente restava aperta la questione di quale fosse l’obiettivo che intendeva raggiungere per quanto riguarda i miglioramenti tecnici e come pagare i costi della sperimentazione. In ogni caso, la corrispondenza con i famigliari indica chiaramente che in questo periodo il proposito di Marconi rimaneva saldamente quello di cedere il brevetto non appena il sistema avesse raggiunto un grado di efficacia tale da renderlo utilizzabile praticamente. La soluzione che il giovane inventore considerava come ideale era di vendere il brevetto ricavandone un pagamento in contanti e una cointeressenza sulla cessione delle licenze d’uso (o sulla eventuale rivendita del brevetto ad altre società), garantita o da un contratto, nel caso si fosse trattato di un ente pubblico, oppure, nel caso si fosse trattato di una società privata, dalla proprietà di un pacchetto azionario adeguato.76 Nelle lettere ai famigliari non vi sono accenni alla possibilità di mantenere un legame stabile con tale ente, pubblico o privato che fosse. Il suo interesse, in altri termini, era volto a massimizzare i benefici ricavabili dalla vendita, al più controllando nella fase iniziale le decisioni prese dall’acquirente riguardo all’esecuzione del programma di miglioramenti a breve termine che riteneva necessario, alla assegnazione di licenze per l’uso del brevetto o alla eventuale successiva vendita del brevetto ad altre società. Ma non era intenzione di Marconi farsi imprenditore e di sicuro non fu lui a concepire l’idea di creare una società per la commercializzazione della propria invenzione. L’idea fu di Davis. Quando il cugino irlandese avesse cominciato a considerare quella possibilità non è chiaro, ma di sicuro la rese esplicita all’inizio del 1897. 76. Si veda in particolare la lettera inviata al padre il 21 marzo 1896, Lende Coll. 204 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA Mentre ancora erano in corso le trattative con Sheridan aveva già avviato contatti con conoscenti, soprattutto ma non esclusivamente irlandesi, nell’ambito dei commercianti di grano della City per ottenere la loro adesione alla proposta di costituzione di una società. Quando infatti Sheridan lasciò il campo, Davis presentò immediatamente a Marconi la propria proposta: la somma offerta per il trasferimento del brevetto alla società era 15.000 sterline, più una larga quota di azioni della stessa. Davis non solo affermò di aver già reperito tale somma, ma che avrebbe garantito personalmente il capitale di garanzia. La reazione di Marconi fu tutt’altro che entusiasta; al contrario, dichiarò immediatamente che era sua intenzione attendere la decisione che il GPO avrebbe potuto prendere (così almeno pensava) a seguito delle dimostrazioni in preparazione presso Bristol. Dello stesso parere erano Giuseppe e Annie Marconi, entrambi favorevoli all’idea originale di vendere il brevetto e scettici, se non apertamente ostili, nei confronti di Davis e del suo progetto. La corrispondenza tra Davis, Marconi e Morten e il diario delle trattative tenuto da quest’ultimo indicano chiaramente che nel periodo tra aprile e maggio i rapporti tra i due cugini si fecero decisamente tesi.77 Da un lato, Davis continuò a fare pressione perché il cugino accettasse la propria proposta di costituzione di una società, accusandolo non solo di non avere spirito imprenditoriale, ma di non essere neppure in grado di fare i propri interessi.78 Dall’altro lato Marconi, impegnato nelle prove sul canale di Bristol e poi nei preparativi delle prove per la Marina italiana, si mantenne fermo nella richiesta di attendere un’offerta da parte degli enti governativi inglesi, o quanto meno di mantenere con essi un rapporto privilegiato anche nell’eventualità che si fosse costituita una società. In realtà, Marconi cercò anche di provocare una risposta da parte di Preece, informandolo, sia direttamente sia tramite Graham (sempre nella sua funzione di consulente) delle offerte che gli erano state fatte e anche della loro entità.79 Probabilmente Preece non ritenne quella possibilità verosimile, convinto com’era che Marconi non fosse in grado di realizzare il suo sistema senza il sostegno tecnico del GPO. Questa era infatti la tesi sostenuta dal direttore tecnico di quell’ente 77. Si veda la corrispondenza in Marc. Arc., His 43 e Morten Cutler & Co., “Sale of Patent”, cit. 78. Copia della lettera inviata da Davis a Morten Cutler & Co., 14 aprile 1897, Marc. Arc., His 43. 79. Lettera di Graham a Preece, 9 aprile 1897, IEE Arc., Papers of W. H. Preece, MSS 022/II/ 75. Lettera di Marconi a Preece, 10 aprile 1897, IEE Arc., Papers of W. H. Preece, MSS 022/II/ 76. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 205 anche nel documento in cui consigliava ai suoi superiori di formulare una proposta di acquisto del brevetto. Marconi, per parte sua, non poteva sapere di quella proposta, che per altro non venne accolta tempestivamente dalla dirigenza del GPO; e se anche ne fosse stato informato, non avrebbe potuto fare altro che constatare che la somma suggerita da Preece, 10.000 sterline, era inferiore a quella offertagli da Davis. Durante queste trattative Marconi non solo si valse della consulenza legale di Owen, come si è accennato sopra, ma richiese ripetutamente la consulenza di Graham, sia per quanto riguardava i rapporti con il GPO che con Davis. A riprova del fatto che non rientrava nei piani del giovane inventore vincolarsi alla società nel lungo periodo, Marconi sollevò obiezioni alla richiesta da parte di Davis di impegnarsi a rimanere in Inghilterra per tre anni come dipendente della società, con la qualifica di direttore tecnico, e chiese a Morten di trovare un modo per evitare quella clausola.80 Davis tuttavia non cedette né alle obiezioni del cugino italiano né ai suoi ripetuti tentativi di posporre la decisione; d’altra parte, come Graham fece notare al proprio cliente, quella era l’unica offerta disponibile e non era un’offerta di poco conto. Fu dunque su suggerimento di Graham, e dopo che Davis dimostrò di avere a disposizione il capitale necessario per il pagamento del brevetto e per avviare la società, che Marconi, all’inizio di maggio, accettò di considerare la proposta del cugino. A quel punto Morten venne autorizzato a stilare la proposta di creazione della società, ma ancora non si trattava della decisione definitiva: la discussione sui termini del contratto e la stesura dello stesso si prolungarono per due mesi, coinvolgendo gli avvocati di Davis, Morten come intermediario e Owen a cui Marconi aveva affidato la tutela dei propri interessi. Durante quel periodo Marconi continuò a mantenere un atteggiamento tale da far temere al cugino un cambiamento di parere. Alla fine, il 20 luglio, mentre Marconi si trovava in Italia per le prove a La Spezia, Owen con delega da parte di quest’ultimo sottoscrisse l’atto di vendita del brevetto e di creazione della società. Nella creazione della Wireless Telegraph & Signal Co. fu dunque Davis a svolgere la funzione dell’imprenditore, in un ruolo simile a quello che Mathew Boulton giocò nei confronti di James Watt. Si trattò di una scommessa altamente rischiosa, non solo per Davis, ma anche per quanti accettarono di sottoscriverla: mentre comunque Marconi avrebbe por80. Morten Cutler & Co., “Sale of Patent”, cit., p. 18. 206 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA tato a casa 15.000 sterline, la società acquistava un brevetto che avrebbe ancora potuto rivelarsi debole o addirittura nullo, nonostante le risorse e le competenze che erano state profuse nella sua preparazione. La creazione della società Il fatto che l’attività di Davis fosse legata al commercio di grano fu ovviamente contingente e, almeno all’apparenza, non si sarebbe detto un settore in cui potesse essere facile reclutare sostenitori per un nuovo metodo di telegrafia senza fili. Tuttavia proprio le comunicazioni erano una tecnologia di importanza vitale per questo settore – come del resto per altri settori commerciali che operavano sulle grandi distanze. L’Inghilterra era uno dei mercati più importanti a livello internazionale per il commercio di grano e di cereali in generale. Le trattative per la vendita del carico di navi provenienti da tutti i maggiori paesi produttori avvenivano mentre queste erano ancora in viaggio. Non appena le navi si avvicinavano alle coste inglesi e la qualità del prodotto che trasportavano poteva essere valutata, se ne stabiliva il prezzo. A quel punto il carico veniva venduto presso i mercati di Londra, il Baltic e il Corn Exchange, o di altre città, soprattutto Liverpool, e le navi venivano dirette verso i porti di destinazione, in Inghilterra o in altri porti europei. Un sistema di comunicazione rapido ed efficiente era quindi uno strumento essenziale; per questo motivo i commercianti di cereali non solo avevano fatto ricorso alla telegrafia fin dai suoi esordi, ma avevano già adottato anche la telefonia. Nel 1888 il London Corn Trade Association e il Baltic Exchange avevano accettato un’offerta della United Telephone Co. per un collegamento diretto tra i rispettivi uffici londinesi al prezzo di 13 sterline e 17 scellini per anno, più il costo delle telefonate. Alla fine del 1896, proprio nel periodo in cui il sistema di Marconi stava imponendosi all’attenzione del pubblico inglese, si stava discutendo la possibilità di stabilire una nuova linea privata tra i due centri londinesi e gli uffici del Corn Trade Association di Liverpool.81 L’elenco delle persone che sottoscrissero la proposta di costituzione della società indica chiaramente dove Davis cercò il sostegno necessario a lanciare l’impresa. 81. H. Barty-King, Food for man and beast, Hutchinson Benham Ltd, Londra, 1978, pp. 17 e 31-7. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 207 Nomi, indirizzi e attività professionali indicate dai sottoscrittori originari (19 luglio 1897): James Fitzgerald Bannatyne Henry Jameson Davis Thomas Wiles Summerville, Limerick (Irlanda) 82 Mark Lane, Londra 2 Catherine Court, Londra Henry Obré 6 Crosby Square, Londra Manliffe T. Goodbody 6 Crosby Square, Londra Cyril Frederick Bennett 6 Crosby Square, Londra Samuel William Ellerby South Sea House, Londra Robert Alexander Patterson South Sea House, Londra Frank Wilson South Sea House, Londra gentiluomo ingegnere commerciante di grano commerciante di grano commerciante di grano commerciante di grano commerciante di grano commerciante di grano commerciante di grano Fonte: Marconi Archive, His 44. James Fitzgerald Bannatyne era un ricco mercante originario della contea di Limerick, in Irlanda, che aveva abbandonato l’attività commerciale e si era stabilito presso Exeter, dove aveva acquistato una grande ed elegante residenza. Thomas Wiles, socio della ditta di commercianti di grano Joseph Wiles & Son, Ltd (di cui poi divenne direttore e presidente), era un membro del Baltic Exchange e del London Corn Exchange.82 Henry Obré, originario della contea di Cork, era socio della ditta Harris Brothers & Co., una delle maggiori operanti nel settore del commercio del grano e fu anche direttore del Baltic Exchange.83 Membri del Baltic Exchange (South Sea House) e commercianti di grano erano anche Cyril F. Bennett, Samuel W. Ellerby, Frank Wilson e Robert A. Patterson (della ditta Patterson Brothers & Co., di Liverpool). Manliffe F. Goodbody era membro di una famiglia di commercianti e agenti di cambio di Dublino con interessi in vari settori tra cui i cereali e il tabacco.84 82. H. Bassett (ed.), Business men at home and abroad. A biographical directory of partners, principals, directors and managers of important business firms and institutions at home and abroad. 1912-1913, 16 St. Paul’s Chambers, Ludgate Hill, Londra, 1913. 83. Ivi; Who was who, 1916-1928, p. 788. 84. In realtà la corrispondenza di Davis indica che vi fu un altro importante contributo da parte di J. P. Smith (1.500 sterline), che infatti divenne uno dei primi direttori della società e uno dei maggiori azionisti. Lettera di J. P. Smith a Davis; Marc. Arc., His 43. 208 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA Nel comunicare a Preece la vendita del brevetto e la creazione della società, Marconi indicò i motivi che lo avevano indotto ad accettare la proposta di Davis: Molti motivi mi hanno indotto a concludere. Il primo è che se pure gli esperimenti hanno avuto molto successo, tuttavia l’apparato deve venir costruito in una forma più pratica, e inoltre esperimenti più prolungati devono venir intrapresi. Ho anche avvertito che l’impresa è troppo grande per me solo dato che tutti i governi in Europa desiderano che vengano condotti esperimenti. Inoltre le spese per i brevetti sono troppo alte per me specialmente perché devo brevettare altri miglioramenti. Questi motivi, oltre alla grande incertezza dei brevetti e alla vigorosa opposizione che è stata mossa nei miei confronti da Lodge in Inghilterra, Tesla in America, e altri in Europa, mi hanno indotto a compiere questo passo.85 La società fu costituita il 20 luglio del 1897, con un capitale di 100.000 sterline in 100.000 azioni da 1 sterlina ciascuna. Non era una società delle più piccole nel suo settore: solo 20 delle 149 nuove imprese create nel 1897 e operanti nell’ambito dell’industria elettrica avevano un capitale iniziale di quell’ordine di grandezza e solo nove lo superavano.86 Marconi ricevette come pagamento parziale per la cessione del brevetto 60.000 azioni. Le rimanenti 40.000 azioni furono messe in vendita e dei proventi così ottenuti 15.000 sterline in contanti furono date a Marconi per completare il pagamento del brevetto;87 la quota residua, 25.000 sterline, costituì il capitale di lavoro della società.88 Marconi a sua volta si impegnò a trasmettere a Davis 10.000 delle proprie azioni: 5.000 per il ruolo che questi aveva svolto nella creazione della società e altre 5.000 a rimborso delle spese che aveva sostenuto nel corso di quel processo. Primi direttori della società furono i maggiori azionisti: Appleby, William Smith, Bannatyne, Davis e Marconi; quest’ultimo fu nominato anche direttore tecnico e nel prospetto non si fece cenno a limiti temporali circa la sua disponibilità ad occupare quella carica.89 85. Lettera Marconi a Preece, Bologna 27 luglio 1897; Marc. Arc., His 43. 86. “New public companies of 1897”, in The Electrician, 40, 1898, pp. 221-222. 87. Questa somma fu depositata presso la Westminster Bank di Londra. Lettera di Marconi al padre, 8 agosto 1897; Lende Coll. 88. Dattiloscritto “Factual Extracts”, p. 1, Marc. Arc., His 44. Dattiloscritto “Prospectus, The Wireless Telegraph and Signal Company Limited”, Marconi Archive, His 44. 89. La sede fu l’ufficio di Davis in Mark Lane e il primo dipendente fu uno dei segretari di Davis, Henry W. Allen che rimase il fedele e leale segretario della società per più di trent’anni. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 209 La composizione degli azionisti Nonostante i timori dei genitori, Marconi ottenne condizioni decisamente favorevoli: come risulta dal resoconto che, a norma del Companies Act del 1893, tutte le società dovevano consegnare al termine dell’anno finanziario, anche dopo la cessione di 10.000 azioni al cugino e la condivisione con quest’ultimo di altre 10.000 azioni il giovane inventore si assicurò il controllo della società con 40.000 azioni a proprio nome.90 Quanto a Davis, che oltre ad aver ricevuto 10.000 azioni da Marconi ne aveva sottoscritte 5.000 al momento della costituzione della società, risultò con 15.000 azioni il secondo maggior azionista dopo il cugino e mantenne quella posizione anche dopo che in novembre ne vendette 6.170. Di conseguenza i due cugini alla fine del 1897 controllavano insieme 58.830 delle 95.015 azioni allocate, cioè il 62% del totale. Il resoconto citato offre un quadro dettagliato del profilo degli azionisti nei primi mesi di vita della società. Delle 99 persone che vi sono elencate, metà indicò degli indirizzi irlandesi e il 35% dichiarò attività o interessi ricollegabili al commercio del grano. Nessuno dei nomi dei famigliari italiani di Marconi appare nell’elenco; neppure i parenti irlandesi più stretti, con l’eccezione di Davis, figurarono tra i sottoscrittori iniziali e neppure tra i maggiori azionisti nella fase di avvio della società. Stando a questi documenti, e a meno che Davis non si fosse valso indirettamente del loro appoggio finanziario (ma non vi sono prove documentarie a questo riguardo), il decollo della Wireless Telegraph & Signal Co., non fu sostenuto direttamente dal “whiskey money” dei Jameson e dei Davis, come è stato spesso suggerito dagli storici che si sono occupati delle origini di questa società.91 Il maggior supporto venne semmai dalla rete di conoscenze in cui questo gruppo familiare era inserito e che era costituito, come si è visto, principalmente da mercanti di grano, in gran parte irlandesi.92 90. Summary of Capital and Shares of the Wireless Telegraph & Signal Company Ltd. (2 dicembre 1897), Companies House, Londra. 91. Aitken, Syntony and spark, cit., pp. 224-225. 92. Summary of Capital and Shares, cit. 210 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA Occupazione e/o stato sociale dichiarati dagli azionisti alla fine del 1897: Mercanti di grano (e attività connesse) 31 Mercanti 23 Gentiluomini e possidenti 18 (tra cui Marconi) Altre professioni 13 (tra cui Davis, che si definì ingegnere) Donne vedove, nubili o sposate 11 (di cui 6 riconducibili a famiglie di mercanti di grano) Agenti di cambio 3 Fonte: Summary of Capital and Shares of the Wireless Telegraph and Signal Company Ltd., 2 December 1897 (Companies House). Lo stesso documento consente di individuare i maggiori azionisti oltre a Marconi e Davis. Azionisti maggiori (esclusi Marconi e Davis) e loro occupazione o stato civile dichiarato, dicembre 1897: James F. Bannatyne Thomas A. Ferguson John Peter Smith gentiluomo, Summerville, Limerick mercante, Limerick mercante di grano, Barrow in Furness (Lancashire) Richard Smith mercante di grano, Lancaster (Lancashire) William Smith mercante di grano, Broughton (Lancashire) John Mooney mercante, Dublino Edgar Appleby proprietario di mulini da grano, Blackburn George Ross mercante, Dublino Peirson Turner ingegnere, Ipswich Augusta Bassett maritata, Hatfield, Hertsfordshire David H. Chapman mercante, Cork William H. Odlum gentiluomo, Isleworth (?) William W. Goodbody agente di cambio, Dublino 3.300 3.000 2.000 2.000 2.000 1.460 1.250 1.000 1.000 1.000 1.000 750 600 Fonte: Summary of Capital and Shares of the Wireless Telegraph & Signal Company Ltd., 2 dicembre 1897 (Companies House). Anche in questo caso la presenza di persone con interessi nel settore del commercio del grano è prevalente: John Peter, Richard e William Smith erano soci della ditta Walmsley & Smith, mercanti di grano di Lancaster.93 John Mooney era partner della ditta Johnston, Mooney & O’Brien, Ltd., fornai e mugnai di Dublino94 e Augusta Bassett era la moglie di Theodore Bassett, socio della ditta Harris Brothers 93. Men of Note in Finance and Commerce, Effingham Wilson, Londra, 1900-1 e Bassett, Business men at home and abroad, cit. 94. Bassett, Business men at home and abroad, cit. DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA / 211 & Co., mercanti di grano (e quindi di Obré, uno dei sottoscrittori originari).95 Azioni controllate da gruppi familiari, dicembre 1897: J. P., R. e W. Smith (mercanti di grano, Lancashire) 6.000 Famiglia Goodbody (mercanti e proprietari di mulini, Dublino) 3.770 Famiglia Pike (Joseph e Ebenezer: direttori di società, settore trasporti, Cork) 1.200 Samuel M. e Edward M. Hutchinson (mercanti di grano, Liverpool) 1.000 Fonte: Summary of Capital and Shares of the Wireless Telegraph & Signal Company Ltd., 2 dicembre 1897; Companies House, Londra. Altri due aspetti particolarmente significativi emergono dal resoconto di fine 1897: se pure gli azionisti maggiori erano benestanti, nessuno di loro, ad eccezione di Bannatyne, era davvero facoltoso; inoltre nessuno di loro aveva collegamenti diretti col settore delle tecnologie elettriche. Quanto questa seconda caratteristica sia stata il risultato di una strategia perseguita intenzionalmente da Davis è una delle questioni che rimangono da chiarire. Conclusione Ad un primo livello di analisi, quanto emerge da questo studio non fa che confermare un tema noto, cioè il rapporto indissolubile tra gli aspetti tecnici e quelli economici nello sviluppo di una nuova tecnologia: già nella fase precedente alla creazione della società l’attività di sperimentazione fu essenzialmente legata alla capacità di reperire finanziamenti per sostenerla e al tentativo di identificare uno sbocco commerciale per il nuovo metodo di comunicazione senza fili. Non si trattò quindi di due processi paralleli, ma di due aspetti di uno stesso processo. Il tentativo di fornire una “mappa” dei costi dà rilievo a voci che nelle ricostruzioni storiche disponibili risultano meno evidenti, quali quelle legali, brevettuali e di supporto organizzativo e mette in evidenza il loro elevatissimo peso economico. 95. Ivi e Summary of Capital and Shares, cit. 212 / DALL’INVENZIONE ALL’IMPRESA Come si è accennato nell’introduzione, una stima accurata di quanto venne speso nel periodo dall’inizio del 1896 all’estate del 1897 non era tra gli obiettivi dell’indagine qui proposta. Tuttavia anche questa “mappa” essenzialmente qualitativa indica chiaramente che i costi della fase di avvio furono più alti di quelli che, allo stato attuale delle conoscenze, vennero sostenuti con finanziamenti provenienti dall’Italia. Il contributo dei parenti inglesi, e soprattutto di Davis, non si limitò quindi al sostegno finanziario e organizzativo di un piano d’azione ben definito, ma si caratterizzò piuttosto come un’intervento diretto nella delineazione di quel piano. Come ho già suggerito, la creazione della Wireless Telegraph & Signal Co. non fu la soluzione auspicata da Marconi, ma piuttosto un’alternativa accettata per mancanza di proposte più attraenti. Quanto a Marconi, la convizione che ai meriti tecnologici della propria invenzione dovesse corrispondere un valore commerciale fu un abito mentale acquisito in ambito famigliare e in cui si riflette chiaramente l’insegnamento e l’esperienza paterna. Questa convinzione, ben consolidata al momento della partenza da Bologna, costituì un tratto distintivo del piano messo in atto dal giovane inventore italiano al momento del suo arrivo nella capitale inglese e ne fu anche uno dei punti di forza. Tuttavia, gli elementi raccolti seguendo la traccia degli investimenti e delle trattative pre-societarie indicano che Marconi non ebbe, in quella prima fase, un atteggiamento o delle aspirazioni imprenditoriali: queste semmai maturarono successivamente e furono fortemente condizionate dagli sviluppi relativi alla struttura e alla organizzazione della società, oltre che dai suoi rapporti con gli enti pubblici e privati interessati all’uso della telegrafia senza fili. LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 213 LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA IN ITALIA TRA L’UNITÀ E LA PRIMA GUERRA MONDIALE Ariane Dröscher Introduzione Con l’unificazione, il Regno d’Italia aveva ereditato dai singoli stati italiani un grande numero di istituzioni per l’istruzione superiore. Il Regno delle Due Sicilie aveva contribuito con l’Università di Napoli e con le tre università siciliane di Messina, Palermo e Catania. Lo Stato Pontificio vantava le tre università marchigiane di Macerata, Urbino e Camerino, quella umbra di Perugia, le università emiliane di Bologna e di Ferrara e l’Università di Roma. Dal Granducato di Toscana il regno aveva ereditato le università di Siena e quella di Pisa, nonché l’Istituto di Studi superiori e di perfezionamento di Firenze. I Ducati di Modena e di Parma contribuirono con un’università ciascuno, la Lombardia con l’Università di Pavia, il Regno di Sardegna con le due grandi università di Torino e di Genova e con le due piccole università sarde di Cagliari e Sassari. Infine, nel 1866 si aggiunse l’Università di Padova. Il nuovo regno dispose dunque di numerose istituzioni superiori che, per di più, erano mal distribuite sul territorio nazionale. L’ateneo di gran lunga maggiore d’Italia, per esempio, si trovava a Napoli. Dopo Parigi, Berlino, Vienna e Londra, l’università partenopea, infatti, era la quinta più grande d’Europa e sopperiva alle esigenze di tutto il meridione d’Italia, fatta eccezione per le isole. Al contrario, le università di Bologna, di Ferrara e di Modena, così come quelle di Siena, Pisa e Firenze si trovavano nel raggio di meno di settanta chilometri. D’altro canto la Sardegna, una delle regioni più povere e meno densamente popolate d’Italia e, soprattutto, con un analfabetismo che all’indomani dell’unità colpiva circa il 90% della popolazione,1 si concedeva il lusso di ben due università. 1. T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza, Roma, 2001, p. 95 (1a ed. 1963). 214 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA La forte determinazione da parte del nuovo governo nazionale a imporre all’Italia un sistema d’istruzione centralizzato, richiedeva inoltre un adattamento delle università alle esigenze didattiche dei curricoli uniformati. Qualunque ateneo che aspirasse al privilegio di assegnare lauree e diplomi – un attributo indispensabile per attirare studenti – era ora obbligato a presentare tutti i corsi di base richiesti dal Ministero della pubblica istruzione. In particolare per le università minori, questa nuova esigenza comportò la fondazione di nuove cattedre con conseguenti problemi finanziari e carenza di personale. Nel complesso quadro generale un caso particolare, poi, era rappresentato dall’Università di Roma, che il governo nazionale voleva trasformare in pochi anni in un ateneo degno d’una capitale europea. Anche per la dotazione di attrezzature, gabinetti, laboratori e musei la situazione delle università italiane era molto eterogenea. Diverse università, per esempio, erano sedi di istituzioni scientifiche di tradizione secolare, tuttavia ridotte spesso a malinconiche testimonianze di un glorioso passato. Nella seconda metà dell’Ottocento quei luoghi non rispondevano più alle esigenze di centri di formazione e ricerca sperimentale come quelli ai quali l’Italia dichiarava di ispirarsi. Negli anni Settanta si assistette dunque a una notevole attività edilizia: istituzioni e cliniche furono rinnovate, molte altre furono create ex novo, mentre tutte vennero dotate di attrezzature scientifiche e didattiche, di tecnici capaci di utilizzarle e di coadiutori, assistenti, dissettori e preparatori laureati, pronti a istruire gli studenti del nuovo regno. La situazione finanziaria della giovane nazione si presentava tuttavia, com’è noto, particolarmente precaria, aggravata dal fatto che la classe dirigente stentava a riconoscere nei fatti, nonostante le molte dichiarazioni retoriche, l’importanza della ricerca per lo sviluppo economico del paese.2 In particolare, in considerazione del numero relativamente basso di studenti universitari, la chiusura di alcuni atenei sembrava la soluzione più ovvia e, in effetti, vari progetti di riforma andarono in questa direzione. Tra questi è noto quello del fisico e elettrofisiologo Carlo Matteucci, ministro della pubblica istruzione dal 1861 al 1862. Matteucci divise le università in due categorie. Nelle sue intenzioni si dovevano creare, da un lato, pochi grandi centri di ricerca ben dotati 2. R. Maiocchi, “Il ruolo delle scienze nello sviluppo industriale italiano”, in Storia d’Italia, Annali 3, Scienza e tecnica, Torino 1980, pp. 865-999 e I. Porciani (a cura di), Università e scienza nazionale, Jovene Editore, Napoli 2001. LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 215 e all’altezza delle grandi istituzioni europee, capaci di formare nel modo migliore le élite del paese; dall’altro lato si poteva lasciare che un certo numero di università minori rispondessero essenzialmente alle necessità locali. In quest’ottica, le università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino (più tardi anche quelle di Padova e Roma) furono classificate di prima classe, mentre le università di Cagliari, Catania, Genova, Macerata, Messina, Modena, Parma e Siena furono etichettate come di seconda classe, con un conseguente minor flusso di finanziamenti. Nel 1895, poi, la proposta di legge Martini prevedeva la chiusura degli atenei di Macerata, Messina, Modena, Parma, Sassari e Siena.3 Ma né questa proposta, né la speranza di Matteucci in una “lenta morte” delle università più piccole e meno produttive, risultò realizzabile di fronte alla ferma volontà delle autorità locali di mantenere in vita la “propria” istituzione di formazione superiore. Perfino Sassari, la più minacciata tra le università statali italiane, riuscì a resistere.4 Le università di Ferrara, Perugia, Camerino e Urbino furono trasformate in università “libere”, senza tuttavia per questo essere private o confessionali. I finanziamenti restavano a carico dell’erario nazionale ma, mentre le università statali nel senso stretto dipendevano direttamente dallo stato, che con il suo sistema centralizzato le controllava politicamente, amministrativamente e finanziariamente, quelle cosiddette libere erano finanziate a livello locale ed erano legate da un punto di vista amministrativo al comune o, nel caso dell’Università di Urbino, alla provincia. Il Ministero della pubblica istruzione si trovava così nel dilemma di dover spartire i modesti fondi destinati all’istruzione superiore tra 17 università statali, 4 università libere e un istituto superiore. Nel contesto europeo questa cifra è da considerarsi piuttosto alta, soprattutto se paragonata al numero modesto degli iscritti. Nell’anno accademico 189192, infatti, gli studenti italiani erano circa 17.000. Tra il 1860 e il 1900 il numero rappresentava soltanto lo 0,64‰-0,7‰ della popolazione, men- 3. M. Moretti, “La questione delle piccole università dai dibattiti di fine secolo al 1914”, in M. Da Pantano (a cura di), Le università minori in Italia nel XIX secolo, Sassari, 1993, pp. 19-44. 4. Sul tema si vedano I. Porciani, “La questione delle piccole università dall’unificazione agli anni Ottanta”, in Da Pantano (a cura di), Le università minori in Italia nel XIX secolo, cit., pp. 9-18 e G. P. Brizzi, J. Verger (a cura di), Le università minori in Europa (secoli XV-XIX), Rubettino, Catanzaro, 1998. 216 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA tre d’altro canto vi era un’università ogni 1.436.114 abitanti.5 Ben diversa la situazione a nord delle Alpi: la Germania possedeva una università ogni 2.470.000 abitanti, la Francia una ogni 2.556.000, l’Inghilterra soltanto una ogni 4.143.000.6 Anche se le spese per le università italiane erano ufficialmente a carico dell’erario nazionale, i comuni contribuirono in misura rilevante. L’entità dell’impegno finanziario da parte del ministero, il sostegno concesso dalle amministrazioni locali e le dotazioni dei consorzi costituiti sporadicamente in alcune città per sostenere il proprio ateneo, possono spiegare alcune differenze tra università dello stesso rango. La crescita delle cattedre e del numero dei docenti Nelle università italiane le facoltà erano originariamente cinque – Teologia, Giurisprudenza, Medicina e chirurgia, Scienze fisiche, matematiche e naturali, Lettere e filosofia –, divenute quattro con la soppressione nel 1873 delle facoltà di teologia (Tab. 1).7 Delle 22 istituzioni italiane di istruzione superiore, 21 possedevano una facoltà (o sezione) di giurisprudenza, 20 una facoltà (o sezione) di medicina e chirurgia, 16 una facoltà (o sezione) di scienze fisiche, matematiche e naturali e solo 11 una facoltà (o sezione) di lettere e filosofia. Queste cifre rispecchiavano, anche se non esattamente in termini proporzionali, il numero degli studenti iscritti. Nel quadriennio 1896-1900 la Facoltà di medicina e chirurgia aveva il maggior numero di studenti, con una media del 38,8% sul totale degli iscritti, seguita da Giurisprudenza, con il 37%, Scienze matematiche, fisiche e naturali, con il 14,9%, e Lettere e filosofia, con il 9,3% degli studenti.8 5. Statistiche quantitative sugli studenti universitari si trovano in E. Marcon, “Istruzione superiore”, in ISTAT: Le rivelazioni statistiche in Italia dal 1861 al 1956, Roma, 1957 e in Svimez, Cento anni di vita nazionale attraverso le statistiche delle regioni, Roma, 1961. 6. A. Colombo, “Per una storia dei modelli di università: dalla legge Casati all’autonomia degli atenei”, in G. P. Brizzi, A. Varni, (a cura di), L’università in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspetti e momenti, CLUEB, Bologna, 1991, p. 36. 7. I dati delle tabelle, dei grafici come pure i dati riportati nel testo si basano, se non annotato diversamente, sulle informazioni riportate per ciascun anno negli Annuari del Ministero dell’Istruzione Pubblica ossia dell’Appendice al Bollettino ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica. Per ulteriori dati si veda A. Dröscher, Le facoltà medico-chirurgiche italiane (1860-1915). Repertorio delle cattedre e degli stabilimenti annessi, dei docenti, dei liberi docenti e di tutto il personale scientifico, Studi del Centro interuniversitario per la storia delle università italiane, 4, CLUEB, Bologna, 2002. 8. C. F. Ferraris, “Statistiche delle Università e degli Istituti superiori”, in Annali di Statistica, 5, 1913, p. xxxv. LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 217 Giurisprudenza Medicina e Chirurgia Bologna Cagliari + + + + Scienze matematiche, fisiche e naturali + + Catania Genova + + + + + + Macerata + Messina Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia + + + + + + + facoltà fino al 1862 1862 – 1879: corsi 1879: chiusa + + + + + + + + 1862/63: unite 1862/63: unite + + 1862/63: unite + Pisa Roma Sassari Siena Torino Firenze + + + + + “Sezione” 1866: chiusa + + + + + “Sezione” Camerino Ferrara Perugia + + + + + + Urbino + università libere istit. sup. università statali Le singole facoltà medico-chirurgiche, d’altra parte, mostravano tra loro grandi differenze nel numero di cattedre, nella varietà degli insegnamenti, nella permanenza media di un professore su una stessa cattedra, nella quantità e nell’equipaggiamento di cliniche e stabilimenti scientifici annessi e nel numero di dipendenti che vi lavoravano. Si presenta così un panorama molto variegato dello stato e dello sviluppo di ciascun ateneo, di cui nella tabella 1 offro un sintetico quadro generale. 1862/63: unite + + “Sezione” fino al 1865: naturali 1866: fisiche e nat. 1863/64 unite facoltà fino al 1863 1863 – 1871: corsi 1871: soppressi Filosofia e Lettere Teologia + solo cattedre 1872: soppresse 1876: chiusa solo cattedre facoltà dal 1873 1862: chiusa 1873: chiusa 1873: chiusa + 1864: chiusa 1873: chiusa + + + solo cattedre facoltà dal 1873 + + 1861 – 1867 + “Sezione” 1873: chiusa 1873: chiusa 1873: chiusa 1873: chiusa 1873: chiusa 1873: chiusa 1873: chiusa 1873: chiusa 1873: chiusa Facoltà fino al 1862 1862-1874: corsi 1874: soppressi 1864 – 1869 Facoltà fino al 1862 1862 – 1893: corsi dal 1869: solo matematiche pure 1893: soppressi Tabella 1. Le università italiane e le loro facoltà (1861-1915). In questo saggio concentrerò l’attenzione sulle facoltà di medicina e chirurgia. Per un’analisi dello sviluppo quantitativo delle facoltà mediche italiane nel periodo 1860-1915 sono naturalmente da tenere presenti le storie di ogni singola università, da cui si possono ricavare alcune informazioni generali. 218 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA Le università di Padova e di Roma fecero parte del Regno d’Italia rispettivamente dal 1866 e dal 1870, mentre nel 1908 l’Università di Messina fu colpita dal noto terremoto, che causò la morte di 84.000 persone in città. Molti edifici universitari subirono dei severi danni e le facoltà e gli istituti di Messina cessarono praticamente di esistere, anche se gli Annuari del Ministero della Pubblica Istruzione continuarono a pubblicarne i dati. La Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Macerata fu sospesa nel 1862, nel 1868 cessarono i rimanenti corsi di Chirurgia minore e di Ostetricia e nel 1880, infine, furono sospesi anche gli insegnamenti dei primi anni del Corso di veterinaria e di quello speciale di farmacia. In sostanza, all’Università di Macerata rimaneva attiva soltanto la Facoltà di giurisprudenza. La città di Firenze non era sede di un’università, ma del Reale Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento. In seguito ad accordi stabiliti nel 1859 con le Università di Pisa e di Siena, la Sezione di medicina e chirurgia di Firenze forniva solo gli ultimi due anni del Corso medico-chirurgico e con questo tutti i corsi clinici. Verso la fine del periodo qui considerato, però, Firenze introdusse nel suo curricolo più corsi di discipline di base, come patologia generale e anatomia patologica, assumendo vieppiù le caratteristiche di un ateneo. Le università di Pisa e di Siena, dal canto loro, potevano conferire solo lauree di primo grado. In seguito agli accordi presi con il Reale Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, gli studenti di medicina e chirurgia furono obbligati a compiere nelle due università toscane solo i primi quattro anni del Corso medico e a rivolgersi per gli ultimi due anni alla Sezione di medicina e chirurgia di Firenze. A partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento, però, nonostante tali accordi, Pisa e Siena introdussero corsi clinici specialistici, riuscendo così ad avere un curricolo di studi completo. Ciò premesso, tra il 1862 e il 1910 il numero complessivo di cattedre mediche in Italia fu in continua crescita (Fig. 1): si passò da una media di 12,8 insegnamenti per università nel 1862, a una di 13,4 nel 1875 e 17,5 nel 1890, per raggiungere i 23,2 insegnamenti ufficiali nel 1910: in poco più di quarant’anni i docenti furono quasi raddoppiati. Nel quinquennio 1910-15 ci fu una flessione del numero delle cattedre causata da un generale calo degli insegnamenti ufficiali, in particolare nelle grandi università. Tra il 1910 e il 1911 la Facoltà medico-chirurgica romana, per esempio, perse ben 7 cattedre e quella napoletana addirittura 10. In effetti, dietro l’andamento generale si nascondono grandi differenze locali. L’aspetto più evidente è il crescente divario tra le universi- 1. Lo sviluppo degli insegnamenti ufficiali nelle facoltà mediche delle università statali e dell’Istituto superiore di Firenze (1870-1915). LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 219 220 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA tà grandi e quelle piccole (Fig. 2). Prendendo in esame lo sviluppo della facoltà medica più grande in Italia, quella dell’Università di Napoli, e comparandola con la più piccola, quella dell’Università di Sassari, si osserva che nel 1862 la facoltà napoletana disponeva di 17 cattedre contro le 11 di Sassari, cioè appena un terzo in più. Nel 1875 Napoli ne possedeva più del doppio (21 a Napoli, 10 a Sassari), nel 1890 circa il 150% in più (32 a Napoli, 13 a Sassari) e, infine, nel 1910 il 240% in più (51 a Napoli, 15 a Sassari). Negli anni seguenti Napoli conobbe una fase decrescente scendendo a 32 cattedre nel 1914, per aumentare nuovamente a 42 nel 1915, mentre il numero delle cattedre mediche di Sassari – 15 – si stabilizzò. Nel corso dei cinquantacinque anni tra l’unità e la Prima guerra mondiale, dunque, la Facoltà di medicina sassarese crebbe del 36,4%, aumentando di 4 cattedre, mentre quella dell’Università di Napoli crebbe del 147,1%, con un incremento di 25 cattedre. Lo sviluppo straordinario dell’ateneo partenopeo è ancora più evidente se confrontato con quanto andava accadendo nelle facoltà mediche di media grandezza, come quelle di Bologna, Genova, Padova e Pavia. Anche queste ultime furono decisamente distanziate da Napoli: nel 1875 ciascuna di queste poteva disporre di 13-16 cattedre, nel 1890 di 16-18 e nel 1910 di 21-24 cattedre: circa 8 cattedre più di Sassari, ma pur sempre 28 meno di Napoli. Considerando, d’altra parte, il numero 2. Crescita del numero di cattedre mediche nell’università italiana più piccola (Sassari), in un’università medio-grande (Bologna) e nell’università più grande (Napoli). LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 221 degli studenti iscritti – che nel 1861-62 a Napoli erano un terzo di tutti gli studenti universitari italiani – le aule e i laboratori della facoltà medica partenopea erano decisamente sovraffollati e meno adeguatamente attrezzati di quelli delle università minori. Dopo Napoli, la facoltà medica con il maggior numero di cattedre ufficiali fu inizialmente quella di Torino, che nel 1872 disponeva di 19 cattedre, divenute 29 nel 1915. Intorno al 1900, in ogni caso, l’università piemontese fu superata dall’ateneo romano, che nel 1910 aveva 35 cattedre mediche. Una menzione speciale merita la facoltà medico-chirurgica dell’Università di Catania. Inserita dal ministro Matteucci tra le università di seconda categoria, l’università siciliana dalla fine degli anni Settanta ebbe uno sviluppo notevole. Dal 1910 poteva offrire ai suoi studenti tra i 22 e i 24 corsi ufficiali – più corsi di quanti erano in grado di offrirne le facoltà mediche di Bologna, Padova o Pavia –, tra i quali vi erano corsi di otorinolaringoiatria, istologia patologica, batteriologia, parassitologia, embriologia e chimica fisiologica. Il Regolamento speciale delle università del nuovo regno, istituito nel 1876, prevedeva per la laurea in medicina e chirurgia sei anni di studi e il superamento degli esami di 17 corsi obbligatori: 4 di questi erano discipline scientifiche e 13 più strettamente mediche. Si trattava degli insegnamenti di: chimica, divisa in chimica generale, organica e inorganica; botanica; zoologia, anatomia e fisiologia comparata; fisica sperimentale; anatomia umana normale, comprendente l’istologia, l’anatomia descrittiva e topografica; fisiologia umana; patologia generale; anatomia patologica; materia medica e farmacologia sperimentale; patologia speciale chirurgica (dimostrativa); clinica medica; clinica chirurgica (e medicina operatoria); oftalmoiatria e/o clinica oculistica; dermosifilopatia e/o clinica dermosifilopatica; ostetricia e/o clinica ostetrica (e ginecologia); medicina legale e igiene; psichiatria e/o clinica psichiatrica (o clinica delle malattie mentali e nervose). Non tutte le università, tuttavia, erano in grado di offrire ai propri studenti tutti i corsi obbligatori elencati. Fino alla metà degli anni Settanta, nella maggior parte delle università minori, mancarono i corsi di clinica dermosifilopatica e clinica psichiatrica, mentre il corso di patologia speciale medica fu spesso unito a quello di clinica medica e la patologia speciale chirurgica a quello di clinica chirurgica. A fine secolo nelle università medio-grandi furono inoltre istituiti nuovi insegnamenti ufficiali come pediatria, embriologia, anatomia 222 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA microscopica o istologia (normale o patologica), odontoiatria e otorinolaringoiatria, corsi che, almeno nelle facoltà maggiori, erano spesso accompagnati da un vasto spettro di altri corsi complementari e specialistici, come batteriologia, ortopedia, neurologia e psicologia sperimentale.9 Tra gli insegnamenti specialistici facoltativi furono istituiti, tra gli altri, quelli di traumatologia (all’Università di Napoli, di Roma e, temporaneamente, a quella di Padova), elettroterapia (a Genova, Napoli, Roma, Firenze e, per un breve periodo, anche a Torino), neurologia o neuropatologia (a Roma, Pavia, Torino e, per qualche tempo, a Palermo), malattie esotiche (a Napoli e a Roma) e medicina del lavoro (solo a Napoli). Il primato per il numero di insegnamenti medici ufficiali era detenuto dalla facoltà medica di Napoli, dove furono tenuti molti corsi spesso inesistenti in altre università, non di rado coperti da un professore ordinario. Un altro aspetto degno di nota è la proporzione tra professori ordinari, straordinari e incaricati presso le facoltà mediche italiane: un dato, anche questo, che varia molto da un’università all’altra. A Napoli, per esempio, gli insegnamenti basilari furono coperti nel 94,8% dei casi da professori ordinari. Nelle altre università grandi o in quelle medio-grandi, invece, i professori ordinari impegnati in corsi basilari erano il 7279%, mentre in quelle più piccole il 46-56%. Il numero complessivo di ordinari nelle facoltà mediche italiane fu sempre alto rispetto a quello degli altri ruoli (Fig. 1) e, dopo un periodo di relativa stabilità o perfino leggero regresso, durato circa fino al 1890, il loro numero crebbe continuamente, per ritornare pressoché costante dopo l’impennata degli anni 1910-11. Il numero dei professori straordinari, al contrario, registrò una buona crescita fino alla metà degli anni Ottanta, seguita da una relativa stabilità fino al 1896. Dopo il 1900 gli straordinari calarono progressivamente, tanto da far pensare che, alla fine, questo tipo di professorato fosse diventato realmente la figura straordinaria e provvisoria prevista dal Regolamento universitario del 1876.10 9. Va tenuto presente, d’altra parte, che corsi come batteriologia, antropologia o parassitologia potevano mancare nella facoltà medica, ma far parte dell’insegnamento ufficiale della facoltà scientifica, oppure essere tenuti come corso libero da un libero docente. 10. Secondo il Regolamento il professore straordinario percepiva solo il 70% dello stipendio di un ordinario e doveva essere confermato di anno in anno finché non fosse diventato ordinario. LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 223 Nei primi anni del Novecento e per quanto concerne i professori incaricati si nota un forte incremento, spiegabile con l’introduzione di una grande varietà di corsi specialistici, ridimensionati tuttavia a partire dal 1910. Sul numero relativamente alto di cattedre vacanti, contrassegnate nelle pubblicazioni ufficiali con la sigla “N.N.”, che caratterizzò gli anni a cavallo del 1912, pesa fortemente la situazione dell’Università di Messina dove dopo il terremoto del 1908, come si è detto, la maggior parte delle cattedre esistettero solo sulla carta. Un quadro alquanto diverso emerge dai dati relativi alla crescita nel numero dei liberi docenti, chiamati anche insegnanti liberi o docenti privati. Si trattava di una figura ispirata a quella del Privatdozent tedesco, presente in alcune università italiane anche molto prima dell’unità. Secondo la legge Casati del 1859, chi era in possesso del titolo di libero docente e voleva tenere un corso agli studenti per l’anno successivo, era tenuto a presentare al rettore, secondo modalità prestabilite, il programma del corso, con i giorni e le ore previste, e a compilare un registro degli argomenti trattati durante il corso, esattamente come dovevano fare i docenti ufficiali. Tali corsi, che potevano essere svolti anche in sedi diverse da quelle universitarie, avevano il medesimo valore di quelli tenuti dai professori ufficiali e tutelavano allo stesso modo i diritti degli studenti, cosicché l’insegnamento libero acquistò nel corso del tempo un carattere sia complementare, sia concorrenziale rispetto all’insegnamento ufficiale. Inoltre, in particolare prima del 1900, poiché anche gli insegnanti ufficiali avevano il diritto di proporsi come liberi docenti, sia contemporaneamente, sia dopo la rinuncia al loro ruolo da titolari, molti approfittavano di questa opportunità per approfondire argomenti che ritenevano non fossero trattati in modo soddisfacente nel curricolo ufficiale. Così, ad esempio, negli anni Settanta l’embriologia fece il suo ingresso nelle facoltà italiane con corsi liberi tenuti quasi sempre da professori di anatomia umana. Guglielmo Romiti, in particolare, si ispirò alla tradizione tedesca scegliendo ogni anno un argomento speciale da approfondire.11 In alcune università anche l’anatomia microscopica e l’istologia si crearono in questo modo degli spazi nel curricolo universitario. Nonostante la figura del libero docente fosse già presente, i nomi e i titoli dei corsi degli insegnanti liberi, salvo poche eccezioni, si trovano 11. G. Romiti, La scienza e l’insegnamento. Prelezione al corso di anatomia umana, Firenze, 1878, p. 17. 224 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA pubblicati in modo sistematico e completo negli Annuari solo a partire dal 1885, per questo motivo l’analisi comparativa non è possibile prima di quella data. Una considerazione generale sullo sviluppo quantitativo della libera docenza evidenzia le proporzioni sempre maggiori che essa andò acquistando nel corso del tempo: nel 1885 nelle 16 facoltà mediche delle università statali e nella Sezione di medicina e chirurgia dell’Istituto superiore di Firenze erano ammessi 233 liberi docenti; trent’anni più tardi, nel 1915, il loro numero era cresciuto più di sei volte, arrivando a 1.477, quattro volte il numero degli insegnanti ufficiali (Fig. 3). 3. Numero dei liberi docenti attivi nelle facoltà medico-chirurgiche delle università statali e dell’Istituto superiore di Firenze (1885-1915). Per i liberi docenti si presentano dislivelli locali analoghi a quelli degli insegnanti ufficiali. Nelle università piccole essi rappresentarono inizialmente una figura minoritaria: nel 1900, per esempio, non se ne trova nemmeno uno nella facoltà medica di Cagliari, soltanto 3 in quella di Sassari, 9 a Modena, 11 a Messina, 14 a Catania e a Siena e 15 a Parma. Mentre i liberi docenti erano 24 a Padova, 27 a Bologna, 30 a Pavia, 32 a Palermo e 33 a Firenze. Nel 1915, invece, il loro numero era ovunque cresciuto: 16 liberi docenti di corsi medico-chirurgici sono registrati alle università di Cagliari e di Sassari, 45 in quella di Catania e di LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 225 Parma, 49 all’Università di Modena e 52 in quella di Siena. Nelle università medio-grandi il loro numero oscillava tra gli 84 di Firenze e i 106 di Pavia. Nelle tre università maggiori – Torino, Roma e Napoli – il numero dei liberi docenti assunse via via dimensioni enormi: nel 1900 insegnavano all’Università di Roma 59 liberi docenti, mentre all’Università di Torino erano 69. Nel 1915 erano 106 a Torino e 228 a Roma. Presso la facoltà medico-chirurgica partenopea già nel 1885 uno studente poteva scegliere tra 101 corsi liberi che diventarono 179 nel 1900 e salirono addirittura a 345 nel 1915. Le cliniche e gli stabilimenti scientifici annessi alle facoltà mediche È possibile tracciare un grafico dello sviluppo quantitativo nel tempo anche degli istituti, delle cliniche, dei musei, dei gabinetti, dei laboratori, delle attrezzature e delle biblioteche di area medica (Fig. 4). Per un’interpretazione corretta di questi dati, tuttavia, sono necessarie alcune precisazioni. Va ricordato, per esempio, che gli istituti medici erano riportati negli Annuari solo dall’anno della loro apertura, ossia da quando venivano effettivamente dotati di personale e resi operativi, non dalla data di approvazione del progetto e relativo stanziamento finanziario da parte del ministero e del Parlamento (data peraltro rintracciabile negli Atti Ufficiali). Non sempre, inoltre, la comparsa negli Annuari di una clinica o di uno stabilimento nuovi corrispondeva all’effettiva costruzione o acquisizione di nuovi spazi. Spesso queste nuove istituzioni nascevano all’interno di altre già esistenti, oppure da una loro divisione: talvolta a singoli reparti destinati a specifici rami di ricerca si assegnava un proprio direttore. In questo modo si ottenevano delle istituzioni autonome, senza che ciò comportasse un reale aumento dei locali a disposizione delle facoltà. Altre volte, due o più stabilimenti con nomi diversi erano in effetti dislocati all’interno dello stesso spazio. Fu il caso, per esempio, del Gabinetto di patologia generale e del Gabinetto di istologia di Pavia, entrambi diretti da Camillo Golgi e ospitati nel medesimo edificio. Tenendo presente questa realtà, nel 1861 le 14 facoltà mediche delle università statali italiane risultano dotate di 72 stabilimenti scientifici e cliniche universitarie (si consideri che Padova e Roma non facevano ancora parte del Regno d’Italia e non vengono comprese nell’analisi l’Istituto di Firenze e l’Università di Macerata). Nel 1870, completata 4. Sviluppo quantitativo delle cliniche e degli stabilimenti annessi alle facoltà medico-chirurgiche delle università statali italiane. Gli istituti della sezione medico-chirurgica di Firenze non sono stati considerati perché i relativi dati non compaiono negli Annuari prima del 1878. 226 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 227 l’acquisizione delle università di cui si è detto, gli stabilimenti passarono a 123, per diventare 274 nel 1915, ovvero più del doppio rispetto a quarantasei anni prima. Fin dal 1861 molte università disponevano di cliniche mediche e chirurgiche e di stabilimenti anatomici, dislocati per lo più al Nord. Negli anni Sessanta e Settanta si assistette a un più spiccato incremento degli istituti medici al Centro-sud. Ad esclusione delle università di Napoli e di Palermo, al Sud esistevano pochissimi stabilimenti dove gli studenti potessero acquisire un minimo di esperienza pratica. Negli anni Sessanta e Settanta furono effettuati molti interventi per dotare le facoltà di cliniche oculistiche e gabinetti per l’anatomia patologica e per la fisiologia. Nello stesso periodo, invece, la situazione istituzionale delle università settentrionali, tradizionalmente ricche di istituzioni ospitanti collezioni scientifiche e luoghi adatti alla ricerca sperimentale, rimase pressoché invariata (Tab. 2). Un impulso all’edilizia universitaria si ebbe tra il 1876 e il 1888, questa volta in tutto il regno. Le discipline che maggiormente godettero di questa operosità furono la patologia generale, l’igiene e la dermosifilopatia. Dagli anni Novanta, invece, la crescita complessiva rallentò, fatta eccezione per il biennio 1908-1909, durante il quale si diede vita a 34 nuovi stabilimenti, nella maggior parte dei casi destinati alla pediatria, all’otorinolaringoiatria, alla patologia speciale medica e alla patologia speciale chirurgica; e in misura minore destinati a rami specialistici come la parassitologia, la batteriologia e la psicologia (Tab. 2). 228 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA Tabella 2. Anno d’apertura (e chiusura) delle cliniche e degli stabilimenti annessi alle facoltà medico chirurgiche delle università statali e alla Sezione di medicina e chirurgia dell’Istituto superiore di Firenze.12 Clinica medica Clinica chirurgica Ostetricia Clinica oculistica Clinica dermosifilopatica Clinica psichiatrica Clinica neurol./ neuropatol. Clinica pediatrica Clinica otorinolaringoiatrica Clinica traumatologica Clinica terapeutica Semeiotica Malattie della nutrizione Patologia speciale medica Patologia speciale chirurgica Medicina operatoria Anatomia umana Anatomia topografica Fisiologia Materia medica Anatomia patologica Patologia generale Igiene Medicina legale Anatomia microscopica/ Istologia Chimica fisiologica Batteriologia Parassitologia medica Psicologia sperimentale Antropologia (criminale) Elettroterapia Bologna (1860) (1860) Cagliari (1860) (1860) Catania 1864 1864 (1860) 1860-1882 (1860) (1860) (1860) 1870 1870 1892 1897 1909 Messina (1861) 1862 Modena (1861) (1861) 1874 Genova (1860) (1860) 1864-1895 (1860) 1879 1864 1875 1905 1863 186513 1865 1884 1887 1896 (1861) (1861)-1902 1863 1878 1878 1913-1914 1909 1910 1888-1890 1909 1909 1911 1909 (1860) (1860) 1899 1909 188414 (1861) 1861 (1860) 1864 1894 1879 1875 1909 1896 1886 (1860) (1860)-1861/ 188616 1878 1867 (1860) 1883 1902 1893 1885-1894/ 1903 1864 1892 1897 1897 1879 1892 1892 1905 (1860)17 1883 188818 1888 1896 1896 188815 1865 1878 1870-1873/ 1879 1879 1888 189019 1879 1908 1908 (1860) (1861) (1860) 1861 1901 1895 1902 1909 12. Gli anni tra parentesi indicano che lo stabilimento poteva essere stato aperto anche prima di quella data, al di fuori del periodo qui in esame. 13. Fino al 1877 la Clinica delle malattie cutanee era unita alla Clinica medica e la Clinica delle malattie sifilitiche a quella chirurgica. 14. Clinica unita alla Clinica chirurgica. 15. Clinica unita alla Clinica chirurgica. 16. Fino al 1861 e dal 1913 stabilimento unito al Gabinetto di anatomia descrittiva. 17. Fino al 1861 stabilimento unito al Gabinetto di anatomia topografica. 18. Fino al 1891 stabilimento unito al Gabinetto di medicina legale e igiene. 19. Fino al 1903 stabilimento unito al Gabinetto di medicina legale. LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 229 Napoli I: (1861) II: (1861) III: 1908 I: (1861) II: 1908 Padova (1866) 1886-1894 Palermo (1861) Parma (1860) Pavia (1860) Pisa (1860) (1866) (1861) (1860) 1861-1889 (1860) 1885-1891 Ostetricia (1861) (1861) (1860) Clinica oculistica Clinica dermosifilopatica (1861) 1868 (1866) 1868-1881 (1866) 1877 (1860) –1885 (1860) (1860) (1860) (1861) 1870 1880 1881 1886 1885 1880 1875 1888 1888 (1860) 1877 1887 1877 1896 1908/ 1908-1911 1890-92 1908 1907 Clinica medica Clinica chirurgica Clinica psichiatrica Clinica neurol./ neuropatol. Clinica pediatrica Clinica otorinolaringoiatrica Clinica traumatologica Clinica terapeutica Semeiotica Malattie della nutrizione Patologia speciale medica Patologia speciale chirurgica Medicina operatoria Anatomia umana Anatomia topografica Fisiologia Materia medica Anatomia patologica Patologia generale Igiene Medicina legale Anat. microscopica/ Istologia Chimica fisiologica Batteriologia Parassitologia medica Psicologia sperimentale Antropologia (criminale) Elettroterapia 1877 189420 1914 1912 I 1882 II: 1908 1889 1906 (1861) 1905 1902 1888 1886 1892 1868 188621 (1866) 1890 1886 (1861) 1881 1900 (1860) (1860) 1885 189622 (1860) (1861) (1861) (1861) 1880 1880 1880 (1866) 1868 (1866) 1886 1888 (1866) 1863 (1861) (1861) 1888 1888 1899 1888-1906 (1860) (1860) (1860) 1890 1908 1893 (1860) (1860) (1860) 1877 1886 1877 187723 (1860) 1863 1885 1888 1888 1888 1906 1908 1909 1911 1886 20. Tra il 1894 e il 1907 la clinica fu unita all’Istituto di medicina legale. 21. Clinica unita alla Clinica chirurgica. 22. Clinica unita alla Clinica chirurgica generale. 23. Nel biennio 1901-1902 e nel 1915 lo stabilimento fu unito al Gabinetto di patologia generale. 230 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA Clinica medica Roma (1870) Sassari (1860) Siena (1860) Clinica chirurgica (1870) (1860) (1860) Ostetricia Clinica oculistica Clinica dermosifilopatica (1870) (1870) (1870) 1878 1873 1904 1880 1885 1883 1871-1873/ 1883 1901 1905 1883 Clinica psichiatrica Clinica neurologica/ neuropatologica Clinica pediatrica Clinica otorinolaringoiatrica Clinica traumatologica Clinica terapeutica Semeiotica Malattie della nutrizione Patologia speciale medica Patologia speciale chirurgica Medicina operatoria Anatomia umana Anatomia topografica Fisiologia Materia medica Anatomia patologica Patologia generale Igiene Medicina legale Anatomia microscopica/ Istologia Chimica fisiologica Batteriologia Parassitologia medica Psicologia sperimentale Antropologia (criminale) Elettroterapia Torino (1860) 1863-1874 1861 (1860)-1900 (1860) (1860) (1860) 1882 1864 Firenze (1860) (1860) 1872 1878 1878 1885-88 (1860) 1912 1901 1886-1886/ 1902 1883 1908 1915 1888-1890 1909-1910/ 1914 1909-10 1903 1885 1883-1905/ 190926 (1870) 1885-1891/ 189428 (1870) (1870) (1870) 1888 1882 1905 191324 191325 1888 1888 1881 1908 1909-191027 1908 1907 1902-1902/ 1907 (1860) (1860) (1860) (1860) 1878 1878 1878 1888 1902 1863 1873 1877 1888 1884-189130/ 1902 1884-1885/ 1888 (1860) 1882 (1860) 1881 1882 (1860)29 (1860) 1892 1885 1882 1875 1902 1888-1893/ 1908 1908 1908 1915 24. Clinica unita alla Clinica medica. 25. Clinica unita alla Clinica chirurgica. 26. Dal 1910 clinica unita alla Clinica chirurgica. 27. Clinica unita alla Clinica chirurgica. 28. Dal 1893 stabilimento unito al Gabinetto di anatomia umana normale descrittiva e topografica. 29. Fino al 1884 questo stabilimento fu elencato solo nella Sezione di farmacia. 30. Clinica unita al Gabinetto di medicina legale e igiene. LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 231 Anche per quanto concerne l’analisi comparativa delle cliniche e degli stabilimenti scientifici annessi alle facoltà mediche sono necessarie alcune rapide considerazioni. Le facoltà mediche delle università di Bologna, Padova, Pavia, Napoli e Torino disponevano già nel 1870 di 10 o 11 stabilimenti medici, le università di Genova, Palermo e Roma di 9, le piccole università di Modena e quella di Parma di 8, l’Università di Catania, quella di Messina, le università di Pisa, Sassari e Siena da 3 a 5 stabilimenti medici ognuna. In seguito le differenze si equilibrarono, al punto che nel 1915 le facoltà mediche piccole si trovarono con 14-16 cliniche e stabilimenti annessi a ciascuna, mentre le facoltà medio-grandi avevano 16-18 stabilimenti ciascuna. Soltanto le facoltà dell’Università di Roma (con 23 istituti) e dell’Università di Napoli (con 27) si spingevano oltre quella media. Il personale scientifico e tecnico degli istituti medici Il numero delle persone attive in una clinica universitaria o in uno stabilimento scientifico annesso può essere un valido indicatore dell’ampiezza dell’istituto stesso. Il personale addetto al funzionamento di queste istituzioni era rappresentato da quattro figure professionali: il direttore, il personale scientifico subalterno, il personale tecnico e gli assistenti volontari, gli alunni interni e i frequentatori. Il direttore di una clinica o di uno stabilimento scientifico era l’unico responsabile e da lui dipendeva tutto il personale addetto. Di solito era anche il titolare della corrispondente cattedra. Nel caso di una sua prolungata assenza, o qualora il posto fosse vacante, un aiuto o un assistente ricopriva l’incarico di direttore in veste di sostituto; sebbene raramente, nello stesso istituto potevano trovarsi anche due direttori. Il personale scientifico subalterno, o il gruppo dei cosiddetti collaboratori scientifici ufficiali, era nominato dal direttore. Questo gruppo era composto dagli aiuti (chiamati anche coadiutori), dagli assistenti (chiamati anche astanti), dai dissettori, settori, preparatori e conservatori laureati. Nei primi decenni dopo l’unità nelle diverse facoltà mediche italiane queste figure erano indicate con una così grande varietà di denominazioni, che risulta assai complicato sia paragonarle tra loro, sia metterle in un rapporto gerarchico. Solo nel corso del tempo la tipologia dei collaboratori sarà unificata e, specie nei grandi istituti, la gerarchia si farà più evidente. Dal 1900, infatti, chi tra i giovani medici vole- 232 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA va intraprendere la carriera accademica iniziava come frequentatore e in seguito passava alla qualifica di assistente volontario. Conquistata una posizione stipendiata con il ruolo di aiuto preparatore, si poteva poi diventare assistente straordinario, quindi assistente ordinario, fino a raggiungere la carica più alta, quella di aiuto. Il personale tecnico comprendeva i tecnici, i macchinisti, i meccanici, i modellatori, i disegnatori e i conservatori non laureati. Questi, come anche i custodi, gli inservienti e le levatrici, erano dei semplici impiegati senza possibilità di accesso alla carriera accademica, riservata ai soli laureati. Gli istituti medici erano poi spesso popolati da una quarta figura che si distingueva dal comune studente perché frequentava l’istituto più assiduamente di quanto non imponesse il Regolamento universitario e mostrava uno spiccato interesse per qualche ramo della medicina: erano questi gli assistenti volontari, gli alunni interni e i frequentatori. Per le prime tre categorie si trattava di personale scientifico e tecnico ufficiale e stipendiato, mentre il quarto gruppo di persone lavorava senza avere una posizione ufficiale e senza retribuzione, con la speranza, però, di diventare in futuro parte del gruppo degli assistenti ufficiali. Mi soffermerò sulla seconda categoria di personale, quella del personale scientifico subalterno. Uno sguardo d’insieme ai dati relativi al “personale scientifico subalterno” mostra come il numero di queste persone aumentò in modo più continuo e decisamente più evidente rispetto a quello degli insegnamenti e degli istituti (Fig. 5). Così, se nel 1870 il resoconto annuale del Ministero dell’istruzione pubblica riportava 161 nominativi di subalterni addetti alle facoltà mediche italiane, nel 1915 il loro numero fu pari a 695, ossia più che quadruplicato. Grande impulso si ebbe negli anni 1887-1888 e 1907-1909, quando il numero dei nuovi posti creati fu pari quasi al numero totale dei posti esistenti nel 1870 (153 contro 161). Un esame più dettagliato delle singole istituzioni mostra che ci fu un grande divario nella quantità di questo personale secondo l’università e il tipo di istituto. Nel 1915 nella facoltà medico-chirurgica dell’università napoletana, ad esempio, lavoravano 116 collaboratori scientifici ufficiali, in quella di Modena e in quella di Cagliari solo 22. Gli istituti più grandi erano inizialmente i gabinetti di anatomia umana, superati poi dalle cliniche mediche, mentre raramente i gabinetti di patologia generale, medicina legale o materia medica ebbero più di un collaboratore. 5. Sviluppo quantitativo del personale scientifico subalterno degli istituti annessi alle facoltà medico-chirurgiche statali. Nel grafico sono stati considerati tutti gli aiuti, coadiutori, assistenti, preparatori ecc. che appartennero alla categoria del personale scientifico subalterno. Non sono stati inclusi i direttori e nemmeno i tecnici, meccanici, custodi, conservatori non laureati e le levatrici. É stato escluso il personale della Sezione medico-chirurgica di Firenze. LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 233 234 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA Scendendo un po’ nel dettaglio si osserva che nel 1910 la sola clinica medica presso l’Università di Roma, diretta da Guido Baccelli, dava lavoro a 22 aiuti e assistenti.31 La clinica chirurgica e la clinica ostetricoginecologica romane ospitavano ciascuna 8 giovani medici retribuiti. L’Università di Napoli disponeva nel 1910 di 3 cliniche mediche e 2 chirurgiche, ciascuna con 8 o 9 giovani collaboratori medici. All’Università di Sassari la Clinica medica aveva invece solo uno, poi due e dal 1909 tre aiuti e/o assistenti. I gabinetti anatomici e anatomico-patologici ebbero spesso 3 o 4 assistenti e dissettori, ma quello partenopeo ne aveva 7 nel 1900. Gli altri istituti e gabinetti medici di solito erano dotati di almeno uno o due assistenti, tra loro spiccano però l’Istituto di patologia generale e d’istologia di Camillo Golgi a Pavia con ben 5 assistenti (nel 1913) e gli Istituti d’igiene di Napoli (diretto da Vincenzo De Giaxa), quello di Roma (diretto da Angelo Celli) e di Torino (diretto da Luigi Pagliani) con 5 o 4 collaboratori scientifici (a partire dal 1908). Infine, gli istituti di fisiologia delle università napoletana, romana, torinese e bolognese, rispettivamente dirette da Filippo Bottazzi, Luigi Luciani, Angelo Mosso e Pietro Albertoni, godevano tutti della collaborazione di 4 o 5 impiegati laureati (a partire dal 1891). È possibile fare ora qualche considerazione generale circa la carriera degli assistenti delle università italiane nel periodo in esame. Molti assistenti si ritiravano dall’università dopo pochi anni di attività, altri, invece, rimanevano per lunghi periodi nella medesima istituzione, presumibilmente nella speranza di succedere un giorno al direttore. Verso la fine del periodo qui considerato, intorno al 1915, era evidente all’interno degli istituti una rigida gerarchia di collaboratori, dal frequentatore all’aiuto. Durante la scalata per raggiungere il grado di aiuto, raramente si produceva il passaggio da una disciplina all’altra, tanto meno a un cambio di sede universitaria. Facoltà mediche e discipline biologiche a confronto Le facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali ebbero istituzionalmente molti punti in comune con le facoltà medico-chirurgiche. Nel 31. Annessi alla clinica medica erano il gabinetto di semeiotica clinica medica e il laboratorio per le malattie della nutrizione. Guido Baccelli era stato due volte ministro dell’istruzione pubblica. LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 235 periodo in esame, tra il 1861 e il 1915, entrambe s’ispirarono a un ideale sperimentale e di formazione pratica degli studenti. Entrambe, dunque, all’indomani dell’unità ebbero bisogno di un’adeguata dotazione di laboratori, gabinetti, attrezzature e personale scientifico e di nuovi insegnamenti. É diventato ormai un luogo comune nella storiografia affermare che le scienze naturali nelle università del nuovo regno furono fortemente trascurate a beneficio delle scienze mediche, giuridiche, dell’ingegneria e della matematica pura.32 Uno studio dello sviluppo quantitativo delle discipline biologiche a confronto con quello delle scienze mediche sembra smentire questa convinzione. Molto dipende naturalmente da quale punto di vista si decide di adottare per un’analisi quantitativa. Il numero degli insegnamenti biologici ufficiali, per esempio, fu di fatto molto minore di quello degli insegnamenti medici; tuttavia il loro rapporto rimase pressoché stabile durante tutto il periodo qui in esame (Tab. 3). Per quanto concerne il numero degli stabilimenti scientifici annessi, invece, è da osservare che in Italia le discipline biologiche, al contrario di quelle mediche, erano tradizionalmente ben dotate di orti botanici, Tabella 3. Numero delle cattedre di discipline biologiche e mediche presso le università statali italiane (1861-1915). Anno accademico 1861/62* 1866/67* * 1870/71 1875/76 1880/81 1885/86 1890/91 1895/96 1900/01 1915/16 Biologia 34 36 37 39,5 42 49 50 50 56 64 Medicina 184 201 229 230 244 284 299 291 309 382 Rapporto 18,47% 17,91% 16,16% 17,17% 17,21% 17,25% 16,72% 17,18% 18,12% 16,75% * Senza Padova e Roma, che nel 1861/62 ancora non appartenevano al Regno d’Italia. ** Senza Roma, che nel 1866-67 ancora non apparteneva al Regno d’Italia. 32. Maiocchi, “Il ruolo delle scienze nello sviluppo industriale italiano”, cit., p. 900; G. B. Rizzo, “L’ordinamento della Facoltà di Scienze nelle università italiane”, Rivista d’Italia, a. XIV, v. I , 1911, pp. 388 e ss. 236 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA Tabella 4. Numero delle istituzioni scientifiche collegate alle discipline biologiche e a quelle mediche presso le università statali italiane (1861-1915). Anno accademico 1861/62* 1866/67* * 1870/71 1875/76 1880/81 1885/86 1890/91 1895/96 1900/01 1915/16 Biologia 27 33 34 37 40 43 47 48 48 50 Medicina 75 99 128 137 165 195 233 229 242 289 Rapporto 36% 33,33% 26,56% 27% 24,24% 22,05% 20,17% 20,96% 19,83% 17,3% * Senza Padova e Roma, che nel 1861-62 non appartenevano ancora al Regno d’Italia. ** Senza Roma, che nel 1866-67 non apparteneva ancora al Regno d’Italia. musei, gabinetti e attrezzature varie.33 Infatti, nel 1861 quattro su cinque professori di discipline biologiche (79,4%) erano anche direttori di uno stabilimento, mentre tra i medici soltanto due su cinque avevano a disposizione uno stabilimento (40,8%). Con il passare degli anni le facoltà medico-chirurgiche, come si è visto, recuperarono velocemente, ma è solo dopo il 1900 che il rapporto tra stabilimenti e insegnamenti si equiparò (Tab. 3 e tab. 4). Nel 1900 su 56 insegnanti ufficiali di discipline biologiche, 48 (85,7%) potevano disporre di uno stabilimento scientifico; nella medicina e chirurgia, invece, le 309 cattedre esistenti avevano a disposizione solo 242 stabilimenti (78,3%). Nel 1915, tuttavia, le distanze tra le due facoltà si erano in gran parte accorciate: la biologia godeva di 50 stabilimenti e di 64 cattedre ufficiali (78,1%), la medicina di 289 istituzioni e di 382 cattedre (75,7%). Il leggero calo nel rapporto tra stabilimenti e cattedre è da ricondurre all’introduzione di numerosi nuovi corsi, coperti quasi sempre o da incaricati o da titolari di un’altra cattedra e quindi istituzionalmente legati a stabilimenti già esistenti. Uno sguardo al numero di collaboratori scientifici attivi nelle discipline biologiche mostra uno sviluppo iniziale sostanzialmente simile a quello del personale medico. A partire dalla fine degli anni Settanta, 33. Il numero dei laboratorio fondati tra il 1860 e il 1939 si trova anche in R. Maiocchi, “Gli istituti di ricerca scientifica in Italia durante il fascismo”, in R. Simili (a cura di), Ricerca e istituzioni scientifiche in Italia, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 207–209. LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA / 237 Tabella 5. Numero dei collaboratori scientifici addetti alle istituzioni biologiche e mediche presso le università statali italiane (1861-1915). Anno accademico 1861/62* 1866/67* * 1870/71 1875/76 1880/81 1885/86 1890/91 1895/96 1900/01 1915/16 Biologia 35 48 52 53 55 80 96 101 107 100 Medicina 117 149 169 165 238 281 413 417 485 695 Rapporto 29,91% 32,21% 30,77% 32,12% 23,11% 28,47% 23,24% 24,22% 21,86% 14,39% * Senza Padova e Roma, che nel 1861-62 ancora non appartenevano al Regno d’Italia. ** Senza Roma, che nel 1866-67 ancora non apparteneva al Regno d’Italia. tuttavia, il rapporto si spostò sempre più a favore delle discipline mediche che nell’anno accademico 1915-16 totalizzarono il ragguardevole numero di 695 medici impiegati (Tab. 5). Mettendo a confronto il numero dei collaboratori scientifici pagati con il numero degli stabilimenti, l’andamento appare più eterogeneo. Nel 1861-62 negli stabilimenti medici lavoravano in media 1,56 assistenti, dissettori e altro personale laureato, mentre negli stabilimenti biologici solo 1,3 addetti per stabilimento. Dalla metà degli anni Ottanta questo rapporto si capovolse a favore dei biologi: ora erano gli stabilimenti biologici a ospitare in media 1,86 collaboratori laureati retribuiti per stabilimento. Nel 1890 questo numero crebbe a 2,04 addetti per stabilimento e nel 1900 a 2,23. Nello stesso periodo negli stabilimenti medici troviamo mediamente solo 1,44 (nel 1885) o 1,77 (nel 1890) giovani scienziati retribuiti per stabilimento. Nel 1900 il loro numero medio aumentò a 2 per superare nel 1915 di nuovo quello dei collaboratori delle discipline biologiche, che fornivano posti di lavoro retribuito mediamente a 2,4 persone per stabilimento. Anche se questi dati sono da interpretare con cautela,34 sembrano 34. L’indicatore più importante per poter valutare l’importanza assegnata dal Ministero della pubblica istruzione alle varie discipline, è senz’altro lo stanziamento di fondi. Purtroppo non sono ancora state elaborate analisi in questo senso. Alcuni dati per i primi anni del Novecento si trovano in R. Simili, “I laboratori sperimentali. Cure e ricette”, in R. Simili (a cura di), Ricerca e istituzioni scientifiche in Italia, cit., pp. 135-181. 238 / LO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ DI MEDICINA tuttavia indicare che l’opinione diffusa tra gli storici di una trascuratezza delle scienze naturali da parte del ministero non sia del tutto fondata. Le scienze biologiche in Italia nel periodo in esame certamente non ebbero una fioritura che consentisse loro di competere a livello internazionale, ma poggiavano pur sempre su basi istituzionali abbastanza solide. Non bisogna poi dimenticare il bassissimo numero degli iscritti. Negli ultimi sette anni dell’Ottocento i corsi medici ebbero in media 6.744 iscritti, 1.124 studenti per ognuno dei sei anni di studio. Nello stesso periodo solo 372 studenti erano iscritti ai corsi di laurea di scienze naturali, ossia 93 per ognuno dei quattro anni di corso. Queste cifre corrispondono all’1,5% del totale degli studenti italiani e a una media di 22 studenti per ogni facoltà di scienze. Ancora più desolante era la situazione degli studenti che completarono il loro studio con una laurea: tra il 1893 e il 1899 le università italiane laureavano in media 47 studenti, cioè 2,8 studenti per ogni facoltà scientifica.35 Da questo punto di vista la situazione in termini di cattedre e altre risorse delle scienze biologiche in quegli anni può dirsi perfino privilegiata. 35. A. Dröscher, “Die Entwicklung biologischer Disziplinen an den italienischen Universitäten (1860-1900)”, in U. Hoßfeld and T. Junker (Hrsg.), Die Entstehung biologischer Disziplinen II. Beiträge zur 10. Jahrestagung der DGGTB in Berlin 2001, Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin, 2002, pp. 39-53 e Id., “Academic zoology in Italy between 1861 and 1900”, in A. Minelli, S. Casellato (a cura di), Giovanni Canestrini zoologist and Darwinist, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2001, pp. 301- 320. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 239 DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE, 1877-2005 Paola Govoni … se lo studio delle donne all'università corrisponde a un vero bisogno della società femminile, esso prenderà piede, e porterà utili frutti; nel caso contrario, dopo un entusiasmo passeggero cadrà da sé, e si mostrerà simile a un fuoco di paglia. Nuova Antologia, 1873.1 Nonostante l'incremento più forte di partecipazione femminile agli studi accademici si sia determinato durante gli anni settanta, è solo durante gli anni novanta [del Novecento] che si verifica il sorpasso delle donne sugli uomini. Istat, Donne e università, 2001.2 Introduzione Nel 1873 la Nuova Antologia pubblicò un lungo articolo sulle Studentinnen, come furono chiamate anche in Italia per un certo periodo le donne che si iscrivevano all’università. Il nuovo fenomeno sociale stava entusiasmando molte donne di qua e di là dell’Atlantico generando in numerosi uomini, in particolare docenti universitari, perplessità e timori, quando non aperte ostilità.3 L’autore dell’articolo pubblicato Un ringraziamento speciale va a Gianna Pomata e Giuliano Pancaldi che hanno letto il saggio e, come sempre, sono stati generosi di suggerimenti e incoraggiamento. Un grazie sincero va inoltre a Teresa Bertilotti, che ha letto una versione preliminare del saggio e mi ha fornito alcuni importanti suggerimenti bibliografici, e a Andrea Cammelli e Angelo Di Francia, per avere discusso con me alcune questioni statistiche relative alla storia degli studenti e dell’università. La responsabilità per quanto affermato in queste pagine, naturalmente, resta soltanto mia. 1. D. Padelletti, “Le donne alle università di Zurigo ed Edimburgo”, in Nuova Antologia, 23, V, maggio 1873, pp. 149. Il matematico Dino Padelletti aveva trascorso un lungo periodo di studio tra Zurigo, Dresda, Berlino e Londra. 2. Istat, Donne all’università, Bologna, il Mulino, 2001, p. 17. 3. Interessanti testimonianze dell’epoca, che forniscono anche dati statistici sull’istruzione femminile in Europa e negli Stati Uniti, si trovano in S. Jex-Blake, Medical women. Two essays, I. Medicine as a Profession for Women, II. Medical Education of Women, W. Oliphant, Edinburgh, 1872; H. Lange, Higher education of women in Europe, Translated and accompanied by comparative statistics By L. R. Klemm, Ph. D., New York D. Appleton and company, 1890 (1° ed. orig. Berlin, 1888); R. Furlani, L’educazione della donna presso i popoli più civili, Opera premiata al concorso Ravizza della Città di Milano, Roma, Società Editrice Dante Alighieri (Albrighi Segati & C.), 1903. Circa la storiografia più recente, tra gli altri, M. Rossiter, Women scientists in America. Struggles and strategies to 1940, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1982; E. S. Eschbach, The higher education of women in England and America, 1865-1920, Garland Publ., New York-London, 1993; “Histoires de pionnières”, dossier di Travail, genre e sociétés, 4, 2000; P. M. Mazón, Gender and the modern research university. The admission of women to German higher education, 1865-1914, Stanford University Press, Stanford, 2003. 240 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE sul periodico italiano, un matematico, era invece incoraggiante circa i successi conseguiti da quelle Studentinnen nelle università di Zurigo e Edimburgo e ipotizzava anche per l’Italia un futuro in cui le donne avrebbero dimostrato interesse nei confronti dell’istruzione universitaria. Nonostante in Italia non fosse esistita, a quanto pare, alcuna norma volta a impedire l’iscrizione delle donne all’università, per varie ragioni – alcune note e di natura sociale ed economica, altre invece che restano da indagare – soltanto nel 1877 fu conseguita la prima laurea femminile del Regno d’Italia. Tra l’intervento della Nuova Antologia e la realtà documentata per gli anni Novanta del Novecento, dunque, le studentesse nelle università italiane hanno conseguito un obiettivo che nemmeno le più ottimiste nell’“età del progresso” avrebbero mai pensato realizzabile: diventare più numerose degli uomini nelle aule degli atenei italiani. Per dare al fenomeno la rilevanza che merita è il caso di ricordare che nel 1871 le donne più colte erano le lombarde, comunque analfabete nel 50% dei casi, insieme alle piemontesi, analfabete nel 51% dei casi. In Sicilia, in Sardegna e in Puglia le donne erano analfabete in più dell’85% dei casi, mentre in Calabria e in Basilicata lo era ben il 95% delle donne.4 In quegli anni, tuttavia, si fece molto per estendere l’istruzione e, se è vero che l’alfabetizzazione degli italiani e delle italiane migliorò troppo lentamente rispetto alle ambizioni delle élite di una nazione che voleva accorciare in fretta le distanze con i paesi d’oltralpe, in alcuni settori i risultati non mancarono. D’altra parte, anche alle giovani dei ceti abbienti non era richiesto molto di più, oltre che leggere e scrivere, conoscere un po’ di francese, cantare e danzare con grazia, eventualmente sapere eseguire un acquerello. I genitori desiderosi di dare alle figlie una formazione superiore, magari finalizzata a una professione, e le giovani più ambiziose di studiare – le protagoniste della conquista dell’università di cui mi occuperò – appartennero spesso alla piccola e media borghesia, ceti in formazione in quei primi decenni difficili dell’Italia unita, ma anche attraversati da forti spinte all’innovazione.5 4. C. M. Cipolla, Istruzione e sviluppo. Il declino dell’analfabetismo nel mondo occidentale, UTET, Torino, 1971, pp. 79 e 80. 5. L’origine sociale delle studentesse di cui ho esaminato i fascicoli personali (Università di Bologna e Università di Roma, La Sapienza) si può collocare nella piccola e media borghesia. Per una testimonianza a stampa si veda Relazione statistica della Istruzione pubblica e privata in Italia, compilata da documenti ufficiali per l’Esposizione di Parigi, Tip. Eredi Botta, Roma, 1878, p. 133 e seguenti. Questa realtà è confermata in A. Cammelli, F. Scalone, “Donne, università e professioni. Il caso dell’ateneo bolognese alla fine dell’Ottocento”, in Storia in Lombardia, 3, 2001, in part. pp. 87-88. Sul tema si veda inoltre M. De DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 241 Nel 1900 sul Bollettino ufficiale del ministero dell’istruzione pubblica (d’ora in poi, Bollettino)6 si pubblicavano i risultati conseguiti nel campo dell’istruzione femminile nei primi decenni postunitari. Nell’anno scolastico 189596 nei collegi e convitti, pubblici e privati, e nelle scuole superiori comunali, erano iscritte 7.319 alunne. Nei ginnasi le alunne erano 1.030, nei licei 233, nelle scuole tecniche 3.393, negli istituti di musica 320, 299 in quelli di belle arti. Circa gli istituti tecnici, “ove predomina l’insegnamento professionale a cui la donna non ha attitudine, furono iscritte le sole donzelle che aspiravano alla laurea in scienze, le quali furono in tutto 65 nei governativi e 22 nei pareggiati.”7 Ma nelle scuole normali e complementari, invece, dove si formavano le maestre elementari, le studentesse erano 21.203.8 Non vanno dimenticate le scuole presso i monasteri, naturalmente, che nel 1899 contavano 95.404 alunne, un dato non riportato dal Bollettino.9 Per quanto concerne l’istruzione superiore, invece, già dal 1883 il Ministero aveva scritto a tutti i rettori e ai presidi degli istituti superiori, chiedendo di inviare i dati riguardanti le iscritte e le laureate.10 Tutti risposero, ma allegando ben poche informazioni: fino ad allora, infatti, Giorgio, Le italiane dall’unità a oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali, Roma-Bari, Laterza, 1992, in part. capp. v e vi. Per la ricca bibliografia sulla storia dell’istruzione rimando a G. Genovesi, Storia della scuola in Italia dal Settecento a oggi, Laterza, Bari, 2004. La storiografia sul contesto economico e sociale dell’Italia del periodo è naturalmente vasta, mi limito a citare F. Chabot, Storia della politica estera italiana, Laterza, Bari, 1951; G. Are, Economia e politica nell’Italia liberale (1890-1915), Il mulino, Bologna, 1974; S. Lanaro, Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia (1870-1925), Marsilio, Venezia, 1979; V. Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell’Italia 1861-1981, il Mulino, Bologna, 1990; A. M. Banti, Storia della borghesia italiana. L’età liberale, 1861-1922, Donzelli, Roma, 1996; P. Bianchi, La rincorsa frenata: l’industria italiana dall’unità nazionale all’unificazione europea, Il mulino, Bologna, 2002. 6. Il Bollettino fu denominato Bollettino Ufficiale. Ministero della Pubblica Istruzione (BUMPI), nel periodo 1874-1887; Bollettino Ufficiale dell’Istruzione, (BUI), nel periodo 18871891; quindi, Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica, (BUMIP), nel periodo 1891-1923. 7. Dell’istruzione e educazione della donna, supplemento al n. 10, BUMIP, a. XXVII, v. 1, Roma, 10 marzo 1900, p. 494. Sull’istruzione tecnica in relazione allo sviluppo del paese, fondamentale resta C. G. Lacaita, Istruzione e sviluppo industriale in Italia, 1859-1914, Giunti Barbèra, Firenze, 1973. 8. Dell’istruzione e educazione della donna, cit., pp. 474-498. 9. Furlani, L’educazione della donna presso i popoli più civili, cit., p. 135. I censimenti sono naturalmente fonti straordinarie e sempre ricche di sorprese anche per la storia dell’istruzione e della ricerca, così come l’Annuario Statistico Italiano. 10. Le informazioni che seguono sono tratte dal carteggio tra il ministero e i rettori conservato in “Statistiche delle donne che frequentano le università”, Archivio Centrale dello Stato (ACS), Divisione istruzione superiore, 1883, Busta 58. L’anno seguente quegli scambi il BUMPI avrebbe pubblicato un breve quadro riassuntivo registrando 33 donne iscritte nelle università e istituti superiori (19 studentesse e 14 uditrici), e 105 iscritte presso gli Istituti superiori di magistero femminile di Firenze e Roma (BUMPI, v. X, no.VII, luglio 1884, “Statistica degli studenti iscritti”, p. 286). 242 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE le laureate erano state 8 in tutto il regno. Gli unici commenti arrivarono dal preside dell’Accademia scientifico-letteraria di Milano, entusiasta dei risultati conseguiti dalle sue studentesse, il quale auspicava interventi nel settore dell’istruzione superiore femminile per rispondere, dichiarava, “a esigenze intellettuali veramente e universalmente sentite”.11 Fu solo nel 1902, quando l’analfabetismo femminile su base nazionale era sceso intorno al 50%,12 che sul Bollettino si pubblicarono i nomi delle prime 224 laureate del regno.13 L’episodio, come vedremo, ebbe un’eco su diversi giornali dell’epoca. Quelli rapidamente richiamati, dunque, sono i dati quantitativi concernenti gli esordi di un rapporto tra le donne e l’università in Italia: 224 laureate in circa un quarto di secolo, a fronte di un numero di laureati che oscillava nello stesso periodo tra i 2.000 e i 3.000 l’anno.14 D’altra parte, nell’anno scolastico 1901-02 le studentesse dei licei – governativi e pareggiati – erano state soltanto 315, su un totale di 12.938 studenti.15 Questi numeri rimandano a un contesto di generalizzata arretratezza rispetto all’Europa, capace tuttavia di lasciare spazio, come vedremo, a eccezioni di qualche interesse. È vero, infatti, che, nel 1889, nella confinante Svizzera le donne erano l’8% della popolazione studentesca universitaria, in Inghilterra l’11% e negli Stati Uniti, nel 1888, il 29,3%.16 Ed è vero che in Italia l’accesso delle donne all’istruzione superiore, al contrario che in quei paesi, non assunse mai l’aspetto di 11. “Statistiche delle donne che frequentano le università”, ACS, Divisione istruzione superiore, 1883, Busta 58. 12. T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Roma, Laterza, 2001, p. 95 (1° ed. 1963). 13. V. Ravà, “Le laureate in Italia”, in BUMPI, v. 1, n. 14, 3 aprile 1902, pp. 634-654. 14. Nel 1913-14, per esempio, i laureati furono 3.962 (Istituto Centrale di Statistica, Annuario statistico dell’istruzione italiana, a. s. 1947-48, serie I, v. 1, 1950, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1950, “Dati retrospettivi”, p. 183). Sul tema si veda A. Cammelli, “Contare gli studenti. Statistica e popolazione studentesca dall’unità a oggi”, in Annali di Storia delle Università Italiane, 4, 2000, p. 6 (disponibile anche all’indirizzo www.cisui.unibo.it). Il numero complessivo dei laureati poneva l’Italia al fondo della classifica di tutti i paesi per i quali è disponibile una documentazione. A. Cammelli, A. Di Francia, Studenti, università, professioni: 1861-1993, in M. Malatesta (a cura di), Storia d’Italia. Annali 10. I professionisti, Einaudi, Torino, 1996, p. 27. 15. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione generale di statistica, Annuario Statistico Italiano. 1904, Tip. G. Bertero, Roma, 1904, p. 175. 16. Dati dei rispettivi ministeri dell’educazione riportati da L. R. Klemm in Lange, Higher education of women in Europe, cit., p. xxiv. Arretrata anche la situazione della Francia, dove nel 1887 si stimava circa un 2% di studentesse universitarie. Per i dati relativi all’Italia, elaborazione dei dati forniti in Istituto centrale di statistica, Sommario di statistiche storiche dell’Italia, 1861-1975, Roma, 1976, p. 56. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 243 una “rivoluzione”,17 ma semmai quello di una lenta conquista. Al contrario di quanto si potrebbe pensare oggi, tuttavia, magari con in mente l’immagine della donna intellettualmente “inferiore” che schiere di antropologici impegnati a misurare e pesare crani e cervelli diffondevano in quegli anni, 72 di quelle prime 224 laureate in Italia – circa una laureata su tre – conseguì una laurea in scienze o medicina. E, come si vedrà, parecchie di loro si affermarono professionalmente proprio in campo scientifico. Nei decenni che seguirono quegli esordi, il numero complessivo delle iscritte aumentò lentamente fino a che, nella prima metà degli anni Venti del Novecento, il numero delle iscritte alle facoltà scientifiche – con “scientifiche” intenderò sempre le facoltà di scienze naturali e di medicina – raggiunse il picco rispetto a quasi tutta la prima metà del secolo. Negli anni Trenta, mentre aumentò il numero complessivo delle iscritte, calò invece in modo sensibile quello delle iscritte alle facoltà scientifiche. Quindi, a ridosso della Seconda guerra mondiale, vi fu una prima, importante impennata: sia complessiva nel numero delle iscritte, sia relativa al numero delle iscritte alle facoltà scientifiche. Un successivo, significativo momento nella storia dei rapporti tra donne e istruzione superiore fu tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta del Novecento, quando a un massiccio incremento complessivo delle iscrizioni corrispose un brusco calo di quelle alle facoltà scientifiche: una contrazione che nel caso degli uomini sarebbe arrivato solo negli anni Ottanta. Da allora la crescita delle iscrizioni delle donne all’università non ha più subito flessioni, fino al sorpasso degli uomini, avvenuto nell’anno accademico 1990-91: un trend che, com’è noto, non accenna a diminuire. Infine, va segnalata una novità che riguarda le iscrizioni al settore tecnico-scientifico negli ultimi anni: dal 2000, mentre il numero degli uomini iscritti a quei settori ha continuato a calare suscitando l’allarme di molti, si nota invece una ripresa delle iscrizioni femminili in quegli stessi settori.18 Questi dati costituiscono un ovvio punto di riferimento per la storiografia di genere, così come per la storia degli studenti e dell’uniM. Bryant, The unexpected revolution. A study in the history of the education of women and girls in the nineteenth century, University of London, Institute of Education, London, 1979. 18 Miur, Direzione generale per gli studi e la programmazione, L’università in cifre. 2005, Le Monnier, Firenze, 2005, p. 36 (disponibile anche all’indirizzo, http:// www.miur.it/ustat/documenti/pub2005/index.asp). 17 244 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE versità. Ma che cosa possono dirci di interessante per la storia della scienza in Italia? Il punto che mi preme evidenziare in questo saggio su donne e scienza è che in una società come quella italiana, caratterizzata da investimenti per lo più scarsi nell’istruzione scientifica e da scarsa mobilità sociale, le donne nell’ultimo secolo sono state l’attore più dinamico, capace – pur in assenza di specifiche politiche di supporto – di conquistare un ruolo crescente e poi dominante nell’istruzione superiore, con una forte presenza nei settori scientifici. L’iscrizione a una facoltà piuttosto che a un’altra, è noto, è determinata da un equilibrio difficile tra scelte personali (nelle quali contano anche l’accettazione o il rifiuto dei ruoli di genere) e il calcolo delle probabilità di trovare un lavoro. È soprattutto in riferimento a quest’ultimo punto che lo studio quantitativo di lungo periodo sull’accesso delle donne all’istruzione scientifica superiore può offrire un indicatore utile per l’analisi della diffusione della cultura scientifica in Italia. Le variazioni nel numero delle iscrizioni femminili alle diverse facoltà, in definitiva, possono aiutarci a capire alcuni aspetti del legame tra istruzione scientifica e sviluppo in Italia nell’ultimo secolo e mezzo. Come sia avvenuto il primo accesso delle donne all’istruzione superiore è una storia che è stata indagata in modo frammentario dalla storiografia esistente.19 Su chi furono le prime laureate in discipline scientifiche e che cosa fecero di quella laurea, le notizie sono ancora più scarse. Studiare la storia dell’accesso femminile alla cultura scientifica superiore in Italia significa aprire un nuovo campo d’indagine, con gli 19. Un saggio particolarmente ricco di suggerimenti per nuove ricerche resta M. Raicich, Liceo, Università, professioni: un percorso difficile, in S. Soldani (a cura di), L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminili nell’Italia dell’Ottocento, Milano, Angeli, 1989, pp. 147-181. Si vedano inoltre S. Ulivieri, La donna e gli studi universitari nell’Italia postunitaria, in F. De Vivo, G. Genovesi (a cura di), Cento anni di Università. L’istruzione superiore in Italia dall’Unità ai nostri giorni, ESI, Napoli, 1986; T. Tomasi, L. Bellatalla, L’università italiana nell’età liberale (1861-1923), Napoli, Liguori, 1988; M. De Giorgio, Donne e professioni, in Malatesta (a cura di), Storia d’Italia, Annali 10, I professionisti, cit. Più ricca la bibliografia sull’istruzione femminile elementare e media: I. Porciani (a cura di), Le donne e la scuola: l’educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento, Il Sedicesimo, Firenze, 1987; S. Ulivieri, Donne e scuola. Per una storia dell’istruzione femminile in Italia, in E. Beseghi, V. Telmon (a cura di), Educazione al femminile: dalla parità alla differenza, La Nuova Italia, Firenze, 1992; F. Pesci, Pedagogia capitolina. L’insegnamento della pedagogia nel Magistero di Roma, dal 1872 al 1955, Ed. Ricerche Pedagogiche, Parma, 1994. Anche per ulteriori rimandi bibliografici: E. Soldani, “S’emparer de l’avenir: les jeunes filles dans les écoles normales et les établissements secondaires de l’Italie unifiée (1861-1911)” in Paedagogica Historica, 40, 1 & 2, April 2004, p. 123-142. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 245 entusiasmi e i rischi che una simile operazione comporta.20 D’altra parte, è sembrato questo un punto di partenza ineludibile per cominciare a scrivere una storia – di cui questo saggio offre alcuni primi, parziali risultati – dell’ingresso delle donne italiane nei laboratori, nel settore della divulgazione e del giornalismo scientifici e in quello delle professioni mediche e tecniche. Nelle pagine che seguono affronterò, in primo luogo e con maggiori dettagli, i passi iniziali compiuti dalle donne nelle università italiane e nelle facoltà scientifiche tra il 1877 e il 1900, fornendo un profilo prosopografico delle prime 72 laureate in scienze e medicina del regno. Quindi, più rapidamente, fornirò i dati sull’accesso delle donne ai corsi universitari e ai dottorati di ricerca scientifici fino al 2005. Si può anticipare che questo studio non sfata, ma certo mitiga significativamente il mito che vorrebbe dominante nell’età del positivismo in Italia21 un’immagine della donna inconciliabile con il suo dedicarsi allo studio della scienza. Se è vero che le scienze antropologiche e mediche diffusero allora in Europa l’idea di una donna “scientificamente inferiore” all’uomo,22 è vero anche che le giovani che decisero di studiare all’università si diressero verso lo studio delle scienze naturali, matematiche, fisiche e mediche in numeri (percentualmente) consistenti, evidentemente incuranti o determinate a confutare quel pregiudizio. L’immagine di una scienza come motore di sviluppo e cambiamento sociale fu più forte della propaganda sessista (che andava di pari passo 20. Punto di partenza per una storia degli studenti e dell’istruzione superiore nell’Italia del periodo sono le ricerche coordinate da Andrea Cammelli e in particolare ai fini di questo studio, Cammelli, Di Francia, Studenti, università, professioni: 1861-1993, cit.; Cammelli, “Contare gli studenti. Statistica e popolazione studentesca dall’unità a oggi”, cit.; Cammelli, Scalone, “Donne, università e professioni. Il caso dell’ateneo bolognese alla fine dell’Ottocento”, cit. Si vedano inoltre gli Annali di Storia delle Università Italiane, disponibili nel sito del Centro interuniversitario per la storia delle università italiane (www.cisui.unibo.it). Per i dati contemporanei Miur, Ufficio di statistica (www.miur.it/ ustat/Statistiche/BD_univ.asp) e Consorzio interuniversitario Almalaurea (www.almalaurea.it). 21. Su questo periodo restano fondamentali A. Santucci (a cura di), Scienza e filosofia nella cultura positivistica, Milano, Feltrinelli 1982 e P. Rossi (a cura di), L’età del positivismo, Bologna, il Mulino 1986. 22. V. P. Babini, F. Minuz, A. Tagliavini, La donna nelle scienze dell’uomo, Angeli, Milano, 1986; L. Jordanova, Sexual visions. Images of gender in science and medicine between the eighteenth and twentieth centuries, University of Wiscontin Press, Madison, 1989; P. Govoni, “Divulgare e tradurre: Giovanni Canestrini, le razze e la donna” in A. Minelli, S. Casellato (a cura di), Giovanni Canestrini Zoologist and Darwinist, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 2001, pp. 69-93. Il clima misogino e antipositivista di una città come Bologna è ricostruito in V. P. Babini, Il caso Murri, il Mulino, Bologna, 2004. 246 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE con quella razzista), almeno su quelle donne che ebbero il coraggio di tentare l’avventura universitaria. Gli inizi dell’avventura, 1877-1900 Con un impatto sulla sfera pubblica molto diverso rispetto a quello avuto dalle poche “dottrici” e “filosofesse” dell’età dell’Illuminismo,23 fu negli anni Settanta dell’Ottocento che in Italia le donne iniziarono ad avvicinarsi alla scienza non più beneficiando della condiscendenza di padri, fratelli, mariti o amanti illuminati, ma entrando con le proprie forze dalla porta principale: quella della formazione superiore e dell’università. E del resto fu nella seconda metà dell’Ottocento che ovunque nei paesi occidentali le donne iniziarono la difficile battaglia per la conquista dei diritti civili, compreso quello all’istruzione.24 (Fig. 1) In Francia le donne furono ammesse all’università nel 1863, quando Lione fu il primo ateneo ad aprir loro le porte,25 mentre a Parigi la prima iscrizione femminile fu accettata nel 1867. Nel 1889 le studentesse universitarie erano 817, di cui 559 francesi e 258 straniere.26 Nel Regno 23. Questo periodo ha beneficiato dell’attenzione della storiografia internazionale. Tuttavia, restano da chiarire questioni importanti come, per esempio, le ragioni della scomparsa delle donne dall’ateneo bolognese nei primi decenni dell’Ottocento, dopo un periodo di relativa apertura nel Settecento, uno dei molti casi emblematici dei difficili rapporti tra donne e scienza nella cultura europea. Su donne e illuminismo, tra gli altri: P. Findlen, “Science as a career in Enlightenment Italy. The strategies of Laura Bassi”, in Isis, 84, 1993, pp. 441-69; B. Ceranski, “Und sie fürchet sich vor niemandem”. Die Physikerin Laura Bassi (1711-1778), Campus, Frankfurt-New York, 1996; M. Mazzotti, “Maria Gaetana Agnesi. Mathematics and the making of Catholic Enlightenment”, in Isis, 92, 4, 2001, pp. 657-683 e Id., Another Enlightenment: The world of Maria Gaetana Agnesi, Johns Hopkins University Press, Baltimore, in corso di stampa. Dei numerosi, importanti scritti di Marta Cavazza si vedano, “Dottrici” e lettrici dell’Università di Bologna nel Settecento, in Annali di storia delle università italiane, 1, 1997, pp. 109-126 e “Minerva e Pigmalione. Carriere femminili nell’Italia del Settecento”, in The Italianist, 16, 1997, pp. 5-17. Per ulteriori rimandi, P. Findlen, R. Messbarger (eds.), The Contest for Knowledge: Debates Over Women’s Learning in Eighteenth-century Italy, University of Chicago Press, Chicago, 2005. Circa alcune importanti questioni storiografiche relative alla storia di genere rimando agli scritti di Gianna Pomata e in particolare a “Close-ups and long shots: Combining particular and general in writing the histories of women and men”, in H. Medick, A.-C. Trepp (eds.), Geschlechtergeschichte und Allgemeine Geschichte: Herausforderungen und Perspektiven, Wallstein Verlag, Göttingen, 1998, pp. 101-124. 24. Per una storia del femminismo europeo si veda a K. Offen, European feminism, 1700-1950. A political history, Stanford, Stanford University Press, 2001. 25. C. Lécuyer, “Une nouvelle figure de la jeune fille sous la IIIe République: l’étudiante”, in G. Houbre (dir.), Le temps des jeunes filles, Clio, 4, 1996. 26. C. Christen-Lécuyer, “Les premières étudiantes de l’Université de Paris” in Travail, genre et Société, 4, octobre, 2000, p. 39. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 247 1. Il 13 marzo 1896 il Times riferiva del rifiuto opposto dalla Congregation dell’Università di Oxford ad ammettere le donne al B.A degree. A pochi giorni di distanza seguì una decisione analoga del Senato dell’Università di Cambridge. Il Punch del 21 marzo commentava la notizia con questa vignetta. Il togato che sbarra l’accesso di un college a una donna in vesti di Minerva esclama: “Very sorry, Miss Minerva, but perhaps you are not aware that this is a monastic establishment”.27 (Collezione privata). Unito, il primo college femminile era stato il Queen College di Londra, fondato nel 1848, ma fu l’Università di Londra la prima, nel 1878 e con largo anticipo su Oxford e Cambridge, a concedere alle donne il titolo di studio legale, una scelta seguita nel 1889 dalle università di Edimburgo e Aberdeen, ad esclusione delle facoltà di medicina. Note invece le vicende delle due più antiche università d’Inghilterra (Fig. 1): l’Università di Oxford concesse il titolo legale alle donne soltanto nel 1920, sebbene fin dal 1879 queste poterono ugualmente studiare grazie ad 27. Punch, or the London Chiarivari, March 21, 1896, p. 134. Fu soltanto alla fine dell’età moderna che iniziarono a ridisegnarsi, in relazione alla scienza, ruoli di genere tramandatisi intatti fin dal medioevo, quando in Europa ovunque si gettarono le fondamenta del tempio – maschile – della scienza: l’università. Su questo tema si veda D. F. Noble, Un mondo senza donne. La cultura maschile della Chiesa e la scienza occidentale, Bollati Boringhieri, Torino, 1994 (1° ed. orig. New York, 1993). 248 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE alcuni college fondati da sostenitori e sostenitrici dei diritti delle donne all’istruzione superiore, come Lady Margaret Hall e Somerville College.28 All’Università di Cambridge fu concesso alle donne il diritto di conseguire il titolo legale addirittura nel 1947,29 ma fin dal 1873 le donne poterono beneficiare dei femminili Girton College e, dal 1875, del Newnham College. Nel mondo di lingua tedesca l’Università di Zurigo fu la prima, nel 1867, a consentire l’iscrizione alle donne.30 In Svizzera, nell’anno accademico 1898-99, dei 4.438 studenti iscritti 937 erano donne, nella maggior parte dei casi russe.31 Dal 1859 le donne si erano iscritte a centinaia nelle università russe, ma tra il 1863 e il 1864, a causa di forti pressioni sociali, le porte delle università furono loro chiuse e lo sarebbero rimaste fino al 1878. Fu questa la ragione che, dal 1864, spinse centinaia di giovani russe, spesso studentesse di scienze o di medicina, a lasciare il paese e diffondersi per l’Europa: 32 si comprende così perché la prima laureata in matematica e fisica alla Sorbona fu una russa, Elena Lej,33 così come in Italia la prima laureata, in medicina, fu la russa Ernestina Paper. La Germania, infine, fu l’ultimo dei grandi paesi ad ammettere le donne all’università, come lamentava Helene Lange, protagonista del movimento per i diritti delle donne in quel paese e autrice di una importante inchiesta su donne e università in Europa, un libro che ebbe larga fortuna nella edizione americana, alla quale fu aggiunto un saggio sull’istruzione superiore femminile negli Stati Uniti. In Germania, un decreto del 1878 ammetteva le donne soltanto ad alcuni corsi, lasciando di fatto ai docenti la possibilità di decidere sulla loro ammissione caso per caso.34 28. M. G. Brock, M. C. Curthoys (eds.), Nineteenth-Century Oxford, Part 2, The History of the University of Oxford, v. 7, Clarendon press, Oxford, 2000, cap. 10, “The Women’s colleges”. 29. C. N. L. Brooke, A History of The University of Cambridge, 1870-1990, v. 4, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 324-330 e R. McWilliams Tullberg, Women at Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 30. Mazón, Gender and the modern research university, cit., p. 54. 31. N. Tikhonov, “Student migrations and the feminisation of European universities”, in Clio. Actes de l’histoire de l’immigration, 2002 (http://barthes.ens.fr/clio/revues/AHI/ articles/preprints/tiko.html). 32. Il caso più noto è quello di Sofja Kovalevskaja. Si veda S. Kovalevskaja, Memorie d’infanzia, introduzione di L. Guidotti, Bologna, Pendragon, 2000. 33. Lej si laureò a 24 anni, ma la sua vita si concluse tragicamente con un suicidio. D. Gouzévitch, I. Gouzévitch, “The difficult challenger of no man’s land or the Russian road to the professionalization of women’s engineering (1850-1920)”, in Quaderns d’Historia de l’Hinginyeria, iv, 2000, p. 193. 34. Lange, Higher education of women in Europe, cit., p. 117. Su Lange esiste una vasta letteratura, rimando al recente C. Dollard, “Sharpening the “Wooden Sword” in Imperial DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 249 Il paese dove le donne avevano raggiunto i risultati più incoraggianti su questo fronte – la nazione cui i sostenitori del diritto delle donne all’istruzione superiore guardavano come a un ideale cui ispirarsi, anche dall’Italia 35 – erano gli Stati Uniti. Già dagli anni Trenta dell’Ottocento le americane disponevano sia di college femminili, a partire dal Mount Holyoke College (allora denominato Mount Holyoke Female Seminary), fondato da Mary Lyon, sia di college basati sulla coeducazione, come Oberlin College, fondato da John Jay Shipherd, istituzioni dove la scienza era posta con enfasi al centro del curricolo di studi. Ma gli anni d’oro furono gli anni Sessanta e Settanta, quando le donne cominciarono ad essere ammesse nei college maschili, furono fondate istituzioni basate sul principio della coeducazione come la Cornell University (1865) e vennero inaugurati college femminili straordinari come il Vassar a Yale (1865), il Wellesley a Boston (1875) e il Radcliffe ad Harvard (1879). Così, come già accennato, secondo i dati forniti dall’Annual report of the Commissioner of Education nel 1888 negli Stati Uniti, le donne erano il 29,3% della popolazione studentesca di livello universitario.36 In Italia, dalla fine degli anni Settanta, qualche rarissima giovane cominciò ad avvicinarsi all’università, forse incoraggiata dal nuovo regolamento del 1876,37 che specificava che alle donne era consentito iscriversi all’università, senza che per altro, come si è detto, ci fosse mai stato il divieto. In ogni caso, ebbero certamente un ruolo nell’attirare le giovani agli studi superiori i dibattiti nazionali e internazionali sui diGermany: Marital status and education in the work of Helene Lange”, in Women’s History Review, 13, 3, 2004, pp. 447-466. Su donne e istruzione superiore in Germania, si veda Mazón, Gender and the modern research university. The admission of women to German higher education, 1865-1914, cit. 35. Furlani, L’educazione della donna presso i popoli più civili, cit. 36. Lange, Higher education of women in Europe, cit., p. xxiv. I dati sugli Stati Uniti sono riportati nel libro di Lange nella introduzione, curata da L. R. Klemm. Ma naturalmente si veda anche Rossiter, Women scientists in America. Struggles and strategies to 1940, cit. Sull’accesso delle donne all’università e al sapere scientifico, si veda Noble, Un mondo senza donne, cit., il cap. 10, “Le donne in un mondo senza donne”. La tesi di Noble, che suggerisce un forte legame tra le grandi riforme educative e i movimenti religiosi (o antireligiosi), mi pare si possa applicare anche al contesto italiano postunitario. Qui le élite liberali, spesso fortemente anticlericali, dimostrarono in diversi casi una particolare apertura nei confronti delle donne e della loro istruzione. Si tratta di un tema di straordinario interesse che andrebbe approfondito con nuove ricerche. 37. Nel nuovo regolamento si legge: “Le donne possono essere iscritte nel registro degli studenti e degli uditori, ove presentino i documenti richiesti.” In “Nuovi regolamenti Universitari”, BUMPI, 1876, v. II, n. XII, gennaio 1876, p. 12. Quello stesso anno nella sezione Istruzione superiore del Bollettino, compariva il primo nome di una studentessa, Emma Colombini nella sezione “Posti di studio, assegni e sussidî universitari”, “Un sussidio agli studenti poveri dell’Università di Modena” (BUMPI, maggio 1876, vol. II, n. V, p. 368). 250 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE ritti delle donne 38 e le cronache che riportavano – come nel caso ricordato della Nuova Antologia – quanto accadeva oltralpe. Furono quegli stimoli, con tutta probabilità, a dare alle prime studentesse il coraggio di entrare in un mondo interamente di uomini, a costo di farsi accompagnare a tutte lezioni dalla madre, come fece Cornelia Fabri, laureatasi in matematica nel 1891;39 una condizione, d’altra parte, che condividevano con le inglesi.40 Ma chi furono le prime laureate in Italia? Con che diploma si erano iscritte all’università? Quali le facoltà scelte e che cosa fecero in seguito della laurea? Come accennato, nel 1902 il Bollettino pubblicava i nomi delle prime 224 laureate, “donne italiane le quali […] seppero raggiungere quell’alto grado di coltura che le dimostra atte a gareggiare coll’uomo in ogni ramo del sapere.”41 Non si trattava, a dire il vero, soltanto di italiane, almeno una dozzina erano straniere: Ernestina Paper, Anna Kuliscioff, Livia o Lidia Pöet (la prima laureata in giurisprudenza nel 1881), Margherita Traube (erroneamente Traub nel Bollettino), le sorelle Giulia Sofia e Maria (Marussia) Bakunin, Maria Fischmann e altre ancora. Molte di quelle prime laureate conseguirono più di una laurea: 29 si laurearono sia in lettere sia in filosofia, una si laureò sia in medicina sia in scienze naturali, una sia in matematica sia in scienze, una, infine, conseguì tre lauree, in giurisprudenza, in lettere e in filosofia. Le lauree in discipline scientifiche furono 73: di cui 27 in scienze naturali, 22 in medicina, 19 in matematica, 2 in fisica, 2 in chimica, 1 in “chimica e farmacia”. Di quelle laureate, 202 si erano iscritte all’università con la licenza liceale, ma 20 avevano frequentato altre scuole, ragione per la quale in al38. F. Pieroni Bortolotti, Alle origini del movimento femminile in Italia, Torino, Einaudi 1975 (1 ed.1963) e Id., Alle origini della questione femminile in Italia 1848 - 1892, Torino, Einaudi, 1975. La storia delle donne in Italia vanta un’importante tradizione e per ragioni di spazio in questo saggio non posso che rimandare ad alcuni dei saggi collettanei più recenti e alle loro ricche bibliografie: S. Bellassai, M. Malatesta (a cura di), Genere e mascolinità. Uno sguardo storico, Roma, Bulzoni, 2000, in particolare il saggio di Maura Palazzi; P. Di Cori, D. Barazzetti (a cura di), Gli studi delle donne in Italia. Una guida critica, Roma, Carocci, 2001; A. Rossi-Doria (a cura di), A che punto è la storia delle donne in Italia, Viella, Roma, 2003; M. Palazzi, I. Porciani, (a cura di), Storiche di ieri e di oggi. Dalle autrici dell’Ottocento alle riviste di storia delle donne, Viella, Roma, 2004 e M. Malatesta, Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell’Europa contemporanea, Einaudi, Torino, 2006, il cap. VI, “Donne e uomini nelle professioni”. 39. M. Modoni Georgiou, “Cornelia Fabri, scienziata ravennate”, in Ravenna studi e ricerche, 2, 1997, p. 160. 40. Durante uno dei tentativi – poi fallito – di farsi accettare dalla facoltà di medicina in Scozia, Sophia Jex-Blake si era assicurata la collaborazione delle mogli di alcuni docenti affinché l’accompagnassero alle lezioni. Jex-Blake, Medical women, cit., p. 84. 41. Ravà, “Le laureate in Italia”, cit., p. 641. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 251 cuni casi si dovettero cimentare in complicate sperimentazioni istituzionali per potersi iscrivere all’università. Fu il caso di Evangelina Bottero e Carolina Magistrelli, le prime due laureate in scienze dell’Italia unita che, provenienti la prima da Acqui Terme e la seconda da Mantova, nel 1875 si erano conosciute a Firenze, dove frequentarono la scuola normale e il corso complementare alla scuola normale.42 Mentre si preparavano per diventare maestre, le due scoprirono la loro passione per le scienze naturali ma, ottenuto il diploma, si trovarono naturalmente la porta degli atenei sbarrata. Una scappatoia c’era: farsi accettare come “studenti uditori”. Trasferitesi a Roma, riuscirono nell’impresa e dopo un anno come “uditori”, Bottero e Magistrelli scrissero al ministro dell’istruzione chiedendo di essere ammesse al secondo anno. Ottenuta l’approvazione del ministro, la richiesta passò al rettore della Sapienza che la sottopose al consiglio di facoltà accompagnandola con un suo parere favorevole. Nel gennaio del 1880 il consiglio deliberò a favore dell’iscrizione delle due ragazze al secondo anno di studi, “avendo riguardo alle speciali loro condizioni per gli studi anteriormente compiuti”.43 Nel giugno del 1881, dopo avere realizzato la tesi e altre ricerche sperimentali per le quali avevano ottenuto premi e borse di studio,44 Bottero e Magistrelli si laurearono in scienze naturali.45 Nel 1880 il medesimo consiglio di facoltà aveva accolto la domanda presentata a nome di Margherita Traube da Stanislao Cannizzaro.46 In quel caso la facoltà decretò d’ufficio che era possibile “riguardare come equipollenti a quelli degli studi tecnici” gli studi fatti dalla donna precedentemente.47 Nel 1883 Traube sarebbe stata la prima laureata – non italiana – in fisica del regno. Più complicate le cose per chi si voleva iscrivere a medicina, come nel caso, noto, di Maria Mon42. Bottero e Magistrelli sono nell’elenco delle studentesse allegato a G. F. Airoli, L’Istituto Superiore Femminile di Magistero in Firenze dall’a.s. 1883-84 al 1885-86, Tip. Coop., Firenze, 1886, pp. 33-37. 43. “Registro dei verbali della Facoltà di scienze fisico-matematiche e naturali, Copie autentiche, titolo IV, posiz. 3°”, Archivio generale studenti, Università di Roma, La Sapienza, p. 129. 44. BUMPI, aprile 1880, v. VI, n. IV, p. 344. 45. Fascicoli personali di Evangelina Bottero Pagano (AS2630) e Carolina Magistrelli Sprega (AS715), Archivio generale studenti, Università di Roma, La Sapienza. 46. Traube era vedova di tal prof. Böll; in seguito sposerà Guglielmo Mengarini, fisico presso la stessa facoltà di scienze di Roma. Con il nome Margherita Mengarini, Traube è elencata tra i corrispondenti di Eugenie Strong, dove viene identificata come sorella del prof. Traube (Girton College Archive, Cambridge, Personal Papers of Eugenie Strong, GCPP Strong). 47. “Registro dei verbali della Facoltà di scienze fisico-matematiche e naturali”, cit., p. 138. 252 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE tessori. Con un diploma di scuola tecnica e a digiuno di latino e greco, Montessori poté però iscriversi a scienze naturali. Dopo avere superato gli esami del biennio, identici nelle due facoltà, ottenne il trasferimento alla facoltà di medicina.48 Per quanto concerne gli studi coltivati dalle prime 224 laureate, come ho anticipato esse non scelsero solo le lettere o la filosofia, ma si diressero decise anche agli studi scientifici e medici. (Fig. 2). 2. Le laureate in Italia per settore, periodo 1877-1900.49 Per le scienze, come per le lettere, la scelta era probabilmente finalizzata in primo luogo all’insegnamento.50 Medicina, invece, era forse la facoltà scelta dalle giovani più decise a imporsi come donne in un mondo di uomini, in Italia come nel resto d’Europa e negli Stati Uniti. Ma 48. Si vedano A. Matellicani, Maria Montessori alla “Sapienza” di Roma, tra didattica e ricerca 1890-91/1918-19, Tesi di laurea in Pedagogia generale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2000-01 e V. P. Babini, L. Lama, Una donna nuova. Il femminismo scientifico di Maria Montessori, Angeli, Milano, 2003. Montessori compare nel Bollettino in diversi luoghi come insegnante di igiene e antropologia presso l’Istituto superiore femminile di magistero di Roma, ma naturalmente anche come libera docente di antropologia presso l’Università di Roma. Note le vicende relative alla libera docenza, cui fu abilitata nel 1905 (BUMIP, a. XXXII, v. I. n. 1, 5 gennaio 1905, p. 20). Sulla organizzazione universitaria nel periodo in esame si veda il saggio di Ariane Dröscher in questo libro. 49. Dati in Ravà, “Le laureate in Italia”, cit. 50. C. F. Ferraris, “Statistiche delle Università e degli Istituti superiori”, in Annali di statistica, v, 6, 1913, p. xvi. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 253 l’opposizione del mondo medico fu anche la più difficile da superare, ovunque. Nel 1893 Paolo Mantegazza, antropologo e medico – che oggi definiremmo razzista e sessista e che in quegli anni godeva di una vasta fama nazionale e internazionale –, era il portavoce di un pensiero diffuso circa le – “scientifiche” – ragioni che erano all’origine del divieto alle donne di esercitare molte professioni, in primo luogo l’avvocatura, a causa della loro “inferiorità intellettuale, […] timidezza […] grande impressionabilità” e così via. Nel suo stile, tuttavia, Mantegazza denunciava anche il “pregiudizio beota contro la medicina esercitata dalle donne, mentre l’America, l’Inghilterra, la Francia e perfino la Russia contano a cento a cento brave dottoresse”.51 In realtà, l’avventura delle donne nel mondo della medicina non fu facile in nessun paese, come testimoniano le vicende di Elisabeth Blackwell, Elisabeth Garrett e Sophia Jex-Blake.52 Circa l’Italia, la testimonianza di una di quelle prime dottoresse può essere utile. Nel 1891 scriveva a Critica Sociale un lettore sorpreso nello scoprirsi lui, “un grasso borghese”, più interessato “delle questioni che riguardano la donna” del periodico socialista. Filippo Turati affidò la risposta a Anna Kuliscioff la quale, d’accordo con il lettore circa il poco spazio dedicato alle donne dal giornale, offriva uno squarcio interessante dei cambiamenti in atto nei rapporti tra donne e sfera pubblica alla fine del secolo. Scriveva Kuliscioff in una pagina famosa: La stessa grande industria poi ebbe i suoi benefici effetti non soltanto sulla donna del proletariato, ma ben anche nelle classi medie. Queste povere classi medie, che vanno in malora di giorno in giorno hanno pure figliole da collocare e queste figliole, senza dote e senza blasone, non possono neppure sognare un modesto matrimonio e sono spinte, volere o no, ad invadere il campo professionale: maestre, che crescono come funghi, telegrafiste, telefoniste, impiegate postali, ragioniere, medichesse, avvocatesse, che vengono osteggiate, respinte, derise e devono raccomandarsi a tutti i santi moderni, che si 51. P. Mantegazza, Fisiologia della donna, Bietti, Milano, 1932, X (1° ed. Treves, Milano, 1893), cit. p. 326 e p. 292. Su questo autore e la sua immagine della donna, si vedano A. Rossi-Doria, Antisemitismo e antifemminismo nella cultura positivistica, in A. Burgio, (a cura di), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870-1945, il Mulino, Bologna, 1999, pp. 455-73 e P. Govoni, Un pubblico per la scienza. La divulgazione scientifica nell’Italia in formazione, Carocci, Roma, 2002, cap. 5. In magistratura il divieto alle donne di partecipare ai concorsi rimarrà fino al 1963. G. Di Federico, A. Negrini, “Le donne nella magistratura ordinaria” in Polis, 2, 1989, pp. 179-223. 52. Si vedano S. Roberts, Sophia Jex-Blake. A woman pioneer in nineteenth-century medical reform, Routledge, London, 1993; E. S. More, Restoring the balance. Women physicians and the profession of medicine, 1850-1995, Cambridge, Harvard University Press, 1999; J. Boyd, The excellent doctor Blackwell. The life of the first woman physician, Sutton, Phonix Mill, 2005. 254 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE chiamano uguaglianza e libertà, per poter vivere modestamente e bastare a sé stesse.53 L’immagine fornita da Anna Kuliscioff, come spesso accade, era ispirata dalla sua esperienza personale. Nata in Crimea, Kuliscioff si era iscritta a medicina presso l’Università di Berna nel 1883, quindi nel 1884 si era trasferita all’Università di Napoli. Nel corso del 1885 – con risultati non particolarmente lusinghieri, pare – condusse le sue ricerche per la tesi di laurea sull’eziologia della febbre puerperale nel laboratorio pavese di patologia sperimentale di Camillo Golgi. Quindi tornò a Napoli, dove si laureò nell’anno accademico 1886-87.54 Appena laureata Anna Kuliscioff fu effettivamente una delle medichesse “derise” di cui scriveva nell’articolo sulla Critica Sociale. Trasferitasi a Milano aveva tentato la carriera ospedaliera, ma la possibilità le fu negata e lei optò, con successo, per la pratica privata della medicina. Kuliscioff descriveva dunque sulla base della propria esperienza le difficili condizioni delle prime donne scese in campo a competere con gli uomini in settori qualificati, come la medicina o l’avvocatura. Tuttavia si dimostrava ottimista, non tanto a proposito del numero di maestre, telegrafiste e telefoniste, davvero numerose in quell’ultimo decennio del secolo, ma circa il numero di medichesse e avvocatesse. Nel 1891 le laureate in medicina in Italia erano 6, compresa Kuliscioff. Per non parlare delle “avvocatesse”: nel 1891 vi era soltanto una laureata in giurisprudenza, la già menzionata Pöet.55 Nel 1916, venticinque anni dopo l’intervento di Kuliscioff, Virginia Treves Tedeschi, tra gli anni Ottanta dell’Ottocento fino agli anni Venti del Novecento nota con lo pseudonimo di Cordelia, autrice e giornalista di enorme successo, ma anche editore di grande abilità, in un suo 53. A. Kuliscioff, “Il sentimento nella questione femminile”, in Critica Sociale, II, 9, 1 maggio 1892, pp. 142-143. 54. L. Belloni, “Anna Kuliscioff, allieva del Cantani e del Golgi e le sue ricerche sulla etiologia della febbre puerperale”, in Physis, 20, 1-4, 1978, pp. 337-348. Ravà riporta come data di laurea di Kuliscioff il 1885, ma Belloni sostiene che la laurea fu conseguita nell’anno accademico 1886-87, in data da verificare. Sulla vita e l’attività politica di Anna Kuliscioff non posso che rimandare alle migliori basi di dati, come per esempio Lilith (http:/ /www.retelilith.it/). 55. Pöet – riportata con il nome “Livia” in Ravà – aveva conseguito la laurea nel 1881 a Torino, si veda Ravà, “Le laureate in Italia”, cit., p. 650. La seconda laureata in giurisprudenza sarebbe stata, nel 1894, Teresa Labriola. Figlia di Antonio, Teresa Labriola fu femminista e impegnata politicamente (finì per aderire al fascismo) e fu attiva nel campo dei diritti delle donne. Nel 1900 divenne libera docente in filosofia del diritto presso l’Università di Roma (BUMIP, anno XXVII, v. 2, numero 49, 6 dicembre 1900, p. 2054). DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 255 libro dedicato a Il lavoro delle donne, affermava: “Una delle facoltà più frequentate dalle donne nelle Università è quella della medicina; ciò che dà argomento nei giornali e in società a serie discussioni sulla donna medichessa”.56 Eppure, quando Virginia Tedeschi scriveva di donne medichesse (oltre che di impiegate, telefoniste e insegnanti, in tutto due milioni di lavoratrici secondo i suoi dati),57 le iscritte a medicina, in tutta Italia, erano 93.58 Come dimostrano le testimonianze di Anna Kuliscioff e Virginia Tedeschi Treves, ma anche gli interventi su giornali come La donna, la gloriosa testata fondata e diretta da Gualberta Alaide Beccàri, i periodici specialistici dedicati all’università e i giornali locali, la stampa prese a commentare ogni nuovo successo conseguito dalle donne in campo universitario e professionale. Anche la meno impegnata Cordelia, la testata a lungo diretta da Ida Baccini, pubblicava notizie sulle studentesse, magari dando spazio a raccontini edulcorati e incoraggianti, come quello del 1887 in cui si descriveva la vita di un’immaginaria, unica “studentina” dell’Università di Padova.59 Sfogliando la pubblicistica del periodo 1890-1915, insomma, si può avere la sensazione che, come scriveva Kuliscioff nel 1891 e come confermava Tedeschi Treves nel 1916, schiere di neo laureate si stessero riversando sul mercato italiano del lavoro. I dati, si è visto, smentiscono quell’immagine giornalistica. Le 56. Cordelia, Le donne che lavorano, Treves, Milano, 1916, p. 103. Su questa interessante figura si veda V. Afflerbach, Cordelia e il suo mondo. Vita, opere e traguardi di Virginia Treves - una scrittrice di fine Ottocento tra il romanzo rosa ed il femminismo, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2000. Circa il lavoro femminile: A. Groppi (a cura di), Il lavoro delle donne, Roma-Bari, Laterza, 1996; M. Palazzi, Donne sole. Storia dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime e età contemporanea, B. Mondatori, Milano, 1997; C. Giorgi, G. Melis, A. Varni (a cura di), L’altra metà dell’impiego. La storia delle donne nell’amministrazione, Bononia university press, Bologna, 2005. 57. Cordelia, Le donne che lavorano, cit., p. 7. 58. Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica, Gli studenti delle università italiane. Indagini statistiche, Supplemento al n. 59 del 31 dic. 1923, Tip. Operaia romana coop., Roma, 1923, p. 205. Il dato si riferisce all’anno accademico 1914-15. 59. Donnina, “All’Università”, in Cordelia, IV, 12, 13 marzo 1887, pp. 155-157. Innumerevoli gli interventi del periodico La donna. I giornali specialistici commentarono i dati pubblicati da Ravà (si veda per esempio, E. Gurrieri Norsa, “Le laureate in Italia”, in L’università italiana, 14-15, 15 ottobre 1902, p. 182.) e anche i giornali locali riportavano i successi delle concittadine laureate (per esempio, circa Evangelina Bottero si veda La Gazzetta D’Acqui, 21-22 marzo 1883; circa Amalia Moretti Foggia, si veda La gazzetta di Mantova, 22-23 novembre 1898). Poteva accadere, naturalmente, che i giornali criticassero il fenomeno delle donne all’università come fece un quotidiano bolognese che definì il fenomeno come un “andare a rovescio da ciò che stabilito da madre natura” (Il Resto del Carlino, 23 aprile 1902, cit. in Cammelli, Scalone, “Donne, università e professioni. Il caso dell’ateneo bolognese alla fine dell’Ottocento”, cit., p. 75). 256 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE poche laureate in un quarto di secolo, incarnazione peninsulare della new woman di modello inglese e nordamericano, donne che con la conquista dell’istruzione superiore cominciavano a guadagnarsi un ruolo economicamente attivo in famiglia e nella società,60 non potevano costituire una concorrenza reale per gli uomini.61 Tra quanto discusso “nei giornali e in società” e la realtà del paese, correva un abisso che sfuggiva a donne di pari lucidità e successo professionale e che osservavano i cambiamenti sociali in atto in Italia da opposte sponde politiche, come Anna Kuliscioff e Virginia Tedeschi Treves. Chi si occupa di storia sociale della scienza ed è abituato, come chi scrive, a sondare le reazioni della cosiddetta sfera pubblica attraverso le testimonianze rintracciate nei periodici e nella produzione editoriale, trova in un’analisi come quella qui tentata, conferme dell’importanza di punti di riferimento quantitativi quando si affrontano temi poco sondati dalla storiografia. L’enfasi data al fenomeno delle laureate nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento in alcuni giornali e periodici, aveva a che fare più con quanto si auspicava per l’Italia, magari osservando quanto accadeva oltralpe e oltre oceano, che con la realtà di ristrettissime cerchie di studentesse e laureate. La storia quantitativa qui tentata ci aiuta a dare al fenomeno dell’accesso delle donne all’università in Italia confini realistici e concreti che autorizzano in particolare ad apprezzare quelle prime 72 laureate in discipline scientifiche come delle vere e proprie sperimentatrici sociali. Esordi di carriera Vediamo ora un poco più in dettaglio chi furono quelle prime laureate in scienze e medicina.62 60. C. Christensen Nelson (ed.), A new woman reader, Broadview Press, Peterborough, 2000 e S. Rowbotham, A century of women. The history of women in Britain and the United States, Penguin Books, London, 1999. 61. Si tratta naturalmente di un problema aperto e che andrebbe affrontato con una ricerca ad hoc che tenesse conto dei dati della storia economica. Tuttavia, i casi delle prime laureate visti fin’ora e in particolare il successo avuto come medici privati dalle prime dottoresse sembrerebbe smentire l’idea di una disoccupazione intellettuale tra le donne con un’istruzione superiore, come sostenuto nell’importante M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, Bologna, il Mulino 1974. 62. A più di cento anni dalla pubblicazione del rapporto dell’ingegnere Ravà, ho deciso di riproporre qui tutti i loro nomi. Per ragioni di spazio non mi sarà possibile riportare tutte le informazioni reperirete, ma soltanto quelle trovate nel Bollettino o in altri DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 257 La prima fu Ernestina Paper, originaria di Peretz, vicino a Odessa. Laureatasi in medicina a Firenze nel 1877, dopo avere iniziato gli studi a Pisa, Paper “ottenne la matricola di libero esercizio in Firenze”63 . Nel 1878 pubblicò su La nazione un annuncio in cui segnalava l’apertura di uno studio dove avrebbe praticato come medico “delle donne e bambini”.64 Come andarono gli affari e chi furono i pazienti è tutto da scoprire. Anche la seconda laureata, Maria Farné Velleda, conseguì la laurea in medicina, a Torino nel 1878. Nel 1879 fu registrata una laurea in lettere, poi un vuoto fino al 1881, quando si laurearono Evangelina Bottero e Carolina Magistrelli, le prime laureate in scienze, già ricordate. Dopo avere scritto e pubblicato insieme un manuale sul telefono, con la prefazione del fisico Pietro Blaserna con il quale avevano studiato,65 nel 1882 Bottero e Magistrelli furono assunte dall’appena inaugurato Istituto superiore femminile di magistero di Roma.66 Qui insegnarono fino al 1922, Bottero fisica e Magistrelli – che pubblicherà altri manuali scientifici e fu anche direttrice dell’Istituto – scienze naturali, ma per un certo periodo anche igiene e antropologia, supplendo Maria Montessori.67 Nel 1882 risultano essersi laureate due donne in lettere e nel 1883 una in scienze, Margherita Traube, di cui si è detto. Nel 1884 si laureò una sola donna, Giuseppina Cattani, in medicina, prima donna ad avere documenti d’archivio. Si tratta di informazioni largamente lacunose, ma che mi auguro possano costituire la piattaforma di partenza per nuove ricerche, tesi di laurea e di dottorato. 63. Informazioni nella risposta del rettore di Pisa al Ministero in relazione al numero delle iscritte (zero) e delle laureate (solo Paper), presso l’ateneo pisano. “Statistiche delle donne che frequentano le università”, ACS, Divisione istruzione superiore, 1883, Busta 58. Di Paper conosciamo quanto ricostruito nel saggio di Marino Raicich, ma la ricerca (non solo su Paper) si è fermata con quelle pagine. Raicich, Liceo, Università, professioni, cit. 64. La nazione, mercoledì 6-7 marzo 1878, p. 3. 65. E. Bottero, C. Magistrelli, Il telefono, con pref. del prof. P. Blaserna, 39 fig. intercalate nel testo, Loescher, Torino, 1883. 66. Su questo Istituto di straordinario interesse si veda Pesci, Pedagogia capitolina, cit. Si veda inoltre, G. Di Bello, A. Mannucci, A. Santoni Rugiu (a cura di), Documenti e ricerche per la storia del magistero, L. Manzuoli ed., Firenze, 1980. 67. La loro presenza nel Bollettino è per questa ragione molto frequente e non potrò citare qui i numerosi luoghi dove sono registrati i loro avanzamenti di carriera. Sulle vicende intellettuali e professionali di Bottero e Magistrelli ho in corso di pubblicazione un articolo dal titolo, “Le donne e la scienza in Italia tra età liberale e fascismo: Il caso Bottero & Magistrelli”, di prossima pubblicazione in un numero speciale della rivista Genesis, curato da Teresa Bertolotti e Maria Pia Casalena, dal titolo Tra le righe. Donne e mediazione culturale nell’Italia contemporanea (1880-1960). 258 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE avuto un posto di lavoro nell’università italiana,68 che attende ancora una biografia.69 La carriera di Cattani iniziò appena laureata, come assistente di laboratorio,70 quindi beneficiò di un assegno per “posti di studio”,71 confermato nel 1886,72 fino a che, nel maggio 1887, “fu abilitata per titoli alla libera docenza con effetti legali in patologia generale presso la regia università di Torino”.73 Nel dicembre del 1888 Cattani fu nominata assistente presso il gabinetto di patologia generale dell’Università di Bologna.74 Per una decina d’anni s’impegnò in ricerche di laboratorio sul sistema nervoso e nel 1887 tentò senza successo un concorso da professore ordinario.75 Resasi conto che per lei non c’erano possibilità di carriera adeguate alle sue ambizioni, nel dicembre del 1894 Cattani lasciò l’Università di Bologna76 per accettare l’offerta di dirigere il gabinetto di radiologia e la sezione di anatomia patologica e batteriologica dell’Ospedale di Imola. Di Giuseppina Cattani si segnalano le ricerche nel campo della microspia e in particolare quelle sul tetano e i 68. Giuseppina Cattani è segnalata una prima volta nel Bollettino (insieme a Gustavo Pisenti) come “allievo provvisorio nel gabinetto di patologia generale, Bologna” (BUMPI, febbraio 1884, v. X, n. II, p. 63). 69. Su Cattani, così come su altre studentesse e docenti dell’ateneo bolognese, si veda Alma Mater Studiorum. La presenza femminile dal XVIII al XX secolo. Ricerche sul rapporto donna/cultura universitaria nell’ateneo bolognese, Clueb, Bologna, 1988. Ringrazio Roberta Passione per avermi fatto leggere un suo scritto inedito dal titolo, Medical research and women’s emancipation: The case of Giuseppina Cattani. 70. BUMPI, gennaio 1885, v. XI, n 1, p. 44. Con decreti ministeriali 22, 24, 26 dicembre 1884 “Cattani, Giuseppina fu nominata assistente al gabinetto di patologia generale nell’Università di Bologna”. 71. Ibid., dicembre 1885, v. XI, n. XII, p, 1070. “Con decreto 18 dicembre 1885” si legge che “Furono conseguiti per concorso posti di studio di perfezionamento all’interno” tra i quali, per “la medicina e la chirurgia” a Cattani. 72. Ibid., ottobre 1886, v. XII, n. XII, p. 1362. Quell’anno lo stesso tipo di assegno fu conferito anche a Maria Sacchi. 73. BUI, maggio 1887, v. XIII, fasc. II, p. 258. La nomina avvenne con decreto 5 maggio 1887. 74. Ibid., dicembre 1888, v. XIV, n. XII, fasc. II, p. 240. Il decreto di trasferimento da Torino a Bologna è registrato in BUI, 5 gennaio 1889, a. XVII, n. 1, p. 19. Successive conferme di nomina in BUMIP, a. XVIII, parte III, n. 16, 11 novembre 1891; ibid., a. XIX, parte II, n. 31, 3 agosto 1892, p. 1308; ibid., a. XXII, v. I, n. 3, 17 gennaio 1895, p. 71 (stipendio 1.320 lire). 75. Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, anno 1887, sabato 30 aprile, num. 10, p. 2424. Il concorso bandiva un posto da professore ordinario. La commissione, non giudicando nessuno degli otto candidati all’altezza del posto a concorso, promosse professore straordinario Antonino Rossi-Giliberti. 76. BUMIP, a. XXII, v. I, n.3, 17 gennaio 1895, p. 71. Con decreto 28 novembre 1894 si confermava Cattani nel ruolo di assistente presso il gabinetto di patologia generale per un altro anno, ma nella pagina successiva (ibid., p. 72) con decreto 1° dicembre 1894 era accettata la rinuncia di Giuseppina Cattani, sostituta con il medesimo stipendio dal dott. Alessandro Bruschettini. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 259 suoi rapporti con Camillo Golgi, commissario nel concorso tentato e perso nel 1887. Ma è soprattutto il lavoro presso l’Ospedale di Imola che attende di essere ricostruito, un’attività in cui anni di ricerca scientifica si fusero con un impegno professionale dando vita a una combinazione rara per una donna in quegli anni in Europa. Nel 1885 si laureano, secondo i dati del Bollettino, cinque donne, tre in lettere e due in discipline scientifiche: Kuliscioff, di cui si è detto, e Maria Sacchi, in storia naturale all’Università di Pavia.77 Nessuna donna si laureò nel 1886 e nel 1887 soltanto Iginia Massarini, che conseguì la laurea in matematica a Napoli. Nel febbraio del 1884, Massarini aveva vinto, ironia della sorte insieme con Gino Loria – più tardi assertore dell’impossibilità per le donne di occuparsi seriamente di matematica – ,78 una borsa di studio di 800 lire che le consentì di continuare gli studi.79 Dopo un tentativo fallito di insegnare cosmografia presso l’Istituto superiore femminile di magistero di Roma, Iginia Massarini insegnò presso una scuola tecnica.80 Nel 1888 furono tre le donne che conseguirono la laurea, in lettere.81 Nel 1889 una sola laurea in medicina, quella di Maria Babacci a Bologna, mentre nel 1890 vi furono due laureate, una fu Edvige Benigni, in medicina a Roma. Nella sua tesi su “Diagnosi e trattamento chirurgico dei tumori solidi della mammella nella donna”, Babacci, come altre studentesse di medicina, dimostrava un interesse particolare per le patologie femminili 82 e, come molti scienziati dell’epoca, per argomenti come 77. Ancora studentessa, Sacchi era stata “assistente provvisoria” presso l’orto botanico universitario (“Con lettera ministeriale 22 novembre 1884”, in BUMPI, dicembre 1884, v. X, n. XII, p. 688). 78. Nel 1901 Loria tenne una conferenza dal titolo “Donne matematiche”, dove sosteneva l’impossibilità per le donne di occuparsi seriamente di scienza. Si veda G. Loria, Donne matematiche. Lettura tenuta nella grande aula della R. Accademia Virgiliana di Mantova la sera del 27 dicembre 1901, Mantova, 1902. 79. Borsa confermata nel luglio di quello stesso anno “per studi di perfezionamento” (BUMPI, febbraio 1884, v. X, n. II, p. 69 e ibid., luglio 1884, v. X, n. VII, p. 269). 80. Informazioni tratte da una lettera inviata da Iginia Massarini al Ministero della pubblica istruzione, 15 novembre 1890, in Divisione istruzione superiore, (1882-1890), B. 955, Ministero pubblica istruzione, ACS. 81. Una delle laureate fu Teresa Lessona, che studiò con Arturo Graf a Torino. Figlia di Adele Masi, divulgatrice scientifica e traduttrice di alcune delle opere di Charles Darwin, e del naturalista e divulgatore Michele Lessona, Teresa Lessona fu insegnante di storia e geografia e preside della Scuola normale di Mondovì. Sul laboratorio editoriale dei Lessona si veda Govoni, Un pubblico per la scienza, cit., cap. 4. 82. Fascicolo personale di Maria Babacci, Posizione 186 no. 68 del Registro dell’Immatricolazione e della carriera scolastica, Facoltà di medicina e chirurgia, Archivio storico, Università di Bologna. 260 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE la psicologia sperimentale positiva o un misterioso “materialismo spirituale”.83 Nel 1891 furono sei le donne che si laurearono e tra loro, in matematica a Pisa, la già ricordata Cornelia Fabri. Fabri fu incoraggiata agli studi dal padre Ruggero che, laureato in scienze fisiche e matematiche alla Sapienza, dopo una breve parentesi come assistente nell’ateneo romano, era ritornato a Ravenna, sua città di origine, dove ricoprì incarichi amministrativi. Ruggero Fabri continuò tuttavia a coltivare i propri interessi scientifici, in particolare nel campo dell’elettricità, e fu in contatto, tra gli altri, con Vito Volterra. Questa la ragione, forse, per la quale decise di iscrivere a Pisa, e non nella più vicina Bologna, la figlia Cornelia, che fin da piccola aveva dimostrato un forte interesse per lo studio e, in particolare, per la matematica. Cornelia Fabri fu dunque allieva di Vito Volterra e anche all’università, come già in precedenza a scuola, si confermò una studentessa particolarmente brillante. Dopo la laurea, ottenuta con il massimo dei voti e la lode, Cornelia Fabri rientrò a Ravenna dove non svolse mai una professione. Profondamente religiosa e mai sposatasi, pubblicò alcuni articoli specialistici e per qualche tempo continuò a occuparsi di matematica e di fisica.84 Nel 1892 furono dieci, secondo i dati forniti dal Bollettino, le donne che conseguirono una laurea, tra le quali Rina Monti in storia naturale a Pavia, Giuseppina Cinque in medicina a Palermo e Ida Terracini in matematica a Torino. Cinque e Terracini non sembrano aver lasciato tracce nel Bollettino, mentre ve ne sono numerose di Monti, nel 1902 libera docente di anatomia e fisiologia comparata e assistente nel gabinetto omonimo dell’ateneo pavese, dove sono conservate alcune sue carte. Rina Monti nel 1911 divenne professore ordinario: la prima donna in quel ruolo in Italia.85 Eppure, anche la vita e le opere di questa 83. E. Benigni, Materialismo spirituale,Tip. di G. Balbi, Roma, 1898 e Id., Elementi di psicologia sperimentale positiva, Roux e Viarengo, Torino, 1900. 84. Di Cornelia Fabri Volterra ebbe a dire: “Conservo vivissima memoria della signorina Cornelia Fabri […] la prima, e forse la migliore, fra le molte allieve che ebbi in seguito a Torino e a Roma. Ricordo che il suo esame di laurea fu un avvenimento per l’Università di Pisa, non solo perché per la prima volta veniva ivi ad addottorarsi una donna, ma anche perché la prova fu sostenuta in modo ammirevole dalla candidata, che riportò i pieni voti assoluti e la lode”. La dichiarazione di Volterra è riportata in G. Mesini, In Memoria di Cornelia Fabri, Arti Grafiche, Ravenna, 1925, p. 9, cit. in F. Toscano, “Cornelia Fabri” in F. Gàbici, F. Toscano, Scienziati di Romagna, Sironi, Milano, 2006, pp. 213. In quella stessa sessione di laurea discusse la tesi anche Federigo Enriques. Per un elenco delle opere scientifiche di Cornelia Fabri, si veda Toscano, “Cornelia Fabri”, cit. 85. BUMIP, a. XXXVIII, v. II, n. 32, 27 luglio 1911, p. 2644, dove si legge: “Monti dott. Rina, professoressa straordinaria stabile di zoologia, anatomia e fisiologia comparate, è DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 261 scienziata, che fu direttrice del laboratorio annesso alla cattedra di anatomia comparata, prima a Sassari poi, dal 1914, a Pavia, attendono di essere ricostruite.86 Nel 1893 le lauree conseguite da donne risultano 16, di cui tre seconde lauree in lettere o filosofia. Le laureate in discipline scientifiche furono quattro: Costantina Levi in matematica a Torino, Giulia Sofia Bakunin in medicina a Napoli, Taliana Wedenissow (così riferiva il Bollettino, il nome esatto era Tatiana Wedenison) in storia naturale a Pavia e Maria Fischmann, in medicina a Pisa. Tatiana Wedenison era stata la prima iscritta – nel 1888 – al Politecnico di Milano, dove aveva iniziato a frequentare la sezione speciale, detta “normale”, di scienze naturali: un indirizzo di studi pensato per formare gli insegnanti di discipline scientifiche nelle scuole superiori. Quindi si era trasferita a Pavia, dove conseguì la laurea in scienze naturali.87 Giulia Sofia Bakunin era figlia di Michail Aleksandrovic, il rivoluzionario russo, e di Antossia Kwrathovoska che, alla morte del marito, si trasferì a Napoli dove fece studiare le figlie, Giulia Sofia e Maria, di cui si dirà. Non ho trovato notizie di un’attività scientifica o professionale di Giulia Sofia Bakunin, né delle altre laureate nel 1893, ad eccezione di Fischmann. Originaria di Odessa, Maria Fischmann era arrivata a Pisa dopo avere studiato nelle università di Zurigo e Berna. Laureatasi in ostetricia fu per un breve periodo “assistente volontaria” nell’istituto di clinica chirurgica dell’Università di Pisa e, con il nome da coniugata di Maria Di Vestea, fu attiva promossa al grado di ordinario della stessa disciplina con lo stipendio di L. 7.000, a decorrere dal 1° luglio 1911”. La sede della cattedra era Sassari. Le carte di Rina Monti Stella, relative al periodo 1915-1924, sono conservate presso l’Archivio storico del Dipartimento di biologia dell’Università di Pavia. 86. “Con RD 31 dicembre 1914, registrato alla Corte dei Conti addì 25 gennaio 1915, Monti prof. Rina, ordinario di zoologia, anatomia e fisiologia comparata e direttrice del gabinetto annesso alla cattedra, nella R. Università di Sassari, è trasferita col suo consenso alla cattedra della stessa disciplina nella R. Università di Pavia e nominata direttrice del gabinetto annesso alla cattedra, conservando il grado, lo stipendio e l’assegno di cui è provveduta, dal 1° gennaio 1915”. Nel documento si osservava inoltre “che la Signora Monti nel corso della sua carriera scientifica si è occupata di svariati argomenti di ricerca zoologica (specialmente riguardanti l’istologia del sistema nervoso degli animali inferiori, la isto-fisiologia degli animali ibernati, la biologia degli organismi acquatici) portando in ogni campo un contributo la cui importanza è generalmente riconosciuta” e “Che buona parte dell’opera scientifica della Monti si è svolta nell’Ateneo di Pavia e che ritornandovi quale Direttrice di un laboratorio zoologico Ella potrebbe riprendere e dare maggiore impulso alle sue ricerche di idrologia”. BUMIP, a. XLII, v. I, n. 8, 25 febbraio 1915, p. 406. 87. A. Galbani, “Donne al Politecnico di Milano: studenti e docenti dalle origini al 1950”, in A. Galbani (a cura di), Donne politecniche, Libri Scheiwiller, Milano, 2001, p. 56 e p. 59. 262 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE in campo sociale e politico e divenne nota come divulgatrice di igiene.88 Anche nel 1894 le laureate furono 16, una in giurisprudenza e sei in discipline scientifiche. Le lauree in scienze naturali furono tre, quella di Elisa Gagnatelli a Pavia, di Dina Gereschi a Roma89 e di Elisa Norsa a Bologna. Due le lauree in matematica, quella di Lia Predella a Pavia e di Emma Bortolotti a Bologna,90 e una laurea in medicina, quella di Viola Marcellina Corio a Roma. Ho trovato traccia nel Bollettino di Elisa Norsa che, attiva nel campo dell’istruzione e dell’emancipazione femminili,91 lavorò presso l’ateneo bolognese come assistente nel gabinetto di zoologia dal 1900 al 1910.92 Malata da tempo, nel 1907 era stata persuasa da Carlo Emery, direttore dell’Istituto di zoologia presso cui lavorava, a lasciarsi declassare da assistente a preparatore: il posto di assistente fu dato a Alessandro Ghigi. Ma nel 1909 Norsa subì un incidente d’auto e nel 1910 lasciò il servizio.93 Norsa in ogni caso si era dimostrata dotata di autoironia piuttosto che di quello spirito battagliero femminile tanto temuto negli atenei d’Europa. Commentando i dati sulle prime laureate pubblicati nel Bollettino, si era limitata a sognare “che quando l’istruzione sana e profonda della donna sarà più diffusa e, corrispondentemente, gli uomini saranno psichicamente evoluti in modo da apprezzarla nel suo alto valore, sarà inutile scrivere dei libri come quello di cui parlo in questa Rivista, sott’altra rubrica”.94 Il 88. BUMIP, a. XLII, v. II, n. 37, 16 settembre 1915, p. 2731. Sull’attività politica e sociale di Fischmann, si veda A. Peretti, “Da Odessa a Pisa: una donna medico tra interessi pedagogici, diritti della donna e impegno sociale”, in Fuori dall’ombra. Studi di storia delle donne nella provincia di Pisa (secoli XIX e XX), Studi pisani, 14. 89. Gereschi aveva frequentato il Liceo Mamiani di Roma e nella sua carriera universitaria aveva conseguito buoni e talvolta ottimi voti a esclusione che in fisica sperimentale (18/30). “Registro della carriera scolastica degli studenti e uditori”, v. 3, posizione 714, Archivio generale studenti, Università di Roma, La Sapienza. 90. Fascicolo personale 529 n. 378 del Registro di immatricolazione della carriera scolastica – Facoltà di Scienze matematiche e fisiche naturali, Archivio Storico, Università di Bologna. 91. The World’s Congress of Representative Women, v. 2, Rand McNally, Chicago, 1894, p. 938. 92. BUMIP, a. XXVII, v. II, n. 50, 13 dicembre 1900, p. 2097, dove si segnalava un aumento di stipendio da L. 1.200 a L. 1.320, e ibid., a. XXXII, v. II, n. 43, 26 ottobre 1905, p. 2183, dove si confermava la posizione per il 1905. In ibid., a. XXXVIII, v. I, n. 23-24, 25 maggio-1 giugno 1911, p. 1886 si segnalava la cessata attività dall’ufficio di assistente presso l’Istituto di zoologia dell’Università di Bologna. 93. Fascicolo 2188; n. 443 del Registro di immatricolazione della carriera scolastica. Facoltà di scienze matematiche e fisiche naturali, Archivio storico, Università di Bologna. Informazioni tratte dalla lettera del 3 maggio 1910 di Carlo Emery al rettore, ivi. 94. Gurrieri Norsa, “Le laureate in Italia”, cit., p. 182. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 263 libro che Elisa Norsa poche pagine dopo recensiva s’intitolava Come essere felici sebbene maritati, del reverendo inglese Edward J. Hardy, in quegli anni un successo internazionale. Nel 1895 si laurearono 22 donne (due conseguirono una seconda laurea), sei in discipline scientifiche. Di queste, tre si laurearono in matematica: Cornelia Pressi a Padova, Stella Sacchi a Pavia e Ersilia Bisson a Padova. Sempre a Padova, ma in scienze naturali, si laureò Amalia Moretti Foggia, che nel 1898 avrebbe conseguito la seconda laurea in medicina a Bologna. Dopo avere praticato a lungo e con successo come medico a Milano, Moretti Foggia divenne una pubblicista di successo tenendo per molti anni sulla Domenica del Corriere, con lo pseudonimo di dottor Amal, una rubrica di igiene e medicina e, firmandosi Petronilla, una rubrica di cucina e alimentazione.95 Nello stesso anno Bice Ferrari si laureò in medicina a Bologna, dopo avere iniziato gli studi all’Università di Modena, dove fu “assistente straordinaria”.96 Quello stesso 1895 a Napoli si laureò in chimica Maria Bakunin che ebbe una carriera brillante presso quella stessa università. Dal 1905 Bakunin fu socio, e in seguito anche presidente, dell’Accademia Pontaniana; nel 1912 fu ammessa all’Accademia delle scienze fisiche e matematiche della Società Reale di Napoli97 e nel 1946 fu nominata socio corrispondente dei Lincei.98 Professore straordinario dal 1912 e ordinario dal 1917,99 – la seconda donna in quel ruolo in Italia dopo Rina Monti –, anche l’attività di questa studiosa non ha attirato la curiosità degli storici, se non in modo agiografico. Sarebbe interessante, invece, esaminare le strategie 95. R. Dall’Ara, Petronilla e le altre. Il mestolo dalla parte di lei, Edizioni Tre Lune, Mantova, 1998. 96. Fascicolo personale posizione 1633 del Registro dell’Immatricolazione e della carriera scolastica, Archivio storico, Università di Bologna. Ancora studentessa Bice Ferrari si sposò con uno studente di medicina. 97. BUMIP, anno XXXVIII, vol. II, n. 35-36, 10-17 agosto 1911, p. 2872. 98. Nel Novecento le prime scienziate ammesse ai Lincei furono Maria Bakunin e l’archeologa Paola Zancani Montuoro. La prima fu eletta Socio corrispondente, la seconda Socio nazionale, su proposta di Benedetto Croce. Lettera di Benedetto Croce ai Lincei, Napoli, 4 settembre 1946. Fascicolo “Elezioni 1946”, B 1, Archivio dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Si veda inoltre, Lettera del Presidente dell’Accademia, Guido Castelnuovo, al Ministro della pubblica istruzione, 4 dicembre 1946 e risposta del Ministero in data 15 febbraio 1947. Fascicolo “Elezioni 1946”, B1, Archivio della Accademia Nazionale dei Lincei. 99. BUMIP supplemento del n. 13 del 28 marzo 1918, Ruolo di anzianità dei professori ordinari e straordinari delle RR università e degli istituti di istruzione superiore, Tip. Operaia romana coop., Roma, 1918. Naturalmente sono numerosi i luoghi in cui nel BUMPI sono registrati gli avanzamenti di carriera di Bakunin. Qui ho segnalato il fascicolo dove si trovano sintetizzati gli scatti di carriera più importanti. 264 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE di carriera di Bakunin e verificare, per esempio, se alle qualità accademiche abbiano corrisposto risultati importanti in laboratorio. Nel 1896 risulta che furono conseguite da donne 25 lauree (nove in discipline scientifiche), di cui una in giurisprudenza e sei seconde lauree, compresa quella di Emma Bortolotti a Bologna in scienze naturali. Sempre in scienze si laurearono Maria Mirabella a Palermo, Zina Leardi a Pavia e Matilde Marchesini, la seconda laureata in fisica del regno, presso l’Università di Roma. Le laureate in matematica furono due, Lucia Desimone a Messina e Lucia Valentini a Pavia. Prima di trasferirsi a Pavia, dove avrebbe terminato gli studi, Lucia Valentini nell’anno accademico 1889-90 si era iscritta (prima donna a farlo) alla Scuola preparatoria di ingegneria presso il Politecnico di Milano.100 Le laureate in medicina furono tre: a Torino Adelina Rossi, a Pavia Emilia Concornotti e a Roma Maria Montessori, di cui si è detto. Di Rossi non ho trovato tracce, mentre Emilia Concornotti nel 1900 lavorava presso il reparto maternità dell’ospedale di Napoli e fu autrice di alcune pubblicazioni su sperimentazioni condotte sui problemi gastrointestinali nei lattanti.101 Nel 1897 le lauree conseguite da donne furono 13, di cui cinque in discipline scientifiche: quattro in matematica, quelle di Elena Vanni a Roma, Emilia Tagliacozzo a Napoli, Maria Riva e Norma Crema a Pavia, e una in medicina, quella di Maria Fernanda Venturini a Napoli. Nel 1898 le lauree femminili salirono a 29 (sei in discipline scientifiche), di cui due seconde lauree e due lauree in giurisprudenza. Le laureate in medicina furono quattro, tra le quali Amalia Moretti Foggia che conseguì a Bologna la seconda laurea,102 Ester Bonomi a Genova, Olga Bondolfi a Torino e Arianna Papazafiropulo a Napoli. Le laureate in matematica furono due, Anita Moretti a Pavia e Ida Maestro a Padova. Ho trovato tracce di Bonomi che, dopo una specializzazione in pediatria a Parigi, si dedicò alla libera professione. Femminista e confe100. Galbani, “Donne al Politecnico di Milano”, cit., p. 56. La prima laureata presso il Politecnico fu, nel 1913, Gaetanina Calvi. Ibid., p. 58. 101. Ravà, “Le laureate in Italia”, cit., p. 640. Sia la tesi di laurea, sia diverse delle pubblicazioni di Concornotti furono inviate a Camillo Golgi e sono ora conservate nel famoso archivio delle miscellanee del premio Nobel. E. Concornotti, Ricerche cliniche e sperimentali sull’Infantina nell’alimentazione dei lattanti sani e di quelli infermi, Tocco & Salvietti, Napoli, 1909, già pubbl. in La pediatria, 11, 1909. 102. La tesi di Moretti Foggia su “Le ovaie nelle peritoniti sperimentali”, denota, così come per altre laureate in medicina, un interesse per le patologie femminili. Fascicolo 2849 n. 2001 del Registro di immatricolazione della carriera scolastica – Facoltà di medicina e chirurgia, Archivio storico, Università di Bologna. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 265 renziera di successo, pare che Bonomi incoraggiasse le giovani cui si rivolgeva a inoltrarsi “nei campi del subcosciente”, studiando la psicoanalisi.103 Nel 1899 le donne che si laurearono salirono a 44, ma ben 11 furono le seconde lauree, tutte in lettere o filosofia, mentre le laureate in discipline scientifiche furono 12: due in matematica, Anaide Grassi a Pisa e Sofia Todaro a Roma; tre in medicina, Aldina Francolini a Firenze,104 Clementina Musso a Torino e Rosalia Coduri a Pavia; sette in scienze naturali, Angelina Galiani a Palermo, Emilia Borghesio a Torino, Emma Pugliesi a Padova, Maria Pasquali a Napoli, Maria Stoppiana a Torino, Pia Monteforte e Anna Foà a Roma. Di Anna Foà restano tracce interessanti.105 Nello stesso anno della laurea Foà, che apparteneva a una famiglia numerosa e di scarsi mezzi, fu nominata assistente nel Gabinetto di anatomia comparata diretto da Giovanni Battista Grassi. Nel 1917 ottenne la libera docenza in entomologia agraria e dal 1912 divenne aiuto di anatomia comparata (nel 1918 lo era ancora).106 Autrice con Grassi di uno studio sulla fillossera spesso citato, aveva collaborato con lo scienziato nella stesura di quell’importante saggio sui “Progressi della biologia” nel volume sui Cinquanta anni di storia italiana, scrivendo, ma non firmando, la lunga sezione dedicata alla medicina sociale.107 Nel 1900, infine, le lauree conseguite da donne salirono a 53, con otto seconde lauree, ancora una volta tutte in lettere o filosofia. Le laureate in discipline scientifiche furono 11: una in matematica a Pavia, Teresa Magnani e, sempre a Pavia ma in chimica, Ernesta Marangoni (probabile corrispondente di Albert Einstein),108 una in chimica e farmacia a 103. M. A. L., “Uomini e donne della nostra epoca. Ester Bonomi”, in La Donna Italiana, 9, gennaio 1934, pp. 36-38, cit. in De Giorgio, Le italiane dall’unità a oggi, cit., p. 474. 104. Francolini raccontò la sua esperienza in “Come divenni dottoressa” in Cordelia, XXII, 8, 7 dicembre 1902. 105. Fascicolo personale di Anna Foà, posizione AS2270, Archivio generale studenti, Università di Roma, La Sapienza. I documenti del fascicolo si fermano al 1917. 106. BUMIP, anno XXXIX, vol. I I, n. 42, 22 agosto 1912 e ibid., a. XLV, vol. I, n. 27, 4 luglio 1918. 107. In una nota a p. 285 Grassi stesso segnalava che l’autore di quella parte era la “dott.a Anna Foà”. B. Grassi, Progressi della biologia in Cinquanta anni di storia italiana (18611910), v. 3, Hoepli, Milano, 1911, pp. 287-343. Si veda inoltre Contributo alla conoscenza delle fillosserine ed in particolare della fillossera della vite del prof. Battista Grassi e dei suoi allievi Anna Foa [et al.]; seguito da un riassunto teorico-pratico della biologia della fillossera della vite della dott. Anna Foa, Tip. G. Bertero, Roma, 1912. 108. Di recente sono state pubblicate tre brevi lettere di Albert Einstein a Ernesta Marangoni, che fu farmacista a Pavia. Date e luoghi coincidono ed è verosimile che con una laurea in chimica Ernesta Marangoni – la laureata nel 1900 – si sia dedicata alla gestione di una farmacia. Si veda E. Sanesi, “Einstein a Pavia”, in L. Fregonese (a cura di), Gioventù 266 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE Napoli, Ione [sic] Foà. Le laureate in scienze furono sette: Giuditta Mariani a Pavia, Alice Bombardi Lavezzo e Antonietta Romaro a Padova, Clementina Borsieri a Roma, Vincenziana Salem a Palermo e Giuseppina Gentile a Napoli. In medicina, le laureate furono Ines Gardini a Firenze e Pierina Delzoppo a Torino. Di questa classe di laurea ho trovato traccia di Clementina Borsieri, che nel 1908 fu abilitata alla libera docenza in zoologia presso l’Università di Roma. Da quell’anno fino al 1952 (ad esclusione di una lunga parentesi dal 1943 al 1948, pare, per ragioni di salute) Clementina Borsieri tenne un corso – sempre il medesimo – sui pesci e sulla loro classificazione.109 Abbiamo così considerato le 72 laureate in scienze o medicina nel primo quarto di secolo dal primo ingresso delle donne nell’istruzione superiore in Italia. Come si è detto, rappresentavano circa un terzo del totale delle laureate. Molte di loro, come si è visto, furono attive professionalmente, raggiungendo in alcuni casi alti livelli di carriera. Ben quattro divennero professore ordinario: Bottero e Magistrelli presso un istituto superiore e Monti e Maria Bakunin presso un ateneo (i docenti degli istituti superiori, anche femminili, e università erano equiparati a tutti gli effetti). Diverse altre lavorarono all’università, ma senza raggiungere alti livelli di carriera, come Fischmann Di Vestea, Sacchi, Concornotti, Foà, Norsa e Borsieri. Cattani, dopo avere lavorato nell’università diresse la sezione sperimentale di un ospedale. Traube collaborò per un certo tempo con l’università e fu in seguito attiva come giornalista. I medici Kuliscioff e Montessori divennero protagoniste della scena pubblica a livello nazionale e internazionale. Moretti Foggia, Fischmann Di Vestea e Bonomi divennero divulgatrici di successo nazionale. Alcune praticarono la professione medica privatamente e con successo, come Moretti Foggia e Bonomi. Marangoni svolse probabilmente la professione di farmacista a Pavia. Numerose, poi, pubblicarono scritti scientifici. È probabile che altre tra quelle 72 laureate abbiano ottenuto risultati professionali non trascurabili: si tratta di continuare una ricerca che qui è stata solo iniziata. Un’ultima osservazione: soltanto di Iginia Massarini vi sono testimonianze che insegnò in una scuola felice in terra pavese. Le lettere di Albert Einstein al Museo per la Storia dell’Università di Pavia, Cisalpino, Milano, 2005, p. 72. 109. Clementina Borsieri, come tutti i docenti universitari italiani ad esclusione di 12, com’è noto, giurò fedeltà al fascismo e rassicurò il regime di essere di razza ariana e religione cattolica. Queste e altre informazioni nel fascicolo personale, “Borsieri Clementina”, posizione AS 5827, Archivio generale studenti, Università di Roma, La Sapienza. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 267 superiore. Dunque, non fu la scuola l’unica prospettiva professionale per le laureate delle facoltà scientifiche in quegli anni. Dal 1900 alla Seconda guerra mondiale I risultati importanti conseguiti professionalmente da alcune delle prime laureate in discipline scientifiche in Italia, non devono far dimenticare la difficile situazione nazionale. Nell’anno accademico 191415, alla vigilia della Prima guerra mondiale, le iscritte all’università erano complessivamente soltanto 1.486: il 5,6% degli studenti.110 In alcuni circoli il problema dello scarso accesso delle donne all’istruzione era particolarmente sentito, come testimonia il concorso Ravizza del liceo Beccaria di Milano per il biennio 1889-1901, che si occupò del tema. Il lungo titolo recitava: “Studio comparativo di ciò che si fa per l’educazione pubblica e privata della donna nei paesi più civili: determinazione dei principi fondamentali a cui deve informarsi tale educazione, e, conseguentemente, in che e come debba e possa completarsi e riformarsi, particolarmente in Italia, perché risponda degnamente al suo scopo”. Il vincitore, Renzo Furlani, scrisse un libro che resta una fonte preziosa per la storia dell’educazione femminile in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, comparabile all’importante inchiesta di Helene Lange.111 Eppure, agli inviti a favore di un potenziamento all’istruzione femminile come quello di Furlani e della commissione milanese che gli diede il premio e pubblicò il libro, non fecero seguito azioni politiche 110. Elaborazione dati in Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica, Gli studenti delle università italiane. Indagini statistiche, Supplemento al n. 59, cit., p. 203 e p. 205. 111. Furlani, L’educazione della donna presso i popoli più civili, cit. Furlani era un insegnante dell’Istituto tecnico e nautico di Genova. Da una prima ricognizione dei documenti conservati presso l’archivio storico del Liceo Beccaria non risulta che all’edizione 1889-1891 del concorso abbiano partecipato delle donne, né che ve ne fossero nella commissione che assegnò il premio. Informazioni fornitemi dalla prof.ssa A. Conte che si sta occupando dell’ordinamento dell’archivio del Beccaria e che ringrazio. Partecipò al concorso anche tal Roberto Puccini, di diverso orientamento rispetto al Furlani, che in seguito pubblicò il suo scritto con una introduzione di Luisa Anzoletti. In questo caso, si tratta di una fonte preziosa, non di dati sull’istruzione, bensì di più tradizionali immagini della donna del periodo. Si veda R. Puccini, L’educazione della donna ai nostri tempi ne’ popoli più civili, con pref. di Luisa Anzoletti, Tip. L. F. Cogliati, Milano, 1904. Su Anzoletti, M. P. Casalena, La storia, la scuola, la missione delle donne: voci femminili di fine Ottocento, comunicazione al convegno “Donne e Nazione”, Università e Archivio di Stato di Pisa, novembre 2004. 268 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE conseguenti, coraggiose e proiettate nel lungo periodo. Fu un’occasione mancata, soprattutto in considerazione delle circostanze favorevoli che si sarebbero create in Italia nei primi anni del Novecento, superate le crisi economiche e sociali degli anni tra 1893 e il 1902. Nel 1913, commentando della ripresa economica, Carlo Francesco Ferraris, statistico e scienziato dell’amministrazione pubblica, nell’introduzione a una delle sue ricerche più importanti sull’istruzione superiore tra il 1893 e il 1911, osservava con soddisfazione che a partire dal 1902 si era assistito in Italia a un incremento delle iscrizioni maschili in settori con sbocchi produttivi come l’ingegneria e l’agraria. Il fatto, a suo parere, era positivo perché concomitante con un altro fenomeno interessante: Credo quindi di essere nel vero affermando che nella più affannosa ricerca della ricchezza nel secolo ventesimo la popolazione italiana abbia volte le sue energie più direttamente alle professioni economiche nello stretto senso della parola e sentito minore impulso verso gli studi superiori che danno accesso ad alcune delle professioni comunemente designate come liberali, sia pell’esercizio privato, sia pei pubblici uffici. Ed il concorso sarebbe per tale motivo probabilmente stato anche minore, se nel sesso femminile non si fossero intensificate la propensione agli studi superiori o la necessità di adirvi, contribuendo così a riempire in parte i vuoti lasciati dalla diserzione del sesso maschile. Credo del resto che sia da considerarsi un vantaggio se, mentre il sesso maschile attenderà vigorosamente alla produzione della ricchezza materiale, il sesso femminile darà opera maggiore alla coltura intellettuale. Avremo così due fattori di civiltà in armonico reciproco sussidio per azione di entrambi i sessi e ne deriverà una elevazione in tutta la nostra vita sociale.112 Nonostante l’analisi e gli appelli di esperti e politici della levatura e dell’influenza di Ferraris e i modelli stranieri cui ispirarsi, additati da Furlani e da molti interventi a favore di una maggiore istruzione anche per le donne, fin dai tempi di Francesco De Sanctis e Pasquale Villari, fino a Luigi Credaro – tutti ministri del regno, compreso Ferraris –, la risposta della società italiana fu debole, in mancanza di sostegni concreti all’istruzione femminile superiore, come sarebbe stata l’istituzione di un sistema di borse di studio efficiente e, soprattutto, l’incentivazione dell’istruzione liceale anche per le donne. Uno dei problemi da superare per le donne italiane fu quello di vincere il pregiudizio (tra i molti altri) che riteneva come pericolosa sui banchi del liceo – la scuola che apriva le porte a ogni facoltà universitaria – la convivenza di giova112. C. F. Ferraris, “Statistiche delle Università e degli Istituti superiori”, cit., p. XXVI. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 269 ni di entrambi i sessi.113 Se all’inizio del Novecento, come si è detto, la presenza femminile nei licei era irrisoria, anche alla fine della Prima guerra mondiale il numero delle ragazze nei licei classici si manteneva molto basso: nell’anno scolastico 1919-20 i “licenziati” erano stati 4.685, le “licenziate” 932.114 D’altra parte, i licei femminili furono istituiti soltanto nel 1923 da Giovanni Gentile, con il “fine d’impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirino né agli studi superiori né al conseguimento di un diploma professionale”.115 Le materie insegnate nel neo istituito liceo femminile erano lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica, due lingue straniere (una obbligatoria, l’altra facoltativa), storia dell’arte, disegno, lavori femminili ed economia domestica, musica e canto, uno strumento musicale, danza. Il liceo femminile di cui si era discusso per decenni, da un lato non consentiva l’accesso delle donne all’università (il liceo femminile durava soltanto tre anni), dall’altro non prevedeva nemmeno un’ora la settimana di matematica o scienze naturali.116 In effetti, le alunne che si iscrissero ai sette licei che furono aperti nel regno, furono soltanto 120 nel 1922-23 e 124 l’anno successivo.117 In ogni caso, le statistiche dicono che negli anni precedenti la Prima guerra mondiale le donne perseverarono nello studio delle scienze naturali all’università, incoraggiate dalle possibilità di trovare lavoro come insegnanti e forse anche da quanto accadeva a nord delle Alpi: il clamore suscitato dai ben due premi Nobel conferiti a una donna, Marie Curie, il primo nel 1903, il secondo nel 1911, ha avuto probabilmente un impatto anche in Italia: un altro episodio che sarebbe interessante approfondire con uno studio della stampa periodica nazionale. 113. Gina Lombroso è testimone di come, negli anni Ottanta dell’Ottocento e in una città come Torino, si potesse essere l’unica ragazza in un’aula di liceo. D. Dolza, Essere figlie di Lombroso. Due donne intellettuali tra ‘800 e ‘900, Angeli, Milano, 1990, p. 49. 114. Ministero dell’Economia Nazionale, Direzione Generale della Statistica, Annuario Statistico Italiano, seconda serie, v. VIII, anni 1919-1921, Indici economici fino al 1924, Provveditorato Generale dello Stato, Roma, 1924-25, p. 134. In quello stesso anno scolastico le licenziate dalle scuole normali erano state 8.494 (889 gli uomini); le licenziate dalle scuole complementari erano state 5.703 (44 gli uomini); 2.019 le licenziate dai ginnasi (7.063 gli uomini); 11.231 le licenziate dalle scuole tecniche (17.572 gli uomini); 1.227 le licenziate dagli istituti tecnici (5.905 gli uomini). Ivi. 115. Art. 65 in Capo 7° “Dei licei femminili”, in “Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all’ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali”, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 2 giugno 1923, n. 129, p. 4350. 116. Ibid., p. 4354. 117. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Centrale di Statistica, Annuario Statistico Italiano, seconda serie, v. IX, anni 1922-1925, Stabilimento Poligrafico per l’Amministrazione dello Stato, Roma, 1926, p. 77. 270 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE Fu nel 1908 intanto – quando nasceva La voce e Benedetto Croce pubblicava alcuni dei suoi saggi più importanti –, che una ragazza torinese, Emma Strada, espugnò l’ultima roccaforte maschile nel mondo universitario italiano (e, pare, europeo): la facoltà di ingegneria.118 Il 1908 fu anche l’anno del primo Congresso nazionale delle donne italiane, che attirò sulla questione femminile l’attenzione di un pubblico ampio, nonché del Vaticano, che in quello stesso anno promosse la creazione dell’Unione fra le donne cattoliche d’Italia.119 Fu solo negli anni Venti, tuttavia, che il numero complessivo delle laureate iniziò ad assumere una reale consistenza. Se nel periodo 190110 le laureate erano state 211 e 368 nel periodo 1911-20 (i laureati erano stati 4.622), nel periodo 1921-30 le laureate salirono a 1.166 (i laureati a 8.279), nel 1931-40 furono 2.020 (i laureati 11.628) e nel 1941-50, a cavallo della Seconda guerra mondiale, 5.115 (i laureati 18.479).120 Quanto alle scelte fatte dalle giovani tra gli anni immediatamente precedenti la Prima guerra mondiale e la Seconda guerra mondiale, si assiste a una crescita – fino agli inizi degli anni Venti – delle lauree nelle facoltà di scienze, così come di quelle in medicina, che crescono anche nel decennio successivo insieme con quelle in farmacia (Tab. 1). Tabella 1. Laureate e diplomate in istituti superiori, periodo 1913-1941.121 118. Emma Strada conseguì la laurea in Ingegneria civile al Regio Politecnico di Torino nel 1908, a pieni voti e lode e fu tra le fondatrici dell’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti. Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, AIDA, http:// www.aidiaitalia.org/chisiamo.htm 119. La bibliografia più aggiornata su questi temi (dal 2000 a oggi) è disponibile in un database bibliografico a cura della Società Italiana delle Storiche (http:// www.societadellestoriche.it/main.php?pag=riviste). 120. Istituto centrale di statistica, Sommario di statistiche storiche dell’Italia, 1861-1975, cit., p. 56. 121. I dati della tabella sono una rielaborazione di quelli forniti in Istituto centrale di statistica, Statistica dell’istruzione superiore nell’anno accademico 1945-46, Tip. Failli, Roma, 1948, tav. 11, pp. 98-99. Nella categoria “Altro” sono conteggiate le laureate in Scienze politiche (prima laureata nel 1923-24; 157 in tutto il periodo qui considerato [tpc]), ingegneria (105 laureate in tpc), architettura (prime due laureate nel 1924-25; 53 in tpc), Agra- DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 271 Il fenomeno fa pensare a un effetto della propaganda positivista a favore del sapere scientifico e tecnologico, protrattasi con successo fino alla Prima guerra mondiale e continuata poi in tono minore: un clima che a quanto pare ha avuto effetti a lungo termine in campo educativo. Dall’altro lato, ebbe certo un ruolo l’impulso dato dalla Grande Guerra alla ricerca in campo scientifico e il coinvolgimento delle donne nelle diverse attività del paese, a partire da quelle belliche e industriali.122 Certamente l’impiego delle laureate nel sistema dell’istruzione fu importante, come lasciano intuire i dati dei censimenti: nel 1911 in Italia vi erano complessivamente 121.024 insegnanti di cui 75.251 erano donne, pari al 62,1% dell’intero corpo docente nazionale.123 Nel 1921 (entro gli antichi confini) gli insegnanti erano 182.121, dei quali 128.266 donne,124 pari al 70,4%. Le insegnanti sarebbero salite a 134.985 nel censimento del 1931, raggiungendo il 72,7% del corpo docente nazionale.125 Ma lo sbocco nella scuola non è forse l’unica spiegazione dell’aumentato numero delle studentesse nelle facoltà scientifiche. Il numero delle laureate nella facoltà di scienze crebbe infatti fino all’anno accademico 1923-24 quando si raggiunse il picco, cui seguì un calo, accompagnato da una crescita considerevole delle iscrizioni ai corsi letterari. Pur ricordando che stiamo sempre parlando di poche centinaia di persone, se a determinare gli spostamenti delle donne da una facoltà all’altra fossero state in primo luogo le possibilità di lavoro offerte dalla scuola i dati, almeno a partire dal 1927, ci dovrebbero restituire una realtà inversa, cioè di forte calo delle iscrizioni ai corsi letterari e aumento nei corsi scientifici. Nel 1926, infatti, il regio decreto n. 2480 sul regolamenria (prima laureata nel 1914-15; 69 in tpc) e Chimica industriale (prima laureata nel 193334; 5 in tpc). Per gli anni accademici 1927-28 e 1928-29 non sono riportati i dati delle lauree femminili. Nella tab. con “Scienze” s’intende naturalmente la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali. Altre fonti verificate sono Gli studenti delle università italiane. Indagini statistiche, suppl. 59, cit. 122. Le donne impegnate nell’industria bellica, che nell’ottobre 1915 erano meno di 15.000, raggiunsero alla fine del conflitto le 200.00 unità. V. Franchini, Il contributo delle maestranze femminili all’opera di allestimento di materiali bellici (1915-1918), Luigi Alfieri editore, Milano Roma, s.d. 123. Direzione generale della statistica e del lavoro. Ufficio del censimento, Censimento della popolazione del Regno d’Italia al 10 giugno 1911, vol. VII, Relazione, Tip. Bertero, Roma, 1916, p. 126. 124. Presidenza del consiglio dei ministri, Istituto centrale di statistica, Censimento della popolazione del Regno d’Italia al 1° dicembre 1921, serie VI, v. XIX, Relazione generale, Stabilimento poligrafico per l’Amministrazione dello Stato, Roma, 1928, anno VI, p. 252. 125. Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia, VII censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931 –IX, v. IV, Relazione generale, parte seconda, tavole, Tip. Failli, Roma, 1935, p. 243. 272 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE to per i concorsi a cattedre nelle scuole superiori (denominate all’epoca scuole medie) e firmato dal ministro della Pubblica istruzione Pietro Fedele, escluse le donne dai concorsi per le cattedre di lettere classiche nei licei (solo inseguito denominati “classici”); lettere italiane e storia negli istituti tecnici e magistrali; lettere italiane, latine e storia, e filosofia e storia nei licei e nei licei scientifici.126 Sarebbe stato logico, dunque, aspettarsi che le studentesse si rifugiassero nelle scienze. Invece una ripresa delle laureate nelle facoltà scientifiche si produsse soltanto con l’inizio della Seconda guerra mondiale, in un contesto di aumento generalizzato delle iscrizioni (Fig. 3). Nel corso degli anni Venti, è noto, ai miti di un progresso e di una modernità trainati dalle scoperte scientifiche e tecnologiche, in tutta Europa se ne sostituirono altri, spesso d’ispirazione idealista e spiritualista, che si appellarono al motto della “bancarotta della scienza”, lanciato da alcuni già verso la fine dell’Ottocento.127 Fu forse a quel clima, nazionale e internazionale e che raggiunse ampie proporzioni nella sfera pubblica dopo il primo conflitto mondiale, che furono sensibili le donne che si iscrissero all’università tra la seconda metà degli anni Venti e l’inizio della Seconda guerra mondiale. Ciò non toglie che negli anni Venti e Trenta del Novecento lo spoglio delle fonti stia portando alla luce numerosi nomi di donne attive nelle università e negli stabilimenti annessi.128 Si può anticipare già ora che, fino al 1931, furono più numerose le donne che entrarono come docenti nelle facoltà scientifiche (di scienze, medicina e farmacia) di quante non siano entrate in quelle di lettere.129 I nomi di alcune di quelle donne 126. Si tratta dell’art. 11 del R.D. 9 dicembre 1926, n. 2480, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 29 marzo 1927, n. 73 e in Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, anno 1927 (V), v. I, (dal 1° gennaio al 2 aprile 1927), Provveditorato generale dello stato, Roma, 1927 – anno V, p. 1232. La restrizione riguardava le classi di concorso IV, V, VI e VII. Il decreto riservava invece alle donne i concorsi per il ruolo di maestra giardiniera negli istituti magistrali (ibid., p. 1233). Per le tabelle che illustrano le classi di concorso si veda ibid., pp. 1248-1251. 127. H. W. Paul, “The debate over the Bankruptcy of science in 1895”, in French Historical Studies, 3, 1969, pp. 299-327; R. MacLeod, “Il dibattito sulla “bancarotta della scienza”. Il credo della scienza e i suoi critici, 1885-1900”, in Intersezioni, 2, 1983, pp. 361-82; L. Mangoni, Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento, Einaudi Torino, 1985; J. W. Burrow, The crisis of reason. European thought, 1848-1914, Yale University press, New Haven, 2000. 128. Circa le donne attive nelle facoltà medico-chirurgiche una fonte utile è A. Dröscher, Le facoltà medico-chirurgiche italiane, 1860- 1915. Repertorio delle cattedre e degli stabilimenti annessi, dei docenti, dei liberi docenti e del personale scientifico, Clueb, Bologna, 2002. 129. Nell’anno accademico 1931-31 dei 1.614 docenti complessivi, tra università libere e regie, 25 erano donne, 11 presso le facoltà di lettere, 8 presso le facoltà di scienze, 4 3. Le laureate in scienze in Italia nel periodo 1913-1942 (valori assoluti). Dati ministeriali e Istat. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 273 274 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE sono in qualche caso noti, le matematiche Pia Nalli e Elena Freda130 o Rina Monti e Maria Bakunin di cui si è detto, quasi dimenticate, invece, le numerose altre.131 Non si può non fare un cenno a questo punto alla riforma che nel 1923 mise a punto Giovanni Gentile, perché questa segnò, com’è noto, in modo importante la storia dell’istruzione scientifica italiana in generale e di quella femminile in particolare.132 Nella nuova riorganizzazione degli studi le scienze furono eliminate, per esempio, nell’Istituto superiore per il magistero femminile, da dove per decreto sparirono le cattedre delle discipline scientifiche. Una ricerca in corso sull’attività di alcune docenti dell’Istituto superiore di magistero femminile di Roma sta rivelando risvolti di particolare interesse per uno studio della diffusione della cultura scientifica nel paese. Quell’Istituto, così come quello di Firenze, era destinato a formare le docenti delle scuole normali, dove studiavano le future insegnanti elementari. Il numero delle iscritte a quei due Istituti, confrontato con quello degli iscritti in altri istituti superiori e posto in relazione con lo scarso accesso delle donne agli studi superiori in generale, si mantenne sempre piuttosto alto: si partì con 105 iscritte il primo anno (complessivamente, tra Firenze e Roma) e si raggiunsero le 327 iscritte nell’anno accademico presso quella di medicina e 2 di farmacia. Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia, Statistiche intellettuali. Statistica dell’istruzione superiore per l’anno accademico 1931-32 e notizie statistiche per gli anni accademici dal 1927-28 al 1930-31, v. 11, Tip. Failli, Roma, 1936, pp. 74-75. 130. E. Giannetto, Freda, Elena, in Dizionario biografico degli italiani, v. 50, Istituto della Enciclopedia Treccani, Roma, 1998, pp. 356-357. 131. Si tratta, tra le altre, delle matematiche Paolina Quarra, Angela Maria Molinari, Emma Sciotelle, Anna Vivanti e Rosaria Giordano, le fisiche Giuseppina Guidi, Luigia Fabaro, Teresa Angrisani, Melena Fambri, Teresa Oneglio, Eva Mameli, Marta Moretti e Rosa Mariola, le astronome Tersilla Comi e Teresita Castelli, i medici Teresa Barocelli, Teresa Bonfitto, Carmelita Rossi, Carmela Macciotta, Maria Pelanda, Daria Baldi, Socilla Sacchi, Ernesta Vecchi, le botaniche Irma Pierpaoli, Grazia Moscatello Calderara e Adele Zagolin, le chimiche Maria Clotilde Bianchi, Gilda Canuto, Anna Maria Mauro, Emma Fabris, Maria Badino, Anna Mannessier, Teresa Barni, le zoologhe Rosa Olimpia Nardelli e Elena Mistretta, l’esperta di zooculture Anita Vecchi e di meccanica razionale Lauretta Baeri, e si potrebbe continuare, con Giuseppina Pastori e molte altre. Per ragioni di spazio mi è impossibile riportare qui i luoghi del Bollettino in cui ho trovato informazioni su queste studiose. 132. Sulla storia dell’università in Italia limito i rimandi a V. Ancarani (a cura di), La scienza accademica nell’Italia post-unitaria. Discipline scientifiche e ricerca universitaria, Angeli, Milano, 1989; Bellatalla, Tomasi, L’Università italiana nell’età liberale (1861-1923), cit.; G. P. Brizzi, A. Varni (a cura di), L’università in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspetti e momenti, Clueb, Bologna, 1991; G. Fioravanti, M. Moretti, I. Porciani (a cura di), L’istruzione universitaria (1859-1915), Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 2001. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 275 1901-02 (sempre complessivamente nei due istituti).133 Nell’anno accademico 1910-11 il numero delle diplomate fu 54 (21 a Firenze; 30 a Roma), un numero che non si allontanava molto da quello dei diplomati presso l’Istituto di studi superiore di Firenze, che quell’anno erano stati 33 (tutti uomini).134 Dal 1882 fino alla riforma Gentile in quegli Istituti vi erano state anche cattedre di chimica, fisica e scienze naturali. Certamente nell’Istituto di Roma, quelle discipline furono insegnate in laboratori attrezzati da docenti di sicura professionalità. Nell’Italia tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, dunque, alcune centinaia di docenti donne formatesi in quegli istituti e andate in seguito a insegnare nelle scuole normali, hanno trasmesso alle loro allieve, future maestre delle scuole elementari, una solida cultura scientifica, impostata su una didattica di tipo sperimentale. Con la riforma di Gentile le cose cambiarono: negli Istituti entrarono gli uomini, ma uscirono le scienze.135 La trasformazione di quegli Istituti superiori fu definitiva nel 1935, quando divennero Facoltà di magistero. Questo portò un cambiamento radicale nella formazione di studentesse e studenti che avrebbero portato nelle scuole italiane un sapere orientato verso la cultura umanistica e classica e molto meno aperto a quella scientifica e sperimentale. Nel frattempo, fu proprio nella seconda metà degli anni Venti che le ragazze cominciarono a iscriversi ai licei classici in numero crescente. Nell’anno scolastico 1926-27 il numero delle iscritte ai licei era complessivamente (nei licei governativi e pareggiati) 12.202, mentre i maschi erano 42.482.136 In effetti, anche una lettura rapida dei dati pubblicati dall’Annuario Statistico Italiano suggerisce che fu nei primi anni Venti 133. Per i dati dal 1882 al 1906, si veda Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica, Annuario Statistico Italiano, 1905-1907, Tip. G. Bertero, Roma, 1908, p. 288. Nel periodo indicato, le iscritte presso questo istituto furono circa lo stesso numero degli iscritti (complessivi a livello nazionale) alla Scuola superiore di medicina veterinaria e quelli alla Accademia scientifico-letteraria di Milano. 134. Le diplomate l’anno precedente erano state 72. BUMIP, anno xxxix, n. 33, 11 luglio 1912, p. 2177. A partire da questo anno il BUMIP riporta le statistiche degli studenti differenziate tra maschi e femmine. 135. La soppressione della cattedra di fisica avvenne con R. D. 11 gennaio 1923, n. 190, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 14 febbraio 1923, n. 37 e BUMIP, anno L, vol. I, n. 8, 22 febbraio 1923, p. 535. Inoltre, si veda R. D. 13 marzo 1923, n. 736, che detta le norme per il riordinamento degli Istituti superiori di magistero, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 1923, n. 88 e BUMIP, anno L, vol. I, n. 17, 26 aprile 1923, pp. 1385-1390. 136. Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia, Annuario statistico italiano, anno 1928 – VI – terza serie, v. II, Stabilimento Poligrafico per l’Amministrazione dello Stato, Roma, 1928, anno VI, p. 75. 276 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE che i comportamenti delle donne in materia di istruzione iniziarono a cambiare in modo sostanziale. Erano anni, d’altra parte, in cui i movimenti femminili, prima delle censure fasciste, raggiunsero una ricchezza e una varietà di posizioni davvero notevoli.137 Mettendo a confronto l’aumento nel numero delle iscritte nelle scuole superiori, delle iscritte all’università e il numero delle docenti, emerge un fenomeno sociale importante che ebbe come protagoniste le donne e che già nel primo dopo guerra non era sfuggito a Giovanni Gentile. Questi nel 1918 si era rivolto all’allora ministro dell’istruzione paventando una grave decadenza della scuola superiore il cui primo sintomo si sarebbe manifestato nell’abbandono della carriera di insegnante da parte degli uomini attratti verso carriere più vantaggiose e virili: e invasa dalle donne, che ora si accalcano alle nostre università, e che, bisogna dirlo, non hanno e non avranno mai né quell’originalità animosa del pensiero, né quella ferrea vigoria spirituale, che sono le forze superiori, intellettuali e morali, dell’umanità, e devono essere i cardini della scuola formativa dello spirito superiore del paese.138 Pochi anni dopo, infatti, questa era la situazione degli iscritti ai corsi universitari umanistici. Se nell’anno accademico 1921-22 gli iscritti ai corsi per la laurea in lettere e il filosofia erano 1.547 e le iscritte 1.300 (i laureati in quei corsi in quell’anno furono 223, le laureate 145), l’anno accademico successivo le donne iscritte ai medesimi corsi furono 1.387 e gli uomini scesero a 1.257 (i laureati 293, le laureate 173). Nel medesimo anno accademico, ai corsi universitari di scienze matematiche, fisiche e naturali le iscritte per ottenere la laurea in “matematiche pure” erano 395, mentre gli iscritti erano 386; nei corsi per la laurea in “fisicomatematica” le iscritte furono 131 e gli iscritti 35, per la laurea in scienze naturali le iscritte furono 214 e gli iscritti 207.139 Mentre il numero dei laureati nel complesso continuava a essere superiore a quello delle laureate, l’aumento delle iscritte manifestava un nuovo e forte interesse da 137. L’Almanacco della donna italiana è una fonte straordinaria per testare la ricchezza delle società e associazioni femminili fino agli anni Venti del Novecento. Nel volume del 1921, per esempio, nella rubrica “Società femminili” sono elencate 25 tra associazioni e circoli. Almanacco della donna italiana, 1921, Bemporad, Firenze, pp. 360-382. 138. G. Gentile, Il problema scolastico del dopoguerra, Riccardo Ricchiardi editore, Napoli, 1919, p. 8. Si tratta di una lettera aperta che Gentile aveva originariamente pubblicato su un quotidiano. G. Gentile, Esiste una scuola in Italia? Lettera aperta al ministro della P. I. on. Berenini, in Il resto del Carlino, 4 maggio 1918. 139. Presidenza del consiglio dei ministri, Istituto centrale di statistica, Annuario Statistico Italiano, seconda serie, v. IX, anni 1922-1925, cit., pp. 97-99. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 277 parte delle donne per gli studi superiori e lasciava prevedere, nel giro di pochi anni, un aumento consistente delle laureate. Il fenomeno si sarebbe presto proiettato in molti settori economici, pubblici e privati e, inevitabilmente, nelle scuole superiori dove le donne – che già da decenni erano la maggioranza degli insegnanti delle scuole elementari e normali140 –, stavano aumentando ovunque. Un altro indicatore interessante dell’ascesa femminile nel settore dell’istruzione negli anni Venti è il numero dei presidi. Nell’anno scolastico 1926-27 nelle scuole governative i presidi erano 851 e le presidi 61, negli istituti privati i presidi erano 3.260 e le presidi erano 2.313.141 Se con la riforma del 1923 Gentile non fosse intervenuto con quell’articolo (il n. 12) che impediva alle donne di diventare presidi, probabilmente le donne sarebbero presto state a capo della maggior parte delle scuole superiori.142 Lo stesso fenomeno, naturalmente, si sarebbe verificato nel settore delle discipline umanistiche nei licei, classici e scientifici, e negli istituti tecnici e magistrali senza gli interventi legislativi del 1926 di cui si è detto.143 Il calo delle iscrizioni femminili alle facoltà scientifiche si concluse, si è visto, con l’inizio del secondo conflitto mondiale, quando anche le iscrizioni complessive delle donne crebbero in modo considerevole. All’indomani della Seconda guerra mondiale l’Istituto Centrale di statistica commentava il dato con un’enfasi particolare: “Fino al 1934-35 l’aumento [delle iscrizioni] procede pressoché uguale per i maschi e per le femmine, ma dal 1935 in poi, come è illustrato dal grafico 4 [qui, fig. 4] esso è molto più forte per queste ultime, e ciò nonostante il notevole e ingente aumento avutosi per i maschi dall’anno 1941 in poi.”144 140. Sulle maestre tra Otto e Novecento la letteratura è molto vasta, rimando a S. Soldani, “Maestre d’Italia”, in Groppi (a cura di), Il lavoro delle donne, cit., pp. 368-397. 141. Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia, Annuario Statistico Italiano, anno 1928, cit., p. 76. Purtroppo l’Annuario non riporta il numero dei presidi negli anni precedenti. 142. Art. 12: “I presidi sono scelti dal ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne”, in “Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all’ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali”, cit., pp. 4350-4351. 143. Anche per un elenco dei decreti che durante il fascismo esclusero le donne dal mercato del lavoro (pubblico e privato), si veda M. V. Ballestrero, La protezione concessa e l’eguaglianza negata, in Groppi, (a cura di), Il lavoro delle donne, cit., pp. 445-469. 144. Istituto centrale di statistica, Statistica dell’Istruzione superiore nell’anno accademico 1945-46, Roma, Tipografia Failli, 1948, pp. 37 e 38. L’aumento dei maschi va naturalmente collegato ai vantaggi (reali o presunti) derivanti dall’iscrizione a un’università in tempo di guerra in rapporto al servizio militare. 278 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE 4. Grafico dell’Istituto centrale di statistica (1948) per illustrare il forte incremento delle iscrizioni universitarie femminili rispetto a quelle maschili tra il 1935 e il 1946.145 (Biblioteca del Dipartimento di scienze statistiche, Università di Bologna). In effetti, già nell’anno scolastico 1936-37, complessivamente nelle scuole medie classiche, scientifiche e magistrali che consentivano uno sbocco universitario, le alunne erano state 114.305 (gli alunni 155.395).146 Circa le facoltà di scienze, nell’anno accademico 1936-37 i laureati in complesso furono 569, di cui 194 donne,147 e nell’anno accademico 193940 i laureati in scienze salirono a 1.145, di cui 331 donne.148 145. Ibid., p. 37. 146. Istituto centrale di statistica, Annuario Statistico Italiano, anno 1938 – XVI, quarta serie, v. 5, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1938 – XVI, p. 270. 147. Ibid., p. 280. 148. Istituto centrale di statistica, Annuario Statistico Italiano, anno 1941 – XIX, quarta serie, v. 8, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, a. XIX, [1941], p. 298. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 279 I rapporti tra donne e scienza nelle università italiane, nuovamente più stretti dall’inizio della Seconda guerra mondiale, si sarebbero mantenuti ottimi fino agli anni Cinquanta. Dal dopo guerra a oggi L’incremento più consistente d’iscrizioni femminili dopo la Seconda guerra mondiale fu, come già ricordato, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. Se nell’anno accademico 1960-61 la percentuale di popolazione femminile con una laurea era l’1,7% (3,7% la maschile), dieci anni dopo (1970-71), il 7,2% delle donne possedeva una laurea, con un incremento del 324% c. (Fig. 5).149 Se fermiamo l’attenzione sulle scelte in tema di facoltà, un dato colpisce: le iscritte alle facoltà scientifiche sono passate dal 31,9% del numero complessivo delle studentesse nel 1950-51, al 12,2% delle colleghe circa cinquant’anni dopo, nel 1997-98:150 il calo di interesse delle donne nei confronti della scienza è stato più accentuato proprio negli anni in cui l’aumento delle iscrizioni femminili è stato maggiore (Fig. 6). D’altra parte, la crisi nei rapporti tra donne e scienza era già percepibile alla fine degli anni Cinquanta. I laureati del gruppo scientifico nell’anno accademico 1952-53 furono 4.205, di cui 2.499 donne;151 nell’anno accademico 1962-63, i laureati nel medesimo gruppo scientifico erano scesi a 4.034, di cui soltanto 1.745 donne.152 Il calo più drammatico fu tuttavia nel decennio successivo. Ma il minimo storico, come sappiamo, fu toccato nel 2000.153 Oggi a sud delle Alpi gli equilibri di genere nel settore della ricerca scientifica ai vertici della carriera sono notoriamente insoddisfacenti.154 E, com’è noto, classifiche nazionali e internazionali indicano come in149. Elaborazione dati in Istat, Donne all’università, cit. 150. Nella tabella i dati relativi alle iscrizioni alla Facoltà di agraria sono inclusi nel settore scientifico. Istat, Donne all’università, cit., p. 118. 151. Istituto centrale di statistica, Annuario Statistico Italiano, 1955, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma [1965], p. 122. Complessivamente 20.059 laureati, di cui 6.387 laureate. 152. Istituto centrale di statistica, Annuario Statistico Italiano, 1965, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma [1965], p. 122. 153. Miur, Direzione generale per gli studi e la programmazione, L’università in cifre. 2005, cit. 154. Circa l’Italia e l’Europa, Women and Science. Statistics and indicators. She figures 2006 disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/ she_figures_2006_en.pdf. Per gli Stati Uniti si veda Y. Xie, K. A. Shauman, Women in science: Career processes and outcomes, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2003 e il sito 5. Percentuali di popolazione italiana femminile e maschile con laurea, periodo 1950/51 –1998/99. Elaborazione dai dati Istat e ministeriali. 280 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE 6. Percentuali di donne iscritte nel settore scientifico rispetto al totale delle iscrizioni femminili, periodo 1950/51 – 1997/98. Elaborazione dai dati Istat e ministeriali. . DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 281 7. Studenti e studentesse universitari iscritti negli atenei italiani, 1911-2006 (valori assoluti). Elaborazione dai dati Istat e ministeriali. 282 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 283 sufficienti le prestazioni dell’Italia – uno degli otto paesi più industrializzati del globo – nei settori dell’istruzione, oltre che della ricerca.155 Eppure, se si osservano i dati concernenti l’università italiana nel lungo periodo come ho tentato di fare in queste pagine, c’è un indicatore in totale controtendenza rispetto alla situazione che ci affligge: le donne. Il grafico in figura 7 illustra l’andamento delle iscrizioni, maschili e femminili, nel Novecento fino all’anno accademico 2005-06. Come si vede, le donne iscritte all’università, invisibili fino agli anni Venti, quando raggiunsero il 10% del totale degli iscritti, sono aumentate in modo considerevole con il secondo conflitto mondiale, hanno consolidato il loro numero negli anni Cinquanta, hanno compiuto un balzo importante verso la fine degli anni Sessanta e raggiunto gli uomini nell’anno accademico 1990-91, mentre le laureate hanno superato i laureati nel 1992. La crescita delle iscritte è continuata dopo il 2000, a conferma di una spinta sociale che appare davvero straordinaria. 8. Immatricolati nei corsi di matematica, scienze e tecnologie per sesso (per 100 immatricolati). A.a. 1998/99-2003/04. Grafico pubblicato in Miur – DG Studi e programmazione, L’università in cifre, cit., p. 36. del National Center for Education Statistics, http://nces.ed.gov/. Negli ultimi anni giornali scientifici come Nature e Science hanno dedicato uno spazio crescente a questi temi. 155. OECD, Organization for Economic Co-operation and Development, PISA 2003. Technical Report, documento disponibile all’indirizzo http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/49/60/35188570.pdf Per la situazione delle università italiane, si veda “World University Rankings 2006”, in Times Higher Education Supplement, October 2006. 284 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE Tabella 2. Dottoresse e dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo in Italia nel 2005. Elaborazione da Miur – DG Studi e programmazione, L’università in cifre, cit., p. 52. Nel contesto ormai stabile di crescita delle lauree femminili – nel 2005 ogni 100 laureati, 57 erano donne, in aumento anche rispetto all’anno precedente – c’è una novità importante e di interesse non solo per chi si occupa di donne e scienza, ma di chiunque sia interessato ai rapporti tra scienza, istruzione e sviluppo in Italia. (Fig. 8) Come si vede nel grafico in figura 8, negli ultimi anni, mentre le iscrizioni maschili nel settore scientifico denotano un calo, le iscrizioni femminili sono in ripresa. A quell’incremento incoraggiante si affianca un altro dato, relativo ai dottorati di ricerca. Nella tabella 2 sono illustrati i dati concernenti i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo in Italia nel 2005 in alcuni dei principali settori disciplinari. Come si vede, nel 2005 le donne sono state complessivamente il 50,9% dei dottori di ricerca, con punte del 72,40% nelle scienze biologiche, del 61,50% nelle scienze mediche, del 59,40% nelle scienze chimiche. DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 285 Conclusione L’esame di lungo periodo qui delineato consente di individuare quattro periodi significativi nei rapporti tra donne e istruzione scientifica superiore in Italia tra il 1877, data della prima laurea femminile, e il 2005, quando le donne furono il 50,9% dei dottori di ricerca. La fase degli esordi, che si concluse con la Prima guerra mondiale, fu caratterizzata da un numero molto esiguo di laureate. Tuttavia, più spesso di quanto si potrebbe essere portati a pensare, quelle pioniere scelsero in molti casi di laurearsi in scienze o in medicina (1 ogni 3 c.). Si è visto inoltre che i risultati conseguiti sul piano professionale da alcune di quelle prime laureate furono spesso positivi, talvolta importanti. Una seconda fase nella storia dei rapporti tra donne e scienza va dalla Grande Guerra ai primi anni Venti del Novecento, quando in soli sei anni accademici (1918/19-1923/24) il numero delle laureate crebbe del 134%: in quegli anni, il numero delle laureate in scienze segnò il picco più alto della prima metà del secolo. Una terza fase nei rapporti tra donne e istruzione scientifica superiore, questa volta in negativo, coincise con il balzo cruciale verso la parità numerica con gli uomini tra gli iscritti all’università, prodottosi tra la fine degli anni Sessanta e il decennio successivo. In quel decennio, il numero delle laureate crebbe considerevolmente nel complesso, ma nelle scienze calò percentualmente in modo sensibile rispetto agli anni Quaranta e Cinquanta. La relativa lontananza delle donne dalle facoltà scientifiche si è interrotta soltanto negli ultimi anni e i dati a partire dal 2001 sembrano indicare una quarta, straordinaria fase nei rapporti tra donne e scienza in Italia. Sono infatti in aumento le iscrizioni femminili nei settori tecnicoscientifici e i risultati conseguiti dalle donne a sud delle Alpi a livello del dottorato di ricerca, anche in alcuni settori scientifici, sono superiori alla media europea.156 I dati relativi all’accesso delle donne all’istruzione superiore presentati in queste pagine autorizzano ad affermare che i risultati conseguiti dalle donne negli atenei italiani hanno assunto nel corso del Novecento 156. Per una maggiore attenzione alla situazione contemporanea rimando a P. Govoni, “Donne e scienza nelle università italiane: dall’esclusione al sorpasso, 1877-2005”, in Atenei, bimestrale del Miur, in corso di stampa. Per un’ulteriore bibliografia su questi temi, Id., “Il genere allo specchio. Una rassegna su donne e scienza”, in R. Simili (a cura di), Scienza a due voci, Olschki, Firenze, 2006, pp. 333-353. 286 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE le proporzioni di una straordinaria conquista. Si tratta del più importante – meno celebrato e ancor meno perseguito – dei successi dell’università in Italia nell’ultimo secolo e mezzo. Ma quali fenomeni in particolare hanno spinto le donne ad avvicinarsi o allontanarsi dalla scienza in quel lungo arco di tempo? Ciò che sembra comune ai quattro periodi qui individuati è una sinergia tra eventi culturali e sociali di portata internazionale, le politiche educative e i movimenti culturali nazionali. Le ragioni economiche che sottendono il fenomeno sono, com’è ovvio, altrettanto importanti, ma andranno indagate a fondo in un’altra fase della ricerca, anche in considerazione della difficoltà che ci sono ad affrontare fenomeni sui quali ricerche sociologiche importanti sembrano in contrasto con alcune analisi economiche più recenti.157 L’aumento e il calo talvolta bruschi nel numero delle iscrizioni femminili alle facoltà scientifiche che abbiamo osservato, sembrano verificarsi quando concreti interventi nel campo dell’istruzione – tipicamente delle riforme accompagnate da ampie discussioni sui media – hanno coinciso con più generalizzati movimenti culturali a favore o contro la scienza. Ciò naturalmente se si esaminano a parte gli effetti collegati ai conflitti mondiali, sui quali bisognerà fare (in altra sede) delle considerazioni specifiche.158 Il tipo di sinergia cui mi riferisco, si verificò una prima volta nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento, durante l’età del positivismo che coincise con la lunga fase degli esordi delle donne nell’università. L’interesse per le scienze dimostrato dalle prime laureate in quella fase si può a mio avviso ricondurre al clima favorevole, in Italia e in Europa, alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Negli anni della cosiddetta “scienza per tutti”,159 le poche donne che affrontarono gli 157. Mi riferisco all’ipotesi di una disoccupazione intellettuale in Italia, fino agli anni Settanta del Novecento (Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, cit.) che sembrerebbe in contrasto con le esigenze di personale sempre più qualificato – dunque anche laureato – nel contesto delle società industrializzate e ora dette della conoscenza (A. Ciccone, F. Cingano, P. Cipollone, The private and social return to schooling in Italy, Banca d’Italia, Temi di discussione del servizio studi no. 569, January 2006). 158. Che le due guerre mondiali abbiano intensificato i rapporti tra scienza e società è un dato risaputo e indagato dalla storiografia scientifica a livello internazionale, ma il fenomeno attende di essere studiato per quanto concerne le donne in Italia. 159. Sul fenomeno “scienza per tutti”, si vedano, tra gli altri, B. Bensaude-Vincent, A. Rasmussen (éds.), La science populaire dans la presse et l’édition XIXe et XXe siècles, Paris, CNRS Editions, 1997; W. H. Brock, Science for all. Studies in the history of Victorian science and education, Aldershot, Variorum, 1996; R. MacLeod, Public science and public policy in Victorian England, Aldershot, Variorum, 1996 e Id., The “Creed of science” in Victorian En- DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE / 287 studi universitari si dimostrarono sensibili a una diffusa campagna a favore di una scienza additata come motore di sviluppo e modernità. In quegli anni, com’è noto, furono molti in Italia gli interventi di riforma, sia a favore dell’istruzione popolare, sia di quella media e superiore. Sebbene mai nessuno allora si sia rivolto alle donne invitandole a studiare le scienze, quelle poche tra loro che decisero di tentare l’avventura degli studi universitari risposero in modo positivo a un clima generale attento ai temi dell’educazione e insieme favorevole alle scienze. Un’analoga, pronta risposta delle donne – questa volta in direzione contraria, cioè di una presa di distanza dalle scienze – si produsse durante il fascismo, tra la seconda metà degli anni Venti e per tutto il corso degli anni Trenta, quando ai miti di un progresso e di una modernità trainati dalle scoperte scientifiche e dalle applicazioni tecnologiche, in tutta Europa se ne sostituirono altri, spesso di segno contrario. Molte donne in quegli anni dimostrarono – in termini di scelta della facoltà – una sensibilità a un clima che in Italia, com’è noto, trovò tra gli altri nel ministro Gentile un sostenitore convinto. In questo stesso periodo, sembrerebbe più evidente una sensibilità delle donne al clima culturale piuttosto che a stimoli economici e di carriera. Dopo il 1926, infatti, ci si sarebbe aspettato semmai un incremento delle iscrizioni femminili alle facoltà scientifiche in risposta a quanto deciso dal decreto del ministro Fedele sui concorsi nelle scuole superiori. Nulla di tutto ciò: le donne, come si è visto, disertarono le facoltà scientifiche e si iscrissero numerose ai corsi di indirizzo umanistico. Una terza sinergia, ancora una volta negativa per le scienze, si realizzò tra gli anni Sessanta e Settanta, quando la riforma aprì le porte dell’università anche agli studenti e alle studentesse provenienti dagli istituti tecnici e professionali. Si era in piena guerra fredda e il clima era ovunque più ostile nei confronti della scienza e degli scienziati, in particolare tra i giovani e le femministe.160 In quegli anni, mentre il numero gland, Aldershot, Variorum, 2000; A. Daum, Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert, München, Oldenbourg Verlag, 1998; Govoni, Un pubblico per la scienza, cit.; G. Cantor, S. Shuttleworth (eds.), Science seriliazed: Representations of the sciences in the the Nineteenth-century periodicals, Cambridge, Mass., MIT press, 2004. 160. Sulla cosiddetta seconda onda del femminismo in Italia, si veda T. Bertilotti, A. Scattigno (a cura di), Il femminismo degli anni Settanta, Viella, Roma, 2005. Circa lo scarso interesse dei movimenti femminili nei confronti della scienza, la testimonianza di una protagonista d’eccezione è in E. Fox Keller, Sul genere e la scienza, presentaz. di P. M. Manacorda, Garzanti, Milano, 1987 (1 ed. orig. Yale, 1985), p. 18. Tuttavia, circa l’importante influenza del femminismo nel farsi della scienza del Novecento, si vedano L. Schiebin- 288 / DONNE E SCIENZA NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE delle laureate crebbe nel complesso in modo esponenziale, calò in modo altrettanto importante quello delle iscritte alle facoltà scientifiche (la contrazione delle iscrizioni scientifiche maschili, lo ricordo, si sarebbe prodotta negli anni Ottanta). Anche in questo caso sembra evidente una sinergia tra eventi culturali, internazionali e nazionali, movimenti giovanili e femministi, spesso critici nei confronti della scienza, e interventi nazionali nel campo dell’educazione, come la riforma della scuola superiore e la nascita della cosiddetta università di massa. Infine, i dati relativi al riavvicinamento delle donne alla scienza negli ultimi anni – un fenomeno che ancora non si osserva tra gli uomini – sembrano prodursi in un momento in cui nuove riforme dell’università e discussioni intorno a esse avvengono in un clima, nazionale e internazionale, nuovamente favorevole alla scienza.161 ger, Has feminism changed science?, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999 e A. N. H. Creager, E. Lunbek, L. Schiebinger (eds.), Feminism in twentieth-century science, technology, and medicine, The University of Chicago Press, 2001. 161. Per il ricco panorama delle attività in questo settore, si vedano N. Pitrelli, G. Sturloni, (a cura di), La comunicazione della scienza. Atti del I e II Convegno Nazionale, intr. di P. Greco, prolusione di P. Rossi, SISSA, Zadigroma, Roma, 2004 e Id., Id., (a cura di), La stella nova. Atti del III Convegno annuale sulla comunicazione della scienza, Polimetrica International scientific publisher, Milano, 2005. GLI AUTORI E LE AUTRICI / 289 GLI AUTORI E LE AUTRICI Paola Bertucci collabora con il CIS. È autrice di diversi articoli sulla storia culturale dell’elettricità nel Settecento e ha curato, con Giuliano Pancaldi, il volume Electric bodies. Episodes in the history of medical electricity (Bologna, 2001). Ha recentemente completato una monografia intitolata Viaggio nel paese delle meraviglie. Scienza e curiosità nell’Italia del Settecento, che sarà pubblicata da Bollati Boringhieri nel 2007. Marco Bresadola è ricercatore di storia della scienza all’Università di Ferrara. Si occupa di medicina e scienze della vita tra Sei e Settecento, argomento su cui ha pubblicato articoli in riviste italiane e internazionali. È curatore, con Giuliano Pancaldi, di Luigi Galvani International Workshop (Bologna, 1999). È autore di Una università “riformata”. Scienza e medicina a Ferrara alla fine del Settecento (Ferrara, 2003) e, con Marco Piccolino, di Rane, torpedini e scintille. Galvani, Volta e l’elettricità animale (Torino, 2003). È in corso di stampa presso L. Olschki il secondo volume dei Quaderni di osservazioni di Antonio Vallisnieri, di cui Bresadola ha curato l’edizione critica. Christian Carletti è dottorando in storia della scienza presso l’Università di Bari e collabora con il CIS. I suoi studi riguardano la scienza dell’elettricità in Italia nell’Ottocento e i rapporti tra ricerca sperimentale e innovazione tecnologica. È stato visiting fellow presso l’Office for History of Science and Technology dell’Università di California a Berkeley e, insieme con Giampietro Berti, sta curando la pubblicazione dell’inventario degli strumenti del gabinetto fisico dell’Università di Padova nel 1849. Ariane Dröscher è professore a contratto di Storia della biologia all’Università di Bologna e di Filosofia della scienza all’Università 290 / GLI AUTORI E LE AUTRICI di Bolzano. Le sue ricerche vertono sulla storia della biologia e delle istituzioni scientifiche italiane e sui rapporti tra scienza tedesca e scienza italiana tra Otto e Novecento. È autrice di numerosi saggi e di due libri: Die Zellbiologie in Italien im 19. Jahrhundert (Halle, 1996) e Le facoltà medico-chirurgiche italiane, 1860-1915 (Bologna, 2002). Paola Govoni è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di filosofia, collabora con Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bologna e con il CIS. I suoi studi vertono sui rapporti tra scienza e pubblico e tra donne e scienza in età moderna e contemporanea. È autrice di Un pubblico per la scienza. La divulgazione scientifica nell’Italia in formazione (Roma, 2002) e di Che cos’è la storia della scienza (Roma, 2004). Anna Guagnini è ricercatrice confermata presso il Dipartimento di filosofia dell’Università di Bologna e collabora con il CIS. Le sue indagini vertono sulla ricerca tecnologica e sui processi di invenzione, innovazione e sviluppo tra Otto e Novecento, con particolare riguardo per la storia delle applicazioni industriali dell’elettricità. È autrice, con Robert Fox, di Laboratories, workshops, and sites. Concepts and practices of research in industrial Europe, 1800-1914, (Berkeley, 1999), e ha curato, con Ian Inkster, Patents in History, numero speciale di History of Technology (24, 2002). Massimo Mazzotti è docente di antropologia e sociologia della scienza presso l’Università di Exeter e professore a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna. La sua ricerca si concentra sulla dimensione sociale della conoscenza matematica e delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto italiano. È stato research fellow del Dibner Institute (MIT), Kenneth May Fellow presso la University of Toronto e collabora con il CIS. È autore di Another Enlightenment: The world of Maria Gaetana Agnesi, in corso di stampa. Raffaella Seligardi è dottoressa di ricerca in storia della scienza e collabora con il CIS. Ha pubblicato vari articoli sulla storia della chimica e della farmacia a fine Settecento e sui laboratori di chimica e di farmacia in Italia nella prima metà del XX secolo. È autrice di Lavoisier in Italia. La comunità scientifica italiana e la rivoluzione chimica (Firenze, 2002). È membro del Consiglio direttivo del Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica. INDICE DEI NOMI Abbri, F., 73, 79, 82, 85, 93, 94, 97 Abetti, G., 145 Adams, W. G., 198 Adelmann, H. B., 17, 18, 23, 37, 38, 40 Adet, P. A., 85, 86 Afflerbach, V., 255 Agnesi, M. G., 12 Agrimi, J., 21, 26, 27 Aitken, H. G. J., 176, 195, 209 Albertoni, P., 234 Algarotti, F., 5, 55 Allen, H. W., 208 Amatori, F., 121 Ambrosoli, L., 105 Amici, G. B., 157 Amoretti, C., 73 Ancarani, V., 163, 274 Andria, N., 91 Angelini, A., 52, 55 Angrisani, T., 274 Anzoletti, L., 267 Appleby, E., 208, 210 Appleyard, R., 190 Araldi, G., 48, 49 Arato, F., 73 Are, G., 241 Aréjula, J. M. de, 87, 101 Ariosto, L., 128 INDICE DEI NOMI / 291 Armani, G., 105 Atti, G., 122 Aubin, D., 143, 158 Avesani, B., 11, 110, 123, 128-141 Avesani, G., 128 Babacci, M., 259 Babini, V. P., 245, 252 Baccelli, G., 234 Baccini, I., 255 Badino, M., 274 Badoni, G., 108 Baeri, L., 274 Baker, E. C., 188 Baker, W. J., 176 Bakunin, G. S., 250, 261 Bakunin, M., 250, 263-264, 266, 274 Bakunin, M. A., 261 Baldi, D., 274 Ballestrero, M. V., 277 Bannatyne, J. F., 207, 208, 210, 211 Banti, A. M., 121, 241 Barazzetti, D., 250 Barbagli, M., 256, 286 Bardini, C., 121 Barisani, M., 128 Barni, T., 274 Barocelli, T., 274 Barras, V., 35 292 / INDICE DEI NOMI Barsanti, G., 73, 122 Barty-King, H., 206 Baseggio, G., 49 Basile, B., 19, 35 Bassett, A., 210 Bassett, H., 207 Bassett, T., 210 Bassi, L., 5, 54, 56-57, 65 Becagli, V., 73, 122 Beccàri, G. A., 255 Beccari, I. B., 52, 53, 55 Becchetti, P., 153 Belfanti, C. M., 111 Bellassai, S., 250 Bellatalla, L., 244, 274 Bellini, L., 32 Belloni, L., 17, 254 Beltrano, M. C., 143 Benassi, E., 19 Benguigui, I., 58 Benigni, E., 259-260 Bennett, C. F., 207 Bennett, J., 158 Bensaude-Vincent, B., 286 Benzi, U., 25 Berengo, M., 48, 109, 121 Beretta, G., 136 Beretta, M., 82 Bernabeo, R., 22, 40 Bernardello, A., 113 Bernardi, W., 17, 94 Berthollet, C. L., 76, 85, 96 Berti, G., 11, 289 Bertilotti, T., 239, 257, 287 Bertoloni Meli, D., 17, 18, 19, 20, 22, 26, 40 Bertucci, P., 9, 10, 47, 51, 52, 61, 62, 63, 68 Beseghi, E., 244 Betri, M. L., 106 Bevilacqua, F., 78 Biagioli, G., 108 Bianchi, G., 53, 54, 63-64, 67 Bianchi, M. C., 274 Bianchi, P., 241 Bienkowski, 97 Bigatti, G., 108 Bigazzi, D., 106, 121 Bigg, C., 143 Bisson, E., 263 Black, J., 81, 85 Blackwell, E., 253 Blaserna, P., 163, 257 Boehm, K., 178 Boffito, G., 158 Bombardi Lavezzo, A., 266 Boncompagni, G., 36 Bondolfi, O., 264 Bonfiglioli, S., 37 Bonfitto, T., 274 Bonghi, R., 160, 172 Bònoli, F., 169 Bonomi, E., 264-265, 266 Bonvicino, C. B., 95 Bonzi, G., 55-56, 58 Borella, P., 127 Borelli, G. A., 23 Borghese, M., 35-37 Borghesio, E., 265 Borsieri, C., 266 Bortolotti, E., 261, 264 Bose, G. M., 51 Bottazzi, F., 234 Bottazzini, U., 162 Bottero Pagano, E., 251, 255, 257, 266 Boulton, M., 205 Bouquot, 62 INDICE DEI NOMI / 293 Bowman, F. H., 182 Boyd, J., 253 Bramwell, F., 200 Braun, F., 183 Brenni, P., 152 Bresadola, M., 5, 8, 9, 51 Bret, P., 72, 81 Brezé, G. B. A., marchese di, 95 Bricarelli, C., 145 Brioschi, F., 170 Brisson, M. J., 90 Brizzi, G. P., 215, 216, 274 Brock, M. G., 248 Brock, W. H., 286 Brooke, C. N. L., 248 Brooke, E., 27 Brugnatelli, L. V., 78, 79, 81, 82, 83, 84, 92, 95, 96, 100, 101, 103, 104 Bruschettini, A., 258 Bryant, M., 243 Buffoni, L., 149, 152, 153 Burgio, A., 253 Burns, E., 187 Burrow, J. W., 272 Buzzetti, D., 7 Buzzoni, D., 127 Cacchiatelli, P., 144 Cacciatore, G., 163, 164, 167 Cadet de Gassincourt, L. C., 90 Cafagna, L., 105, 108, 121 Caizzi, B., 122 Calcagno, G. C., 94, 130 Calderara, P., 127 Calvi, G., 264 Cameron, J., 182 Cammelli, A., 239, 240, 241, 245, 255 Campiglio, A., 127 Cannizzaro, S., 251 Cantarella, E., 109 Cantor, G., 287 Canuto, G., 274 Capua, L. di, 32 Capuano, F., 82 Caracciolo, A., 150, 162 Caravale, M., 150 Carletti, C., 10, 11 Carlisle, A., 84 Carlson, W. B., 175 Carpmael & Co., 179, 180, 182, 184, 185 Carpmael, A., 180, 182, 184 Carpmael, E., 180, 182, 184 Carr, G. A., 187 Carradori, G., 79, 81, 84, 93, 100, 101, 104 Casalena, M. P., 257, 267 Casellato, S., 238, 245 Castellani, G., 171 Castelli, T., 274 Castelnuovo, G., 263 Cattaneo, C., 105. 107, 109 Cattani, G., 257-259, 266 Cavazza, M., 5, 18, 52, 56, 57, 246 Cavendish, H., 93 Celli, A., 234 Ceranski, B., 56, 245 Cerruti L., 72 Cervi, A., 28-29 Chabot, F., 241 Chapman, D. H., 210 Chapman, J. B., 190 Chinnici , I., 143, 145, 158, 163, 167, 169 Chomel, N., 49, 50 Christen-Lécuyer, C., 246 Christensen Nelson, C., 256 294 / INDICE DEI NOMI Ciardi, M., 94, 111 Ciccone, A., 286 Cigna, G. F. , 90, 95 Cingano, F., 286 Cini, T., 138 Cinque, G., 260 Cioni, G., 93 Cipolla, C. M., 240 Cipollone, P., 286 Clark, B., 170 Clark, W., 48 Cleter, G., 144 Coccia, A., 41 Coduri, R., 265 Cohen, J., 108 Colli, A., 121 Colombini, E., 249 Colombo, A., 216 Colucci, L., 105 Comi, T., 274 Cominzoni, A., 136 Concornotti, E., 264, 266 Conrad, L. I., 28 Conte A., 267 Cooper, M., 190 Cordelia, v. Tedeschi Treves, V. Corio, V. M., 261 Cornelio, T., 32 Cornoldi, G. M., 160 Court, S., 96 Crawford, A., 81, 93, 94 Creager, A. N. H., 288 Credaro, L., 268 Crell, L., 78, 81, 88, 96, 102, 103 Crema, N., 264 Crepas, N., 121 Crepax, N., 105, 108, 121, 122 Crespi, M., 53 Crisciani, C., 21, 26, 27 Croce, B., 263, 270 Crosland, M., 87, 88, 96, 102 Curie, M., 269 Curley, J., 145 Curthoys, M. C., 248 Da Pantano, M., 215 Dal Negro, P., 49 Dal Prete, I., 57 Dall’Ara, R., 263 Dam, H. J. W., 198 Darnton, R., 48 Darracq, 103 Darwin, C., 259 Daum, A., 287 Davis, H. J., 178-179, 184-188, 199201, 203-206, 208-212 Davis, J., 162 De Giaxa, V., 234 De Giorgio, M., 241, 244, 265 de la Métherie, J. C., 76, 77, 84, 85, 86, 88, 94, 95, 96, 103 De La Rue, W., 148 de Luc, J. A., 87, 88 De Mauro, T., 213, 243 De Sanctis, F., 268 de Sousa, L., 193 De Vivo, F., 244 Deiman, J. R., 79 Del Negro, P., 122 Della Peruta, F., 109 della Riccia, A., 196 Delpiano, P., 73 Delzoppo, P., 66 Denza, F., 143, 158, 168 Desimone, L., 264 Di Bello, G., 257 Di Cori, P., 250 Di Federico, G., 253 INDICE DEI NOMI / 295 Di Francia, A., 239, 241, 244 Di Giandomenico, M., 5 Di Vestea, M., v. Fischmann, M. Dibattista, L., 7 Dickson, S., 101 Dietrich, P. F., baron de, 96 Dinges, M., 35 Dollard, C., 248 Dolza, D., 269 Dolza, L., 110, 111 Donadoni (vescovo di Sebenico), 57 Donati, G. B., 157, 158, 168 Doni, C., 19 Dood, K. J., 107 Dooley, B., 48 Doroshenko, S. I., 8 Dröscher, A., 13, 14, 216, 238, 272 Dunlap, O., 176 Dutour, E.-F., 60 Dutton, H. I., 178 Edge, D., 8 Edison, T. A., 175 Einstein, A., 265 Ellerby, S. W., 207 Emery, C., 261 Enriques, F., 260 Eschbach, E. S., 239 Evans, R., 62 Fabaro, L., 274 Fabbroni, G., 79 Fabri, C., 250, 260 Fabri, R., 260 Fabris, E., 274 Faithful & Owen, 201 Falciasecca, G., 177 Fambri, M., 274 Farné Velleda, M., 257 Faye, H., 166 Fedele, P., 272, 287 Federico, G., 108, 122 Ferguson, T. A., 210 Ferraresi, A., 111 Ferrari, B., 263 Ferrari, G., 146 Ferraris, C. F., 216, 252, 268 Ferraro, M., 17 Ferrero, A., 192, 195 Findlen, P., 48, 56, 57, 245 Finzi, R., 171 Fioravanti, G., 274 Fiorentino, C., 148 Fischmann Di Vesta, M., 250, 261, 266 Fiuman, C., 136 Fleming, J. A., 183, 198 Foà, A., 265, 266 Foà, I., 266 Foderà Serio, G., 169 Fontaine Maury, M., 145 Fontana, F., 73, 78, 91, 92, 93, 95, 104 Fontana, G. M. U., 95 Fourcroy, A. F., 76, 83, 96, 100 Fox Keller, E., 287 Fox, R., 72 Frängsmyr, T., 6 Franchini, V., 271 Francolini, A., 265 Freda, E., 274 Fregonese, L., 78, 265 French, R., 18 Freschi, G., 138 Friedel, R., 175 Fugazza, M. C., 105 Furetière, A., 50 296 / INDICE DEI NOMI Furlani, R., 239, 241, 267 Fusinieri, A., 156, 157 Gàbici, F., 260 Gagnatelli, E., 261 Galbani, A., 261, 264 Galiani, A., 265 Galilei, G., 155 Galison, P., 166 Galvani, L., 5 Gardini, I., 266 Garofalo, S., 49 Garratt, G. R. M., 191, 196 Garrett, E., 253 Gasparini, L., 143, 153 Gaudiano, A., 53 Gauvin, J.-F., 60 Gavazzi, P., 148 Gavey, J., 190 Gemelli, B., 17, 20, 33, 35 Generali, D., 33 Genovesi, G., 241, 244 Gentilcore, D., 26 Gentile, Giovanni, 269, 274, 275277, 287 Gentile, Giuseppina, 266 Gereschi, D., 261 Gherardi, P. E., 50, 51, 57-58 Ghigi, A., 262 Giannetti, R., 121 Giannetto, E., 274 Gibb, D. E. W., 194 Gibelin, J., 92 Giglioli, P. P., 170 Gioannetti, V. A., 95 Giobert, G. A., 79, 81, 82, 92, 94, 95, 99, 101, 103 Gioeni, G., 81 Giordano, R., 274 Giorgi, C., 255 Giorgi, F., 93 Giorgi, P., 5 Giulio, C., 95 Giusti, R., 108 Glänzel, W., 8 Gobbo, R., 105 Golgi, C., 225, 234, 254, 259, 264 Golinski, J., 48 Goodbody (famiglia), 221 Goodbody, M. T., 207 Goodbody, W. W., 210 Göttling, J. F. A., 82, 83, 100 Gouzévitch, D., 148 Gouzévitch, I., 148 Govoni, P., 17, 48, 162, 245, 253, 285 Graf, A., 259 Graham, J. C., 182, 183, 204, 205 Gramatowski, W., 145 Grandi, G. B., 28-29, 38 Grassi, A., 265 Grassi, G. B., 265 Greco, P., 288 Griselini, F., 57 Groppi, A., 255, 277 Guagnini, A., 12, 13, 180 Guazzo, V., 111 Guerrini, A., 19 Guidi, G., 274 Guidotti, L., 248 Guiniggi, F., 37 Gullino, G., 106 Guyton de Morveau, L. B., 96, 101 Habermas, J., 48 Hahn, R., 8, 61, 112 Haitun, S. D., 8 Hardy, K. A., 8 Hardy, E. J., 263 INDICE DEI NOMI / 297 Harkness, W., 163 Hassenfratz, J. H., 85, 94 Hearnshaw, J. B., 158 Heilbron, J. L., 6, 51, 60 Hermbstaedt, S. F., 86 Holmes, F. L., 6, 74 Houbre, G., 246 Hozier, H., 194 Hudson, P., 8 Hufbauer, K., 71, 81, 158 Hughes, T. P., 175 Hunt, B. J., 188 Hutchinson, E. M., 211 Hutchinson, S. M., 211 Infelise, M., 48, 49, 50 Ingen Housz, J., 78, 92 Inkster, I., 12 Israel, P., 175 Jackson, H. B., 189, 191, 194 Jacquin, N. J., 99 Jallabert, J., 55, 58, 59, 64, 66 Jameson Marconi, A., 177, 179, 199, 201-202, 204 Jameson, A., 201 Janssen, J., 158 Jarausch, K. H.,8 Jesi, F., 173 Jex-Blake, S., 239, 250, 253 Jolly, W. P., 176 Jones, C., 166 Jordanova, L., 245 Kelvin, Lady (Frances Anna Blandy), 198 Kelvin, Lord (William Thomson), 198 Kemp, G., 190, 191, 202 Kempe, H. R., 190, 191, 192, 202 Kirchhoff, G., 157 Kirwan, R., 76 Klaproth, M. H., 99 Klemm, L. R., 239, 241, 249 Knoefel, P. K., 73 Koerner, L., 48 Kovalevskaja, S., 248 Kraus, F. X., 66 Kuliscioff, A., 250, 253-256, 259, 266 Kwrathovoska, A., 261 Labriola, A., 254 Labriola, T., 254 Lacaita, C. G., 105, 106, 126, 127, 136, 241 Laforgia, E. R., 105 Lama, L., 252 Lamb, J. C., 194 Lamberti, G., 127 Lambertini, P. (Benedetto XIV), 65-67 Lanaro, S., 241 Landriani , M., 91, 92, 93, 95 Lange, H., 239, 241, 248, 249, 267 Latour, B., 150 Lavoisier, A. L., 74, 76, 77, 81, 85, 86, 90, 92, 94, 96 Lazzarini, A., 108 Le Fèvre de Gineau, L., 77 Leardi, Z., 264 Lécuyer, C., 246 Lej, E., 248 Lessona, M., 259 Lessona, T., 259 Levi, C., 261 Licini, S., 108 Lloyd Wise, W., 179 298 / INDICE DEI NOMI Lockwood, D. P., 21, 22, 25, 28 Lockyer, N., 163 Lodge, O. L., 181, 193, 208 Long, P. O., 107 Lorenzoni, G., 165 Lorgna, A. M., 97 Loria, G., 259 Louis, A., 59 Luciani, L., 234 Lunbek, E., 288 Lyon, M., 249 Macciotta, C., 274 Maclaurin, W. R., 176 MacLeod, R., 272, 286 Macleod, C., 178 Macquer, P. J., 90 Maestro, I., 264 Maffei, S., 57 Maffiodo, B., 94 Magellan, J., 76 Maggi, P., 136 Magistrelli Sprega, C., 251, 257, 266 Magnani, T., 265 Magrini, L., 108 Maiocchi, R., 214, 235, 236 Majocchi, A., 106, 107, 109 Malatesta, M., 241, 244, 250 Malpighi, M., 8, 9, 17-41, 52 Malusa, L., 160 Mameli, E., 274 Manacorda, P. M., 287 Manara, A., 149, 152, 153 Mandrino, A., 143 Mangoni, L., 272 Mannessier, A., 274 Mannucci, A., 257 Mantegazza, P., 253 Manzini, G., 28 Manzini, P., 82, 94 Marangoni, E., 265 Marchesini, M., 264 Marchis, V., 111 Marcon, E., 216 Marconi, D., 176 Marconi, Giuseppe, 177, 188, 191, 201-202, 204 Marconi, Guglielmo, 12, 13, 176210, 212 Marescotti, R., 18 Mariani, G., 266 Mariola, R., 274 Marivetz, E.-C., 87 Marland, H., 27 Marmiroli, P., 30-31, 40, 45 Marr, A., 62 Marsili, L. F., 52 Martin W., 178 Martina, G., 144, 148, 160, 162 Martinière, A.-A. Bruzen de la, 50 Masi Lessona, A., 259 Masini, G., 176 Masnovo, A., 160 Massarini, I., 259, 266 Mastai Ferretti, G.M. (Pio IX), 144 Mata, M. E., 108 Matellicani, A., 252 Matteucci, C., 13, 214, 221 Mauro, A. M., 274 Maury, M. F., 145 Mazón, P., 239, 248, 249 Mazza, N., 136, 137 Mazzotti, M., 5, 11, 12, 55, 144, 152, 245 McWilliams Tullberg, R., 248 Meadows, A. J., 158 Medick, H., 246 Melis, G., 255 INDICE DEI NOMI / 299 Melloni, M., 156 Mengarini, G., 251 Meschiari, A., 158 Mesini, G., 260 Messbarger, R., 246 Meusnier de La Place, J. B. M. C., 93 Meyer, J. F., 85 Mezzogori, L., 32, 33 Micheli, G., 155 Milocco, S., 49 Minelli, A., 238, 245 Minesso, M., 130 Minuz, F., 245 Mirabella, M., 264 Mistretta, E., 274 Modoni Georgiou, M., 250 Moed, H. F., 8 Molinari, A. M., 275 Mondino de’ Liuzzi, 5 Monge, G., 96 Mongez, J. A., 84 Montalenti, G., 82 Monteforte, P., 265 Montessori, M., 250-251, 257, 264, 266 Monti, R., 260, 263, 266, 274 Monti, S., 49, 50 Mooney, J., 210 Morand, J.-F.-C., 62 More, E. S., 253 Moreri, L., 50 Moretti Foggia, A., 255, 264, 266 Moretti, A., 264 Moretti, Marta, 274 Moretti, Mauro, 215, 274 Morgagni, G., 19, 22, 23, 24, 50, 51, 52, 56 Morozzo, C. L., 76, 94, 95 Morten, Cutler & Co., 183, 194, 200, 201, 204, 205 Moscatello Calderara, G., 274 Moscati, P., 91 Mosso, A., 234 Moulton, H. F., 182 Moulton, J. F., 182, 183, 184 Munster, L., 31 Muratori, L., 49, 50, 57, 58 Musschenbroek, P., 58 Musso, C., 265 Naldi, G. C., 34-35 Nalli, P., 274 Napione, C. A., 95 Nardelli, R. O., 274 Nardini, V., 160 Nastasi, P., 97 Neave, E. W. J., 84, 85 Negri, G., 127 Negrini, A., 253 Nicholson, W., 84 Noble, D., 247, 249 Nollet, J. A. (Abbè), 9, 10, 47, 55, 58-70 Norsa Gurrieri, E., 255, 261-262, 266 Nye, M. J., 8 Obré, H., 207 Odlum, W. H., 210 Offen, K., 246 Olivi, G., 81 Oneglio, T., 274 Opoix, C., 87 Owen, R., 201, 205 Pacinotti, L., 187 Padelletti, D., 239 300 / INDICE DEI NOMI Paets van Troostwijk, A., 79 Pagliani, L., 234 Palazzi, M., 250, 255 Pallotti, V., 94 Pancaldi, G., 5, 6, 7, 9, 10, 51, 52, 68, 78, 83, 136, 173, 239 Pancino, C., 27 Papazafiropulo, A., 264 Paper, E., 248, 250, 257 Pasquali, M., 265 Passione, R., 258 Pasta, R., 73, 122 Pastore Stocchi, M., 48, 49 Pastori, G., 274 Patterson, R. A., 207 Paul, H. W., 272 Pazzagli, R., 108 Pedrocco, G., 94 Pelanda, M., 274 Pennuto, C., 41 Penrose, C., 189, 191 Peretti, A., 262 Pesci, F., 244, 257 Pestre, D., 6 Peter, J., 210 Pianciani, G. B., 156 Piazzi, G., 164 Piccolino, M., 9, 51 Pichler, R., 113 Pieroni Bortolotti, F., 250 Pierpaoli, I., 274 Pigatto, L., 143 Pignatelli, A. (Innocenzo XII), 37 Pigozzi, V. A., 33 Pike (famiglia), 211 Pio IX, 144-145, 150, 151 Piolanti, A., 160 Pisenti, G., 258 Pitrelli, N., 288 Pivati, G. F., 9, 47-55, 57-58, 64, 66-68 Pizzamiglio, P., 144, 146, 150 Plessi, G., 22, 40 Pocock, R. F., 191, 192, 196 Pöet, L., 250, 254 Pohle, J., 145 Poleni, G., 50, 51, 57 Polverari, A., 148 Pomata, G., 21, 29, 34, 239, 246 Porciani, I., 214, 215, 244, 250, 274 Pörner, K. W., 95 Porter, R., 68 Pradella, C., 30-31, 42 Predella, L., 261 Preece, W. H., 180, 181, 182, 187194, 197-200, 204, 207 Pressi, C., 26 Pressyl, F. C., 127 Pressyl, L., 127 Priano, M., 105 Price, D. J. de Solla, 8 Priestley, J., 68, 76, 77, 78, 85, 9193, 104 Proja, S., 155 Proverbio, E., 158 Psalidopoulos, M., 108 Puccini, R., 267 Pugliese, G., 50 Pugliesi, E., 265 Puymaurin, J. P. C. de Marcassus, barone di, 76 Pyenson, L., 60 Quarra, P., 274 Quazza, G., 162 Quinterio, F., 127 Radau, R., 153 INDICE DEI NOMI / 301 Radice, A., 128, 130, 133 Raicich, M., 244, 256 Rambaldi, A., 30 Ramsay, W., 198 Rasmussen, A., 286 Ravà, V., 242, 250, 252, 256, 264 Réaumur, R., 55, 59 Redi, F., 19, 35 Redondi, P., 155, 157, 173 Reeves, B., 163 Respighi, L., 146, 168 Riva, M., 264 Rizzo, G. B., 235 Roberts, L., 48, 68, 79 Roberts, S., 253 Robertson (famiglia), 198 Rocchi, G., 55, 56 Romaro, A., 266 Romiti, G., 223 Ross, G., 210 Rosse, Lord (Lawrence Parsons), 198 Rossi, A., 264 Rossi, C., 274 Rossi, F., 95 Rossi, P., 82, 245, 253, 288 Rossi-Doria, A., 250 Rossi-Giliberti, A., 258 Rossiter, M., 239, 249 Roversi Monaco, F., 6 Rowbotham, S., 256 Rozier, J. B. F., 84, 91, 92 Sacchi, M., 258, 259, 266 Sacchi, Socilla, 274 Sacchi, Stella, 263 Sage, B. G., 87, 88 Salem, V., 266 Saltonstall, W., 83 Saluzzo, G. A., 94, 95 Sama, C. M., 56 San Severino, duca di, 36 Sanchez Navarro-Neumann, M., 154 Sanesi, E., 65 Santoni Rogiu, A., 257 Santucci, A., 245 Savaresi, A., 96, 97 Savary, J., 49, 50 Sbaraglia, G. G., 18, 38 Scalone, F., 240, 244, 255 Scarselli, F., 54, 56, 57 Scattigno, A., 287 Schaffer, S., 48, 63, 68, 150, 166 Scheele, C. W., 92 Schiaparelli, G. V., 149, 152 Schiebinger, L., 287, 288 Schmoch, U., 8 Sciotelle, E., 274 Secchi, A., 11, 143, 145-161, 163-173 Segreto, L., 121 Seligardi, R., 10, 71, 72, 79, 82, 91, 106 Sella, Q., 160, 162, 169 Senebier, J., 91 Sergi, G., 172 Serristori, L., 138 Shapin, S., 34, 63 Shauman, K. A., 279 Sheridan (Messrs), 200, 204 Shipherd, J. J., 249 Short, H., 47 Shuttleworth, S., 287 Sibum, O., 143 Silberston, A., 178 Simili, R., 236, 237, 285 Simon, J., 96 Siraisi, N., 21, 29 302 / INDICE DEI NOMI Smeaton, W. A., 96 Smith, J. P., 207, 211 Smith, R., 210, 211 Smith, W., 208, 210, 211 Snelders, H. A. M., 79 Soave, F., 73 Soldani, S., 244, 277 Soojung-Kim Pang, A., 162 Spallanzani, L., 100 Sperry, E., 175 Stauder, W., 154 Stoppiana, M., 265 Strada, E., 270 Strong, E., 251 Sturloni, G., 288 Toscano, F., 260 Traube, M., 250, 251, 257, 266 Trepp, A.-C., 246 Troja, M., 91 Tucci, P., 149, 152, 153, 158 Turati, F., 253 Turiel, A., 105 Turner, A., 60 Turner, P., 210 Turner, W. H., 189 Tyndall, J., 159 Tabarroni, G., 144, 146, 150 Tacchini, P., 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172 Taddia, M., 85 Tagliacozzo, E., 264 Tagliavini, A., 245 Tassoni, P. C., 28-29, 30 Tattersall, A. R., 186 Taylor, J. E., 190 Tedeschi Treves, V., 255-256 Tega, W., 17 Telmon, V., 244 Terracini, I., 260 Tesla, N., 208 Thompson, E., 175 Thompson, S. P., 193, 198 Tihavsky, F., 99 Tikhonov, N., 248 Todaro, S., 265 Tollard, H., 102 Tomasi di Lampedusa, G., 167 Tomasi, T., 244 Tondi, M., 96, 99 Vaccà Berlinghieri, L., 92, 93, 95 Valentini, L., 264 Vallisneri, A., 9, 20, 33, 41 Valotti, B., 177 Van Mons, J. B., 81, 83, 84, 100, 102, 103 van Raan, A. F. J., 8 Vanneschi, A., 167 Vanni, E., 264 Vanzetti, C., 130 Varni, A., 216, 255, 274 Vasco, E., 155 Vasta, M., 110, 111 Vauquelin, N., 83, 100 Vecchi, A., 274 Vecchi, E., 274 Venturi, G. B., 100, 103 Venturini, M. F., 264 Veratti, G., 56-57, 63, 65-67 Verger, J., 215 Viganò, F., 127 Villari, P., 268 Vivanti, A., 274 Udías, A., 154 Ulivieri, S., 244 Urqhuart, D., 199-200, 203 INDICE DEI NOMI / 303 Volta, A., 74, 78, 79, 81, 83, 84, 91 Voltaire, 59 Volterra, V., 260 von Born, I., 99 von Ruprecht, A., 81, 96, 99 Watt, J., 76, 205 Wear, A., 28 Wedenison, T., 261 Wedenissow, T. v. Wedenison, T. Wiles, T., 207 Wilson, F., 207 Winkler, J. H., 58 Wynne, F., 199-200, 203 Xie, Y., 279 Yeo, R., 49 Zagolin, A., 274 Zamagni, V., 241 Zamboni, G., 136 Zancani Montuoro, P., 263 Zaninelli, S., 121 Zanotti, F. M., 50, 54-58, 64-65, 67 Zucchi, A., 130 304 / INDICE DEI NOMI Finito di stampare nel Dicembre 2006 dalla Tipografia Negri Fotocomposizione Linosprint, Bologna
Scarica