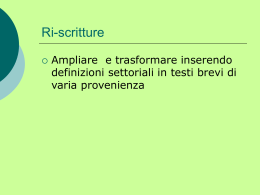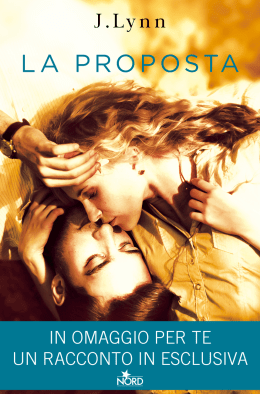1 Estratto da Ingrid Noll, Tutto solo per me Titolo originale dell’opera Der Hahn is tot Traduzione dal tedesco di Barbara Griffini Copyright © 1991 by Diogenes Verlag AG Zürich All rights reserved © 2014 astoria srl corso C. Colombo 11 – 20144 Milano Prima edizione: agosto 2014 ISBN 978-88-96919-89-7 La prima edizione italiana è stata pubblicata da Mondadori nel 1996 con il titolo Il gallo è morto Progetto grafico: zevilhéritier www.astoriaedizioni.it A scuola, come insegnanti, avevo due vecchie zitelle che dicevano sempre di avere perso il loro fidanzato in guerra. Se, come me, non sei sposata né vedova né divorziata, se non hai un compagno fisso o almeno un fidanzato, per non parlare di figli, e non puoi nemmeno vantare qualche storia occasionale, allora, oggi come un tempo, finisce che ti affibbiano un appellativo denigratorio. Comunque sia, io non sono una vecchia zitella come le mie insegnanti. E c’è perfino chi considera positiva la mia condizione: le colleghe sposate invidiano spesso la mia indipendenza, i miei viaggi, la mia carriera professionale, e quando mi attribuiscono qualche romantica avventura vacanziera, io rispondo con sorrisi eloquenti. Guadagno bene e mi tengo in forma. Adesso, a cinquantadue anni, sono meglio di quand’ero giovane. Dio mio, se vedo le foto di allora! Almeno dieci chili di troppo, degli occhiali che certo non mi donavano, scarpe tozze con le stringhe e la gonna a balze. Ero una di quelle donne di cui ci si può fidare per andare a rubare cavalli, come si usa dire, e che con il tempo finisce anche con l’assomigliarci. Perché nessuno mi ha mai detto che si poteva fare diver1 samente? Disprezzavo i cosmetici, senza per questo avere però l’aria del tipo “acqua e sapone”. Avevo un sacco di complessi. Oggi sono sempre in linea e ben curata; per abiti, profumi e soprattutto scarpe non bado a spese. È servito a qualcosa? Ai tempi della gonna a balze studiavo legge. Perché proprio legge? Forse perché non avevo una particolare predisposizione per le lingue, e a essere sincera nemmeno per altre cose, e un po’ ingenuamente pensavo di essermi sistemata bene in quella facoltà neutrale. Sono stata fidanzata con Hartmut per molti anni. Ci eravamo conosciuti il primo semestre. Non è mai stata una passione accecante; studiavamo insieme fino a notte fonda, e poi era troppo tardi per tornare a casa. Così nacque una relazione fissa che, a dire il vero, davo per scontato che sarebbe finita con il matrimonio, due figli e uno studio legale intestato a entrambi. Poco prima della laurea – in quel periodo non avevo in testa altro che codici e paragrafi – Hartmut mi comunicò per iscritto che di lì a poco si sarebbe sposato. Caddi dalle nuvole e non superai l’esame. Hartmut invece si laureò e poco tempo dopo diventò padre. Di tanto in tanto lo vedevo passeggiare nel parco con moglie e carrozzina. Passai un brutto periodo, ingrassavo tragicamente per poi dimagrire di nuovo e per nulla al mondo mi sarei ripresentata all’esame. Mia madre morì proprio in quei mesi, mio padre era già morto da tempo. Non ho fratelli né sorelle; insomma, ero molto sola. Durante le vacanze, tra un semestre e l’altro, avevo lavorato spesso per una compagnia di assicurazioni e assistenza legale. Mi venne offerto un posto come perito; non era niente di eclatante e pagavano male. Tuttavia accettai, perché dovevo cominciare a camminare con le mie gambe, anche se avevo ricevuto una piccola eredità da mia madre. Questa era la mia situazione ventisette anni fa. Rimasi a Berlino per altri otto anni. Feci un po’ di carriera; ero diligente, ambiziosa come una neolaureata e, del resto, non avevo altre distrazioni. Il successo professionale mi fece bene, cambiai anche aspetto, diventai molto più sicura di me, facevo di tutto per mantenere la linea, andavo regolarmente dal parrucchiere e dall’estetista e mi rifeci il guardaroba con costosi abiti in stile inglese. Durante gli ultimi anni a Berlino uno dei principali mi notò e si impegnò a promuovermi. Dopo un intervallo di cinque anni, ebbi la mia seconda storia con un uomo. Forse ne fui addirittura un po’ innamorata, comunque al primo posto per me c’era la gratificazione personale. Quell’uomo mi trovava intelligente, elegante, simpatica e persino carina, e io rifiorii. Non mi importava che fosse sposato. Quando alla fine, due anni più tardi, tutti, compreso l’ultimo fattorino, erano al corrente della nostra relazione, lo venne a sapere anche la moglie. La storia in sé stava già esaurendosi, quando scoppiò il putiferio. Di notte venivo svegliata di soprassalto dal telefono, nella casella della posta trovavo lettere anonime di minaccia, la mia automobile era tappezzata di gomme da masticare e una volta quella donna era addirittura riuscita a svuotare un intero tubetto di attaccatutto nelle serrature delle portiere: ovviamente non poteva essere stata che lei. Visto però che il mio principale di notte non si fermava mai a casa mia, non capivo come la moglie potesse telefonarmi alle quattro del mattino senza che lui se ne accorgesse. Più tardi scoprii anche questo: lui aveva già una nuova amica, dalla quale dormiva eccome. Così sua moglie, tutte le volte che si ritrovava a letto da sola, cercava se non altro di disturbarlo con 2 3 gli squilli del telefono. E naturalmente credeva che lui fosse a casa mia. In quei giorni feci subito domanda di assunzione presso molte assicurazioni in svariate città, però passò un anno intero prima che la cosa andasse in porto. Non m’importava dove sarei finita, volevo solo andare via e ricominciare da capo. A circa trentacinque anni mi trasferii a Mannheim. Non conoscevo la città né nessuno che vi abitasse. Dopo sei mesi, però, mi ricordai che la mia compagna di scuola Beate doveva vivere da quelle parti, in qualche cittadina sulla Bergstrasse. Da quando, dopo la maturità, mi ero trasferita a Berlino, avevamo perso i contatti e in tutti quegli anni ci eravamo viste soltanto una volta a una riunione di vecchi compagni di classe. Quando eravamo giovani, a Kassel, Beate abitava alla fine della mia via. Non saprei dire se altrimenti sarebbe diventata mia amica. Andando a scuola passavo per forza davanti a casa sua, dove mi fermavo e le facevo un fischio. Ero sempre molto puntuale, Beate invece no. A volte avevo l’impressione che si svegliasse proprio con il mio fischio. Dovevo sempre aspettare a lungo prima che si degnasse di comparire sulla porta di casa, e spesso arrivavo a scuola in ritardo per colpa sua. Però non andavo mai da sola, dovevo sempre aspettarla davanti a casa sua. Beate aveva un’amica del cuore e una seconda amica del cuore, e numerose amiche di second’ordine, tra cui io. Per me, invece, c’erano solo due o tre di quest’ultima categoria e soprattutto nessuna amica del cuore. Beate aveva sposato un architetto, della sua vita non sapevo praticamente altro. Quando la chiamai, mi invitò subito a una festa in programma per qualche giorno dopo. Ci andai e vidi l’idillio familiare: tre bambini deliziosi, un marito bello e affascinante, una casa stupenda, una Beate radiosa che aveva cucinato una cena squisita per un sacco di gente simpatica. Tutto come nelle fiabe. In fondo, io ero risentita per tanta felicità. Me ne tornai a casa di pessimo umore e carica di invidia. Eppure, nonostante tutto, ricambiai l’invito, e quando Beate veniva a Mannheim a fare acquisti, dopo la chiusura dei negozi, passava a farmi una visitina. Tuttavia non capitò spesso. Questo rapporto non tanto stretto cambiò improvvisamente quando, dieci anni più tardi, il mondo ideale di Beate andò in frantumi. I bambini deliziosi erano diventati difficili e ribelli, venivano bocciati, fumavano spinelli, rubavano, non rientravano a casa la sera. Il marito affascinante aveva iniziato una relazione con una collega molto più giovane. E, come ai tempi della mia tragedia con Hartmut, lei alla fine restò incinta, lui chiese il divorzio e fondò una nuova famiglia. Beate cadde in una profonda depressione e per settimane intere mi riempì le orecchie con i suoi pianti sia per telefono sia di persona. Lei in qualche modo si sentiva capita da me e io, tutt’a un tratto, avevo la piacevole sensazione di poter aiutare e consolare qualcuno. Solo da quel momento diventammo vere amiche. Del resto Beate non fece la lagnosa a lungo, non era proprio il tipo. E non restò nemmeno amareggiata e chiusa in se stessa, ma si mise a combattere e a lavorare. Naturalmente, una volta che i figli si furono trasferiti altrove per l’università, dovette anche lasciare la casa che venne venduta. Beate ottenne dall’ex marito un appartamento di tre locali e un equo assegno mensile. Ma lei voleva guadagnarsi il pane da sola e così, a quarantaquattro anni, cominciò a lavorare per la prima volta in vita sua per ricevere uno stipendio. 4 5 Certo anche negli anni precedenti non era rimasta con le mani in mano, giacché per far quadrare il bilancio, gestire una famiglia numerosa e un marito stressato c’era voluta una buona dose di diligenza e di capacità organizzativa; anche se nell’ultimo punto non aveva avuto successo. Beate diventò segretaria part-time dei corsi serali, all’inizio solo come assistente. Due anni dopo mandava avanti la baracca ed era completamente realizzata nella sua nuova professione. Beate si entusiasmava per tutti i nuovi corsi ai quali poteva partecipare gratis. Cominciò con quelli di ceramica e di pittura su seta, proseguì poi con la danza del ventre e la meditazione trascendentale, studiò l’italiano e si ritrovò insieme ad altre donne a discutere della propria posizione nella società. A parte Beate, non veniva a trovarmi quasi mai nessuno. Del resto il mio appartamento era troppo piccolo per ospitare molta gente. Beate a volte mi faceva visita senza avvisare e io non avevo niente in contrario. Un’altra eccezione era una collega piuttosto anziana, la signora Römer. Le mancava poco alla pensione e lavorava nella nostra agenzia da un’infinità di anni. La signora Römer sapeva tutto, conosceva tutti e godeva di molti privilegi: aveva una stanza confortevole per lei sola, il che non era giustificato dal lavoro che svolgeva, inoltre poteva portare con sé il suo vecchio cane. Quando, alcuni anni prima, la figlia si era sposata ed era andata via di casa, per la prima e unica volta la signora Römer andò in crisi, perché il cane, del quale fino ad allora si era occupata la ragazza, non poteva rimanere tutto il giorno in casa da solo. Dunque avrebbe dovuto sbarazzarsene, aveva detto lamentandosi, perché abitava troppo lontano per tornare a casa nell’intervallo di pranzo e portarlo a passeggio (non aveva l’automobile). Dopo un po’ la signora Römer era così disperata che tutti noi, colleghi e colleghe, andammo a turno dal principale a intercedere in suo favore per la storia del cane. Alla fine le fu concesso di portarlo con sé in via sperimentale; era un cane vecchio, grasso e pigro, che se ne stava sdraiato sotto la scrivania senza mai muoversi. Il principale, comunque, fece presente a tutti che quella doveva rimanere un’eccezione. La signora Römer aveva anche un’altra peculiarità: una figlia illegittima. Per la sua generazione una scappatella con conseguenze del genere equivaleva a una tragedia e la signora Römer mi aveva raccontato di essere stata letteralmente ripudiata dal padre. Solo quando questi morì, la madre osò riprendere contatto con lei. La signora Römer non parlava mai del padre di sua figlia; se alle feste aziendali, quando l’atmosfera era più rilassata, le veniva chiesto qualcosa in proposito, lei si limitava a dire che era una storia lunga che comunque non voleva raccontare. Anche a me non rivelò mai niente in proposito, benché con il tempo fossimo entrate così in confidenza da diventare quasi amiche. Un giorno, infatti, ebbe un altro problema con il cane. Io mi offrii spontaneamente di tenerle di tanto in tanto il suo beniamino, se ne aveva bisogno. A dire il vero, a me gli animali non piacciono, anzi, i cani mi fanno persino un po’ paura, ma quel povero cocker avevo avuto modo di conoscerlo abbastanza bene in ufficio, per cui pensavo che per un fine settimana sarei riuscita a sopportarlo. La signora Römer era felicissima. Ogni quattro settimane se ne andava via senza il cane, e io mi ritrovavo il grasso cocker sotto il letto. Con il tempo, tra noi due si stabilì persino un rapporto amichevole, tanto che, con mio grande raccapriccio, mi sorpresi a parlargli nella lingua idiota con cui ci si rivolge ai bebè. 6 7 In un certo senso, ammiravo la signora Römer che a suo tempo aveva scelto di avere quella figlia illegittima. Quando ero giovane, prima dell’epoca della pillola, avevo sempre vissuto nel terrore di un’eventuale gravidanza, oggi invece, che non posso più avere figli, me ne rammarico. Quasi quasi mi dispiace non aver almeno sperimentato, come tante donne, un’interruzione volontaria di gravidanza o un aborto spontaneo, perché anche se sono esperienze negative, se non altro mi avrebbero permesso di vivere qualche settimana di maternità. Nella mia vita quest’esperienza manca completamente. E anche le mie vicende con gli uomini non sono state proprio una meraviglia. La storia con Hartmut aveva lasciato una ferita aperta. Anche la relazione con il mio principale berlinese non mi aveva fatto certo bene, il solo ricordo quasi mi umiliava. Dopo quella volta non ho più avuto storie con colleghi, perché non volevo ritrovarmi esposta ai pettegolezzi e alle chiacchiere. In agenzia mi considerano una persona molto perbene, mi rispettano, hanno persino fiducia. In vacanza, negli anni passati, mi è capitato spesso di conoscere qualcuno, ma l’ultima avventura di questo genere risale ormai a cinque anni fa e mi ha lasciato dell’amaro in bocca. Forse ero ormai troppo vecchia per l’amore e dovevo chiudere questo capitolo con un bilancio gravemente in perdita. La signora Römer e Beate, dunque, erano le uniche persone che venivano a farmi visita. Il mio appartamento è minuscolo, sempre in ordine e forse un po’ impersonale. Io non sono un tipo creativo. Purtroppo non so che farmene di musica, teatro, pittura eccetera. Naturalmente leggo, però alla cosiddetta letteratura preferisco un libro di attualità, un giornale economico o un giallo. Qualche volta Beate aveva cercato di intervenire nella mia vita sostenendo che il mio abbigliamento, i miei mobili, il mio gusto erano, nel com- plesso, poco originali. E dire che il gusto e lo stile hanno un ruolo importantissimo nella mia vita, peccato che non sia capace di applicare a me stessa le mie raffinate concezioni estetiche. La casa di Beate, naturalmente, è l’opposto della mia: piuttosto caotica. Tutti quei mazzi di fiori secchi a me darebbero un gran fastidio, così come quei manifesti colorati e quelle cianfrusaglie fatte da lei. Personalmente trovo che Beate si vesta in modo troppo giovanile. Ritengo più decoroso attenersi alla propria età. Tuttavia siamo buone amiche, io in gonna grigia di tweed e camicetta di seta color avorio, filo di perle e twinset – stile Grace Kelly, dice Beate –, lei con i suoi calzoni un po’ folli da cavallerizza e i gilè colorati. I miei mobili: neri e bianchi, di un rigore giapponese, sempre classici e della migliore qualità. I suoi: ogni volta diversi, prima Ikea – tutto legno naturale – poi pitturati da lei in oro e viola. Anche nel resto Beate voleva convertirmi al suo stile di vita. Le faceva piacere portarmi con sé, mi invitava alle sue feste, voleva sempre farmi iscrivere ai suoi beneamati corsi serali. Io le promettevo di accompagnarla di tanto in tanto a qualche conferenza. Alla fine, dopo lungo tempo, decidemmo di andare a sentire una conferenza sulla lirica delle guerre di liberazione antinapoleoniche. Cominciava alle otto di sera e io arrivai da Beate puntuale alle sette e mezza. Già sulle scale udii il suo pianoforte scordato, lasciato in casa da uno dei figli. Beate mi aprì. “Heidi, Heidi, il tuo nido è sui monti,” si sentiva echeggiare. La figlia più giovane era a casa per le vacanze: una ventenne a mio giudizio molto infantile. Beate fece una strana faccia. “Sai, divento nonna!” Entrai e vidi Lenore che cantava seduta al pianoforte. Guardai Beate perplessa. Lei annuì: “Sì, Lessi è incinta!”. 8 9 Ero così sconvolta che mi scappò di dire: “Però si può ancora fare qualcosa!”. Lessi si voltò di scatto e all’unisono con sua madre disse: “Come, scusa?”. Le due non pensavano affatto a un’interruzione di gravidanza, anzi parevano felici. E dire che nella vita di Lessi non c’era proprio niente che andasse per il verso giusto: non aveva il fidanzato, era all’inizio del corso per diventare insegnante di ginnastica ed era completamente immatura. Mi irritai per la mancanza di buonsenso, ma in qualche modo invidiavo quelle due anime innocenti. “Non volermene a male,” disse Beate, “mi ha dato la notizia solo dieci minuti fa e non posso andarmene proprio ora. Sii buona, vacci da sola e domani mi racconti com’è stata!” Me ne andai il più in fretta possibile, e avrei tanto voluto tornare direttamente a casa. In realtà era solo per Beate che andavo a sentire quella solfa letteraria. Se quel giorno fossi rientrata subito a casa, il destino di alcune persone sarebbe stato ben diverso. Dunque ci andai, anche se ero piuttosto distratta. Pazienza, ormai avevo programmato la mia serata così. La piccola sala era gremita. Quando entrò il relatore, tutti applaudirono. Era un tipo prestante, capelli ricci, brizzolato, occhi di un azzurro intenso, abbigliamento disinvolto ma scelto con cura, statura media, piuttosto esile. Senz’altro un bell’uomo, e io dimenticai Beate e Lessi. Quando poi iniziò a parlare, dimenticai anche tutto quello che mi circondava e non ricordo più niente di quello che disse su Ernst Moritz Arndt, Theodor Körner e Friedrich Rückert. La sua voce risuonava così suadente da farmi venire il capogiro, il cuore mi batteva forte, sentivo un certo languore nello stomaco. Non era il famoso amore a prima vista, bensì al primo suo- no. Fu la sua voce calda a esercitare su di me un richiamo erotico così irresistibile che cominciai a sognare e un’ora e mezza dopo ritornai a casa stordita. Una tardona come me, che si prende una cotta del genere, e pensare che ero ormai convinta di essere assolutamente immune al fascino degli uomini belli e delle voci eccitanti. “Quando i vecchi fienili si infiammano…” Il giorno seguente chiamai subito Beate durante l’intervallo di mezzogiorno. Ma per lei l’unico argomento era la figlia incinta e, volente o nolente, dovetti darle retta. Alla fine, però, si decise a domandarmi come era andata la conferenza del giorno prima e così ebbi finalmente modo di chiederle se sapeva qualcosa del relatore. “Be’, sai, i docenti li conosco tutti più o meno bene, lui però non è di qui, verrà da noi al massimo una volta al semestre per tenere una conferenza. A dire il vero, non so proprio dirti niente.” Io non sono certo il tipo che strombazza subito i propri sentimenti confusi, nemmeno all’amica migliore. Per me non c’è niente di peggio che rendermi ridicola. Mi espressi con molta cautela tentando di cavare ancora qualcosa a Beate. “Posso provare a chiedere in giro,” si offrì alla fine, “qualcuno lo conoscerà di sicuro. Inoltre pare che abbia scritto anche un libro.” Il giorno dopo era sabato. Entrai in una libreria di Mannheim, per prudenza evitai quella dove compravo i miei libri di solito, e domandai dell’autore Rainer Engstern. La commessa sfogliò il suo voluminoso catalogo. Infine disse che, sì, certo, esisteva un autore di nome Rainer Witold Engstern che aveva scritto un breve trattato sulla pittura del Trecento, e mi chiese se per caso volessi ordinare quel 10 11 libretto. Naturalmente dissi di sì e che sarei potuta passare a ritirarlo già il martedì seguente. Intanto mi sembrava di essere tornata giovane, anzi adolescente. Solo allora mi era capitato di fantasticare così spesso e di provare desideri altrettanto irrealistici. Mi stavo forse comportando come una ragazzina? Passai l’intero fine settimana a trastullarmi, sorridere, canticchiare e guardarmi allo specchio. Chissà, forse mi vestivo davvero troppo da vecchia? Decisi di comprarmi qualcosa di vezzoso, magari un abitino estivo con la gonna ampia e svolazzante. In effetti avevo sempre avuto gonne dritte, tailleur rigorosi e completi giacca-pantalone; era forse ora di puntare invece sullo stile romantico e svagato? E avrei dovuto liberarmi anche della mia pettinatura abituale, l’ormai trentennale taglio à la garçonne? Ma a che scopo? Quell’uomo non lo conoscevo neppure e lui non sapeva nemmeno chi fossi. Era sicuramente sposato, con figli e un giro di conoscenze completamente diverso dal mio. Ma la sensazione sconvolgente di essere innamorata era già di per sé preziosa, perché ero fermamente convinta che non mi sarebbe capitato mai più. Andai a ritirare il libretto che avevo ordinato. Che persona eclettica, pensai: la conferenza era sulla letteratura romantica, questo volumetto invece affrontava il mondo reale nella pittura del Trecento. Eclettico, oppure tendeva alla dispersione? Sul retro della copertina c’era una breve biografia dell’autore con fotografia. Che uomo stupendo, pensavo continuamente. Aveva tre anni meno di me, era sposato, insegnante, viveva nei pressi di Heidelberg. Aveva studiato germanistica, storia dell’arte e francese. Lessi due volte l’opuscolo. Non avevo mai sentito nominare quella casa editrice, la tiratura era bassa. Il testo lo trovavo intelligente ma con argomenti poco scientifici, per quanto potessi giudicare. Come ho già detto, io non mi interesso di arte ma, a dire il vero, le pantofole, i candelieri, i tessuti e gli edifici raffigurati avevano una loro attrattiva per chiunque li avesse osservati e le descrizioni del loro sostrato culturale erano senz’altro interessanti. Doveva sicuramente essere un ottimo insegnante! La signora Römer mi strappò dal mio mondo dei sogni. Era andata a fare una visita di controllo e sarebbe dovuta entrare in ospedale già la settimana seguente per un sospetto tumore al seno. Affrontava la cosa con forza e coraggio. Mi guardò con aria supplichevole: sapevo che si trattava del cane. Sarei stata molto egoista, se non le avessi offerto subito di farmi carico del suo quadrupede per tutto il periodo della sua permanenza in ospedale. Arrivai addirittura a mentire, sostenendo che ero felice di potermene occupare perché mi avrebbe aiutato a superare i momenti di solitudine. A posteriori mi rendo conto che forse tutto sarebbe potuto andare diversamente se quella volta non avessi avuto in custodia il cocker della signora Römer. Di solito, quando torno dall’ufficio, non ho alcun motivo di uscire un’altra volta di casa. Faccio il bagno, mi infilo la vestaglia, magari lavo qualcosa o mi metto a stirare, mangio e vado a sdraiarmi davanti al televisore. Non è particolarmente esaltante, ma la maggior parte della gente fa altrettanto. Il cane, però, non era d’accordo. È vero che voleva tornare a casa per bere e mangiare – dopotutto aveva passato tutto il giorno in ufficio anche lui – ma poi riteneva di avere diritto, se non altro per abitudine, a una passeggiata. Quando trascorreva con me il fine settimana, a mezzogiorno lo portavo regolarmente al parco mentre alla sera non ne avevo voglia. Fu allora che mi venne un’idea avventu- 12 13 rosa. Scartabellai l’elenco telefonico. Dove abitava il mio Rainer Witold Engstern? O dovevo forse chiamarlo solo Witold? Sfogliai, inizialmente invano, ma alla fine lo trovai. Eccolo: R. Engstern, Ladenburg. Dio mio, adesso, in macchina senza il traffico delle ore di punta, ci sarei arrivata in un quarto d’ora. Trovai persino una cartina stradale di Ladenburg e alla fine scovai la sua via, un po’ fuori dal centro storico. Il cane mi guardava con aria interrogativa. Io mi sentivo giovane e desiderosa di avventure. Avevo ancora una tuta da jogging del mio ultimo soggiorno termale a Bad Sassbach, che di solito non mettevo mai. Me la infilai, legai il cane al guinzaglio, scesi le scale di corsa, montai in macchina e via! Con il cuore che batteva vidi comparire i due campanili della chiesa di San Gallo a Ladenburg. Svoltai nella Weinheimer Strasse e parcheggiai sulla Trajanstrasse che non era nelle immediate vicinanze di casa sua bensì almeno tre isolati più avanti. Quindi scesi, lasciai che il cane annusasse il bordo del marciapiede e gli feci fare una passeggiata cercando di non dare nell’occhio. La zona dove abitava Witold comunque era molto bella: case rurali ristrutturate con gusto e per fortuna non in modo così leccato come nella città vecchia. Nella via in questione erano stati costruiti alcuni edifici nuovi e il numero 29 si trovava quasi in fondo, coperto di vite selvatica. Ovviamente non potevo fermarmi lì a ispezionare la casa. Era ancora chiaro; allora attraversai la strada e camminai sul lato opposto, da dove potevo osservare bene quella villetta monofamiliare. Nessuna luce all’interno, un’aria vagamente abbandonata, ma c’era un’automobile parcheggiata proprio davanti alla porta. Il mio cuore ardito continuava ad avere un battito accelerato, quasi stessi compiendo qualche impresa temeraria. Proseguii ancora per un breve tratto fino in fondo alla via, quindi mi voltai e tornai indietro sul lato opposto della strada, cioè il suo. Vidi così la casa da una prospettiva diversa. Nel giardinetto sul davanti c’erano fiori di malva e digitale, mentre sul retro si scorgeva un frutteto un po’ inselvatichito. Il terreno accanto non era edificato. Liberai il cane e lasciai che andasse a frugare su quel pezzo di terra pieno di ortiche e di verga aurea. Così potei fermarmi per qualche istante. Il cane, però, non aveva più voglia di gironzolare, sicché ce ne andammo. Io ero ancora piuttosto eccitata. Due isolati più avanti dovevamo attraversare la strada, ma siccome era un quartiere tranquillo, pacifico, non prestai troppa attenzione. Un campanello di bicicletta mi strappò bruscamente dai miei sogni. Rimasi con il fiato sospeso. Witold! Stavo quasi per finire sotto le ruote della sua bicicletta. Lui frenò, mi guardò e sorrise. Sorrisi a mia volta, in uno stato di confusione totale e, di nuovo, con quel rombo nelle orecchie. Doveva aver detto qualcosa come “Attenzione!”, ma poi se n’era subito andato. Mi aveva guardato in faccia! Mi aveva sorriso! Ero felice come una bambina. Tornai a casa cantando, abbracciai il cane, lo baciai, andai a letto e non chiusi occhio. Per tutta la notte Witold, seduto sulla bicicletta, con un paio di jeans trasandati e un maglione rosso, mi guardò e mi sorrise. La sera dopo rifeci lo stesso giro alla stessa ora, ma con un abbigliamento curato. Questa volta le finestre al primo piano erano aperte e si udiva appena il suono lontano di una radio. Ebbene, non avevo fretta; ogni giorno avrei potuto riprovare a carpire uno sguardo e un sorriso. Forse il cane sarebbe scappato nel suo giardino e io sarei dovuta andare a recuperarlo, Witold sarebbe stato davanti a un cespuglio di rose profumate con le cesoie in mano, mi avrebbe 14 15 guardato negli occhi, avrebbe sorriso, forse chiacchierato un po’ con me. Continuavo a vagheggiare nuove possibilità. Già il giorno seguente. Avevo promesso alla signora Römer che l’indomani sarei andata a farle visita in ospedale. Intanto avevo saputo che le avevano tolto il seno destro, il che mi lasciò costernata. Uscii puntuale dall’ufficio. In quei giorni lavoravo nella stanza della signora Römer, perché il cane era abituato a stare sotto quella scrivania, con il benestare del principale. Un giorno, dopo anni che il cane si era installato in quel posto, ed era sempre stato zitto e buono, il principale era entrato con aria affabile per chiedere notizie dell’animale, che allora si chiamava ancora Micki o un altro nome altrettanto banale. Quando vide il principale in piedi davanti alla scrivania, il cane cominciò a lamentarsi con voce vellutata. “Senti un po’,” si meravigliò il principale, “hai una bellissima voce da baritono. Sei il Fischer-Dieskau della razza canina?” Da allora Micki si chiamò per tutti Dieskau. Uscita dall’ufficio, montai in macchina con Dieskau e andai direttamente in ospedale. Strada facendo acquistai dei fiori, poi lasciai il cane in macchina e corsi su per le scale linde dell’ospedale. La signora Römer era distesa, con il drenaggio che le usciva dalla camicia da notte, ma per il resto aveva l’aspetto di sempre. Disse che non era stato poi così tremendo. “Sa, ormai ho passato i sessanta e a quest’età non si dà più tanto valore all’aspetto fisico. Se questo intervento mi ha veramente tolto il cancro, non sprecherò più una sola parola al riguardo.” Mi chiese soprattutto del suo Dieskau, fu felice di sapere le nostre avventurose escursioni serali, senza naturalmente che io le dicessi dove eravamo andati. Quel giorno ero in ritardo su tutto. Arrivai a casa solo alle sette passate, dovevo ancora farmi il bagno e mangiare e alla fine mi fermai a lungo davanti all’armadio. Cosa potevo mettermi questa volta? Certo non la tuta da jogging, che era color grigio topo e mi aveva stufato. Un tailleur? No, nemmeno quello andava bene, sarei sembrata di nuovo una perfetta donna d’ufficio. Alla fine mi infilai un paio di calzoni bianchi, un maglione blu scuro e delle scarpe basse. Cominciava appena a imbrunire, e questa volta incontrai Witold nella via parallela, però non in bicicletta. Mi passò di fianco in fretta e furia, senza vedermi, con un’espressione assente; evidentemente voleva fare ancora un salto in centro. La macchina era parcheggiata davanti a casa sua, le finestre erano tutte chiuse, nessuna luce accesa. Tornai con Dieskau alla mia macchina. Quando ci fummo seduti entrambi, cambiai idea, scesi di nuovo e lasciai solo il cane, che tanto non aveva mai niente in contrario, anzi, considerava la macchina come una seconda cuccia. Mi incamminai verso il centro storico. Le strade erano bagnate, doveva essere appena piovuto. Meno male che avevo delle scarpe comode, perché l’acciottolato non era adatto ai tacchi alti. Witold doveva trovarsi da queste parti, magari in un bar. Non ero mai entrata da sola in un bar la sera, e anche con dei conoscenti ci andavo molto di rado. Ero molto incerta. Il primo locale aveva le finestre basse che davano sulla strada, per cui mi fu facile gettare un’occhiata all’interno, però non riuscii a vedere Witold. Nel secondo locale entrai e mi guardai intorno. “Ehi, vieni a cercare il tuo vecchio?” mi domandò un tale decisamente alticcio. Uscii subito e non ebbi più il coraggio di mettere piede negli altri locali. Alla fine scelsi un posto più distinto, mi sedetti in un angolo e ordinai del vino con selz. 16 17 Naturalmente lui non era nemmeno lì. Pagai, passeggiai un po’ sulla piazza del mercato, andai a guardare la fontana con la statua della Madonna in cima a un’alta colonna. Ovunque c’erano i resti delle mura antiche; davanti a una scuola – era quella dove insegnava lui? – lessi: “Verso il 90 d.C. i soldati romani costruirono una fortezza di pietra nei pressi dell’insediamento celtico di Lopodunum”. Forse Witold era andato al cinema? Studiai il programma dei film e mi domandai se fosse il caso di entrare all’ultimo spettacolo. Poi tornai a guardare le vetrine e gironzolai ancora un po’. In una vecchia casa in pietra e legno c’era una festa di nozze, e sopra il portone sventolava una corda da bucato piena di vestitini da bebè. Quando fu buio, tornai un’altra volta davanti alla casa di Witold. Al pianterreno adesso c’era la luce accesa. La strada era deserta, tutto il quartiere sembrava quasi abbandonato; dopotutto era estate, tempo di vacanza. Mi addentrai tra i ciliegi e i noci del terreno vicino fino a raggiungere il giardino di Witold. Sollevai la rete metallica semidivelta e passai sotto senza troppe acrobazie. In ogni caso i calzoni bianchi non erano stati una buona scelta: innanzitutto perché si sporcavano facilmente e poi perché risaltavano troppo nell’oscurità. Le foglie dei noci si stagliavano nere contro il cielo scuro. Dietro un grosso melo ritenni di essere abbastanza al sicuro. Il mio cuore palpitava impazzito. Mi sentivo come una ladra, una persona che non aveva niente a che fare con l’onesta impiegata che ero. Il lato lungo della casa dava sul giardino. Sulla facciata le imposte erano chiuse, probabilmente si trovavano lì l’ingresso, il bagno e la cucina. Attraverso una grande portafinestra scorrevole si vedeva il soggiorno illuminato. Proprio davanti alla vetrata c’era una scrivania alla quale sedeva una persona, probabilmente Witold. Mi avvicinai a tentoni, lentamente e con molta cautela. Alcuni rami bagnati mi strisciarono sulla faccia, un guscio di lumaca scricchiolò sotto i miei piedi. Per fortuna ero circondata da fitti alberi da frutta ancora pieni di foglie, per cui il bagliore della luce non mi raggiungeva. A quel punto riuscii a riconoscere bene l’oggetto del mio desiderio. Stava lavorando alla scrivania. Quaderni di scuola? No, c’erano le vacanze. Forse un nuovo libro, una conferenza per i corsi serali, una lettera. Di tanto in tanto si fermava, con aria pensosa guardava verso il giardino buio, e a me sembrava che mi stesse guardando dritto negli occhi. Ma certo non poteva vedermi. Non riuscivo a staccarmi da quella scena. Sono proprio una guardona, pensai. Witold indossava un paio di calzoni di velluto a coste, scarpe di corda scalcagnate, un cardigan verde senza un bottone e con i buchi sui gomiti. Io non potrei mai sopportare una trasandatezza del genere sulla mia persona: non appena perdo un bottone lo riattacco subito, i maglioni strappati finiscono immediatamente nel sacco per la Croce Rossa. Sua moglie, invece, non doveva essere altrettanto pignola. E poi, chissà dov’era? In salotto regnava un notevole disordine, una coperta di lana scivolata per terra accanto al divano, un’azalea ormai secca sul davanzale, i portacenere stracolmi e cumuli di giornali. La padrona di casa doveva essere una sciattona oppure trovarsi in viaggio o a letto malata, o forse il lavoro la impegnava troppo? In cuor mio speravo che non esistesse affatto. Witold scriveva e scriveva. Di tanto in tanto si toglieva gli occhiali a mezzaluna, magari fumava una sigaretta o camminava su e giù per la stanza. Una volta squillò il telefono. Witold parlò tutto concitato, anzi, arrabbiato, poi all’improvviso buttò giù la cornetta e si accese subito un’al- 18 19 tra sigaretta. Non riprese più a scrivere ma girovagò per la stanza come un leone in gabbia. Quindi telefonò a sua volta a qualcuno, parlò a lungo, tacque, parlò di nuovo a lungo e chiuse di colpo. Quando lasciò la stanza, io sgattaiolai fuori dal labirinto di alberi e per poco non inciampai in un ramo spezzato. Stava lampeggiando. Finalmente mi avviai verso casa; era tardi e io ero in uno stato di confusione totale. In quei giorni persi qualche chilo, benché da tempo ormai non ne avessi più bisogno; dormivo male, avevo le occhiaie e, così almeno mi pareva, molte più rughe sotto gli occhi, inoltre ero tormentata dalle vampate di calore che fino ad allora mi avevano risparmiata. In ufficio stavo seduta davanti al lavoro da sbrigare senza riuscire a concentrarmi, non facevo più straordinari e avevo molta difficoltà a trovare le formule più corrette. Il principale non mancò di notarlo. Con gentilezza constatò che la malattia della signora Römer doveva starmi molto a cuore. “Lei è un eccellente psicologo,” commentai nel tono più cordiale possibile, e lui sorrise lusingato. Il fine settimana uscii a fare acquisti con Beate. Volevo che mi consigliasse. A dire il vero fu un po’ difficile. Alla fine lei tornò a casa con due camicette cangianti comprate da C&A, un golfino da bebè per il nipote in arrivo, una gonna pantalone in saldo e delle strane scarpe con la punta a becco d’anatra. Io invece avevo acquistato un costoso abito estivo a fiori viola e azzurri che avevo provato e tenuto direttamente addosso; era stato l’unico vestito sul quale eravamo riuscite a trovare un accordo. Per strada incontrammo due uomini, Beate conosceva proprio tutti. A quanto pareva, un tempo suo marito aveva costruito una casa per loro. Il primo era grafico, il secondo faceva il compratore per un grande magazzino. Andammo a bere un caffè e Beate flirtò senza ritegno con tutti e due. Del resto, avevo l’impressione che dopo il divorzio lei non si fosse certo ritirata a vita monacale, anche se non mi raccontava niente di quello che faceva, probabilmente per riguardo. Con il mio bel vestito nuovo, le guance arrossate dal caffè e quella sensazione nuova ed eccitante nella pancia, scoprii tutt’a un tratto che sorridendo in un certo modo, emettendo risate gutturali e facendo battere spesso le ciglia riuscivo anch’io ad attirare l’attenzione. Dio mio, chissà perché non l’avevo capito trent’anni prima. Quando i due se ne furono andati, Beate disse: “È una coppia simpatica da morire, vivono insieme da dieci anni. Con loro si chiacchiera che è una meraviglia. Tra l’altro, volevo dirti che ho appena avuto qualche notizia su quel Rainer Engstern”. Avrei tanto voluto gridare: “E perché non me lo hai detto subito!”. Poi pensai con spavento: non sarà per caso omosessuale, visto che Beate lo menzionava in quel contesto? Quanto a me, non sarei mai stata capace di inquadrare correttamente quei due dongiovanni, in questo campo non avevo alcuna esperienza. “Allora, ascolta bene,” cominciò Beate, “Lessi ha un’amica, Eva, che è amica di uno dei figli di Engstern.” “E com’è?” domandai subito. “Non lo so, probabilmente è un ragazzo simpatico, sta facendo il servizio civile.” “No, intendevo il padre!” “Ah, lui insegna a Ladenburg (questo l’ho già scoperto anch’io, pensai), i suoi allievi lo chiamano Engstirn,* però 20 21 * Gioco di parole: Engstern tradotto letteralmente significa “stella Lessi dice che è benvoluto. Una volta, infatti, è andata a casa sua.” “E la madre?” domandai. “Be’, c’è qualcosa che non quadra, pare che sia in viaggio da un sacco di tempo,” rispose Beate. Non osai chiedere di più, ma dentro di me esultavo. Qualcosa che non quadra! Perfetto, forse allora il mio Witold era libero. A casa fui di nuovo tormentata dai dubbi. Ma se era veramente libero, chissà se avrebbe scelto proprio me, ammesso che ci fossimo conosciuti. Adesso mi capitava di stare davanti allo specchio più spesso che negli ultimi vent’anni. Mi osservavo con senso critico. Forse avrei dovuto farmi un lifting, anche se avevo sempre disprezzato questo genere di cose. Lui aveva quarantanove anni, era terribilmente bello e per di più si dice che gli uomini di quell’età certo non prediligono le donne della mia. Per la sera, adesso avevo un programma ben preciso: verso l’imbrunire uscivo con Dieskau per cercare di incontrare l’uomo dei miei sogni. Nell’oscurità mi insinuavo furtiva nel suo giardino, senza cane, e tra l’altro solo con calzoni scuri: ormai avevo una specie di tenuta da lavoro, proprio come un ladro. Qualche volta facevo anche il suo numero di telefono: mai da casa mia bensì da una cabina (troppo spesso avevo letto di dispositivi per la rilevazione delle chiamate). Allora lo sentivo annunciare il suo nome, a volte con voce allegra, altre stanca. Riagganciavo subito e pensavo, è a casa, forse è seduto alla scrivania. Una sera stavo quasi per andare a sbattere contro la sua bicicletta, questa volta stretta”, mentre Engstirn significa “fronte stretta”, ovvero una persona di vedute limitate. (N.d.T.) però deliberatamente. Lui sorrise di nuovo, come la prima volta, e mi disse con la sua voce mozzafiato: “Buonasera, sempre soprappensiero, eh?”. Gli sorrisi anch’io, ma purtroppo non riuscii a rispondergli né con una battuta spiritosa né con una frase intelligente. Dopo due settimane la signora Römer venne dimessa. Io le riportai il suo Dieskau, in parte felice e in parte triste perché avrei perso un compagno. Ma per quale motivo non sarei dovuta andare a passeggio la sera anche da sola? La signora Römer aveva un’altra richiesta che le stava a cuore: ben presto sarebbe dovuta andare a fare una cura, sicché si ripresentava il problema del cane. Sua sorella era allergica ai peli degli animali, sua figlia era negli Stati Uniti per un anno. Ovviamente mi dichiarai subito disposta a ospitare il cane per altre quattro settimane. La prima sera senza Dieskau, non uscii. Del resto, in quelle due settimane erano rimaste indietro molte faccende da sbrigare. Il mio piccolo ménage domestico era quasi degenerato, la cesta della roba sporca era piena fino all’orlo, avevo urgente bisogno di rifarmi il colore ai capelli e una maschera nutriente per il viso. Però mi sentivo come una drogata che solo con un grandissimo sforzo di volontà riesce a trattenersi dall’andare alla ricerca dell’oggetto delle sue brame. Ero proprio un vecchio fienile in fiamme. Il giorno dopo partii senza cane. Stava già imbrunendo quando oltrepassai la casa di Witold, davanti alla porta c’era anche un’altra automobile. Visite! Mi spaventai all’idea che Lessi, la figlia di Beate che era già venuta una volta con la sua amica, potesse casualmente trovarsi lì di nuovo e vedermi. Però sarebbe stata una strana coincidenza; l’automobile, comunque, non aveva l’aria di appartenere a dei giovani, era troppo piccolo-borghese. Gironzolai per Ladenburg fin- 22 23 ché non fu completamente buio. Ormai conoscevo la zona. Protetta dall’oscurità, iniziai il secondo giro di ricognizione. Come l’ultima volta, mi infilai nella piantagione di meli, qualcosa mi entrò in un occhio, e io sentii che il forte palpito del mio cuore era segno di una nuova vitalità. Sì, c’erano visite. A quanto pareva, non si trattava del figlio, bensì di una donna. La grande porta a vetri era aperta e si potevano cogliere brandelli di conversazione. Che fosse la moglie? China, quasi carponi, mi avvicinai ancora un po’. Quella sconosciuta poteva avere circa quarant’anni, ma li portava male. Era magra, con i capelli neri, un viso interessante anche se certamente non bello. Sopra una camicetta color verde intenso portava una collana vistosa in stile orientale. Fumava senza sosta e pareva che anche Witold si fosse acceso parecchie sigarette. Detesto tutto quel fumare come turchi. Se fossi stata sua moglie, gli avrei fatto perdere l’abitudine da un pezzo. Una bottiglia di vino vuota stava rotolando sul pavimento, colpita poco prima da quella donna con un calcio di stizza; sul tavolo c’era un’altra bottiglia incominciata, accanto due bicchieri mezzi pieni. Witold parlava poco e a bassa voce, sicché non riuscivo a capire assolutamente niente di quello che diceva. La donna, invece, gridava con voce stridula, quasi isterica. Tutt’a un tratto capii cos’aveva: era alcolizzata. Non era ancora ubriaca, ma negli anni della mia gioventù avevo vissuto da vicino il declino di una zia alcolizzata e adesso mi sembrava di vederla resuscitata. Doveva trattarsi proprio di sua moglie. Per quanto riuscivo a capire, lei gli stava facendo grandi rimproveri attribuendogli la colpa del fallimento del loro rapporto. Una volta riuscii anche a sentire chiaramente le parole di Witold: “Hilke, è stata la tua ultima opportunità, non avresti assolutamente dovuto interrompere! Adesso ci risiamo da capo!”. Ma certo, Hilke non aveva terminato la cura di disintossicazione, era fuggita. Tra l’altro, in fondo all’ingresso, si scorgevano due borse da viaggio non ancora disfatte. Witold mi faceva una gran pena, quel poveretto non si meritava una moglie del genere. Aveva mandato in malora la casa, il marito e anche i figli! A poco a poco capivo sempre di più l’infelicità di Witold. Anche se era piena estate, sotto i meli umidi faceva un bel freddo. Strisciando carponi, mi avvicinai di un altro metro. Una mela cadde a terra facendo scricchiolare i rami. Per qualche secondo Witold e Hilke sembrarono tendere l’orecchio al rumore, ma poi ripresero a parlare, fumare e bere. Finora avevo assistito a scene del genere solo al cinema. Si sfogavano, si lanciavano ogni sorta di accuse, si accanivano l’uno contro l’altra, si odiavano dal più profondo del cuore. Lei lo chiamava “Rainer”, il che mi andava benissimo, perché per me lui era “Witold”. Li avevo spiati a lungo cercando di non far battere troppo forte il mio cuore, affinché quei due in soggiorno non lo sentissero ticchettare come una bomba. Come era sua abitudine, Witold di tanto in tanto passeggiava su e giù per la stanza e una volta lanciò attraverso la vetrata scorrevole aperta un mozzicone di sigaretta ancora accesa; cadde vicinissimo a me e io già temevo che il bagliore potesse aumentare e tradire la mia presenza. La sigaretta si spense e io decisi che era ora di andarmene. Nonostante la grande eccitazione mi sentivo molto stanca, in fondo era già piuttosto tardi. Proprio mentre stavo per voltarmi, Hilke tutt’a un tratto gridò: “Allora ammazzo prima te e poi me!” e dalla tasca 24 25 della giacca tirò fuori una rivoltella. Per lo spavento caddi sul ginocchio destro facendomi anche piuttosto male. Santo cielo, ma era impazzita? Avrei voluto precipitarmi in casa per fare da scudo a Witold, ma lui, con due grandi passi, l’aveva già raggiunta e le aveva semplicemente tolto di mano quell’arnese. Lei lo lasciò fare senza opporre resistenza. A quel punto non andai più a casa. Trascorsero forse cinque minuti di silenzio, durante i quali i due si limitarono a guardarsi l’un l’altra disgustati, come all’inizio. Witold era seduto sul divano, con la rivoltella in mano. Non sembrava affatto interessato a sapere dove l’aveva presa. Parlarono di nuovo del passato, di altri uomini, di altre donne, della suocera e dei figli, di soldi, anche di quella casa avvolta dalla vite americana. Riuscivo a capire poco perché non conoscevo gli antefatti. Ma improvvisamente Hilke, con voce gelida e tagliente, disse: “Se io non fossi andata a letto con lui, la tua merda non sarebbe mai stata pubblicata”. Witold diventò bianco come un cadavere. Sollevò la rivoltella e sparò alla donna. Il colpo mi fece balzare in piedi, mi precipitai sulla terrazza, in piena luce. Hilke cadde riversa, strabuzzò gli occhi, il sangue le sgorgava dalla camicetta verde. Witold le fu subito accanto, gridò qualcosa, corse al telefono, si fermò di nuovo, prese l’elenco, lo sfogliò, si accorse di non avere gli occhiali a portata di mano, imprecò, guardò di nuovo la donna sanguinante e sembrò perdere il lume della ragione. Entrai nella stanza. Lui non sembrò affatto sorpreso. “Presto, chiami un medico,” mi disse bianco come un cencio, e si accasciò su una sedia. Gli accesi una sigaretta e gli misi in mano il bicchiere. “Adesso provvederò a tutto io,” dissi il più tranquillamente possibile. Lui mi guardò con un’espressione vacua, come se stesse galleggiando sotto una spessa campana di vetro, non bevve né fumò. È sotto shock, pensai. Poi andai dalla donna. Era pallida, non si sentiva più il respiro. Come in un primissimo piano, vidi che la sua collana di corallo, argento e madreperla adesso non risaltava più sullo sfondo verde ma sulla camicetta completamente intrisa di sangue scuro e lucido. “Sua moglie è morta,” dissi. Lui emise un forte gemito. “La polizia,” disse a stento indicando con il bicchiere il telefono. Mi avvicinai all’apparecchio. No, non puoi farlo, mi balenò in testa, sarà condannato, proprio adesso che ci siamo appena conosciuti. Lo metteranno in galera per chissà quanti anni! “Dobbiamo fare in un altro modo,” dissi. “Per un omicidio le danno l’ergastolo, bisogna almeno che passi come omicidio preterintenzionale.” Lui mi guardò disorientato e a un certo punto sembrò che stesse lottando contro un attacco di nausea. “Ha in casa qualcosa di forte?” gli chiesi, perché mi era capitato di leggere che un gesto compiuto in stato di ubriachezza non poteva essere considerato premeditato e intenzionale. Witold cercò l’armadio a tentoni, afferrò una bottiglia di whisky aperta e me la porse. “Adesso stia bene attento,” dissi sforzandomi di esercitare su di lui tutto il mio potere di suggestione, “beva questa bottiglia fino all’ultima goccia. Quando crollerà a terra perdendo conoscenza, io aspetterò ancora dieci minuti, poi chiamerò la polizia. Durante l’interrogatorio lei dirà di non riuscire a ricordare più niente.” Witold voleva ribattere, nonostante lo stato di shock 26 27 trovava che in quel piano ci fosse qualcosa di illogico o di indecente. Ripeté varie volte “ma”, e poi si attaccò alla bottiglia. Evidentemente l’idea che di lì a breve sarebbe finito a terra con la mente annebbiata, sottraendosi per diverse ore alla confusione generale, gli parve tutto sommato una delle possibilità migliori. Beveva e beveva, di tanto in tanto gli andava di traverso e io avevo una gran paura che vomitasse subito tutto. In cinque minuti, durante i quali ci limitammo a guardarci, lui scolò tutto il whisky. Io appoggiai la mia mano sulla sua. “Andrà tutto bene,” gli dissi in tono materno. Lui fece una smorfia come un bambino rimasto solo e provò l’impellente bisogno di distendersi sul tappeto. Bene, e ora? La polizia, pensai. Ma dietro di me sentii un rantolo. Il sangue mi si gelò nelle vene. Mi voltai: Hilke si muoveva, si lamentava, era viva. Questa non ci voleva, Witold doveva essere liberato da lei per sempre. Presi la rivoltella che era proprio davanti a me sul tavolino del divano, andai verso la porta del balcone, mirai al cuore, sparai, e la colpii alla testa. Hilke si ripiegò su se stessa. Witold emise un sospiro, anche se non aveva capito niente. Compresi subito di avere commesso un errore. Sparare una seconda volta perché alla prima non si è mirato bene non può più passare come omicidio preterintenzionale. Adesso bisognava farlo apparire legittima difesa, in fondo era stata Hilke a sparare per prima. Adesso avrei dovuto sparare a Witold da dove era seduta lei. A quel punto, però, cominciai a diventare isterica, provavo soltanto un irrefrenabile impulso di fuggire. Eppure dovevo farlo. Mi misi vicino alla sedia di Hilke e sparai sul tappeto a una spanna dalla gamba di Witold. Witold gridò e gemette di nuovo, e io mi accorsi che la sua gamba sangui- nava. Dovevo averlo colpito, forse solo di striscio. Sollevai la gamba dei suoi calzoni, ma grazie al cielo non era niente di grave, di questo non occorreva che mi preoccupassi. E se qualcuno aveva udito gli spari? Per fortuna la casa era un po’ isolata, accanto c’era il terreno vuoto, gli altri vicini erano in vacanza. Ma proprio tutti? Dovevo andarmene il più in fretta possibile. Uscii dalla portafinestra e strisciai di nuovo sotto i meli. Alt! dissi improvvisamente a me stessa, le impronte digitali! Cosa avevo toccato? Tornai indietro. Ovvio, l’arma, il bicchiere, Witold. Infilai la rivoltella e il bicchiere nella borsa, non avevo più la forza di pulirli. Facevo fatica a non correre. E se qualcuno mi aveva visto? Finalmente raggiunsi la macchina, montai e partii tremando in tutto il corpo. Avevo l’oscuro presentimento di aver sbagliato tutto fin dal principio. Poi mi venne in mente che dovevo assolutamente chiamare la polizia, lo avevo promesso a Witold. Mi fermai a una cabina telefonica che già conoscevo bene. Per fortuna il numero delle chiamate d’emergenza era bene in vista sulla prima pagina dell’elenco, perché al momento non mi sarei ricordata nemmeno il numero di casa mia. Con una voce completamente estranea sentii me stessa dire: “Ho appena udito degli spari…”. Fui subito interrotta, mi chiesero nome e indirizzo. Io però non risposi e gridai: “Andate subito,” diedi l’indirizzo di Witold e riagganciai. Risalii in macchina in fretta e furia e mi diressi verso casa. Quando arrivai, scoppiai in un pianto interminabile. Mi battevano i denti, ero completamente esausta ma al tempo stesso sveglia e lucida. Non riuscivo a immaginare che di lì a poche ore sarei andata in ufficio a lavorare, eppure dovevo farlo, perché di solito non mi ammalavo mai e certo non dovevo dare nell’occhio proprio in questo fran- 28 29 gente. Riempii la vasca d’acqua calda, ci entrai per scongelarmi e fermare il battito dei denti. Non appena fui nella vasca, mi venne in mente con orrore che magari la polizia poteva non aver capito bene l’indirizzo, che forse Witold stava ancora sanguinando, più forte di prima, fino a morire dissanguato per colpa mia, senza potermi più rivolgere né uno sguardo né un sorriso. Dovevo accertarmene, telefonandogli. Ma avevo sempre quell’idea fissa dei dispositivi per la rilevazione delle chiamate. E allora di nuovo in strada, a cercare una cabina telefonica da dove chiamare! Se però qualcuno del vicinato mi avesse visto adesso, in piena notte, in una cabina telefonica, la cosa avrebbe per forza destato sospetti. Però non potevo certo lasciare che Witold morisse dissanguato! Mi costrinsi a uscire dalla vasca, mi asciugai in qualche modo, m’infilai l’accappatoio e presi le chiavi dell’appartamento della mia vicina. Lei era in vacanza e io andavo tutti i giorni a innaffiarle i fiori. Attraversai il pianerottolo, aprii la porta, presi il telefono e composi il numero di Witold. “Pronto, chi parla?” domandò una voce maschile sconosciuta. Riagganciai, era tutto a posto, Witold sarebbe stato medicato e messo in un letto. Ero un po’ sollevata, richiusi a chiave l’appartamento della mia vicina e tornai a immergermi nell’acqua calda della vasca. Se però qualcuno ha visto accendersi la luce in casa della vicina proprio adesso che lei è in viaggio – mi passò per la mente – penserà che è ben strano! E se quelli avevano il dispositivo per la rilevazione delle chiamate, sembrerà più che mai sospetto che qualcuno telefoni dall’appartamento di una donna che al momento si trova in Italia. E poi, santo cielo! Nella mia borsetta c’erano un bicchiere non mio e soprattutto l’arma del delitto. Non avevo più pace in quella vasca. Uscii, mi asciugai per la seconda volta, m’infilai di nuovo l’accappatoio. Avvolsi il bicchiere in un asciugamano che feci sbattere un paio di volte sul tavolo della cucina. Le schegge di vetro le rovesciai nella pattumiera che tanto avrei svuotato il mattino seguente. Avrei forse dovuto far fare la stessa fine anche alla rivoltella? Sarebbe stata una bella imprudenza, dovevo disfarmene in modo più astuto. Alla fine giunsi però alla conclusione che non correvo alcun rischio immediato. Nessuno poteva mettermi in relazione con l’accaduto, a Ladenburg nessuno mi conosceva. Witold non sapeva chi fossi, mi aveva visto tre volte in tutto, di cui due solo di sfuggita e la terza in stato di shock. Inoltre non poteva certo ricordare tutto l’accaduto: quando io avevo sparato i due colpi, lui non era più lucido. Che quadro avrebbe potuto farsi la polizia? Avevo commesso qualche errore, avevo dimenticato in giro qualcosa? No, io non fumo e quindi non lascio mozziconi di sigaretta come prova sul luogo del delitto, né perdo fazzoletti cifrati. Però quando pensai alle impronte che dovevo aver lasciato sul terreno umido del giardino, e poi anche sul tappeto, mi sentii improvvisamente gelare il sangue. Avevo indossato delle scarpe da ginnastica per potermi muovere più agilmente. Di solito non le metto mai, sono un altro ricordo del periodo di cura come la tuta grigio topo. Dovevo farle sparire! Le presi subito e le infilai nel sacco della Croce Rossa già mezzo pieno. Sarebbero passati a ritirarlo la settimana successiva. La rivoltella invece la infilai in una valigia che sistemai nel ripostiglio, ripromettendomi di trovare l’indomani un nascondiglio migliore. 30 31
Scaricare