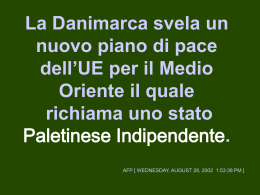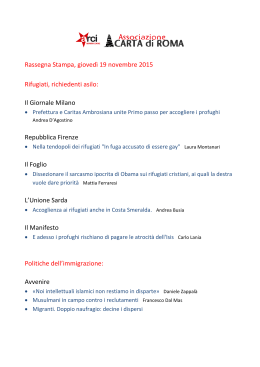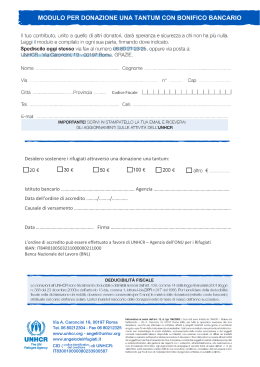Memorie con-divise
Popoli, Stati e Nazioni nel Mediterraneo e in Medio Oriente
Que
sto
ebo
ok a
A cura di Paolo Branca e Marco Demichelis
1
sto
Que
ok a
ebo
r
ppa
e
tien
a
na C
iulia
2
a\nG
In copertina: Ali Hassoun
Arab Spring, olio su tela cm 150x150 2010.
Seconda Parte
Israele – Palestina: memoria, folklore e narrazione
1. IL VILLAGGIO SENZA TEMPO. DINAMICHE POLITICHE
NELLA PRODUZIONE DEL CAMPO RIFUGIATI DI
DHEISHA (WEST BANK) COME LUOGO DELLA MEMORIA
Anita de Donato
2. DINAMICHE DI ESCLUSIONE E DI INCLUSIONE NELLE
NARRAZIONI ISRAELIANA E PALESTINESE SUL
CONFLITTO
Enrico Bartolomei
3. DONNE ISRAELIANE E PALESTINESI, NARRATIVE A
CONFRONTO
Giulia Daniele
4. IL
PATRIMONIO
POPOLARE
FOLKLORE E FOLKLORISMO
Cristiana Baldazzi
PALESTINESE
TRA
Memoria e identità nella letteratura araba contemporanea
INTRODUZIONE
Marta Petriccioli
1. MEMORIA E POTERE: PER UNA RICERCA AZIONE IN
LETTERATURA
Jolanda Guardi
2. MEMORIA E IDENTITÀ NELLA LETTERATURA “ISPANOMAROCCHINA” E NELLA LETTERATURA SAHARAUI IN
LINGUA SPAGNOLA
Selena Nobile
3. NAWWARTUNA - ITALIANO PER ARABI
Giuliana Cacciapuoti
Questo ebook
3
appartiene a\n
Giuliana Cacc
iapuoti
oo
oe
b
st
Qu
e
4.
SECRET SON DI LAILA LALAMI: MEMORIA,
RISCRITTURA DEL PASSATO, INVENZIONE
DELL’IDENTITÀ
Mariangiola Li Vigni
5. LA COSTRUZIONE DELLA MEMORIA COLLETTIVA
ATTRAVERSO IL RICORDO INDIVIDUALE: IL CICLO DI
RAPPRESENTAZIONI
AL-SAHRAIYYA
NEL
TEATRO
EGIZIANO CONTEMPORANEO
Alba Rosa Suriano
Storia e Nation Building in Medio Oriente e Nordafrica: analisi
e prospettive.
1. IL MODELLO DELLA TURCHIA IN PROSPETTIVA
STORICA: LE DIFFERENZE CON IL MONDO ARABO.
Stefano Maria Torelli
2.
“GUERRA CIVILE LATENTE”: RITI CONTESI E STRATEGIE
DI NATION-BUILDING NEL LIBANO DEL DOPOGUERRA.
Enrica Camporesi
3. L’EVOLUTION DE LA CONCEPTION FRONTALIÈRE DU
COLONISATEUR
FRANCO-ESPAGNOL
ET
SES
RÉPERCUSSIONS SUR L’OUEST SAHARIEN, 1900-1960.
Jesús Mª Martínez Milán
4. DALL’ARABIA ALL’AFRICA: DALL’IMPERO INFORMALE
ALL’OSSESSIONE PER IL CONTROLLO
Beatrice Nicolini
4
t
es
u
Q
oo
b
oe
Israele – Palestina: memoria, folklore e narrazione
IL VILLAGGIO SENZA TEMPO.
DINAMICHE POLITICHE NELLA PRODUZIONE DEL CAMPO
RIFUGIATI DI DHEISHA (WEST BANK) COME LUOGO DELLA
MEMORIA.
Anita de Donato
Anita de Donato
Dal
2012/2013,
Dottoranda
in
“Antropologia
della
Contemporaneità: Etnografia delle Diversità e delle Convergenze
Culturali”, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano.
Dal 2013, nomina a Cultore di Antropologia Economica e dello Sviluppo,
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano.
Abstract
La ricerca etnografica che propongo è focalizzata sulla
produzione del campo rifugiati di Dheisha, situato nella West Bank, come
luogo di costruzione sociale della memoria del periodo precedente alla
diaspora e dell’identità dei suoi abitanti, attraverso l’analisi
dell’organizzazione e dell’uso dello spazio messi in atto dai rifugiati e delle
strategie amministrative delle autorità istituzionali. La costruzione del
campo rifugiati come luogo della memoria emerge come un’arena politica
dove si dispiega la competizione tra differenti gruppi d’interesse per la
definizione dello status del campo rifugiati e dei suoi abitanti.
Le strategie di controllo e di amministrazione dello spazio e delle
risorse del campo rifugiati messe in atto dall’ANP e dall’UNRWA1 mirano
al cambiamento dell’interpretazione locale della memoria storica e
culturale dei villaggi d’origine, per stabilizzare il campo rifugiati come
sobborgo proletario ed integrare i suoi abitanti come cittadini dell’ANP.
Di fronte al tentativo dell’UNRWA e dell’ANP di estendere il potere
dell’ANP sullo spazio del campo rifugiati attraverso lo sviluppo delle
infrastrutture e l’amministrazione di risorse e servizi, i rifugiati rivendicano
le condizioni di temporaneità del campo rifugiati, rispetto all’area urbana
1 L’ UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) è un’organizzazione umanitaria
creata dall’ONU nel 1949 con lo scopo di gestire le operazioni di soccorso nei confronti dei
rifugiati palestinesi nei Territori Occupati, in Giordania, Siria ed in Libano, fino al loro ritorno
nelle terre occupate.
5
Qu
circostante, come una forma di opposizione politica finalizzata al
mantenimento del campo rifugiati come luogo della memoria dello status di
rifugiato e del relativo diritto al ritorno alle terre perdute.
I rifugiati mettono in atto una continua e creativa riproduzione
spaziale e simbolica dei modelli culturali e politici e dei legami sui quali si
basava l’organizzazione tribale delle “comunità immaginate” dei loro
villaggi d’origine. In questo modo ricostruiscono il loro mondo sociale,
dando senso alla loro realtà di dispersione, e rivendicano la loro specificità
culturale e politica nei confronti delle forze d’occupazione israeliane,
dell’UNRWA e dell’ANP. Le reinventate tradizioni tribali e le pratiche
rituali costituiscono un idioma di solidarietà incorporato ed esprimono
rivendicazioni legate al contesto economico e politico contemporaneo.
I differenti immaginari del campo rifugiati come luogo “arretrato”
o come espressione di “autenticità culturale” riflettono la costruzione delle
differenze tra il gruppo d’interesse dei cittadini dell’area urbana e quello
dei rifugiati, come strategie politiche messe in atto nel contesto della
crescente competizione per le risorse materiali e simboliche dell’area, e
della loro iniqua distribuzione da parte delle autorità istituzionali.
Lo spazio sociale del campo di Dheisha ed il suo significato sono
soggetti al cambiamento, plasmati dai movimenti e dalle relazioni di potere
tra i suoi abitanti, in relazione alla crescente segmentazione economica
della società nella West Bank, all’istituzione dell’ANP2 ed alle strategie
coloniali messe in atto dalle forze militari israeliane.
oe
est
bo
ok
ne
rtie
pa
ap
Giu
a\n
C
oti
u
ap
6
i
acc
2 L’ANP (Autorità Nazionale Palestinese) è stata creata nel luglio 1994 in seguito agli accordi
di Oslo nel settembre 1993.
aC
lian
THE TIMELESS VILLAGE
POLITICAL RELATIONS IN THE CONSTRUCTION OF THE
REFUGEE CAMP OF DHEISHA (WEST BANK) AS A PLACE OF
MEMORY
This ethnographic research focuses on the production of the
refugee camp of Dheisha, situated in the West Bank, as a place of social
construction of the memory of the period before the Diaspora and of the
identity of its dwellers, through the analysis of the organization and the use
of the space acted by refugees and the management strategies of the
institutional authorities. The construction of the refugee camp as a place of
memory emerges as a political arena in which different interest groups
compete for the definition of the status of the refugee camp and its
inhabitants.
The strategies of management and control of the space and
resources in the refugee camp acted by the PNA and the UNRWA aim at
changing the local interpretation of the historical and cultural memory of
the villages of origin of refugees, in order to stabilize the refugee camp as a
proletarian suburb and to integrate its dwellers as citizens of the PNA.
Facing the attempt of the PNA and the UNRWA to extend the
PNA’s control over the space in the refugee camp through the
infrastructure development and the administration of services and
resources, refugees claim the temporary nature of the camp, compared to
the surrounding urban area, as a form of political opposition to keep the
refugee camp as a place of memory of the refugee status and the related
right of return to the occupied lands.
Refugees undertake a continuous creative spatial and symbolic
reproduction of the cultural and political models and ties on which the
tribal organization of the “imaged communities” of their villages of origin
was, once, grounded. So doing, they rebuild their social world, giving a
sense to their reality of dispersion, and claim their cultural and political
specificity towards the Israeli occupation forces, the UNRWA3 and the
PNA4. The reinvented tribal traditions and ritual practices constitute an
embodied idiom of solidarity and express claims related to the
contemporary economic and political frame.
The different imaginaries of the refugee camp as a “backward”
place or as an expression of “cultural authenticity” reflect the construction
of differences between the interest group of the urban citizens and that of
the refugees, as political strategies acted in the context of the growing
competition for the material and symbolic resources in the area and their
unequal distribution by the institutional authorities.
The social space of Dheisha camp and its meaning are subject to
change, shaped by the movements and the power relations among its
inhabitants, related to the growing economic segmentation of the society in
the West Bank, the institution of the PNA and the colonial strategies acted
by the Israeli military forces.
3 The UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) is an humanitarian organization
created by the UNO on 1949 to manage the relief operations to Palestinian refugees in the
Occupied Territories, in Jordan, Syria and Lebanon, until their return to the occupied lands.
4 The PNA (Palestinian National Authority) has been created on July 1994 following the Oslo
agreements on September 1993.
7
Qu
es
to
iene
ppart
ook a
to eb
Ques
Questa ricerca etnografica è focalizzata sulla produzione del campo
rifugiati di Dheisha, situato nella West Bank, come luogo di costruzione
sociale della memoria del periodo precedente alla diaspora e dell’identità
dei suoi abitanti, attraverso l’analisi dell’organizzazione e dell’uso dello
spazio messi in atto dai rifugiati e delle strategie amministrative delle
autorità istituzionali.
Mentre l’area A5 nella periferia di Betlemme dove è situata
Dheisha, è sotto l’amministrazione ed il controllo delle istituzioni dell’ANP,
la terra dove si estende Dheisha dal 1948 è stata affittata per 99 anni al
governo locale (alla sua nascita era quello giordano) dall’UNRWA, che
amministra il campo rifugiati. L’UNRWA ha la prerogativa di organizzare
lo spazio del campo rifugiati e garantisce l’allocazione di servizi sociali
quali l’edificazione del suo spazio, i servizi sanitari di base, l’istruzione,
razioni di cibo, la raccolta di rifiuti, la manutenzione del sistema idraulico,
fognario e di quello elettrico, ed il controllo della qualità dell’acqua.
La rappresentazione dello spazio del campo rifugiati è oggetto di
competizione tra le forme di conoscenza incorporata messe in atto dai
rifugiati attraverso le pratiche ed il linguaggio del corpo, le strategie
amministrative dell’ANP e la conoscenza esperta dell’UNRWA.
Nonostante l’UNRWA abbia una lista dei gruppi tribali e dei villaggi
d’origine delle famiglie di Dheisha, rappresentando queste dimensioni
d’appartenenza tribali come residui del passato che non influenzano le
pratiche amministrative, l’agenzia essenzializza e riduce la complessità del
reale per scopi amministrativi e di controllo.
Come sostenuto da Abdallah-Latte (Abdallah-Latte 1998),
registrando i rifugiati ed allocando i servizi sulla base della famiglia
nucleare, l’agenzia imprime la tendenza a considerare questa parte della
famiglia estesa come economicamente indipendente, favorendo il processo
di nuclearizzazione familiare e la disgregazione della famiglia estesa, la
principale fonte di sicurezza sociale e del potere di resistenza di ogni
individuo all’oppressione quotidiana. Dall’analisi dei conflitti tra i membri
della famiglia è emerso come tale processo sia già incoraggiato dalla
crescente competizione economica, dall’influenza dei modelli culturali
uliana
a\nGi
puoti
ia
Cacc
CLI_2
0130
5 Gli accordi di Oslo del ’93 hanno deciso la frammentazione della West Bank e della Striscia
di Gaza in differenti zone distinte dalle lettere A, B, C e dalla loro amministrazione. Le aree A
sono sotto l’amministrazione ed il controllo della sicurezza dell’ANP; le aree B sono sotto
l’amministrazione dell’ANP per quanto riguarda gli affari civili, ma sotto il controllo della
sicurezza delle forze militari israeliane; le aree C sono sotto l’amministrazione ed il controllo
della sicurezza delle forze militari israeliane, anche se queste ultime non si occupano
dell’allocazione di servizi alla popolazione palestinese come quelli educativi e sanitari, lasciati
sotto la responsabilità dell’ANP.
1
9691
0303
8
Ques
t
occidentali e dal crescente numero di famiglie guidate da donne (perché
vedove, divorziate o con il marito in un carcere israeliano).
Invece di garantire ai rifugiati il diritto al ritorno alle terre perdute,
favorendo la disgregazione dei legami sociali alla base delle dimensioni
d’appartenenza legate alla cultura politica tribale (la comunità di villaggio,
il gruppo tribale e la famiglia estesa), l’agenzia limita il processo di
riproduzione sociale e culturale della comunità di rifugiati.
Nonostante le strategie amministrative dell’UNRWA considerino i
rifugiati come clienti indistinti e passivi, caratterizzati solo dal possesso
della tessera di registrazione dell’UNRWA, costoro dimostrano la propria
capacità di autodeterminazione e di manipolazione del potere
amministrativo dell’agenzia, appropriandosi dello spazio e delle risorse
simboliche e materiali del campo rifugiati attraverso pratiche individuali e
collettive che eludono e contestano il ruolo decisionale e di controllo
dell’agenzia.
La vicinanza delle case di Dheisha, difficilmente distinguibili l’una
dall’altra, riflette la mancanza di pianificazione nell’edificazione del campo
rifugiati, la cui espansione segue solo la spontaneità e le esigenze quotidiane
delle famiglie.
Durante gli anni ’60 l’ONU ha sostituito le tende nelle quali aveva
accolto i rifugiati intorno al 1949, quando Dheisha è stata istituita, con
locali di cemento della grandezza di 7 m2, inadatti ad ospitare le famiglie
palestinesi. Inizialmente i rifugiati interpretavano la costruzione delle case
come una negazione della temporaneità del campo rifugiati ed una rinuncia
al diritto di tornare alle terre perdute, tradendo la causa comune.
9
Qu
e
s
to e
boo
k
ap
pa
r
t
i
ene
a
\nG
cc
iulia
n
a
Ca
1
LI_
20
iC
ia
p
u
ot
10
Que
sto
ebo
ok a
ppa
rtien
e a\
nGi
ulia
Figura 1: i tetti delle case del campo rifugiati di Dheisha.
Figura 2: una delle vie del campo rifugiati di Dheisha.
Col passare del tempo sono state le stesse famiglie palestinesi ad
ampliare in modo autonomo le stanze in base alle esigenze ed alle
possibilità economiche e materiali (come la profondità delle fondamenta e
la disponibilità di spazio).
11
na C
acc
Questo ebook appartiene a\nGiuliana Cacciap
Anche se il campo rifugiati è stato creato dall’ONU con il senso
della temporaneità in vista di una rapida soluzione della “questione” dei
rifugiati, ha dato ospitalità a diverse generazioni di palestinesi durante
sessanta anni di limbo, come un luogo di permanente temporaneità.
Figura 3: il campo rifugiati di Dheisha intorno agli anni ’50.
Figura 4: il campo rifugiati di Dheisha intorno agli anni ’70.
Nonostante gli edifici all’interno del campo rifugiati ufficialmente
appartengano all’UNRWA, i rifugiati si vendono le case tra loro (o lo
spazio dove costruirle) in modo non ufficiale, mediando il potere
dell’agenzia, che ratifica ufficialmente il cambiamento di residenza deciso
in modo autonomo.
La seguente mappa sociale, tracciata in base alle indicazioni di una
famiglia di Dheisha, mostra la divisione dello spazio del campo rifugiati in
12
puo
ccia
a
C
a
lian
tien
Giu
e a\n
ḥārāt (rioni). La maggioranza delle famiglie che vive in ogni hāra (rione)
appartiene allo stesso villaggio d’origine o alla stessa ḥamūla (gruppo
tribale), dimensioni d’appartenenza che si sovrappongono. In risposta
all’occupazione militare israeliana ed alla repressione messa in atto
dall’ANP e dall’UNRWA, i rifugiati si appropriano della realtà e creano
spazi di manovra per la sopravvivenza, riaffermando collettivamente la
memoria del periodo precedente alla diaspora, attraverso la ricostruzione
spaziale e simbolica delle “comunità immaginate” dei loro villaggi
d’origine, creando ciò che Randa Farah ha chiamato “l’universale
metaforico villaggio d’origine” (Farah; 1998:6).
Lo spazio sociale del campo di Dheisha ed il suo significato sono
soggetti al cambiamento, plasmati dai movimenti e dalle interazioni tra i
suoi abitanti, in relazione al contesto politico ed economico locale. La
mancanza di omogeneità dei rioni riflette i processi di mobilità sociale
intrapresi da alcune famiglie che si trasferiscono dal campo rifugiati. I
gruppi tribali sono frammentati dalla crescente segmentazione economica
che si sovrappone a queste grandi reti di solidarietà, come risultato
dell’integrazione nel sistema di mercato capitalista.
Una frase che mi ha detto un giovane uomo di Dheisha esprime il
ruolo della ḥamūla (gruppo tribale) nella vita degli abitanti del campo
rifugiati: “Se investo qualcuno con la macchina, la ḥamūla viene e mi aiuta,
ma non se la mia famiglia sta morendo di fame”.
Nonostante la ḥamūla (gruppo tribale) abbia cambiato il suo
significato, è ancora uno spazio politico ed una forma di rappresentazione
quando l’onore del lignaggio viene minacciato, come emerge dall’analisi
dei contesti privati dell’ospitalità familiare, del matrimonio e della
negoziazione tribale per risolvere i conflitti tra le famiglie. Il tribalismo non
è un residuo del passato, ma un modello per stabilire relazioni di solidarietà,
un linguaggio in continuo cambiamento.
to
Ques
ar
p
p
a
ok
ebo
13
book
sto e
Que
r
appa
tiene
Figura 5: mappa sociale del campo rifugiati di Dheisha, tracciata
sulla base delle indicazioni di una famiglia del campo rifugiati.
i
a\nG
cc
a Ca
ulian
14
Questo ebook appartiene a\nGiuliana Cacciapuoti CLI_20
Figura 6: legenda della mappa sociale del campo rifugiati
di Dheisha.
La mancanza di riproduzione di spazi pubblici come la maḍāfa,
il luogo dell’ospitalità della ḥamūla (gruppo tribale) istituito nei villaggi
palestinesi prima del ’48 (Hannoyer 1989), riflette l’assenza di forme
collettive di rappresentazione a livello del gruppo tribale e del campo
rifugiati, dovute all’attuale segmentazione economica ed alla mancanza
della condivisione delle risorse nel passato.
Come si può vedere in questa mappa storica le famiglie di
Dheisha provengono da circa 33 villaggi differenti, ognuno con la propria
specifica identità sociale e culturale.
15
st
o
ue
Q
Figura 7: mappa della Palestina storica. I villaggi d’origine delle
famiglie di Dheisha sono evidenziati in giallo.
Il caso che segue riguarda uno di quei pochi villaggi sgomberati, i
discendenti degli abitanti dei quali condividono collettivamente almeno in
parte le funzioni di riproduzione sociale quali la costruzione creativa ed il
16
e
o
o
eb
17
st
6 Alcune persone provenienti da questo villaggio affermano: «Zakaria era famosa per la
cultura dei suoi abitanti. Non in tutti i villaggi le persone studiavano. A Zakaria quasi tutte».
ue
Q
mantenimento della memoria storica e la socializzazione delle nuove
generazioni.
Ogni anno, in occasione della consegna dei diplomi di scuola
media superiore, numerose famiglie originarie del villaggio di Zakaria
partecipano alla premiazione degli studenti che hanno terminato la scuola
secondaria (con particolare riguardo nei confronti di coloro che hanno
ottenuto i migliori voti finali), organizzata dal Comitato del villaggio di
Zakaria, composto da volontari provenienti dal villaggio.
Tale strategia collettiva di resistenza consiste nell’appropriazione
simbolica e nella reinterpretazione della realtà, attraverso il mantenimento
dei legami tra i discendenti degli abitanti di questo villaggio, frammentati
dall’occupazione militare, dal tempo e dalla crescente segmentazione
economica. In assenza della condivisione della terra che legava gli abitanti
del villaggio, la collettività di Zakaria valorizza il livello di scolarizzazione
come un elemento sulla base del quale costruire e mantenere nel tempo
l’immagine distintiva del proprio villaggio. Proiettando nel presente un
elemento eletto come simbolo del passato ed accorciandone così le distanze,
assegna alla scolarizzazione il significato di simbolo della continuità storica
e culturale e nello stesso tempo valorizza e stimola l’unica fonte di mobilità
socio-economica individuale e collettiva, conciliando la resistenza
simbolica all’occupazione israeliana con quella materiale. La rivendicazione
della specificità culturale del villaggio di Zakaria rispetto ad altri villaggi
sgomberati concorre alla formazione di un senso d’appartenenza costruito
anche sulla differenziazione dall’”altro” rifugiato6.
e
a
n
tr ie
k
sto
o
bo
e
e
Qu
Figura 8: mappa del villaggio di Zakaria prima della diaspora
del 1948, ricostruita dal comitato del villaggio sulla base delle
conoscenze tramandate riguardo a come lo spazio era
socializzato in questo villaggio.
Il legame con il passato del villaggio sgomberato, rivissuto nel
presente contesto del campo rifugiati, costituisce un punto di riferimento per
la costruzione dell’identità collettiva degli abitanti di Dheisha, così come
del sé di ogni rifugiato.
A differenza della concezione dell’UNRWA, nei discorsi che
riguardano la loro vita, anche le nuove generazioni di rifugiati parlano della
loro storia come se non iniziasse con la condizione di rifugiato, ma con la
vita nel villaggio d’origine del loro lignaggio patrilineare, nonostante non
l’abbiano mai esperita.
I rifugiati percepiscono il loro legame con la popolazione e con la
terra del loro villaggio d’origine come naturale e trascendente la storia,
identificando metaforicamente la popolazione con il luogo del villaggio.
Nonostante siano consapevoli dei radicali cambiamenti che hanno avuto
18
p
ap
luogo nel tempo per quanto riguarda lo stile di vita, le attività di sussistenza
e le relative capacità apprese e tramandate, nell’immaginazione simbolica
dei rifugiati, tornare alla terra perduta implicherebbe trovare il villaggio
come se non avesse subito trasformazioni nel tempo e ristabilire la stessa
organizzazione sociale ed economica dello spazio, idealizzata come
egualitaria nonostante fosse molto gerarchica. Nella costruzione della storia
mitica dei rifugiati, il tempo viene percepito come ciclico, non astratto ma
legato ad altri aspetti della società locale (come gli eventi sociopolitici, le
cinque preghiere quotidiane islamiche o il mese di digiuno del Ramadan).
Nella cultura tribale la storia non è lineare ma mitizzata in termini di
“sequenze di concrete esperienze irregolari”7, rappresentate come isole
temporali.
o
e
b
o
o
k appa
Quest
L’analisi delle pratiche amministrative dell’UNRWA all’interno
del campo di Dheisha rivela il graduale ritiro dell’agenzia dalle sue
responsabilità di procacciatrice di servizi sociali, a partire dall’istituzione
dell’ANP nel ’94, per rendere i rifugiati sempre più dipendenti
dall’amministrazione dell’ANP, con l’obiettivo di slegarli da forme di lealtà
differenti da quella allo Stato.
Il continuo processo di urbanizzazione e lo sviluppo delle
infrastrutture ha inglobato fisicamente il campo rifugiati di Dheisha nella
periferia di Betlemme, amministrata dall’ANP. La continuità dello spazio
del campo rifugiati con quello urbano riflette le intense relazioni di lavoro
tra i rifugiati, che cercano un impiego nell’area urbana, i cittadini e le
istituzioni governative, le quali sono le principali procacciatrici di lavoro
dei rifugiati.
Il campo rifugiati è legato allo spazio urbano anche dal sistema di
allocazione della risorsa dell’acqua. Il sistema idraulico e quello fognario di
Dheisha sono stati costruiti dalle forze militari israeliane all’inizio degli
anni’80, prima dell’istituzione dell’ANP, quando amministravano la West
Bank (dal ’67 al ’94). Per ridurre i costi di costruzione del sistema idraulico
di Dheisha, l’UNRWA lo ha allacciato alle pre-esistenti infrastrutture della
città di Betlemme, amministrate dall’ANP, la quale distribuisce l’acqua agli
abitanti di Dheisha. Nonostante la manutenzione del sistema idraulico e di
quello fognario di Dheisha sia sotto la responsabilità dell’UNRWA,
l’agenzia li sta ristrutturando in collaborazione con l’ANP, che finanzia i
lavori8 assegnati ad una ditta palestinese attraverso un appalto pubblico9.
7 Eickelman, Dale. “Time in a Complex Society: A Maroccan Example” (1977). In: Layne;
1994: 151.
8 I finanziamenti sono donati dalla USAID (United States Agency for International
rtiene
19
Il progetto consiste nella costruzione di nuovi condotti idraulici
fognari per risolvere i problemi della contaminazione dell’acqua e della
distribuzione disomogenea di questa risorsa dovuti rispettivamente al
deterioramento dei materiali del sistema idraulico e fognario e ad alcuni
difetti di costruzione10.
I rifugiati interpretano lo sviluppo delle infrastrutture come la
conciliazione delle politiche dell’UNRWA e dell’ANP per il comune
obiettivo di portare avanti un processo di at-tawṭyn (insediamento)11 del
campo rifugiati di Dheisha, per assimilarlo nella periferia urbana come
sobborgo sottoproletario.
Rivendicano le condizioni di marginalità e di precarietà implicate
dalla temporaneità del campo rifugiati come forma di opposizione politica
per mantenere il campo rifugiati come luogo della memoria dello status di
rifugiato e del relativo diritto al ritorno alle terre occupate. Nonostante
questo, la seconda e la terza generazione di rifugiati, a differenza della
prima che ha vissuto a Dheisha, accetta il miglioramento delle condizioni di
vita all’interno del campo rifugiati, realizzando la loro permanenza a lungo
termine nel territorio come ospiti.
Il campo dove la cooperazione tra l’UNRWA e l’ANP è più
stretta è quello dei servizi sanitari primari. Data la mancanza di personale
specializzato, di materiali e strumenti per soddisfare i bisogni della
comunità di rifugiati, il centro sanitario dell’UNRWA si appoggia ad
ospedali pubblici e privati per trattamenti più specifici, pagando una parte o
Development).
9 L’UNRWA ha messo a disposizione degli ingegneri che hanno ideato il progetto e che
controllano il buon proseguimento dei lavori.
10 Le forze d’occupazione israeliane hanno costruito i condotti dell’acqua di Dheisha sotto
quelli fognari. Con il tempo le tubature si sono deteriorate, portando alla formazione di buchi
che permettono alle sostanze di scarto del sistema fognario di entrare nelle tubature dell’acqua,
contaminandola seriamente. Per affrontare questo problema e garantire ai rifugiati condizioni
di vita salutari, l’ufficio per la salute ambientale dell’UNRWA ogni giorno compie delle
rilevazioni per il controllo della qualità dell’acqua (se c’è), attraverso il prelievo di tre
campioni in zone diverse del campo rifugiati. Nel caso in cui l’acqua sia contaminata, le
famiglie che vivono nella zona interessata vengono avvertite di non usarla fino a quando il
problema non sia risolto. Inoltre la pompa che permette di far salire l’acqua raccolta in due
grandi cisterne, dal condotto principale (che percorre la strada principale che collega
Gerusalemme - Betlemme - Hebron) alle case del campo rifugiati, costruito su un terreno in
pendenza, non è abbastanza potente da poter rifornire di questa risorsa le famiglie della parte
superiore del campo rifugiati, le quali non godono dell’allocazione nazionale d’acqua.
11 Questo è il termine usato dai rifugiati per riferirsi alla loro integrazione come cittadini.
La radice della parola è la stessa di “cittadinanza”.
t
Ques
20
ppa
ok a
o
b
e
o
tutte le spese. Il sistema sanitario amministrato dall’ANP offre a tutti i
cittadini e rifugiati palestinesi la possibilità di contrarre un’assicurazione
medica che copre una parte delle spese per le cure dispensate dagli ospedali
pubblici e privati nella West Bank12. Creando una dipendenza vitale dei
corpi dei rifugiati dall’ANP, l’UNRWA e l’ANP tentano di integrarli come
cittadini nella società della West Bank.
Anche il cambiamento nel tempo delle strategie educative
dell’UNRWA riflette l’obiettivo dell’agenzia di ostacolare le rivendicazioni
dei rifugiati. Fino all’istituzione dell’ANP nel ’94, l’UNRWA ha avuto un
importante ruolo nella diffusione di un elevato livello di scolarizzazione tra
gli abitanti dei campi rifugiati13. Garantendo ai rifugiati l’accesso ad uno dei
principali mezzi di mobilità socio-economica individuale14 in condizioni di
spossesso e di precarietà economica, l’agenzia aveva l’obiettivo di facilitare
la loro integrazione nei paesi ospitanti15 (Schiff 1995). L’agenzia stessa era
la principale procacciatrice di lavoro per i rifugiati.
Attualmente L’UNRWA offre ai giovani rifugiati un livello
educativo di bassa qualità ed infrastrutture insufficienti ad accogliere
l’elevato numero di studenti, giustificando la decadenza del sistema
educativo con la crisi finanziaria.
Partecipando alle strategie di censura dei testi e dei programmi
scolastici attuate dalle autorità israeliane16, l’UNRWA ostacola la
to
es
Qu
12 Nel caso in cui nel territorio palestinese non vi siano le strutture e le competenze necessarie
al trattamento di un paziente, il Ministero della Sanità palestinese lo manda in un ospedale
della Giordania o dell’Europa con un documento che certifica il pagamento delle spese
ospedaliere da parte dell’ANP. Il resto degli sborsi economici (il viaggio, la permanenza del
paziente e di un eventuale accompagnatore) è a carico dei pazienti.
13 Le scuole dell’UNRWA erano rinomate per offrire una preparazione scolastica che veniva
giudicata essere la migliore nella regione, sulla base di una misurazione standardizzata
effettuata attraverso test statistici distribuiti in tutte le scuole degli Stati arabi nei quali opera
l’UNRWA.
14 Il sistema scolastico dell’UNRWA formava una forza lavoro ben istruita che spesso
migrava nei paesi del Golfo o in Giordania ad occupare posizioni lavorative ben remunerate,
come ad esempio gli insegnanti, molti dei quali donne, che negli anni ’80 erano richiesti e ben
remunerati (Layne 1994).
15 Gli USA, che nel dopoguerra dominavano diplomaticamente ed economicamente le
pratiche dell’ONU, credevano che fosse possibile risolvere i problemi politici dei rifugiati
attraverso un rapido sviluppo economico che avrebbe favorito la loro integrazione in loco,
eludendo la rivendicazione di un rimpatrio su larga scala (Schiff 1995).
16 Nonostante le scuole dell’UNRWA adottino gli stessi testi e programmi scolastici delle
scuole pubbliche dell’ANP, visionati dall’UNESCO, secondo alcuni insegnanti il Dipartimento
dell’Educazione israeliano li censura causando ritardi nello svolgimento dei programmi e
nell’assunzione di testi aggiornati. L’istituzione israeliana rimuove dai libri di testo tutti gli
aspetti che riguardano l’identità palestinese, la sua autenticità culturale, il suo legame con il
territorio e le sue rivendicazioni. L’UNRWA partecipa alle politiche di censura richiedendo
e
ien
art
pp
ka
oo
eb
21
Qu
es
to
costruzione e la trasmissione di una memoria storica collettiva palestinese e
la formazione della coscienza politica degli studenti, affidate alla sola
capacità degli insegnanti di eludere le pratiche di censura e di controllo.
Opprimendo culturalmente i rifugiati e limitando le loro
possibilità di trovare lavoro, la capacità degli stessi di emanciparsi e di
elevare la loro condizione economica (di svilupparsi, nel linguaggio del
moderno paradigma dello Sviluppo) sono limitate. In questo modo i
rifugiati, che costituiscono il principale fattore destabilizzante nelle
negoziazioni tra Israele e l’ANP, risultano esclusi dalla distribuzione del
potere istituzionale e dalla possibilità di formare la futura classe dirigente
della Palestina. Mantenuti in condizioni precarie che li rendono più
facilmente soggiogabili, la loro voce è negata.
Da luogo simbolico della lotta per la liberazione nazionale della
Palestina, il campo rifugiati è considerato un’anomalia destabilizzante
all’interno del nascente contesto nazionale, da smantellare dissolvendo la
sua dipendenza dall’UNRWA ed integrandolo come un sobborgo urbano
sottoproletario nella periferia di Betlemme17.
Nonostante i rifugiati percepiscano l’UNRWA come un agente
paternalista che incide sempre meno sulle condizioni di vita nel campo
rifugiati, gli abitanti di Dheisha si appropriano della realtà assegnando un
valore ed un significato politico alla presenza dell’UNRWA18, considerata
un simbolo ed una garanzia che l’irrisolta questione dei rifugiati palestinesi
che aspettano di tornare alle loro terre non venga liquidata, come dimostra il
murales riportato di seguito.
agli insegnanti di non schierarsi politicamente durante il loro lavoro e controllando che si
attengano ai programmi scolastici de-politicizzati.
17 Tale situazione rende evidente l’importanza della de-naturalizzazione del concetto
d’identità, che è il prodotto sempre in cambiamento di un processo dinamico di costruzione
sociale. Così come è stata prodotta, l’identità di rifugiato può essere smantellata, mostrando un
chiaro esempio di trasmutazione antropologica.
18 Il ruolo di assistenza a-politica, che risulta equivoco nel contesto delle continue violazioni
dei diritti umani nel quale opera, è una delle scelte obbligate che l’UNRWA deve abbracciare
per poter essere legittimata ad agire nei confronti dei rifugiati negli Stati ospitanti. Il nodo della
questione verte sul significato di politica, arena di conflitto tra l’UNRWA e la comunità di
rifugiati.
22
Figura 9: Murales che rappresenta la tessera di registrazione dell’
UNRWA, uno dei simboli dell’azione umanitaria dell’agenzia.
Nell’istituzione e nello sviluppo del campo rifugiati di Dheisha,
l’UNRWA non ha previsto la pianificazione di luoghi pubblici d’incontro
come piazze, giardini o parchi, che l’agenzia e l’ANP reputano pericolosi
focolai di tensioni sociali. Oltre al controllo sociale, l’obiettivo è quello di
censurare il confronto e l’espressione pubblica dei rifugiati.
Allo scopo di ottenere la legittimazione dei rifugiati,
nell’elaborazione del discorso nazionale prima l’OLP ed in seguito l’ANP
hanno eletto la cultura simbolica e materiale dei villaggi come simbolo
dell’appartenenza nazionale palestinese. L’obiettivo è di elevare ad
un’eredità comune la pluralità delle identità sociali associate ai vari gruppi
tribali, per integrarle nell’appartenenza alla nazione palestinese. Sebbene
l’ANP partecipi alla costruzione del campo rifugiati come luogo della
memoria, attraverso le strategie di repressione ed il controllo degli spazi e
degli eventi pubblici19 durante i quali avviene l’invenzione e l’esibizione
dell’appartenenza nazionale, si appropria dell’immaginazione collettiva dei
rifugiati e li esclude dalla negoziazione dei suoi significati.
19 Spazi come le scuole dell’UNRWA, le strade, le moschee e le ONG locali, ed eventi come
gli spettacoli di danza e gli incontri cerimoniali ufficiali.
Q
23
ue
st
o
eb
o
Que
I murales dipinti da alcuni giovani rifugiati sui muri esterni di
alcune case di Dheisha distinguono lo spazio del campo rifugiati dall’area
urbana di Betlemme.
Come ha sostenuto Peteet riguardo ai graffiti, analizzando il
contesto di Beit Hanina (una piccola città nella periferia di Gerusalemme)
durante gli anni ’90 (Peteet 1996), anche a Dheisha la forma di produzione
culturale dei murales costituisce una pratica di resistenza, fonte e veicolo di
potere dei rifugiati nel contesto di relazioni politiche asimmetriche con le
forze militari israeliane, l’ANP e l’UNRWA. Attraverso il linguaggio
comune dei murales, la comunità di Dheisha si appropria dello spazio dei
muri delle case come di una molteplicità di arene pubbliche dove esibire e
negoziare collettivamente l’interpretazione locale dello status di rifugiato ed
esprimere la propria voce nel processo di costruzione dell’identità
nazionale.
Sulla base delle storie raccontate dai loro parenti anziani o
deceduti che hanno vissuto nei villaggi sgomberati, nei murales i giovani
rifugiati rappresentano i villaggi appropriandosi di alcuni elementi simbolici
degli stessi come la terra, i prati, gli ulivi, le fonti d’acqua ed i pozzi, ed
usandoli come linguaggio metaforico per esprimere lo status di rifugiato e le
relative rivendicazioni20.
Nel ridare forma collettivamente in modo creativo alle
rappresentazioni dei loro villaggi d’origine, i rifugiati idealizzano e fissano
nel tempo la vita negli stessi in contrasto con le attuali condizioni di vita nel
campo rifugiati. Il campo rifugiati è un luogo di costruzione sociale della
memoria e dell’identità dei suoi abitanti, che permette loro di tramandare
nelle generazioni il senso d’appartenenza alle terre perdute, dando un
significato alla loro attuale condizione di dispersione ed oppressione.
e
sto
k
boo
artie
app
24
n
iulia
\nG
ne a
20 La selezione di questi elementi non sempre corrisponde alla realtà storica (per esempio non
tutti i villaggi avevano un pozzo), ma include elementi che sono assenti nel campo rifugiati e
nei Territori Occupati in generale, come il mare, risorsa e bellezza che inspira una forte
nostalgia per un’esperienza mai vissuta.
e
sto
Qu
Figura 10: un murales nel campo rifugiati di Dheisha che
rappresenta uno dei villaggi sgomberati dalle forze
d’occupazione israeliane.
In alcuni murales i rifugiati dipingono alcuni elementi considerati
rappresentativi della cultura dei villaggi, contestualizzandoli come simboli
dell’identità nazionale palestinese negata dalla colonizzazione israeliana.
Mentre il discorso nazionalista delle istituzioni dell’ANP integra le diverse
culture locali in un’unità politica rendendole anonime, gli abitanti di
Dheisha si appropriano del linguaggio della rappresentazione nazionale,
personalizzandolo ed assegnando ai suoi simboli il significato del
riconoscimento da parte dell’ANP del loro status e del loro diritto a tornare
ai villaggi d’origine.
25
e
b
Q
to e
s
e
u
Figura 11: questo murales rappresenta
differenti dimensioni
d’appartenenza legate tra loro dalla struttura di un albero, le cui radici
esprimono il legame con la terra occupata,interpretata in generale come
la Palestina storica. Le pratiche popolari palestinesi associate ai villaggi
sgomberati (la dabka,ovvero una danza popolare collettiva, il circo, le
tecniche di tessitura punto e croce e le vecchie grandi chiavi delle case
sgomberate) sono rappresentati insieme ad elementi connessi alla
colonizzazione israeliana (come il muro di segregazione, la prigione ed
il filo spinato) e con simboli nazionali che non fanno riferimento alla
cultura dei villaggi (come la moschea Al-Aqsa, simbolo di
Gerusalemme e della Palestina). I simboli che rappresentano le
dimensioni d’appartenenza estese della comunità mondiale di
musulmani (come il Corano) e di quella dei fratelli arabi, sono indice
delle nuove risorse mobilitate dai rifugiati per dare un significato alla
realtà di oppressione ed alla rivendicazione dei loro diritti.
26
LI
_2
iap
uo
ti C
cc
Ca
a
i an
a\
nG
iul
e
ar
tie
n
pp
ka
oo
eb
to
es
Qu
Figura 12: murales dipinto da alcuni giovani rifugiati sul muro esterno
di una casa del campo rifugiati di Dheisha.
Alcuni murales commemorano i giovani rifugiati persi nella lotta
quotidiana all’oppressione militare israeliana ed elevano il loro status a
quello di martire, appropriandosi della legittimità di definire il significato ed
il valore di questa figura, nel contesto del movimento di liberazione
nazionale. Percorrendo le strade del campo rifugiati questi murales
mostrano la produzione di una storia mitica della resistenza nazionale della
comunità di Dheisha, nella creazione di una continuità storica, geografica e
sociale nel frammentato contesto palestinese. Ad ogni ragazzo dipinto
corrisponde un evento della storia in un tempo mitico, fluido ed irregolare.
Nel dipingere i murales, gli abitanti di Dheisha mettono in atto un
processo di “territorializzazione” del campo rifugiati come spazio di
resistenza nazionale, eleggendo questo valore nella definizione della propria
identità sociale.
27
a
ia
C
na
ul
Gi
\n
a
e
n
ie
art
p
p
ka
o
to
s
ue
o
eb
Figura 13: questo grande murales raffigura il volto di uno dei martiri
morti durante l’assedio militare israeliano della Chiesa di Betlemme
(avvenuto nel 2002 e durato 39 giorni), circondato da alcuni simboli
nazionali e islamici e dai nomi di tutti i martiri di Dheisha, che vengono
aggiunti di volta in volta. Questo disegno rappresenta un resoconto non
conclusivo della storia di resistenza della comunità di rifugiati,
simboleggiato da un evento storico mitizzato come esempio
dell’eroismo e del potere del popolo palestinese e dell’impunità dei
soldati israeliani.
Q
28
liana Cacciapuoti C
Questo ebook appartie
ne a\nGiu
Figura 14: questi murales, dipinti in corrispondenza della bāb almukhayyam (la porta del campo rifugiati), considerata uno degli
accessi principali del campo rifugiati, rappresentano i volti dei leader
nazionali Arafat (il rappresentante per eccellenza della nazione
palestinese) e Abu Jihad (uno dei più vicini collaboratori di Arafat,
morto assassinato dalle forze d’occupazione israeliane), offrendo un
esempio del processo di “territorializzazione” del campo rifugiati come
spazio della resistenza nazionale.
La memoria popolare21 che i rifugiati rivendicano nei confronti
della generica narrazione storica dell’ANP non comprende solo il ricordo
rimodellato dei villaggi d’origine sgomberati, ma anche la particolare storia
di oppressione e resistenza del campo rifugiati all’occupazione militare
israeliana e l’importante sacrificio di molti combattenti provenienti da
Dheisha nella lotta di liberazione nazionale.
Per questo motivo gli abitanti di Dheisha hanno deciso di
mantenere il tornello che regolava l’entrata e l’uscita dal campo rifugiati dal
’67 al ’94, quando era sotto l’assedio dei junūd (soldati) israeliani, che
avevano chiuso il suo spazio con reti rinforzate e filo spinato e che
imponevano lunghi coprifuoco, impedendo per mesi ai rifugiati di andare a
lavorare e di rifornirsi cibo.
21 Per memoria popolare, accolgo l’interpretazione del Gruppo della Memoria Popolare del
Centro per gli Studi Culturali Contemporanei in Birmingham, che la definisce come oggetto di
studio e dimensione della pratica politica (Farah; 1998: 2).
29
b
sto e
e
u
Q
oo
a\
e
n
e
i
part
p
a
k
Figura 15: Tornello che regolava l’entrata e l’uscita dal campo rifugiati di
Dheisha durante l’assedio militare israeliano della West Bank (’67 – ’94).
Dall’istituzione dell’ANP nel ’94 Israele ha ritirato il suo esercito
dalle aree A della West Bank. Ciò nonostante, consapevoli della reputazione
politica dei rifugiati, i soldati israeliani continuano a discriminarli rispetto ai
cittadini. Durante le notti entrano nelle case di Dheisha per catturare
persone e tenerle in prigione per sei mesi o più per “detenzione
amministrativa”22. Oltre a limitare i movimenti e l’autonomia dei palestinesi
all’interno della West Bank, i check-point militari israeliani agiscono come
22 Si tratta della possibilità di recludere una persona nelle carceri israeliane per un periodo
compreso generalmente tra i sei mesi ed un paio di anni, senza che abbia commesso alcun
reato, con il solo pretesto di sospettare che sia pericolosa per la sicurezza nazionale israeliana.
Durante il primo mese di reclusione (il periodo delle indagini) nessuno, neanche l’avvocato,
può sapere in quale carcere sia trattenuta la persona arrestata, che praticamente scompare.
Durante il periodo di detenzione i palestinesi subiscono violenze e torture di vario tipo,
finalizzate ad estorcere informazioni o anche solo a scopo punitivo.
30
confini simbolici, creando forme di discriminazione strutturale tra i
palestinesi che svantaggiano in particolare i rifugiati e disgregano la società
palestinese e la sua capacità di resistenza. La permeabilità di questi confini,
l’uso dello spazio e delle sue risorse materiali e simboliche, legati alla
nazionalità (israeliana o palestinese), alla classe d’appartenenza, al luogo di
residenza, alla confessione religiosa (ebraica, islamica o cristiana) ed alla
fedina penale, costituiscono termini d’identificazione e di differenziazione e
risorse sempre più importanti nella definizione delle gerarchie locali.
pa
ka
p
o
e
s
to
eb
o
Qu
Figura 16: Uno dei check-point militari israeliani per entrare a
ّ ( ”حاجزcheck-point del tunnel)
Gerusalemme, chiamato in arabo “النفق
ed in ebraico “mahsum menharent”; situato nella West Bank, nella terra
di Beit Jala, una piccola cittadina nella periferia di Betlemme
(Settembre, 2010).
La percezione dello spazio e dell’identità sociale, che similmente
al contesto giordano analizzato da Layne (Layne 1994) sono prodotte dal
continuo riposizionamento dei rifugiati nei confronti degli “altri” e del
mondo materiale, assumono forme differenti in base alla libertà di
movimento ed alle pratiche repressive esperite. Anche le strategie militari
israeliane partecipano al significato del campo rifugiati come luogo della
memoria ed alla formazione dell’identità dei rifugiati. Costoro si
appropriano delle pratiche militari, assegnando alle stesse un importante
31
s
e
u
Q
ruolo nella costruzione della mascolinità, dell’onore e dello status di
rifugiato. Come ha affermato Peteet (Peteet 1994), la detenzione assume il
significato di rituale di passaggio all’età adulta ed a ruoli di resistenza con
maggiori responsabilità.
Figura 17: il muro di segregazione costruito dalle forze militari
israeliane separa il villaggio di ( أبو ديسAbū Dīs) in due parti: una è
compresa nella West Bank, l’altra nella periferia di Gerusalemme, che
è stata inclusa nel territorio dello Stato di Israele (Settembre, 2010).
32
ّ (il
Figura 18: la parte del muro di segregazione situata vicino al النفق
tunnel) costruito dalle forze militari israeliane per collegare l’area di
Beit Jala,nella West Bank, a Gerusalemme (Luglio, 2011).
Questo eb
ook appa
rtiene a\n
33
Giuliana C
acciapuot
i CLI_2
La produzione e lettura dei murales costituiscono pratiche situate
culturalmente e storicamente. I simboli esibiti e la loro lettura sono
polisemici e si rivolgono a diversi destinatari, quali Israele, l’ANP e la
stessa comunità di rifugiati, conciliando diversi messaggi e significati23.
Attraverso tale produzione culturale i rifugiati creano un legame tra il
tempo, lo spazio e l’identità, conciliando le diverse dimensioni
d’appartenenza che compongono la poliedrica identità sociale di ogni
persona, mobilitate come risorse in base al contesto relazionale. I rifugiati
partecipano alla produzione del discorso dell’ANP ed alla lotta di
liberazione nazionale e mobilitano l’appartenenza nazionale allo scopo di
soddisfare le necessità quotidiane. Nello stesso tempo, nella rivendicazione
della propria specificità culturale e politica, l’aggressività e l’autonomia
dall’ANP (così come da qualsiasi autorità esterna al campo rifugiati, come
le forze militari israeliane e l’UNRWA), che con gli accordi di Oslo ha
perso la legittimazione dei rifugiati24, sono eletti come valori importanti che
partecipano alla definizione dell’onore collettivo del campo rifugiati ed alla
formazione dell’identità politica e sociale dei suoi abitanti, distinguendoli
dalla popolazione urbana della zona di Betlemme, sotto l’amministrazione
dell’ANP.
Le relazioni dialogiche che la comunità di rifugiati intrattiene con
l’ANP, nel corso della competizione per il controllo dello spazio del campo
rifugiati e delle sue risorse materiali e simboliche, emergono con chiarezza
dall’analisi delle negoziazioni tribali delle soluzioni dei conflitti tra famiglie
e delle celebrazioni dei matrimoni. In tali situazioni i rifugiati rifiutano
l’autorità delle istituzioni dell’ANP ed esprimono la propria specificità
culturale, sociale e politica come forma di auto-determinazione e di autorappresentazione, mobilitando ed adattando continuamente al nuovo
contesto del campo rifugiati elementi culturali e pratiche rituali che
caratterizzavano il sistema tribale dei villaggi d’origine, conservati nella
memoria delle persone più anziane. Tali forme di conoscenza incorporata
assumono il significato di simboli del legame con un passato associato ad
una supposta autenticità culturale. Come sostenuto da Van Aken nel
contesto della Valle del Giordano (Van Aken 2003), le tradizioni
Qu
est
oe
boo
ka
ppa
rtie
ne
a\n
Giu
lian
aC
23 Se di fronte ai militari israeliani i murales simboleggiano l’unità della popolazione
palestinese nella lotta di liberazione nazionale e nel contesto nazionale esprimono l’identità
della comunità di rifugiati, alcuni murales lasciano emergere le differenze gerarchiche tra gli
stessi rifugiati, come quelle legate alle dimensioni d’appartenenza del partito politico, della
classe sociale e di genere.
24 In occasione degli Accordi di Oslo l’ANP ha dimostrato di voler eludere la rivendicazione
dei rifugiati di tornare alle terre perdute.
34
acc
iap
uot
i
reinventate costituiscono il linguaggio comune attraverso il quale le
famiglie si appropriano dello spazio e negoziano il significato di casa e
comunità, che in mancanza di una terra condivisa si basa sulla costruzione
creativa di un comune senso d’appartenenza culturale.
Le occasioni rituali d’incontro come quelle prese in analisi hanno
assunto il nuovo significato di arene politiche, dove la comunità diventa la
base della riproduzione sociale e culturale sotto la responsabilità della
famiglia estesa25. In mancanza di spazi pubblici d’incontro e nelle
condizioni di censura politica messe in atto dalle forze d’occupazione
israeliane, dall’ANP e dall’UNRWA, il confronto pubblico è espresso
attraverso il linguaggio del corpo ed è privatizzato all’interno della sfera
della famiglia, riducendo l’estensione dello spazio sociale e delle reti di
relazioni di solidarietà.
Nella competizione per il controllo dello spazio del campo
rifugiati, la produzione del campo di Dheisha come luogo della memoria
non ha solo una funzione conservativa, ma costituisce uno strumento di lotta
del gruppo svantaggiato dei rifugiati, nel contesto delle relazioni
asimmetriche di potere con le forze militari israeliane, con l’UNRWA e con
l’ANP.
ia
ac
c
na
C
ia
G
i
ul
n
e
tr ie
n
a\
a
ap
p
k
sto
bo
o
_
ti
pu
o
Allo scopo di mediare le relazioni con i rifugiati e di esercitare il
suo controllo senza ribellioni che destabilizzerebbero il difficile governo dei
territori occupati, l’ANP legittima queste pratiche tribali e coopta le persone
che assumono ruoli tribali autoritari legittimati dalla comunità di Dheisha26.
Con lo stesso proposito, nel tentativo di diffondere un senso d’appartenenza
nazionale nei campi rifugiati, Abu Mazen continua il processo di
costruzione del corpo esecutivo dello Stato avviato da Yasser Arafat, che
con la formazione dell’ANP nel ’94 aveva iniziato ad assumere alcuni
combattenti dei campi rifugiati in differenti settori delle forze di sicurezza
e
Q
u
e
25 In tali contesti hanno luogo la trasmissione della memoria, la costruzione sociale dei valori
e dei significati culturali, la mediazione del cambiamento sociale, la negoziazione delle
gerarchie locali e l’espressione pubblica di appartenenze e differenze.
26 Nell’ambito del controllo sociale e dell’amministrazione della giustizia le istituzioni del
proto-stato palestinese delegano le proprie prerogative alle figure tribali che hanno un ruolo di
potere legittimato dalle famiglie di Dheisha: ne sono un esempio il kafīl (garante) dell’accordo,
il wajuh ḥāl (volto della situazione), ovvero il portavoce di una famiglia, ed il mukhtār (colui
che è scelto). In ogni caso, per sancire l’autorità superiore dello Stato, l’ANP mantiene il potere
ultimo di controllo sull’esito positivo delle negoziazioni consuetudinarie per risolvere i
conflitti.
35
C
L
I
palestinesi27. Nel tentativo di cambiare l’interpretazione locale del valore di
martire e di resistenza nella formazione dell’identità individuale e collettiva,
l’ANP incarcera chiunque non rispetti l’accordo che nel 2007 Abu Mazen
ha stipulato con le forze militari israeliane, riguardo alla deposizione delle
armi ed al ritorno alle famiglie dei combattenti ricercati che avrebbero
firmato l’accordo28. Tali strategie mirano a cooptare e controllare coloro che
costituiscono la forza armata della resistenza nazionale (che non ha un
esercito professionale), ma allo stesso tempo un potenziale potere di
sovversione della fragile nascente autorità nazionale.
Nell’arena politica nazionale si dispiega la competizione tra
diversi gruppi d’interesse per la definizione di resistenza legittima, per il
controllo del potere di resistenza e delle risorse materiali e simboliche e per
la soluzione finale delle negoziazioni israeliano-palestinesi.
Per mantenere il riconoscimento da parte delle potenze occidentali
della sua legittimità a condurre le negoziazioni con Israele, l’ANP prova ad
ottenere il monopolio della violenza e della resistenza all’occupazione
israeliana e reprime qualsiasi forma di opposizione (anche se pacifica) che
infici l’immagine di consenso e di controllo politico, nonostante non sia in
grado di garantire la sicurezza della popolazione che vive nella West Bank e
dei rifugiati in particolare.
La competizione tra la comunità di Dheisha e l’ANP per la risorsa
dell’acqua è un linguaggio attraverso il quale questi due attori di potere
competono per la definizione dello status del campo rifugiati e del suo
significato. Lo status di rifugiato è associato a particolari diritti sociali ed
economici stabiliti da Arafat. I rifugiati non pagano l’acqua, l’elettricità, il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e le tasse governative per le
attività commerciali all’interno del campo rifugiati. Con l’obiettivo di
costruire una struttura di potere maggiormente centralizzata del nascente
Stato palestinese (Trottier 2000), dalla scomparsa di Arafat l’ANP cerca di
monopolizzare il controllo dell’acqua e prova a forzare i rifugiati a pagare
questa risorsa, approvvigionando sempre meno le loro case e giustificando
tali pratiche con l’occupazione israeliana.
27 Nella lotta contro l’occupazione israeliana, il campo rifugiati di Dheisha è stato un terreno
di mobilitazione da parte dell’OLP, che sosteneva economicamente i combattenti e le loro
famiglie.
28 Senza un sostegno economico e di fronte al controllo ed alla repressione politica dell’ANP, i
combattenti hanno dovuto accettare quel che considerano una svalutazione della causa
palestinese. Nonostante il conclamato processo di pace, l’edificazione delle colonie e le
violente prevaricazioni messe in atto dalle forze militari israeliane e dai coloni nei confronti
della popolazione civile palestinese continuano.
36
Qu
oti
u
iap
c
ac
C
a
i
iul
an
Per rivendicare l’opposizione politica a qualunque tentativo di
rendere permanente il campo rifugiati, i suoi abitanti enfatizzano la
differenza dello status di rifugiato rispetto a quello di cittadino dell’ANP,
rifiutando collettivamente di pagare l’acqua. L’acqua assume il valore di
arena politica dove in gioco vi è la legittimità del nascente Stato palestinese,
rappresentato dall’ANP.
Q
s
ue
to
o
eb
o
p
a
k
p
n
tie
r
a
\n
a
e
G
Alcuni giovani abitanti di Dheisha mettono in scena nella strada di
fronte al campo rifugiati delle manifestazioni di protesta contro l’ANP per
la mancanza d’acqua, appropriandosi simbolicamente dello spazio esterno
al campo rifugiati, amministrato dall’ANP, con l’obiettivo di esprimere la
voce ed affermare il potere dei rifugiati.
Le manifestazioni rivelano il loro carattere di spazio pubblico
d’incontro tra differenti gruppi d’interesse, ognuno con la propria
definizione di sé e degli altri. L’acqua costituisce un’interfaccia politica, un
luogo di costruzione della comunità attraverso la negoziazione delle
gerarchie, delle appartenenze e delle differenze, nel comune linguaggio
delle pratiche sociali.
Il fatto che non tutti i rifugiati partecipino alle manifestazioni
riflette la mancanza di uniformità nella distribuzione dell’acqua all’interno
del campo rifugiati, causata da alcuni difetti di costruzione del sistema
idraulico29. Nonostante la condivisione dello status di rifugiato, la
differenziata disponibilità d’acqua crea discontinuità nelle esperienze
quotidiane delle famiglie di Dheisha, che nel mettere in atto diverse
strategie di manovra30, spesso entrano in conflitto tra loro.
Alcune famiglie sono rifornite da una maggiore quantità d’acqua
grazie al possesso di legami sociali all’interno delle amministrazioni
dell’ANP, una risorsa sempre più importante nella definizione dello status
sociale, il cui possesso è sempre più legato all’appartenenza di classe.
Wāsṭa (mediazione) è il tipo di modello relazionale attraverso il quale i
rifugiati mediano le relazioni verticali e manipolano i processi istituzionali
che regolano la distribuzione delle risorse da parte dell’ANP, dell’UNRWA
29 Il fatto che, come ho già spiegato nella nota n. 8, la pompa che fa circolare l’acqua nel
campo rifugiati, costruito in pendenza, non sia abbastanza potente da permettere all’acqua di
raggiungere tutte le case, causa una divisione dello spazio di Dheisha in due parti: quella
inferiore, rifornita dalla distribuzione nazionale d’acqua, e quella superiore, che non può
usufruirne.
30 Per soddisfare l’esigenza quotidiana d’acqua, le famiglie della parte superiore di Dheisha
hanno costruito collettivamente un sistema idraulico con il quale sottraggono illegalmente
acqua all’ANP, dimostrando la loro creatività ed il loro ruolo attivo nella competizione per il
controllo di questa risorsa con l’amministrazione e le sue regole.
37
\
ne a
e
i
t
r
appa
to eb
s
e
u
Q
ook
e delle ONG locali, attraverso il linguaggio egualitario della visita e
dell’ospitalità. Attraverso queste pratiche gli abitanti di Dheisha affermano
la loro autonomia dall’UNRWA e dall’ANP e la capacità di appropriarsi del
contesto locale. La disponibilità d’acqua è un indice dello status delle
famiglie, sempre più determinato dalla classe sociale d’appartenenza, e
riflette la crescente segmentazione economica della comunità di Dheisha.
Dall’analisi delle manifestazioni emerge una delle dimensioni di
potere dello status di rifugiato. Mobilitare una manifestazione in un campo
rifugiati facendo leva sulla parte della popolazione più disagiata e con un
basso status sociale e risolvere in seguito il problema, significa avere il
potere di controllo sul campo rifugiati. Le condizioni di vita nel campo
rifugiati creano una marginalità sociale che in determinate occasioni può
costituire una fonte di potere personale, strumentalizzata dai rifugiati che
occupano una carica importante all’interno delle forze di sicurezza
palestinesi. Grazie alla loro posizione nell’ANP, questi attori elargiscono
servizi a titolo personale, ottenendo potere nella gerarchia locale, privilegi e
la possibilità di delinquere senza problemi.
Considerando i diritti sociali dei rifugiati come privilegi che
aumentano le tasse governative e che ostacolano la costruzione di un
moderno Stato democratico, alcuni cittadini dell’area di Betlemme si
oppongono alle proteste dei rifugiati, entrandoci in conflitto.
L’ANP non distribuisce l’acqua in modo omogeneo, creando una
gerarchia tra gli spazi che riflette la struttura politica legata alla
segmentazione in classi della società palestinese dei Territori Occupati31. La
discriminazione strutturale su base territoriale costruita attorno alla
distribuzione dell’acqua, nell’includere alcuni ed escludere altri, influenza e
rafforza la costruzione di diverse identità collettive, elaborate in
opposizione alla definizione degli “Altri”.
Le condizioni di marginalità del campo rifugiati partecipano alla
costruzione dell’immagine del sé e del luogo di residenza da parte dei
rifugiati di Dheisha, in relazione alla classe media urbana che vive nell’area
di Betlemme, che i rifugiati considerano più fortunata.
Il luogo di residenza è una delle dimensioni d’appartenenza che
partecipano alla costruzione dell’immagine del sé e dell’altro e si basa sulla
condivisione delle esperienze di vita e sulla creazione di reti di relazioni di
solidarietà quotidiane tra i suoi abitanti, che danno forma allo spazio ed
31 Le città come Betlemme, dove vivono alcuni impiegati dell’ANP ed altri membri dell’élite
urbana, sono privilegiate da un maggior rifornimento d’acqua rispetto ai villaggi rurali ed in
particolare ai campi rifugiati, particolarmente svantaggiati.
38
Q
u
e
s
to
e
b
o
o
k
appart
all’identità sociale durante una continua produzione ed affermazione della
comunità.
Come ha sostenuto anche Layne per quanto riguarda la Giordania
(Layne 1994), nella graduale ristrutturazione dell’ANP sul modello del
moderno Stato occidentale, l’influenza dell’evoluzionismo sociale e della
modernizzazione porta alla diffusione di una concezione dicotomica della
relazione tra cittadinanza - associata alla classe media urbana locale - ed
appartenenza tribale – associata ai rifugiati.
Tale situazione si verifica soprattutto tra la più educata e
privilegiata élite urbana dell’area di Betlemme che, nella costruzione delle
differenze dai rifugiati, interpreta gli elementi e le pratiche della cultura
della classe media occidentale come segni di distinzione sociale e nuovi
criteri nella costruzione del sé e dell’altro, che portano a differenti
interpretazioni del contesto locale ed a nuove pratiche nelle interazioni
sociali.
Analizzando le relazioni matrimoniali tra rifugiati mussulmani e
cittadini cristiani, il processo di costruzione di un’appartenenza etnica e
religiosa da parte delle comunità cristiane dell’area di Betlemme emerge
come una strategia finalizzata al mantenimento del potere economico e
politico di una classe sociale privilegiata, escludendo i rifugiati dagli spazi
pubblici, dalla partecipazione alla negoziazione dei significati culturali e
dalla condivisione delle risorse simboliche e materiali locali.
Come reazione alle politiche di esclusione messe in atto dall’élite
urbana, gli abitanti di Dheisha associano un valore negativo alla cultura ed
ai modelli d’interazione della classe media occidentale ed idealizzano il
sistema morale tribale associato al campo rifugiati, considerandolo
un’espressione di “autenticità culturale”, come ha sostenuto anche Farah per
quanto riguarda il campo rifugiati al-baq’a in Giordania (Farah 1998).
I differenti immaginari collettivi del campo rifugiati, prodotti da
cittadini e rifugiati utilizzando il linguaggio morale, quello culturale e
religioso, costituiscono strategie politiche agite nel contesto di una crescente
competizione per le risorse materiali e simboliche dell’area, che ostacola la
coesione sulla concezione della realtà, dell’ANP, della cittadinanza e dello
status di rifugiato, oltre che sulle strategie di resistenza alle forze
d’occupazione israeliane32.
iene a\nGiu
32 È importante sottolineare che i differenti gruppi d’interesse che compongono la società
palestinese della West Bank non sono omogenei né per quanto riguarda le visioni, né le
pratiche. E’ importante considerare la dimensione della soggettività delle scelte e delle
esperienze vissute. L’opposizione tra cittadini e rifugiati non è dicotomica, ma contestuale e
39
Le ONG di Dheisha, dirette da alcuni rifugiati, non partecipano
alle manifestazioni di protesta per la mancanza d’acqua. La
professionalizzazione e la de-politicizzazione del ruolo delle ONG locali
sono le condizioni necessarie per ottenere i finanziamenti dai donatori
occidentali e si fondano sulla concezione di sviluppo come progresso
economico perseguibile attraverso la diffusione di pratiche individuali di
auto-aiuto (Hanafi and Tabar 2005).
Con l’obiettivo di ottenere legittimità da parte dei rifugiati, le
ONG locali approfittano della concezione della politica come slegata dalle
pratiche sociali, implicata dal paradigma di sviluppo, e creano spazi di
manovra per agire politicamente. Organizzano alcune attività culturali come
le lezioni di dabka (una danza collettiva popolare palestinese) e le visite ai
villaggi sgomberati33, prendendo parte alla continua reinvenzione culturale
del sistema tribale, orientato alla produzione della collettività di Dheisha
come una comunità di rifugiati. Tuttavia le organizzazioni, che si sono
adattate agli standard dei progetti a breve termine del paradigma dello
sviluppo, non prevedono programmi a lungo termine per supportare la
formazione di relazioni di solidarietà legate alle dimensioni d’appartenenza
tribali, permettendo ai rifugiati di marcare il contesto in termini culturali e
creando continuità spaziale e temporale.
Gli abitanti di Dheisha interpretano le attività organizzate come
pratiche di museificazione, cristallizzazione e reificazione della loro
appartenenza culturale, che alienano il potere dei rifugiati di definire il loro
mondo sociale e la loro identità e partecipano al processo di taṭbī’a
(normalizzazione)34 delle condizioni dei campi rifugiati e della loro
permanente presenza.
Concependo i cambiamenti sociali come una responsabilità
individuale, le “ONG dello sviluppo” favoriscono un processo di desviluppo e di privatizzazione della resistenza, ostacolando la partecipazione
pubblica dei rifugiati e diminuendo il loro potere nella competizione per la
definizione dello status del campo rifugiati. Amministrate come ditte private
che offrono servizi sociali ai rifugiati sulla base di relazioni politiche e
personali, le ONG rinforzano le discriminazioni strutturali locali.
Qu
es
to
eb
oo
ka
pp
riguarda specifici aspetti della vita quotidiana e specifiche dimensioni dell’incontro sociale.
33 Le foto scattate durante queste gite vengono spedite ad alcune organizzazioni straniere per
essere mostrate come evidenza della situazione dei rifugiati palestinesi. Tali progetti
partecipano al mantenimento della memoria storica e geografica dei villaggi d’origine ed alla
rivendicazione del diritto al ritorno da parte della comunità di Dheisha.
34 Tale termine, usato dai rifugiati, ha la stessa radice della parola “natura”.
40
ar
tie
ne
La rappresentazione del campo rifugiati come luogo della
memoria è il prodotto di dinamiche relazioni di potere tra differenti
immaginari collettivi, nel contesto della competizione per le risorse
materiali e simboliche locali.
Se da un lato il campo rifugiati suscita nei suoi abitanti un senso
di sicurezza e di potere legato al possesso del capitale sociale costituito
dalle reti di relazioni di solidarietà che lo caratterizzano, dall’altro lato
questo luogo di residenza e lo status ad esso associato sono percepiti come
fonti di discriminazioni nel confronto con la società esterna al campo
rifugiati.
Di fronte al tentativo dell’ANP di estendere il suo potere nello
spazio del campo rifugiati, la produzione dello stesso come luogo della
memoria costituisce un oggetto di rivendicazione politica da parte degli
abitanti di Dheisha. Il linguaggio incorporato delle tradizioni e delle
pratiche rituali esprime rivendicazioni legate alla modernità ed ai
cambiamenti socio-economici e politici del contesto locale.
Questo
ebook
ene a
apparti
41
ook a
to eb
Ques
Figura 19: il campo rifugiati di Dheisha (2010).
tiene
ppar
42
Bibliografia
Abdallah-Latte, Stéphanie. 1998. “History and Differences: Family Links in
Palestinian Camps in Jordan”, paper presented at the Annual Conference
of Middle East Studies Association of North America. Chicago. December.
CERMOC-Amman/EHESS-Paris.
Farah Randa. 1998. “Palestinian Identity, Refugees and UNRWA: Changing
Political Context and Issues”. Paper presented at the Annual Conference of
the Middle East Studies Association of North America (Chicago, December
1998).
Hanafi, Sari e Tabar, Linda. 2005. “The Emergence of a Palestinian
Globalized Elite. Donors, International Organizations and Local NGOs”.
Institute of Jerusalem Studies. Muwatin, The Palestinian Institute for the
Study of Democracy. Jerusalem.
Hannoyer Jean. 1989. “L’hospitalité, économie de la violence”. Dans
Maghreb-Machrek Monde Arabe, n. special: “Espaces et sociétés du monde
arabe”. Paris, La Documentation française, n.123, p.226-240.
Layne, Linda. 1994. “Home and Homeland. The Dialogics of Tribal and
National Identities in Jordan”. Princeton University Press.
sto
e
Qu
Peteet, Julie. 1994. “Male Gender and Rituals of Resistance in the
Palestinian Intifada: a Cultural Politics of Violence”, in American
Ethnologist 21, no.1 (1994: 31-49).
bo
o
e
Peteet, Julie. 1996. “The Writing on the Walls: the Graffiti of the Intifada”.
Cultural Anthropology, Vol. 11, n.2 (May, 1996), 139-159.
ne
p
p
art
ie
ka
Schiff, Benjamin. 1995. “Refugees unto the Third Generation. UN Aid to
Palestinians”.
Trottier, Julie. 2000. “Water and the Challenge of Palestinian Institution
Building”. In: Journal of Palestine Studies, Vol. 29; N. 2 (Winter, 2000);
pp. 35-50.
Van Aken, Mauro. 2003. “Facing Home. Palestinian Belonging in a Valley
of Doubt”. Shaker Publishing.
43
DINAMICHE DI ESCLUSIONE E DI INCLUSIONE NELLE
NARRAZIONI ISRAELIANA E PALESTINESE SUL CONFLITTO.
Enrico Bartolomei
Enrico Bartolomei
Laureato in Relazioni Internazionali all'Università di Perugia con
una tesi sugli aspetti storici, storiografici e politici della questione dei
rifugiati palestines, dal 2008 ha effettuato periodi di ricerca sul campo in
Israele/Palestina e Libano. I suoi interessi di ricerca sono orientati sul
pensiero politico contemporaneo palestinese ed arabo, sulle narrazioni e
storiografie palestinesi ed israeliane e in generale sul rapporto tra
produzione del sapere ed esercizio della violenza. Attualmente svolge un
dottorato di ricerca all'Università di Macerata sull'idea di Stato
democratico nel pensiero politico palestinese.
Abstract
Nei conflitti asimmetrici, caratterizzati da un notevole squilibrio
nei rapporti di forza, l'attore dominante riesce ad imporre una narrazione
del conflitto funzionale al perseguimento dei propri interessi. Il potere di
presentare come legittima la propria narrazione, marginalizzando le
versioni degli attori più deboli, genera delle dinamiche di inclusione e di
esclusione che entrano a far parte della fabbrica sociale, culturale e
istituzionale, riproducendo le gerarchie di potere che le hanno originate. In
primo luogo, questo studio si propone di analizzare in che modo la
narrazione israeliana dominante del conflitto abbia servito gli interessi
politici di Israele, delegittimando allo stesso tempo le rivendicazioni dei
palestinesi. In secondo luogo, si esaminerà il tentativo palestinese di
presentare una narrazione alternativa attraverso il paradigma
interpretativo del colonialismo di insediamento e la parola d'ordine dello
Stato democratico, avanzata dal movimento di resistenza in seguito alla
Guerra del giugno 1967 e ufficialmente adottata dall'Organizzazione per la
Liberazione della Palestina come obiettivo strategico della lotta.
L'obiettivo del presente studio è mostrare come l'idea di Stato
democratico abbia contribuito al superamento di un discorso basato sulla
contrapposizione nazionale, religiosa o etnica, per avanzare l'idea di una
società post-coloniale che includa i coloni ebraici su un piano di parità
accanto agli indigeni palestinesi.
In asymmetric conflicts, characterized by a strong imbalance
between the two sides, the dominant actor create a narrative of the conflict
artiene a\nG
app
Questo ebook
44
00
30
39
69
11
Giu
lian
aC
acc
iap
uo
ti C
LI_
20
13
that serves its own interests. The power to present one's own narrative as
legitimate, marginalizing those of the weaker actors, generates dynamics of
inclusion and exclusion that become part of the social, cultural and
institutional fabric, thus reproducing hegemonic power structures from
which they originated. First of all, this study aims at analyzing how the
dominant Israeli narrative of the conflict, while delegitimizing Palestinians'
demands, served Israeli political interests. Secondly, it will examine
attempts by the Palestinian resistance movement to create an alternative
narrative through the slogan of the democratic state, officially adopted as
the strategic objective of the Palestine Liberation Organization.
This study aims at showing how the paradigm of settler
colonialism and the idea of a democratic state have been employed to
deconstruct the Israeli narrative, to challenge dominant understandings of
the conflict as a national, religion or ethnic one and finally to support the
idea of a post-colonial society which would include Jewish settlers on an
equal footing alongside indigenous Palestinians.
Qu
est
oe
bo
o
ka
pp
art
ie
ne
a\n
Nei conflitti asimmetrici, caratterizzati da un notevole squilibrio
nei rapporti di forza, l'attore dominante riesce ad imporre una narrazione del
conflitto e un'immagine del nemico funzionali al perseguimento dei propri
interessi. Gli intellettuali e gli accademici legati all'establishment politicomilitare svolgono un ruolo decisivo nel riprodurre la narrazione dominante e
nello stabilire i termini mediante l’ interpretazione il conflitto. Il potere di
presentare come legittima la propria narrazione, marginalizzando le versioni
degli attori più deboli, genera delle dinamiche di inclusione e di esclusione
che entrano a far parte della fabbrica sociale, culturale e istituzionale,
riproducendo in vari modi (simboli, linguaggio, valori, sistema educativo,
burocrazia, ecc.) le gerarchie di potere che le hanno originate35.
Questo è particolarmente vero nel caso del conflitto israelopalestinese, in cui la diseguale relazione di potere fra le parti ha permesso
all'establishment israeliano di utilizzare stereotipi nazionali o miti storici
35 Si veda: Rosemary Shinko, "Discourses of Denial: Silencing the Palestinians,
Delegitimizing their Claims", Journal of International Affairs, Vol. 58, No. 1, Fall 2004;
Laurence J. Silberstein, "Postzionism: A critique of Zionist Discourse (Part 1)", PalestineIsrael Journal, Vol. 9, No.2, 2002. Più in generale, sulla relazione tra potere, conoscenza e
pratiche discorsive, si veda: Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews & Other
Writings, 1972-77, Pantheon Books, New York 1980; James F. Keeley, "Toward a Foucauldian
Analysis of International Regimes", International Organization, vol. 44, no. I, Winter 1990.
45
come vere e proprie armi propagandistiche36. Il discorso israeliano sul
conflitto, accettato in Occidente come obiettivo, è stato senza dubbio una
della ragioni del successo politico di Israele e ha in larga misura contribuito
alla legittimazione delle politiche di colonizzazione e occupazione nei
confronti dei palestinesi. Se, da un lato, la narrazione israeliana ha
contribuito a marginalizzare e delegittimare la causa palestinese, dall'altra
ha assicurato alle politiche israeliane l’appoggio delle opinioni pubbliche e
il supporto dei governi occidentali. Per dirla con lo storico palestinese Nur
Masalha, «il sionismo fu (e rimane) non solo qualcosa che ha a che fare con
la colonizzazione della terra palestinese, ma anche con la colonizzazione
delle menti - ebraiche, arabe, europee, americane»37.
In primo luogo, questo saggio si propone di illustrare in che modo
la narrazione israeliana abbia servito gli interessi dell'agenda politica di
Israele, delegittimando allo stesso tempo le rivendicazioni dei palestinesi.
Lo scopo è quello di rivelare gli effetti di potere connessi ai meccanismi di
inclusione e di esclusione che la leadership israeliana ha adoperato nella
rappresentazione di sé e del nemico. In secondo luogo, si esaminerà il
tentativo palestinese di presentare una narrazione alternativa attraverso la
parola d'ordine dello Stato democratico, avanzata dal Mrp in seguito alla
Guerra del giugno 1967 e ufficialmente adottata dall'Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (Olp). La proposta di Stato democratico
contribuì a legittimare le aspirazioni nazionali palestinesi agli occhi
dell'opinione pubblica mondiale: l'idea che i palestinesi lottassero per una
società inclusiva anche dei coloni ebraici era presentata in netta
contrapposizione al carattere coloniale, discriminatorio ed esclusivo dello
Stato ebraico, e apriva alla possibilità di una convivenza futura nella terra di
Palestina.
oo
k
b
sto
e
e
Qu
1. Dinamiche di esclusione nella narrazione israeliana del
conflitto
Come nota lo studioso Joseph Massad, la narrazione israeliana,
presentando la colonizzazione della Palestina e la creazione dello Stato di
Israele come legati all’esistenza stessa del popolo ebraico, ha fornito la
giustificazione ideologica per le politiche di colonizzazione ed occupazione
36 Michael Suleiman, “National Stereotypes as Weapons in the Arab-Israeli Conflict”,
«Journal of Palestine Studies», Vol. 3, No. 3, Spring 1974, pp. 109-121.
37 Nur Masalha, The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the Subaltern
Reclaiming Memory, Zed Books, London 2012, p. 5.
46
r
a
pp
a
Q
u
e
sto
nei confronti dei palestinesi38. La narrazione israeliana si è appropriata di
diversi eventi della storia del popolo ebraico allo scopo di creare un legame
diretto tra il passato ebraico e il presente della colonizzazione. Uno su tutti,
lo sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale, utilizzato per
giustificare retrospettivamente le aspirazioni coloniali del movimento
sionista: «appropriandosi dell'Olocausto nazista e delle sue vittime, il
sionismo e Israele hanno asserito che qualsiasi riconoscimento
dell'Olocausto è un riconoscimento del diritto di Israele ad esistere, e al
contrario che ogni tentativo di negare ad Israele il suo presunto diritto
all'esistenza era simultaneamente una negazione dell'Olocausto»39.
Inoltre, impostando il discorso sull'antisemitismo, il sionismo è
riuscito a definire il conflitto in termini di lotta per la sopravvivenza della
comunità ebraica in un ambiente arabo ostile, antisemita e votato alla sua
distruzione40: in questa prospettiva, le politiche israeliane potevano essere
presentate al mondo in termini di legittima difesa e di lotta per la
sopravvivenza. Il doppio processo di appropriazione selettiva della storia
ebraica e rimozione tout court di quella palestinese ha contribuito
largamente all'accettazione degli obiettivi del movimento sionista
nell'opinione pubblica occidentale e, specialmente, in quella statunitense.
Per dirla con Edward Said, la creazione di Israele nel 1948 è stata possibile
anche «perché i sionisti avevano già vinto la battaglia politica per la
Palestina nel mondo internazionale in cui si discutevano idee,
rappresentazioni, retorica, e immagini»41.
Il conflitto del 1948 è un chiaro esempio di rappresentazione degli
eventi storici secondo la narrazione dominante israeliana. Nei mesi che
precedettero il ritiro britannico dalla Palestina la leadership sionista tenne
un doppio atteggiamento: da un lato descriveva in pubblico lo scenario
apocalittico di un secondo Olocausto e presentava i palestinesi e gli arabi
come terroristi, gangster o addirittura nazisti; dall'altro, nelle riunioni
private e nei discorsi a uso interno, era ben consapevole della schiacciante
iul
e
b
o
ok a
p
p
a
rtien
e
a
\nG
acc
iana
C
ia
p
u
oti
CL
00
I_20
13
38 Joseph Massad, "Palestinians and Jewish History: Recognition or Submission?", Journal of
Palestine Studies, Vol. 30, No. 1, Autumn 2000, pp. 52-67.
39 Ivi, p. 55.
40 Questo traspare in molte dichiarazioni di leader sionisti e nella letteratura israeliana sul
conflitto. Si vedano, ad esempio, le opere di Yehoshafat Harkabi, capo dell'intelligence militare
e accademico: Arab Attitudes to Israel, Keter Publishing House, Jerusalem 1972. Nel 1969
l'Unione Democratica Amici di Israele pubblicò in italiano un opuscolo, sempre dello stesso
autore, intitolato L'antisemitismo arabo, nel quale si sostiene che la volontà araba di
distruggere Israele affonderebbe le proprie radici nell'antisemitismo (benché di natura diversa
da quello europeo) e nasconderebbe intenzioni genocide.
41 Edward Said, C. Hitchens (a cura di), Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the
Palestinian Question, Verso, London 1988, p. 1.
303
9
6
911
47
Questo ebook appartie
superiorità militare di cui godeva42. Fin dalla Dichiarazione di
Indipendenza, la leadership dello Stato ebraico stabilì un legame diretto tra
creazione dello Stato di Israele, Olocausto e colonizzazione della Palestina:
«l'Olocausto commesso contro il Popolo di Israele in tempi recenti [...] ha
dimostrato ancora una volta palesemente la necessità di una soluzione al
problema del popolo ebraico, che manca di una patria e di indipendenza. La
soluzione è il rinnovamento [renewal] dello Stato ebraico in Israele, che
spalancherà le porte della patria a ogni ebreo»43.
All'interno del discorso sionista, che stabiliva un collegamento
diretto tra la tragedia degli ebrei in Europa e l'immigrazione ebraica in
Palestina, era estemamente difficile per i palestinesi guadagnarsi uno spazio
alternativo di supporto per le proprie rivendicazioni nazionali. Fino al 1980,
nota lo storico israeliano Ilan Pappé, il punto di vista storiografico nei
confronti dei palestinesi era «monolitico e basato su stereotipi»44. Secondo
l'esperto di studi ebraici Laurence J. Silberstein, laddove la storiografia
israeliana tradizionale impiegava termini come "guerra di liberazione",
"focolare nazionale ebraico", aliyah45, "redenzione nazionale",
"riunificazione degli ebrei in esilio", aveva già sposato il quadro di
riferimento interpretativo sionista. In questo modo, la storiografia
tradizionale ha legittimato la versione storica sionista, escludendo allo
stesso tempo la prospettiva palestinese da qualsiasi resoconto ufficiale sul
passato di Israele46. L'invenzione e la mobilitazione da parte sionista di
paradigmi etnocentrici e di mitologie bibliche ("terra promesa", "popolo
eletto", "ritorno", "un popolo senza terra per una terra senza popolo"),
sostiene Nur Masalha, permisero di svuotare (concettualmente ancor prima
che fisicamente) la Palestina dei suoi abitanti originari e legittimare le
politiche di colonizzazione e pulizia etnica nei confronti dei palestinesi47.
42 Ilan Pappe, La pulizia etnica della Palestina, Fazi Editore, Torino 2009, pp. 96-98.
43 Joseph Massad, art. cit., p. 53.
44 Ilan Pappe, "Post-Zionist Critique on Israel and the Palestinians: Part I: The Academic
Debate", Journal of Palestine Studies, Vol. 26, No. 2, Winter 1997, p. 32.
45 In ebraico "salita". Indica l'immigrazione ebraica in Israele.
46 Laurence J. Silberstein, "Postzionism: A Critique of Zionist Discourse (Part 2)", PalestineIsrael Journal, Vol.9, No.3, 2002. Si veda anche: Baruch Kimmerling "Academic History
Caught in the Cross-Fire: The Case of Israeli-Jewish Historiography", History and Memory,
Vol. 7, No. 1, 1995, pp. 41-65.
47 Nur Masalha, The Bible and Zionism: Invented Traditions, Archeology and PostColonialism in Israel-Palestine, Zed Books, London 2007.
48
ne
Tuttavia, ciò che sorprende della nakba48, è il fatto che «la pulizia
etnica del 1948 sia stata cancellata quasi del tutto dalla memoria globale
collettiva e rimossa dalla coscienza del mondo»49. La negazione della
pulizia etnica della Palestina, completata con la sistematica cancellazione di
ogni traccia storica dell’esistenza dei palestinesi e dalla reinvenzione di un
paesaggio sionista, rimane centrale per il successo dell'impresa coloniale
israeliana. Per dirla con Nur Masalha, «la negazione è stata sempre una
componente chiave del discorso israeliano, negazione dell'esistenza del
popolo palestinese, negazione della sua pulizia etnica nel 1948, negazione
del suo diritto al ritorno, negazione delle sue rivendicazioni su
Gerusalemme e così via, ad infinitum e ad nauseam»50. A partire dalla
nakba, il popolo palestinese scomparve dai dizionari, dalle mappe
geografiche e dalla memoria collettiva internazionale, e i palestinesi erano
descritti solamente in termini vaghi e generali come "profughi arabi" o
"arabi israeliani"51.
Durante la guerra del giugno 1967, la leadership israeliana fece di
nuovo leva sui temi dell'Olocausto e dell'antisemitismo per legittimare la
propria politica espansionista. Alla vigilia della guerra, secondo uno schema
ormai consolidato, la propaganda israeliana aveva insistito sul fatto che
qualsiasi attacco a Israele avrebbe comportato un secondo Olocausto. La
conseguenza fu che l'opinione pubblica europea e statunitense accettò
largamente l'idea secondo cui la comunità ebraica in Palestina fosse davvero
in pericolo di annientamento. L'esempio che segue illustra come le pratiche
discorsive e di rappresentazione della realtà permettono all'attore dominante
(Israele) di inquadrare gli eventi secondo schemi interpretativi
(antisemitismo, "secondo Olocausto", "gli ebrei a mare") che riflettono la
propria agenda politica (espansione territoriale e altra ondata di pulizia
etnica).
Il primo presidente dell’Olp Ahmad Shuqairy sarà ricordato come
“l’uomo che ha dato un cattivo nome ai palestinesi minacciando di buttare a
48 Termine arabo per "catastrofe", si riferisce alla pulizia etnica della Palestina nel 1948, che
portò all'espulsione di circa 750 000 palestinesi e alla distruzione di oltre 500 tra villaggi e
quartieri urbani. Ilan Pappé, La pulizia etnica della Palestina, cit.
49 Ilan Pappe, La pulizia etnica della Palestina, cit., p. 21. Solo a partire dalla seconda metà
degli anni Ottanta la cosiddetta "nuova storiografia israeliana" ha rimesso in discussione la
narrazione sionista ufficiale del 1948, decostruendone i principali miti fondativi.
50 Nur Masalha, The Politics of Denial: Israel and the Palestinian Refugee Problem, Pluto
Press, London 2003, p. 255.
51 Elias Sanbar., “Out of Place, Out of Time”, «Mediterranean Historical Review», Vol. 16,
No. 1, pp. 87-94.
st
o
ue
Q
49
e
par
tien
ea
\nG
iulia
na
Cac
ciap
uot
i CL
I_2
013
003
039
691
1
mare gli ebrei”52. Secondo la versione israeliana degli eventi, durante una
conferenza stampa tenuta alla vigilia della guerra, Shuqairy avrebbe esortato
gli eserciti arabi a “buttare gli ebrei a mare”. Sebbene l'allora presidente
dell'Olp fosse rinomato per i toni accesi della sua retorica, sembra che le
origini di questa espressione risalgano a un discorso pronunciato dal primo
ministro israeliano Ben Gurion nel 1961 e solo in seguito, grazie a un'abile
propaganda israeliana, la formula "buttare gli ebrei a mare" fu di volta in
volta attribuita al presidente egiziano Nasser, al capo dell’Olp Shuqairy e
persino allo stesso Arafat53.
Lo studioso statunitense William James Martin ha passato al
setaccio tutti i discorsi di Nasser senza trovare traccia di espressioni che
invitavano a "buttare a mare" gli ebrei54. Tra il 1973 e il 1974, il membro
del parlamento britannico Christopher Mayhew aveva offerto la somma di
5.000 sterline a chiunque avesse fornito la prova di dichiarazioni genocide
da parte di Nasser o di qualsiasi altro leader arabo. Dopo aver ricevuto
svariate lettere in cui si riportavano citazioni di vari leader arabi, che il
deputato britannico dimostrò essere infondate, Mayhew fu portato in
tribunale da un certo Warren Bergson. Nel febbraio del 1976, il ricorrente
dovette però riconoscere dinanzi all'Alta Corte di Giustizia di non essere
riuscito a trovare alcuna dichiarazione che potesse essere descritta come
genocida55.
Anche lo storico israeliano Moshe Shemesh ha cercato di far luce
su questa vicenda. Secondo quanto riportato dal quotidiano libanese «AlYawm», interrogato sul destino degli ebrei in caso di vittoria araba,
Shuqairy avrebbe in realtà risposto: «faremo ogni tentativo per assistere [gli
ebrei] e facilitare la loro partenza via mare verso i paesi di origine»56. Al
tempo, la dichiarazione del capo dell’Olp non attirò l’attenzione di nessuno.
Shemesh afferma che «fu solamente in seguito alla Guerra, quando Israele
lancia la sua campagna di informazione incentrata sull’ostilità araba verso
Que
sto
e
boo
k ap
52 Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organisation: People, Power and Politics,
Cambridge University Press, Cambridge 1983, p. 31.
53 L’11 Ottobre 1961 Ben Gurion dichiara davanti alla Knesset: «Abbiamo documenti espliciti
che testimoniano come [gli arabi] se ne siano andati seguendo gli ordini dei leader arabi […]
supponendo che l’invasione degli eserciti arabi alla scadenza del Mandato avrebbe distrutto lo
Stato ebraico e buttato tutti gli ebrei nel mare, vivi o morti». In William M. James, “Who is
Pushing Whom into the Sea?”, Counterpunch, March 11, 2005.
54 Ibidem.
55 Su questa vicenda si veda: Manchester Guardian, September 9, 1974; "Mayhew sued for £
5000", Manchester Guardian, October 8, 1974, p. 5; "Apology on Mayhew Challenge",
«Manchester Guardian», February 24, 1976, p. 7.
56 Moshe Shemesh, “Did Shuqayri Call For Throwing the Jews into the Sea?”, Israel Studies,
Summer 2003, p. 72.
50
artie
ne a
\nGiu
li
Ques
to
eboo
k app
Israele prima del conflitto, che l’espressione di Shuqairy venne sfruttata a
pieno»57. In questo modo l'aggressione israeliana, che portò all'occupazione
di Cisgiordania, Striscia di Gaza, Alture del Golan e Sinai, poteva essere
presentata come una guerra difensiva, necessaria per scongiurare un
secondo Olocausto.
Shuqairy dal canto suo negò di aver pronunciato quelle frasi che, a
suo avviso, erano state fabbricate ad hoc dalla propaganda sionista58. Il fatto
che vari circoli arabi e palestinesi, per questioni di politica interna59, lo
accusarono di aver contribuito alla disfatta screditando la causa araba agli
occhi del mondo fece sì che la versione israeliana fosse in parte recepita
anche nel mondo arabo. La frase “buttare gli ebrei a mare”, che evoca nelle
coscienze occidentali immagini altamente emotive relative allo sterminio
degli ebrei in Europa, fu abilmente sfruttata dai leader israeliani per
giustificare le politiche di occupazione ed espropriazione nei confronti dei
palestinesi, e fu acriticamente riproposta dalla letteratura occidentale sul
conflitto60.
2. Il Mrp e la "battaglia" per l'opinione pubblica: la proposta di
Stato democratico
La disfatta del 1967 rivelò il vuoto delle strutture politiche nel
mondo arabo. Il Mrp approfittò del discredito in cui era caduto l’ideale
panarabista (nasseriano e baathista) agli occhi degli arabi, per ritagliarsi uno
spazio autonomo nella politica mediorientale. Tra il settembre 1968 e il
57 Ivi, p. 73.
58 In una conferenza stampa tenuta ad Amman il 1 giugno 1967, quindi prima dello scoppio
delle ostilità, Shuqayri afferma: «non vogliamo buttare gli ebrei a mare. Questa è una vecchia
accusa che fu fabbricata per la prima volta dai sionisti contro i leader palestinesi nel 1929 [...].
Siamo contro Israele in quanto Stato, non contro gli ebrei in quanto ebrei», poi continua
sostenendo che tutti gli ebrei palestinesi che rinuncino alla fedeltà al sionismo e allo Stato di
Israele potranno rimanere in Palestina: «gli altri se ne andranno nello stesso modo in cui
vennero; vennero dal mare, e se ne andranno dal mare. Siamo pronti a lavorare insieme alle
Nazioni Unite per facilitare il loro ritorno ai loro paesi originari». In "News Conference
Statements by the Head of the Palestine Liberation Organization ash-Shuqayri", Amman, June
1, 1967, in International Documents on Palestine 1967, Institute for Palestine Studies, Beirut
1970, pp. 570-571.
59 Una nuova generazione di leader, che rappresentava le organizzazioni di guerriglia, stava
per rimpiazzare la "vecchia guardia" dei notabili alla guida dell'Olp.
60 Tragica ironia della storia, i palestinesi di Haifa e di Jaffa, durante la pulizia etnica del 1948,
furono letteralmente "buttati a mare" dalle milizie ebraiche. Si veda: Walid Khalidi, "Selected
Documents on the 1948 Palestine War", Journal of Palestine Studies, Vol. 27, No. 3, Spring,
1998, pp. 60-105; Ilan Pappe, La pulizia etnica della Palestina, cit.
51
Q
ue
febbraio 1969, le organizzazioni di guerriglia61 presero definitivamente il
controllo delle istituzioni dell'Olp, scalzando la "vecchia guardia" dei
notabili. Uno dei meriti del Mrp fu quello di aver compreso fin dall'inizio
l’importanza di dover combattere, accanto alla lotta di liberazione, anche la
battaglia politica per il consenso dell’opinione pubblica mondiale.
Presentando una versione coerente del proprio passato e una visione
rivoluzionaria di futuro, i palestinesi costruirono lo spazio all'interno del
quale poterono riappropriarsi della propria identità nazionale, legittimare le
proprie rivendicazioni politiche e mettere in discussione la narrazione
israeliana degli eventi. Per la prima volta dalla nakba, i palestinesi
diventarono i narratori di se stessi.
Nel primo comunicato internazionale alla stampa mondiale del
gennaio 1968, Fatah si propone di «illuminare l’opinione pubblica mondiale
sulla portata e il significato della sua lotta [...] correggendo alcuni malintesi
sulle proprie operazioni e sulla natura della lotta»62. Nel documento si legge
che le operazioni di Fatah «non sono in alcun modo dirette al popolo
ebraico in quanto tale»63, ma al «regime fascista-militare-sionista»64. In "La
liberazione dei territori occupati", un testo usato per la formazione dei
guerriglieri nei campi di addestramento, si legge che è necessario presentare
con chiarezza gli obiettivi della lotta di liberazione «affinché non ci si
accusi di fascismo, antisemitismo e di altre imputazioni»65. Nella
dichiarazione del Comitato centrale del gennaio 1969, si afferma che
l'obiettivo di Fatah è «la restaurazione dello Stato palestinese indipendente e
democratico, i cui cittadini, quale che sia la loro confessione, godranno di
uguali diritti»66.
In A Strategy for the Liberation of Palestine, documento del
febbraio 1969, il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), la
seconda organizzazione più importante dopo Fatah, elenca con estrema
lucidità i fattori che «hanno distorto la verità sulla nostra guerra di
liberazione e ancora minacciano di falsare la corretta visione della vera
61 In questa sede si prenderanno in considerazione le tre organizzazioni palestinesi più
importanti a livello politico e militare: Fatah, Fronte popolare per la liberazione della Palestina,
Fronte democratico popolare per la liberazione della Palestina.
62 "Press Release No.1 by the Palestine National Liberation Movement Fateh", International
Documents on Palestine 1968, The Institute for Palestine, Beirut 1971, p. 304.
63 Ivi, p. 305.
64 Ibidem.
65 "La liberazione dei territori occupati", «Studi ed esperienze rivoluzionarie», n. 8, 1968, in
Rivoluzione palestinese, quindicinale del Comitato di solidarietà con il popolo di Palestina,
numeri 2-3, Roma, 1 maggio 1969, p. 11.
66 Bichara e Naïm Khader (a cura di), Testi della rivoluzione palestinese 1968-1969, Bertani
Editore, Verona 1976, p. 200.
52
LI
_2
iap
uo
ti C
Qu
es
to
eb
oo
ka
pp
ar
tie
n
e
a\
nG
iul
i an
a
Ca
cc
natura di questa guerra agli occhi di molte persone»67. Tra questi «c'è stata
la connessione tra la nascita del movimento sionista e la persecuzione degli
ebrei in Europa. Poi c'è stata l'associazione fra l'ascesa di Israele e il
trattamento nazista degli ebrei nella Seconda guerra mondiale. In aggiunta a
ciò c'è stata l'influenza dominante imperialista e sionista in ampie fasce
dell'opinione pubblica mondiale»68. Il documento prosegue chiarendo che il
movimento di liberazione palestinese non è rivolto contro gli ebrei, ma
«contro il sionismo in quanto movimento aggressivo razziale collegato
all’imperialismo»69. Lo scopo del Mrp è quindi duplice: «distruggere lo
Stato di Israele come istituzione militare, politica ed economica»70 e
edificare al suo posto uno «Stato democratico nazionale in Palestina, in cui
sia arabi sia ebrei vivranno come cittadini con uguali diritti e doveri e che
costituirà parte integrante della presenza progressista nazionale democratica
araba»71.
In sostanza, le principali organizzazioni di resistenza palestinesi
operano un fondamentale ripensamento della natura del nemico, i cui
pilastri sono la netta distinzione tra sionismo ed ebraismo, l’accettazione di
milioni di ebrei sul suolo della Palestina come fatto irreversibile, la proposta
di convivenza in uno Stato laico e democratico e l’appello agli ebrei
progressisti e antisionisti affinché si uniscano alla lotta. Fino a quel
momento, la leadership tradizionale palestinese e araba fornisce due letture
del sionimo e di Israele: la prima lo considera un progetto nazionalista
ebraico a cui occorre contrapporre un nazionalismo (wataniyya) palestinese
o un nazionalismo (qawmiyya) arabo; la seconda lettura, formulata in
termini religiosi, considera Israele come uno Stato confessionale a cui dover
contrapporre un movimento che faccia appello alla umma islamica. Il Mrp
rifiuta di costruire un antagonismo esclusivamente nazionalista o religioso,
o incentrato sulla disumanizzazione del nemico, ispirarandosi invece ai
movimenti di liberazione nazionale e all'anticolonialismo terzomondista (gli
esempi dell'Algeria, di Cuba, della Cina e del Vietnam influenzano
enormemente il Mrp in questa fase). Utilizzando il paradigma analitico del
colonialismo di insediamento, il sionismo è concepito come un movimento
coloniale e Israele come l'avamposto che l'imperialismo, con l'aiuto delle
forze reazionarie locali, ha impiantato nel cuore del mondo arabo per
67 The Popular Front for the Liberation of Palestine, A Strategy for the Liberation of Palestine,
Pflp Information Department, Amman 1969, Cap. X.
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
53
o
Quest
impedirne l'unità e sfruttarne le risorse. Per questa ragione nei documenti
delle organizzazioni di resistenza palestinesi gli ebrei israeliani sono
considerati spesso "vittime" del sionismo.
Per quanto Israele si sia sempre definito come "Stato ebraico",
contribuendo alla confusione tra ebraismo, sionismo e Israele, il Mrp ha
sempre cercato di distinguere tra l'ebraismo in quanto religione, il sionismo
in quanto movimento coloniale e Israele in quanto Stato esclusivista,
evitando così di cadere nella "trappola ideologica" che equipara
antisionismo e antisemitismo. Come ha evidenziato l'antropologa
Julie Peteet, i palestinesi hanno cercato di non impiegare il termine "ebrei"
per riferirsi a coloro che si stabilirono in Palestina e crearono lo Stato di
Israele, ma di utilizzare invece il termine "sionisti": «questo faceva parte di
un atteggiamento politico che sottolineava la natura coloniale del conflitto e
non le sue dimensioni religiose o etniche»72. Il fatto che la lotta palestinese
sia inserita nel solco delle lotte di liberazione dal colonialismo e
dall’imperialismo permette al Mrp di guadagnare la solidarietà dei
movimenti terzomondisti e dei circoli progressisti e della sinistra radicale
occidentale. La causa palestinese assume così una dimensione simbolica
universale in quanto rappresenta la lotta di liberazione di un popolo del
Terzo Mondo contro l’ultima sopravvivenza di colonialismo occidentale73.
ebook
\nGiuli
iene a
appart
ana C
L'adozione della proposta di Stato democratico in cui palestinesi ed
ebrei avrebbero convissuto con pari diritti e responsabilità comporta una
ridefinizione fondamentale della natura e degli obiettivi della lotta di
liberazione. Nei testi politici delle organizzazioni di resistenza - esaminate
brevemente di seguito - si opera una sostanziale umanizzazione della figura
del nemico, che passa attraverso la rivalutazione di una storia ebraica
sganciata dalla vicenda sionista e di un passato di armoniosa convivenza tra
ebrei ed arabi precedente all'arrivo del sionismo in Palestina; la rilettura dei
compiti attuali del Mrp, che deve inglobare le componenti ebraiche
antisioniste e acuire le contraddizioni all'interno della società israeliana; la
visione di una società futura, laica e democratica, che includa a pieno titolo
la componente ebraica, "liberata" finalmente dal sionismo.
969
00303
I_2013
uoti CL
acciap
72 Julie Peteet, “Words as Interventions: Naming in the Palestine: Israel Conflict”, Third
World Quarterly, Vol. 26, No. 1, 2005, p. 171.
73 Alain Gresh, "Reflections on the Meaning of Palestine", Journal of Palestine Studies, Vol.
41, No. 1, Autumn 2011, p. 68.
54
3. "Liberare gli ebrei dal sionismo": la decostruzione della
narrazione sionista
Una della formulazioni più esaustive del pensiero della corrente di
maggioranza di Fatah si trova in una pubblicazione del Centro di ricerca
dell'Olp col titolo Towards a Democratic State in Palestine. The Palestinian
Revolution and the Jews Vis-à-Vis the Democratic, Nonsectarian State in
the Palestine of the Future74. Nella prima parte del saggio, “The Palestinian
Revolution and the Jews”, l’autore sostiene che l'elemento rivoluzionario
nell'idea di Stato democratico consiste nel fatto che, dopo essere stati
espulsi dalla loro terra, i palestinesi facciano appello alla creazione di un
paese che comprenda anche gli ex-aggressori. Nei trent’anni del Mandato
britannico, si legge nel testo, l'ostilità dei palestinesi era diretta
principamente contro la potenza mandataria; in seguito all'espulsione dei
palestinesi per mano di leader ebrei che volevano la creazione di uno Stato
ebraico, i palestinesi furono spinti «ad odiare gli ebrei, qualsiasi cosa
“ebraica”, qualsiasi cosa connessa col loro nemico»75. L’inizio della
rivoluzione palestinese76 segna anche il sorgere di un nuovo atteggiamento
nei confronti del nemico, in cui la distinzione tra "ebreo" e "sionista"
cominciò ad aquisire significato. Questo cambiamento, continua il testo, è
determinato da una serie di fattori: l’esigenza di definire gli obiettivi della
lotta di liberazione, che non poteva più limitarsi alla vendetta; il contributo
degli ebrei progressisti che intentavano un dialogo con la resistenza; lo
studio della storia ebraica e la riscoperta del pensiero degli intellettuali ebrei
umanisti.
Nella seconda parte del saggio “An Approach to the Study of
Jewish Attitudes”, l'autore afferma che molte delle immagini sul conflitto
sono state architettate dai sionisti tramite la loro macchina propagandistica.
Ne fornisce un esempio il successo avuto nell’identificare ebraismo e
sionismo agli occhi della maggioranza degli ebrei, specialmente nei paesi
occidentali, e le immagini deumanizzanti utilizzate per descrivere i
palestinesi e la loro leadership. Il merito della rivoluzione palestinese,
continua il testo, è di aver presentato una soluzione alternativa
74 Mohammed Rasheed (pseudonimo del leader di Fatah e dell’Autorità Nazionale Palestinese
Nabil Sha'th), Towards a Democratic State in Palestine. The Palestinian Revolution and the
Jews Vis-à-Vis the Democratic, Nonsectarian State in the Palestine of the Future, PLO
Research Center, Beirut 1970. Ripubblica tre articoli apparsi nel periodico in lingua inglese
«Fateh», tra il novembre del 1969 e il gennaio del 1970.
75 Ivi, p. 14
76 Si intende il 1° gennaio 1965, data della prima operazione di Al-'Asifa, l’ala miliare di
Fatah, contro Israele.
55
Q
all'esclusivismo sionista: per questa ragione «un dialogo si sta sviluppando
tra i rivoluzionari palestinesi e gli ebrei, liberali, progressisti, socialisti e
persino conservatori»77, nella speranza che un numero sempre maggiore di
ebrei si unisca alla causa palestinese.
Nella terza e ultima parte, "Towards a Democratic Palestine",
l'autore affronta il tema dello Stato democratico, l'unica alternativa sia
all’esilio dei palestinesi e all’edificazione di uno Stato costruito su basi
razziste, sia alla cancellazione della presenza ebraica in Palestina. Lo Stato
democratico rappresenta una visione progressista e non settaria di
convivenza futura, da realizzare in seguito allo smantellamento delle
strutture militari, economiche e politiche di Israele. Nel futuro Stato, si
legge nel testo, «tutti gli ebrei, musulmani e cristiani che vivono in Paestina
o che sono stati esiliati con la forza, avranno diritto alla cittadinzanza
palestinese»78.
Il Fronte democratico popolare per la liberazione della Palestina
(Fdplp) dà un apporto fondamentale al dibattito in un documento del
settembre 1969 intitolato A Popular Democratic Solution for the Palestine
Problem. In questo scritto si introducono importanti novità: si rifiutano
«tutte le soluzioni scioviniste, reazionarie, sioniste e imperialiste»79 che
prevedono sia il riconoscimento dello Stato di Israele sia il “buttare a mare
gli ebrei”. Il Fdplp, organizzazione di ispirazione marxista-leninista, si
propone di «erigere uno Stato palestinese popolare e democratico per arabi
ed ebrei nel quale non ci sarà posto né per la discriminazione né per
l’oppressione nazionale [qawmi] o di classe e dove venga rispettato il diritto
degli arabi e degli ebrei di perpetuare e sviluppare le proprie culture
indigene [al-thaqafa al-watani]»80.
Il discorso si fa sempre meno nazionalista: il concetto di
“coesistenza di musulmani, cristiani ed ebrei”, presente nei testi di Fatah e
di ispirazione religiosa, viene sostituito con quello di “coesistenza degli
arabi e degli ebrei”, che fa riferimento all’esistenza di due popoli. Il testo
sembrerebbe introdurre un'altra novità laddove si legge che grazie alla lotta
Qu
est
oe
boo
ka
ppa
rtie
ne
a\n
Giu
lian
aC
acc
iap
77 Ivi, p. 30.
78 Ivi, p. 35.
79 "Draft Resolution Submitted by the Popular Democratic Front for the Liberation of
Palestine at the Sixth Session of the Palestine National Council Concerning 'a Popular
Democratic Solution for the Palestine Problem' ", International Documents on Palestine 1969,
The Institute for Palestine Studies, Beirut 1972, p. 777.
80 Ibidem. Nella traduzione inglese dell'Institue for Palestine studies qawmi è tradotto con
"national" e watani con "indigenous". In italiano la traduzione più esatta di qawmi, in questo
contesto, sarebbe "etnico".
56
uot
i CL
armata si riuscirà a «liberare gli ebrei dal sionismo»81 e stabilire uno «Stato
democratico nel quale arabi ed ebrei godranno di uguali diritti nazionali
[watani] e responsabilità»82. Il riferimento a diritti "nazionali" al popolo
ebraico è assolutamente nuovo e non mancherà di attirare le critiche delle
altre organizzazioni di resistenza83. Nell’ultima parte della proposta si
rivolge un «appello a tutti gli elementi o i gruppi antisionisti e
antimperialisti all’interno di Israele e tra gli ebrei affinché supportino questa
soluzione»84. Anche qui, per la prima volta, l'appello è rivolto non solo alle
comunità ebraiche fuori dalla Palestina, ma anche a quelle israeliane, purché
non sioniste.
In un’intervista apparsa su «Africasia» nel 1970, il Segretario
generale del Fdplp Nayef Hawatmeh afferma che, per la prima volta,
un'organizzazione palestinese ha proposto una «soluzione internazionalista
delle questioni israeliana e palestinese»85 che supera sia «l'influenza
dell'ideologia delle classi governanti, ideologia feudale e religiosa o, al
meglio, piccolo borghese con sfumature antisemite»86, sia le posizioni dei
feudatari e dei capitalisti ebraici. Questi ultimi, appellandosi all'unità del
popolo ebraico e al “ritorno alla terra promessa”, hanno creato la
distinzione tra ebrei e gentili, isolando il proletariato ebraico dai lavoratori
dei rispettivi paesi. Con la creazione di Israele, continua Hawatmeh, il
sionismo ha ulteriormente rafforzato l’alienazione del proletariato ebraico.
La soluzione avanzata dal Fdplp consiste nella creazione di «uno Stato
democratico e socialista dove israeliani e arabi godranno degli stessi
diritti»87 e che, secondo la visione panarabista dell'organizzazione, sia
«integrato in una federazione o confederazione araba (come la Jugoslavia o
la Cecoslovacchia, per esempio)88.
Nel marzo del 1974, Hawatmeh pubblica un’intervista sullo
Yedioth Aharonot, uno dei più diffusi giornali israeliani. Non era mai
successo che un leader palestinese si rivolgesse direttamente ad un pubblico
israeliano. In quest’intervista, che suscita più reazioni nel Mrp che
all’interno dell’opinione pubblica israeliana, il segretario del Fdplp cerca di
ie
ap
pa
rt
est
o
Qu
eb
oo
k
n
G
i
u
lia
\n
ne
a
81 Ibidem.
82 Ibidem.
83 Per una discussione dell'argomento si veda: Alain Gresh, Storia dell’Olp. Verso lo Stato
palestinese, Edizioni Associate, Roma 1988, pp. 60-61.
84 Ivi, p. 778
85 Documents of the Palestinian Resistance Movement, Merit Publications, New York 1971, p.
15.
86 Ibidem.
87 Ibidem
88 Ibidem.
57
na C
partiene a\nGiulia
Questo ebook ap
stabilire delle possibilità di dialogo che «dipenderanno dallo sviluppo delle
correnti progressiste, democratiche, antisioniste e antimperialistiche in seno
alla società israeliana»89. Hawatmeh riconosce che nelle condizioni attuali,
dove «la maggioranza degli israeliani è orientata verso la reazione»90, la
realizzazione immediata di uno Stato democratico è impossibile. Per questa
ragione, il punto di partenza deve essere il soddisfacimento di certi diritti
nazionali palestinesi (tra cui la costituzione di un'autorità nazionale
palestinese in Cisgiordania e Striscia di Gaza e il ritorno dei profughi), che
«consentirà ai palestinesi e agli israeliani progressisti e democratici, ostili
all'imperialismo e al sionismo, di stabilire un dialogo»91. Non a caso il
Fdplp è tra le prime organizzazioni della resistenza palestinese a stringere
contatti con gruppi israeliani antisionisti come il Matzpen e ad avanzare
l'idea di uno Stato palestinese su parti della Palestina come fase intermedia
per la liberazione completa.
Il Fplp di George Habash, anch'essa organizzazione di ispirazione
marxista-leninista e di orientamento panarabista, elabora la sua posizione
sullo Stato democratico nell'opuscolo Palestine: Towards a Democratic
Solution, pubblicato nel 1970. Nel testo si distingue tra soluzione
democratica alla questione ebraica e soluzione democratica alla questione
israeliana. Se si parla di soluzione democratica alla questione israeliana,
diventerebbe legittimo parlare di uno Stato federale in Palestina, opzione
decisamente rifiutata in quanto «nessun movimento progressista di
liberazione è autorizzato a trovare una “soluzione democratica” a una
situazione di aggressione»92 (lo Stato di Israele). Pertanto, non può esistere
una soluzione democratica alla questione israeliana93, perché non può
esserci soluzione democratica a un problema coloniale. Tuttavia, «è dovere
di ogni movimento di liberazione nazionale progressista trovare una
"soluzione democratica" a un popolo che è stato usato dalle forze
dell’aggressione e utilizzato [...] per preservarla»94. In altre parole, spetta al
movimento di liberazione palestinese rimuovere sia la manifestazione
visibile di questa aggressione, lo Stato di Israele, sia la motivazione
ideologica che ne è alla base, il sionismo. La soluzione democratica, nella
89 Ibidem.
90 Ivi, p. 314
91 Ivi, p. 315.
92 Palestine: Towards a Democratic Solution, P.F.L.P. Information Departement, [s.l.], 1970,
p. 14.
93 Il Fplp polemizza con alcune dichiarazioni rilasciate da leader del Fdplp, nelle quali si
auspicava la soluzione della "questione israeliana" nell'ambito di una federazione o
confederazione sul modello jugoslavo o cecoslovacco.
94 Palestine: Towards..., cit., p. 14.
58
o eboo
Quest
sua giusta impostazione, «riguarda direttamente gli ebrei che vivono in
Palestina, e non lo Stato israeliano. È una soluzione democratica della
"questione ebraica" [...]. Non è una "soluzione democratica" della "entità
israeliana", né del movimento sionista»95. Certo, il movimento nazionale
palestinese si è impegnato a liberare sia gli arabi che gli ebrei e nella lotta
bisogna guadagnare alla causa palestinese «gli ebrei vittime dello
sfruttamento sionista»96, ma questo compito per il Fplp è complicato dal
fatto che il proletariato ebraico a sua volta fruisce dello sfruttamento degli
arabi. Lo smantellamento dello Stato israeliano diventa quindi la conditio
sine qua non per «liberare le classi vittime dello sfruttamento sionista»97.
In un'intervista al «Baghdad Observer», un rappresentante anonimo
del Fplp appoggia la creazione di «uno Stato della masse arabe proletarie,
socialiste e unite [...] dove scompaiono tutte le forme di sfruttamento
economico e sociale, così come l’oppressione razziale nazionale, religiosa o
di altro tipo»98. Il segretario generale Habash, in un’intervista al quotidiano
libanese «al-Ahrar», ribadisce che il destino della Palestina è strettamente
connesso a quello del più vasto mondo arabo: il Fplp si impegna perciò a
«presentare una soluzione democratica alla questione ebraica in Palestina in
modo che tutti i cittadini ebrei possano godere e godranno
indiscriminatamente e in maniera eguale i diritti di cittadinanza all’interno
di una Palestina liberata, organicamente unita con la patria e la nazione
araba»99.
Per molti versi, il celebre discorso del presidente dell'Olp Yasser
Arafat all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre del 1974
segna una svolta nell'affermazione della narrazione palestinese del conflitto
e nella sua legittimazione al più alto livello delle organizzazioni
internazionali. Ribaltando alla radice l'equazione sionista tra antisionismo e
antisemitismo, Arafat sostiene che il sionismo è esso stesso una forma di
antisemitismo: «Il sionismo è un’ideologia imperialista, colonialista,
razzista; è profondamente reazionario e discriminatorio; ha codici
retrogradi, affini all'antisemitismo ed è, a conti fatti, un’altra faccia della
stessa medaglia»100. Secondo Arafat è antisemita proporre, come soluzione
rtiene
k appa
95 Ivi, pp. 14-15.
96 Ivi, p. 18.
97 Ivi, p. 21.
98 Ivi, p. 26-27.
99 Ivi, p. 35. L’intervista, pubblicata il 23 maggio 1970 su «al-Ahrar», è riprodotta anche in
«International Documents on Palestine 1970», Institute for Palestine Studies, Beirut 1973, pp.
801-805.
100 “Palestine at the United Nations”, Journal of Palestine Studies, Vol. 4, No. 2, Winter
1975, p. 184.
l
a\nGiu
59
del problema ebraico, l’alienazione degli ebrei dalle comunità o nazioni di
cui avevano fatto parte, per insediarli con la forza nella terra di qualcun
altro. Così come è indice di antisemitismo la discriminazione perpetrata nei
confronti degli ebrei di origine orientale. Nel discorso torna il tema degli
ebrei vittime del sionismo: «gli ebrei europei sono stati trasformati negli
strumenti dell’aggressione»101. In questa prospettiva la proposta di «Stato
democratico in cui cristiani, ebrei e musulmani vivono nella giustizia,
nell’uguaglianza e nella fraternità»102, viene presentata come una possibilità
di riscatto per gli ebrei stessi, una «rivoluzione anche per gli ebrei»103.
Nel discorso di Arafat la lotta palestinese viene collocata all'interno
dei movimenti di liberazione contro l'imperialismo e il colonialismo: la
causa palestinese si carica di un valore morale universale e questo
contribuisce alla sua accettazione presso strati sempre più larghi
dell'opinione pubblica progressista e democratica internazionale. Non a
caso il 22 novembre successivo l'Assemblea Generale approva le
Risoluzioni 3236 e 3237, che riconosce i diritti del popolo palestinese
all'autodeterminazione, all'indipendenza e alla sovranità nazionale, e
accordava all'Olp lo status di osservatore alle Nazioni Unite. Un anno dopo,
l'Assemblea Generale approva la Risoluzione 3379, che equipara il
sionismo a una forma di razzismo e di discriminazione razziale104.
In conclusione, si può affermare che l'accettazione in Occidente della
narrazione israeliana come neutrale e obiettiva ha determinato la
marginalizzazione della narrazione palestinese e ha ristretto
significativamente le possibilità per i palestinesi di ottenere il diritto
all'autodeterminazione, al ritorno e all'indipendenza. Il primo tentativo di
decostruzione del discorso israeliano sul conflitto e di affermazione di una
narrazione palestinese alternativa, si ebbe in seguito alla disfatta del giugno
1967, quando il Mrp si affermò come forza autonoma nel mondo arabo.
L’ispirazione laica e anticolonialista della lotta di liberazione, incarnata
nella proposta di Stato democratico palestinese, era presentata dal Mrp in
netta antitesi al sionismo esclusivista. La proposta di Stato democratico
palestinese rappresentava un invito a smantellare il carattere coloniale e
discriminatorio su cui si fondava lo Stato israeliano, per consentire
finalmente agli israeliani, "liberati dal sionismo", di impostare la
to e
Que
s
101 Ibidem.
102 Ivi, p. 191.
103 Ivi, p. 187.
104 La Risoluzione n. 3379 fu revocata nel 1991 come condizione israeliana per la
partecipazione alla Conferenza di pace di Madrid.
60
convivenza con i palestinesi su basi di eguaglianza, senza distinzioni di
sorta.
L'importanza di questa visione del futuro sta nel fatto che i
palestinesi avevano immaginato una società post-coloniale che avrebbe
incluso anche i coloni ebraici, superando definitivamente il discorso basato
sull’inconciliabilità dei due nazionalismi o fondato sulla contrapposizione
religiosa, etnica o di altro tipo. Il nuovo discorso palestinese, che legge la
realtà israeliana attraverso le lenti del colonialismo di insediamento, sposta
il terreno del confronto sul campo coloniale, i cui attori sono un movimento
coloniale di insediamento e un movimento di liberazione nazionale. In
questa prospettiva, la proposta di Stato democratico può essere considerata
una narrazione-ponte che, attraverso la ridefinizione dell'identità palestinese
in senso inclusivo dell'alterità israeliana, apriva ad una potenziale
riconciliazione in una futura società post-coloniale. Questo avrebbe
permesso a palestinesi e israeliani di muoversi progressivamente verso una
prospettiva di convivenza e di riconciliazione legata ad un processo di
decolonizzazione della Palestina storica.
Bibliografia
(Inclusi gli articoli e i documenti politici citati nel testo, ad eccezione di
quelli raccolti in volumi, annuari, ecc.).
Documents of the Palestinian Resistance Movement, Merit Publications,
New York 1971
Fatah, "La liberazione dei territori occupati", «Studi ed esperienze
rivoluzionarie», n. 8, 1968, in «Rivoluzione palestinese», quindicinale del
Comitato di solidarietà con il popolo di Palestina, numeri 2-3, Roma, 1
maggio 1969
Alain Gresh, "Reflections on the Meaning of Palestine", «Journal of
Palestine Studies», Vol. 41, No. 1, Autumn 2011, pp. 67-81
Q
u
es
Baruch Kimmerling "Academic History Caught in the Cross-Fire: The Case
of Israeli-Jewish Historiography", «History and Memory», Vol. 7, No. 1,
1995, pp. 41–65
t
o
oe
b
61
Joseph Massad, "Palestinians and Jewish History: Recognition or
Submission?", «Journal of Palestine Studies», Vol. 30, No. 1, Autumn 2000,
pp. 52-67
“Palestine at the United Nations”, «Journal of Palestine Studies», Vol. 4,
No. 2, Winter 1975
Ilan Pappé, "Post-Zionist Critique on Israel and the Palestinians: Part I:
The Academic Debate", «Journal of Palestine Studies», Vol. 26, No. 2,
Winter 1997, pp. 29-41
Julie Peteet, “Words as Interventions: Naming in the Palestine: Israel
Conflict”, «Third World Quarterly», Vol. 26, No. 1, 2005, pp. 153-72
The Popular Front for the Liberation of Palestine, Palestine: Towards a
Democratic Solution, P.F.L.P. Information Departement, [s.l.], 1970
The Popular Front for the Liberation of Palestine, A Strategy for the
Liberation of Palestine, Pflp Information Department, Amman 1969
Mohammed Rasheed, Towards a Democratic State in Palestine. The
Palestinian Revolution and the Jews Vis-à-Vis the Democratic,
Nonsectarian State in the Palestine of the Future, PLO Research Center,
Beirut 1970
Elias Sanbar, “Out of Place, Out of Time”, «Mediterranean Historical
Review», Vol. 16, No. 1, pp. 87-94
Qu
Rosemary Shinko, "Discourses of Denial: Silencing the Palestinians,
Delegitimizing their Claims", «Journal of International Affairs», Vol. 58,
No. 1, Fall 2004, pp. 47-73
es
to
eb
oo
ka
Laurence J. Silberstein, "Postzionism: A critique of Zionist Discourse",
«Palestine-Israel Journal», Vol. 9, No.2 & No. 3, 2002
pp
art
ien
Michael Suleiman, “National Stereotypes as Weapons in the Arab-Israeli
Conflict”, «Journal of Palestine Studies», Vol. 3, No. 3, Spring 1974, pp.
109-121
ea
\nG
iul
62
ian
aC
ac
cia
pu
oti
C
partie
Questo ebook ap
DONNE ISRAELIANE E PALESTINESI, NARRATIVE A CONFRONTO
Giulia Daniele
Giulia Daniele
Assegnista di ricerca in Scienza Politica presso la Scuola
Superiore Sant’Anna (Pisa), nel dicembre 2011 ha ottenuto il titolo di Ph.D.
in Politics, Human Rights and Sustainability e Politics of the Middle East
sotto accordo di cotutela tra la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e
l’Institute of Arab and Islamic Studies dell’Università di Exeter (UK),
scrivendo una tesi intitolata Along an Alternative Road: Women,
Reconciliation, and the Israeli-Palestinian Conflict.
I suoi principali interessi di ricerca sono: politica del Medio
Oriente (con focus su conflitto israelo-palestinese), attivismo politico dei
movimenti di donne in Medio Oriente e Nord Africa, risoluzione dei conflitti
e narrative etno-nazionali.
Abstract
A partire dall’inizio degli anni Novanta, sia nel mondo accademico
sia all’interno dei movimenti delle donne è diventato centrale il tema
riguardante il rapporto tra ‘genere’ e ‘nazionalismo’ in realtà di conflitto e
post-conflitto. Tenendo in considerazione la profonda inestricabilità tra
narrative storiche e vite quotidiane dei due popoli, palestinese ed
israeliano, il paper si propone di ridefinire tale discorso, e, in particolare,
il ruolo giocato da donne attiviste nel decostruire le proprie identità etnonazionali (in primis il fondamento sionista alla base dello Stato di Israele).
Dopo aver delineato tale problematica nel contesto dei principali
movimenti di donne nei Territori Occupati Palestinesi e in Israele, l’analisi
volge verso una delle esperienze congiunte tra donne palestinesi ed
israeliane più conosciute a livello internazionale, quella del Jerusalem
Link, fondata sulla cosiddetta ‘transversal politics’ attraverso un percorso
comune di riconoscimento e cooperazione.
L’attuale status quo ha tuttavia generato numerosi ostacoli
nell’attuazione di simili iniziative a causa del perdurare di una condizione
di potere asimmetrico tra le due parti. Utilizzando principalmente le
interviste condotte durante la recente ricerca sul campo, il mio contributo è
diretto ad interpretare parallelamente le proposte innovative e le strategie
fallite che sono emerse da analoghe esperienze. Infatti, nonostante la
presente realtà israelo-palestinese appaia ancora lontana da prospettive di
riconoscimento e riconciliazione, diventa sempre più inevitabile indicare
63
politiche che possano essere in grado di riportare le due narrative verso un
cammino condiviso.
Since the early 1990s the interaction between ‘gender’ and
‘nationalism’ has significantly grown both in academia and in women’s
feminist movements in conflict and post-conflict contexts. By taking account
of a deep inextricability between historical narratives and everyday lives of
Palestinians and Israelis, the research paper aims at redefining such a
discourse, and in particular, the role played by women activists in
deconstructing ethno-national identities (especially focussing on the Zionist
foundation of the state of Israel). Following the analysis of the foremost
examples of women’s activism both in the occupied Palestinian territories
and in Israel, the study deepens into one of the most recognized cases of
joint politics between Palestinian and Israeli Jewish women, the Jerusalem
Link, based on the so-called ‘transversal politics’ throughout a process of
mutual recognition and cooperation.
Nevertheless, the current reality has revealed problematic
obstacles to such women’s feminist political proposals, mainly due to the
ongoing asymmetry between the two sides. By using the most recent
fieldwork outcomes, my contribution elaborates what has emerged from this
kind of political experiences, interpreting its constructive attitudes and its
unsuccessful strategies at the same time. Despite the current stalemate of
any processes of recognition and reconciliation between Palestinians and
Israeli Jews, it is time to deal with feasible political alternatives embracing
both narratives in a common pathway.
A partire dall’inizio degli anni Novanta nelle realtà di conflitto e
post-conflitto l’interazione tra ‘genere’ e ‘nazionalismo’ ha avuto un
riflesso fondamentale sul ruolo giocato dalle donne all’interno dei
movimenti nazionalisti, così come nelle politiche indirizzate ai processi di
risoluzione dei conflitti fondati sui principi di riconoscimento e
riconciliazione. Parallelamente, mettendo in discussione la complessità del
controverso legame tra nazionalismo e femminismo, e intrecciando la sfera
pubblica con quella privata, la cosiddetta transversal politics ha creato le
basi per stabilire forme appropriate di interazione e dialogo tra donne
appartenenti a società in conflitto105. Tale definizione è stata coniata da un
gruppo di intellettuali femministe, tra cui Nira Yuval-Davis, con lo scopo di
105 Floya Anthias, Nira Yuval-Davis (edited by), Woman-Nation-State, London, Macmillan,
1989.
64
Qu
_2
ti
o
pu
I
CL
cia
c
problematizzare l’omogeneità dei movimenti di donne
e di rinforzarne
Ca
l’approccio femminista. In particolare, è stata principalmente
utilizzata per
a
descrivere le esperienze congiunte tra donne
palestinesi
ed
israeliane
n
finalizzate ad andare oltre alle divergenzeliaetno-nazionali attraverso un
iu
processo democratico e partecipativo.
G
Nella specificità israelo-palestinese,
lo scoppio dell’Intifadah aln
a\ con notevoli differenze, inasprito
Aqsa nell’ottobre 2000 ha, seppure
e dei settori più vulnerabili nelle due
enormemente le condizioni dinvita
e
società, ponendo interrogativi
alla sfida proposta dalle
rti traproblematici
a
principali esperienze congiunte
donne palestinesi ed israeliane. In tale
pp della popolazione oppressa, le palestinesi hanno
contesto in cui, sul versante
a
continuato ad essere
k vittime dell’occupazione esterna militare israeliana e
o
del costume patriarcale
tradizionale, mentre su quello dello Stato occupante,
o
le israeliane,eb
assoggettate al mito della sicurezza nazionale, hanno dovuto
fronteggiare
o un clima ideologicamente sempre più aggressivo e
st due sono gli interrogativi di fondo, che saranno oggetto di
militarizzato,
e
u
questa
Q riflessione. Il primo è: in dicotomie ormai consolidate quali ‘noi e
loro’, ‘occupato e occupante’, ‘oppresso e oppressore’, l’identità di genere
costituisce un fondamento cruciale nella costruzione di un legame
egualitario tra palestinesi ed israeliani, senza più disparità di potere e
privilegi tra le due parti? Il secondo: la transversal politics rappresenta una
strategia politica finalizzata a superare le brutalità del conflitto e a creare
ponti alternativi in vista di una futura ‘coesistenza’ in Palestina/Israele?
Dopo il fallimento degli accordi di Oslo e la sconfitta attuale della
proposta ‘due stati per due popoli’, un numero crescente di intellettuali,
accademici e attivisti ha riportato alla luce la discussione riguardante la
creazione di uno stato unico – la cosiddetta soluzione One State – dal mar
Mediterraneo al fiume Giordano, in cui ogni cittadino potrà vivere con
eguali diritti sulla terra di Palestina ed Israele106. Seguendo una narrazione
storica intrecciata, la proposta di uno stato unico, egualitario e democratico
da un lato e l’analisi dell’identità etno-nazionale in una prospettiva di
genere dall’altro offrono un approccio critico volto alla de-costruzione di
una delle principali barriere all’idea di una terra in cui auto-determinazione,
libertà e uguaglianza possano essere garantite a tutti i cittadini: palestinesi,
israeliani o appartenenti a ogni altro gruppo minoritario.
106 Sul tema della soluzione One State si veda in particolare: Ali Abunimah, One Country: A
Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse, New York, Metropolitan Books, 2006;
Jamil Hilal (ed.), Where Now for Palestine: the Demise of the Two-State Solution, London, Zed
Books, 2007; Virginia Tilley, The One-State Solution: a Breakthrough for Peace in the IsraeliPalestinian Deadlock, Manchester, Manchester University Press, 2005.
65
Facendo interagire narrative spesso in contrapposizione tra loro, il
principale obiettivo del saggio è quello di formulare una chiave di lettura
critica a partire dalla mobilitazione politica delle donne palestinesi e
israeliane, in modo tale da apportare una visione alternativa rispetto al più
recente dibattito intorno al conflitto israelo-palestinese. Sia attraverso il
riconoscimento dell’importanza delle iniziative sostenute dalle attiviste
palestinesi e israeliane, sia ponendo nuovi spunti di riflessione, la seguente
analisi vuole proporre alcune riflessioni sulla necessità di colmare la
distanza tra il discorso accademico e la pratica politica sul campo. In questo
senso, il progetto One State avanza una visione pluralistica alternativa alla
risoluzione del conflitto israelo-palestinese, mentre la prospettiva di genere
evidenzia come le donne identifichino se stesse con il nazionalismo da
angolature differenti rispetto a quelle proposte dalle attuali leadership.
1.
Donne palestinesi ed israeliane: sfide tra occupazione
militare e nazionalismi
to
es
Qu
In quanto settori più deboli della società, le donne palestinesi ed
israeliane sono state costrette a prendersi carico dei peggiori effetti sociali,
politici, economici e psicologici che incombono sulle vite delle loro
famiglie. Le donne palestinesi hanno avuto, specialmente nei decenni
passati, ruoli centrali nella lotta sociale e nazionale per l’autodeterminazione del proprio popolo; le donne israeliane hanno preso parte,
più o meno criticamente, al discorso opprimente della sicurezza
nazionale107. Infatti, da un lato le palestinesi hanno ricoperto il ruolo di
attiviste all’interno di una nazione senza stato, dall’altro le israeliane vivono
in una realtà di nazionalismo istituzionalizzato e fortemente fondato sul
concetto di stato-nazione.
In questo senso, le condizioni strutturali del conflitto che hanno
prodotto l’aggravarsi delle narrative etno-nazionali hanno costituito il
principale ostacolo al raggiungimento di un futuro comune sulla terra di
Palestina. In una simile realtà di prolungata occupazione militare, pur con le
differenze legate alla notevole disparità di potere e privilegi tra palestinesi e
israeliani, si è generato un cosiddetto ‘impatto di genere’, il quale ha
rinforzato i conflitti interni ad ognuna delle comunità: dei palestinesi della
West Bank e della Striscia di Gaza, dei palestinesi cittadini di Israele, degli
ebrei israeliani.
art
pp
ka
oo
eb
an
iuli
\nG
ea
ien
ac
66
aC
107 Tamar Mayer (ed.), Women and the Israeli Occupation, London, Routledge, 1994.
p
cia
A partire da questo quadro, l’approccio critico delle donne attiviste
intervistate durante la ricerca sul campo, avvenuta tra il 2009 e il 2011, ha
posto al centro del dibattito il contrasto tra i risultati ottenuti dalle loro
iniziative di lotta e resistenza quotidiana, e ciò che è invece rimasto soltanto
a livello teorico. Infatti, se i pilastri fondanti adottati dalle donne attiviste
contro l’occupazione militare e contro la crescente radicalizzazione delle
rispettive identità nazionali hanno contribuito a costruire una prospettiva
critica nei confronti dell’attuale impasse, dall’altro le divisioni sia tra le due
parti del conflitto sia interne agli stessi movimenti delle donne hanno
ostacolato il raggiungimento di una politica unitaria tra le donne palestinesi
e israeliane.
Entrando nel vivo della questione, è fondamentale sottolineare
come a partire dagli anni della prima Intifadah, iniziata nel dicembre 1987,
si sono avviati consistenti cambiamenti nella politica del movimento delle
donne palestinesi, che pure sin dagli anni Venti aveva partecipato
attivamente alla lotta nazionale: uno dei suoi principali obiettivi si è
espresso fino ad oggi nella volontà di trasformare le strutture di genere
presenti nel sistema patriarcale. Questa presa di posizione ha influenzato
l’intera società108, se teniamo conto che, come ha scritto l’attivista e
accademica Rita Giacaman:
Questo ebook appartiene a\nGiuliana Cacciapuoti
«la coscienza femminista è parte integrante della coscienza
nazionale generale, poiché esiste simultaneamente ad essa in uno
scambio dialettico costante»109.
Unendo gli obiettivi della lotta di liberazione nazionale e quelli
della lotta di liberazione delle donne all’interno di una società ancora
fortemente patriarcale, la testimonianza di un’altra leader storica, Amal
Khreishe, mette in risalto il ruolo giocato dalle attiviste palestinesi nel
ricostruire la propria identità nazionale in connessione con una prospettiva
femminista:
«significato di ‘femminismo’ riflette il processo di empowerment
delle donne che consiste nel renderle libere da ogni ostacolo che il
sistema patriarcale ha costruito nei secoli. Ciò evidenzia come sia
necessario cambiare le relazioni di potere nella nostra società al
108 Lisa Taraki (ed.), Living Palestine: Family Survival, Resistance and Mobility under
Occupation, New York, Syracuse University Press, 2006.
109 Rita Giacaman in Suha Sabbagh (ed.), Arab Women: Between Defiance and Restraint,
New York, Olive Branch Press, 1996.
67
fine di ottenere giustizia e non soltanto uguaglianza. Per noi donne
palestinesi, ‘femminismo’ significa liberarsi dalle terribili
conseguenze che l’occupazione militare israeliana continua a
generare»110.
In modo parallelo, nei primi anni Novanta le donne ebree israeliane
(fino allora dipinte dal discorso sionista come fulcro necessario per la
sopravvivenza della collettività e dello stato ebraico) hanno compiuto,
insieme alle palestinesi israeliane,111 i primi passi verso un riconoscimento
graduale: ciò ha implicato che le questioni di genere non sono potute
rimanere estranee rispetto alle strutture militarizzate della politica dei propri
governi e alle oppressioni continue nei confronti del popolo palestinese.
Così descrive una delle fondatrici del movimento femminista israeliano
nella città di Haifa, Edna Zaretsky-Toledano:
sto
Que
«Sono diventata una femminista ‘radicale’ iniziando ad ascoltare le
storie e le esperienze dirette di donne, attiviste e non, a partire dalla
fine degli anni Ottanta. È importante sapere ascoltare, incoraggiare
se stesse e altre donne a condividere le nostre storie individuali,
combattendo contro la dura realtà in cui viviamo e le sue
imposizioni sociali. Io mi sento responsabile per ciò che continua
ad accadere in questa terra: so cosa significa essere un’ebrea che
vive in Israele e sono consapevole che sto vivendo come
‘occupante’»112.
ebo
2.
L’esperienza del Jerusalem Link: una speranza illusoria?
ok a
nGi
e a\
rtien
ppa
Come nella soluzione One State che prevede un’unità statale
israelo-palestinese, così nelle narrative delle donne ebree e arabe prima,
israeliane e palestinesi poi, il concetto di ‘coesistenza’ evidenzia la sfida
principale nei confronti di entrambe le identità nazionali. Nei decenni
precedenti la formazione dello Stato di Israele e l’espulsione dei palestinesi
dalle proprie terre, il contatto quotidiano tra le native arabe e le pioniere
ebree raffigura uno degli esempi più forti della capacità delle donne di
oltrepassare separazioni etniche e territoriali. Le prime testimonianze
68
ia
acc
na C
ulia
110 Intervista in data 9 dicembre 2009, Ramallah.
111 Come minoranza all’interno dello stato ebraico, le donne palestinesi cittadine di Israele
hanno dato vita ad azioni congiunte (anche con le palestinesi della West Bank e di Gaza)
finalizzate a prevenire ogni ulteriore discriminazione etno-nazionale e di classe.
112 Intervista in data 10 novembre 2010, Haifa.
ap
ok
bo
to
e
Qu
es
risalgono agli anni Venti e Trenta quando forti alleanze tra lavoratrici arabe
ed ebree, in particolare nelle fabbriche, si sviluppano fino ad unirsi in lotte
comuni per ottenere uguali diritti salariali rispetto agli uomini113.
Dopo il 1948, ricordato come l’anno della ‘catastrofe’ dai
palestinesi (Nakba) e della ‘guerra d’indipendenza’ dagli ebrei israeliani,
isolati esempi di attivismo congiunto tra le differenti comunità presenti sul
territorio hanno tentato di sfidare la politica mainstream, e in particolare i
principi fondanti del nuovo stato ebraico. Tra le realtà di attivismo politico
che hanno coinvolto sia palestinesi sia ebree cittadine di Israele è da
ricordare una delle principali organizzazioni nate in quegli anni, il
Movement of Democratic Women for Israel (TANDI), considerato un
esempio precursore delle iniziative congiunte.
Soltanto all’inizio degli anni Novanta, i movimenti di donne di
entrambe le parti hanno cominciato ad analizzare, dall’interno della propria
specifica realtà, la complessità di esperienze di ‘coesistenza’ che richiedono
“una cura e un aggiustamento costante”114. La cosiddetta transversal
politics, attraverso la formula di “cambiamento e radicamento”115, diventa,
in tale contesto, un passaggio nodale per andare oltre l’idea di ‘Altro’ come
nemico e per costruire un riconoscimento reciproco delle parti in conflitto,
in cui diventa fondante “l’inclusione della differenza all’interno
dell’uguaglianza”116.
Numerose tematiche affrontate in un’ottica di genere (alcune delle
quali hanno fatto emergere forme simili di oppressione, discriminazione e
ingiustizia) sono state al centro del confronto politico tra attiviste pacifiste
israeliane e palestinesi in vista di una condivisione delle proprie battaglie
quotidiane. Valendosi di una prospettiva di cooperazione egualitaria, le
donne palestinesi hanno nutrito la speranza di una trasformazione radicale
delle posizioni politiche della controparte, mentre dall’altro le israeliane
hanno aumentato la loro fiducia
nella costruzione di relazioni
interpersonali. Ma la transversal politics è riuscita davvero a creare,
attraverso le esperienze condivise di donne legate a forti identità nazionali,
uno spazio capace di proporre linee di lettura ed azioni innovative
nell’ambito di un progetto di ‘coesistenza’ tra le due popolazioni?
113 Deborah S. Bernstein (ed.), Pioneers and Homemakers: Jewish Women in Pre-State Israel,
Albany NY, State University of New York Press, 1992.
114 Ayala H. Emmet, Our Sisters’ Promised Land: Women, Politics and Israeli-Palestinian
Coexistence, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2003, p. 16.
115 L’espressione è stata definita da alcune femministe italiane (in particolare appartenenti al
network delle Donne in Nero e alla Casa delle Donne di Bologna e Torino) lavorando con altre
donne di zone in conflitto, soprattutto dai Balcani e Palestina/Israele.
116 Nira Yuval-Davis, “What is “Transversal Politics”?, Soundings, XII, Summer 1999, p.95.
69
A partire dalla prima conferenza ufficiale incentrata sul dialogo tra
donne israeliane e palestinesi, intitolata Give Peace a Chance – Women
Speak Out e tenutasi a Bruxelles nel 1989, numerosi incontri internazionali
sono stati organizzati al fine di proporre una visione di genere nelle
relazioni di potere e una differente percezione socio-politica degli
argomenti in questione. Nel 1993, un gruppo di donne israeliane e
palestinesi ha dato vita al Jerusalem Link, uno dei progetti congiunti più
famosi e internazionalmente riconosciuti, grazie ai finanziamenti
dell’Unione Europea. Attraverso un’azione che prevedeva sia una politica
‘dal basso’ che il coinvolgimento delle leadership, le donne partecipanti
hanno richiamato l’urgenza di conquistare un livello di empowerment tale
da poter prospettare un modello di cooperazione tra israeliane e palestinesi,
che facesse maturare, in accordo con il diritto internazionale, una visione
condivisa su questioni quali il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, la creazione di uno Stato palestinese
indipendente a fianco di Israele, e la divisione della capitale Gerusalemme,
oggetto come è noto della disputa più delicata 117.
Se a livello teorico i punti di interesse comune sembrano essere
stati ben delineati e sostenuti sia dalle palestinesi sia dalle israeliane, il tema
dell’appartenenza nazionale e quello connesso alla sicurezza sono divenuti
le priorità sostenute durante le riunioni congiunte tra le due parti. Ne è
dimostrazione l’affermazione della coordinatrice israeliana Molly Malekar,
la quale spiega:
«ogni volta che ci incontriamo il primo punto messo sul tavolo è
quello legato al tema nazionale, e succederà lo stesso fino a quando
non si porrà fine all’occupazione militare e potremo diventare due
partner che discutono partendo da uno stesso livello»118.
Sebbene i propositi iniziali avessero ottenuto un appoggio univoco,
la costruzione di un dialogo egualitario tra i diversi punti di vista ha subito
complicazioni tali da far fallire in parte, se non totalmente, il progetto della
coalizione. Negli ultimi anni, infatti, le strategie di lavoro comune si sono
imbattute in un’impasse dovuta all’impossibilità di raggiungere una
posizione unica sulle questioni centrali, come il diritto al ritorno o l’impatto
della violenza strutturale del conflitto nei confronti della vita quotidiana
Qu
70
est
117 Cynthia Cockburn, From Where We Stand: War, Women’s Activism and Feminist
Analysis, London, Zed Books, 2007, pp. 112-115.
118 Intervista in data 19 ottobre 2009, Gerusalemme.
300
201
_
I
L
C
i
puot
e a\n
a Ca
Giulian
ccia
delle donne119. Allo stato attuale, sembra impraticabile instaurare un dialogo
giusto e paritario a causa dell’asimmetria nell’influenza politica che la parte
israeliana usa in modo forzato nei confronti delle palestinesi, attuando
disparità di potere e privilegi tra le partecipanti.
Analizzando la prospettiva macro del conflitto, la condizione
illegale e tragica di occupazione dei territori palestinesi produce uno
squilibrio profondo tra le due parti e il dialogo diventa soltanto apparente: le
donne israeliane, in quanto cittadine del paese occupante, hanno uno Stato
mentre le donne palestinesi, appartenenti al popolo sotto occupazione
militare, non hanno ancora raggiunto questo diritto. La cosiddetta
‘normalizzazione’ dello status quo sta portando ad una legittimazione
assoluta delle responsabilità coloniali dello Stato di Israele, come se la
questione palestinese fosse ormai stata risolta120. Ciò rappresenta una delle
cause principali del fallimento della maggior parte dei progetti tra
palestinesi e israeliani, a partire dalle iniziative congiunte tra donne. A tale
proposito, l’attivista femminista Haggith Gor ha così spiegato:
rtien
a
p
p
a
ok
«riguardo ai progetti congiunti falliti, credo che i palestinesi non
accettino più questo tipo di cooperazione a causa della
continuazione dell’occupazione militare, delle sue terribili
conseguenze e della ‘normalizzazione’ delle relazioni tra
‘occupante’ e ‘occupato’»121.
o ebo
t
s
e
u
Q
Una tale politica di cooperazione ha dovuto affrontare non solo la
chiara e ferma denuncia nei confronti dell’oppressore, ma anche la necessità
di rafforzare i rapporti interni così come affermare le più rilevanti sfide e
differenze. L’attuale situazione si è aggravata in seguito all’esplosione della
seconda Intifadah nell’ottobre 2000, e alla più recente Operazione Piombo
Fuso nella Striscia di Gaza nel dicembre 2008 e gennaio 2009. La brutalità
della violenza utilizzata dall’esercito israeliano nei confronti di civili
palestinesi ha prodotto profonde divisioni anche all’interno di simili progetti
congiunti, a partire dall’esperienza del Jerusalem Link. Nonostante venga
riconosciuto che le esperienze condivise stanno attraversando una
difficilissima transizione, entrambe le parti sostengono l’importanza di non
119 Janet M. Powers, Blossoms on the Olive Tree: Israeli and Palestinian Women Working for
Peace, Westport, Praeger, 2006, pp. 6-13.
120 Daphna Golan, “‘Separation’, ‘Normalization’ and Occupation”, Palestine-Israel Journal
of Politics, Economics and Culture, II, n. 2, 1995.
121 Intervista in data 2 dicembre 2009, Tel Aviv.
71
11
9
6
39
1
20
3
3
00
0
mettere la parola fine al progetto, ed esplicitano la volontà di continuare a
coltivarlo, quando saranno superati gli ostacoli attuali.
Lo sostiene Rula Salemeh, a capo del consiglio direttivo del
Jerusalem Center for Women, secondo la quale:
pu
a
i
cc
a
aC
o
LI_
C
ti
«dopo Gaza, tutte noi abbiamo deciso di ragionare nuovamente sul
significato dei nostri progetti congiunti con le israeliane, e abbiamo
deciso di lavorare per il novantacinque per cento su progetti con
partner locali palestinesi, e soltanto un cinque per cento con Bat
Shalom. Dopo Gaza nulla è più come prima. […] Abbiamo bisogno
di designare nuove strategie con le nostre sorelle di Bat Shalom,
ma in questo momento dobbiamo concentrare le nostre forze sul
lavoro interno alla società palestinese nella West Bank e nella
Striscia di Gaza»122.
ia
iul
n
E lo afferma anche la coordinatrice israeliana Molly Malekar che
sottolinea:
tie
r
a
pp
a
k
ne
G
n
\
a
«ora è necessario ricostruire una base di fiducia su cui riprendere in
mano la relazione: dobbiamo riportare l’attenzione sull’obiettivo
della fine dell’occupazione e della risoluzione dei principali punti
critici come la questione di Gerusalemme, il diritto al ritorno e gli
insediamenti»123.
Q
s
ue
t
oo
b
oe
‘Riconoscimento’ e ‘coesistenza’ tratteggiano il percorso parallelo
di due narrative: la proposta politica della soluzione One State e le
esperienze storiche congiunte di donne palestinesi ed israeliane, volte a
prospettare una realtà ancora inedita rispetto a quella vissuta finora in cui i
due popoli potranno seguire principi di cooperazione e condivisione.
Elemento comune ai due sentieri diventa la necessità di decostruire
entrambe le identità etno-nazionali, in particolare la politica esclusivista
israeliana improntata sull’ideale sionista. Sia la critica di genere sia il
modello alternativo di Stato unico, seppure con i fallimenti e le
insufficienze incontrati nel tentativo di raggiungere un reale livello
egualitario tra le parti, testimoniano come l’unico punto di partenza nella
riconciliazione tra palestinesi ed israeliani possa essere l’ammissione
dell’esistenza dell’‘Altro’, senza negare alcuna narrazione storica, a partire
122 Intervista in data 21 ottobre 2009, Ramallah.
123 Intervista in data 19 ottobre 2009, Gerusalemme.
72
t
Q
s
ue
dalla conditio sine qua non di riconoscere ogni dramma storico e ogni
rappresentazione identitaria124.
In questa prospettiva, il mio contributo ha voluto indirizzare due
dibattiti attuali come quello legato all’attivismo politico delle donne
palestinesi e israeliane, e le alternative per la risoluzione del conflitto, verso
un’analisi critica della situazione di ineguaglianza e discriminazione che
continua tra ‘occupante’ e ‘occupato’ in una realtà ormai completamente
‘normalizzata’. Sottolineando come l’occupazione militare costituisca
l’ostacolo principale ancora irrisolto del conflitto israelo-palestinese, da una
parte le proposte lanciate dalle politiche dei movimenti delle donne,
dall’altro quelle esposte dalle strategie alternative per una soluzione equa
del conflitto, dovrebbero essere tenute in considerazione a livello
accademico e politico come possibili direzioni da seguire. Nonostante un
profondo senso di disillusione e sconforto stia prevalendo sul campo degli
attivisti sia palestinesi sia israeliani, è ancora presente la determinazione per
superare questa fase di difficoltà e incomunicabilità tra le due parti, come
dimostrano le seguenti parole dell’attivista femminista Nabila Espanioly:
«abbiamo bisogno di una maggiore consapevolezza politica, non è
sufficiente dire ‘basta all’occupazione’. È fondamentale iniziare
davvero a parlare di riconoscimento, riconosciamo chi è
l’occupante e chi è l’occupato, riconosciamo che la Palestina è
sotto occupazione dal 1948 e che oggi non ci resta che meno del
ventidue per cento della nostra terra»125.
Anche se un processo come quello delineato costituisce uno
scoglio difficile da superare, la ri-problematizzazione di politiche
alternative, come la soluzione One State nel livello generale del conflitto e
la critica di genere nel contesto specifico delle esperienze condivise tra
donne palestinesi ed israeliane, può aprire la strada nella direzione di una
coesistenza duratura e giusta, senza più disparità di potere e privilegi. In
questo senso, l’ideale della transversal politics, emergente in una delle zone
di conflitto più problematiche al mondo, ha permesso di ridefinire, per
mezzo di network formali e non, le relazioni interne insidiate dalle sfide
pericolose del nazionalismo e dell’autorevolezza secolare del patriarcato,
attraverso una nuova agenda femminista in grado di far coesistere realtà
inevitabilmente legate tra loro, seppur differenti e ancora ostili. Seguendo il
124 Ilan Pappé in Jamil Hilal, Ilan Pappé (a cura di), Parlare con il nemico, Torino, Bollati
Boringhieri, 2004.
125 Intervista in data 15 settembre 2010, Nazareth.
73
tracciato della narrativa collettiva formatasi in questi decenni,
l’inestricabilità delle storie e memorie condivise, in primis quelle tra donne,
rimane una delle poche immagini di speranza nel futuro della terra di
Palestina/Israele.
Floya Anthias, Nira Yuval-Davis (eds.), Woman-Nation-State, London,
Macmillan, 1989.
Deborah S. Bernstein (ed.), Pioneers and Homemakers: Jewish Women in
Pre-State Israel, Albany NY, State University of New York Press, 1992.
Cynthia Cockburn, From Where We Stand: War, Women’s Activism and
Feminist Analysis, London Zed Books, 2007.
Ayala Emmet, Our Sisters’ Promised Land: Women, Politics and IsraeliPalestinian Coexistence, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2003.
Daphna Golan, ‘Separation’, ‘Normalization’ and Occupation, «PalestineIsrael Journal of Politics, Economics and Culture», II, n. 2, 1995.
Hannah Herzog, Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and
Palestinian Women in Israel, «Israel Studies», III, n. 1, 1998, pp. 61-84.
Jamil Hilal (ed.), Where Now for Palestine: the Demise of the Two-State
Solution, London, Zed Books, 2007.
Jamil Hilal, Ilan Pappe (a cura di), Parlare con il nemico, Torino, Bollati
Boringhieri, 2004.
Tamar Mayer (ed.), Women and the Israeli Occupation, London, Routledge,
1994.
Julie M. Peteet, Gender in Crisis: Women and the Palestinian Resistance
Movement, New York, Columbia University Press,1991.
Janet M. Powers, Blossoms on the Olive Tree: Israeli and Palestinian
Women Working for Peace, Westport, Praeger, 2006.
74
Questo ebook appartiene a\nGiuliana Cacciapuoti CLI_2013003
Bibliografia
Simona Sharoni, Gender and the Israeli-Palestinian Conflict: the Politics of
Women's Resistance, New York, Syracuse University Press, 1995.
Lisa Taraki (ed.), Living Palestine: Family Survival, Resistance and
Mobility under Occupation, New York, Syracuse University Press, 2006.
Nira Yuval-Davis, Gender & Nations, London, Sage, 1997. Id., What is
Transversal Politics’?, «Soundings», XII, Summer 1999.
Questo eboo
75
PATRIMONIO POPOLARE PALESTINESE TRA FOLKLORE E
FOLKLORISMO.
Cristiana Baldazzi
Cristiana Baldazzi
Dal 2006 ricercatore di Lingua e letteratura araba all’Università
di Trieste (Dipartimento di Studi Umanistici), ha trascorso periodi di
ricerca e di studio a Tunisi, Il Cairo, Damasco, Beirut e Londra. I suoi
ambiti di ricerca riguardano l’area siro-palestinese ed egiziana tra XIX e
XX secolo (Il ruolo degli intellettuali arabi tra Impero Ottomano e
Mandato: il caso della famiglia Zu‘aytir 1872-1939, Istituto Universitario
Orientale di Napoli, 2005); in particolare si occupa di letteratura
memorialistica – diari, memorie, autobiografie, resoconti di viaggio – sia
dal punto di vista letterario sia da quello storico e più propriamente della
storia sociale.
Abstract
Questa nota prende in esame i lavori di alcuni etnografi
palestinesi e il loro approccio al folklore (Tawfiq Canaan, Khalil Totah,
Omar Saleh Barghouti, Elias Haddad, Stephan Hanna Stephan e Nimr
Sirhan, autore della Mawsū‘at al-fulklūr al-filastīnī, 1989), usando come
griglia di interpretazione l’accezione gramsciana al folklore, ancora oggi
attuale e da cui hanno tratto ispirazione i Subaltern Studies. Questa
prospettiva consente di mettere in luce da un lato come il folklore sia una
potente arma per costruire e salvaguardare l’identità palestinese e
dall’altra come esso venga utilizzato dall’élite palestinese principalmente
per scopi ideologici e nazionalistici. Il folklore, perse le sue potenzialità,
diventa parte di un processo di acculturazione che riflette, come in uno
specchio, l’ideologia israeliana degenerando in entrambi i casi nel
folklorismo.
Que
sto
ebo
ok a
ppa
rtien
This paper deals with a number of Palestinian ethnographers’
studies and their different approaches to folklore (Tawfiq Canaan, Khalil
Totah, Omar Saleh Barghouti, Elias Haddad, Stephan Hanna Stephan and
Nimr Sirhan, author of the Mawsū‘at al-fulklūr al-filastīnī, 1989). I have
used Gramsci’s schema of analysis, which is still relevant today (and which
has influenced Subaltern Studies). From this perspective folklore is both a
powerful weapon to build and protect the Palestinian identity and a tool of
the Palestinian elite used primarily for ideological and nationalistic aims.
Folklore has lost much of its potential and become part of an acculturation
76
e a\
nGi
Que
sto
e a\
rtien
ppa
ok a
ebo
process which reflects, paradoxically, as if a mirror, the Israeli ideology
degenerating into exploitation through folklorism.
Patrimonio popolare palestinese tra folklore e folklorismo∗
013
LI_2
oti C
iapu
acc
na C
ulia
nGi
Perdere la memoria significa perdere se stessi, la propria identità;
analogamente una comunità che perde la memoria rischia di smarrire la
propria identità. Se per ogni società la trasmissione delle proprie tradizioni è
essenziale e necessaria, per una società minacciata nella sua identità, come
quella palestinese, questa trasmissione assume significati del tutto peculiari
di enorme rilevanza. Da qui vorrei partire per un’analisi del folklore e
dell’uso che ne viene oggi fatto in Palestina.
La nota prende in esame alcuni studi demologici di autori palestinesi
partendo da quelli degli anni venti (Tawfiq Canaan e altri studiosi a lui
contemporanei) fino ad arrivare ai più recenti, per mettere in luce il loro
differente approccio al folklore, utilizzando come griglia di riferimento
l’accezione gramsciana sul tema. Tornato in auge soprattutto con i subaltern
studies, che ne fanno il loro ispiratore, Gramsci ha guardato al folklore
come “concezione del mondo e della vita” del popolo, inteso come
“l’insieme delle classi subalterne e strumentali” che si contrappongono alle
“classi ufficiali ed egemoniche” (Gramsci, 1979:268). Ma pur riconoscendo
l’importanza dello studio scientifico del folklore, in una prospettiva politica
ben precisa, quella del partito rivoluzionario che mira all’emancipazione dei
subalterni, Gramsci dà una valutazione critica del folklore. Prospettiva, a
mio avviso ancora attuale, che mi sembra fornire utili chiavi di lettura
rispetto alle tendenze emerse nella demologia palestinese attuale.
In arabo il termine più utilizzato per folklore, oltre al calco
dall’inglese fulklūr, è al-turāṯ al-ša‘bī, eredità, patrimonio popolare, che
comprende appunto sia racconti, miti, leggende, superstizioni, canzoni,
balli, giochi, ecc., sia materiali scritti, talismani, amuleti, sia più in generale
modi di fare, usi e costumi popolari cioè taqālīd, così come registra
l’Encyclopedie de l’Islam (EI2, s.v. taḳālῑd supplemento).
1
691
77
039
Ringrazio la Prof.ssa Franca Balsamo (discussant del panel nel convegno di SeSamo a
Milano) per le sue preziose osservazioni.
∗
003
1. Canaan e il suo circolo
I primi studi palestinesi sul folklore risalgono agli anni Venti, e
furono pubblicati principalmente nella rivista britannica The Journal of the
Palestine Oriental Society (1920-1948)126, per opera di un gruppo di
“Nativist ethnographers”, come li definisce Salim Tamari, formato da
Tawfiq Canaan127, Khalil Totah128, Omar Saleh Barghouti129, Elias Haddad
e Sthephan Hanna Stephan (Tamari, 2004). La figura più nota è Canaan
(1882-1964), nato a Beyt Jala vicino Bethlehem, medico affermato come un
altro famoso studioso di folklore italiano Giovanni Pitré, pubblica i suoi
lavori in tedesco e in inglese; la sua prima monografia risale al 1914
Aberglaube und volksmedizin im lande der Bibe (Superstizione e medicina
popolare nella Terra della Bibbia). Grazie alla sua professione, che lo porta
126 The Palestine Oriental Society, come riporta l’Introduzione del primo numero della sua
Rivista (The Journal of the Palestine Oriental Society, JPOS), nata per iniziativa
dell’assiriologo americano Albert T. Clay, si pone l’obiettivo di “favorire la cultura e la
pubblicazione di ricerche sull’Oriente Antico”. «La creazione di questo Centro favorirà le
relazioni personali con gli studiosi di ogni origine, oltre a essere un’occasione, per quel vasto
numero di persone che abitano in Palestina e si interessano ai nostri studi, di incontrare e di
confrontarsi con personalità scientifiche di fama mondiale» (JPOS, 1920, I, p. 3).
127 Nato a Beyt Jala (Tawfῑq Kanā‘an, 1882-1964), nel 1899 dopo la scuola secondaria
(Schneller School), frequentò l’American University of Beirut dove si laureò nel 1905 e tra il
1912 e il 1914 si recò ad Amburgo per specializzarsi in microbiologia e in medicina tropicale.
Coprì incarichi di rilievo in numerosi ospedali della Palestina e avviò ricerche anche nel campo
della tubercolosi e della malaria. Dopo la guerra (cui dovette partecipare tra le file dell’esercito
ottomano), nel 1919 diventò direttore del Lebbrosario a Talbiyye, unico ospedale del genere in
tutta la regione siro-palestinese. Nel 1944 fondò la ǧam‘iyya ṭibiyya ‘arabiyya li-Filasṭīn
(Società araba medica palestinese), che pubblicava anche una rivista (Maǧalla al-ṭibiyya al‘arabiyya al-filasṭīniyya); durante gli eventi del 1947-1948, la Società prestò soccorso a molti
combattenti e collaborò con la Croce Rossa. Nel 1948 dopo la distruzione della sua casa (la
collezione di amuleti fu tratta in salvo, ma non la biblioteca), Canaan insieme alla sua famiglia
visse ospite per oltre due anni del patriarcato greco ortodosso continuando la sua professione di
medico. Nel 1950 contribuì alla fondazione dell’ospedale Augusta Victoria, che diresse fino al
1955, quando andò in pensione. Accanto alle numerose pubblicazioni mediche e nel campo del
folklore, Canaan nel 1936 pubblicò due testi sulla questione palestinese: Qaḍiyya ‘Arab
Filasṭῑn (La questione degli Arabi di Palestina) e Ṣirā‘ fῑ Arḍ al-Salām (La lotta nella Terra
della pace), nei quali accusava i Britannici di portare avanti una politica anti araba. Per una
descrizione molto dettagliata della vita si rinvia a (al-Nāšif, 2002).
128 Pedagogo e storico, nato a Ramallah da una famiglia quacchera, Totah (Ḫalῑl Ṭūṭaḥ, 18861955), studiò in Palestina e Libano poi negli Stati Uniti, dove nel 1926 ottenne il suo PhD alla
Columbia University. Tornato in Palestina ricoprì vari incarichi nel campo dell’istruzione, nel
1944 si trasferì definitivamente negli Stati Uniti. Pubblicò i suoi lavori in inglese e in arabo, tra
i quali: The Contribution of the Arabs to Education (New York, Columbia Univ., 1926) ; Arab
Progress in Palestine (1946); Ta’rīḫ Filasṭīn (1922), scritta insieme a O. S. al-Barghuti (Cfr.
Ricks, 2009; Totah Hilden, 2007; http://www.passia.org/images/personalities/totahkhalil/khalil-text.htm). Le sue memorie sono state pubblicate da Thomas M. Ricks (2009a).
129 Nato a Deir Ghassana (‘Umar al-Ṣāliḥ al-Barġūṯī,1894-1965), nei pressi di Ramallah,
studiò a Gerusalemme e a Beirut. Avvocato, scrisse articoli di folklore, sui costumi dei beduini
e sul sistema feudale, oltre a una Storia della Palestina in collaborazione con Totah. Gran parte
dei suoi articoli sono stati pubblicati in JPOS (dove il suo nome è trascritto ‘Omar es-Saleh elBarghuthi), si veda Bibliografia.
Questo
78
ebo
rtiene
ok appa
a\nGiu
ok
rtien
a
p
ap
130 La Collezione di Canaan è tra le più prestigiose e ricche; consta di oltre 1400 esemplari, tra
amuleti e oggetti relativi alla medicina e a pratiche folkloriche, raccolti e catalogati
personalmente dal medico palestinese che di ognuno aveva compilato una scheda con la
descrizione del suo significato e uso. La famiglia Canaan dopo il 1848 conservò gelosamente la
collezione con l’auspicio che rimanesse in Palestina; nel 1996 la donò all’università di Bir Zeit
che ha allestito una mostra permanente nella Galleria di Etnologia e Archeologia della
Biblioteca; le foto di molti esemplari sono visibili nel sito dell’Università e sono stati
pubblicati in un Catalogo curato nella versione inglese da Khaled Nashef (al-Nāšif) e in quella
araba da Wisām ‘Abdallah: Ya Kafi Ya Shafi: The Tawfiq Canaan Collection of Amulets,
Birzeit 1998. (Cfr. al-Nāšif, 2002; Tamari, 2004; Ju’beh, 2005).
131 Pubblicò Marriage Conditions in a Palestinian village (1931-1935, 2 voll.), cui seguirono
Child problems among the Arabs: studies in a Muhammadan village in Palestine (1950), e
Muslim Death and Burial: Arab customs and traditions studies in a village in Jordan (19591965, 2 voll.). (Suolinna, 2000).
132 L’antropologo tedesco Franz Boas (1858-1942) si dedicò attivamente alla raccolta del
folklore di varie tribù degli indigeni d'America, poiché riteneva che il folklore, riflesso della
cultura locale, fosse in via di estinzione e dunque avesse bisogno di una repentina, opera di
salvataggio.
79
Que
s
bo
to e
a fare visite in giro per le campagne palestinesi, Canaan matura un profondo
attaccamento per la sua terra; scrive infatti alcuni articoli sull’agricoltura
(Canaan, 1909; 1928), e mostra un vivo interesse per le condizioni dei
contadini e soprattutto per le loro credenze “spirituali”, come attestano non
solo i suoi lavori ma anche la vastissima collezione di amuleti130 che
raccoglie negli anni proprio tra i suoi pazienti. La formazione di Canaan,
rispetto al cosiddetto circolo palestinese, è più vicina a quella degli
orientalisti occidentali con i quali entra in stretto contatto nell’American
School for Oriental Research (fondata nel 1900) della quale diventa
membro nella sede di Gerusalemme guidata dal 1920 al 1929
dall’archeologo W. Foxwell Albright, e nell’Evangelical German Institut of
Archaeology, diretta da Canaan e da Gustave Dalman dal 1903. L’interesse
di Canaan si concentra sulle credenze popolari piuttosto che sulla
ricostruzione della vita quotidiana, come nel caso di Dalman e Hilma
Granqvist131, sebbene condivida la visione orientalista fondata sugli studi
biblici; egli riteneva infatti, al pari di Dalman, che per meglio comprendere
il Vecchio Testamento fosse necessario studiare il folklore palestinese; le
tradizioni popolari soprattutto quelle del fellāḥ sembrano per lui
manifestazioni ‘residuali’ della vita quotidiana d’epoca biblica. La sua
impostazione non sembra dunque allontanarsi molto da quella di fine
Ottocento che considerava il folklore il riflesso di una cultura in via di
estinzione, una sorta di “relitto” da salvare132. Le caratteristiche primitive
della Palestina – afferma Canaan - stanno scomparendo molto più
velocemente che in passato tanto che molte andranno perse; bisogna dunque
affrettarsi a raccogliere nel modo più completo e accurato tutto il materiale
riguardante il folklore, gli usi, i costumi e le superstizioni della Terra
Santa133. Le fonti cui Canaan attinge per una comparazione col passato sono
quelle del Vecchio Testamento; in ogni ambito del quotidiano rintraccia dei
paralleli con la Bibbia, per esempio, offrire il “primo-frutto” a Dio (Canaan,
1928:126), oppure lasciare a vedove, orfani e poveri parte del raccolto
rimasto sugli alberi134; si tratta di sopravvivenze bibliche in una popolazione
che secondo Canaan per molti versi è “as primitive as their ancestors of two
thousands years ago”135. I riferimenti alle Sacre Scritture sono rintracciabili
anche in altri autori, tra cui Stephan H. Stephan, che nel suo studio sul
Cantico dei Cantici evidenzia dei paralleli tanto nella struttura quanto nel
linguaggio con le canzoni popolari palestinesi (Stephan, 1922); o Haddad
che individua nei costumi contadini forti tracce dello spirito e del senso
della Bibbia (Haddad, 1920: 209). Riconosciuto il valore scientifico a questi
lavori, preziosi nel loro genere, va tuttavia rilevato come essi si collochino
all’interno di una certa concezione canonica della storia palestinese, in cui è
centrale la tradizione biblica, secondo l’interpretazione data dall’Occidente
cristiano e ripresa dal sionismo poi per costruire Israele136.
La società contadina, attraverso il suo patrimonio “folk” superstizioni, canzoni, dialetto, ecc. - accumulato nel corso dei secoli, oltre
alla cultura biblica, comune a cristiani, musulmani ed ebrei sefarditi, riflette
anche l’antica cultura semitica. Nel suo “Haunted springs and water demons
in Palestine”, Canaan afferma che è molto diffusa tra le popolazioni
133 «The primitive features of Palestine are disappearing so quickly than before long most of
them will be forgotten. Thus it has become the duty of every student of Palestine and the Near
East, of Archaeology and the Bible, to lose no time in collecting as fully and accurately as
possible all available material concerning the folklore, customs and superstitions of the Holy
Land». (Canaan, Muhammadan Saints, cit. Tamari, 2004: 35).
134 «After harvesting a piece of ground or gathering the olives from certain trees, everybody is
allowed to gather the remaining ears or fruits. Widows, orphans and poor are given the
preference. This is again a survival of a Biblical custom» (Canaan, 1928: 127).
135 «A study of the effect of two antagonist phenomena in nature, light and darkness, on the
life of the present inhabitants of Palestine (who are in many respects as primitive as their
ancestors of two thousand years ago) may explain certain allusions in the Bible» (Canaan,
1931: 15).
136 Nel 1949 un gruppo di studiosi, cartografi, archeologi, geografi e storici, incaricati dal
Primo Ministro israeliano Ben Gurion costituirono il Negev Names Committee (NCC), che
iniziò a raccogliere una “concrete documentation of the continuity of a historical thread that
remained unbroken from the time of Joshua Bin Nun until the days of the conquerors of the
Negev in our generation” (Benvenisti, 2000:12). Il compito che Ben Gurion affidò al Comitato
è spiegato in questa lettera: «We are obliged to remove the Arabic names for reasons of state.
Just as we do not recognize the Arabs’ political proprietorship of the land, so also do we not
recognize their spiritual proprietorship and their names» (Benvenisti, 2000:14). I toponimi
furono quindi anglicizzati o ebraicizzati in base anche alle Sacre Scritture.
Qu
es
to
eb
oo
ka
pp
art
ien
80
ea
\nG
Qu
semitiche la vecchia credenza popolare che sorgenti, cisterne e corsi
d’acqua siano popolati di esseri (Canaan, 1920:153); e prendendo come
caso di studio le maledizioni, sostiene che esse sono esattamente “quelle
degli antichi Semiti” (Canaan, 1933: 235)137. L’obiettivo sembra allora
quello di rintracciare una continuità storica tra l’epoca preislamica e quella
della società contadina attuale; secondo Canaan, infatti: non si potrebbe
avere una migliore descrizione delle antiche credenze semitiche di quelle
riprodotte dalla semplice immaginazione del fellāḥ palestinese138; è infatti in
tale contesto rurale, meno soggetto ai cambiamenti nei costumi, rispetto
alla realtà urbana, che è possibile trovare tali sopravvivenze139.
I contadini sembrano pertanto incarnare l’anima incontaminata,
dunque, locale e autentica della nazione che va salvata dalla minaccia delle
forze occidentali moderne. Motivo questo che spinge Tamari a usare, il
concetto di “nativism” sopra accennato, sebbene né Canaan né gli altri
studiosi palestinesi lo avessero utilizzato.
L’idea di una cultura contadina, pura, immutata da migliaia di
anni, attraversa gran parte degli studi demologici degli anni Venti, ma resta
viva anche in quelli di epoca successiva sebbene con implicazioni diverse.
Con
Canaan e il suo circolo si afferma innanzitutto il concetto
fondamentale, ma ancora oggi negato da parte sionista, dell’esistenza di
un’identità palestinese che non nasce in risposta al sionismo, ma affonda le
sue radici in un passato remoto, sia esso biblico, semitico, o feniciocananeo, con tutte le implicazioni che ne derivano140. Un’identità
palestinese simboleggiata per l’appunto dalla figura del fellāḥ, che ne
incarna al contempo storia e cultura in una dimensione fortemente
idealizzata, in cui scompaiono riferimenti spazio-temporali; il contadino
unisce e mobilita con una profonda forza emotiva, trascendendo passato e
presente. E se tale simbologia è anche altrove utilizzata nella costruzione
del discorso nazionale – nell’Egitto degli anni Venti tanto nelle sculture
quanto nei quadri la contadina rappresenta l’anima del paese, essendo
to
es
k
oo
eb
ap
ne
rtie
pa
137 In un altro articolo sulla legge non scritta diffusa tra le donne di Palestina, Canaan afferma:
«[…] the traditional law affecting women seems to be a legacy from the earliest days of
Semitic civilization» (Canaan, 1933: 203).
138 Egli afferma «The representation of good against evil, white against black, angels against
devils, light against darkness, upper against lower world and God against Satan, is a very old
idea in Semitic religions and we could not have it better pictured than as reproduced by the
simple imagination of a Palestinian fellah» (Canaan, 1920: 156).
139 «The simple, crude, but uncontaminated patriarchal Palestinian atmosphere is fading away
and European civilization, more sophisticated but more unnatural, is taking its place» (Canaan,
Muhammadan Saints, cit. Tamari, 2004:35).
140 La bibliografia sull’argomento è vastissima, cfr. Khalidi (1997) e Gerber (2003).
aC
an
uli
Gi
a\n
81
ac
oti CLI
u
p
a
i
c
na Cac
a
i
l
u
i
G
a\n
depositaria di quanto c’è di virtuoso e nobile nella nazione egiziana (Baron,
1997:123) - nel caso palestinese assume una valenza specifica molto forte,
in quanto si sviluppa in contrapposizione al suo omologo israeliano. Infatti
il discorso sul fellāḥ assume significati suoi propri in una realtà quotidiana,
dominata dalla censura politica di Israele, che nega ogni rappresentazione
nazionale della Palestina araba – la bandiera per es. – costringendo i
palestinesi a ricorrere a simboli quali l’olivo o il fellāḥ appunto, per dare
espressione, indirettamente, al proprio sentimento nazionale (Swedenburg,
1990: 24).
Questo
appa
ebook
rtiene
2. Sirḥān
Con la nascita dell’Olp, la sconfitta del 1967 (naksa) e la
conseguente dispersione del popolo palestinese, ma soprattutto con
l’intensificarsi della politica israeliana di negazione storico-culturale dei
palestinesi, il folklore diviene strumento di salvaguardia dell’esistenza
passata e presente, ma anche mezzo di resistenza (muqāwama), attraverso
cui infondere nel popolo nuova forza. Questo è quanto emerge dalle parole
di Nimr Sirḥān nella prefazione alla seconda edizione dell’Enciclopedia del
folklore palestinese141. Frutto di un lungo lavoro iniziato intorno alla metà
degli anni Sessanta con l’apertura di un archivio del folklore palestinese
(1966), in cui Sirḥān ha raccolto soprattutto canzoni, musica e danze
popolari, l’Enciclopedia si è poi ampliata, arricchendosi con altri contributi,
già editi, sia occidentali sia arabi. Nella definizione di al-turāṯ al-ša‘bī,
Sirḥān sottolinea in primo luogo la storicità del folklore palestinese, che si
tramanda da un passato lontano come dimostrano anche i lavori sul dialetto
palestinese di studiosi occidentali (Barthélemy, ecc.). Il folklore, aggiunge,
non è «un’accozzaglia di pratiche magiche e di superstizioni degli strati più
poveri e dei contadini», ma è un patrimonio cui hanno contribuito tutte le
classi sociali e le cui origini sono difficili da datare; alcune canzoni
popolari, per es., sembrerebbero risalire al I secolo dell’egira.
Contrariamente alle espressioni artistiche ufficiali (al-fann al-rasmī), nelle
quali l’artista trasforma il suo sentire individuale in arte, il folklore esprime
le esigenze e i sentimenti più diffusi tra il popolo che, ritrovandosi in esso,
lo fa proprio diffondendolo e tramandandolo nel tempo (Sirḥān, 1989:5253).
In secondo luogo, Sirḥān pone in rilievo il dato nuovo che emerge
dopo gli anni Settanta l’autodeterminazione: ora sono i palestinesi, in prima
persona, a condurre la propria lotta (niḍāl), e pur ribadendo che la questione
141La prima edizione del 1977-1981 arrivava fino alla lettera zāy.
82
Qu
e
sto
palestinese riguarda l’intero mondo arabo, il legame tra società, territorio e
cultura locali diventa più stretto. Scopo fondamentale del folklore è ora
quello di tenere in vita il patrimonio popolare che oppone così la sua
resistenza all’occupazione. Sirḥān dedica un capitolo della sua Enciclopedia
proprio allo spirito della resistenza (rūḥ al-muqāwama), che ricostruisce
attraverso le canzoni popolari diffuse nei campi e quelle trasmesse
dall’emittente Ṣawt filasṭīn (Sirḥān 1989:795).
Così, nonostante l’industrializzazione e il conseguente
impoverimento della società contadina sempre più dipendente dalle rimesse
dei familiari che lavorano nei paesi del Golfo (Swedenburg 1990: 23), in
questa nuova fase storica, quando un terzo della popolazione delle aree
rurali in Cisgiordania si reca a lavorare in Israele (Tamari,1981), il fellāḥ
continua a simboleggiare, come all’inizio del secolo, l’anima della nazione;
di una nazione che, sebbene smembrata, resiste. Anche la letteratura
contribuisce a rafforzare tale visione di un passato pastorale mitico, di una
Terra perduta simboleggiata dalla campagna, da arance, ulivi e fichi d’India.
In tal senso indicativo l’uso del termine ṣubbār, che oltre a designare una
pianta forte, resistente ad ogni intemperie - il cui omologo ebraico è sabra,
nome con cui sono chiamati gli ebrei nati in Palestina prima del 1948 –
rimanda al significato di pazienza ma anche di tenacia e ostinazione. Si
delinea così il concetto di ṣumūd, in quanto strategia politica: resistere sul
territorio, malgrado le difficoltà dell’occupazione. Concetto che trova anche
in questa fase il suo simbolo nel fellāḥ, legato indissolubilmente alla terra.
Ma senza entrare nelle degenerazioni cui il concetto di ṣumūd giunge, tanto
da essere utilizzato come termine cinico, auto denigratorio per indicare
immobilismo e speculazioni economiche (Tamari, 1991: 63), risulta però
funzionale al nostro discorso sull’uso del folklore. Ancora una volta
chiamato in causa per glorificare il mondo contadino, non privo di
contraddizioni, che accomuna l’intera società in un passato mitico nel quale
affondare le proprie radici: un popolo, senza divisioni né differenze di
classi, che unito affronta la sua lotta nazionale. L’Olp e con esso le
numerose organizzazioni politiche ispirate a istanze di sinistra azzerano il
dibattito politico interno per porsi come fronte unico contro l’occupazione
israeliana142.
e
142 Tali scelte politiche hanno contribuito al successo di Ḥamas; movimento che è riuscito a
interpretare quelle istanze sociali del tutto dimenticate dalla borghesia dell’Olp con una rete
sociale che si è posta come obiettivo anche quello di affrontare le difficoltà del quotidiano oltre
che portare avanti una politica di liberazione nazionale.
83
3. Gramsci
Su questo aspetto vorrei richiamare il significato che Gramsci
attribuisce al folklore143, che mi sembra illustri bene il vuoto politico in cui
si muove l’élite palestinese quando utilizza il folklore, appunto, in una
dimensione esclusivamente ideologica, tradendone la natura. Gramsci infatti
riconosce nel folklore “una cosa molto seria e da prendere sul serio”, “non
una bizzarria o un elemento pittoresco” (Gramsci, 1979: 270). La lettura
gramsciana, come sapientemente illustra Cirese, guarda al folklore tenendo
sempre presente una meta, un modello cui tendere. Modello che Gramsci
ricava dalla concezione marxista, il che implica, quale risultato del processo
di emancipazione, la fine “del distacco tra cultura moderna e cultura
popolare o folklore (Gramsci, 1979: 217). Nella prospettiva gramsciana il
folklore è innanzitutto un mezzo attraverso cui l’intellettuale entra in stretto
contatto con i bisogni, le aspirazioni, i sentimenti diffusi del popolo144. Ma
tenendo ben presente che il compito civile e politico è quello di contribuire
a “un progressivo acquisto della coscienza della propria personalità storica”
da parte di quelle masse di uomini vittime di anni di esclusione e
subalternità (Gramsci, 1978: 333). Coscienza non immobile e immutabile
nel tempo, e che certo non si ottiene - riprendendo ancora Gramsci - con
l'idoleggiamento della tradizione, vera o presunta, ma attraverso la
formazione di quella “coscienza ‘teorica’ creatrice di valori storici e
istituzionali, fondatrice di Stati” (Gramsci, 1978:1041).
Siamo dunque molto lontani da quella concezione del folklore che
ha portato a una sorta di ‘museificazione’ della Palestina attraverso una
rivivificazione del passato, non di rado incline alle tendenze più retrive e
conservatrici, funzionali però all’ideologia nazionalista e alla propaganda
del potere politico: ruralismo, localismo, concezione subalterna della donna.
In nome della lotta nazionale vengono mitizzate le tradizionali virtù
contadine: l’attaccamento alla Terra, la fecondità delle donne, esaltata in
chiave anti-israeliana – quasi a voler assecondare l’ossessione nazionalista
ebraica della crescita demografica smisurata dei palestinesi – e
Questo ebook appartie
143 L’interesse di Gramsci per il folklore non si esprime soltanto nelle pagine delle
Osservazioni sul folclore - dove teorizza il pensiero quasi schematicamente - ma interessa
l’intera sua opera, sia i Quaderni, sia le Lettere, sono ricchissimi di riferimenti al folklore,
poiché, come suggerisce Cirese, scaturisce da tutto intero l’impegno teorico-politico
dell’intellettuale sardo (Cirese, 1976:101).
144 A mo’ di esempio cito la traduzione di una serie di novelle popolari dei Fratelli Grimm che
Gramsci scrisse per il nipote, dove oltre ad effettuare un adeguamento ambientale, cambiando
le nebbie nordiche con un paesaggio sardizzato e sostituendo la lepre selvatica con la più
nostrana gallina, traduce il senso comune impregnato di fatalismo e di superstizione con un
senso comune laico ispirato alla ratio (Boninelli, 2007: 104).
84
t
es
u
Q
l’autosufficienza domestica, cioè una forma di autarchia, come risposta ai
lunghi periodi di “chiusura” e d’isolamento dei Territori palestinesi
(Tamari, 1991: 62). Certamente in ogni nazione si è verificato un processo
di rivisitazione delle tradizioni, con l’esaltazione di alcune l’omissione di
altre, e che tende ad accentuarsi, laddove l’identità nazionale è messa in
discussione, se non negata (Smith, 1992). Ma nel caso palestinese appare
piuttosto come un processo meccanico e intenzionale - che Cirese definisce
di acculturazione (Cirese, 1984:19) - dove il folklore sembra piuttosto un
fardello cui restare legati secondo un’ottusa ideologia nazionalista.
Emblematica, a tal proposito, l’organizzazione del mawsim di al-Nabῑ Ṣāliḥ
da parte dello stesso Nimr Sirḥān nel 1997, che tornato in Palestina dopo
l’esodo del 1948, ha “ridato vita” attraverso il Ministero della cultura dell’
Autorità nazionale palestinese (ANP), a questo popolare pellegrinaggio da
tempo ormai tramontato; non da ultimo perché il luogo dove si svolgeva era
caduto sotto occupazione israeliana. Spostato in una zona controllata
dall’ANP, il mawsim è ufficialmente organizzato: “Ho deciso di resuscitarlo
nell’ambito del mio lavoro sulla resurrezione della nazione palestinese e
del patrimonio palestinese. Bisogna che le persone e il popolo sentano di
possedere un patrimonio molto antico che risale a Ṣalāḥ al-Dῑn al-Ayyūbῑ”
(Aubin-Boltanski, 2006: 127). Mawsim, come osserva Emma AubinBoltanski, spesso chiamato mahraǧan festival, per ampliare lo spazio di
ricezione all’intera popolazione, facendone una festa nazionale o meglio
nazionalista, a cui tutti i palestinesi sono chiamati. Ma appare chiaro che
nella realtà il mawsim, resuscitato astoricamente, non esprime una forza
autentica, popolare – tanto che i pellegrini rimpiangono il “vero” mawsim145
– perdendo così ogni caratterizzazione folklorica, per assumerne una
soltanto vetero-nazionalista. Lo stesso può dirsi dei vari mahraǧan
organizzati dal Ministero palestinese della cultura dell’ANP, il Qabatiyya
Canaanite festival o il Festival della musica di Yabus che celebrano
un’identità nazionale le cui radici vengono fatte risalire a ben prima di
Cristo, ai tempi dei Canaanei e dei Gebusiti con un’operazione simmetrica
nelle modalità ideologiche a quella compiuta da Israele. Basti pensare che
nella metà degli anni Quaranta esisteva un gruppo Canaanita anche tra i
sionisti dell’Yishuv. Sicché non appare casuale come sottolinea Zakariyya
Muḥammad il fatto che questa “ideologia canaanita” palestinese finisca per
condividere la tesi sionista «di un nostro perenne conflitto con gli ebrei
145 Un anziano di Hebron afferma a proposito del mawsim di Nabi Musa: «Avant Nabi Musa
c’était la fête de l’union de la Palestine. Hajj Amin al-Husseini accompagné de son armée était
notre guide religieux et politique! Mais tout cela est fini maitenant» (Aubin-Boltanski, 2006:
122).
85
risalente a ben prima del Re Salomone» (Tamari, 2004: 29-30). Scontro
perenne che non sembra risparmiare né il folklore palestinese né quello
israeliano; come dimostra l’invenzione nel 1944 della danza popolare
israeliana (Israeli folk dance) da parte di Gurit Kadman (1897-1987) e
Rivka Sturman (1903-2001) - due ginnaste tedesche emigrate in Palestina
negli anni Trenta - che crearono artificialmente un patrimonio “popolare
genuino”: «There was no choice; one had to create dances» (Roginski,
2007: 49), così afferma146 testualmente la Kadman, contraddicendo con le
sue parole il concetto stesso di danza popolare che per sua natura non può
essere creata da nessun coreografo. La nuova danza che si ispirava a molti
balli, si basava principalmente su passi di danza ebraico- yemenita e su
quelli di danze arabe locali, sebbene la connotazione fosse solo israeliana. Il
folklore palestinese veniva incorporato nelle performances nazionali
d’Israele dopo essere stato rimosso e svuotato della propria identità.
Torno dunque alle ragioni che sorreggono il folklore palestinese,
minacciato nel suo essere, non soltanto a causa del normale trascorrere degli
anni, come avviene per ogni tradizione, bensì anche per effetto di
un‘espropriazione politica e culturale: l’annientamento del popolo
palestinese - come afferma Ḥasan al-Bāš (1986), autore di uno studio sui
giochi e le canzoni popolari - è passato anche attraverso “lo svuotamento
della personalità di tutto ciò che essa serbava, compreso il suo al-turāṯ alša‘bī” (al-Bāš, 1986:6). Si spiega allora quella febbre di archiviazione che
sembra aver colpito i palestinesi che in ogni parte del mondo collezionano
abiti, canzoni, scrivono memorie e autobiografie, cercando in questo modo
di lasciare traccia del loro turāṯ. Come pure si spiega la tendenza di un
folklore, quello palestinese, minacciato anche nel nome, generalmente
chiamato arabo, o beduino (Stein, 1998), che nelle sue manifestazioni
ufficiali si snatura per ripiegarsi astoricamente nell’angusto alveo
dell’ideologia nazionalista. Operazione paradossalmente speculare a quella
del suo omologo israeliano, che in entrambi i casi sembra proprio
degenerare nel folklorismo147; qui inteso come consapevole manipolazione
146 «How [was it] possible that the Jewish nation with one of the oldest traditions in the world
should be lacking a folk dance tradition [and] could we revive those [biblical] dances? It turned
out that of those ancient dances no testimonies whatsoever remained which could help us to
understand, to reconstruct, to revive them… for us people who fervently wished to have
dances of our own and in our lifetime». Segue nel testo.
147 Molto ampia la bibliografia sul tema e con posizioni discordanti; si rimanda a titolo
esemplificativo allo studioso di folklore americano, Richard M. Dorson (1959;1973), che ha
coniato il termine fake lore, e a Newall (1987) che, da posizioni diverse, spiega le origini del
folklorismo.
Qu
es
to
eb
86
oo
ka
pp
art
del materiale folklorico a scopi ben precisi: ideologici, politici,
propagandistici, turistici e perfino commerciali (Dundes, 1989).
In conclusione, la ricca articolazione di piani della formulazione gramsciana
mi sembra evidenzi i profondi limiti della concezione di folklore oggi più
diffusa in Palestina, che esalta in chiave romantica o post-romantica l’idea
di “popolo-nazione”, quale entità indistinta, in cui non ci sono classi e
categorie sociali, per contrapporre alla nazione ciò che le è estraneo,
oppressori e nemici. Una visione dunque che non coglie e non sa sfruttare
la forza di cui il folklore è capace, la sua tenacia, e soprattutto la sua
rappresentatività socio-culturale. La questione vera non è dunque quella di
negare una realtà oggettiva, ma quella di prenderne coscienza per superarla.
Come faceva Gramsci, quando - ricorda sempre Cirese – si sforzava di
esplicitare l’intenso portato “dei cafoni del Sud” cogliendone la specificità,
le componenti e le potenzialità innovatrici senza mai cadere nell’illusione
che la nuova cultura proletaria stesse tutta bella e fatta nel folklore, senza
cedere al mito di una civiltà contadina immobile da preservare anche nel
futuro (Cirese 1977:166).
Studi demologici palestinesi
Barghuti (1922), Omar Saleh “Judicial Courts among the Bedouin of
Palestine”, in Journal of the Palestine Oriental Society, II,1922, pp.34-65.
— (1924), “Rules of hospitality”, in Journal of the Palestine Oriental
Questo
Society, IV, 1924, pp. 175-203.
ebook a
— (1929), “Traces of the Feudal System in Palestine”, in Journal of the
Palestine Oriental Society, IX, 1929, pp. 70-79.
Canaan (1909), Tawfiq, “Der Ackerbau in Palästina”, in Globus, 96, 1909,
pp. 272 – 293.
— (1913), “Der Kalender des Palästinensischen Fellachen”, in Zeitschrift
des Deutschen Palästinaverein, 36, 1913, pp. 266-300.
— (1914), Aberglaube und volksmedizin im lande der Bibe, Hamburg, L.
Friederichsen, 1914.
87
ppartie
— (1920), “Haunted Springs and Water demons in Palestine”, in Journal
of the Palestine Oriental Society, I, 1920, pp. 153-170.
— (1927), Muhammadan Saints and Sanctuaries in Palestine, London,
Luzac, 1927 (già pubblicato in Journal of the Palestine Oriental Society,
IV,1924, pp. 1-84; V,1925, pp.161-222; VI,1926, pp.1-69; VII, 1927,pp. 188).
— (1927a), “The Child in Palestinian Arab Superstition”, in Journal of the
Palestine Oriental Society, 1927, VII, pp.159-186.
—
(1928), “Plant-lore in Palestinian Superstition”, in Journal of the
Palestine Oriental Society, VIII,1928, pp. 125-168; riedito in Jerusalem
i CLI
puot
a
i
c
c
— (1931a), “Unwritten laws affecting the Arab woman of Palestine”,
a Ca in
n
a
i
l
u 172-203.
Journal of the Palestine Oriental Society, XI, 1931,
\nGipp.
a
e
n
— (1931), “Light and darkness
artiniePalestine Folklore”, in Journal of the
p
p
a
k XI, 1931, pp. 15-36.
Palestine Orientale
ooSociety,
b
e
o
est
—u(1932-33),
“The Palestinian Arab house : its architecture and folklore”,
Q
Quarterly, 24,2005, pp. 57-64.
in Journal of the Palestine Orientale Society, XII, 1932, pp. 221-247; XIII,
1933, pp.1-81.
— (1933), “The curse in Palestinian Folklore”, in Journal of the Palestine
Orientale Society, XV,1933, pp. 235-279.
—
(1934), “Modern Palestinian beliefs and practices relating to God”, in
Journal of the Palestine Oriental Society, XIV,1934, pp.59-92.
—
(1962), “Superstition and Folklore about bread”, in Bulletin of the
American School of Oriental Research, 167,1962, pp. 36-47.
Haddad (1920), Elias, “Political Parties in Syria and Palestine (Qaisî and
Yemenî), in Journal of the Palestine Orientale Society, I, 1920, pp.209-214.
88
—
(1921), “Blood Revenge among the Arabs”, Journal of the Palestine
Orientale Society, I, 1921, pp. 103-112.
— (1923), “Methods of education and correction among the fellahin”, in
Journal of the Palestine Orientale Society, III,1923, pp.41-44.
— (1930), “Folklore and Songs from El-Qubēbe”, Journal of the Palestine
Oriental Society, L,1930, pp. 199-213, scritto con H. Henry Spoer.
Sirḥān (1989), Nimr, Mawsū‘at al–fulklūr al–filasṭīnī, al–ṭab‘a al–ṯāniya
al–kāmila min al–alif ilà al–yā’, ‘Ammān, Munaẓẓama al–taḥrīr al–
filasṭīniyya, 3 voll., 1989.
Stephan (1922), Stephan H. “Modern Palestinian Parallels to the Song of
Songs”, in Journal of the Palestine Orientale Society, II, 1922, pp.199-278.
— (1923), “Palestinian Animals stories and fables”, Journal of the Palestine
Orientale Society, III, 1923, pp.167-190.
— (1925), “Lunacy in Palestinian Folklore”, Journal of the Palestine
Orientale Society, V, 1925, pp. 1-16.
— (1925-1929), “Animals in Palestinian Folklore”, Journal of the Palestine
Orientale Society, V,1925, pp. 92-155; IX,1929, pp. 88-99.
— (1932), “Palestinian nursery rhymes and songs”, in Journal of the
Palestine Orientale Society, XII, 1932, pp. 62-85.
Bibliografia
Aubin-Boltanski (2006), Emma, “Le folkloriste comme technicien de la
book
Questo e
mémoire”, in Territoires palestiniens de mémoire, dir. Nadine Picadou,
Paris-Beyrouth, Karthala-Ifpo, 2006, pp.115-137.
Aubin-Boltanski (2007), Emma, Pèlerinage et nationalisme en Palestine.
Prophètes, héros et ancêtres, Paris, Ehess, 2007.
89
appa
Baron (1997), Beth, “Nationalist Iconography: Egypt as a woman”, in
Ques
to eb
Rethinking Nationalism in the Arab Middle East, edd. J. Jenkowski, I.
Gershoni, New York, Columbia Univ. Press, pp.105-124.
ook a
al-Bāš (1986), Ḥasan, Aġānī wa al‘āb al-aṭfāf fī al-turāṯ al-ša‘bī al-filasṭīnī,
Dimašq, Dār al-ǧalīl, 1986.
Benvenisti (2000), Meron, Sacred Landscape. The buried history of the
Holy Land since 1948, Berkeley–Los Angeles, London, Univ. California
press, 2000.
Boninelli (2007), Giovanni Mimmo, Frammenti indigesti. Temi folclorici
negli scritti di Antonio Gramsci, Roma, Carocci, 2007.
Cirese (1976), Alberto M., Intellettuali, folklore, istinto di classe, Torino,
Einaudi, 1976.
— (1977), “Gramsci e il folklore come concezione tradizionale del mondo
delle classi subalterne”, in Problemi, 1977, 49, pp. 155-167.
— (1984), Cultura egemonica e culture subalterne, Palerno, Palumbo,
1984.
Cocchiara (1952), Giuseppe, Storia del folklore in Europa, Torino, Einaudi,
1952.
Dorson (1959), Richard M., “Folklore and fakelore”, in American Mercury,
LXX, 1950, pp. 335-343.
— (1973), “Is a Folklore a discipline”, in Folklore, 84, 1973, pp.177-205
Dumani (2009), Bišāra, “Aršifāt Filasṭīn wa al-Filasṭīniyyīna”, in Awrāq
‘ā’iliyya. Dirāsāt fī al–ta’rīḫ al–iǧtimā‘ī al– mu‘āṣir li–Filasṭīn. Taḥrīr
Zakariyyā Muḥammad, Ḫālid Farāǧ, Salīm Tamārī, ‘Iṣām Naṣṣār, al-Quds,
Mu’assasat al-dirāsāt al-muqaddasiyya, 2009, pp. 11-18.
Dundes (1989), Alan, “The fabrication of fakelore”, in Folklore matters,
Knoxville, Tenn., 1989, pp. 40-56
90
ppart
ien
EI2, Encyclopædia of Islam, ed. by P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E.
Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs et al., 12 vols. with indexes
and etc., Leiden, E. J. Brill, 1960–2005.
Fox (1980), William S., “Folklore and Fakelore: some sociological
considerations”, in Journal of the Folklore Institute, 17, 2/3, 1980, pp. 244261.
Gerber (2003), Haim, “Zionism, Orientalism and the Palestinians”, in
Journal of Palestine Studies, XXXIII, n. 40, 2003, pp. 23-41
Glock (1994), Albert, “Archeology as cultural survival: the future of the
Questo ebo
ok
Palestinian past”, in Journal of Palestine Studies, XXIII, n. 3, 1994, pp. 70–
84.
Gossiaux (1995), Jean-François, “Le sens et le verbe sur deux modes
opposés d’instrumentalisation politique du folklore”, L’Homme, 135, 1995,
pp. 127-134.
Gramsci (1978), Antonio, Quaderni del carcere, Torino, Einaudi, 1978.
appartien
— (1979), Letteratura e vita nazionale, Roma, Editori Riuniti, 1979.
Ju’beh (2005), Baha’, “Magic Talismans. The Tawfiq Canaan Collections
of Palestinian amulets”, in Jerusalem Quarterly, 22-23, 2005, pp.103-108.
Khalidi (1997), Rashid, Palestinian Identity: The construction of modern
national consciousness, New York, Columbia Univ. Press, 1997.
al-Nāšif (2002), Ḫālid “Tawfῑq Kan‘ān: taqwīm ǧadῑd”, in Maǧallat alDirāsāt al-Filasṭīniyya, 50, 2002, pp. 69-91; una versione ridotta è in
Jerusalem Quarterly, 2002, 16, pp. 12-26.
Newall (1987), Venetia J., “The adaption of Folklore and Tradition
(Folklorismus)”, in Folklore, 98, 2, 1987, pp. 131-151.
91
Pirinoli (2005), Christine, “Effacer la Palestine pour construire Israël.
Transformation du paysage et enracinements des identités nationales”,
Etudes rurales, 173–174, 2005, pp. 67–86.
Ricks (2009), Thomas M., “Khalil Totas: the Unknown years”, in
Jerusalem Quarterly, 34, 2009, pp. 51-77.
— (2009a), Turbulent times in Palestine : the diaries of Khalil Totah,
1886-1955, Beirut, Institute of Palestine studies, 2009.
Roginski (2007), Dina, “Folklore, Folklorism, and Synchronization :
Preserved-Created Folklore in Israel”, in Journal of Folklore Research, 44,
1, 2007, pp. 41-66.
Smith (1992), Anthony D., Le origini etniche delle Nazioni, Bologna, Il
Mulino, 1992.
Q
production”,in Social Text, 16, 3, 1998, pp. 91-124.
u
e
s
t
oe
Stein (1998), Rebecca Luna, “Israeli Tourism and Palestinian cultural
Suolinna (2000), Kirsti, “Hilma Granqvist: A scholar of the Westermarck
bo
School in its decline”, in Acta Sociologica, 43, 4, 2000, pp.317-323.
ok a
ppa
r
t
i
e
ne a
Swedenburg (1990), Ted, “The Palestinian peasant as national signifier”, in
Anthropolgical Quarterly, 63, I, 1990, pp. 18-30.
Tamari (1981), Salim, “In League with Zion: Israel’s Search for a Native
Pillar”, in Journal of Palestine Studies, 12, 4, 1983, pp. 41-56.
— (1991), “The Palestinian Movement in transition: Historical Reversals
and the uprising”, in Journal of Palestine Studies, XX, 2, 1991, pp.57-70.
\nG
i
u
l
iana
— (2002), “The last Feudal Lord in Palestine”, in Jerusalem Quarterly, 16,
2002, pp. 27-42.
— (2004), “Lepers, Lunatics and Saints. The Nativist Ethnography of
Tawfiq Canan and his Jerusalem Circle”, in Jerusalem Quarterly, 20, 2004,
pp. 24-43.
pu
Cac
cia
92
na
c
Ca
ot
u
p
cia
lia
Totah Hilden (2007), Joy, “Totah and Ziyadeh: Mentor and student”, in
Q
u
t
es
o
eb
k
oo
a
a
pp
r
n
tie
e
a\
iu
G
n
Jerusalem Quarterly, 32, 2007, pp. 94-102.
93
MEMORIA E POTERE: PER UNA RICERCA - AZIONE IN
LETTERATURA
Jolanda Guardi
Jolanda Guardi
Arabista, attualmente svolge attività di ricerca presso l’Universitat
Rovira i Virgili di Tarragona e presso l’Università degli Studi di Milano. È
membro del comitato scientifico del SIMReF, Seminari Interdisciplinar de
Metodologia de Recerca Feminista dell’Università di Barcellona. Si occupa
prevalentemente di letteratura e del rapporto tra intellettuali e potere. Nel
2008 è stata insignita del Premio Internazionale Benhadūga per la
traduzione dall’arabo; nel 2010 del Custodian of the Two Holy Mosquees
King Abdullah International Prize for Translation e nel 2011 del titolo di
Teologa Honoris Caus dal CTI, Coordinamento Teologhe Italiane. Ha al
suo attivo numerose pubblicazioni anche in lingua araba.
Abstract
Nel presente articolo considero la relazione tra la memoria come
prodotto intellettuale dell’Accademia e il potere, in particolare così come si
manifesta nello studio della letteratura araba. Il modo in cui la letteratura
araba è stata e in parte è studiata e resa fruibile al pubblico dei lettori,
contribuisce a delineare un’immagine degli “Arabi” come gruppo
omogeneo con caratteristiche fissate una volta per sempre. In tal modo la
letteratura araba diviene quello che è stato chiamato il “referente assente”,
ossia un contenitore vuoto da riempire, di volta in volta, con quanto
funzionale al discorso politico e ideologico del momento. In conclusione,
cercare di decolonizzare il discorso sulla letteratura araba, porta alla
costruizione di un altro discorso, quello del colonialismo epistemologico.
Dopo una discussione di quanto esposto, l’articolo propone un’alternativa
possibile quella di un approccio scientifico alla letteratura araba che la
consideri come letteratura-azione.
e a\nGiulian
Que
s
to
e
b
o
o
k
a
p
partien
In this paper I questioned the connection between memory as an
intellectual product of the Academia and power, especially in relation with
the study of Arabic literature. The way Arabic literature is studied and let
disposable to the reading public in fact, contribute in shaping an image of
the “Arabs” as an homogeneous group, which is of course not, with once
and forever fixed characteristics. In this way Arabic literature becomes
what has been called an “absent referent”, an empty jug to be filled with
ideology, socio political issues and stereotypes depending on the political
94
trend. In the end trying to decolonize the discourse on literature we still
build another discourse: the one of epistemological colonialism. After
discussing all this, the paper proposes a new way to study Arabic literature
as action-literature.
pp
art
ien
e
a\n
Giu
iap
aC
acc
lian
Il presente articolo vuol essere una riflessione necessaria poiché, a
mio parere, ciò che è mancato in ambito accademico è una riflessione sul
modo di studiare il mondo arabo e l’islām che ritengo sempre più
necessaria.
Parto dal presupposto che la memoria149 sia un processo volto a
selezionare, attraverso uno strumento di potere, la relazione accademica,
quale sia la cornice entro la quale si debba comprendere il mondo arabo,
facendo particolare riferimento al discorso inerente lo studio della
letteratura araba. In tal senso il vocabolo ‘memoria’ diviene connesso al
potere, in quanto il processo di attribuzione di senso della memoria
comporta una selezione e la capacità di fornire di senso un argomento
attraverso la costruzione, appunto, di una memoria, è segno di potere.150
L’assenza di un’analisi sulla metodologia adottata impedisce, di
fatto, l’evoluzione della disciplina;151 prova ne sia il fatto che quanto sta
uo
The term research is inextricably linked to European imperialism and
colonialism.
The word itself ‘research’, is probably one of the dirtiest words in the
indigenous world's vocabulary.
Linda Tuhiwai Smith148
Qu
est
oe
bo
ok
a
148 Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous People, Zed
Books, London 2012, p. 1.
149 Gioco qui sulla polisemia del termine: memoria come funzione psichica, come memoria
collettiva e come testo (mémoire) accademico.
150 U. Fabietti-V. Matera, a cura di, Memoria e identità. Simboli e strategie del ricordo,
Meltemi, Roma 1999. C. Hähnel-Mesnard, M. Liérard-Yeteran & C. Marinas, sous la direction
de, Culture et mémoire. Représentations contemporaines de la mémoire dans les espaces
mémoriels, les arts du visuel, la littérature et le théâtre, Les Editions de l’Ecole Polytechnique,
Palaiseau 2008. M. Halbwachs in La memoria collettiva, Unicopli, Milano 2001, afferma che
la memoria è legata agli effetti sociali di un avvenimento che, fino a quando questi perdurano,
difficilmente un gruppo sociale dimentica.
151 La disciplina cui faccio riferimento è la cosiddetta “arabistica”, che comprende lo studio
della lingua, della letteratura e, più in generale, di tutto quanto legato al mondo arabo. Già la
denominazione rende chiaro come, in realtà, non si tratti di una disciplina vera e propria, e si
cerchi di raggruppare sotto questa etichetta temi che rimandano a discipline diverse e che
sarebbero accomunati dal fattio di essere riferiti al “mondo arabo”, entità anch’essa di tutt’altro
che facile definizione. In ogni caso all’interno dell’arabistica, la prevalenza è stata data
tradizionalmente agli studi filologici.
95
avvenendo nel mondo arabo fatica a essere letto al di là di consuete cornici
di riferimento che, tuttavia, si rivelano incapaci di render conto delle
complessità.152 In tal senso il presente contributo vorrebbe costituire uno
stimolo a un dibattito che da troppo tempo attende di essere avviato sul
quadro epistemologico di riferimento, sul ruolo della ricercatrice e del
ricercatore, sulle strategie utilizzate per l’analisi dei dati – siano essi relativi
alle società, alla letteratura o al discorso religioso che vede il mondo arabo
come centro di interesse.
Per questo considero la letteratura come pratica sociale interrelata
con il potere, le ideologie e i valori espressi dalle autrici e dagli autori. Sono
consapevole che questa ricerca non sarà obiettiva, nel senso che i miei
valori, i miei interessi e il mio modo di intendere la ricerca la
influenzeranno. Facendo riferimento al pensiero di Donna Haraway in
relazione alle “politics and epistemology of locations”,153 considero base
della conoscenza la parzialità e non l’universalità. Questo approccio alla
conoscenza, denominato “situated knowledge”, sapere situato, produce
mappe concettuali che riflettono l’appartenenza di classe genere ed etnia di
chi produce ricerca.
Il ripensamento di alcuni concetti e del loro utilizzo all’interno
delle diverse teorie della conoscenza è, per diverse discipline, in atto sin
dagli anni ’70. I concetti di autenticità, obiettività, rappresentazione –
considerati fino a tempi recenti facenti automaticamente parte delle teorie
epistemologiche di volta in volta abbracciate – e il rapporto che intercorre
fra questi e le questioni legate al potere e all’autorità sono stati ampiamente
discussi in ambito umanistico e in quello delle scienze sociali.154 Gli
studiosi coinvolti nel dibattito si chiedevano come il mondo “postmoderno”
152 Per render conto delle complessità intendo un approccio analitico integrato a un approccio
sistemico; l’analisi di singole componenti, infatti, non è sufficiente a comprendere le realtà di
cui parlo, perché essa non è composta solo da queste sue parti ma è anche composta
dall’insieme. Il riferimento è, ovviamente, all’epistmeologia della complessità di E. Morin e, in
particolare alla “testa ben fatta”, che comporta “un’attitudine generale a porre e a trattare i
problemi; principi organizzatori che permettano di collegare i saperi e di dare loro senso".
Secondo Morin, questa "testa ben fatta", mettendo fine alla separazione tra le due culture,
quella umanistica e quella scientifica, consentirebbe di rispondere alle formidabili sfide della
globalità e della complessità nella vita quotidiana, sociale, politica, nazionale e mondiale. Cfr.
E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello
Cortina, Milano 2000.
153 Donna Haraway citata in Diane Wolf, ed., Feminist Dilemmas in Fieldwork,
WestviewPress, Boulder 1996, pp. 14-15.
154 Un buon testo di riferimento è G. E. Marcus and M. M. J. Fischer, Anthropology as
Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences, University of Chicago
Press,Chicago 1986.
Questo
96
e
iuli
iene a\nG
Questo e
book app
art
dovesse essere rappresentato nelle sue diverse manifestazioni
interdisciplinari contemporanee, rispondendo che le discipline che si
interessano di contemporaneità avrebbero dovuto ripensare se stesse per
rispondere alla sfida che tale cambiamento rappresentava.
Lo studio del mondo arabo, tuttavia, è restato quasi totalmente al di
fuori di questo dibattito, rimanendo legato a modi di pensiero e pratiche
ancorate “nel positivismo del diciannovesimo secolo”,155 ossia a modelli di
conoscenza ampiamente superati. In rapporto ad altri campi del sapere
perché gli studi sul mondo arabo (in Europa in particolare) sono rimasti
relativamente isolati dal punto di vista intellettuale? E questo isolamento
come ha influito sullo sviluppo della “professione” di arabisti e islamologi,
con quali conseguenze?
In realtà il mio obiettivo non è quello di dare risposte a questa
domanda, ma di esplicitare la riflessione epistemologica. Il punto principale
da cui partire per una riflessione sugli studi letterari e sulla produzione di
conoscenza di letteratura araba è quello di riflettere sul proprio modo di
produrre conoscenza. Il riferimento all’archivio è, in quest’ambito,
essenziale nella declinazione fra memoria e potere, poiché, come afferma
Jacques Derrida:
«Non esiste potere politico senza controllo dell’archivio, se
non della memoria. L’effettiva democratizzazione può essere
sempre misurata con questo criterio essenziale: la
partecipazione e l’accesso all’archivio, la sua costituzione e la
sua interpretazione».156
Quest’affermazione, non solo stabilisce una relazione fra memoria e
potere, ma sottolinea anche il legame che questi due elementi intrattengono
con la democratizzazione, che qui intendo, come dirò oltre, come fornire
agentività al mio oggetto di studio. Gli studi arabo islamici, in definitiva, si
occupano di culture, avvenimenti e persone e cioè di storia e memoria. Ciò
si traduce in potere nei confronti di ciò che viene registrato e in come viene
interpretato e conduce a considerare dove questo potere viene negoziato ed
esercitato; di conseguenza, il discorso che si genera in questo ambito è
intessuto con le istituzioni politiche e il contesto sociale in maniera talmente
155 Elizabeth Kaplan, “Many Paths to Partial Truths’: Archives, Anthropology, and the Power
of Representation” in Archival Science, 2: 2002, pp, 209-220. Ringrazio Roberta Amato per
avermi segnalato questo articolo.
156 Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression, University of Chicago Press,
Chicago and London 1995, p. 4, nota 1.
97
profonda che “sostenere seppur in modo residuale la propria innocenza e
obiettività è totalmente infondato”.157
Come afferma Clifford Geertz:
«if you want to understand what a science is, you should look
at what its apologists say about it; you should look at what the
practitioners do»158.
Ques
to eb
ook a
Ho individuato la “pratica” di coloro che si occupano di mondo
arabo e islām nell’ambito che mi interessa, ossia quello delle istituzioni e
del potere, e a cui Geertz fa riferimento, nella produzione del discorso sul
mondo arabo. Questa produzione, legata alla rappresentazione di una
determinata cultura, di persone e di avvenimenti fa riferimento alla storia e
alla memoria intesa come esercizio di potere. Obbiettivo di quanto segue è,
pertanto, quello di stabilire una relazione fra la formazione di un discorso
sul mondo arabo – in particolare riguardo alla letteratura – e quello di una
“memoria” istituzionalizzata che funge da archivio, al quale fanno
riferimento coloro che di letteratura araba si occupano. Essi creano così una
sorta di Necronomicon,159 un insieme di pseudobiblia, con le loro adeguate
fonti letterarie e iconografiche, che assume il ruolo di opera di riferimento
principale; da questo, traendo informazioni, “ognuno potrà, attraverso la sua
ars combinatoria, associarle secondo il proprio gusto, magari integrarle con
altre che ci sono sfuggite, [...], e costruirsi il proprio, personale grimorio, un
“proprio” Necronomicon”.160 Il risultato è un discorso che si perpetua
immutato su un oggetto che, al contrario, è in evoluzione.
Per ragionare su quanto qui affermato, inoltre, adotterò un metodo
interdisciplinare; credo che un approccio interdisciplinare comparativo
possa contribuire a riconsiderare l’ambito degli studi arabo islamici in una
prospettiva più ampia, riorientandoci verso l’ambiente intellettuale più vasto
entro il quale vengono prodotte le pubblicazioni relative al mondo arabo.
Su tutto, a mo’ di filo rosso, e per fornire una rappresentazione “visuale” di
come, a mio modo di vedere, opera il discorso sul mondo arabo, ho scelto
l’installazione di Kader Attia, Ghosts:
157 Elizabeth Kaplan, op. cit., p. 211.
158 C. Geertz, “Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture” in The
Interpretation of Cultures, Basic Books, New York 1973, p. 5.
159 S. Basile, a cura di, Necronomicon. Storia di un libro che non c’è, Fanucci Editore, Roma
2002.
160 Ibi, p. 11.
98
ppa
Kader Attia, Ghosts, installazione, fogli di alluminio, 2007.
L’installazione di Attia ben simboleggia, a mio parere, la relazione
tra domestico e addomesticato161 che si manifesta nello studio della
letteratura. Le donne di Attia, infatti, sono senza volto e cave (il
contenitore), realizzate con un materiale di uso quotidiano in cucina
(alluminio). L’opera riveste un carattere di forte impatto visivo e si
focalizza sull’uso del velo, mostrando come la donna sia assente (i
contenitori sono vuoti) dal discorso che la concerne. Quest’installazione ben
riassume, pertanto, la presenza del mondo arabo nel discorso che lo
riguarda. Esso è, infatti, assente e costituisce soltanto l’oggetto di un
discorso, è un ghost, un fantasma, un contenitore vuoto, da riempire di volta
in volta con contenuti adatti e funzionali al discorso stesso. Nell’ambito
degli studi sulla letteratura araba, inoltre, “the absent referent”162 assume
diverse sfaccettature: il contenitore vuoto è, di volta in volta, la produzione
in lingua araba – occultata rispetto a quella in letteratura francese per quanto
riguarda i paesi del Maghreb – il mondo arabo stesso – nel tentativo di
assimilazione condotto dalle operazioni di traduzione – il genere –
identificato solitamente con il cosiddetto universo femminile ma mai
utilizzato come categoria di analisi.163 In una parola, per riprendere il titolo
di un lavoro di Daniel Varisco il mondo arabo è “oscurato” nel discorso
accademico, che propone una lettura del mondo arabo musulmano come di
Questo eboo
161 Anne McClintock, Imperial Leather, Routledge, London & New York, pp. 31-36.
162 Carol. J. Adams, The Sexual Politics of Meat. A Feminist-Vegetarian Critical Theory,
Continuum, New York London 2010.
163 Joan Scott, “Gender as a Useful category for Historical Analysis” in The American
Historical Review, Vol. 91, n. 5, Dec. 1986, pp. 1053-1075.
99
Qu e
un sistema di credenze piuttosto che come dinamica comportamentale e
relazionale in un suo specifico ambiente cutlurale.164
Nel saggio introduttivo al volume Lo Yemen raccontato dalle
scrittrici e dagli scrittori,165 Isabella Camera d’Afflitto osserva:
«Del resto anche noi traduttori e arabisti dobbiamo interrogarci sul
nostro ruolo e su quanto possiamo influenzare la produzione
letteraria araba in genere con le nostre scelte di traduzioni non
sempre oculate [...]”.166
Camera d’Afflitto – una delle poche ad aver rilevato il problema167 –
coglie il nodo della questione, pur restando una voce isolata nel campo degli
studi letterari e di traduzione e senza approfondire l’affermazione. Ciò può
essere dovuto, in parte, al fatto che formulare generalizzazioni utili su
problemi teoretici costituisce raramente l’oggetto di interesse al testo che i
critici letterari preferiscono praticare,168 e al fatto che, al momento, mi pare
che il modello storicista sia quello prevalente negli studi letterari.169
Affrontare lo studio della letteratura araba, tuttavia, dovrebbe
portarci a considerare la teoria come uno scambio fra i testi teoretici e
l’opera letteraria piuttosto che applicare tout court la teoria a un testo,
poiché la teoria stessa è letteratura e noi stessi che la ricerchiamo siamo
narrazioni. 170
In tal senso, per affrontare lo studio della letteratura araba, credo
debbano essere tenuti presenti alcuni presupposti di base, che riprendo così
come definiti da Barbaba Biglia pur se in un altro contesto.171 Tra tali
assunti mi pare di dover considerare in particolare:
164 D. M. Varisco, Islam obscured: the Rethoric of Anthropological representation, Palgrave
McMillan, New York 2005.
165 Isabella Camera d’Afflitto, a cura di, Lo Yemen raccontato dalle scrittrici e dagli scrittori,
Editrice Orientalia, Roma 2010, in particolare l’Introduzione.
166 Ivi, p. 22.
167 Si veda anche I. Camera d’Afflitto, Cento anni di cultura palestinese, Carocci, Roma
2007.
168 Ellen Rooney, “Introduction” in idem, ed., The Cambridge Companion to Feminist
Literary Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 1.
169 Con modello storicista intendo il posizionare chiaramente il testo in un contesto storico, in
un ambito culturale o socio-politico che fornisce un orizzonte di interpretazione.
170 Barbara Johnson, The Critical Difference. Essay in the Contemporary Rethoric of Reading,
John Hopkins University Press, Baltimore and London 1985 si è occupata a fondo di questo
aspetto, in particolare in relazione al concetto di ri-lettura di un testo.
171 Barbara Biglia, Narrativas de mujeres, tesi di dottorato, Università di Barcellona, 2005,
100
a. un’esplicita intenzione della ricerca per il cambiamento sociale,
ovverosia la consapevolezza che la ricerca muove all’interno di un ambito
epistemolgico e pratico volto a contrastare gli abusi di potere e le
discriminazioni;
b. un’altrettanto esplicita ammissione della parzialità del proprio
punto di vista.172
c. di conseguenza, un’assunzione di responsabilità relativamente
agli usi che possono essere fatti dei risultati conseguiti dalla ricerca.
boo
oe
est
Qu
Per quanto attiene il primo di tali assunti, è indubbio che il mondo
arabo sia rappresentato in Italia all’interno di un discorso che vede la
produzione intellettuale legata a interessi economici nazionali e
internazionali.173 Tali interessi hanno portato l’Italia a firmare trattati
economici con alcuni paesi – come, a esempio, Egitto, Marocco e Tunisia –
e accordi che comprendono anche azioni di politica culturale. Ciò ha
condotto inevitabilmente a una maggior attenzione per questi paesi,
ponendoli al centro della ricerca letteraria – e non solo – per molti
decenni174 e influenzando al contempo il campo della traduzione dall’arabo.
Solo in tempi recenti175 si è assistito a uno spostamento verso zone altre del
mondo arabo – il volume citato Lo Yemen raccontato dalle scrittrici e dagli
scrittori176 ne è un esempio. Di conseguenza, l’immagine che viene
veicolata dalla letteratura studiata e tradotta sotto la generica e banalizzante
etichetta “letteratura araba” ha contribuito a definire una “memoria” del
campo letterario che non rende conto della complessità e della varietà; si è
costituito così una sorta di “monopolio della memoria”177 indotto da questi
studi che costituisce il riferimento principale per chiunque si occupi di
letteratura araba. Tale monopolio, che solo timidamente riesce in tempi
ppa
ka
per gentile concessione dell’autrice.
172 Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science question in Feminism and the
Privilege of Partial Perspective” in Feminist Studies, Vol. 14, No. 3, (Autumn 1988), pp 575599.
173 Gayatri Chakravorti Spivak, “Can the Subaltern Speak?” in Cary Nelson and L. Grossberg,
eds. Marxism and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press, Urbana and
Chicago, 1988, pp. 271-313.
174 R. Jacquemond, Conscience of the Nation. Writers, State, and Society in Modern Egypt,
(transl. by D. Tresilian), The American University in Cairo Press, Cairo New York 2008.
Jacquemond focalizza la sua ricerca in particolare sull’Egitto. La questione qui discussa è
affrontata nel testo in particolare nei capitoli 3 e 4, pp. 69-107.
175 Isabella Camera d’Afflitto, Cento anni di cultura palestinese, op. cit.
176 Cfr. Nota 18.
177 Mutuo l’espressione da A. Shatz, “A Love Story between an Arab Poet and his Land” in
Journal of Palestine Studies, Vol. 31, No. 3 (Spring, 2002), pp. 67-78, p. 71.
rtie
iuli
\nG
a
ne
ana
101
Ca
c
recenti a essere spezzato, non consente un approccio interdisciplinare e, di
conseguenza, non permette una lettura delle società arabe che fornisca
agentività agli attori, i quali vengono mantenuti in posizione subalterna: in
tal modo nello studio della letteratura araba “the Subalterne can not
speak”.178
Ciò detto, cosa significa fornire agentività? E a chi? Con
agentività, intendiamo l’autorità politica di effettuare un cambiamento sia
esso locale o temporale179 attraverso il proprio lavoro di ricerca e/o la
propria produzione narrativa. Naturalmente, fornire agentività agli autori
significa, per quanto sto affermando, che le traduttrici e i traduttori
dall’arabo dovrebbero tener conto di quella che Venuti chiama “the
ethnocentric violence of translation”.180 Essa si associa a una teoria della
scorrevolezza del testo tradotto e ha come conseguenza innanzitutto
l’invisibilità della traduttora/e, il cui scopo, in quest’ottica, sarà quello di
eliminare qualunque elemento che possa attirare l’attenzione sulla lingua o
il testo di partenza, “movimento storico verso l’uniformità della sillabazione
e della grammatica mediante un’ideologia che ha prediletto i passaggi
agevoli e privi di idiosincrasie, l’eliminazione delle asperità ecc.: vale a dire
qualsiasi cosa potesse concentrare l’attenzione sul linguaggio in sé”.181
Tradurre, così, risulta chiaramene marcato ideologicamente e si
rende dunque necessario valorizzare la lingua dell’altro182 concentrandosi su
quella che de Beaugrande chiama translatability, definita come “the
dialectical interaction between what should be required of translators and
what actually gets achieved”.183 In tale rapporto dialettico si instaura una
relazione fra lingua dominante e lingua periferica che vede le lingue
dominanti all’apice di una scala gerarchica e introduce il concetto di non
Que
sto
178 Gayatri Chakravorti Spivak, op. cit.
178 Nancy Armstrong, “What feminism did to novel studies” in Ellen Rooney, ed., The
Cambridge Companion to Feminist Literary Theory, Cambridge Uinversity Press, Cambridge
2006
179 Nancy Armstrong, ibid. p. 100. Per cambiamento locale o temporale intendo la possibilità
che, attraverso i propri studi – e in questo caso anche le proprie traduzioni – si possa
contribuire fattivamente al dibattito intellettuale sia nei paesi di origine degli autori che in
quelli di produzione di ricercatrici e ricercatori e traduttrici e traduttori in prospettiva
diacronica.
180 L. Venuti, L’invisibilità del traduttore, Armando, Roma 1992.
181 Bernstein in S. Faiq, S., Cultural Encounters in Translation from Arabic, Multilingual
Matters, Clavedon & New York 2004, p. 45.
182 R. De Beaugrande, “Geopolitics, Geolinguistics and Translatability” in ibi, pp. 5-18; A. K.
Halliday, Language in a Changing World, Australian Association for Applied Linguistics,
Sidney 1994.
183 R. De Beaugrande, op. cit., p. 11.
ebo
ok a
ppa
rtien
102
e a\
nGi
ulia
na C
acc
iapu
oti C
traducibilità di alcune lingue,184 forme letterarie (come la poesia) ed
espressioni delle lingue periferiche, gustificando in tal modo la presenza di
programmi inadeguati, traduzioni mal fatte e non riconoscimento del lavoro
del traduttore. A un livello più moderato questa stessa ideologia promuove
la traduzione da lingue periferiche posto che vengano modificate per
adeguarsi al linguaggio dominante per assomigliarvi.
La riflessione su questo aspetto e l’azione volta a rompere con
questo modo di intendere la traduzione porta a superare quella stagnazione
che Maḥmūd Darwīš ha evidenziato, richiamando alla necessità di far
evolvere il proprio pensiero per non fare “mera attualità”.185 È evidente che
tale proposta epistemologica non può non essere politica, e collettiva,
poiché ritengo che la conoscenza collettiva sia sempre superiore a quella
individuale e perché la “tecnica”, ossia il metodo tramite il quale studiamo
la letteratura, non è sufficiente: senza un quadro epistemologico preciso
(questo il senso, qui, della parola politica) l’esercizio della tecnica nel
leggere la letteratura araba non è critica.
In secondo luogo, ritengo necessario il superamento del concetto
di obiettività e il ripensamento di quello di scientificità della produzione
accademica. Pur consapevole di operare un movimento di “incursione” dalla
periferia verso il centro, non posso fare a meno di notare come
l’androcentrismo presente nell’estetica, nell’etica e nelle aree
dell’epistemologia e della metafisica non sia stato ancora, nell’ambito degli
studi di arabistica, sottoposto a una critica che ricollochi la problematica
della conoscenza.186 Credo sia pertanto necessario partire dal privilegio di
una prospettiva parziale. La posizione degli studi letterari come obiettiva è
stata criticata, a esempio, da Edward Said in Cultura e imperialismo187 e da
Gayatri Chakravorti Spivak;188 ciononostante queste opere non vengono
praticamente considerate nel campo degli studi di letteratura araba. Le
studiose femministe, inoltre, hanno criticato a fondo la presunta obiettività
della ricerca cosiddetta “scientifica” anche nel campo della ricerca
Qu
es
to
eb
oo
ka
184 L.-J. Calvet, Piccolo trattato di glottofagia, Mazzotta, Milano 1977.
185 A. Shatz, “A Love Story between an Arab Poet and his Land. An Interview with Mahmud
Darwish”, op. cit., p. 69.
186 Per quanto segue faccio riferimento, in particolare, a Linda Alcoff and Elizabeth Potter,
“Introduction: When Feminism intersects epistemology” in idem, Feminist Epistemologies,
Routledge, New York and London 1992, pp. 1-14 e Donna Haraway, Simians, Cyborgs and
Women: The Reinvention of Nature, Routledge, New York 1991, pp.149-181.
187 E. Said, Cultura e imperialismo, (trad. S. Chiarini e A. Tagliavini), Gamberetti, Roma
1998.
188 Gayatri Chakravorti Spivak, op. cit.
pp
ar
tie
ne
a\
nG
iul
103
ian
a
Ca
cc
iap
letteraria.189 Oltre, dunque, alla riflessione sul post coloniale e alla sua
relazione/opposizione con il post moderno, la crescente consapevolezza
delle implicazioni politiche nelle teorie della conoscenza ha portato a
chiedersi quale sia il punto di vista dal quale le teorie epistemologice di
riferimento in campo letterario partono. La risposta è che, lungi
dall’incarnare quell’obbiettività e quella scientificità che pretendono, a
dominare la teoria della conoscenza è, nella nostra comunità, un “gruppo di
maschi dominanti e che questo soggetto ha un punto di vista, una
prospettiva che coinvolge assunti e valori basati sul genere di attività in cui
tale gruppo è coinvolto”.190 Un’attenzione a questo aspetto è stata dedicata
da numerose autrici (e pochi autori in verità) anche nel mondo arabo e da
molto tempo, a cominciare dai saggi, poco studiati, di May Ziyāda191 per
finire con gli interventi contempornei di Aḥlām Mostaġānmī192 o Jumana
Haddad,193 Ġādāt as-Sammān194 e Hodà Barakāt:195 non si tratta qui di
letteratura femminile o di donne, ma di una critica dai toni spesso accesi in
relazione alle teorie della conoscenza e al processo di scrittura e, è tempo di
riconoscerlo, dell’offerta di un’alternativa al genere di romanzo che non fa
altro che riproporre modelli eteropatriarcali nei quali la narrativa diviene
una, se non la maggior causa, del confinamento dei generi a ruoli
precostituiti.196 La principale conseguenza di questa critica, che mi interessa
portare in evidenza, è la riconosciuta necessità di una “letteratura azione” –
e arriviamo con questo al terzo assunto sopra menzionato. La scelta di
numerose intellettuali arabe va, oggi, in questo senso: esse, infatti, si
discostano dalla produzione letteraria fine a se stessa e danno il via a
iniziative che vogliono incidere sulla società.
Esperienze come Nisyān.com di Mostaġānmī197 o Ğasad di
198
Haddad,
propongono un nuovo canone letterario che, pur essendo
to
s
ue
Q
189 Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Question in Feminism and the Privilege of
Partial Perspective”, op. cit.
190 Linda Alcott & Elizabeth Potter, op. cit., p. 6.
191 Mayy Ziyāda, Al-a‘māl al-mağhūla li-May Ziyāda, a cura di ß. Zaydān, Manšurāt almağma‘ aṯ-ṯaqāfī, Bayrūt 1996.
192 Aḥlām Mostaġānmī, www.nisyan.com (ultimo accesso 30.06.2012).
193 Jumana Haddad, Ho ucciso Shahrazad, (trad. di Ornella Capezio), Mondadori, Milano
2011.
194 Ġādāt as-Sammān, Kawābīs Bayrūt (Incubi di Beirut), Manšurāt Ġādāt as-Sammān,
Bayrūt 2000.
195 Hodà Barak, Ḥağar aḍ-ḍaḥk (La pietra del riso), Dār an-nahār, Bayrūt 2005.
196 Nancy Armstrong, op. cit., p. 107.
197 Aḥlām Mostaġānmī, Nisyān.com (Oblio.com), Dār al-adāb, Bayrūt 2009.
198 Ğasad è una rivista fondata da Jumana Haddad che così ne descrive le finalità:
“L’obbiettivo di Ğasad non è facilitare la masturbazione degli uomini, ma indagare con
104
p
p
ka
o
o
eb
en
ti
ar
periferico, si pone – ci pone – alcune domande che intaccano il canone
dominante: cosa significa essere un’autrice ribelle? Ha ancora senso restare
ai marigni della letteratura dominante ritenendola il punto di riferimento?
La risposta, credo, è che alla letteratura è assegnato il ruolo di
mettere a disagio il suo uditorio, di incrinare le sue certezze. L’anti autrice,
allora, opposta all’autrice interamente integrata nel campo letterario del
potere, dimostra che chi svolge questa funzione, nel mondo contemporaneo,
non è il saggio o il mistico, ma la scrittrice impegnata, visionaria, caustica e
penetrante.199
Si passa così inevitabilmente alla definizione di un nuovo canone
letterario, poiché la letteratura araba è intesa nella società di oggi come
verità e resistenza al campo del potere; essa, quindi, diventa azione. Non ha
più molto senso dunque, parlare ancora di “letteratura araba” ed è
necessario uscire da quella che considero una “etnografia letteraria”; sarà
necessario, d’ora in poi, parlare semplicemente di letteratura.
Occuparsi di letteratura richiede, pertanto, la stessa “ricerca
azione”, l’abbandono dell’archivio e della memoria letteraria. Conoscere la
bibliografia critica pregressa, come afferma Francesco Muzzioli, è utile,
«ma la sua autorevolezza e la sua legittimità non sono per niente scontate.
Non è detto che dobbiamo per forza accettarla senza accertarla».200 Fare
ricerca scientifica in letteratura significa, allora, contribuire agentivamente
alla formazione dell’immagine del mondo arabo e quindi il lavoro di ricerca
non può più essere limitato alla pubblicazione di “memorie”; significa
aprire gli archivi201 – reali e mentali – ossia quella “biblioteca di sapere
onnicomprensivo immaginato al di fuori dei confini dello stato e
dell’impero, sapere che si considera proprietà di un nemico”,202 e immettere
sapienza la coscienza del corpo e il suo inconscio”. In Jumana Haddad, Ho ucciso Sharazad,
op. cit., p. 72.
199 Riprendo quest’ultimo periodo dal mio “Letteratura-azione: Nisyān dot com di Aḥlām
Mostaġānmī”, in Marie-Christine Juillon-Clara Bulfoni-Virginia Sica, a cura di, Al di là dei
cliché. Rappresentazioni altre del femminile, Franco Angeli, Torino 2012, pp. 30-38. Il periodo
è ispirato da Alessandra Consolaro, Resistance in today’s Hindi world: Mohandās by Uday
Prakāśk (paper presentato al 21° ECMSAS, Bonn, 26-29 luglio 2010) manoscritto concesso
dall'autrice.
200 F. Muzzioli, Comparare la critica, free download www.disp.let.uniroma1.it (ultimo
accesso 24.04.2011), p. 3.
201 Per il ruolo dell’archivio nella formazione di un’idea di letteratura e per come questo modo
di intenderlo influenza ancora oggi la produzione letteraria dei paesi ex-colonie si veda T.
Richards, The Imperial Archive. Knowledge and the fantasy of Empire, Verso, London & New
York 1993, in particolare il Capitolo 4, pp. 111-152. Ringrazio Paolo D’Urbano, SOAS,
London, per avermi segnalato il volume.
202 Ibi, p. 111.
105
Q
ue
s
nel campo intellettuale un modo di studiare la letteratura che la considera
parte integrante della società, significa considerare la letteratura come un
mezzo attraverso il quale il potere opera attraverso la lingua e la cultura
letteraria per modellare significati, valori, soggettività e identità. Un
approccio che potrà essere solo interdisciplinare,203 poiché coinvolge testi di
fiction accanto ad altri testi, forme e pratiche in relazione a sviluppi socio
economici più ampi.204
«In altri periodi, compreso l’attuale, la critica tende a
presentarsi come un fatto neutro e naturale, come un ruolo più
che non come un punto di vista e in tal caso pretende il
consenso di tutti in virtù del suo prestigio e della sua
competenza; e può accadere che il discorso sul testo non
presenti, in apparenza altro che l’intenzione di una semplice
spiegazione o di un giudizio di gusto, magari ristretto al
singolo oggetto in esame. [...] eppure questo atteggiamento
“morbido” nasconde tutta una serie di scelte non di poco
conto (il solo fatto di occuparsi di un libro è una decisione che
comporta una coscienziosa selezione)»205.
ana Cacc
ebook
a
p
p
a
rt
ie
n
e
a\nGiuli
Così, Muzzioli introduce allo studio della critica letteraria.
Conoscere “come” è da sempre posto in condizione subalterna rispetto a
conoscere “cosa” e ciò crea una gerarchia di conoscenze che riproduce le
gerarchie mente/corpo e intellettuale/manuale. Lo scopo di una teoria della
conoscenza, al contrario, non dovrebbe essere solo quello di soddisfare la
curiosità intellettuale, ma anche quello di contribuire a un obbiettivo
emancipatorio: «la diffusione di democrazia nella produzione di
conoscenza»206.
In questo, l’Accademia gioca un ruolo fondamentale, e non è più
pensabile che gli “arabisti” rimangano, per usare le parole di Maxime
Rodinson, nella loro “gabbia dorata”.207 Una maggior conoscenza dei
meccanismi che governano il mondo intellettuale non dovrebbe avere come
Questo
203 J. Clifford, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del XX secolo, Bollati Boringhieri,
Torino 1999 e idem, Ai margini dell’antropologia, Meltemi, Roma 2004, in particolare il
capitolo 3; Clifford è stato il primo a intersecare gli studi di letteratura con quelli di
antropologia. Si veda anche A. McClintock, op. cit.
204 Cfr. Chris Weedon, “Postcolonial feminist criticism” in Gill Plain & Susan Sellers, eds., A
History of Literary Criticism, Cambridge University Press, Cambridge 2007, pp. 282-300.
205 F. Muzzioli, Comparare la critica, op. cit.
206 Linda Alcott & Elizabeth Potter, op. cit., p. 13.
207 M. Rodinson, Il fascino dell’Islam, Dedalo, Bari 1988, p. 144.
106
effetto far sì che lo studioso si scarichi di una reponsabilità morale ma, al
contrario, dovrebbe insegnargli a “combattere in se stesso e negli altri
l’indifferentismo opportunista o l’abusato conformismo che accorda al
mondo sociale quel che domanda, tutti i piccoli nulla della compiacenza
rassegnata e della complicità sottomessa”.208 In tale contesto, particolare
attenzione verrà anche data al linguaggio utilizzato nella ricerca che,
anziché essere criptico ed escludente, sarà chiaro senza essere per questo
meno incisivo.
In definitiva, quindi, lo studio della letteratura deve uscire dalla
logica che vuole qualunque cosa fonte di appropriazione, nella quale un
oggetto di conoscenza è solo questione di potere. Quello che mi auguro, in
definitiva, è che chi si occupa di letteratura araba non sia più “haunted” dai
fantasmi dell’immagine che ho proposto all’inizio quando legge un
romanzo tradotto in lingua italiana o un saggio sulla letteratura araba.
Concludo con le parole di Sara AbuGhazal, intellettuale libanese:
«Sono ossessionata dalla conoscenza. Me ne rendo conto ogni
volta che parlo. A volte preferei non partecipare per niente agli
incontri, e mandare un messaggio registrato che le persone
potrebbero mandare in onda se volessero sentire quello che ho
da dire. In esso si direbbe che abbiamo bisogno di produrre
conoscenza e so che non è facile e che è ben lontano
dall’immagine della femminista radicale che con un martello
colpisce il patriarcato, non incoraggia a scendere in piazza e
cantare. Voglio dire, cosa grideremmo? “Produci conoscenza
adesso!”? Sarebbe noioso e facilmente accusabile di elitismo.
La conoscenza è stata dirottata dall’élite e io (tu) la reclamo
perché (io) tu vieni dai margini, dal meno privilegiato, dal
fondo della piramide socioeconomica. Voglio produrre
conoscenza perché è così che sopravvivo [corsivo mio].
Io (e te) siamo solo agenti e continuiamo e completiamo la
conoscenza fino a che essa non sarà completamente esposta e
compresa. Il mio (tuo) senso di ingiustizia non è diverso dal
sentimento di privilegio che gli attori del patriarcato provano e
continuano a riprodurre in diverse forme di ideologia e tragedie
per non perderlo. Voglio produrre conoscenza, “come può
questa conoscenza renderci liberi?»209.
Qu
es
to
eb
oo
ka
pp
ar
tie
ne
a\n
Gi
208 P. Bourdieu, Homo Academicus, Les Editions de Minuit, Paris 1984, p. 15.
209 Sara AbuGhazal “Audre Lodre quote mining and rambles from an editor in despair” in
http://www.sawtalniswa.com (post del 23.03.2011; ultimo accesso 21.04.2011).
107
uli
an
aC
ac
Bibliografia
Alcoff Linda and Potter Elizabeth, (eds)., Feminist Epistemologies,
Routledge, New York and London 1992.
Bourdieu P., Homo Academicus, Les Editions de Minuit, Paris 1984.
Camera d’Afflitto Isabella, a cura di, Lo Yemen raccontato dalle
scrittrici e dagli scrittori, Editrice Orientalia, Roma 2010.
Derrida J., Archive Fever: A Freudian Impression, University of
Chicago Press, Chicago and London 1995.
Haraway Donna, “Situated Knowledges: The Science question in
Feminism and the Privilege of Partial Perspective” in Feminist
Studies, Vol. 14, No. 3, (Autumn 1988), pp 575-599.
Jacquemond R., Conscience of the Nation. Writers, State, and
Society in Modern Egypt, (transl. by D. Tresilian), The American
University in Cairo Press, Cairo New York 2008.
Kaplan Elizabeth, “Many Paths to Partial Truths’: Archives,
Anthropology, and the Power of Representation” in Archival
Science, 2: 2002, pp. 209-220.
McClintock Anne, Imperial Leather, Routledge, London & New
York.
Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma
del pensiero, Raffaello Cortina, Milano 2000.
Muzzioli F., Comparare la critica, free download
Que
www.disp.let.uniroma1.it (ultimo accesso 24.04.2011).
sto e
book
Richards T., The Imperial Archive. Knowledge and the fantasy of
appa
108
rtien
e a\n
Giul
iana
Cac
cia
Empire, Verso, London & New York 1993.
Rooney Ellen (ed)., The Cambridge Companion to Feminist Literary
Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
Tuhiwai Smith Linda, Decolonizing Methodologies: Research and
Indigenous People, Zed books, London 2012.
Varisco D. M., Islam obscured: the Rethoric of Anthropological
representation, Palgrave McMillan, New York 2005
Ziyāda Mayy, Al-a‘māl al-mağhūla li-May Ziyāda, a cura di ß.
Zaydān, Manšurāt al-mağma‘ aṯ-ṯaqāfī, Bayrūt 1996.
Q
u
est
o
e
bo
pp
ok
a
n
art
ie
G
ea
\n
109
MEMORIA E IDENTITÀ NELLA LETTERATURA “ISPANOMAROCCHINA” E NELLA LETTERATURA SAHARAUI IN LINGUA
SPAGNOLA
Selena Nobile
Selena Nobile
Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università
degli Studi di Lecce (2003). Dottorato di Ricerca in Studi Letterari
Linguistici e Culturali (Università del Salento 2008). Titolo della tesi: La
Literatura Hispano-marroquí. Un modelo mediterráneo posorientalista y
posoccidentalista). Ha realizzato studi sulla letteratura bilbaina di
espressione spagnola, su César Vallejo e Oswald de Andrade, sulle
letterature africane di espressione spagnola (Guinea Equatoriale, Marocco,
Sahara Occidentale e Camerun) e sulle letterature della migrazione in
Spagna e in Italia, in particolare sulle scritture femminili della migrazione.
Attualmente insegna letteratura spagnola presso l’Università del Salento e
presso l’Università della Basilicata.
Abstract
Con il presente studio mi propongo di analizzare il tema della
memoria e della costruzione dell’identità nella letteratura ispanomarocchina e nella letteratura saharaui in lingua spagnola. In particolare,
mi concentrerò sulla questione della lingua, per mettere in evidenza come
la lingua spagnola, che è stata lingua coloniale in Marocco e nel Sahara
Occidentale, entra oggi nella costruzione identitaria nel Sahara come
lingua di lotta e resistenza, nel rivendicare uno spazio identitario e nel
riscatto della memoria; e in Marocco come lingua che esprime il
polimorfismo
identitario
attraverso
un’apertura
verso
una
“transculturazione” mediterranea.
The present study sets out to investigate memory and identity
construction in the Hispano-Moroccan and in the saharaui literatures, both
written in Spanish. More particularly, this study focuses on the key role
played by Spanish, which has been a colonial language in Morocco and in
Western Sahara. In Sahara, Spanish represents a language of fight and
resistance in the identity construction as well as in the vindication of an
identity space and in the memory redemption. In Morocco, Spanish
110
Que
sto e
boo
k ap
part
ien
0030
3969
11
sto e
book
appa
rtien
e
a\nG
iulian
a Ca
cciap
uoti
CLI_
2013
expresses the identity polymorphism through an opening towards a
Mediterranean “transculturation”.
Negli ultimi anni abbiamo assistito all’ “emergenza” (Guillén)
delle letterature africane d’espressione spagnola e a quelle della diaspora o
della migrazione africana in Spagna, letterature che in varie occasioni,
parafrasando Deleuze e Guattari, ho definito letterature minori. Ho
utilizzato questa definizione per mettere in evidenza il loro sguardo
alternativo, altro, che svela le contraddizioni del discorso monologico
imperante “occidentalista”, contribuendo a decostruire anche quel modello
critico, sia di stampo anglosassone che di stampo francofono, fondato su
una dialettica oppositiva che è stata utilizzata per analizzare quelle
manifestazioni culturali provenienti dai “margini del mondo”. Un modello
universalizzante ed unidirezionale che ha trovato la sua giustificazione
nell’interazione binaria tra centro/periferia, identità/alterità, letteratura
nazionale/letteratura postcoloniale e che, a mio avviso, per certi versi,
continua a riproporre una relazione egemonica ed eurocentrica proprio
perchè da un lato difende la sopravvivenza del concetto di letteratura
nazionale nel momento in cui vengono analizzate le letterature europee e
dall’altro riduce tutto ciò che viene elaborato nel resto del mondo, ed in
particolar modo in Africa, alla categoria di postcoloniale, periferico, come
se fosse un unico mondo indifferenziato e subalterno all’occidente.
Al contrario, credo che queste scritture non possano uniformarsi
a questa dialettica, anzi, contribuiscono, in modo determinante, ad elaborare
un modello di analisi dinamico, poroso, interstiziale che scivola e si
sovrappone dal centro alla periferia, dall’identità all’alterità, e che, per
tanto, si situa in uno spazio frontaliero, di contaminazione nel quale non
esiste una relazione unidirezionale ma di osmosi reciproca e paritaria, e
possono stimolare, pertanto, la critica a rivedere quelle categorie troppo
rigide e date per universali ed immutabili.
In questo mio intervento, pur sottolinenado il fatto che in vari
paesi africani, negli ultimi anni, si è assistito alla pubblicazione di opere
redatte in lingua spagnola, anche in paesi che non hanno subito il
colonialismo spagnolo come nel caso del Camerun e della Tunisia,
analizzerò la poesia saharaui in lingua spagnola, in particolar modo mi
occuperò dei poeti de La Generación de la Amistad210 e, alcuni degli
Que
210 Con questa definizione si indica un gruppo di poeti e scrittori che hanno condiviso una
tappa della loro formazione culturale nel Sahara ma anche a Cuba e che hanno deciso di
collaborare per promuovere la causa del popolo saharaui. La scelta di questa “etichetta” non è
casuale ma si rifà agli intelettuali spagnoli de La Generación del 27 o detti anche Generación
de la Amistad. Fecero parte di questo gruppo poeti e scrittori come Lorca. Alberti, Cernuda,
111
Questo ebook appartie
ne a\nGiuliana Cacciap
uoti CLI_2
scrittori più rappresentativi della letteratura ispano-marocchina come
Mohamed Lahchiri, Ahmed Ararou e Larbi El Harti. Cercherò di porre
l’accento su alcuni di quegli elementi che, a mio avviso, dimostrano
l’alternatività di queste letterature, il loro essere minori attraverso la
relazione che questi autori stanno stabilendo con la lingua spagnola. La
scelta di elaborare uno studio comparato tra queste due realtà nasce dalla
necessità, a mio avviso, di far incontare questi mondi almeno dal punto di
vista culturale, data la complessità delle loro relazioni politiche e
diplomatiche legate al conflitto per l’autodeterminazione della RASD.
Difatti, sia in Marocco, che nel Sahara Occidentale, lo spagnolo è
stata lingua coloniale, in entrambi i casi però, se analizziamo con attenzione
le opere letterarie redatte in questa lingua, a differenza di altre letterature
africane scritte nelle lingue europee, manca quella dimensione della
lacerazione, della frammentazione dell’io, della perdita dell’identità all’atto
di scegliere la lingua imposta, la lingua della metropoli come lingua
dell’espressione letteraria. Dimensione che invece viene considerata come
paradigma delle letterature africane, punto di partenza e di arrivo all’atto di
classificarle come letterature postcoloniali. Allo stesso tempo è assente la
violazione della norma sancito dall’accademia, di fatto, la lingua spagnola
non subisce grandi fenomeni di “africanizzazione” così come è avvenuto in
ambito anglofono, francofono e lusofono. In linea di massima la sintassi
non viene alterata, non ne viene celebrato l’errore come atto costitutivo
dell’approriazione della lingua come ‘bottino di guerra’ (Kateb Yasín). Si
assiste quasi esclusivamente all’utilizzo di termini provenienti dall’hasania,
dalla dariya, dall’arabo moderno e il francese che vengono ‘agglutinati’
nella lingua spagnola. (Elemento quest’ultimo molto evidente soprattutto
nella poesia saharaui dato che molti termini in hasania diventano parte
integrante del componimento poetico). Anche per queste peculiarità, queste
letterature svelano i limiti della critica ‘postcoloniale’. Di fatto,
parafrasando Mbare Ngom, si può affermare che queste letterature hanno
seguito e seguono una traiettoria completamente differente rispetto alle altre
letterature africane, visto che è anche assente o quasi la dimesione
anticoloniale che ha caratterizzato ad esempio le letterature della
negritudine211. Assenza dovuta anche al fatto che queste letterature sono
‘emerse’ tempo dopo la fine del colonialismo e l’urgenza di scrivere è
legata pertanto ad altre situazioni contingenti che non sempre sono
direttamente connesse con la memoria coloniale.
Salinas, Dámaso Alonso etc.
211Mbare, MGOM, “Introducción” in Literatura de Guinea Ecuatorial, Ed. de Mbare,
MGOM, Donato NDONGO-BIDYOGO, Casa de África, Madrid, 2000.p.p. 11-29. p 18.
112
o
es
t
u
Q
Per quanto riguarda il Sahara Occidentale la scelta della lingua
spagnola non è riducibile esclusivamente all’esperienza coloniale, pur
essendosi questa protratta per circa un secolo, fino al 1975. In accordo con
Coriolano Pereira Rocha Júnior e con Juan Carlos Gimeno Martín infatti è
possibile affermare che molti giovani saharaui conoscono lo spagnolo, non
tanto per l’effetto coloniale, ma per altri processi posteriori, anche se alcuni
di questi sono legati all’antica relazione coloniale212. Per molti di loro la
lingua di Cervantes è la lingua della cultura, la lingua nella quale hanno
potuto studiare per poi potersi dedicare alla causa dell’autodeterminazione
del popolo saharaui. Bisogna considerare il fatto che molti di loro come Ali
Salem Iselmu, Bahia Mahmud Awah, Chejdan Mahmud, Limam Boicha,
Luali Lehsan, Mohamed Salem Abdelfatah Ebnu Saleh Abdalahi, infatti
hanno studiato a Cuba. Pertanto, «el desarrollo del español se ha dado con
más fuerza, producto de la solidaridad revolucionaria más que de la relación
colonial»213.
Non è una casualità che, per esempio, Limam Boicha nella sua
poesía “Poligamia” utilizzi la metafora della poligamia per affermare il suo
sentirsi parte di tre mondi Cuba, il Sahara e le Canarie (metonimia della
Spagna) accomunati dalla stessa lingua:
eb
oo
k
a
r
pp
a
e
tie
n
a\
iu
nG
lia
na
«Yo soy un hombre
que practica la poligamia,
y cuento con una ventaja:
mi religión me lo permite.
Ca
c
c
ia
ti
pu
o
Eso es todo,
y lo confieso en alta voz,
al amigo y al desconocido,
9
39
6
0
00
3
3
2
0
1
_
CL
I
Tengo tres…
tres amantes…
y a las tres las quiero por igual.
212Juan, GIMENO; Coriolano, ROCHA, “Memorias orales en el Sáhara Occidental: la poesía
en hasanía”. In 7º Congresso Ibérico de Estudos Africanos, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos das
independências africanas: desafios para a modernidade: actas. Lisboa: CEA, 2010. [Consult.
Maggio 2010]. Disponíibile in: http://hdl.handle.net/10071/2418. p.3
213Juan, GIMENO; Coriolano, ROCHA, “Memorias orales en el Sáhara Occidental: la poesía
en hasanía”. Cit., p. 4.
A partire da questo momento tutte le traduzioni dallo spagnolo sono mie. L’evoluzione dello
spagnolo è il risultato più della solidarietà rivoluzionaria che delle relazioni coloniali.
113
al vecino,
con su expresión devota,
y a Ella, mi querida aurora.
sto
Que
Tengo tres…
tres amantes:
Sahara, Cuba y Canarias;
y a las tres
las quiero por igual».214
Giu
114
a\n
214 Limam, BOICHA. “Poligamia” in Los versos de la madera, Puentepalo, Las Palmas de
Gran Canaria, 2004. pp 49-50.
215Mohamed, SALEM Abdelfatah, Ebnu, “Cubana” in Voz de fuego, Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, 2003. p. 91. «Mentre mi dileguo/sotto le ali bianche/di una zanzariera
di palma/Pronto per morire tra/l’umidità delle tue cosce di primaverili».
ne
«Bajo la promesa del calor
desapareció la lluvia,
los colores son enigmáticos
y la nueva ciudad es una basta colina,
algunas palabras suenan lejanas
y el olor de la fruta es un espejismo.
La familia reunida alrededor del té
conversa de forma espontánea
y el horizonte desaparece en el cielo.
El turbante, el siroco,
la lógica del desierto
rtie
Ali Salem Iselmu nella poesia “Reconciliación” propone invece
una ibridazione dell’identità tra il mondo beduino del Sahara e il Caribe
definendosi beduino e caribeño allo stesso tempo:
ppa
ok a
ebo
Anche Mohamed Salem Abdelfatah Ebnu nella sua poesia
“Cubana” celebra Cuba trasfigurata come una donna nella quale immergersi
e forse perdersi per sempre:
«........…
Mientras me evaporo
Bajo las alas blancas
De un mosquitero de yagua,
Listo para morir entre
La humedad de tus muslos de primavera»215.
o
eb
o
p
ka
p
tie
r
a
Q
sto
e
u
impone la naturaleza de las cosas.
El sabor de la leche es extraño
y cada paso persigue una nueva huella
en una ruta infinita;
ser beduino y caribeño
se lleva dentro del alma».216
Si può affermare, pertanto, che lo spagnolo permette a questi
poeti di stabilire un ponte culturale con il mondo latinoamericano
simbolizzato da José Martí nel poema “El caimán barbudo” di Bahia
Mahmud Awah, quel ponte che Paul Gilroy definirebbe The Black Atlantic
e che ricongiungerebbe l’Africa all’Europa (in particolar modo la Spagna)
attraverso l’America visti anche i continui rimandi e le continue
sovrapposizioni che si possono rintracciare negli omaggi a Lorca, Cernuda,
la Generación del 27 e a Valle Inclán, e in particolar modo a Max Estrella il
protagonista della sua Luces de Bohemia, come nel caso del poema
“Utopía” di Zahra Hasnaui:
«De Chile
Max Estrella,
el gallego parisino,
De Colombia
las palabras asombradas,
De Perú
la música de Calle,
De Guatemala
las soluciones esperadas,
De África,
los cubanos llegaron.
Se juntaron
son, salsa,
jaima, jarana.
Sin banderas,
quedó la isla de Kilburn.
Solté amarras,
quemé las barcas
quemé los remos217.
216Ali SALEM ISELMU “Reconciliación” in Bahia, Mahmud, AWAH, Literatura del Sahara
Occidental, breve estudio. p. 39.
115
Que
Allo stesso modo però, lo spagnolo è con parole di Ali Salem
Iselmi «una identidad para los saharaui en una región con tendencia
francófona»218. È quell’elemento che afferma l’identità collettiva di un
popolo che grida a gran voce e denuncia la sua condizione di subalternità e
di minorizzazione e la differenzia: «No es sentido como una imposición,
sino como un legado diferenciador con respeto a Marruecos y motor de
acercamiento a otros pueblos entre otros los de Latinoamérica»219. In questo
senso questa poesia si fa minore nella definizione di Deleuze e Guattari
soprattutto per quello che definiscono «l’innesto dell’individuale
sull’inmediato politico»220. L’esperienza del singolo si fa esperienza di un
popolo tutto e diventa l’allegoria stessa di un popolo che resiste. Lo
spagnolo diventa quindi lo strumento attraverso il quale è possibile
internazionalizzare la questione del popolo saharaui. La definirei, quindi,
come la lingua della resistenza e in un certo senso, queste poesie, svolgono
il ruolo che a suo tempo svolse la letteratura aljamiado-morisca, ovvero di
resistenza e di difesa della propria identità collettiva, di riscatto della
memoria e di rifiuto dell’omologazione, così come si può vedere in Bahia
Mahmud Awah nel suo poema “Mi razón de ser”:
«Alguien, tal vez confundido,
me preguntó,
Eres…
Y le dije que William Shakespeare,
encontró su razón de poeta
y dramaturgo, en ser inglés.
217Zahra, HASNAUI, “Utopía” in:
http://www.generacionamistadsaharaui.com/poesia/zahra_hasnaui.htm#Utopia.
«Dal Cile/Max Estrella,/il galiziano parigino,/Dalla Colombia/le parole meravigliate,/Dal
Perù/la musica della Strada,/Dal Guatemala/le soluzioni sperate,/Dall’Africa/i cubani
arrivarono./Si unirono/sono, salsa,/tenda,/jarana./Senza bandiere,/rimase l’isola di
Kilburn./tolsi gli ormeggi,/bruciai le barche/bruciai i remi».
218Bahia, Mahmud, AWAH; Conchi, MOYA, El porvenir del español en el Sahara
Occidental, Bubok Publishing S.L., 2010. p.80: «Un’identità per i saharaui in una regione con
tendenze francofone».
219Bahia, Mahmud, AWAH; Conchi, MOYA, op.cit., p 4: «Non è sentito come
un’imposizione, ma come un elemento di differenziazione rispetto al Marocco, ed è sentito
come un motore di avvicinamento ad altri popoli tra i quali quelli latinoamericani».
220 Gilles, DELEUZE, Félix, GUATTARI, Kafka. Per una letteratura minore, Quodlibet,
Macerata, 1996. p.33.
116
Mientras que yo sigo simplificando
esa razón con los que intentan
situarme a la deriva,
y convertirme de ser en no ser.
Entonces nunca será una razón
diluirme en sangre de besamanos,
o transformarme en creyente
que reza God save the King.
Y se lo digo en la lengua
de Byron y de Shakespeare,
To be or not to be, that is the question,
I’m not Moroccan,
sorry, esta es mi razón de ser, saharaui»221.
È una letteratura che denuncia per far conoscere, per chiedere
giustizia e per farsi ascoltare, e come tale è una letteratura corale, collettiva.
Difatto, è una poesia che dialoga e si completa con la poesia in hasania
poichè rievoca gli stessi spazi geografici come il Tiris costantemente
celebrato da tutti i poeti saharaui. È interessante notare come quasi tutti i
poeti abbiano dedicato un poema a questa regione del Sahara Occidentale.
La loro è in buona parte la poesia dell’esule che canta la propria terra, la
anela, la sogna e la idealizza, ricordandone le bellezze per salvaguardarne la
memoria e il ricordo. E attraverso il ricordo individuale riscattare la
memoria collettiva proponendo quella contaminazione lingüística a cui ho
fatto cenno precedentemente e che vede la costante presenza di parole come
saguia, lehbalia, timish, Leglat, Galb, Badia, jadra etc… che diventano un
unicum con la lingua castigliana.
Nel caso del Marocco, lo spagnolo è stata lingua coloniale fino al
1956, anche se il legame celebrato dagli autori va oltre l’epoca coloniale, la
trascende e prescinde da essa, anche per loro rappresenta un legame
221 Bahia, Mahmud, AWAH, “Mi razón de ser” in Literatura del Sahara Occidental, breve
estudio. p.40.: «Qualcuno, forse confuso,/mi chiese,/Sei…/E dissi che William Shakespeare,
trovò la sua ragione di poeta e/drammaturgo, nell’essere inglese./Mentre io continuo a
semplificare/questa ragione con coloro che cercano/di situarmi alla deriva,/e trasformarmi da
essere in un non essere./Quindi mai sarà una ragione/diluirmi in sangue di baciamani,/o
trasformarmi in credente/che prega God save the King./E glielo dico nella lingua di Byron e di
Shakespeare,/To be or not to be, that is the question,/I’m not Moroccan/sorry, questa è la mia
ragione di essere, saharaui».
117
Qu
to
es
Qu
culturale un legado andalusí che per alcuni autori potrebbe perfino definirsi
neo-morisco come nel caso di Mohamed Chakor e in parte per
Abderrahman El Fathi. Il loro però è un legame individuale, idiosincratico
che si concretizza nella scelta personale della lingua spagnola come lingua
di espressione letteraria, una scelta che non innesca un meccanismo di
collettivizzazione come nel caso dei saharaui. Ma è il punto di partenza di
un individuo che superando i suoi conflitti interiori sceglie la lingua di
Cervantes per aprirsi ai mondi ispanici e da lì alla letteratura dei mondi, in
un processo di constante transculturazione che definisco mediterranea. La
scelta dello spagnolo per gli scrittori ispano-marocchini si allontana,
pertanto, da tutte le costruzioni legate ai Postcolonial Studies, poichè si
muove innanzi tutto in uno spazio sociolinguistico molto complesso in cui è
molto difficile distinguere tra lingua materna, autoctona, nazionale,
referenziale e lingua coloniale, desterritorializzata etc. per parafrasare
Gobbard e il suo modello tetralinguistico (Deleuze; Guattari).
Difatto, in Marocco convivono in posizione diglossica varie
lingue: l’arabo, il tamazight, il francese, lo spagnolo e la haquitía (lingua
quest’ultima che oramai sta scomparendo). Quando parliamo di arabo, però
è necessario decostruire la sua immagine monolitica tenendo conto di tutte
le varianti che convivono nel paese dalla fusha (arabo classico), all’arabo
moderno, alla dariya o arabo marocchino. Delle tre varianti dell’arabo solo
la dariya potrebbe considerarsi lingua autoctona e materna assime al
tamazight e potrebbe essere lingua referenziale in accordo con Gobbard. Sia
la dariya che il tamazight però non hanno una tradizione scritta per cui
esiste uno sfasamento tra le lingue letterarie e quelle orali, l’arabo moderno
e la fusha potrebbero, di fatto, mancare di referenzialità come viene
sottolineato da Mohamed Lahchiri nel suo racconto “Moras Pisoteadas”. In
quest’opera l’autore descrive le ragioni della scelta individuale dello
spagnolo come lingua letteraria. Racconta infatti di un bambino originario
di Ceuta che negli anni sessanta viene inviato a studiare a Chauen. Il
Marocco di quegli anni aveva da poco ottenuto l’indipendenza e sembrava
offrire molte possibilità ai ragazzini poveri di Ceuta. Giunto a Chauen però
il bambino scopre di non conoscere l’arabo classico, vuole scrivere una
lettera ai suoi genitori per raccontare loro di come si mangi bene nel
collegio dove si trova, ma non sa come si dica “plato”222 in fusha, pertanto:
«puso el nombre con que era llamado el recipiente en árabe hablado en
Ceuta y en Marruecos –pensó que era la misma palabra para el árabe escrito
ka
oo
eb
e
en
118
ti
ar
pp
222 Mohamed, LAHCHIRI, “Moras Pisoteadas” in Una tumbita en Sidi Embarek y otros
cuentos ceutíes, Imprenta Dar al-Karaouines, Casablanca, 2006. p. 132: “piatto”.
y el hablado en Marruecos-: tabsil, plural: tabasil»223. Quando i suoi
compagni scoprono l’errore si prendono gioco di lui così che il bambino:
«Romp[e] la carta y escrib[e] a su familia en español, en letra muy clara,
para que sus hermanas pudieran leerla y traducirla a su madre»224.
Tra l’arabo classico e moderno del quale non conosce alcune
parole legate alla referenzialità, alla quotidianità e lo spagnolo sceglie il
secondo perchè lo sente che gli appartiene, e perchè in questo modo
affranca la propria libertà prendendo le distanze da un padre che non lo
ama.
Anche Larbi El Harti e Ahmed Ararou, nei racconti
rispettivamente “La alienada”, “La compañera infalible” e “La resaca” si
sono confrontati con la scelta personale, identitaria, della lingua spagnola
come lingua di espressione letteraria.
“La alienada” e “La compañera infalible” sono due autobiografie
romanzate e complementari che hanno come tema di fondo il rapporto che
l’autore ha con le lingue del Marocco e con la loro referenzialità. Nel primo
El Harti descrive la condizione di alienazione vista come impossibilità di
comunicare con gli altri nella quale si trova la sua lingua madre, una lingua
popolare e sentimentale metafora stessa della sua identità. Questa lingua che
potrebbe essere sia la dariya che il tamazight, subisce una doppia
alienazione una rispetto al mondo occidentale e l’altra rispetto al mondo
arabo: «Tenías razón. Je suis aliéné»225. Questa alienazione dovuta anche ad
una condizione di egemonia esercitata da parte delle lingue dell’occidente e
dall’arabo classico o comunque l’arabo parlato nel Máshreq produce una
forma di schizzofrenia molto simile a quella descritta da Fanon ne I dannati
della terra e ne Il negro e l’altro:
Qu
est
«Lo soy [esquizofrénico] porque mi lengua- esa que tu desprecias
porque la hablan les domestiques, le jardinier et le chauffeur; esa que
sólo te sale para cagarte en la puta madre que parió a tanta fealdad. Esa
lengua nuestra, digo, la lengua del barro, de los juegos y de la tibieza del
miedo de los interminables cuentos de abuelas eternas, fue corroída,
223 Mohamed, LAHCHIRI, “Moras Pisoteadas”. Cit., p.132: «Utilizzò il nome con il quale era
chiamato il recipiente nell’arabo dialettale di Ceuta e del Marocco-pensò che fosse la stessa
parola sia nell’arabo scritto che in quello parlato in Marocco-:tabsil, plurale tabasil».
224 Mohamed, LAHCHIRI, “Moras Pisoteadas”, cit., p.132: «Strappa la lettera e scrive alla
sua famiglia in spagnolo, con lettere molto chiare, affichè le sue sorelle possano leggerla e
tradurla a sua madre».
225Larbi, EL HARTI, “La alienada” in La puerta de los vientos. Narradores marroquíes
contemporáneos, Destino, Barcelona, 2004. pp. 89-104. p.89: «Hai ragione. Je suis aliéné».
119
oe
bo
ok
s
e
Qu
atormentada, minimizada aquella mañana frente al bigotito redentor de
ignorancias descarriadas, tallado desde arriba por el bigote superior del
pequeño todopoderoso Generalísimo226».
Per sopravvivere a questa condizione di alienazione e di
silenziazione imposta l’autore cerca di identificarsi e di assimilarsi all’altro,
all’uomo occidentale: «Tenía que ser otro. No había otra salida»227, decide
di indossare quindi una “maschera bianca”, e inizia un viaggio verso la
Francia, l’Inghilterra e la Spagna. Ben presto però scopre di essere agli
occhi dell’Europa sempre l’altro e lo scopre metaforicamente quando inizia
la guerra in Iraq nel 2003:
«una fabulosa guerra que enfrentó la humanidad entera al ejército más
peligroso del mundo, que a los dos días de enfrentamiento, demostró
poseer grandes cualidades para la desbanda (96). [En ese momento] el
día en que el mundo entero atacó a Irak en defensa de la libertad de los
pueblos. Súbitamente, dejé de ser uno de ellos. Mi amistad cayó en
desgracia. Rápidamente, me deshicieron de mi individualidad y me
convertí en vosotros. Me lo decían a mí, que había nutrido mis
creencias en la utopía del nosotros» 228.
Nonostante i suoi innumerevoli sforzi sarà sempre l’altro, il
diverso: «Las armas de mis amigos eran contundentes. Nunca había visto
tantos argumentos, ni tanta pasión lógica»229. L’unica via d’uscita che gli
rimane è quella, pertanto, di assimilarsi al mondo arabo e alla sua lingua:
226Larbi, EL HARTI, “La alienada”. cit., pp. 92-93. «Sono [schizofrenico] perché la mia
lingua-quella che tu disprezzi perché la parlano les domestiques, Le Jardinier et le chauffeur,
quella che solo ti viene fuori per maledire la fottuta madre che creò tanta bruttezza. Questa
nostra lingua, dico, la lingua del fango, dei giochi e della tiepida paura dei racconti
interminabili delle nonne eterne, venne corrotta, tormentata, minorizzata quella mattina
dinnanzi ai baffi redentori di ignoranze ribelli, intagliati dall’alto dal baffo superiore del
piccolo onnipotente Generalissimo».
227 Larbi, EL HARTI, “La alienada”. Cit., p 94. «Dovevo essere un altro. Non c’era altra via
d’uscita».
228 Larbi, EL HARTI, “La alienada”. cit., p 98: «una favolosa guerra che fece scontrare
l’umanità intera contro l’esercito più pericoloso del mondo, e che dopo due giorni di scontri,
dimostrò di possedere le grandi qualità per la disfatta [...]. [In quel momento] il giorno in cui il
mondo intero attaccò l'Iraq per difendere la libertà dei popoli. Improvvisamente, smisi di essere
uno di loro. La mia amicizia cadde in disgrazia. Rapidamente, si sbarazzarono della mia
individualità e mi trasformai in voi. Me lo dicevano a me, che mi ero sempre nutrito dell’utopia
del noi».
229 Larbi, EL HARTI, “La alienada”. cit., p. 98. «Le armi dei miei amici erano contundenti.
Non avevo mai visto tante argomentazioni, nè tanta passione logica»
120
«el árabe que hablábamos era la expresión de toda Umma, gran comunidad
unida en torno al fuego sagrado de la lengua»230. Inizia così un viaggio
verso l’oriente si reca prima in Giordania e poi in Siria ma anche in questi
paesi subisce una alienazione e una silenziazione, il suo arabo, infatti risulta
incomprensibile ai suoi fratelli nella arabità:
«para negociar el precio de mi desplazamiento a Damasco, hablé el
árabe que me habló mi madre desde que tuve uso de razón. Estaba en
casa y no necesitaba expresarme de otra forma que no fuera la mía. El
conductor me miró pasmado. El bigote le temblaba de curiosidad.
Intenté explicarme como si-es-tu-vie-se-a-cla-ran-do-al-go a-un-deficien-te-men-tal. El señor no salía de su asombro. Me quedé sin aliento
231
».
La lingua della madre rivela la sua totale impossibilità di
comunicare con il mondo arabo un mondo falsamente monolitico e
monolinguistico. Il protagonista quindi sostiene che:
«Decidí esgrimir el árabe clásico que aprendí a fuerza de sangre,
gracias a un alfaquí, que me maltrataba porque no soportaba la
existencia de mi padre [...]. Habló como un libro. Esta vez lo entendí
perfectamente. Pasé un mes jurando mi pertenencia árabe, musulmana,
africana y bereber. Me expresé además en árabe, en el mejor árabe,
aprendido en las mágicas lecturas de Alhallaj, Omar Aljayam, Abu
Nawas, Nizar Kabbani, Adonis, Mahmud Darwich, Hassan Najmi »232.
230 Larbi, EL HARTI, “La alienada”, cit., p. 96: «L’arabo che parlavamo era l’espressione di
tutta una Umma, una grande comunità unita intorno al fuoco sacro della lingua».
231Larbi, EL HARTI, “La alienada”, cit., p. 99: «per negoziare il prezzo del mio trasporto a
Damasco, parlai l’arabo che mi aveva parlato mia madre sin da quando avevo avuto l’uso della
ragione. Ero in casa e non avevo bisogno di esprimermi in un altro modo che non fosse il mio.
Il conducente mi guardò sbalordito. I suoi baffi tremavano con curiosità. Cercai di spiegarmi
come se ste-ssi chi-are-ndo qu-al-cosa a un-de-fi-ce-nte men-ta-le. L’uomo non riusciva a
riprendersi dallo sconcerto. Rimasi senza fiato».
232 Larbi, EL HARTI, “La alienada”, cit., p. 100: «Decisi di sfoderare l’arabo classico che
avevo imparato a forza di botte, grazie a un alfaqui, che mi maltrattava perché non poteva
tollerare l'esistenza di mio padre (100). Parlò come un libro. Questa volta lo compresi
perfettamente. Trascorsi un mese giurando la mia appartenenza araba, musulmana, africana e
berbera. Mi espressi inoltre in arabo, nel migliore arabo, imparato nelle letture magiche di
Alhallaj, Aljayam Omar, Abu Nawas, Nizar Kabbani, Adonis, Mahmud Darwish, Hassan
Najm».
121
Questo eb
o
Ma nonostante tutto si rende conto che i suoi argomenti non
convincono nessuno e non riesce a dimostrare la sua arabità:
«Después de un festín de malhumor agresivo y ácido sobre mi cuerpo
árabe, uno de aquellos hombres sin rostro, el más riguroso y supongo
el más inteligente de los cuatro, me disparó a bocajarro, de nuevo en el
aeropuerto: “Si eres árabe, ¿por qué no hablas como todo el mundo?”»
233
.
Senza dubbio però, alla fine del racconto, il momento di massima
alienazione è simbolizzato dal fatto che il protagonista debba ricorrere
all’uso del francese, come lingua franca per stabilire un contatto tra due
arabi (suo padre e un amico libanese):
«comprendí más tarde que no podían entender cómo el hijo, recién
incorporado a la familia después de muchos años de exilio, es decir,
yo mismo, árabe y musulmán del barrio, de la calle que daba al mar,
traducía las palabras de su padre, árabe, musulmán, saharaui,
solidario con el pueblo palestino e íntimo, vía satélite, de Oriente,
para que un hermano musulmán, árabe hasta que se pruebe lo
contrario, libanés solidario con el pueblo palestino, y que hablaba
francés, entendiese de qué iba la fiesta del desencuentro y de la orgía
de la fractura »234.
Se ne “La alienada” questa lacerazione non viene risolta ne “La
compañera infalible”, invece, l’autore mette in evidenza come con il tempo
sia riuscito a risolvere questa frammentazione dell’io e come sia riuscito a
costruire una sua identità polimorfa e multilingue:
Questo
ne a\n
ebook ap
partie
233 Larbi, EL HARTI, “La alienada” cit., p. 100: «Dopo un festino di malumore aggressivo e
acido sul mio corpo arabo, uno di quegli uomini senza volto, il più rigoroso e credo il più
intelligente dei quattro, mi spiattellò a bruciapelo, di nuovo in aeroporto: “Se sei un arabo,
perché non parli come tutti gli altri?"».
234 Larbi, EL HARTI, “La alienada”. cit., p. 104: «Compresi, più tardi, che non riuscivano a
capire come il figlio, recentemente incorporato alla famiglia dopo molti anni di esilio, cioè, io
stesso, arabo e musulmano del quartiere, della strada che dava sul mare, traducesse le parole di
suo padre, arabo, musulmano, saharaui, solidario con il popolo palestinese e intimo, via
satellite, con l’Oriente, affinché un fratello musulmano, arabo fino a prova contraria, libanese,
solidario con il popolo palestinese, e che parlava francese, comprendesse verso che direzione
andasse la festa del dis-incontro e dell’orgia della frattura».
122
«los conflictos íntimos [y cómo, una vez] madurados los procesos de
interiorización de los opuestos, recono[ce], sin ningún complejo, que
el español constituye una parte privilegiada de [su] patrimonio
individual» 235.
Oramai, non cerca più di ritrovare una referenzialità collettiva ma
risolve il conflitto nella dimensione dell’io. Pertanto per El Harti lo
spagnolo:
«es [su] lengua de expresión literaria y sentimental. Por encima de la
pertenencia en un sentido convencional, prima [su] conciencia de
libertad, sin más ataduras que [sus] convicciones personales. Esa
conciencia [suya] e individual, sin renegar de nada, y reconociendo
todas las voces que la conciertan, se identifica con la lengua española
[...] Cuando esa lengua [el castellano] atraviesa mi carne y los muchos
años de memoria que la han trabajado y la uso, la amo, la castigo, la
moldeo a mi imaginario, con todos sus horrores y defectos y también
con sorprendentes momentos de ternura, deja de ser comunitaria y se
me entrega pura belleza y compañera infalible»236.
La sua identità marocchina quindi è la seguente:
«lo soy con todos los elementos que configuran mi marroquinidad y
mi derecho a una ciudadanía adulta y sin tutelas […] Podría ser de
cualquier parte del país… Pero yo diría más bien una alfombra que es
síntesis de todas. Por mi sentimentalidad y vocación corren voces de
África, signos de una cultura judía tan propia como la de otros que
niegan es mía, referencias, símbolos y mitos amazighen, y una
235 Larbi, EL HARTI, “La compañera infalible”. In Hesperia Culturas del Mediterráneo
Especial Marruecos. Fundación Tres Culturas, Fundación José Luis Pardo, Agosto 2005. 241244. p. 244: «I conflitti intimi [e come, una volta] maturati i processi di interiorizzazione degli
opposti, riconosce, senza alcun complesso, che lo spagnolo costituisce una parte privilegiata
del [suo] patrimonio individuale».
236 Larbi, EL HARTI, “La compañera infalible”, cit., p. 244: «è [la sua] lingua di espressione
letteraria e sentimentale. Al di sopra della sua appartenenza in senso convenzionale primeggia
la [sua] coscienza di libertà, senza più legami se non le [sue] convinzioni personali. Questa
consapevolezza [sua] e individuale, senza rinnegare nulla, e riconoscendo tutte le voci che la
concertano, si identifica con la lingua spagnola [...]. Quando questa lingua [il castigliano]
attraversa la mia carne e i molti anni della memoria che l’hanno lavorata e la uso, la amo, la
castigo, la modello sulla base della mia immaginazione, con tutti i suoi orrori e difetti e anche
con sorprendenti momenti di tenerezza, smette di essere comunitaria e mi si concede pura
bellezza e compagna infallibile».
123
es
u
Q
eb
o
t
es
u
Q
herencia arabomusulmana… […]. Yo soy todo eso. No reniego de
nada »237.
Nel racconto “La resaca”, Ahmed Ararou, con ironia si confronta
con il tema della scelta della lingua di Cervantes come lingua d’espressione
letteraria. Così come per El Harti, la sua è una scelta individuale, personale
frutto della presa di coscienza che la sua è una identità polimorfa e che non
deve chiedere scusa a nessuno se ha deciso di scrivere in una lingua nella
quale si sente di più a suo agio:
«Estas [las palabras], en toda escritura que aspira a ser literatura, e
independientemente del idioma que uno maneja, están condenadas a
renunciar a la autopista idiomática comunitaria»238.
Ararou, infatti, decostruisce la rappresentazione della lingua
madre, e sceglie come atto di suprema ribellione all’omologazione, la lingua
del padre:
«un escritor sin obra [que descubrió] su afición a la grafomanía en
español [...], no porque quisiera de alguna forma rechazar la lengua
materna, como afirman las teorías psicoanalíticas, o porque quisiera
asimilarse a la cultura colonizadora, sino porque quiso entender el
lenguaje del padre. Un padre silencioso y violento que cuando se
expresaba utilizaba palabras extranjeras alternando el uso de insultos,
cuando estaba enfadado, con cantos populares al despertarse por la
mañana. Palabras foráneas como “será posible…, me cao en diez, hijo
de…, maleante [...] [pero que no eras tan entrañas con respeto] al
habla local de su tierra, ya que su madre, legataria de la tradición
idiomática, usaba palabras que no le parecían ajenas como ‘tenedor’,
‘cuchara’, ‘destornillador’»239.
237 Larbi, EL HARTI, “La compañera infalible”, cit., p. 241: «Lo sono con tutti gli elementi
che compongono la mia Marocchinità e il mio diritto a una cittadinanza adulta e senza tutela
[...] potrebbe essere di qualunque parte del paese ... Ma io direi che è piuttosto un tappeto
sintesi di tutte. Per il mio sentimentalismo e vocazione scorrono voci dell’Africa, i segni di una
cultura ebraica che mi appartiene tanto quanto quegli altri negano che sia mia, i riferimenti, i
simboli e i miti Amazigh e una eredità arabo-musulmana ... [...]. Sono tutto questo. Non
rinnego nulla».
238Ahmed, ARAROU, “La resaca” in La puerta de los vientos. Narradores marroquíes
contemporáneos, Destino, Barcelona, 2004, p.p. 51-77. p.57: «Queste [parole], in tutta la
scrittura che aspira ad essere letteratura, indipendentemente dalla lingua che uno maneggia,
sono condannate a rinunciare all’autostrada idiomatica comunitaria».
239Ahmed, ARAROU, “La resaca”, cit., pp. 53-54: «Uno scrittore senza opera [che scoprì] la
sua passione per la grafomania in spagnolo […], non perché volesse in qualche modo
124
E con questo rifiuta tutta quella retorica legata al tema della
lacerazione che soffrirebbe colui che, all’atto si scegliere una lingua
letteraria “rifiuterebbe” la lingua madre, o ancora peggio matrigna, (sempre
che, tenendo conto quanto detto poco fa si possa considerare l’arabo
moderno, lingua madre):
«Escribir en una lengua ‘forastera’ se considera, según una convención
desatinada y comúnmente avalada, el acto pecaminoso más aborrecible
de cuantos existen [...]. Si por casualidad te enganchan, descubrirás
más cosas sobre tu frustrado instinto parricida que cristaliza en una
saludable pero peligrosa esquizofrenia»240.
Que
Ararou decostruisce pertanto tutte le teorie postcoloniali e
ironizza sull’applicazione del complesso di Edipo che spiegherebbe il
rifiuto della lingua materna in favore di una lingua straniera:
sto
ebo
ok a
«la denegación de la lengua materna, y por extrapolación denegación
de la madre en carne y hueso, y en pelotas, eso sí, porque de no ser así
el griego no funciona, sería un exponente claro de un conflicto edípico
mal negociado que convierte el incestuoso deseo de la figura materna
en condena de la lengua nacional, arrojando a los que lo padecen en
los brazos hospitalarios de un manual de gramática extranjera»241.
ppa
respingere la lingua madre, come sostengono le teorie psicoanalitiche, o perché volesse
assimilarsi alla cultura colonizzatrice, ma perché voleva comprendere la lingua del padre. Un
padre silenzioso e violento che quando si esprimeva utilizzava parole straniere alternando l’uso
di insulti, quando era arrabbiato, con canti popolari quando si svegliava la mattina. Parole
straniere come "sarà possibile ... me ne fotto, figlio di ..., discolo [...] [ma non erano così
criptiche rispetto] al dialetto della sua terra, visto che sua madre, erede della tradizione
idiomatica, usava parole che non gli sembravano straniere come ‘coltello’, ‘cucchiaio',
'cacciavite».
240Ahmed, ARAROU, “La resaca”, cit., pp. 51-52: «Scrivere in una lingua ‘forestiera’ è
considerato, secondo una convenzione comunemente ed irragionevolmente accettata, l'atto
peccaminoso più ripugnante che esista [...]. Se casualmente ti dovesse capitare, scopriresti più
cose sul tuo frustrato istinto patricida che cristallizza in una salubre ma pericolosa
schizofrenia».
241Ahmed, ARAROU, “La resaca”, cit., p. 52: «Il rifiuto della lingua madre, e per astrazione
il rifiuto della madre in carne ed ossa, sì, altrimenti, se così non fosse, il greco non
funzionerebbe, sarebbe un segno chiaro di un complesso edipico mal negoziato che trasforma
l'incestuoso desiderio della figura materna in condanna della lingua nazionale, lasciando coloro
che ne soffrono nelle braccia ospitali di un manuale di grammatica straniera».
125
rtien
e
Questo
ebo
o
k
a
p
p
artien
Egli, esalta, allo stesso tempo, la possibilità di scegliere una
lingua alternativa all’atto di fare letteratura: «para los que desconfían de la
operancia de las ‘teorías del centro’ y prefieren los gajes de la errancia a la
inquietante armonía de la ‘morada heidegeriana»242.
Uno scrittore infatti nell’atto di scrivere fa altro da sè, scrivere
significa incontrare il proprio doppio:
«yo soy dos, y estoy en cada uno de ellos [...] [y al mismo tiempo
significa también] sufrir una leve y esporádica escisión a la cual
tampoco escaparían los nativos del suelo y ultramar españoles. Nada
grave, al fin y al cabo, puesto que tan sólo se trataba de una intuitiva
confianza en el poder liberador del lenguaje»243
e prendere atto de «la ruptura momentánea con los canónicos hábitos de la
lengua materna»244.
Per concludere vorrei solo dire che in questo mio intervento ho
cercato di sottolineare come attraverso il rapporto con la lingua fattore
imprescindibile nella costruzione dell’identità sia gli scrittori saharaui,
nella loro dimensione collettiva che gli ispano-marocchini, nella loro
dimensione individuale stanno proponendo un modelo altro che sfugge alla
narrazione postcoloniale. In entrambi i casi pur tenendo conto delle debite
differenze queste le letterature stanno stabilendo un dialogo transculturale
Europa-Africa-America un dialogo paritetico e rivoluzionario che merita di
essere studiato affinchè un pubblico sempre più vasto e variegato possa
avvicinarsi a queste letterature “emergenti”.
Bibliografia
Ahmed, ARAROU, “La resaca” in La puerta de los vientos. Narradores
marroquíes contemporáneos, Destino, Barcelona, 2004, p.p. 51-77.
242Ahmed, ARAROU, “La resaca”, cit., p. 51: «Per coloro che non si fidano dell’operatività
delle 'teorie del centro' e preferiscono le sfide dell’erranza all’inquietante armonia della
“dimora heidegeriana "».
243Ahmed, ARAROU, “La resaca”, cit., pp. 56-57: «Io sono due e mi trovo in ognuno di loro
[...] [e, allo stesso tempo significa anche] soffrire una lieve e sporadica scissione alla quale non
sfuggirebbero nemmeno gli spagnoli nativi e d’oltremare. Nulla di grave, dal momento che
dopo tutto, si trattava solo di una intuitiva fiducia nel potere liberatorio del linguaggio».
244Ahmed, ARAROU, “La resaca”, cit., p. 57: «la rottura momentanea con le abitudini
canoniche della lingua madre».
126
Bahia, Mahmud, AWAH, Literatura del Sahara Occidental, breve estudio.
Versos Refugiados, Universidad de Alcalá Fundación General, 2007.
o
Quest
Bahia, Mahmud, AWAH; Conchi, MOYA. El porvenir del español en el
Sahara Occidental, Bubok Publishing S.L., 2010.
Limam, BOICHA. Los versos de la madera, Puentepalo, Las Palmas de
Gran Canaria, 2004.
ebook
Gilles, DELEUZE, Félix, GUATTARI, Kafka. Per una letteratura minore,
Quodlibet, Macerata, 1996.
iene a
appart
Frantz, FANON, I dannati della terra, Einaudi, Torino, 1962. Trad. de
Carlo Cignetti.
_Il negro e l’altro, Il Saggiatore, Milano, 1965, Trad. de Mariagloria
Sears.
\nGiuli
Juan, GIMENO; Coriolano, ROCHA, “Memorias orales en el Sáhara
Occidental: la poesía en hasanía”. In 7º Congresso Ibérico de Estudos
Africanos, 9, Lisboa, 2010 - 50 anos das independências africanas: desafios
para a modernidade: actas. Lisboa: CEA, 2010. [Consult. Maggio 2010].
Disponíibile in: http://hdl.handle.net/10071/2418
uot
acciap
ana C
Édouard, GLISSANT, Introduction à une poétique du divers, Gallimard,
1996. Poetica del diverso, Meltemi, Roma, 1998, traducción de Neri
Francesca.
Claudio, GUILLÉN, “Mundos en formación: los comienzos de las
literaturas nacionales”, in Múltiples moradas. Ensayo de Literatura
Comparada, Tusquets Editores, Barcelona, 2 edición 2007 p.p. 299-335.
i CLI_2
Larbi, EL HARTI, “La alienada” in La puerta de los vientos. Narradores
marroquíes contemporáneos, Destino, Barcelona, 2004. P.p. 89-104.
_“La compañera infalible”. In Hesperia Culturas del Mediterráneo
Especial Marruecos. Fundación Tres Culturas, Fundación José Luis Pardo,
Agosto 2005. 241-244.
30396
01300
Zahra, HASNAUI, “Utopía” in:
127
http://www.generacionamistadsaharaui.com/poesia/zahra_hasnaui.htm#Ut
opia
Mohamed, LAHCHIRI, “Moras Pisoteadas” in Una tumbita en Sidi
Embarek y otros cuentos ceutíes, Imprenta Dar al-Karaouines, Casablanca,
2006.
Mbare, MGOM, “Introducción” in Literatura de Guinea Ecuatorial, Ed. de
Mbare, MGOM, Donato NDONGO-BIDYOGO, Casa de África, Madrid,
2000.p.p. 11-29.
García, Francisco. MOSCOSO, “Situación lingüística en Marruecos: árabe
marroquí, bereber, árabe estándar, lenguas europeas”. AM, 10 (20022003)
153-166.
Disponible
en
<http://
www.pliegosdeopinion.net/pdo11/11pensamiento/11lenguas/Situacionmosc
oso.pdf > [consultato il 20/09/2006].
Selena, NOBILE, La literatura hispano-marroquí. Un modelo mediterráneo
posorientalista y posoccidentalista, Tesi dottorato, Università del Salento,
Italia, 2008
_“Las literaturas ‘menores’ hispano-africanas. De la literatura poscolonial
a la de la migración: el caso de Guinea Ecuatorial y de Camerún” in De
Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafricanas, Ed. de LandryWilfrid Miampika, Patricia Arroyo, Verbum, Madrid, 2010, pp. 266-281.
liana
\nGiu
tiene a
ppar
ook a
b
e
o
t
Ques
puoti
Caccia
Mohamed, SALEM Abdelfatah, Ebnu, Nómada en el exilio, Asociación
Cultural Almenara, Marbella, 2008.
_Voz de fuego, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2003.
128
CLI_
Qu
est
oe
boo
ka
ppa
rtie
ne
a\n
Gi u
lian
NAWWARTUNA - ITALIANO PER ARABI
Giuliana Cacciapuoti
Giuliana Cacciapuoti
Esperta di lingua araba e cultura arabo- musulmana presso
l’Università degli Studi di Napoli l’Orientale. Si occupa di didattica
dell’italiano come seconda Lingua per arabofoni. E’ incaricata della
ideazione di programmi e progetti innovativi sui temi della relazione
interculturale, dell’identità e della diversità di genere, in particolare nei
contesti complessi delle società europee e nordamericane. Nel contesto
italiano svolge ricerche con le donne e con le ragazze immigrate, anche di
seconda generazione. In base a una sua proposta, insegna, a partire dal
2003, “Comunicare con l’Islam”, nel corso di Alta Formazione per
dirigenti superiori del Ministero dell’Interno. Nel 2008 è stata nominata
Mentor per l’ American Society for Muslim Advancement.
Abstract
Il testo, riassume i risultati di numerosi progetti e ricerche condotte
a partire dal 1990, e illustra i poster presentati a Milano nel corso del
Convegno. Essi documentano due decenni di attività nell’ambito della
ricerca e della didattica interculturale, realizzate in un’area svantaggiata
quale l’Italia meridionale a favore dei parlanti arabo. Le tre fasi attraverso
le quali si articola il percorso, nel quadro delle attività legate alla tutela
giuridica e linguistica di arabofoni, coprono la fase di sperimentazione
(1990-2000), la collaborazione con le iniziative di ricerca universitaria
nell’ambito della didattica dell’italiano per arabi e per il mantenimento
della cultura di origine (2000-2007), infine le attività contro la dispersione
scolastica delle seconde generazioni arabofone e per il consolidamento
della lingua italiana (2007-2010). Le attività illustrate sono state realizzate
con la partecipazione e il sostegno dei seguenti soggetti: Università degli
studi di Napoli L’Orientale; Cattedra Jean Monnet Facoltà di Scienze
Politiche – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; AIMC –
Associazione Immigrati Marocchini in Campania; Ufficio Territoriale del
Governo della Prefettura di Caserta; CSA di Caserta; Rai Radio televisione
italiana/ Rai teche/ Rai Educational
This paper, based on the results of several projects and research
works carried out since 1999, presents the experience of two decade of
educational project, aimed at integrating second-generation Arabic
129
a
ebook
Quest
o
speaking people, as shown by the three posters presented in Milan. The data
refer to a disadvantaged area as southern Italy is. The actions presented,
described from the point of view of the legal treatment and linguistic
maintenance of Arabic speaking people, are divided into three periods:
experimental period (1999-2000); period of cooperation with universities in
experimental activities to design courses of Italian language as second
language for Arabic speaking people and promoting actions preserving
both, mother tongue and cultural background (2007-2010); interventions to
fight school dropping out and to consolidate Italian as second language of
Arabic-speaking pupils and students. Research activities sponsored by
Università degli studi di Napoli L’Orientale; Cattedra Jean Monnet
Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”, AIMC – Associazione Immigrati Marocchini in Campania;
Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Caserta; CSA di
Caserta; Rai Radio televisione italiana/ Rai teche/ Rai educational.
È interessante ripercorrere le tappe dell’immigrazione araba e
musulmana nel nostro Paese nella prospettiva dell’offerta formativa e
didattica specifica dedicata agli arabofoni. In due decenni si notano
profondi e altalenanti cambiamenti (in ambito legislativo, istituzionale,
amministrativo, demografico, sociale, psicologico e culturale, nei media e
nell’opinione pubblica) che si sono sviluppati con un processo dinamico
nella sfera pubblica nazionale e locale. La modifica della percezione del
diverso da sé arabo e musulmano nel corso del tempo e il cambiamento
stesso delle diverse realtà italiane nell’ambito dell’istruzione pubblica, sono
motivi di interesse per chi voglia comprendere i mutamenti della società
italiana contemporanea con uno sguardo specifico al contesto migratorio
arabo-musulmano. Con-dividere la memoria delle tappe della didattica
dell’italiano per la comunità arabofona italiana, una realtà per presenze
numeriche e culturali cospicua e significativa, aggiunge un piccolo tassello
per riflettere sul rapporto significativo tra arabi e italiani. Il X Convegno
dell’Associazione SE.Sa.MO sul tema delle memorie condivise mi ha spinto
a realizzare una serie di poster sulle attività didattiche realizzate,
nell’ambito della ricerca e della didattica interculturale, a favore dei
“parlanti arabo” nel nostro Paese, in particolare nell’Italia meridionale,
nell’arco temporale degli ultimi vent’anni, perché i temi della presenza
italiana in Nord Africa e l’attualità contemporanea si ricongiungono
idealmente ai temi del Convegno milanese. Un cordone mai reciso con le
realtà nordafricane, in particolare con la Tunisia e la Libia, fatto di legami e
130
reminiscenze presenti nella memoria di molte famiglie o comunità
meridionali, si riannodò rapidamente nei primi anni delle migrazioni verso
l’Italia da parte dei nordafricani. Si rinnovarono contatti per ragioni di
studio, lavoro o ricordi familiari. Si registrò una partecipazione collettiva
che sorprende se oggi si osserva la realtà quotidiana della relazione tra il
nostro Paese e i migranti arabofoni, la diffidenza e la distanza che esiste tra
due realtà che condividono il medesimo spazio urbano. Presentare un
sintetico excursus, che tenga conto dei cambiamenti legislativi intervenuti
nel tempo in materia di formazione e tutela linguistica degli immigrati, offre
la chiave per una maggiore comprensione dei problemi e per una corretta
impostazione delle soluzioni. Non potendo in questi Atti riportare i poster,
il lavoro è riassunto nel testo seguente, suddiviso in tre diversi momenti.
Esso si articola in:
Q
ue
st
o
eb
Poster 1, 1990-2000. Prime sperimentazioni e primi corsi di italiano come
“lingua seconda” per arabi.
oo
k
ap
pa
Poster 2, 2001-2007. Consolidamento di progettazione e collaborazione
pubblica con iniziative di ricerca universitaria nell’ambito della didattica
dell’italiano per arabi e per il mantenimento della cultura di origine arabo –
musulmana.
rti
en
e
a\
nG
Poster 3, 2007-2010. Italiano per arabofoni: seconde generazioni e azioni
di tutela linguistica con illustrazione di esempi significativi di risultati
raggiunti; prospettive future nell’ambito della didattica interculturale
dedicata agli arabofoni di seconda generazione per il consolidamento della
lingua italiana e contro la dispersione scolastica dei “parlanti arabo”. Una
serie di Enti che hanno preso parte a questo processo storico, quali RAIDSE, il sistema degli IRSSAE/IRRE, i Provveditorati agli Studi (divenuti
CSA), non ci sono più. Stiamo sperimentando cambiamenti e riforme; in
definitiva riflettere sugli ultimi venti anni del rapporto istruzione-didattica
dell’italiano per gli arabofoni ci aiuta a capire quali siano le esperienze
scarsamente condivise e quali quelle fortemente condivise, in modo da
fotografare l’odierno contesto didattico-educativo del nostro Paese.
iu
lia
na
Ca
cc
ia
pu
1. POSTER 1, 1990-2000. Prime sperimentazioni e primi corsi di italiano
come lingua seconda per arabi.
L’anno 1990 è per l’immigrazione in Italia una sorta di anno-zero.
Con l’approvazione della Legge 39/90, ricordata anche come Legge
Martelli, si apre un nuovo corso per la politica nei confronti dei migranti in
131
ot
iC
LI
_2
Italia. In Italia uno dei luoghi-simbolo della prima immigrazione è il litorale
domiziano, sbocco sul mare della Provincia casertana dove si estende la
Terra di Lavoro, zona agricola che impiega braccianti stranieri nelle
raccolte stagionali. Le condizioni dei migranti qui sono drammatiche:
l’uccisione di Jerry Essan Masslo ne fa un luogo-simbolo, che costringe la
classe politica ad affrontare la realtà dell’immigrazione e soprattutto a
legiferare in materia. Si concentra lì una popolazione adulta arabofona
consistente, all’epoca tra le più numerose in Italia. Il Provveditorato di
Caserta, in assenza di ogni indicazione legislativa, rileva la necessità di
istituire corsi di italiano per arabi nelle scuole pubbliche, corsi detti
“sperimentali”, nell’ambito delle 150 ore per adulti-lavoratori. Si tratta di un
primo passo verso il riconoscimento della presenza e dell’esigenza didattica
e formativa degli stranieri in Italia. Il Ministero della Pubblica Istruzione
emana la “Circolare 205/90 Educazione interculturale”, base di tutte le
future iniziative didattiche dedicate al multiculturalismo e all’intercultura.
La circolare recita:” L'educazione interculturale è condizione strutturale
della società multiculturale. Il compito educativo, in questo tipo di società,
assume il carattere specifico di mediazione fra le diverse culture di cui sono
portatori gli alunni; mediazione non riduttiva degli apporti culturali diversi,
bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti
modelli”. È allora in questo clima di attenzione per gli stranieri che si
muovono le Istituzioni pubbliche.
Tutti gli IRRSAE, poi IRRE, oggi Enti soppressi, promossero in
Italia corsi di formazione per docenti di lingua italiana per arabi. Docenti di
lingua italiana ancora non identificati come docenti di “Lingua seconda” o
L2. Tutti questi corsi sono sperimentali, ma dato altamente positivo è che si
istaura una la comunicazione tra docenti dalla Sicilia alla Lombardia e si
apre un’ampia discussione sull’educazione interculturale e sulla didattica
dell’italiano per gli stranieri parlanti lingue extraeuropee, di cui gli
arabofoni all’epoca sono il gruppo più consistente. Nello spirito di apporto e
di scambio tra culture diverse, la RAI intende assolvere alla sua funzione
di servizio pubblico e ben presto, proprio sulla scorta del dibattito
nazionale, i vertici dell’azienda rilasciano dichiarazioni pubbliche in merito
alla necessità di avviare programmi per l’insegnamento dell’italiano agli
stranieri. Il DSE, ossia il Dipartimento Scuola Educazione, oggi RAI
Educational, investe nel prodotto radiofonico e si produce nella sede RAI di
Napoli Nawwartuna/ Benvenuti Italiano per arabi. In onda su Radio TRE,
dalle 18.30 alle 18.50, nel periodo da aprile 1991 a maggio 1992, questo è
stato il primo corso di italiano per arabofoni trasmesso da una rete
nazionale. La sua diffusione interessò l’Italia e parte del Nord Africa. La
Questo e
book app
artiene a
132
\nGiulian
a Caccia
trasmissione suscitò notevole interesse tanto da richiedere una replica e un
“surplus” di 15 minuti nei quali si parlava della cultura araba. Pietro
Vecchione ( allora direttore del Dipartimento Scuola-educazione DSE)
scrisse: “Rispondendo ad un bisogno diffuso ed espresso da tutte le
comunità di nordafricani residenti in Italia, fu naturale l’atto di rivolgersi a
giovani che, usciti dalle aule dell’Istituto Universitario Orientale, già da
tempo lavoravano con alcune comunità arabe insediate in Campania, che è
una delle regioni con maggiore presenza di arabofoni (dati Caritas 1990)”.
Naghib Mahfuz, lo scrittore egiziano premio Nobel per la letteratura,
nell’intervista concessa per il programma, rivolgendosi ai suoi concittadini
emigrati in Italia, sottolineava l’importanza ”di apprendere una lingua,
impararla con correttezza e proprietà, perché - diceva - questo consente di
capire meglio la natura e la ricchezza culturale e di civiltà del paese di
accoglienza”.
In questo decennio l’attenzione agli “extracomunitari” è alta, tra
volontariato, curiosità, voglia di capire una nuova realtà, prime avvisaglie
di venti di guerra (i conflitti Iran- Iraq e le guerre del Golfo); si segnalano
anche i primi episodi di intolleranza, se non di aperto razzismo, ma gli
immigrati arabi e musulmani non sono ancora oggetto di diffidenza e paura.
Intanto il nostro paese si dota di leggi che permetteranno nuove
esperienze, non più episodiche e pionieristiche, ma sistematiche nell’ambito
della scuola pubblica. Un punto di arrivo, che negli anni successivi
permetterà di attivare corsi di italiano per arabi a scuola e corsi di lingua
araba in orario extrascolastico, è la Legge Quadro sull’Immigrazione (L.
40/98, detta Turco-Napolitano); la legge si occupa della scuola e dei nuovi
alunni. All’art. 38, comma 3, Istruzione degli stranieri ed educazione
interculturale, si dice: “La comunità scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio delle culture e della tolleranza: a tal fine promuove
e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura e della
lingua di origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni”. È
l’ingresso a scuola degli alunni e alunne straniere a pieno titolo e poiché,
con la riforma del Titolo V della Costituzione, le competenze in materia di
Istruzione passano alle Regioni, è giunto il momento per gli Enti locali di
dare risposte.
Qu
es
to
eb
oo
ka
2. POSTER 2 2001-2007. Consolidamento della progettazione e
collaborazione pubblica con le iniziative di ricerca universitaria nell’ambito
della didattica dell’italiano per arabi e per il mantenimento della cultura di
origine.
133
pp
art
ien
e
L’impianto legislativo e l’attitudine delle istituzioni e
dell’opinione pubblica italiana, nonostante l’11 settembre e l’avanzare
dell’islamofobia, dal 2001 al 2007, manifesta l’intenzione di costruire
percorsi di inclusione per nuovi cittadini. Il contesto culturale, in cui si
inserisce il sentire del cittadino comune, non guarda più alla comunità
straniera con generica curiosità o blanda e benevola tolleranza.
L’immigrazione, divenuta strutturale nel nostro Paese, anche se non con
l’incidenza conosciuta da altri Paesi europei, è in costante aumento.
Mancando un preciso progetto politico nazionale, l’opinione pubblica si
orienta verso l’ostilità, se non il dichiarato razzismo, nei confronti
dell’immigrazione. In questo contesto la Legge 189/01, detta Bossi-Fini, pur
non incidendo materialmente sulle disposizioni in materia di istruzione e
didattica, incide in maniera profonda sul comune sentire. In ogni modo,
nonostante la condizione di contraddittoria indeterminatezza, è ancora
possibile proporre soluzioni sperimentali e didattiche per le comunità
arabofone, sebbene si tratti di comunità musulmane e dunque oggetto di
crescente diffidenza nel climax montante di ostilità verso il mondo araboislamico instauratosi dopo l’11 settembre.
A partire dal 2001 è preferibile, per ciò che concerne la didattica
per gli arabofoni, studiare il caso della Regione Campania. Qui sono ancora
presenti comunità consistenti di “parlanti arabo” e la Regione promuove una
serie di iniziative finanziate sia con risorse regionali che con risorse
nazionali ed europee. In Campania si parte da una situazione di grave
difficoltà, con un gap enorme di servizi sociali ed educativi, che si riesce a
colmare grazie alla gestione unificata delle politiche sull'immigrazione nei
piani sociali di zona (L.286/94 e 328 /2000 ) e alla collaborazione con le
scuole e le Università. Gli interventi in campo scolastico-educativo hanno,
tra le altre finalità, una priorità: prevenire, contrastare e recuperare la
dispersione, gli abbandoni e i disagi della popolazione migrante,
consolidando la conoscenza della lingua italiana per un miglior inserimento
scolastico e per il successo formativo delle alunne e degli alunni stranieri, in
modo da realizzare l’integrazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi
straniere/i e delle loro famiglie. Nell’anno scolastico 2005-2006 i dati
diffusi dal M.I.U.R. indicano che il 78% degli alunni stranieri sceglie
istituti tecnico - professionali rispetto al 55% degli alunni italiani mentre il
41% di italiani sceglie i licei tra gli stranieri solo il 18 %.
Il dato più allarmante è che 7 alunne/i su 10 di origine straniera,
all’ingresso nella scuola superiore, sono in ritardo formativo. In Campania,
per finanziare i progetti di italiano per arabi, si utilizzano i fondi del FSE –
POR Campania (asse III, misure 3.6 e 3.4), usufruendo dello status di
0
ot
i
pu
ci
a
ac
ia
na
iu
l
G
e
a\
n
tie
n
r
pp
a
ok
a
o
o
es
t
eb
u
Q
C
C
LI
00
3
3
2
0
1
_
134
1
1
969
3
0
003
3
1
0
LI_2
Que
sto
ok
ebo
a
ien
t
r
a
pp
nG
e a\
iu
aC
lian
a
oti C
u
p
ccia
Regione Obiettivo 1, ossia Regione in condizione di svantaggio rispetto
alle aree più ricche del resto d’Europa. Oltre a seguire gli indirizzi
legislativi nazionali, ci si avvale anche della Legge regionale 33/94
(Interventi per
la popolazione immigrata in Campania) e della Legge 328/2000 (Interventi
per l’immigrazione nei piani sociali di zona), cui si ricollega il Protocollo
d’intesa tra Regione Campania e Ufficio scolastico regionale per la
Campania in materia di educazione interculturale. Non si sostengono solo i
progetti di lingua, ma questi vengono integrati con la formazione specifica
dei docenti, grazie a 6 corsi sperimentali di formazione interculturale per
docenti delle cinque province della Campania e alla pubblicazione di ”
Ciao! Piccola guida per un’interazione consapevole con bambini e genitori
stranieri nella scuola”, opuscolo che viene distribuito in tutte le scuole
campane in modo capillare. Ogni scuola elementare e media della regione
ne riceve una copia, nella speranza che non siano state rinchiuse
immediatamente in qualche armadietto. Accompagna la didattica di italiano
L2 anche il Progetto “Bauli Volanti”, affiancato da una pubblicazione che
raccoglie materiali bibliografici per la realizzazione di scaffali e attività
interculturali nelle scuole. Nell’opuscolo sono indicati testi che si
riferiscono alla cultura di origine, come le favole della tradizione araba;
questi testi sono disponibili, in questa sorta di biblioteche itineranti, in
lingua italiana e, dove possibile, in testo bilingue o in lingua originale. I
dati, a partire dal 2007, sono eloquenti: la Campania è la prima regione
meridionale per presenza di immigrati.
Perciò si rende necessario avere sempre più percorsi didattici finalizzati al
consolidamento della lingua italiana per alunne e alunni stranieri. Si sceglie
di farli in orario extrascolastico nelle scuole pubbliche, con docenti esperti
e formati, come indicato, per l’insegnamento della lingua italiana come L2
per arabofoni. Sono partner delle attività le associazioni delle comunità
locali, come l’ Associazione dei Marocchini in Campania(AIMC), e le
Istituzioni, tra cui la Provincia e il CSA di Caserta. Il punto di arrivo, per
preparare al meglio gli arabofoni all’ingresso alla scuola superiore, è il
progetto Ge.St.I (2005-2007) realizzato dalla Regione Campania con
L’Università l’Orientale. Il Progetto prevedeva libri di testo per arabi o
cinesi per facilitare lo studio della lingua italiana, della storia e della
geografia nella scuola media inferiore, per evitare il gap culturale e
l’abbandono degli studi da parte degli arabofoni nel passaggio alla scuola
superiore e per impedire l’abbandono e l’insuccesso formativo. Il progetto
si è chiuso definitivamente nell’ottobre 2011 con l’edizione dei testi.
135
3. POSTER 3 2007-2010. Italiano per arabofoni: seconde generazioni e
azioni di tutela linguistica.
La Campania si colloca in Italia al secondo posto per abitanti e al
primo per densità abitativa. Ha il più alto indice di natalità d'Italia e oggi
vanta la più alta percentuale di giovani, sia italiani che immigrati. Gli ultimi
tre anni hanno visto emergere due fenomeni specifici: a) la presenza di
italiani di origine araba;
b) una significativa presenza di ragazze di origine marocchina.
Nell’ambito della didattica e delle tutele linguistiche e culturali, si
deve purtroppo sottolineare la rarefazione, se non addirittura l’abbandono,
di politiche istituzionali, nazionali, locali
e settoriali (assessorati
all’Immigrazione o all’Istruzione) espressamente destinate agli arabofoni.
Resta solo l’attività universitaria, su tutto il territorio nazionale, non solo in
Campania, portata avanti dai Centri linguistici di Ateneo e integrata da
attività e progetti di ricerca (finanziamenti F.E.I./Fondo Europeo per
l’Integrazione) o da iniziative individuali.
Capoluogo di
provincia
Città più popolata
Napoli
Avellino
Benevento
Napoli
Napoli
Salerno
Salerno
Giugliano in
Caserta
Campania*
Torre del Greco*
Avellino
Benevento
Pozzuoli*
Benevento
Salerno
*Città della provincia di Napoli
ues
to
Q
Caserta
Salerno
Fonte Istat
Capoluogo
di provincia
con più alto
numero di
immigrati
Capoluogo di
provincia con più
alto numero di
seconde
generazioni
arabofone
Napoli
Caserta
Avellino
Seconde Generazioni arabofone in Campania
eb
pp
ook
a
Anno
Minorenni
Nati in Italia
2008
20366
12235
2007
17635
10866
2006
Fonte M.I.U.R.
15278
9601
136
In Italia, negli ultimi venti anni, gli alunni stranieri sono passati dai
12.000 dell’anno scolastico 1988-1989, ai quasi 630.000 dell’anno 20082009, con un’incidenza sulla popolazione scolastica del 7%. Si sono
disattese tutte le proiezioni statistiche, che ritenevano possibile una presenza
di alunni stranieri nel Paese, verso il 2030, intorno al 9-11%. Così non è
stato; oggi non solo la scuola italiana (soprattutto la scuola primaria) non ha
“chiuso” per mancanza di alunne /i grazie al tasso di natalità delle famiglie
immigrate, ma in alcuni contesti le percentuali di alunne e alunni stranieri
nelle classi superano il tetto del 30%. La maggior parte degli studenti sono
rumeni (105.682, il 16,79% del totale), seguiti dagli albanesi (91.829),
mentre i marocchini arabofoni sono al terzo posto(83.608), prima di cinesi
(30.776) e ecuadoriani (18.923).
La regolarizzazione di un gran numero di immigrati in Italia ha
favorito i ricongiungimenti familiari e, conseguenzialmente, ha accresciuto
il numero dei figli degli immigrati presenti sul nostro territorio. Fino al
2008, la presenza degli alunni stranieri nelle scuole campane ha subito un
continuo incremento. Tra questi, notevole è la componente costituita dalle
seconde generazioni arabofone nate e/o cresciute in Campania (con un
aumento di circa 2000 unità ogni anno): Marocco, Tunisia, Algeria ed
Egitto sono le nazionalità maggiormente rappresentate.
In Campania la situazione scolastica è stata favorita dalla
distribuzione territoriale “a macchia di leopardo” delle famiglie immigrate,
residenti in tutta la Regione e in moltissimi Comuni, anche piccoli. Il lavoro
di sostegno e di lotta alla dispersione scolastica condotto negli anni
precedenti ha dato dei risultati apprezzabili, tanto che si è registrato un
discreto successo formativo, soprattutto per quanto riguarda le ragazze
marocchine, che hanno conseguito un diploma superiore, proseguendo
spesso gli studi in ambito universitario.
Molte di loro hanno partecipato a corsi di lingua italiana e/o per il
mantenimento della cultura di origine nell’arco del triennio 2005-2007. Si è
trattato di corsi pomeridiani attivati presso la stessa scuola di frequenza
mattutina, con gruppi al massimo di 15 allievi, in particolare provenienti
dalle scuole di Castel Volturno (Caserta), località densamente abitata da
famiglie immigrate.
Azioni di tutela linguistica e culturale negli ultimi anni si
propongono o si devono proporre in un ambito generale di riferimento che
deve tenere conto dei rapidi cambiamenti avvenuti nella società italiana.
Innanzitutto occorre sostenere i percorsi nella scuola pubblica, ossia nello
Q
ue
st
137
o
eb
oo
k
ap
pa
rti
e
nG
na
a
i
iul
c
Ca
p
a
i
c
u
iC
t
o
_
LI
20
0
13
0
3
30
9
1
69
1
spazio pubblico, per impedire che le nuove generazioni nate e cresciute in
Italia restino chiuse in “enclaves” separate.
È importante poi, poiché si è dato all’Università il compito di
formare i docenti di Italiano L2, rendere questi percorsi condivisi a livello
di programmi in tutte le differenti sedi universitarie del Paese, per ottenere
un orientamento e una certificazione univoca. Inoltre bisogna lavorare per
estendere la formazione dei docenti di L2 a tutti gli operatori sociali
afferenti al mondo dell’immigrazione e per ordinare in ambito legislativo la
mediazione interculturale. Infine ultimo tema, oggi prioritario, è quello
delle nuove italiane e dei nuovi italiani. Occorre la riforma della legge sulla
cittadinanza, ma, in attesa di ciò, si può e si deve agire nell’ambito della
didattica e della tutela linguistica e culturale. In Campania la nuova legge
regionale sull’immigrazione (L. R. Campania 6/2010) ha affrontato,
nell’articolo 19, i temi dell’educazione interculturale. La realtà scissa,
esterna e interna, dei giovani di origine straniera e la percezione che questi
ultimi, in quanto figli, hanno dei genitori come cittadini di serie B,
implicano il rischio per tali soggetti di elaborare una doppia identità,
camaleontica, negli spazi familiari e nella vita pubblica. Tutto ciò può
creare conflitti di lealtà in relazione alle aspettative genitori/figli, alla
dinamica successo/insuccesso, alla relazione con la propria origine
culturale, all’adesione/ condivisione/rifiuto della società circostante. Di qui
la necessità e validità di percorsi didattici interuniversitari che
approfondiscano tali questioni e attivino sperimentazioni , come il Progetto
“Scuola di solidarietà e di diritti umani”, i cui protagonisti testimonial sono
stati i G2 (Seconda Generazione di arabofoni residenti in Campania),
progetto alla cui realizzazione ha contribuito anche economicamente la
comunità marocchina residente in Regione.
Q
138
s
ue
to
oo
b
e
k
p
ap
a
e
n
e
rti
a\
Alla fine del percorso si può osservare che, indipendentemente
dalle sperimentazioni o dalle attività consolidate, tutte le istituzioni
pubbliche, nazionali e locali, le agenzie educative, le istituzioni
accademiche, sono chiamate a far la propria parte, senza tralasciare la
collaborazione con le varie forme di associazionismo delle comunità
arabofone. Si segua con attenzione e cura l’insegnamento della lingua
italiana e si ripensi e riprogetti la tutela della lingua e della cultura
d’origine araba. Un paese proiettato nel futuro e nella modernità si
costruisce su memorie e culture diverse condivise. Oggi, in tempi detti “di
crisi”, una luce di speranza in fondo al tunnel appare. Il percorso delle
ragazze e dei ragazzi arabi e musulmani di seconda generazione è
complesso, ma offre una grande opportunità di crescita e cambiamento al
oo
Qu
eb
o
t
s
e
nostro Paese, che deve saperne approfittare per ripartire e ritornare a essere
in sintonia col mondo che cambia e si evolve. Sarà questa una sfida anche
per i G2 per avviare un dialogo culturale paritario con tutte le donne e gli
uomini che oggi vogliono tornare a essere protagoniste e protagonisti nella
vita sociale, politica e culturale del nostro Paese.
APPENDICE
FONTI LEGISLATIVE RELATIVE ALL’EDUCAZIONE
INTERCULTURALE E ALLA MEDIAZIONE.
DECRETO LEGISLATIVO 286/1998 “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, N.394/1999,
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’articolo, comma 6, del decreto legislativo del luglio
1998, n. 286.
LEGGE 6 marzo n.40/1998, art.3
DOCUMENTO PROGRAMMATICO RELATIVO ALLA POLITICA
DELL’IMMIGRAZIONE E DEGLI STRANIERI NEL TERRITORIO
DELLO STATO. Parte terza: politiche di integrazione.
DECRETO LEGGE N. 416/1989, coordinato con la legge di conversione n.
39/1990 recante: “Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione di cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello stato”.
LEGGE 482/1999, “Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche”.
LEGGE REGIONALE CAMPANIA 33/94”Normativa regionale campana
dell’immigrazione integrata da LEGGE REGIONALE n.11/07, all’articolo
35, politiche per gli immigrati, prevede che «La Regione sostiene azioni
mirate a favorire l’inclusione sociale delle persone immigrate e la loro
139
tutela. A tal fine promuove e favorisce misure volte a: a) istituire servizi di
accoglienza, di informazione e mediazione; b) realizzare interventi di
sostegno all’inserimento lavorativo e abitativo; c) tutelare i diritti di
cittadinanza e attuare l’integrazione tra culture diverse per il superamento di
diffidenze discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza
C.M. 21 OTTOBRE 1999, N.249. “Scuole collocate in zone a forte
processo immigratorio”, Applicazione artt.5 e 29 del C.C.N.I. “Scuola”Indicazioni operative.
ok
ue
s
t
o
ebo
C.M. 2 Marzo 1994, n. 73, “Dialogo interculturale e convivenza
democratica: l’impegno progettuale della scuola”.
Q
C.M. n.5 del 12 gennaio 1994, “Iscrizione nelle scuole e negli istituti di
ogni ordine e grado di alunni stranieri privi di permessi di soggiorno”.
C.M. 26 luglio 1990, n. 205, “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri.
L’educazione interculturale”.
C.M. n. 301 del 1989, Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo:
promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto”.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE E CIES Roma ,7 dicembre 2000 (www. istruzione.it).
L’EDUCAZIONE
INTERCULTURALE
NELLA
SCUOLA
DELL’AUTONOMIA, cd-rom del Ministero della pubblica istruzione,
2001.
DIREZIONE GENERALE PER L’ISTRUZIONE MEDIA NON
STATALE, COORDINAMENTO FORMAZIONE DELGI INSEGNANTI,
Roma, 27 novembre 2000.
ACCORDO DI PROGRAMMA ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE E
ALL’IMMIGRAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA
E LA
SOCIETA’DANTE ALIGHIERI PER LA CERTIFICAZIONE P.L.I.D.A.
DELLA LINGUA ITALIANA aprile 2006 (www. regione.campania.it link politiche sociali).
140
Bibliografia
Cedric Audebert C., Mohamed Kamel Dorai., Migration in a globalised
World, New Research Issues and Prospects, IMISCOE Research,
Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010
Qu
Giuliana Cacciapuoti, Il quaderno d’Italiano, Corso di italiano per arabi,
Luciano editore, Napoli 2011
oe
est
bo
Giuliana Cacciapuoti, MEDIAZIONE CULTURALE: sperimentazioni e
strumenti per l’interazione consapevole nelle esperienze progettuali della
Regione Campania in campo interculturale”, in « Interagendo, Spazi di
confronto delle mediazioni», Università degli Studi di Napoli “S.Orsola
Benincasa”, Elio Sellino editore, Napoli 2007, pp. 169-182
ok
Eleonore Kofman , Gender and International Migration in Europe.
Employment, Welfare and Politics, Routledge, , London-New-York 2000.
Will Kymlicka , La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna,
1999 [1995].
141
Gi
Kammerer P., “Germania: un secolo di politica migratoria” in Gli
immigrati in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte, a cura di Basso
P. e Perocco F., Franco Angeli , Milano, 2003.
a\n
Gerd Hofstede ., Culture’s Consequences , Sage publication, Thousend
Oaks,2001
ne
Giacomo Di Gennaro., Fabio Massimo Lo Verde ,Giuseppe Moro (ed.) «Il
Mezzogiorno dopo la grande regolarizzazione», a cura di Fondazione ISMU
, Franco Angeli, Milano 2006
rtie
Francesca Della Puppa, Lo studente di origine araba, Perugia, Guerra,
2006.
pa
Marcel Crul.,Pathways of success for the children of immigrants, IMES,
University of Amsterdam, Amsterdam, 2007
ap
Giuliana Cacciapuoti, Chiaro Francesco, Cirillo Paola, Nawwartuna,
italiano per arabi, IRRSAE Campania, Napoli 1994 voll. III-IV
Mirella Cassarino intervista Giuliana Cacciapuoti- “Saperi Umanistici e
flussi migratori”, i ,in «Saperi umanistici oggi- Le Forme e La storia»
n.s.IV,2011,1- a cura di 2Antonio Pioletti Rubbettino editore, Catanzaro
2011
Maddalena Toscano, Pamela Wadsworth, Cristiana Massioni (ed.)
Intercultural Communication, Education for a multicultural society Resources for Teachers- U.N.O., Napoli 2003
Massimo Vedovelli., Stefania Massara., Anna Giacalone Ramat A., Lingue
e culture in contatto. L’italiano come L2 per gli arabofoni, Milano, Franco
Angeli, 2004.
1
L
I
_
20
iC
a
p
u
ot
i
a
iuli
an
G
ea
\n
ien
to
Qu
es
e
b
o
ok
p
p
a
rt
a
142
Ca
cc
SECRET SON DI LAILA LALAMI: MEMORIA, RISCRITTURA DEL
PASSATO, INVENZIONE DELL’IDENTITÀ
Mariangiola Li Vigni
Mariangiola Li Vigni
Nel 2004 si laurea in Lingue e Letterature Straniere presso
l’Università degli Studi di Catania (sede di Ragusa) con una tesi sulle
riscritture arabe contemporanee della Storia della Città di Rame delle Mille
e una Notte.
Nel 2012, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Studi Inglesi e
Angloamericani presso l’Ateneo di Catania, discutendo una tesi dal titolo
Discorso antiegemonico e questioni identitarie in Secret Son di Laila
Lalami.
Le sue pubblicazioni includono due articoli – rispettivamente sulle scene
conviviali nelle Mille e una Notte e su al-Shaytàn ya‘iz di Nagìb Mahfùz – e
una rassegna bibliografica sulla letteratura marocchina in lingua inglese.
Attualmente è docente a contratto di lingua araba presso l’Ateneo di
Catania.
Questo ebook appartiene a\nGiuli
ana Cacciapuoti
Abstract
Il contributo è incentrato sul romanzo Secret Son (Algonquin
Books, 2009) di Laila Lalami (Rabat, 1968), scrittrice marocchina
trapiantata negli Stati Uniti che fa parte di quel gruppo di autori «who
negotiate the space of Morocco from outside the nation» (Mimoune, 2009).
In Secret Son, ambientato prevalentemente a Casablanca, Lalami
affronta questioni connesse all’identità e alla memoria. Se la prima è da
intendersi, secondo la visione postmoderna, come il risultato di ‘costruzioni
narrative’ (Holstein-Gubrium, 1999), anche la seconda si connota, di
conseguenza, in quanto ‘narrazione’ e addirittura ‘invenzione’: in Secret
Son, l’identità maschile del capitalista Nabil Amrani è plasmata e
riplasmata dall’infermiera berbera Rachida, la quale compie ogni sforzo
pur di non rivelare al figlio Youssef la verità circa la propria relazione
clandestina con Nabil e le circostanze del suo concepimento. Ora, ciò che
Youssef conosce, attraverso la madre, del passato personale e familiare
veicola le sue percezioni identitarie, progressivamente ridefinite man mano
che emergono nuovi elementi sull’identità paterna.
Una volta presentate le modalità con cui muta e si evolve la
consapevolezza identitaria di Youssef, saranno messe in luce le motivazioni
che hanno condotto il personaggio materno a ‘inventare’, attraverso bugie
143
e reticenze, l’identità di Nabil, evidenziando gli aspetti che concorrono a
configurare Secret Son come discorso antiegemonico e postcoloniale: in
esso, a essere riscattata non è soltanto la marginalità di Rachida – donna,
berbera, proletaria – ma anche l’identità ibrida del protagonista, «halfBerber and half-Arab», grazie alla quale Youssef può infine riconciliarsi
con la madre e con la propria appartenenza nazionale.
In this paper, I focus my attention on the novel Secret Son
(Algonquin Books, 2009) by Laila Lalami (Rabat, 1968), a Moroccan
author living in the USA and belonging to that group of Moroccan-born
writers «who negotiate the space of Morocco from outside the nation»
(Mimoune, 2009).
Secret Son, set mainly in Casablanca, deals with themes related to
memory and identity. If the latter is, in postmodern terms, the product of
narrative constructions (Holstein-Gubrium, 1999), the former is to be
likewise interpreted as ‘narration’ or even ‘invention’: in Secret Son,
capitalist Nabil Amrani’s male identity is narrated by Rachida, a Berber
nurse who has been fighting for all her life to hide from Youssef, her son,
the truth about her affair with Nabil and the way he was conceived. It is
precisely what Youssef knows about his personal and family past that
shapes his identity perception, which is gradually redefined while new
ingredients make clear his father’s identity.
Once the evolution of Youssef’s identity awareness is described,
attention will be paid to the reasons which led Rachida to lie and invent
Nabil’s identity, underlining those aspects of the novel allowing to consider
it as a postcolonial and anti-hegemonic discourse: in Secret Son, together
with Rachida’s marginality as a woman, a Berber and a proletarian, it is
the protagonist’s hybrid identity («half-Berber and half-Arab») to be
redeemed: through that hybridity, also characterizing culture and history of
Morocco, Youssef can finally reconcile himself with his mother and his
national belonging.
L’opera di Laila Lalami, scrittrice marocchina trapiantata negli
Stati Uniti,245 si pone in relazione con alcune tradizioni letterarie – la
245 Laila Lalami è nata nel 1968 a Rabat, da una famiglia della piccola borghesia. Risiede in
California dal 1992; attualmente insegna, in qualità di Assistant Professor, scrittura creativa
alla University of California, Riverside. Nel 2003, è stata insignita del British Council Literary
Prize per la short story El Dorado, nucleo narrativo del successivo romanzo Hope and Other
144
Q
produzione araba e, al suo interno, quella marocchina di espressione inglese
– che di recente hanno suscitato un certo interesse da parte della critica
occidentale.246 Immigrata di prima generazione, Lalami. Tali autori
sembrano avvertire particolarmente l’urgenza di rappresentare le culture e le
società di provenienza, negoziando lo spazio della madrepatria dal luogo
della diaspora statunitense.247
1
0
I_
2
L
ti
C
o
ap
u
i
ac
c
na
C
ia
iu
l
G
a\
n
Dangerous Pursuits, Algonquin Books, Chapel Hill 2005 (edizione italiana: La speranza e
altri sogni pericolosi, trad. di Maria G. Cavallo, Fusi Orari, Roma 2007).
246 Tra gli studi pubblicati sulle letteratura araba anglofona, indico almeno: l’articolo di Hilary
Kilpatrick Arab Fiction in English: A Case of Dual Nationality, in «New Comparison» 13,
1992, pp. 46-55; i due volumi di Geoffrey P. Nash: The Arab Writer in English: Arab Themes
in a Metropolitan Language, 1908-1958, Sussex Academic Press, Portland 1998, e The AngloArab Encounter. Fiction and Autobiography by Arab Writers in English, Peter Lang, Berna
2007. Sulla produzione arabo-americana, si rimanda a: Steven Salaita, Arab American Literary
Fictions, Cultures, and Politics, Palgrave Macmillan, New York-Basingstoke 2007; e al
volume miscellaneo Arab Voices in Diaspora. Critical Perspectives on Anglophone Arab
Literature, a cura di Layla Al Maleh, Rodopi, Amsterdam-New York 2009. In Marocco,
l’esistenza di un corpus di testi letterari scritti originariamente in inglese è stata più volte
segnalata da Mohamed Laamiri, il quale ha curato la pubblicazione di un’antologia nel 2001
(Moroccan Literature in English: A Selection from the First Forum for Moroccan Creative
Writers in English Organised by the English Department, Oujda, in Collaboration with the
British Council Rabat, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Oujda), e ha pubblicato,
nel 2008, una bibliografia di testi in inglese di autori marocchini e tunisini. La bibliografia è
preceduta da un’introduzione critica dello stesso Laamiri, il quale scorge in questa produzione
originale «the first harbingers of a new era where silenced cultures acquire an English voice».
Cfr. Mohamed Laamiri, On Maghrebi Literature in English, <http://medi-cafe.
britishcouncil.org/news/_17/>
247 È in questi termini che si è espresso il giovane critico marocchino Daoudi Mimoune in un
contributo sul romanzo Si Yussef (1992) di Anouar Majid. Cfr. Tangier: A Space Reconstructed
in Anwar Majid’s Si Yussef, in Tangier at the Crossroads, Volume II: The International
Conference Performing Tangier 2008, a cura di Khalid Amine et al, Altopress, Tangeri 2009,
pp. 233-8: 233.
248 Algonquin Books, Chapel Hill.
e
tie
n
p
a
r
k
ap
bo
o
st
o
e
ue
Q
69
1
9
3
0
3
0
13
0
Secret Son (2009), su cui si incentra il presente studio è il secondo
romanzo di Lalami,248 è un’opera che, nel proporre una visione del Marocco
contemporaneo ‘dall’interno’, riprende temi distintivi delle letterature
transnazionali, a cominciare da quelli connessi all’emigrazione, all’identità
e alla memoria: nel romanzo, scritto in terza persona, è possibile
rintracciare, infatti, parte dell’esperienza della stessa autrice, attenta a
rappresentare i personaggi durante i loro spostamenti tra due luoghi o tra
due continenti. Proprio le situazioni di ibridismo e liminalità che
contraddistinguono le vicende ed esistenze di alcuni dei personaggi
principali permettono una lettura postcoloniale e antiegemonica del
145
romanzo, in cui a essere prediletta è la prospettiva ‘dai margini’, in termini
etnici, culturali, di classe e di genere.
Secret Son, ambientato quasi interamente a Casablanca in un arco
temporale – circa tre anni – posteriore al 2004,249 è la storia del giovane
Youssef, il quale, avendo trascorso l’intera esistenza, insieme alla madre
Rachida, in una casa piccola e fatiscente di Hay An Najat (nome fittizio di
un quartiere popolare di Casablanca), scopre all’improvviso di essere il
figlio illegittimo di un noto imprenditore della città, Nabil Amrani; dopo
avere trascorso due anni nell’appartamento paterno situato nella zona
residenziale di Anfa, il protagonista è costretto a far ritorno a Hay An
Najat,250 dove, avendo visto fallire ogni onesto tentativo di trovare
un’occupazione, accetta di essere coinvolto dal gruppo fondamentalista di
Hatim Lahlou nell’omicidio del giornalista Farid Benaboud. La vicenda si
conclude con l’arresto di Youssef.
Il romanzo riproduce, attraverso le dicotomie Anfa/Hay An Najat,
capitalisti/proletari, quel dualismo socioeconomico distintivo delle società
249 Nel racconto, compare due volte la data del 16 maggio 2003, in cui si sono verificati, a
Casablanca, gravi attentati terroristici contro obiettivi israeliani ed europei (Lalami ha dedicato
all’evento un contributo online: Days of Terror, <http://www.huffingtonpost.com/lailalalami/days-of-terror_b_ 21069.html>). Ma il romanzo contiene altresì un riferimento allo
tsunami che si è abbattuto sulle coste meridionali dell’Asia il 26 dicembre 2004, e invita
pertanto a posticipare l’inizio della trama di quasi due anni, facendolo coincidere almeno con il
marzo successivo («“We’re already in March,” [Rachida] said»; Laila Lalami, Secret Son, cit.,
p. 4).
250 Preoccupata dalle trasformazioni subite dal figlio a contatto con il padre, Rachida rivela a
Malika, moglie di Nabil, la verità su Youssef, e la donna ottiene l’espulsione del giovane da
Anfa. L’esperienza del ritorno a Hay An Najat – regressione al passato, al mondo dell’infanzia
– si configura come un vero e proprio trauma per il protagonista. Il trauma di Youssef ricorda,
in parte, quello del reduce dalla Grande Guerra. Secondo Giovanni De Leva, il ritorno in patria
del reduce sancisce il fallimento di un percorso di formazione: «Partito con l’intenzione di
provare se stesso, il volontario scopre che la guerra di trincea nega la possibilità di cimentare il
proprio valore, di forgiare dunque una nuova identità. La delusione di tale aspettativa comporta
il primo ostacolo alla reintegrazione del reduce». Giovanni De Leva, Il ritorno del reduce, in
Esilio, Quaderni di Synapsis VII, Atti della Scuola Europea di Studi Comparati (Pontignano,
18-25 settembre 2006), a cura di Roberto Russi, Le Monnier, Firenze 2008, pp. 217-25: 217. Il
processo di reintegrazione risulta solo parziale, secondo De Leva, in quanto l’esperienza della
guerra non ha permesso al reduce di plasmare una nuova identità in grado di garantirgli fama e
prestigio: la guerra viene vissuta come un’occasione mancata. In termini analoghi è possibile
interpretare la vicenda del protagonista di Secret Son. Tornando a casa dalla madre –
recedendo, cioè, allo spazio dell’infanzia –, Youssef riconosce il fallimento della propria
ricerca identitaria: «He realized now that he had only played the part of Youssef Amrani, but
all along he had remained Youssef El Mekki». Laila Lalami, Secret Son, cit., p. 192. La
convivenza con il padre è stata, anche per Youssef, un’occasione mancata.
Questo ebo
146
dei paesi in via di sviluppo,251 che converge simbolicamente nella
contrapposizione Nabil/Rachida: in essa, le connotazioni di genere si
arricchiscono di connotazioni sociali, etniche e culturali, dal momento che
Nabil Amrani è un arabo alto-borghese,252 laddove la madre di Youssef
proviene dal villaggio ‘periferico’ di Sefrou ed è berbera. Proprio
l’appartenenza di Nabil all’etnia araba ‘dominante’, insieme alla sua identità
di uomo e capitalista, contribuisce a definire il suo ruolo egemone nei
riguardi di Rachida, discendente degli antichi abitanti del Marocco che
furono colonizzati dagli arabi tra VII e VIII secolo.
In Secret Son, si trova traccia di quella che, in Algeria e in
Marocco, è stata definita la question berbère, generata dalle rivendicazioni
avanzate dalle popolazioni berbere in materia di diritti culturali e linguistici
di fronte ai processi di islamizzazione e arabizzazione che hanno
attraversato i due paesi nordafricani nel periodo postcoloniale.253 Ad
esempio gli studenti berberi dell’università frequentata da Youssef
avanzano richieste precise finalizzate alla creazione di un dipartimento di
lingua e cultura berbera:254
«The university already had departments of Arabic, French,
English, Spanish, and German, so why, the Berber Student Alliance
demanded, did it not have one for Tamazight? This was
discrimination, they argued, part of a long-standing pattern in this
country»255.
251 Sono stati, per primi, gli economisti a impiegare il termine ‘dualismo’ in riferimento a tali
società, in cui forme di economia tradizionale coesistono con un’economia moderna importata
dalle società economicamente più avanzate. Cfr. André Adam, Les classes sociales urbaines au
Maroc, in «Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée» 8, 1970, pp. 223-38: 224.
252 Sull’origine straniera della classe borghese nel mondo arabo per ‘Abdallàh al-‘Arwi, cfr.
Zouhir Louassini, Il romanzo marocchino: l’ora del lettore, in Le letterature del Maghreb:
recupero della tradizione o risposta all’egemonia culturale?, a cura di Isabella Camera
D’Afflitto, volume speciale di «Oriente Moderno» 16/2-3, n.s., 1997, pp. 267-74: 271.
253 Sulla question berbère, cfr. Maxime Ait Kaki, De la question berbère au dilemme kabyle à
l’aube du XXIème siècle, préface de Charles Zorgbibe, L’Harmattan, Paris 2004.
254 In Marocco, l’esigenza di istituire strutture di ricerca e dipartimenti allo scopo di
preservare e divulgare la lingua Tamazight, sfociata, nel 2001, nella fondazione del Ma‘had alMalaki li-th-Thaqafah ’l-Amazighiyyah (Giuliano Mion, La lingua araba, Carocci, Roma
2007, p. 132), è stata dettata dall’uso quasi esclusivamente orale del berbero, lingua che non
presenta un sistema di trascrizione unanimemente riconosciuto. Tale è stato il peso delle
battaglie portate avanti dai berberi del Marocco che lo statuto di lingua ufficiale del paese,
accanto all’arabo, è oggi riconosciuto al berbero dalla stessa costituzione marocchina, la sesta
dall’indipendenza del paese, ratificata nel 2001.
255 Laila Lalami, Secret Son, cit., p. 28.
Qu
est
oe
boo
ka
ppa
rtie
ne
a\n
Giu
lian
aC
acc
iap
147
uot
i CL
I
cia
c
Ca
a
n
ulia
e
Gi
n
\
a
Le strategie adottate nel romanzo sono antiegemoniche nella
misura in cui, fra l’altro, al berbero, lingua della madre – e della memoria –,
è riservato un ruolo centrale nel processo di definizione identitaria di
Youssef, poiché sarà proprio una frase in berbero pronunciata da Rachida a
chiarire al protagonista la verità sulla propria discendenza:
p
ka
p
ien
t
r
a
«She needed him to believe her. She took a deep breath, and when she
released it, she spoke in the language of her childhood, in Tamazight,
the words rolling on her tongue like a declaration of love. “Hati
lmaaqul aktinigh, aywi, amni.”256 “It’s true, then,” [Youssef] said.257».
e
eb
o
t
s
oo
Secret Son suggerisce, dunque, uno strettissimo legame tra berbero,
madre e memoria: Rachida è, infatti, l’unica depositaria, attraverso la lingua
ancestrale, della verità sulle origini, e la sola testimone in grado di far
conoscere al giovane figlio gli eventi del passato; tuttavia, la donna mente a
lungo sull’identità del padre di Youssef e sulle circostanze del suo
concepimento.
Qu
L’identità è, per i postmoderni, il risultato di atti narrativi; scrivono
Holstein e Gubrium:
«Increasingly, we’re hearing that our lives are storied [...]. Not only is
there a story of the self, but it’s been said that the self, itself, is
narratively constructed. [...] constructions of the self are conditioned
by working senses of what we should be at particular times and
places258».
In Secret Son, anche la memoria, presupposto dell’identità, si
configura in quanto narrazione: Rachida inventa la memoria – prodotto di
rappresentazioni e ricostruzioni, più che dato naturale ed empirico – e la
narra a Youssef;259 quelle di Rachida sono ‘storie orali’260 sull’identità del
padre assente e sulle circostanze accidentali della sua morte.
256 ‘Ecco, te lo dirò’.
257 Laila Lalami, Secret Son, cit., p. 281.
258 James A. Holstein, Jaber F. Gubrium, The Self We Live By. Narrative Identity in a
Postmodern World, Oxford University Press, New York-Oxford 2000, p. 3.
259 I racconti di Rachida risultano soggetti alle variabili di qualunque narrazione: voce, punto
di vista, velocità narrativa. Centralità del testimone e testimonianza in quanto narrazione sono
due delle principali questioni connesse alla trasmissione della memoria secondo Vincenzo
Matera. Cfr. Eventi di memoria, in Ugo Fabietti, Vincenzo Matera, Memorie e identità. Simboli
e strategie del ricordo, Meltemi, Roma 1999, pp. 91-117: 91.
260 Alessandro Portelli, Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo, introd. di Ronald
Grele, Donzelli Editore, Roma 2007.
148
ar
Qu
e
o
t
s
e
bo
pp
ok a
L’identità, scrive Ugo Fabietti, è un prodotto della memoria, e in quanto tale
è costruita grazie a «un processo selettivo che ricorda certe cose e ne
dimentica altre».261 In Secret Son, l’oblio (al quale Rachida ha consegnato
tutto ciò che riguarda la propria esistenza fino al momento della relazione
clandestina con Nabil) non è un fatto naturale dovuto alla distanza
temporale degli eventi narrati, ma è piuttosto un atto volontario con il quale
la madre di Youssef tace i fatti reali per riferirne altri, frutto di invenzione.
Ora, come ha osservato Alessandro Portelli:
«L’interesse della testimonianza non consiste solo nella sua
aderenza ai fatti ma anche nella sua divaricazione da essi, perché
in questo scarto si insinua l’immaginazione, il simbolico, il
desiderio»262.
Si potrebbe dire, ancora con Fabietti, che Rachida metta in atto una
‘politica della memoria’ «finalizzata al perseguimento di obiettivi
determinati»:263 in questo caso, l’invenzione dei ricordi è funzionale a
orientare le scelte e, dunque, il destino di Youssef; dato il vincolo che esiste
tra identità e memoria, infatti, ciò che il protagonista conosce del proprio
passato, inventato dalla madre attraverso narrazioni volutamente artificiose
e reticenti, influisce sulla sua consapevolezza identitaria e concorre altresì a
determinare le sue attese per il futuro.
Nel primo dei racconti proposti da Rachida al figlio, Nabil El
Mekki, nome che la madre da’ al padre di Youssef morto cadendo giù dal
tetto, quando il protagonista aveva solo due anni, – era «a fourth-grade
teacher, respected by colleagues and students alike for his dedication».264
Quest’ultimo dato non è casuale, dal momento che, tra le aspettative di
Rachida per il figlio, rientrano il completamento della formazione scolastica
e l’impiego fisso presso un ufficio o un’istituzione pubblica. I racconti di
Rachida, a sua volta impiegata come infermiera in un ospedale, hanno
svolto un ruolo importante nel trasmettere a Youssef l’ideale del lavoro
statale dipendente:
«All his life, he had dreamed of becoming an actor. [...] Of course,
Youssef knew that his dream was unachievable – no different than
261 Ugo Fabietti, La memoria come processo selettivo: ricordo e oblio, in Ugo Fabietti,
Vincenzo Matera, Memorie e identità, cit., pp. 13-6: 14.
262 Alessandro Portelli, Storie orali, cit., p. 13.
263 Ugo Fabietti, Memorie, culture e identità, in Ugo Fabietti, Vincenzo Matera, Memorie e
identità, cit., pp. 9-13: 11.
264 Laila Lalami, Secret Son, cit., p. 7.
149
wanting to win the lottery when you can’t even afford to buy a ticket –
but it provided a refuge from the more sobering turns he knew his life
would, by necessity, have to take: finish high school, go to university,
and, with any luck, find a steady job that would finally get his mother
and him out of Hay An Najat265».
Nel giorno della promozione di Youssef, Rachida inventa un nuovo
racconto sull’identità paterna:
«“I passed,” [Youssef] announced, as soon as he pushed the door
open. “Praise be to God,” his mother said [...]. Youssef had never seen
his mother so happy. [...] “I’m going to make something special for
dinner tonight,” she said. “What would you like?” His thoughts drifted
to his father, as they always did on special occasions. “If only he
could have seen me,” he said. Her face returned to its usual cautious
seriousness. “What’s wrong?” he asked. [...] “What is it that you’re
hiding from me?” “Nothing.” Youssef took the shirt from her hand.
“Tell me,” he said»266.
Il genitore di Youssef, ora presentato come un avvocato di nome,
risulta chiamarsi Nabil Amrani. Rachida narra di averlo conosciuto in
ospedale, dove Nabil si sarebbe recato dopo essere rimasto ferito durante
uno scontro con la polizia. Stando a questa nuova versione, inoltre, il
concepimento di Youssef sarebbe avvenuto al di fuori del vincolo
matrimoniale, mentre la morte di Nabil sarebbe stata causata, una settimana
prima delle nozze, da un incidente stradale.
Il racconto di Rachida genera un improvviso mutamento nell’autopercezione di Youssef, nonché nelle sue aspettative per l’avvenire:
«When he still believed he was the son of a respectable schoolteacher,
he had modest but clear ambitions – to become a teacher himself or
perhaps a civil servant. But now that he knew he was the illegitimate
son of a community organizer, he felt somehow diminished, as though
he were already marked for an unfavorable future267».
ook
Questo eb
265 Ivi, p. 6.
266 Ivi, pp. 22-3.
267 Ivi, p. 26.
150
appartie
La prima parte della verità è ormai nota a Youssef, il suo essere,
cioè, un figlio illegittimo («It was a tale of outrageous misfortune, and yet it
was utterly ordinary: he had been born an illegitimate child»).268
È per il tramite di Hatim Lahlou, presidente di Al Hizb, che
vengono alla luce le menzogne di Rachida e si verifica il progressivo
sfaldamento dell’universo fittizio da lei creato. Hatim è il portavoce di
un’opposizione strisciante al governo ufficiale e alle fasce sociali
progressiste e intellettuali simboleggiate da Nabil Amrani e dall’amico
Farid Benaboud. Ma il fondamentalismo è rappresentato in tutto il suo
potenziale sovversivo, oltre che verso l’ordine statale e sociale costituito,
anche rispetto a un diverso tipo di autorità: quella, tutta privata e domestica,
di Rachida.
Al termine dell’alluvione, Hatim fa ristrutturare, a Hay An Najat,
l’edificio dello Star Cinema, ove stabilisce la sede di Al Hizb, offrendo ogni
settimana la proiezione gratuita di un film. La prima pellicola è Fatmah,
film egiziano del 1947 diretto da Ahmed Badrakhan e interpretato da Umm
Kulthum e Anwar Wajdi. La trama, che presenta alcuni aspetti in comune
con la storia di Youssef e Rachida,269 stimola, al termine della proiezione,
un dibattito, condotto dallo stesso Hatim, sul significato morale del film:
Qu
es
«“Umm Kulthum’s misery is her own fault. This is what happens
when Muslim women engage in relations with dissolute men. That
is the message of this movie. Let it be a warning to the sisters in
the audience.” And with this, he stared down the single teenage
girl who was in attendance»270.
toIl
discorso patriarcale di Hatim sembra rivolto alla sola
componente femminile della platea, ritenuta quasi la principale responsabile
della moralità collettiva in Marocco; non è un caso che proprio la visione di
Fatmah segni l’inizio delle tensioni tra Youssef e Rachida, in quanto porta
alla luce i sospetti del protagonista riguardo alla madre e alla ‘sua’ storia
(«he had always felt that something was amiss in the stories she had told
eb
oo
ka
pp
art
ien
ea
\nG
iul
ian
268 Ivi, p. 24.
269 Fatmah è, come Rachida, un’umile infermiera; chiamata in casa del pashà ammalato per
curarlo, Fatmah vi risiede per un lungo periodo, durante il quale desta le attenzioni del fratello
più giovane del pashà, Fathy. Quest’ultimo, già fidanzato e prossimo a sposarsi, seduce
Fatmah, la sposa e subito dopo la abbandona; Fatmah dà alla luce un figlio maschio, che Fathy,
trascinato in tribunale dai vicini di Fatmah, rifiuta di riconoscere. Solo all’epilogo del film,
l’uomo, tradito dalla fidanzata e deluso, fa ritorno dalla sposa e dal figlio.
270 Laila Lalami, Secret Son, cit., p. 20.
aC
ac
151
cia
pu
oti
CL
I_2
01
30
him»).271 Al film Fatmah e al gruppo fondamentalista che lo ha selezionato
per la proiezione, è affidato il ruolo di ristabilire l’ordine, contro il
(dis)ordine creato dalla figura materna: il film è il primo degli indizi grazie
ai quali Youssef verrà a conoscenza della relazione clandestina della madre
con Nabil. È significativo, peraltro, che la trama di Fatmah, sempre
presentata dal punto di vista di Youssef, risulti, per così dire, mutilata in
modo da focalizzare l’attenzione del lettore sugli aspetti che la vicenda della
protagonista ha in comune con quella di Rachida: così, ad esempio, sono
omessi sia il fatto che il concepimento di Fatmah sia avvenuto nel contesto
di un’unione coniugale, sia il lieto fine:
«[Youssef] watched as the righteous Umm Kulthum was seduced
by the debonair Wajdi, who later abandoned her when she became
pregnant»272.
«He told [Rachida] about the movie, describing how Umm
Kulthum had been deceived, how she had fallen in love with the
handsome Anwar Wajdi, how she had had to go to court to prove
the baby’s paternity»273.
La fiction proiettata sullo schermo cinematografico, lungi dal
distogliere il protagonista dalla realtà, in questo caso induce piuttosto a
interrogarla ed esplorarla, permettendone il progressivo svelamento.274
Il secondo indizio fornito a Youssef da Hatim è la fotografia a
colori di Nabil Amrani, pubblicata sulla rivista Casablanca Magazine
diretta da Farid Benaboud:
«[Youssef] unfolded the magazine. On the opposite page was a
color picture of a middle-aged man, under the headline NABIL
271 Ivi, p. 21.
272 Ivi, p. 20.
273 Ivi, pp. 20-1.
274 Il rapporto della fiction con la storia appare qui invertito rispetto a quello evidenziato dalla
critica settecentesca a proposito del romanzo moderno, inteso come narrazione fantastica priva
di qualsiasi legame con la realtà. Sull’approccio della critica italiana al romanzo del XVIII
secolo, cfr. Nunzio Zago, Due romanzieri del Settecento: Chiari e Piazza, in Id., La parola
reticente nel Decameron e altri saggi, Salarchi Immagini, Comiso 2000, pp. 53-85. Nel caso di
Fatmah, viceversa, la citazione diventa componente interessante di una riflessione metatestuale
sulla coincidenza tra fiction e vita. Tra ipotesto e ipertesto si stabilisce una relazione per certi
versi analoga a quella che intercorre tra il quinto canto dell’Inferno dantesco e il libro
‘galeotto’ su Ginevra e Lancillotto. Se, tuttavia, nella Divina Commedia, il libro arturiano è
anticipazione e prefigurazione del gesto dei personaggi, in Secret Son, la visione di Fatmah
svela per via analettica la colpa commessa da Rachida un ventennio prima.
152
es
Qu
AMRANI: ‘OUR BUSINESSES ARE TREATED UNFAIRLY.’
Youssef stared at the man in the picture, at his blue eyes and
aquiline nose, his dark hair and wide forehead. [...] Could this be
his father?»275.
Questo e
boo
k
a
p
p
a
r
tiene a\n
La foto sulla rivista svela la menzogna di un altro documento,
l’immagine in bianco e nero che il protagonista ha ricevuto dalla madre, e
che ha finora ritenuto l’unico ricordo del padre morto. La foto rappresenta:
«a young man in his twenties, in a dark suit and gray tie, with his
hair combed back neatly, as if he were on his way to an important
appointment. His smile was timid, or perhaps reluctant; Youssef
had never been able to tell»276.
Giulia
Si tratta di un ‘oggetto della memoria’277 fabbricato da Rachida a
sostegno delle proprie narrazioni sulla figura di Nabil, così come la madre
di Youssef l’ha plasmata e inventata. Di nuovo, è parte di quel mondo
narrato da Rachida che va in frantumi, e ancora una volta per mano di
Hatim. Il ruolo riconosciuto al fondamentalismo nel romanzo è,
chiaramente, quello di scuotere le sicurezze esistenziali del protagonista e di
avviare la sua ricerca identitaria che sfocia nella ricerca del padre e nel
temporaneo abbandono della madre. Ma in Hatim, l’autrice rappresenta
anche, almeno inizialmente, il difensore dell’ordine garantito dalla ‘legge
del padre’ contro il ‘caos del matriarcato’: ciò che conta, nella società
patrilineare rappresentata nel romanzo, è la discendenza dal padre, dal quale
si ereditano il nome e il cognome.
La conferma, da parte della madre, che l’uomo fotografato sulla
rivista Casablanca Magazine è il vero padre di Youssef segna il momento
di maggiore pathos del romanzo:
na Cacc
ia
p
u
o
t
i
C
LI_2013
0
«“Is this ... him?” She nodded once and handed him back the
magazine. He ran into the bedroom again, this time returning with
the framed black-and-white photograph. “Then who is this?” [...]
“Youssef Boualem.” [...] With all his might, and without being
275 Laila Lalami, Secret Son, cit., pp. 36-7.
276 Ivi, p. 4.
277 Cfr. Ugo Fabietti, Oggetti di memoria, in Ugo Fabietti, Vincenzo Matera, Memorie e
identità, cit., pp. 63-89. Per Fabietti, gli oggetti della memoria sono «quei prodotti materiali
dell’attività umana che acquistano un alto valore simbolico per il fatto di condensare alcune
rappresentazioni cruciali del passato della comunità». Ivi, p. 63. Le fotografie sono oggettidocumenti importanti per ricostruire il passato di una comunità, specie familiare.
03039
153
1
69
9
03
3
0
30
20
_
I
L
1
aware that he was howling, Youssef threw the frame against the
wall. Glass shards flew across the yard. “Why?” he asked. “Why
didn’t you tell me the truth? All of it?”»278.
iap
ti
uo
C
Ad andare in frantumi è, insieme al quadro, la consapevolezza
identitaria del protagonista, la quale perde ora unità e stabilità, mentre il
personaggio vede moltiplicarsi le opportunità di riconoscersi in nuove
immagini e identità compatibili con il ruolo sociale di Youssef Amrani:
i
\nG
ul
a
ian
C
c
ac
«He stared at the name for a long while, wondering what kind of a
person Youssef Amrani was. His existence until that moment had
been nothing more than a role – he had played the part of Youssef
El Mekki, lived in his house, eaten his food, slept in his bed, and
gone out with his friends, but all along he had been Youssef
Amrani. That was who he really was. If he could be Youssef
Amrani, he would not have to play any part at all. He could be, at
long last, himself»279.
e
ien
a
Nel frattempo, muta anche il modo del protagonista di accostarsi,
ad esempio, alla letteratura. Finché si credeva orfano, infatti, Youssef:
ok
pa
ap
rt
«had [...] felt a special kinship with the fatherless heroes of
literature – from Inspector Ali to Tom Sawyer, from Batman to
David Copperfield – but now he saw that all along he had been
like everyone else; he had a father and a mother».280
t
es
u
Q
bo
e
o
La ridefinizione delle percezioni di Youssef sulla propria identità va,
dunque, di pari passo con le progressive rivelazioni sul conto del padre.
La scoperta che il padre è vivo ed è un capitalista offre a Youssef un
rinnovato sguardo verso il passato e nuove prospettive per il futuro. Il
protagonista incontra Nabil Amrani nel suo ufficio ad Anfa, e riceve da
lui le chiavi di un appartamento sito nel medesimo quartiere, ove il
giovane si trasferisce senza la madre. È a questo punto che ha inizio la
sua metamorfosi, dovuta all’imitazione degli stili di vita e dei modi di
vestire e agire del padre.281 Ma Nabil trasmette al figlio soprattutto il
278 Laila Lalami, Secret Son, cit., pp. 40-1.
279 Ivi, p. 73.
280 Ivi, p. 42.
281 «Youssef watched his father. And he learned». Ivi, p. 126. il personaggio è colto nel
dilemma tipicamente moderno che impone, in cambio del progresso economico e di altri
benefici, la rinuncia a una parte della propria identità originaria, nonché costi, come hanno
154
proprio scetticismo nei riguardi della formazione teorica e del sistema
universitario marocchino, il quale «churns out graduates who have no
marketable skills».282 Progressivamente, Youssef si disinteressa agli
studi letterari, fino ad abbandonare definitivamente l’università,
contravvenendo alle attese di Rachida, e ad accettare l’impiego offerto
dal padre nell’albergo di sua proprietà.
È da Nabil, infine, che Youssef apprende che, al momento del
suo concepimento, non soltanto Nabil era già coniugato, ma la coppia
era in attesa della figlia Amal. La scoperta contribuisce a incrinare il
rapporto di Youssef con la madre:
«“The picture on your desk – that’s your daughter?” [...] “Amal.”
“And how old is she?” “Twenty.” “Twenty?” he repeated,
incredulously. His mother had told him that she and his father
had planned on getting married; she had never mentioned that he
was already married – or that he had a child. “And a half. She
turned twenty in January.” They were only six months apart in
age. Her mother had been pregnant with her when his own
mother had gotten pregnant. Why had his mother not told him
this? [...] Did her lies ever end? What else was she hiding?»283.
Le ripetute menzogne di Rachida fanno della madre di Youssef
uno dei personaggi più ambigui del romanzo; le ragioni che hanno indotto
Rachida a mentire sono svelate verso la fine del racconto, quando il lettore
e, successivamente, lo stesso protagonista, scoprono la vera storia del
personaggio materno dalla sua stessa voce: Rachida vanta nobili origini
berbere, discendendo da una famiglia di cavalieri e proprietari terrieri della
regione di Fes; in seguito alla morte della madre, è affidata dal padre
Hammou a un orfanotrofio, dove apprende il mestiere di ostetrica, che ha
modo di praticare a Fes, in casa Amrani. Sedotta da Nabil, viene presto
allontanata dalla madre di lui, ricevendo il denaro necessario per l’aborto;
tuttavia, Rachida, abbandonata la famiglia, dà alla luce Youssef,
stabilendosi con lui a Casablanca e costruendo nuove identità per sé e per il
figlio.284
spiegato Berger e Kellner, in termini di ‘dislocation’, ‘disorientation’, ‘rootlessness’. Peter L.
Berger, Hansfried Kellner, Sociology Reinterpreted. An Essay on Method and Vocation,
Anchor Press/Doubleday, Garden City 1981, p. 148.
282 Laila Lalami, Secret Son, cit., p. 122.
283 Ivi, p. 99.
284 Attraverso la rivelazione dei drammi e delle sofferenze private di Rachida, si crea
un’empatia tra il lettore e il personaggio, del quale emergono i moti psicologici e gli impulsi
155
Quest
Il racconto di Rachida, per la prima volta attendibile e autentico,
riscatta Youssef e il suo senso di appartenenza alla comunità nazionale
marocchina, che si riconosce nelle due componenti principali araba e
berbera. Queste ultime definiscono inequivocabilmente anche l’identità del
protagonista:
«He was an Ouchak from Sefrou on his mother’s side, and an Amrani
from Fès on his father’s side. He was half-Berber and half-Arab; he was
a man of the mountains, and a man of the city; a man of the people and
an aristocrat; a full-blooded Moroccan, with the culture and the history
of a thousand years – a rich identity, of which he could be proud.285
Proprio la duplice origine araba e berbera di Youssef gli permette di
assurgere a metafora di un’identità nazionale marocchina ‘autenticamente’
ibrida, facendo sì che Secret Son si configuri, al pari di altri testi marocchini
contemporanei, come esempio di allegoria nazionale. Ecco che anche la
memoria può finalmente recuperare la propria funzione, creando vincoli
indissolubili con la comunità di appartenenza e permettendo la
riappropriazione dell’identità personale e collettiva. In questo caso, inoltre,
il ricordo svolge una funzione salvifica nei confronti di Youssef: confessare
di essere berbera serve, infatti, a Rachida per convincere il figlio a tenersi
lontano dall’amico Maati, che lavora per Al Hizb e che Rachida ha udito
discutere, in lingua berbera e su questioni segrete connesse al ‘Partito’, con
un agente in borghese.
Le rivelazioni in berbero rendono dunque possibile, agli occhi del
protagonista, il riscatto della figura materna:
«The only constant in his life was his mother. She had played the role
of the widow, when she had never had a husband; the role of an
orphan, when all along she had had a father. She had done it for him.
più profondi. I personaggi di Secret Son non sono classificabili, semplicisticamente, in buoni e
cattivi. L’utilizzo peculiare che Lalami fa del punto di vista, con il narratore focalizzato,
alternativamente, su Youssef, Rachida, Amal e Nabil, permette di cogliere i pensieri, i
sentimenti, i ricordi di ciascuno di essi, rendendo più chiare e coerenti le azioni e motivazioni
di due personaggi apparentemente ambigui come Rachida e Nabil. Laila Lalami fa uso, inoltre,
della tecnica della ‘narrazione speculare’, che consiste proprio nel presentare un medesimo
episodio dal punto di vista dei diversi personaggi coinvolti; ciò si verifica in due occasioni nel
testo: quando il narratore riferisce il primo incontro tra Youssef e Nabil (capitoli Lost and
Found e The Other Side) e, successivamente, l’unico incontro tra Rachida e Amal (capitoli
Secrets and Lies e Heavens and Hells), adottando la prospettiva di ciascun personaggio.
285 Laila Lalami, Secret Son, cit., p. 282.
156
Questo
ebook a
ppa
She had lied her way through his life, and yet she had also given him
the only certainty in it – her love. In the end, she was his only
home».286
Secret Son si configura come discorso antiegemonico e postcoloniale
sotto diversi aspetti. Anzitutto, il romanzo sfida le associazioni spaziali
convenzionali dei concetti di verità e ambiguità, e in particolare il postulato
coloniale per cui «being itself is located at the centre»:287 è dalla parte di
Rachida, non di Nabil, che risiede la verità, confermata dal ricorso al
berbero, poiché è solo esprimendosi nella lingua dei suoi antenati che
Rachida può convincere Youssef di avere compreso fino in fondo la
conversazione tra Maati e l’ufficiale di polizia. Rachida è, insieme ad Amal
Amrani, la vera eroina del romanzo, laddove i personaggi maschili, primo
fra tutti Nabil, sono costruiti in modo da mancare di coerenza e, soprattutto,
di attendibilità: è emblematico, a proposito della fallibilità della memoria,
l’episodio che vede Nabil dinanzi al figlio per la prima volta; benché
Youssef si sia presentato come il figlio di Rachida Ouchak, è solo la
constatazione della somiglianza fisica che rammenta a Nabil quanto
accaduto vent’anni prima:
«In his shock, he reserved a moment of wonder for the work that
memory could do, and for the fact that it could preserve as well as
erase details of the past. When he had heard that Rachida Ouchak’s
son was downstairs, he had simply assumed that she had married and
had had children by this El Mekki whose name Youssef bore. He
simply did not think about her pregnancy or about the abortion she
was supposed to have had».288
artiene a\nG
app
Questo ebook
Lo stesso Nabil non ha mancato di mentire a Malika e ad Amal e di
tacere la verità suYoussef; ed è proprio Rachida a smascherare Nabil
allorché Amal si reca a Hay An Najat per incontrare il fratello: «“How
could he not have known?” [...] “Youssef is his son. He knew”».289
Nel quartiere paterno, inoltre, il protagonista crede di poter
finalmente trovare il suo ‘io’ autentico e di poter essere se stesso, Youssef
Amrani; tuttavia, la posizione sociale di Nabil non gli consente di rivelare il
286 Laila Lalami, Secret Son, cit., p. 283.
287 The Empire Writes Back, a cura di Bill Ashcroft et al, Routledge, London-New York 2002,
p. 89.
288 Laila Lalami, Secret Son, cit., pp. 86-7.
289 Ivi, p. 239.
157
figlio segreto, e così Youssef sarà per tutti, ad Anfa, il lontano parente di
Meknes:
«So went the lie. They became good at it, both of them, Nabil
doing the introductions most of the time, but Youssef chipping in
when someone asked him who he was, with the exact role that his
father had picked for him».290
Ed è sempre nel quartiere borghese di Anfa che si consuma il
dramma finale di Youssef, causato dall’ambigua complicità del partito
fondamentalista e dello stato marocchino: coinvolto nel piano terrorista
concepito da Hatim, Youssef viene arrestato ingiustamente,291 e il suo
nome, quello inventato dalla madre, Youssef El Mekki, viene ribadito,
un’ultima volta, dall’assistente del Commissario di Polizia, rappresentante
dell’autorità che priva Youssef della sua voce parlando a nome suo e di
tutta la cultura marginale che egli rappresenta:
«The Commissaire finally arrived on the scene and was
immediately surrounded by aides who briefed him on the
investigation. He listened, nodding a few times, and then his eyes
came to rest upon Youssef. “This is him?” he asked. “Yes, sir,”
one of his assistants replied, pointing. “His name is Youssef El
Mekki”»292.
ue
s
Q
Il personaggio di Rachida è quello che offre maggiori spunti per
una riflessione sulle questioni culturali e di genere. Riscrittura e invenzione
della memoria e dell’identità sono le strategie grazie alle quali Rachida
rende abitabile la propria condizione di marginalità. La madre di Youssef è
un personaggio marginale da più punti di vista: è marginale in quanto
abitante di Hay An Najat, quartiere dislocato rispetto al centro borghese e
capitalista di Casablanca; in quanto esule, costretta a lasciare il paese natale
in seguito alla relazione con Nabil, già coniugato; in quanto donna, e per di
più sola, che ha sfidato le convenzioni sociali e religiose macchiandosi di
uno dei kaba’ir, il peccato di fornicazione, oggetto di particolare condanna
da parte dell’Islàm.
to
eb
o
ok
ap
p
ar
e
tie
n
290 Ivi, p. 133.
291 «[Youssef] had played a role in the assassination of Farid Benaboud. Naively, he had
believed he was acting like a concerned human being, maybe even a hero: he had tried to stop a
murder. But now he had discovered that the part that had been reserved for him by the state
was that of the failed terrorist, the one who gets caught, the one who makes the police look
good because his arrest proves that the state tried to protect the inconvenient journalist». Ivi, p.
290.
292 Ivi, p. 291.
a\
nG
i
ul
ia
n
158
Ma Rachida è emarginata dalla stessa comunità di Hay An Najat:
«Of course, Youssef and his mother weren’t the only people in Hay
An Najat without a father or a husband, but they seemed to be the only
ones without any family. She was an orphan, raised in the French
orphanage at Bab Ziyyat»293.
«She was different from the other women in Hay An Najat, he knew.
The widow, he had heard some of them call her, a scornful look on
their faces, as though his mother were a leper, as though widowhood
were contagious. The fact that she could speak flawless French
somehow exacerbated their resentment; they said she put on airs»294.
Il passing for widow è, per Rachida, l’equivalente del passing for white
per la comunità nera d’America, giacché costituisce la strategia con cui il
personaggio tenta di trascendere i limiti imposti dalla propria condizione
socialmente stigmatizzata – quella di fornicatrice –, sottomettendosi, al tempo
stesso, a quei medesimi condizionamenti esercitati dall’ambiente sociale
circostante. I ruoli di vedova e di orfano costruiti da Rachida per sé e per
Youssef non sono che il risultato dell’adesione a convenzioni sociali; madre e
figlio si identificano, cioè, nei social selves di cui ha parlato, in quanto le loro
rispettive identità pubbliche inventate sono determinate da leggi sociali e
religiose condivise.
Al tempo stesso, grande importanzassume il fatto che Rachida sfidi le
norme che fanno di una donna ai margini l’oggetto di discorsi prodotti
dall’ideologia dominante ed egemone. Nel narrare la memoria a Youssef, il
personaggio di Rachida, per riprendere un’espressione di Vincenzo Matera,
«oppone resistenza alla storia»:295 ella non solo inventa l’identità del figlio,
ma riscrive quella di Nabil Amrani, che incarna la prospettiva egemone in
quanto uomo, arabo, membro dell’alta borghesia di Anfa e detentore del
potere economico. Il personaggio di Nabil viene narrato in modi diversi, in
maniera da servire agli scopi di Rachida: è un insegnante rispettato finché la
donna intende proporre la figura paterna come modello per il figlio; è un
agitatore politico, quando, viceversa, vuole sminuire Nabil agli occhi di
Youssef, per distoglierlo probabilmente dal pensiero ossessivo del padre.
293 Ivi, p. 7.
294 Ivi, p. 11.
295 Vincenzo Matera, Memoria e potere, in Ugo Fabietti, Vincenzo Matera, Memorie e
identità, cit., pp. 121-51: 123.
159
Questo ebook appartiene
Le storie mendaci di Rachida ne fanno una moderna
Shahrazàd,296 in lotta con il potere maschile – islamico e patriarcale –
che minaccia la sua sopravvivenza in una società fortemente restrittiva.
I racconti orali che inventa per Youssef offrono a Rachida
un’opportunità di preservare, tramite la menzogna e l’artificio, il
controllo sulla propria vita: persino la bugia, scrive infatti Maria
Bettetini, «appare come un atto della volontà di un soggetto libero».297
Ma la libertà, per una donna come Rachida, sembra rimanere relegata
nello spazio privato e domestico, e pertiene all’unico ambito della
fiction.
Qu
es
to
eb
oo
k a Bibliografia
pp
Aa.Vv., Arab Voices in Diaspora. Critical
ar Perspectives on Anglophone
tieRodopi, Amsterdam-New York
Arab Literature, a cura di L. Al Maleh,
ne
2009.
a\n
Maxime Ait Kaki, De la question berbère au dilemme
à l’aube du
Gkabyle
XXIème siècle, préface de Ch. Zorgbibe, L’Harmattan, Paris
iul 2004.
ian
Bill Ashcroft et al, The Empire Writes Back, Routledge, London-New
a C York
2002.
ac
cia
Ugo Fabietti, Vincenzo Matera, Memorie e identità. Simboli e strategie del
p
ricordo, Meltemi, Roma 1999.
James A. Holstein, Jaber F. Gubrium, The Self We Live By. Narrative
Identity in a Postmodern World, Oxford University Press, New York-Oxford
2000.
Hilary Kilpatrick, “Arab Fiction in English: A Case of Dual Nationality”,
«New Comparison», 13, 1992, pp. 46-55.
Laila Lalami, Hope and Other Dangerous Pursuits, Algonquin Books,
Chapel Hill 2005.
—, Secret Son, Algonquin Books, Chapel Hill.
296 Sul recupero della tradizione letteraria araba, in particolare quella delle Mille e una notte,
da parte di alcune scrittrici arabe postcoloniali, cfr. Fadia Suyoufie, The Appropriation of
Tradition in Selected Works of Contemporary Arab Women Writers, in «Journal of Arabic
Literature» 39, 2008, pp. 216-49.
297 Maria Bettetini, Breve storia della bugia. Da Ulisse a Pinocchio, Raffaello Cortina
Editore, Milano 2001, p. 4.
160
uo
ti C
LI
Zouhir Louassini, “Il romanzo marocchino: l’ora del lettore”, in Aa.Vv., Le
letterature del Maghreb: recupero della tradizione o risposta all’egemonia
culturale?, a cura di I. Camera D’Afflitto, volume speciale di «Oriente
Moderno», 16/2-3, n.s., 1997, pp. 267-74.
Geoffrey P. Nash, The Arab Writer in English: Arab Themes in a
Metropolitan Language, 1908-1958, Sussex Academic Press, Portland
1998.
—, The Anglo-Arab Encounter. Fiction and Autobiography by Arab Writers
in English, Peter Lang, Berna 2007.
Alessandro Portelli, Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo, introd.
di R. Grele, Donzelli Editore, Roma 2007.
Tetz Rooke, “Moroccan Autobiography as National Allegory”, in Le
letterature del Maghreb: recupero della tradizione o risposta all’egemonia
culturale?, a cura di I. Camera D’Afflitto, volume speciale di «Oriente
Moderno», 16/2-3, n.s., 1997, pp. 289-305.
Steven Salaita, Arab American Literary Fictions, Cultures, and Politics,
Palgrave Macmillan, New York-Basingstoke 2007.
Fadia Suyoufie, “The Appropriation of Tradition in Selected Works of
Contemporary Arab Women Writers”, «Journal of Arabic Literature», 39,
2008, pp. 216-49.
\n
pp
ea
n
e
i
art
to
ues
Q
161
e
ka
o
o
b
Questo ebook ap
LA COSTRUZIONE DELLA MEMORIA COLLETTIVA ATTRAVERSO
IL RICORDO INDIVIDUALE: IL CICLO DI RAPPRESENTAZIONI ALSAHRAIYYA NEL TEATRO EGIZIANO CONTEMPORANEO.
Alba Rosa Suriano
Alba Rosa Suriano
Laureata in Lettere, indirizzo orientalistico, presso l’Università
degli Studi di Firenze con il massimo dei voti, ha conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca in Lingue e Culture del Mediterraneo presso lo stesso
Ateneo, con una tesi sul teatro indipendente egiziano. Tra il 2009 ed il
2011, ha insegnato per contratto Lingua e letteratura araba, presso la
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania. Risultata vincitrice di
un assegno di collaborazione alla ricerca presso l’Università degli Studi di
Milano, dal dicembre 2011 è ricercatrice a tempo determinato presso
l’ateneo catanese, nel settore disciplinare L-OR/12.
Abstract
La scelta di rappresentare la dialettica tra ricordo individuale e
memoria collettiva si inserisce nel discorso più vasto del rapporto tra
memoria e storia ed in quello che vede a confronto l’espressione della
cultura di un popolo e la sua memoria. Secondo alcuni semiologi la cultura
è «una memoria non ereditaria del collettivo» (Lotman e Uspenskij, 1975).
In questa prospettiva l’identità culturale si costruirebbe grazie alla
trasmissione della memoria attraverso alcuni mediatori che, rielaborandola
e continuamente reiterandola per mezzo della parola, dell’immagine e della
ripetizione rituale, fanno da tramite tra le generazioni.
Si analizzeranno in questo contributo alcuni casi paradigmatici tratti
dalla letteratura teatrale egiziana contemporanea. I testi presi in esame
sono il frutto di un lavoro collettivo dei membri della compagnia
indipendente “al-Misahharati”, diretta dalla regista Abir Ali, e
costituiscono il ciclo di spettacoli “al-Sahraiyya”: “Halawat al-ruh”,
“Hakawi al-haramlik”, “Helw Masr” e “Enta deys ala elby”. In questi testi
si racconta la storia dell’Egitto degli ultimi cinquant’anni attraverso le
tappe fondamentali delle guerre in cui il Paese è stato coinvolto
(1956,1967,1973), in un mosaico di racconti personali e ricordi di famiglia.
Usando la tecnica teatrale del samir, un genere di rappresentazione
peculiare della tradizione araba, la regista mette in scena la tessitura di
quella memoria collettiva, che è sia sedimentazione del ricordo nella
coscienza del singolo, sia trasmissione sociale del patrimonio culturale.
162
The choice to put on stage the dialectic between individual and
collective memory should be part of a wider debate concerning the
relationship between memory and history, and the juxtaposition of a
community culture expression and the memory of the community itself.
According to some semiologists, culture is a «non-inherited memory of a
group» (Lotman e Uspenskij, 1975). In this perspective, a cultural identity
would be constructed with the memory transmitted by mediators who revise
it and reiterate it continuously through speech, images and the ritual
reiteration, and act as intermediaries between generations.
This contribution analyses a few paradigmatic cases in the Egyptian
contemporary drama. The selected texts are the result of a collective work
of the independent company “al-Misahharati”, directed by Abir Ali, and
compose the representation cycle “al-Sahraiyya”: “Halawat al-ruh”,
“Hakawi al-haramlik”, “Helw Masr” and “Enta deys ala elby”. These
plays deal with the Egyptian history of the last fifty years, across three very
important wars (1956, 1967, 1973), in a patchwork of personal and family
memories.
Using the theatrical technique called al-samir, a peculiar version of
Arabic traditional performance, the director shows the structure of the
collective memory, which is not only the consolidation of memory in the
individual conscience, but also the social transmission of cultural heritage.
Introduzione
In questo contributo si è scelto di analizzare alcuni casi paradigmatici
di rappresentazione della dialettica tra ricordo individuale e memoria
collettiva, tratti dalla letteratura teatrale egiziana contemporanea. I testi
presi in esame sono il frutto di un lavoro collettivo dei membri della
compagnia indipendente “al-Misahharati”, diretta dalla regista Abir Ali, e
costituiscono il ciclo di spettacoli “al-Sahraiyya”298: “Halawat al-ruh”,
“Hakawi al-haramlik”, “Helw Masr” e “Enta deys ala elby”299. In questi
testi si racconta la storia dell’Egitto degli ultimi cinquant’anni, attraverso le
tappe fondamentali delle guerre in cui il Paese è stato coinvolto (1956,
1967, 1973), in un mosaico di racconti personali e ricordi di famiglia.
Questo e
book
298 Dalla radice SHR, che significa “stare sveglio, fare nottata” ma anche “serata, festa serale”.
Il significato del termine si avvicina molto a quello di SMR, “trascorrere la serata in piacevole
conversazione con gli amici”, talvolta a quest’idea si accompagna quella di raccontarsi tutti
seduti intorno ad un fuoco.
299 “La dolcezza dello spirito”, “Storie dell’harem”, “Bello l’Egitto” e “Tu calpesti il mio
cuore”.
163
appa
o
o
t
es
eb
u
Q
Usando la tecnica teatrale del samir, un genere di rappresentazione
peculiare della tradizione araba, la regista mette in scena una ricostruzione
della memoria collettiva, i cui tasselli sono i ricordi individuali di semplici
cittadini egiziani, che ruotano attorno ai grandi avvenimenti della storia
dell’Egitto contemporaneo.
La compagnia teatrale “al-Misahharati” è una delle dieci che,
nell’agosto 1990, diedero vita al movimento del Teatro Indipendente
egiziano. Non riconosciuto dagli organi ufficiali nazionali, quali il
Sindacato degli Artisti, il movimento indipendente si è sempre mosso tra le
maglie strette della censura e della cronica mancanza di mezzi economici
per la realizzazione dei propri spettacoli. Recentemente, però, alcune
compagnie sono state insignite di riconoscimenti importanti e “alMisahharati”, ad esempio, è risultata vincitrice alla prima edizione del
Festival del Teatro Nazionale, con lo spettacolo “Hakawi al-haramlik”.
Le tematiche affrontate in questi testi e i ‘linguaggi’ utilizzati dalla
compagnia per rappresentare il contesto storico e culturale dell’Egitto
contemporaneo, ben si inseriscono all’interno della riflessione sul rapporto
tra memoria e ricordo, e su quello che vede a confronto l’espressione della
cultura di un popolo e della sua memoria300.
Ogni popolo crea una comunità inedita e immagina che essa sia, in
realtà, una comunità remota e dimenticata. In tal modo, si costruisce
continuamente la propria identità sulla base di elementi che immagina come
caratteristici della propria storia e della propria peculiarità301. Il dibattito che
ruota intorno ai concetti di memoria e ricordo, vede come protagonisti
alcuni importanti storici e sociologi, come Eric Hobsbawm o Benedict
Anderson. Attraverso i concetti di “invenzione della tradizione” e di
“comunità immaginata”, questi studiosi analizzano il processo di
costruzione della memoria in un’ottica storica (quindi legata a un periodo
preciso, cioè la fine del XIX e l’inizio del XX secolo) e politica (la
propaganda che ha portato alla creazione dell’identità nazionale e al
concetto stesso di “Nazione”). Quest’idea di costruzione della memoria si
lega anche all’idea di “narrazione”: narrare il passato significa ordinare
eventi ed esperienze, che hanno segnato la storia della collettività, secondo
criteri e scelte condizionate da motivazioni di ordine sociale o politico.
300 A tale proposito si veda: Assmann, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria
culturale, Bologna, Il Mulino (1990); Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Milano,
Raffaello Cortina Editore (2003); Halbwachs, I quadri sociali della memoria, Napoli,
Ipermedium Libri (1997); Le Goff, Storia e memoria, Torino, Einaudi (1988); Nora (a cura di),
3 voll., Les lieux de memoire, Gallimard, Paris (1984-92).
301 Anderson, Comunità immaginate, Roma, Manifestolibri (1996) e anche Hobsbawm e
Ranger, L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi (2002).
164
Questo
I drammaturghi e i registi indipendenti hanno dedicato particolare
attenzione al processo di costruzione della memoria collettiva egiziana da
parte del discorso politico e dei media. Da questo punto di vista, il lavoro di
molte compagnie indipendenti può essere interpretato come un tentativo di
produrre un discorso alternativo, che recuperi gli aspetti della storia
collettiva egiziana e l’identità che spesso è stata negata o manipolata dal
discorso ufficiale.
Approccio teorico
Secondo i semiologi Lotman e Uspenskij la cultura è “una memoria
non ereditaria della collettività”: essa è quindi concepita come la
registrazione di quanto è già stato vissuto dalla società302. Questa memoria
deve essere sempre riplasmata, sancita, comunicata e adattata, e sono gli
individui e le culture che la costruiscono interattivamente, attraverso la
comunicazione linguistica, le immagini e la ripetizione rituale. In questa
prospettiva, l’identità culturale si costruirebbe grazie alla trasmissione della
memoria, attraverso alcuni mediatori che, proprio riplasmandola,
rivivificandola e riadattandola, fanno da anello di congiunzione tra le
generazioni:
«La memoria di un gruppo non dispone solo di parole, di storie
scritte o trasmesse oralmente, ma di artefatti, monumenti, simboli,
cerimonie pubbliche e istituzioni attraverso cui la memoria viene
costruita, riprodotta, conservata e trasmessa da una generazione a
quella successiva»303.
Perché ciò abbia luogo, è necessario attraversare un processo di
sedimentazione del ricordo nella coscienza del singolo e di trasmissione
sociale del patrimonio culturale. Secondo Ricoeur, attraverso il confronto
dei nostri ricordi con quelli degli altri, trasformiamo in collettivi i ricordi
individuali e, grazie a tale processo, costituiamo la memoria culturale:
«Fra i due poli della memoria individuale e della memoria collettiva,
non esiste forse un piano intermedio di riferimento, in cui
concretamente si operano gli scambi fra la memoria viva delle
302 “Sul meccanismo semiotico della cultura”, in Lotman e Uspenskij (1975), pp. 39-68
[originale: “O semioticeskom mechanizme kul’tury”, in Trudy po znakovim sistemam, V,
Tartu, 1971, pp. 144-166].
303 Sciolla “Memoria, identità e discorso pubblico” in Rampazi, Tota (a cura di) Il linguaggio
del passato. Memoria collettiva, mass media e discorso pubblico, Roma, Carocci (2005).
165
persone individuali e la memoria pubblica delle comunità alle quali
apparteniamo?»304.
Questo
La memoria culturale, dunque, svolge un ruolo fondamentale nella
formazione dell'identità personale e collettiva, e rappresenta, insieme alla
tradizione nel suo complesso, la memoria primaria in base alla quale una
regione o una nazione si costituisce come insieme omogeneo305. In tale
prospettiva possiamo vedere, nel recupero delle forme di rappresentazione
tradizionali, come il samir o come i racconti dei cantastorie (hakawati), un
tentativo di ri-costruire la propria memoria culturale, attraverso
l’identificazione nei ricordi collettivi e individuali306.
Sia i singoli individui sia le diverse culture organizzano la loro
memoria grazie a mediatori di deposito e pratiche culturali. E’ importante,
quindi, evidenziare in tale processo il ruolo svolto dai mediatori, che sono il
veicolo di trasmissione della memoria e che possono essere testi, immagini
o luoghi. I semiologi della cultura non applicano il concetto di “testo” ai soli
messaggi in lingua naturale, ma anche
ebook
apparti
«a qualsiasi veicolo di un significato globale (“testuale”), sia esso un
rito, un’opera d’arte figurativa, oppure una composizione
musicale»307.
ene a\n
Possiamo, quindi, includere tra i mediatori anche le opere e le
rappresentazioni teatrali, tanto più quando l’esplicito intento del testo
drammatico è quello di raccogliere i ricordi dei singoli attori della
compagnia, rielaborati in modo tale da restituire al pubblico una
rappresentazione articolata e dettagliata della storia collettiva e dei singoli.
a
Giulian
304 Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Milano, Raffaello Cortina Editore (2003), pp.185186.
305 Nora “De la République à la Nation” in Les lieux de mémoire I: La République, Paris,
Gallimard (1984), pp.651-659.
306 Yusuf Idris, nell’introduzione alla sua opera “al-Farafir”, individua nel samir la forma di
rappresentazione araba par excellence, egli difende la solidità di tali forme di rappresentazione,
sostenendo che da questo background poteva nascere una nuova forma teatrale, sviluppatasi
come genere autonomo e ben diversa da quella delle origini306. Proprio in quelle pagine egli
afferma che: «possiamo dire che esiste nella nostra realtà un teatro prettamente egiziano, ma
non ce ne accorgiamo, semplicemente perché vogliamo assomigliare al teatro greco ed europeo
che abbiamo conosciuto, tradotto, imitato o adattato... fin dalla fine del XIX secolo» (Idris,
1964, p.41).
307 Ivanov, Lotman, Piatigorskij, Toporov, Uspenskij “Tesi per un’analisi semiotica delle
culture”, in La semiotica nei Paesi slavi. Programmi, problemi, analisi, Milano, Feltrinelli
(1973), pp. 194-220.
LI_2
puoti C
Caccia
166
Processi di costruzione della memoria nel teatro
contemporaneo: il caso della compagnia “al-Misahharati”
egiziano
È questo il caso, ad esempio, degli spettacoli rappresentati dalla
compagnia egiziana “al-Misahharati”, la cui regista, Abir Ali, è stata una
delle fondatrici del movimento teatrale indipendente. Secondo quanto la
stessa regista ha affermato in un’intervista308, lo scopo del suo gruppo è di
fungere da specchio della vita quotidiana.
La costruzione degli spettacoli si basa inizialmente sulla raccolta di
una grande quantità di informazioni: i membri della compagnia registrano
conversazioni nelle case private di amici e parenti, scegliendo, poi, tra
queste, le storie più interessanti e le canzoni popolari citate. Il testo scritto
che ne deriva serve da canovaccio su cui possono essere fatte successive
modifiche e improvvisazioni. Ogni membro della compagnia, quindi, si fa
selezionatore e trasmettitore dei ricordi raccolti, ricollegandosi in questo
modo anche a una figura tipica della tradizione culturale araba, quella del
rawi.
Il nome stesso della compagnia richiama a un elemento caratteristico
della vita quotidiana e legato a una realtà tipicamente egiziana: il
Misahharati (in arabo classico musahhir) è colui il quale è incaricato di
gridare e suonare il tamburo per svegliare i credenti, affinché possano fare il
suhur, cioè l’ultimo pasto prima dell’alba, durante il mese di Ramadan.
Questo nome è stato scelto dalla stessa Ali come omaggio all’omonima
opera del poeta Fuad Haddad309, che definiva se stesso come un misahharati
al-watan310, poiché il suo intento era di usare la poesia come tamburo per
svegliare le coscienze, sia dal punto di vista sociale che politico:
Questo e
book app
artiene a
\nGiulian
a Caccia
puoti C
«he used this figure as a method of criticism of bad social habits such
as routine. He also strove to constantly remind people of their
strength and Arab identity»311.
La compagnia ha voluto recuperare il concetto di svegliare le persone
nel cuore della notte, intesa come il buio calato sulla loro capacità di
giudizio. L’arte, quindi, viene intesa come foriera di luce, in grado
308 Abu Khadija “Hakawi al-haramlek” in Middle East Online (3 agosto 2004) http://middleeast-online.com/?id=25206.
309 Nato nel 1927 al Cairo da madre siriana di origine libanese, fu naturalizzato egiziano solo
dopo molti anni. Autore di trentadue raccolte poetiche, e membro del Partito comunista
egiziano, venne arrestato dal 1953 al 1956 e dal 1959 al 1964. Morì al Cairo nel 1985.
310 “Misahharati della patria”.
311 El-Noshokaty “Wake up, sleepyhead!” in Al-Ahram Weekly, n.913 (4-10 settembre, 2008).
167
a
aC
c
ti C
o
pu
a
i
c
11
9
96
3
0
03
0
3
01
2
LI_
illuminare chi la fruisce, e proprio da questo desiderio ha inizio la ricerca
volta a individuare e definire una specificità del teatro egiziano, legata alla
cultura e all’esperienza quotidiana e inserita all’interno della società.
In modo particolare, il gruppo ha lavorato alla realizzazione di un
ciclo di quattro spettacoli dal titolo “al-Sahraiyya”, scritti e messi in scena
nell’intervallo 2003-2008, ed elaborati nel corso di laboratori durante i quali
ciascun membro del gruppo raccoglieva e condivideva con gli altri racconti,
ricordi e aneddoti della vita della propria famiglia. La costruzione
dell’impianto narrativo di queste rappresentazioni è basata sul modello delle
notti delle “Mille e una Notte”. Gli spettacoli sono, infatti, composti di
quadri e scene teatrali, ispirati a racconti e facezie sull’esempio della
tradizione popolare, ma anche da canzoni del repertorio folklorico312.
“Halawat al-ruh”, “Hakawi al-haramlik”, “Helw Masr” e “Anta days ala
elby” sono opere che si basano su un progetto di recupero della memoria
collettiva egiziana, attraverso la raccolta di ricordi individuali o di un
gruppo sociale ristretto come la famiglia, mettendo in risalto l’aspetto
dinamico e relazionale della memoria collettiva.
\n
a
e
G
ia
iul
n
«L’idea è quella di dare una visione critica sulla nostra storia sociale
e sulla nostra realtà. Esiste una versione scritta ufficiale,
politicamente sicura della storia, ma la storia sociale non viene
registrata. Noi cerchiamo di mettere davanti agli occhi di tutti
quest’altra storia e di leggerla in maniera differente, in modo tale da
poter vedere i nostri comportamenti positivi e negativi»313.
o
eb
o
p
ka
p
ie
art
n
Nell’opera “Hakawi al-haramlik” vengono messe in scena le
problematiche legate alla quotidianità della società egiziana, i cui i motivi
ricorrenti sono: il matrimonio, in un’ottica di sistemazione sociale e mezzo
economico di avere rapporti sessuali, la religione, come strumento del
potere, e la virilità, come ossessione e modo fanatico di relazionarsi con la
realtà oppressiva in cui si usano pesi e misure differenti per gli uomini e per
le donne. Secondo la regista, infatti:
Q
s
ue
to
«L’idea di haramlek (harem) in questo spettacolo è rilevante perché
le donne sono imprigionate in quello spazio, mentre gli uomini a
guardia sono eunuchi. Vogliamo, quindi, dire che sia gli uomini che
le donne sono oppressi, e se le donne sono maggiormente oppresse
312 Selaiha “Something for everyone” in Al-Ahram Weekly, n. 716 (11-17 novembre, 2004).
313 Ali “Mukhtabir al-Misahharati” (2006), la traduzione in italiano è di chi scrive.
168
non è perché gli uomini sono crudeli, ma perché la società è ingiusta
e agisce per rendere schiavi entrambi»314.
Anche se metà della compagnia è composta di uomini e le storie
narrate hanno come protagonisti personaggi che richiamano fortemente
quelli presenti nelle “Mille e una Notte”, l’accento è posto principalmente
sulle figure femminili. Rappresentate con una vena ironica e umoristica,
queste donne del passato e del presente sono rese anche in modo parodico,
quando per esempio due uomini impersonano due anziane zitelle (con tanto
di scialli e parrucche) che raccontano storie del loro passato, forse condite
di sogni mai realizzati, che nel ricordo possono diventare reali. Lo scopo è
stigmatizzare alcuni comportamenti femminili, con una nota nostalgica per
un passato felice (vero o immaginato) che percorre tutto lo spettacolo.
Nel testo Anta days ala elby, Abir parla della vita inquieta
dell’egiziano medio, mettendone in luce i problemi e le questioni irrisolte,
suscitando l’interesse del pubblico, che si rispecchia nelle situazioni
rappresentate. I protagonisti soffrono della mancanza di una vera identità
sociale e criticano, quindi, la visione convenzionale di un Egitto basato su
una comunità coesa. Il tutto è assolutamente privo di moralismo, ma condito
con sketch umoristici sulla realtà degli ultimi vent’anni. E’ l’esempio dello
spettacolo televisivo condotto da uno sheikh, che dispensa consigli sulla
condotta da tenere in ogni occasione della vita. Tali suggerimenti sono
completamente scollegati dalla realtà quotidiana in cui vivono i giovani
egiziani e, quindi, suscitano le risate del pubblico.
Una delle parti più interessanti, in tal senso, è quella in cui un
giovane interviene telefonicamente durante una trasmissione televisiva per
chiedere conforto: egli, infatti, è laureato da quattro anni, ma non riesce a
trovare lavoro. Per questo motivo non si è potuto ancora sposare e sente la
necessità di avere una donna. Lo sheikh gli suggerisce l’astensione, ma il
giovane obietta che nonostante la sua astensione, le pulsioni sono forti e
chiede come possa risolvere questo problema. Il predicatore, dopo aver
ribadito inutilmente l’importanza dell’astenersi, gli suggerisce di fare molto
sport. Alla fine, imbarazzato dall’insistenza del ragazzo, termina la
telefonata senza rispondergli, si rivolge alle telecamere e saluta gli
spettatori, giustificandosi con la scusa che il tempo a sua disposizione è
terminato:
iene
ppart
ook a
eb
uesto
Q
. السالم عليكم: الشاب
314 Ibidem.
169
a\nG
و عليكم السالم:الشيخ
سنين و لسه ما اشتغلتش4 انا متخرج من:الشاب
و األرزاق على ﷲ يا، أن شاء ﷲ تجد عمل في القريب العاجل.ما ضاقت اال أما فرجت:الشيخ
أخي
أنا لسه ما اتجوزتش فضيلتك:الشاب
تتجوز ازاى و أنت خالي شغل؟ الزواج مسؤولية:الشيخ
أنا آسف يعنى... يعنى.. بس أنا أخشى على نفسي.. أنا عارف فضيلتك أن الجواز مسئولية:الشاب
معصية ﷲ عز و جل..
الصيام.. الصيام.. عليك بالصيام.. cأعوذ با:الشيخ
c أنا بصوم بصوم بصوم على طول فضيلتك و الحمد:الشاب
صوم تاني: الشيخ
وبعدين: الشاب
عليك بممارسة الرياضة.. عليك بال.. عليك بال: الشيخ
باقول لك الرياضة لغاية أمتي؟ لغاية،و بعدين؟؟ لغاية أمتي؟؟ )يكرر العبارة( يا عم الشيخ: الشاب
أمتي؟
315
نترككم فى رعاية ﷲ و أمنه..نظرا النتھاء وقت برنامج فتوى لكل مواطن:(الشيخ )ال رد
Il rapporto tra la tradizione e la memoria
Queste rappresentazioni, che fungono da mediazioni della memoria
collettiva, sono di sicuro impatto sulla coscienza civile nazionale egiziana, e
permettono la ricostruzione degli spazi pubblici di condivisione (fisici e non
solo) sia tra gli attori e il pubblico, sia tra gli spettatori stessi. Questa
ricostruzione avviene attraverso la condivisione
Alcuni studi sulle esperienze storiche di alcuni Paesi usciti da regimi
totalitari hanno dimostrato quanto siano importanti e auspicabili “gli spazi
pubblici” per la ricostruzione della società civile e della vita associativa, e
quindi per il successo della democrazia316. Seyla Benhabib sostiene, infatti,
che una molteplicità di spazi pubblici costituisca la condizione necessaria
per l'instaurazione di una società civile indipendente e vigorosa, elemento
indispensabile di qualsiasi cultura democratica317.
Proprio i profondi mutamenti politici avvenuti in Tunisia e in Egitto,
e tuttora in corso in alcuni Paesi arabi, sono stati fortemente segnati dalla
presenza attiva della società civile di quelle nazioni. La riconquista delle
piazze, come simbolo dell’aggregazione e della vita pubblica, era
un’aspirazione già fortemente radicata nella realtà artistica araba, che il
ppartie
ook a
esto eb
Qu
315 Ali “Enta Days ala Elby” (2008), p. 11.
316 Arendt “Le origini dei totalitarismi”, Torino, Edizioni di Comunità (1999).
317 Benhabib “The Reluctant Modernism of Hannah Arendt”, London, Sage (1996), p. 164.
170
teatro indipendente esprimeva già da molti anni attraverso linguaggi
rappresentativi differenti, a seconda degli interessi delle personalità presenti
nelle varie compagnie.
La grande forza centripeta dell’associazionismo, la richiesta di libertà
civili e d’espressione, sono stati elementi fondanti del teatro indipendente
egiziano fin dai suoi albori, così come la voglia di ri-occupare gli spazi
pubblici, quali i caffè o le strade, che erano stati interdetti a tutte le
manifestazioni con la legge d’emergenza del 1981. Già nel 2005, alcuni
gruppi di giovani attori e registi avevano puntato alla pratica del teatro di
strada (masrah al-shaaria), come atto di disobbedienza civile e come
sperimentazione artistica. Nei posti più disparati della città, sono stati messi
in scena spettacoli di breve durata, che consentivano agli attori di terminare
la rappresentazione prima dell’arrivo della polizia.
Il ritorno alla tradizione e al folklore, supportato dai racconti, dalle
musiche, dagli abiti, dai detti popolari e dalla simbologia, sono le
caratteristiche tecniche qualificanti di molti gruppi indipendenti, in modo
particolare di al-Misahharati. Ogni elemento diventa parte integrante dello
spettacolo, caratterizzando fortemente il linguaggio artistico della
compagnia e rendendone riconoscibili le specificità. La tecnica
rappresentativa usata è quella del samir, una forma teatrale pre-moderna,
tipica della tradizione araba, che prevede la disposizione di attori, cantanti e
suonatori di liuto e percussioni seduti in semicerchio e rivolti verso la
platea, oppure disposti a piccoli gruppi sul pavimento. Si alternano, quindi, i
racconti e le storie, vengono dipinti quadretti umoristici e cantate ballate del
repertorio popolare tradizionale.
Con questi lavori, la Ali mette in scena la tessitura di quella memoria
collettiva, che è sia sedimentazione del ricordo nella coscienza del singolo,
sia trasmissione sociale del patrimonio culturale. Poiché, solitamente, il
processo di ricordare avviene con l’aiuto dei ricordi altrui, e i nostri ricordi
sono inquadrati in racconti collettivi, possiamo affermare con Halbwachs
che «ogni memoria individuale [è] un punto di vista sulla memoria
collettiva»318.
iC
ot
u
p
a
i
Bibliografia
na
lia
Giu
cc
Ca
a\n
e
Arendt, Le origini dei totalitarismi,
tien Edizioni di Comunità, Torino (1999)
r
a
pp
a
k collettiva e lo spazio, Unicopli, Milano (1987), pp.62-63.
omemoria
o
318 Halbwachs,
La
b
to e
s
171
e
Qu
Anderson, Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma (1996)
01
2
LI_
Assmann, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, Il
Mulino, Bologna (1990)
El-Noshokaty, “Wake up, sleepyhead!” in Al-Ahram Weekly, n.913 (4-10
settembre, 2008)
Halbwachs, I quadri sociali della memoria, Ipermedium Libri, Napoli
(1997)
ID., La memoria collettiva e lo spazio, Unicopli, Milano (1987)
Hobsbawm e Ranger, L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino
(2002)
Idris “al-Farafir”, D…r al-Taïr–r, Il Cairo (1964)
Lotman, Ivanov, Piatigorskij, Toporov, Uspenskij, “Tesi per un’analisi
semiotica delle culture”, in La semiotica nei Paesi slavi. Programmi,
problemi, analisi, Feltrinelli, Milano (1979), pp. 194-220
Le Goff, Storia e memoria, Einaudi, Torino (1988)
artie
Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Milano, Raffaello Cortina Editore
app
ebook
uesto
Q
Sciolla, “Memoria, identità e discorso pubblico” in Rampazi, Tota (a cura
(2003)
di) Il linguaggio del passato. Memoria collettiva, mass media e discorso
pubblico, Roma, Carocci (2005)
Selaiha, “Something for everyone” in Al-Ahram Weekly, n. 716 (11-17
novembre, 2004)
Uspenskij, “Sul meccanismo semiotico della cultura”, in Tipologia della
cultura, Lotman e Uspenskij (a cura di), Bompiani, Milano (1975), pp. 39
68
172
ian
Giul
n
\
a
e
n
Nora (a cura di), 3 voll., Les lieux de memoire, Gallimard, Paris (1984-92)
Storia e Nation Building in Medio Oriente e Nordafrica, analisi e
prospettive.
IL MODELLO DELLA TURCHIA IN PROSPETTIVA STORICA: LE
DIFFERENZE CON IL MONDO ARABO.
Stefano Maria Torelli
Stefano Maria Torelli
Research Fellow dell’ISPI e Ph.D. Candidate in Storia delle
Relazioni Internazionali presso l’università di Roma “La Sapienza”. Tra i
fondatori del Centro Italiano di Studi sull’Islam Politico (CISIP), i suoi
campi di ricerca si concentrano sulla politica mediorientale, lo studio
dell’Islam politico e il rapporto tra religione e relazioni internazionali, con
una particolare attenzione per la Turchia e la Tunisia. E’ curatore del
volume “La primavera araba. Origini ed effetti delle rivolte che stanno
cambiando il Medio Oriente” (Vita e Pensiero, Milano, 2012) e ha
pubblicato articoli su riviste accademiche internazionali come Middle East
Policy e Insight Turkey. Cura una rubrica settimanale sul Medio Oriente
per Sette – Corriere della Sera.
Abstract
Il cosiddetto “modello turco” è stato chiamato in causa come
possibile esempio da seguire per i Paesi arabi interessati dalle rivolte del
2011. La comparazione è stata avanzata soprattutto per i due attori –
Tunisia ed Egitto – che, rispetto ad altri come Libia, Yemen e Siria, sono
già stati testimoni di un cambio di regime. Il presente articolo intende
fornire una definizione di cosa sia davvero il “modello turco”,
contestualizzandolo dal punto di vista geografico e temporale e, in seguito,
comparando le sue caratteristiche strutturali con quelle di Tunisia ed
Egitto. Ciò che emerge da una simile analisi comparata è l’impossibilità
attuale di mettere in correlazione gli eventi tunisini ed egiziani con il
percorso compiuto dalla Turchia – e dal suo partito di ispirazione islamica,
AKP – negli ultimi trent’anni. In particolare, si sosterrà che non possono
essere solo la questione dell’Islam politico e della sua dimensione pubblica
a determinare l’eventualità o meno che il “modello turco” possa essere
perseguito in altri contesti. La presenza dell’Islam politico – e il suo
rapporto con le istituzioni – è solo una delle variabili che hanno concorso
alla formazione del modello turco, che a sua volta è il risultato di un lungo
processo di cambiamenti politici, economici e sociali. Solo questi ultimi
hanno potuto garantire la transizione democratica della Turchia e, con il
oe
Que
st
173
tempo, favorire la nascita di un Islam politico turco sui generis. Il “modello
turco” appare, dunque, come un processo, che i Paesi arabi in transizione
devono ancora percorrere.
The so-called “Turkish model” has been called into question as a
possible example to follow for the Arab countries affected by the 2011’s
riots. The comparison was made especially for the two actors - Tunisia and
Egypt - which, compared to others like Libya, Yemen and Syria, have
already witnessed a regime change. This article aims to provide a definition
of what really is the “Turkish model”, by contextualizing it historically and
geographically and then comparing its structural characteristics with those
of Tunisia and Egypt. What emerges from such a comparative analysis is
the inability to correlate current Tunisians and Egyptians events with the
path that Turkey - and his party-inspired Islamic AKP – has followed in the
last thirty years. In particular, it will be argued that the issues of political
Islam and of its public dimension cannot be the only ones to determine
whether or not the “Turkish model” could be pursued in other contexts. The
presence of political Islam - and its relationship with the institutions - is
only one among the variables that contributed to the formation of the
Turkish model, which in turn is the result of a long political, economic and
social changing process. This changings have been able to ensure the
democratic transition in Turkey and, over time, to encourage the emergence
of a sui generis Turkish political Islam. Therefore, the “Turkish model”
reveals itself as a path that the Arab countries in transition have yet to
embark on.
rt
k ap
pa
to
e
boo
s
Que
Il movimento popolare che ha toccato, a vari livelli di intensità, i
Paesi del Maghreb e del Medio Oriente, ha portato il dibattito - accademico
e non - a interrogarsi sui possibili sviluppi del processo politico interno agli
attori interessati dall’ondata di rivolte del 2011. Tale discorso è valido
soprattutto in relazione a Tunisia ed Egitto, che sono state già testimoni di
un cambio di regime de facto, anche se il loro panorama politico risulta al
momento ancora frammentato e il futuro delle loro organizzazioni
istituzionali è ancora segnato dall’incertezza. La condizione di precarietà
dell’Egitto e della Tunisia, ma anche di Paesi come la Libia, lo Yemen e la
Siria, in cui gli sviluppi delle proteste hanno portato a diversi scenari tra di
loro e non hanno ancora visto delinearsi una via d’uscita alla presente crisi,
è dovuta a vari fattori, di tipo sociale ed economico, oltre che strettamente
politico. Non è questa la sede per analizzare a fondo le peculiarità dei
\nG
iene
a
174
sistemi Paese presi in considerazione319, ma basti ricordare che in Tunisia, a
quattro mesi dalla fuga dell’ex Presidente Zine al-Abidine Ben ‘Ali, ancora
non sono state delineate le tappe del processo di transizione politica che
dovrebbe portare il Paese a una ristrutturazione delle proprie istituzioni e
all’instaurazione di un nuovo governo democraticamente eletto, tramite la
stesura di una nuova carta costituzionale. A Tunisi, dal gennaio al maggio
del 2011, si sono succeduti già tre diversi governi di transizione e il Paese è
stato interessato ancora da episodi di violenza nelle piazze, con scontri tra
manifestanti e forze di polizia, che hanno provocato alcune vittime anche
dopo la fuga di Ben ‘Ali320. In Egitto la situazione appare ancora diversa,
dal momento che il potere è attualmente detenuto di fatto dalla classe
militare, la quale, secondo alcune interpretazioni, si è resa protagonista di
un vero e proprio colpo di Stato ai danni dell’ex Presidente Hosni
Mubarak321 e, attualmente, guida il Paese in attesa di stabilire un più chiaro
processo di transizione politica. Il Consiglio Supremo delle Forze Armate
egiziane (CSFA), che attualmente è al governo al Cairo, ha provveduto alla
composizione di una nuova costituzione provvisoria, approvata tramite
referendum popolare nel marzo del 2011322, in attesa che venga composta
una nuova assemblea costituzionale e redatta una nuova legge fondamentale
che ponga le basi per la riorganizzazione delle istituzioni del Paese.
In un tale clima, si sono levate diverse voci, sia all’interno dei
Paesi arabi, che del mondo occidentale e della stessa Turchia, in favore di
una transizione democratica che possa ricalcare quello che è stato definito il
cosiddetto “modello turco”323. Tale espressione è però soggetta a diverse
interpretazioni e necessita di un’analisi più approfondita, con lo scopo
primario di rendere chiaro quale sia l’oggetto di studio e di paragone e,
quindi, cosa si intenda per “modello turco” e, in secondo luogo, per stabilire
319 Per un’analisi più approfondita delle cause che hanno portato alle rivolte in Tunisia ed
Egitto, si veda INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG), Popular Protest in North Africa
and the Middle East (I): Egypt Victorious?, Middle East/North Africa Report, n. 101, 24
February, 2011 e ICG, Popular Protests in North Africa and the Middle East (IV): Tunisia’s
Way, Middle East/North Africa Report, n. 106, 28 April, 2011.
320 “Deaths in Tunisia clashes”, Al-Jazeera, 26 February 2011.
321 Si veda ad esempio V. KOTSEV, “Military's marching orders confused”, Asia Times
Online, 15 February, 2011.
322 “Large turnout for Egypt's constitutional referendum”, BBC News, 19 March, 2011.
323 Si veda ad esempio O. TASPINAR, “Egypt and the Turkish model”, Today’s Zaman, 7
February, 2011 e M. AKYOL, “Egypt needs the new 'Turkish model'”, Hurriyet Daily News, 8
February, 2011. Il dibattito sul rapporto tra il cosiddetto “modello turco” e i Paesi arabo
costituiva del resto già una questione aperta da anni, si veda tra gli altri O. TASPINAR, An
Uneven Fit? The “Turkish Model” and the Arab World, The Saban Center for Middle East
Policy at the Brookings Institution, Analysis Paper N. 5, August 2003.
pa
oe
ap
book
st
Que
175
\nG
ea
rtien
se le realtà interessate dall’attuale transizione in corso possano
effettivamente seguire tale modello, o al contrario non presentano le
condizioni strutturali di base affinché l’esperienza della Turchia possa
replicarsi anche in tali contesti. Secondo l’interpretazione più diffusa, il
riferimento al modello turco sembra essere stato indotto dalla presenza di
movimenti legati all’Islam politico, sia in Tunisia, che in Egitto, afferenti
all’ideologia della Fratellanza Musulmana. Per ciò che concerne l’Egitto,
soprattutto, si noti come il movimento dei Fratelli Musulmani abbia visto
proprio qui la propria nascita324, mentre in Tunisia il partito al-Nahda,
guidato da Rashid Ghannushi, è nato negli anni Ottanta e si dichiara
ufficialmente seguace della Fratellanza325. La minaccia percepita dai regimi
precedentemente al potere nei due Paesi ha sempre portato i propri capi di
Stato ad estromettere dalla vita politica tali movimenti e, in seguito alla
caduta di Ben Ali e Mubarak, si è spesso fatto riferimento all’Islam politico
come un possibile elemento destabilizzatore nel futuro degli attori arabi
interessati dai movimenti di protesta326.
È in tale cornice, dunque, che va collocato il riferimento fatto più
volte alla Turchia, quale Paese che ha saputo integrare i movimenti politici
che si rifanno ai valori islamici, nell’ambito di un processo di
democratizzazione che non sembra essere stato scalfito, ma semmai
addirittura rafforzato, dalla presenza del Partito di Giustizia e Sviluppo
(Adalet ve Kalkinmi Partisi, AKP) dell’attuale Primo Ministro Recep
Tayyip Erdoğan. Se in prima battuta la chiamata in causa del cosiddetto
“modello turco” è nata dall’esigenza di coniugare gli elementi politici
afferenti alla galassia dell’Islam politico e, dall’altra parte, la riuscita di un
processo di democratizzazione interna in Paesi quali l’Egitto e la Tunisia, ad
un’analisi più attenta tale paragone sembra non essere del tutto calzante. Lo
scopo di questo articolo è proprio quello di ricostruire le fasi del processo
politico della Turchia che ha portato, in ultimo, l’AKP al governo e
confrontarlo con la situazione attuale dei Paesi mediorientali, con
324 Per una ricostruzione esaustiva delle origini e degli sviluppi del movimento della
Fratellanza Musulmana, si rimanda a T. RAMADAN, Il riformismo islamico, Città Aperta
edizioni, Troina (EN), 2004.
325 Il pensiero di Ghannushi, leader del movimento precedentemente in esilio a Londra e,
successivamente, rientrato in Tunisia dopo la caduta di Ben ‘Ali, si può ripercorrere in parte,
tra le altre opere, nei saggi da lui stesso scritti all’interno dell’opera I Fratelli Musulmani e il
dibattito sull’Islam politico, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1996, pp. 4563.
326 Durante i giorni delle proteste in Egitto, lo stesso Mubarak aveva dichiarato che la
Fratellanza Musulmana avrebbe gettato il Paese nel caos qualora lui avesse rassegnato le
dimissioni. “Egypt unrest: Hosni Mubarak warns of chaos if he quits”, BBC News, 3 February,
2011.
176
Qu
es
cciapuot
i CLI
_
2
0
1
3
0
03039
na Ca
Ques
t
o
e
b
o
o
k appart
ie
n
e
a
\
n
G
iulia
particolare riferimento agli attori coinvolti dalla cosiddetta “primavera
araba”. Si dimostrerà, prima di tutto, come il “modello turco” non possa
essere ricondotto semplicisticamente alla presenza di un partito di
ispirazione islamica che governa in concordanza con i principi democratici
e, d’altro canto, come l’esempio della Turchia non possa essere messo a
confronto con la condizione dell’Egitto, della Tunisia e degli altri Paesi
dell’area, dal momento che si presentano ai nostri occhi differenze
strutturali di base difficilmente colmabili, se non altro nel breve-medio
periodo.
La prima precisazione da fare riguarda la definizione stessa di
“modello turco”. Quest’ultimo non può essere descritto e analizzato, se non
attraverso una prospettiva storica che prenda in considerazione almeno gli
ultimi trenta anni delle vicende politiche del Paese. L’attuale panorama
politico, la sua composizione, le sue regole istituzionali e il suo
funzionamento, hanno le proprie radici tra il 1980 e il 1983, vale a dire tra il
colpo di Stato militare imposto dal Generale Kenan Evren, il periodo di
governo formato dalla giunta militare da lui capeggiata e la stesura della
nuova costituzione del Paese327, tuttora in vigore, seppure emendata nel
2010328. Da quel momento la Turchia è stata testimone di un reale processo
di cambiamento delle dinamiche della propria struttura politica e
istituzionale, culminato nell’attuale stato d’essere del Paese e, sotto alcuni
punti di vista, tuttora in corso e non ancora giunto al termine. Fino agli anni
Ottanta, la Turchia è stato un Paese che, dal punto di vista politico e della
rappresentanza sociale, non può essere descritto come un sistema
pienamente democratico. L’influenza dell’elite militare da un lato e la
chiusura ad ampi strati di società civile, dall’altro, rendevano piuttosto il
Paese un modello di Stato semi-autoritario, in cui le libertà civili e politiche
non erano del tutto garantite. Se un ruolo importante nella definizione di
tale struttura interna era giocato dalla particolare collocazione geopolitica di
Ankara - unico attore facente parte della NATO a confinare direttamente
con l’ex Unione Sovietica e baluardo del contenimento occidentale
dell’URSS, in piena era bipolare - la particolare storia della fondazione
della Repubblica turca ha contribuito ad escludere dalla vita pubblica tutti i
riferimenti alla religione e alla cultura musulmana, per preservare il
laicismo di stampo kemalista329. Ciò ha portato gran parte della società
327 Per approfondire questo periodo, si veda tra gli altri ERIK J. ZÜRCHER, Turkey. A
Modern History, I.B. Tauris, London, 2004, pp. 278-291.
328 “Erdogan pulls it off”, The Economist, 13 September, 2010.
329 Per una ricostruzione delle riforme impresse da Mustafa Kemal al’apparato istituzionale e
politico della Turchia, si veda F. L. GRASSI, Atatürk, Salerno Editrice, Roma, 2008, pp. 240-
177
6
civile (che, tra gli altri punti di riferimento, rimaneva legata ai valori e alle
tradizioni dell’Islam) a non essere rappresentata nella vita politica del Paese
e ad esserne esclusa. Del resto, lo stesso discorso è valido per le minoranze
etniche, in particolar modo la comunità curda, la quale non era riconosciuta
come tale dalla Costituzione e alla quale veniva negata la libertà di
esprimere le proprie peculiarità anche dal punto di vista culturale330. La
transizione guidata dalla giunta militare di Evren e, successivamente,
dall’allora Primo Ministro Turgut Özal, ha avuto tra gli obiettivi principali
quelli di integrare per la prima volta la società civile nelle dinamiche
politiche del Paese e di dare maggiore spazio alle minoranze fino a quel
momento estromesse dalla vita pubblica331. Per il raggiungimento di tale
scopo, Özal aveva individuato nell’economia, soprattutto le piccole e medie
imprese, il motore fondamentale dell’innovazione politica turca332 e, nel
contempo, ha fatto sì che anche elementi come le associazioni ispirate dai
valori islamici potessero gradualmente essere integrate nel processo di
democratizzazione del Paese333. Del resto, tale passaggio risultava
fondamentale per un reale cambiamento della struttura politica e
istituzionale della Turchia, dal momento che l’intuizione alla base delle
riforme ozaliste consisteva proprio nell’apertura a tutti gli elementi
precedentemente lasciati da parte nella formazione delle politiche del
Paese334. Sembra essere, questo, il primo passo di quello che a ragione
315.
330 La comunità curda ha storicamente subito delle discriminazioni all’interno della Turchia,
come il divieto di usare la lingua curda in pubblico e la negazione stessa della sua diversità
etnica. La Turchia si è sempre riferita al popolo curdo come ai “Turchi della montagna”,
facendo riferimento al fatto che la maggior parte della popolazione curdo-turca abitava le aree
montagnose nel Sud-Est del Paese. Si veda P. ROBINS, Turkey and the Middle East, The
Royal Institute of International Affairs, London, 1991, pp.5-6.
331 Fu proprio grazie a lui che vi fu una prima apertura nei confronti delle minoranze etniche
ed un riconoscimento dei diritti culturali del popolo curdo fino all’abolizione della Legge 2932
del 1983 che, di fatto, negava ai Curdi l’uso della propria lingua e ne metteva al bando le opere
musicali e letterarie. Si veda B. ARAS e H. KONI, “Turkish-Syrian Relations Revisited”, in
Arab Studies Quarterly, Vol. 24, N. 4, Fall 2002, p. 55.
332 Lo stesso Özal, del resto, era un uomo di affari ed un imprenditore, con ottimi rapporti con
le istituzioni statunitensi e le organizzazioni internazionali economiche come il Fondo
Monetario Internazionale e la Banca Mondiale (per la quale era stato consulente per alcuni
progetti tra il 1971 ed il 1973).
333 Özal riuscì a sdoganare l’Islam come elemento della vita pubblica turca, grazie alla sua
integrazione con il nazionalismo: infatti il Primo Ministro rivendicava il ruolo dell’Islam turco
rispetto a quello arabo, come una forma di credo ed ideologia molto più moderata e, quindi,
perfettamente compatibile con il sistema laico, secolare e democratico esistente in Turchia.
334 Per una valutazione generale delle riforme di Özal, si veda S. LAÇINER, “Ozalism (NeoOttomanism): an Alternative in Turkish Foreign Policy?”, in Journal of Administrative
Sciences, N. 1-2, 2003-2004.
Questo ebook apparti
178
rtie
ne
a\n
Gi
Qu
est
oe
bo
ok
ap
pa
dovrebbe essere denominato il “modello turco”. Si tratta infatti di un
passaggio che non può essere tralasciato nella ricostruzione e nell’analisi
dell’attuale panorama politico del Paese, in cui si inserisce anche l’elemento
dell’Islam politico. E’ stato proprio grazie alle aperture e alla stagione
riformatrice inaugurata da Turgut Özal che il contesto politico turco ha
saputo integrare al suo interno anche i movimenti afferenti all’Islam
politico. Islam politico che, a ben guardare e come si avrà modo di
approfondire in seguito, risulta essere differente da quello della maggior
parte dei Paesi arabi, dall’Egitto alla Giordania, fino al Maghreb335.
Una prima considerazione da fare nel paragonare il “modello
turco” all’Egitto e alla Tunisia attuali, riguarda le modalità con le quali Özal
è giunto al potere nel 1983, dopo il periodo di governo della giunta militare.
In quell’anno, infatti, si tennero nuovamente in Turchia libere elezioni
parlamentari, le quali portarono il Partito della Madrepatria (Anavatan
Partisi, ANAP) ad ottenere una significativa maggioranza parlamentare
grazie al 45% dei consensi e a formare un governo stabile in grado di far
uscire il Paese dalla crisi istituzionale che si protraeva da più di un
decennio336. La società della Turchia si trovava in una condizione per alcuni
versi simile a quella odierna egiziana e tunisina, con un clima generale di
sfiducia nei confronti della classe politica, avvertita come poco
rappresentativa rispetto alle reali esigenze della popolazione e non adeguata
a far fronte alla crisi sociale, economica e politica che il Paese stava
vivendo. Se da un lato fu in questo clima che si era generato il colpo di
Stato condotto dal Capo di Stato Maggiore interarmi Kenan Evren,
dall’altro si evince un elemento di importante discontinuità con il passato
stesso del Paese, dal momento in cui la giunta militare al potere tra il 1980 e
il 1983, ha posto le basi per un processo di transizione politica che potesse
imprimere una svolta decisiva alla Turchia, tramite il mantenimento della
sicurezza nella situazione di emergenza e disordine sociale che si profilava,
la creazione di un nuovo impianto costituzionale nei limiti del quale
avrebbe dovuto prendere forma il cambiamento del Paese e, in ultimo, la
garanzia dello svolgimento di libere consultazioni elettorali, che avrebbero
portato l’ANAP a prendere il potere337. La situazione attuale della Tunisia e
335 Non a caso, ad esempio, la Turchia non è inserita come caso studio all’interno della pur
esaustiva opera a cura di M. CAMPANINI e K. MEZRAN, I Fratelli Musulmani nel mondo
contemporaneo, Utet, Milano, 2010, che fornisce una completa carrellata del movimento e
della sua presenza nei vari teatri del mondo musulmano, dall’Africa al Medio Oriente, fino alle
sue propaggini negli Stati Uniti e in Europa.
336 W. HALE, Turkish Foreign Policy 1774 –2000, Frank Cass Publishers, London, 2000, p.
164.
337 S. LAÇINER, op. cit.
179
dell’Egitto sembra, per alcuni versi, essere molto simile a quella della
Turchia ad inizio anni Ottanta. Sebbene non si possano fare dei paragoni tra
le precondizioni politiche e istituzionali, in quanto sia al Cairo, che a Tunisi,
governavano capi di Stato che avevano costruito una rete di potere e
alleanza interne di tipo clientelare e, d’altro canto, autoritario, rendendo
quei sistemi relativamente stabili al loro interno338, il confronto sembra
piuttosto reggere per ciò che concerne la percezione della società nei
confronti del mondo politico. In aggiunta, seppur nate da percorsi diversi, le
cornici entro le quali si trovavano ad agire le classi dirigenti della Turchia
all’indomani del colpo di Stato del 1980 e dell’Egitto e della Tunisia in
seguito al movimento della cosiddetta “primavera araba” e alla caduta dei
precedenti regimi, potrebbero essere a ragion veduta paragonate. A fronte
del cambiamento occorso nella classe politica turca, passato tramite un
chiaro processo di riforme istituzionali, economiche e sociali, a partire dallo
svolgimento di una tornata elettorale avvenuta in un contesto relativamente
libero, l’Egitto e la Tunisia attuali non hanno però ancora definito le
modalità dell’annunciata stagione di riforme interne, né tantomeno risulta
chiaro se e quando si procederà ad indire elezioni democratiche e con quali
attori partecipanti. Già dal punto di vista dell’avvio di un processo
riformatore che possa fungere da preludio all’inclusione di tutti i movimenti
sociali e politici nel processo di formazione politica, dunque, laddove il
“modello turco” attuale ha le proprie origini profonde nei cambiamenti
descritti e avviati più di trent’anni fa, risulterebbe evidente come l’Egitto e
la Tunisia, qualora non stabiliscano chiaramente le tappe del loro processo
di revisione istituzionale e non procedano ad attuare prima di tutto una
riforma elettorale e costituzionale, potrebbero difficilmente replicare
l’esempio della Turchia.
Oltre all’elemento elettorale, che ha avviato l’onda lunga della
stagione riformatrice in Turchia, vi sono inoltre da considerare due fattori
che contestualizzano il cammino di Ankara negli anni passati, fino alla
formazione del cosiddetto “modello turco”. Si tratta di due elementi che
sono divenuti fondanti rispetto all’evoluzione della Turchia negli ultimi tre
decenni, e sono correlati all’ambiente esterno entro il quale il Paese si è
trovato a portare avanti il processo di democratizzazione: la fine della
Guerra Fredda e di tutte le sue dinamiche e i negoziati della Turchia per
l’accesso all’Unione Europea. L’epoca bipolare aveva limitato le scelte di
politica non solo estera, ma anche interna, del governo di Ankara, portando
cia
a
i
u
l
i
an
Ca
c
G
e
a
\n
ien
oo
k
pa
rt
ap
b
s
t
o
e
e
Qu
2
ti
pu
o
338 Vi è comunque da sottolineare come il sistema posto in essere da Mubarak in Egitto era
sottoposto a pressioni interne già da qualche anno, con la prospettiva del suo ritiro dalla vita
pubblica nelle elezioni presidenziali che avrebbero dovuto svolgersi proprio nel 2011.
180
CL
I_
ne
181
ok appartie
339 Per ripercorrere la natura delle relazioni turco-statunitensi durante il periodo della Guerra
Fredda, si veda A. L. KARAOSMANOĞLU e S. TAŞHAN (a cura di), Middle East, Turkey
and the Atlantic Alliance, Foreign Policy Institute, Ankara, 1987.
340 Per un inquadramento della politica estera turca nel dopo-Guerra Fredda, si veda anche M.
AYDIN, Turkish Foreign Policy, framework and analysis, Center for Strategic Research,
Ankara, 2004
341 Si pensi che la Turchia, dopo gli anni del governo di Özal, durato dal 1983 al 1989, ha
avuto 12 governi diversi guidati da otto diversi Primi Ministri, fino al 2002, anno in cui è salito
al potere l’AKP. Allo stesso tempo, è in questo periodo che vi è stato un fiorire di associazioni
e movimenti nati dalla società civile. La Turchia era arrivata ad avere circa 2.700 fondazioni,
50.000 associazioni e 1.200 rappresentanze sindacali, cooperative e camere di commercio,
soprattutto nelle aree urbane. Queste nuove forme di associazione nascevano proprio come
opposizione alla classe politica al potere fino a quel momento. Si veda H. KRAMER, A
Changing Turkey, Brooking Institution Press, Washington D. C., 2000, pp. 17-23.
Questo ebo
la Turchia a dover agire all’interno di determinati schemi e a limitare la sua
azione politica nei confronti di regioni, come quella mediorientale, che non
rientravano appieno nel blocco occidentale a guida statunitense. L’accento
posto sulla stabilità e, soprattutto, sulla sicurezza, concorreva inoltre a
determinare la natura stessa del regime turco fino all’inizio degli anni
Ottanta. I frequenti colpi di Stato succedutisi con cadenza quasi decennale
tra il 1960 e il 1980, la necessità di estromettere tutti quegli elementi non
direttamente ricollegabili al mondo militare, ma piuttosto agli ambienti della
sinistra da un lato e, dall’altro, proprio agli ambienti islamisti, sono tutte
politiche che gli stessi Stati Uniti, alleati strategici della Turchia, la quale
costituiva per loro un partner privilegiato nella regione, hanno in qualche
modo appoggiato nella logica del contenimento tipico dell’era bipolare339.
Venendo meno il fattore strategico con la caduta dell’Unione Sovietica, la
Turchia ha potuto ampliare il proprio raggio di azione, oltre che nei
confronti delle aree confinanti, anche all’interno del proprio panorama
politico340.
In questo modo, a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, le
riforme già avviate da Özal presero definitivamente piede e il Paese, come
già detto, fu testimone di un allargamento senza precedenti della vita
politica e pubblica a tutti gli elementi facenti parte della società turca. Se è
vero che il fiorire di nuovi attori interni ha portato ad un periodo di
instabilità politica durata per tutto il decennio degli anni Novanta341, allo
stesso tempo è stato grazie a questa stagione di rinnovata competizione
interna che il Paese ha saputo raggiungere livelli di democrazia sempre
maggiori, ergendosi a modello per la regione. Negli stessi anni, l’avvio di
negoziati sempre più stretti con l’Unione Europea in vista di una sua
possibile adesione all’organizzazione hanno agito a elemento stimolante per
le riforme della Turchia. La necessità di adeguare il proprio sistema
ook a
to eb
Ques
politico, economico e sociale agli standard europei ha spinto i governi
succedutisi ad Ankara a mettere tale questione al primo posto della propria
agenda politica e ha prodotto risultati soddisfacenti per la
democratizzazione del Paese. L’inclusione dell’elemento dell’Islam politico
all’interno della vita pubblica turca è passata anche attraverso l’influenza di
questi due fattori, senza i quali è difficile dire se vi sarebbe stata la
transizione politico-istituzionale che è avvenuta in Turchia, preludio alla
partecipazione di partiti come il Partito del Benessere (Refah Partisi, RP)342
e, successivamente, l’AKP, al processo di formazione dell’agenda politica
del Paese. Anche in questo caso, siamo dunque di fronte a due tappe di
fondamentale importanza per la definizione di quello che sarebbe stato il
futuro della Turchia; elementi che non sono presenti nelle dinamiche che
hanno portato i sistemi istituzionali di Tunisia ed Egitto ad essere messi in
discussione. Al contrario, se per la Turchia, grazie alla scomparsa delle
logiche legate all’ordine internazionale bipolare, l’influenza occidentale e in
particolar modo europea hanno svolto un ruolo costruttivo rispetto al nuovo
modello politico interno che si andava delineando, per l’Egitto di Mubarak e
la Tunisia di Ben ‘Ali i rapporti con l’Occidente, in particolare Paesi come
Stati Uniti, Francia e Italia, si sono piuttosto basati sul mantenimento dello
status quo.
Tale discorso risulta sicuramente più valido per il regime di
Mubarak, visto il peso geopolitico, strategico, economico e culturale
dell’Egitto, rispetto alla Tunisia. Gli attori esterni occidentali, piuttosto che
spingere per un programma di riforme interne come accaduto per la Turchia
nel dopo-Guerra Fredda, hanno invece mantenuto una politica che, in nome
di una supposta stabilità regionale, ha legittimato quei regimi agli occhi
della comunità internazionale, secondo logiche molto simili a quelle che
avevano portato gli Stati Uniti a sostenere i governi a guida militare - o
sotto la penetrante influenza dell’esercito - in Turchia, fino agli anni
Ottanta. I cambiamenti occorsi all’interno di questi Paesi a seguito della
cosiddetta “primavera araba”, sembrano essere stati di natura prettamente
interna, piuttosto che influenzati da eventi esterni e, in questo senso, non vi
sono stati fattori che hanno svolto il ruolo che per la Turchia è stato rivestito
dal nuovo contesto regionale e internazionale all’indomani della caduta
342 Si tratta del partito fondato da Ecmettin Erbakan, leader dell’Islam politico in Turchia fino
alla fine degli anni Novanta e Primo Ministro, il primo nella storia della Turchia a provenire
dall’ambiente dell’Islam politico, tra il 1996 e il 1997. L’Attuale AKP ne rappresenta il
movimento che, in parte ne ha colto l’eredità, pur rinnovandone i caratteri. Per l’ascesa al
potere del RP e le sue caratteristiche, si veda anche İ. DAĞI, “Transformation of Islamic
Political Identity in Turkey: Rethinking the West and Westernization”, in Turkish Studies, Vol.
6, N. 1, March 2005, pp. 21-37.
tien
ppar
182
to
s
ue
Q
dell’Unione Sovietica e dalle pressioni impresse dall’Unione Europea in
senso riformatore. Sebbene in seguito alla caduta di Ben ‘Ali e Mubarak
l’Occidente abbia espresso una posizione più netta a sostegno delle
popolazioni tunisina ed egiziana343, è ancora presto per poter stabilire il
grado di influenza che l’atteggiamento di attori come gli Stati Uniti e
l’Unione Europea potrà avere sull’eventuale processo di democratizzazione
e transizione politica di questi Paesi. Anche in questo caso, dunque,
l’accostamento con la situazione della Turchia risulta se non altro
prematuro, dal momento che non sembrano ancora esservi alcuni di quegli
elementi strutturali che hanno permesso ad Ankara di compiere il cammino
delle riforme. Se da un lato la Turchia è oggi additata come un modello per
le realtà arabe interessate dai movimenti di protesta dei primi mesi del 2011,
d’altra parte la genesi del “modello turco” non può essere ignorata e il
constatare la differenza dei relativi punti di partenza da un lato e, dall’altro,
l’attuale assenza dei fattori determinanti della creazione di quel modello,
inducono ad osservare i cambiamenti in atto in Egitto e Tunisia con
maggiore attenzione e profondità di analisi, evitando di incorrere in
affrettati paragoni.
In ultima istanza, vi è da analizzare la natura stessa del modello di
Islam politico che si è costituito in Turchia e che, in alcuni casi è diventato
la ragion d’essere del paragone tra il “modello turco” e la sua trasposizione
nei Paesi arabi mediorientali e maghrebini. La stessa presenza di un
movimento, le cui radici si ritrovano proprio nei valori della cultura
musulmana, alla guida della Turchia, è stata additata come l’esempio da
seguire negli altri contesti della regione del Medio Oriente. E’ stato già
analizzato come il modello turco non possa essere semplicemente ridotto
alla dialettica tra un partito di ispirazione islamica e le istituzioni
democratiche del Paese, come se si trattasse di una condizione cristallizzata
e senza prendere in esame tutto il lungo cammino che ha fatto sì che la
situazione attuale potesse essere determinata. Ciò detto, occorre esaminare
le peculiarità dell’Islam politico turco e dei suoi sviluppi nella storia, al fine
di comprendere quanto questo possa costituire un esempio da seguire per i
Paesi arabi, oppure quanto se ne differenzia344. Il modello seguito in Turchia
343 Si pensi ad esempio al fatto che durante l’ultimo G8 tenutosi in Francia, i Paesi
partecipanti hanno deciso di stanziare 20 miliardi di dollari da destinare ai movimenti di
protesta arabi e ai nuovi governi. Si veda “G8 commits $ 20 bn to 'Arab Spring'”, Al-Jazeera,
27 May, 2011.
344 Per approfondire questo aspetto si veda, tra gli altri, M. H. YAVUZ, “Is There a Turkish
Islam? The Emergence of Convergence and Consensus”, in Journal of Muslim Minority
Affairs, Vol. 24, N. 2, October 2004, pp. 213-232, e A. RABASA e F. S. LARRABEE, The
Rise of Political Islam in Turkey, Rand Corporation, Santa Monica, 2008.
183
st
o
ue
Q
dai movimenti e dalle organizzazioni politiche di matrice islamica, poi
strutturatisi in veri e propri partiti politici, è connotato da fattori endogeni
che non possono essere ricondotti alla galassia della Fratellanza Musulmana
che ha preso piede in Egitto e, di lì, in molti altri Paesi arabi, tra cui la
Tunisia stessa. Sembra anzitutto doveroso ricordare come la Turchia non
abbia avuto, a differenza di quasi tutti i Paesi arabi della regione, un passato
da oggetto delle potenze e degli interessi coloniali, ma semmai abbia
ricoperto addirittura un ruolo di soggetto delle dinamiche - se non
propriamente colonialiste - imperialiste, tramite l’istituzione dell’Impero
Ottomano345, di cui l’attuale Repubblica di Turchia è lo Stato successore346.
Questa precisazione risulta di fondamentale importanza, nella
misura in cui tutto il dibattito interno al cosiddetto riformismo islamico, che
ebbe proprio in Egitto uno dei suoi centri più attivi e che sarebbe culminato
negli anni Venti del secolo scorso con la nascita del movimento dei Fratelli
Musulmani, è nato in gran parte come reazione all’occidentalizzazione dei
Paesi arabi e dei loro costumi. Occidentalizzazione che era indotta proprio
dalla vicinanza dell’elemento occidentale, quasi esclusivamente francese e
inglese, negli stessi territori arabi, tramite lo strumento del colonialismo e
dell’imperialismo347. Queste esperienze hanno indotto i movimenti politici
di natura islamica a interrogarsi sulle possibili reazioni che il mondo arabo e
musulmano avrebbe dovuto avere nei riguardi dell’influenza occidentale e,
di contro, si è progressivamente formato quel movimento che ancora oggi è
rappresentato dalla Fratellanza Musulmana e che propone una sintesi che si
in grado di mantenere le innovazioni positive dell’Occidente, pur
preservando la natura dell’Islam348. Se è vero che le varie manifestazioni dei
modi di vivere, percepire e professare l’Islam sono anche il frutto
e
345 Un’ottima monografia circa la storia dell’Impero Ottomano risulta essere ancora quella di
S. J. SHAW e E. K. SHAW, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Cambridge
University Press, 1976.
346 Più che vero e proprio Stato successore dell’Impero Ottomano, la Turchia moderna è la
risultante della guerra di indipendenza guidata da Mustafa Kemal contro le forze ancora
occupanti a seguito del Trattato di Sèvres del 1920. Per approfondire tale periodo si veda F. L.
GRASSI, op. cit., pp. 176-239.
347 Per una ricostruzione della genesi del pensiero riformista islamico si veda T. RAMADAN,
op. cit.
348 Il fondatore della Fratellanza Hassan al-Banna, sosteneva che, nonostante non di dovesse
provare vergogna per l’emulazione di alcuni aspetti dell’Occidente, come il modello offerto dai
programmi delle scuole e dal progresso scientifico, “[…] a margine di tale considerazione, i
Fratelli Musulmani ritengono che le conoscenze e i concetti debbano assumere un abito
islamico e che in essi si innesti l’anima dell’intelligenza islamica con i concetti della
sorveglianza divina, della fratellanza, del sentimento umanitario, allontana dosi così dal
male”. Citato in Ibidem, p. 353.
184
s
ue
to
ok
o
eb
dell’ambiente entro il quale ci si trova ad agire349, risulta evidente come la
Turchia abbia sviluppato una forma di Islam politico, nel tempo, diversa dai
movimenti che hanno preso piede negli altri Paesi arabi. L’Attuale partito al
governo dell’AKP è la risultante di un processo che ha visto i movimenti di
matrice islamica adattarsi al contesto in cui sono maturati, un contesto
caratterizzato dalla struttura istituzionale e politica creata da Atatürk al
momento della nascita della nuova Turchia, e che non prevedeva alcun
posto per le manifestazioni dell’Islam nella vita pubblica del Paese. In tale
contesto, i movimenti di ispirazione islamica hanno sempre agito nella sfera
del privato e della società e non avrebbero trovato spazio nella vita pubblica
se non vi fossero stati i cambiamenti e le aperture dall’inizio degli anni
Ottanta, cui si è accennato precedentemente. Questi movimenti, di cui
l’AKP rappresenta solo l’ultima evoluzione, hanno saputo sfruttare le
opportunità fornite dalla liberalizzazione della politica turca e, consci del
terreno su cui andavano ad agire, sono stati sempre fautori, a differenza
della Fratellanza Musulmana, di un’economia di libero mercato e
dell’iniziativa individuale all’interno della società350. Soprattutto
quest’ultimo aspetto si differenzia in maniera sostanziale dalla tradizionale
visione comunitaria dell’Islam e della maggior parte movimenti, anche
politici, che si rifanno ai valori musulmani, in cui l’aspetto comunitario è
sempre messo, al contrario, in primo piano.
È anche grazie a questi nuovi aspetti, favoriti dal clima economico,
sociale e politico entro cui si collocavano le varie forme dell’Islam politico
turco, fino a giungere all’AKP, che quest’ultimo ha saputo ottenere
consensi interni, ponendosi come una reale e percorribile alternativa ai
partiti politici pre-esistenti. In questo senso, si potrebbe affermare che i
partiti politici afferenti ai valori musulmani in Turchia siano stati in un certo
senso plasmati dalla realtà in cui si sono trovati ad operare e in cui sono
nati, mentre, viceversa, la paura in alcuni ambienti circa l’islamizzazione
delle società e della politica in Tunisia ed Egitto a seguito della “primavera
araba”, si fonda su un principio opposto. Il timore espresso dagli oppositori
di una maggiore partecipazione dell’Islam politico alla vita pubblica in
Egitto e Tunisia, sostengono cioè che tali movimenti, quali la Fratellanza
Musulmana ed al-Nahda, possano forgiare un nuovo modello istituzionale e
Q
349 Si veda M. H. YAVUZ, op. cit.
350 Si tratta di una concezione fondamentale della definizione dell’Islam politico turco. La
centralità dell’azione individuale, in un contesto di forte liberalizzazione politica ed
economica, è stata alla base della nascita dei movimenti di ispirazione islamica in Turchia ed è
anche un concetto che sembra essere stato ripreso dall’AKP. Si veda anche Ibidem, pp.141142.
185
politico che ricalchi gli ideali islamici351, così come è stato per l’Iran a
seguito della rivoluzione khomeinista del 1979. Ed è proprio di fronte ad un
simile scenario che da più parti si è fatto appello affinché, anche in questi
Paesi, si possa perseguire una “via turca”, piuttosto che iraniana, di
cambiamento interno. Se da un lato occorre sgombrare il campo da ogni
dubbio circa la reale possibilità che il modello iraniano possa essere valido
anche per l’Egitto e la Tunisia352, dall’altro tale articolo ha tentato di
mettere in evidenza le differenze che intercorrono anche rispetto al
panorama turco. L’eventuale democratizzazione dei due paesi
maggiormente coinvolti dalla “primavera araba” e, successivamente,
l’inclusione anche dei movimenti che si rifanno all’Islam politico nel loro
processo istituzionale, dipendono in prima istanza dalla messa in moto di un
preciso programma di riforme politiche, sociali ed economiche. Solo dopo
questo passo, come accaduto in Turchia, sarà possibile ottenere un
panorama politico variegato e pluralista353, all’interno del quale qualsiasi
attore potrà competere per la guida del Paese. Non si tratta solo di un
processo che deve interessare la Fratellanza Musulmana in Egitto e alNahda in Tunisia, ma che deve coinvolgere tutte le sfere della società e del
mondo politico coinvolte. Soltanto allora si potrà discutere delle eventuali
similitudini tra tali movimenti e l’AKP e della possibile riproposizione del
“modello turco” in quei Paesi.
Bibliografia
Campanini e Mezran K. (a cura di), I Fratelli Musulmani nel mondo
Questo
contemporaneo, Utet, Milano, 2010
351 Si veda a tal proposito un polemico articolo pubblicato dal Washington Institute for Near
East Policy, storicamente filo-israeliano e vicino alle posizioni neo-con, il giorno stesso delle
dimissioni di Mubarak. “The Muslim Brotherhood: On the Record”, Washington Institute for
Near East Policy, Policy Watch N. 1753, 4 February, 2011. Sulle paure circa
un’islamizzazione delle istituzioni egiziane e tunisina si veda anche “Islamists ready for their
close-up?”, Al-Jazeera, 10 March, 2011.
352 Le divergenze tra l’Iran e i due Paesi arabi sembrano essere troppe ed insormontabili:
caratterizzato da una comunità sciita, che contempla una gerarchia di tipo ecclesiastico, il
primo, e sunniti i secondi; guidati da un leader carismatico e universalmente riconosciuto come
tale - l’Ayatollah Khomeini - gli iraniani nel 1979, mentre caratterizzati da movimenti per lo
più di stampo secolare e senza una chiara guida e punto di riferimento, gli egiziani e i tunisini
oggi. Per un’analisi della società iraniana e dell’evoluzione politica dalla Rivoluzione del 1979
ad oggi, si veda R. GUOLO, La via dell'Imam - L'Iran da Khomeini ad Ahmadinejad, Ed.
Laterza, Bari, 2007.
353 Il riferimento non è, dunque, alla sola componente musulmana o dell’Islam politico, ma a
tutte le minoranze e le espressioni delle comunità e della società civile di tali Paesi.
186
Daḡi İ., Transformation of Islamic Political Identity in Turkey: Rethinking
the West and Westernization, Turkish Studies, Vol. 6, N. 1, March 2005
International Crisis Group (ICG), Popular Protest in North Africa and the
Middle East (I): Egypt Victorious?, Middle East/North Africa Report, n.
101, 24 February, 2011
a
ok
p
ICG, Popular Protests in North Africa and the Middle East (IV): Tunisia’s
Way, Middle East/North Africa Report, n. 106, 28 April, 2011
C., 2000
Lačiner S., Ozalism (Neo-Ottomanism): an Alternative in Turkish Foreign
e
eb
o
st
o
Kramer, H., A Changing Turkey, Brooking Institution Press, Washington D.
Qu
Policy?, Journal of Administrative Sciences, N. 1-2, 2003-2004
Larrabee, F. S. and Rabasa, A., The Rise of Political Islam in Turkey, Rand
Corporation, Santa Monica, 2008
Pacini, A. (a cura di), I Fratelli Musulmani e il dibattito sull’Islam politico,
Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1996
Ramadan, T., Il riformismo islamico, Città Aperta edizioni, Troina (EN),
2004
Robins, P., Turkey and the Middle East, The Royal Institute of International
Affairs, London, 1991
Taspinar, O., An Uneven Fit? The “Turkish Model” and the Arab World,
The Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution,
Analysis Paper N. 5, August 2003
Yavuz, M. H., Is There a Turkish Islam? The Emergence of Convergence
and Consensus, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 24, N. 2, October
2004, pp. 213-232
Zürcher, E. J., Turkey. A Modern History, I.B. Tauris, London, 2004
187
Qu
est
oe
boo
ka
ppa
rtie
ne
a\n
G
188
ne
e
i
rt
a
p
ap
iu
G
n
a\
o
bo
k
GUERRA CIVILE LATENTE”: RITI CONTESI E STRATEGIE DI
NATION-BUILDING NEL LIBANO DEL DOPOGUERRA.
Enrica Camporesi
ue
Q
o
st
e
Enrica Camporesi
Dopo la Laurea Triennale in Storia all’Università di Bologna,
Enrica Camporesi (n.1985) ha conseguito a febbraio 2011 la Laurea
Magistrale con lode in Lingue e Letterature Orientali (arabo)
all’Università Cà Foscari di Venezia, sotto la direzione di Rosella Dorigo.
La tesi di laurea, frutto di un anno di ricerche sul campo a Beirut e redatta
in Erasmus all’Università di Aix-en-Provence, è dedicata alle
problematiche storiografiche nel Libano del dopoguerra e loro influenze
sulla produzione teatrale sperimentale.
Interessata a studiare come insider gli intrecci fecondi tra storia
contemporanea e teatro di ricerca, Enrica Camporesi abita al Cairo da
settembre 2011 dove lavora come responsabile PR e comunicazioni per DCAF, il maggiore festival multidisciplinare d’Egitto dedicato alle arti
contemporanee.
Abstact
Il concetto di “guerra civile latente”, elaborato nel Libano
nell’immediato dopoguerra in ambito artistico e accettato in campo
storiografico nel corso degli anni ‘90, descrive la condizione di
irrisolutezza del conflitto e di emergenza continua, aggravata dagli eventi
recenti della storia libanese contemporanea. Si considera in questa sede la
definizione di “guerra civile latente” alla luce delle politiche ufficiali di
riconciliazione e pacificazione nazionale e in riferimento al ruolo della
società civile e degli “operatori della cultura della memoria” nello
sviluppare modelli alternativi di commemorazione del conflitto.
Si introducono quindi alcuni casi di studio significativi in quanto
pratiche tradizionalmente legate ai processi di nation-building come
l'insegnamento scolastico della storia nazionale e la redazione di un libro
di testo unitario e supra-confessionale, la ricostruzione del centro storico di
Beirut e la celebrazione 13 Aprile a Giornata nazionale della Memoria per
commemorare le vittime e gli scomparsi della guerra.
Si sottolinea infine come l'elaborazione di forme di
commemorazione sub-nazionali tra loro competitive (in particolare,
partitiche e confessionali) rifletta la pluralità delle appartenenze identitarie
e dei progetti nazionali concorrenti che caratterizzano il Libano moderno
sin dalla sua fondazione.
189
ti
pu
o
ia
a
i
u
l
i
an
C
a
cc
G
The notion of “latent civil war” has been elaborated in the
visual/performing arts field in Lebanon in the aftermath of the civil war and
it has since been widely accepted by civil society, media and academics to
describe the situation of perpetual emergency and unresolved sociopolitical tension that marks contemporary Lebanese history. Amongst the
many factors that have contributed to this feeling of latent conflict was the
inability of post-war governments to directly promote reconciliation
policies, while at the same time proclaiming a highly controversial Amnesty
law.
As a reaction to the politics of “state-sponsored amnesia” officially
promoted in the nineties, members of civil society (“cultural agents of
memory”) actively engaged in the field of social reconciliation, suggesting
alternative models for thinking about the conflict and remembering its
victims.
Some case studies, traditionally linked to the nation-building
process, are considered here, such as the editing of national history books,
the teaching of history in public schools (primary and high school level),
the reconstruction of the symbolic space of Downtown Beirut and the long
process leading to the establishment of April 13th as the official national
anniversary of the Civil W0ar.
The few cases introduced here, as well as the whole debate that
developed in Lebanon in the nineties around public/private commemoration
policies of the civil war, are interesting examples of the variety of national
narratives and competitive identities promoted by political parties, religious
communities and civil society in contemporary Lebanon.
ea
\n
n
art
ie
pp
ok
a
bo
sto
e
e
Qu
La questione delle identità nazionali libanesi, con il loro relativo
carico di miti e immaginari, è centrale per contestualizzare il tema della
commemorazione della guerra civile, divenuto un ulteriore terreno di
competizione per le numerose narrative esistenti sullo Stato-Nazione
libanese. Inoltre, alle problematiche identitarie oggetto di tanta letteratura
accademica354, si somma il tema del settarianismo sintetizzato in campo
politico: il sistema del confessionalismo politico prevede infatti una
354 Vedi ad esempio: Salame, Ghassane (1986) Lebanon’s injured identities: who represents
whom during a civil war? Oxford, Centre for Lebanese studies. Ghassane Salame, sociologo,
storico e ministro della Cultura negli anni 2000, individuava nelle alleanze familiari, di partito,
di comunità religiose, i soggetti promotori di quelle ideologie confessionali, sub-nazionali e
supra-nazionali competitive capaci di definire un sentimento ambivalente di appartenenza alla
nazione libanese, sin dal Patto Nazionale del 1943.
190
191
appa
ook
o eb
Que
st
355 Le comunità storicamente riconosciute (formula elaborata dall'amministrazione francese in
epoca mandataria) sono 18. Il sistema del confessionalismo politico prevede in particolare che i
cittadini godano dei diritti politici sanciti dallo stato libanese solo in quanto membri di una
delle comunità religiose riconosciute.
356 Accordo non scritto stipulato nell'estate del 1943 tra Bechara al-Khoury, esponente della
comunità maronita, e Ryad el-Sulh, sunnita, il Patto Nazionale (al-mithaq al-wataniyy) tentò di
rispondere alla questione dell'identità nazionale all'alba dell'indipendenza (concessa dalla
Francia il 22 novembre 1943): in cambio della promessa cristiana di riconoscere il volto arabo
del paese e di rifiutare l'intromissione straniera (francese) negli affari interni, i leader
musulmani riconobbero la totale indipendenza e sovranità del Libano entro i confini del 1920,
rinunciando a qualsiasi ambizione di annessione alla Grande Siria. Il Patto decretava la
divisione delle massime cariche dello Stato secondo i criteri del confessionalismo politico di
epoca mandataria e tardo-ottomana: il Presidente della Repubblica doveva essere maronita; il
Primo Ministro, sunnita; il portavoce del Parlamento, sciita. Tale sistema è stato di fatto
riconfermato dagli accordi al-Ta'if del 1989-90.
357 Il biennio 1989-1991 fu caratterizzato da una grande instabilità politica che vide il
succedersi di alcuni governi di unità nazionale fino all'esecutivo di Rashid el-Sulh, in carica
fino al 1992, quando le prime elezioni nazionali del dopoguerra portarono al potere il primo
governo di Rafiq al-Hariri (1992-1998).
358 Nell'Ottobre 1989 i deputati superstiti del Parlamento del 1972 firmarono a Al-Ta’if, in
Arabia Saudita, la Carta di riconciliazione nazionale, promossa su iniziativa dell'Alta
Commissione Araba Tripartita (tripartite arab high commission) composta da Arabia Saudita,
Algeria, Marocco. La Carta impose il ritorno ad una situazione di pace civile, lo
smantellamento delle milizie e alcuni provvedimenti politici e istituzionali strutturali che
imponevano il riequilibrio dei poteri delle principali comunità, riaffermando il sistema del
confessionalismo politico. Gli Accordi consolidarono il principio della sovranità nazionale
sull'intero territorio libanese, occupato dall'esercito israeliano a sud e invaso dalle truppe
siriane. Iniziava un lungo periodo definito dal giornalista Samir Kassir di Pax Siriana, a causa
dell'ingerenza civile e militare della Siria in tutti gli affari interni e esteri della politica libanese.
Kassir, Samir (2000 : 6-22).
359 Neuwirth-Pflistch (2001: 1-40). Neuwirth, A.- Pflistch, A., a cura di, (2001) Crisis and
memory in Islamic
r
spartizione proporzionale delle cariche politico-istituzionali del paese in
base al peso demografico di ogni comunità storicamente riconosciuta355,
secondo il principio politico del Libano “somma di minoranze”.
Tale visione, affiancata dalle scelte liberaliste in campo
economico e sistematizzata nella filosofia del libanismo elaborata negli anni
’30-’40 da Michel Shiha, trovò una prima applicazione pratica nel Patto
Nazionale del 1943356 e venne ripresa come principio guida degli Accordi di
Pace di al-Ta'if del 1989-90, che segnarono la fine della guerra civile e
l’inizio della II° Repubblica.
Il periodo immediatamente successivo alla fine della guerra357 e alla
firma degli Accordi di Ta’if358 fu segnato dal graduale ripristino delle
condizioni materiali di sicurezza nel paese attraverso politiche ufficiali di
riconciliazione e pacificazione nazionale aspramente criticate dalla società
civile che le ribattezzò “politiche dell’amnesia”359.
pp
a
Questo ebook
In questo quadro, lo storico Theodor Hanf (1993)360 ha sostenuto
come da un lato il confessionalismo politico e il liberalismo economico361
siano i tratti distintivi e fondativi del Libano moderno (vedi anche
Traboulsi, 2007),362 mentre dall’altro è l'esperienza traumatica collettiva
della guerra civile a forgiare un nuovo senso di appartenenza alla Nazione.
In questa analisi, il senso di appartenenza alla nazione libanese sarebbe
venuto in essere ex negativo dal collasso dello Stato e dalle ceneri della
guerra, così come una forma di memoria condivisa sarebbe venuta in essere
ex negativo dal trauma collettivo che aveva colpito trasversalmente
famiglie, comunità, milizie, partiti.
A oltre vent’anni dalla fine della guerra civile (e dagli studi di
Hanf), è possibile argomentare tale intuizione alla luce di una vasta
letteratura sull’argomento.363
Amnesia collettiva e “operatori della cultura della memoria”
«L'uscita dalla guerra nella vita quotidiana, percepibile grazie al
silenzio dei cannoni e alla ritrovata libertà di circolare, (…) non è stata
pensata, né ancor meno teorizzata come un'uscita dalla guerra sul
piano politico. Da cui deriva la curiosa assenza di una categoria di
“dopo-guerra” presso la maggior parte dei libanesi»364.
Di fronte alle “politiche dell’amnesia” governative, spettò alla società
civile e alle élite artistico-intellettuali promuovere narrazioni alternative
della guerra civile che sottolineassero soprattutto quanto l’esperienza della
guerra fosse stata tragicamente e trasversalmente simile per l’intero popolo
libanese:
societies Wurzburg-Beirut, Ergon.
360 Hanf, Theodor (1993). Il titolo programmatico di quest'opera fondamentale sulla storia
politica libanese è Coexistence in Wartime Lebanon. Decline of a State and rise of a Nation.
361 Sulla centralità del sistema economico liberale per le sorti dello Stato e della Nazione
libanese, vedi ad es. i discorsi del Presidente della Repubblica gen. Michel Suleiman rilasciati
in occasione del 22 novembre, Festa nazionale dell'Indipendenza.http://presidency.gov.lb
362 Traboulsi, Fawaz (2007) A history of modern Lebanon, Northampton, PlutoPress.
363 Per una bibliografia esaustiva sull’argomento vedi Haugbolle, Sune (2010) War and
Memory in Lebanon Cambridge, Cambridge University Press.
364 Kassir, Samir (2000: 6) Dix ans après, comment ne pas réconcilier une société divisée? in
« Monde Arabe Maghreb-Machrek », 169, 6-22.
192
«Art, media, activism and public debate in Lebanon suffers at
once too much and too little memory. This conclusion emerged
in reaction to the scarce efforts by the successive post-war
governments in Lebanon to promote public debate and
commemoration of the civil war. In the vacuum of what many
critics have called state-sponsored amnesia, political groups and
parties recreated hardened memories from the war within closedoff discursive and physical realms, such as particular media and
the neighbourhoods. Consequently, the burden of creating and
sustaining civilian memory has fallen squarely on civil society.
Their challenge has been to break the silence and involve the
population in memory work that would show how similar the
war experience had actually been for ordinary people»365.
Secondo gli operatori della cultura della memoria descritti da
Haugbolle366, la retorica di “dimenticare la guerra per ricominciare”
caratterizzò de facto l'atteggiamento dell'intera classe politica attiva negli
anni '90, formata da leader miliziani ed ex-signori della guerra, convertiti
politici dopo gli Accordi di Ta’if.
In particolare, la legge di amnistia generale (al-‘ufū al-‘āmm, legge
n. 84 del 1991)367 e il piano di ricostruzione del centro storico di Beirut
(legge n. 117 del 1991)368 furono descritte in quest’ottica come un tentativo
di state-sponsored amnesia to practice oblivion369, secondo la definizione di
Michael Young, editorialista del quotidiano libanese anglofono The Daily
Star.
Inoltre la gestione clientelare del ritorno dei profughi e degli sfollati
(stimati tra le 50.000 e 500.000 persone) e le indagini di facciata sugli
scomparsi (17.000 persone stimate) contribuirono a radicare nella società
193
Questo ebook appartiene
365 Haugbolle (2010: 74).
366Lo studioso danese definisce cultural agents of memory quelle personalità, associazioni,
enti coinvolti nella produzione di memorie della guerra civile destinate ad un uso pubblico e
critiche delle narrative ufficiali.
367 La legge di amnistia generale promulgata il 26 agosto 1991 decretò la rinuncia da parte
dello Stato a perseguire i crimini compiuti dai cittadini libanesi fino al 28 marzo 1991
(escludendo dunque i combattenti palestinesi, siriani, ecc.) e interruppe le azioni legali e i
processi già avviati. L’amnistia non riguardava gli omicidi di personalità religiose, politiche,
diplomatiche (art. 3). Imponeva inoltre il disarmo delle milizie e il loro reinserimento
nell'esercito libanese regolare.
368 Vedi ad es. Kabbani, Oussama (1992) Prospects for Lebanon: the reconstruction of Beirut,
Oxford, Markaz li-‘l-buhuth al-lubnaniyyah/Centre for Lebanese Studies.
369 Michael Young, The Daily Star, 21/2/1999. Cit in Neuwirth-Pflistch (2001:28).
civile un profondo sentimento di ingiustizia, irrisolutezza della guerra civile
e di sfiducia nelle Istituzioni.370
Un sentimento descritto tra gli altri da Darina al-Joundi, attrice
libanese e autrice del monologo autobiografico “Quando Nina Simone ha
smesso di cantare”:
«A Beirut nulla era davvero cambiato. Mi sembrava strano
camminare per le vie della città senza le grida dei miliziani,
senza il rumore delle pallottole. Nel giro di qualche giorno la
città avrebbe cambiato completamente faccia, tutti avevano fretta
di voltare pagina, di dimenticare i centocinquantamila morti per
niente. In un batter d’occhio i cecchini, i tiratori, gli assassini si
sono confusi con la folla. Un esercito di assassini volatilizzati da
un colpo di bacchetta magica che si chiama amnesia. La guerra
aveva causato oltre trecentomila feriti, ma per strada non si
vedeva un invalido. La società libanese si vergognava dei suoi
handicappati, li aveva nascosti o cancellati come errori di
ortografia. Ognuno aveva voltato pagina, senza leggerla, con la
massima rapidità. I libanesi si sono sbarazzati della storia della
guerra come di un cadavere»371.
k
sto
o
bo
n
e
a
p
ap
e
e
L’instabilità politica interna, l'ambivalente presenza siriana, le ripetute
operazioni belliche lanciate da Israele nel dopoguerra contro il Libano
meridionale (1993, 1996, 1999, 2000, 2001, 2006) contribuirono ad
aggravare il sentimento di una mancata riconciliazione nazionale e di un
perpetuo “stato di emergenza”. E’ in questo contesto che, nel corso degli
anni ’90, dall’ambito artistico, giornalistico e dell’attivismo civile372 si è
affermata anche in ambito storiografico la definizione di “guerra civile
latente”, a descrivere la situazione di radicale tensione politica e sociale
rimasta irrisolta nonostante gli accordi di pace e le politiche governative
ufficiali.
Strettamente legati al processo di nation-building del Libano
contemporaneo, si introducono alcuni casi di studio significativi alla
Qu
370 Vedi ad es. Kassir (2000). Vedi anche KARAM, Karam (2006) Le mouvement civil au
Liban: revendications, protestations et mobilisations associatives dans l'après‐guerre, Paris,
Karthala ‐ IREMAM.
371 Al-Joundi (2009: 117). Al-Joundi – Kacimi (2009) Quando Nina Simone ha smesso di
cantare, trad. it, Torino, Einaudi.
372 Vedi tra gli altri: Samir Kassir, Jibran Tueni, Elyas Khury, Bilal Khbeiz, Rabi’ Mroue,
Widad Halwani, l'associazione UMAM, l'associazione Ashkal Alwan, …
194
en
rti
a\
contestualizzazione della nozione di “guerra civile latente”: la redazione di
un libro di storia unitario e l’insegnamento della storia contemporanea, la
ricostruzione del centro storico di Beirut, il riconoscimento ufficiale del 13
Aprile a Giornata nazionale della Memoria, evento originariamente nato
come celebrazione minoritaria promossa dagli attivisti del Lijnat ahali almakhtufiin wa almafqudin fi Lubnan (Comitato dei familiari dei rapiti e
degli scomparsi in Libano).
Educazione alla nazione
La redazione di un libro di storia unitario era stato previsto sin dagli
Accordi di Ta’if, secondo quanto concordato in materia di educazione. In
particolare, il Piano per la Rinascita dell'Educazione, approvato dal
Consiglio dei Ministri nell'agosto 1994, stimava necessaria la revisione e
sviluppo dei curricula in modo tale da rafforzare il legame alla nazione e
l'integrazione e da incoraggiare l'apertura culturale e spirituale, insieme
all'unificazione dei libri di testo nei due campi di studio della Storia e
dell'Educazione nazionale.373 Non è questa la sede per entrare nei dettagli
delle vicende giuridiche e politiche delle numerose commissioni ministeriali
(miste, a livello confessionale) incapaci di redigere un testo scolastico di
storia approvato all'unanimità per gli istituti pubblici inferiori e superiori
(pari al 40% del totale). Si sottolinea però che le divergenze ideologiche
delle commissioni non riguardarono la storiografia della guerra civile, i cui
eventi sono tuttora esclusi da tutti i curricula se non a livello universitario,
ma si concentrarono sugli fatti della storia antica e moderna del Libano. In
particolare, suscitò polemiche inconciliabili la terminologia usata per
descrivere il periodo della conquista araba del VII° secolo, la
colonizzazione francese del XX° e l'Indipendenza del Libano dalla Francia
(1943-46).
È stato inoltre messo in luce374 come il tentativo da parte della
commissione ministeriale di unificare i libri di testo in nome di una ritrovata
coesione nazionale abbia di fatto riprodotto quelle logiche di
frammentazione comunitaria che intendeva superare.
Come scrive lo storico 'Usamah Makdisi nel saggio Beirut, a city without
History?
195
b
Que
s
t
o
e
373 Bashshur, Munir (2003: 159) The deepening cleavage in the educational system in Hanf,
T.-Nawaf, S., a cura di, (2003) Lebanon in Limbo: postwar society and State in an uncertain
regional environment Baden, Nomos.
374 Bashshur (2003: 167).
«The Republic of Lebanon gained its independence in 1943;
its history came to a sudden end in 1946. For, according to
government education policy, there is no history of Lebanon
after 1946, the year in which the official unified history
curriculum draws to a close (…) as a result, the last
centralized history curriculum in Lebanon was defined in
1946 and has not officially been modified on a national scale
since then»375.
Se i programmi di storia nelle scuole superiori si fermano al 194346, è opportuno anche ricordare che i libri di testo variano notevolmente in
base alla località e orientamento degli istituti scolastici oltre che la
formazione dei suoi insegnanti,376 che fino all’aprile 2011 esistevano solo
tre corsi universitari dedicati alla storia contemporanea tenuti
rispettivamente da Carla Eddé e da George Corm all'USJ e da Fawaz
Traboulsi all'AUB,377 che le cifre degli iscritti ai corsi di Storia sono in forte
calo.378
Tali osservazioni si pongono in piena continuità con gli studi dello
storico Ahmad Beydoun che, in piena guerra civile, sosteneva come la
storiografia e l'insegnamento della storia in Libano si facessero terreno
aperto per la contrapposizione e l'autoaffermazione delle identità subnazionali riconosciute dal sistema confessionale.379
Nel testo citato, Makdisi connette direttamente le pratiche
dell’insegnamento della storia con le politiche di ricostruzione della capitale
lanciata nel 1992-1994 dalla compagnia SOLIDERE (Societe Libanaise
pour le developpement et la reconstruction) di proprietà Hariri (all’epoca
anche primo ministro).
In questa analisi, Makdisi considera i discorsi sulla commemorazione
della guerra e le strategie ufficiali di ricostruzione come precise intenzioni
della classe politica dirigente di promuovere una narrazione elitaria e
375 Makdisi, Saree (2006) Beirut, a city without history?, in 2006 Makdisi, Ussama –
Silverstein, Paul, a cura di, Memory and Violence in the Middle East and North Africa ,
Bloomington,
Indiana University Press, pp. 201‐214.
376 Vedi Abou Moussa, Tanos (1996), Entre identité nationale et identités communautaires:
l’enseignement de l’histoire au Liban, Tesi di dottorato presentata all’Università Paul Valery Montpellier III - Histoire et civilisations.
377 Ricerca sul campo, settembre 2009-giugno 2010.
378 Intervista a Fawaz Ṭraboulsi, storico e docente all’American University di Beirut,
2/6/2010, AUB, Beirut.
379 Beydoun, Ahmad (1984), Identité confessionnelle et temps social chez les historiens
libanais contemporains, Beirut, Publication de l’Université Libanaise.
196
Q
ue
nostalgica della Storia contemporanea, capace di privilegiare i momenti
rampanti della nazione libanese a discapito di una riflessione profonda sulla
guerra civile, che non trova né i tempi né gli spazi adeguati per la
riconciliazione del corpo sociale.
Lo spazio simbolico del centro città: controversie della ricostruzione
La lunga e costosa campagna di SOLIDERE, apertamente attaccata
da larga parte della società civile, costituisce in proposito un esempio
lampante delle occasioni mancate dai governi libanesi del dopoguerra per
articolare un discorso realmente inclusivo sulla commemorazione del
conflitto.
Più in particolare, le tappe principali del piano di ricostruzione videro
in primo luogo l'espropriazione forzata degli immobili del centro risarciti ai
legittimi proprietari con azioni della medesima società; seguirono le
demolizioni massive nella zona del Burj (nome più familiare ai beirutini
della Sahat al-Shuhada'/Piazza dei martiri), di al-Saifi, di Bashurah, del
quartiere ebraico Wadi Abu Gamil e dei mercati; si aprì infine la fase tuttora
in corso delle ricostruzioni.
Dal 1994, SOLIDERE lanciò la campagna pubblicitaria Beirut,
madinah ‘arifah li-'l-mustaqbal/Beirut, an ancient city for the future, che di
fianco alle demolizioni, promuoveva un programma di scavi archeologici.
Un approccio criticato dagli “operatori della cultura della memoria” perché,
se nella pratica si impegnava a preservare resti di epoche antiche sepolte nel
cuore della città (le mura fenicie, i bagni romani e altri resti mamelucchi e
ottomani), allo stesso tempo cancellava ogni traccia del passato recente
della guerra civile, riaffermando sul piano dell’urbanistica gli stessi
principi della legge di amnistia generale approvata dal Parlamento nel 1991.
Come commenta Samir Kassir, in perfetta armonia con l'immagine di
“uomo nuovo e senza memoria” del premier:
«il progetto Hariri con la sua proposta di una configurazione
in rottura con la morfologia urbana nota e di una finalità
economica eterocentrata, aveva tutti i tratti di un progetto di
città nuova, in netta discontinuità con il passato, in altre
parole privo di memoria. La memoria architettonica (…) la
memoria sociale (...), la memoria della rottura [il periodo
della guerra civile]. Spazio durevole del confronto, il centro
invocava invece la conservazione, anche solo stilizzata, del
197
Qu
es
t
u
Q
to
s
e
fuori-tempo della guerra, almeno come anamnesi o come
rituale di profilassi collettiva»380.
Ciò che nel dibattito intellettuale della seconda metà degli anni '90
è stato maggiormente criticato delle politiche del Premier Hariri e della
compagnia SOLIDERE è la nozione di identità della città implicitamente
proposta con la ricostruzione. Secondo molti intellettuali (tra cui George
Corm, Jade Tabit, Salim Sa‘adah, Yusuf Taklah, Fu'ad 'Awwada, Nabil
Bayhum, Michael Davie, Ussama Kabbani, ...), i piani di ricostruzione
tentavano di eguagliare il ruolo di capitale internazionale giocato da Beirut
nel periodo 1950-'70381, sospesa tra un passato ricco di glorie archeologiche
e un futuro passatista, rivisitato alla luce di un moderno “gigantismo
saudita” che ben simbolizzava gli accordi politico-economici stretti tra il
miliardario Hariri e la casata di Riyad.382 In tale prospettiva, il tempo della
riflessione sul conflitto e una visione capace di includere anche il
traumatico passato recente, erano del tutto assente dai piani proposti per il
centro storico.
Per quanto riguarda la ristrutturazione di Piazza dei Martiri, ad
esempio, diversamente dallo spazio circoscritto e familiare del vecchio
Burj, la nuova spianata aperta verso il mare ricordava a molti il
prolungamento della Green Line (linea di separazione che durante la guerra
civile divideva Beirut Est da Beirut Ovest) fin nel cuore della città. Secondo
l'interpretazione dell'architetto Jade Tabet, la natura di luogo pubblico e il
potenziale di luogo della memoria costituito dal Burj erano dimensioni
sacrificate ad altre logiche economico-politiche:383
«L'objectif ultime de cette logique urbaine qui veut exclure
de la ville nouvelle les “déviances” et les “anormalités”, c'est
d'y ériger une citadelle purifiée, un espace idéal débarrassé à
jamais du désordre et de la confusion. Si l'on détruit les restes
du centre ancien, c'est qu'ils peuvent constituer une réalité
dangereuse, impossible à maîtriser puisqu'elles abrite une
380Kassir, Samir (2009: 637), Beirut. Storia di una città, Torino, Einaudi. ed. originale
francese (2003) Histoire de Beyrouth, Paris, Fayard.
381 Kabbani, Oussama (1992), Prospects for Lebanon: the reconstruction of Beirut, Oxford,
Markaz li-‘l-buhuth allubnaniyyah/Centre for Lebanese Studies.
382 Vedi ad es. la moschea Mohamed al-Amin, in piazza dei Martiri a Beirut, lanciata da Rafiq
Hariri nel 2002 e inaugurata qualche anno più tardi.
383 Tabet, Jade (2001: 68), Beyrouth. La brûlure des rêves, Paris, Collection Monde HS, 127,
Autrement.
198
pluralité d'usages, une multiplicité de relations, d'échanges,
de modèles hétérogènes et parfois même contradictoires,
difficiles à intégrer dans la gestion efficace d'une ville
“moderne”. Traduction spatiale d'un fantasme issu des
débordements de la guerre libanaise, celui d'une société
normalisée, ordonnée, disciplinée, qui servirait d'assise à un
néoliberisme débridé, l'enjeu réel du projet apparaît alors
dans toute sa clarté: non pas l'aménagement de l'espace, mais,
tant au niveau économique que symbolique, la prise de
possession des lieux».
Meccanismi simili di appropriazione elitaria/contestazione civile di
celebrazioni della memoria nazionale si possono esemplificare seguendo
l'iter delle commemorazioni ufficiali della guerra civile.
Riti contesi: 13 Aprile, Giornata nazionale della Memoria
Il Presidente ha espresso il desiderio che il 13 Aprile rimanga nei
cuori e nelle menti dei libanesi come ricordo e come principio. Questo
anniversario è un'occasione per riflettere sulle divisioni e gli scontri interni
tra i libanesi che condussero alla devastazione ed alla distruzione, alcuni dei
quali continuano fino ad oggi. Per quanto riguarda il suo valore di monito, il
popolo libanese dovrebbe sapere che può costruire lo Stato che desidera
solo attraverso il dialogo, la comprensione reciproca, la concordia sotto il
segno della Costituzione e del Patto di coesistenza nazionale, il rispetto
delle Leggi e il riconoscimento reciproco. Così da stabilire uno Stato forte e
capace di difendere la nazione e i suoi cittadini e di assicurare
l'indipendenza e la dignità della Patria»384.
Questo ebook appartiene a\nGi
La scelta governativa del 2005 di festeggiare il 13 Aprile come
Giornata nazionale della memoria della guerra civile si colloca sulla linea di
altre ricorrenze ufficiali intese a celebrare i fondamenti comunitari,
consociativi e di solidarietà nazionale del Libano moderno.385
384 Cfr. discorso del Presidente della Repubblica Gen. Michel Suleyman in occasione delle
celebrazioni del 13 aprile 2011:
http://www.presidency.gov.lb/arabic/news/pages/details.aspx?nid=9325
385 Vedi Haugbolle (2010: 197). Cfr. ad es. la celebrazione del 22 novembre, giorno
dell’Indipendenza dalla Francia (1943), tradizionalmente festeggiata dal Presidente della
Repubblica nella residenza di Ba’abda, dove riceve le massime autorità confessionali libanesi e
delegazioni diplomatiche internazionali; il 18 aprile, in memoria dei bombardamenti israeliani
199
La data commemora l'attacco falangista ad un autobus di
combattenti palestinesi a Ain el-Rummaneh (13 aprile 1975), episodio
riconosciuto quasi all'unanimità dalla storiografia libanese come l'inizio
della guerra civile.
Nel 2005, il riconoscimento istituzionale del 13 Aprile come
Giornata nazionale della Memoria costituì un momento di svolta nelle
politiche nazionali della memoria, significativo perché in primo luogo
ricordava la commemorazione dell'inizio delle ostilità e non degli accordi di
pace che le terminarono, onorando cosi la formula la ghalib wa la maghlub
(né vincitori, né vinti), definizione elaborata dal gen. Fu'ad Shehab a
conclusione degli scontri del 1958, ma entrata nel linguaggio corrente per
descrivere gli esiti della guerra civile del 1975-90. L'espressione offre il
vantaggio di una deresponsabilizzazione collettiva di tutti i politici, i
miliziani e i civili coinvolti nella guerra.
La decisione di riconoscere il 13 Aprile a Festività Nazionale
costituì uno spartiacque perché il provvedimento riconosceva una delle
principali richieste avanzate dalla società civile nel corso degli anni
'90/2000, dopo un decennio di rifiuti da parte delle stesse istituzioni statali
durante il primo governo Hariri (1992-1998).
Nell'aprile 2001 il convegno pubblico Dhakira lil-mustaqbal (Una
memoria per il futuro) aprì ufficialmente una discussione pubblica sui temi
della memoria collettiva e delle responsabilità governative. Guidata da
giornalisti, accademici, storici, scrittori, attivisti come Alexandre Najjar,
Samir Kassir, Maha Yahya, Ahmad Beydoun, Amal Makarem, la
conferenza pubblica del 13 Aprile 2001 si organizzò in movimento
permanente e dal 2003 collaborò con il Comitato dei Familiari dei Rapiti e
degli Scomparsi in Libano (Lijnat ahali al-makhtufiin wa almafqudin fi
Lubnan), fondato dall'attivista e pacifista Widad Halwani nel 1982, dopo la
scomparsa del marito. Dopo che le puntuali richieste sulla questione degli
scomparsi erano state liquidate dal primo governo Hariri (legge sugli
scomparsi del 1995 e inchiesta del 2000386), il Comitato aveva in effetti
\
ea
n
e
i
art
pp
sto
e
u
Q
ka
boo
e
del 1996 sul Libano meridionale (massacro di Qana) respinti dalla moqawama (resistenza) di
Hizbollah; il 25 marzo, festa cristiana dell'Annunciazione, riconosciuta nel 2010 dal Presidente
della Repubblica gen. Suleyman come festività trans-confessionale e, dunque, nazionale. Oltre
alle tradizionali festività religiose celebrate dalle singole comunità, altre proposte di
celebrazioni secolari nazionali sono state finora escluse dal calendario ufficiale: Hizbollah
aveva suggerito, ad esempio, di celebrare il Giorno di Gerusalemme (Yawm al-quds) l'ultimo
venerdì di Ramadan; Solange Jemayel, vedova di Bachir, ex-Presidente della Repubblica e
leader del Kata'ib, aveva proposto la data dell'assassinio del marito (14 settembre 1982) come
festività nazionale.
386 Nel 2000, l'apertura di una speciale commissione d'inchiesta governativa sugli scomparsi
200
na
ulia
nGi
deciso di allargare le proprie rivendicazioni, sollecitando tra l'altro il
governo a riconoscere il 13 Aprile come giornata di commemorazione
nazionale degli scomparsi e a fondare un monumento nazionale, atti di
celebrazione nazionale a vocazione supra-confessionale e unitaria invocati
per onorare tutte le vittime della guerra, confortarne i familiari e ammonire
le nuove generazioni.
La campagna Tandhakir wa tan'ad promossa dall'Associazione
Memoria per il Futuro e dal Comitato ricevette un buon appoggio
mediatico, in particolare dai quotidiani al-Safir387 e an-Nahar388, e il 13
aprile 2003, al Teatro al-Medina di Beirut, si celebrò per la prima volta una
Giornata della Memoria che vide la partecipazione di qualche migliaio di
persone e un grande corteo in Piazza dei Martiri in memoria delle
manifestazioni pacifiste organizzate in periodo di guerra sulla Green Line
dagli stessi attivisti.
La battaglia per un collettivo devoir de mémoire condotta dalla
società civile trovò un alleato politico naturale in al-Yaser al-dimuqratiyya
(La Sinistra Democratica), partito secolare fondato all'inizio del 2004 sotto
la guida di Samir Kassir, Georges Hawi, Elias Atallah, Ziyad Majid, Elyas
Khoury.389
Il movimento, che raccoglieva una rappresentanza significativa
della ex-leadership comunista, si fece spazio sulle pagine del quotidiano anNahar diretto da Jibran Tueni e, nel dicembre dello stesso anno, promosse la
redazione della Dichiarazione dell'Hotel Bristol,390 momento di svolta
Questo eboo
non aveva portato ad alcun risultato concreto, risolvendosi in un provvedimento emanato nel
2001, dopo solo 6 mesi di indagini, che dichiarava “morti tutti gli scomparsi da più di 4 anni il
cui corpo non è stato ritrovato”. Tale provvedimento, inaccettabile dai familiari e dai membri
del Comitato, è stato interpretato come un atto di deresponsabilizzazione della classe politica e
un ulteriore affronto alla memoria degli scomparsi. Karam (2006: 188).
387 Dossier pubblicati tra l'8 e il 12 Aprile 2003, con interviste a politici e intellettuali. Cit. da
Haugbolle (2010:
201).
388 La casa editrice Dar al-Nahar aveva pubblicato nel 2002 il testo curato dall'attivista Amal
Makarem: Dhakirahli-'l-mustaqbal/Mémoire pour l'avenir/Memory for the future, Beirut, Dar
al-Nahar.
389 Vedi Kassir, Samir (2005). Primavere. Per una Siria democratica e un Libano
indipendente, Messina, Mesogea.
390 http://www.lebanonwire.c om/0412/04121801bristol_declaration.asp
Alleanza formale dei partiti di opposizione sotto la guida del PSP di Joumblatt contro le
ripetute ingerenze siriane, la Bristol Declaration firmata da numerosi partiti della mu'rada
(opposizione) manifestava contro l'imposizione siriana di prolungare il mandato al Presidente
della Repubblica uscente Emile Lahoud, impedendo lo svolgimento di libere elezioni.
L'opposizione aveva trovato un appoggio internazionale insperato nella Risoluzione n. 1559
201
politica nell'organizzazione dell'opposizione libanese alle ingerenze siriane
che, anche in seguito all'assassinio di Rafiq al-Hariri (14 febbraio 2005),
sfociò nelle manifestazioni di piazza della Intifada al-Istiqlal (marzo-aprile
2005).
Senza entrare nell’analisi politica delle manifestazioni e contromanifestazioni di piazza che videro la formazione di due nuove alleanze
contrapposte (la coalizione filo-siriana dell'8 marzo vs la coalizione del 14
marzo), si intende sottolineare qui l'uso politico della “retorica della
memoria” da parte dello schieramento guidato da al-Mustaqbal (il partito di
al-Hariri) in occasione della Jum'at al-wahda al-wataniyyah (la Settimana
dell'unità nazionale), festival organizzato nel centro storico di Beirut, dal 3
al 13 Aprile 2005, in occasione del trentennale della guerra civile.
Nelle intenzioni dei promotori della Settimana dell'unità nazionale
(tra cui Bahiyya al-Hariri, sorella del premier assassinato), la
commemorazione del 13 Aprile era stata promossa come celebrazione
nazionale inclusiva, tentando di superare le divisioni politiche esplose
durante la primavera beirutina:
i
«noi tutti meritiamo il Libano dell'unità, della sovranità,
dell'indipendenza e del futuro. Per restare il Libano di tutti e,
sopra a tutti, una Patria per la vita».391
p
cc
ia
na
uo
t
Ca
iul
ia
G
e
tr ie
n
a\
n
a
k
sto
bo
o
ap
p
e
e
Qu
3
20
1
_
CL
I
Di fatto, il linguaggio scelto per le celebrazioni escludeva la
coalizione filo-siriana dell'8 marzo, guidata da Hizbollah, definendola exnegativo come il movimento della frammentazione nazionale (vs unità),
dell'illegittimità (vs sovranità), della dipendenza dalle potenze vicine (in
riferimento all’ingerenza siriana vs indipendenza), del passato (inteso come
mantenimento dello status quo vs il futuro, al-mustaqbal, inteso non solo
come “modernità”, ma è anche il nome del partito di Hariri).
D'altra parte, la retorica ottimista e proiettata al futuro di un Libano
unitario, la cui prosperità e sicurezza è stata minata nel corso della storia
solo dagli interventi stranieri (secondo l'interpretazione storiografica
classica descritta dall’espressione di Gibran Tueni “una guerra per gli
altri”)392, deresponsabilizzando la classe politica locale e, in sostanza,
dell'ONU (2/9/2004), che imponeva il ritiro delle truppe siriane dal suolo libanese e lo
smantellamento di tutte le milizie armate agenti nel paese.
391 Kulluna nastahiqqu Lubnan al-wahida. Al-sayyada. Al-istiqlal wal-mustaqbal. Liyabqi
Lubnan lijami' wafawqa al-jami' watanan lilhayat Cit. in Haugbolle (2010: 221).
392 Tueni, Ghassan (1985), Une guerre pour les autres, Beirut, Dar An-Nahar.
202
voltando la pagina nera della guerra civile senza leggerla, era una strategia
che non rispondeva neanche alle richieste avanzate dalla società civile, che
infatti organizzò contro-manifestazioni di protesta in alcuni spazi pubblici
simbolici della capitale come Shari’a Dimashq (la Green Line, appunto).
\nGiu
ook appa
rtiene a
Questo e
b
L’impossibile accordo sulla commemorazione unitaria della guerra
civile e sulla stesura di un libro di storia condiviso, le controversie sulla
ricostruzione di Beirut e la battaglia per l’appropriazione delle date
simboliche della guerra civile riflettono i progetti politici e le identità
nazionali, sub-nazionali e supra-nazionali promossi in competizione
reciproca dalle comunità religiose, dai partiti politici e dalla società civile
libanese, perpetuando uno stato di tensione politica continuamente irrisolta
e aggravata dagli eventi della storia piu’ recente.
Tra queste, il ritiro completo delle truppe siriane dal Libano dopo
trent'anni di occupazione (fine aprile 2005), il governo di larga intesa
nominato da Fu'ad Siniora (maggio 2005), l'assassinio di numerosi
intellettuali e politici impegnati contro il regime siriano (l'esecuzione di
Samir Kassir, George Hawi e Jibran Tueni, tra giugno e dicembre 2005), il
sit-in permanente organizzato dalla coalizione dell'8 marzo attorno al
Parlamento libanese (2007-2008), la crisi di governo di dicembre 2010 e
quindi lo scoppio della rivoluzione e della guerra civile in Siria mantengono
il paese in uno “stato di emergenza” strutturale, cui le diverse forze
politiche reagiscono riproducendo narrative discordanti sui fondamenti
stessi della Nazione libanese.
ti CLI_
lia
n
a
C
a
c
ciapuo
203
Q
ue
st
Bibliografia
Beydoun, Ahmad (1984) Identité confessionnelle et temps social chez les
historiens libanais contemporains, Beirut, Publication de l’Université
Libanaise.
Hanf, Theodor (1993) Coexistence in Wartime Lebanon. Decline of a State
and rise of a Nation.
Hanf, T.-Nawaf, S., a cura di, (2003) Lebanon in Limbo: postwar society
and State in an uncertain regional environment Baden, Nomos.
Haugbolle, Sune (2010) War and Memory in Lebanon Cambridge,
Cambridge University Press.
Kabbani, Oussama (1992) Prospects for Lebanon: the reconstruction of
Beirut, Oxford, Markaz li-‘l-buhuth allubnaniyyah/Centre for Lebanese
Studies.
Karam, Karam (2006) Le mouvement civil au Liban: revendications,
protestations et mobilisations associatives dans l'après‐guerre, Paris,
Karthala ‐ IREMAM.
Kassir, Samir (2009: 637) Beirut. Storia di una città, Torino, Einaudi. ed.
originale francese (2003) Histoire de Beyrouth Paris, Fayard.
Kassir, Samir (2000:6-22) Dix ans après, comment ne pas réconcilier une
société divisée? in « Monde Arabe Maghreb-Machrek », 169.
Makarem Amal (2002), a cura di, Dhakirah li-'l-mustaqbal/Mémoire pour
l'avenir/Memory for the future, Beirut, Dar al-Nahar.
Neuwirth, A.- Pflistch, A., a cura di, (2001) Crisis and memory in Islamic
societies Wurzburg-Beirut, Ergon.
Tabet, Jade (2001) Beyrouth. La brûlure des rêves Paris, Collection Monde
HS, 127, Autrement.
Traboulsi, Fawaz (2007) A history of modern Lebanon, Northampton,
PlutoPress.
204
ne a\nGiuliana C
Questo ebook appartie
L’EVOLUTION DE LA CONCEPTION FRONTALIÈRE DU
COLONISATEUR FRANCO-ESPAGNOL ET SES RÉPERCUSSIONS
SUR L’OUEST SAHARIEN, 1900-1960
Jesús M. Martinez Milan
Jesús M. Martinez Milan
Professor of Economic History and Foreign Relations at the
University of Las Palmas de Gran Canaria. his research focuses on the
history of the Spanish colonialism in the Maghreb and the Spain’s foreign
relations. His publications include Las pesquerías canario-africanas, 18001914 (Madrid, 1992); España en el Sahara occidental y en la zona sur del
protectorado en Marruecos, 1885-1945 (Madrid 2003); “Integrating
Western Saharan Coastal Fisheries into the International Economy”
International Journal of Maritime History, (june 2008) vol. XX, No 1, 281292; and “Les pêcheurs canariens dans les eaux mauritano-sahariennes, de
l’occupation du Sahara Occidental au départ de l’Espagne, 1885-1975” in
Alberto López Bargados and Jesús Martínez Milan (eds), Cultures du
littoral. Dynamiques frontalières entre les Canaries et la côte saharomauritanienne (Barcelona, 2010), 93-124.
Abstract
Cet article a comme but l’analyse de l'évolution du concept de
frontière dans l'espace saharien, expérimentée par le colonisateur Franco Espagnol. Si dans un premier temps le territoire a été délimité en utilisant
les méridiens, les parallèles et les accidents géographiques ; au fur et à
mesure que la pénétration coloniale est devenue évidente à l'intérieur du
territoire cité - spécialement de la part des Français - il a évolué vers un
concept de frontière qui essayait de conjuguer les lignes de délimitation
avec l'espace territorial d'une tribu ou d’un ensemble de tribus, sans tenir
en compte que la perception de l'espace dans la pensée tribale était
totalement différente.
La rivalité et les intérêts hispano-français dans la région dans les
années postérieures à la Deuxième Guerre mondiale, ont empêché tout type
d'accord frontalier au-delà de ce qui était établi dans les traités et les
conventions signées entre 1900 et 1912, sauf celui de la délimitation de la
frontière sud-est du Sahara avec la Mauritanie. La décolonisation du
Maghreb a fini par changer en intangibles des frontières qui ont nui à la
société nomade, puisqu'elle a vu s’altérer son mode de vie par imposition
des puissances colonisatrices.
205
to
Que
s
This article aims to analyse the evolution of the concept of border in
the Sahara as a result of French-Spanish colonization. The territory was
initially delimited using meridians, parallels and geographic accidents, but
the onset of colonial penetration in this territory – particularly by the
French – produced an evolution of the concept of border that endeavoured
to match delimitation lines with the territorial area of a tribe or set of
tribes; this concept failed to take into consideration the fact that the tribal
perspective of space was completely different.
Rivalry and Spanish-French interests in the region in the years
following the Second World War impeded any kind of agreement as to the
setting of frontiers beyond what was established in the treaties and
agreements signed between 1900 and 1912, apart from the delimitation of
the south-eastern frontier of the Sahara with Mauritania.
The
decolonization of the Maghreb finally rendered intangible frontiers that
endangered nomad society, a way of life that was prejudiced by the
imposition of the colonial powers.
ebo
ok
_20
oti C
LI
na C
ac
c
i
a
pu
lia
e
a
\
nGi
u
n
ppa
rtie
a
Cette communication a pour objet de réfléchir à l’évolution du
concept de frontière au sein des puissances coloniales, notamment de la
France, et ses répercussions sur les populations hassanophones du sud du
Maroc et de l’espace saharien.
S’ils délimitaient au départ les frontières en fonction des méridiens,
des parallèles et des accidents géographiques, les colonisateurs européens –
au fur et à mesure qu’ils approfondissaient leur connaissance des sociétés
colonisées – évoluèrent vers des conceptions frontalières qui essayaient
d’accorder cette délimitation au territoire d’une kabila ou d’un ensemble de
kabilas (délimitation anthropogéographique) sans se soucier du fait que non
seulement les sociétés nomades ou semi-nomades, à l’inverse des
populations sédentaires du sud du Maroc, ne sont pas liées à un espace
déterminé, mais que les alliances politiques (leff) forgées entre les tribus
changeaient en fonction de multiples facteurs, dépassant ainsi les limites
territoriales d’une tribu ou d’une confédération de tribus.
Les débuts de la pénétration espagnole dans la région, à partir de
1930, rendirent les choses un peu plus difficiles, non seulement parce qu’ils
ignoraient (et ils mirent un certain temps à les appréhender) les subtilités
d’une société tribale que les différentes administrations coloniales
françaises (Mauritanie, Algérie et Maroc) avaient réussi à diviser en
compartiments étanches, mais également parce que désormais, les tribus
sahariennes et du sud du Maroc allaient de nouveau être l’objet d’un
processus de différenciation qui affecterait une fois de plus leur identité,
206
telle qu’ils la concevaient avant la colonisation européenne, comme un
ensemble de groupes interdépendants parlant la même langue (le hassaniya).
uo
p
a
i
De la frontière naturelle et géométrique aux tentatives d’implantation
acc
C
d’une frontière anthropogéographique.
a
lian
u
i
Gmars 1981, au Laboratoire
Lors de journées d’étude organisées en
a\ndisparu, de l’Université Paris
Connaissance du Tiers-Monde, aujourd’hui
e
VII, intitulées “Problèmes de frontières
tien dans le tiers-monde”, le géographe
r
a
p le problème des frontières héritées des
français Yves Lacoste aborda
apSous
k
colonisateurs européens.
le titre: “Typologie géopolitique”, Lacoste
boo de frontières que l’on différencie habituellement,
proposa une e
classification
o
lui-même
est n’étant pas d’accord avec cette même classification. Il mentionna
u
tout
Q d’abord les frontières dites “naturelles”, qui coïncident par endroits
avec des accidents topographiques. Il évoqua ensuite les frontières
géométriques liées aux méridiens et aux parallèles, puis, en dernier, les
frontières anthropogéographiques, “qui correspondent en totalité ou
partiellement, aux limites spatiales d’un groupe ethnique, d’un peuple ou
d’une nation”393.
Lorsque la France et l’Espagne divisèrent l’espace saharomauritanien et le protectorat marocain, elles procédèrent à une délimitation
qui, afin de servir leurs intérêts, s’effectua en fonction des accidents
topographiques, des méridiens et des parallèles. La réalité apprit cependant
aux colonisateurs qu’une chose était la délimitation des frontières sur le
papier, qui ne correspondait pas à la réalité, et une chose bien différente
étaient les subtilités d’un territoire et d’une population nomade installée
entre les contreforts du sud du Maroc et le fleuve Sénégal.
La première tentative de modification des frontières, bien que sans
évolution conceptuelle de cette dernière, eut lieu au printemps 1911. A cette
date, le haut responsable de la politique française en Mauritanie, le colonel
Patey, proposa une redéfinition des frontières qui impliquait deux options :
garder Oued ed-Dajab ou déplacer la frontière méridionale qui séparait le
Río de Oro de la Mauritanie vers le nord, en l’établissant sur une ligne qui
irait du cap Barbas sur la côte atlantique jusqu’à un point de la frontière
orientale situé en face de la Sebja de Iyīl. La colonie de Mauritanie aurait
ainsi pu accroître son territoire grâce à la péninsule du cap Blanc, l’Adrār
393 Cf. Yves LACOSTE (1982): “Typologie géopolitique”, in Frontières. Problèmes de
frontières dans le tiers-monde. Journées d’études des 20 et 21 mars 1981. Paris, L’Harmattan,
Pluriel-débat numéro 30, pp. 9-14.
207
_2
LI
ti C
Sutūf et la ligne des puits et des postes frontières qui jalonnaient la frontière
méridionale du Sahara occidental394.
La deuxième tentative eut lieu sept ans plus tard (fin 1918). Une
fois de plus, le ministère des Colonies (dont dépendait l’AOF) demanda au
Quai d’Orsay de négocier avec l’Espagne pour, soit obtenir la cession du
Sahara occidental, soit déplacer la frontière méridionale jusqu’au cap
Bojador et transférer la frontière orientale vers l’Atlantique, afin de
contrôler les territoires parcourus par les Ulād Delīm, les Ulād Bū as-Sba’a
et les Rgeibāt. Cette stratégie correspondait en tout point à la volonté
française de placer les grandes tribus nomades sous sa domination, ce qui
devait également lui permettre de mettre fin aux razzias et d’en finir avec le
caractère bipolaire du nomadisme Rgeibāt395. Au-delà de cette redéfinition
territoriale démesurée, souhaitée par l’administration coloniale française en
Mauritanie, la redéfinition frontalière qu’elle proposait était plus proche
d’une conception anthropogéographique des “limes” qu’à une délimitation
ad hoc.
Au fur et à mesure que les Français s’installaient au sein de
l’espace maroco-saharien et approfondissaient leur connaissance de la
société tribale, certains responsables se rendirent compte qu’un tracé basé
sur des accidents naturels, des méridiens et des parallèles, n’avait aucun
sens. Le premier à critiquer une telle conception fut le général Calmel. En
1926, alors que l’on délimitait la frontière aux confins du sud-ouest
marocain, ce général se montra favorable à ce que les lignes de démarcation
d’une région coïncident avec les limites tribales, afin d’éviter que ne se
produisent en cas contraire des “dissensions, des pressions internes et
finalement, des soulèvements et des rebellions d’un côté ou de l’autre.” Il
terminait son explication en affirmant qu’au cours des siècles, “les tribus se
sont installées dans une poche de terrain déterminée et seules les lignes de
démarcation établies de cette manière (…) offrent une certaine stabilité”396.
Néanmoins, vu son manque de connaissance en la matière, ce que Calmel
Qu
es
to
eb
oo
ka
pp
ar
tie
ne
a\
nG
394 Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Étrangères Paris (ADMAEP), série
Nouvelle, sous-série Afrique Equatoriale Française, contentieux territorial franco-espagnole,
dossier général, vol. VIII (mars 1907-janvier 1914). Note sur le Río de Oro. Saint Louis, 11
mars 1911. Cf. également, Jesús Mª Martínez Milán (2003): España en el Sáhara Occidental y
en la zona sur del Protectorado en Marruecos, 1885-1945. Madrid, UNED, pp. 238-239.
395 ADMAEP, s. Afrique 1918-1940, ss. Afrique Occidentale Espagnole, affaires générales,
vol. 1 (décembre 1918-octobre 1937), liste annexe au d. nº 306. Le ministre des Colonies au
ministre des Affaires Étrangères. Paris, 17 décembre 1918, pp. 2, 11 et 12. Y, MARTÍNEZ
MILÁN, op. cit., pp. 248-250.
396 Ibidem. Note sur la détermination de la frontière aux confins sud-ouest du Maroc, par le
général Calmel. s.l.n.d.
208
iul
ian
a
C
eb
oo
ka
p
Qu
es
to
proposait n’avait pas grand-chose à voir avec la réalité tribale de la région
comprise entre le sud du Maroc et la frontière méridionale du Sahara
occidental à cette époque.
Calmel voulait que l’enclave d’Ifni fasse entièrement partie de la
France, en laissant aux Espagnols un couloir le long de la côte qui partirait
de la rive sud de l’Uād Nūn, au niveau de Goulimin (qui resterait sous
domination française), et se prolongerait en ligne droite vers Smara, où elle
rejoindrait par une tangente le courbe décrite par la Sebja de Iyil. Cette
délimitation ne satisfaisait personne au sein de l’administration française,
car son ignorance de la société bidān aurait laissé aux mains des Espagnols
une partie de la confédération Tekna, et ne prenait pas en compte les zones
de nomadisation des Rgeibāt Sahel. Profitant de la proposition de Calmel, le
gouverneur de la Mauritanie, le lieutenant Fournier, insista afin de déplacer
la frontière orientale du Sahara vers un point proche de la côte atlantique
qui leur permettrait de contrôler les territoires de nomadisation non
seulement des Rgeibāt plus méridionaux, mais également de deux des trois
factions formant les Rgeibāt al Guasīm (plus septentrionaux). Une fois de
plus, et c’était déjà la troisième, l’administration coloniale mauritanienne
profitait de la moindre occasion pour réclamer un contrôle absolu de la
majeure partie des territoires de nomadisation de la confédération Rgeibāt.
Deux ans plus tard (1928), sous la dictature de Primo de Rivera,
l’Espagne offrit d’occuper Sidi Ifni, à un moment où la France n’avait pas
encore commencé sa pénétration de la zone présaharienne du Maroc. Cette
nouvelle poussa les Français à s’entendre avec les Espagnols, mais surtout à
étudier pour l’avenir des formules de délimitations frontalières différentes,
en optant, dans certains cas, pour une démarcation territoriale clairement
anthropogéographique. Ce fut précisément cette année-là que le Centre de
Documentation Sociologique (CDS), organisme dirigé par le capitaine de
corvette Robert Montagne et le lieutenant François de la Chapelle, et
dépendant de l’état-major des troupes d’occupation française au Maroc,
avait entrepris, avec le soutien de la Direction générale des affaires
indigènes et l’Institut des Hautes Etudes Marocaines, une série d’études sur
le terrain afin de fournir à l’armée française des données plus approfondies
sur la géographie et l’ethnographie des territoires situés entre l’Anti-Atlas et
le fleuve Sénégal, afin de rechercher des solutions plus en accord avec leurs
intérêts.
Entre mars et avril 1928, aussi bien la résidence générale de Rabat
que le CDS prièrent le gouvernement français de faire pression sur Madrid
afin d’éviter l’occupation d’Ifni, en allant jusqu’à proposer de l’échanger
contre une région limitrophe de la Guinée espagnole. Comme cela était
209
Quest
o
ebook
ap
impossible, parce que les Espagnols auraient demandé des ajustements au
nord du protectorat, Montagne et son équipe se montrèrent favorables au
respect du statu quo. Plus encore : si l’occupation devenait effective, ils
proposaient de maintenir la frontière orientale telle qu’elle avait été définie
en 1912 et de faire tout leur possible pour que les tribus d’Ait Lahsen et
d’Ait Moussa u Ali, qui nomadisaient entre le Nūn et le Drā, demeurent
dans l’orbite française, afin d’empêcher les Espagnols de faire la jonction
entre leurs territoires de Sidi Ifni et de Tarfaya, dont les conséquences sur
leurs intérêts étaient considérées comme graves397.
Finalement, l’enclave de Sidi Ifni ne fut pas occupée, car la
dictature de Primo de Rivera, malgré ses efforts, ne put corriger l’inertie de
la politique coloniale espagnole dans la région, qui consistait en de petits
détachements situés à des points précis de la côte atlantique, sans aucune
volonté de pénétrer à l’intérieur du territoire, vu le coût humain et
économique que cela supposait, sans compter les répercussions d’une telle
action en matière de politique intérieure.
Avec l’avènement de la II République, la politique de la France
envers l’Espagne se durcit. Paris, basant sa politique bilatérale sur le rapport
de force, ne voulait céder sur aucun des points sensibles398.
Sept mois plus tard (14 novembre), Montagne et de la Chapelle
présentaient un rapport intitulé “France et Espagne. Collaboration et
délimitation des frontières”399, une synthèse de ceux élaborés auparavant
par le CDS en ce qui concerne les relations franco-espagnoles au sud du
Maroc et le Sahara occidental. En marge des considérations géographiques,
les deux officiers étaient convaincus que lors des conversations futures avec
l’Espagne au sujet de la délimitation frontalière, le principe
anthropogéographique devait l’emporter sur toute autre considération. Sur
cette base, ils proposaient la solution suivante: dans la région d’IfniTarfaya, ils pensaient que la France pourrait céder à l’Espagne la totalité de
la confédération des Ait Ba ‘Amran, ainsi que quelques concessions
éventuelles sur la frontière septentrionale, concernant l’enclave liée à la
kabila des Ahel Sahel. En échange, Madrid devrait renoncer à toute
prétention sur la région du Nūn, à la totalité de la piste Fum el HossamTindūf, aux bassins du fleuve Drā, et enfin, au sud-est du Sahara occidental
partie
ne a
\
n
G
i
u
liana
C
acci
a
p
u
o
ti CL
I_201
3
0
0
3
0
3969
11
397 Cf. Jesús Mª Martínez Milán: “Sidi Ifni en el contexto del colonialismo español en el sur
de Marruecos, 1912-1956”, in Hesperis-Tamuda (sous presse).
398 Cf. Yves Denèchère (1999): La politique espagnole de la France de 1931 à 1936. Une
pratique française de rapports inégaux. Paris, L’Harmattan, p. 181.
399 Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT), série 3-H, caisse 311. France et Espagne.
Collaboration et délimitation des frontières. Rabat, 14 novembre 1930.
210
(la région du Tiris). Au cas où l’Espagne n’accepterait pas la question du
Nūn, les frontières d’Ifni demeureraient inchangées.
En outre, les deux officiers proposaient une répartition des kabilas
entre les deux nations. En principe, cette répartition – de type
anthropogéographique et issue d’une connaissance embryonnaire des
alliances politiques entre les différentes factions et sous-factions d’une
kabila avec la France – concernait uniquement le pays Tekna et quelques
grandes tribus du Sahara occidental dont la majeure partie des Ulād
Delīm400. En ce qui concerne les Tekna, Montagne et De la Chapelle
laissaient aux mains des Espagnols les Izargiyyīn et Yagut du leff Ait
Yemel, ainsi que d’autres moins importantes. Le reste des Tekna, ainsi que
les Kunta, quelques Ulād Delīm et la puissante confédération Rgeibāt
devaient rester sous la domination coloniale française. Si cette décision
n’était pas du goût des Espagnols, on proposerait une nouvelle répartition
tribale, plus favorable à la France, qui contrôlerait les deux leff dominant la
région Tekna et la majeure partie des Rgeibāt401.
Cependant, la “pacification” des confins algéro-mauritanomarocain, l’occupation d’Ifni et la poussée, dans le Sahara occidental, du
gouvernement de Madrid, remirent en cause les prétentions françaises et les
obligèrent à revoir leur délimitation frontalière dans un sens plus
anthropogéographique. En mai 1934, le lieutenant-colonel Chatras,
commandant du territoire d’Agadir, envoya une étude au général de brigade
Catrous sur la question frontalière d’Ifni. En analysant les deux options, la
délimitation naturelle ou anthropogéographique, Chatras choisit la première,
vu que les Espagnols utilisaient désormais l’argument ethnique, mettant en
danger les intérêts politiques et les alliances conclues par leurs homologues
européens dans la région du Nūn. Catroux était du même avis, et c’est ce
qui ressortit de la réunion technique que maintinrent à Rabat à la mi-juin les
envoyés spéciaux des deux pays. Lors de cette réunion, les Espagnols ne
demandèrent pas seulement le contrôle de la confédération Ait Ba ‘Amran,
mais également un corridor de 25 kilomètres de large qui unirait Ifni et
Tarfaya, afin de pouvoir intervenir dans les affaires du pays Tekna. Après
deux jours intenses de réunion – et après la fin de non-recevoir des Français,
qui voyaient bien que les Espagnols voulaient intervenir dans les affaires du
Nūn – les deux commissions acceptèrent de se retirer des postes qui
faisaient l’objet du contentieux, et de se répartir provisoirement leur
ka
o eb
oo
st
Que
n
ppa
rtie
400 Sur cette tribu, cf. Alberto López Bargados (2003): Arenas coloniales. Los Awlād Dalīm
ante la colonización franco-española del Sáhara. Barcelone, Bellaterra.
401 Jesús Mª Martínez Milán (2003), op. cit., pp. 270-280.
211
surveillance, afin de maintenir un modus vivendi acceptable, aussi
longtemps que possible402.
Le triomphe de la délimitation traditionnelle sur les autres conceptions
frontalières.
Les lignes qui séparaient les possessions et les zones de protectorat
des deux pays ne furent pas modifiées et l’on ne procéda jamais au bornage
des frontières, malgré quelques tentatives en 1901. La seule chose qu’on
avait obtenue était de fracturer encore un peu plus, autant que faire se peut,
le degré de cohésion des fractions et sous-fractions des différentes kabilas
qui peuplaient les territoires colonisés.
Après la période difficile traversée par les deux pays entre 1936 et
1945, la découverte de fer à Iyil au début des années cinquante, relança
l’intérêt pour la délimitation frontalière, car la France, cherchant des ports
qui lui permettraient d’exporter ledit minerai, avait le choix entre Villa
Cisneros et Port Etienne. Les études avaient démontré un fait indéniable : la
première option était plus courte, en termes de distance, et moins chère sur
le plan économique.
Au début de l’année 1951, le gouvernement de Franco demanda à
la France le bornage de la frontière située entre le Sahara et la Mauritanie.
Les négociations qui s’ouvrirent l’année suivante à San Sebastian,
terminèrent cette même année par un accord entre les deux puissances, qui
s’entendirent sur sa démarcation, et par l’acceptation de Madrid d’un accord
de bon voisinage entre les autorités des deux territoires et la librecirculation dans la région d’Oued-ed-Dajab d’une mission scientifique
française chargée d’étudier aussi bien la construction d’une ligne ferroviaire
entre Fort Gouraud et Port Etienne, de 700 km, qu’une autre ligne de 380
km qui partirait du même fort pour rejoindre Villa Cisneros403.
Cependant, à cause d’un ensemble de facteurs, dont, parmi les plus
évidents, l’absence d’accord entre l’AOF, MIFERMA et l’Espagne sur le
tracé définitif, l’accord ne put être signé que vers la fin de 1956, le bornage
de cette partie de la frontière ne commençant qu’au premier semestre de
l’année suivante404.
oo
k
to
a
eb
ue
s
Q
ien
e
rt
pp
a
402 Cf. Jesús Mª Martínez Milán, op.cit., in Hesperis-Tamuda (sous presse).
403 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN), Madrid, série F, caisse 252, lettre
nº 782 du 22 août 1952.
404 Le conseil d’administration de MIFERMA décida d’étudier l’option de Port Etienne, grâce
à des investissements technologiques qui permettraient de baisser les coûts: des trains plus
lourds, des bateaux au tonnage plus élevé et surtout la construction d’un tunnel de 2 kilomètres
qui traverserait le massif du Choum afin d’éviter de passer par le territoire du Sahara
212
a
La guerre d’Ifni-Sahara qui éclata à la fin de cette même année et
termina en avril 1958, paralysa provisoirement la démarcation de cette ligne
frontalière, qui reprit une fois la région pacifiée. A partir de ce moment et
parallèlement à la rétrocession au Maroc de la zone sud du protectorat,
l’Espagne décida de mieux exploiter les ressources du Sahara occidental.
C’est dans ce cadre qu’il faut insérer l’entrevue du ministre de l’Armée
Espagnole (général Barroso) et l’ambassadeur de France à Madrid, à la fin
de l’année 1959. Au cours de leur entretien, Barroso fit clairement
comprendre à l’ambassadeur que l’Espagne avait l’intention de demeurer
sur ce territoire, et d’y mener à bien un vaste programme de recherches
minières et pétrolifères, qui devraient entraîner l’installation permanente des
européens :
«Il faudra (commenta Barroso) les protéger, ce qui ne sera pas
toujours facile : nous avons vu refluer vers nos postes des
techniciens italiens qui travaillent dans la concession obtenue
par eux plus au nord, et qui ne se sentaient plus en sécurité. Il
serait extrêmement souhaitable que nous puissions augmenter
la population européenne du pays ; on ne se sait jamais ce qui
peut arriver dans l’avenir : si un jour, les circonstances
devaient rendre inévitable une consultation des populations
locales, l’appoint des voix européennes joint à l’appui des
tribus favorables à l’Espagne contribuerait à contrebalancer
les votes qui réclameraient l’indépendance»405.
Le ministre ne lui fit pas seulement comprendre que l’Espagne
souhaitait rester dans la colonie du Sahara, mais il insista sur le fait que
l’exportation des minerais de Tindouf et de Fort Gouraud ne pouvait se faire
économiquement et raisonnablement qu’à travers le territoire espagnol, ce à
quoi l’ambassadeur français lui répondit que ce serait très coûteux et que
Port Etienne bénéficiait d’un emplacement privilégié. Cette idée d’utiliser le
port de Villa Cisneros pour exporter le minerai devait continuer à être
to
es
213
Qu
occidental. Cf. Michel Catala (2008): "La France et l’Espagne face à l’émergence des
revendications marocaines sur le Sahara occidental en 1956 ", in Jean-Marc Delaunay (éd.) :
Aux vents des puissances. Paris, Presse Sorbonne Nouvelle, pp. 133-134. Y, Pierre Bonte
(2001) : La Montagne de Fer. La SNIM (Mauritanie) : Une entreprise minière saharienne à
l’heure de la mondialisation. Paris, Karthala, pp. 49-50.
405 CADN, Rabat, Caisse 88, secret, affaire: conversation avec le ministre de l’Armée. M.
Roland de Margerie à son Excellence M. le Ministre des Affaires Étrangères. Madrid, le 18
décembre 1959.
eb
en
ti
ar
p
p
ka
o
to
o
eb
défendue au début des années soixante par d’anciens militaires français
ayant servi dans l’administration coloniale406.
L’idée de délimiter les frontières territoriales en accord avec les
entités tribales ou supertribales naquit de l’expérience acquise par les
Français au cours de leur “pénétration pacifique” au Maghreb pendant
l’entre-deux guerres, et fut l’une des options envisagées par les militaires
français face à la pénétration espagnole des territoires voisins, afin d’y
exercer leur domination sur les kabilas les plus importantes et leurs
territoires. Voyant que dans de nombreux cas, une kabila ou un groupe de
kabilas dépassait son territoire de nomadisation, en vertu d’alliances
politiques conclues avec des tribus différentes, ils se rendirent compte que
ce type de délimitation ne servait pas leurs intérêts. Cette option, qu’aussi
bien Montagne que De la Chapelle considérait comme étant plus
appropriée, et qu’ils étudièrent jusque dans ses moindres détails, fut
immédiatement “substituée” par le maintien d’une conception frontalière
traditionnelle au moment où les Espagnols entrèrent aussi bien dans les
confins du Maroc que dans le Sahara et utilisèrent également l’argument
ethnique afin, entre autres, de parvenir à l’union tant désirée de leurs
colonies d’Ifni et du Sahara avec la zone de Tarfaya.
La période de transition (qui ne fut pas très importante dans le cas
de l’Espagne) de la décennie 1936-1945, mit un point final à toute
modification de la conception frontalière des deux parties, vu que les
intérêts en jeu étaient aussi opposés que des plaques tectoniques. Entre 1945
et 1960, les Espagnols et les Français s’entendirent uniquement sur la
délimitation in situ de la frontière sud-est du Sahara et de la colonie
mauritanienne en fonction de leurs intérêts économiques. L’indépendance
du Maroc, la guerre d’Ifni-Sahara et l’indépendance par la suite de la
République Islamique de Mauritanie achevèrent de figer ses frontières, qui
avaient été définies avant la Seconde Guerre Mondiale. Les grands perdants
furent les tribus nomades de l’espace saharien qui virent comment leur
espace, leur société et leur manière de vivre avaient été compartimentés et
réglementés en fonction de règles imposées par la “civilisation” européenne.
s
ue
Q
406 Cf. colonel Dives (1963), L’A.O.E. et les relations franco-espagnoles. CHEAM, doc.
3849. Et, teniente Cros (1962), Les relations franco-espagnoles au Sahara Occidental.
CHEAM, doc. 3651.
214
DALL’ARABIA ALL’AFRICA: DALL’IMPERO INFORMALE
ALL’OSSESSIONE PER IL CONTROLLO
Beatrice Nicolini
Beatrice Nicolini
Laureata in Scienze politiche all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano dove insegna Storia e istituzioni dell’Africa e ha aperto il
primo corso di lingua e cultura Swahili. Diplomata in Relazioni
internazionali e Diritto comparato all’Università di Harvard, USA, Dottore
di ricerca in Storia dell’Africa, Università di Siena, ha iniziato le sue
ricerche in Asia sud-occidentale per poi ampliarle all’Africa orientale.
Vincitrice del Premio della Society for Arabian Studies di Londra per il
volume Makran, Oman and Zanzibar (2004), si occupa di storia
dell’oceano Indiano e ha al suo attivo circa cento pubblicazioni, la
maggioranza su riviste internazionali.
st
o
ue
Q
Abstract
«… The Imaum of Muscat has extensive possessions in Africa …».407
John Croft Hawkins (1798-1851), Capitano dell’Indian Navy, il 21 giugno
1842 così iniziò i suoi Memoranda sulla situazione delle coste est africane
dell’Oceano Indiano. Tale rapporto era destinato all’amministrazione
anglo-indiana sia nei presidi dell’India (Bombay e Calcutta), sia a Londra.
E tra gli scopi vi fu la necessità da parte della Gran Bretagna di
identificare autorità e poteri che potessero consentire la stabilizzazione di
ciò che fu definito “l’impero informale”.408 Copiosa letteratura su queste
ampie, ancorché poco studiate, tematiche specifica la presenza di porti, di
isole e di interi litorali est-africani nelle mani di gruppi di potere arabi che
ne controllavano - o meglio, avrebbero dovuto controllare - anche i
movimenti e le migrazioni marittime. Questi movimenti riguardarono
principalmente i commerci e le migrazioni inclusero la tratta degli
schiavi.409 La regione del Golfo Persico/Arabico viene qui considerata
e
k
bo
o
a
ap
p
rti
e
ne
a\
n
G
iu
an
a
li
407 John Croft Hawkins, Memoranda, June 21st, 1842, The National Archives, Kew, Foreign
Office, 54/4, ff. 255-6.
408 “It’s an empire without legal bases, a de facto empire instead of a union of reigns under an
emperor”. J. Onley, Britain’s Informal Empire in the Gulf, 1820-1971, “Journal of Social
Affairs”, vol. 22, n. 87, 2005, pp. 29-45; J. Onley, The Arabian Frontier of the British Raj
Merchants, Rulers, and the British in the Nineteenth-Century Gulf, Oxford University Press,
Oxford, 2007.
409 B. Nicolini, L’Oceano Indiano occidentale. Scorci di storia, Polimetrica International
Publishers, Monza, 2009.
C
u
ac
c
ia
p
ot
i
0
LI
_2
C
215
to
s
ue
Q
nell’ambito più ampio di percorsi entro l’oceano Indiano con riferimento ai
ruoli svolti da differenti gruppi di potere. In tal senso, gli approcci storici e
storiografici che videro in passato una serie di nette e chiare attribuzioni di
potere e di apporti da parte di differenti gruppi etnico-socio-religiosi alle
‘immense ricchezze’ di tale ampio mare e ai ruoli svolti dai rispettivi
leader, vanno probabilmente ripensati alla luce di nuove ipotesi di lavoro e
di ricerca.
«… The Imaum of Muscat has extensive possessions in Africa …».
John Croft Hawkins (1798-1851), Captain of the Indian Navy, on 21st June
1842 opened his Memoranda on the situation of East African littorals in the
Indian Ocean. This report was destined both to the British-Indian
Administration of the Bombay and Calcutta Presidencies, and to London.
Between the aims of this document there was the necessity for Great Britian
to identify reliable authorities, political leaderships, and powers who could
consent the stabilization of what has been named the “Informal Empire”.
Abundance of literature about this topic, yet not much studied for this
region, identified a series of ports, littorals, and islands along East African
coasts, all of them in Arab hands; the Arabs groups were supposed to
exercise a control on the maritime and migration movements as well. These
movements did regard mainly trade, and migration included the slave trade.
The Persian/Arab Gulf region has been taken in consideration within its
Indian Ocean wider routes, with particular reference to the different roles
played by the many groups of power. Accordingly, the historic and
historiographical approaches that saw in the past relationships a sharp and
clear definition of powers, as well as the contributions to this large Sea
“immense riches” by different ethnic-social-religious entities, should
probabily be reread under new research hypothesis lights.
1. Questioni metodologiche
In un ampio spazio che abbiamo preferito denominare “nastro
culturale” come l’Oceano Indiano occidentale s’impongono alcune brevi
riflessioni.410 Le navigazioni furono molto più ampie di quanto si possa
410 B. Nicolini, The Myth of the Sultans in the Western Indian Ocean during the 19th century:
A New Hypothesis, Migrants and the Making of Indian Ocean Cultures, Indian Ocean: Cultures
in Contact, “African & Asian Studies”, vol. 8, Brill Academic Publishers, Leiden, 2009, pp.
239-287; B. Nicolini, The Indian Ocean: A Cultural Bow, in H. Alsudairy, E. Maestri, B.
Nicolini, Communication with the ‘Other’. Arab Dimensions, Cultural Mediation and Bows,
216
Que
sto
supporre: i porti dell’India occidentale furono connessi con il Golfo
Persico/Arabico, con la Penisola Arabica, con il Corno d’Africa e con i
litorali e le isole est-africane. Entro tale quadro, le identità arabe in Africa
orientale, pretese o reali, rappresentano uno dei temi cruciali per una
miglior comprensione degli avvicendamenti dei poteri lungo le coste
dell’Oceano Indiano tra la fine del diciottesimo e la prima metà del
diciannovesimo secolo. A questo riguardo si ritiene indispensabile non
seguire solamente i processi di dominazione. Le leadership arabo-omanite
furono progressivamente costruite in epoca contemporanea soprattutto dai
rappresentanti britannici nell’Oceano Indiano anche per consentire la
creazione d’autorità e di poteri politico-militari che probabilmente mai
esistettero, e non solo secondo le concezioni occidentali. Qui riteniamo ebbe
inizio la costruzione dell’impero informale, la nascita del potere della
dinastia degli Yarubi prima e dei Bu Sa’id poi dell’Oman nell’Oceano
Indiano.411 Il loro fu un potere anche militare, rafforzato da superiorità
tecnologiche e dal commercio delle armi. Nondimeno, non fu mai un
controllo, un reale dominio, un concreto possedimento.
Va precisato che quando si prendono in esame vaste regioni come
questa, le insidie sono numerose. Innanzitutto gli ‘sguardi’, e cioè le
prospettive e le scelte metodologiche: l’Oceano Indiano occidentale visto
dall’Europa, dall’Asia, dall’Arabia e dall’Africa modifica radicalmente le
tematiche affrontate e le relative conclusioni. Così come le scelte, obbligate
o meno, di privilegiare il mare, le prospettive marittime, o la terra, le terre, e
le relative problematiche terrestri possono alterare considerevolmente i
percorsi di ricerca. La regione del Golfo Persico/Arabico viene qui
considerata nell’ambito più ampio di percorsi entro l’Oceano Indiano con
riferimento ai ruoli svolti da differenti gruppi di potere. In tal senso, gli
approcci storici e storiografici che videro in passato una serie di nette e
chiare attribuzioni di potere e di apporti da parte di differenti gruppi etnicosocio-religiosi alle ‘immense ricchezze’ di tale ampio mare e ai ruoli svolti
dai rispettivi leader, vanno probabilmente ripensati alla luce di nuove
ipotesi di lavoro e di ricerca.
Nell’Oceano Indiano occidentale certamente un’antica globalità
ebbe luogo; nondimeno, siamo certi di una serie di entusiastiche e liriche
descrizioni di vitalità marittime popolate da diverse tipologie di persone,
ebo
ok a
ppa
rtie
ne
a\n
Crissma Working Papers, n. 19, Educatt, Milano, 2010, pp. 46-67.
411 B. Nicolini, Re-reading the role of Oman within its International Trade Relations from
16th to the 19th centuries, in S. Wippel (ed.), Conceptual Considerations on “Space” and
“Region” and Political, Economic and Social Dynamics of Region-Building in Oman, Springer
Science, Dordrecht, The Netherlands, 2013.
217
Giu
lia
idee, religioni, tutte coesistenti in una sorta di mondo pacifico, armonico, e
meravigliosamente fluido? E, soprattutto, quali armonie furono spezzate
dalla presenza europea?
Le prove di tali affermazioni si possono in parte ritrovare nei
rapporti archeologici, nei dati emersi dagli studi di cultura materiale, dalle
fortificazioni nello Yemen, e dalle similitudini antropologiche da cui
emerge un mondo ampissimo, ma non globalizzato. Le relazioni conflittuali
furono presenti nella maggioranza dei litorali e nelle isole coinvolte;
Campbell ha scritto della necessità di sviluppare approcci più ‘olistici’ allo
studio dell’Oceano Indiano nel suo complesso; nei suoi studi, egli ha
evidenziato come gli ‘eurocentristi’ e gli ‘asiacentristi’ abbiano contribuito
a visioni che percepirono gli africani come vittime sostanzialmente passive
di fronte a forze esterne (arabe, asiatiche ed europee), e come i contributi
economici africani all’economia globale si siano limitati essenzialmente a
forza lavoro servile e non specializzata condotta verso i centri principali di
produzione nel mondo dell’Oceano Indiano.412 I legami inter e intraregionali dovrebbero venire pienamente riconosciuti ed estrapolati nei
movimenti e negli scambi di persone, idee, tecnologie e prodotti.
Coerentemente, Potter ha rammentato che ampia parte della storia
dell’oceano Indiano – e per estensione del Golfo Persico/Arabico – sin dal
primo periodo moderno, è stata trattata dalla prospettiva delle intrusioni e
dalle dominazioni da parte di poteri esterni: i portoghesi durante il
sedicesimo secolo, gli olandesi nel diciassettesimo, e gli inglesi a partire dal
diciottesimo. Le grandi compagnie commerciali che operarono nella
regione, la Compagnia delle Indie Orientali britannica (fondata nel 1600),
l’olandese Verenigde Oostindische Compagnie (fondata nel 1602), e la
francese Compagnie Française des Indes (fondata nel 1664), lasciarono
voluminose documentazioni che sono state ampiamente indagate da storici e
da studiosi.413 Questi materiali, a fronte delle documentazioni provenienti
dal Golfo Persico/Arabico e dall’oceano Indiano, hanno frequentemente
trasmesso immagini di una regione dedicata a commerci marittimi e alle
resistenze o alle collaborazioni con personaggi stranieri. Queste inevitabili
esigenze ci conducono ad una successiva riflessione metodologica: le
relazioni tra il mare e la terra; è onesto ammettere che una grande
maggioranza di recenti contributi accademici si è concentrata sul mare, sui
viaggi e sulle navigazioni marittime, sulle coste, sulle genti marittime, e sui
412 G. Campbell, “The Indian Ocean World: Africa in the first global economy”,
Transforming Culture e-journal 3/2 epress.lib.uts.edu.au/journals/TfC, 2008.
413 L. Potter (ed.), The Persian Gulf in History, Macmillan Palgrave, New York, 2009, pp. 124.
218
Que
sto
commerci sfociando inevitabilmente in ciò che ho osato denominare una
“ubriacatura d’acqua”.414 A questo riguardo, mi trovo piuttosto d’accordo
con Walsh;415 egli affermò che recenti indagini sulla storia della civiltà
Swahili hanno enfatizzato gli orientamenti commerciali e marittimi delle
economie locali e regionali ma hanno dedicato poca attenzione alle attività
di sussistenza con basi sul territorio, incluse le attività agricole e gli
sfruttamenti della flora e della fauna terrestri. Guardando per un momento a
questa parte della storiografia sull’oceano Indiano, risulta naturale ripensare
a Villiers che può essere considerato un pioniere nell’attirare l’attenzione
dalla terra agli imperi costruiti sul mare nel Golfo Persico/Arabico e
nell’oceano Indiano.416 Certamente, ciò che ho denominato ‘ubriacatura
d’acqua’ lo seguì per lungo tempo. E uno dei risultati ha prodotto analisi
dell’oceano Indiano concentrate – ancora oggi – principalmente sul mare.
Le conseguenze di tali interpretazioni potrebbero venir travisate: osservare e
studiare il Golfo Persico/Arabico, l’Asia sud-occidentale, la Penisola
arabica, e l’Africa orientale dal mare, sul mare e verso il mare può lasciare
inevitabilmente le tematiche terrestri, in alcuni casi, nell’ombra. Ora, una
volta ‘approdati’ sulla costa Swahili, è interessante introdurre le concezioni
di ‘appartenenza’ e di ‘uguaglianza’, poiché tali paradigmi appartengono
ancora alle obsolete ambizioni di ‘contenere’ e ‘classificare’ soprattutto ciò
che non si conosce.
Ciò conduce alla complessa questione delle fonti. Per quanto
riguarda l’Africa orientale, esistono documentazioni persiane e arabe per i
periodi più antichi, le cronache arabo-swahili, notoriamente di
decodificazione ostica e, in alcuni casi, svianti, e una vasta documentazione
europea a partire dalla fine del quindicesimo secolo. A queste si aggiungono
le tradizioni orali che vanno adoperate con estrema cautela e grande
discernimento. La verità, è onesto ammetterlo, è che per l’Africa tutte le
fonti si sono rivelate, e sono, sostanzialmente inadeguate. Vi è naturalmente
un’eccezione: l’archeologia. Ove si sono felicemente integrati gli studi e le
scoperte archeologiche, straordinarie analisi e conclusioni hanno dischiuso
mondi impensabili per gli approcci eurocentristi e per le generazioni di
storici che mai avrebbero immaginato negli africani tante e tali capacità e
grandiosità.417 Si deve proprio all’archeologia il superamento del ‘mito’
della separazione tra la costa e l’interno del continente est-africano, così
414 B. Nicolini, L’Oceano Indiano occidentale. Scorci di Storia, op. cit.
415 M. Walsh, Island Subsistence: Hunting and the Exploitation of Wildlife in the Zanzibar
Archipelago, presentata nel 2006 a Zanzibar.
416 A. Villiers, Sons of Sindbad, Arabian Publishing, London, 2007.
417 C.M. Kusimba, The Rise and Fall of Swahili States, Altamira Press, Walnut Creek, 1999.
219
Q
u
e
sto
Q
come il superamento delle concezioni che attribuirono gli impulsi, gli
sviluppi e le innovazioni come solamente provenienti dall’esterno, è cioè
sempre e solo dal mare. Fino a considerare la costa Swahili e le sue isole
come scarsamente africanizzate o persino ‘non africane’. Sempre seguendo
questi processi, non si può ignorare l’elemento importante rappresentato
dalla ‘mitezza’ della tratta degli schiavi ‘orientale’.418 Siamo tutti convinti
della rilevanza della flessibilità entro il concetto di schiavitù, e della
necessità di procedere a riletture di quel mito costituito dalla schiavitù
‘orientale’ non violenta, e composta da schiavi domestici leali, concubine,
eunuchi, comparata alla violenza brutale, unita alle grandi quantità di
schiavi, della tratta atlantica. Certamente la storia dell’oceano Indiano non
è, e non è solamente, una storia di schiavitù.419 E la presenza della schiavitù
e di società schiavistiche in Africa orientale non può e non deve giustificare
la riduzione, quand’anche la mortificazione, delle prospettive. Palaver, tra i
pochi studiosi italiani, per quanto mi è dato di sapere, ha descritto le
particolarità e le implicazioni dei percorsi carovanieri dalle coste verso
l’interno nella regione dei Grandi Laghi, dove i Nyamwezi svolsero un
ruolo significativo e dove i commerci assistettero ad un’influenza anche
africana dei percorsi globali a lunga distanza, modificando, a tratti, le
strutture economico-socio-ambientali di tali ampie aree420.
Una successiva riflessione riguarda invece il ‘mito’ dei sultani
dell’Oman. L’identità araba in Africa orientale, pretesa o reale, rappresenta
uno dei temi cruciali per una miglior comprensione della successione dei
poteri lungo le coste dell’oceano Indiano durante i secoli diciottesimo e
diciannovesimo. Le leadership arabo-omanite, come anticipato, furono
progressivamente ricostruite soprattutto dalle autorità britanniche in queste
regioni per consentire la creazione di autorità, e di poteri politico-militari
che probabilmente, come già accennato, mai esistettero secondo le
concezioni occidentali.
eb
o
ok
ap
p
e
tr ie
n
a
418 O. Pétré Grennouillau, Les traites négrières. Essai d’histoire globale, Bibliotheque des
Histoires, Gallimard, Paris, 2004.
419 S. Bose, A Hundred Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global Empire, Harvard
University Press, Cambridge, 2006; S. Bose, “Blackbirders Refitted: Towards a Connective
Oceanic History of Slavery and Resistance”, relazione: The International Conference: The
Indian Ocean and Arab Slave Trades: Global Connections and Disconnections, G. Lehrman
Center - Yale University, 2008.
420 K. Palaver, Lungo le piste d’Africa. Commerci locali e strategie imperiali in Tanzania
(secoli XIX-XX), Carocci, Roma, 2008; K. Palaver, Un’altra Zanzibar. Schiavitù, colonialismo
e urbanizzazione a Tabora (1840-1916), F. Angeli, Storia Urbana, Milano, 2011.
n
a\
220
ar
o
eb
ok
p
ap
to
2. “The Island of Zanzebar is very productive”
Q
s
ue
Così il Capitano John Croft Hawkins descrisse l’isola estafricana.421 Presso le coste dell'Africa equatoriale, separata dal continente
per un canale largo appena cinquanta chilometri, si trova l'isola di Zanzibar
(in kiswahili Unguja). Essa è la più grande isola corallina della costa
orientale dell’Africa e forma parte di una scogliera corallina che si estende
dalla vicina isola di Pemba (la verde, o isola di smeraldo), a nord, fino
all’isola di Mafia a sud, costituendo una sorta di costa estranea al
continente.
Zanzibar è posizionata al 6° grado di latitudine sud ed a 39° gradi
di longitudine est, è larga 20-30 chilometri e lunga circa 85; la città, dal
nome omonimo, è situata nel lato occidentale dell’isola, e il suo porto, uno
dei migliori dell’Africa orientale, consente un profondo ancoraggio per
l’attracco di navi. Zanzibar rappresentò sempre l'unica isola di preminenza
strategica grazie a due variabili di fondamentale importanza: i monsoni e la
sua prossimità al continente. La ricorrenza regolare dei monsoni consentì i
contatti continui con l’India, il Mar Rosso e il Golfo Persico/Arabico; la
vicinanza dalla costa rappresentò una posizione strategica ideale per i
commerci tra l’interno del continente africano e l’oceano Indiano.
Nonostante l’estrema eterogeneità della popolazione di Zanzibar (una
società polietnica), le aree sudorientali dell’isola sono principalmente
abitate da genti di lingua bantu, conosciute come hadimu (in Kiswahili pl.
wahadimu), mentre a nord vivono i tumbatu (pl. watumbatu); l’isola di
Pemba invece è abitata dal gruppo omonimo wapemba. Questi tre gruppi
sono musulmani sunniti della scuola shafita, anche se fortemente
caratterizzati da riti africani tradizionali. Sia i wahadimu sia i watumbatu
praticano l’endogamia, sono dediti alla pesca, all’agricoltura e
all’allevamento, le donne wahadimu gestiscono interamente la
fabbricazione di funi ricavate dai filamenti del cocco nei villaggi
meridionali dell’isola. Fino al 1800, i villaggi wahadimu furono sottoposti
all’autorità del Mwenye Mkuu, il capo. Nondimeno, durante i primi decenni
del diciannovesimo secolo i wahadimu e i watumbatu vennero espropriati
dagli arabi dell’Oman dalle zone occidentali più fertili dell’isola.422
421 John Croft Hawkins, Memoranda, June 21st, 1842, Foreign Office, 54/4, f. 225.
422 Molti wahadimu e watumbatu hanno privilegiato come loro autoreferenzialità una origine
Shirazi; tale autoidentificazione li sottrasse a etichette deteriori, dovute alle persecuzioni
politiche negli anni Sessanta del ventesimo secolo. Viceversa, il grande mantello della comune
etnicità Shirazi consentì loro di rifarsi ai gloriosi fasti di una nobile e antica origine. Intervista
concessa da A. Sheriff, Zanzibar, 19/8/1994. A. Sheriff & C. Tominaga, The Ambiguity of
Shirazi Ethnicity in the History & Politics of Zanzibar, “Christianity and Culture”, n. 24,
221
All’inizio del 1800 i legami tra la costa orientale africana e il mare
consentirono numerosi contatti commerciali. Il periodo che va dal 1805 al
1820 è pertanto considerato come cruciale per la storia dell'Africa orientale:
in questo senso, emblematica fu certo l’ascesa dell’egemonia della tribù
omanita dei Al Bu Sa’id, ibaditi, a Zanzibar. Durante il diciannovesimo
secolo si ritiene che l’isola di Zanzibar rappresentasse uno dei quattro
terminali del potere mercantile arabo-omanita dei Al Bu Sa’id insieme con
il porto di Muscat in Oman, i porti della fascia costiera asiatica del
Baluchistan, il Makran, i centri mercantili delle coste dell’India occidentale
e i litorali dell’Africa orientale. A ciò conseguì che vi fossero rapporti di
potere tra i baluch del Makran, gli arabi dell’Oman, le comunità mercantili
dell’India occidentale e gli swahili di Zanzibar, dove gli omaniti furono i
leader politici, i baluch la forza militare, gli indiani i finanziatori, banchieri
ed esattori, e gli swahili schiavi. Nulla di più inesatto e obsoleto.
Durante tutto il 1800 l’irresistibile fascino degli spazi vuoti - blank
spaces - sui planisferi, sempre accompagnato da un’apologia del
meraviglioso come riconoscimento della diversità attirò l’attenzione di
viaggiatori, avventurieri, mercanti, studiosi, letterati ed eccentrici funzionari
occidentali. Attraverso le loro testimonianze appare un approccio molto
diverso nei confronti dell’Oriente in generale e dell’Africa sud-orientale in
particolare, soprattutto per quanto riguarda l’ambito culturale inglese e
quello francese.
A tale riguardo, la Francia, figlia dell’Illuminismo e del
Positivismo, spaziò verso queste terre “esotiche” attratta dal fascino del
curioso e del magico. Per l’Inghilterra, invece, il magico significò
soprattutto commercio e commercio voleva dire precisa conoscenza della
geomorfologia, dei pesi, delle misure, delle monete e degli usi e costumi
locali. Non a caso l’imperialismo e le sue recenti teorizzazioni423 implicano
una ridefinizione anche di queste regioni ‘sospese’ tra Asia e Africa.
bo
oe
est
Qu
Sendai, 1990.
423 A.G. Hopkins, P.J. Cain, British Imperialism: Innovation and expansion, 1688-1914,
Longman, London, 1993; E. Said, Culture and Imperialism, Vintage Books, New York, 1993;
M. Mamdani, Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of late Colonialism,
Princeton University Press, Princeton, 1996; V.G. Kiernan, Colonial Empires and Armies
1815-1960, McGill-Queens University Press, Montreal and Kingston, 1998; S.J. Rockel, R.
Halpern (eds.), Inventing ‘Collateral Damage’: Civilian Casualties, War and Empire,
Between-the-Lines Press, Toronto, 2009; A.G. Hargreaves (ed.) Memory, Empire, and
Postcolonialism: Legacies of French Colonialism, Lexington Books, Lanham, 2005; P.M.E.
Lorcin (ed.), Algeria and France 1800-2000: Identity, Memory, Nostalgia, Syracuse University
Press, Syracuse, 2006; P. Palumbo (ed.) A Place in the Sun: Africa in Italian Colonial Culture
from Post-Unification to the Present, University of California Press, Berkeley, 2003; C. Elkins,
Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain?s Gulag in Kenya, Henry Holt and Company,
222
ok
ap
r
ppa
ok a
ebo
Que
sto
La documentazione d’archivio ivi acclusa tenta di approfondire un
aspetto meno studiato di questo periodo storico, ossia la figura ed il ruolo
effettivamente svolto da Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id (r. 1806-1856).
Le precondizioni attraverso le quali il potere di alcuni tra i protagonisti del
mondo mercantile dell’oceano Indiano si realizzò furono rappresentate,
come accennato, da una molteplicità di elementi.
Fino al diciannovesimo secolo la navigazione su dhows,424 su
imbarcazioni leggere dalla vela triangolare, in novembre dall’Asia e
dall’Arabia in direzione sud, sud-ovest, durava trenta, quaranta giorni, in
condizioni atmosferiche ottimali; mentre in dicembre, grazie alla
stabilizzazione del monsone,425 il viaggio durava solamente venti,
venticinque giorni. Tale modello di navigazione venne inoltre rafforzato
dalle correnti equatoriali che soffiano verso sud, facilitando ulteriormente il
percorso da nord. Tra marzo e aprile il monsone di nord-est lascia il posto ai
venti del monsone di sud-ovest e la corrente equatoriale colpisce la costa
africana all'altezza di Cabo Delgado (al confine con il Mozambico). Qui i
venti soffiano verso nord, la navigazione da sud verso l’Asia è oltremodo
facile e sicura. La primavera426 è dunque la stagione migliore per partire via
mare dall’isola di Zanzibar. Da metà maggio a metà agosto le tempeste sono
invece frequenti e inibiscono i percorsi marittimi nell’oceano Indiano.427
Tale regolare alternanza di correnti e di venti monsonici condusse
facilmente verso l’Africa viaggiatori, avventurieri, mercanti ed esploratori.
La ricorrenza regolare dei monsoni consentì collegamenti costanti con
l’India, il Mar Rosso ed il Golfo Persico/Arabico, mentre la vicinanza dalla
New York, 2005; J. Guy, The View across the River: Harriette Colenso and the Zulu Struggle
Against Imperialism, University Press of Virginia, Charlottesville, 2002; A. Hochschild, King
Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa, Mariner Books,
New York, 1999; A. Isaacman, R. Roberts (eds.), Cotton, Colonialism, and Social History in
Sub-Saharan Africa, 1995; T. Falola, Colonialism and Violence in Nigeria, Indiana University
Press, Bloomington, 2009; L. de. Witte, The Assassination of Lumumba, Verso Books,
London, 2001; J.E. Davis, Constructive Engagement? Chester Crocker & American Policy in
South Africa, Namibia & Angola, 1981-8, J. Currey, Oxford, 2007.
424 Si rammenta che daw è una parola kiswahili non usata dagli arabi e storpiata dagli inglesi
in dhow. G.F. Hourani, Arab Seafaring, Princeton University Press, Princeton, 1951, nuova.
ed., 1995, p. 89; D. Agius, Seafaring in the Arabian Gulf and Oman: People of the Dhow
Kegan Paul Ltd, London, 2005, paperback, Routledge, London, 2009; D. Agius, Classic Ships
of Islam: From Mesopotamia to the Indian Ocean, E.J. Brill, Leiden, 2008.
425 Il termine ha origine dall’arabo mawsin (pl. mawasin), stagione, da cui il portoghese
monçao.
426 Le stagioni in realtà non sono suddivise come in Europa ma dipendono dalle correnti
marittime.
427 A. Sheriff, Slaves, Spices & Ivory in Zanzibar. Integration of an East African Commercial
Empire into the World Economy, 1770-1873, J. Currey, London, 1987, p. 8 e sgg.
223
e
ien
a
rt
a
pp
a
k
o
o
eb
costa rappresentò una posizione strategica ideale per i commerci tra
l’interno dell’Africa e l’oceano Indiano. Fino al 1820 i monsoni costrinsero
le grandi navi mercantili britanniche a salpare dall’Europa verso l’India, e
viceversa, sempre e solo durante la stagione invernale, fino all’inizio della
primavera; ne consegue che almeno sei mesi costituivano il tempo minimo
necessario di pausa tra un viaggio e l’altro. Le lettere e i dispacci dell’East
India Company dovevano quindi partire sempre alla fine di agosto, o
all’inizio di settembre come data ultima, per giungere in India prima che si
rompesse il monsone. L’accrescimento dei contatti commerciali e politicodiplomatici francesi con le coste dell’oceano Indiano occidentale, proprio in
quelle basi strategiche fondamentali per le rotte marittime britanniche,
condusse a un prolungamento dei tempi di comunicazione, con danni
commerciali incalcolabili e pesanti ripercussioni a livello politico regionale
e centrale; ciò implicò che i tempi dei monsoni impedissero per lunghi mesi
la conoscenza degli eventi, quindi la possibilità di impartire le direttive da
parte delle autorità politiche, amministrative e commerciali centrali entro
tempi brevi; di conseguenza, si verificò inevitabilmente che i rappresentanti
in loco delle due Potenze avrebbero spesso costretto Londra e Parigi a
prendere atto di situazioni già decise.
L’Europa modificò le vie principali dei grandi traffici sulla base di
nuove esigenze mercantili; ma non distrusse completamente gli assetti
locali, e soprattutto, non riuscì a modificare le leggi naturali che regolavano
la navigazione secondo l’alternarsi dei monsoni, poiché, fino
all’introduzione delle navi a vapore, restò in vigore una sorta di
competizione ad armi pari. Con l’ascesa della dinastia omanita degli Al Bu
Sa’id alla fine del diciottesimo secolo, emerse come l’oceano Indiano
occidentale costituisse una sintesi culturale attraversata da incessanti flussi
migratori; tali flussi diedero vita a quella civiltà composita e cosmopolitica
che durante il diciannovesimo secolo assistette alle scelte strategiche
britanniche di attribuire agli arabi dell’Oman - sempre secondo la
concezione dell’impero informale - il ruolo di trait d’union politicocommerciale. La presenza di numerose opportunità economico-commerciali
lungo la costa orientale dell’Africa costituì un catalizzatore che fece di
Zanzibar la nuova residenza degli Al Bu Sa’id. Non a caso, copiosa
letteratura sull’argomento testimonia che Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu
Sa’id creò nell’oceano Indiano occidentale un grandioso e potente impero
mercantile.428 I principali fattori dell’ascesa di tale rete commerciale
to
s
ue
Q
428 Fra le numerose biografie su Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id si rimanda a J.G.
Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia, Calcutta, 1915, 2 voll., in
particolare vol. 1, pp. 440-469; R.S. Ruete, Said Bin Sultan (1791-1856). Ruler of Oman and
224
Questo
ebook a
ppartien
marittima furono rappresentati dall’espansione del commercio delle spezie,
soprattutto delle coltivazioni di chiodi di garofano nelle isole di Zanzibar e
di Pemba, dalla tratta degli schiavi, dalla crescente esportazione di avorio
dall’Africa verso l’India occidentale429 e verso l’Europa e dalle loro
implicazioni internazionali con le Potenze europee dell’epoca.
3. “The Imaum of Muscat”
Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id parlava molte lingue, oltre
all’arabo, hindi, persiano e swahili; aveva visitato l’isola di Zanzibar per la
prima volta nel 1802 quando aveva undici anni e ne era rimasto stregato.
Egli costituì un esempio importante della rivalutazione del commercio di
spezie come mezzo di affermazione di un’élite dal forte potere tramite
l’espansione delle coltivazioni di chiodi di garofano a Zanzibar, attuata su
sua iniziativa. La creazione di una nuova nicchia di sfruttamento agricolo
proprio a Zanzibar e a Pemba fu destinata a trasformare queste due isole in
un impero commerciale. Alla fine del diciottesimo secolo l’introduzione dei
chiodi di garofano (Eugenya caryophyllata, della famiglia delle Mirtacee)430
Zanzibar. His Place in the History of Arabia and East Africa, London, 1929; R.S. Ruete, The
Al Bu Said Dynasty in Arabia and East Africa, “Journal of the Royal Asiatic and Central Asian
Society”, vol. 16, A. Ouseley, London, 1929, pp. 417-432; S.A.S. Farsi, Seyyid Said Bin
Sultan. The Joint Ruler of Oman and Zanzibar (1804-1856), Lancers Books, New Delhi, 1986;
V. Maurizi, History of Seyd Said, Sultan of Muscat, I° ed. London, 1819, nuova ed. Cambridge,
1984.
429 L’avorio delle zanne degli elefanti asiatici, dalle striature rossastre, duro e non adatto alla
fabbricazione di oggetti pregiati, poiché il processo d’ingiallimento è immediato, è sempre
stato di qualità inferiore a quello africano. La richiesta di avorio dall’Africa fu sempre molto
alta in India perché le donne induiste indossavano braccialetti dal polso fino al gomito e
cavigliere in occasione delle nozze; i bracciali erano bruciati alla loro morte, e, in seguito
all’abolizione del Sati (la morte della vedova arsa viva sulla pira con il marito), spezzati in
segno di lutto. La pratica del sati fu ufficialmente proibita il 4 dicembre 1829 da Lord William
Bentick (1774-1839), allora Governatore dell’India britannica, che decise di punire e reprimere
l’atto come qualsiasi altro delitto A. Sheriff, The Rise of a Commercial Empire: An Aspect of
the Economic History of Zanzibar 1770-1873, unpublished Ph.D. Thesis, University of
London, 1971, pp. 118-120.
430 Fin dal III secolo a.C. gli inviati di Java alla corte Han della Cina tenevano in bocca i
chiodi di garofano per profumare l’alito durante le udienze davanti all'imperatore. Le piante di
chiodi di garofano, originarie delle isole Molucche, furono inizialmente sfruttate dagli olandesi,
i quali avevano compreso il notevole valore commerciale di tale profumatissima e preziosa
spezia, dalle proprietà anche medicamentose. Intorno al 1770, il mercante francese Pierre
Poivre riuscì a venire in possesso di alcuni semi per l’attuazione di un progetto di sviluppo
agricolo francese nelle isole Mascarene; nei primi anni del 1800, i chiodi di garofano vennero
quindi introdotti a Zanzibar dai francesi. I primi esperimenti diedero esiti positivi, l’ambiente
era perfettamente adatto alla coltivazione destinata a fare di Zanzibar il maggior esportatore
mondiale di chiodi di garofano. L’isola era infatti divisa in due aree ecologiche: la parte
225
e
ti
pu
o
ia
ian
a
ac
c
C
ul
nelle due isole tropicali determinò una nuova percezione delle potenzialità
economico-commerciali, si noti, non per gli occhi degli europei, bensì per
quelli degli Al Bu Sa’id.
Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id decise di impegnare le sue
sostanze e le sue energie in tale progetto agricolo; certo erano indispensabili
coraggio e fiducia, poiché le piante impiegano dai sette agli otto anni per
produrre i primi fiori e i raccolti si presentano ad una distanza di almeno
dieci anni dalla prima messa a dimora delle piante; poiché le gemme devono
venire staccate prima della fioritura, i raccolti avvengono in tre periodi
intervallati, tra agosto e dicembre, e richiedono una manodopera attenta e
numerosa, a causa dell'irregolarità della gemmazione, oltre alla necessità di
una costante sarchiatura per il mantenimento delle piante.431 Va inoltre
considerato che la coltivazione dei chiodi di garofano era simile a quella dei
datteri in Arabia, perfettamente conosciuta dagli arabi,432 i quali
procedettero all'acquisizione di terre a Zanzibar a spese degli Swahili sia
tramite relazioni matrimoniali - sull’isola vi furono numerosi matrimoni tra
omaniti e donne wahadimu, funzionali all’acquisizione di diritti sui terreni
più fertili - sia per esproprio.433 L’esproprio legalizzato da parte degli
omaniti e una dubbia interpretazione dell’istituto giuridico dell'usufrutto
condussero all'appropriazione delle terre Swahili, appunto, per confisca.
Nel 1835, Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id possedeva fino a
quarantacinque mashamba a Zanzibar. La “mania dei chiodi di garofano”,
con profitti altissimi sul costo originario, diede vita a una sorta di
aristocrazia terriera araba finanziata dalle comunità mercantili indiane. Così
gli arabi si sostituirono gradualmente all’antica aristocrazia terriera di
origine Swahili. Non si produsse tuttavia una frattura grazie all’abilità dei
mercanti indiani, i quali progressivamente recuperarono le élites locali
delegando loro determinati compiti ed uffici, e quindi coinvolgendole nel
grande “business” dell’oceano Indiano.
\
n
G
i
n
e
a
tie
pa
r
p
ok
a
o
Q
ue
s
226
t
o
e
b
occidentale più collinosa era una fitta foresta fino a quando, tra il 1700 e il 1800, venne
disboscata dagli schiavi per la piantagioni di chiodi di garofano, mentre il resto era paludoso e
non adatto alle coltivazioni.
431 La coltivazione dei chiodi di garofano nell’isola di Pemba ebbe minor fortuna che a
Zanzibar, a causa di un ciclone che distrusse gran parte delle piante intorno ai primi decenni
del 1800. N.R. Bennett, A History of the Arab State of Zanzibar, “Studies in East African
History”, London, 1987, pp. 28-29.
432 A. Ubaydli, Democracy in the Islamic World: the Agrarian Economy as a Base for Early
Democratic Tendencies in Oman, intervento tenuto in occasione del Convegno B.R.I.S.M.E.S.,
University of St. Andrews, 8-10/8/1992.
433 A. Sheriff, The Rise of a Commercial Empire, op. cit., p. 175; N.R. Bennett, A History of
the Arab State of Zanzibar, “Studies in East African History”, London, 1987, pp. 24-25.
Lungo il litorale africano viceversa, non mancarono profonde
lacerazioni e modificazioni all’interno della società, a causa
dell’immissione massiccia di schiavi dall'interno e all’ulteriore afflusso di
elementi arabi ed asiatici (Tabora - città chiave dell'itinerario commerciale
nell'interno - divenne praticamente una città araba). Si definirono identità
culturali profondamente diverse fra realtà insulare e continentale, dove, a
partire dagli anni Trenta dell’Ottocento, l’apertura delle vie carovaniere
produsse una vera e propria rivoluzione economica e sociale. Il successo
agricolo sovvertì rapidamente l’ordine tradizionale e le piantagioni, insieme
con gli schiavi per coltivarle, si diffusero con l’espansione delle coltivazioni
dei chiodi di garofano. Col crescere delle piantagioni la domanda di schiavi
si fece sempre più intensa. Nel 1811 su 15.000 schiavi giunti a Zanzibar,
7000 furono destinati alle mashamba.434 Nel 1822 le piante raggiunsero
un’altezza di circa quattro metri e mezzo.435 Inoltre, a causa della
progressiva messa in atto dei provvedimenti imposti dalla Gran Bretagna
per l’abolizione della tratta, il prezzo medio di uno schiavo lungo il litorale
est-africano era sceso intorno ai 20 dollari di Maria Teresa,436 la metà
rispetto agli anni precedenti. L’espansione delle coltivazioni di chiodi di
garofano provocò così un afflusso annuo di schiavi che da 6000 nella prima
decade dell’Ottocento giunse a fino a 20.000 nella seconda metà del
diciannovesimo secolo. E fu proprio la coltivazione di chiodi di garofano
che si rivelò vitale per l’espansione dell’economia zanzibarita. Infatti, i
ricavi per gli Al Bu Sa’id incrementarono con una rapidità straordinaria: da
4.600 dollari di Maria Teresa nel 1834, a 25.000 dollari nel 1840.437
La Gran Bretagna vide con estremo favore la coltivazione e
l’esportazione di prodotti agricoli tropicali in quanto potevano rappresentare
una valida alternativa economica per i capi orientali al commercio di
schiavi. Tuttavia, la crescente diffusione di chiodi di garofano a Zanzibar
implicò anche un forte aumento di richiesta di manodopera a costo zero
(l’alta mortalità nelle mashamba costringeva al rinnovo quasi totale della
manodopera impiegata ogni quattro anni) che produsse, come anticipato,
profonde lacerazioni e modificazioni all'interno della società est-africana.
La confisca delle terre più fertili di proprietà degli Swahili, l’immissione
book
sto e
Que
434 M.R. Bhacker, Trade and Empire in Muscat and Zanzibar: Roots of British Domination,
London, 1992, p. 128.
435 C.S. Nicholls, The Swahili coast: politics, diplomacy and trade on the East African
littoral, 1798–1856, St. Antony's College, Oxford. Publications, no. 2., George Allen and
Unwin, London, 1971, p. 82.
436 C. Semple: A Silver Legend: The Story of the Maria Theresa Thaler, Barzan Press,
London, 2004,
437 Ibidem, p. 127.
227
ap
t
r
pa
ok
ap
o
to
eb
s
ue
massiccia di schiavi e la scarsità numerica dei gruppi etnico-tribali degli
wahadimu e dei watumbatu sull'isola, relegò quest'ultimi ai margini della
società; nondimeno, l’afflusso di arabi e di asiatici, attirati dal nuovo e
lucroso mercato (nel 1819 vi erano duecentoquattordici indiani residenti a
Zanzibar), esasperò sempre più la situazione da un punto di vista britannico.
La figura di Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id fu descritta nei
Memoranda come “signore dei mari” con suo centro l’isola di Zanzibar.
Restava un grosso e intricato nodo da sciogliere per il governo britannico:
come sarebbe stato possibile combattere per l’abolizione della tratta degli
schiavi e, al tempo stesso, allearsi con uno dei più noti e potenti protettori di
trafficanti di schiavi, il quale a sua volta traeva proprio da questo
commercio la più laute entrate del suo impero economico?
Fu questo il punto cruciale attorno a cui ruotarono le relazioni fra
Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id, l’East India Company e Londra, dopo
che la Francia aveva perso le sue basi strategico-commerciali (Île de
France/Mauritius e Bourbon) nell’oceano Indiano nel 1810.438 Fu un nodo
che animò vivaci dibattiti anche politici all'interno delle varie forze e
componenti britanniche. Come emerge dai Memoranda, i funzionari
britannici consideravano il capo omanita una delle chiavi strategiche
fondamentali entro il loro sistema di estensione dell’influenza e del
controllo politico e commerciale nell’oceano Indiano, che era nato dalle
guerre napoleoniche come architettura difensiva contro la minaccia
francese. Nondimeno, desideriamo qui ribadire che il tipo di controllo che i
capi omaniti esercitarono su ciò che le esigenze geostrategiche europee
avevano definite come i loro domini, fu decisamente aleatorio e patriarcale.
Per quanto riguarda i militari, gli arabi dell’Oman sempre reclutarono
soldati dall’Asia centro-meridionale, e, a partire dal 1784, dall’énclave
omanita di Gwadar. 439
Il secondo - non certo per potere ed importanza agli occhi della
dinastia omanita - gruppo era rappresentato dalle comunità mercantili
indiane. Esse erano composte soprattutto da Bhattia induisti dalla penisola
del Cutch, Bohra sunniti da Surat e Khoja ismailiti da Hyderabad.
L’importante ruolo economico-commerciale rivestito dagli indiani chiamati
Q
438B. Nicolini, The Fist Sultan of Zanzibar. Scrambling for Power andTrade in the Nineteenth
Century Indian Ocean, M. Wiener, Princeton, 2012.
439 Da tempi immemorabili furono in vigore stretti contatti tra l’Oman e le popolazioni baluch
della fascia costiera del Makran. Intorno alla fine del diciottesimo secolo Nasir khan I (17491817), dei brahui di Kalat concesse il porto di Gwadar a Sultan bin Ahmad Al Bu Sa’id (17921804) - padre di Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id - il quale fuggì da Muscat intorno al 1784
a causa di lotte dinastiche in corso in Oman; B. Nicolini, Maritime Indian Ocean Routes: the
port of Gwadar/Gwātar, “Quaderni Asiatici”, Milano, 2013, in corso di stampa.
228
dagli inglesi banyan (da vanijah - commercianti) in Africa orientale fu
legato al periodo della preminenza politica e commerciale dei portoghesi,
poiché quest’ultimi non vollero lasciare i commerci nelle mani dei
musulmani. Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id s’inserì entro tale fluido
meccanismo basato su un ampio raggio di collegamenti, godendo delle
funzioni mediatrici e dei prestiti delle varie comunità indiane presenti a
Zanzibar e introdotte nella realtà Swahili. Si trattò dunque di motivazioni
religiose, oltre a cause economiche e commerciali. L’emergere di una élite
sì legata al potere politico, ma anche in contatto con le popolazioni
autoctone, fu all’origine dello splendore commerciale del Sultano omanita.
Grazie a una relazione quasi simbiotica tra la famiglia ismailita dei Topan
provenienti dalla penisola indiana del Cutch e gli Al Bu Sa’id, i commerci
fruttarono discreti proventi sia a Muscat sia a Zanzibar, dove la prosperità
commerciale raggiunse il suo apice intorno al decennio 1870-80.
Il ruolo svolto dalle Potenze europee, e in particolare dai trattati
firmati rispettivamente nel 1822, 1845 e nel 1873 tra l’Oman e la Gran
Bretagna a scopo strategico e commerciale per l’abolizione della schiavitù,
fu cruciale per lo sviluppo delle reti commerciali marittime nell’oceano
Indiano. Esso condizionò fortemente il passaggio, certamente graduale e
non privo di forti resistenze, degli Al Bu Sa’id dalla tratta degli schiavi alla
coltivazione dei chiodi di garofano, la principale risorsa economica
dell’isola di Zanzibar, e di spezie lungo la costa dell’Africa orientale. Il
risultato di tale graduale trasferimento d’interessi fu che Saiyid Sa’id bin
Sultan Al Bu Sa’id pose la sua residenza a Zanzibar intorno al 1833 senza
certo abbandonare i suoi interessi in Arabia.
Riguardo alla tratta degli schiavi, il consolidamento del potere
inglese a Zanzibar, favorito dalla presenza di Atkins Hamerton, console
britannico e Political Agent del Governo di Bombay, a partire dal 1841,
operò tenacemente in funzione dell'abolizione della tratta.440 Ciò
nondimeno, i trattati che si susseguirono durante il 1800 tra la Gran
Bretagna e Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id per l’abolizione del
commercio degli schiavi, e, al tempo stesso, volti a conservare la preziosa
alleanza di Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id, ebbero scarsissimi effetti
sulla tratta, alla sua massima espansione nel biennio 1845-7.
Questo
ebook ap
partiene
a\nGiuli
Due fattori principali si scontrarono durante il diciannovesimo
secolo: da un lato la costante ricerca delle forze insite nella politica
440 Durante la seconda metà del diciannovesimo secolo vi fu a Zanzibar un console inglese, un
console francese e un console americano: un fenomeno unico nella storia di questa
regione.
229
regionale che consentì a Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id un confronto
diretto - e spesso vincente - con le Potenze europee, dall’altro l’analisi degli
obiettivi e delle strategie di potere messe in atto dall’Occidente con la sua
schiacciante superiorità militare e tecnologica. Questi furono elementi in
grado di sviluppare legami fondamentali tra le popolazioni dell’interno
dell’Africa orientale e i principali porti commerciali dell’India occidentale,
dell’Arabia orientale e dell’Asia sud-occidentale, così come germi del
successivo e ineluttabile declino della seconda metà del diciannovesimo
secolo. Numerose componenti condussero a tale declino; tra queste: la
progressiva distruzione delle risorse naturali nell’interno africano, il
risentimento degli altri centri commerciali lungo la costa africana per essere
stati esclusi dalla recente prosperità di Zanzibar, gli attacchi contro la tratta
degli schiavi su cui si basava la ricchezza dell’isola e dell’intera regione, e
la presenza fortemente competitiva di europei e americani rispetto agli arabi
dell’Oman. Saiyid Sa’id bin Sultan Al Bu Sa’id morì alle Seychelles su un
dhow che lo conduceva a Zanzibar il 19 ottobre del 1856. Fu la fine di
un’epoca. Il Canning Award del 1861 confermò suo figlio Majid bin Saiyid
Al Bu Sa’id Sultano di Zanzibar e l’altro suo figlio Thuwaini bin Saiyid Al
Bu Sa’id a capo di Muscat; Majid bin Saiyid Al Bu Sa’id dovette tuttavia
versare a Muscat 40.000 dollari americani (circa 850 sterline) annui per la
compensazione della perdita di Zanzibar che, nel 1889, divenne Protettorato
britannico.
Se da un lato il processo di verticalizzazione e di potenziamento
del potere reso sempre più autocratico dei capi locali e regionali da parte
delle politiche imperiali - ancora da verificare se con le stesse modalità di
quelle applicate dalla Gran Bretagna nella colonia indiana441 - costituì le
basi per la creazione dell’impero informale, dall’altro la necessità del
controllo conobbe il suo apice nella stabilizzazione dei confini politici
nell’oceano Indiano. Processi, questi, che diedero vita a profondi solchi che
ancora oggi sottendono a numerose problematiche intra e inter-regionali. Si
può dunque concludere che, a dispetto delle strategie britanniche volte
prima allo sviluppo dell’impero informale e poi all’estensione del controllo,
del dominio e del possesso, furono le popolazioni, i commerci, le culture, e i
loro percorsi gestiti da principi-mercanti omaniti, da soldati, amministratori
e banchieri asiatici - non certo rigidamente divisi in categorizzazioni ormai
obsolete - a rappresentare le molteplici continuità intrinseche all’oceano
Indiano occidentale. Un vero e proprio “nastro culturale”, nonostante le
ian
a
C
ul
ien
e
\
n
G
i
a
rt
oo
k
pp
a
a
b
s
t
o
e
e
Qu
ti
pu
o
ia
ac
c
441 L. Potter, The Persian Gulf. Tradition and Transformation, Foreign Policy Association,
Headline Series n. 333-334, 2011, pp. 13-20.
230
uo
p
a
i
cc
a
aC
Bibliografia
\n
ian
l
u
Gi
numerose pressioni e le modificazioni introdotte dall’Europa durante tutto il
1800.
rtie
a
p
Brill, Leiden, 2008.
a
ne
Agius D., Classic Ships of Islam: From Mesopotamia to the Indian Ocean,
Bose S., A Hundred Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global
p
Empire, Harvard University Press, Cambridge, 2006.
a
ok
Campbell G., The Indian Ocean World: Africa in the first global economy,
o
Transforming Culture, e-journal 3/2 epress.lib.uts.edu.au/journals/TfC,
b
oe
2008.
st
Kusimba C.M., The Rise and Fall of Swahili States, Altamira Press, Walnut
e
Qu
Creek, 1999.
Nicolini B., L’Oceano Indiano occidentale. Scorci di storia, Polimetrica
International Publishers, Monza, 2009.
Nicolini B., “Re-reading the role of Oman within its International Trade
Relations from 16th to the 19th centuries”, in S. Wippel (ed.), Conceptual
Considerations on “Space” and “Region” and Political, Economic and
Social Dynamics of Region-Building in Oman, Springer Science, Dordrecht,
The Netherlands, 2013.
Nicolini B., “The Indian Ocean: A Cultural Bow”, in H. Alsudairy, E.
Maestri, B. Nicolini, Communication with the ‘Other’. Arab Dimensions,
Cultural Mediation and Bows, Crissma Working Papers, n. 19, Educatt,
Milano, 2010, pp. 46-67.
Nicolini B., The Myth of the Sultans in the Western Indian Ocean during
the 19th century: A New Hypothesis, Migrants and the Making of Indian
Ocean Cultures, Indian Ocean: Cultures in Contact, African & Asian
Studies”, vol. 8, Brill, Leiden, 2009, pp. 239-287.
231
Onley J., Britain’s Informal Empire in the Gulf, 1820-1971, Journal of
Social Affairs”, vol. 22, n. 87, 2005, pp. 29-45.
Onley J., The Arabian Frontier of the British Raj Merchants, Rulers, and
the British in the Nineteenth-Century Gulf, Oxford University Press,
Oxford, 2007.
Palaver K., Un’altra Zanzibar. Schiavitù, colonialismo e urbanizzazione a
Tabora (1840-1916), F. Angeli, Milano, 2011.
\
Pétré Grennouillau O., Les traites négrières. Essai d’histoire globale,
Bibliotheque des Histoires, Gallimard, Paris, 2004.
a
a
pp
Potter L.G. (ed.), The Persian Gulf in History, Macmillan Palgrave, New
k
oo
eb
o
t
Potter L.G., The Persian Gulf. Tradition and Transformation,
es Foreign
u
Policy Association, Headline Series nn. 333-334,Q2011.
York, 2009.
Villiers A., Sons of Sindbad, Arabian Publishing, London, 2007.
232
rtie
a
ne
Que
s
to e
b
o
ok a
p
p
art
nG
i
e
n
e
a\
a
iul
i
a
n
aC
ccia
pu
oti
13
C
L
I
_20
11
00
3
0
396
9
233
Q
o
bo
e
sto
e
u
Memoranda by Captain John Croft Hawkins, Indian Navy, to the
Governement Council, June 21st 1842, Foreign Office, 54/4, folios 255257.
234
rtiene
k appa
o eboo
Quest
liana C
acciap
a\nGiu
uoti CL
I_2013
0 0 303
9691
Scarica