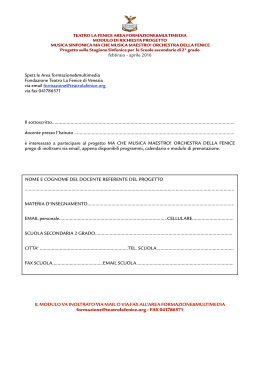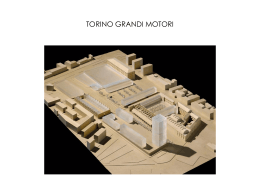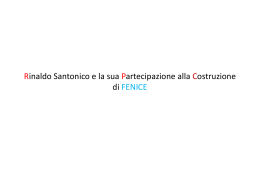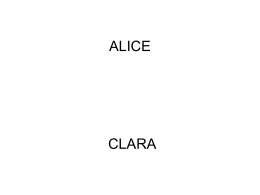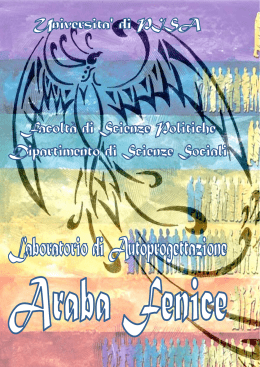FILOLOGIA ROMANZA
(prof. Francesco Zambon)
SAGGI PER IL CORSO
MONOGRAFICO
1999-2000
Il mito della fenice nella poesia romanza
del medioevo
AVVERTENZA: Le abbreviazioni contenute nelle note
rinviano alla Bibliografia inserita alla fine dei tre saggi.
133
1.
Francesco Zambon
Il bestiario igneo di Giacomo da Lentini
Quello che si potrebbe definire come il “bestiario igneo” di Giacomo da
Lentini è quasi interamente racchiuso in due sonetti, anche se il suo alone
simbolico si allarga a molti altri testi (non solo di Giacomo) attraversando
alcuni dei nuclei tematici fondamentali del suo canzoniere e di tutta la
poesia siciliana. Si tratta di Sì como 'l parpaglion c'à tal natura e di Lo
badalisco a lo specchio lucente; il secondo, in verità, di paternità dubbia,
essendo attribuito al Notaro dal Laurenziano Rediano 9 e dal Parmense
1081, mentre il Vaticano Barberino 3953 lo assegna a Monaldo [d'Aquino].
Ma le considerazioni che qui si faranno non possono che avvalorare gli
argomenti interni portati da Antonelli a favore dell'attribuzione a Giacomo
da Lentini.
Converrà partire da qualche osservazione circa le fonti delle similitudini
zoologiche. Come si sa - specie dopo le minuziose analisi di Bruni e di
Brugnolo1 - l'immagine del parpaglione deriva da quella del parpaillos che
fer el foc nella canzone Sitot me sui a tart di Folchetto di Marsiglia,
combinata - in virtù del comune campo metaforico (incendio d'amore) e
della esplicita o sottintesa presenza in entrambe della candela (che ricorre,
come si vedrà, anche altrove in Giacomo) - con la similitudine dell'“enfan /
cui la candela platz” e che vi si scotta di Abril ni may di Elias Cairel. Il tema
del fuoco si prolunga nell'emblema finale della fenice, comunque si voglia
leggere il verso 14, “rendendo vita come la finise” (Antonelli: “restituendo
al cuore la vita non appena la finisce”)2 o rendegli vita com'a la finise
(Panvini: “gli restituisce la vita, come avviene alla fenice”).3 Del mito
feniceo è qui evocato il dato essenziale dell'incendio e della rinascita; ma
per la probabile aequivocatio su fenise si dovrà risalire anche in questo caso
- oltre che alle tradizioni oitaniche indicate da Antonelli (Roman de la Rose
e Cligès)4 - alla poesia trobadorica, e a due grandi trovatori: Raimbaut
d'Aurenga e Peire Vidal. La canzone Apres mon vers vueilh sempr'ordre di
1
Cfr. Bruni 1990, pp. 210-273 e Brugnolo 1995, pp. 265-337.
Giacomo da Lentini, Poesie, p. 346.
3
Panvini 1994, p. 99.
4
Cfr. Antonelli 1979, pp. 346-347.
2
134
Raimbaut, incentrata sul tema della fedeltà amorosa, si chiude con il distico
(ed. Pattison, vv. 64-65):
Plus qe ja fenis fenics
non er q'ieu non si' amics.
[Come mai non muore la fenice / non sarà mai che io non vi sia amico]
Analago il senso del bisticcio con il verbo fenir, ancora, nella seconda
tornada del sirventese Pos ubert ai mon ric tezaur di Peire Vidal (ed. Avalle,
vv. 90-94), dove pure fenics rima con amics ed è già presente il tema
siciliano della gioiosa autodistruzione dell'amante nella donna amata (o nel
fuoco amoroso):
Amiga, tan vos sui amics,
qu'ad autras en paresc enics
e volh esser en vos fenics,
qu'autra jamais non amarai
et en vos m'amor fenirai.
[Amica, tanto vi sono amico, / che verso le altre sembro nemico / e voglio essere
in voi fenice, / poiché non amerò mai altra donna / e in voi compirò il mio amore]
E animale della fine (del testo) la fenice lo è anche in Giacomo: cifra in
un certo senso - se è vero che il sonetto si scrive dalla fine - del sonetto
stesso, della sua circolarità.
Quanto all'altro sonetto, Lo badalisco a lo specchio lucente, non hanno
bisogno di commento le similitudini del cigno, del pavone (la “natura”, che
figura già nel cosiddetto Physiologus bizantino,5 è ripresa in molti bestiari o
enciclopedie del medioevo come il De avibus di Ugo di Fouilloy, il De
proprietatibus rerum di Bartolomeo Anglico, il Tresor di Brunetto Latini)6
e, di nuovo, la fenice. Più complessa, invece, è l'origine della prima
immagine, quella del basilisco, le cui fonti sono state finora indicate solo
molto vagamente: Sanguineti7 cita L'iconographie de l'art chrétien di Réau a
proposito di un capitello di Vézelay, dove è raffigurato un personaggio che
oppone uno scudo di cristallo al basilisco per proteggersi contro i suoi
malefici. La leggenda cui Giacomo allude è, in prima istanza, quella
notissima - e già attestata da Plinio - secondo cui il basilisco ha la proprietà
di uccidere con lo sguardo (Nat. hist. XXIX,19,66: “qui hominem, uel si
aspiciat tantum, dicitur interemere”); a essa fa direttamente riferimento il
distico iniziale di un altro sonetto (dello stesso Giacomo? di Rinaldo
d'Aquino?): Guardando basalisco velenoso / che 'l so isguardare face l'om
5
Cfr. Fisiologo, pp. 204-205.
Si vedano i riferimenti in Carrega e Navone 1983, pp. 470-471.
7
Cfr. Sanguineti 1965, p. 35.
6
135
perire.8 L'uccisione del mostro per mezzo di un cristallo o di un vetro
opposto al suo sguardo è descritta, fra i bestiari, soltanto dalla versione
lunga del Bestiaire di Pierre de Beauvais, composta però tra il 1245 e il
1268: “Chi volesse uccidere questa bestia dovrebbe avere un vaso traslucido
di cristallo o di vetro, attraverso il quale possa vedere la bestia chiaramente.
In modo che, quando tiene la testa dentro al vetro o al cristallo, il basilisco
non possa vedere colui che vi si trova dentro e il suo sguardo si fermi sul
vetro o sul cristallo: giacché esso ha una natura tale per cui, quando lancia il
suo veleno attraverso gli occhi e questo si ferma su qualche ostacolo, il
veleno rimbalza su di esso e ne provoca la morte”9.
Le fonti di questo capitolo non sono state ancora studiate adeguatamente:
manca del resto a tutt'oggi una esauriente Storia del basilisco. Florence
McCulloch si limita a classificare la descrizione di Pierre de Beauvais (o
piuttosto di un suo continuatore) fra il “materiale non-bestiario” contenuto
nella sua opera.10 Tale descrizione ci riporta in realtà a una tradizione molto
precisa, e cioè ai temi magico-fantastici inclusi nelle leggende orientali e
bizantine relative ad Alessandro Magno. La tecnica per uccidere il basilisco
opponendo uno specchio al suo sguardo è uno dei consigli di Aristotele ad
Alessandro contenuti nel Secretum secretorum, risalente a un originale
(Kitâb Sirr al-‘asrâr) che sarebbe stato tradotto dal siriaco in arabo da
Yahya ibn al-Bitriq (IX secolo) e poi diffuso in Occidente attraverso varie
traduzioni latine e volgari; sappiamo che il maestro Teodoro lo riassunse per
l'imperatore Federico II.11 Il tema si ritrova poi nei Gesta romanorum e in
alcune redazioni interpolate della Historia de preliis Alexandri Magni. Nei
Gesta si legge: “Alessandro regnò, ottenendo il dominio di tutto il mondo.
Una volta gli accadde di radunare un grande esercito e di assediare una città:
in questo stesso luogo subì numerose perdite fra i suoi soldati e fra altre
persone senza che fossero feriti. Meravigliandosi molto di ciò, chiamò i
filosofi e chiese loro: "Maestri, come può accadere questo, che i miei soldati
muoiano improvvisamente senza ferite?" Quelli risposero: "Non c'è da
stupirsi, giacché sopra le mura della città c'è un basilisco, dal cui sguardo i
soldati sono avvelenati e muoiono". Chiese allora Alessandro: "Che rimedio
c'è contro il basilisco?" Gli risposero: "Si ponga uno specchio in alto fra
l'esercito e le mura, dove si trova il basilisco; quando guarderà nello
8
Se ne veda il testo in Giacomo da Lentini, Poesie, pp. 400-401.
Art. XVb: Basilecoc, in Pierre, Best. (ed. Rebuffi), p. 178,13-22: “Qui ceste beste voldroit
tuer, il li covenroit avoir I cler vaisel de cristal ou de voire, par coi il peüst veïr la beste
parmi la clarté. Que quant il aroit la teste el voire ou el cristal, que il ne peüst celui
aperchoivre qui dedens seroit, et que li regars de la beste arestast al cristal ou al voire, que
la beste a tel nature, quant ele gete son venin per les ex et s'il areste encontre alcune cose,
qu'il resorst sor lui ariere; et si l'en covient morir”.
10
Cfr. McCulloch 1962, pp. 199-200.
11
Cfr. Kantorowicz 1994, p. 306.
9
136
specchio, il riflesso del suo sguardo tornerà verso di lui e così morirà". E
così fu fatto”.12
La storia è ripresa in termini ancor più immaginosi nella Historia de
preliis, che peraltro un letterato della mouvance fredericiana, il giudice
Quilichino da Spoleto, versificò nei distici della Historia Alexandri Magni.13
Nella cosiddetta recensione J3 si racconta: “Inoltrandosi per il passaggio
orientale, camminò per sette giorni su quel sentiero strettissimo; l'ottavo
giorno trovarono un basilisco orribile e fetido a causa della decrepitezza, che
era talmente velenoso da corrompere l'aria non solo con il puzzo ma con lo
stesso sguardo, per quanto esso si estendeva. Così, passando, Macedoni e
Persiani cadevano senza vita al solo sguardo del serpente. I soldati,
scorgendo tale pericolo, non andavano oltre dicendo: “Davanti a noi sul
cammino sta il potere degli dèi, che ci mostra come non dobbiamo
proseguire oltre la traversata”. Allora Alessandro si avviò da solo sulla cima
del monte, in modo da poter scorgere da lontano la causa di una simile
peste. E stando sulla cima del monte, vide il basilisco che stava in mezzo al
passo e dormiva sempre. Ma quando sentiva avvicinarglisi un uomo o un
animale, apriva gli occhi e tutti quelli che guardava morivano
immediatamente. Visto ciò, Alessandro scese subito dal monte e stabilì dei
limiti che nessuno doveva oltrepassare. Poi fece costruire un grande scudo
lungo sei cubiti e largo quattro, e all'esterno fece inserire sulla supercifie
dello scudo un grandissimo specchio e fece fare delle calzature di legno alte
un cubito. Preso lo scudo sul braccio e indossate le calzature ai piedi, si
avviò in direzione del basilisco tenendo contro di sé lo scudo, in modo che
non si vedessero assolutamente né il capo né i fianchi né i piedi. E ordinò a
tutti i suoi soldati di non tentare assolutamente di superare i limiti. Quando
fu vicino al basilisco, quello aperse gli occhi e guardò lo specchio con
rabbia: contemplando se stesso nello specchio, subito fu ucciso. Quando si
accorse che era morto, Alessandro gli salì sopra, chiamò i suoi soldati e
disse: “Venite e guardate chi vi uccideva”. Accorsi, quelli videro il basilisco
morto. E subito, per ordine di Alessandro, lo bruciarono, elogiando fra loro
la sapienza di Alessandro”.14 Con qualche variante, che la avvicina alla
12
Gesta Romanorum, cap. 139; cfr. Oesterly 1872, pp. 493-494: “Alexander regnavit, qui
dominium tocius mundi obtinuit. Accidit semel quod grandem exercitum collegit et
quandam civitatem circumdedit, et in eodem loco plures milites et alios sine vulnere amisit.
Cum vero de hoc multum miraretur, philozophos vocavit et ait eis: O magistri, quomodo
poterit hoc esse, quod subito sine vulnere milites mei moriuntur? At illi dixerunt: Mirum
non est; est enim quidam basiliscus super murum civitatis, cujus aspectu milites inficiuntur
et moriuntur. Ait Alexander: Quale remedium est contra basiliscum? Cui dixerunt: Ponatur
speculum elevatum inter exercitum et murum, ubi est basiliscus, et cum in speculum
respexerit, reflexus ejus intuitu ad se ipsum redit et sic morietur. Et factum est”.
13
Cfr. Pfister 1912, pp. 249-301.
14
Cfr. Historia de preliis, pp. 152-154: “Et dum per medium transitum orientis intraret,
ambulavit per dies VII et per illud artissimum iter; VIII vero die invenerunt basiliscum
137
notizia del Bestiaire di Pierre de Beauvais, la narrazione si trova anche nel I
libro del Tresor di Brunetto Latini: “Sappiate che Alessandro li trovò e fece
fare delle grandi ampolle di vetro in cui entravano alcuni uomini e potevano
vedere i basilischi, senza che questi li vedessero; e i soldati li uccidevano
con le frecce: in tal modo il suo esercito ne fu liberato”.15
Vi è in tutte queste descrizioni del basilisco un evidente incrocio con il
mito antico di Medusa - una delle tre Gorgoni - quale è narrato da
Apollodoro (II,4,2): essa è uccisa da Perseo, il quale si serve di un
lucentissimo scudo nel quale può osservare l'immagine riflessa del mostro
(che ha capelli di serpenti) prima di tagliargli la testa; fra gli oggetti magici
impiegati nell'impresa vi è anche l'oscuro elmo di Ade che rende invisibili.16
La fusione tra questa leggenda e quella del basilisco è stata probabilmente
favorita dal racconto di Lucano, secondo cui dal sangue di Medusa
gocciolato al suolo sarebbero nati tutti i serpenti velenosi del luogo e fra
questi il basilisco “che emette sibili capaci di atterrire tutti gli altri mostri, e
uccide prima ancora di mordere e attorno a sé per largo tratto mette in fuga
ogni vivente per regnare solo sulle sabbie deserte”.17 Come osserva Massimo
orribilem et dierum antiquitate fetidum, qui tante venositatis erat, ut non solum fetore sed ex
ipso visu, quantum contemplari poterat, aerem corrumpebat. Transeuntes itaque Macedones
et Perse solo visu serpentis cadebant exanimes. Milites cernentes tale periculum non
amplius procedebant dicentes: “Deorum virtus ante nos in itinere consistit, que nos amplius
non transire demonstrat”. Tunc Alexander cepit solus per superiorem partem montis
ascendere, ut a longe posset causam tante pestilentie previdere. Et cum in superiori parte
montis consisteret, vidit basiliscum in medio tramite consistentem, et dormiebat continuo.
Cum autem sentiebat hominem vel animal appropinquare sibi, aperiebat oculos et quotquot
aspiciebat, ilico interibant. Quod cum vidisset Alexander, continuo descendit de monte et
constituit terminos, quos nullus presumeret excedere. Et fecit fieri clipeum magnum longum
cubitis VI et latum cubitis IIII, et ab exteriori parte in superficie clipei fecit speculum
maximum interponi fecitque sibi subtellares ligneos per cubitum altos. Et accipiens clipeum
in brachio suo et subtellares in pedibus cepit contra basiliscum opposito sibi clipeo incedere
ita, quod nec caput nec latera nec pedes ullatenus videri poterant. Et precepit universis
militibus suis, ut nullus terminos excedere attemptaret. Cum autem propinquus esset
basilisco, aperuit ille oculos et irato animo inspiciens speculum semet ipsum contemplans in
speculo illico extinctus est. Alexander itaque sentiens illum exanimem ascendit super eum et
vocans milites suos ait: “Venite et videte occisorem vestrum”. At illi festinantes viderunt
basiliscum mortuum. Et continuo illum iussu Alexandri Macedones cremaverunt et
laudabant omnes ad invicem sapientiam Alexandri”. La stessa descrizione si legge, in forma
abbreviata, anche nelle Guerre di Alessandro medioinglesi (XV secolo): cfr. Alessandro,
pp. 295-297 (testo e traduzione a cura di C. Bologna) e 604-605 (commento dello stesso
studioso).
15
Tresor, cap. 140: “Et sachiés que Alixandres les trova, et fist faire grandes ampoles de
voirre ou homes entroient dedens ki veoient les basiliques, mais il ne veoient ceaus, ki les
ocioient des saietes; et par itel engin en fu delivrés il et son ost”.
16
Cfr. Graves 1963, pp. 295-296.
17
“[..] sibilaque effundens cunctas terrentia pestes, / ante uenena nocens, late sibi summouet
omne / uulgus et in uacua regnat basiliscus harena”, Phars. IX, 724-726; trad. it. in Lucano,
Farsaglia, p. 471.
138
Izzi, qui “troviamo la ragione per cui di tutte le valenze velenose del
basilisco, è quella legata allo sguardo che acquista la preminenza: si tratta di
una fusione tra due elementi della mitologia classica, la Gorgone dallo
sguardo pietrificante e il suo figlio naturale, il basilisco che sparge la morte
con la sua sola presenza”.18 Il mito della Gorgone, del resto, è incluso fra le
descrizioni di animali e di mostri contenute nella redazione bizantina del
Fisiologo; vi si legge che il suo capo fu usato da Alessandro per sbaragliare i
nemici: “Chi veda un serpente o un altro animale, oppure un proprio
nemico, e gli mostra per arte [magica] la testa della Gorgone, lo incenerisce,
come faceva il re Alessandro, che per mezzo di essa dominò tutti i popoli”.19
In un capitolo extravagante, contenuto in alcuni manoscritti del Physiologus
greco, si legge anche che il basilisco - capace di disseccare gli arbusti e di
rendere deserte le città con il suo fiato - cammina con il capo rivolto
all'indietro; per ucciderlo, i dotti lo abbagliano dirigendo i raggi del sole
verso i suoi occhi per mezzo di uno specchio: l'animale, non vedendo più la
propria ombra, muore.20 Nella misura in cui Giacomo da Lentini poteva
conoscere queste leggende, legate anche alla magia catottrica, la sua
similitudine è dunque evocatrice di un ricco complesso leggendario e
simbolico: Alessandro Magno, l'Oriente, Perseo e Medusa, gli specchi
magici...
Tuttavia anche qui la fonte immediata, già indicata di sfuggita da
Gaspary21 ma non segnalata da Fratta,22 è provenzale. A proposito della
similitudine fra lo sguardo micidiale della donna e quello avvelenato del
basilisco, Garver - citato anche da Vuolo - rileva come non abbia precedenti
nella poesia trobadorica.23 Quella dell'uccisione del mostro per mezzo dello
specchio è invece sviluppata nella celebre canzone Si com l'arbres per
sobrecargar di Aimeric de Peguilhan, anche in altri punti utilizzata dai
Siciliani (ed. Shepard-Chambers, vv. 25-32):
No sai nulh “oc” per qu'ieu des vostre “no”,
per que soven tornon mei ris en plor;
et ieu cum folhs ai gaug de ma dolor
et de ma mort, quan vei vostra faisso.
Quo·l bazelesc qu'ab joy s'anet aucir,
quant el miralh se remiret e·s vi,
tot atressi etz vos miralhs de mi,
que m'aucietz quan vos vei ni·us remir.
18
Izzi 1982, p. 110.
Fisiologo, pp. 246-247. Per l'incrocio fra la leggenda del basilisco e il mito della Gorgone
nella tradizione del Fisiologo, cfr. Goldstaub 1895, p. 379.
20
Cfr. Fisiologo, pp. 246-247.
21
Cfr. Gaspary 1882, p. 105 nota 2.
22
Cfr. Fratta 1996.
23
Cfr. Garver 1907, p. 280, e Vuolo 1962, p. 136.
19
139
[Non conosco nessun “sì” con il quale scambierei il vostro “no”, cosicché spesso
il mio sorriso si volge in pianto; ed io come un pazzo provo gioia del mio dolore e
della mia morte, quando vedo il vostro viso. Come il basilisco che gioiosamente va a
uccidersi quando si guarda e si vede nello specchio, così voi siete specchio di me,
giacché mi uccidete quando vi vedo e vi guardo].
La dipendenza di Giacomo da Aimeric è provata soprattutto dal suo con
isbaldimento, che non ha alcun fondamento nelle leggende tradizionali e
riprende invece l'ab joy del poeta provenzale. Si tratta, questa volta, di un
evidente incrocio con il mito di Narciso e con la sua evocazione in Bernart
de Ventadorn, cui rinvia il miralh de mi di Aimeric. Del resto la similitudine
del basilisco che si specchia è ripresa anche da Bondie Dietaiuti nella
canzone Madonna me è avenuto simigliante:24
Madonna, ben ò inteso che lo smiro
aucide 'l badalischio a la 'mprimera;
di voi similemente m'è avenuto
per un vedere ond'io piango e sospiro,
che 'nmantenente m'allumò la spera,
onde coralemente son feruto.
Oimé, chiaro miraglio ed amoroso,
sì per lo primo sguardo
vi 'maginai, ond'ardo,
né del mio cor non fui mai poderoso.
A proposito di questo passo, che riassume i temi più tipici del Notaro, le
postille di Torraca edite da Aniello Fratta rimandano precisamente ad
Aimeric, in associazione - per i versi finali - a Bernart de Ventadorn, Can
vei la lauzeta mover: “Miralhs, pus me mirei en te, / m'an mort li sospir de
preon” [“Specchio, dopo che mi sono mirato in te, / i sospiri mi hanno
ucciso dal profondo”].25 In ogni caso, con l'evocazione del basilisco, siamo
nel cuore di una costellazione tematica e simbolica che comprende quasi
tutti gli ingredienti fondamentali del laboratorio poetico di Giacomo da
Lentini: fuoco, luce, vetro, specchio, sguardo, immagine...
Molti di essi sono presenti o impliciti anche nelle altre similitudini dei
due sonetti considerati: in essi infatti gli emblemi animali non sono
semplicemente giustapposti come tessere di un prezioso mosaico, ma in
parte si sovrappongono conferendo rilievo e spessore simbolico particolari
ad alcuni temi o parole chiave, secondo una tecnica applicata
sistematicamente in quegli stessi anni da Richard de Fournival nel Bestiaire
d'amours. È intorno a questi temi e a queste parole, in realtà, che si
agglutina e orbita il bestiario di Giacomo. Nel sonetto Sì como 'l parpaglion,
infatti, i temi del fuoco e dell'incendio sono comuni a parpaglione e fenice
24
25
Panvini 1962, p. 293.
Cfr. Fratta 1996, p. 21.
140
(nonché allo zitello), quello del gioco / diletto al parpaglione e allo zitello,
mentre quello della rinascita è esclusivo della fenice: il cuore dell'amante è
dunque una sorta di “mostro dei mostri”, in cui si assommano le proprietà
meravigliose di più creature.
Analogo, ma più complesso, il caso del sonetto Lo basalisco a lo
specchio lucente. Ai temi della luce e del fuoco (che qui associano fenice e
basilisco, anche perché secondo molte descrizioni - da Isidoro fino a
Hildegart von Bingen - il fiato di quest'ultimo è infuocato e incenerisce ogni
cosa), della morte (che affianca gli stessi due animali al cigno) e della
rinascita (ancora riservato alla sola fenice), si aggiungono quelli dello
sguardo (basilisco e pavone), del canto (cigno) e del turbamento (pavone),
mentre si intensifica quello della gioia, già presente nell'immagine dello
zitello in Sì como 'l parpaglion; questo tema - fondamentale nel Notaro - è
anzi la vera filigrana del sonetto, attraversando tutte le “nature” zoologiche
come dato accessorio rispetto a quelli più caratteristici e insoliti (lo specchio
in cui si vede il basilisco, l'incendio della fenice ecc.).
La rete di collegamenti potrebbe essere facilmente estesa anche agli
emblemi animali o mitologici di altri componimenti - dello stesso Giacomo
o di poeti diversi: in particolare alle due sequenze di sonetti nelle quali
Santangelo aveva creduto di poter riconoscere due tenzoni poetiche fra vari
autori, rispettivamente “sul canto e l'amore” e “sul parpaglione e il fuoco
d'amore”.26 Del primo gruppo fanno parte, oltre a Lo basalisco, Un oseletto,
che canta d'amore di Rinaldo d'Aquino, l'adespoto Quando gli ausignuoli e
gli altri agielli, Quando l'aire rischiara e rinserena di Bondie Dietaiuti,
L'usciel fenice quando ven'al morire di Giovanni d'Arezzo, Guardando
basalisco venenoso (attribuito da Santangelo a Rinaldo) e l'adespoto
Guardando la fontana, il buon Narciso. Al secondo appartengono, insieme a
Sì como 'l parpaglion (anche questo attribuito da Santangelo a Rinaldo
d'Aquino), gli adespoti Lo mio folle ardimento m'à conquiso e Lo
parpaglion, guardando a la lumera, infine Chi non avesse mai veduto foco
dello stesso Giacomo. Più che di vere e proprie tenzoni, si tratterà di quel
lavoro in collaborazione o di variazione su temi fissi - o testi trobadorici sul quale insistono gli studiosi più recenti della Scuola poetica siciliana.27 Il
confronto fra tutti questi componimenti, in ogni caso, permette di osservare
l'espansione ulteriore di alcuni temi chiave - come quelli del fuoco (che
genera anche l'immagine della salamandra) e dello sguardo (che si articola
intorno al mito di Narciso in Guardando la fontana, il buon Narciso ed è
presente anche nella lunga similitudine della pantera nella canzone Pir meu
cori allegrari di Stefano Protonotaro). Esso lascia affiorare anche
collegamenti sotterranei come quello fra il cigno e la fenice, in virtù del
26
27
Cfr. Santangelo 1928, pp. 204-230.
Cfr. in particolare Bruni 1990, p. 255.
141
canto in punto di morte (che è anche un dato tradizionale del mito feniceo);
nel sonetto L'uscel fenice di Giovanni d'Arezzo, infatti, il riferimento al
favoloso uccello ingloba sia il tema del canto sia quello dell'incendio:28
L'uscel fenice quando ven' al morire,
dice la gente che fa dolce canto,
ed è gran meraviglia, a lo ver dire,
cantare de la cosa onde vien pianto.
[...]
Or avenisse a me com' adovene
a lo fenisce che more cantando,
e ardendo di se stesso si riface:
se lo foco d'amore che me tene,
aucidendo mi gesse recriando,
sofereria da Amor la morte in pace.
Non solo le similitudini zoologiche di Giacomo da Lentini non si
riducono - come in molti epigoni - a esteriori ornamenti retorici ma, a un
attento esame, esse si rivelano una presentazione cifrata della sua intera
filosofia amorosa. Nel sonetto Sì come il sol che manda la sua spera, il
dardo di Amore che attraversa gli occhi e colpisce il cuore, accendendo un
fuoco “ch'arde dentro e fuor non pare”, è paragonato al raggio di sole che
attraversa un vetro e va a riflettersi su uno specchio. In Or come pote sì gran
donna entrare, lo stesso processo è descritto con altre immagini: la donna
amata è paragonata alla candela che arde nella lucerna e la cui luce
attraversa il vetro “sanza far rottura”; allo stesso modo la figura della donna
- quella pintura interiore di cui Giacomo parla in Meravigliosamente e in
altri componimenti - si imprime nel cuore dell'amante. Come hanno
mostrato Favati e la Bianchini,29 sono esattamente i termini in cui
l'innamoramento è descritto da Alexandre nel Cligès di Chrétien de Troyes,
dove però è il cuore a essere paragonato alla candela accesa nella lanterna
(“Donc est li cuers el vantre mis, / ausi com la chandoile esprise / est dedanz
la lenterne mise”):30 l'immagine proveniente dall'esterno attraversa gli occhi
come il raggio di sole che attraversa il vetro della lucerna oppure una
vetrata, senza romperla (“Ja n'iert si forz ne anterine / que li rais del soloil n'i
past, / sanz ce que de rien ne la quast”),31 e si riflette nello specchio del
cuore (“li mereors au cuer”).
Questa teoria e le immagini che la raffigurano sono cifrate nel mosaico
zoomorfo dei due sonetti Sì como 'l parpaglion e Lo badalisco: basta
28
Santangelo 1928, pp. 213-214.
Cfr. Favati 1963 e Bianchini 1996, pp. 26-47.
30
Cligès, vv. 714-716, in Chrétien, Oeuvres, p. 190.
31
Cligès, vv. 724-726, in Chrétien, Oeuvres, p. 191.
29
142
sciogliere il rebus e si troverà in essi la più completa esposizione della
dottrina amorosa di Giacomo da Lentini. La similitudine del parpaglione è
forse scattata, per interferenza con i testi di Folchetto e di Elias Cairel, a
partire da quella della candela in Chrétien; ma il parpaglione attiva inoltre i
temi del fuoco, della luce, dell'incendio. Nel primo sonetto, la fenice evoca
ancora incendio, poi morte e vita nel fuoco; nel secondo il basilisco
condensa fuoco, sguardo, vetro, specchio, morte; la fenice - di nuovo incendio e morte / vita nel fuoco. Le altre similitudini dei due sonetti zitello, pavone, cigno - aggiungono o ricalcano i temi della luce / fuoco,
dello sguardo, del canto. Un basilisco-fenice (o un parpaglione-fenice) è
dunque l'amante che accoglie nello specchio del cuore, attraverso il vetro
degli occhi, l'immagine (il dardo igneo) della donna e ne brucia di un fuoco
nascosto e inestinguibile. Giacomo ripete spesso che questo fuoco appiccato
dalla pintura interiore è esperienza propriamente ineffabile (cfr. almeno la
canzone Amando lungiamente): l'araldica zoologica è la soluzione poetica a
questo problema espressivo. Sintomaticamente, in Madonna dir vo voglio
(vv. 24-31), è proprio l'emergenza di questa tematica a sviluppare l'altro
emblema equivalente del “bestiario igneo” di Giacomo, quello della
salamandra, la cui evocazione si dissolve in una dichiarazione di impotenza
a dire gli effetti della vita nel foc'amoruso:32
Foc'aio al cor non credo mai si stingua;
anzi si pur alluma:
perché non mi consuma?
La salamandra audivi
che 'nfra lo foco vivi stando sana;
eo sì fo per long'uso,
vivo 'n foc'amoruso
e non saccio ch'eo dica [...]
32
Giacomo da Lentini, Poesie, pp. 12-13.
143
2.
Francesco Zambon
Il bestiario della Sapienza celeste
La sezione zoologica che occupa la maggior parte del terzo libro
dell’Acerba di Cecco d’Ascoli, è stata fatta risalire alle fonti più disparate,
senza che si sia potuti approdare finora a conclusioni davvero soddisfacenti.
Agevolati dalla fondamentale somiglianza di quasi tutti i trattati sugli
animali dall’XI al XIII secolo, gli studiosi che si sono occupati della
questione hanno di volta in volta indicato questo o quel testo, non senza
lasciar trasparire in questo modo le personali interpretazioni dell’opera
33
cecchiana. Così G. Castelli era convinto che il “bestiario” dell’Acerba
derivasse, almeno in parte, dal folklore ascolano o comunque italiano;
Friedrich Lauchert,34 specialista del Fisiologo greco e latino, lo pretese
appunto ricavato da quest’ultimo; F. Crespi,35 curatore di una fra le più
importanti edizioni del poema e cui premeva mettere in evidenza la
ricchezza e la qualità della dottrina scientifica di Cecco, cercò di
dimostrarne la stretta dipendenza dal De animalibus di Alberto Magno,
largamente citato nel suo commento; E. Frizzi propose il Tresor di Brunetto
Latini,36 altri parlarono di semplici fole o superstizioni popolari. A prima
vista la proposta più fondata appare quella del Lauchert, il quale afferma
letteralmente che il bestiario del terzo libro non è “altro che una diretta
rielaborazione del Fisiologo”:37 e pur dovendo ammettere che le
applicazioni morali e spirituali annesse alle singole descrizioni zoologiche
sono originali, fa tuttavia notare che Cecco “può aver appreso tutta questa
tecnica solo dal Fisiologo”.38 Effettivamente, dei 46 animali trattati
nell’Acerba poco meno della metà è compresa nel Fisiologo; lo studioso ne
elenca 18: fenice, aquila, pellicano, salamandra, struzzo, notticora, pernice,
upupa, tortora, sirena, aspide, vipera, coccodrillo, leone, iena, pantera,
castoro, unicorno. A questi andrebbero aggiunti almeno il caladrio e la
scimmia. Ma si può forse concluderne che la sezione zoologica dell’Acerba
33
Cfr. Castelli 1892.
Cfr. Lauchert 1890, pp. 1-12.
35 Cfr. Crespi 1927.
36 Cfr. Frizzi 1877. Si vedano anche Palermo 1860, II e Bariola 1879.
37 Lauchert 1890, p. 4.
38 Ibid., p. 4.
34
144
costituisca semplicemente “una rielaborazione in versi del Fisiologo”,39
paragonabile ai Bestiaires francesi di Philippe de Thaün e di Guillaume le
Clerc? In realtà, se alla sua base si trovano in effetti le “nature” del
Fisiologo, vi compare anche un numero considerevole di notizie
supplementari che sarebbe inutile cercare nel bestiario greco o nelle sue
versioni latine e volgari. Certo, i versi di Cecco sull’unicorno (III,XLV,4-6:
“Dentro nel cor li prende umilitade; / vedendo la pulzella a·lei s’aplica, /
così lo prende la virginitate”)40 ripetono la leggenda tradizionale: “…gli
mettono davanti una casta vergine; allora l’animale balza nel suo seno, e lei
lo riscalda e lo nutre: poi lo conduce al palazzo regale”.41 Ma i versi che
precedono (ibid., 1-3: “Quante l’alicorno è fera forte, / che l’alinfante
combatte e nimica / e molte volte l’uom conduce a morte!”) non trovano
alcun riscontro nel Fisiologo. Sicché, se si volessero integrare i riferimenti
“fisiologici” con tutte le altre fonti necessarie a spiegare il testo dell'Acerba,
bisognerebbe risalire a Plinio, Solino, Ambrogio, Isidoro e altri ancora. Ma
non ci s’inganni: quest’opera di raccolta o, se si preferisce, di
“incrostazione”, di nuovi materiali intorno allo scheletro dell’opuscolo greco
fu dovuta non tanto all’erudizione o alla fantasia del poeta ascolano, quanto
alla folta schiera dei compilatori di enciclopedie e bestiari latini,
specialmente a partire dal XII secolo.42
Cecco d’Ascoli utilizzò una di queste compilazioni: e precisamente il De
rerum proprietatibus di Bartolomeo Anglico, la cui larga diffusione
nell’Italia settentrionale è stata già da tempo riconosciuta. In particolare,
Vittorio Cian ne ha studiato un volgarizzamento mantovano nella sua ampia
monografia su Vivaldo Belcalzer e l’enciclopedismo italiano,43 studio più
recentemente approfondito da Ghino Ghinassi.44 Dante stesso, sembra, era a
conoscenza dell’opera e del resto, come notifica un documento citato dal
Cian, “il De proprietatibus rerum era il manuale classico di scienze naturali
più in uso nelle scuole di Parigi”, tanto che “lo troviamo registrato
nell’elenco ufficiale dei testi che i librai parigini davano in prestito agli
studenti a un prezzo determinato da apposita tariffa”.45 E non soltanto la
versione di messer Vivaldo ne documenta la diffusione tra Lombardia,
39
Ibid., p. 4.
Le citazioni dell'Acerba sono tratte dall'edizione di B. Censori ed E. Vittori indicata in
bibliografia. Gli eventuali emendamenti al testo fornito in questa edizione, piuttosto
corrotto, sono stati inseriti fra parentesi uncinate < >: le correzioni sono state operate sulla
base del confronto con le edizioni dell'Acerba fornite da Rosario 1926 e Crespi 1927. Per la
sezione zoologica, si veda ora anche Morini 1996.
41 Carmody 1941, p. 128.
42 A questo proposito si vedano specialmente Sbordone 1949 e Mc Culloch 1962.
43 Cfr. Cian 1902.
44 Cfr. Ghinassi 1965.
45 Cian 1902, p. 49.
40
145
Veneto e Toscana intorno ai primi decenni del ‘300 - periodo in cui si
colloca verosimilmente la composizione dell’Acerba - ma lo stesso Brunetto
Latini nella sezione zoologica del Tresor, che il suo più recente editore, il
Carmody, ritiene derivato in massima parte dal terzo libro del De Bestiis,46
sembra in realtà aver utilizzato l’enciclopedia di Bartolomeo.47 Della sua
fortuna negli ambienti scientifici e culturali italiani l'Acerba offre una
ulteriore, precisa testimonianza, come si potrà concludere da un dettagliato
confronto fra i due testi.
In alcuni casi, Cecco non andò oltre una trascrizione pressoché letterale
del testo latino, come nel capitolo sulla “noticora” (III,XIII,1-6):
Noticora, querendo 'l cibo, grida;
di notte canta, in volando preda.
Dove son corpi morti, ivi s'anida;
vede la notte, ma dal giorno è cieca;
agli altri uccelli è ‹angosciosa e feda›;
com' più risguarda 'l Sol più 'l viso a‹cc›eca.
Bartolomeo:48
Nocticoras est noctis corvus; sic dicitur eo quod noctem amat, quia de ncte volans
cibum querit et querendo clamitat: cuius clamor est volucribus odiosus, ut dicit
Isi(dorus). Est autem avis lucifuga et solem videre non potest; sepulchra et loca
mortuorum inhabitat et frequentat; in parietibus et in locis rimosis nidificat; ova
columbarum et monedularum frangit et devorat et cum eis pugnat. Hec dicitur noctua
quasi de nocte acute tuens; de nocte autem videt, ex orto autem splendore solis eius
visus hebetatur.
La traccia evidente dell'originale si ritrova, oltre che nell'andamento
paratattico e accumulativo del discorso, soprattutto nei ricorrenti latinismi:
“noticora” (nocticorax), “querendo 'l cibo, grida” (cibum querit et querendo
clamitat), “viso” (visus); ma l'intera descrizione segue scrupolosamente il
capitolo latino, contratto a volte in formule più icastiche come nell'antitesi di
luce e cecità dell'ultimo verso: “com' più risguarda 'l Sol più 'l viso
a‹cc›eca”, che introduce efficacemente la similitudine con l' “alma viziosa e
rea”.
In altri casi, invece, l'Ascolano operò un più o meno riuscito intervento di
taglio e di ricomposizione sul tessuto non di rado prolisso del trattato latino:
46
Erroneamente attribuito a Ugo di San Vittore; il testo è edito in PL 127, coll. 15-164.
Sull'attribuzione, cfr. Mc Culloch 1962, addenda p. 31.
47 Cfr. Introduzione a Brunetto, Tresor, p. XXVII. Lo studioso peraltro avverte che questo
bestiario “non basta a spiegare l'origine delle conoscenze del Latini”: certo, almeno per
alcuni capitoli, sembra si possano sostituire i numerosi rimandi di Carmody con il solo
riferimento all'enciclopedia di Bartolomeo.
48 Bart. Anglico, De propr. rerum, XII,287.
146
così, dovendo ricondurre il leopardo alla significazione dell'astuto e crudele
Tentatore, ritaglia solo poche indicazioni dal lungo capitolo di Bartolomeo
(III,XL,1-12):
Di leonessa liopardo nasce
e lo leone gia' con leoparda.
Nud'è di piatà quando se irasce;49
disdegna si non prende ‹in› quattro salti,
e per vergogna in terra si si guarda;
pensando sdegna delli vili asalti.
Enganna il lion nella sua caverna,
qual' ha due bocche et è in mezzo stretta:
così natura vuol che qui discerna.
Vedendo lo leon, prende a fuggire,
e lo leon lui consegue in fretta:
come tu sai, li convien morire.
Bartolomeo (XVIII,65, con omissione dei numerosi brani non ripresi da
Cecco):
Leopardus est bestia sevissima de leonis et pardi adulterio generata, ut dicit Isi(dorus)
li.xii. Nam ut dicit Pli(nius) leone cum parda aut pardo cum leena concubente [...].
Saliendo non currendo insequitur predam: et si in tertio saltu predam non rapit vel in
quartu, pre indignatione sistit et victus retrocedit; [...] unde timens leonem, facit foveam
subterraneam duplex orificium habentem, unum per quod intrat et aliud per quod exit.
Est autem fovea illa in utroque orificio valde ampla et in medio magis stricta. Veniente
itaque leone in foveam se mergit, quem persequens leo foveam cum impetu subintrat,
ubi triumphare putat de leopardo, sed propter magnitudinem corporis per medium fovee,
ubi strictior est, libere transire nequit, quem sciens leopardus ita in strictura impeditum,
illam foveam egreditur, et nunc in parte opposita foveam intrans, leonem a tergo
morsibus et unguibus aggreditur [...]. Leopardus quando egrotat sanguinem capre
agrestis bibit.
Della leggenda dell'astuta vittoria riportata sul leone, Cecco conosceva
forse anche la versione contenuta nella terza parte del Bestiario Toscano:50
ma se pure nell'Acerba si risente un'eco di quest'ultimo (“fugendole
dinanci”, “...è facta con due bocche tanto strecte...”, “cussì ingannandolo”),
49
Il testo di Crespi ha “capro si pasce”, notizia che trova un preciso riscontro in
Bartolomeo: “sanguinem capre agrestis bibit”. Quello del Rosario ha: “quando se pasce”.
50 Eccone il testo: “...lo suo ingengno vince e confunde lo leone in cotale mainera, che
fugendole dinanci per la sua leggereçça e schifando la sua potentia alla quale non potrebbe
resistere, conducendolo a la sua thana, la quale ingengnosamente è facta con due bocche
tanto strecte iscarsamente quant'elli tanto solamente possa esciere. Fugendo per quella tana
entro passa, però che puoe. Lo leone si li adiriçça diriecto, credendo passare e prenderlo, e
non può per la strecteçça del luogo né girare né volcere non può. Allora lu leopardo lo quale
è iscito per altra bocha, torna da la parte dirieto del leone, e cussì ingannandolo lo conquide
a morte” (Garver e McKenzie 1912, pp. 85-86).
147
la precisione della descrizione (“qual ha due bocche et è in mezzo stretta”)
presuppone nell'Ascolano la conoscenza diretta dell'originale (“in utroque
orificio valde ampla et in medio magis stricta”), frainteso dal
volgarizzamento toscano: “la quale ingegnosamente è facta con due bocche
tanto strecte iscarsamente quant'elli tanto solamente possa esciere”.51
Certo, non sarebbe difficile ricomporre il mosaico di notizie offerto dai
capitoli dell'Acerba attingendo ora al Fisiologo, ora a Brunetto, ora ad
Alberto Magno e agli altri testi addotti dagli interpreti: tutti attingevano a
loro volta ad un comune patrimonio naturalistico-simbolico. Ma in nessuno
di questi testi è possibile ritrovarle interamente e nell'ordine osservato da
Cecco, tranne che nel De rerum proprietatibus di Bartolomeo.52 Inoltre, nei
non rari casi di discordanza tra le varie fonti, la versione adottata dal poeta è
sempre quella di Bartolomeo, spesso in evidente contrasto con le altre.
Crespi, che sosteneva la derivazione dal De animalibus di Alberto, si è
trovato spesso nella necessità di attribuire alla “fantasia” o a clamorose
sviste di Cecco le divergenze che risultavano dai suoi raffronti. Così per il
capitolo sul grifone; Alberto, dopo aver descritto il misterioso animale
mezzo aquila e mezzo leone che abita nei monti iperborei ed è tanto robusto
da sollevare un cavallo col cavaliere in groppa, conclude:53
Dicunt autem in montibus illis esse aurum, et gemmas, et maxime smaragdos. Dicunt
etiam, quod si gryphes in nidis sunt, propter speciale iuvamentum ponunt achates
lapides
Cecco avrebbe confuso gli smeraldi con le agate e aggiunto un
riferimento ai serpenti velenosi, assente in Alberto (III,xx,1-6):
Lo grifone è assai forte ma pur teme
per molti animali che sono in monti,
che per lor corpo lo tossico freme.
Sempre nel nido lo smiraglio pone,
sicché non sieno li suo nervi punti:
per questa pietra fa defensione.
51
Camus (1909, p. 10) scrive: “Abbiamo qui un primo esempio dei miscugli in questione.
Scavarsi un tana non è proprio di un felino, ma della iena, e tutto ciò che abbiamo letto
dovrebbe figurare sotto la rubrica 'De la natura de la hiena', nel capitolo che segue quello
del leopardo nell'Acerba”. Ma neppure qui la confusione, se confusione c'è, è attribuibile a
Cecco.
52 Partendo dalle indicazioni contenute nella prima edizione del presente saggio (1974),
Costantini e Camuffo 1988 hanno mostrato come il De proprietatibus rerum di Bartolomeo
Anglico sia anche una delle principali fonti del lapidario che segue la sezione zoologica
dell'Acerba.
53 Alberto Magno, De animal., p. 638.
148
Ma basta leggere il succinto paragrafo di Bartolomeo de griphe per
scagionarlo completamente dall’accusa (XIII,19):
Griphes inter volatilia recitantur Deuteronomio xiiii. Et dicit ibi glosa: quod griphes est
quadrupes, capite et alis aquile similis et reliquo corpore similis est leoni et habitat in
hyperboreis montibus, equis et hominibus maxime infestus; in nido suo reponit lapidem
smaragdum contra venenosa animalia montis.
Da un’analoga svista nascerebbero due versi sulla cicogna (III,XI,7-8):
D’animali venenosi si nutrica
e lor veleno giamai no·ll’offende.
Nel De animalibus si legge infatti (p. 618):
Avis aquatica est plusquam terrestris, et piscibus pascitur, et lumbricis, et ranis, et
aliquibus non venenatis serpentibus: […] venenata vero, ut buffones, non comedit.
Ma anche in questo caso la diversa notizia è riportata dal De rerum
proprietatibus (XII,8):
Quamvis autem venenosa comedant […] venenum tamen naturam earum non superat
nec immutat.
Del resto l’intero capitolo sulla cicogna deriva puntualmente da
Bartolomeo: oltre a trarne la leggenda del suo amor filiale, che si legge
anche nel Fisiologo e in Alberto Magno, Cecco riferisce ulteriori notizie
assenti in questi ultimi testi e reperibili solo in pochissimi altri bestiari
medievali (III,XI,1-3):
Cicogna, quando ha ‘l mal, be·llo conosce,
che beve a forza dell’acqua marina,
così da lei fuggir fa l’angosce.
Ciconia vel ibis est avis fluvialis que seipsam purgat rostro suo; quia quando ex ciborum
multitudine sentit se gravatam aquam marinam intra rostrum recolligit quam per anum
ad interiora infundit; que remolliendo cibi compacti duriciam mordicando intestina
superflua ejicit et emittit.54
ibid., 4-6:
54
Qui effettivamente Cecco ha commesso un errore di interpretazione, facile a spiegarsi
con il ricorso alla fonte: egli ha tradotto con “beve a forza dell'acqua marina” il latino
“aquam marinam intra rostrum recolligit”, trascurando il resto della frase “quam per anum
ad interiora infundit”. Si può tuttavia pensare anche agli strani pudori del poeta, su cui si
veda Alessandrini 1955, p. 183.
149
Se mai in fallo truova suo compagna,
<l>a sdegna, e mai con lei non s’avicina:
sola pensando va per la campagna.
…femine fidem servat in qua si masculus aliquo casu adulterum concubitum persenserit,
ultra secum non coabitat, sed rostro si potest eam transverberat atque necat.
ibid., 9:
naturalmente le serpe nimica.
…serpentibus est inimica.
Castelli, senza alcun serio fondamento, affermò non soltanto che Cecco
d’Ascoli conoscesse di prima mano Platone, Aristotele, Euclide, Avicenna e
tutti gli altri autori citati nelle sue opere, ma “che egli abbia avuto altresì
piena conoscenza delle opere di Alberto Magno, da cui Dante attinse a larga
mano, dei [sic] Livres dou Tresor di Brunetto Latini, della Composizione del
mondo di Ristoro d’Arezzo, di tutte le moralisasiones [sic], dei lapidarii,
bestiarii, physiologi, dei trattati e delle enciclopedie più accreditate nelle
scuole d’allora, e del libro dottrinale più notevole del sec. XIII, lo Speculum
majus di Vincenzo di Beauvais”.55 Ma, per quanto i trattati latini e i capitoli
astrologici dell’Acerba presuppongano una cultura non superficiale, lo
studio del bestiario può far sorgere qualche dubbio sull’effettiva ampiezza
della erudizione di Cecco, e soprattutto sulla sua presunta “chiaroveggenza”
scientifica.56 Lo stesso raffronto tra il poema e il De animalibus di Alberto
Magno (che costituirebbe solo uno degli innumerevoli testi noti a Cecco!)
mostra come, se Alberto sottoponeva non di rado al vaglio della critica e
dell’osservazione sperimentale le “nature” tradizionali, l’Ascolano si
accontentasse invece di quanto trovava nell’enciclopedia di Bartolomeo o
nei pochi altri compendi da lui consultati. Dello struzzo aveva scritto
Alberto (p. 645):
De hac ave dicitur, quod ferrum comedat et digerat: sed ego non sum hoc expertus: quia
ferrum a me pluribus struthionibus obiectum comedere noluerunt.
Mentre il secondo non fa che ripetere la leggenda corrente (III,IX,1-3):
Astruzzo per la sua caliditate
en nut<ri>mento lo ferro converte,
non vola in aire per sua gravitate.
55
Castelli 1892, pp. 99-100.
Castelli (1892, p. 115) pretende ad esempio che Cecco sia stato il solo, nel suo tempo, “a
parlare del tuono in maniera da divinare quasi l'elettricità”.
56
150
Anche qui le sue parole riecheggiano chiaramente quelle di Bartolomeo
(XXX,33):
…sed propter ponderositatem sui corporis cum avibus in aera non levatur […] Tante
enim caliditatis est quod ferrum digerit et consumit.
Lo spazio dottrinale che separa Alberto Magno da Cecco può essere
misurato ancor meglio mettendo a confronto i rispettivi brani sulla
salamandra. L’immagine dell'Acerba (III,VII,1-2: “La salamandra, che nel
foco vive, / e l’altro cibo la sua vita sprezza, / non sono in lei potenzie
passive”) è modellata sulle stilizzazioni dei rimatori amorosi: “La
salamandra audivi, / che dentro al foco vive stando sana” (Giacomo da
Lentini), “La salamandra nello fuoco vive, / ed ogni altro animale ne
perisce” (Chiaro Davanzati).57 Alberto, invece, non soltanto critica l’antica
favola (“Multi autem sequentes Iorach Philosophum dicunt, quod hoc
animal vivit in igne: et hoc est falsum”), ma cerca di individuarne il
probabile fondamento scientifico (pp. 670-71): “Ciò è falso, se si eccettua
quanto dice Galeno nel Libro delle complessioni, e cioè che se la salamandra
resta nel fuoco per poco tempo, il fuoco non la attacca; ma se vi rimane a
lungo, il fuoco la brucia”.58
Così egli respinge la pretesa che la talpa si cibi di sola terra, il camaleonte
di sola aria ecc., secondo l’associazione di quattro animali agli elementi
della natura frequente nei bestiari medievali: è evidente che Cecco introduce
nel poema tale associazione non come una dottrina scientifica, ma come
semplice emblema di verità spirituali. In un solo caso il poeta ascolano si
consente, a sua volta, una critica nei confronti di quanto affermava
l’enciclopedia di Bartolomeo (e Alberto stesso riferisce credulo); si tratta del
capitolo sul pavone, di cui si legge nel De rerum proprietatibus (XIII,31):
…cuius caro est tam dura ut vix putredinem senseat nec facile coquitur
Cui Cecco ribatte (III,XXI,1-6):
Ciò che·si dice, dico, non è vero
che, morto, lo paon non si corrompa:
quel che già vidi tocca ‘l tuo pensiero.
Ben si conserva assai, ma non d’agosto
o quando ‘l Sol in Cancro mostra pompa:
di lui s’acorge ‘l naso e anche ‘l gusto.
57
Cfr. anche Menichetti 1965, Introd., pp. LVIII-LIX. Castelli 1892 (p. 129-130) sosteneva
una poco probabile origine popolare di questi versi dell'Acerba.
58 “…falsum nisi pro tanto sicut dicit Galen(us) in libro complexionum, quod videlicet
salamandra si in igne parvo tempore moretur, ignis impressionem non efficit in ea: sed si
diu moretur, adurit eam ignis”.
151
Un giudizio dunque, eccezionalmente nell’Acerba, fondato sull’osservazione sperimentale, per quanto elementare (“quel che già vidi…”, “di lui
s’acorge ‘l naso…”); ma forse la sua segreta ragione sta nell’allusione
astrologica, inutile e compiaciuta: “o quando ‘l Sol in Cancro mostra
pompa”. Ben nota è l’importanza dell’astronomia e dell’astrologia (cui è
interamente dedicato il primo libro dell’Acerba) nella cultura di Cecco,59 e
non è strano quindi che egli vi si riferisca di continuo anche trattando degli
animali, i cui occulti rapporti di simpatia e antipatia con gli astri venivano
indagati sin nelle più antiche tradizioni.60 Dall’enciclopedia di Bartolomeo
egli ne desunse numerosi esempi, come testimoniano tra gli altri i capitoli
sullo struzzo e sull’ostrica,61 ma in qualche caso tali riferimenti sembrano
introdotti nella materia zoologica dallo stesso poeta: l’intero paragrafo sullo
scorpione, del tutto estraneo alla tradizione dei “bestiari”, è stato aggiunto
da Cecco nella sezione dedicata ai rettili: “Quando la Luna inluma
Scarpione, / la prima faccia che figura scolpe / non può da scorpion aver
lesione” (III,XXXV,1-3).
Circa la possibile conoscenza da parte di Cecco di bestiari italiani,
Goldstaub e Wendriner si sono pronunciati negativamente scrivendo che
“non è possibile constatare un influsso dei nostri bestiari su Cecco”.62 Frizzi,
smentito poi da Bariola e da Lauchert, aveva dal canto suo affermato che le
notizie dell’Acerba sugli animali e sulle pietre preziose “sembrano attinte al
Tesoro di Brunetto Latini, seppure [Cecco] non ricorse direttamente alla
tradizione volgare, essendo allora quelle cognizioni abbastanza note e
comuni”:63 ad ogni modo, i brani che egli cita in appoggio alla sua tesi
(sull’aquila e sul pellicano) derivano chiaramente, specie il secondo, da
Bartolomeo Anglico.64 In realtà, per alcuni capitoli, Cecco utilizzò
59
Sulle numerose opere astrologiche di Cecco si vedano soprattutto Boffito 1898, 1903,
1905a, 1905b e Thorndike 1949 (Commento alla Sfera del Sacrobosco).
60 Se ne riconoscono ampie vestigia nel Fisiologo greco, poi passate nelle sue versioni
latine e romanze.
61 Dello struzzo, ad esempio, scrive l'Ascolano: “De giugno, quando vede quelle stelle /
lobatte in oriente bene aperte, / sotterra l'uova, scordasi di quelle” [III,IX,4-6]. E
Bartolomeo, nel capitolo De struthione: “Item quando venit tempus ut ova pariat, ad stellas
que vocantur virgilie sive pleiades oculos levat; non cum ova ponit nisi quando illa stellatio
oritur vel ascendit: cum enim viderit stellam circa mensem Iunii arenam fodit et ibi ponit
ova sua”.
62 Goldstaub e Wendriner 1892, p. 187 nota 2.
63 Frizzi 1877, p. 486.
64 L'Acerba: “Il policano col paterno amore / tornando al nido fatigando l'ale, / tenendo li
suo nati sempre al core, / vede<l>i uccisi dall'impio serpe / e tanto per amor de lor li 'incale
/ che lo suo lato fin al cor discerpe. // Piovendo 'l sangue sopra li suoi nati / dal cor, che
sente le gravose pene, / de mort<e> alla vita son tornati” [III,VI,1-9]. Bartolomeo, De propr.
rerum: “Hanc autem naturaliter odit serpens, propter quod serpens dum pro pastu mater exit
nidum repens per arborem pungit et interficit pullos suos super quos mater rediens lugere
152
effettivamente un bestiario italiano, e cioè la versione toscana del Tresor
falsamente attribuita a Bono Giamboni,65 della cui lettura recano traccia
numerosi passi del terzo libro dell’Acerba. Della iena per esempio si legge
(III,XLI,1-9):
Cava li morti della sepoltura
ienna, e contrafà l’umana boce
per devorar l’umana criatura.
Muta ‘l sexo, animal sodomito,
e quanto può a li can sempre nuoce,
<a la> sua voce onni animal sta quito.
Giase con leonessa, questa fera,
e nasce di costor animal feroce
che, chi la vede, di vita dispera.
La descrizione è in tutto aderente al De rerum proprietatibus66 (e non
mancano anzi riscontri letterali), ma la sua parentela con il corrispondente
passo del Tesoro italiano (più che con quello francese, che riportiamo tra
parentesi nei luoghi più significativi) è altrettanto indiscutibile (p. 253):67
Hyene è una bestia, che l’una volta è maschio e l’altra è femina, ed abita quivi ove abbia
presso cimitero di uomini morti, e cavano li corpi degli uomini, e mangianli (fr.: “et
mangue les cors des mors”). […] Ma li più dicono, ch’egli non ritorna quindi ond’egli è
entrato. Ed usano nelle case, ove son stalle, e contraffanno la boce dell’uomo, e del
cane, e divoranli (fr.: “et contrefait la vois as homes”) […] E sappiate che in Etiopia
giace questa bestia con la lionessa (fr.: “gist ceste beste avec la femele du lion”), ed
ingenera una bestia che ha nome cococie o ver corococte, che contraffà altresì la boce
dell’uomo (fr.: “ki autresi ansiut la vois des homes”).
Si direbbe che l’Ascolano avesse sott’occhio sia Bartolomeo sia la
versione toscana del Tresor. Nel capitolo sulla cicala, accanto alla diffusa
notizia del suo canto che neppure la morte interrompe e a quella delle strane
alchimie con cui è possibile ucciderla e resuscitarla, entrambe derivate
dall’enciclopedia latina, si leggono questi versi (III,XII,4-6):
Quant’è più pura l’aire, più risona
la voce sua, che fa tacer lo cucco
per tridum fertur, deinde in pectore se vulnerat et sanguinem super eos respergens eos a
morte suscitat” [XX,29]. runetto, Tresor: “Pelican est .i. oisel en Egypte, de cui li ancient
dient que leur faons fierent o les eles luer pere enmi le visage, por quoi il se corroucent en
tel maniere que il les occient. Et quant la mere les voit tuez, ele plore et fait grandisme dolor
.iii. jors; tant que en la fin ele naffre ses costez a son bec et fait le sanc espandre sur ses fiz,
tant que por ochoison dou sanc resordent et tornent en vie” (p. 150).
65 Cfr. Segre 1953, pp. 62-63.
66 Da cui deriva probabilmente anche il capitolo del Tresor.
67 Il testo del Tesoro è citato dall'edizione di L. Carrer indicata in bibliografia.
153
sicché suo tristo canto più non sona.
Essi riportano una “natura” descritta nel capitolo Del cuculo, e di sua
viltade, nel Tesoro italiano, di cui non è traccia né in Bartolomeo né nel
Tresor (II, p. 202):68
E sappiate che ‘l cuculo non canta di state, poi che le cicale cominciano loro canto, che
lo odiano molto, che quando le cicale l’odono cantare, incontanente vanno ov’egli è, ed
entrangli sotto l’ali, e non ha podere di levarlise da dosso, e tanto gli fanno noia,
mordendogli le sue carni, che non sta in luogo fermo, anzi va volando di uno arbore in
altro, e non becca mai, e sì si lascia morire. In questa maniera ha la cicala potere
d’uccidere il cuculo.
Un caso analogo, e per molti versi istruttivo, è quello della graziosa
descrizione della tortora (III,XXIII,1-6):
La tortora, per sé sola piangendo,
vedova di compagna, in secco legno,
el luoco più deserto va querendo;
non s’acompagna mai poi che·la perde;
de bevar acqua chiara si desdegna,
né mai <non> sta, né canta in ramo verde.
Castelli la pretese imitata da un canto popolare, raccolto ad Ascoli: in
realtà, se essa manca o è molto ridotta nel De rerum proprietatibus, la si può
leggere in numerosi bestiari italiani del XIII secolo, e in particolare nella
versione toscana del Tresor (p. 197): “…e quando non lo possono trovare,
ché è perduto, allora osserva castitade e più non bee in acqua chiara, e non si
posa mai in alcun ramo verde, anzi sempre in secco”. Bisogna ancora
aggiungere che questa “natura” risale almeno alla redazione bizantina del
Fisiologo: “E se mai succede che uno dei due muoia, non si unisce più in
seconde nozze, ma geme per il rimanente della sua vita; infatti non si posa
più in albero dal fogliame ombroso perché non sia rigoglioso il suo cuore, né
beve acqua pura per non alimentare amore nel suo cuore, ma intorbida
l’acqua con le ali, e la beve al fine di condurre la vita nella saggezza”.69
*
* *
68
Nell'Acerba sono facilmente riscontrabili anche altre tracce della lettura del Tesoro. I
versi di Cecco sulla scimmia: “Forte s'allegra, nella Luna nuova, / la simia, e, quando è
mezza, s'atrista / che par che sopra lei pensier piova” [III,XLVI,1-3] riecheggiano per la
prima parte quasi alla lettera il Tesoro: “...e molto s'allegra della luna nuova, e della tonda
si conturba maravigliosamente” (p. 262), mentre nella seconda ricordano più da vicino
Bartolomeo: “nova luna exultant, media et cava tristantur” [XVIII,94]. Cfr. anche il
capitolo sullo struzzo.
69 Fisiologo, p. 218 (e cfr. le note). La traduzione è nostra.
154
La presente rassegna delle fonti del bestiario cecchiano, per quanto
incompleta,70 permette non solo di individuare con sicurezza alcune delle
letture che hanno ispirato l’Acerba, ma anche, e soprattutto, di correggere
alcune interpretazioni correnti del poema, o almeno di una sua parte: poco
interessato alle questioni scientifiche come alle tradizioni popolari, Cecco
d’Ascoli utilizzò le nozioni di zoologia che gli offrivano le enciclopedie più
consultate del tempo, come un repertorio di emblemi o di simboli. E se il
commento di Crespi al bestiario dell’Acerba appare ormai del tutto
inservibile, saranno anche da rivedere le interpretazioni che prestano a
Cecco una cultura e delle intenzioni che egli non aveva. A tale scopo,
occorre considerare anche la “cornice” entro cui il “libro delle bestie” si
colloca: esso è infatti introdotto da un capitolo sulla donna e sulla natura
dell’amore. L’accostamento, tutt’altro che insolito nelle letterature
medievali, è stato da taluni interpretato come un’esplicita assimilazione
dell’amore ai “moti e alle funzioni animali”. Scrive Castelli: “Terminato il
libro secondo, ch’è un trattato delle virtù, comincia il libro terzo, ch’è degli
animali, col capitolo sull’amore, e in tal modo riconduce la questione ne’
suoi veri confini, in quelli cioè della storia naturale, che comprende pure
l’astrologia e la fisiologia”.71 Certo, è vero che tutta la prima parte del
capitolo consiste in una disquisizione sugli influssi astrali e sulle
determinazioni fisiche dell’amore,72 e che Cecco avverte di non voler
“trattar d’amore divino”; ma l’avvertenza non deve intendersi valida oltre il
luogo cui si riferisce, poiché il seguito del testo, in cui s’innesta il bestiario,
ha una natura completamente diversa. Vi si parla infatti di una passione
spirituale del poeta che non ha più nulla a che vedere con il fuoco dei sensi
(III,I,109-12 e 115-20):
Chi che non segue la carnal salute
e sguarda donna come Sol in fango,
discaccia d’ogni vizio servitute
e vede la certezza dello bene.
[. . . ]
Amor dell’atto quanto è più lontano
tanto è più possente ‘l dolce foco
che tien gioioso sempre il cor umano.
Ardendo il fa la vita il ben sentire
70
Le “nature” della “lumerpa”, dell'uranoscopo, dello stellino e poche altre non sono
presenti né in Bartolomeo né nel Tesoro: si potrebbe risalire ad Alberto Magno (per la
“lumerpa”), Plinio (per l'uranoscopo) ecc., ma è più probabile che anche in questi casi
Cecco si sia servito di qualche compilazione zoologica del suo tempo.
71 Castelli 1892, p. 106.
72 Dalla quale si sviluppa la polemica con Dante sull'immutabilità dell'amore nato negli
amanti “per consimil stella” [III,I,61-72].
155
donna mirando nel beato loco
che pace con dolcezza par che spire.
Questa donna che dà beatitudine, nemica delle genti oscure che la “vista
carnal<e> vanno pur cherendo”, cioè di coloro che non sanno elevarsi dalle
cose materiali alle celesti, è divenuta senza dubbio una Donna simbolica,
proiettata nel “beato loco” di una dimora superiore. Nel capitolo seguente,
con cui esordisce il “bestiario” e in cui essa viene paragonata alla fenice e ad
altri uccelli, Cecco è ancor più esplicito: la definisce l’”alma bella”
“tra<scesa> al mondo per salute umana” (v. 8), la “fontana” di grazia (v. 11)
per coloro che ne sono degni, colei che “morse […] col disio soverchio”
(corrispondente all’excessus mentis dei mistici), la “luce” del poeta (vv. 1415), cioè “quella parte dell’anima che è luce della Sapienza che vuole
ricongiungersi a lei”.73 Per quanto nel mondo appaia rivestita di figura
umana, essa “fu nanti ‘l tempo e nanti ‘l cel” (v. 22), e - come egli spiega “fa beata nostra umanitade / seguendo ‘l ben che per lei s’acquista” (vv. 2324). I mirabili versi con cui si era concluso il primo capitolo sono
particolarmente eloquenti (III,I,133-40):
Io so’ dal terzo celo trasformato
in questa donna, ch’i’ non so’ chi fui,
per cui me sento ognora più beato.
Da lei comprese forma il mio intelletto,
mostrandome salute gli occhi suoi
mirando la virtù del suo cospetto.
Dunqua, io so’ ella, e se da me se sgombra,
allor di morte sentiraggio l’ombra.
Non si tratta evidentemente dell’”anima gemella”, come annota
candidamente Castelli: qui il linguaggio di Cecco è ben diverso da quello
del lamento amoroso che si legge nel IV libro dell’Acerba (III,103-110) e di
cui forse si ricorderà il Petrarca (“Oimè quegli occhi da cui son lontano, /
[…] / <oimè> la dolce fe’ di quella mano…”), come pure dalla violenta
invettiva contro le donne (IV,XI,115-28), paragonate al “veleno”, alla “porta
infernale” ecc. Del resto, la distinzione è chiaramente operata dallo stesso
poeta nei versi precedenti all’invectiva (IV,XI,106-10):
Mai non fu in donna virtude perfetta,
salvo <in> Colei che inanzi al cominciare
creata fu et in eterno eletta.
Rade fiate, come disse Danti,
s’entende sottil cosa sotto benna.
73
Valli 1928, p. 252.
156
Cecco si riferisce dunque in modo esplicito al linguaggio simbolico
comune anche alla poesia amorosa di Dante. Alcuni esegeti, come
Lauchert,74 hanno voluto interpretare la misteriosa Donna come un emblema
della Virtù. Ma l’angelica creatura descritta nell’Acerba non sembra davvero
riducibile a una personificazione morale. È evidente che qui è rappresentata
la Sapienza celeste, madonna Intelligenza, l’icona femminile dei “Fedeli
d’Amore” cristiani e islamici.75 Il miglior commento a questi versi di Cecco
potrebbero essere le parole con cui Henry Corbin riassume la dottrina
dell’amore divino in Ibn ‘Arabî: “Di una vera potenza spirituale è investita
l’Immagine umana la cui bellezza manifesta sotto forma sensibile Dio [dice
Cecco: “Quest’è la donna qual mai non coverse / spera dell’umana
qualitade, / avegna che nel mondo qui co<n>verse”], Bellezza che è
l’attributo divino per eccellenza, e poiché il suo potere è un potere spirituale
[Cecco: “La guida delli celi la conduce”, “fa beato l’omo”], è una potenza
creatrice. Essa crea l’amore nell’uomo [Cecco: “Da questa vien la dolce
luce / che luma l’alma de desio d’amore”], desta in lui la nostalgia che lo
conduce oltre la propria apparenza sensibile [Cecco: “Tolle la viltà di questa
vita / al tristo amor che commete offes<a> / amando più che <Deo> cosa
nutrita”, cioè la creatura più del Creatore], e che sollecitando la sua
Immaginazione attiva [Cecco: “Allora cresce lo ‘ntelletto agente / mirando
di bellezza la <salute>”] a produrre per essa quello che i nostri trovatori
chiamavano “amore celeste” (l’amore spirituale di Ibn ‘Arabi), lo porta alla
conoscenza di sé, cioè alla conoscenza del suo signore divino [“…fa volar la
mente nostra accesa / nel gran disio dello ben divino”]”.76 E proprio alla
poesia sufica fanno pensare alcune espressioni dell’Acerba di cui è difficile
trovare l’equivalente perfino negli stilnovisti, come la formula: “Dunqua, io
so’ ella”, che rinvia alle dottrine dell’unio mystica in Al Hallâj: “Io sono
colui che ama, e colui che io amo è me. Siamo due spiriti che abbiam preso
albergo in un sol corpo”,77 o in Rûmî: “Due figure, due forme ma un'anima
sola, tu e io”, “Tu e io senza più tu né io ci uniremo nell’estasi”.78 Luigi
74
Cfr. Lauchert 1890, p. 8.
Così aveva interpretato anche Valli 1928 (p. 254): “...qui si parla della santa e divina
Sapienza, che al solito è la perfetta delle donne, che fa tornare da morte a vita, che dà tutte
le virtù a chi la segue e lascia gli altri nella 'morte' e per la quale Cecco d'Ascoli dice di
ardere d'amore, confessando poi che è la donna di tutti i buoni, la Sapienza nella quale
come presso tutti i 'fedeli d'amore' la Intelligenza attiva della filosofia pagana si è fusa con
la Rivelazione cristiana divenendo mistica Sapienza” (i corsivi sono dell'autore). Lo stesso
Crespi 1929 (p. 308) scrive: “Così la dottrina d'amore di Cecco d'Ascoli si confonde con la
tradizione antichissima della Sarasvati indiana, la parola, il verbo, la verità divina”.
76 Corbin 1958, pp. 124-125. I brani dell'Acerba citati sono i seguenti: III,II,19-21; III,II,43;
III,III,38; III,IV,7-8; III,V,16-18; III.III,23-24; III,V,14-15.
77 Moreno 1951, p. 137. Cfr. anche Massignon 1931, M. 10, 15, 16.
78 Bausani 1994, p. 138; cfr. Nicholson 1956, p. 35.
75
157
Valli ricorda a tale proposito la figura “moglier e marito” di Francesco da
Barberino, immagine alchimistica della coniunctio sive coitus, e un passo di
Averroè: “la massima beatitudine dell’animo umano è nella sua suprema
ascensione. E dicendo ascensione intendo il suo perfezionarsi e nobilitarsi in
modo che si congiunga con la intelligenza attiva e siffattamente uniscasi a
quella che diventi uno con essa”.79
Il bestiario dell'Acerba - e in modo particolare la sezione iniziale dedicata
gli uccelli, simboli universali delle creature angeliche - si dispiega come un
manto intessuto degli emblemi appartenenti alla Donna celeste. Attraverso
le figure multiformi degli esseri alati traspare nitidamente quest’unica
figura, i cui attributi misteriosamente si riflettono nelle “nature” della fenice
o dell’aquila o della cicogna. La simbolica provenienza orientale della
Sophia (cui alludono per esempio anche le vesti lavorate “a la nobele guisa
di Suria” o il lapidario orientale dell’Intelligenza) è indicata sia nella
descrizione della fenice (“morendo nasce […] / in quelle parti calde
d’oriente”),80 sia in quella della “lumerpa” (“Inelle parti d’Asia maggiore /
lumerpa nasce…”, III,IV,1-2). Così il canto innalzato dai volatili diventa un
simbolo del linguaggio immateriale e angelico dell’Ispiratrice, quello che il
Corano (XXVII,15) chiama appunto “linguaggio degli uccelli” (III,X,1-2):
El cigno è bianco, sanz’alcuna macchia,
e dolcemente canta nel morire…
II,XII,1:
Canta la cicala per l’ardente Sole…
III,XXV,1-2:
Canta sì dolcemente la serena
che, chi l’atende, dolce fa dormire…
Un altro schema ricorrente nel testo è quello della contrapposizione fra
un determinato uccello, che simboleggia la Donna oppure l’anima che la
“porta” in sé, e il serpente, immagine tradizionale del demonio: i figli del
pellicano vengono uccisi dal serpente e poi risuscitati dal sangue della
madre, la cicogna “d’animali venenosi si nutrica / e lor veleno giamai
no·ll’offende” (III,XI,7-9), l’avvoltoio “da velenosi animali fa l’uom securo;
/ ardendo le sue penne, li serpenti / fugono tutti” (III,XVIII,7-9), il grifone
teme “per molti animali che sono in monti, / che per lor corpo lo tossico
79
Valli 1928, p. 252.
La provenienza orientale è uno dei dati fondamentali nel mito della fenice: cfr. qui, cap.
X, “Il mito della fenice nel medioevo romanzo”, pp. 180-188.
80
158
freme” (III,XX,2-3), e così via. La contrapposizione fra uccello e serpente è
uno dei fondamentali geroglifici sacri, riscontrabile nelle tradizioni
occidentali come in quelle orientali; Guénon scrive che essa rappresenta “la
lotta degli angeli contro i demòni, delle potenze celesti contro le potenze
infernali, cioè l'opposizione tra gli stati superiori e gli stati inferiori”: nella
tradizione indù la incarna il combattimento fra il Nâga (serpente) e il
Garuda: “il Garuda è l'aquila, e, altrove, è sostituito da altri uccelli come
81
l'ibis, la cicogna, l'airone, tutti nemici e distruttori dei rettili”. Si può forse
scorgere in questi passi un esempio di quegli “aspetti dualistici e
oscuramente demonici” osservati da qualche interprete in numerosi passi
dell’opera di Cecco.82
Se i versi dedicati all’Ispiratrice divina, misterioso centro dell’Acerba,
mostrano la precisa traccia di conoscenze esoteriche, la maggior parte del
terzo libro si configura invece come un tradizionale bestiario (e lapidario)
moralizzato.83 Nelle sezioni dedicate agli animali acquatici e terrestri non si
parla più della celeste Sapienza, ma della semplice Virtù, che incomincia a
sostituirsi a “costei” fin dagli ultimi capitoli sugli uccelli: “L’uom ch’è
prode figliuol di vertu<t>e / più fa col core che non fa con la bocca…”
84
(III,XIX,13-4). La provenienza enciclopedica di quasi tutto il “materiale”
zoologico che vi è contenuto testimonia comunque del suo carattere ancora
simbolico, o più propriamente allegorico. Nell’enciclopedia il mondo “non è
che un’immensa esemplificazione” delle verità spirituali o morali, “e la
scienza universale – o enciclopedia – che lo indaga e rappresenta, viene ad
essere una grande moralisatio scientifica insieme e religiosa. Anzi in questa
enciclopedia moralizzata la scienza non è più fine a se stessa, ma deve
servire ed è subordinata di continuo ad un’altra scienza superiore, la
teologia”.85 Lo dimostra anche la presenza, in gran parte dei manoscritti più
antichi del De rerum proprietatibus, di glosse marginali che illustrano il
senso allegorico delle notizie riportate e che risalgono con ogni probabilità
allo stesso autore.86 Nel proemio, del resto, egli aveva scritto (e le parole
non hanno, come vorrebbe il Cian, “un significato puramente generico”):
“Quest'opera riuscirà utile a me e forse ad altri che non conoscono le nature
e proprietà delle cose disseminate nei libri dei santi e dei filosofi, al fine di
comprendere gli enigmi delle Scritture (ad intelligenda enigmata
81
Guénon 1978, p. 57.
Cfr. Mazzantini 1929, p. 147.
83 Sul lapidario dell'Acerba, si vedano Battelli 1927 e Costantini e Camuffo 1988.
82
84
Si veda però la recente interpretazione di Claudio Ciociola, il quale ritiene che i deittici
presenti nel testo (“questa”, “questa donna” ecc.) si riferiscano alle illustrazioni delle
diverse virtù che Cecco aveva previsto di inserire e che non furono poi realizzate nei
testimoni superstiti (cfr. Ciociola 1992, pp. 22-24).
85 Cian 1902, p. 56.
86 Cfr. Meyer 1988 e Van den Abeele 1999, p. 126.
159
scripturarum), che sono state trasmesse e velate dallo Spirito Santo sotto i
simboli e le figure delle realtà naturali e artificiali (sub simbolis et figuris
proprietatum rerum naturalium et artificialium), come mostra il beato
87
Dionigi nella Gerarchia angelica”.
Dinanzi ad un universo divenuto nella Scrittura e nel sapere del
medioevo semplice riflesso delle verità eterne, si trattava quindi di costituire
un organismo coerente di nozioni che fosse in grado di interpretarlo secondo
i suoi sensi superiori. Rimane sempre sottinteso, anche se Bartolomeo o altri
non lo dicono espressamente, che la “natura” dell’unicorno - per citare solo
un esempio - serve a spiegare lo “et exaltabitur sicut unicornis cornu meum”
del Salmo. D’altronde, molti dei miti e delle leggende che si tramandavano
intorno agli animali come verità scientifiche non erano che sacri emblemi
dell’antichità: ne aveva coscienza Alberto Magno, il quale distingue
chiaramente in vari passi del De animalibus le nozioni comprovate
dall’indagine naturalistica dai geroglifici appartenenti alle dottrine
88
teologiche, all’alchimia ecc. Al termine del capitolo sul basilisco egli
scrive (p. 667): “Quanto insegna Ermete, cioè che il basilisco genera in
vitro, non lo intende del basilisco reale, ma di un elisir alchemico con il
quale si trasmutano i metalli”.89 Altrove, dopo aver narrato con ricchezza di
particolari la leggenda della fenice, egli mostra di non essere all'oscuro della
sua origine esoterica concludendo (p. 638): “Come dice Platone, noi non
dobbiamo criticare le cose che vengono tramandate nei libri dei sacri
templi”.90
Andranno quindi radicalmente corrette, e non solo per quanto riguarda il
bestiario, alcune recenti interpretazioni del poema, come quella di Achille
Tartaro, il quale scrive che “documento della crisi, L’Acerba ci scopre in
particolare l’avvenuta dissoluzione dell’aspirazione di totalità che aveva
animato sul piano concettuale come su quello delle strutture letterarie il
messaggio di Dante”, e che la visione teologica unitaria del fiorentino “cede
alla settorialità scientifica di Cecco”.91 In realtà, la configurazione
enciclopedica dell’Acerba non comporta, almeno in linea di principio,
alcuna “settorialità scientifica” intesa in senso moderno. Il Tartaro è qui
forse ancora condizionato dall’immagine ottocentesca, quale risulta
87
Cfr. Cian 1902, p. 56. Questi princìpi erano stati formulati da sant'Agostino nel De
doctrina christiana, cfr. qui cap. II, “Teologia del bestiario”, pp. 24-25.
88
Cfr. in proposito, qui, II, “Teologia del bestiario”, pp. 37-38.
89
“…et quod Hermes docet basiliscum generare in vitro, non intelligit de vero basilisco,
sed de quodam elixir alchimico quo metalla convertuntur”.
90
“…et sicut dicit Plato, non sunt a nobis calumnianda quae libris sacrorum delubrorum
conscripta referuntur”.
91
Tartaro 1971, p. 484.
160
soprattutto dal libro di Castelli e persiste nel commento di Crespi, di un
Cecco d’Ascoli anticipatore della scienza sperimentale e ricco di intuizioni
precorritrici. Il superamento di tale immagine,92 cui necessariamente
conduce lo studio delle fonti culturali di Cecco, dovrebbe portare
innanzitutto ad una correzione del suo rapporto con Dante: rapporto che non
sarà più da porre nei termini di una contrapposizione tra cultura simbolicoteologica (nell’Alighieri) e cultura materialistica, scientifica, settoriale
(nell'Ascolano). Le ragioni del contrasto, espresso apertamente
nell’Acerba,93 andranno cercate a un altro livello. Nel suo complesso, il
poema appartiene ancora alla letteratura degli specula e delle compilazioni
moralizzate, e non si discosta molto, nonostante tutto, dai canoni
compositivi del Tresor di Brunetto Latini: si potrebbe parlare, in
contrapposizione alla “scienza sacra” su cui è rigorosamente fondato il
simbolismo della Commedia, di una “scienza moralizzata”, i cui originari
fondamenti simbolici sono stati obliati (come nelle sezioni astrologiche,
magiche ecc.) oppure ridotti a significazioni superficiali, generalmente di
carattere morale (come nella maggior parte del bestiario).
Lo stesso episodio della Donna-Intelligenza, sul piano delle strutture
propriamente letterarie e stilistiche, conferma tale atteggiamento in qualche
modo “reazionario”. Esso si configura infatti come una tipica canzone
cortese prestilnovistica - alla Rigaut de Berbezilh o alla Inghilfredi, per
intenderci - in cui il ragionamento d'amore si esprime attraverso una
concatenazione di metafore zoologiche (o anche “lapidarie”, “erbarie” ecc.):
il procedimento stilistico è quello tradotto in “genere” dal Bestiaire
d’Amours di Richard de Fournival, ossia l’adattamento della materia dei
repertori moralizzati alla casistica amorosa. L’archetipo culturale è evidente
nell’Acerba come nell’esempio estremo di questa poesia emblematica, il
Mare amoroso: e lo stesso Tartaro non ha mancato di osservare come “il
fondamentale criterio giustappositivo” del “bestiario” cecchiano sia
“mutuato dalle compilazioni enciclopediche e lasciato penetrare nella
tessitura sintattica del dettato”.94 Del resto, se il termine di Mare evoca, tra
gli altri,95 il significato di compendio, miscellanea e simili, il titolo
dell’Acerba, secondo alcune recenti interpretazioni,96 deriverebbe da
acervus (mucchio, coacervo) nell’identica accezione. Gli stilnovisti, nel
respingere queste forme letterarie, coerentemente rifiutarono anche la
92
Che Rossi 1903 aveva già intrapreso, recensendo il libro di Castelli.
Tuttavia la questione dell'autenticità del famoso attacco contro Dante del I libro (il passo
è assente in una parte autorevole della tradizione manoscritta del poema, fra cui l'Eugubino
edito da Censori e Vittori) potrà essere affrontata solo nel quadro di uno studio complessivo
della tradizione.
94 Tartaro 1971, p. 484.
95 Per cui cfr. soprattutto Coomaraswamy 1973.
96 Cfr. Petrocchi 1965, p. 594.
93
161
cultura che ne stava alla base (o viceversa): in Guinizzelli, Cavalcanti o
Dante non vi è quasi più alcun esempio delle metafore animali e minerali
tanto frequenti in un Chiaro Davanzati. Non a torto, quindi, si è parlato per
Cecco di “antistilnovismo”,97 ma, anziché riferire il termine alla sola
invettiva contro le donne, si dovrebbe estenderlo al complessivo
atteggiamento culturale del poeta; al pari dell’autore dell’Intelligenza, che
illustrò le qualità della sua divina Ispiratrice per mezzo del “lapidario di
Evax”, l’Ascolano ricorse alle meccaniche accumulazioni del Mare amoroso
e della lirica siciliana. È vero che nell’Acerba non si tratta più di una donna
o di una passione terrestre - né vi mancano echi del linguaggio stilnovistico
- ma è proprio la letteratura enciclopedica ad offrire esempi di questa
reinterpretazione spirituale del bestiario: oltre al De avibus dello pseudo98
Ugo di San Vittore, che descrive le tappe della vita mistica, si può pensare
al Poème moralisé sur les propriétés des choses parzialmente edito da
Raynaud,99 in cui gli animali e le altre creature del mondo divengono figure
della Vergine Maria.
Dopo l’Acerba e l’Intelligenza, la cultura enciclopedica che le ispirava
sarebbe quasi interamente scomparsa dalla nostra letteratura maggiore (a
meno di non comparirvi in forma caricaturale come nel Morgante del Pulci
o nel curioso Bestiario di Leonardo),100 per rifugiarsi nelle raccolte di
emblemi e di geroglifici dell’età rinascimentale. Ma già nei versi
dell’Ascolano si respira un’atmosfera “anacronistica” e quasi pietrificata che
a volte possiede un fascino misterioso. Si riconoscono qua e là mirabili
figure e frammenti perfetti, come i pochi capitoli sull’Intelligenza attiva: ma
queste gemme poetiche sono disperse nei morti cataloghi di un sapere ormai
dimenticato. “Il simbolo resta, ma, quando lo ‘spirito’ si è ritirato, è ormai
soltanto una forma vuota”, ha scritto Guénon a proposito dei residui
occidentali della consocenza sacra: è quanto si può dire dell’Acerba, che
vale forse di più per ciò che nasconde che per ciò che rivela.
97
Cfr. Tartaro 1971, p. 482 nota.
98
Sul quale si veda, qui, il cap. VI, “Pictura e scriptura. La simbologia della colomba nel
De avibus di Ugno di Fouilloy”.
99 Cfr. Raynaud 1885.
100 Una delle cui fonti principali è poi la sezione zoologica dell'Acerba: cfr. Alessandrini
1955, pp. 147-156 (“Cecco e Leonardo”).
162
3.
Francesco Zambon
Il mito della fenice nella poesia romanza del medioevo
Simile al fantastico uccello che rinasce periodicamente dalle proprie
ceneri, il mito della fenice è una storia di successive risorgenze: pur
conservando quasi inalterati i suoi dati essenziali (morte e resurrezione,
unicità, rapporto con il sole), tale mito si adattò via via a diversi climi storici
e culturali incarnando nuovi temi religiosi, scientifici o filosofico-letterari.
Malgrado le trasformazioni subite, il mito feniceo può forse gettare un ponte
fra concezioni lontanissime nel tempo e nello spazio, ma tutte incentrate
intorno a un nucleo profondo: il nesso misterioso e necessario fra morte e
nascita, inizio e fine, creazione e distruzione. Simone Weil ha più volte
sottolineato il rapporto fra la vicenda di Osiride e quella di Cristo; nella
Lettre à un religieux essa scrive: “Se Osiride non è un uomo vissuto sulla
terra pur essendo Dio, al pari di Cristo, quantomeno la storia di Osiride è
una profezia infinitamente più chiara, più completa e più vicina alla verità di
tutto ciò che è chiamato con questo nome nell'Antico Testamento”.101
Simone Weil probabilmente non lo sapeva, ma il mito primitivo della fenice
si costituì in Egitto proprio in stretta relazione con la figura di Osiride originariamente dio della terra egiziana e della sua vegetazione - per essere
poi riferito, in epoca cristiana, alla morte e alla resurrezione di Cristo. A
queste fasi antiche della sua storia - dalla mitologia egiziana alla tarda
antichità pagana e cristiana - sono state dedicate approfondite indagini, fra le
quali i due dottissimi libri di Hubaux e Leroy102 e di Van den Broek;103
meno studiata è invece la sua storia ulteriore, che presenta tuttavia episodi di
grande rilievo specialmente nella lirica medioevale e barocca, oltre che nella
simbologia ermetica. La sua ripresa da parte di alcuni poeti romanzi - e
soprattutto italiani - fra il XII e il XIV secolo si configura come un nuovo e
coerente adattamento del mito, che assurge a cifra di una inedita dottrina
amorosa incentrata sul tema della morte / rinascita della Donna.
Il carattere principale della fenice nel mito antico - che ha molti punti di
contatto con quello del benu egiziano, anche se forse non ne deriva
101
Weil 1974, p. 22.
102
Hubaux e Leroy 1939.
103
Van den Broek 1972.
163
direttamente - è quello di essere un uccello solare: animale sacrum Soli lo
definiscono Manilio104 e Tacito,105 mentre Orapollo afferma
categoricamente che “la fenice è simbolo del sole”.106 Tale carattere risulta
già dal suo aspetto fisico, quale si trova descritto nella maggior parte delle
fonti: secondo Achille Tazio, che riassume nel romanzo Leucippe e
Clitofonte (II secolo d.C.) i dati tradizionali, le sue ali sono un misto di oro e
di porpora, e il suo capo è circondato da una raggiera di penne - quasi una
corona - che simboleggia appunto il sole.107 Inoltre, in molte versioni il suo
incendio rinnovatore ha luogo nella città di Eliopoli, centro del culto solare
egizio. Come ha mostrato Marcel Detienne,108 questi dati trovano conferma
anche nella sua stretta affinità e quasi “consustanzialità” con gli aromi di
natura ignea - in particolare il cinnamomo, la mirra, l'incenso - di cui essa si
serve per costruirsi il rogo. La natura solare della fenice diventa del tutto
esplicita nelle descrizioni che la mettono in rapporto con il ciclo giornaliero
o annuale del sole. In un apocrifo veterotestamentario del II secolo dopo
Cristo, la Apocalisse greca dello pseudo-Baruc, il profeta assiste al levarsi
del sole preceduto sull'orizzonte dalla fenice, che accompagna l'astro - cinto
di una corona d'oro - lungo tutto il suo percorso diurno formando uno
schermo ai suoi raggi perché non brucino gli esseri viventi sulla terra;
l'uccello-satellite riappare, stremato dal calore che ha dovuto filtrare per
tutto il giorno, all'ora del crepuscolo, allorché gli angeli tolgono al sole la
sua corona per rinnovarla. Questo testo, insieme ad altre fonti,109 ha indotto
qualche studioso a pensare che la fenice possa essere stata in principio la
personificazione mitica del pianeta Venere, Phôsphóros o Lucifer il mattino
e Hésperos o Vesper la sera; come hanno osservato Hubaux e Leroy, “il
mito della fenice, che attribuisce tanta importanza al concetto di identità,
interpreterebbe poeticamente una scoperta astronomica che sembra essere
stata fatta in tempi antichissimi ed era degna di ispirare meditazioni ai
mitografi come agli astrologi: quella che la stella del mattino è lo stesso
astro che la stella della sera”.110 Assai più frequente è tuttavia l'associazione
del mitico uccello a un lungo ciclo di anni, sulla cui durata peraltro le fonti
divergono: per alcuni è di 500 o 540 anni, per altri di 1000, per altri ancora
104
Cfr. Plinio, Nat. hist., X,4.
105
Tacito, Annales., VI,28.
106
Orapollo, Hierogl.., I,34. Sul carattere solare della fenice, si veda Van den Broek, pp.
233 sgg.
107
Leucippe e Clitofonte, III,25.
108
Cfr. Detienne 1975, p. 33.
109
Una descrizione analoga si trova per esempio nel cosiddetto Fisiologo di Vienna; se ne
veda il testo in Hubaux e Leroy 1939, pp. XXXIV-XXXVI. Sulla fenice come scorta del
sole, cfr. Van den Broek 1972, pp. 261-304.
110
Hubaux e Leroy 1939, p. 4.
164
né più né meno di 1461. Quest'ultima cifra, fornita da Tacito,111 è quella che
definisce la durata del cosiddetto periodo sothiaco, cioè il numero di anni
dopo il quale - il 15 giugno, giorno della piena del Nilo e inizio dell'anno
secondo il calendario civile egiziano - il sole sorge insieme alla stella più
luminosa del cielo, Sothis o Sirio: poiché la rivoluzione di Sirio dura 365
anni e un quarto, ciò avviene ogni 365 anni e un quarto x 4, cioè ogni 1461
anni. Più difficile è dare un'interpretazione delle altre cifre, che comunque
stanno in vario modo a indicare il Grande Anno, cioè il ciclo al termine del
quale - secondo la cosmologia classica - il sole, la luna, i pianeti e le stelle
fisse completano la loro corsa e ritornano alla posizione di partenza:
Manilio, citato da Plinio, fa del resto coincidere espressamente la vita della
fenice con la durata del Grande Anno.112 In ogni caso, essa è il simbolo
dell'apokatástasis, del periodico rinnovamento dell'universo che segue la sua
distruzione alla fine di ogni ciclo e dà inizio a una nuova età dell'oro; ne era
ancora consapevole Orapollo: “Quando [gli Egiziani] vogliono
simboleggiare il grande rinnovamento ciclico degli astri raffigurano la
fenice; alla sua nascita, infatti, ha luogo un rinnovamento delle cose”.113
Tale rinnovamento cosmico, dopo un Grande Anno o una sua porzione, è
raffigurato dalla caratteristica fondamentale che gli scrittori antichi
attribuiscono concordemente alla fenice: quella di morire e di rinascere
periodicamente. Esistono però versioni discordanti del mito, riconducibili a
due modelli fondamentali.114 Il primo, meno diffuso, è inaugurato dalla più
antica descrizione che ci sia pervenuta del fantastico uccello, quella fornita
da Erodoto - il quale peraltro non nasconde i propri dubbi circa la veridicità
di quanto riferisce - nel II libro delle Storie: “C'è - scrive - un altro uccello
sacro in Egitto, che si chiama fenice. Io non l'ho visto se non dipinto: infatti
esso appare in Egitto molto raramente; a quanto dicono gli Eliopolitani, ogni
cinquecento anni, quando gli muore il padre [...]. Dicono cioè che, partita
dall'Arabia, [la fenice] trasporta il corpo del proprio padre nel tempio del
Sole, avvolto nella mirra, e qui lo seppellisce. E lo trasporterebbe in questo
modo: prima fa con la mirra un grosso uovo e vi introduce il padre, poi con
altra mirra tappa il buco fatto nell'uovo, in modo che, introdotto il cadavere,
il peso sia lo stesso, e infine, così spalmatolo di mirra al di fuori, trasporta
l'uovo con dentro il corpo in Egitto, nel tempio del Sole”.115 Erodoto non
accenna alla nascita della nuova fenice che, secondo questa tradizione,
avverrebbe a partire da un verme formatosi durante la decomposizione dei
111
Tacito, Annales., VI,28,3.
112
Plinio, Nat. Hist.., X,5.
113
Orapollo, Hierogl., II,57.
114
Cfr. Van de Broeck 1972, pp. 146-161.
115
Erodoto, Storie, II,73.
165
resti paterni. Secondo l'altra tradizione - quella che ha goduto di maggior
successo e si è finalmente imposta come la versione standard del mito - la
fenice, giunta a una estrema vecchiaia, si adagia in un nido pieno di aromi
preziosi e vi si incendia, per effetto del calore solare o per virtù degli aromi
stessi; dalle ceneri nasce infine la nuova fenice. Entrambe le tradizioni - che
si trovano non di rado contaminate fra loro - presentano comunque
oscillazioni su numerosi punti di dettaglio: in particolare sulla provenienza
della fenice (India, Arabia, Etiopia, Libano o un più generico Oriente), sulle
modalità e sul luogo della sua morte (collocata ora nella stessa India, ora
nella mitica Pancaia, altra terra solare, ma per lo più in Egitto) e sulle fasi
della rinascita (che secondo qualche fonte attraversa alcuni stadi intermedi:
verme, uovo, uccellino). Una mirabile sintesi del mito classico si legge nel
carme De ave phoenice attribuito a Lattanzio (III secolo), dove tutte le sue
componenti tradizionali - comprese le due versioni della morte e della
rinascita - sono fuse in una narrazione visionaria e ricca di risonanze
simboliche. Lattanzio, o chi per lui, riferisce che la fenice nasce in un luogo
beato situato a Oriente, il boschetto del Sole, al centro del quale scaturisce
una fonte che lo inonda dodici volte all'anno: unico al mondo, l'uccello
segue costantemente Febo nel suo corso, segnando le ore diurne e notturne.
Trascorsi mille anni, la fenice sente il suo corpo appesantito dalla vecchiaia
e parte per il nostro mondo allo scopo di rinnovarsi; giunge in Siria (che da
essa avrebbe ricevuto il nome di Fenicia), sceglie un'alta palma (che le
dovrebbe il suo nome greco phoînix) e vi costruisce in cima un nido o un
sepolcro: “seu nidum sive sepulchrum: / nam perit ut vivat, se tamen ipsa
creat” [“un nido o un sepolcro: infatti muore per vivere, creando però se
stessa”]. Dopo averlo riempito con i più preziosi aromi orientali, si immerge
per dodici volte in un'onda sacra e si installa nel nido stesso, attendendo il
sorgere del sole. Allo spuntare del primo raggio, rivolge all'astro un canto
meraviglioso; poi, quando il disco solare si è interamente svelato, lo saluta
tre volte battendo le ali, spande sul proprio corpo i profumi che aveva
raccolto in Oriente e si infiamma, colpita da un raggio etereo che si
congiunge alla fiamma scaturita dal nido: rapita da una morte vitale genitali morte - si riduce così in cenere. Ma la natura inumidisce questa
cenere, la condensa e la feconda: ne esce così una larva lattiginosa senza
membra, che a poco a poco cresce assumendo la forma di un uovo: da
questo, terminato il periodo di incubazione, esce infine la nuova fenice.
Questa cresce nutrendosi solo del nettare caduto dal cielo e, una volta
divenuta adolescente, ritorna al proprio paese scortata dal coro di tutti gli
esseri alati; prima, però, avvolge i resti paterni in un globo di mirra, di
balsamo e di incenso e li porta a Eliopoli, deponendoli sopra l'altare del
santuario. Qui tutti accorrono a vedere la prodigiosa creatura: le sue piume
sono vermiglie, con riflessi dorati e iridescenti; il suo becco è avorio e
diamante, i suoi occhi brillano come due ametiste con una fiamma scarlatta
166
al centro, il suo capo è circondato da un nimbo raggiante. Il poema si
conclude con alcuni versi che esprimono efficacemente il paradosso su cui si
incentra tutto il mito feniceo:116
At fortunatam sortis finisque volucrem,
cui de se nasci prastitit ipse deus!
Femina seu mas sit seu neutrum seut sit utrumque,
felix quae Veneris foedera nulla colit:
mors illi Venus est, sola est in morte voluptas:
ut possit nasci, appetit ante mori.
Ipsa sibi proles, suus est pater et suus heres,
nutrix ipsa sui, semper alumna sibi.
Est eadem sed non eadem, quae est ipsa nec ipsa est,
aeternam vitam mortis adepta bono.
[Destino e morte fortunati quelli di questo uccello, cui Dio ha concesso di nascere da
se stesso! Maschio o femmina o né l'uno né l'altro, felice creatura, che non conosce i
vincoli di Venere! La sua Venere è la morte; la morte, il suo solo amore: per poter
nascere, desidera morire. È il proprio figlio, padre, erede; è insieme la nutrice e la
nutrita. È lei e non lei, la stessa e non la stessa, conquistando con la morte una vita
eterna].
“Aeternam vitam mortis adepta bono”: sia o no Lattanzio l'autore del
poemetto, queste parole si prestano ottimamente ad aprire il capitolo
cristiano del mito. Ed è un capitolo indispensabile per comprendere la
similitudine Donna-fenice nella poesia romanza delle Origini. Ben presto si
impose, nell'apologetica e nella simbologia cristiana, il paragone fra la morte
e resurrezione della fenice e quelle di Cristo. Esso è sviluppato nel
Physiologus greco (II-III secolo d.C.) e di qui discende a quasi tutti i bestiari
medioevali: “Esiste in India un uccello detto fenice: ogni cinquecento anni
se ne va verso gli alberi del Libano, ed empie le sue ali di aromi, e si
annuncia con un segno al sacerdote di Eliopoli, nel mese nuovo, Nisan o
Adar, cioè nel mese di Famenòth o di Farmouthì. Il sacerdote, avvertito,
giunge e carica l'altare di sarmenti di vite: l'uccello allora entra in Eliopoli,
carico di aromi, e sale sull'altare, e il fuoco si accende da sé e lo consuma.
L'indomani, il sacerdote frugando l'altare scopre nella cenere un verme; il
secondo giorno, lo trova divenuto un piccolo uccello, e il terzo, lo trova
divenuto un uccello adulto; il quale saluta il sacerdote, e se ne va nella
propria dimora. Se dunque quest'uccello ha il potere di uccidersi e di
rinascere, come possono gli insensati Giudei indignarsi contro le parole del
Signore: "Ho il potere di deporre la mia anima, e il potere di riprenderla"
[Giov 10,18]? La fenice è un'immagine del Salvatore nostro: Egli è sceso
infatti dai cieli, ha steso le sue due ali, e le ha portate cariche di soave odore,
cioè delle virtuose parole celesti, affinché anche noi spieghiamo le mani in
116
De ave phoenice, vv. 161-170.
167
preghiera, e facciamo salire un profumo spirituale mediante buoni
comportamenti”.117 L'anonimo redattore ha dunque ripreso la versione più
corrente del mito (incendio della fenice e sua resurrezione dalle ceneri),
contaminandola però - come numerosi altri scrittori - con quella di tipo
erodoteo (Eliopoli, il verme da cui si sviluppa la nuova fenice) e
introducendo un elemento originale: la scansione in tre giorni della rinascita
(verme, uccellino, uccello adulto), che allude ai tre giorni trascorsi dalla
morte alla resurrezione di Gesù. Nell'allegoria, il prodigio è additato come
una prova naturalistica della resurrezione stessa e non manca di essere
sfruttato anche il riferimento agli aromi, interpretati come un simbolo degli
insegnamenti spirituali di Cristo.
La fortuna di questo tema fu enorme nella letteratura come nell'arte
cristiana sino alla fine del medioevo e anche oltre: la fenice diventò una
delle figure cristiche per eccellenza. Ma non fu questa la prima utilizzazione
del mito classico da parte degli autori cristiani. Il più antico testo cristiano
che vi faccia riferimento è la Lettera ai Corinzi di Clemente Romano (95-98
d.C.), dove il sacro uccello è citato come argomento a favore della
resurrezione della carne. Scrive Clemente: “Carissimi, notiamo come il
Signore ci mostri di continuo la futura resurrezione di cui ci diede come
primizia il Signore Gesù Cristo risuscitandolo dai morti. Osserviamo,
carissimi, la resurrezione che avviene di volta in volta. Il giorno e la notte ci
mostrano la resurrezione; cessa la notte e sorge il giorno; se ne va il giorno e
sopraggiunge la notte. Prendiamo i frutti. In che modo e in qual parte
germoglia il seme? Uscì il seminatore e gettò nella terra i semi; secchi e
nudi caduti nella terra si dissolvono. Poi la grandezza della provvidenza del
Signore li fa rinascere, e da uno solo crescono molti e portano frutto”.118
Segue la narrazione del mito feniceo, presentato nella versione “erodotea” e
perciò senza alcun riferimento al rogo e alla rinascita dalle ceneri. E
Clemente commenta: “Riteniamo, dunque, cosa grande e straordinaria che il
creatore dell'universo opererà la risurrezione di coloro che lo hanno servito
santamente nella sicurezza di una fede sincera. Non ci comprova anche in un
uccello la grandezza della sua promessa?”.119 La stessa idea è sviluppata da
Cirillo di Gerusalemme nelle Catechesi e da Tertulliano nel De
resurrectione mortuorum. Anche Tertulliano, per sostenere la tesi della
resurrezione futura, parte dall'osservazione della natura che continuamente
distrugge per rinnovare, con l'alternanza del giorno e della notte, con quella
delle stagioni, con il ciclo di morte e di rinascita nella vegetazione:
“Meraviglioso è il modo: conservatrice da rapinatrice, afferra per restituire,
distrugge per custodire, uccide per vivificare, per reintegrare danneggia, per
117
Fisiologo, cap. 7.
118
Clemente, 2 Cor 14,1-5, trad. it. in Padri apostolici, p.
119
Ibid., 16,1, trad. it. in Padri apostolici, p.
168
ingrandire, prima sbriciola, se è vero che restituisce tutte le cose più ricche e
più belle di quando le ha distrutte, davvero, con una distruzione che è un
profitto, con un'offesa che è un'usura e con un danno che è un lucro. Mi basti
dirlo una volta sola: tutto quanto l'universo è ricorrente: tutto quello che tu
incontri, è stato, tutto quello che perderai, sarà: niente non sarà una seconda
volta: tutto quanto ritorna nel suo stato dopo che se ne è allontanato, tutto
quanto incomincia quando ha finito, tutto finisce perché possa nascere:
niente perisce se non per salvarsi”.120 Ma lo scrittore africano si rende conto
che l'esempio dei cicli naturali è insufficiente e - con mossa analoga a quella
di Clemente e di Cirillo - ne indica uno a suo giudizio più convincente e
paradossale, quello della fenice: “Se l'universo non ti raffigura a sufficienza
il fenomeno della resurrezione, se niente del genere ti sigilla ciò che è stato
creato da Dio, in quanto si sostiene che le singole cose dell'universo non
tanto muoiono quanto cessano e si pensa che esse non tanto siano rianimate
quanto riformate, accetta il seguente esempio, completo e sicuro, che vale
per questa speranza, se è vero che esso riguarda una cosa animata, soggetta
tanto alla vita quanto alla morte. Mi riferisco a quell'uccello che è tipico
dell'Oriente, famoso perché è unico, straordinario a causa della sua
discendenza, il quale, eseguendo di sua spontanea volontà il suo funerale, si
rinnova, con una morte che è la sua nascita morendo e succedendo a se
stesso, di nuovo fenice quando non è più oramai nessuno, di nuovo lui
stesso quando non è già più, il medesimo-altro. Che cosa c'è di più evidente
e di più testimoniato a vantaggio di questa causa, o in favore di quale altra
cosa esiste una prova siffatta? Lo dice anche Dio nella sua scrittura: "e
fiorirai come una fenice" [Sal 92,13], cioè rifiorirai dalla morte, dal tuo
funerale, in modo da credere che anche dal fuoco si può ricavare la sostanza
corporea. Che noi valiamo più di molti passeri, ce lo ha assicurato il
Signore: niente di straordinario, se noi valiamo di più anche delle fenici”.121
In questi passi la fenice diventa quindi figura, prima ancora che di Cristo,
dello stesso cristiano o dell'uomo in generale, destinato alla resurrezione e
alla vita eterna dopo la morte: figura quindi dell'uomo escatologico
reintegrato nella sua pienezza e perfezione originaria, nella condizione di
immortalità che gli apparteneva nel Paradiso terrestre e che è destinato a
riconquistare - “con una morte che è la sua nascita” - alla fine dei tempi.
Non diversa sembra essere la simbologia implicita nel De ave phoenice di
Lattanzio - dove all'uccello sono attribuite altre caratteristiche “edeniche”
come androginia e verginità - e in varie sue raffigurazioni paleocristiane
come quelle della Catacomba di Priscilla a Roma o della Basilica di
120
Tertulliano, De resurr. mort., 12,5-6.
121
Ibid., 13,1-4.
169
Aquileia.122 Del resto il parallelo tra la fenice e l'anima che vive dopo la
morte è uno dei dati più antichi del mito. Nella religione egiziana il benu originariamente connesso al dio solare Re o a Osiride, dunque ai temi della
creazione e rigenerazione del mondo - poteva essere anche una figura del
morto che rinasce nell'oltretomba; nel capitolo 17 del Libro dei morti sono
pronunciate queste parole a nome dell'anima del defunto: “A me appartiene
lo ieri, io conosco il domani. Fu fatta la lotta degli dei al mio comando. Io
conosco questo dio grande [Re o Osiride] che è in esso. Io sono questa
grande fenice che è in Eliopoli che custodisce ed enumera per Quel che
è”.123 E all'imbalsamazione del benu morto, di cui parlano numerosi testi
egiziani, potrebbe in qualche modo risalire la descrizione dell'uovo di mirra
in cui la fenice seppellisce il padre morto nella versione “eliopolitana” del
mito. Anche nel mondo classico la fenice è stata interpretata come un
simbolo dell'anima. Nel frammento 304 di Esiodo, citato da Plutarco nel
Tramonto degli oracoli, è detto che la fenice vive nove volte più del corvo,
cioè 972 “generazioni” (= anni):124 questa cifra (di cui i mille anni di vita
che numerose fonti attribuiscono alla fenice rappresentano forse un
arrotondamento) fu poi indicata come corrispondente alla durata delle
peregrinazioni che l'anima deve compiere dopo la morte prima di una nuova
incarnazione.125 Il mistero della fenice diventa così quello della
sopravvivenza dell'anima nella dottrina orfico-pitagorica della
metempsicosi.
A queste concezioni può essere in qualche modo avvicinata la simbologia
esoterica della fenice che figura in uno dei testi gnostici di Nag ‘Hammâdi,
la cosiddetta Origine del mondo (II, 5). Dopo aver richiamato la tripartizione
antropologica degli gnostici (“Fino al termine del mondo vi sono tre uomini
con le loro stirpi: il pneumatico dell'eone, lo psichico, e il terrestre”), il
redattore paragona le “tre fenici del paradiso” (quella “immortale”, quella
che “dura mille anni” e quella “che sarà consumata”) ai tre battesimi, quello
“pneumatico”, quello “di fuoco” e quello “di acqua”.126 Le tappe progressive
della conversione sono dunque segnate dalle diverse fasi che le fonti
assegnano al rinnovamento della fenice: immersione nell'acqua, incendio nel
fuoco, rinascita. Uccello unico, che compendia in sé i tre momenti del
tempo, la fenice ha naturalmente il suo habitat nel Paradiso, terra delle
origini e regno escatologico, qui identificato con l'Egitto. “Questi grandi
segni apparvero soltanto in Egitto. Nessun'altra regione è contrassegnata
122
Cfr. Van den Broeck 1972, pp. 381-382. In alcuni scritti è suggerito anche il rapporto
fra il rogo della fenice e quello del martire cristiano; cfr. Tardieu 1974, p. 247.
123
Testi egizi, p. 272. Cfr. in proposito Van de Broeck 1972, p. 21.
124
Plutarco, De def. orac.., 11; 415 C.
125
Cfr. Van den Broek, pp. 132-145.
126
Origine del mondo, 122,8-14, in Testi gnostici, p.
170
così da assomigliare al paradiso di Dio”.127 In definitiva la fenice - che
riunisce in sé tutti gli opposti: origine e fine, vita e morte, Oriente e
Occidente, maschio e femmina - diventa qui una figura dello gnostico, che
ha operato in sé la congiunzione degli estremi e raggiunto la condizione
perfetta di monachós: “Ma il verme generato dalla fine - dichiara l'Origine
del mondo - è anche un uomo; a suo riguardo sarà scritto: "Il giusto crescerà
come fenice"; ora la fenice prima appare viva, poi muore, e risorge
nuovamente, essendo essa un segno per colui che si manifesterà al termine
dell'eone”. Osserva in proposito Michel Tardieu: “L'apocatastasi, che è
rigenerazione escatologica, è anche ritorno all'origine. Dopo aver seppellito
suo padre, la giovane fenice ritorna verso la patria d'origine; così, lo
gnostico, al termine della sua apodêmía nel mondo, "ritorna al luogo da cui
è venuto". Uccello di ogni giorno, ma anche presente all'origine e alla fine,
la fenice è signora del tempo. È quindi abilitata a svolgere il ruolo di tipo o
di testimone dell'esistenza giusta e felice, sia nell'età dell'oro che nella
parusia [...] Uccello delle palme e del sole, divenuto, dopo aver percorso i
tre momenti del tempo, testimone dell'esistenza giusta, la fenice è il simbolo
perfetto dello gnostico, anche lui viaggiatore in paese straniero, ma che
sempre si ricorda della sua patria e vi fa ritorno”.128
*
*
*
Mentre i bestiari medioevali ripetevano, senza innovazioni di grande
rilievo, la comparazione del Physiologus tra la morte e resurrezione della
fenice e quelle di Cristo, alcuni poeti romanzi - dapprima provenzali, poi
francesi e italiani - incominciarono a elaborare una versione “profana” del
mito, sviluppando una similitudine tra la fenice e l'amante che si consuma
nella fiamma amorosa. Il primo sembra essere stato Rigaut de Berbezilh, la
cui fama è legata proprio alla sua predilezione per le immagini zoologiche;
egli la include, dopo quelle con altri animali, nella IV cobla della celebre
canzone Atressi con l'orifanz:129
e s'ieu pogues contrafar
127
Ibid., 122,33-123,2, in Testi gnostici, p.
128
Tardieu 1974, p. 261.
129
Rigaut de Berbezilh, p. 123.
171
fenis, don non es mais us,
que s'art e pois resortz sus,
eu m'arsera, car sui tan malanans
e mos fals ditz messongiers e truans;
resorsera en sospirs et en plors
la on beutatz e iovenz e valors
es [...].
[E s'io potessi imitare / la fenice, che è sempre una sola / e si arde e poi risorge, / io
mi arderei, perché sono tanto sventurato / nelle mie false parole menzognere e
perfide; / risorgerei in sospiri e in pianti / là dove si trovano bellezza e giovinezza e
valore...].
La similitudine fu poi ripresa da altri trovatori come Raimbaut d'Aurenga
e Peire Vidal, da un troviero come Thibaut de Champagne e soprattutto da
numerosi poeti siciliani e toscani, a partire da Giacomo da Lentini, che la
usa due volte, fino a Guittone, Chiaro Davanzati e Dino Frescobaldi, il quale
la colloca in apertura della grande canzone Per gir verso la spera. Più che le
risonanze cristologiche della leggenda, è qui sfruttato il tema del martirio,
già presente del resto - in chiave religiosa - nella letteratura cristiana antica:
al martire cristiano si sostituisce il martire d'amore, nella sua paradossale
condizione di vita / morte. L'immagine - che sfrutta solo i dati essenziali
della leggenda: morte e resurrezione, fuoco, più raramente unicità
dell'esemplare - può così associarsi e talvolta sovrapporsi a quella di altri
animali che incarnano lo stesso paradosso, come la farfalla che si brucia alla
candela o la salamandra che vive nel fuoco, riducendosi gradualmente a un
semplice cliché del linguaggio lirico medioevale.
Ben più complesso e denso di implicazioni simboliche è il riferimento al
mito della fenice nel secondo romanzo di Chrétien de Troyes, il Cligès, dove
a evocarla è il nome stesso della protagonista femminile, Fénice. Per la
prima volta nella letteratura romanza la mitica creatura è associata a una
donna; e in questa nuova elaborazione del simbolo si intravedono già le
linee essenziali di un mito amoroso che avrà in Cecco d'Ascoli e in Petrarca
i suoi più alti cantori. Il Cligès narra la storia d'amore di due giovani, Cligès,
legittimo erede al trono di Costantinopoli, e Fénice, figlia dell'imperatore di
Germania e sposa dello zio di Cligès, Alis, che regge provvisoriamente
l'impero contravvenendo però all'impegno assunto di non prendere moglie.
Fin dal primo incontro con il giovane alla corte di Colonia, Fénice si
innamora perdutamente di lui, che ne ricambia il sentimento. Dopo le nozze
con Alis, Fénice riesce con uno stratagemma a mantenersi casta per il suo
amato; quindi architetta con la complicità della maga Thessala un piano per
potersi unire definitivamente a Cligès: assume una pozione che la fa
sembrare morta e - creduta tale anche per le torture che le infliggono tre
diffidenti medici di Salerno - viene sepolta in una tomba costruita
dall'artigiano-architetto Giovanni. La notte stessa Cligès, aiutato da
172
Giovanni, esuma e trafuga il corpo dal cimitero portandolo in una torre,
costruita dallo stesso Giovanni all'interno di un magnifico verziere: qui,
dopo qualche tempo, Fénice rinviene e può trascorrere più di un anno di
perfetta felicità con il suo amante. I due saranno scoperti ma, dopo la
provvidenziale morte di Alis, potranno infine coronare il loro sogno
d'amore.
Lo stesso Chrétien, presentando Fénice, fornisce la spiegazione del suo
nome citando il mitico uccello:
Fenyce ot la pucele a non:
ce ne fu mie sanz reison,
car si con fenix li oisiax
est sor toz les autres plus biax,
ne estre n'an pot c'uns ansamble,
ausi Fenyce, ce me sanble,
n'ot de biauté nule paroille.
Ce fu miracles et mervoille
c'onques a sa paroille ovrer
ne pot Nature recovrer.
130
[La fanciulla si chiamava Fénice, / e non senza ragione: / perché, come l'uccello
fenice / è più bello di tutti gli altri / ed è unico al mondo, / così Fénice, a mio parere,
/ non aveva uguale in bellezza. / Fu un miracolo e un prodigio: / mai Natura poté
operare / in modo da farne una simile].
Le caratteristiche cui si riferisce lo scrittore sono dunque la straordinaria
bellezza (“sor toz les autres plus biax”) e l'unicità (“estre n'an pot c'uns
ansamble”), dati correnti - come si è visto -nella descrizione tradizionale
della fenice. Ma lo svolgimento della vicenda induce a ritenere, come hanno
fatto parecchi interpreti del romanzo, che il nome di Fénice evochi
tacitamente il nucleo stesso del mito feniceo: la morte e la resurrezione.
Attraverso la sua falsa morte, Fénice muore a una falsa esperienza amorosa,
imposta con la forza da un usurpatore, Alis; con la sua “rinascita” essa nasce
al vero amore per Cligès, imperatore legittimo. Tale rinascita è situata da
Chrétien nella cornice di un vero e proprio Eden, al centro del quale sorge
un albero meraviglioso: qui - come sulla palma-phoînix dei racconti antichi
e medioevali, che per certi versi esso richiama131 - Fénice, potremmo dire, fa
il suo “nido”. Nulla autorizza nel romanzo a interpretarla come il simbolo
dell'anima che, morendo al mondo e sottraendosi al falso dio che lo governa,
risorge in una dimensione superiore per unirsi in mistiche nozze con il suo
Io celeste o con il vero Dio. Eppure in tutto il romanzo la sua figura balugina
di riflessi simbolici e sacrali: la “grant clarté”, più forte di quattro
130
Cligès, vv. 2707-2716, in Chrétien, Oeuvres, p.
131
Cfr. Polak 1972, pp. 304-316.
173
carbonchi,132 con cui, apparendo, essa illumina tutto il palazzo, è la stessa
con la quale nell'ultimo romanzo di Chrétien, il Conte del Graal, il sacro
Piatto appare a Perceval nel castello del Re Pescatore, facendo impallidire la
luce di tutte le candele; e “molt sainte chose” [“santissimo oggetto”],133
come il Graal, è detto da maestro Giovanni il suo corpo quando viene
rinchiuso nella bara come una reliquia “en leu de saintuaire” [“dentro a una
chiesa”].134 Anche le torture che le sono inflitte dai medici prima della
sepoltura non possono non far pensare alla passione di Cristo, cui rinvia del
resto lo stesso simbolo della fenice, o al martirio di una santa.
La centralità di questi temi “fenicei” nel romanzo è confermata anche dal
parallelismo con la vicenda di Cligès, la cui figura finisce per sovrapporsi a
quella di Fénice in una medesima storia simbolica di morte e di rinascita.
Già quando egli arriva al seguito di Alis nella reggia di Colonia la sua
bellezza - dice Chrétien - si fonde con quella della fanciulla come in un
unico raggio di sole nascente che illumina tutto il palazzo (si noti il
riferimento all'aurora, tradizionale nel mito antico):
Un po fu li jorz enublez,
mes tant estoient bel andui,
antre la pucele et celui,
c'uns rais de lor biauté issoit,
don li palés resplandissoit
tot autresi con li solauz
qui nest molt clers et molt vermauz.
135
[La giornata era un po' nuvolosa / ma entrambi erano tanto belli / - la fanciulla e
Cligès - / che dalla loro bellezza emanava un raggio / di cui splendeva il palazzo, /
simile al sole / che sorge luminoso e vermiglio].
Poi, mentre Fénice sta mettendo in opera il suo piano, Cligès dimostra
tutto il suo valore combattendo al torneo di Oxford, dove indossa
successivamente quattro armature - una nera, una verde, una vermiglia e una
bianca - e affronta con ciascuna di esse i quattro più famosi cavalieri di
Artù. Prima che l'eroe indossi l'ultima armatura e, vinti i primi tre avversari,
concluda in parità il duello con lo zio Galvano, Chrétien commenta: “Par
tans sera de quatre mue, / se il chascun jor par costume / oste et remet
novele plume” [“Presto Cligès avrà fatto quattro mude, / togliendosi e
riprendendo / ogni giorno un nuovo piumaggio”].136 Anche Cligès è dunque
132
Cligès, vv. 2732-2733, in Chrétien, Oeuvres, p.
133
Ibid., v. 6078, in Chrétien, Oeuvres, p.
134
Ibid., v. 6076, in Chrétien, Oeuvres, p.
135
Ibid, vv. 2736-2742, in Chrétien, Oeuvres, p.
136
Ibid., vv. 4892-4894, in Chrétien, Oeuvres, p.
174
una sorta di fenice che, dopo aver affrontato ogni prova mortale, rimette
“novele plume”; l'equivalenza delle due immagini è confermata dal
paragone di Fénice con un astore in muda, implicito nel pretesto che egli
inventa per potersi recare senza suscitare sospetti alla torre dove si nasconde
la fanciulla: “un ostor i a mis en mue, / si dit que il le vet veoir” [“Vi ha
lasciato un astore in muda / e dice che va a vederlo”].137 .La fusione ideale
dei due protagonisti - affermata dallo stesso Cligès nel lamento pronunciato
davanti a Fénice creduta morta: “une chose estiens andui” [“eravamo una
cosa sola”]138 - è del resto sottolineata anche da Chrétien quando descrive la
loro felicità amorosa: “Einsi est lor voloirs comuns / con s'il dui ne fussent
que uns” [“Così il loro desiderio è comune / come se loro due fossero uno
solo”].139 Non si può non sottoscrivere, a questo riguardo, il commento di
Charles Méla: “"Novele plume": l'immagine così formulata a proposito di
Cligés permette di intendere metaforicamente un poco oltre "la plume" di
cui è fatto il letto della falsa morta, mentre il pretesto dell'astore in muda
abbraccia, nell'accostamento di tutti i termini, la realtà segreta della
trasmutazione in corso. Cligès ne ha portato i colori - volta a volta nero,
verde, vermiglio e bianco - secondo cui si dispone la materia dell'Opera. Il
corpo di Fénice, fra le mani di Thessala, dei medici di Salerno e
dell'architetto Giovanni, ne ha subìto la passione e ne ha portato il processo
dalle ombre sotterranee fino alla sua risalita alla luce del giorno per
l'apertura della torre su un verziere paradisiaco”. Le vicende intrecciate dei
due protagonisti - egli conclude - traducono “l'unità di una medesima
operazione, dalla quale rinascerà un uomo nuovo, per grazia di un amore che
ha saputo vincere le proprie tenebre”.140
Il paragone fra la donna e la fenice, praticamente assente nella poesia
trobadorica,141 si ritrova in un manoscritto del galante Bestiaire d'amours di
Richard de Fournival, dove il mitologema messo a profitto è, come in
Chrétien, l'unicità dell'esemplare. Di qui passa nella versione toscana del
trattato nota con il titolo di Diretano Bando: “Così siete sola al mondo dichiara il corteggiatore all'amata - come uno uccello c'ha nome fenice, che
unqua non se ne truova se non è una. E quando è vecchia, allora sì s'arde.
Veramente anzi che la se arda, reca al fuoco un'erba c'ha natura, che poi ch'è
arsa nascie adesso una altra fenice; e così non è se non una”.142 Ma in area
137
Ibid., vv. 6304-6305, in Chrétien, Oeuvres, p.
138
Ibid., v. 6241, in Chrétien, Oeuvres, p.
139
Ibid., vv. 6327-6328, in Chrétien, Oeuvres, p.
140
Méla 1992, pp. 17-18.
141
Si può indicare soltanto il senhal “Bels Fenics” in una canzone di Raimon Bistors di
Arles. Cfr. Bianchini 1996.
142
Grion 1869, p. 282.
175
italiana - dove peraltro, come si è detto, ebbe larghissima diffusione la
similitudine fra il mitico uccello e l'amante che arde nel fuoco della passione
- fu Cecco d'Ascoli a elaborare nel capitolo secondo del III libro dell'Acerba
il primo grande emblema della Donna-fenice. Egli vi tratta di una misteriosa
Donna beatificante e celeste che rappresenta la divina Sapienza o
Intelligenza, cioè la rivelazione teofanica che illumina con la sua luce la
parte superiore della nostra mente - l'intelletto passivo - e stacca gli uomini
dalle cose materiali per innalzarli alla contemplazione delle realtà eterne. Di
essa Cecco afferma che preesiste a tutte le cose (“fu nanti 'l tempo e 'anti 'l
cel suo vista”),143 è di natura puramente spirituale anche se appare fra gli
uomini,144 illumina “di splendor divin” l'intelletto passivo, che si accresce
“mirando di bellezza la sua luce”,145 e in questo modo “fa volar la mente
nostra accesa / nel gran disio dello ben divino”,146 assicurandogli salvezza e
beatitudine: “E l'anima, ch'a luce fu creata / per sol montare nelle dolci
scale, / per li occhi di costei divien beata”.147 Al culmine della visione
beatificante, che provoca un'uscita della mente dai suoi limiti umani, si
realizza la trasformazione del contemplante nella Donna celeste, la unio
mystica con lei:
Io so' dal terzo celo trasformato
in questa donna, ch'i' non so' chi fui,
per cui me sento ognora più beato.
Da·lei comprese forma il mio intelletto,
mostrandome salute gli occhi suoi
mirando la virtù del suo cospetto.
Dunqua, io so' ella, e se da me se sgombra,
allor di morte sentiraggio l'ombra.
148
Questa Donna indica evidentemente la stessa realtà metafisica
dell'Angelo purpureo o della Natura Perfetta descritti nei racconti mistici di
Sohrawardî, cioè - come ha spiegato Henri Corbin - il nostro “Io celeste”, la
nostra paredra o guida divina il cui incontro ci dischiude la rivelazione degli
orizzonti sovrumani.149 Ed è proprio nel cuore di questa trattazione che
Cecco ricorre al mito della fenice, inaugurando un vero e proprio “bestiario
143
L'Acerba, III,II,22. Gli eventuali emendamenti al testo, piuttosto corrotto, sono inseriti
fra parentesi uncinate < >.
144
Ibid., III,II,19-21.
145
Ibid., III,II,10 e 23-24.
146
Ibid., III,V,14-15.
147
Ibid., III,V,31-33.
148
Ibid., III,I,133-140.
149
Cfr. Corbin 1971, soprattutto pp. 297-307.
176
della Sapienza divina” che, mutando progressivamente carattere, assume poi
la forma di un più tradizionale bestiario moralizzato. Questa Donna, egli
dice, è simile alla fenice che “morendo nasce”: quando si sente gravata
dall'età, accende infatti una fiamma con il battito delle sue ali nelle calde
regioni dell'Oriente e si incendia; dopo essersi così trasformata “in polver
trita”, riprende vita per virtù della Luna e torna nel suo stato primitivo,
rimanendo sempre unica al mondo (“al mondo non è mai più che una”).150
La descrizione - che, come avviene nella maggior parte del bestiario
dell'Acerba, segue fedelmente il capitolo sulla fenice del De proprietatibus
rerum di Bartolomeo Anglico151 - sintetizza dunque, con la sola eccezione di
un insolito riferimento all'influsso lunare, i dati più correnti della leggenda.
Ma del tutto originale è la spiegazione allegorica che segue:
Così costei, che <alterna> al tempo more
per la grifagna gente obscura e ceca,
accende fiamma de desio nel core;
ardendo, canta delle giuste note;
col dolce foco l'ignoranza spreca,
e torn'al mondo per l'ecelse rote.
La guida delli celi la conduce
nell'alma, ch'è disposta per sua luce.
152
La morte della fenice raffigura dunque la condizione di esilio e di
persecuzione in cui versa la divina Sapienza nel mondo, abitato dalla “gente
obscura e ceca”, cioè da uomini privi di occhi spirituali e incapaci di
contemplare le realtà celesti. A questo mondo essa “muore” per rinascere in
una dimensione più alta e poi ridiscendere, guidata da Dio, verso le anime
disposte ad accogliere la sua “luce intellettual, piena d'amore”. Il “dolce
foco” che accende nei cuori non è una fiamma di voluttà o di amore carnale,
ma quella di un desiderio mistico - il “disio soverchio” di cui Cecco aveva
parlato qualche verso prima153 - che dissolve in essi le tenebre
dell'ignoranza. Rispetto alla precedente descrizione e al capitolo di
Bartolomeo sulla fenice, questa interpretazione allegorica introduce un
nuovo tema, appartenente tuttavia al nucleo tradizionale del mito: quello del
canto in punto di morte, simbolo della amorosa dottrina che la Sapienza
santa trasmette “ardendo”, cioè morendo al mondo e al tempo. Ad esso
Cecco fa allusione anche nel sonetto (in verità di dubbia attribuzione) Io non
150
L'Acerba, III,II,25-36.
151
Cfr. qui il cap. XI, “Il bestiario della Sapienza celeste. Gli animali simbolici
dell'Acerba”, pp. 143-150.
152
L'Acerba, III,II,37-44.
153
Cfr. ibid., III,II,14.
177
so ch'io mi dica, s'io non taccio, dove la fenice non è più immagine della
Donna ma del poeta stesso che, combattuto da opposti sentimenti, canta in
punto di morte: “Sì ch'io ridendo vivo lagrimando, / come fenice nella morte
canto”.154 Sembra così delinearsi quella identificazione fra amante e
Sapienza divina, quel mistico congiungimento con la paredra o con l'“Io
celeste”, che egli aveva descritto al culmine della precedente trattazione:
“Dunqua, io so' ella”. Il canto della fenice, del resto, potrebbe essere riferito
di riflesso anche all'anima che, illuminata dalla luce della Sapienza,
proclama la vera dottrina: tanto più che, poco più avanti, nel capitolo
dedicato al cigno è detto che l'anima desiderosa di conquistare questa Donna
“canta, nella morte, inamorata / andando al suo Fattor così beata”.155 La
fenice di Cecco d'Ascoli rinnova dunque, a distanza di secoli, quella del
trattato II, 5 di Nag ‘Hammâdi, che “prima appare viva, poi muore, e risorge
nuovamente, essendo essa un segno per colui che si manifesterà al termine
dell'eone”: simbolo dello gnostico che, grazie al battesimo spirituale, ritorna
alla sua patria celeste dopo aver patito l'esilio nel mondo inferiore. E gli
ardui versi dell'Acerba si illuminano di un cupo bagliore se si pensa che, per
non aver rinunciato a dissipare l'ignoranza cantando “delle giuste note”, il
poeta ascolano - tragica fenice - finì arso sul rogo.
Lo stesso complesso di idee esoteriche si ritrova nel mito del misterioso
uccello Simurgh - la fenice persiana - descritto nell'epopea mistica islamica,
in particolare nelle opere di ’Attâr et di Sohravardî. Nell'Arcangelo
purpureo, Sohravardî narra che la Simurgh ha il suo nido in cima all'albero
solare Tûbâ, che sorge sulla montagna Qâf e rappresenta il centro del
Malakût o “paradiso” cui l'anima fa ritorno dopo essere evasa dalla prigionia
terrestre: ogni volta che una di esse scompare sulla terra, dove si dirige per
assicurare la sussistenza della vegetazione, una nuova Simurgh spicca il
volo dall'albero Tûbâ. In un altro trattato, l'Incantesimo di Simurgh,
Sohravardî riferisce che ogni upupa, in primavera, abbandona il suo nido e
vola verso la montagna Qâf: qui, dopo essersi spogliata con il proprio becco
delle vecchie piume, diventa una Simurgh, che porta un piumaggio
multicolore, si nutre di fuoco e, modulando un suono meraviglioso dal quale
derivano tutte le conoscenze, risveglia dal sonno i dormienti. Ma il racconto
più straordinario è certamente quello che conclude Il verbo degli uccelli di
’Attâr, riassunto anche da Borges nel Manuale di zoologia fantastica. Vi si
narra come la schiera degli uccelli intraprenda un lungo e penoso viaggio
alla ricerca della Simurgh; dopo molti anni di vagabondaggio per valli e per
montagne, solo pochissimi - trenta - sopravvivono, con corpi e anime
154
Se ne veda il testo in Rosario 1926, p. 156. Sul problema attributivo e sui rapporti fra
questo sonetto e il petrarchesco Pace non trovo (CXXXIV), si veda Santagata 1990, pp.
234-236.
155
L'Acerba, III,X,7-8. Cfr. in proposito Zambon 1983, p. 419.
178
distrutti, e incontrano un araldo che li invita a tornare a casa per non
rimanere incendiati dal lampo che balena dalla sublime creatura. Ma i trenta
superstiti, poiché già dentro di loro divampa l'incendio, non desistono e
riescono infine a contemplare Simurgh, annientandosi e rinnovandosi
completamente nella sua visione: “Nell'immagine del volto di Simurgh
contemplarono il mondo, e dal mondo videro emergere il volto di Simurgh.
Osservando più attentamente si accorsero che i trenta uccelli altri non erano
che Simurgh, e che Simurgh era i trenta uccelli: infatti, volgendo
nuovamente lo sguardo verso Simurgh, videro i trenta uccelli, e guardando
ancora se stessi rividero lui. O meraviglia, questo era quello e quello era
questo”.156 È evidente come, in tutti questi testi, la Simurgh rappresenti il
doppio divino di ogni essere umano, unico e pur diverso per ciascuno, che
come in uno specchio abbagliante e incendiario vi contempla la propria vera
identità. Commenta Henri Corbin: “Essa è l'Io celeste e l'Angelo protettore,
il Volto imperituro di quell'essere; corrisponde alla Natura Perfetta che è
insieme padre e figlio del mistico, perché si nutre alla fiamma del suo Graal;
ciò significa che, in questo modo, l'essere umano muore al suo io inferiore.
Quando la combustione è completa, l'anima umana (l'upupa) è diventata
quella fenice-simurgh che, rinascendo dalle proprie ceneri, spicca il volo "in
primavera" verso l'Oriente, verso la vetta della montagna Qâf”.157 La
coincidenza con la fenice-Sapienza di Cecco d'Ascoli non potrebbe essere
più completa.
Ma il mito feniceo elaborato da Cecco non è forse la cristallizzazione
simbolica di un tema presente anche in altri poeti del suo tempo e che
costituisce una delle grandi novità della poesia amorosa italiana rispetto ai
modelli trobadorici, quello della morte della Donna? Nella lirica provenzale,
infatti, esso è del tutto marginale, pur prefigurandosi in quelli della
lontananza o della superiorità sociale della domna: dei quarantatre planhs o
lamenti funebri che ci sono pervenuti solo cinque sono dedicati alla dama
dell'autore e uno di questi, il bellissimo chan-plor, è di un poeta italiano,
Lanfranco Cigala. Ma già presso i Siciliani, con le grandi canzoni Morte,
perché m'ài fatta sì gran guerra di Giacomino Pugliese e Amando con fin
core e con speranza di Pier delle Vigne, questo tema - in accordo con un
crescente astrattismo del discorso amoroso - incomincia ad assumere un
ruolo sempre più importante, fino a culminare nelle figure - decisive per
tutta la poesia amorosa occidentale - di Beatrice e di Laura. Se la morte di
Beatrice nella Vita nova, come avevano già suggerito Perez e Pascoli, deve
essere messa in rapporto con quella della biblica Rachele che, secondo
l'esegesi mistica di Riccardo di san Vittore, rappresenta l'excessus mentis per
mezzo del quale si superano i limiti umani e ci si eleva alla contemplazione
156
Verbo degli uccelli, p. 206.
157
Corbin 1971, p. 233.
179
delle realtà divine, il suo senso profondo non differisce molto da quello che
Cecco d'Ascoli attribuisce alla morte della sua Donna-fenice. Del resto, la
sola spiegazione plausibile - e perfettamente logica - che sia stata fornita
della terza giustificazione addotta da Dante nella Vita nova per tacere della
morte di Beatrice (“tractando converrebbe essere me laudatore di me
medesimo, la qual cosa è al postutto biasimevole a chi lo fa”)158 rimane
quella proposta da Luigi Valli con riferimento all'esegesi vittorina: “Nessuna
lode più alta poteva fare Dante a se stesso che raccontare di essere giunto a
un altissimo sviluppo di spirito mistico e a quell'excessus mentis nel quale
consiste appunto la morte di Beatrice o, che fa lo stesso, di Rachele”;159
tanto più se si mette questo passo in rapporto con le parole dell'Epistola a
Cangrande in cui Dante, a proposito del “trasumanar” nel primo canto del
Paradiso, cita il rapimento di san Paolo al terzo cielo e rinvia fra l'altro
proprio a Riccardo di san Vittore gli invidi ai quali ciò non bastasse.160 Che
il mito di Beatrice avesse qualche rapporto con quello della fenice-Sapienza,
è quanto lascia intendere anche un altro passo di cui non è stata data finora
una spiegazione soddisfacente: gli ultimi due versi del sonetto attribuito a
Cino da Pistoia Infra gli altri difetti del libello, in cui Dante è rimproverato
di non aver riconosciuto, quando contemplò la sua Donna in Paradiso,
“l'unica fenice / che con Sion congiunse l'Appennino”.
Non sorprende perciò che nel Canzoniere petrarchesco Laura trovi nella
fenice uno dei suoi grandi emblemi, la cui ombra simbolica si allarga dalle
Rime in Vita a quelle in Morte. Nelle prime - secondo una ormai consolidata
tradizione lirica - Petrarca aveva già riferito a se stesso la leggenda nella
prima strofa della canzone, di gusto tipicamente “medioevale”, Qual più
diversa et nova (CXXXV), dove il mitico uccello è la prima delle meraviglie
convocate a rappresentare la sua strana condizione di amante:
Là onde il dì vèn fore,
vola un augel che sol senza consorte
di volontaria morte
rinasce, et tutto a viver si rinova.
Così sol si ritrova
lo mio voler, et così in su la cima
de' suoi alti pensieri al sol si volve,
et così si risolve,
et così torna al suo stato di prima:
arde, et more, et riprende i nervi suoi,
et vive poi con la fenice a prova.
161
158
Vita nova, XIX,2.
159
Valli 1928, p. 374.
160
Cfr. Ep. Cani Grandi de la Scala, 28,80.
161
RVF CXXXV, vv. 5-15.
180
Il volo della fenice che si incendia volontariamente nel sole (dato
abbastanza inconsueto, ma in qualche modo latente nelle fonti162 e già
formalizzato nella canzone Per gir verso la spera del Frescobaldi)
rappresenta dunque il voler del poeta che si consuma nel suo amore per
Laura, identificata qui al sole secondo una simbologia frequente nel
Canzoniere, e continuamente rinasce per tornare ad ardere in questo fuoco; è
un tema classico della poesia amorosa, che si ritrova in altre formule di
sapore “feniceo” come quella del sonetto CLXIV, v. 2: “mille volte il dì
moro et mille nasco”. Al modello simbolico dell'Acerba sono invece
riconducibili, malgrado la parziale diversità degli elementi descrittivi, i testi
in cui il meraviglioso uccello diventa una figura di Laura: si tratta dei sonetti
CLXXXV, CCX, CCCXXI (cui va aggiunto il contiguo CCCXX) e della
“canzone delle visioni” (CCCXXIII). In questo gruppo di liriche,
intimamente connesse tra di loro, non si trova rappresentata soltanto la
bellezza e unicità della donna, ma è anche - e soprattutto - cifrato il grande
mito della morte e rinascita in una dimensione puramente immateriale di
colei “che 'n terra morendo, al ciel rinacque”.163 Nei primi due sonetti, che
appartengono alle Rime in Vita, non viene ancora fatto alcun riferimento al
sacrificio dell'uccello: sono evocati soltanto gli splendidi colori del suo
piumaggio, la sua origine orientale, la sua unicità. Ma è probabile che la
scelta dell'emblema prefigurasse già in qualche modo, per il Petrarca, il
funereo destino di Laura. Nei sonetti CCCXX e CCCXXI, invece, il volo
altero di Questa fenice (“che per lo nostro ciel sì altera vola”) è ormai un
“ultimo volo”, quello della morte, e sulla terra non sono rimasti che il nido
vuoto e la cenere. Questo scenario trova la sua rappresentazione più
compiuta nella penultima strofa della canzone Standomi un giorno solo a la
fenestra, dove l'emblema della fenice segue altre rappresentazioni
simboliche della morte di Laura e in particolare quelle del lauro schiantato
dalla folgore (str. 3) e della fontana inghiottita dall'abisso (str. 4):
Una strania fenice, ambedue l'ale
di porpora vestita, e 'l capo d'oro,
vedendo per la selva altera et sola,
veder forma celeste et immortale
prima pensai, fin ch'a lo svelto alloro
giunse, et al fonte che la terra invola:
ogni cosa al fin vola;
ché, mirando le frondi a terra sparse,
e 'l troncon rotto, et quel vivo humor secco,
volse in se stessa il becco,
162
Isidoro, Etymol., XX,7,22) scrive per esempio che la fenice “rogum sibi instruit et
conuersa ad radium solis alarum plausu voluntarium sibi incendium nutrit”.
163
RVF CCCXXXI, v. 28.
181
quasi sdegnando, e 'n un punto disparse:
onde 'l cor di pietate et d'amor m'arse.
164
La descrizione iniziale (piume di porpora e d'oro, alterigia, unicità)
riassume i dati descrittivi dei sonetti CLXXXV, CCX e CCCXXI, ossia la
visione trionfale di Laura viva: “veder forma celeste et immortale / prima
pensai”. Ma nella seconda parte della strofa il mito feniceo si risolve ormai
nella sentenza “ogni cosa al fin vola”: la fenice è il volare verso la fine, il
ridursi in cenere di Laura e di tutte le cose, tema centrale della canzone.
Questa immagine ingloba in sé, nella costruzione a scatole cinesi delle strofe
3-5, anche quelle immediatamente precedenti del lauro e della fontana: né si
tratta di associazione gratuita da parte del Petrarca, poiché albero e fonte
erano in molte narrazioni della leggenda (per esempio nel De ave phoenice
di Lattanzio) elementi simbolici caratterizzanti dell'habitat edenico della
fenice.165 Attraverso la lente del mito tradizionale, la morte della donna
diventa così il nucleo visibile o invisibile dal quale si innerva una complessa
rete metaforica che percorre tutto il Canzoniere: quella che si potrebbe
chiamare con Contini la “sindrome linguistica della fenice”166 e che non
comprende soltanto - come egli ha indicato - solitudine, alterigia e piume
purpuree ed aurate, ma anche numerosi altri temi simbolici: sole, fiamme,
cenere, ali e volo, nido.167 Sono in gran parte temi classici del linguaggio
amoroso medioevale, privi in origine di qualsiasi rapporto con il mito
feniceo: nel quale però trovano a un certo punto la loro ricapitolazione e
quasi il loro centro segreto.
Nessuno di questi testi accenna alla resurrezione: la quinta strofa di
Standomi un giorno, in particolare, par segnare un momento di disillusione e
di radicale pessimismo: “ogni cosa al fin vola”. Ma proprio il riferimento
alla fenice - che conservava nel medioevo le stimme della simbologia
cristica e che Cecco d'Ascoli aveva già eletto come emblema di una Donna
la cui morte è rinascita in una dimensione più alta (“morendo nasce”) prolunga questo volo fino agli spazi celesti in cui Laura, nella Seconda Parte
del Canzoniere, risorge come donna angelo e guida spirituale del poeta. Nel
sonetto CCCXXI questo rapporto fra morte e ascensione è esplicito: qui
infatti l'“ultimo volo” della fenice è diretto al cielo (v. 13); e nel verso
“Sol'eri in terra; or se' nel ciel felice” è mirabilmente condensato tutto il
ciclo simbolico di Laura: unica fra le donne mentre era in vita, beata in cielo
dopo la morte. Come altrove nel Canzoniere, morte e beatitudine tendono a
164
Ibid. CCCXXII, vv. 49-60.
165
Cfr. Hubaux e Leroy 1939, pp. 56-65, e Van den Broeck 1972, pp. 305-334.
166
Contini 1979, p. 24.
167
Cfr. Zambon 1983, pp. 421-422.
182
coincidere: fine (“ogni cosa al fin vola”) e felicità (“or se' nel ciel felice”) si
fondono nel geroglifico della fenice.
In realtà, la “resurrezione” di Laura resta taciuta perché, nel mito
petrarchesco, essa spetta non tanto alla donna quanto all'io-poeta, che la
fenice non raffigura soltanto nella canzone CXXXV, ma - in maniera più
dissimulata - anche nel gruppo di liriche in cui la mitica creatura diventa un
emblema di Laura. Nella prima strofa di Qual più diversa et nova i dati
riferiti all'io erano l'unicità e mancanza di compagno (simbolo di “diversità”
e di amore non contraccambiato), il volo verso il sole (corrispondente a
quello del desiderio verso Laura), il volontario incendio (cioè la “morte”
amorosa) e la resurrezione (il continuo rinascere del desiderio grazie al
quale il ciclo ricomincia). Alcuni di questi motivi persistono anche nelle
altre poesie fenicee, combinandosi con i dati pertinenti a Laura. Nel sonetto
CLXXXV non è tanto Laura-fenice a incendiarsi, ma è il poeta che arde
dentro al fuoco acceso da Amore nei capelli luminosi di lei (“un liquido
sottile / foco che m'arde”), mentre in CCCXX il “nido” vuoto di Laura è
quello in cui ora vive Petrarca. Anche negli altri testi l'incendio è sempre
riferito all'amante: nei sonetti CCCXX e CCCXXI esso è provocato dagli
occhi o dal viso della donna (“da' belli occhi suoi, che 'l cor m'ànn'arso”;
“arsi quanto 'l mio foco ebbi davante”; “il bel viso onde quel lume venne /
che vivo et lieto ardendo mi mantenne”), nella canzone Standomi un giorno
la fiamma “di pietate et d'amor” è invece suscitata dalla morte di Laura. La
similitudine “tradizionale” di Qual più diversa et nova non è dunque
superata dalle successive, ma continua a essere operante nello sviluppo di un
mito poetico che intreccia le figure dell'amante e dell'amata in un unico
emblema di morte e di rinascita. A entrambi si riferiscono - ma con
significati diversi - l'unicità, il nido, il volo verso l'alto, la morte volontaria;
a Laura soltanto spettano la luce e la cenere; al solo Petrarca il fuoco e la
rinascita. Spiccato da uno stesso nido, il volo celeste della donna è fusione
nel sole e irradiazione di una luce che tutto illumina; quello dell'io-poeta è
invece incendio amoroso in questa fiamma. Ma, sorprendentemente, le
ceneri che restano di questo rogo sono quelle di Laura, vittima del suo
funereo destino, mentre al Petrarca è riservata - in quanto amante e poeta una dolorosa resurrezione. In realtà, la polisemia del simbolo suggerisce
l'inseparabilità delle due vicende, simili in ciò a quelle di Fénice e di Cligès:
in Laura anche Petrarca si inciela, in Petrarca anche Laura risorge e ottiene
vita immortale. Il mito petrarchesco della fenice può essere sintetizzato da
questo schema:
183
La fenice petrarchesca è cifra del necessario e inesorabile dileguare della
donna in quanto essere reale, fisico, e del suo risorgere come fantasma
interiore o mito poetico; essa è per eccellenza la figura di Laura, come di
ogni cosa che al fin vola e proprio in questo - grazie alla poesia - raggiunge
eternità, perfezione, bellezza assoluta. Perciò la sua rinascita non può essere
detta: essa coincide con la scrittura stessa, è la possibilità stessa del
ragionare, dello scrivere di Laura. Dalle ceneri, nelle quali si sono
consumati insieme il poeta e la sua donna, nasce la nuova fenice del canto
poetico, del supremo canto petrarchesco, potremmo quasi dire del suo
“canto feniceo”.
Dopo essere stata Osiride e Cristo, anima trasmigrante post mortem e
cosmo che si rinnova al compimento del Grande Anno, dopo aver incarnato
la perfezione dello gnostico e la resurrezione del cristiano, la fenice - alle
soglie della modernità - diventa dunque donna. In questa sua estrema
rinascita essa naturalmente reca ancora su di sé l'impronta sacrale che ne
aveva segnato la storia più antica, e in particolare quella cristica. Ma il mito
è ormai annesso al campo di quella esperienza amorosa intorno alla quale
ruotano la letteratura e il pensiero del medioevo occidentale. In Cecco o in
Dante - come nei “platonici” di Persia - questo amore è riflesso o tramite di
un itinerarium mentis in Deum; ma già in Chrétien de Troyes e poi in
Petrarca, “inventori” rispettivamente del romanzo e della lirica moderni,
esso è ormai al centro di una ricerca di identità psicologica e sociale che
assume la donna come specchio enigmatico dell'io. Il volo della fenice
petrarchesca è sospeso esattamente su questo crinale che divide Oriente e
Occidente, sacro e profano, trascendenza e immanenza; le sue ali hanno
184
ancora i profumi e la luce dell'Oriente, ma sono ormai chiuse nei plumbei
orizzonti occidentali: “Fama ne l'odorato et ricco grembo / d'arabi monti lei
ripone et cela, / che per lo nostro ciel sì altera vola” - il nostro cielo, quello
dell'uomo e della storia, non più quello dell'Eden orientale. Con il passare
dei secoli queste ali dovevano farsi così pesanti da poter essere facilmente
impallinate dall'erudizione di Leopardi, che nel capitolo dedicato alla fenice
nel Saggio sopra gli errori popolari degli antichi ironizza dottamente su
questo “pregiudizio universale”.168 Ma il midollo più interno del mito resiste
fino al nostro tempo; una terrestre fenice è ancora l'anguilla di Montale,
anche se il suo rogo si è ridotto a una piccola scintilla: “la scintilla che dice /
tutto comincia quando tutto pare / incarbonirsi, bronco seppellito”. Sono
pressappoco le parole usate da Tertulliano nella grande pagina sulla fenice
del De resurrectione mortuorum: “Tutto quanto incomincia quando ha
finito, tutto finisce perché possa nascere: niente perisce se non per
salvarsi”.169
168
Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, XVI, in Leopardi, Prose, p. 854.
169
Tertull., De resurr. mort., 12,6.
185
BIBLIOGRAFIA
a) Testi
Agostino, De doctr. christ.
S. Aurelii Augustini, De doctrina christiana, ed. G.M. Greeen, CSEL 80,
Vindoboniae, Hoelder-Pichler-Tempsky 1963 [trad. it. S. Agostino, La
dottrina cristiana, trad. di V. Tarulli, Roma, Città Nuova 1992].
Agostino, Epist.
S. Agostino, Le Lettere, I, trad. di L. Carrozzi, Roma, Città Nuova 1969.
Agostino, Enarr. in Ps.
S. Agostino, Esposizioni sui Salmi, II, trad. di V. Tarulli, Roma, Città Nuova
1971; III, trad. di T. Mariucci, Roma, Città Nuova 1976.
Alberto Magno, De animal.
Alberto Magno, De animalibus, in Opere, VI, Lugduni 1651.
Alessandro
Alessandro nel medioevo occidentale, a cura di P. Boitani, C. Bologna, A.
Cipolla, M. Liborio. Introd. di P. Dronke, Milano, Mondadori ("Fondazione
L. Valla") 1997.
Ambrogio, De Tobia
S. Ambrosii, De Tobia, ed. C. Schenkl, CSEL 32,2, Vindoboniae, HoelderPichler-Tempsky 1897, pp. 519-573.
Ambrogio, Exam.
S. Ambrosii, Exameron libri sex, ed. C. Schenkl, CSEL 32, Vindoboniae,
1896 [trad. it. in Sant'Ambrogio, Opere, a cura di G. Coppa, Torino, UTET
1969, pp. 108-387].
Ambrogio, Expl. Ps.
S. Ambrosii, Expositio psalmorum XII, ed. M. Petschenig, CSEL 64,6,
Vindoboniae, Hoelder-Pichler-Tempsky 1919.
Antonio, Serm.
186
S. Antonii Patavini, O. Min., Sermones domenicales et festivi, curantibus B.
Costa, L. Frasson, I. Luisetto, coadiuvante P. Marangon, 3 voll. Padova,
Edizioni Messaggero 1979.
Barn.
Epître de Barnabé, ed. R.A. Kraff e P. Prigent, SC 172, Paris, Ed. du Cerf
1971 [trad. it. in I Padri apostolici, a cura di A. Quacquarelli, Roma, Città
Nuova 1976, pp. 179-214].
Bart. Anglico, De rerum propr.
Venerandi patris Bartholomaei Anglici, ordinis Minorum viri eruditissimi,
opus de rerum proprietatibus..., Frankfurt 1601 [rist. anast. Frankfurt a.M:
1964].
Beer 1986
Master Richard's Bestiary of Love and Response, transl. by J. Beer,
University of California Press.
Bestiaires d'amours
Li Bestiaires d'Amours di maistre Richard de Fornival, a cura di C. Segre,
Milano-Napoli, Ricciardi 1957 [trad. it. Richard de Fournival, Il bestiario
d'amore, a cura di F. Zambon, 4a ed., Milano, Luni 1999].
Bestiario di Cambridge
Il Bestiario di Cambridge, trad. it. di S. Ponzi, introd. di F. Zambon,
present. di U. Eco, Milano, F.M. Ricci 1974.
Bloy, La femme pauvre
L. Bloy, La femme pauvre [1897], Paris, UGE, 1983.
Boffito 1903
A. Boffito, Il De Principiis Astrologiae di Cecco d'Ascoli, in “Giornale
Storico della Letteratura Italiana”, Suppl. n. 6.
Boffito 1905a
A. Boffito, Il commento di Cecco d'Ascoli all'Alcabizzo, Firenze, Olschki.
Boffito 1905b
A. Boffito, Il De eccentricis et epicyclis di Cecco d'Ascoli, in “Pubblicazioni
dell'Osservatorio del Collegio alle Querce”, Serie in 4°, n. 7.
Bologna 1977
187
Liber monstrorum de diversis generibus / Libro delle mirabili difformità, a
cura di C. Bologna, Milano, Bompiani.
Bonaventura, Coll. in Hexäem.
S. Bonaventurae, Collationes in Hexaëmeron, ed. F. Delorme, Firenze,
Quaracchi 1934.
Boutière 1964
J. Boutière, A.-H. Schutz e I.-M. Cluzel, Biographies des troubadours,
Paris.
Brunetto, Tresor
Li Livres dou Tresor de Brunetto Latini, éd. crit. par F. Carmody, Berkeley e
Los Angeles, University of California Press 1948.
Buber 1979
M. Buber, I racconti dei Chassidim [1949], trad. it., Milano, Garzanti.
Butturf 1968
D.R. Butturf, The Monsters and the Scholar, an Edition and Critical Study
of the “Liber Monstrorum”, Diss. Illinois (cfr. “Diss. Abstracts”, XXX,
1969, coll. 312B-313A).
Cammino di mezzo
Le stanze del cammino di mezzo, a cura di R. Gnoli, Torino, Boringhieri
1961.
Carmody 1939
F. Carmody, Physiologus Latinus. Editions préliminaires, versio B, Paris.
Carmody 1941
Physiologus latinus, versio Y, ed. by F.J. Carmody, in “University of
California Publications in Classical Philology”, 12, pp. 95-134.
Carrega e Navone 1983
Le proprietà degli animali, a cura di A. Carrega e P. Navone, Genova, Costa
& Nolan.
Chrétien, Oeuvres
Chrétien de Troyes, Oeuvres complètes, éd. publiée sous la dir. de D.
Poirion, avec la collaboration d'A. Berthelot, P.F. Dembowski, S. Lefèvre,
K.D. Uitti et Ph. Walter, Paris, Gallimard (“Bibliotèque de la Pléiade”)
1994.
188
Clark 1992
W.B. Clark, The Medieval Book of Birds. Hugh of Fouilloy's Aviarium,
Binghamton (N.Y.).
Clemente, Strom.
Clemens Alexandrinus, Stromata Buch I-VI, ed. O. Stählin e L. Früchtel,
GCS 52, Berlin 1960 [trad. it. Clemente Alessandrino, Gli Stromati. Note di
vera filosofia, Introd., trad. e note di G. Pini, Roma, Edizioni Paoline 1985].
Corpus Herm.
Corpus Hermeticum, texte établi par A.D. Nock et traduit par A.-J.
Festugière, 4 voll., Paris, Les Belles Lettres 1972.
Crespi 1927
F. Stabili, L'Acerba, a cura di F. Crespi, Ascoli.
Curley 1979
Physiologus, transl. by M.J. Curley, Austin & London, University of Texas
Press.
Davanzati, Rime
Chiaro Davanzati, Le Rime, a cura di A. Menichetti, Bologna, Pàtron 1965.
De Clercq 1959-1960
Ch. de Clercq, Le “Liber de rota verae religionis” d'Hugues de Fouilloi, in
“Archivum Latinitatis Medii Aevi”, 29, pp. 219-228 e 30, pp. 15-37.
De Clercq 1961
C. de Clercq, Le “Liber de pastoribus et ovibus” d'Hugues de Fouilloi, in
“Archivum Latinitatis Medii Aevi”, 31, pp. 77-107.
Delisle 1868-1881
L. Delisle, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale, Paris.
Dionigi, De coel. hier.
Denys L'Aréopagite, La hiérarchie céleste, intr. par R. Roques, étude et
texte crit. par G. Heil, trad. et notes par M. de Gandillac, SC 58 bis, Paris,
Editions du Cerf 1970 [trad. it. in Dionigi Areopagita, Tutte le opere, trad. di
P. Scazzoso, intr., parafrasi, note e indici di E. Bellini, Milano, Rusconi
1981, pp. 69-135].
Diretano Bando
189
Lo Diretano Bando, ed. G. Grion, in “Il Propugnatore”, 2, 1869.
Eliano, Nat. anim.
C. Aeliani, De natura animalium libri XVII, ed. R. Hercher, Leipzig,
Teubner 1865-1866; rist. anast. Graz 1971 [trad. it. Claudio Eliano, La
natura degli animali, 2 voll., intr., trad. e note di F. Maspero, Milano,
Rizzoli 1998].
Epifanio, Pan.
Epiphanius, Ancoratus und Panarion, I-III, ed. K. Holl, GCS 25, 31, 37,
Leipzig 1915, 1922, 1933.
Erbetta 1966
M. Erbetta, a cura di, Gli Apocrifi del Nuovo Testamento, II. Atti e leggende,
Torino, Marietti.
Erodoto, Storie
Erodoto, Storie, a cura di A. Mattioli, 2 voll. Milano, Rizzoli 1958.
Filone, De opif. mundi
Philon d'Alexandrie, De opificio mundi, intr., trad. et notes par R. Arnaldez,
Paris, Editions du Cerf 1962.
Filostrato, Vita Apoll.
Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, a cura di D. Del Corno, Milano,
Adelphi 1978.
Fisiologo
F. Sbordone, Physiologus, Mediolani, In Aedibus Societatis Dante Alighieri,
Albrighi, Segati e C. 1936 [trad. it. Zambon 1990].
Francesco, Scritti
Francesco d'Assisi, Gli scritti e la leggenda, a cura di G. Petrocchi, Milano,
Rusconi 1983.
Garver e McKenzie 1912
M.S. Garver e K. McKenzie, Il Bestiario Toscano secondo la lezione dei
codici di Parigi e di Londra, in “Studi Romanzi”, 8, pp. 1-100.
Gesta Romanorum
Gesta Romanorum, hrsg. von H. Oesterly, Berlin 1872.
Giacomo da Lentini, Poesie
190
Giacomo da Lentini, Poesie, a cura di R. Antonelli, Roma, Bulzoni 1979.
Giov. Crisostomo, Difesa
Giovanni Crisostomo, Difesa delle immagini sacre, Roma, Città Nuova
1983.
Giovanni Scoto
Exp. in ier. coel.
Johannis Scoti Eriugenae, Expositiones in ierarchiam coelestem, ed. J.
Barbet, CCSL 31, Turnholti, Brepols 1975.
Goldstaub e Wendriner 1892
M. Goldstaub e R. Wendriner, Ein Tosco-Venezianischer Bestiarius, Halle.
Guillaume, Best.
Guillaume le Clerc, Le Bestiaire, ed. R. Reinsch, Leipzig 1892 [rist.
Wiesbaden, M. Sänding].
Haupt 1863
M. Hauptii, Opuscula, II, Leipzig, pp. 218-252.
Historia de preliis
Die Historia de preliis Alexandri Magni. Rezension J3, hrsg. von K.
Steffens, Meisenheim a.C. 1975.
Hommel 1890
F. Hommel, Der äthiopische Physiologus, in “Romanische Forschungen”, 5,
pp. 13-36.
Isidoro, Etymol.
Isidori Hispalensis Episcopi, Etymologiarum sive Originum libri XX, ed.
W.M. Lindsay, 2 voll., Oxford, Oxford University Press 1911.
Libro XII (De animalibus): Isidorus Hispalensis, Etymologiae, Livre XII:
Des animaux, Texte établi, traduit et commenté par J. André, Paris, Les
Belles Lettres 1986.
Kaimakis 1974
D. Kaimakis, Der Physiologus nach der ersten Redaktion, Meisenheim /
Glam.
L'Acerba
Cecco d'Ascoli, L'Acerba, secondo la lezione del cod. eugubino del 1376, a
cura di B. Censori ed E. Vittori, Ascoli Piceno 1971.
191
Le Bestiaire
Le Bestiaire, texte intégral trad. en français moderne par M.-F. Dupuis et S.
Louis. Reprod. en fac-similé des miniatures du ms. du Bestiaire Ashmole
1511 de la Bodleian Library d'Oxford. Prés. et comm. de X. Muratura et D.
Poirion, Paris, Philippe Lebaud 1988.
Legendae s. Francisci
Legendae s. Francisci Assisiensis saeculis XIII et XIV conscriptae,
Quaracchi 1926-1941.
Leopardi, Prose
G. Leopardi, Prose, a cura di R. Damiani, Mondadori, Milano 1988.
Libri carolini
Libri carolini, ed. H. Bastgen, MGH, Leg. sec. III, Concilia t. II suppl.
Lucano, Farsaglia
M. Anneo Lucano, Farsaglia, a cura di L. Griffa, Milano, Adephi 1962.
Luciano, Dialoghi
Luciano di Samosata, I Dialoghi e gli Epigrammi, trad. di L. Settembrini,
Roma, Casini.1962.
Mann 1888
M.F. Mann, Der Bestiaire Divin des Guillaume le Clerc, in “Französische
Studien”, 6, pp. 37-73.
Massignon 1931
L. Massignon, Le Diwan d'al Hallaj, in “Journal Asiatique”, 218.
Moreno 1951
M.M. Moreno, Antologia della mistica arabo-persiana, Bari, Laterza.
Morini 1996
Bestiari medievali, a cura di L. Morini, Torino, Einaudi.
Nicholson 1956
R.A. Nicholson, Rumi, poet and mystic, London.
Orapollo, Hierogl.
192
F. Sbordone, Hori Apollinis Hieroglyphica. Saggio introduttivo, ed. critica
del testo e commento, Napoli 1940 [trad. it. Orapollo I Geroglifici, a cura di
M.A. Rigoni. e E. Zanco, Milano, Rizzoli 1996].
Origene, C. Celsum
Origene, Contro Celso, trad. di A. Colonna, Torino, UTET 1971.
Origene, Homil. in Cant.
Origène, Homélies sur le Cantique des Cantiques, intr., trad. et notes par O.
Rousseau, SC 37 bis, Paris, Ed. du Cerf 1966.
Origene, In Cant.
Origenes, In Canticum Canticorum, ed. W.A. Baehrens, “Die grichischen
Schriftsteller der drei ersten Jahrhunderte” 33, Berlin, 1925 [trad. it.
Origene, Commento al Cantico dei Cantici, a cura di M. Simonetti, Roma,
Città Nuova 1976].
Origene, Hom. in Luc.
Origenes, Die Homilien zu Lukas in der Uebersetzung des Hieronymus und
die griechisce Reste der Homilien und des Lukaskommentars, ed. M. Rauer,
GCS 35, Leipzig-Berlin 1930.
Origene, Hom. in Num.
Origenes, Homilien zum Hexateuch in Rufins Uebersetzung, ed. W.A.
Bährens, GCS 30, Leipzig-Berlin 1921.
Padri apostolici
I Padri apostolici, a cura di A. Quacquarelli, Roma, Città Nuova 1976.
Palermo 1860
F. Palermo, I manoscritti della Biblioteca Palatina di Firenze, II, Firenze.
Papias
Papias, Elementarie doctrine rudimentum, Venezia 1496 [rist. anast. Torino
1966].
Peire Vidal
Peire Vidal, Poesie, a cura di D'A.S. Avalle, Milano-Napoli, Ricciardi 1960.
Pierre, Best. (ed. Cahier)
Le “Physiologus” ou Bestiaire, ed. Ch. Cahier e A. Martin, Mélanges
d'archéologie, d'Histoire et de Littérature, 4 voll., Paris 1847-1856, II, pp.
85-232; III, pp. 203-288; IV, pp. 55-87.
193
Pierre, Best. (ed. Rebuffi)
C. Rebuffi, Il “Bestiaire” di Pierre de Beauvais. Edizione critica, tesi datt.,
Pavia 1971-1972.
Pierre, Best. (vers. corta)
G.R. Mermier, Le Bestiaire de Pierre de Beauvais (Version courte), Paris,
A.G. Nizet 1977.
Philippe, Best.
Il “Bestiaire” di Philippe de Thaün, in Morini 1996, pp. 103-285.
Pitra 1855
J.B. Pitra, Spicilegium Solesmense, III, Parisiis.
Plinio, Nat. hist.
Plotino, Enn.
Plotin, Ennéades, texte établi et traduit par E. Bréhier, 6 voll., Paris, Les
Belles Lettres 1960-1963.
Plutarco, De def. orac.
Plutarco, De Is. et Osir.
Plutarco, Iside e Osiride, introduzione di D. Del Corno, trad. e note di M.
Cavalli, 2a ed., Milano, Adelphi 1986.
Porsia 1976
Liber monstrorum, a cura di F. Porsia, Bari 1976.
Prière de Jésus
Un moine de l'Eglise d'Orient, La prière de Jésus, Paris, Chevetogne 1963.
Propriétés des choses
Raynaud, Le poème moralisé sur les propriétés des choses, in “Romania”,
14, 1885, pp. 487-537.
Prudencio, Obras
Prudencio, Obras completas, ed. J. Gayo, Madrid, B.A.C. 1943.
Prudenzio, Carm.
Aurelii Prudentii Clementis Carmina, ed. M.P. Cunningham, Turholti,
Brepols (CC 126) 1966.
194
Prudenzio, Hamart,
Prudenzio, Hamatigenia, introduzione, traduzione e commento a cura di
Roberto Palla, Pisa, Giardini 1981.
Raimbaut d'Aurenga
W.T. Pattison, The Life and Works of the Troubadour Raimbaut d'Orange,
Minneapolis, The University of Minnesota Press 1952.
Rigaut de Berbezilh
Rigaut de Berbezilh, Liriche, a cura di A. Varvaro, Bari, Adriatica Editrice
1960.
Rosario 1926
Cecco d'Ascoli, L'Acerba, a cura di P. Rosario, Lanciano, Carabba.
Rumi, Poesie
Rumi, Poesie mistiche, a cura di A. Bausani, 5 ed., Milano, Rizzoli 1994.
RVF
F. Petrarca, Il Canzoniere, a cura di M. Santagata, Mondadori, Milano 1996.
Sacchi 1981
P. Sacchi, a cura di, Apocrifi dell'Antico Testamento, Torino, UTET.
Sanguineti 1965
I sonetti della Scuola siciliana, a cura di E. Sanguineti, Torino, Einaudi.
Segre 1953
C. Segre, Volgarizzamenti del Due e Trecento, Torino, UTET.
Simonetti 1993
Testi gnostici in lingua greca e latina, a cura di M. Simonetti, Milano,
Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori.
Solino, Collect.
C. Iulii Solini, Collectanea rerum memorabilium, a cura di T. Mommsen,
Berlin, Weidmannschen 1895.
Tesoro
Il Tesoro di B. Latini volgarizzato da Bono Giamboni, ed. L. Carrer, 2 voll.,
Venezia 1839.
195
Testi buddhisti
Testi buddhisti in sanscrito, a cura di R. Gnoli, Torino, UTET.
Testi egizi
Testi religiosi egizi, a cura di S. Donatoni, Torino, UTET.
Testi gnostici
Testi gnostici, a cura di M. Simonetti, Torino, UTET.
Thorndike 1949
L. Thorndike, The “Sphere” of Sacrobosco and its Commentators, The
University of Chicago Press, Chicago, pp. 343-411.
Tommaso Cant., De nat. rerum
Thomas Cantimpratensis, Liber de natura rerum, ed. H. Boese, Teil I: Text,
Berlin-New York, 1973.
Tresor
Brunetto Latini, Li Livres dou Tresor, ed. F.J. Carmody, Berkeley, Calif.
1948.
Ugo di San Vittore, De tribus diebus
Ugo di S. Vittore, I tre giorni dell'invisibile luce. L'unione del corpo e dello
spirito, a cura di V. Liccaro, Firenze, Sansoni.
Ugo di San Vittore, Didasc.
Ugo di San Vittore, Didascalicon, intr., trad., e note di V. Liccaro, Milano,
Rusconi 1987.
Verbo degli uccelli
Farîd ad-dîn ’Attâr, Il verbo degli uccelli, a cura di C. Saccone, SE, Milano
1986.
Wilhelm 1960
F. Wilhelm, Denkmäler deutscher Prosa des 11. und 12. Jhs., München.
Zambon 1999
Richard de Fournival, Il bestiario d'amore, a cura di F. Zambon, 4a ed.,
Milano, Luni.
196
b) Studi
Agamben 1977
G. Agamben, Stanze, Torino, Einaudi.
Alessandrini 1955
M. Alessandrini, Cecco d'Ascoli, Firenze.
Assunto 1961
R. Assunto, La critica d'arte nel pensiero medioevale, Milano, Il Saggiatore.
Baltrusaitis 1988
J. Baltrusaitis, Medioevo fantastico, trad. it., Milano, Adelphi.
Baltrusaitis 1999
J. Baltrusaitis, Risvegli e prodigi. La metamorfosi del gotico, trad. it.,
Milano, Adelphi.
Bariola 1879
F. Bariola, Cecco d'Ascoli e l'Acerba, in “Rivista Europea”. 15.
Battelli 1927
G. Battelli, Il lapidario dell'Acerba, in “Rassegna”, 35, pp. 205-211.
Beatrice 1971
P.F. Beatrice, L'allegoria nella Psychomachia di Prudenzio, in “Studia
Patavina”, 17, 1971, pp. 25-73.
Benoist 1975
L. Benoist, Signes, symboles et mythes, Paris, PUF.
Berger de Xivrey 1836
J. Berger de Xivrey, Traditions tératologiques, ou récits de l'antiquité et du
Moyen Age en occident sur quelques points de la fable, du merveilleux et de
l'histoire naturelle, Paris.
Bianchini 1996
S. Bianchini, Cielo d'Alcamo e il suo contrasto. Intertestualità romanze
nella scuola poetica siciliana, Messina, Rubbettino.
Bianciotto 1984
197
G. Bianciotto, Sur le “Bestiaire d'Amour” de Richard de Fournival, in
Epopée animale, pp.
Bichon 1976
J. Bichon, L'animal dans la littérature française aux XIIème et au XIIIème
siècles, 2 voll., Lille, Université de Lille III.
Bologna 1980
C. Bologna, Mostro, in Enciclopedia, IX, Torino, Einaudi, pp. 556-580.
Brugnolo 1995
F. Brugnolo, La Scuola poetica siciliana, in Storia della letteratura italiana,
diretta da E. Malato, I: Dalle Origini a Dante, Roma, Salerno, pp. 265-337.
Bruni 1990
F. Bruni, La cultura alla corte di Federico II e la lirica siciliana, in Storia
della civiltà letteraria italiana, I: G. Bàrberi Squarotti, F. Bruni, V. Dotti,
Dalle Origini al Trecento, Torino, UTET, pp. 210-273.
Cames 1971
G. Cames, Allégories et symboles dans l'Hortus deliciarum, Leiden, E.J.
Brill.
Cantini 1931
G. Cantini, De fontibus Sermonum s. Antonii, qui in editione Locatelli
continentur, in “Antonianum”, 6, 1931, pp. 354-360.
Cantini 1934
G. Cantini, La tecnica e l'indole del Sermone medievale ed i Sermoni di s.
Antonio di Padova, in “Studi francescani”, 31, 1934, pp. 60-80 e 195-224.
Carmody 1938
F.J. Carmody, De bestiis et aliis rebus and the Latin Physiologus, in
“Speculum”, 13, pp. 153-159.
Castelli 1892
G. Castelli, La vita e le opere di Cecco d'Ascoli, Bologna.
Charbonneau-Lassay 1940
L. Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire du Christ, Paris-Liège, Desclée de
Broower [rist. anast. Milano, Arché 1975].
Chaytor 1945
198
H.J. Chaytor, From Script to Print, Cambridge.
Chenu 1972
M.D. Chenu, La teologia nel Medio Evo. La Teologia nel sec. XII, trad. it.,
Milano, Jaca Book.
Cian 1902
V. Cian, Vivaldo Belcalzer e l'enciclopedismo italiano, in “Giornale Storico
della Letteratura Italiana”, Suppl. n. 5, pp. 1-192.
Clark 1982
W.B. Clark, The illustratrated medieval Aviary and the lay brotherhood, in
“Gesta”, 21, pp. 63-74.
Contini 1979
G. Contini, Saggio d'un commento alle correzioni del Petrarca volgare, in
Id., Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), 2a ed.,
Einaudi, Torino.
Coomaraswamy 1987
A.K. Coomaraswamy, Il mare [1947], trad. it. in Id., Il grande brivido.
Saggi di simbolica e arte, Milano, Adelphi, pp. 355-361.
Coomaraswamy 1977
A.K. Coomaraswamy, Come interpretare un'opera d'arte, Milano, Rusconi.
Corbin 1958
H. Corbin, L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn 'Arabi, Paris,
Flammarion.
Corbin 1971
H. Corbin, En Islam iranien, II. Sohravardî et les Platoniciens de Perse,
Gallimard, Paris.
Costa 1981
B. Costa, Le fonti dei “Sermones” di sant'Antonio, in Smalley e Costa 1981,
pp. 23-24.
Costantini e Camuffo 1988
A.M. Costantini e M.L. Camuffo, Il “Fiore di virtù”: una nuova fonte per
l'“Acerba”, in “Rivista di Letteratura italiana”, 6, pp. 247-258.
Cotogni 1936
199
L. Cotogni, Sovrapposizione di Visioni e di Allegorie nella Psychomachia di
Prudenzio, in “Rendiconti della R. Accademia Nazionale dei Lincei”, Serie
VI, 12.
Crespi 1929
F. Crespi, La dottrina d'amore nell'“Acerba” di Cecco d'Ascoli, in
“Giornale Storico della Letteratura Italiana”, 93.
Crespo e Frade 1967
F. Crespo e F. Frade, Anotações e comentàrios sobre o “Livro das Aves”, in
“Geographica”, 9, pp. 21-39.
Da Gama Caeiro 1966
F.J. Da Gama Caeiro, Nature et symbole chez s. Antoine de Padoue, in La
filosofia della natura nel medioevo. Atti del terzo congresso internazionale
di filosofia medioevale. Passo della Mendola (Trento), 31 agosto - 5
settembre 1964, Milano 1966, pp. 363-371.
Darrel Jackson 1969
B. Darrel Jackson, The Thoery of Signs in Saint Augustine's “De Doctrina
christiana”, in “Revue des études augustiniennes”, 15, pp. 9-49.
Davy 1964
M.-M. Davy, Initiation à la symbolique romane. XIIe siècle, Paris,
Flammarion.
De ave phoenice
De Bruyne 1946
E. de Bruyne, Etudes d'esthétique médiévale, 3 voll., Brugge, De Tempel
[rist. Paris, Albin Michel 1998].
De Bruyne 1963
E. de Bruyne, Historia de la estética, II. La antigüetad cristiana. La Edad
Media, trad. spagnola, Madrid, B.A.C.
De Champeaux e Steckx 1972
G. de Champeaux e dom S. Sterckx, Introduction au monde des symboles,
2e éd., La Pierre-qui-vire, Zodiaque.
De Clercq 1962
Ch. de Clercq, Le rôle de l'image dans un manuscrit médiéval (Bodleian,
Lyell 71), in “Gutenberg Jahrbuch”, 37, pp. 23-30.
200
De Clercq 1963
Ch. de Clercq, Hugues de Fouilloy, imagier de ses propres oeuvres?, in
“Revue du Nord”, 45, pp. 31-42.
De Clercq 1970
Ch. de Clercq, La nature et le sens du “De avibus” d'Hugues de Fouilloy, in
“Miscellanea Mediaevalia”, 7, pp. 279-302.
Detienne 1975
M. Detienne, I Giardini di Adone, trad, it., Torino, Einaudi 1975.
Doimi 1947
S. Doimi, Le scienze naturali in sant'Antonio, in S. Antonio Dottore della
Chiesa. Atti delle settimane antoniane tenute a Roma e a Padova nel 1946,
Città del Vaticano 1947, pp. 437-459.
Duby 1979
G. Duby, Saint Bernard, l'art cistercien, Paris, Flammarion.
Dolcetti Corazza 1992
V. Dolcetti Corazza, Il Fisiologo nella tradizione letteraria germanica,
Alessandria, Edizioni dell'Orso.
Duncan 1924
Th. S. Duncan, The Wesel in Religion, Myth and Superstition, in
“Washington University Studies”, Human. Series, 12, pp. 33-66.
Eliade 1962
M. Eliade, Mefistophélès et l'androgyne, Paris, Gallimard.
Eliade 1971
M. Eliade, La nostalgie des origines, Paris, Gallimard.
Eliade 1977
M. Eliade, Forgerons et alchimistes, nouv. éd. corrig. et augm., Paris,
Flammarion.
Epopée animale
Epopée animale, fable, fabliau. Actes du IVe Colloque de la Société
Internationale Renardienne (Evreux, 7-11 septembre 1981), Paris, P.U.F.
1984.
201
Evdokimov 1972
P. Evdokimov, L'art de l'icône. Théologie de la beauté, Paris-Liège, Desclée
de Brouwer.
Favati 1963
G. Favati, Una traccia di cultura neoplatonica in Chrétien de Troyes: il
tema degli occhi come specchio ("Cligès", vv. 629-749), in Studi in onore di
Carlo Pellegrini, Torino, pp. 3-13.
Ferrua 1942
A. Ferrua, Il Bestiario di Cristo, in “La Civiltà Cattolica”, 2, pp. 22-30.
Folena 1965
G. Folena, Cultura e poesia dei Siciliani, in E. Cecchi e N. Sapegno, Storia
della Letteratura italiana, I: Le Origini e il Duecento, Milano, Garzanti, pp.
271-347.
Festugière 1944
A.-J. Festugière, La Révélation d'Hermès Trismégiste, 3 voll., Paris, Les
Belles Lettres.
Fratta 1996
A. Fratta, Le fonti provenzali dei poeti della Scuola siciliana. I postillati del
Torraca e altri contributi, Firenze, Le Lettere.
Frizzi 1877
E. Frizzi, Saggio di studi sopra Cecco d'Ascoli, in “Propugnatore”, 10.
Garver 1907
M.S. Garver, Sources of the beast similes in the Italian lyric of the thirteenth
century, in “Romanische Forschungen”, 21, pp. 176-320.
Gaspary 1882
A. Gaspary, La Scuola poetica siciliana del secolo XIII, trad. it., Livorno,
Vigo 1882.
Gatti Perer 1983
“La dimora di Dio con gli uomini” (Ap 21,3). Immagini della Gerusalemme
celeste dal III al XIV secolo, a cura di M.L. Gatti Perer, Milano, Vita e
Pensiero.
Gerhardt 1970
202
M.I. Gerhardt, Zoologie médiévale: préoccupations et procédés, in
“Miscellanea Mediaevalia”, 7, pp. 231-248.
Ghinassi 1965
G. Ghinassi, Nuovi studi sul volgare mantovano di Vivaldo Belcalzer, in
“Studi di Filologia italiana”, 23, pp. 19-172.
Giacon 1945
B. Giacon, Le scienze naturali nei Sermoni di s. Antonio di Padova Dottore
evangelico, Padova 1945, pp. 141-147.
Gnilka 1963
G. Gnilka. Studien zur Psychomachie des Prudentius, Wiesbaden.
Gobry 1969
I. Gobry, Hugues de Fouilloy, in Dictionnaire de Spiritualité, VII, Paris,
Beauchesne, col. 880-886.
Goldstaub 1895
M. Goldstaub, Zwei Beschwörungsartikel der Physiologus-Literatur, in
Abhandlungen Tobler, Halle 1895.
Graves 1963
R. Graves, I miti greci [1955], trad. it., Milano, Longanesi 1963.
Gregory 1966
T. Gregory, L'idea di natura nella filosofia medievale prima dell'ingresso
della “Fisica” di Aristotele, in La filosofia della natura nel Medioevo,
Milano 1966.
Guénon 1945
R. Guénon, Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, Paris,
Gallimard.
Guénon 1990
R. Guénon, Simboli della Scienza sacra [1962], 1a ed. “Gli Adelphi”,
Milano, Adelphi.
Haering 1979
N. Haering, Notes on the “Liber Avium” of Hugues of Fouilloy, in
“Recherches de Théologie ancienne et médiévale”, 46, pp. 53-83.
Henkel 1976
203
N. Henkel, Studien zum Physiologus im Mittelalter, Tübingen.
Herzog 1966
R. Herzog, Die allegorische Dichtkunst des Prudentius, Muenchen.
Hippeau 1860
Ch. Hippeau, Introduction a Richard de Fournival, Le Bestiaire d'Amour,
suivi de la Réponse de la Dame, Paris [rist. anast. Genève, Slatkine 1969].
Hist. litt. de France
Histoire littéraire de France, ouvrage commencé par les bénédictins de la
Congrégation de Saint-Maure et continué par les membres de l'Institut, Paris
1733-1974.
Hubaux e Leroy 1939
J. Hubaux e M. Leroy, Le mythe du phénix dans les littératures grecque et
latine, Liège, Fac. de Philosophie et Lettres; Paris, Droz.
Izzi 1982
M. Izzi, I mostri e l'immaginario, Roma, Edizioni del Graal 1982.
Jonas 1978
H. Jonas, La religion gnostique [1958], trad. francese, Paris, Flammarion.
Kantorowicz 1994
E. Kantorowicz, Federico II imperatore, trad. it., 2a ed., Milano, Garzanti.
Klingender 1971
F.D. Klingender, Animals in Art and Thought to the End of the Middle Ages,
London.
Lauchert 1889
F. Lauchert, Geschichte des Physiologus, Strassburg, K.J. Truebner [rist.
anast. Genève, Slatkine 1974].
Lauchert 1890
F. Lauchert, Zum Physiologus: Der tiergeschichtliche Abschnitt der Acerba
des Cecco d'Ascoli, eine Bearbeitung des Physiologus, “Romanische
Forschungen”, 5, pp. 1-12.
Le Goff 1977
204
J. Le Goff, L'Occidente medievale e l'Oceano Indiano: un orizzonte onirico
[1970], in Id., Tempo della Chiesa e tempo del mercante, trad. it., Torino,
Einaudi, pp. 257-277.
Leclercq 1983
J. Leclercq, Cultura umanistica e desiderio di Dio. Studio sulla letteratura
monastica del Medio Evo [1957], trad. it., Firenze, Sansoni.
Lucken 1992
Ch. Lucken, Du ban du coq à l'“Ariereban” de l'âne (A propos du
“Bestiaire d'Amour” de Richard de Fournival, in “Reinardus”, 5, pp. 109124.
Malaxecheverria 1982
I. Malaxecheverria, Le bestiaire médiéval et l'archétype de la féminité, in
“Circé”, 12-13.
Malaxecheverria 1986
Bestiario medieval, ed. a cargo de I.M. Malaxecheverria, Madrid, Siruela.
Mâle 1958
E. Mâle, L'Art religieux du XIIIe siècle en France, 2 voll., 8a ed., Paris,
Colin.
Manitius 1931
M. Manitius, Geschichte der Lateinischen Literatur des Mittelalters,
München.
Marangon 1976
P. Marangon, S. Antonio, Rolando da Cremona e la nuova cultura. Spunti
per una ricerca, in “Il Santo”, 16, fasc. 1, genn.-apr. 1976, pp. 131-137.
Marangon 1977
P. Marangon, alle origini dell'aristotelismo padovano (sec. XII-XIII),
Padova 1977, pp. 38-39.
Marrou 1958
H.-I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, De
Boccard.
Martins 1963
M. Martins, O Livro das Aves, in “Brotéria”, 77, pp. 413-416.
205
Mazzantini 1929
Mazzantini rec. a Crespi 1927, in “Giornale Storico della Letteratura
Italiana”, 94.
McCulloch 1962
F. McCulloch, Mediaeval Latin and French Bestiaries, Chapel Hill,
University of Carolina Press.
Méla 1992
Ch. Méla, Introduction a Chrétien de Troyes, Cligès, Paris, Le Livre de
Poche.
Muratova 1977
X. Muratova, “Adam donne leurs noms aux animaux”. L'iconographie de la
scène dans l'art du Moyen Age: les manuscrits des bestiaires enluminés du
XIIe et du XIIIe siècles, in “Studi medievali”, 18.
Muratova 1984
X. Muratova, Problèmes de l'origine et des sources des cycles d'illustrations
des manuscrits des bestiaires, in Epopée animale, pp. 383-408.
Ohly 1977
F. Ohly, Probleme der mittelalterlichen Bedeutungsforschung und das
Taubenbild des Hugo de Folieto, in Id., Schriften zur mittelalterlichen
Beteungsforschung, Darmstadt, Wissenschafliche Buchgesellschaft, pp. 3292.
Ohly 1985
F. Ohly, “Deus geometra”. Appunti per la storia di una rappresentazione di
Dio [1982], in Id., Geometria e memoria. Lettera e allegoria nel Medioevo,
trad. it. Bologna, Il Mulino, pp. 189-247.
Pallis 1969
M. Pallis, Il Loto e la Croce [1968], trad. it., Torino, Borla.
Panvini 1962
B. Panvini, Le Rime della Scuola siciliana, I: Introduzione - Testo critico Note, Firenze, Olschki.
Panvini 1994
B. Panvini, Poeti italiani della corte di Federico II, Napoli, Liguori.
Pastore Stocchi 1981
206
M. Pastore Stocchi, Aspetti letterari nei “Sermones” antoniani, in Poppi
1982, pp. 55-70.
Peltier 1946
H. Peltier, Hugues de Fouilloy, chanoine régulier, prieur de Saint-Laurentau-Bois, in “Revue du Moyen Age latin”, 2, pp. 25-44.
Perry 1950
B.E. Perry, Physiologus, in Pauly-Wissowa, Real-Encyclopaedie des
classischen Altertumwissenschaft, Neue Bearbeitung. XX, col. 1074-1129.
Peterson 1954
E. Peterson, Die Spiritualität des
“Byzantinische Zeitschrift”, pp. 60-72.
griechischen
Physiologus,
in
Petrocchi 1965
G. Petrocchi, Cultura e poesia del Trecento, in Storia della Letteratura
italiana, II, Milano, Garzanti, pp. 559-724.
Pfister 1912
F. Pfister, Die Historia de preliis und das Alexanderepos des Quilichinus, in
"Münchener Museum für Philologie des Mittelalters und der Renaissance",
Bd. 1, Heft 2, 1912.
Poirion 1988
D. Poirion, Histoires dites naturelles, in Le Bestiaire, pp. 11-51.
Polak 1972
L. Polak, Cligès, Fénice et l'arbre d'amour, in “Romania”, 93, 1972, pp.
304-316.
Pollmann 1971
L. Pollmann, Zur Struktur der “Psychomachia” von Prudentius, in
Mélanges Boutière, Liège, I, pp. 481-500.
Poppi 1982
Le fonti e la teologia dei Sermoni antoniani, a cura di A. Poppi, Padova,
Edizioni Messaggero.
Pozzi 1981
G. Pozzi, La parola dipinta, Milano, Adelphi.
Puech 1888
207
A. Puech, Prudence. Etude sur la poésie latine chrétienne, Paris.
Puech 1979
H.-Ch. Puech, Sur le manichéisme et autres essais, Paris, Flammarion.
Rahner 1971
H. Rahner, La nascita di Dio, in Id., L'ecclesiologia dei Padri, Roma,
Edizioni Paoline, pp. 13-143.
Rapisarda 1959
E. Rapisarda, Poesia e religiosità: Cristo e l'Eucarestia in Prudenzio, in
Convivium dominicum. Studi sull'Eucarestia nei Padri della Chiesa e
Miscellanea Patristica, Catania.
Réau 1955
L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, I, Paris, PUF.
Ripanti 1980
G. Ripanti, Agostino teorico dell'interpretazione, Brescia, Paideia Editrice.
Roques 1975
M. Roques, Tératologie et théologie chez Jean Scot Erigène, in Id., Libres
sentiers vers l'érigénisme, Roma.
Rossi 1903
Rossi, rec. a Castelli 1892, in “Giornale Storico della Letteratura Italiana”,
21, pp. 389-391.
Roy 1974
B. Roy, La belle e(s)t la bête. Aspects du bestiaire féminin au moyen âge, in
“Etudes françaises”, 10.
Rowland 1989
Sanson 1980-1981
M. Sanson, Il “De avibus” di Ugo di Fouilloy. Fonti e simbolismo, Tesi di
perfezionamento, Università di Padova.
Santagata 1990
M. Santagata, Per moderne carte, Il Mulino, Bologna.
Santangelo 1928
208
S. Santangelo, Le tenzoni nella letteratura italiana delle origini, Genève,
Olschki.
Sbordone 1936
F. Sbordone, Ricerche sulle fonti e sulla composizione del Physiologus
greco, Napoli, G. Torella.
Sbordone 1949
F. Sbordone, La tradizione manoscritta del “Physiologus” latino, in
“Athenaeum”, Nuova Serie, 27, pp. 246-280.
Schneider 1986
M. Schneider, Gli animali simbolici e la loro origine musicale nella
mitologia e nella scultura antiche [1946], trad. it. Milano, Rusconi.
Schneider 1976
M. Schneider, Pietre che cantano, trad. it., Milano, Archè.
Smalley 1982
B. Smalley, The use of Scripture in St. Antony's “Sermones”, in Poppi 1982,
pp. 285-297.
Smalley e Costa 1981
B. Smalley e B. Costa, Le fonti dei “Sermones” antoniani, Padova.
Strubel 1975
A. Strubel, “Allegoria in factis” et “allegoria in verbis” in “Poétique”, 23,
pp. 342-357.
Tardieu 1974
M. Tardieu, Trois mythes gnostiques. Adam, Eros et les animaux d'Egypte
dans un Écrit de Nag ‘Hammadi (II, 5), Paris.
Tartaro 1971
A. Tartaro, Studio della “Commedia” e poemi dottrinali, in Letteratura
Italiana Laterza. Il Trecento, I, Bari, Laterza.
Tatarkiewicz 1979
W. Tatarkiewicz, Storia dell'estetica, II. L'estetica medievale [1970], trad.
it., Torino, Einaudi.
Todorov 1977
T. Todorov, Théories du symbole, Paris, Ed. du Seuil.
209
Todorov 1978
T. Todorov, Symbolisme et interprétation, Paris, Ed. du Seuil.
Treu 1959
U. Treu, Ottergezücht. Ein patristischer Beitrag zur Quellekunde des
Physiologus, in “Zeitschrift für d. neutestamentliche Wissenschaft”, 50, pp.
103-123.
Treu 1966
U. Treu, Zur Datierung des Physiologus, in “Zeitschrift für d.
neutestamentliche Wissenschaft”, 57, pp. 101-104.
Valli 1928
L. Valli, Il linguaggio segreto di Dante e dei “Fedeli d'Amore”, Roma [rist.
Luni, Milano 1994].
Van den Broeck 1972
R. Van den Broek, The Myth of the Phoenix according to Classical and
Early Christian Traditions, Leiden, E.J. Brill.
Vuolo 1962
Il Mare Amoroso, a cura di E. Vuolo, Roma, Istituto di Filologia Moderna.
Weil 1974
S. Weil, Lettre à un religieux, Paris, Éd. du Seuil.
Yates 1972
F. Yates, L'arte della memoria [1966], trad. it., Torino, Einaudi.
Zambon 1980
F. Zambon, “Allegoria in verbis”: per una distinzione tra simbolo e
allegoria nell'ermeneutica medievale, in Simbolo, metafora, allegoria,
Padova, Liviana, pp. 73-106.
Zambon 1983
F. Zambon, Sulla fenice del Petrarca, in Miscellanea di studi in onore di
Vittore Branca, I: Dal Medioevo al Petrarca, Olschki, Firenze 1983, pp.
411-425.
Zambon 1990
Il Fisiologo, a cura di F. Zambon, 3a ed., Milano, Adelphi 1990.
210
Zambon 1997
F. Zambon, Il romanzo in prosa, in La letteratura francese medievale, a
cura di M. Mancini, Bologna, Il Mulino 345-385.
Zolla 1973
E. Zolla, Storia del fantasticare, 2a ed., Milano, Bompiani.
Zolla 1975
E. Zolla, Le meraviglie della natura. Introduzione all'alchimia, Milano,
Bompiani.
211
Scaricare