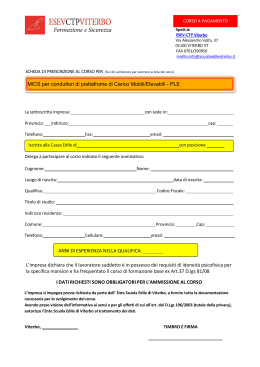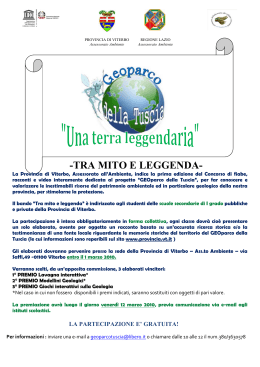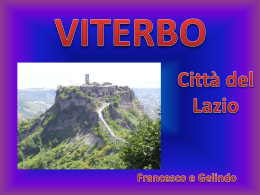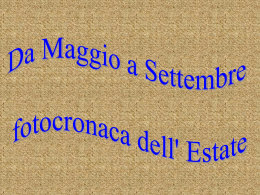Associazione Teatrale Pescara Colli affiliata Domenica 4 dicembre 2011 L’Associazione Teatrale PerStareInsieme organizza la quarta gita, nella quale si abbinano religione, cultura e spettacolo. Nel ringraziarvi per la partecipazione a questo importante appuntamento culturale, vi auguriamo una buona giornata con la speranza che il programma che è stato predisposto sia di vostro gradimento. Questo semplice opuscolo per le notizie generali sui luoghi da visitare, sul programma e su quanto ci è sembrato utile sottoporre alla vostra attenzione. Affinché possa essere garantita una buona riuscita dell’evento, è necessario attenersi agli orari ed al programma sotto riportati. Per qualsiasi informazione ed esigenza rivolgersi a Ferdinando (cell. 3401483349). Grazie e buona giornata a tutti. PROGRAMMA Ore 6,30 – Partenza da Via Di Sotto (Piazzale Conad). Ore 10,30 – S. Messa nel Convento delle Clarisse di Santa Rosa. Visita libera al Convento e/o al Centro Storico di Viterbo. Ore 13,30 – Pranzo al sacco condiviso presso il Convento. Ore 15,00 – Partenza per Civitavecchia. Ore 16,00 – Ritrovo al Teatro Traiano per ritirare i biglietti al botteghino. Ore 19,30 circa – Partenza da Civitavecchia. Ore 23,30 circa – Rientro a Pescara. È prevista una sosta lungo il percorso. L'area di Viterbo era conosciuta con il nome di Surrenà quindi Tuscià così chiamata dalla popolazione etrusca che un tempo viveva al nord del Lazio. La regione Viterbese è indubbiamente una zona ricca di storia e arte, una delle meglio conservate in Italia, importante testimonianza del genio e del mistero degli Etruschi. Secondo i documenti storici, l'area Viterbese fu poi sotto il dominio di Roma e nel secolo VIII, la città prese il nome di Castrum Viterbii. Fu poi fortificata nel 773 dal Re dei Longobardi Desiderius nel tentativo di conquistare Roma. Da allora la città divenne la seconda roccaforte del Papato e prese il nome di Città dei Papi. Durante la lunga controversia tra la Chiesa Cattolica e l'Impero, Viterbo si sviluppo come libero comune, dopodiché con il supporto dei Franchi la città venne inclusa nello Stato Papale. Nel 1164 tramite il Barbarossa Viterbo divenne dimora fissa dell'anti-Papa Pasquale III, che usò la milizia della città contro la Roma del Papato. Nel 1172 la città divenne un prosperoso comune, uno dei più importanti del centro Italia con circa 60.000 abitanti. Verso il 1207 la città venne scomunicata dal Vaticano perché dimora dei Papi eretici e fu poi sconfitta da Roma. Per tutto il secolo XIII la città di Viterbo fu alternativamente governata dalla tirannia delle famiglie Gatti e Di Vico e, in quanto simpatizzante dei Guelfi, divenne dimora fissa dei Papi Alessandro IV e Urbano IV che fu eletto nella città. Altri furono poi i Papi eletti in Viterbo tra cui ricordiamo Gregorio IX (nel 1271), Giovanni XXI (nel 1276), Nicola III e il francese Martino IV. La città in effetti ha sempre vissuto le vicissitudini del Papato e la sua storia offre un differente percorso solo dal 1879 quando divenne poi parte della storia dell'Italia intera. Chiese, piazze, palazzi, porte e fontane Palazzo Del Podestà Attuale sede degli uffici comunali, venne eretto nel 1264 quale Palazzo del Capitano del Popolo. Subì numerosi rifacimenti in epoche successive e nel 1700 fu inserito il grande balcone al primo piano. Dell’antico prospetto rimangono solo poche tracce. Sono visitabili, ad ingresso gratuito, tutti i giorni dalle ore 9,00 (domenica ore 10,00) alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Palazzo Papale Venne costruito su commissione di Raniero Gatti nel 1266 al fine di offrire ai pontefici ospiti della città una dimora sicura. Tale decisione coincise con l’iniziativa intrapresa nel 1257 da Alessandro IV il quale, preoccupato per l’instabilità politica presente a Roma, ritenne opportuno trasferire la sede pontificia in una città, in cui fosse più facile riorganizzare la resistenza guelfa. Il colonnato, oggi presente solo sul lato meridionale, si estendeva in principio anche su quello opposto ed aveva la funzione di reggere l’originaria copertura della loggia. L’interno, articolato in una serie di ambienti che hanno subito grosse modifiche tra il XV e il XVII secolo, è in primo luogo rappresentato dalla Sala del Conclave, che occupa il secondo piano di quello che oggi viene definito l’edificio merlato. Anche se più tarda rispetto al resto della struttura, essa accolse uno degli eventi più importanti nella storia dello Stato Pontificio, vale a dire il Conclave per l’elezione di Gregorio X, conclusosi dopo 33 mesi. Gli spazi interni sono illuminati da 12 bifore a tutto sesto, sormontate da monofore rettangolari e composte da archetti trilobati poggianti su una colonnina centrale e due piccole semicolonne laterali. Palazzo Farnese L'origine del palazzo è legata alla famiglia dei Tignosi: come intuibile dalle caratteristiche architettoniche del portone d'ingresso e del cortile, la fondazione dovette avvenire nella seconda metà del XIII secolo. La famiglia Farnese, da cui oggi il palazzo prende il nome, se ne impossessò in occasione degli stretti rapporti intercorsi con Viterbo, quando nel 1431 Ranuccio Farnese venne incaricato di difendere la città dai continui attacchi dei Di Vico. Palazzo degli Alessandri Venne edificato nel corso del XIII secolo, in un periodo di grande espansione sia della città che della classe aristocratica. Pochi anni più tardi il palazzo rischiò di essere distrutto a seguito dell'abbandono della città da parte della famiglia Alessandri e dei Gatti per aver fatto parte della fazione guelfa: fu Innocenzo IV a fermare l'azione dei Tignosi e dei Cocco e a voler salvaguardare il palazzo. Palazzo Chigi Eretto nella seconda metà del Quattrocento per volere della famiglia Caetani, mercanti pisani trasferitisi nella città, l’edificio fu acquistato dai Chigi nel primo decennio del Cinquecento. Palazzo Poscia Appartenente ad una delle più illustri famiglie della città, è un chiaro esempio dell’edilizia privata viterbese del XIV secolo, caratterizzata principalmente dalle case con scala esterna, detta “profferlo”, assimilazione di forme già radicate in ambito rurale. Palazzo Pamphili Fu fatto costruire all'inizio del 1400 dai monaci di San Martino che si venivano a rifugiare qui quando c'era qualche guerra ed era pericoloso restare nella loro abbazia. Nel 1564, quando il fratello del papa e sua moglie, Donna Olimpia Maidalchini, diventarono principi di San Martino, anche il Palazzo dell'Abate diventò di loro proprietà. Cattedrale di S. Lorenzo La chiesa sorge sul colle del Duomo, ritenuto il più antico nucleo abitato della città di Viterbo, già abitato fin dal tempo degli Etruschi. Ne sono un’eloquente testimonianza alcune pietre arcaiche di un antico pagus (termine riferito al diritto amministrativo romano per indicare una circoscrizione territoriale rurale) all’ingresso della piazza S. Lorenzo, La Cattedrale sorge sulle rovine di quel tempio pagano dedicato ad Ercole il cui ricordo è oggi emblematicamente presente nello sguardo "impietrito" del leone nemeo da lui ucciso che, insieme alla palma (conquistata a Ferento al termine di una storica battaglia nel 1172), è lo stemma della città. Chiesa del Gesù Fu eretta a capo della piazza del Mercato, per secoli il centro della vita civica e sociale di Viterbo, ed è citata in documenti pubblici fin dal 1080. Nel XIII secolo, in seguito al cruento omicidio di Enrico di Cornovaglia, la chiesa conosce una fase di decadenza, rimane una parrocchia di secondaria importanza, stretta com’era tra la cattedrale di S. Lorenzo e la collegiata di S. Maria Nuova. Chiesa di S. Giovanni Battista del Gonfalone Costituisce un pregevole esempio di barocco viterbese. Venne eretta a cura della Confraternita del Gonfalone, dalla quale ha preso il nome corrente, anche se la dedica storicamente è al precursore di Cristo. Chiesa della SS.Trinità La chiesa è nota ai viterbesi come Santuario della Madonna Liberatrice, perché legata alla venerazione per la miracolosa immagine della Vergine, attribuita a Gregorio e Donato d’Arezzo. Il miracoloso evento avvenne il 28 maggio 1320: come riferiscono numerosi cronisti locali, il cielo sopra la città si era oscurato in tal misura da terrorizzare la popolazione; schiere di demoni con il corpo di corvi, nottole e aquile si muovevano in quelle tenebre minacciando l’inferno. Nello sgomento e nella paura, apparve la figura della Madonna venerata nella cappella di S. Anna nella chiesa della Trinità, che invitava i viterbesi a recarsi a pregare davanti alla sua immagine. Tutta la città si radunò ai piedi della Vergine, implorandone protezione e immediatamente la preghiera fu accolta. Chiesa del Suffragio Soltanto nel 1618 il "Suffragio", come è chiamato dai Viterbesi, ebbe tal nome. La primitiva costruzione sorta nel piano di San Matteo in Sonsa, era dedicata a S. Quirico, martire di Antiochia, ed aveva aperto la sue porte ai fedeli fin dal sec. XII. Pìù volte è documentata nel Duecento insieme ad altre parrocchie della zona: S. Stefano, S. Matteo e S. Giovanni. Della sua antica architettura sappiamo soltanto che aveva uno spazioso portico dinanzi la facciata, sotto il quale erano usi i notai rogare i loro atti. Chiesa di S. Francesco La costruzione iniziò nel 1237 su un’area dipendente dalla parrocchia di S. Angelo in Spatha, donata ai Francescani da Gregorio IX con bolla del 9 dicembre 1236, ove, agli inizi del millennio, era stato eretto il Castello di Sonza, piccolo fortilizio longobardo. Porta Romana Sulla sua sommità si trova la statua di S. Rosa, Patrona della città, con a fianco gli stemmi di Clemente XI e Innocenzo X, che si recò a Viterbo in occasione del matrimonio di suo fratello Panfilo e donna Olimpia Maidalchini. Fu rifatta in sostituzione di una porta più antica che si apriva sotto la torre, trasformata in campanile della chiesa di San Sisto. Detta, porta Pamphilia o Innocenziana perché venne inaugurata nel 1643 da Innocenzo X venuto a Viterbo a trovare sua cognata Donna Olimpia Pamphili, è ora denominata roamna perché da accesso alla volta di Roma. Porta della Verità Fu chiamata anticamente Porta dell'Abate per la sua vicinanza con l'abbazia di S. Maria della Verità. Sopra la porta sono posti gli stemmi di Benedetto XIII, del governatore Oddi, del vescovo Sermattei e del comune di Viterbo. L'epigrafe, collocata sulla sua sommità, ricorda che nel 1728 per comodità il Comune provvide ad allargare la rozza e vecchia porta ormai in rovina. Porta Fiorentina Chiamata anticamente porta S. Lucia, l'attuale struttura fu realizzata nel 1768, sotto il pontificato di Clemente XIII, per volere del Comune. Sebbene non fu lui a volerne il restauro, lo stemma del papa venne posto sulla sommità della porta insieme a quello del vescovo Giacomo Oddi, del governatore benedetto Lo Presti e, più in basso, del Comune. Porta Faul L’etimologia del monogramma FAUL che denomina la porta, viene fornito dalle fonti gia nel XV secolo, attraverso il sacerdote domenicano Annio da Viterbo, studioso serio, ma pieno di fantasia. Il forte campanilismo e l’ingegno erudita lo portarono a raccontare storie di origini mitologiche della città. Noè aveva fondato quattro castelli: Fanum, Arbanum, Vetulonia, Longola. Le iniziali di questi quattro nomi diedero origine al monogramma. Dall'unione di questi quattro centri sarebbe nata Viterbo. Dopo questo racconto venne messo, sotto la zampa del leone dello stemma, un globo diviso in quattro parti in cui apparivano le lettere F.A.U.L.: appunto le iniziali dei castelli che avevano formato Viterbo. Fontana Grande Costruita nel 1212 per volontà del Comune, Fontana grande è sicuramente la più famosa tra quelle inserite nel tessuto della città. La sua realizzazione venne affidata ai maestri scalepllini Pietro e Bertoldo di Giovanni, i cui nomi sono riportati nell'epigrafe posta nella vasca inferiore della fonte. essa prese il posto di quella che in un documento del Liber Censum è ricordata nel 1192 come fontem Sepalis, sottoposta a lavori di restauro già a partire dal 1206. Tale denominazione appare legata alla presenza di una serie di colonnine unite da barre di ferro orizzontale che fungono da recinto (sepes = ripari). Il centro storico di Viterbo, come avviene in ogni località turistica, offre l’occasione di acquistare prodotti tipici della zona e souvenir. Segnaliamo un negozio di tipicità della Tuscia che si trova in Via Saffi 102 al piano terra del Palazzo Poscia e a due passi da Piazza del Plebiscito. Ejelo, la Bottega del Gojo In dialetto viterbese Ejelo significa “Eccolo” ed è comunemente usato quando qualcuno trova quello che stava cercando. Gojo invece usato per indicare una persona giudicata pazzerellona. Nel negozio si trovano prodotti artigianali realizzati esclusivamente a mano nella Tuscia, specialità gastronomiche e manufatti artistici. Inoltre è possibile trovare vini doc., prodotti biologici e di biocosmesi. Alcuni esempi: tozzetti di viterbesi (biscotti tipo cantucci con la nocciola), rustici alle nocciole (pasta con farina di nocciole), pasta alle castagne, Armerina, Cimina e Francigene (birre artigianali), creme da spalmare a base di nocciole, caffè, latte, Susianella (salame tipico con cuore, fegato, pancetta di maiale), panettone con castagne e nocciole o ricoperto di crema di nocciole, varie spezierie, liquori vari (grappe, amari, liquore di castagne, anisetta). Nata da famiglia di modeste condizioni, a 17 anni entrò nell’ordine delle terziarie dopo aver avuto una visione. In questo periodo fece diversi pellegrinaggi e soprattutto una dura penitenza. Mentre si faceva intensa la guerra tra Guelfi e Ghibellini insieme alla famiglia fu esiliata: tornò in patria dopo la morte di Federico II, ma la sua vita fu assai breve. Sulla sua morte non si sa Polittico. Secondo altare, navata sinistra. Il polittico firmato (sul praticamente nulla solo che listello ai piedi dello scomparto) del maestro viterbese Francesco alcuni anni più tardi il suo corpo d’Antonio Zacchi detto Il Balletta (XV secolo). L’opera, datata 1441, è stato ritrovato intatto. raffigura la Madonna in trono col Bambino tra S. Rosa e S. Caterina La morte di Rosa si d’Alessandria; nelle cuspidi, l’Annunciazione e la Madonna della commemora il 6 marzo. Ma le Misericordia; nei pilastri laterali: S. Giovanni Battista, S. Antonio feste più note in suo onore Abate, S. Margherita, S. Maria Maddalena, S. Ludovico da Tolosa e sono quelle di settembre, che S. Chiara; nella predella: Cristo in pietà tra la Madonna e S. ricordano la traslazione del Giovanni Evangelista e, ai lati, S. Paolo, S. Lorenzo, S. Lucia, S. corpo nell’attuale santuario a lei Biagio, S. Francesco e S. Bartolomeo. dedicato. Il trasporto della Macchina di Santa Rosa è la festa viterbese per antonomasia, dedicata alla patrona Santa Rosa, attraverso una manifestazione unica al mondo, esaltante, quasi indescrivibile per la sua bellezza, spettacolarità ed emozione. La macchina di Santa Rosa consiste in una torre illuminata da fiaccole e luci elettriche, realizzata in metalli leggeri e in materiali moderni quali la vetroresina (che hanno sostituito da diversi anni il ferro, il legno e la cartapesta), alta circa trenta metri e pesante cinque tonnellate che la sera del 3 settembre viene sollevata e portata a spalla da un centinaio di robusti uomini detti "Facchini" lungo un percorso di poco più di un chilometro articolato in vie, talvolta molto strette e piazze del centro cittadino, tra ali di folla in delirio con l'animo sospeso tra emozione, gioia e anche un certo timore. Ma ogni descrizione riportata sulla carta o in video è pressoché inutile in quanto nulla può rendere l'idea se non assistere dal vivo al trasporto delle macchine di santa rosa,sempre capace di suscitare sensazioni nuove seppur nella ripetitività dell'evento che si compie ogni anno. Le origini della Macchina risalgono agli anni successivi al 1258, quando, per ricordare la traslazione del corpo di S. Rosa dalla Chiesa di S. Maria in Poggio al Santuario a lei dedicato, avvenuta il 4 settembre per volere del papa Alessandro IV, si volle ripetere quella processione trasportando un'immagine o una statua della Santa illuminata su un baldacchino, che assunse nei secoli dimensioni sempre più colossali. Il modello attuale è nuovo (dal 2009) e si chiama "Fiore del Cielo" . Il 3 settembre è una giornata tutta particolare per i viterbesi (ma anche per le moltitudini di turisti incuriositi che la manifestazione attira in massa ogni anno, sempre in numero maggiore), molti dei quali scendono in strada fin dalla mattina, ma lo è ancora di più per i facchini, gli "eroi per un giorno" che dal 1978 sono riuniti in sodalizio e si fregiano del titolo di Cavalieri di S. Rosa e che trasportano da sempre le varie macchine. Dopo il pranzo essi, vestiti nella tradizionale divisa bianca con fascia rossa alla vita (il bianco simboleggia la purezza di spirito della patrona, il rosso i cardinali che nel 1258 traslarono il suo corpo), si recano in Comune dove ricevono i saluti delle autorità cittadine, poi vanno in visita a sette chiese del centro, infine in ritiro al convento dei cappuccini, dove il capofacchino impartisce loro le ultime indicazioni sul trasporto. Verso le 20, i Facchini preceduti da una banda musicale che intona il loro inno, partendo dal Santuario di Santa Rosa percorrono a ritroso il tragitto della Macchina, acclamati dalla folla, fino a raggiungere la Chiesa di S. Sisto, presso Porta Romana, accanto alla "mossa". Qui viene impartita loro dal vescovo la cosiddetta benedizione in articulo mortis, che prende in considerazione eventuali incidenti e pericoli. Le varie categorie di facchini, vale a dire i "ciuffi" (dal caratteristico nome del copricapo in cuoio che protegge la nuca agli uomini posizionati nelle nove file interiori), le "spallette" e le "stanghette" (i facchini occupanti le file esterne, rispettivamente laterali e anteriori e posteriori), vanno a prendere posto sotto le travi alla base della Macchina ed ai fatidici ordini del capofacchino "Sotto col ciuffo e fermi!", "Sollevate e fermi!" e quindi "Per Santa Rosa, avanti!" iniziano il difficile percorso. Dopo cinque soste, i facchini devono compiere il grande sforzo finale: percorrere una ripida via in salita che conduce al Santuario. Viene effettuata quasi a passo di corsa, con l'aiuto di corde anteriori in aggiunta e di travi dette "leve" che spingono posteriormente. Quando la gigantesca torcia splendente è posata sui cavalletti di sostegno è stato compiuto un altro trasporto: è il trionfo di un'intera città. I volti dei facchini fino ad allora tesi e angosciati per la fatica del loro atto di devozione diventano sorridenti e commossi per la felicità. La Macchina di Santa Rosa rimane esposta per alcuni giorni successivi al 3 settembre, mentre l'urna dove è custodito il corpo della Patrona è visitata da migliaia di fedeli. . Sull’autore di questa bellissima commedia si trova moltissimo materiale, in quanto Molière è considerato uno dei grandi autori del teatro. Le sue opere sono continuamente rappresentate in tutti i teatri del mondo e sono tradotte in tutte le lingue. Perciò, tralasciando volutamente notizie facilmente reperibili, ci limitiamo ad offrire una nota sulla morte di Molière, quando cala definitivamente il sipario sulla sua arte di attore e autore. Gli ultimi anni di Molière saranno amareggiati dalla rivalità con G.B. Lulli, che ha portato a Parigi l'opera lirica italiana. Prima collaboratore, poi nemico del commediografo, Lulli ha per sé la protezione del re Luigi e il favore di una parte del pubblico. Il 17 febbraio 1673, alla quarta rappresentazione del Malade imaginaíre, Molière, da tempo sofferente di petto, ha sulla scena un attacco del male, ma riesce a vincere la sofferenza e a terminare lo spettacolo. E appena ebbe il tempo di mettersi a letto che la tosse continua da cui era tormentato raddoppiò di violenza. Gli sforzi che fece furono tali che una vena gli si ruppe nei polmoni. Come si rese conto del proprio stato, volse tutti i suoi pensieri al Cielo; un istante dopo perse la parola e rimase soffocato in mezz'ora dalla grande quantità di sangue che gli usciva dalla bocca". Ad assisterlo, oltre a sua moglie Armanda, vi erano due suore, ma nessun prete, malgrado egli l'avesse chiesto. Il giorno dopo, il curato della parrocchia di sant'Eustachio rifiutò alla salma del poeta l'inumazione in terra consacrata, giusta la scomunica che da sempre colpiva gli attori, o, più precisamente, quelli che non facevano in tempo a rinnegare in punto di morte il loro passato e la loro professione. E' Armanda a intervenire presso il re, che raccomanda all'arcivescovo di Parigi di adoperarsi per evitare il nascere di un "caso". Così, onde non nasca un "caso", Molière viene seppellito il 21 febbraio, nel cimitero di San Giuseppe: lo strappo alla regola era stato consentito a condizione che i funerali avessero luogo di notte, senza concorso di pubblico, e in assenza di sacerdoti. Buon amico degli attori italiani, discepolo del napoletano Tiberio Fiorilli (il popolare Scaramouche), l'attore Molière ha "collaborato" con il commediografo, ha contribuito a dargli il senso pratico del teatro, le risorse del mestiere, la conoscenza delle esigenze della scena e dei pubblico. In un tempo in cui imitazioni e rifacimenti sono di largo uso (il che non impedisce ai critici di gridare continuamente al plagio) Molière "prende il suo bene" dovunque lo trovi, ma lo cerca soprattutto negl'intrecci, nei tipi, nelle maschere della commedia dell'arte e della commedia "sostenuta" degli Italiani. Le reminiscenze della commedia latina e della arsa medievale sono insignificanti o di seconda mano. Non si creda tuttavia che Molière si limiti a servirsi con mano maestra degli strumenti dei mestiere o a rifare in meglio soggetti e modelli più o meno venerabili. Nulla di meno libresco delle sue commedie e nulla di più immediato della sua comicità che, traendo materia dell'attenta lettura del gran libro del mondo, è originale creazione di una fantasia che si rivela inesauribile nello scoprire e nell'approfondire i contrasti fra l'uomo e la marionetta, fra la semplicità delle leggi naturali e le stravaganti infrazioni della caricatura. Gli intrecci convenzionali, i luoghi comuni del ridicolo, gli stessi documenti tratti dal vero non danno che lo schema e il canovaccio sul quale l'arte traccia figure, di lieve e indelebile rilievo. Da: www.teatrodinessuno.it presenta Il borghese gentiluomo Con ‘Il borghese gentiluomo’, Molière creò una novità assoluta, non è facile infatti trovare la giusta definizione per questa celebre opera che, riduttivamente, viene definita una comédieballet. L’estrema libertà con cui l’autore tratta la vicenda, i toni farseschi, satireggianti, gli elementi fiabeschi, onirici, la prosa densa di ritmo, la tessitura musicale scritta da JeanBaptiste Lully, la coreografia dei balletti, il tutto, è teso a una teatralità assoluta di grande effetto comico. La trama è molto semplice: un ricco borghese sogna di diventare nobile, lo desidera con tutte le sue forze, lo pretende con un’esaltazione fuori dal comune. Intorno a lui ruota un’umanità di adulatori e di scrocconi, un’umanità priva di autentiche qualità, che si nutre di ‘senso comune’, che ovviamente lo raggira e asseconda la sua follia, pur di ottenerne un guadagno. A questi si contrappone la moglie del protagonista, tutta senso pratico e concretezza, che cerca in ogni modo di farlo rinsavire. Di fronte all’ ennesimo rifiuto del ‘borghese’ di dare in sposa sua figlia al ragazzo che ama, perché privo di nobili natali, tutti d’accordo gli giocano la beffa finale attraverso la famosa ‘Cerimonia Turca’ e anche la moglie che, pur criticandolo aspramente ha fino ad allora cercato di proteggerlo, gli si schiera contro lasciandolo definitivamente solo, nella sua folle utopia. “La nostra lettura di questo grande classico del teatro internazionale – dice Massimo Venturiello – non intende tradire in alcun modo le intenzioni dell’autore, ma al contrario approfondirle, rispettando anzitutto quello spirito di libertà che anima l’intera opera. Non ci saranno pertanto limiti geografici e temporali e l’azione si colloca in una atmosfera visionaria dal sapore napoletano-parigino, con tutto quello che ne consegue, dalla lingua parlata alla musica. In particolare le musiche originali di Germano Mazzocchetti, vanno in questa direzione e accrescono l’ironia insita in tutto il lavoro, ricercando arrangiamenti e sonorità che spaziano dal rinascimento alla sceneggiata napoletana. I brani cantati, alcuni dei quali già previsti dall’autore e le coreografie di Fabrizio Angelini, contribuiscono a ‘mostrare’ la vicenda di questo ‘borghese’ accentuandone con sottile sarcasmo, la miseria ideologica. L’obiettivo da raggiungere è stato quello di costruire un prodotto fortemente popolare, nel senso più alto, capace cioè di coinvolgere e divertire lo spettatore, stimolandone una riflessione, attraverso il racconto di un microcosmo, nel quale, malgrado la lontananza temporale, è facile rispecchiarsi. Non è forse a noi molto vicino questo ‘borghese’, con la sua necessità di adeguarsi al gusto dominante, che nega le sue origini, i suoi valori e che è pronto a trasformarsi in ‘altro da sé e a modificare persino la sua immagine fisica? Non è forse una malattia del nostro tempo quella di inseguire patologicamente un ideale fisico e psichico imposto dai nostri media? Non siamo forse circondati da eterni giovani, da bellezze siliconate, da rampanti pronti a tutto? Questo allestimento rappresenta inoltre una caparbia necessità di mettere in scena il ‘gran teatro’, a dispetto dei tagli e delle logiche di mercato dominanti, che inevitabilmente impongono agli enti privati una linea produttiva restrittiva e di conseguenza pericolosa per il futuro del nostro teatro.” Nella splendida cornice del Teatro dell'Aquila di Fermo, il 27 aprile è stata rappresentata la "Prima" della versione moderna de IL BORGHESE GENTILUOMO, comédie-ballet di Molière, prodotta e allestita dall'Antheia di Roma in collaborazione con Ortomagico Musical di Fermo. Questa spassosissima opera, dal ritmo serrato e travolgente, si snoda intorno alla figura, sempre comicissima, del ricco borghese Monsieur Jourdain (che vorrebbe farsi gentiluomo e si copre invece solo di ridicolo) interpretato da uno straordinario e versatile Massimo Venturiello, qui nella duplice veste di attore e regista, il quale, con magnetica professionalità, ha saputo attribuire al suo personaggio un carattere augusto ed insieme risibile, realizzando appieno il messaggio della satira sferzante. Al suo fianco Tiziana Tosca (Madame Jourdain) la quale come sempre, da grande interprete, ha saputo dominare la scena con estrema naturalezza ed una presenza piena ma insieme leggera e scherzosa, pungente e provocatoria, ammaliando con la sua voce matura e melodica, dalle sfumature a volte quasi jazzistiche. A realizzare la comicissima parodia dell'insegnamento dell'arte e della scienza dell'esser nobili, in una alternanza di truffe e sberleffi, ha affiancato i protagonisti una compagnia di bravissimi attori, quali Camillo Grassi, Franco Silvestri, Elena Jador Braschi, Dario Ciotoli, Mimmo Padrone, Gennaro Cuomo, e Francesca Colapietro, e la giovane di talento Elisa Smerilli. Divertenti le interpretazioni dei "maestri" del borghese (scherma, danza, canto, filosofia, moda) nell'intrecciare rivalità nell'ottenere denaro dal povero truffato e deriso Jourdain. Alla versione originale, il regista Venturiello, da artista qual è, ha saputo porre rivoluzionarie e creative modifiche, pur rimanendo fedele al canovaccio secentesco, riuscendo a ridisegnare un'opera di così difficile definizione attraverso intelligenti spunti di contemporaneità. Primi fra tutti l'ambientazione partenopea della Napoli più anticonformista, simbolo di libertà di stile e genere, in perfetta coesione con la libertà provocatrice di Molière. Degna di nota la gustosa particolarità linguistica, per cui i vari personaggi si esprimono con un diverso dialetto italiano, pittorescamente traduttore del ruolo impersonato. Altro punto di forza dell'opera è stata la frizzante vivacità musicale, di immediata godibilità, con musiche inedite a firma del Maestro Germano Mazzocchetti, noto per le sue straordinarie colonne sonore per la tv, il cinema e il teatro, e la sua singolare unicità di artista nelle produzioni jazzistiche. Realizzando splendidi e variegati affreschi sonori, il compositore è stato magistralmente capace di tradurre l'intento registico di liberarsi dal fraseggio originale minuettistico, poco adatto ad una rinascita culturale, costruendo una partitura nuova e coinvolgente, che pur evocando il microcosmo comico di ambizioni e follie proprie del testo di Molière, attraverso il messaggio musicale conduce lo spettatore nel riconoscere visioni più che mai familiari nel nostro tempo. Geniali la scenografia di Alessandro Chiti, dalle soluzioni pittoriche, architettoniche e prospettiche, e il gioco chiave di luci di Umile Vainieri. Avvincente e coinvolgente la coreografia curata da Fabrizio Angelini, artista completo e firma dei più celebri musicals italiani. Sfarzosi ed efficaci i costumi di Santuzza Calì, con i suoi artistici nastri, piumazzi, sgargianti e chiassosi colori nel vestire di ridicolo il protagonista. Il vero successo di critica e pubblico ha egregiamente premiato l'intelligente iniziativa della Provincia di Roma, la quale, su progetto dell'Assessore del Lavoro Smeriglio, ha finanziato un corso di formazione professionale per giovani artisti di spettacolo, garantendo ad otto di essi l'immediato inserimento nella straordinaria Compagnia di Tosca e Venturiello. Silvia Arosio da: www.blogosfere.it MASSIMO VENTURIELLO Giordàn TOSCA Signora Giordàn – Musa CAMILLO GRASSI Maestro di filosofia – Coviello – Turco FRANCO SILVESTRI Maestro di danza – Muftì ELENA JADOR BRASCHI Marchesa – Cantante – Turco DARIO CIOTOLI Sarto – Allievo – Turco ELISA SMERILLI Nicoletta – Servitore – Aiuto sarto MIMMO PADRONE Maestro di scherma – Cleonte GENNARO CUOMO Maestro di musica – Dorante – Gran Turco FRANCESCA COLAPIETRO Lucilla – Un servitore – Aiuto sarto – Un turco SCENE COSTUMI ALESSANDRO CHITI SANTUZZA CALÌ MUSICHE GERMANO MAZZOCCHETTI COREOGRAFIE FABRIZIO ANGELINI AIUTO COREOGRAFO IDEAZIONE LUCI RICCARDO BORSINI UMILE VAINIERI REGIA MASSIMO VENTURIELLO Nell’ambito delle attività sociali e culturali della Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Benedetto Abate di Pescara Colli si è legalmente costituita l’Associazione Teatrale PerStareInsieme” È un’associazione senza scopi di lucro, rivolta in modo particolare ai parrocchiani ed ha come finalità quella di creare fra i suoi componenti un positivo clima di condivisione di esperienze che conduca alla scoperta dell’importanza dello stare bene insieme. Obiettivi fruizione dei migliori spettacoli teatrali rappresentati sul territorio; analisi e la comprensione del linguaggio e delle tecniche teatrali; allestimento di spettacoli teatrali dialettali e in lingua. Commedie e spettacoli rappresentati dal luglio 2008 ad oggi Lu ziprete – da Eduardo Scarpetta (7 repliche) La cantata dei pastori – da Andrea Perrucci (2 repliche) Lu diavule e l’acqua sande – da Camillo Vittici (5 repliche) La condanna dell’Innocente – di Alberto Cinquino (3 repliche) …e volò libero – di Carmine Ricciardi Titillo – da E. Scarpetta (4 repliche) La fattura – di Evaldo e Isabella Verì (4 repliche) Lu testamente – di Michele Ciulli (12 repliche) Natale in casa Bongiorno di C. Natili e C.Giustini (6 repliche) La scommessa e Gennareniello da E. De Filippo (2 repliche) La compagnia si diverte – farse e sketchs di autori vari Altre attività culturali Cineforum sul film La strada di Federico Fellini Gite a Roma per assistere agli spettacoli La strada con Venturiello e Tosca al Teatro Valle, a Il piacere dell’onestà con Leo Gullotta, al Teatro Eliseo e a Perugia al Teatro Morlacchi per L’inganno con Glauco Mauri e Roberto Sturno. Visione degli spettacoli teatrali proposti dal Teatro Comunale di Città Sant’Angelo. Attività sociali Destinazione dell’incasso netto di uno spettacolo in beneficenza ad una famiglia aquilana colpita dal terremoto, di due spettacoli all’AISLA, e di uno spettacolo alla Caritas Parrocchiale. Info: Carmine Ricciardi (presidente) cell. 3489353713 Recapito: c/o Carmine Ricciardi Strada Colle Scorrano 15 - 65125 Pescara Colli e-mail: [email protected] Prossimamente domenica 18 dicembre 2011 – 18,30 Auditorium Parrocchiale Chiamatemi… don Tonino(lettura teatrale di un testo di F. Cardinali) La compagnia si diverte sketchs e farse per ridere insieme COSE TURCHE commedia dialettale in tre atti di Samy Fayad Date e sedi da definire
Scarica