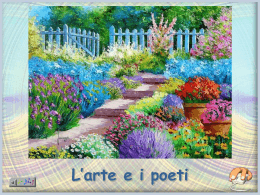LUCIO ZINNA GLI EQUILIBRI DELLA POESIA Brevi saggi relazioni interventi Seconda edizione riveduta ed ampliata Bagheria, 2014 1 Prima Edizione: Quaderni di Arenaria, Palermo 2003. Seconda edizione (riveduta e ampliata), www.luciozinna.it, 2014. © Copyright Lucio Zinna, 2003-2014. 2 INDICE Notizia Che cosa (non) è la letteratura Poesia e verità Poesia e naturalezza Il poeta tra «creatività» e «diversità» Del tradurre e del tradire Dalla “trasparenza” al “concreto” La critica letteraria oggi in Italia. Malesseri e prospettive Pag. 4 “ “ “ “ “ “ 5 12 17 23 28 32 “ 50 3 NOTIZIA I brevi saggi raccolti in questo volume, in parte riveduti e/o aggiornati, sono originati da relazioni tenute in convegni, simposi, incontri di studio e interventi su riviste e in volumi collettanei. Il periodo va dal 1992 al 2012. In particolare: Che cosa non è la letteratura è la relazione tenuta al Convegno sullo stesso tema, svoltosi a Torino – Libreria Village – il 20 novembre 1996 e pubblicata sulla rivista «Hebenon», Torino, a. XXII, n° 3-4, a prile-ottobre 1997, che ha raccolto gli atti del convegno. Poesia e verità è la relazione (derivata da registrazione su nastro magnetofonico) tenuta nell’incontro-dibattito con gli studenti della Cattedra di Poesia e Poetica dell’Università di Palermo (docente il Prof. Salvatore Lo Bue) nell’anno accademico 1996-97. Poesia e naturalezza è il testo della relazione tenuta il 14 ottobre 2008, nell’Aula Magna dell’Accademia della Politica, nell’incontro su “Arte e Poesia”, nell’ambito delle manifestazioni su “Il discorso naturale – Giornate delle creature” (Palermo, 4-14 ottobre 2008). Il poeta tra diversità e creatività è la comunicazione pronunciata al Convegno Nazionale di Studi sul tema: «L’elogio della diversità: il cambiamento tra emarginazione e creatività», svoltosi a Caltagirone (CT) nei giorni 22 e 23 maggio 1992, organizzato dal Dipartimento Salute Mentale – Neuropsichiatria Infantile – della U.S.L. n° 29 di Caltagirone (CT). Del tradurre e del tradire è il testo dell’intervento pronunciato in occasione del secondo incontro del ciclo “Les nouveaux dialogues” (Palermo, 10/7/95 Gran Café Nobel), organizzato dal Centro Internazionale di Etnostoria, ospite il poeta Marc Quaghebeur, Direttore dell’Archivio e Museo della Letteratura di Bruxelles. Pubblicato sulla rivista “Etnostoria”, nuova serie, n.1-2,/1995 e su “Arenaria”, vol. II, ILA Palma, Palermo, 2009. La critica letteraria oggi in Italia. Malesseri e prospettive è stato pubblicato sulla rivista “Fermenti” [Fondazione Marino Piazzolla, Roma], a. XLI, n° 238, 2012, qui riproposto con due aggiunzioni e alcuni varianti formali. Dalla trasparenza al concreto è il testo apparso nel volume di AA:VV: “Linee odierne della poesia italiana”, a cura di Roberto Bertoldo e Luciano Troisio, edito da I Quaderni di Hebenon, Burolo (TO), 2001, con successive integrazioni. 4 CHE COSA (NON) È LA LETTERATURA 5 Dire cosa “non è” la letteratura può essere semplice, a condizione di aver chiaro cosa «è»: è qui che la faccenda si complica. Secondo un’elementare considerazione, all’ambito letterario afferiscono quelle opere la cui materia è costituita dal linguaggio verbale, dalle parole: tale materia rende la letteratura distinguibile da altre espressioni artistiche, benché permanga comune il valore intrinseco: letteratura non è musica, pittura, scultura etc. Ma così dicendo, si indica cosa generalmente s’intende per letteratura, delimitando un ampio conteiner in cui trovano luogo non solo le opere poetiche, di più raffinata creatività, ma anche quelle prosastiche, sia che possano attingere alla poeticità (narrativa, drammaturgia, scritti religiosi), sia che non vi attingano (saggi critici, filosofici, scientifici etc.), purché abbiano una loro rilevante peculiarità espressiva e concettuale. Per tale motivo, ad esempio, Il Principe di Machiavelli è opera riguardante non solo la scienza della politica ma anche e fortemente la letteratura. La cosiddetta manualistica appartiene alla letteratura solo in un senso molto lato, in quanto documento scrittorio, ma senza alcuna rilevanza particolare, a meno che un determinato testo non registri peculiari ed evidenti pregi che gli consentano di uscire dalla genericità e di collocarsi, diciamo pure, in più spirabil aere. È il caso, ad esempio, della famosa Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis. Può accadere altresì che in un testo di storia della letteratura italiana si trovino, in maniera pertinente, trattati un libro di belle maniere come Il Galateo del Della Casa o il ricettario gastronomico dell’Artusi, mentre sono ignorate (talvolta ingiustamente, ma questo è un altro discorso) tante opere di poesia o di narrativa. Una bussola che orienti con tutta certezza in tale periplo non esiste. Alla mancanza di uno strumento di precisione si sopperisce ricercando e valutando il cosiddetto valore letterario, a fondamento di opere di genere diversissimo, dal poema al saggio storico. Ed è proprio sulla consistenza di tale valore (compito precipuo della critica letteraria), vale a dire sul valore da attribuire a questo valore, che tutto si complica e si sfrangia nell’opinabile, nonostante gli encomiabili criteri di scientificità nei procedimenti analitici e valutativi. Cosa determina tale valore? L’eleganza dello stile? È elemento bastevole? Il grado di poeticità riscontrabile in un testo? Secondo quale tassonomia? E 6 chi ha stabilito che sia indispensabile – e infatti così non è – rilevare una dimensione artistica, per esempio, in un’opera storiografica o filosofica? Ciò, beninteso, a condizione di ammettere che i concetti di poesia e arte siano identificabili. Ma se poeticità e artisticità, ancorché non identificabili, possono essere paralleli e confluire in prodotti letterari che si pongano e propongano come opera d’arte e che a tale esito pervengano, identificabili non sono né confluenti nel caso di prodotti letterari che non abbiano come loro finalità la creazione di un’opera d’arte: un saggio scientifico, perfettamente scevro di elementi poetici, può tuttavia possedere i crismi di una sua «artisticità» nella traduzione da atto in opera, nel suo incarnarsi pienamente nel linguaggio, nella realizzazione delle finalità perseguite, nell’organizzazione compositiva ecc. Eppure le sopra descritte qualità non bastano a fare di quel testo «letteratura». Resta da vedere a quale momento della vita spirituale corrispondano quei prodotti dell’umana creatività inscrivibili nel fenomeno «letteratura», quale specificità li faccia essere tali e quali siano la loro provenienza e destinazione. In merito alla provenienza, mi pare che essa non possa darsi che nel singolo (in alcuni rari casi, anche in una coppia e si usa allora l’espressione scrittura a quattro mani), il quale filtra in sé tutto ciò che la vita gli pone (e impone) e che costituisce sostrato (e lievito) di ogni opera d’arte. Mi pare anche che, in merito alla destinazione, si possa (purché non se ne faccia un dogma) accogliere ancora quanto indicato dal Croce, il quale riteneva che la letteratura movesse alla formazione e al progresso della civiltà (“ingentilimento umano”). In merito allo specifico della letteratura, esso non può che farsi consistere nel linguaggio, con tutta l’intransitività che lo connota; un “linguaggio per sé”, con i suoi “significati secondi” e inversi, in senso barthesiano, così come ampiamente condiviso dalla critica formalistica. Tuttavia non mi pare che il concentrare l’attenzione sugli strumenti della moderna ars rethorica (linguistica, semantica) autorizzi implicitamente ad espungere dal concetto di letteratura un giudizio di valore. Non mi convince, insomma, la concezione di una letteratura come scienza, nel senso indicato da Barthes, né l’avvento da lui propugnato di una “mitologia della scrittura”. Non mi convince una scienza della letteratura che non sia anche scienza dei contenuti, ma solo scienza delle condizioni del contenuto (cioè le forme). Non mi convincono una scienza della letteratura e una poetica come scienza in cui il poeta, azzerato come creatore, non sia poietès ma soltanto autore «saputo e vissuto dal sistema linguistico che è prima della poesia e che lo assume e lo vive», come esplicita Salvatore Lo Bue (Artifizio e pòiesis, Palermo, 1979, p.30), il quale nota altresì: «Ed è una poesia senza origine e senza poeti che la poetica come scienza, come scienza dei segni e dei principi generabili determina: la poetica dell’inesistenza della pòiesis, di ogni pòiesis, che è poetica dell’inesistenza del poeta, di ogni poeta come incarnazione della pòiesis e sapienza delle vie della poesia.» (ib, p.31) E ancora: «La scienza della letteratura, la poetica come scienza, non può dunque comprendere la determinazione poetica, ma comprende il determinato: il termine diventa principio. Il determinato è l’unico 7 modo di scienza della determinazione, dal determinato è la determinazione sempre postuma che non è determinazione, ma operazione poetica priva del principio di se stessa ma capace di tutti i principi della vuotezza del principio: il mito dei poietès è il mito del poièin, ma è nello stesso tempo il mito dell’esistenza.» (ib, p.32) Lo stesso dicasi per una certa tendenza della semiotica uber alles. Di recente, in un suo articolo, Renato Barilli, riferendosi a un «tempo del rigorismo semiotico», da considerare ormai trascorso, rilevava come oggi si sia evidenziato un «rovesciamento di fronte» che ci è venuto proprio «da tutti i cultori francesi dei riti della semiotica, a cominciare dal gran capo Roland Barthes, che pretendeva che tutti ci imponessimo il cilicio della linguistica andando ad applicarlo per esempio al terreno recalcitrante della moda, e perfino della retorica, lo strumento concepito fin dall’antichità proprio per intervenire negli ambiti ambigui e indeterminati dove non è possibile “tagliare la testa al toro”.» (R. Barilli, Todorov, per favore, la bellezza no, in “L’immaginazione”, a. XXVII, n. 260, Gennaio-Febbraio 2011, p. 23). E così come non ritengo soddisfacente la valutazione di un’opera letteraria esclusivamente secondo i parametri della cosiddetta critica biografica e/o psicologica, non ritengo altresì soddisfacente una valutazione esclusiva secondo i parametri della cosiddetta critica semiologica, secondo cui il “prodotto” letterario è autonomo nei confronti dell’autore, emancipato da questi, per cui vicende e sentimenti concernenti l’autore possono essere utilizzati solo come punti di riferimento esterni e tenendo conto della loro eterogeneità al materiale dell’indagine (c.fr. C. Segre, I segni e la critica, Torino, 1969, p.89). È fuor di dubbio che l’eccezionalità di opere quali Il castello o Il processo sia da ricercare in fattori endogeni alle opere stesse, le quali eccezionali non sono per aspetti e circostanze della vita dell’autore, ad esempio: perché e in quanto Kafka era funzionario di un Ente di Assicurazioni e scriveva di notte in un angusto appartamentino praghese. Ma è altrettanto fuor di dubbio che non tutte, ma molte cose sono spiegabili, di quelle opere, anche in relazione ai dati biografici, al vissuto dell’autore: alle condizioni storiche e sociali del suo tempo, alle situazioni affettive, alle sue aspirazioni, ansie, fobie. Ritengo che, una volta posta in essere la composizione (e l’etimologia del termine, da cumponere, mettere insieme, indica come nell’atto confluisca una moltepliclità di elementi), si stacchi il cordone ombelicale tra il testo, che può ire infra la gente, e il suo autore, ma che obliarne la filiazione non sia, mi vien da dire, né serio né decoroso e che soprattutto non sia utile, poiché è preferibile possedere più strumenti per penetrare in un’opera anziché uno solo, data la pluralità costitutiva dello stesso cum-ponere. E parimenti: ogni concezione estetica non può essere negata per essere ricavata da una semiologia, poiché in tal caso si assumerebbe la semiologia stessa come estetica. E ancora: piuttosto che ridurre il poeta a semplice autore di un’espressione linguistica, in cui prevalga l’elemento estetico, preferisco capovolgere: vale a dire, considerarlo “autore” di un’espressione estetica in cui si sia posta peculiare attenzione all'espressione linguistica. 8 Se è vero che è una particolare forma, una particolare scrittura, a rendere “poetico” un testo, mi pare altrettanto vero che il raggiungimento di tali esiti sul piano formale non sia né possa del tutto essere avulso da una Weltanshauung che quel testo avvolge e di cui (anche involontariamente) finisce per essere exemplum. Qualcosa di ultra-mondano contribuisce a imprimere il ritmo interiore in alcune grandi opere; senza una tensione “metafisica” (implicita o esplicita) che quelle opere vivifica e fa muovere, quel ritmo non sarebbe nato o sarebbe stato, per così dire, vuoto e cioè non avrebbe costituito (potuto costituire) linguaggio. Tensione metafisica celata, per esempio, in quell’elemento catartico che è la «Provvidenza» nei Promessi Sposi manzoniani o il «destino» nei Malavoglia verghiani. O il «tempo distruttore», riscattato nella poesia, nei Sepolcri di Foscolo e il «tempo perduto» e ritrovato nella memoria, nella Recherche di Proust. Il linguaggio è per l’opera letteraria come il corpo per l’essere umano: battito cardiaco, respiro. Esiste un preciso rapporto, è stato osservato, tra il corpo e la grammatica: «Anche il significato di molte categorie sèmiche è in relazione con la nostra corporeità. Le opposizioni alto/basso, sopra/sotto, prima/dopo, davanti/dietro, sono possibili solo a individui, come gli esseri umani, che conoscono l’esperienza della loro posizionalità corporea. Non solo, ma in particolare i valori figurati di queste opposizioni dipendono dall’esperienza fisica, per es., di trovarsi in posizione dominante (maggior possibilità di controllo, e perciò di dominio) o più bassa (minor controllo, soggezione, ecc.); in testa, e perciò con funzione di guida, e anche con maggior pericolo, o in coda, seguendo l’iniziativa di altri, ma più defilati alle offese, e così via. Il tema della corporeità potrebbe estendersi ulteriormente, per es., alle sensazioni che forniscono i materiali per le nostre rappresentazioni. La stessa parola estetica richiama a percezioni fisiche, ed è attraverso percezioni visive che noi leggiamo, e cogliamo gli effetti grafici e iconici; è attraverso percezioni uditive che avvertiamo i giochi fonici del linguaggio, per non parlare di tratti personali, come l’acutezza, il timbro, il volume, ecc.. Proseguendo ancora, non si può ignorare che l’arte ha anche effetti psicologici, soprattutto emotivi, che contribuiscono pure, e non poco, al suo effetto su noi lettori, muniti di un corpo che vibra e partecipa.» (C. Segre, Notizie dalla crisi, Torino, l993, pp.241-2). E più oltre: «L’uomo è il responsabile del proprio linguaggio, e con esso designa la realtà. Per questo ha il diritto di affermare che l’uomo è la misura di tutte le cose (...) . E già a proposito delle misure, si sa che le misure di lunghezza in origine erano quelle che si traggono dal corpo umano: il piede, il cubito, il braccio, ecc. Anche nella metrica greca, troviamo il daktylos “dito”, il piede, il kôlon “membro”, il verso acefalo, “senza testa”; e nella grammatica incontriamo, fra l’altro, l’articolo, “piccolo arto.» (ib, p.251). Opera letteraria non può darsi al di fuori del linguaggio, alla stregua della persona umana (tomisticamente intesa), che non potrebbe essere “rationalis naturae” (anzi non potrebbe essere tout court) se intanto non fosse “individua substantia”, impiantata sull’in-dividuum – nella sua unità e inscindibilità – e dunque sulla corporeità. Ma è anche vero che, come la sola individualità non 9 determina personalità (la sola corporeità non esaurisce la dimensione umana nella sua integralità), così il solo “linguaggio” non determina opera d’arte. La scrittura è il corpo dell’opera letteraria, in quanto fatta di parole. Il poeta toglie la parola dall’inerzia del vocabolario e la vivifica: la ri-significa (a tale uopo, la metafora è uno dei suoi strumenti di maggiore forza). E così la parola da precisa può divenire indeterminata e da generica specifica e così via. Ma nell’anima dell’opera letteraria ci sono ben altri aspetti che non sono soltanto formali. Come è detto nel Dhwani: «Parole e significati sono il corpo della poesia; e il sapore (rasa) ne è l’essenza; le Virtù sono come l’eroismo e altre qualità dell’anima, gli errori come il fatto di essere cieco e altre infermità, gli stili come gli atteggiamenti particolari del corpo, gli ornamenti come i braccialetti, gli orecchini e altre acconciature.» (R. Daumal, Natura essenziale della poesia, in: ”La conoscenza di sé”, Milano, 1986, p.97) Vogliamo semplicemente affermare che un testo letterario è importante per come è detto, ovvero la sua forma, ma non solo per questa, essendo parimenti rilevante quel che dice, ossia il suo contenuto, quel che significa. È importante altresì per la sua possibilità/capacità di spingersi oltre il suo contenuto, persino di muovere oltre l’intenzione stessa dell’autore; importante, ancora, per la varietà/possibilità delle sue interpretazioni, diciamo pure per la sua implicita trascendenza ermeneutica. Non a caso si è soliti usare, in questi casi, il sintagma “testo significativo”, non solo per la sua rilevanza formale, ma anche e peculiarmente per la sua significazione, che non è soltanto e necessariamente determinata dalla sua forma, la quale può, a sua volta, essere connotata da complessità (Comedia di Dante, Ulisse di Joyce etc.) o da chiarezza espositiva (Pinocchio di Collodi, Orlando Furioso di Ariosto, poesie di Neruda etc.): l’ampiezza di interpretazioni non ne viene depauperata, se tale significazione esiste. Il testo, dunque, nel suo complesso e nella sua complessità. Bisogna porre, infine, quel tanto di attenzione a una dimensione, latu sensu, “etica” dell’opera letteraria. Tale dimensione è presente allorché la lettura (o la scrittura) di un libro produca interiori modificazioni, quali che siano, in chi legge (o in chi scrive), per cui si avverte dopo la lettura (o la scrittura) di non essere più esattamente gli stessi di come eravamo prima, quando quell’esperienza di lettura (o di scrittura) ci mancava. Un libro di elegante scrittura, di virtuosismi espressivi, che non lasci traccia nella nostra interiorità, che non susciti in noi anche una semplice riflessione sulla vita o sulla morte, sul reale o sull’irreale, sull’amore o sull’odio o su quel che vi pare, che non slarghi alcun orizzonte, è non più che un bell’esercizio, un bel documento letterario. È pari a quelle opere di intensa significazione, ma scialbe sul piano espressivo, talvolta fino al rischio di rendere banali quelle significazioni stesse. E ancora, possiamo ignorare quella forma limite della gioia estetica che Valèry chiamava “incantamento”? (c.fr. A. Henry, Metonimia e metafora, Torino, 1975, p.6). E le atmosfere? Togliete le atmosfere dalla letteratura e l’avrete resa cionca, anzi ferita a morte. 10 Certo, è con la parola – poetica – che esse si creano nel testo letterario, ma poi assumono una rilevanza che va anche oltre la parola. Certe atmosfere letterarie finiscono per esistere per se stesse (per es., la cucina di Fratta nelle Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo) e possono restare in noi, anche quando le parole con cui lo scrittore, il poeta, le aveva evocate, si sono fatte in noi confuse, approssimative, frammentarie o svaniscono nella nostra mente. Atmosfere create in noi dalle parole, attraverso le parole, ma che in noi possono continuare ad esistere anche a prescindere da esse. Il discorso potrebbe ancora continuare, sulla medesima linea, per i numerosi altri aspetti relativi al fenomeno «letteratura», ma mi pare sia già sostanzialmente concluso. Ho comparato più sopra il «linguaggio» al corpo della letteratura. Potrei, usando un’altra metafora, aggiungere che esso è il pane della letteratura e, in maniera subdola, suggerire subito dopo che non di solo pane… 11 POESIA E VERITA’ 12 Nella ricerca della verità – compito generalmente considerato di esclusiva pertinenza dei filosofi – la poesia può offrire una propria via? In altri termini: la poesia può costituire un modo di ricercare la verità, su parametri diversi da quelli della filosofia? Giova rilevare preliminarmente che fine della poesia non è la verità ma la poesia stessa, il “far poesia”, l’espressione poetica. Una verità “oggettiva” espressa in maniera impoetica non produce poesia né alla poesia pertiene; al contrario, qualcosa di non vero (o anche di eticamente ingiusto) che sia espresso in termini poetici, assume rilevanza estetica, riguarda la poesia. Ad esempio, il fatto che l’al di là possa non esistere o non essere così come Dante lo descrive, non sminuisce di un grammo il valore della Divina Commedia. Analogamente, i buoni sentimenti, così come le idee giuste, non “fanno” necessariamente poesia. I canti di Maldoror di Lautréamont o I fiori del male di Baudelaire non sono propriamente bibbie dei buoni sentimenti, ma sono opere di autentica poesia. Era motivato lo sdegno di Ugo Foscolo nei riguardi delle norme sui cimiteri dettate dall’Editto di Saint Cloud, per il rigido egualitarismo delle tombe, che rendeva indistinguibili quelle dei giusti e quelle dei malvagi, con conseguente abuso di fosse comuni (in cui era finito immeritatamente anche il povero grande Parini). Meno valido appare il suo rifiuto della norma che voleva i sepolcri “fuor de’ guardi pietosi”, ossia lontano dall’abitato, prescrivendo l’ubicazione di singole sepolture e camposanti fuori dalla cinta urbana, come oggi universalmente condiviso e praticato; da questo punto di vista, i tempi hanno dato torto al Foscolo, il che non lede minimamente la grandezza del suo carme I Sepolcri. La “verità” della poesia consiste essenzialmente nel suo essere un baluardo contro la banalità, che tutto depotenzia e svilisce, in primis facoltà critiche e creative, e il cui peso è assai più grave – sul piano degli esiti artistici – di quello della menzogna, benché comunemente spregiata dai poeti. 13 Personalmente, ritengo “vera” la realtà degli “oggetti” che si pongono avanti a noi e colpiscono i nostri sensi, come si suol dire; gli “oggetti” sono “reali” e la realtà degli oggetti è, tautologicamente, oggettiva. Ciò non significa affatto che debba aprioristicamente considerarsi non vero tutto ciò che non colpisca i nostri sensi o non li colpisca ancora: la storia della scienza è ricca di casi in cui l’invenzione di strumenti scientifici capaci di potenziare i nostri sensi ha rivelato l’esistenza di ignoti mondi che, prima, sarebbero stati considerati fole. Il microscopio ci ha rivelato l’universo dell’infinitamente piccolo, l’audiometro ci consente di registrare l’estensione dei suoni percepiti dal nostro orecchio, in tutta la loro gamma, per non dire dell’affascinante scoperta degli ultrasuoni, che non sono alla portata della nostra sensorialità (bensì a quella di alcuni animali, cosa che dovrebbe, fra l’altro, indurci a ridimensionare la nostra spocchia antropocentrica). Insomma, un moderato, intelligente sensismo può costituire una buona bussola, per chi sappia usarla senza pregiudizi, così come è giovevole un moderato, intelligente relativismo, che tenga conto delle grandi lezioni di Protagora di Abdera e di Gorgia da Lentini, fino a Pirandello e ad Einstein. Vale a dire: mi è impossibile non considerare vero ciò che fermamente ritengo sia tale e fino a quando lo riterrò tale. Come potrei prescinderne? Tutto ciò, ovviamente, ha un senso profondo se si evitano atteggiamenti acritici e dogmatici (che contrastano intanto, per definizione, col concetto stesso di “relativo”), nella considerazione, dunque, che la mia verità possa non essere tale anche per gli altri (e viceversa). Va parimenti considerato che nuove riflessioni, constatazioni etc. possano sempre indurci a rivedere saggiamente le nostre posizioni. E’ questo un motivo assai valido per tenere presenti, quotidianamente praticandoli, i principi di tolleranza, dialogo, democrazia etc. L’esercizio della poesia è, per lo più, corroborante dei suddetti principi. Trattasi di un’operazione a forte componente individuale, che non ignora affatto ciò che è collettivo e ciò che, per sua natura, tende all’assoluto, anche inconsapevolmente e anche agendo nel cuore stesso del relativo. Non di rado, il far poesia finisce per attuare una sorta di percorso, il più variegato possibile da individuo a individuo, dal relativo all’assoluto. Non può negarsi una certa componente narcisistica implicita nello stesso atto poetico, ma tale considerazione è da intendere nel senso giusto. Il “narcisismo” del poeta non va classificato in senso comune, patologico, bensì metaforico. Il poeta “è” Narciso nei riguardi della poesia, potendosi questa configurare come l’acqua in cui egli si specchia, in cui riflette, più che la propria immagine, tutto se stesso e principalmente la propria interiorità. Attraverso questa “acqua” e questo “riflettere” e ri-flettersi (etimologicamente: da flectere ossia piegare e “ripiegare” su di sé) il poeta comprende se stesso e incontra gli altri, nei quali si riflette. La spiritualità della poesia consiste innanzitutto nella consapevolezza di sé e dei rapporti e questa si fa lievito della parola 14 poetica. Senza tale consapevolezza non potrebbe esserci spiritualità, come non potrebbe essercene senza concretezza: il poeta comprende sé attraverso gli altri e viceversa; parimenti cerca di comprendere il reale attraverso le cose. Non diversamente egli tende a comprendere la vita anche attraverso la morte e spesso la poesia è una sorta di “contemplatio mortis”, anche se non sempre così appare. L’esercizio della poesia comporta altresì un modo di abituarsi-alla-morte, rendendola, in certo senso, a-temporale, traendo, da tale “abitudine” non solo maggiore consapevolezza nell’impegno etico-esistenziale (che ingloba e supera, dunque, il vecchio engagement sartriano), ma anche un po’ più di vita, di linfa vitale. Scrivere poesia è colloquio con la “mors” attraverso la “res” e il superamento di questa. Mediante tale colloquio il poeta muove alla ricerca di una verità altra, che non può esaurirsi nella mera osservazione, perché, diciamo pure, la trascende. L’osservazione della realtà è solo un indispensabile punto sorgivo, un input. Nata nel silenzio, la poesia è un modo di sfuggire al silenzio stesso (perfino in pieno frastuono) e quindi alla morte. Non saprei dire se esistano altri modi di sfuggire alla morte. . Il rapporto tra poesia e tempo è, più che intenso, essenziale. Il presente è fuggevole e il poeta cerca di cogliere il fluire del tempo, ma anche lo spirito dei tempi in cui gli è dato di vivere, facendosene testimone (poeta scriba). Il futuro non è ancora e non ci appartiene se non ipoteticamente (è, in atto, imprendibile); eppure il poeta tende a proiettarsi nel tempo o a trarre prospettive dall’osservazione di elementi della contemporaneità. Talvolta (al di fuori di ogni dimensione, per così dire, cabalistica) riesce ad antivedere accadimenti o orientamenti, a farsi “profeta” (poeta vate) ; più spesso anticipa gusti e sensibilità future con la propria sensibilità e con la sua naturale pulsione verso il nuovo, dando vita, in campo estetico, a nuove tendenze (poeta d’avanguardia). La poesia trova altra linfa nella memoria, senza la quale non esisterebbe. Data la fugacità del presente e la dis-appartenenza del futuro, una realtà compiuta è certamente il passato, che nella memoria rivive, si rifà presente, magicamente. Un esempio perfetto è dato dalla “Recherche” di Proust, che è anche una grande opera di poesia. E’ nel territorio della memoria che si incontrano “poesia” e “verità”. Quest’ultima è, nell’accezione greca, a-letheia, ovvero: “ciò che non è latente”, che non si dimentica, che non è immerso nel fiume Lete. In questo senso, poesia è propriamente un ricordare, nell’accezione etimologica di “richiamare al cuore”. Poesia non è solo rappresentazione della realtà, è soprattutto rifigurazione di essa. Il reale, filtrato attraverso la sensibilità del poeta, il suo mondo interiore, è ri-significato, come è ri-significata la parola nei riguardi del linguaggio comune. La parola morta nel suo uso convenzionale, rinasce nella poesia, come la fenice dalle proprie ceneri. 15 Completamente rinnovata e originale, con nuova significazione, la parola poetica ha una verginità rinascente, come le urì nel paradiso di Maometto. Il poeta non parla di qualcosa, come chiunque: dice qualcosa e rende nuovo quel che “dice”, per cui ciò che è antico diventa nuovo e viceversa. Nella sua ricerca di un equilibrio (o di un compromesso?) tra l’esigenza di una realtà oggettiva (fosse anche questa l’idea) e un’esigenza di libertà formale, Mallarmé pervenne alla realtà della forma e cioè del verso, il quale crea una realtà – propria – che si pone di fronte alla realtà empirica come realtà di forme, appunto. Secondo quest’ottica, la poesia non è più propriamente espressione del sentimento personale del poeta, ma una realtà assoluta, dato che esiste per sé. La parola reinventata rende il verso un oggetto del tutto nuovo (e, in fondo, estraneo al poeta stesso) che corrisponde misteriosamente alla struttura del cosmo; è postulata, quindi, una realtà metafisica. A parte tali connotazioni mallarmeane (connaturate all’estetica simbolista), la poesia si pone come ricerca dell’oltre, nella considerazione e accettazione della condizione umana, della finitezza e imperfezione del nostro essere. E pur non essendo la verità il suo fine, la poesia intraprende una strada tutta propria, alla ricerca della verità: una sorta di metodologia dell’anima per attingere alla verità. Da questo punto di vista, poesia e filosofia si trovano ad avere un obiettivo comune, nella radicale diversità del percorso. Diciamo pure che non c’è poesia che non ricerchi, espressamente o implicitamente, la verità, come non c’è poesia senza una pulsione verso l’assoluto, la cui ricerca coinvolge (anche inavvertitamente) il poeta, perfino nella rappresentazione degli aspetti minuti dell’esistenza. Come ricerca l’assoluto nelle piccole cose, così il poeta non manca di ricercare ciò che relativizza l’assoluto, che riesce a limitarlo o addirittura a negarlo. Anche in questo senso la poesia è da intendere come “terra di libertà”, in cui ogni esplorazione è possibile. 16 POESIA E NATURALEZZA 17 Per porre in rapporto i due termini “poesia” e “naturalezza” occorrerebbe in primis definirli, allo scopo di poter procedere secondo precisi punti di riferimento. Ma la poesia sfugge a ogni de-finizione, che è un’inevitabile ‘recinzione’. La vastità di ambiti e di forme in cui si dispiega il ‘far poesia’, la varietà e complessità delle componenti, richiederebbero un lungo e comunque non esaustivo discorso. Mi limiterò ad esprimere una mia opinione, en poète, dunque personale, oltre che certamente incompleta. Ho avuto modo di dire, in altra occasione, che per me la poesia è un modo di leggere il mondo e al tempo stesso di guardarlo a distanza. Leggerlo, al di là delle apparenze, nelle sue essenze: nella sua essenza. So bene che la poesia non può ridursi a questo, pur non trascurabile, impegno. Attività dello spirito umano fondata sul verbum, si dispiega in un linguaggio non comune ma giocato con parole comuni, eppure fatte nuove: ri-significate, potenziate, e mirate a uno scopo ambizioso, quale è il tentativo, sempre spostabile in avanti, di compiere l’incredibile operazione di esprimere, quanto più possibile, l’inesprimibile. Un fine, per dirla con Borges, che è cosa da poco: l’assoluto. Ma dopo aver detto questo non s’è ancora detto tutto. ‘Naturalezza’ può considerarsi, in senso generale, ciò che è conforme alla natura, considerata nella sua autenticità primigenia, nella sua elementarità quintessenziale, oltre che come ambito – spazio vitale – di tutti gli esseri viventi, che alle sue leggi sono soggetti pena la loro sopravvivenza. E poiché la poesia ricerca le essenze e l’autenticità, un primo incontro si pro/ponibile su questo terreno. Consapevolmente o no, la poesia tende alla naturalezza. Resta da vedere in che modo. ‘Naturalezza’ si contrappone ad ‘artificio’ come ‘artificiale’ si contrappone a ‘naturale’ e il contrasto si fonda sul principio attivo di entrambi e sulla loro collocazione. Infatti, tale principio è intrinseco a tutte le cose naturali, che fa agire dall’interno, mentre è estrinseco a quelle artificiali, facendole agire dal loro esterno. La vita umana, nelle sue fasi evolutive, procede avvalendosi di ambedue queste forze operative, come se ne avvale l’arte, frutto tanto di ‘naturalezza’ – intesa come spontaneità ed immediatezza – quanto di 18 ‘artifizio’, inteso sia nel senso dell’inserimento, nella creazione artistica, di fattori im-pertinenti al reale, sia nel senso della tecnica espressiva: perizia magistrale al servizio dell’autentico. Per gli antichi greci l’arte era techne, come poiein era il ‘fare’. La poesia ha dunque, etimologicamente, una sua operatività costitutiva che converge nel ‘creare’: concetto più vicino a noi, dell’era cristiana, dato che al mondo classico era estraneo quello di ‘creazione’ (ex nihilo nihil). La poesia mira alla naturalezza come suo punto-luce, ma è singolare il fatto che per raggiungerlo non possa fare a meno dell’artificio, nella sua duplice veste di finzione creativa e di possesso di tecniche specifiche, raffinate e personalizzate. Poiesis e artificio sono virtualmente contrastanti, concretamente interferenti, in un equilibrio da invenire di volta in volta, perché si dia arte. Diceva Goethe che «il genio è esercizio», intendendo sottolineare che, senza un’adeguata perizia tecnica, il talento di base e l’intuizione resterebbero velleitari. Immediatezza e spontaneità si manterrebbero allo stato grezzo o al più in quello di «semilavorato», espressione usata in proposito da Antonio Pizzuto in alcune lettere della sua corrispondenza con l’amico scrittore Salvatore Spinelli. Spesso un testo poetico appare tanto più spontaneo e ‘naturale’ quanto maggiore è la techne del poeta e ciò anche quando la composizione emerga, come si suol dire, di getto e non richieda aggiustamenti di tiro, poiché in tali casi, peraltro infrequenti, la competenza formale dell’autore agisce come retroterra. Ma per lo più, la naturalezza compositiva si raggiunge attraverso un’attenta ri/elaborazione formale. Ad esempio, la poesia I mari del sud (da Lavorare stanca) di Cesare Pavese, dà l’impressione, a chi legge, di una spontaneità senza pari. I versi paiono nati lì per lì. Questa, a mo’ di esempio, la prima strofe: Camminiamo una sera sul fianco di un colle, in silenzio. Nell’ombra del tardo crepuscolo mio cugino è un gigante vestito di bianco, che si muove pacato, abbronzato nel volto, taciturno. Tacere è la nostra virtù. Qualche nostro antenato dev’essere stato ben solo – un grand’uomo tra idioti o un povero folle – per insegnare ai suoi tanto silenzio. Sennonché guardando la bozza manoscritta, questi versi rivelano una gestazione assai laboriosa: ci si trova di fronte a una carta geografica di ripensamenti. Leopardi stilò tre stesure dell’Infinito: la prima in prosa poetica, senza scansione di versi, quasi un abbozzo per fermare i concetti; la seconda è già nel suo volto noto; la terza registra varianti formali che affinano il testo. Nella prima, l’incipit è il seguente: Oh quanto a me gioconda, quanto cara fummi quest’erma (sponda) plaga (spiaggia) e questo roveto, che all’occhio copre l’ultimo orizzonte! 19 Impreciso l’aggettivo “gioconda”, terribile quel “fummi”, inopportuno il punto esclamativo; si noti l’incidenza, nella stesura definitiva, della sostituzione di “roveto” con “siepe”, mentre la ‘dispositio’ è davvero usata ad substantiam acti, per così dire. Ove mai il poeta avesse lasciato immutati tali versi iniziali, non solo il testo poetico ne avrebbe risentito esteticamente, ma ne sarebbe stato leso lo stesso senso di infinità, che invece, nella stesura finale, mirabilmente emerge, in una forma che non può essere altra. Il lievito della poesia sta nell’intuizione leopardiana, senza la quale il testo non sarebbe sorto, ma senza la successiva rielaborazione esso non avrebbe volato così alto. La poesia, se ama la spontaneità rifugge dallo spontaneismo, frutto di un’intuizione e di un’immediatezza maturate esteticamente in maniera inadeguata. Le vie della poesia non sono lastricate di buone intenzioni come quelle della provvidenza: le buone intenzioni non bastano come non bastano i buoni sentimenti (o il loro contrario), se non si elevano ‘alle vette dell’arte’, come una volta si sarebbe enfaticamente detto. Tanto avviene con un linguaggio originale che renda nuovo il tema trattato: unico e universale. E sublime, in una dimensione altra, che è poi quella dell’oltre. Per converso, un eccesso di artificio farebbe scadere il prodotto artistico, rendendolo, appunto, artificioso. Non a caso Immanuel Kant parlava del genio come «la natura che dà regole all’arte». Ma è anche vero che l’arte media le proprie regole con quelle della natura. E non è nemmeno detto che gli squilibri da un lato e dall’altro non possano fare arte (e qui dovremmo ricorrere a quelle che Gillo Dorfles ha chiamato «le oscillazioni del gusto»). Se, per riferirci alle arti figurative, si può notare, per fare appena un esempio, un di più di naturalezza nel vedutismo del Canaletto, un eccesso di artifizio può rinvenirsi nel cubismo di Picasso, e dato che il bello artistico è relativo, le opere di ambedue possono essere delibate, specie nella loro storica collocazione, e comunque a seconda delle papille esteticamente gustative di cui ognuno disponga. L’eccesso di artificio può, in alcuni artisti (o in alcuni fruitori del prodotto artistico) provocare fenomeni di rigetto o generare in altri una forte attrazione: il discrimine è determinato dal quoziente di naturalezza in dotazione a ciascuno, in altri termini, dalla linea di demarcazione tra una concezione sostanzialmente realistica dell’arte (non a caso il Realismo francese del sec. XIX prese il nome di Naturalismo) e un’altra che ne prescinda, extra o ultra realistica, come è accaduto con il Surrealismo, sia in letteratura che nelle arti figurative, o con l’astrattismo e l’informale nelle arti figurative, in genere con le avanguardie storiche e le neoavanguardie. L’autore de Il Gattopardo, Tomasi di Lampedusa, non amava l’opera lirica, poiché trovava innaturale il rappresentare la vita cantando in ogni circostanza. Il melodramma gli appariva artefatto e su di esso ironizzava. Né gli amici, fra i quali Bebbuzzo Sgadari di Lo Monaco, appassionato e competente melomane, riuscirono mai a persuaderlo diversamente. Andrea Vitello, nella sua biografia lampedusiana, narra che il singolare nome Bendicò, attribuito dall’autore al cane del Principe di Salina, fosse derivato dall’arietta del III atto del Rigoletto di Verdi in cui Maddalena risponde alle blandizie del Duca in questi termini: «Ah! Ah! Rido ben di core, / Ché tai baje costan poco». 20 Al pari del sentimento del tempo, è vivo nella poesia il sentimento della natura, che gli spagnoli chiamano “sentimiento de la naturaleza”, nato dallo sgomento di fronte alla grandezza dell’universo, o dalla paura che incutono certi terribili eventi naturali, o dalla serenità che può infondere la contemplazione di un paesaggio etc. Il poeta coglie, amplifica ed esemplifica il particolare feeling con la natura, esprimendo il senso dell’essere, peraltro tipicamente umano. Questo rapporto attrattivo è stato affievolito negli ultimi cinque-seicento anni, a seguito di alcune implicazioni del pensiero umanistico-rinascimentale, in particolare dalla concezione antropocentrica, la quale valse, è vero, a far acquistare fiducia all’uomo, che si era sentito soggiogato, limitato, dal teocentrismo medioevale. L’antropocentrismo comportava una salutare spinta in avanti, per l’homo faber, ampliandone gli orizzonti, ma quel considerare l’uomo «signore della natura» e «re del creato» sarà il germe di una posizione di dominio che, eludendo la concezione onnicentrica di Giordano Bruno, filtrerà nella fisica moderna, cartesiana e post-cartesiana, che affievolirà il primigenio rapporto tra l’uomo e la natura, meccanizzando quest’ultima. Di essa l’uomo si considererà padrone, fino a soffocarla e comprometterla, com’è ormai (drammaticamente) palese. Ancor più sarà ottenebrato il sentimento panico, intenso nel mondo classico. Infranta così la visione armonica – profondamente umana – delle cose, sarà accentuato il senso di disorientamento dell’uomo di oggi. Orbene, è la poesia a tenere desta l’attenzione sull’insopprimibile esigenza di naturalezza, sull’importanza che non si sciolga né allenti la liaison uomo-natura. C’è in tal senso una lucida consapevolezza in non pochi poeti contemporanei, per lo più non formalisti, nei quali la natura amplia i suoi confini fino a farsi cosmo: visione cosmica della natura. Naturalezza come cosmicità. Penso, ad es., a Whitman e al suo Canto di me stesso, da cui traggo i seguenti lacerti: Un fanciullo mi chiese Cos’è l’erba? E me ne offrì con le sue mani [cariche; Come potevo rispondere al fanciullo? Io non so cosa sia più di [quanto egli stesso non lo sappia. Penso che debba essere il vessillo della mia inclinazione, tessuto [di verde speranza. Oppure penso che sia il fazzoletto del Signore, Un dono profumato, un ricordo lasciato volutamente cadere, Recante in qualche angolo il nome del suo proprietario, Così che si possa vederlo, ed osservarlo attentamente e chiedere [Di chi? O immagino che l’erba sia essa stessa un fanciullo, un bimbo nato [dalla vegetazione. E più oltre: Io so di essere eterno, So che questa mia orbita non potrà essere mai misurata con un [compasso da falegname So che non svanirò come il cerchio di fuoco tracciato da un [fanciullo nella notte con un tizzo acceso. 21 Agli antipodi, exemplum di una scissione reattiva e radicale, la fascinosa poesia di Robinson Jeffers, che canta la natura (in specie la costa rocciosa di Monterey) e ne decanta l’imperitura bellezza, in assenza dell’uomo, dalla cui presenza (non da quella degli animali) dovrebbe essere depurata. Penso alla «terra desolata» di Eliot, alla poesia di Montale, di Luzi, al loro diverso modo di esprimere il disagio – e il rimpianto – per lo iato di cui stiamo discorrendo. Penso, ancora, ad Ungaretti de I fiumi: Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia. E il non ‘credersi’, il non sentirsi, in armonia è il tormento dell’uomo contemporaneo, senza natura, come nell’Espressionismo tedesco. Se la poesia non perderà di vista la ‘sua’ naturalezza, in senso lato, allora potremo sperare che l’arco uomo-natura possa essere ricostituito: nella vita, non solo nel verso. E sarà – come osserva Luzi nel suo Discorso naturale – un “servizio agli altri”, senza “contropartita”: «Per lo meno per avvisarli di quanto hanno perso, di quanto viene loro sottratto in naturalezza, in umanità, in santità vorrei dire, ogni giorno». In un suo testo poetico Vann’Antò fa ricorso alla grande metafora dell’arcobaleno: Oh cchi beddu arcu r’amuri oh cchi beddu tricculuri ca sciu fora l’arcuné: pani vinu e uògghiu c’è. Tricculuri ri la paci. Pruvirenzia ca si compiaci E n’ammustra l’arcunè: pani vinu e uògghiu c’è. Lu diluviu ca fiìniu, torna e arriri suli ri Diu ca fa n-cielu l’arcunè: pani vinu e uògghiu c’è. E l’arcunè esprime e rappresenta il senso di appagata serenità per il rinnovarsi di un ancestrale contatto, anzi, della sintonia antropocosmica, della coniunctio terra-cielo, proprio all’insegna della naturalezza, di ciò che è elementare, essenziale, nella vita di ogni giorno. Al netto di ogni orpello. Riferimenti essenziali Robinson Jeffers, La bipenne, Guanda, Parma, 1969. Mario Luzi, “E non vergognarti”, in Discorso naturale, Quaderni di Messapo, Siena 1980. Giuseppe Ungaretti, L’allegria, Mondadori, Milano 1942. 22 Vann’Antò, U vascidduzzu, Il Fondaco, Messina 1956. Andrea Vitello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sellerio, Palermo 1987. Walt Whitman, Foglie d’erba, traduzione di R. Sanesi, Ed. Giannotta, Verona 1979. IL POETA TRA «CREATIVITA’» E «DIVERSITA’» 23 Esiste davvero una «diversità» del poeta, rapportabile alla sua creatività? Nel porre tale domanda prescindo dalla vecchia problematica, di matrice romantica, connessa al rapporto genio-sregolatezza, né intendo riferirmi al vasto filone del «maledettismo», che attraversa i secoli, meglio identificabile nell’arco temporale che si estende dal Rinascimento ad oggi: da Villon a Bukovski, per intenderci, attraversando, va da sé, i maudits propriamente detti. Una tale dimensione si fa più chiara alla coscienza del sociologo della letteratura proprio nei nostri tempi. Ne prescindo perché il discorso mi pare capovolgibile, per quanto riguarda sia il rapporto genio-sregolatezza che il fenomeno del «maledettismo». Il primo è del tutto occasionale: esistono geni che non sono sregolati e persone sregolate tutt’altro che geniali; per quanto attiene al secondo, esistono scrittori e poeti il cui abisso interiore (Manzoni, Yourcenar) e/o esistenziale (De Amicis) produce un’arte rasserenata e c’è – sempre fugacemente semplificando – il caso dei maledettissimi Canti di Maldoror il cui autore, Lautréamont, visse una vita tanto riservata da far considerare la sua esistenza un mistero biografico; perfino fisicamente non abbiamo di lui alcun ritratto. E così via. Al di la, dunque, di tali impercorribili tracciati, mi pare opportuno, invece, il riferimento a una diversità del poeta in quanto tale. È una questione sottile, che rischia di far smarrire il senso reale delle cose. Intanto non può negarsi che il poeta, in quanto “creativo” partecipi a quel perno della «creatività» che consiste nel cosiddetto «pensiero divergente» (vedansi, ad esempio, fra i tanti, gli studi in proposito di pedagogisti quali Kenneth Richmond o Giovacchino Petracchi), che è del poeta come di tutti i creativi, in ogni settore. Tale perno non gli consente, in linea di massima (non certo in senso assoluto) l’appartenenza alla categoria dei conformisti (il cui pensiero, come è noto, è «convergente»): chi diverge è già diverso, anche se tale diversità dovesse manifestarsi soltanto in ambito estetico e non evidenziarsi nella quotidianità. C’è infatti una diversità che proviene dalla spiccata sensibilità che fa essere il poeta dotato di particolari antenne. Ignazio Buttitta, in una sua poesia, espresse tale condizione chiamando il poeta «latru»: ladro. 24 Ladro di che? Leggiamo questa poesia, che si intitola, appunto, Pueta e latru: ‘Nmenzu la fudda passu e nuddu sapi cu sugnu, si m’arrassu o mi ’ncugnu nuddu si nni ‘mporta; ma la me strata gritta o torta, iu l’attrovu lu stissu, ca nascivu pirchissu e pirchissu sugnu pueta. Passu, e comu un latru misuru e squatru ogni cristianu; ed affunnu li manu gattalori dintra lu cori di li genti, e ci spremu li lamenti; e li ncasu cchiù funnu li mau e zoccu ‘mmestu scippu di lu sestu e lu mettu a lu cippu di la fantasia pi farini tumia; ed ogni magghia scatinu, e zoccu attrovu arriminu: ca sugnu un pisci mmistinu chi rumpi riti lenzi e tartaruni. Chi nni sapi la fudda ca mentri passu grapu la midudda d’ognunu comu un granatu e ci sucu li pinzeri? Chi nni sapi ca è chistu lu misteri di lu pueta; c’avi milli lapi, e tutti cercanu meli: c’avi milli stiddi, e tutti grapinu celi?! (Tra la folla passo / e nessuno sa chi sono, / se m’allontano / o mi accosto / non se ne interessa nessuno; / ma la mia strada / dritta o storta, / la trovo ugualmente, / 25 poiché sono nato per questo / e per questo sono poeta. // Passo, / e come un ladro / misuro e squadro / ogni persona; / e affondo le mani / feline /nel cuore / della gente, / e ne spremo i lamenti; / e affondo ancor più le mani / e quel che urto / sradico /dal suo assetto/ e lo pongo / nel ceppo / della fantasia / per farne TUMIA; / ed ogni maglia scateno / e tutto sommuovo, / e quel che trovo / rimesto: / perché sono un’orca / che rompe reti lenze e tartanoni. // Che ne sa la folla / che mentre passo / apro il cervello / di ognuno / come un melograno / e ne succhio i pensieri? / Che ne sa / che questo è il mestiere / del poeta; / che ha mille api, / e tutti cercano miele: / che ha mille stelle; / e tutte aprono cieli ?!) “Ladro”, dunque, per sua inalienabile condizione, in quanto furtivo interprete dei pensieri e dei sentimenti degli altri. È un’opinione non dissimile da quella che espresse un altro poeta siciliano, Bartolo Cattafi, nel corso di un dibattito su «il ruolo del poeta oggi», che si tenne nel 1976 nell’ambito delle manifestazioni del Premio Internazionale di Poesia Mondello, a cui parteciparono, oltre Cattafi, Piero Bigonciari, Felice Chilanti, Elio Giunta, Francesco Serrao, Silvio Ramat e chi vi parla. Cattafi ebbe a dire: «Un uomo è un poeta e un poeta è un uomo. È un fatto esistenziale. L’uomo si esprime anche attraverso la poesia. C’è l’uomo giocatore di tennis, c’è l’uomo idraulico, c’è anche l’uomo poeta. Dovranno accettare i nostri vicini, anche l’uomo poeta, potranno anche linciarlo, comunque l’uomo poeta è insopprimibile come è insopprimibile la pianta uomo. Poi sul fatto di questa articolazione della poesia, il campo è molto ampio, molto libero, perché appunto la poesia è libertà. La poesia non è mai la legge del gregge, quindi è un fatto biofisiologico.» Tiriamo un po’ le somme. Dunque, il poeta è un uomo come gli altri, ma, per condizione biofisiologica (poiché «un fatto biofisiologico» è la poesia) è poeta e quindi la legge della poesia, che non è quella del gregge, diventa la sua. L’essere poeti diviene un «mestiere», come dice Buttitta o, come la intende Cattafi, un’attività, praticata per lavoro o per sport, comunque quale effetto di una condizione nativa, endogena. Tale condizione porta l’uomo poeta a partecipare intensamente della vita di tutti e a farsene interprete, pur nella considerazione della propria individualità, anzi in virtù di questa. “Uomo poeta” come c’è l’homo œconomicud di Marx o l’homo ludens di Huizinga. Un essere al tempo stesso comune e diverso, che svolge la propria vita come tutti, ma la cui vera legge è la poesia, la quale non segue la legge del gregge, poiché si identifica con la libertà. Vivere in tal modo vuol dire vivere in due diverse dimensioni, cercando di conciliarle o quanto meno di alternarle. Non può trattarsi di un fatto superficiale, forse neppure indolore. Nel gregge si vive più sicuri. E si muore anche con altrettanta sicurezza: quando una pecorella precipita in un burrone con tutte le altre appresso («quel che l’una fa l’altre fanno» dice Dante). Ora, il poeta non sta fuori dal gregge, dunque non è né un bandito né un disadattato: sta nel gregge, ma non col gregge. Ci sta dentro, ma non ne assume la “legge”(che è quella della massificazione, dell’omologazione, di tutte le qualsiaserìe, per così dire) ossia non è ne è condizionato, non ne fa propria l’essenza. La parola “legge” non va intesa, quindi, nella comune accezione, come corpus giuridico e normativo, mentre la legge del poeta è da intendere come sinergia tra principio vitale ed esigenza di libertà. 26 Contemporaneamente “dentro” e “fuori”, in una ricerca di equilibri, il poeta avverte, da un lato, l’impulso a vivere una vita comune, con tutte le suggestioni e i fastidi della quotidianità, per sentirsi in consonanza; d’altro lato, non manca di avvertire in tutto ciò un senso di estraneità perché si sente ricco d’altro: un quid che non ha punti in comune con l’avvolgente banalità quotidiana. Quest’altro di cui è ricco sfugge a molti, mentre procura a lui interiore gratificazione e un (dolceamaro) senso di compiutezza. L’unico modo per superare la dilemmatica alternanza è quello di vivere su due piani interferenti, addirittura con-temporanei e co-spaziali. Una conciliazione difficile, che solitamente il poeta rende non impossibile e che finisce per potenziare la sua creatività, ma anche la sua, del tutto peculiare, «diversità». È qualcosa di cui dovrebbero tenere conto le mogli dei poeti e i mariti delle poetesse. 27 DEL TRADURRE E DEL TRADIRE 28 Etimologicamente “tradurre” (da trans-ducere) equivale a “trasportare” l'agente del “traducere”, ossia il “traduttore”, ha il significato originario, di “trasportatore”. L'etimo corrisponde altresì a “condurre attraverso”, concetto che va ben oltre quello di un semplice “trasportare”: implica un andare insieme, un procedere accanto, passo dopo passo, che di per sé comporta un costante relazionarsi e un quoziente di immedesimazione. Se assumiamo per un momento una metafora fluviale, con una sponda di partenza e una di arrivo, il traduttore è il nocchiero ed il viaggio, più che “trasporto” è un rapporto. Abbiamo quindi un “passaggio” da un testo di partenza a uno di arrivo e un rapporto fra due codici linguistici; appare indubbia non solo la complessità dell'operazione, ma anche e peculiarmente l’importanza della qualità del processo. Orbene, quale che sia il testo da trans-ducere (un’opera di poesia o di narrativa,saggio scientifico o una relazione tecnica), il compito del traduttore a me pare consista, in primo luogo, nell’evitare due opposte situazioni: 1) Operare per difetto: limitare il lavoro di mediazione (quale in effetti è) a una pura e semplice trasposizione da un codice linguistico a un altro. Beninteso, non può esserci mediazione senza trasposizione, ma se questa si limita ad essere letterale, il “rapporto” si depaupera in semplice “trasporto”, come di oggetti, secondo l’espressione siciliana del carriari, che si usa nei traslochi. Ad esempio, tradurre in inglese la voce verbale “andiamo” nel verso iniziale di “Pastori d'Abruzzo” di D'Annunzio (“Settembre, andiamo, è tempo di migrare”) con “let’s go” sarebbe un modo di ferire concettualmente e liricamente l’intero testo (non solo il primo verso). La traduzione letterale può invece giovare in certi casi, quando si vogliano ottenere particolari effetti voluti dall'autore dell'originale: semplicità, ironia etc. A valenza ironica deve intendersi, per citare un caso, la traduzione del toponimo “Via Duca della Verdura” che il poeta siculo-americano Nat Scammacca (che si esprime prevalentemente in inglese) effettua nel titolo di una sua poesia, costituito appunto da un recapito: “Andrew Donus, Via Duke of Vegetables 27, Palermo” (la valenza ironica può evincersi anche dal fatto che la parola “Via” permanga in lingua italiana). 2) Operare per eccesso: spingersi extra petitum, vale a dire oltre la sponda di arrivo (suo limite naturale), pretendendo di creare un’opera sganciata dall’originale e facendo di questo un altro-da-sé. Si tratterebbe di uno 29 stravolgimento, in cui il traduttore soggiace, per lo più, alla tentazione di creare un’opera nuova o di orientare l'attenzione del lettore su di sé più che sull’originale. E’ stato osservato che, in tal caso, si verifica qualcosa di simile alla recita teatrale, allorché l'attore interpreta più se stesso che il personaggio. Stanislavskij era, a tal proposito, severo e una volta redarguì una sua allieva perché aveva “civettato” con i suoi ammiratori, mostrando loro “le gambette”: Shakespeare - ebbe a dire alla giovane il grande teorico e maestro dell'arte scenica - non aveva scritto per questo motivo La bisbetica domata. Fra questi due poli, l’uno e l’altro diversamente scombinati, esiste per il traduttore un universo di possibilità operative (ancorché tutte strettamente attinenti al suo ruolo di mediatore), confluenti in quello che Jiří Levý chiama “rimodellamento responsabile di un’opera”, ossia un processo “originalmente creativo” che sta “al confine tra scienza e arte” o “tra riproduzione artistica e creazione originale”, laddove, a me pare, il “tra” serva a sottolineare l’interdipendenza tra la riproduzione artistica e la creazione originale, in cui i due termini della questione considerati singolarmente sarebbero monchi e fuorvianti. Mi pare necessario, intanto, sgombrare il campo da alcuni stereotipi. Per “riproduzione”, ovviamente, non deve intendersi qualcosa di automatico (di “fotocopiabile”, per così dire), trattandosi appunto di ri/produzione creativa (artistica). Questa, d’altronde, non va riferita esclusivamente all’opera letteraria bensì ad ogni testo significativo, compresi saggi scientifici e relazioni tecniche, che richiedono anch’essi e ampiamente doti di creatività (capacità ermeneutica, puntualità ed estro nella trasposizione terminologica, soluzioni linguistiche non banalizzanti, stile e fluidità del messaggio, etc.). Del resto, non è infrequente il caso di saggi scientifici e relazioni tecniche che, pur nello specifico, abbiano una loro rilevanza letteraria, che rende appetibile il messaggio. Penso alla qualità estetica di certe pagine dell’etnologo Giuseppe Cocchiara, che esaltano il valore scientifico della trattazione. Potrei far riferimento a certe relazioni – che accompagnavano o no rendiconti - e corrispondenza amministrativa di Ippolito Nievo, quando a Palermo era Vice Intendente di Finanza della Spedizione dei Mille prima e dell’Esercito Meridionale poi; l’allusività di certe espressioni, la sottile ironia di certi incisi, rivelano l’autore di quel capolavoro che è il romanzò Le Confessioni di un Italiano e impreziosiscono atti amministrativi fondati sull’esattezza dei dati e sul linguaggio tecnico (quello che oggi si chiama “burocratese”). Un traduttore che non ne tenesse conto tradirebbe lo spirito di quei testi. Recentemente sono state tradotte in italiano e pubblicate da Einaudi le ineccepibili relazioni tecniche di Franz Kafka, nel suo ruolo di funzionario, a Praga, di un istituto di assicurazioni (che era qualcosa a mezzo tra i nostri INPS e INA). Si pensi che egli fu il primo – e con anticipo di decenni – a sostenere che l'asbestosi (grave sindrome provocata dal contatto con l'amianto) doveva considerarsi malattia professionale per gli operai del settore. Il lavoro del traduttore non è stato meno creativo in tale circostanza di quello svolto da coloro che si sono cimentati nelle traduzioni de II castello, de II processo o dei racconti. 30 È bene considerare superata la concezione secondo la quale la traduzione di un’opera letteraria si ponga come fatto creativo mentre la traduzione di opere di altro genere fatto creativo non sarebbe o lo sarebbe meno. Ho usato alcune volte il verbo tradire, in effetti ricorrente nell'ambito della problematica, una sorta di peccato originale che la trasposizione in quanto tale si porta appresso. Ma a ben vedere, più che originale, il peccato rischia di essere terminale. “Tradire”, proprio nell’accezione etimologica (da tradere, ossia trans + dare) che vuol dire “consegnare a”. Giuda tradisce in quanto consegna Gesù ai pretoriani. Dunque, consegnare un testo tradotto a chi non si dovrebbe. Ad esempio, la banalizzazione di un testo scientifico è una “consegna” a chi non è il naturale destinatario del messaggio; più opportuna e leale, in tal senso, una sintesi esplicativa, che non sarebbe comunque più traduzione. Inoltre, il tradurre non va considerato come costituito da due momenti, il primo riguardante il contenuto, il secondo lo stile, quasi quest'ultimo fosse un belletto, qualcosa di sovrapponibile. Una tale dicotomia renderebbe (paradossalmente) intraducibili alcuni testi di narrativa sperimentale o buona parte della poesia contemporanea, in cui il contenuto è fievole o non esiste addirittura (si pensi alle avanguardie storielle o ai neoformalisti). A parte ciò, tanta poesia (antica e moderna) possiede – a seconda degli autori, delle tendenze estetiche o di altro – una più o meno elevata aliquota di mistero, di imponderabilità, di incomprensibilità talvolta, elementi costitutivi del testo, che il traduttore non può in ogni caso spianare, perché ciò equivarrebbe a “tradire” l’originale, anzi ad azzerarlo. Più o meno come avviene nelle parafrasi di testi poetici, nelle quali si fanno esercitare gli scolari: una prassi che comporta vantaggi didattici, ma che si risolve nel rendere impoetico il testo medesimo. Uno stereotipo, ancora, riproduce nell'ambito del tradurre, con la medesima terminologia, certe valutazioni maschili nei riguardi di una donna con cui si abbia una relazione: bella e fedele, bella e infedele, brutta e fedele, etc. Si usa anche l’aggettivo “libera”. E più realistico porre in essere considerazioni di altro genere, che comunque ho già cercato di evidenziare nel mio intervento e che possono, conclusivamente, essere le seguenti: a) che una traduzione debba essere identica all’originale (o diversa dall’originale, che fa lo stesso) è tutt’altro che un dogma. Ogni traduzione implica un certo grado di manipolazione funzionale e creativa, in cui sono tuttavia deteriori il gratuito, l'ornamentale, la banalizzazione; b) nella traduzione, la lingua (in quanto strumento di comunicazione) si fa discorso (non semplice equivalenza di codici linguistici, cioè “trasporto”) e “trasformazione” (trans-formatio) della scrittura nel linguaggio e in funzione di esso. Come osserva Meschonnic, grande traduttore di testi biblici, occorre dare importanza al ritmo del testo, inteso come “organizzazione della parola nella scrittura, socialità e soggettività del discorso, sua storicità”. Tale ritmo non è formale, è bensì “il ritmo eraclitiano del movimento del soggetto nel suo linguaggio” (Meschonnic). Inoltre, tradurre un testo resta sempre un problema in fieri, come fatto di ricerca, di evoluzione del gusto (e delle sue “oscillazioni”, delle quali ebbe 31 modo di trattare Gillo Dorfles negli anni Sessanta) e in rapporto alla sensibilità epocale. Ciò anche nella considerazione che nessuna opera è “chiusa”, mentre ogni traduzione resta aperta a nuove soluzioni. Anche da questo punto di vista giova parlare di perenne fluire, di “ritmo eraclitiano”. 32 DALLA “TRASPARENZA” AL “CONCRETO” 33 Il cosiddetto “pubblico della poesia” non è mai stato, in verità, numericamente pari a quello degli stadi,1 in epoca sia di bassa che di alta alfabetizzazione. In passato, quale plausibile motivazione del limitato interesse del “pubblico” verso la poesia, poteva addursi un’altrettanto limitata veicolazione del prodotto letterario in genere e in specie di quello poetico, la cui fruizione finiva per essere riservata prevalentemente ai ceti più colti e benestanti. Nei nostri tempi, almeno nel nostro Paese, a una progressiva elevazione del benessere materiale e a una lenta ma costante e incisiva diminuzione dell’analfabetismo non è corrisposta una parallela levitazione del numero dei lettori di poesia. Il fenomeno pare essersi sfrangiato per un verso e solidificato per un altro, considerato che con l’elevazione del livello d’istruzione i lettori di poesia sono percentualmente diminuiti, fino a non costituire più una risorsa di mercato per l’industria editoriale, che del settore, ormai da tempo, o non si occupa o se ne cura, in più benevoli casi, come una sorta di fiore all’occhiello. Una recente ricerca internazionale del CEDE (Centro Europeo dell’Educazione) condotta nei paesi dell’OCSE, ha rilevato – per quanto concerne l’Italia – l’esistenza di un considerevole analfabetismo di ritorno, riguardante un cittadino su tre. Ovvero: il possesso di un titolo di studio non è di per sé garanzia di un rapporto ottimale tra livello d’istruzione e competenza alfabetica, intendendo quest’ultima quale capacità di raccogliere, comprendere e utilizzare informazioni contenute in libri, tabelle e grafici.2 Secondo un altro rapporto OCSE dello stesso periodo, l’8,35% dei laureati italiani non è in grado di utilizzare la scrittura; il 25,25% ha capacità un po’ più elevata, ma con il rischio di arretrare al livello inferiore; il 48,15 se la cava discretamente e solo il 17,85% dispone di una competenza alta o molto alta. Tra i diplomati, il 10% incontra difficoltà nell’interpretazione di un testo scritto, mentre il 33,5% è in bilico. 3 Non è dato conoscere (ma nemmeno difficile dedurre) quanti fra questi – sia della fascia culturalmente più qualificata e avvertita, già di per sé ristretta, sia delle altre - si dedichino alla lettura di opere di poesia. Ancor più marcata appare la frattura con il “grande pubblico” (vale a dire lo spectator indifferenziato), certamente distratto dai mass-media e costantemente catturato nell’attenzione da un bombardamento di notizie, oltre che allettato da varie spettacolazio- 34 ni, specie televisive, politica e religione comprese. E mentre per la produzione narrativa e per quella saggistica possono costituire incentivi per le vendite forme anche indirette di pubblicità, i libri di poesia pare si avvalgano assai poco di simili chances, di fatto scarsamente praticate. E’ stato, in varie occasioni, avanzato il sospetto che il costo elevato dei libri scoraggi l’acquisto di opere letterarie; i “lettori presentiti” e i giovani, che per lo più hanno meno denaro, “devono accontentarsi di letture retrodatabili, attraverso i remainders e le bancarelle tradizionali”.4 A un’osservazione del genere, certamente fondata, si può contrapporre la considerazione, almeno per quanto riguarda la poesia, che la “retrodatabilità” non costituisce un grosso problema, mentre il costo dei biglietti per assistere ai “concerti” di divi della canzone o a competizioni calcistiche, con ben altri afflussi, non è certo inferiore a quello dei libri di poesia o d’altro. E tuttavia, quando alcuni anni fa Mondadori si è provato a lanciare una collana economica di poeti famosi (”I Miti”), il successo è venuto: nel 1997 si registrava la vendita complessiva di tre milioni e mezzo di esemplari per i 43 volumi pubblicati in quel torno, con una media di 85.000 copie per volume, a fronte delle poche migliaia della tiratura ordinaria. Nello stesso anno, Einaudi registrava un 30% di incremento di vendite della sua collana “bianca” di poesia, con un aumento da sei a dieci titoli annuali, mentre Garzanti sopperiva alla chiusura della collana minore di testi avviando la serie di agili volumetti “Di cosa parlano i poeti”.5 Nonostante tali impennate, gli spazi editoriali per la poesia non paiono essersi sostanzialmente ampliati e immutata resta globalmente la diffidenza dell’industria editoriale verso il prodotto poesia. Francesco De Nicola e Giuliano Manacorda, curatori dell’annuario di poesia I limoni 1997 dell’editore Caramanica, osservavano che un momento di così “propizio legame” tra poesia e grande editoria non giovava necessariamente ai poeti, soprattutto a quelli che non sono anche professionisti affermati, docenti universitari, magistrati, giornalisti, funzionari della RAI o di grandi complessi editoriali o industriali, insomma appartenenti a quelle categorie di potere cui il grande editore guarda spesso con rispetto e per il quale può anche pubblicare qualche libro di poesia che venderà pochissime copie, ma che sicuramente riceverà attenzioni sufficienti dalla stampa e dalla critica più disponibile ai compromessi. 6 Per il poeta che non può vantare l’appartenenza a “categorie protette”, notano ancora i menzionati studiosi, non resta che provvedere alla pubblicazione a proprie spese o affidarsi (solitamente con più esosi costi) a “editori di poesia” o ai vari “registi del sottobosco letterario che si nutrono dei sogni dei poeti”. 7 Denunce del genere non sono mancate, a varie riprese, con particolare riguardo dagli anni sessanta in poi; citiamo, a titolo esemplificativo, quella lanciata da Domenico Cara nel 1979, a proposito della “situazione triste ed 35 antieroica” dei libri pubblicati in proprio, che finiscono per diventare sempre più “un coatto falso bibliografico” essendo di fatto introvabili in qualsiasi punto di vendita nel luogo in cui si stampano (e ovviamente anche fuori); non letti dalla critica, invano cercati da qualcuno, invenduti anche perché non esposti – o peggio – non accettati dai librai, spesso distribuiti controvoglia, o con paura di spreco di spazi altrimenti utilizzabili. 8 Introvabili ma strabocchevoli nella quantità, per cui pare che l’elevazione del livello degli studi abbia prodotto più facitori che lettori di versi; è certo infatti che se fosse dedicato pari entusiasmo tanto alla creazione di propri testi quanto alla lettura di quelli altrui, l’editoria riguardante le opere poetiche non registrerebbe crisi di mercato e non indurrebbe così tanti editori a sbarrare in vario modo le porte alla poesia. Una così caotica situazione finisce per disorientare il ridotto e pencolante “pubblico della poesia” il quale, non appena si trovi ad accostarsi a poeti della contemporaneità più o meno nuovi, trova non sempre corrispondente alle aspettative l’avallo in qualche modo orchestrato per alcuni di essi. Per converso, può accadere al lettore “presentito” di poesia di reperire, anche occasionalmente, nella veicolazione cosiddetta semiclandestina, qualche poeta di tutto riguardo, ancorché non proprio noto, fra quanti si affidano all’editoria minore o alla esoeditoria. Non è allora azzardato tracciare due linee nella situazione attuale: una riguardante l’ufficialità (termine con il quale è da intendere la poesia che si muove nell’ambito della culturaEstablishment) e un’altra che l’affianca, della semiclandestinità (termine che è un po’ l’equivalente di altri, quali: bohemienne, in senso classico e mürgeriano, esclusi melodrammatici traslati; underground, in senso letterale, escluse ormai implicazioni di carattere ideologico, etc.), assai più numerosa e invasiva, benché in tutto o in parte fuori circuito, nel cui ambito è possibile trovare un po’ di tutto, dalle velleitarie sconsideratezze alle più raffinate prove di poesia, dalle spericolate sperimentazioni agli esiti più ragguardevoli di voci più o meno clamantes in deserto. C’è da chiedersi se il disorientamento del “pubblico della poesia” sia dovuto alla bizzarra situazione, per così dire, politico-mercantile del settore, nel nostro Paese (altrove il fenomeno non assume aspetti così macroscopici), o non abbia un suo pendant anche sul piano estetico. In altri termini, c’è da chiedersi se e in che misura abbiano potuto contribuire i poeti stessi ad allontanare pian piano i loro lettori. Un aspetto rilevante e sicuramente positivo della poesia italiana nell’ultimo trentennio consiste nella (progressiva) multiderezionalità delle tendenze, del resto in linea con la complessizzazione della società odierna, pluralistica e connotata dalla varietà dei modelli di riferimento; società instabile e mutevole, richiedente continui adeguamenti. Non c’è da stupirsi se, in poesia, manchi oggi una linea guida o, per dirla con Giuliano Manacorda 36 una bussola che guidi il lavoro degli autori lungo un viaggio che sia insieme personalissimo e comune o, fuor di metafora, ogni poeta appare impegnato su una particolare ricerca formale, su una sua propria visione delle cose, senza che le tante, o troppe, presenze riescano a disegnare un panorama (letterario, ma non solo) organico, riconoscibile, tramandabile come il ritratto di una condizione che fu la nostra nel lungo occaso del millennio.9 Dalle forme neo e/o tardo sperimentali ai riflussi classicheggianti (talvolta con revival di metri e ritmi, dal sonetto alla rima, fosse anche interna al verso), c’è tutto un verzicare di soluzioni formali, talvolta anche con esiti apprezzabili. Circa un ventennio fa Luciano Anceschi, intervenendo ne “Il Verri” su «Gli equilibri della poesia», dopo aver sottolineato come la parola tenda continuamente a mettere in crisi se stessa e come vada registrandosi una continua espansione dell’aria segnica, rilevava che la poesia appare ora irreducibile ad una unica idea di sé; ci sono contemporanee tradizioni diverse, talora anche intrecciate tra loro. […] la poesia appare come un protendersi continuo dell’immaginare e dell’idea dell’immaginare in tutte le direzioni secondo tutte le sollecitazioni e le possibilità in infinite linee vettoriali (e ciò non vuol dire che la poesia si trovi ora in una situazione felice.” 10 In merito alle neoavanguardie, rilevava lo studioso che «le poetiche della poesia sperimentale sono tante da non poter essere numerate.11 Non è il caso di aggiungere che le poetiche non ascrivibili alle neoavanguardie non erano di meno e che tanto le prime quanto le seconde non si sono quantitativamente ridotte negli ultimi decenni del secolo. Una tale varietà e una tale mobilità possono essere sollecitanti per il poeta. Ma lo sono parimenti per il lettore di poesia? O tendono a confonderlo? Ritorna la vexata quaestio se il poeta, con la propria parola, debba avvicinarsi alla gente o non curarsene, seguendo il proprio fantasma creativo. L’interrogativo è di per sé pericoloso. Proponendosi di rivolgersi a tutti e ad ogni costo, il poeta rischia una grave compromissione, ossia di cedere all’ovvio, che è negazione della poesia. Fino a che punto sono conciliabili originalità e comunicabilità? È questione complessa. Intanto il “pubblico della poesia” dovrebbe essere dotato almeno degli strumenti essenziali per accostarsi al genere: se questi mancano non può fondarsi un vero rapporto. È anche vero che tale rapporto finirebbe, d’altro canto, per essere eluso se fosse il poeta a trincerarsi capziosamente nel trobar clus. Ogni volta che si fa stanco il linguaggio della poesia, risulta salutare la sberla delle avanguardie, che praticano linguaggi inediti, esclusivi, nella fondata convinzione che non possa darsi poesia nuova con un linguaggio usurato. Ma è anche illusorio credere che basti frantumare lo strumento linguistico e sovvertirlo per essere sic et simpliciter originali. Occorre un quid novi più profondo che vi si affianchi - un colpo d’ala -, in mancanza del quale non si ha più il vecchio ma nemmeno il nuovo. Il poeta inglese Gerard Marley Hopkins aveva trovato una sua formula, condensata nella seguente espressione: linguaggio comune intensificato. Va considerato infatti che tale 37 “intensificazione” (da non intendere ovviamente come un caricare le tinte, bensì come un ri-significare la parola), nei poeti autentici, rende il linguaggio personale (singolare da ‘collettivo’ qual era), salvaguardando innovazione e tradizione, creatività e comunicabilità, nonché le esigenze di chi scrive e quelle di chi legge. Gli equilibri della poesia, appunto. In un suo saggio, apparso circa una dozzina di anni fa,12 Paolo Valesio, dopo aver rilevato che la poesia nella sua assolutezza «non può rientrare negli schemi di discorsi in cui la dimensione comunicativa offuschi e deprima quella espressiva», essendo la poesia «inevitabilmente, ontolologicamente, opposta alla comunicazione massificata»13, sostiene che sia giunta la fine del «periodo dell’illegibilità» dei testi poetici, parallela alla fine del periodo strettamente “lirico” della poesia italiana e che ci si muova verso un superamento della “opacità” versus la “trasparenza”, distinguendo quest’ultima da altri apparentati o antitetici (trans-lucenza, invisibilità, diversa dalla non-visibilità, etc.)14. Tra i poeti contemporanei italiani, nota Valesio, due si erano avvicinati di più alla trasparenza, nell’ultimo periodo della loro produzione: Antonio Porta e Adriano Spatola: entrambi questi ben diversi poeti cominciano nella loro seconda (e purtroppo ultima) fase a scrivere versi in cui emerge una trasparenza: trasparenza dei loro testi (acque più limpide di quel che fossero una volta) sopra gli scogli delle grandi questioni mute poste dalla vita, e dalla sua precarietà.15 La via della trasparenza, secondo Valesio, si apre uscendo dai «confini angustamente lirici, scegliendo la discorsività narrativa, o dialogica».16 Una tale fenomenologia estetica, nota ancora lo studioso (poeta, oltre che estetologo), non deve “essere guardata soltanto all’insegna della limpidezza”17 e cioè di una trasparenza pura, che può essere “ingannevole e causare le più brutali delle sorprese”, come accade al passero che scambi il terso vetro di una portafinestra con l’aria libera, rimanendo tramortito dal violento urto. Solo allora, nota Valesio, ci si può rendere conto della funzione “aiutevole” di qualcosa che prima sembrava goffo ed esteticamente non appropriato: quei profili colorati, o decalcomanie, di uccelli che si vedono talvolta appiccicati a porte e finestre o portefinestre. La loro funzione, appunto, è quella di avvertire i volatili che troppo ingenuamente credono nella trasparenza assoluta: “Attenzione, qui c’è del solido, non potete trapassare.”18 Per altri versi, sviluppa un discorso non proprio analogo (riguardante la dialettica parola-silenzio), tuttavia da considerare in questa sede, Ermanno Krumm, intervenendo sulle poesie di “Coro” di Giuliano Gramigna, silloge a proposito della quale parla di “poesia della dicibilità”, che superi “le falsificazioni ideologiche e pastoie consumistiche”19 e ponga in essere se stessa uscendo dalla propria basilare in-dicibilità: 38 Quella che saggia le condizioni di dicibilità è una grande linea (seppure non molto frequentata) del novecento. Un rasoio specialissimo che, da una parte, taglia le esercitazioni dello “sperimentalismo”, e quei testi che perdono di vista l’interrogazione sul chi parla e con essa la punta di necessità che tiene la poesia agganciata anche nei più spericolati movimenti, nei più rischiosi passaggi. Dall’altra, questa linea, taglia le zone di scrittura che si esercitano all’interno di una scuola, di un’estetica, di una rete di temi e figure. Si delinea così un modo di fare poesia dove l’interrogazione sulle condizioni di dicibilità parte da un minimale ma fondamentale, da un contatto fatico, un borborigmo, un balbettio in cui però si gioca, nel nostro secolo, la possibilità per la poesia di continuare ad esistere. È la furia eroica e insieme l’eroica reticenza che non cessa di ricercare poesia nei giri ellittici di un mutismo di fondo, di costruire poesia tirandola dal silenzio che la costituisce, di contribuire alla sua interminabile rinascita, nella perdita prima ancora che nella riuscita. 20 Nel testo di Gramigna, Krumm individua tre tipologie di poesia, che emblematizza in: frase-scena, imago, uova-linguaggio. In sintesi: «la prima tipologia è caratterizzata da un parlare discorsivo – la “parlotteria del sogno” – che funziona per agencement d’un enunciato che va ampliandosi in una frase-scena»; 21 la seconda è «la terra dell’inganno» in cui la poesia «conosce l’impossibilità di nascere e di finire», «la terra di nessuno, il luogo della sospensione e della non poesia»;22 nella terza «non c’è consolazione della chiacchiera protratta, ma esposizione in piena luce di un’anfibiologia tra dover e poter scrivere.»23 Un a fondo particolarmente significativo, senza tergiversazioni, proviene da Alfonso Berardinelli nel suo lucido saggio La poesia verso la prosa, in special modo nel “Prologo” ai testi critici che in quel volume sono raccolti. La teoria di Roman Jakobson secondo la quale, fra le funzioni linguistiche, quella “poetica” avrebbe come caratteristica «quella di non comunicare altro messaggio che il messaggio di comunicare un messaggio»24 – con la conseguente netta distinzione tra lingua poetica e lingua comune, per cui la seconda serve anzitutto a comunicare, mentre la prima «sarebbe tanto più se stessa quanto più si sottrae al funzionamento comunicativo»25 –, è contestata dal Berardinelli sul piano estetico, ma anche su quello linguistico (con riferimento a Franco Brioschi e Costanzo Di Girolamo). Tale teoria infatti «non sarebbe che una versione tardiva e ammodernata della poetica dell’arte per l’arte», per cui la letteratura stessa «sarebbe fuga dalla comunicazione e dal significato» e «i procedimenti della letterarietà sarebbero quindi procedimenti che staccano la poesia dalla comunicazione, che isolano la funzione auto-referenziale o poetica dalle altre funzioni linguistiche, soprattutto dalla prosa.»26 Altre teorizzazioni (Barthes) e «l’egemonia strutturalista e neoformalista durata nelle università per circa vent’anni”, pare abbiano reso – sempre secondo l’autore – inarrestabile il cammino del linguaggio poetico «sulla strada della depurazione anticomunicativa.»27 C’è di più: 39 Quasi senza rendersene conto, ipnotizzati da un’autorità teorica che definiva la lingua poetica come lingua che fugge dalla discorsività, dall’emotività e dalla rappresentazione, la maggior parte dei giovani autori che hanno cominciato a pubblicare dagli anni settanta in poi non hanno varcato i confini e i recinti ristretti fissati dall’estetica formalistica e dalle avanguardie informali. Secondo cui, in poesia, tutto era possibile, tutto era concesso, fuorché dire qualcosa. 28 Discorsività, emotività e rappresentazione sono indicate dunque quali linee-guida per un (implicito) rinnovamento della poesia attuale dal suo interno, superando la stessa dinamica chiarezza-oscurità, concetti (in Berardinelli pressoché corrispondenti a quelli valesiani di trasparenzaopacità) e certo non assoluti: Si è sempre chiari e oscuri per qualcuno, per un pubblico determinato, con la sua competenza letteraria e le sue attese, come direbbero i teorici della ricezione. In quanto caratteristiche testuali e basta, la chiarezza e l’oscurità non hanno molta consistenza. Non sono qualità intrinsecamente stabili. L’oscurità di cui per decenni, fino a qualche tempo fa, è stata accusata in blocco tutta l’arte moderna (…) non era tanto una caratteristica di testi e opere, quanto una qualità indifferenziata attribuita dall'esterno, un giudizio globalmente negativo del pubblico diciamo borghese e della critica diciamo accademica. Gli artisti e il loro linguaggio, i poeti con i loro sogni e le loro verità non comunicavano più o non comunicavano abbastanza con la maggior parte dei membri della loro stessa classe. L’oscurità era il risultato di una comunicazione interrotta o disturbata.29 Per quanto riguarda la nuova poesia italiana, il risultato della non-lettura è stato prodotto, secondo Berardinelli, dalla «massa dei non-poeti di seconda e terza serie, guidata da un ristretto gruppo di attivi non-poeti di prima serie.» 30 Ipotesi polemica che, in ogni caso, rimanda a responsabilità da ricercare anche nell’ambito della categoria dei poeti e non soltanto in quello del (genericissimo) “pubblico della poesia”. Nel suo articolo “Linea mediterranea e malumori del tempo”, Elio Giunta respinge come “totalizzante” (tale, cioè, da coprire l’intera area geografica della nostra repubblica delle lettere), quale una certa usualità letteraria vorrebbe far apparire, «la linea di un individualismo volutamente asettico e formalistico, figlio più di sofisticata pratica letteraria che di consistente tenuta poetica», a cui può contrapporsi una linea basata su un insistente esistenzialismo passionale, “con al fondo verità problematiche viste dal basso” – secondo una lucida interpretazione di Natale Tedesco -, e, soprattutto un linguaggio che ha il fascino di un’ironia talvolta efficacemente corrosiva o sa di intonazioni nostalgiche, più spesso di solarità.31 In questa linea l’autore fa consistere “lo spirito e il linguaggio mediterraneo” , ancora tutto da studiare. 32 40 Altra tendenza, infine (sempre sulla linea della trasparenza, della discorsività, della mediterraneità o comunque la si voglia chiamare, secondo l’angolo di osservazione) è da rilevare, quasi in appendice, in una serpeggiante propensione tematica alla concretezza, di cui possono cogliersi non più che indizi in poeti più o meno giovani (in letteratura, com’è noto, l’essere giovani non ha connotazioni strettamente cronologiche). Una peculiare attenzione alle cose, alle res rerum: una sorta di poetica degli oggetti (nonché dei luoghi), capace (anche storicamente: da Pascoli a Cattafi) di coesistere con vari orientamenti estetici. Una ricerca di qualcosa che sappia consistere, che non si disperda nel vento, per così dire, che abbia una sua densità, che sappia coagulare (e “denso”, “coagulato” è, etimologicamente, il senso di “concretus”). Il reale, insomma, nella sua fisicità, nell’evidenza della nostra diretta esperienza, sensoriale e mentale. È concreto ciò che cresce, appunto, con la nostra esperienza (cum + crescere). Fisicità degli oggetti, fisicità del corpo. La “res” come l’esistente-individuale-concreto, l’id quod (“ciò che”, laddove l’astratto è l’id quo: “ciò per cui “); “res” come tutto ciò che può essere oggetto di pensiero e di giudizio, nella rilevanza (etimologica) del “reor”. Ci limiteremo ad alcune esemplificazioni, fra le tante. Ad un impianto narrativo di fondo si affida Paolo Ruffilli nel suo “Camera oscura”. Il poeta fa perno sull’oggettività di uno o più album di famiglia, con l’emersione di eventi memoriali, la conseguente registrazione di emozioni, la traduzione infine nel linguaggio poetico. I testi muovono dalla descrizione – apparentemente impersonale – di una foto (l’incipit dei vari morceaux è solitamente ricognitivo), quasi con una tecnica da école du regard. Dopo la perlustrazione, il poeta passa ai raccordi: al ‘calo’ nel tempo trascorso, alle circostanze che determinarono l’evento fotografico (richiamato alla memoria o ricostruito attraverso particolari, anche minimi), fino a leggere al di là delle sagome, dei gesti, delle cose, dei paesaggi. Figure e oggetti si muovono “sulla traccia del concreto”, chiarisce il poeta in una sua composizione: disegnano l’altra faccia del presente scisso, evanescente e sfilacciato: quella del discorso sistemato, fatta logica porzione di un immenso, specchio o ritratto di un valore rifondato, esperibile…alfabeto, perfino da l’abisso, del non senso.33 Un universo vibratile, che emerge da un verseggiare asciutto, come se la parola volesse presentarsi asettica, con la stessa indifferenza dell’obiettivo; e invece essa va a caricarsi di umori, di esaltazioni e ferite che il vissuto ha cosparso. Nel poemetto “Patmos” di Rodolfo Di Biasio, l’isola delle Sporadi in cui Giovanni vide e rivelò l’Apocalisse – isola del mito e della distanza – si fa 41 metafora di un intenso bilancio esistenziale, oltre che espressione tanto di una partecipazione al dramma del mondo quanto di un distacco da esso, in una superiore visione del reale e dei suoi affanni. C’è una sintonia profonda tra stato d’animo – interiorità – e “le cose”, perciò esse “smuoiono nella mano” allorché il poeta avverte la “scissione” e lo “scardinamento” derivati dallo stare in luoghi diversi: e allora è un vedere e insieme un non vedere e intristisce l’occhio che coglie il bordo delle cose e non le trapassa. E subito dopo: Toccarle, le cose, nemmeno basta più: o almeno a me non basta. Al modo dello sguardo anche il tatto. Questi ciottoli marini lampi li chiamano qui, questi ciottoli marini, dico, che ribadiscono in sé colore e musica il loro colore è balenio lama intarsio è acqua e luce e la musica il loro perpetuo franare verso solo verso il mare smuoiono nella mia mano. Svuotata del suo calore la mia mano si fa essa stessa una fredda cosa.34 Sempre sul tema della distanza, Marco Giovenale intitola Res una non ponderosa silloge, ispirata a un suo obbligato soggiorno fiorentino (con sofferta distanza da Roma), che «ha obbligato alcune parole alla frattura» e ha comportato non solo cupezza e contrattempi, ma anche «esperienze e […] vita davvero». A tutto ciò il poeta – precisa in una breve nota introduttiva - dà «il nome di cose, RES, nel presente segmento di storia “mondiale”, che invece – proprio al contrario – non sembra avere intenzione di scollarsi dalla lattescenza delle immagini, dei signa, che sono fatui e deboli.»35 E così, più in dettaglio: Mezzo mese in chiavica Oltrarno bastò a dissetarmi d’eterno. Oppure: 42 Un frutto matura nel petto: dolore di stucco da cielo a radice è sterco dirotto. E ancora: La polvere di gesso passa al vento a miglior vita. In terra non tanto: una traccia circoscritta. 36 De Re (intorno alla cosa) intitola Angelo Manuali una sua raccolta di versi dedicata a “la misteriosa cosa”, “proprio la cosa, quella lì”, fatta “concetto, sembianza”, “quella che nella mente si confronta”, rivolgendo la sua attenzione alla «cosa che è»,37 dunque res realis’ e res rationalis. In Ingannando l’attesa Aldo Gerbino affronta il tema del tempo che trascorre – e quindi della vita e della morte – con l’occhio rivolto alla realtà circostante e alla problematicità e poliedricità dei suoi aspetti, nel segno di una concretezza che fa costantemente i conti col quotidiano. Una sezione è dedicata ai “Tufi”, con specifico riferimento alla calcarenite: Lascia che essa, la Pietra, modelli il mio corpo, le mani, le pieghe degli occhi, le ciglia di vinile, l’anima.” 38 I 20 testi poetici di tale sezione celebrano la pietra e il suo respiro, nonché la capacità in essa implicita di generare sensazioni ed evocazioni: richiami mentali, speculativi, memoriali. Richiami, anche, di carattere storico-sociale, come in “Viscere di fuoco”, in cui il giallo cromo dello zolfo evoca il fantasma dei carusi delle miniere, il loro duro lavoro e le loro fanciullezze e adolescenze straziate. Ne Lo specchio capovolto di Rita Baldassarri le cose brillano di luce propria, come stelle vive, in una poesia luminosa, che fa leva sulla contemplazione della natura. Assieme a lune e prati, soli ed erbe, stelle e foglie e tanti animali, le cose si muovono con vigorosa levità, colte nel fluire dei giorni e trasformate in finissime essenze.39 Così anche per i Sassi, che danno titolo alla sua ultima silloge e alla poesia d’apertura: Sassi, messaggi del mare contro il vetro dell’aria per chiamare la terra che scende giù, non vista, dalla camera in ombra del bosco che tanfa erba sudata e le radici a pendere dall’alto, filamenti di luce; 43 sassi lanciati alla terra, schiocco di incantamenti per le trasformazioni possibili: sul corpo rugoso un vestito di pizzi di schiuma e via sulla carrozza a precipizio di cavalloni verso il castello della notte in una metamorfosi d’acqua; la terra che sogna il ringiovanimento dal canto del bosco ed il mare la chiama e le scrive messaggi d’amore sui sassi.40 Cose si intitola la recente silloge poetica di Edoardo Sanguineti41: 38 testi composti tra il 1996 e il 1998, che non aggiungono molto – sul piano della scrittura e su quello dei contenuti – alla poesia dell’autore, quale si è andata (via via o fin dagli esordi?) configurando. Testi, in ogni caso, riconducibili a quel “realismo allegorico” in cui lo stesso Sanguineti fa consistere la “formula” che gli è “più cara”. (42) L’andamento è prevalentemente diaristico, da annotazioni di viaggio, con riferimenti costanti alla concretezza dei fatti della vita quotidiana. E “fatti” sono, più che “cose”, quelli su cui si concentra l’attenzione del poeta (o meglio: fatti come cose, da intendere, dunque, nel senso di: succedono cose), salvati dal loro dissolvimento nell’oblio (in cui normalmente precipitano i mille avvenimenti che costellano le giornate degli uomini qualsiasi) per effetto della loro celebrazione – o museificazione – nel testo poetico. Già considerato in Postkarten (1978), il «piccolo fatto vero» sanguinetiano, osserva Fausto Curi in prefazione, ha una “esemplarità”, consistente nel suo essere, prima che poeticamente, […] storicamente significante, di una significatività che il poeta deve estrarre e rendere palese. […] ”il piccolo fatto vero” intanto è significativo, e potenzialmente memorabile, in quanto è un “fatto” che, pur minima, ha una sua portata storica, in quanto, direttamente o indirettamente, implica anche gli altri, perché, insomma, meglio che un “piccolo fatto vero” è un piccolo fatto storico.43 Del resto, l’io narrante (e la poesia di Sanguineti fa leva su valenze e ritmi narrativi) si (rap)presenta come uno dei tanti («noi tutti, individuati individui individuabili»44), con peculiarità anch’esse ben delineate: “io sono, nel mio complesso, un corretto signore complessato”,45 con marcata configurazione di intellettuale (marxiano e un po’ erotomane), che – a parte la «immersione in una interiorità molto fisica e corporea», come fa notare Niva Lorenzini recensendo il libro ,46 va osservando e descrivendo, nel suo girovagare, altri come lui. Tutto è filtrato attraverso una fine, arguta ironia, che investe, e in definitiva salva, uomini e cose. Un dialogo interiore, carico di sentimentali valenze, tuttavia tenute a bada, è quello che Daniela Monreale traduce nella sua – esteticamente finissima – silloge Lo sguardo delle cose. 47. Un racconto esistenziale, il cui riferimento a un «tu», a volte magnetico e/o evanescente, si snoda tra frequenti supporti oggettuali e attraverso lo «sguardo delle cose», appunto: quello che noi 44 rivolgiamo ad esse e quello che esse ci rivolgono. Colloquio anche questo. Per effetto della costanza della loro interazione (e iterazione) con le vicende della quotidianità, le cose perdono il loro ruolo periferico, di contorno, per farsi figurazioni di centrale rilevanza. E vi si «rifugia» la persona, quando quale sale il disincanto, allorché giova prendere distanza dagli assilli, anche per evitare rischi di «anoressie sentimentali»48: servono, come rifugi, le cose dette a mira degli occhi, quietamente portate in mezzo. Come nocche sul vetro, toccano e chiedono luminose definizioni, che galleggino nelle tue braccia e tacciano. Che poi siano lapilli di fonemi, lallazioni, per un bleso resistente niente, facciamo che il segno sia semplicemente. Sia.49 Barbara Carle, in una sua silloge bilingue (inglese e italiana), Tangible remains / Toccare quello che resta 50, rivela, fin dal titolo, l’attenzione ai molteplici e, appunto, tangibili, aspetti della realtà circostante, che si presentino a noi quali «reliquie» di centinaia o migliaia di anni, sopravvissute ai vari crolli di civiltà e, precisa l’autrice, «vorremmo immaginarle superstiti del prossimo blackout»51. Una poesia della concretezza, dopo le tante dissolvenze novecentesche nelle arti e nelle lettere (astrattismo, surrealismo, informale, nonsense, neoformalismo etc.). E di fronte al reale la poetessa si colloca, con i grandi timoni di cui dispone la nostra corporeità, che sono i cinque sensi più il sesto. Un’inversione di percorso, nella sottesa considerazione che non si possa giungere all’astrazione (ab trahere) se non partendo − traendo − dal concreto e non recidendo i ponti con esso. Il reale è osservato nei suoi aspetti minuti, a volte anche umili, che ne definiscono i contorni e la pregnanza, il loro senso riposto, la loro radicale significanza, alla scoperta dei fili segreti e profondi che intercorrono in ogni frammento del cosmo, al di là delle distanze di tempi, spazi e dimensioni. Le sensazioni, dunque, come input, patrimonio di sollecitazioni, anche sul piano estetico, per stabilire un dialogo, palese o recondito, tra tangibile e intangibile, tra visibile e invisibile, tra voce e silenzio. Abbiamo così poesie dedicate alla bottiglia, al bicchiere, al tappo e al cavaturaccioli, alla candela, alla sedia, al pettine, alla lima, alle forbici, a carta e matita, a una foto, a dipinti e così via. Ma anche a presenze vegetali e loro derivati (eucalipto, mango, ulivo, olio d’oliva, tulipani, mughetti) e animali, come nelle finissime poesie dedicate alla gatta siamese Shakti e all’occhio del gatto. Si indovina la presenza dell’uomo, anche se, nella sua dimensione fisica, compare solo tangenzialmente. Il grande pittore e incisore Giorgio Morandi può offrirci un exemplum delle altezze a cui possa attingere l’arte anche prescindendo dalla trattazione dei cosiddetti ‘grandi temi’ (le sue bottiglie e i suoi bicchieri sono capolavori); possiamo anche fare riferimento alle Odas elementales di Pablo Neruda. Il bello della poesia consiste, fra l’altro, nella sua capacità di raggiungere alte vette tanto con L’Infinito di Leopardi (che muove, com’è ben noto, dalla 45 concretezza della “siepe” e si inoltra, senza limiti, nel suo superamento) quanto con l’Ode alla cipolla del poeta cileno. Una poetica degli oggetti in cui questi sono liricamente e indagati (in un linguaggio essenziale, mobile, incisivo) per coglierne forma e sostanza, la loro pertinenza a una realtà più vasta e alta. Anima rerum, si direbbe. Poesia delle cose, poiché c’è poesia nelle cose, tutto sta nel riuscire (e qui si misura il poeta) a farla sprigionare da esse, liberarla, in un’operazione maieutica che la parola ri-significata nel verso rende possibile. È così per la poetessa: La mia scopa possiede questo forte odore dell’aperto smuove la mia casa col profumo di erica spazzola via la polvere grigia con piume solari.52 Gli occhi del gatto: i suoi cristalli acquistarono virtù imparando a catturare la luce e a trasformarla in una via lattea. Ora nella sua pupilla splendono inconcepibili distese di tempo una minuscola galassia brilla nel suo duomo.53 L’Eucalyptus si fa sintesi di equilibrio cosmico e psicologico: tra la terra e l’aria tra il mobile e l’immobile, la luce e il buio. Se colleghi tutti i suoi punti, realizzerai un ampio cerchio di terra, acqua e fuoco. […] Rasserena e purifica con l’aroma unico e porta l’equilibrio all’anima con la sua essenza benevola e terapeutica.54 E basta un semplice rettangolo di carta, una foto in bianco e nero che ritrae due fratellini in riva al mare, per leggere dentro − intra/vedere − il destino stesso dell’essere umano, nell’inafferrabile e imprevedibile mistero dell’universo. Occupandosi criticamente della poesia di Cesare Greppi, Marisa Bulgheroni si sofferma sul testo Parlo delle sole cose che sono ed esamina la dialettica materia-intelletto: la resistenza della materia a essere definitivamente nominata, e dunque conosciuta, sfida la rapacità acquisitiva dell’intelletto. Quasi in forma estranea di “natura morta”, che contrae l’enigma del visibile e lo ingigantisce per avvicinarlo all’occhio, l’interno di una casa si definisce qui come punto interno alla poesia, dove l’ordine delle cose e l’ordine delle parole vertiginosamente si confondono l’uno con l’altro, ognuno decretando il proprio limite invalicabile. La parola varca sicura il cerchio di indisciplina che racchiude un centro inaccessibile: “Parlo 46 delle sole cose che sono / intorno a cominciare / dalla scura gramigna / intorno alla calma casa. / Questa è piena e immobile…55 Bulgheroni fa rilevare altresì come nella poesia di Greppi assuma rilevanza la corporeità, in particolare: l’urto tra la parola come suono, come ritmo, forza sonora e trascinante e creatrice (“soffio”) e la parola come veicolo di un “corpo”, di un grande referente enigmatico che si apre un varco attraverso i sensi.56 Al corpo è da alcuni poeti rivolta analoga attenzione che alle cose. Al corpo come metafora stessa della scrittura. È così, ad esempio, in una sorta di poemetto narrativo di Enio Sartori, in cui è rappresentata una storia d’amore, dal titolo Vedi alla voce corpo. Il rapporto tra corporeità e scrittura è evidenziato in prefazione da Adone Brandalise: Così converrà andare, come Enio Sartori propone, alla voce “corpo” non per trovarvi scritto o descritto il corpo ma per seguire il disegno manualmente “curvato”, corporeamente sinuoso, di una scrittura che sa far sì che le parole si ritraggano, non senza la giusta (nel senso di esattamente dosata, calibrata al punto “giusto”) resistenza, cedendo alla disperata salute di un corpo che silenziosamente avviene lì dove esse ad un tempo parlano o tacciono (o anche, si potrebbe dire, lì dove “si vive”), non per loro virtù ma non senza di esse. 57 Giunge infine Ragioni e canoni del corpo, un’antologia di versi inediti di poeti contemporanei curata da Luciano Troisio.58 Il soggetto specifico è l’Elogio del corpo (nella sua interezza o parti di esso) e «sua difesa “naturale”», l’uno e l’altra giustificati dal “colpo di grazia” oggi inferto alla fisiologia umana, sostituita «con una “fisiologia tecnologica” già in grado di operare miliardi di miliardi di operazioni al secondo»:59 Körpeding. Corpo concreto, “quel d’Adamo”, materia e “realtà palpabile” ma non “corpo dello schiavo”, non solo ologramma-virtuale; tema che si propone di contribuire a togliere di mezzo l’estraniazionealienazione del poeta, il suo espiare anche l’antico scandalo della carne e della contraddizione. Corpo che faccia riflettere sulla trappola del mondo delle idee, che annulli le polarità, indaghi finalmente sull’occulta cosmetica valorizzazione particulare, ma anche sull’altrettanto inespugnabile Anticorpo dell’Utopia.60 Ragioni del corpo e suoi canoni. Linguaggio del corpo, corporeità come linguaggio. Ed è come se alcuni poeti tendessero, attraverso la poesia, ad una – forse inconsapevole – (ri)appropriazione dei linguaggi non verbali da parte di quello verbale, in quanto metalinguaggio. Ma potrebbe anche trattarsi del di una (forse altrettanto inconsapevole) esigenza di frenare – attraverso una, per così dire, iper-concretezza dei simboli – l’eccessiva evanescenza del linguaggio verbale, così come l’ultimo Novecento aveva in gran parte voluto che fosse. 47 NOTE 1) Di un assai scarso interesse verso la poesia, manifestatosi già prima del ’68,avevano dato segnale F. CORDELLI e A. BERARDINELLI in: Il pubblico della poesia, Milano, Lerici, 1975. 2) G. BENEDETTI, Rischio analfabetismo per due italiani su tre, in: “Corriere della Sera”, Milano, a.125°, n° 118, 17.05.2000, p. 17. 3) Ib. 4) D. CARA, Letteratura e pubblico oggi in Italia, Palermo, Edizioni di Sintesi, 1979, pp.3-4. Non muta la situazione a distanza di qualche decennio. Ne Il sogno della letteratura (Roma, Gaffi, 2013, p. 167) D. MARCHESCHI, in un suo intervento dal titolo “Frammenti per una riflessione sul romanzo (1980-2010)”, scrive: « È chiaro che certa editoria tende a stampare solo le opere ritenute più vendibili secondo il mercato e che i giornali danno risalto al già noto e a ciò che li fa vendere. Prevale un criterio economico e pubblicitario, e questo porta ad un offuscamento. Ma può essere una debolezza dell’editoria trascurare a volte il fatto che il libro non è un sapone o un’automobile e che è, insomma, una merce irriducibile alla realtà totalmente reificata della merce medesima. Così certi critici, che facilmente si fanno banditori con la grancassa di un tale deficit concettuale e strutturale di molta nostra cultura, dimenticano quei lettori autentici, più numerosi di quanto non si crede, che hanno bisogno di parole vere, necessarie. Magari non sono milioni di miliardi, ma sta ad ognuno scegliere quello a cui tiene di più. » 5) F. DE NICOLA, G. MANACORDA (a cura di), I limoni – La poesia in Italia nel 1997, Marina di Minturno, Caramanica, 1998, pp.5-6. 6) ib. 7) ib. 8) D. CARA, cit., p.10. 9) G. MANACORDA, Un anno di poesia, in: F.DE NICOLA, G.MANACORDA, cit.,p.11. 10) L. ANCESCHI, Variazioni su alcuni equilibri della poesia che san di essere precari, in: “Il Verri”, Bologna, VI serie, n°1, 1° sem., 1976, p.16. 11) L. ANCESCHI, cit., p.15. 12) P. VALESIO, Fantasma di poesia futura – Per un’estetica della poesia di oggi-domani, in: “Inonija”, Cosenza, n° 8, Dic.1990-Giu. 1991, p.11. 13) P. VALESIO, cit., pp.11-14 passim. Le implicazioni della lirica, secondo l’A., non risparmiano le stesse avanguardie e neoavanguardie, in Italia o altrove: “Il grido e la frase spezzata, il cachin-no o la risata, la cacofonia – tutti questi gesti sperimentali sono una conferma e contrario del persistente fascino esercitato dalla lirica: una lirica-che-si-vergogna-di-sé-stessa è ancor più restrittivamente lirica di una lirica che francamente si dichiari come tale.” (cit., p.13). 14) P. VALESIO, cit., p.14. 15) P. VALESIO, cit., p.13. 16) P. VALESIO, cit., p.15. 17) ib. 18) P. VALESIO, CIT., p..15. 19) E. KRUMM, La poesia della dicibilità, in: “Testuale”, Milano, a.8°, n°13-14, Dic.1991-Giu.1992, p.49. 20) E. KRUMM, cit., pp.49-50. 21) E. KRUMM, cit., p.50. 22) E. KRUMM, cit., p.51. 23) E. KRUMM, cit., p.52. 24) A. BERARDINELLI, La poesia verso la prosa, Torino, Bollati-Boringhieri, 1994, p.12. 25) Ib. 48 A. BERARDINELLI, cit., p.13. A. BERARDINELLI, cit., p.14. ib. A. BERARDINELLI, cit., p.72. A. BERARDINELLI, cit., p.201. E. GIUNTA, Linea mediterranea e malumori del tempo, in: “Arenaria”, Palermo, a. XII, nn.33-34, sett.1995-apr.1996, p.49. 32) ib. 33) P. RUFFILLI, Camera oscura, Milano, Garzanti, 1988, p.77. 34) R. DI BIASIO, Patmos, Grottammare, Stamperia dell’Arancio, 1995, pp.1415. Testo confluito in: R. DI BIASIO: Altre contingenze, Marina di Minturno, Caramanica, 1999. 35) M. GIOVENALE, Res, Roma, Stamperia Romana, 1995, p.3. In epigrafe, l’opuscolo reca il seguente frammento da P. VOLPONI: «Ma le cose vere intorno a lui restano sempre vere, necessarie e non dette, le cose vanno avanti e finiranno per trovare una lingua loro…» (p.7). 36) M. GIOVENALE, cit., testi VII, VIII, IX. 37) A. MANUALI, De Re (Intorno alla cosa), Foggia, Bastogi, 1995, pp.23-4. 38) A: GERBINO, Ingannando l’attesa, Palermo, Novecento, 1997, p.12. 39) c.fr. R. BALDASSARRI, Lo specchio capovolto, Ragusa, Libro Italiano, 1998. 40) R. BALDASSARRI, Sassi, Chieti, Tabula Fati, 1999, p.11. 41) E. SANGUINETI, Cose, Napoli, Pironti, 1999. 42) “Io voglio fare, se ci riesco, arte realistica al massimo, e realistico è l’opposto del naturalismo, non l’imitazione della cosa ma la sua struttura. La formula che più mi è cara è realismo allegorico.” (E. Sanguineti), c.fr. C.VITIELLO, Postfazione a E. SANGUINETI: Cose, cit., p.63. Peraltro, nel testo n° 18, sono evidenziati dall’autore gli elementi meccanici, “fisiologici” del far poesia: «la poesia, in certo senso, è una macchina organica: (voglio dire, cioè) / assai rigorosamente fisiologica): / (che esige una manutenzione sorvegliata, / cautelosamente controllata): (è come fare i tagliandi, per l’auto […] » (cit., p.38). 43) F. CURI, Prefazione a: E. SANGUINETI, Cose, cit., p.7. 44) E. SANGUINETI, Cose, cit., testo n° 12, p.31. 45) E. SANGUINETI, cit:, testo n° 3, p.21. 46) N. LORENZINI, Realtà e stilizzazione, le ‘Cose’ di Sanguineti, in: “L’Immaginazione”, Lecce, a. XVII, n° 168, maggio 2 000, p.24. 47) D. MONREALE, Lo sguardo delle cose, Nuova Editrice Magenta, Varese 2001 48) D. MONREALE, cit., p.28 49) D. MONREALE, cit., p.19 50) B. CARLE, Tangible remains /Toccare quello che resta, Ghenomena, Formia, 2009. 51) Ib. Nota “Al lettore”, p. 119. 52) B. CARLE, cit,, Scopa, p. 26. 53) B. CARLE, cit,, Occhio di gatto crisoberillo, p. 34. 54) B. CARLE, cit,, Eucalypto, p. 43. 55) M. BULGHERONI, La parola e il corpo, in: “Testuale”, cit., p.21. 56) M. BULGHERONI, cit., p.20. 57) A. BRANDALISE, Prefaz. a: E. SARTORI: Vedi alla voce corpo, Roma, Ellemme, 1989, p.8. 58) L. TROISIO (a cura di), Ragioni e canoni del corpo, Milano, Terziaria, Asefi, 2001. Sono antologizzati 93 poeti in lingua italiana, reclutati, scrive in premessa il curatore. «in parte con sistema allargato, chiedendo cioè a una ventina 59) Op. cit., p.18. 60) Ibidem. 26) 27) 28) 29) 30) 31) 49 LA CRITICA LETTERARIA OGGI IN ITALIA. MALESSERI E PROSPETTIVE 50 Si avanza da qualche tempo e da più parti la (tautologica) ipotesi di una crisi della critica letteraria, in Italia, fatto che non dovrebbe allarmare più di tanto, dato che i concetti di crisi e di critica sono etimologicamente interconnessi e se la critica cogliesse l’occasione di interrogarsi seriamente sul proprio ruolo e sulle proprie prospettive non potrebbe che derivarne benefici effetti. Vero è che qualcuno tende a presentare la faccenda in maniera più fosca, parlando di morte della critica letteraria o quanto meno delineandone uno stato comatoso, in alcuni casi in tandem con la situazione attuale della letteratura, vista nel suo complesso, in altri casi in contrapposizione a una florida salute della letteratura stessa, al contrario, dunque, di quanto era avvenuto negli anni Sessanta e Settanta, in cui una critica piuttosto agguerrita si era affannata a parlare di morte dell’arte, in primis di poesia e romanzo. Non può negarsi oggi una condizione di malessere della critica letteraria e l’immagine di floridezza della letteratura, se c’è, è più apparente che reale, affidata com’è, in prevalenza, a un’esuberante produttività sul piano quantitativo. Ѐ la floridezza ingannevole di chi, essendo in sovrappeso, si trovi alle soglie di un’obesità foriera di malanni e complicanze. Da qui, ma solo in parte, il disagio della critica letteraria, dato che questa si trova a seguire (inseguire?) le sovrabbondanze della produzione poetica e narrativa, avvertendone e somatizzandone le carenze, i disagi, le malformazioni. A tale sovrabbondanza pare faccia riscontro un prosciugamento e deperimento della critica, peculiarmente quella detta “ militante”. Ma non siamo al collasso né ci pare si possa parlare, per usare un’espressione di Mario Lavagetto, di « eutanasia della critica ». Paolo Fabbri, in un’intervista del 2008, faceva notare che «in giro non ci sono più critici […] nessuno fa più un discorso critico ». In effetti la critica letteraria, in atto, non sempre riesce a muoversi adeguatamente nei propri recinti, limitandosi piuttosto a ciondolare nei dintorni di se stessa, disperdendosi in pubblicazioni a carattere divulgativo, in voci di enciclopedia (specialistiche o popolari che siano) e simili, per non dire delle recensioni (spesso ad usum delphini), sempre più espunte dalla stampa quotidiana o dai periodici a larga diffusione in cui figurano ridotte a frettolose schede illustrative, con ampia prevalenza della narrativa. Della poesia si tende a parlare sempre meno, mentre, per quanto concerne la saggistica, paiono 51 privilegiati i testi storici con agganci all’attualità o quelli che trattano di attualità sociologica o politica, meno quelli di estetica o di teoria della letteratura. Per uscire da questi asfittici schematismi nell’attività recensoria bisognerà rivolgersi, ovviamente, alle riviste specializzate, che restano pressoché estranee alla maggior parte del pubblico dei lettori. Ne esistono ancora di notevole livello e affidabilità, anche se, per lo più, messe in difficoltà dall’abolizione della riduzione delle tariffe postali per l’editoria (l’Italia è ora tra i pochi paesi al mondo, forse l’unica, che non contempli tariffe postali agevolate “per la diffusione della cultura”). Interessanti anche al riguardo (in una massa confusa e indistinta) alcuni siti on line. La critica militante dovrebbe essere normalmente quella che tiene in fermento il milieu letterario, svolgendo il suo ruolo, che consiste nella capacità di interpretazione e di ponderata valutazione di un testo letterario nell’ampiezza delle sue creative risorse o delle sue carenze. In tempi come quelli che attraversiamo si assiste invece a un uso improprio e strumentale della critica, mirato ad affiancare interessi editoriali, con un più o meno pedissequo adeguarsi, ad es., a una produzione narrativa quantitativamente squilibrata, di intrattenimento, esemplata, come ha rilevato Filippo La Porta, sulla fiction (alla quale peraltro aspira, spesso preludendola). Dilagano il giallo poliziesco, l’horror, la fantascienza, le biografie. Daniela Marcheschi rileva che «certa editoria tende a stampare solo le opere ritenute più vendibili secondo il mercato e che i giornali danno risalto al già noto e a ciò che li fa vendere. Prevale un criterio economico e pubblicitario, e questo porta ad un offuscamento. Ma può essere una debolezza dell’editoria trascurare a volte il fatto che il libro non è un sapone o un’automobile e che è, insomma, una merce irriducibile alla realtà totalmente reificata della merce medesima. Così certi critici, che facilmente si fanno banditori con la grancassa di un tale deficit concettuale e strutturale di molta nostra cultura, dimenticano quei lettori autentici, più numerosi di quanto non si crede, che hanno bisogno di parole vere, necessarie.» (D. Marcheschi, Il sogno della letteratura, Gaffi, Roma 2012, p. 167) La Porta ha messo in luce come tutto tenda ad essere ‘romanzato’, dalla politica alla cronaca, quasi non esistesse altro obiettivo che il divertissement, in mancanza della sostanza e del senso del reale, lasciando che tutto finisca per affogare in una sorta di « nichilismo estetico ». Tanto emerge dal suo caustico pamphlet “Meno letteratura per favore!”. Il titolo pare richiamare in qualche modo l’espressione “il resto è letteratura”, correntemente usata allorché si voglia indicare qualcosa di secondario, di non essenziale, come per dire: non facciamo chiacchiere inutili, caricandole della pretesa di volerle far apparire più di quel che effettivamente sono. In realtà La Porta vuol dire altro: deplora che chiunque, dai politici ai giornalisti agli scienziati, voglia riferire qualcosa, tenda a ridurla, quanto più possibile, a “storie”, forse per una captatio benevolentiae nei confronti del lettore, sull’onda lunga dei reality show, ma soprattutto di quel che ‘tira’ in libreria. La poesia può considerarsi, da tempo, se non divorziata, quanto meno separata in casa con il pubblico dei lettori, il quale (fatte le debite eccezioni) se ne cura poco e del resto si è via via diradato. In pari misura è andata invece crescendo una moltitudine poetante, i cui adepti finiscono sempre più per rinchiudersi in una sorta di riserva, leggendosi a vicenda, non di rado 52 continuando a complicarsi il linguaggio e l’esistenza, il primo per apparire originali a tutti i costi, la seconda per incentivare un prodotto sempre più emarginato dagli editori (data la carenza di lettori). Un prodotto tuttavia guardato con occhi lucidi e vogliosi da editori a pagamento (alcuni particolarmente esosi) a cui non pochi finiscono per rivolgersi in mancanza d’altro. Ed è strano che, a saper cercare, si trovino anche in queste riserve alcune voci autentiche, mentre non mancano mediocrità e successi costruiti nelle collane della grossa editoria. Tra le cause di primaria importanza relative alla frattura tra pubblico e poesia, pare debba considerarsene una, non remota ma nemmeno recente, consistente in prolungati periodi di pervicace cripticità del dire poetico, in un eccesso di letterarietà. Ogni prodotto artistico nasce, com’è noto, dall’equilibrio tra due elementi imprescindibili: artificio e poiesis. Quest’equilibrio si è franto, in molteplici occasioni. Più artificio che poiesis. Troppo il primo, assai poco la seconda. Circa una ventina di anni fa, in un suo saggio dal titolo “Fantasma di poesia futura”, Paolo Valesio sosteneva ormai giunta la fine sia del « periodo dell’illeggibilità » dei testi poetici sia del periodo strettamente « lirico » della poesia italiana; era altresì del parere che ci si movesse verso un superamento della « opacità » in direzione della « trasparenza ». Citava il caso di due poeti, Antonio Porta e Adriano Spatola, che – provenienti dalle fila della neoavanguardia – si erano avvicinati di più alla « trasparenza » nell’ultimo periodo della loro produzione poetica. Una trasparenza, ovviamente, non assoluta (che sarebbe, a sua volta, ingannevole) versus una « discorsività narrativa e dialogica », in maniera non molto dissimile a quanto indicato, pochi anni dopo, da Alfonso Berardinelli nel suo saggio “La poesia verso la prosa” (1994). Dopo aver stigmatizzato « i confini e i recinti ristretti fissati dall’estetica formalistica e dalle avanguardie informali », il critico osservava che, secondo tali principi estetici, in poesia era stato « tutto possibile, tutto concesso, fuorché dire qualcosa » e indicava la discorsività, l’emotività e la rappresentazione quali linee-guida per un rinnovamento della poesia dal suo interno. In effetti, nel Novecento, si era coltivato, pressappoco in tutto il secolo, in varie forme e sotto varie spinte estetiche, il mito della frantumazione e della dis-armonia quali fondamenta imprescindibili della novità e dell’originalità, in letteratura come nelle altre arti, e in quel mare la poesia si era immersa, col suo tallone d’Achille proprio nell’infatuazione verso la in-dicibilità, toccando alcune punte estreme negli anni Sessanta e Settanta, con propaggini varie nei decenni successivi e fino ai giorni nostri, anche se innumeri e crescenti segnali di mutamento, di inversione di rotta, possono cogliersi fin dagli stessi anni Settanta. In quel clima e in seguito a quelle spinte, si era instaurato un bislacco gioco tra poeta e critico. L’uno cercava di apparire quanto più possibile oscuro e linguisticamente avventuroso, non di rado affidandosi a un interiore flusso di accostamenti verbali a la buena de Dios, magari poi intervenendo e riformulando con ulteriori complicazioni intellettualistiche. L’altro si affannava ad applicare formule, poniamo di linguistica generale, riscontrando esemplificazioni, a volte arrampicandosi sugli specchi, cavandosela, anche 53 egregiamente, per via della competenza professionale. Un gioco a nascondere, per bambini viziati. Erano gli stessi anni Sessanta e Settanta in cui, come accennavamo più sopra, si teorizzava sulla morte dell’arte: di tutte le arti, della poesia manco a dirlo, del romanzo in particolare, come in un ossessivo refrain. E si trascurava di considerare che le arti procedono anche per evoluzione, non solo per rivoluzione, e che i generi letterari sono soggetti a trasformazione. Chissà per quale motivo appariva strano il concetto di evoluzione del romanzo. Era come se questo, non potendo più assurgere ai fasti raggiunti dai capolavori della letteratura mondiale, poniamo sette-ottocenteschi, non trovasse più motivo per continuare ad esistere; appariva inconcepibile un romanzo che utilizzasse ancora le medesime impalcature in un tempo così diverso. Come se fosse impossibile costruire un romanzo su nuove fondamenta e con nuova architettura. Grandi, distanti e come obsoleti i modelli classici del romanzo, poniamo Fielding e Dickens, Hugo e Stendhal, Dostoevskij e Tolstoj, Manzoni e Nievo. Idem per i modelli, anch’essi architettonicamente assai elaborati, del feuilleton: Dumas, Sue, Montepin, Natoli, per citarne alcuni, che registrano tutte le possibili architravi del genere. Ma già il romanzo ottocentesco aveva subito mutazioni negli ultimi decenni dello stesso secolo XIX, con il realismo francese e il verismo italiano. Si pensi a Zola, Maupassant, Verga (un po’ meno a De Roberto, ancora legato a schemi formali della narrativa ottocentesca). E anche il romanzo d’appendice mutava abito, per assumere quello, più prêt à porter; del romanzo popolare (bastino, a mo’ di esempio, i nomi di Mastriani e della Invernizio). Né occorre dire che la prima metà del Novecento – non solo italiano, non solo europeo – registrava nel romanzo una produzione ricca di opere di rilevanza eccezionale per invenzione narrativa: famosi e autentici pilastri della narrativa mondiale, in cui non mancano certo impulsi innovatori (basti fare i nomi – che non sono i soli – di Proust, Joyce, Kafka, Musil, e dei nostri Buzzati e Gadda) . Eppure nel 1960 il genere romanzo è considerato spacciato, senza possibilità di lazzaresche resurrezioni. Intanto, quasi sul discrimine degli anni Sessanta, nel 1958 (un anno dopo la pubblicazione del Pasticciaccio gaddiano), erano apparsi in Italia due romanzi di autori siciliani e uno di autore straniero, in traduzione italiana, che non davano affatto allarmanti segnali patologici per quel genere letterario, anzi ne confermavano la vitalità. Tre grandi opere destinate a rimanere, esemplate in maniera al tempo stesso consona ed eccentrica nei riguardi dei modelli ottocenteschi e proto novecenteschi, diversamente utilizzati con moderna sensibilità: “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, edito da Feltrinelli, “Il mondo giovine” di Salvatore Spinelli, edito da Ceschina, “Il dottor Zivago” di Boris Pasternak, edito da Feltrinelli. Ed è proprio su quel discrimine e nel corso degli anni Sessanta e Settanta che un altro siciliano, Antonio Pizzuto (amico di Spinelli, il cui romanzo considerava un capolavoro di equilibrio stilistico e di buon gusto, a cui era riservata « una sorte, una risonanza, di panico somigliante a quella che toccò a Joyce quando fu pubblicato l’Ulisse »), andrà pubblicando le sue più significative opere narrative: “Signorina Rosina” (1956, 1959), “Si riparano 54 bambole” (1960), “Ravenna” (1962), “Paginette” (1964), “Sinfonia” (1966), “Vezzolanica” (1967), “Testamento” (1969) e nel 1975, anno della scomparsa dello scrittore, “Giunte e virgole”. Altre importanti opere usciranno postume, ma quelle menzionate, apparse durante il pressing neoavanguardistico, bastano da sole a offrire un rilevante exemplum di innovazione del genere, secondo parametri difformi da quelli delle neoavanguardie (a cui Pizzuto rimane decisamente estraneo): un’innovazione che coinvolge, dall’interno, la struttura del romanzo e il linguaggio che lo innerva. In quel periodo la critica cavalcava, come abbiamo accennato, la tigre neoavanguardistica. Non si può dire che emergessero ragionevoli elementi di riflessione sulla funzione stessa della critica. Tutto finì per sobbollire nel medesimo calderone, nel quale uno dei principali ingredienti era l’identificazione tra critica e specialismo. La critica era settoriale, mononucleare, per cui il testo letterario era osservato e analizzato con il superiore distacco dell’uomo di scienza, secondo un criterio, appunto, specialistico, vale a dire da un solo punto di vista. Si notomizzava una parte trascurando l’insieme, ossia il prodotto letterario nella sua interezza e complessità, nella ricchezza delle sue connessioni, implicazioni, rimandi. La critica era o psicanalitica o strutturalista o formalistica o storicistica o sociologica o decostruzionista, perfino femminista. Nel clima – da necrofori – della morte dell’arte, era come se la critica si fosse parcellizzata, chiudendosi in esclusivi recinti dall’accesso precluso ai non addetti ai lavori. Non si riusciva ad immaginare che potesse avvalersi, ad es., dell’apporto di altre scienze, da considerare, per così dire, ausiliarie per il lavoro critico (filosofia, psicologia, storia, sociologia, linguistica etc.), delle quali fosse necessario possedere i fondamentali, allo scopo di potersene servire all’occorrenza, disponendo di maggiori frecce nell’arco e secondo un modello aperto. E considerato altresì che esiste un filo rosso tra interpretazione di un testo e interpretazione del reale, nella molteplicità delle sue manifestazioni (è “reale” tutto quanto appartiene all’uomo e al mondo: immaginazione, fantasia, onirico, follia, ad es., rientrano nella dimensione del reale, non sono estranei o esterni ad esso) e nella dinamica tra dis/velamento e ri/velazione. Un sussulto di «responsabilità», a partire dagli anni Ottanta (con parole-chiave quali “stile”, “tradizione”, “realismo”) coglie Emanuele Zinato in un suo recente e interessante saggio; sussulto da non sottovalutare, anche se – a nostro avviso – ancora fievole. Il malessere della critica, non solo letteraria, trova oggi non poche radici nel persistere di propaggini le cui radici risalgono ai primi decenni del Novecento. Nasce, in buona sostanza, dalla difficoltà ad accettare ed accogliere un principio elementare, posto ai margini nel corso del secolo XX, secondo cui, in arte, le frantumazioni formali sono utili se funzionali a una più ampia e ricca visione d’insieme, altrimenti navigano nel vuoto, si limitano all’apparenza, al dato fenomenico, non incidendo sulla sostanza. La grande illusione di un secolo è stata quella di ritenere che tali formali frantumazioni garantissero tout court originalità e creatività. Assumiamo, a mo’ di specimen, quanto accaduto nell’ambito delle arti plastiche e figurative, lasciandoci condurre per un po’ da quanto ebbe a dirne un eccentrico e geniale pittore surrealista, Salvador Dalì, in un aureo e sconcertante libello, apparso nel 1956 a Parigi, dal titolo provocatorio “Les 55 Cocus du vieil art moderne”, derivato da una conferenza tenuta dall’artista alla Sorbona (in traduzione italiana il libro apparirà nel 1991). Vi si denunciava la mistificatoria introduzione nell’arte moderna della « bruttezza » spacciata per « nuova bellezza non convenzionale » e avallata proditoriamente da quelli che l’autore chiamava « critici ditirambici » e senza mezzi termini « cornuti ». Prendeva di mira, il Dalì, in particolare, il conterraneo Picasso e la sua arte, con non peregrine argomentazioni e documentazioni tecniche. Affermava, tra l’altro: « Picasso, un giorno, mi ha confidato nell’intimità che a nessuno dei panegiristi del suo cubismo grigio era mai fregato di vedere che cosa i suoi quadri rappresentassero. Così da questi mostruosi accademismi sono nati tutti i neo-plasticismi e in particolare quell’esempio degradante di debolezza mentale che pomposamente si chiama “astrazione-creazione”». Togliendo la tara della polemica, il peso netto rimane rilevante. Fatto sta che dall’orinatoio di Duchamp si arriva per via diretta all’esibizione di qualsiasi oggetto considerato “artistico” perché estrapolato dal proprio contesto e collocato in ambito museale: si pensi alla “merda d’artista” di Manzoni fino alle molte spettacolarizzazioni. Comunque voglia girarsi la frittata, non basta dire “questo oggetto è un’opera d’arte” per renderla effettivamente tale, per mutare ipso facto in opera d’arte una ruota di bicicletta o un orinatoio, come provocatoriamente ha preteso di fare Duchamp, con tutti i meriti che gli sono dovuti. In ogni caso, l’oggetto – decontestualizzato e museificato – si pone solo convenzionalmente “come” prodotto artistico, vale a dire fino a quando stiamo al gioco, poiché in concreto sappiamo bene che esso, l’oggetto, è estraneo all’arte e qualora lo fosse, lo sarebbe in maniera occasionale, involontaria, etc. L’arte, oltre tutto, non può consistere solo nel suo enunciato (“questo oggetto è”) né l’oggetto può divenire quel che viene enunciato (appunto, “un’opera d’arte” o altro). Qualcosa di simile al “Fiat lux” (ma qui non è detto che la “lux” sia “facta” per davvero). Un oggetto, estrapolato da una sua strumentale fungibilità (bicicletta o pisciatoio) e conseguentemente collocato in una dimensione contemplativa (contempl-attiva), quale sostanzialmente è la dimensione estetica, resta quel che era in origine, poiché la nuova collocazione non lo fa smettere, sic et simpliciter, di essere quel che era e di rimanere quel che di fatto rimane e ciò ancorché non sia più usato secondo la destinazione originaria, mentre dalla nuova collocazione non deriva alcuna assorbenza di artisticità. Ѐ vero anche il contrario. Non basta dipingere una pipa per poterci fumare. In questo senso, resta esemplare la lezione di Magritte (“Ceci n’est pas une pipe”). La sola intenzionalità non fa opera d’arte, peraltro impossibile senza un autore che come tale la concepisca e la realizzi: un’opera d’arte è un prodotto assai composito e complesso perché nasca per caso o involontariamente. Per caso o involontariamente potrebbe essere nato l’universo, qualora non fosse oggetto di superna creazione, ma un’opera d’arte non può nascere a caso (diciamo provocatoriamente che dispone di una sua implicita spocchia genetica): non la Divina Commedia, non la Pietà di Michelangelo, non la Sesta di Beethoven. 56 A meno che non sia vero il contrario, ossia che tutto può essere ed è opera d’arte: un ferro da stiro, un tronco d’albero, un sasso, una conchiglia, un paio di calze e allora dove tutto è nero niente nero. E dove tutto fosse arte, non sarebbe proprio il caso di parlare di arte e di perdere sulla questione del tempo che altrimenti potrebbe essere prezioso. Per vie traverse si arriva, per fare un solo caso, alla morte di un incolpevole cane randagio che un artista, se tale è da considerare, il costaricano Guillermo Habacuc, mise in mostra nella sua città, San José, nel 2007, lasciando che morisse di fame e di sete, considerando tutto l’affaire “opera d’arte”, consistente, appunto, nel guardare l’agonia e sofferenza del povero animale. Habacuc intendeva accentrare l’attenzione sull’indifferenza umana nei confronti di altri esseri viventi e significare che nella sua città muoiono di fame e malattie migliaia di randagini senza indignazione di alcuno. Non si è saputo che fine avesse fatto il cane, a un certo punto scomparso (se fosse stato messo in galleria quando era prossimo alla fine e lì lasciato morire, se fosse stato nutrito di nascosto o se fosse fatto fuggire, ammesso che ne avesse avuto la forza, ma non pare che ne avesse). Il fatto è un altro. Si è tollerato per troppo tempo (come da qualche anno va denunciando il poeta toscano Marco Cipollini) che gesti clamorosi e massmediatici fossero contrabbandati per arte: dai rivestimenti di plastica dei monumenti all’esibizione di fantocci di bambini impiccati agli alberi di una via, alla colorazione in rosso dell’acqua di Fontana di Trevi e così via. Una somma di stranezze più o meno ammantate da seriose motivazioni estetiche e con variegato clamore di tube (la critica d’arte ha grosse responsabilità al riguardo). Non è certo difficile considerare che il cosiddetto “atto artistico”, presente in tanta parte dell’arte contemporanea, per quanto originale sia o pretenda di essere, resta solo un gesto, spesso provocatorio, il cui fine è quello di attirare l’attenzione: su un principio estetico da contrapporre a un altro e/o su un personaggio che ne sia l’attore. Può essere collocato tutt’al più nella sfera della divulgazione artistica, un fatto pubblicitario. E parimenti, la gestualità può tradursi in arte nel mimo, nella danza, nel teatro, non nelle arti plastiche e figurative, nell’ambito delle quali non genera che un conato di opera d’arte, se non una sua azione mistificatoria.Tutto resta inscrivibile nella sfera dell’intenzionalità. Come l’intenzione di uccidere non è reato, perché non si commette il delitto, come il proposito di essere caritatevoli non si risolve in carità, perché il beneficando resta privo di beneficio, così il gesto artistico non genera arte ma ne resta rigorosamente al di qua, come un Giulio Cesare che non valichi il Rubicone, pago solo di esservi giunto. Occorre liberarsi dalle grandi illusioni di un secolo, durante il quale non si è avuto il coraggio di dire che il re è circolato nudo. In letteratura, in particolare, occorre riscrivere il Novecento, concentrandosi sulle molte e grandi presenze autentiche e sulla vasta produzione sommersa di eccellenza. Uscire dal Novecento, un secolo grande e terribile, non per svalutarne gli innegabili meriti e le conquiste, bensì per non consistere nelle sue défaillances, per entrare a pieno titolo nel nuovo secolo: questo può essere, al momento attuale, il compito di una critica consapevole. Uscirne può essere faccenda assai meno sconvolgente di quanto si immagini, intanto 57 prendendone coscienza, quindi facendo leva sulla capacità, indispensabile ad ogni artista, di dire “cose” nuove o antiche in maniera nuova, ossia personale e inusuale. Il banale non la ‘naturalezza’ è il primo nemico dell’arte, la quale nasce da un enorme paradosso, consistente nell’aspirazione dell’uomo all’assoluto (dunque all’espressione dell’ineffabile), come ebbe modo di dire Borges. Per tentare di esprimere l’inesprimibile, non sempre può risultare utile o necessario sfasciare tutto o farsi scivolare addosso un sacco di polvere di carbone. Riferimenti bibliografici Alfonso Berardinelli, La poesia verso la prosa, Torino, Bollati Boringhieri, 1994. Luca Canali, La crisi della poesia, in “L’immaginazione”a. XXVII, n° 264, agostosettembre 2011. Domenico Cara, Letteratura e pubblico oggi in Italia, Palermo, Edizioni di Sintesi, 1979. Marco Cipollini, Trattatello rivoltoso de l’uomo di Fucecchio ossia Marco Cipollini poeta esule all’età sua, Fucecchio, Quaderni di Erba d’Arno, 2007. a Salvador Dalì, I cornuti della vecchia arte moderna, [1 ediz. Paris 1956], traduz. italiana di E.Bonfanti, Genova, Il Melangolo, 1991. Paolo Fabbri, Intervista con Tonino Bucci, in “Liberazione”, 9 ottobre 2008. Filippo La Porta, Meno letteratura, per favore!, Torino, Bollati Boringhieri 2010. Mario Lavagetto, Eutanasia della critica, Torino, Einaudi, 2005. Salvatore Lo Bue, Artifizio e poiesis, Palermo, Manfredi, 1979. Daniela Marcheschi, Il sogno della letteratura, Gaffi, Roma 2012. Emanuele Zinato, Le idee e le forme. La critica letteraria in Italia dal 1900 ai nostri giorni, Roma, Carocci, 2011. 58
Scarica