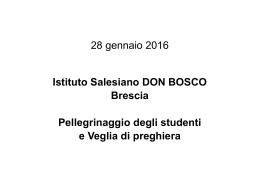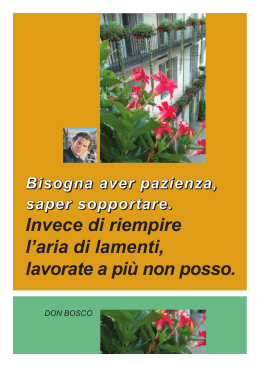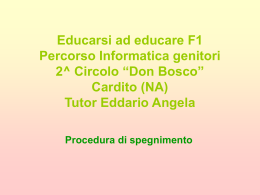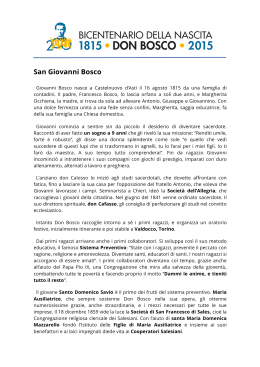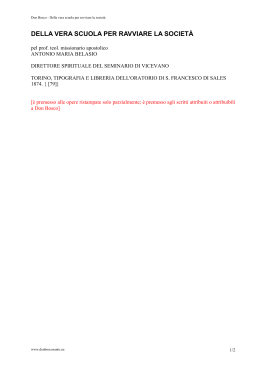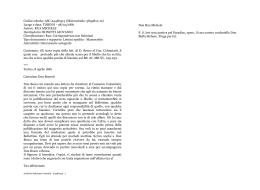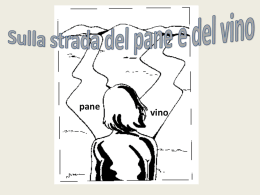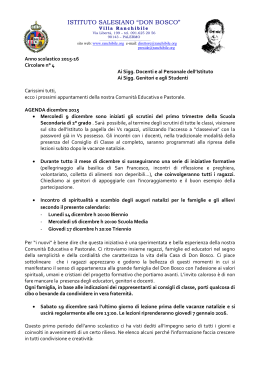N. 54
24 Ottobre 1930
Anno XI.
ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE
DELLA SOCIETÀ SALESIANA
SOMMARIO.
I. ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE
IL RETTO n MAGGIORE: Il Coadiutore Salesiano - Mons. Ignazio Canazei
- Strenne pel 1931
pago 877
IL DIRETTOHE SPIRITUALE: Catecbismo - Compagnie religiose e Azione
Cattolica
pag o 878
IL CONSIGLIERE SCOLASTICO: Mezzi a tener vivo e desto tra gli scolari
l' amoro allo ·studio
pag. 882
Il, CONSIGLIERE ' PROFEBSlONALE: Disposizioni del XIII Cap. Gen. per
i! biennio di perfezionamento
pag. 8~3
IL CONSIGLIERE DEI, CAP . ::lUP.: Oratorii festivi ed Ex-Allievi
II.
p"g. 885
COMUNICAZIONI E NOTE.
Il Coadiutore Salesiano secondo la mente del Beato D. Bosco
pago 888
NB. - I Direttori diano sempre lettura di questi Atti alla Comunità.
II.
OOMUNIOAZIONI E NOTE
IL COADIUTORE SALE SIANO
secondo la mente del Beato Don Bosco .
L a Divina, Provvidenz a ci h a conservato in un prezioso documento il
vivo ritratto del coadiutore salesiano, dipinto dallo stesso Beato Don Bos<Ìo:
le qUf1lit~ es teriori, le doti interiori, l'ttificio, lo sp'i1'ito del coadiutore vi
sono delineati con mano si~lU"a e con rilievi precisi, "Ciò fece il B eato Fondatore nella prima conferenza da lui tenuta ai suoi novizi coadiutori del
1883, nella casa di formazione di San B enigno Canavese, Ecco qui le sue
testuali parole, che io presenterò distinte in vari punti secondo la div ersiUl dei concetti,
N alite till1ere, pusilluq gl'ex, V 0'1: s1:ete il 1Jusillo gl'eX, m,a non vogUate
chè crescente,
Vi esporTò cltw 1J ens'ÌP1'i, Il 1J"rimo è l'es1JoTvi qual è la mia i dea' del coachuto1'e scf.lesiano, Non ebbi anco?'a, nwi .t empo e comodità d'i espO'l'la, bene.
f emere
J.
i"
I, '
l° Foi d,t mqtw siete ?'aclttltctti qui ad impct?,Q.'re l'aTte ed amlnaest?'anli nella
rc/.igione e 1Jietcl., Pe1'chè~ Pe?'chè io ho bisogno di aÌ1tfanl,i . Vi sono delle cose
che i 1J1-eii e,ì i chieTi ci non 1Jossono fet?'e e le faTete voi,
2° lo ho bisogno eli p?'endeTe qt.alcuno di voi e manda?'lo in tona ti1J09.~:g,fia
e di?'gl'i: - T?t p ensaci a fa?'la andan ava.nti bene, - 1l1ande.nw 1m altro in
tona librç1"ic. e di?'gli: - Tt. di?'igi che tutto ?'iesca bene, - .111andanLe tono in
tona casa e di?'gli: - Tt. c.V?'ai cu?'a che q1.el lab01'atO?"io o q1tei labomto?'i camminino con O1'cl'ine , non manchi nulla: 1),l'ovvecli quanto OCCO?'l'e, 1Je1'chè i lavo?'i
?'iescct.n o come devono ?'ù .scù'e, 3° lo ho bisogno cli ave?' q1wlc1tnO in ogn'i casa, a cui si possano affida?'e
le cose di maggio?' confidenza, an che il maneggi o eli dena?'o, ?:l contenzioso, che
?'appnsenti lct casa all'estento,
10 Ho bisogno che vadano bene le cose d'i cucina, cli portie?'ic., eli gua?'daroba, i nfenne?'ia, scwl'estin, ecc .. ,. nhe t'utto si llTocuri a tem1Jo, nient/l si spl'echi,
neSS1.no esce., ecc",
50 H o bisogno di lJorsone ben PTe2Ja?'ate o eli confì.denz(/, a. ct.i pote?' afTicllt?'e
qu~ste incombenze: voi dov/ltc essc?'e qt.est'i tal·?: .. ,
-
889-
60 In t~?W 2J[~? 'ol(t : voi non dovete esse're chi lavo 'l'n solo di?'ettam.ente o fatica, ma bensì quasi chi di?'ige, Voi dovete esse?'e cO?ne pad?'oni st~g li alt7'i
ope?'ai, non come se?'vi, l'utto lJe?'Ò con ?"egola e nei limiti n ecessa?'i.: ma t1.~tto
avete da fa?'e voi alla din zione, come pad?'oni voi stessi delle cose dei /.abo?'ato?'i,
7° Questa è l'idea d el coadiutore 8alesiano , lo ho tanto bisogno di a v er
molti che mi vengano a d aiutare in ques to modo, Sono pe?'ciò contento che
abbiate abiti adattati e puliti; che abbiate letti e celle convenienti, pe?'chè non
elovete esse?'e se?'vi ma pad7'oni, non sudditi sempZicemente ma supe?'io?'i,
II.
8° Om vi espmTò 'il secondo pensiem , Dovendo veni?'e così ,i n ait~to, i n
ope?'e gl'aneli e delicate, elovete 2J?'oct~?'a?'vi molte vi?'tù , e dovendo pnsiede?'e ad
alt?'i, dovete p?'i?l1C~ ' di tutto da?'e buon esemp'io,
go Bisogna che dove si t?'ova tmo di voi , si sic~ ce?'ti che 1J.1à vi sa.?'à l'm'cline ,
la mOTalità, il bene, ecc",
10° .Che, si sal infatuatus fuel'it, se i l sale che p?'ese?'va da,lla co?"ru2"io?te ,
,qi riducesse a I.al punto da 2Je?'Cle?'e la St~a vi?'tì~, nllo?'a s070 ?'esta che S'l:a calpestato, ecc, ..
Il ° Conchit~dia.?no d1mque come abbict?no 'incominciato: N olite timere,
pusillus gl'ex, N Olt vogliate teme?'e chè ,il nt~nle?'O c?'esce?'à, ma spec'ialmcntc
bisogna che si c?'esca in bontà ed enC?'gia., e allo?'Q. sante come leoni invincibili
e pot?'ete fa?'e molto del bene ,
12° E lJoi: complacui t dare vohis re.g nutn ; Begno e non sm'v itì~, e special .
me?tle av?'ete Regno ele?'?w!
.[
q uesto discorso d el nostro Beato P adr e e li'ondatore è come la . rivela zione di un'invenzione u scita dalla sua mente e dal suo cuore; è l' espressione
di un program ma e di uno spu'ito nuovo. in conformità coi tempi ch e cor rono e coll'apostolato che Don Bosco doveva compiere n el monclo ,
Conviene farvi sopra a,lcune riflessioni, P er questo divider e in dodici
p unt i le p arole del nostro Beato Padre: così sarà più facile capire questa
mu'abile specialità, tanto nella sua materia, come nella sua form a, ed ap parirà nello stesso t empo come il B eato Fondatore avesse idee molto chiare
e precise sulla grande opera e sulla sp eciale missione ricevuta dal Cielo
e d a lui confidata ai suoi figli ,
INTRODU7,l ONE,
Don Bosco incomincia con un preambolo, nel qua le cerca di far coraggio
a quel suo piccolo gruppo eli ascritti o novizi artigiani, che erano una ventina, Dice loro di non iscoraggiarsi per il piecolo numero e prof eticam ente
li assicura, tanto al principio come al fine d el suo discorso, ch e il numero
sarebbe aumentato presto, come difatti avvenne, In seguito propone il
tema della sua con.fer en~ a, ch e v uoI dividere in due pa.rti, corrispondenti
a questi due pensieri: 10) spiegare il concetto, il fine, l 'oggetto e il caratter e
speciale d el coadiutore salesiano; 2° ) esporne le condizioni o qualità mo rali, ossia le vu' I;Ì! speciali, p erch è corrisponda alla su a v ocazione e possa.
c onse~uir e il fine dell'Op era e dpll a Missione Salesiana,
v
$
-
890-
PAR'l'E 1.
1. -
I,
,I
,II:
!
Il
II
I,l.
I
I
Religione e pietà- - Arte e mestlerl.
- Fine della scuola.
11 primo punto spiega il perchè della casa di noviziato, che è la preparazione e la formazione spirituale e profeRsionale dei confratelli coadiutori
come futuri capi e maestri salesiani; ed anch e ci dà la ragione di questa
nuova Opera dei confratelli coadiuto:d . Ecco le parole di Don Bosco: « Voi
dunque siete radunati qui ad imparare l'arte ed ~Lmmaestrarvi ' nella religione e pietà IL L'istruzione religiosa e l'abito della solida pietà è la ragione tanto del noviziato quanto del biennio di perfezionamento che immediatamente lo segue: questa formazione religiosa poi va accompagnata
coll'esercizio dell'arte e del mestiere al quale ciascuno si è dedicato.
In questo doppio esercizio spirituale e materiale vediamo quasi rinnovato
il programma di quegli antichi r eligiosi benedettini, che circa mille anni
prima avevano abitato quella stessa casa, dove il Beato Don Bosco parlava ai suoi giovani fi3li e che fu fondata, dall'Abate S. Guglielmo di Volpiano. Quel programma era espresso nel motto Om et Labora, cioè abito
di orazione ed abito di lavoro; Don Bosco secondo lo spirito della Chiesa
lo adattava alle nuove esigenze dei tempi.
Il nostro Beato Padl'e aggiunge poi un secondo motivo, per il quale i
suoi ascritti sono riuniti in questa casa di formazione, per attendervi agli
esercizi della vita interiore e del lavoro . Egli si domanda: «Pp.rchè siete qui~ l)
E risponde: « Perchè io ho bisogno di aiutanti I). ' Dà poi la ragione di questo
bisogno d'aiutanti o coadiutori. « Vi sono delle cose che i preti ed i chierici
non possono fare e le farete voi l).
Per compiere dunque l'apostolato salesiano, ch", Don Bosco si era proposto tra la gioventù povera ed abbandonata, per togliere quei ragazzi
dall'oziosità e dalla strada, ispirar loro l'amore e l'abito del lavoro, non gli
bastavano i chierici ed i sacerdoti: egli aveva , bisogno di religiosi operai,
lavoratori, anzi veri maestri di laboratorio e di officina. Quello dunque
che non potevano fare i chierici ed i sacerdoti lo dovevano fare i coadiutori salesiani. Questo COlicetto fond amentale e caratteristico dell'Opera
Salesiana, Don Rosco lo viene svolgendo e spiegando nei sette punti ' della'
prima p arte con mirabile precisione e semplicità, proprio con quella parola paterna, facile e convineente che conquistava la volontà e l'affetto
eli tanta gioventù.
Ci pare quasi di sentil' ripetere quello che gli Apostoli dissero ai loro
primi discepoli che si erano assai moltiplicati (Atti A1JORt., VI, 2): « Non
è ben fatto che noi abbando.c.iamo la predicallionfl della parola di Dio
per servire alle mense l), cioè per praticare l a carità e 'distribuire le elemosine ai poverelli e dar loro da mangiare. Fra press'a poco la stessa ragione che obhligava il fondatore degli Oratori Festivi e degli Ospizi d'Arti
e, Mestieri a cercarsi altri aiutanti, oltre ai suoi sacerdoti e chierici ed affidar loro non solo la manutenzione e gli uffici della casa, ma specialmente
l'insegnamento delle arti e mestieri e dell'agricoltura. Anzi noi troviamo
nella stessa elezione dei sette primi Diaconi un'altra bella analogia dei coadiutori di Don Bosco, perchè quantunque quelli fo ssero destinati e prepo-
~
I
-
891-
sti specialmente àU'esercizio della c<uità e delle elemosine verso i poveri,
tuttavia aiutavano anche i sacerdoti nel sacro ministero' e nell'istruzione
dei neofiti.; e così pure Don Bosco voleva i suoi Coadiutori anche presso
l'altare ad ai utare il sacerdote e specialmente a d insegnare la Dottrina
cristiana.
2. -
Ho bisogno di molti capi e maestri.
_ Per ben quattro volte il Beato ripete con insistenza: (, lo ho bisogno l>.
E questo un grido di ansietà, di zelo, di apprensione del suo cuore di PadI'e,
al vedere tanta gioventù che si abbrutisce nell'oziosità, nell'abbandono,
nel vizio. (, lo ho bisogno di operai, eli capi o maestri eli arti e mestieri e
di agricoltura l). Volendo togliere dalla strada e dai pericoli tanta povera
gioventù, tan1;i orfanelli abbandonati, aveva, bisogno di aprire bboratori
ed officine e farne scuole cristiane di lavoro.
Fra tutte le arti, Don Bosco dava la preferenza alla tipografia ed alln,
librel'ia , perchè il su o apostolato salesiano .tra il popol o cominciò, non solo
col Catechismo insegn:1to ai .fanèitùli dei suoi oratori festivi, ID:1 anche
colla propaganda moralr e r eli giosa 0 sociale della buona stampa, mediante
le sue Let:ttl,1'e Gattol'/:che, stampate e divtùgate dai giovinetti delle sue tipografie e librerie, insieme agli altri libri ed opuscoli d estinati ad istruire
la gioventù ed il popolo, difendendoli dagli elTori moderni.
Erano passati già circa trentaeinque anni dacchè Don Bosco in Valdocco aveva cominciato il suo primo Ospizio eli artigiani (1847), raccogliendo
poveri orfani fanciulli ahbandonati, e prov:1ndo tutti i sistemi cIle l a sua
carità nelle sue povere condizioni gli consigli:1va e permetteva, per inse. gnare a quei derelitti un mestiere: mandarli a lavorare presso capi-bottega
per la città., ricoverandoli di notte nella ca,sa Pinardi (1847); tenerli nell 'Oratorio, insegnando a lavorare da sarti e calzolai coL. maestri esterni :1
pagamento (1854); lavorare per conto degli. stessi maestri mercenari (1860);
esercitare gli stessi mestieri sotto la direzione di maestri estrTni pagati,
ma per conto della casa. Quante difficoltà, prove, elisinganni avevano' fatto
ripetere a Don Bosco quell'angoscioso lamento: - lo ho bisogno di maestri
e di capi, che sieno della casa, ch e sieno figli miei, religiosi salesiani, col
nostro stesso spirito di pietà., di moralità., di ca,r ità, che lavorino per i l Signore e per le anime! Don Bosco dtmque fin (L1.g1'inizi del suo Oratorio e del suo Ospizio, mentre
ideava le Scuole Professionali ed Agricole, voleva ch e ogni laboratorio ed
ogni azienda, destinati a d albergare i figli del popolo, :1vesse capi e m:1estri
salesiani; che ogni arte e mesti.ere fosse una vera scuola, con teo ria e pratica impart,ite da salesiani; che offrisse agli alunni ogni mezzo per riuscire
operai abili, non solo :1 guadagnarsi il pane, ma anche a divenire padroni
di laboratorio, mantenendosi modelli di onestà e di vita cristifl.na tra la
c1asse operaia e nella civile società. E questo bel risultato oll! come l'ot ·
tenne il Beato Don Bof'co, in tante nazioni, per mezzo delle sue Scuole Professionali ed Agricole, per opera specialmente dei suoi buoni coadiutori,
capi e maestri di arti e mestieri!
Immaginiamoci ora di udire lo ' stesso Beato Don Bosco, che dopo tanti
studi e prove, dopo tanti sospiri e sa,crifizi, trovandosi in San Benigno circondato dai suoi giovani coadiutori artigiani, ripete loro con quell'accento
del suo ardente zelo : (, lo ho bisogno di poter prendere qualcuno di voi c .
iii;
-
892-
mandarlo in una tipografia e dirgli: - Tu pensaci a farla andar e avanti
bene. - .Mandarne un altro in una libl'eria e dirgli: - Tu dirigi, che tutto ·
riesca bene. - Mandanle un terzo in una casa e dirgli: - Tu avrai cura
che quel laboratorio o quei laboratori camminiuo con ordine, non manchi
nulla: provvedi quauto occorre perchè i lavori riescauo come devono riuscire ,). Come si sarauno sentiti animati quei giovani ascritti all'udire quell'invito di Don Bosco, bisognoso di operai, di capi e maestri per. dirigere quei
lah oratori ! Pare di vederli già tutti pronti rispondere generosamente: Padre, eccomi, mandi me dove vuole! È questa una scena che si ripete oggi in tutte le nostre case di aspirandato, di noviziato, di studentati e di perfezionamento magistrale: i Superiori, come Don Bosco, ripetono: - lo ho bisogno di poter prendere qualcuno di voi e mandarlo dove c'è estrema necessità per salvare dei giovanetti
specialmente arJ;igiani. - Si risponda dunque da tutti: - Presente! eccomi '
pronto ad accorrere dove la voce di Don Bosco ci chiama. -
3. -
«Ho bisogno di buoni coadiutori
per ogni casa o collegio~.
N el paragrafo precedente abhiamo visto il nostro Beato Don Bosco
intento a cercare e a distribuire il suo personale di coadiutori nelle sue
tipografie e librerie e negli altri l aboratori o scuol e professionali, incaricandoli di disporre ed ordinare tutto con comp etenza e proprietà. Per
tale ordinamento non bastano i Capi.
Ogni scuola professionale di Don Bosco ha i suoi quattro, sei, otto o
dieci l aboratori di distinte arti e mestieri, in ciascuno dei quali oltre il
maestro o capo, vi sono alcuni vice-capi p er i cinque corsi in cui è diviso
i l tirocinio: quindi uno o più vice-capi hanno l'incarico d'insegnare la teoria e la pratica nei rispettivi corsi. Di qui il gran bisogno di numerosi e valenti coadiutori in ogni l aboratorio.
•
Ma oltre a questi coadiutori, Don Bosco insiste dicendo che ha bisogno
in ogni casa di qualcuno a cui commpttere le cose di maggior confidenza,
anche il maneggio del denaro, il contenzioso, il rappresentare la casa all'esterno. Ecco quindi un altro aspetto delle case salesiane, che crea neces ·
sità di persouale specializzato: le relazioni coi fornitori del materiale p er
tutti i laboratori, utensili, macchine, ecc., il trattare coi clienti che ordinano i lavori; la sorveglianza degli operai esterni indispensabili nelle diverse officine; il dover riscuoter e f attur e, fare acquisti e tenere la contabilità di ogni officina, anzi la manutenzione di tutto lo stabilimento; tutto
questo costituisce un cumulo eli preoccupazioni, eli attenzioni, di lavoro,
da esigere un organismo amministrativo complicato e di enorm e responsabilità .
E Don Bosco, per bocca di tutti quelli che gli succedettero e lo rappre·
sentano in questi stabilimenti di lavoro e di carità, leva la sua voce supplicante, chiedendo aiuto ed invitando i giovani di buona volontà per poter
form are questi uomini della Divina Provvidenzà, questi coadiutori salesiani, che maneggino e dirigano religiosamente e con competenza la grande
impresa di trasformar e i birichini della strada in buoni ed abili operai.
',
-
893-
Così Don Bosco, coi suoi direttori srJesiani, ripete: (, lo ho bisogno di
aver qualcuno In ogni casa a cui si possano affidare le cose di maggior · COll fidenza, gli affari più delicati e di speciale importanza! ,).
N elle case, n egli ospizi, nelle scuole professionali ed agricole oh! come
risuona tuttocll questa parola supplicante cli Don Bosco: (, Ho bisogno di
. coadiutori salesiani! '). Questo bisogno urgente, questa necessità assillante
si fa sentire specialmente nelle Missioni, dove il confratello laico non solo
è il compagno di escursioni, il fedele aiutante del sacerdote, ma è il catechista,. il vero padrino dei neofiti, maestro. e guida, amico fedele, angelo
tutelare di tutti i novelli cristiani.
.Ammiriamo dunque un'opera provvidenziale nella forrùazione di que§lti coadiutori maestri o capi di laboratorio, creati dal Beato Don Bosco;
lodiamo e benediciamo la loro benefica azione in ogni casa e nelle missioni;
ma soprattutto, sentendo l'invito e l a preghiera del nostro B eato P adI' e .
che abbisogna di questi confratelli in gran numero, che abbiano il suo spirito e sieno sparsi per ogni casa, procuriamo di far conoscer e questa necessità dovunque vi so.n o buoni operai che seguono i suoi insegnamenti e paiono atti a secondare i suoi disegni.
4, -
(, Ho bisogno del coadiutore 'uomo di casa' 'l ,
Dna qualità ~peciale del coadiutore di Don Bosco è sempre stato l'affetto alla casa salesiana o alla (, casa di Don Bosco ,), c.o me se fosse la propria ca~a n:1tale; e così fu sempre tradizionale fra i nostri coadiutori l'interessarsi per tutto ciò che appartiene alla casa stessa, come un buon figlio
di famiglia h a cura di tutto ciò che appartiene alla casa del padre. non che
degrinteressi, degli stabili, e di quanto è della famiglia.
Questa caratteristica dei figli dell'Oratorio certament(~ ebbe origine da
quella prima casa di Don Bosco, dove egli stesso con Mamma Margherita,
tutto maneggiava e regolava per mezzo degli allievi antichi, come di figli
- proprii della caS:1, sicchè vi si formava quella cara vita di famiglia, cIle è
la comunicazione o comunità delle cose spirituali e temporali, condite e
maturate al calore dell'amor filiale e dell'affetto domestico.
Don Bosco dunque, mentre fom enta, specie fra gli artigiani, questo
amore alla casa e questo spirito di ~amiglj:1, ora invoca l 'aiuto e la cooperazione di tutti i suoi coadiutori o di quelli che vogliono essere tali, perché
s'incarichino degli uffici di casa o delle faccende domestiche, come plÙizia,
Ol'cline, manutenzione, ripartizioni, portieria, guardaroba, cucina, dispe!lsa,
, infermeria, massime poi la chiesa e la sacrestia,
Per tutte queste occupazioni od uffici di casa egli (' ha bisogno ,) di aiut,anti volonterosi, capaci e pratici, ma più ancora dotati di buon spirito , perchè questi lavori si debbono compiere con una diligpnza e CO!j un amore.
che risplenda agli occhi di tutti, onde si riconosca che questa è casa di Dio
e di religiosi e ilon di l:1voratori o impiegati mercenari o servi salariati.
Gli stessi allievi poi df\llf' case salesiane vedI'anno in questi buoni coadiutori tanti modelli in quel primo ufficio o dovere ch e è di tenere in buon
ordine di assetto, oltre alla propria persona, anche tutte le cose di casa,
delle camere, ecc ... come dei propri vestiti, calzatUl'e, letto, ecc, Questa fu
la prima scuola che sotto il dolce m agistei,o di Mamma Margherita, si aprì
in Valdocco: ella· fu ·la prima madre, la formatrice dei primi coadiutori di
-
894 -
Don Bosco n eilostabilire l a casa o l'ospizio salesiano con l6 spirito di famiglia, quasi f edele riproduzione della Casa di Nazareth.
.
Voglia Iddio che si moltiplichino a ttorno alle case di Don Bosco, come
dent ro di esse, questi mirabili collaboratori che ra,ppreseutano gli angeli
della Divina Provvidenza, dedicandosi alcuni a prC'vvedere e preparare
l'alimento, altri a prendersi cura affettuosa (li tutte le cose della, casa o
del collegio, dove t an ta gioventll t rova la sua salvezza ed i mezzi per la
vita dell'anima e del corpo!
Oh come torna dovunque alle labbra la stessa parola (li Don Bosco:
(' l o ho bisogno di un buon portinaio, di un buon cucinier e, poi del guarda robiere, dell'infermiere, dello spenditore O ' provveditore o commissioniere,
del sacrestano, ecc.! l) . Faccia il Signore che molti rispondano a quel premu"
l' OSO invito del Beato Don Bosco, poichè, aumentando le case e gli stabilimenti salesiani in tante n azioni ed in tante misf\ioni, il bisogno si fa sempre
più urgente e molteplice!
5. -
(' Ho bisogno di coadiutori ben preparati
e di confidenza l) .
Dopo aver enumerate tutte le distinte necessità di personale ch e h a la,
!ma opera sa,lva,trice dell::L gioventù, il Beato compenelia tanti bisogni in
uno che è il principale e della massima m genza e ch e più lo preoccupa:
(, lo ho bisogno di persone ben preparate e di confidenra, a cui po ter affidar e
queste ineombenze! l>.
Ecco la ragione di queste gra,ndi (:ase, di questi stabilim enti di formazione salesiana, aspil':1ndati, no viziati, istit11 t i di p erfezionamento professionale di arti e mestieri e di agricoltura. Don Bosco h a bisogno di person e ben preparate col p erfezionamento morale e r eligioso e cogli a,biti delle
virtù cristiane, con lo spirito salesiano; ed inoltre ben prep arate nell'arte
o mestiere ch e hanno da esercitar e ed insegnar e.
N è gli basta questa buona preparazione e capacità nei suoi coadiutori;
ma vuole ch e sieno persone « di confidenza l) , cio è ch e sieno di fiducia, di
morale sicmezza, di responsabilità. Oh come ripete poi questo concetto
nella seconda, parte con maggior !.nsistenza e più esplicitam ente! E perchè
diventino tali e dieno p rove di queste qualità, si f anno quei saggi, qu elle
belle prove nelle case di formazione.
Qui si noti bene la squisita delicatezza e prudenza del Fondatore, che
non vuole affidare quegli uffici e quelle mall sioni a estranei o impiegati,
più o meno conosciut i: egli vuole per ciascuno di quei posti di responsabilità, per quegli uffici delicati (, persone ben preparate e di confidenza l), cioè
uomini di fede e di vita religiosa, di zelo e di coscienza, di preparazione professionale e di buona volontà, ch e capiscano le sue idee, sieno imbev uti
del suo spirito ed abbiano abbracciata la sua misrione COme venuta dal
cielo e la compiano con spirito di carità; che sieno insomma veri figli di
Don Bosco .
Egli si dirige poi a quei giovani novizi di San Benigno e con affetto di
Padre e di Maestro amabilissimo dice loro ch e li ha scelti proprio p er esser e
i suoi uomini di fiducia, i suoi fidi coadiutori: (, voi elovete esser e questi
t ali l>' È come se dicesse: - Appena. voi avrete termiuato lodevolmente
il vostro noviziato o il vostro corso di m agistero o di pel'fezionamento, io
vel'I'ò a scegliere tra voi i m aestri, i capi e vice-capi di cui abbisogno,
-
895-
e vi incaricherò di questa o di quella tipografia, o libreria, di questo o
eli quel laboratorio o degli altri offici della casa: ma verrò a cercar e e preferirò i coadiutori b en preparati, i v eri confratelli di confidenza, p erch è
appunto di questi io abbisogno, e poi li distribuirò p er tutte le case e li
manderò ad aiutare n elle nostre Missioni. Preparatevi dunque con diligenza, con costanza e con entusiasmo: abbracciat e con amore il vostro mestiere e la vostra arte e f at e onore alla v ostra scuola ed al vostro l aboratorio p er poter compet ere cogli operai e m aestri secolari e p erfino sup er arli,
e così fare onore alla nostra santa r eligione ed all'op era di Don Bosco! -
6. -
« Dovete essere capi, maestri, dirigenti
nel vostro lavoro l) .
Il nostro B eato ora vuole chi arire m e,o:lio il caratt ere sp eciale dei sUOI
coadiutori, che prima h a chiamato uomini di l'esponsabilità, di fiducia e
b en prep arati n ell'arte o m estier e e n ell'officio loro; ed ecco ch e in quest o
punto conferisce loro, in certo qual modo, una specie (li autol'Ìtà dU'ettiva,
una t al quale p adronanza; quasi si direbb e ch e consegna loro la chiav e della
sua casa, dicendo: - Voi altri, miei fi gliuoli, non dovet e esser e semplici
Ìavoratori ed oper ai, m a veri maef'tri, capi e direttori del lavor o e d el la boratorio, non 8 010 in quanto ai r agazzi, vost ri discepoli, ma an ch e riguardo
agli im piegati o J amigli ch e stanno alla vostra dip endenza; n on do vet e es sere servi, ma p adroni e r appresentanti d ella direzione dell'istituto, riguardo
all a vostra m ansione o amministrazione. - Di qui Bi scorge la diff'er enza
che p assa t ra i fr at elli o fr ati laici degli ant ichi or dini monastici e m endicanti, ed anche delle ::tltre congr eg a7.ioni, ed i coa diutori salesiani di Don
Bosco. Questi n on b anno il loro còmpito limitato ai ser vigi dell::L casa r eligiosa e dei sacerdo i;i, n on sono semplici ausiliari della com unità; ma, mentre sono veri e p erfetti r eligiosi e n on ricu sano n eppure qualunque umile
ufficio nell a casa, sono poi anch e educatori e m aestri di un'imp ortante ripartizion e dell'istituto e costit uiscon o un fattore indisp ensabil e dell' Op era
Salesiana.
Si capisce f acilmente ch e l'av ere un s alesiano ca po alla direzione di
un'officina o laboratorio , di una scuola a rli un'azienda qualunqu e n ella
casa salesiana , oppure un salesiano incaricato della portineria, cucina,
guardaroba, infer meri a, ecc., e non una p ersona est erna, secolare, sala riata, è una garanzia sicm a della r egolarità, del m etodo , della m or ale, della
r eligiosità e del buon andament o generale, anzi dello spirit o dell'istitut o
e dell' esito f elice n ella formazione e p ersever anza degli ahUlni, com e pure
del prestigio dell' Opera stessa. Ecco p erchè il Beato sentiva la necessità
di accentuare quest a sp eciale distinzion e fr a il suo coa diutore ed il laico
delle altre congregazioni.
Dopo di av er tolto al nostro coa diutore salesiano la condizione o app arenza (li semplice la vora tore m anuale e di servo del tutto subordinato
agli altri, ed aver insistit o sul car attere di capo e m aestr o, di p a drone e
clirigente, o m eglio, di guida intelligente e huon p ap à di quelli ch e l avor ano insieme con lui ed alla sua dip endenza , Don Bosco riconosce la n ecessità di t emp er ar e l'idea di assoluta p a dron an za ch e qua lcuno potreb be
supporre in questi confrat elli salesia ni. Quindi aqgiunge: (' Tut to questo
s'intende detto in conformità colla R egola e n ei limiti necessari o con ve-
-
896 -
Dienti l), che sono quelli fissati dal Regolamento particolare dei mae!!tri e
capi di laboratorio e d all'ubbidienza ai superiori gerarchici, in santa unione
e carità fraterna.
Ma anch e dopo questo schiarimento, il Beato torna su quel criterio spe··
ciale d el maestro salesiano e ribadisce il chiodo, riguardo a quella specie
di libertà e responsabili1;à che egli concede ai suoi di disporre tutto riguardo
al loro laboratorio, eome padroni di bottega, cioè delle cos(\ a:ppartenenti
alln, casa, a differ enza di quello che ili farebbe o permetterebbe con maestri
e lavoranti esterni, ai quali non si potrebbe concedl-lre tanta libertà ed au';OI'ità sulle cose e persone della casa stessa.
Don Bosco dunqul? con~idera il suo buon coadiutore COllle un vero .figlio
suo, della Congregazione e della ca~a; e per questo gli dà, dopo la santa
Professione, tutte quelle fLttrib uzioni ch e competono ad un vero fil.Slio della
sua grande famiglia, come erede legittimo o partecipante d ei beni della
comunità, per i fini proprii di lei e per l 'uso r eligioso e discreto ch e tutti
i mmu bri della Pia Società se no propongono, per la gloria di Dio ed il bene
rlelle fLnime.
.
7. -
~ Questa è la mia idea del coadiutore,
ed io ho tanto bisogno di averne molti ».
È così convi.'1to il Beato Don Bosco di aver ci dato il concetto esatto
del suo coadiutore, che, terminando la sua esposizione d elle caratteristiche
speciali di questo' suo aiutante; di questo fattore indiflpellsabile della sua
opera, ripete la sua affermazione: « Questa è l 'idea del coadiutore salefliano ! l).
Mirabile creazion e della ment,e e del cuore di Don Bosco!
Ma egli non si contenta della nostra ammirazione. Dopo di averne fatta
una così bella e completa descrizione, esclama subito pieno di ardentissimo
zelo per la salvezza dei figli del popolo e della gioventù operaia: « lo ho
tanto biso~no di averne molti, ch e mi vengano ad aiutare iD questo modo! l).
N OD gli è bastato dirci e ripeter ci che' h a bisogno di aiutanti, ch e h a
bisogno di poter andare a sceglierfli aiutanti per questa o quella opera, che
ha bisogno anzi di aver qualcuno per ogni casa, ch e ha bisogno non solo di
qualcuno, ma di vari fLltri per la. cucina, portineria, guardaroba, infermeria,
sacrestia, ecc. ; ma che soprattutto ha bisogno « di persone ben preparate
e di confidenza l), ed ecco che ora con la maggior insistenza ripete: « lo ho
tanto bisogno di aver molti che mi vengano ad aiuta re in questo modo l),
cioè che vengano ad aiutarmi nelle Scuole di arti e mestieri, come capi e
vice-capi di laboratorio, nelle ' Scuole agricole, come capi di differenti
aziende, come catechisti ed assistenti negli Oratori Festivi, come incaricati
di tutti gli uffici e lavori delle case, e che tutti vengano a prepararsi per
lavorare poi in questo stcsso modo coi medesimi criteri già esposti.
Questo « grande bisogno» ehe ha Don Bosco di aiuto e che ci manifesta
con tanta ansietà ed insistenza è un Invito ed uno stimolo a cercare molte
vocazioni di coadiutori e di operai salesl.ani. Ci pare proprio di vedere in
Don Bosco, secondo 1:1 parabola del Vangelo, quel padre di famiglia che
va d'ora in ora a chiamare operai per la sua vigna. Sembra infatti che egli
non :1.bbia mai lavoratori a sufficienza per la sua opèra di salvare la gio ventìl abbandonata: esce sempre per mezzo dp,i suoi Ispettori e Direttori,
. per condurre nuavi operai, ai quali promette, anche lui gen erosa l'icompensa,
tanto a quelli della prima ora ch e a quelli d ell'undecima. Per tutti c'è posto
-
897-
per tutti c'è la"yoro nella casa e nell'oRpizio salesiàno: Don Roseo soleva
assicurare a tutti i suoi qu elle tre cose che sono restate ]1ruverbiali: Pa'le,
haVO?'o e PW'ad1:so!
Si osservi poi la carità veram ente p at erna di Don Bosco ehe v uoI tel':
minare questa prima v ar te della sua esposizione occup andosi con grande
delicatezza anche di cose est eriori e secondarie riguardo al veRtito, al ·letto
ed alla cella dei suoi cari coadiutori che tratta proprio non come servi, ma
come fi gli suoi, come p adroDi di casa. Ecco le sue paterne p arole: (, Sono
perciò contento che abbiate abiti a dattati e puliti: che abbiat e cell e e letti
~onvenienti, perchè non dovet e essere servi ma padroni, non sudditi sem plicemente, ma sup èriori. (, Ci sembra di sentÌl' ripetere l e p arole di Gesù
ai suoi calj discepoli dovo l'ultima cena: (, Non vi chiamerò già servi, per·
chè il servo non sa quel che si faccia il suo padrone:' ma vi ho chiamati
amici, perchè tutto queUo ch e intesi dal P adre mio, l'ho f atto sapere a voi >).
P ar e proprio che Don Bosco nell'istituire i suoi coadiutori si preoccupasse assai di togliere quel gran pregiudizio ch e poteva esservi in alcuni
eli crederli d 'una condizione i.pferiore nella stima" n ell'affetto, n ell a considerazione del Padre comune; e quindi insiste nel volerli assicmare che sarebbero proprio trattati non da servi, ma da veri figli e frat elli nella fa miglia salesian a ,
Egli dunque si occupa anch e di alcuni par ticola ri sul vestito; s,ùla cella
e sui letti, che vuole sieno decenti e adatti aUa condizione ed agli uffici '311e
i confratelli laici debbono disimpegn are in casa e fuori di c.asa, come maestri,
educatori, commissionieri, ecc. I n quest e espressioni si ammÌl'a il gran cuore
del Beato Don Bosco verso i suoi ospizi p er artigiani e verso i coadiutori,
che dovevano essere il principale fattore, l'anima e la vita di qu esta grande
opera r eligiosa e sociale, eomplem ento degli oratori f estivi.
Per a,ltro. deve notarsi qui che quando il Beato Fondatore si espr esse
in questi termini, dichiarando che egli elevava, in certo modo, i suoi confratelli C0adiutori quasi a'l un r ango sp eciale di padroni e superiori nella
sfera delle Scuole Professiona,li, cioè rig uardo al laboratorio e di fronte agli
altri opeI'ai ed agli allievi, qualcuno ebb e a meravigliarsi e perfino a scan cl a.]izzarsi, come se quei termini fossero di una padronanza e sup eriorità
assoluta e mondanamente intesa; m a devesi avvertire, come chiaramente
lo spiega il testo, che si tratta di una condizione r elativa di sup eriorità,
di padronanza e direzione sia al riguardo al concetto dei laici negli altri
Ordini e Congregazioni, sia rispetto agli impiegati, famigli e p erson e esterne
ed ai proprii allievi, ch e sono affidati allecm e e a,Ua dip enden za dei nostri
coadiutori, come a v eri m aestri e capi. non different,i dai ma.estri ,-"d a'5sist enti di tutti i nostri colleg.i .
•
Il concetto di Don Bosco riguardo al coadiutore salesiano è chiar o,
esatto, complet o ed opportunissimo, Risulta dunque dall'esposizione del
Beato Fondatore che il nostro coadiutore è un superiore riguardo a,i suoi
dip endenti, ÈI un maestro, un educatore, un professionista, un padrone di
. bottega, come si diee volgarmente.. che ha in m ano tutto CiÒ ch e è n eces ·
sario p er praticare e insegnare il suo mestiere, in r elazione coi suoi forni·
tori ; coi s uoi clienti, e soprattutto coi suoi apprendisti o discepoli; m a egli
è anche, e prima di tutto, cioè essenzialm ente, un vero r eligioso, ed un
buon salesiano eli Don Bosco, che, vivendo in comunit?t, sa compiere i suoi
doveri ed è fedele alla· sua· R egola ed· ai R egolam enti della casa e professa
fili ale obb ec1iem:a ai suoi superiori. Per qu esto il B eato Don Rosco volle
-
898 -
chiarire bene il senso delle sue p arole con quella clausola perentoria che
determina e spiega interamente il suo pensiero: (, Tutto però con regola
€' nei limiti necessari 'l. Dunque anche a quelle tali iIiterpretazioni si deve
applicare il detto dell'Apostolo: [,it-tem occidit, spiritus autem vivificato L'inj;erpretare solo letteralmente è cansa di morte, mentre l'intendere secondo
lo spirito ci dà la vita, cioè c'insegna a vivere da buoni salesiani.
Ed i nostri buoni confratelli coadiutori saDno capire e penetrare bene
nello spiritO.di Don Bosco, che ci dà il vero e sicuro concetto della vita e
della missione del salesiano, secondo i bisogni delle anime e della. gioventil
operaia nei nostri tempi: essi non vanno a cercare nella lettera ossia nella
parola mal interpretata, mezzi di esenzione, di libertà o cl 'indipendenza
mondana, perchè Ranno che con questo si mette in pericolo lu propria vor-azio! e e la sa.lvezza dell'anima.
Beati dunque coloro che ascoltano la parola del nostro Beato Padre
con semplicità. di cuore e con ispirito salesiano e la m ettono in pratica.
Ma veniamo alla seconda parte della Conferenza, che è pure assai bella,
opportuna e sommamente interessante.
PARTE If.
8. -
Il coadiutore salesiano specchio
di virtù e di buon esempio.
Se la prima p arte di questa Conferenza è piuttosto teorica perchè ci
dà il concetto del coadiutore, questa seconda parte, ch e ha solo cinque
punti, è sommamente pratica. Qui si spiega quale dev'essere il coadiutore
in se stesso e verso gli altri, quali garanzie deve dare nell'esercizio della
sua missione, quanto grave il pericolo di defezione, se egli mancasse ai doveri della sua vocazione, e finalml'nte Don Bosco termina, secondo il suo
stile, incoraggiando, anzi promettendo la vittoria ed il trionfo.
Il Beato Don Bosco comincia cosÌ la seconda parte del suo discorso:
(' Ora vi esporrò il secondo pensiero. Dovendo venire cosÌ in aiuto', in opere
grandi e delicate, dovete procmarvi molte virtù, e dovendo presiedere agli
altri, dovete prima di tutto darfl buon esempio >).
Il ragionamento non poteva filare più logico e concludente. Egli vuoI
dire: - Basterà ricordarvi che siete aiutanti, ausiliari, coadiutori di Don
Bosco, che siete continuatori della sua opera di r edenzione; che lavorate
con lui in uno stesso campo, cogli stessi mezzi, con ugual sistema e metodo
e con lo stesso fine, e quindi con lo stesso spirito, per convincervi della necessità di procmarvi moltE' virtù, anzi di avere con lui uno stesso modo
di pensare, di sentire, di amare, parlare ed operare, ciò r.he vuoI dire avere
il suo spirito. Di qui la necessità per i nostri coadiutori di studiar bene Don Bosco,
leggere con amore ed interesse specialmente la sua vita, immedesimarsi
nel suo spirito ed imparare da lui e ricopiare in se e praticare tutte le virtil ,
salesiane. Aiuta molto per questo il parlare tra loro dello stesso nostro Padre,
narrare ai giovani i begli esempi ed episodi della sua vita ed animarsi reciprocamente a pregarlO ed a imitarlo per acquistare questa o quella
virtù.
-
899-
Si noti poi che il Beato Don Bosco. chiama (, opere gr andi e delicate»
quelle che egli affida ai suoi coadiutori, p erchè gli. vengano in aiuto, e questo per correggere il pregiudizio di molti ch e sono usi a guardar e materialmente e mondanamente l'arte, il mestiere o l'ufficio dello st esso coadiutore,
messo nel suo laboratorio o nei lavori di casa, come un operaio qualunque
occupato in lavori b assi, in cose di poco conto. - N o, ripete Don Bosco,
le vost.re opere sono gr andi e delicate, p erch è voi avete in mano la gioventù
da educar e, da istruire, da assister e, da incamminar e non solo n el mestiere,
ma nella viJ:tù, nella vita cristiana: sono grandi queste oper e, p er ch è vanno
indirizzate al bene dell'anima, a r aggiungere il fine p er cui siamo IltaH creati
e redenti, la vita eterna. Egli ce l o ha dato come programma nello stemma della Pia Società:
(, D a mihi animas, caetera tolle»; e poi nelle Regole ci ha insegn ato a pratica,re
ogni op er a di carità corporal'3 e spirituale a pro della gioventll, specialmente
poi per istruirfl i nostri ricoverati n ella r eligion e ed insieme avviarli ad
un 'arte e mestiere o all'agricoltlua, p erch è p ossano guadagnarsi onoratam ente il pan e. Ecco dunque le opere 'gr andi alle qnali debbono cooperar e
i nostri coadiutori .
Ed aggilillge Don Bosco che sono anche operfl delicate. Qui pme egli v uole
togliere il pregiudizio che potrebbe sorgei'e anche tra noi, di credere molto
volgar e e p ersino grossolano l'ufficio del coadiutore p er l e opere materi ali
ch e com pie, in paragone .specialmente dello stud'3nte, del ch ierico ed a.IIche
del sacerdote. In quanto a edu catori salesiani, il nostro Beato Padre li h a
equiparati sapientemente ed abilmente agli a,l tri soci della Congr egazione,
facendoli tutti necessari f attori dell'educazione dei suoi artigiani. Anzi,
imitando il nostro Divin Redentore ch e diede la prefer enza agli umili, ai
poverelli, ai figli del popolo ed alla p ecorella smarrita, il nostro Fondatore
si dedicò speciahnente a queste anime n eglette, abbandonate e pericolanti.
E cco p erchè egli. insiste: (' Dovete procmarvi molte virtù l). L p. molte
vÌl'tù sono principalmente le virtù cristiane, teologali e cardina,li ch e c'in. segna il Catechismo; le virtù r eligi.ose, che abbiamo descritte n elle R egole
e n ei Regolamenti, e poi sp ecialmente quelle car atteristich e insegn ate, praticate e l'accom andate dallo stesso Beato Don Bosco n ella form azione pratica elei suoi salesiani . Queste si potrebb ero ridmre anch e a tre: una pietà
solida e fervorosa, un 'ardente ed attiva carità colle 'due quftlità speciali
della pmezza e della p a,zienza o m ansuetudine lI el trattar e con tutti, m assilue coi giovanetti , ed un grande spirito di lavoro e di saerificio p er la gloria di Dio e per il bene delle anim e a noi confidate.
Con queste vil'tù vuole Don Bosco che vada accompagnato il buon
esempio, che poi non è altro se non lo splendore e la fragranza che sp andono
intorno le stesse virtù praticate constantemente, m assime tra i compagni
e i dipendenti, con spontanea semplicità.
Questa è la preminenza e la superiorità che debbono ambi.re i coadiutori salesiani, di condurre a Dio molte a nime più coll'esempio che colla .
p arola . Il non aver abito r eligioso o monacale li m ette in condizione eli bI'
'v alere assai lUeglio, fra secolari ed in mezzo alla gioventll, i loro esempi eli
piet à e di modestia vincendo ogni risp etto umano ed incoraggiando gli
altri a pregar bene, accostarsi ai SS. Sacramenti, uc1iJ'e la parola eli Dio,
prender e p arte alle funzioni religiose, ecc.
N elle nostre Regole il B eato Fondatore, fino dagli inizi della Pia Societ à,
aveva messo come base o criterio fondamentale per forma,r e i suoi soci il
-
900 -
cO~'PirjaccTc et docc?'c del Divin R edentore, cioè l'insegnar e prima coi fatti
che colle parole ed aggiungeva: « A imitazione di N. S. Gesù Cristo, i confratelli, oltre ad esercita.rsi nelle virtù interne, proclU'eranno p erfezionarsi
nella pratica delle virtll esterne e nello studio e lavoro; dopo poi si consa- '
creI'anno COli ogni imp egno a d aiutare il prossimo l; .
Dunque non si parla solo eli virtù praticate in modo comune ' e 'ordinario;
w a si comanda ~i a~p ir are alla p erfezione delle virtù r eligiose, senza di che
no n si potrebbe dare l' aiuto l'ichiesto da opere tanto gr andi e così delicate
quali sono la rigenerazione spirituale e la cristiana educazione di t anta giovent ù abbandonata,
.
Appunto per promuovere l'esercizio esterior e di queste virtù fa una
salutevole impressione quel buon esempio ch e Don Bosco l'accomanda t anto
ai suoi coadiutori, come un gran dovere di ogni educator e, e come la più
efficace lezione. la miglior propaganda ed il più bello e santo apostolato ,
N ello stesso Regolamento dei suoi allievi Don Bosco insegnava il più
b~ll'atto di carità verso i compagni es~ere quello di dar loro buon esempio .
Questo poi insinu ava speci almente come fin e sp eci ale delle Compagnie di
S, Luigi, S, Giuseppe, SS, Sacram ento, ecc, e così pot.è riuscire a d avere tant i
piccoli aiutanti in tutti i soci delle st esse Compagnie per formar e nei suoi
ospizi e collegi un a.mbiente di pietà, di moralità e di tutte le virtù: era
questo uno dei segreti e delle fw'bc?'ic di Don :\3osco. E noi abbiamo sempre
ammirato gli effetti mirabili, e potremmo dire magici, prodotti datant i
cari coadiutori. nel loro abito secolar e, tra i· loro artigianelli e piccoli agl'i,
coltori , quando precedono o accompagnano i loro discepoli n elle pratich e
di pietà, o n el compimento dei d'o veri della vita di comunità e di collegio.
Allora si sente, si gode e si esalta quella bella vita di famiglia tra maestri
e scolari. che caratterizza l'opera ' salesian a,
Questo dunque è il punto essenziale del programma o l a condizione sine
IJtta non, imprescindibile che il B eato Don Bosco imp on e a t utti i suoi coadiutori: Virtù e buon esempio, Compiendo questa condizione morale, tutto
il resto, insegnamento professionale, assistenza. ecc. otterrà un esito feli -.
cissimo .
9. -
« Dove c'è il coadiutore, si deve essere sicuri
dell'ordine, della moralità, del belle! &.
Quando il coadiutore di Don Bosco h a acquistato e possiede le virtù
proprie del salesiano, e risplende in tutta la sua condotta la luce del buon
esempio, risulterà p er conseguenza ciò che dice la Sacra Scrittma dell'uomo
giusto: t utto quello ch e farà andrà p erfettamente e con completa prosp e'
rità: omnia qttaecMmqtW j acict, pTospc?'abuntu?'. Così si avrà la siclU'ezza e
la confidenza di tutti i s uperiori riguardo all'andamento .del la boratorio,
della scuola, dell'assistenza., o di altro ufficio che sia stato affid ato aUo st esso
coadiutore.
Sopra questo punto Don Bosco esige dai suoi coadiutori le maggiori
garanzie e così si esprime: « Bisogna che dove si trova uno di voi, si sia certi
che qui vi sarà l'ordine, la moralità, il bene, ecc, '), Quindi tutti i nostri coadiutori debbono rendersi responsabili a dare, in certo modo, garanzia di
poter ottenere queste tre condizioni o risultati, indispensabili alla buona
c cristiana. cduca7:ione. N<'I deve credersi che il ·nostro Beato Padre richieda
-
\:101 -
troppo ai suoi coadiutori capi o maestri; perchè egli ci ha lasciati i suoi
Regolamenti, tanto per i confratelli, come per gli allievi, e non contento
di regole generali, ci ha tracciato le norme speciali che d eve praticltre il
salesiano nell'educazione della gioventù, mediante il suo capolavoro « Il
Sistema Preventivo ,).
Il fine ed il carattere speciale della nostra Congregazione ù Pia Società,
che si propone d'indirizzare al lavoro ed alla virtù la gioventil abbandonata,
obbliga t utti i Salesiani ed in modo particolare i nostri capi o maestri coadiutori a studiare attentamente e poi praticare diligentemente le norme
che il Beato Don Bosco ci ha lasciato nel suo « Sistema Preventivo ,), illu strato poi copiosamente n ella « Vita,) del Fondatore d allo, storico Don L e moyne. È proprio questa una speciale missione dei nostri coadiutori, perchè
generalmente app unto fra gli artigiani si trovltno i caratteri difficili ed
anchE' p ericolosi (cioè i corrigendi) che la Divina Provvidenzlt manda alle
nostre case come all'arca di rifugio e di salvezza. Per questo sarà non solo
utile, ma necessario conoscere ciò ch e il Beato Don Bosco ci dice sul suo
Sistema che consiste nel prevenire le m anca nze degli allievi mediante una
continua ed amabile assistenza, per non doverle poi reprimere; e così mettere
i giovani stessi nella morale impossibilità di offendere Iddio . Perciò sono
di gran profitto le norme o regole per l'assistenza e correzione dei giovani
che il Beato ci dà nel Cap. V, Art. 102, fino ~,ll 'Art. 111, specialm ente i due
articoli 105 e 108, dove si vede tutto il tesoro di praticità che Don Bosco
aveva accumulato per assiCUl'are l 'esito d ella sua opera nel correggere la
gioventù e condurla soavemente e pazientemente al bene.
N on si contenta dunque Don Bosco che il suo coadiutore sia buono ed
abile nel suo mestiere, ma vuole che sia capa ce di dirigere moralmente i
.>uoi dipendenti e di guidarli con ordine nella moralità e nel bene, cioè nella.
virtù. Perciò dice che la comp.etenza in assistere e dirigere i suoi subalterni
dev'essere tale che ispiri confidenza e dia sicurezza ai Superiori che in quel
laboratorio, in quel dormitorio, in quella scuola dove c'è il confratello, r egni l'ordine, cioè la disciplina, dovere, moralità nelle parole, negli atti, llelle
relazioni tra gli alunui, ed il bene, che comprende ogni virtù, e tutto quello
che può desiderarsi in una cltsa di educazione, cioè recede a malo et fac bonum, al1çmtanamento di tutto ciò che è male e pratica del bene sotto ogni
forma, in tutti i modi.
Come sarebbe felice un superiore d 'istituto salesiano che si vedesse
circondato da questi buoni coadiutori, quali ce li descrisse Don Bosco, uomini di virtù e di buon esempio, abili e ben disposti per dirigere, insegnare
ed assistere i loro artigiani! Come riposerebbe sicUl'o e tranquillo ' sopra.
la responsabilità di questi cari Confratelli, che sanno conser vare l'ordine,
la moralità e tutto ciò che è bene in ogni tempo ed in tutte le ripartizioni
d ell'istituto (chiesa, scuola, laboratorio, cortile, refettorio, dormitorio,
passeggio)! Sarebbe questo il colmo della prosperità e la felicità della casa
dei Superiori e dell'intera comunità: gli allievi stessi ed i loro genitori benedirebbero in coro quest'istituto modello dove trovarono ogni. mezzo per
l'educazione cristiana e professionale, ch,e è un tesoro per le famiglie stesse.
Questo risultato così felice solo si ottenà con l'amore a Don Bosco, con la
fedeltà nel segui.re i suoi insegnamenti, e con la costanza nel praticare i
suoi Regolamenti insieme al suo Sistema Preventivo.
-
90210. -
Il
I
(' Guai, 'si sal infatuatus fuerit'!».
Ma Don Bosco vuole anche, sia pure per un momento, presentarci il
rovescio della medaglia. Dopo quel quadro così bello del coadiutore salesiano, con le qualità e virtù così attraflnti, coi frutti così copiosi, egli ci
lascia trapelare un gravissimo timore, una pena, un dubbio spaventoso,
ed è la possibile defezione di q ualcullo tra questi suoi figli coadiutori. E gli
esprime questa sua pena colle parole stesse del Divin Salvatore ai suoi ùiscepoli: - Si sal in!at~bat1bs ftberit, se questo sale della terra destina to a
preservare dalla corruzione la gioventù, perdesse la sua virtù di prevenire,
di correggere .. . - Don Bosco non vuoI terminare la frase, non h a il cora,ggio
di esporre interamente questo dubbio, fare quest a supposhione. Egli finisce
con un sospiro, con un ,<:~rido di attenti! all'erta !
P erò noi dobbiamo completare e studiare tutta intera quell a sentenza
evangeliea che Don Bosco vuole qui applicata ai suoi cari coadiutori, perchè sieno saldi e fedeli alla loro vocazione: " Voi siete il sale della terra; chè
se il sale diventa scipito, con che si salerM Egli non è pitl buono a nulla,
se non ad essere gAttMo via e calpestato dalla gente (S . MATT., Cap. V, 13) .
Si noti qui che S. Matteo, riportando nel suo Vangelo il divino sermone
del Monte fatto da Gesù ai suoi discepoli, dedica. tutto quel Capo V- a t rattare della p erfezione, in comincian ùo colle Beatitudini, seguendo poi sull 'osservanza della L egge di Dio, specialmente sulla Carità e sull' evitare
tutto ciò ch e PIlÒ essere di scandalo a noi ed agli altri (ibid ., V, 29 e 30). Poi
lo stesso E vangelista applica la m edesima dottrina e gli avvisi all'opera
di salvar e i fanciulli, ch e è l a missione nostra, e rip ete le min accie contro
ogni sorta di scandalo (Cap. XVIII, 5 e 6) .
S. Marco espone la stessa dottrina sul m erit.o che ha chi si occup a dei
f anciulli (Cap. IX, 86), ma fa le stesse minaccie contro chi li scandalizzasse
(ibid . 41), imponendo il sacrificio e la mortificazione dei sensi per n on lasciarsi vincere dalla tentazione (ibid. 42, 44, 46) e finalmente conchiude
colla similitudine del sale . « Buona p.osa è il sale, m a se il sale diventa scipito, con che lo pondirete voi~ Abhia t e in voi sa.l e di virtil e pace a,b biate
tra voi » (ib i d. 49).
San Luca poi riferisce questa stessa simiJitudiue del sale, applicandolo
come simbolo della, mortificazione che è necessaria a tutti quelli ch e vogliono seguire Gesù e rinuncia,r e an e tre passioni ch e trattennero gli invitati
dal p artecipare al gran banchetto della R edenzione e della Grazia; e, termina
colla stess'), sentenza: :' Chiunque eli voi non rinuncia a tutto quello che possiede . non può essere mio discep olo. Buona cosa è il sale, ma se il sale div ('-nta scipito COli ch e "i condirM Non è utile nè p er la terra n è per il letamaio: m a sarà gettato via. Chi h a orecchie da intendere, in~ enda (S. LUCA,
XIV, 33, 34, 35).
L a reticenza dunque t anto significativa del nostro Beato Padre riguardo
alle conseguenze disastrose eel alla fin e disgraziata e fat ale di quegli infelici
che mancassero di fedeltà alla loro santa vocazione e professione, dovrebbe
destare in tutti i liostri coadiutori un salutare timore ed eccitarli a unir~i
in un p atto sacro di solidarietà e formar e tra loro, fino dal Noviziato e più
ancora nel biennio di perfezionamento e preparazione al Magistero, una
lega di osservanza p er la pietà e la modestia, di fed eltà alla Regola ed ai
Regola menti, di unione intima coi loro superiori p er allontanare dalle DO·
"tr e case qUfl.lunque pericolo di defezione o di sc~ndalo. Que~to comune
-
903-
proposito che si suoI f are specialmente nell'atto della professione oh come
consolerà sempre il cuore paterno del nostro Beato Don Bosco e del suo
Successore e come rallegrerà tutti i s uperiori, con gra,ndf\ edificazione di
tutta la Congregazione!
Lo stes~o Beato Fondatore ile! formare la Rua Pia Società praticò non
solo verso i suoi allievi, ma anche con i suoi soci, il Sis1-ema Preventivo che
e~li diceva consistere nel mettere gli educandi n ell'impossibilità di commettere mancalll':e gravi, ed ototenersi quest'effetto coll'assistenzl1 f\ col
promuovere l'amorf' alla Regola,
Applichiamo fra noi questi 8tessi me7.zi che usiamo coi nostri ed ucandi,
paternamente, fraternamente, perchè neSSUDO perda la virtù nè dimentichi
il buon esempio: cosÌ si evÌt:erà il pericolo dello scandalo e delle defezioni,
cioè della corruzione del sale, con quelle tristissime conseguenze che il no-stro Beato Pa,dre uon ebbe iJ coraggio di scoprirci o enumerarci, solo contentandosi di ricord arci le parole di Ge<;ù nel Santo Vangelo, perchè le merlitassimo,
Studiamo dunque e pratichiamo quei preser vativi che il Divin Maestro
con tanta insistenza insegnò ai suoi Apostoli e Discepoli. Sono poi gli stessi,
come si è detto, che la nostra Regola ci suggerisce nei capitoli della Pietà
e dei tre Voti, con le rispettive spiegazioni ch e il Beato Fondatore aggiunse
nella sua bella e pratica Iptroduzione aùe Costituzioni stesse, ampliate nei
Regolamenti e nelle Circolari dei Superiori. Così avremo promosso ed as sicurato la felicità e prosperità nostra ~ dell'Istituto.
11. -
«Si cresca in numero, ma più ancoru
in bontà ed energia ».
Dopo avere il BeMo Don Bosco a ccennato a quei pericoli di defezione,
subito ritorna al suo solito stile d'incoraggiamento e di allegria, dicendo:
N olite time1'e , p1~8ill1~8 g1'ex; allontanate ogni timore, mio piccolo gregge!
Come se dicesse: - lo non ho timore, non sconfido della vostra fedeltù"
della vostra per~everanza; solo vi ho voluto prevenire, mettendovi in guardia contro quei pericoli. Abbiate dunque fiducia, fatevi animo che vincerete e, conservando lo spirito religioso, aumenterete anche di numero.
Indi ripete ai suoi cari coadiutori il primo concetto, assicurandoli anche
dell'aumf\nto (li numero.. cioè del compimento dei suoi desideri di avere
molti coadiutori.. che gli vengano in aiuto per le sue opere: .;( Non vogliate
temere, chè il numero crescerà; ma specialmente bisogna ch e si cresca in
bontà ed energia; e allora sarete come leoni invincibili e potrete fare molto
del bp·ne l). Quanti motivi di allegrezza, di consolazione e di coraggio spiritualt> offrono queste parole ai nostri cari coadiutori!
Don Bosco incomincia e termina la sua bella Conferenza con le parole
che i mesRaggeri celesti, gli Angeli e gli Arcangeli, usavano quando veni
vano ad annunciarp i grandi misteri della nostra religione. Lo troviamo
quest'augurio di pace e di felicità rip etuto nelle Sacre Scritture dell'Antico
e del Nuovo Testamento: Nolite t.irne?·e! Non temete, non dubitate, fuori
ogni tristezza, ogni incertezza o pusillanimità! non inquietatevi per i pericoli, i mali, le contral'i'3tà, le persecuzioni, gli scandali di questo mondo!
Gesù stesso, specialmente dopo la sua risurrezione, comparendo agli Apostoli e Discepoli, che er ano così costernati ed avviliti, li incoraggiava
con queste parole: N olite tirne?'e! l poverini, dopo il tradimento di uno dei
-
904-
loro compagni, dopo le loro debolezze e cadute, avevano proprio vergogna.
e paura di se stessi e si trovavano in una tale prostrazione d'animo da bisognarvi tutta la virtù di Gesù, perchè ris'u scitassero ancor essi con la mente
e col cnore, facendo un vivo atto di f ede, ed un generoso atto di carità,
Si è lamentato tante volte anche fra di noi salesi ani che i nostri coadiutori sono pochi per t ante scuole di arti e mestieri e di agricoltura, per
tanti uffici che richiedono in 0:4ni casa l'opera loro, Si è deplor?to che la
guerra ultima ne abbia sacrificati molti, m entre si richiedeva dall e crescenti
Missioni un maggior numero eli maestri, di catechisti, _Si sono studiati i
mezzi per aumentare il numero delle vocazioni di artigiani; si stanno ' iniziando in ogni Nazione, anche in mezzo a mille difficoltà, le case di forma zione per aspiranti artigiani insieme con le case per il biennio di perfezionamento o di magistero professionale, Don Bosco soleva animare tutti
i suoi allievi colla narrazione di sogni o di visioni, che pronosticavano un
grande aumento. un'espansione immenRa della Congregazione: vedeva. in
mezzo a quelle turbe di giovani tanti suoi coadiutori. Forse a nche allora
la sua promessa alludeva a quei sogni; ma ora una parola di animazione,
di conforto, di augllrio o di prom essa ci viene dal Cielo, dopo l a. beatificazione del nostro Padre. Egli ci ripete: N ohte timel'e, p1tsiUus gTex! È proprio
suonata l'ora della Divina Provvidenza! Si sta per compiere la promessa
del nostro gran Padre. Il numero dei coadiutori di Don Bosco crescerà in
tutto il mondo!
Ma la. promessa di Don Bosco, nella sua Conferenza del 1883 a San Benigno era in certo modo condizionata: Egli non si contentava che ' aumentasse il numero, nè voleva, secondo le parole di Isaia (IX - 3): quel l1Mtltiplicasti gentem et non magnificasti laetitiam; ma raccomandava che col
crescere e moltiplicarsi dei coadiutori si accrescesse· l'111'e la consolazione
della virtù, della bontà, dell'energia spirituale! Ed a questo fin e domandava
la corrispondenza e la cooperazione di tutti i snoi figli .
Egli ripetè: « N oD. vogliate temere, chè il numero crescerà; ma specialmente bisogna che si cresca in bontà ed energia l) . Bisogna dunque convincersi che l'aumentare del numero, il moltiplicarsi della gente nelle case di
Don Bosco non è il miglior benefizio, nè l a magg;or fortuna, ma che la vel;a
prosperità dell'Istituto è specialmente il crescere in bontà ed energia, nel
compimento d el proprio dovere, nel darsi alla virtù , Questo bisogna che
sia lo sforzo e l 'aspirazione massima, di tutti i confratelli. Ed ecco ripetuto
il primo concetto già , esposto in questa seconda parte della sua Confe-.
r enza (80 punto): «Dovete procurarvi molte virtù , dovete prima di tutto
dare bnon esempio! l) . Aggiunse solamente una qualità speciale in cui si doveva crescere e questa era l'energia della volontà, cioè lo sforzo generoso
p er fare il bene, per compiere i proprii doveri religiosi. Bisogna non lasciarsi
vincere dalla prigl'izia spirituale, dalla incostanza, dalla tip.pidezza nel servizio 'di Dio, Per que~to Don Bosco ha raccomandato tanto la fedeltà nelle
pratiche di pietà (meditazione e lettm-a, Santa Messa quotidiana coi Santi
Sacramenti, Esercizio della Buona Morte, Esame e Rendiconto, ecc). L'energia spirituale dunque vuole il nostro Beato Padre che cresca e si applichi
specialmente a questi santi esercizi di pietà, per acquis1iare ed aumentare
la forza di perseverare e fare molto bene!_
Posta questa condizione, il nostro Beato Padre fa una nuova promessa:
« Allora Val sarete come leoni invincibili e potrete fare molto del bene »,
Il leone è l' emblema della forz a e dell'energia e Don Bosco vuole che questo
-
905-
rappresenti una bella caratteristica dei suoi coadiutori che hanno da tro varsi spesso In mezzo al mondo, di fronte a molti pericoli di vanità., d'immoralità, fors e d'irreligione e di allettamento alla vita secolaresca, Ecco
i nemici da combattere e da vincere con l' energia del leone, con la prudenza
del serpente e la semplicità della colomba, come insegna il Vangelo (MATTEO, X ,O 16); ma i salesiani di Don Bosco sono sotto la protezione della
sua Ausiliatrice e, tali p?'aesid'io mtmiti ce?'tantes in vùa, sanno combattere
con l'enerl;'ia e col val ore che l'osserva,nza della Regola e la vita di. comunità loro infondono,
(, Potrete fare molto del bene l), aggiun ge Don Bosco, ricordandoci quanto
ha esposto nella prima p arte della sua Confel'enza ed accennando al fine
della Congregazione che è acquistal'e la perfezione cristiana e compiere
ogni opera, di carità spirituale e corporale verso i giovani, specialmente i
più poveri, È dunque l'opera della rigenerazione o della l'edenzione quella
a cui siamo chiamat.i per cooperare insieme con lo ~tesso Beato Don Bosco ,
12, -
(, Il Padre Celeste vi ammise nel suo Regno
e vi darà il Regno eterno '),
Don Bosco pone termine alla sua Conferenza completando quel testo
evangelico con cui ha incominciato: N olite timm'c, lntsilltts g?'ex, qttia co?nplacttit Pat?'i vest?'o da?'e vobis ?'egntt?n (S, LU CA, XII, 32): nOll vogliate temere, voi, piccolo gregge, perchè il vostro Padre si è compiaciuto di darvi
il suo regno. Ed aggiunge: (, Regno e non servitù, e speci almente avrete
i l Regno ei{el'llo l),
Egli non si contenta di toglim'e ai suoi coadiutori ogni timore, ogni ansietà., nè gli basta promettere aumento di numero e di virtù, coi felici risultati e colle grandi vittori(' nel compimento della l oro missior:e: ma adesso,
colle parole stesse di GeSti, annunzia loro ch e il Padre Celeste si è compiaciuto in dare loro il Regno,
Ecco la ragione per eui Don Bosco esalta il suo vero coadiutore e vuoI
togliere da lui ogni timore di abiezi one e di servitù spiritu ale o temporale:
egli lo dichiara servo di Dio e, come se?'vÌ?'e Deo ?'egna'l'e est, così l'assicura
che avrà una missione grande e sommamente bella e gloriosa e gli ripete
le grandi promesse f atto da Gesù non solo agli Apostoli, ma anch e ai semplici Discepoli ed a t utti i religiosi: (, In verit·à vi dico: che non vi h a alcuno
il qua.1e abbia abbandonato la casa, o i fratelli , o le sorelle, o il padre, o la
madre, o i figliuoli e le possessioni pel' me e pel' il Vangelo , che non l'iceva
il centuplo, adesso in questo t empo, in case (' fr a telli e sorelle e madri e
figliuoli e poss es~ioni in mezzo alle persecuzioni, e nel secolo a,vvenire la
vita eterna '),
Questo stesso ripete S. Luca (XVIII, 29 e 30), Identica promessa poi
si legge più ampiamente e solennemente pl'oclamata da Gesù in S, Matteo
(XIX, 28, 29, 30), quando S, Pietro, parlando a nome di tutti gli Apostoli,
si arrischiò a fare quella domanda al Divin Maestro: (, Ecco che noi abbiamo
abbandonate tutte le cose e ti abbiamo seglùto: che sa.rà dunque di noi ~ ').
E Gesù disse loro: (, In verità vi dico che voi che mi avete seguito, nella l'Ìgenerazione, allor chè il Figliuol dell'Uomo sederà sul trono della sua maestà, sederete anchl' voi sopl'a dodici troni e giudicherete l e dodici tl'ibù
d'Israele, E chiunque avrà abbandonato la casa, o i fratelli, o le sorell e,
o il padre, o .l a ma<lre, o i poderi per amore del mio nome, riceverà il cen-
-
906-
t uplo e la vita eterna: f\ molti primi saranno ultimi e molti lùtimi saranno
i primi».
Dunque il nostro Beato Don Bosco rinnova ai suoi coadiutori buoni e
fedeli quelle medesime 1\oleuni promesse fatte da Gesll ai suoi di scepoli e
specialmente a tutti i religiosi, che fanno le stesse rinunzie per amor di
Dio e delle anime. Il compim en~ o eli queste promesse, cioè il Regno, si ottiene, come ripete Don Bosco, con la gen erosità in lasciar tutto 1JToptej' ?ne,
per N. S. Gesù Cristo; con la fedelt:ì al seguirlo n ell'apostolato, anche secolar e, PP,J" le anime e nel sacrificio per la gloria di Dio.
Di qui quel bell'articolo l fl8 delle nostre Costituzioni, dove lo stesso
dice: {, Ciascuno sia pronto a sopportare, quando occorra, il caldo, il fr eddo,
la sete, la fame, le fatich e ed il disprezzo, ogni qualvolta queste cose servano
alla maggior glori a eli Dio, allo spirituale profitto del prossimo ed all a salvezza dell'anima propria. l).
Questo è il modo eon cui si guadagna il Regno che Gesù h a promesso
e ch e Don Bosco assicura ai suoi coadiutori f edeli .
Don Bosco rip ete di nuovo questa promessa del regno colle parole stesse
di Gesù, complacwit Pa·M·i daTe vobis Regnml1, perchè ha associato inter a mente tutti i suoi coadiutori all'apostolato salesiano, dando loro p arte
importantissima nelle su e opere
P er questo Don Bosco ripete insistent emente: {, Regno e non servitù l),
perchè riC'on08ce come fattore neces~ario il coadiutore salesiano, alla m aniera e nelle proporzion i di quei Di aconi della Chiesa che dicevano non solo
ai Sacerdoti, ma ai Pontefici, come San T.Jorenzo a San Sisto I: {, Oh! Padre,
dove vai senza il tuo figli0 1 l) . l\j" oi dobbiamo stare insieme, siamo inseparabili
così presso l' altare, come nel lavoro e n el sacrificio . I coadiutori di Don
Bosco b anno in l oro mano il ministero quotidiano delle mense e provvedono
in gran parte i.l paLe quotidiano per i nostri poveri giovanetti. Onde il Beato
Don Bosco mostrava per i s\1oi coadiutori uno speciale affetto, ch e soleva
manifestare in mille maniere ed assai graziosamente. Secondo narra Don
Lemoyne, egli soleva dare ai più antichi, che lo aCl"'ompagn:wano I!ei viaggi,
speciali titoli di nobiltà, come di barone, conte o marchese di certe piccole
fr azioni di campo presso i Becchi o l\iondonio, dove egli aveva passata
la sua f anciullezza, e così scherzando, con paterna amabilità e ridendo,
sap eva ricordar e ai suoi figli la vera nobiltà spirituale di servire Iddio, Se?'VÌ1'C Dco j'egnaTe est, e quella sua promessa di r egno e non di servitù.
Ed ecco l'ultima parola ai suoi figli, l a solenne C'onclusione della sua
magistrale Conferenza: {, Speci almente avrete Regno eterno l) . Sopra t utti
i beni che ci h a promesso e proprio come una specialità c'è il Regno eterno,
quel paradiso che er a la promessa ca.ratteristica di Don Bosco: P ane, lavoro e Paradiso! l). Questa assieurazione che f a il Beato a tutti i suoi coadiutori deve infondere nei loro cuori una grande allegria, una viva confiden za di ottenere questo gran premio, ch e è supremo fine dell'uomo, questa
f elicità eterna.
Così r esta definito il coadiutore di Don Bosco dal suo stesso Fondatore
e P adre; e questo cenno che egli ce ne dà deve svegliare in tutti, specialm ente nei giovani artigiani, una grande stima ed ammirazione, sia per il
carattere e la missione affidatagli, sia p er il programma di carità, di lavoro,
di sacrificio che questi salesiani s'impongono p er condurre molte anime a
Dio ed alla e terna felicità . Sieno molti quei generosi ch e vengano a schierarsi flotto la bandiera. di Don Rosco.
-
907-
CONCLUSIONE E PRONOSTH::l.
Passarono già quasi cinquant'anni dacchè Don Bosco dirigeva al piccolo
gruppo dei suoi giovani coadiutori qùelle parole scritturali: (, N alite ti?nc?·e.
pusillus gTex; non vogliate temere, picrolo gregge, perchò voi crescerete )l,
ispixando in loro fiducia, conforto e coraggio. Spesso le parole dell'Apostolo
della gioventl.'i si prendevano, non solo come pronostici, ma come infallibili
profezie. Non sappi::tmo se i presenti desserQ a quelle frasi tutta l 'impor
.t anha ch e avevano, ma certamente quelli erano anni di prodigiosa espansione dell'Opera Salesiana, che già aveva attraversato l'OceallO ed a veva
impiantato anche le sue Missioni nella lontana America, nella P atagonia.
Sei appena erano in quell'anno le Scuole di Arti e Mestieri fondate da.
Don Bosco: l'Or atorio di Valdocco, Sampierdaren a, Nizza Mare, e San Benigno, poi Buenos Aires e P atagones. Ma il Padre della gi oventù guardava
a tutto il mondo e ripeteva ai suoi giovani coadiutori: (, lo ho bisogno di
a.i utanti ... lo bo bisogno eli poter prendere qualcuno di voi e mandarlo lont ano ... Ho bisogno di qualcuno ili voi in ogni casa.. l o ho tanto bisogno di
aver molti che mi vengano ad aiuta,re in questo modo (come coadiutori) ).
Questa voce supplichevo le di Don Bosco, qu esta ansietà e preghiera
dell'uomo eli Dio salì al Cielo, Ralì al trono di Dio e di Maria Aiuto d ei Cristiani e trovò eco anche nei cuori di t anti giovani da lui ricoverati Il ei Buoi
ospizi e molti si ascrissero alla, Pia Società Sa.Jesiana. Nel corso di dieci
lustri le Scuole di Arti e Mestieri e di Agricoltura si moltiplicarono in tutto
il mondo, in quasi tutte le N azioni e nelle varie Missioni estere fino al numero attuale di cento M'onta cinque, che rappresentano 675 laboratori od
officine professiona.Ji, n elle quali si educano cristianamente ed imparano
il loro m estiere, come piccoli operai, circa 10.000 gi'lvani dai 12 ai ] 8 anni.
Questi ogni anno a um entano e si vanno sostituendo dopo un periodo di
5 anni di tirocinio, e così. Don Bosco regala alla società civile ogni anno
alcune migliaia di buoni e valenti operai cristiani.
I maestri, i capi e vice-capi di questi 675 labora,tori e scuole si formarono nell'Oratorio di Valdocco o nella prima scuola di form azione profes ·
sionale di San BEllligno o in altri Istituti Salesiani, che da quelli ebbero i
primi maestri, e se non fu possibile aV81e coadiutori salesiani per tutte
quelle Scuole Professionali, fmono, in generale, gli Antichi Allievj di Don
Bosco che supplirono e tuttora nompletano il numero gi à crescente dei capi
e vice-ca pi salesiani.
Don Bosco dunque vede compiuto il suo pronostico , vede soddisfatta.
pienamente la sua prima promessa: (' N alite ti?nC1'e! Non vogliate temere,
chè crescerete )l. Ma egli ripete ancora: (, lo ho tanto bisogno di aver molti.
coadiutori che mi vengano ad aiutare».
* * *
La Beatificazione di Don Bosco ha prodotto un grande risveglio ed uno
speciale interessamento fra gli amici e Cooperatori dell'Opera Salesiana
ed in particolare verflO le Scuole Professionali ed Agricole, perchè l'ameola.
piil .qplendflnte del nuovo Bllato è. appunto la · ~ua carità· e beneficenza, che
-
908 -
praticò ed ispirò agli stessi Cooperatori suoi per procurare asilo, educazione
cristiana ed un mestiere a tanta povera gioventù orfana e derelitta. Per
questo la Chiesa, nella sua Hturgia, chiama Don Bosco Pad?'e e JJlaest?·o
della gioventù, come sua speciale caratteristica, ed il popolo cristiano di
tutto il mondo h a festeggiato con giubilo immenso la sua elevazione all'onore degli a ltari. Ora si ascolta da tutti con più devota attenzione e con
affettuosa venerazione· la parola di Don Bosco, che dal Cielo ancora va ripetendo: « lo ho tanto bisogno di avere molti che mi vengano ad aiutare
in questo modo (come coadiutori salesiani) ,). Ed il nuovo Beato elargisce
pure dal Cielo le sue benedizioni ed ottiene le più segnalate grazie a quelli
che l' aiutano nell a sua Opera di redenzione.
Frutti quindi speciali d ell a Beatificazione di questo Apostolo della gioventù furono tre nuovi grandi I stituti Professionali per artigiani ed agricoltori, di cui due per Missionari e per il Magistero Professionale. In questi
tre Istituti noi vediamo avverato nuovamente ed in grandi proporzioni
il pronostico, anzi il ripetuto vaticinio di Don Bosco ai suoi primi e pochi
coadiutori- maestri di San Benigno: « Non temete, cIlè voi crescerete').
Ecco dunque che per far creSC!lre il numero dei suoi coadiutori il B. Don
Bosco fa nascere due Istituti per a.spiranti missionari artigiani ed agricoltori
di tutta Italia. Si riunivano questi artigiani fino ad 80 e 90 nell'antica casa
di Foglizzo, ma destinati a trasferirsi in nuova sede più opportuna. Contemporaneamente è sorta la Scuola Agricola Salesia.na di Cumiana per
aspiranti missionari agricoltori ed anche questa ben presto ha raccolto un
80 giovani di buona volontà, che stanno compiendo il loro tirocinio, parificato alle Scuole Agricole Statali .
Quello che segna., per così dire, l'apogeo delle Scuole Professionali ed
Agricole di Don Bosco, e che era il deside?'lttwn del Beato Fondatore nell'aprire il suo ospizio in Roma, è l'inaugurazione dell'Istituto Professionale
« Pio XI,) come monumento del Giubileo Sacerdotale del Pontefice d"lla
beatificazione e collegato con la Scuola Agricola del Mandrione, essa pure
parificata. Queste due opere di educazione popolare e professiona.]e, benedette specialmente d al Sommo Pontefice e sotto l'alta protezione del Governo di S. 111. nella capitale d'Italia aumentano il prestigio dell'umile
ospizio che con tante fatiche e sollecitudini apriva Don Bosco in Valdocco
e che cosÌ meravigliosamente h a steso i suoi l'ami per tutte le N azioni del·
l'antico e del nuovo mondo .
" * *
Ma non bastava tutto questo per soddisfar e ai bisogni della Missione
Salesiana, ai quali accenna il Beato Don Bosco nella sua Conferenza. Come
soddisfare al bisogno urgente di maestri tecnici, di. capi-laboratorio salesiani per le Scuole Professionali di tante l spettorie delle diverse N azioni~
La generosità di un insigne Cooperatore, anzi Presidente dei Cooperatori di Don Bosco, il Senatore Conte Eugenio Rebaudengo, insignito recentemente della Gran Croce dell'Ordine Piano da S. S. Pio XI, ha voluto
destinare un'ingente somma per innalzare in Torino un gran monumento
al Beato Don Bosco e nello stesso tempo pagare un tributo di affetto ai
suoi cari antenati ed alla memoria della sua nobile e virtuosa consorte.
È questo il grandioso Istituto Professionale Oonti Rebattdengo,' in Torino,
destinato a Scuola di Arti e Mestieri per aspiranti missionari, con una' sezione
-
909-
speciale per il biennio di perfezionamento professionale o Corso di Magistero dei giovani coadiutori di tutte le I spettorie Salesiane.
Quello dunque che il Rettor Maggiore col suo Capitolo aveva stabilito
fino dal HJ21 per la form azione dei sacerdoti salesiani , creando uno Studentato Teologico centrale in Torino presso la Casa Madre della Congregazione, ora si attuerà anch e riguardo ai salesiani coadiutori, artigia.ni
ed agricoltori, alcuni dei quali verranno all'Istituto (, Conti Rebauc1engo l),
altri alla Scuola Agricola di Cumiana per compiervi il loro corso di perfezionamento professionale, acquistare il titolo di maestri e ritornare ai loro
paesi per insegnare le arti ed i mestieri o l' agricoltura con lo stesso metodo
e gli stessi programmi delle nostre scuole. Sono pertanto da quarantacinque
Isp ettorie Salesiane, corrispondenti alle principali N azioni e lingue d el
mondo, che manderanno i loro rappresentanti a queste du e Case di Magistero professionale ed agricolo. Così noi che abbiamo avuto la bella sorte
di assistere alla Beatificazione di Don Bosco siamo testimoni del compimento di una delle sue più belle promesse, anzi dell'attuazione di uno
splendido vat.icinio a favore della sua Opera, pronunciato da Lui quando
iniziava in S. Benigno Canavese il primo noviziato d ei suoi coadiutori e
delineava cosi genialmente e santamente la genuina figura del coadiutore
Salesiano.
Ma la gioventù da salvare per mezzo dell'educazione cristiana nelle
scuole professionali ed agricole è sempre numerosa, tanto numerosa che
anche ai nostri posteri parrà ancora di attualità lo stimolante invito del
Beato Padre: (, lo ho tanto bisogno di avere molti, che mi vengano ad aiutare in questo modo l) ! Per quanti siano i buoni coadiutori salesiani, non
ve ne sarà mai nessun di troppo.
'l'ip. S.E./.
Scarica