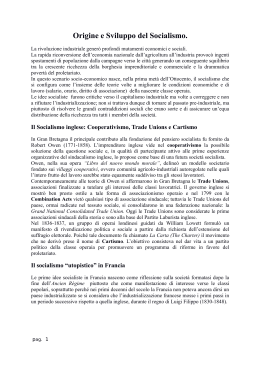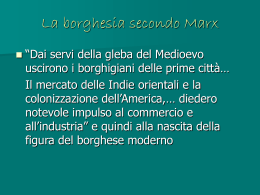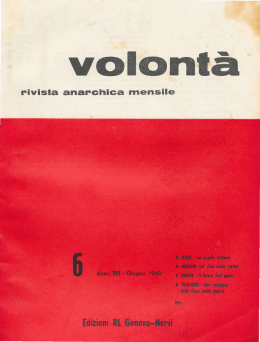FONDATA DA FILIPPO TURATI NEL 1891 DIREZIONE Ugo Finetti Sergio Scalpelli Stefano Carluccio (direttore responsabile) Email: [email protected] Grafica: Gianluca Quartuccio Giordano Rivista di Cultura Politica, Storica e Letteraria Anno CXX – N. 1-2 / 2011 GIORNALISTI EDITORI scarl Via Benefattori dell’Ospedale, 24 - Milano Tel. +39 02 6070789 / 02 683984 Fax +39 02 89692452 Email: [email protected] Registrazione Tribunale di Milano n. 646 / 8 ottobre 1948 e n. 537 / 15 ottobre 1994 – Stampa: Telestampa Centro Italia - Srl - Località Casale Marcangeli - 67063 Oricola (L’Aquila) - Abbonamento annuo: Euro 50,00 Euro - 10,00 ■ L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, GIORGIO NAPOLITANO, PER L’ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DI CRITICA SOCIALE 150 ANNI DI UNITÀ DELLA NAZIONE 120 ANNI PER L’UNITÀ SOCIALE Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha concesso il Suo Alto Patronato alla celebrazione dei 120 anni della Critica Sociale. Il comitato promotore è formato, oltre che dalla stessa Rivista, dalla Società Umanitaria, dalle Ragioni del Socialismo, da Mondoperaio e dagli Amici di Critica Sociale, con la consulenza scientifica della Fondazione Filippo Turati. Pubblichiamo la nota con cui la Direzione della Critica ha illustrato il significato che intende attribuire alla celebrazione di questo anniversario prospettiva, amanti dei nostri ideali, desideriamo cogliere ogni possibilità di collaborazione con le Istituzioni, sia pubbliche che private, per dare un contributo alla conoscenza dei processi storici e delle idee che hanno dato al nostro Paese la democrazia come sua civiltà. In proposito ci permettiamo di anticiparLe che è stata predisposta l’edizione digitale, in un cofanetto di sette DVD, dell’intera Collezione Storica diretta da Filippo Turati (1891-1926) di cui intendiamo fare dono ad ogni biblioteca, centro studi, archivio e ateneo interessato ad arricchire la propria documentazione. Una iniziativa che ci auguriamo possa essere utile ed apprezzata soprattuto dai giovani. ignor Presidente, cento venti anni fa nasceva La vastità delle collaborazioni alla Critica Sociale è di tale amCritica Sociale: nel primo numero del 15 genpiezza da non poterci consentire di abusare ulteriormente della Sua naio 1891, Filippo Turati spiegò ai lettori della cortese attenzione per essere illustrata: si tratta di personalità di Rivista, nel suo editoriale di presentazione della nuova Direzione, spicco del pensiero sociale, economico, giuridico e culturale itale ragioni che lo inducevano a scegliere il nome “Critica Sociale” liano, ma anche internazionale, in un arco di tendenze lasciato semin luogo della vecchia testata “Cuore e Critica” creata nel 1887 dal pre aperto ad ogni contributo. Quindi è solo a titolo indicativo che mazziniano Arcangelo Ghisleri e della quale Turati era già redatricordiamo tra gli autori lo stesso Federico Engels, Vilfredo Pareto, tore. La nuova linea del giornale si proponeva di evolvere il soi coniugi Webb della Fabian Society (con la quale intratteniamo cialismo democratico risorgimentale, umanitario e romantico, vertutt’ora fraterni rapporti di attiva collaborazione), Emile Vanderso un nuovo socialismo scientifico, un socialismo basato sullo stuvelde, Giovanni Mosca, Gaetano Salvemini, Enrico Ferri, Gabriele dio critico della società che si andava formando nella nuova NaRosa, Carlo Rosselli, Giacomo Matteotti, Benvenuto Griziotti, zione, frutto del processo unitario terminato solo 30 anni prima, e Giovanni Montemartini, Attilio Cabiati, e molti altri tra i quali, nel che metteva a fuoco l’esistenza di una “Eterna questione”, come secondo dopoguerra, ricordiamo in segno di omaggio alla memodefinì la Questione sociale. ria, il senatore a vita, Leo Valiani e il giornalista Walter Tobagi. Intendiamo ricordare l’anniversario della Critica Sociale coIn questo quadro di autori della Critica Sociale spiccano, in gliendone la profonda relazione con le sue radici originarie, che particolare, i nomi di due futuri Presidenti della Repubblica: Luigi IL TELEGRAMMA DEL QUIRINALE coincidono con le Celebrazioni del 150 Anniversario dell’Unità Einaudi, che iniziò giovanissimo la sua collaborazione, ancora red’Italia. Vi sono ragioni di fondo, a nostro giudizio, che brevemente sponsabile del circolo socialista universitario di Torino, e che pro“Sono lieto di comunicare che il Presidesideriamo sottoporre alla Sua cortese considerazione e pazienza. seguì a offrire i suoi studi in saggi di grande livello, già divenuto dente della Repubblica ha concesso il Innanzitutto la Rivista sorge prima del Partito dei socialisti (eseditorialista del Corriere della Sera, per un arco di dieci anni (1893Suo Alto Patronato alle Celebrazioni per si già con un ruolo di primo piano nel movimento democratico uni1903); Giuseppe Saragat, che ebbe nella Critica Sociale un punto il 120esimo anniversario di fondazione tario), nel tentativo di contribuire alla costruzione della Nazione di riferimento della sua posizione politica, in particolare con la didella rivista Critica Sociale. Nel formulaattraverso l’ ingresso delle masse lavoratrici - che compaiono per rezione di Giuseppe Faravelli che ne fece per qualche anno una re lʼaugurio per il successo delle manifestazioni, invio un cordiale saluto”. la prima volta sulla scena - nella vita unitaria del nuovo Stato. Il vera e propria corrente socialdemocratica all’interno del Partito fine del gruppo della Critica Sociale fu quello di organizzare la socialista. L’attuale edizione è curata da ex giornalisti dell’Avanti! Donato Marra, Segretario Generale partecipazione dei lavoratori alla vita politica con un proprio parche hanno garantito la continuità della storica testata dopo la chiudella Presidenza della Repubblica tito, formando così un popolo (Il “fare gli Italiani” garibaldino) sura del quotidiano socialista nel 1994. La registrazione di legge con l’educazione alla associazione: alla cooperazione nell’econocon cui le pubblicazioni proseguono, infatti, è ancora la medesima mia, alla mutualità nei sindacati e nelle primordiali strutture di welfare, all’autogoverno nei con la quale Antonio Greppi e Ugo Guido Mondolfo, ereditandola dallo stesso Turati nelmunicipi, nelle battaglie per i diritti, prima di tutto per il suffragio universale e per la legge l’esilio francese, la iscrissero al Tribunale di Milano, nell’ottobre del 1948, secondo la prima elettorale proporzionale. Si coglieva (pur tra le polemiche interne) ogni opportunità offerta legge sulla Stampa della neonata Repubblica italiana, dopo la Liberazione. dalla democrazia liberale per promuovere il movimento dei lavoratori come soggetto protaE’ dunque con viva attesa, Signor Presidente, che Le rivolgiamo la richiesta di un Suo gonista a pieno titolo dello sviluppo e del progresso italiano. Forse questo è il lascito più imAlto Patronato per la celebrazioni dei 120 anni della Critica Sociale. portante dell’idea socialista della Critica Sociale, e costituisce per noi ancora una finalità ed Con stima, la Direzione un metodo di attualissimo valore patriottico. In secondo luogo, il nesso che cogliamo con le Celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, è la ricca documentazione sui processi di organizzazione e di sviluppo delle forme istituzionali, dell’economica e della nuova società unitaria, che Critica Sociale conserva nella sua PER ABBONARSI storia, per la longevità e continuità della sua pubblicazione a cavallo dei due secoli, fino alAbbonamento annuo Euro 50,00 l’avvento del fascismo e all’esilio. Sono molte le altre importanti riviste pubblicate in quegli c/c postale 30516207 intestato a Giornalisti editori scarl anni, ma la continuità della Critica Sociale consente di avere uno sguardo unitario sui processi Banco Posta: IBAN IT 64 A 0760101600000030516207 storici, sulle realizzazioni, le interruzioni, i confronti e i cambiamenti intervenuti nelle poliBanca di Roma: IBAN IT 56 D 02008 01759 000100462114 E-mail: [email protected] tiche dell’epoca. Sotto questo profilo riteniamo la divulgazione del suo archivio essere interessante non Editore - Stefano Carluccio - Direzione editoriale - Carlo Tognoli, Francesco Forte, Rino Formica, Francesco Colucci, Massimo Pini, solo per la storia del movimento dei lavoratori e socialista, ma per la conoscenza, quasi nel Spencer Di Scala, Giuseppe Scanni, Riccardo Pugnalin, Sergio Pizzolante dettaglio, degli studi, dei dibatti e persino delle polemiche che hanno accompagnato la coLa testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7/08/1990 n.250 struzione della Nazione. E’ dunque, a nostro modo di sentire, un patrimonio di tutti gli italiani, un patrimonio nazionale che sentiamo il dovere di rendere disponibile. Infine e in questa “S POSTE ITALIANE S.p.A. Spedizione in a.p.D.L. 353/03 (conv. L. 46/04) Art. 1 comma 1, DCB Milano - Mens. 778000 057003 9 ISSN 1827-4501 11001 ” CRITICAsociale ■ 3 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia ■ LA TESTIMONIANZA DI MASSIMO PINI: “DOPO IL MIDAS MI INCARICÒ DI RIDARE VITA ALLA RIVISTA” QUANDO CRAXI NEL 1976 SALVA LA CRITICA SOCIALE N Massimo Pini el numero del gennaio 1975, la fotografia di un comizio di Luciano Lama, il segretario comunista della CGIL, risaltava sulla copertina di “La Critica Sociale”, una rivista senza pretese stampata su carta giallina. Nell’interno, un avviso riquadrato informava i lettori che “con questo fascicolo, ‘La Critica Sociale’ sospende temporaneamente le pubblicazioni: così ha deciso il suo consiglio di amministrazione prendendo atto che mancano i mezzi per continuare...”. La direzione della rivista - composta dallo storico Ugoberto Alfassio Grimaldi e da Reno Ferrara, condirettore - ricordava che nel lontano ottobre 1926 essa aveva dovuto sospendere le pubblicazioni perché “ormai la bestia fascista imperversava, e dovevano passare diciannove anni prima che questa voce riprendesse a parlare”. Certamente quindi non era di buon auspicio che proprio nel momento in cui “il fascismo risorge e minaccia”, le forze socialiste e democratiche non apparissero in grado di “tenere in piedi viva e vitale la testata gloriosa della “Critica”. E così concludevano i due direttori: “È un fatto che porta a meste considerazioni: quasi ci vedessimo innanzi agli occhi Turati e Faravelli costretti a riprendere la via dell’esilio”. Quell’ultimo numero riportava tra le sue pagine la pubblicità di alcuni istituti bancari: la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, il Banco di Napoli e l’IRFIS, un istituto di credito siciliano. Era quello il risultato degli sforzi di Giannino Parravicini, il socialdemocratico presidente del Banco di Sicilia, e all’epoca il più illustre dei soci della “Critica”, se si esclude Giuseppe Faravelli, direttore per lunghi anni dopo Ugo Guido Mondolfo che aveva fatto rinascere la rivista il 15 settembre 1945. E proprio alla memoria di Giuseppe Faravelli, da poco scomparso, era stato dedicato il numero del dicembre 1974 della “Critica Sociale”, a cura di Virgilio Dagnino. Venuto a mancare Faravelli, la rivista si rivolgeva ai lettori e ai simpatizzanti, chiedendo aiuto, perché la ‘Critica Sociale’ viva”. 15.000 lire annue per un abbonamento sostenitore, 6.000 per un ordinario... Per la verità, tra l’autunno del 1974 e il biennio 1975/6 non era il fascismo a risorgere e a minacciare, ma semmai il comunismo: la variante nazionale di un fenomeno globale alquanto pericoloso per la pace, anche se senescente. In seguito al successo riportato dal referendum per la abrogazione del divorzio, voluto dal segretario della DC Fanfani, e alla valanga di NO che aveva raggiunto quasi il 60% dei votanti, il Partito socialista era diventato, nonostante la mitezza del suo segretario Francesco De Martino, sempre più movimentista. Il centro-sinistra era davvero finito dopo oltre dieci anni, e il certificatore del decesso fu il ministro delle Finanze, il socialdemocratico Mario Tanassi, alle ore 19,30 del primo ottobre 1974. Lo scandalo dei petroli, scoppiato nell’autunno del 1974, portò a conoscenza della opinione pubblica il finanziamento da parte della Unione petrolifera di tutti i partiti, escluso il PCI: era l’inizio della “questione morale”. Però lo stesso PCI aveva offerto alla DC la scappatoia del “compromesso storico”, la formula inventata da Enrico Berlinguer e dai suoi accoliti cattocomunisti, e ispirata dalla tragedia di Salvador Allende in Cile: non si può governare un paese nel mondo occidentale con una maggioranza del 51%, ma solo con ampie coalizioni, quale avrebbe potuto essere quella tra DC e PCI. Alle elezioni amministrative del 15 giugno 1975, il voto sembrò dar ragione alla proposta del “compromesso storico”: il PCI arrivò al 33,4% contro il 12% dei socialisti, il cui amaro commento fu: “Noi abbiamo scosso l’albero e loro hanno raccolto i frutti”. In seguito alla sconfitta della DC, passata dal 38,8% al 35,3%, Amintore Fanfani venne rovesciato e gli subentrò alla segreteria politica Benigno Zaccagnini. Ora che DC e PCI raccoglievano insieme il 70% dei suffragi, le prospettive per il PSI si facevano sempre più inquietanti: al Comitato centrale del 10 luglio 1975 Bettino Craxi, all’epoca vice-segretario e capo della corrente autonomista che si riferiva a Pietro Nenni, volle lanciare un messaggio chiaro a tutti, comunisti per primi: “Insisto nel sottolineare il carattere determinante che ha, deve avere e dovrà avere il nostro partito”. Milano, città di Turati, della Kuliscioff, del sindaco Caldara, era stata la capitale del socialismo riformista; a Milano aveva iniziato le pubblicazioni nel 1891 “La Critica Sociale”, un anno prima che a Genova venisse fondato il Partito socialista italiano. Filippo Turati e Anna Kuliscioff avevano rilevato una testata letteraria che si chiamava “Cuore e Critica”, trasformandola nella “Critica Sociale”, sino a farla divenire, ricorda Carlo Tognoli, “un luogo d’incontro della cultura di sinistra”. Ma nel 1975 a Milano il PCI era il primo partito, con 25 seggi nel consiglio comunale, contro i 22 della DC, i 12 del PSI e cinque del PSDI. Armando Cossutta, responsabile nel PCI degli enti locali, ai primi di luglio elaborò la formula delle “giunte aperte”, un metodo per arrivare al “compromesso storico” mettendo da parte le “giunte rosse”, vale a dire formate con maggioranze che escludessero i democristiani. Nell’ombra Bettino Craxi manovrava: il suo disegno consisteva nel far fallire a Milano la “giunta aperta” e spingere i democristiani all’opposizione. E fu proprio ciò che accadde: come sottolinea Carlo Tognoli, il quale sarà eletto sindaco di Milano dopo le elezioni politiche del 20 giugno 1976, era necessario far saltare ogni possibile intesa fra comunisti e DC, che avrebbe messo fuori gioco i socialisti. Il capolavoro di Bettino Craxi fu di avere costruito addosso ai berlingueriani l’immagine di un successo tattico - la “giunta rossa” - che era in realtà una sconfitta strate- gica per la prospettiva del “compromesso storico”. Nel contempo, Craxi aveva un occhio molto attento per gli equilibri interni del suo partito: divenuto segretario del PSI nel comitato centrale del luglio 1976, dopo la sconfitta di De Martino alle elezioni politiche, egli si era posto il problema di una pubblicazione periodica da affiancare a “Mondo Operaio”, il mensile orientato verso la sinistra di Riccardo Lombardi. Poiché io controllavo una casa editrice, la SugarCo, e facevo parte da dieci anni del circolo dei suoi amici intimi, Craxi mi propose di acquistare le quote della “Critica Sociale” dai soci, tra i quali Giannino Parravicini, Reno Ferrara e Piero Caleffi, l’autore di “Si fa presto a dire fame”, gravemente malato. Si trattava di una missione complessa, perché i soci, dopo la chiusura della rivista, non intendevano cedere il controllo della testata che si era posizionata storicamente fra socialisti e socialdemocratici, non escludendo un interesse verso i laici e i repubblicani di Ugo La Malfa. D’altra parte il ruolo di segretario del PSI ricoperto con tanta passione ed attivismo da Craxi dal luglio 1976 sembrava fin dall’inizio contestato al punto che un capo-corrente dell’epoca, Claudio Signorile, erede politico di Lombardi, aveva dichiarato: “Se non marcerà lo faremo fuori in tre mesi”. Alla fine però riuscii a portare sotto il controllo della mia casa editrice tutte le quote de “La Critica Sociale”, e venerdì 29 aprile 1977 alla Villa Comunale di via Palestro a Milano si svolse la cerimonia di presentazione della nuova serie del quindicinale, con una grafica moderna e completamente rinnovata. Erano presenti il sindaco di Milano Carlo Tognoli, Umberto Dragone vicepresidente della Lega delle Cooperative, il filosofo Riccardo Bauer e il giornalista Italo Pietra, tra gli altri. La rivista, diretta dallo storico Ugoberto Alfassio Grimaldi e con la condirezione di Reno Ferrara esecutore testamentario di Faravelli, ricordava dunque la direzione della vecchia serie, nel nome e nella memoria di Giuseppe Faravelli al quale era stato dedicato il numero 1/2 del 1977, fuori commercio e destinato agli abbonati. Dal numero 4 del 27 maggio 1977 però Ferrara lascerà la condirezione: Umberto Giovine diventerà capo-redattore, e confermata la direzione responsabile di Ugo Intini. Il numero tre del 13 maggio 1977, presentato a Milano alla Villa Comunale, era dedicato alle elezioni europee, ed aveva nel suo interno quattro inserzionisti di pubblicità: la Mondadori, la CBS Sugar, la Cassa di Rispar- mio delle Provincie Lombarde, ed infine la Edilnord. Per chiedere il sostegno pubblicitario, mi ero recato personalmente negli uffici di Berlusconi a Foro Buonaparte 24, su indicazione di Bettino Craxi. Berlusconi, all’epoca noto soprattutto come costruttore di Milano Due, sostenne la “Critica” e anzi ne ospitò gli uffici per un certo periodo. “Non ci pare casuale”, chiarì Carlo Tognoli alla presentazione, “che questa gloriosa testata alla quale è legato il patrimonio più alto e migliore della tradizione laica, riformista, umanitaria del socialismo italiano e, crediamo, non solo italiano, ricompaia in questo momento che è di generale ripresa e considerazione critica delle linee portanti e delle matrici culturali del socialismo nel nostro Paese”. Il direttore Alfassio Grimaldi ci tenne a ribadire: “Non siamo una rivista del partito socialista come ‘Mondo Operaio’, ma dell’area socialista. Perciò saremo aperti alla collaborazione di tutte le componenti laiche e cattoliche della sinistra non comunista...”. Quella dichiarazione faceva capire fin troppo chiaramente ciò che bolliva in pentola nei rapporti fra PSI e PCI, una vera e propria sfida culturale prima ancora che politica. La critica al dogmatismo sovietico, l’accentuazione del carattere pluralistico ed aperto della futura società socialista, la riconsiderazione del rapporto libertà-giustizia sociale, l’intero tessuto in cui si era venuta articolando la trama del revisionismo socialista erano “oggi più che mai”, aveva concluso Carlo Tognoli, “di fronte alla attenzione della cultura di sinistra e ricevono continui apporti di analisi e contributi da parte degli esponenti intellettuali più avvertiti”. Nel numero del 26 agosto 1977 “La Critica Sociale” riportava la “mappa del potere” nella RAI, dopo la lottizzazione voluta dai comunisti col nuovo consiglio di amministrazione presieduto dal socialista frontista Paolo Grassi. La polemica con i comunisti si ampliava quindi dalla disputa ideologica alle ben più concrete questioni del controllo di quotidiani e del monopolio televisivo. Il PCI reagì per la penna di Elio Quercioli, responsabile per il partito del settore dell’informazione, il quale tacciò di “qualunquistiche” le critiche; e non mancò un corsivo anonimo ne “L’Unità” che additava come “pericolose” certe iniziative. Nonostante l’eurocomunismo, lo stalinismo di fondo non riusciva a mascherarsi. Il 14 gennaio 1978 usciva nuovamente la “Critica”; da allora sono trascorsi altri trentatrè anni, e ancora oggi la rivista - dopo 120 anni questo 15 gennaio - è viva e vitale. E’ una delle più antiche testate italiane, testimone e punto di raccolta della tradizione socialista. Essa è sopravvissuta alla tragica fine del Partito socialista italiano, distrutto e costretto alla diaspora dal colpo di Stato di “mani pulite”: ed oggi rappresenta forse l’unico punto di coagulo di una rinnovata organizzazione dei socialisti. Fu dunque profeta Bettino Craxi quando, nel corso della estate del 1976, mi disse: “Bisogna ridare vita alla ‘Critica Sociale’... Ricorda bene: è la cosa più importante da fare in questo momento...”. Il suo messaggio è stato e sarà accolto. La “Critica”, la più antica rivista italiana, ha vissuto e vivrà, nell’auspicio che attorno ad essa facciano fronte non solo le memorie, non solo la storia del movimento dei lavoratori, non solo le analisi grandiose che si trovano nella raccolta che presentiamo, ma le diaspore socialiste finalmente riunite nel nome di Turati, Nenni e Craxi. s 4 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia LA MEMORIA E IL FUTURO ■ IL DISCORSO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO PER I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA “ORGOGLIO, COSCIENZA CRITICA SENSO DELLA MISSIONE, UNITÀ NAZIONALE” Intervento del Presidente Napolitano alla Seduta comune del Parlamento in occasione dell’apertura delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia Montecitorio, 17/03/2011 S ento di dover rivolgere un riconoscente saluto ai tanti che hanno raccolto l’appello a festeggiare e a celebrare i 150 anni dell’Italia unita : ai tanti cittadini che ho incontrato o che mi hanno indirizzato messaggi, esprimendo sentimenti e pensieri sinceri, e a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno promosso iniziative sempre più numerose in tutto il Paese. Istituzioni rappresentative e Amministrazioni pubbliche : Regioni e Provincie, e innanzitutto municipalità, Sindaci anche e in particolare di piccoli Comuni, a conferma che quella è la nostra istituzione di più antica e radicata tradizione storica, il fulcro dell’autogoverno democratico e di ogni assetto autonomistico. Scuole, i cui insegnanti e dirigenti hanno espresso la loro sensibilità per i valori dell’unità nazionale, stimolando e raccogliendo un’attenzione e disponibilità diffusa tra gli studenti. Istituzioni culturali di alto prestigio nazionale, Università, Associazioni locali legate alla memoria della nostra storia nei mille luoghi in cui essa si è svolta. E ancora, case editrici, giornali, radiotelevisioni, in primo luogo quella pubblica. Grazie a tutti. Grazie a quanti hanno dato il loro apporto nel Comitato interministeriale e nel Comitato dei garanti, a cominciare dal suo Presidente. Comune può essere la soddisfazione per questo dispiegamento di iniziative e contributi, che continuerà ben oltre la ricorrenza di oggi. E anche, aggiungo, per un rilancio, mai così vasto e diffuso, dei nostri simboli, della bandiera tricolore, dell’Inno di Mameli, delle melodie risorgimentali. Si è dunque largamente compresa e condivisa la convinzione che ci muoveva e che così formulerò : la memoria degli eventi che condussero alla nascita dello Stato nazionale unitario e la riflessione sul lungo percorso successivamente compiuto, possono risultare preziose nella difficile fase che l’Italia sta attraversando, in un’epoca di profondo e incessante cambiamento della realtà mondiale. Possono risultare preziose per suscitare le risposte collettive di cui c’è più bisogno : orgoglio e fiducia ; coscienza critica dei problemi rimasti irrisolti e delle nuove sfide da affrontare ; senso della missione e dell’unità nazionale. E’ in questo spirito che abbiamo concepito le celebrazioni del Centocinquantenario. Orgoglio e fiducia, innanzitutto. Non temiamo di trarre questa lezione dalle vicende risorgimentali! Non lasciamoci paralizzare dall’orrore della retorica : per evitarla è sufficiente affidarsi alla luminosa evidenza dei fatti. L’unificazione italiana ha rappresentato un’impresa storica straordinaria, per le condizioni in cui si svolse, per i caratteri e la portata che assunse, per il successo che la coronò superando le previsioni di molti e premiando le speranze più audaci. Come si presentò agli occhi del mondo quel risultato? Rileggiamo la lettera che quello stesso giorno, il 17 marzo 1861, il Presidente del Consiglio indirizzò a Emanuele Tapparelli D’Azeglio, che reggeva la Legazione d’Italia a Londra : “Il Parlamento Nazionale ha appena votato e il Re ha sanzionato la legge in virtù della quale Sua Maestà Vittorio Emanuele II assume, per sé e per i suoi successori, il titolo di Re d’Italia. La legalità costituzionale ha così consacrato l’opera di giustizia e di riparazione che ha restituito l’Italia a se stessa. A partire da questo giorno, l’Italia afferma a voce alta di fronte al mondo la propria esistenza. Il diritto che le apparteneva di essere indipendente e libera, e che essa ha sostenuto sui campi di battaglia e nei Consigli, l’Italia lo proclama solennemente oggi”. Così Cavour, con parole che rispecchiavano l’emozione e la fierezza per il traguardo raggiunto : sentimenti, questi, con cui possiamo ancor oggi identificarci. Il plurisecolare cammino dell’idea d’Italia si era concluso : quell’idea-guida, per lungo tempo irradiatasi grazie all’impulso di altissimi messaggi di lingua, letteratura e cultura, si era fatta strada sempre più largamente, nell’età della rivoluzione francese e napoleonica e nei decenni successivi, raccogliendo adesioni e forze combattenti, ispirando rivendicazioni di libertà e moti rivoluzionari, e infine imponendosi negli anni decisivi per lo sviluppo del movimento unitario, fino al suo compimento nel 1861. Non c’è discussione, pur lecita e feconda, sulle ombre, sulle contraddizioni e tensioni di quel movimento che possa oscurare il dato fondamentale dello storico balzo in avanti che la nascita del nostro Stato nazionale rappresentò per l’insieme degli italiani, per le popolazioni di ogni parte, Nord e Sud, che in esso si unirono. Entrammo, così, insieme, nella modernità, rimuovendo le barriere che ci precludevano quell’ingresso. Occorre ricordare qual era la condizione degli italiani prima dell’unificazione? Facciamolo con le parole di Giuseppe Mazzini - 1845 : “Noi non abbiamo bandiera nostra, non nome politico, non voce tra le nazioni d’Europa ; non abbiamo centro comune, né patto comune, né comune mercato. Siamo smembrati in otto Stati, indipendenti l’uno dall’altro...Otto linee doganali....dividono i nostri interessi materiali, inceppano il nostro progresso....otto sistemi diversi di monetazione, di pesi e di misure, di legislazione civile, commerciale e penale, di ordinamento amministrativo, ci fanno come stranieri gli uni agli altri”. E ancora, proseguiva Mazzini, Stati governati dispoticamente, “uno dei quali - contenente quasi il quarto della popolazione italiana - appartiene allo straniero, all’Austria”. Eppure, per Mazzini era indubitabile che una nazione italiana esistesse, e che non vi fossero “cinque, quattro, tre Italie” ma “una Italia”. Fu dunque la consapevolezza di basilari interessi e pressanti esigenze comuni, e fu, insieme, una possente aspirazione alla libertà e all’indipendenza, che condussero all’impegno di schiere di patrioti - aristocratici, borghesi, operai e popolani, persone colte e incolte, monarchici e repubblicani - nelle battaglie per l’unificazione nazionale. Battaglie dure, sanguinose, affrontate con magnifico slancio ideale ed eroica predisposizione al sacrificio da giovani e giovanissimi, protagonisti talvolta delle imprese più audaci anche condannate alla sconfitta. E’ giusto che oggi si torni ad onorarne la memoria, rievocando episodi e figure come stiamo facendo a partire, nel maggio scorso, dall’anniversario della Spedizione dei Mille, fino all’omaggio, questa mattina, ai luoghi e ai prodigiosi protagonisti della gloriosa Repubblica romana del 1849. Sono fonte di orgoglio vivo e attuale per l’Italia e per gli italiani le vicende risorgimentali da molteplici punti di vista, ed è sufficiente sottolinearne alcuni. In primo luogo, la suprema sapienza della guida politica cavouriana, che rese possibile la convergenza verso un uni- CRITICAsociale ■ 5 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia co, concreto e decisivo traguardo, di componenti soggettive e oggettive diverse, non facilmente componibili e anche apertamente confliggenti. In secondo luogo, l’emergere, in seno alla società e nettamente tra i ceti urbani, nelle città italiane, di ricche, forse imprevedibili riserve - sensibilità ideali e politiche, e risorse umane - che si espressero nello slancio dei volontari come componente attiva essenziale al successo del moto unitario, e in un’adesione crescente a tale moto da parte non solo di ristrette élite intellettuali ma di strati sociali non marginali, anche grazie al diffondersi di nuovi strumenti comunicativi e narrativi. E in terzo luogo vorrei sottolineare l’eccezionale levatura dei protagonisti del Risorgimento, degli ispiratori e degli attori del moto unitario. Una formidabile galleria di ingegni e di personalità - quelle femminili fino a ieri non abbastanza studiate e ricordate - di uomini di pensiero e d’azione. A cominciare, s’intende, dai maggiori : si pensi, non solo a quale impronta fissata nella storia, ma a quale lascito cui attingere ancora con rinnovato fervore di studi e generale interesse, rappresentino il mito mondiale, senza eguali - che non era artificiosa leggenda - di Giuseppe Garibaldi, e le diverse, egualmente grandi eredità di Cavour, di Mazzini e di Cattaneo. Quei maggiori, lo sappiamo, tra loro dissentirono e si combatterono : ma ciascuno di essi sapeva quanto l’apporto degli altri concorresse al raggiungimento dell’obbiettivo considerato comune, anche se ciò non valse a cancellare contrasti di fondo e poi tenaci risentimenti. Ho detto dei principali protagonisti, ma molti altri nomi - del campo moderato, dell’area cattolico-liberale, e del campo democratico - potrebbero essere richiamati a testimonianza di una straordinaria fioritura di personalità di spicco nell’azione politica, nella società civile, nell’amministrazione pubblica. compiersi che sotto l’egida dello Stato più avanzato, già caratterizzato in senso liberale, più aperto e accogliente verso la causa italiana e i suoi combattenti che vi fosse nella penisola, e cioè sotto l’egida della dinastia sabauda e della classe politica moderata del Piemonte, impersonata da Cavour. Fu quella la condizione obbiettiva riconosciuta con generoso realismo da Garibaldi, pur democratico e repubblicano, col suo “Italia e Vittorio Emanuele”. E se lo scontro tra garibaldini ed Esercito Regio sull’Aspromonte è rimasto traccia dolorosa dell’aspra dialettica di posizioni che s’intrecciò col percorso unitario, appare singolare ogni tendenza a “scoprire” oggi con scandalo come le battaglie sul campo per l’Unità furono ovviamente anche battaglie tra italiani, similmente a quanto accadde dovunque vi furono movimenti nazionali per la libertà e l’indipendenza. Ma al di là di semplicismi e polemiche strumentali, vale piuttosto la pena di considerare i termini della riflessione e del dibattito più re- ordinamento politico e amministrativo, con cui potesse essere soddisfatto in Italia il bisogno di indipendenza e di coesione nazionale”. E così, attraverso errori non meno gravi delle difficoltà da superare, “fu compiuta” - sono ancora parole dello storico - “un’opera ciclopica. Fu fatto di sette eserciti un esercito solo...Furono tracciate le prime linee della rete ferroviaria nazionale. Fu creato un sistema spietato di imposte per sostenere spese pubbliche crescenti e per pagare l’interesse dei debiti... Furono rinnovati da cima a fondo i rapporti tra lo Stato e la Chiesa”. E fu debellato il brigantaggio nell’Italia meridionale, anche se pagando la necessità vitale di sconfiggere quel pericolo di reazione legittimista e di disgregazione nazionale col prezzo di una repressione talvolta feroce in risposta alla ferocia del brigantaggio e, nel lungo periodo, col prezzo di una tendenziale estraneità e ostilità allo Stato che si sarebbe ancor più radicata nel Mezzogiorno. cente sulle scelte che vennero adottate subito dopo l’unificazione dalle forze dirigenti del nuovo Stato. E a questo proposito si sono registrati seri approfondimenti critici : che non possono tuttavia non collocarsi nel quadro di una obbiettiva valutazione storica del quadro dell’Italia pre-unitaria quale era stato ereditato dal nuovo governo e Parlamento nazionale. Questi si trovarono dinanzi a ferree necessità di sopravvivenza e sviluppo dello Stato appena nato, che non potevano non prevalere su un pacato e lungimirante esame delle opzioni in campo, specie quella tra accentramento, nel segno della continuità e dell’uniformità rispetto allo Stato piemontese da un lato, e - se non federalismo - decentramento, con forme di autonomia e autogoverno anche al livello regionale, dall’altro lato. E a questo proposito vale ancor oggi la vigorosa sintesi tracciata da un grande storico, che pure fu spirito eminentemente critico, Gaetano Salvemini. “I governanti italiani, fra il 1860 e il 1870, si trovavano” - egli scrisse - “ alle prese con formidabili difficoltà”. Quello che s’impose era allora - a giudizio di Salvemini - “il solo Da un quadro storico così drammaticamente condizionato, e da un’”opera ciclopica” di unificazione, che gettò le basi di un mercato nazionale e di un moderno sviluppo economico e civile, possiamo trarre oggi motivi di comprensione del nostro modo di costituirci come Stato, motivi di orgoglio per quel che 150 anni fa nacque e si iniziò a costruire, motivi di fiducia nella tradizione di cui in quanto italiani siamo portatori ; e possiamo in pari tempo trarre piena consapevolezza critica dei problemi con cui l’Italia dové fare e continua a fare i conti. Questi fortificanti motivi di orgoglio italiano trovano d’altronde riscontro nei riconoscimenti che vennero in quello stesso periodo e successivamente, dall’esterno del nostro paese, da esponenti della politica e della cultura storica d’altre nazioni ; riconoscimenti della portata europea della nascita dell’Italia unita, dell’impatto che essa ebbe su altre vicende di nazionalità in movimento nell’Europa degli ultimi decenni dell’Ottocento e oltre. Né si può dimenticare l’orizzonte europeo della visione e dell’azione politica di Cavour, e la significativa presenza, nel bagaglio ideale risorgimentale, della generosa utopia degli Stati Uniti d’Europa. Nell’avvicinarsi del Centocinquantenario si è riacceso in Italia il dibattito sia attorno ai limiti e ai condizionamenti che pesarono sul processo unitario sia attorno alle più controverse scelte successive al conseguimento dell’Unità. Sorvolare su tali questioni, rimuovere le criticità e negatività del percorso seguito prima e dopo al 1860-61, sarebbe davvero un cedere alla tentazione di racconti storici edulcorati e alle insidie della retorica. Sono però fuorvianti certi clamorosi semplicismi: come quello dell’immaginare un possibile arrestarsi del movimento per l’Unità poco oltre il limite di un Regno dell’Alta Italia : di contro a quella visione più ampiamente inclusiva dell’Italia unita, che rispondeva all’ideale del movimento nazionale (come Cavour ben comprese, ci ha insegnato Rosario Romeo) visione e scelta che l’impresa garibaldina, la Spedizione dei Mille rese irresistibile. L’Unità non poté compiersi che scontando limiti di fondo come l’assenza delle masse contadine, cioè della grande maggioranza, allora, della popolazione, dalla vita pubblica, e dunque scontando il peso di una questione sociale potenzialmente esplosiva. L’Unità non poté P roblemi e debolezze di ordine istituzionale e politico, che - nei decenni successivi all’Unità - hanno inciso in modo determinante sulle travagliate vicende dello Stato e della società nazionale, sfociate dopo la prima guerra mondiale in una crisi radicale risolta con la violenza in chiave autoritaria dal fascismo. Ed egualmente problemi e debolezze di ordine strutturale, sociale e civile. Sono i primi problemi quelli che oggi ci appaiono aver trovato - nello scorso secolo - più valide risposte. Mi riferisco a quel grande fatto di rinnovamento dello Stato in senso democratico che ha coronato il riscatto dell’Italia dalla dittatura totalitaria e dal nuovo servaggio in cui la nazione venne ridotta dalla guerra fascista e dalla disfatta che la concluse. Un riscatto reso possibile dall’emergere delle forze tempratesi nell’antifascismo, e dalla mobilitazione partigiana, cui si affiancarono nella Resistenza le schiere dei militari rimasti fedeli al giuramento. Un riscatto che culminò nella eccezionale temperie ideale e culturale e nel forte clima unitario - più forte delle diversità storiche e delle fratture ideologiche - dell’Assemblea Costituente. Con la Costituzione approvata nel dicembre 1947 prese finalmente corpo un nuovo disegno statuale, fondato su un sistema di principi e di garanzie da cui l’ordinamento della Repubblica, pur nella sua prevedibile e praticabile evoluzione, non potesse prescindere. Come venne esplicitamente indicato nella relazione Ruini sul progetto di Costituzione, “l’innovazione più profonda” consisteva nel poggiare l’ordinamento dello Stato su basi di autonomia, secondo il principio fondamentale dell’articolo 5 che legò l’unità e indivisibilità della Repubblica al riconoscimento e alla promozione delle autonomie locali, riferite, nella seconda parte della Carta, a Regioni, Provincie e Comuni. E altrettanto esplicitamente, nella relazione Ruini, si presentò tale innovazione come correttiva dell’accentramento prevalso all’atto dell’unificazione nazionale. La successiva pluridecennale esperienza delle lentezze, insufficienze e distorsioni registratesi nell’attuazione di quel principio e di quelle norme costituzionali, ha condotto dieci anni fa alla revisione del Titolo V della Carta. E non è un caso che sia quella l’unica rilevante riforma della Costituzione che finora il Parlamento abbia approvato, il corpo elettorale abbia confermato e governi di diverso orientamento politico si siano impegnati ad applicare concretamente. E’ stata in definitiva recuperata l’ispirazione federalista che si presentò in varie forme ma non ebbe fortuna nello sviluppo e a conclusione del moto unitario. All’indomani dell’unificazione, anche i progetti moderatamente autonomistici che erano stati predisposti in seno al governo, cedettero il passo ai timori e agli imperativi dominanti, già nel breve tempo che a Cavour fu ancora dato di vivere e nonostante la sua ribadita posizione di principio ostile all’accentramento benché non favorevole al federalismo. E oggi dell’unificazione celebriamo l’anniversario vedendo l’attenzione pubblica rivolta a verificare le condizioni alle quali un’evoluzione in senso federalistico - e non solo nel campo finanziario - potrà garantire maggiore autonomia e responsabilità alle istituzioni regionali e locali rinnovando e rafforzando le basi dell’unità nazionale. E’ tale rafforzamento, e non il suo contrario, l’autentico fine da perseguire. D’altronde, nella nostra storia e nella nostra visione, la parola unità si sposa con altre : pluralità, diversità, solidarietà, sussidiarietà. In quanto ai problemi e alle debolezze di ordine strutturale, sociale e civile cui ho poc’anzi fatto cenno e che abbiamo ereditato tra le incompiutezze dell’unificazione perpetuatesi fino ai nostri giorni, è il divario tra Nord e Sud, è la condizione del Mezzogiorno che si colloca al centro delle nostre preoccupazioni e responsabilità nazionali. Ed è rispetto a questa questione che più tardano a venire risposte adeguate. Pesa certamente l’esperienza dei tentativi e degli sforzi portati avanti a più riprese nei decenni dell’Italia repubblicana e rimasti non senza frutti ma senza risultati risolutivi ; pesa altresì l’oscurarsi della consapevolezza delle potenzialità che il Mezzogiorno offre per un 6 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia nuovo sviluppo complessivo del paese e che sarebbe fatale per tutti non saper valorizzare. Proprio guardando a questa cruciale questione, vale il richiamo a fare del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia l’occasione per una profonda riflessione critica, per quello che ho chiamato “un esame di coscienza collettivo”. Un esame cui in nessuna parte del paese ci si può sottrarre, e a cui è essenziale il contributo di una severa riflessione sui propri comportamenti da parte delle classi dirigenti e dei cittadini dello stesso Mezzogiorno. E’ da riferire per molti aspetti e in non lieve misura al Mezzogiorno, ma va vista nella sua complessiva caratterizzazione e valenza nazionale, la questione sociale, delle disuguaglianze, delle ingiustizie - delle pesanti penalizzazioni per una parte della società - quale oggi si presenta in Italia. Anche qui ci sono eredità storiche, debolezze antiche con cui fare i conti, a cominciare da quella di una cronica insufficienza di possibilità di occupazione, che nel passato, e ancora dopo l’avvento della Repubblica, fece dell’Italia un paese di massiccia emigrazione e oggi convive con il complesso fenomeno del flusso immigratorio, del lavoro degli immigrati e della loro necessaria integrazione. Senza temere di eccedere nella sommarietà di questo mio riferimento alla questione sociale, dico che la si deve vedere innanzitutto come drammatica carenza di prospettive di occupazione e di valorizzazione delle proprie potenzialità per una parte rilevante delle giovani generazioni. E non c’è dubbio che la risposta vada in generale trovata in una nuova qualità e in un accresciuto dinamismo del nostro sviluppo economico, facendo leva sul ruolo di protagonisti che in ogni fase di costruzione, ricostruzione e crescita dell’economia nazionale hanno assolto e sono oggi egualmente chiamati ad assolvere il mondo dell’impresa e il mondo del lavoro, passati entrambi, in oltre un secolo, attraverso profonde, decisive trasformazioni. Ma non è certo mia intenzione passare qui in rassegna l’insieme delle prove che ci attendono. Vorrei solo condividessimo la convinzione che esse costituiscono delle autentiche sfide, quanto mai impegnative e per molti aspetti assai dure, tali da richiedere grande spirito di sacrificio e slancio innovativo, in una rinnovata e realistica visione dell’interesse generale. La carica di fiducia che ci è indispensabile dobbiamo ricavarla dalla esperienza del superamento di molte ardue prove nel corso della nostra storia nazionale e dal consolidamento di punti di riferimento fondamentali per il nostro futuro. Una prova di straordinaria difficoltà e importanza l’Italia unita ha superato affrontando e via via sciogliendo il conflitto con la Chiesa cattolica. Dopo il 1861 l’obbiettivo della piena unificazione nazionale fu perseguito e raggiunto anche con la terza guerra d’indipendenza nel 1866 e a conclusione della guerra 1915-18 : ma irrinunciabile era l’obbiettivo di dare in tempi non lunghi al nascente Stato italiano Roma come capitale, la cui conquista per via militare fallito ogni tentativo negoziale - fece precipitare inevitabilmente il conflitto con il Papato e la Chiesa. Ma esso fu avviato a soluzione con un’intelligenza, moderazione e capacità di mediazione di cui già lo Stato liberale diede il segno con la Legge delle guarentigie nel 1871 e che - sottoscritti nel 1929 e infine recepiti in Costituzione i Patti Lateranensi - sfociò in tempi recenti nella revisione del Concordato. Si ebbe di mira, da parte italiana, il fine della laicità dello Stato e della libertà religiosa e insieme il graduale superamento di ogni separazione e contrapposizione tra laici e cattolici nella vita sociale e nella vita pubblica. Un fine, e un traguardo, perseguiti e piena- mente garantiti dalla Costituzione repubblicana e proiettatisi sempre di più in un rapporto altamente costruttivo e in una “collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese” anche attraverso il riconoscimento del ruolo sociale e pubblico della Chiesa cattolica e, insieme, nella garanzia del pluralismo religioso. Questo rapporto si manifesta oggi come uno dei punti di forza su cui possiamo far leva per il consolidamento della coesione e unità nazionale. Ce ne ha dato la più alta testimonianza il messaggio augurale indirizzatomi per l’odierno anniversario - e lo ringrazio - dal Papa Benedetto XVI. Un messaggio che sapientemente richiama il contributo fondamentale del Cristianesimo alla formazione, nei secoli, dell’identità italiana, così come il coinvolgimento di esponenti del mondo cattolico nella costruzione dello Stato unitario, fino all’incancellabile apporto dei cattolici e della loro scuola di pensiero alla elaborazione della Costituzione repubblicana, e al loro successivo affermarsi nella vita politica, sociale e civile nazionale. Ma quante prove superate e quanti momenti alti vissuti nel corso della nostra storia potremmo richiamare a sostegno della fiducia che deve guidarci di fronte alle sfide di oggi e del futuro! Anche a voler solo considerare il periodo successivo alla sconfitta e al crollo del 1943 e poi alla Resistenza e alla nascita della Repubblica, è ancora incancellabile nell’animo di quanti come me, giovanissimi, attraversarono quel passaggio cruciale, la memoria di un abis- so di distruzione e generale arretramento da cui potevamo temere di non riuscire a risollevarci. Eppure l’Italia unita, dopo aver scongiurato con sapienza politica rischi di separatismo e di amputazione del territorio nazionale, riuscì a rimettersi in piedi. Il primo, e forse più autentico “miracolo”, fu la ricostruzione, e quindi nonostante aspri conflitti ideologici, politici e sociali - il balzo in avanti, oltre ogni previsione, dell’economia italiana, le cui basi erano state gettate nel primo cinquantennio di vita dello Stato nazionale. L’Italia entrò allora a far parte dell’area dei paesi più industrializzati e progrediti, nella quale poté fare ingresso e oggi resta collocata grazie alla più grande invenzione storica di cui essa ha saputo farsi protagonista a partire dagli anni ‘50 dello scorso secolo : l’integrazione europea. Quella divenne ed è anche l’essenziale cerniera di una sempre più attiva proiezione dell’Italia nella più vasta comunità transatlantica e internazionale. La nostra collocazione convinta, senza riserve, assertiva e propulsiva nell’Europa unita, resta la chance più grande di cui disponiamo per portarci all’altezza delle sfide, delle opportunità e delle problematicità della globalizzazione. Prove egualmente rischiose e difficili abbiamo dovuto superare, nell’Italia repubblicana, sul terreno della difesa e del consolidamento delle istituzioni democratiche. Mi riferisco a insidie subdole e penetranti, così come ad attacchi violenti e diffusi - stragismo e terrorismo - che non fu facile sventare e che si riuscì ■ UNA VISITA CHE HA COINCISO CON LE CINQUE GIORNATE MILANO E NAPOLITANO NEL 150° L Carlo Tognoli e manifestazioni per il 150° dell’unità d’Italia hanno toccato il capoluogo lombardo, ma hanno avuto l’epicentro a Roma e a Torino. Si ripete forse ciò che accadde nel 1861 e dopo l’unificazione, quando Milano, che era stata capitale dell’impero romano e dell’Italia Cisalpina sotto Napoleone, vide prima Torino e poi Firenze e Roma assumere un ruolo politicamente più rilevante? No: la presenza del Presidente Giorgio Napolitano per due giornate è il riconoscimento alla città ambrosiana dell’importanza che ebbe nel Risorgimento, che ha avuto dopo la crisi di fine ‘800 che sfociò nel decennio delle riforme giolittiane e dopo il 1945 quando fu alla testa della ricostruzione e del ‘miracolo economico’. La partecipazione del capo dello stato al convegno su Carlo Cattaneo a Palazzo Marino e all’inaugurazione della nuova sede della Regione Lombardia ha un valore particolare in relazione alle recenti decisioni sul federalismo fiscale che ridanno spazio all’Italia delle autonomie e delle regioni. La visita di Napolitano ha coinciso tra l’altro con l’anniversario delle ‘Cinque Giornate’, quando Milano si liberò da sola dal giogo austriaco (episodio unico nell’Impero asburgico sino al 1918!) aprendo di fatto la prima (sfortunata) guerra risorgimentale. Gli storici (e quelli lombardi in particolare) tuttavia sostengono che la città lombarda, nella sua storia, ha privilegiato l’economia e la società, rispetto alla politica e allo stato. Questa è una realtà che non ha impedito a Milano di primeggiare, ma la tolse dal novero delle possibili capitali. Scienza e tecnica erano al primo posto nella gerarchia dei valori del Cattaneo e della borghesia che si formò con la prima industrializzazione da cui nasceva anche la ‘questione sociale’ relativa alle condizioni dei lavoratori. “La Perseveranza”, giornale milanese, scriveva poco dopo l’unificazione: “Nuova York tiene di gran lunga il primato tra le città degli Stati Uniti, sebbene non sia né la capitale dellUnione, né la capitale del suo Stato”. Commentava il professor Giorgio Rumi: “…La società la vince allora sullo Stato, anzi lo eclissa… Ecco nascere un’illusione perniciosa…” perché lo stato e la politica non possono accantonati come fattori superflui. Milano è legata a questa felice ambiguità: capitale senza esserlo, città di relazioni mondiali senza averne la totale consapevolezza, crocevia d’Europa, però con insufficienti infrastrutture di comunicazione con il continente. Il mito di Milano e della Lombardia come luoghi del lavoro, degli scambi, della finanza e dell’innovazione (l’incivilimento di Cattaneo) malgrado le crisi e le difficoltà è ancora vivo. Sta ai milanesi, di nascita e non, rilanciarlo. Questo è il significato, a mio avviso, della presenza di Napolitano a Milano. s a debellare grazie al solido ancoraggio della Costituzione e grazie alla forza di molteplici forme di partecipazione sociale e politica democratica; risorse sulle quali sempre fa affidamento la lotta contro l’ancora devastante fenomeno della criminalità organizzata. In tutte quelle circostanze, ha operato, e ha deciso a favore del successo, un forte cemento unitario, impensabile senza identità nazionale condivisa. Fattori determinanti di questa nostra identità italiana sono la lingua e la cultura, il patrimonio storico-artistico e storico-naturale: bisognerebbe non dimenticarsene mai, è lì forse il principale segreto dell’attrazione e simpatia che l’Italia suscita nel mondo. E parlo di espressioni della cultura e dell’arte italiana anche in tempi recenti : basti citare il rilancio nei diversi continenti della nostra grande, peculiare tradizione musicale, o il contributo del migliore cinema italiano nel rappresentare la realtà e trasmettere l’immagine, ovunque, del nostro paese. Ma dell’identità nazionale è innanzitutto componente primaria il senso di patria, l’amor di patria emerso e riemerso tra gli italiani attraverso vicende anche laceranti e fuorvianti. Aver riscoperto - dopo il fascismo - quel valore e farsene banditori non può esser confuso con qualsiasi cedimento al nazionalismo. Abbiamo conosciuto i guasti e pagato i costi della boria nazionalistica, delle pretese aggressive verso altri popoli e delle degenerazioni razzistiche. Ma ce ne siamo liberati, così come se ne sono liberati tutti i paesi e i popoli unitisi in un’Europa senza frontiere, in un’Europa di pace e cooperazione. E dunque nessun impaccio è giustificabile, nessun impaccio può trattenerci dal manifestare - lo dobbiamo anche a quanti con la bandiera tricolore operano e rischiano la vita nelle missioni internazionali - la nostra fierezza nazionale, il nostro attaccamento alla patria italiana, per tutto quel che di nobile e vitale la nostra nazione ha espresso nel corso della sua lunga storia. E potremo tanto meglio manifestare la nostra fierezza nazionale, quanto più ciascuno di noi saprà mostrare umiltà nell’assolvere i propri doveri pubblici, nel servire ad ogni livello lo Stato e i cittadini. Infine, non ha nulla di riduttivo il legare patriottismo e Costituzione, come feci in quest’Aula in occasione del 60° anniversario della Carta del 1948. Una Carta che rappresenta tuttora la valida base del nostro vivere comune, offrendo - insieme con un ordinamento riformabile attraverso sforzi condivisi - un corpo di principii e di valori in cui tutti possono riconoscersi perché essi rendono tangibile e feconda, aprendola al futuro, l’idea di patria e segnano il grande quadro regolatore delle libere battaglie e competizioni politiche, sociali e civili. Valgano dunque le celebrazioni del Centocinquantenario a diffondere e approfondire tra gli italiani il senso della missione e dell’unità nazionale: come appare tanto più necessario quanto più lucidamente guardiamo al mondo che ci circonda, con le sue promesse di futuro migliore e più giusto e con le sue tante incognite, anche quelle misteriose e terribili che ci riserva la natura. Reggeremo - in questo gran mare aperto - alle prove che ci attendono, come abbiamo fatto in momenti cruciali del passato, perché disponiamo anche oggi di grandi riserve di risorse umane e morali. Ma ci riusciremo ad una condizione: che operi nuovamente un forte cemento nazionale unitario, non eroso e dissolto da cieche partigianerie, da perdite diffuse del senso del limite e della responsabilità. Non so quando e come ciò accadrà ; confido che accada ; convinciamoci tutti, nel profondo, che questa è ormai la condizione della salvezza comune, del comune progresso. s Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano CRITICAsociale ■ 7 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia DOCUMENTO ■ DISCORSO DI FILIPPO TURATI AL CONGRESSO DI LIVORNO (19 GENNAIO 1921) SOCIALISMO E COMUNISMO PRESIDENTE (Argentinn Altobelli): Ed ora la parola è a Filippo Turati per la sua annunziata dichiarazione. (Mentre l’on. Turati muove verso la tribuna degli oratori, tre quinti dei congressisti scattano in piedi prorompendo in un vivissimo applauso. Qualche voce isolata grida: Viva la Russia!; ma più numerose sono le grida di: Viva il Socialismo!. Turati appare alla tribuna e gli applausi non cessano ancora. Ristabilito alfine il silenzio, egli può incominciare il suo discorso). Testamento e fatto personale TURATI: Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale C ompagni amici e compagni avversari (non voglio, non debbo dire nemici). A Bologna un anno fa, in un discorso che fu molto contrastato, che forse ebbe tuttavia qualche conferma dalle vicende dei fatti, io vi pregavo di accogliere le mie parole come un testamento. Senza avere la presunzione di aggiungere lugubre solennità alle mie parole, non debbo farvi oggi diversa dichiarazione. E più che mai anzi debbo ringraziare il Partito ed il Congresso che mi hanno lasciato un altro anno di vita. E’ stato un po’ il mio destino di essere sempre l’imputato davanti a questo o a quel tribunale di guerra. Ma un tribunale che non mi uccide di schianto, che mi lascia ancora qualche respiro, è un tribunale mite… al quale si può essere ancora grati. (ilarità). Perciò invoco dalla vostra cortesia una benevola attenzione. Non avete interesse ad interrompermi. Non lo hanno specialmente quei compagni che più desiderano condannarmi: costoro hanno tutto l’interesse – perché la condanna abbia apparenza di giustizia – di ascoltarmi. Anche se una mia parola fosse mal detta, male intesa, non si dimentichi che è lontana da me ogni intenzione meno che corretta. Se voi non mi interromperete, io vi ruberò poco più di mezz’ora. Non varrebbe la pena di un lungo discorso, né per fatto personale, né per dichiarazione di voto: non per fatto personale perché, sebbene in un certo senso tutto questo congresso sia un po’ anche il mio processo (anzi doveva essere un processo speciale che forse la angustia del tempo non farà celebrare con tutti i riti) tuttavia debbo constatare che gli stessi oratori che mi hanno accusato mi hanno, nello stesso tempo, anche difeso. E poi consentitemi questo orgoglio testamentario ed innocuo: nel profondo del cuore essi hanno sentito che la mia difesa personale, più che nelle mie parole, è in me stesso. Perciò io non avvilirò il congresso, occupandolo, tanto meno in quest’ora, in minuzie che interessino il mio amor proprio personale. Che io abbia usato in scritti o discorsi, in una occasione o in un’altra, frasi più o meno opportune, che io sia caduto o no in qualche infortunio sul lavoro (io dico di no, e rivendico questi pretesi infortuni come il documento della mia sincerità e dei servigi da me resi al partito): tutto ciò ha poca importanza o prova solo che io ho lavorato (commenti). Gli infortuni sul lavoro non avvengono ai critici inerti, a coloro che non si prestano alla rude fatica… (Voci, Bene, bravo!…). Tutto questo – ripeto – ha una ben misera importanza per chi non si crei, negli uomini, degli idoli, dei feticci personali. Se il nostro partito è un partito di classe, se la nostra azione è azione di storia, gli errori (fossero pure) di un uomo non possono scalfirne che l’epidermide. Amici, abbattiamo tutti gli idoli e tutte le idolatrie, ed anche quella idolatria alla rovescia, che consiste nel sopravalutare il danno di frasi e di atti di Tizio o di Caio, di Turati o di Serrati, o fosse pure di Marx e di Lenin (commenti). La forza del Partito non è in determinati uomini, ma nella coscienza del gran numero dei suoi componenti. Alla pattumiera dunque tutte queste quisquilie e leviamoci più alto, molto al di sopra delle persone (approvazioni vivissime). Per dichiarazione di voto. La mozione di Reggio Emilia e l’unità del Partito Né esige un lungo discorso la mia dichiarazione di voto. Nel discorso di Baldesi e di Vaciren, in quello stesso di Lazzaro (che – a dir vero – mi ha trattato un po’ maluccio, al quale però sono grato per avere nelle sue parole sentito pulsare quel senno di profonda umanità che si direbbe inaridito nei teoremi e filosotemi dei teorici nuovo stile), c’era quanto bastava per la nostra difesa dottrinale. C’era in questi discorsi quanto bastava per persuadere quelli che potevano essere persuasi per farli dubitare e pensare. Quanto a quelli che hanno un velo settario sulla mente, per questi vani sono i discorsi. Bisognerà che la evoluzione degli spiriti avvenga spontaneamente, senza forzarli e senza violentarli; e l’evoluzione degli spiriti è senza dubbio in cammino… (commenti vivissimi). Non vi offendete se dico bene di voi dichia- rando che, negli stessi discorsi dei compagni avversari, di quelli che più sono prigionieri di se stessi e della loro tesi di ieri, ho trovato la prova che questa evoluzione è rapidamente in cammino. Quanta differenza fra le avventate previsioni di Bologna e i cauti discorsi degli estremisti e massimalisti di questo congresso! (commenti, rumori. Una voce: Serrati!). TURATI: Non faccio personalità; parlo in generale. Voi non ve ne avvedete, ed è naturale. Ma voi correte verso di noi con la velocità di un treno lampo. Quando la mentalità di guerra (che non è colpa di nessuno) sarà evaporata, quando quella che, con frase felice, Serrati chiamava il socialismo e la psicologia dei combattenti, sarà esaurita, permettendo la riflessione sulle esperienze fatte; allora io credo che l’unità del Partito, una unità più organica e più vera, tornerà a trionfare. Ecco perché pure constatando i dissensi che non giova coprire ed attenuare, ma che giova invece denudare ed analizzare – poiché la critica è necessaria alla vita ed al pensiero dei partiti -, ecco perché noi siamo o rimarremo fermamente unitari. Ecco perché lo stesso, che passo per essere il più destro dei destri, io stesso mi unisco con tutto il cuore alla mozione votata a Reggio Emilia, che vi sarà ripresentata qui, malgrado certe concessioni, certe transazioni, certe – vogliamo dirlo – ambiguità che essa contiene, dovute ad un onesto opportunismo di partito, al desiderio cioè di venire incontro a tutti i compagni, per realizzare con essi una salda e reale unità. (approvazioni, commenti). Nella dottrina: Socialismo e Comunismo Compagni! Non toccherò che due note in questo breve discorso: la nota dottrina e la nota pratica. Sul terreno dottrinale io rivendico sommariamente il mio ed il nostro diritto di cittadinanza nel Socialismo, che è il nostro Comunismo, che non è il socialismo comunista o il comunismo socialista, perché in queste denominazioni, artificiose e ibride, effettivamente l’aggettivo scredita il sostantivo ed il sostantivo rinnega l’aggettivo. Il Comunismo ebbe due sensi nella storia del movimento dei lavoratori: o fu il comunismo critico di Marx e di Engels, contrapposto, per ragioni tutte tedesche e transeunte, ai vari falsi socialismi (feudale, filantropico, ecc.), antirivoluzionari tutti, che sono stati superati da un pezzo, ovunque; - oppure fu il comunismo ideologico nelle previsioni della futura società, il quale al concetto del collettivismo (a ciascuno secondo il suo lavoro, salvo – s’intende – i diritti di assistenza per gli invalidi, per i vecchi, per i bimbi), opponeva come fase successiva il concetto più ampio; “a ciascuno secondo i suoi bisogni”, concetto questo applicabile solo ad una società progredita, in cui sia abbondanza di prodotti. Successioni di fasi, dunque anziché opposizione di concetti e di sistemi. Compagni! Questo Comunismo, che si chiama poi Socialismo, può anche espellermi dalle file del Partito, ma non mi espellerà mai da se stesso, perché francamente, compagni (attribuitelo al privilegio dell’anzianità, non ad un nostro merito personale), questo Socialismo, questo Comunismo non solo lo avevamo imparato fino dalla giovinezza, ma lo abbiamo in Italia da lunghi anni, insegnato alle masse e ai partiti d’avanguardia, quando questi l’ignoravano, quando lo temevano, lo sospettavano, lo avversarono. E’ così che io, con altri pochissimi, in un tempo che i giovani non possono ricordare, abbiamo portato nelle lotte proletarie italiane le finalità supreme del Socialismo: la conquista del potere da parte della classe proletaria, costituita in partito indipendente di classe. Questa conquista del potere che Terracini enunciava come un punto di distinzione fra la sua e la mia frazione, fra il programma antico e il programma nuovo, che egli confessò essere tuttavia in faticosa elaborazione è, da 30 anni ormai, il glorioso programma del partito socialista (approvazioni, commenti). Io posso perciò amichevolmente sorridere di queste novità e di queste pretese scoperte, che furono l’anima della nostra vita da quando incominciammo a pensare (approvazione. Quel che veramente ci distingue Ma non è questo che ci distingue oggi. Ciò che ci distingue non è la generale ideologia socialista – la questione del fine e neppure dei grandi mezzi (lotta di classe, conquista del potere, etc.) -; ma è la valutazione della maturità della situazione e lo apprezzamento del valore di alcuni mezzi episodici. Primi fra questi la violenza che per noi non è e non può essere programma, che alcuni accettano pienamente e vogliono organizzare (comunisti), altri accettano soltanto a metà (unitari comunisti o viceversa). Altro segno di distinzione è la dittatura del proletariato, che per noi, o è dittatura di minoranza, ed è dispotismo che genererà naturalmente la vittoriosa controrivoluzione, od è di maggioranza, ed è un non senso, è una contraddizione in termini, poiché la maggioranza è la sovranità legittima, non può essere la dittatura. 8 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia Terzo punto di dissenso è la coercizione del pensiero, la persecuzione, nell’interno del Partito, dell’eresia, che fu l’origine ed è la vita stessa del Partito, la grande sua forza salvatrice e rinnovatrice, la garanzia che esso possa lottare contro le forze materiali e morali che gli si parano di contro. Ora tutti e tre questi concetti si risolvono poi sempre in uno solo: nel culto della violenza, sia esterna od interna, e hanno un solo presupposto, nel quale è il vero e maggiore punto di divergenza fra noi: la illusione che la rivoluzione sia il fatto volontario di un giorno o di un mese, sia l’improvviso calare di uno scenario o l’alzarsi di un sipario, sia il fatto di un domani o di un post-domani del calendario; mentre la rivoluzione sociale non è un fatto di un giorno o di un mese, è il fatto di oggi, di ieri, il fatto di sempre, che esce dalle viscere stesse della socialità capitalista di cui noi creiamo soltanto la consapevolezza, e così ne agevolano l’avvento; mentre nella rivoluzione ci siamo, e matura nei decenni, e trionferà tanto più presto, quanto meno lo sfoggio della violenza, provocando prove premature e suscitando reazioni trionfanti, ne devierà il cammino. Ond’è che per noi gli scorcioni sono sempre la via più lunga, e la via creduta più lunga è stata e sarà sempre la più breve. La evoluzione si confonde nella rivoluzione, è la rivoluzione stessa, senza sperperi di forze, senza delusioni, senza ritorni. Ed ecco perché il concetto lumeggiato dal compagno Serrati, secondo cui, in omaggio alla disciplina (la quale, ragionevolmente intesa, noi accettiamo senza riserve e senza ipocrisie), noi dovremmo, più di ieri, sottometterci ed appartarci, questo concetto deve essere inteso con molto grano di sale, al pari della formula stereotipa della libertà del pensiero e della critica combinata con la disciplina nell’azione (commenti), ma quando, in un Partito come il nostro, incomincia l’azione? Quando finisce? Per chi crede al momento traumaturgico del trapasso, l’azione è di un momento: e allora si capisce la sottomissione, l’appartarsi di chi non può cooperare. Ma se l’azione è nei decenni, ma se la rivoluzione non è il fatto di un istante, ma il tratto di una lente è faticosa conquista, allora, compagno Serrati, chi si sottomettesse sistematicamente e rinunziasse per un tempo indefinito alla parola e dal pensiero, evidentemente rinnegherebbe se stesso; e voi non avete nessun interesse ad avere dei rinnegati tra voi (approvazione). Sarebbe questo il maggiore tradimento che, per ipocrisia, per vanità o per utile personale, si possa fare al partito. Il socialismo e la violenza Questo culto della violenza, che è negli incunaboli di tutti i partiti nuovi, che è strascico di vecchie mentalità che il Socialismo marxista ha disperse, della vecchia mentalità insurrezionista e blanquista, che a più riprese sembra tramontata e risorge di nuovo, che la guerra ha rinfrescato e rinvigorito; non può essere di fronte alla complessità della lotta sociale moderna, che una recrudescenza morbosa ed effimera. La violenza è del capitalismo, non del socialismo. E’ delle minoranze che intendono imporsi e schiacciare le maggioranze, non delle maggioranze che vogliono e possono, con le armi intellettuali, imporsi per legittimo diritto. La violenza è il contrapposto della forza; è segno di poca fede nelle idee proprie, di paura delle idee altrui; è il rinnegamento delle idee proprie, e tale rimane anche se trionfi per un’ora, poiché apre inevitabilmente la strada alla reazione della insopprimibile libertà della coscienza umana, che diventa controrivoluzione, che diventa vittoria e vendetta dei comuni nemici. Questo avviene sempre nella storia. Anche il Cristianesimo era un’idea immensa, una grande forza, ma si afflosciò, si deformò, tradì se stessa quando volle appoggiarsi ai troni, ai soldati ed ai roghi (applausi). Con la violenza che desta la reazione, metterete il mondo intero contro di voi. Questo è il nostro pensiero di oggi, di ieri, di sempre, ma soprattutto in periodo di suffragio universale; quando voi tutto potrete se avete coscienza, e se no, nulla potrete in ogni modo. Perché voi siete il numero, siete il lavoro, e sarete i dominatori del mondo, se non metterete, con la violenza, il mondo contro di voi. Ecco il fondo del solo nostro dissenso, che è di oggi come di ieri, di sempre. E quando Terracini ci dice, per coglierci in fallo: getti la pietra chi in qualche momento non fece appello alle violenze più pazze; io posso rispondergli francamente: eccomi qua! Questa pietra io posso lanciarla (applausi vivissimi). Purtroppo a noi, può dolere che questa mostruosa fioritura di guerra ci divida, ci allontani dalla meta, ci faccia perdere anni preziosi, facendo involontariamente il massimo tradimento al proletariato, privandolo di conquiste e di vantaggi enormi, e sacrificandolo alle nostre La violenza e il vero marxismo Noi siamo, come voi, figli del “Manifesto” del ’48. Soltanto che noi, pur sentendoci figli di quel “Manifesto”, non lo seguiamo come un sistema che si elevi a dogma religioso, ma criticamente, integrato da oltre sessant’anni di esperienza, corretto e perfezionato, come fu dai suoi stessi autori e dai loro interpreti più autorizzati. Io citai, a Bologna, la celebre prefazione a Le lotte di classe in Francia di Marx, scritta dopo un cinquantennio, nel 1895, dal suo collaboratore e continuatore più fedele, Federico Engels; nella quale è come il coronamento di tutta l’idea marxista. Dopo aver lamentato l’enorme salasso di sangue e di forza che l’esperimento della Comune parigina aveva costato, onde si ebbe in Francia per parecchi decenni l’anemia e l’arresto del movimento proletario; dopo aver dimostrato come la tattica rivoluzionaria abbia dovuto subire una profonda mutazione per effetto delle conquiste del suffragio universale, e chiarito come la violenza, che del resto anche nelle rivoluzioni del passato ebbe una parte assai più superficiale e apparente che profonda e reale, sia diventata oggi, per tante ragioni, anche tecniche, il suicidio del proletariato, mentre la legalità è divisioni ed alle nostre impazienze, suscitando tutte le forze della controrivoluzione. Sì, noi lottiamo oggi troppo contro noi stessi, lavoriamo troppo spesso per i nostri nemici, creiamo noi la reazione, il fascismo, ed il partito popolare. Intimidendo ed intimorendo oltre misura, proclamando (una suprema ingenuità anche noi comunisti) l’organizzazione dell’azione illegale, vuotando di ogni contenuto l’azione parlamentare che non è l’azione di pochi uomini, ma dovrebbe essere, col suffragio universale, la più alta efflorescenza di tutta l’azione, prima di un partito, poi di una classe; noi scateniamo le forze avversarie che le delusioni della guerra avevano abbattuto, che noi avremmo potuto facilmente debellare per sempre. E, cari amici, non vi sarà sempre possibile ripararvi sotto il vecchio ombrello Turati (ilarità vivacissima). Ma conviene rassegnarsi al destino. Le vie della storia non sono facili: il nostro dovere è quello di cercare di illuminarle, adeguando popolarità, evitando le formule ambigue. E questo noi facciamo e faremo, o con voi e fra voi, o separati da voi, perché è il nostro preciso dovere. Noi saremo sempre col Proletariato che combatte la sua lotta di classe. Questo è l’imperativo categorico della nostra coscienza. la sua forza e la sua vittoria sicura; “comprende ora il lettore – egli chiedeva – per qual motivo le classi dominanti ci vogliono ad ogni costo trascinare colà dove spara il fucile e fende la sciabola? Perché ci si accusa oggi di vigliaccheria, quando non scendiamo nelle strade, dove siamo in precedenza sicuri della sconfitta? E perché con tanta insistenza si invoca da noi che abbiamo una buona volta da prestarci alla parte di carne da cannone? Eh! no: non siamo così grulli!” Evidentemente il povero Engels peccava un tantino di presunzione, e – almeno in quest’ultima frase – non prevedeva con esattezza l’avvenire! Ma già in molte delle monografie precedenti, in quelle magnifiche monografie che sono come il compimento e il saggio di applicazione delle teorie astratte, Marx, su questo tema della violenza, aveva corretto abbondantemente il suo pensiero del 1848. Baldesi vi ha citato un suo discorso del ’74 ad Amsterdam. Io vi rammenterò le prefazioni alle varie successive edizioni e traduzioni del “Manifesto”, nelle quali i due autori confessano apertamente di essersi ingannati allora nell’aver sopravalutato le forze rivoluzionarie proletarie (sono del resto le illusioni di tutti i giovani e di tutti i par- titi giovani, e per Marx erano state concessioni inevitabili allo spirito blanquista dei tempi), e nelle quali si ride delle congiure e della azione illegale sistematizzata. Potrei ricordarvi ugualmente quel brano de “La guerra civile in Francia nel 1870-71”, in cui afferma che anche dalla Comune i lavoratori non potevano aspettarsi dei miracoli: “essi sapevano che, per realizzare la loro emancipazione e raggiungere così quelle forme superiori a cui tende la società moderna con tutte le sue forze economiche, essi avrebbero da sostenere delle lunghe lotte e attraversare una serie di fasi storiche, che trasformerebbe le circostanze e gli uomini. Essi non avevano da realizzare l’ideale: dovevano soltanto sviluppare gli elementi di un nuovo mondo che la vecchia società in dissoluzione racchiude nel suo seno”. E rideva, verso la fine dello scritto – già fin dal 1872 – dello spirito poliziesco dei borghesi, che si figura “l’associazione internazionale dei lavoratori che agisce alla maniera di un’associazione segreta, come un Comitato centrale il quale ordina a quando a quando delle esplosioni nei diversi Paesi”. Acquistate nell’atrio del teatro l’opuscolo postumo di Engels, edito da Edoardo Bernstein, I fondamenti del comunismo, e vedrete, alle pagine 15 e 19, quel ch’egli scriveva circa la inutilità, anzi i danni dell’azione illegale, circa la gradualità inevitabile della trasformazione economica e l’impossibilità di abolire la proprietà privata prima che sia creata la necessaria quantità dei mezzi di produzione, e circa la necessità, per l’esercito proletario, di proseguire ancora per molti anni, “con lotta dura e tenace da una conquista all’altra”. Potrei moltiplicare le citazioni dalle fonti, ma non è, purtroppo, con dieci o cento citazioni che muterò l’abito mentale dei dissenzienti pertinaci. Bastino le poche che ho fatte, per i compagni di buona fede, a dimostrare almeno da qual parte siano i vari credi del vero marxismo e che cosa debba pensarsi – alla stregua del esso – del bergsonismo sociale, del socialismo generato dalla carestia, e di tutte le altre decrepite novità che ci vengono oggi ammannite dall’estremismo che si dice comunista. Fu unicamente il culto di alcune frasi isolate dal comizio (“la violenza lavoratrice della nuova storia” e somiglianti), avulse dal complesso dei testi, e ripetute per accidia intellettuale, che, in unione alle naturali ribellioni del sentimento, velò a troppi di noi il fondo e la realtà della dottrina marxista. Quel culto delle frasi, in odio al quale il Marx amava ripetere che egli, per esempio, “non era marxista”, e anche a me – di cento cubiti più piccolo – a udire le scemenze di certi pappagalli, accadde di affermare che io non sono turatiano (ilarità). Perché nessuna formula – neanche quella di Mosca – sostituirà mai il possesso di un cervello, che, in contatto coi fatti e con le esperienze, ha il dovere di funzionare. La violenza nella storia del socialismo italiano. Una facile profezia E vengo alla nota pratica della mia dichiarazione, nella quale mi sarà concesso di essere anche più breve. Sul terreno pratico, quarant’anni o poco meno di propaganda e di milizia mi autorizzano ad esprimervi sommariamente un’altra convinzione. Potrei chiamarla (se la parola non fosse un po’ ridicola) una profezia, facile profezia e per me di assoluta certezza. Vi esorto a prenderne nota. Fra qualche anno – io non sarò forse più a questo mondo – voi constaterete se la profezia si sia avverata. Se avrò fallito, sarete voi i trionfatori. Questo culto della violenza, violenza esterna od interna, violenza fisica o violenza morale – CRITICAsociale ■ 9 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia perché vi è una violenza morale, che pretende sforzare le mentalità, far camminare il mondo sulla testa (Marx come sapete, correggendo Hegel, lo rimise sui suoi propri piedi), e che è ugualmente antipedagogica e contraria allo scopo – non è nuovo, già lo dissi, nella storia del socialismo italiano, come di altri Paesi. Ed il comunismo critico di Marx e di Engels ne fu appunto la più gagliarda negazione. Ma, per fermarci all’arretrata Italia, che, come stadio di evoluzione economica, sia, a un dipresso, di mezzo tra la Russia e la Germania, la storia dei nostri Congressi, che riassume in qualche modo le fasi del Partito, storia (sorridete pure del mio consiglio!) che fareste bene a leggere negli articoli pubblicati nella Nuova Antologia del 1 e del 16 dicembre da un nostro avversario – onesto e di non comune dottrina e di assoluta obiettività – intendo l’on. Meda, Ministro del Tesoro; quella storia dimostra a chiare note come cotesta lotta fra il culto della violenza che pretende di imporsi col miracolo ed il vero socialismo che lo combatte, è stata sempre, nelle più diverse forme, a seconda dei momenti e delle circostanze, il dramma intimo e costante del partito socialista. Ma il socialismo, in definitiva, fu sempre il trionfatore contro tutte le sue deviazioni e caricature. Non è da oggi che noi siamo i social-traditori. Lo fummo sempre: all’epoca degli inizi, all’epoca degli scioperi generali politici, degli scioperi economici a ripetizione, eccetera, eccetera. (Voce: Bravo! Viva la sincerità!) TURATI: Sissignori! Il “Partito operaio”, nel decennio 1880-90, era già una reazione al corporativismo operaio. E noi, che volevamo farne un partito politico, eravamo guardati con sospetto. Nel 1891-92 il Partito operaio si allargava in Partito dei lavoratori (che s’inspirava a un concetto già più ampio, in quanto abbracciava anche i lavoratori del cervello) e più tardi, a Reggio Emilia (1893), in “Partito socialista dei lavoratori italiani”, per diventare finalmente a Parma, nel 1895, sotto i colpi della reazione più dura, il “Partito socialista italiano”. Queste trasformazioni del nome esprimono appunto il concetto della conquista del potere, che noi introducevamo man mano nel programma che il partito aveva tracciato, ai suoi inizi, programma di azione diretta, una specie di presoviettismo dell’epoca. Nel 1892 (Genova) esso culminò nella violenta separazione dagli anarchici. Ma non per ragioni ideologiche di pura filosofia. Forse che dagli anarchici ci divideva la diversa concezione di quello che dovrà essere la società futura? Ma neppure per sogno! Per un avvenire lontano noi tutti possiamo anche professarci anarchici, perché l’ideale anarchico rappresenta – tecnicamente – un superlativo di perfezione. Quel che ci divideva era l’impazienza, la violenza, la improvvisazione, il semplicismo dell’azione. Molti anarchici, tutti riflessivi dell’esperienza e degli anni, ritornarono poi nelle nostre file. Sono note le vicende dal 1891 al 1898. Nel 1904 imperversò il sindacalismo, coi primi grandi scioperi generali, col labriolismo, con lo sciopero agrario di Parma: era il soviettismo italiano di quel tempo, e fu debellato al Congresso di Firenze nel 1908. Oscillazioni, ritorni, transazioni, ce ne furono a josa. Venne poi il ferrismo, ossia il rivoluzionarismo verbale, ossia proprio quello, mutatis murandis, che è oggi il graziadeismo (Ilarità); e venne la transazione integralista dell’ottimo Morgari, che durò appena un paio di anni sui palcoscenici dei nostri comizi (Vivissime interruzioni). TURATI – Non pretenderete mica, spero, che io dica le opinioni vostre. Vi esprimo francamente le mie. Venne dunque l’integralismo, che, a dir vero, in quel momento salvò il Partito (onde noi lo accettammo come un meno peggio al Congresso di Firenze) e che fu l’anticipazione dell’odierno Serratismo, del comunismo unitario, del socialismo comunista, di quel socialismo che sta un po’ di qua e un po’ di là, sia pure per amore dell’unità, ma che reca nel proprio seno la contraddizione insanabile (applausi dei comunisti puri). Sono perfino gli stessi tipi antropologici e somatologici che rinascono e si presentano. La guerra ha ridato una giovinezza perfino all’anarchismo, che ha oggi in Italia un proprio giornale quotidiano. Ebbene, nella storia del nostro partito l’anarchismo fu rintuzzato, il labriolismo… finì al potere, il ferrismo, anticpazione, come ho detto, del graziadeismo (nuova ilarità), fece le capriole che sapete, l’integralismo stesso sparì e rimase il nucleo vitale: il marcio riformismo, secondo alcuni, il socialismo, secondo noi, il solo vero, immortale, invincibile socialismo, che tesse la sua tela ogni giorno, che non fa sperare miracoli, che crea coscienze, Sindacati, Cooperative, conquista leggi sociali utili al proletariato, sviluppa la cultura popolare (senza la quale saremo sempre a questi ferri e la demagogia sarà sempre in auge), si impossessa dei Comuni, del Parlamento, e che, esso solo, lentamente ma sicuramente, crea la maturità di. (Dico, anzi, che noi ci siamo già; non si tratta che di saper valersene e di avanzare). Avrete allora inteso appieno il fenomeno russo, che è uno dei più grandi fatti della storia, ma di cui voi farneticate la riproduzione meccanica e mimetistica, che è storicamente e psicologicamente impossibile, e, se possibile fosse, ci ricondurrebbe al Medioevo. Avrete capito allora, intelligenti come siete (ilarità), che la forza del bolscevismo russo è nel peculiare nazionalismo che vi sta sotto, nazionalismo che del resto avrà una grande influenza nella storia del mondo, come opposizione ai congiurati imperialismi dell’Intesa e dell’America, ma che è pur sempre una forma di imperialismo. Questo bolscevismo, oggi – messo al muro di trasformarsi o perire – si aggrappa a noi furiosamente, a costo di dividerci, di annullarci, di sbriciolarci; s’ingegna di creare una nuova Internazionale pur che sia, fuori dell’Internazionale e contro una parte di essa, per salvarsi o per prolungare almeno la propria travagliata esistenza; ed è naturale, e non comprendo come Serrati se ne meravigli e se ne sdegni, che essa domandi a noi, per necessità della propria vita, anzi della vita del proprio governo, a noi che ci siamo fatti così supini, e della classe, la maturità degli animi e delle cose, prepara lo Stato di domani, e gli uomini capaci di manovrarne il timone. Sempre social-traditori ad un modo, e sempre vincitori alla fine. La guerra dove rincrudire il fenomeno. La lotta sarà più dura, più tenace e più lunga, ma la vittoria è sicura anche questa volta. che preferiamo essere strumenti anziché critici, per quanto fraterni, ciò che non oserà mai domandare al socialismo francese né a quello di alcun altro paese civile. Ma noi non possiamo seguirlo ciecamente, perché diventeremmo per l’appunto lo strumento di un imperialismo eminentemente orientale, in opposizione al ricostituirsi della Internazionale più civile e più evoluta, l’Internazionale di tutti i popoli, l’Internazionale definitiva. Tutte queste cose voi capirete fra breve e allora il programma, che state (come confessaste) faticosamente elaborando e che tuttavia ci vorreste imporre, vi si modificherà fra le mani e non sarà più che il nostro vecchio programma… Bolscevismo e Internazionale Fra qualche anno il mito russo, che avete il torto di confondere con la rivoluzione russa, alla quale io applaudo con tutto il cuore… (Voce: Viva la Russia!) TURATI, continuando: … il mito russo sarà evaporato ed il bolscevismo attuale o sarà caduto o si sarà trasformato. Sotto le lezioni dell’esperienza (e speriamo che all’Italia siano risparmiate le sanguinose giornate d’Ungheria, verso cui la si spinse inconsapevolmente) le vostre affermazioni d’oggi saranno da voi stessi abbandonate, i Consigli degli operai e dei contadini (e perché no dei soldati?) avranno ceduto il passo a quel grande Parlamento proletario, nel quale si riassumono tutte le forze politiche ed economiche del proletariato italiano, al quale si alleerà il proletariato di tutto il mondo. Voi arriverete così al potere per gra- Azione e ricostruzione Il nucleo solido, che rimane di tutte queste cose caduche, è l’azione: l’azione, la quale non è l’illusione, il precipizio, il miracolo, la rivoluzione in un dato giorno, ma è l’abilitazione progressiva, libera, per conquiste successive, obbiettive e subiettive, della maturità proletaria alla gestione sociale. Sindacati, Cooperative, poteri comunali, azione parlamentare, cultura ecc., ecc., tutto ciò è il socialismo che diviene. E, o compagni, non diviene per altre vie. Ancora una volta vi ripeto: ogni scorcione allunga il cammino; la via lunga è anche la più breve… perché è la sola. E l’azione è la grande educatrice e pacificatrice. Essa porta all’unità di fatto, la quale non si crea con le formule e neppure con gli ordini del giorno, per quanto abilmente congegnati, con sapienti dosature farmaceutiche di fraterno opportunismo. Azione prima e dopo la rivoluzione – perché dentro la rivoluzione – perché rivoluzione essa stessa. Azione pacificatrice, unificatrice. Non è un caso che proprio dove più l’azione manca, perché non vi può essere ancora – ad esempio, nel Mezzogiorno – ivi lo estremismo, il miracolismo hanno maggior voga. Non è a caso che, dove la organizzazione è più forte, essi si attenuano e la Confederazione del lavoro è e rimarrà sempre, per sua organica necessità, checché voi tentiate in contrario, col vecchio e vero socialismo. Ond’è, che quand’anche voi aveste impiantato il partito comunista e organizzati i Soviety in Italia, se uscirete salvi dalla reazione che avrete provocata e se vorrete fare qualche cosa che sia veramente rivoluzionario, qualcosa che rimanga come elemento di società nuova, voi sarete forzati, a vostro dispetto – ma lo farete con convinzione, perché siete onesti – a ripercorrere completamente la nostra via, la via dei social-traditori di una volta; e dovrete farlo perché essa è la via del socialismo, che è il solo immortale, il solo nucleo vitale che rimane dopo queste nostre diatribe. E, dovendo fare questa azione graduale, perché tutto il resto è clamore, è sangue, orrore, reazione, delusione: dovendo percorrere questa strada, voi dovrete fino da oggi fare opera di ricostruzione sociale. Io sono qui oggi alla sbarra, dovrei avere le guardie rosse accanto… (si ride) perché, in un discorso pronunziato il 26 giugno alla Camera, Rifare l’Italia! Cercai di sbozzare il programma di ricostruzione sociale del nostro paese. Ebbene, leggetelo quel discorso, che probabilmente non avete letto, ma avete fatto male (Ilarità). Quando lo avrete letto, vedrete che questo capo di imputazione, questo corpo di reato, sarà fra breve il vostro, il comune programma (Approvazioni). Voi temete oggi di ricostruire per la borghesia, preferite di lasciar crollare la casa comune, e fate vostro il “tanto peggio, tanto meglio!” degli anarchici, senza pensare che il “tanto peggio” non dà incremento che alla guardia regia ed al fascismo. (Applausi). Voi non intendete ancora che questa ricostruzione, fatta dal proletariato con criteri proletari, per se stesso e per tutti, sarà il miglior passo, il miglior slancio, il più saldo fondamento per la rivoluzione completa di un giorno. Ed allora, in quella noi trionferemo insieme. Io forse non vedrò quel giorno: troppa gente nuova è venuta che renderà aspra la via, ma non importa. Maggioranza o minoranza non contano. Fortuna di Congressi, fortuna di uomini, tutto ciò è ridicolo di fronte alla necessità della storia. Ciò che conta è la forza operante, quella forza per la quale io vissi e nella cui fede onestamente morrò, eguale sempre a me stesso. Io combattei per essa, io combattei per il suo trionfo: e se trionferà anche con voi, è perché questa forza operante non è altro che il socialismo. Ebbene – conclude con voce rotta dalla commozione Filippo Turati -: Evviva il Socialismo! (Tranne i comunisti secessionisti, tutti i delegati delle altre frazioni ripetono il grido e tributano a Turati ripetute ovazioni, che lo accompagnano mentre egli dalla tribuna si reca nel palco di proscenio a destra, dove lo attendono Treves, Modigliani, D’Aragona, Buozzi, Storchi e molti altri amici. Durante il breve tragitto egli riceve infinite strette di mano ed è più volte abbracciato. I comunisti secessionisti gridano: “Viva la Russia!”). s 10 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia ■ EREDI DEL RISORGIMENTO E DEL MOVIMENTO DEMOCRATICO PER UNA NAZIONE “ANCHE GIUSTA” I SOCIALISTI E IL MITO DI GARIBALDI i cercherebbe invano, scorrendo la “Critica Sociale” del giugno 1892, decennale della morte di Giuseppe Garibaldi, un ricordo dell’Eroe dei Due Mondi, come se i socialisti si fossero ormai lasciati alle spalle la tradizione democratica del Risorgimento. Si era allora alla vigilia della fondazione del Partito socialista e l’intento di Filippo Turati, di Anna Kuliscioff e degli altri promotori di quel progetto, che avrebbe avuto, tra gli altri suoi meriti, anche quello di contribuire in modo significativo all’unificazione politica e culturale del nostro paese, si ponevano l’obbiettivo di segnare nettamente le differenze sul piano programmatico ed organizzativo tra il nuovo partito e la Democrazia radicale e repubblicana, che aveva in Felice Cavallotti il suo massimo esponente. Avevano, nello stesso tempo, il proposito di attrarre verso il socialismo i suoi uomini esponenti più avanzati sui temi sociali. Si trattava di un’operazione indispensabile per garantire al Partito socialista la sua autonomia ed un personale politico adeguato ai suoi compiti, ma estremamente complessa e difficile, poiché il socialismo italiano nasceva sul terreno della democrazia, ne accettava i principi fondamentali, anche se intendeva, naturalmente, conquistare oltre alla democrazia politica anche quella economica, che doveva consistere nella proprietà collettiva dei mezzi di produzione e di scambio. Turati, del resto, al pari di Leonida Bissolati, di Camillo Prampolini e di tanti altri loro coetanei trentacinquenni che costituirono il gruppo dirigente del nuovo partito, se erano nati troppo tardi per poter partecipare alle battaglie del Risorgimento, erano permeati dagli ideali di una patria unita e indipendente, amica degli altri popoli e tendente a costruire una patria più vasta, europea, che venivano loro dal pensiero e dall’azione di Mazzini, di Cattaneo, di Garibaldi. I socialisti della generazione precedente, del resto, erano stati mazziniani e garibaldini e sulla scia di Mazzini e Garibaldi avevano imparato ad associare gli ideali di patria con quelli di redenzione sociale. Quando poi Mazzini aveva preso nettamente le distanze dal socialismo e aveva duramente condannato la Comune di Parigi, Garibaldi, che pure socialista non era, ne aveva preso le difese e aveva poi affermato che l’Internazionale era il Sole dell’avvenire, favorendo così il passaggio di tanti giovani patrioti al socialismo. Essi non rinnegavano la patria, ma volevano che fosse tale veramente per tutti i suoi cittadini, anche per gli operai e i contadini. Credevano poi in una patria più grande, senza confini, ed aderivano quindi all’Internazionale, che si batteva per l’uguaglianza sociale ma anche per l’indipendenza di tutti i popoli. Il movimento operaio era nato in Italia sotto l’egida democratica, di Mazzini e di Garibaldi e si era poi sempre di più avvicinato al socialismo. Moltissime società operaie nominavano Garibaldi loro presidente onorario, considerandolo uno di loro. I socialisti quindi non rinnegavano Garibaldi; al contrario la sua figura e la sua epopea entrava a far parte del loro patrimonio ideale e culturale, senza che vi fosse bisogno di specifiche celebrazioni o rivendicazioni. Nessun socialista, del resto, metteva minimamente in Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale S Maurizio Punzo dubbio che l’unità d’Italia fosse il coronamento di un grande disegno e il punto di partenza di nuovi traguardi politici e sociali. Lo scritto che viene qui ripubblicato risale al giugno 1882. Filippo Turati era allora a Parigi, quando fu raggiunto dalla notizia della morte di Garibaldi. Si trovò così ad assistere alla grande manifestazione che si tenne nella capitale francese in onore dell’eroe italiano. Garibaldi era ben conosciuto ed amato in Francia, non solo per l’epopea delle battaglie combattute prima in America e poi per la liberazione dell’Italia, ma anche per la generosa partecipazione, alla testa delle sue camicie rosse, alla di- fesa della “sorella latina” di fronte al dilagare delle truppe prussiane nel 1870, superando il dolore che gli aveva causato, nel 1859, l’annessione delle sua Nizza alla Francia “La morte di Garibaldi mi fece piangere – erano anni che non piangevo per me”, scrisse Turati all’amico Arcangelo Ghisleri la mattina del 4 giugno. Un particolare che omise nella lettera-articolo, scritto qualche giorno dopo ed inviato alla “Farfalla”, il giornale scapigliato, democratico e repubblicano, cui collaborava e su cui pubblicava molte delle sue poesie. A Parigi si fermò più a lungo del previsto, prima di recarsi a Londra, tappa successiva del suo viaggio, proprio per seguire di persona “la solennità di oggi al Cirque d’Hiver per Garibaldi”, come scriveva, sempre a Ghisleri, il 12. Turati non viaggiava soltanto per diletto, ma era in cerca di una cura che fosse in grado di liberarlo della grave forma di nevrastenia che l’aveva colto quattro anni prima e che influì notevolmente su tutto il periodo della sua giovinezza. La forte reazione emotiva da lui provata nell’apprendere della morte di Garibaldi e poi nell’assistere alla cerimonia parigina in suo onore, non può tuttavia essere spiegata solo dalle sue condizioni psichiche. Per Garibaldi aveva, come molti altri giovani, un’autentica venerazione, poiché rappresentava la conquista dell’indipendenza e dell’unità d’Italia e la fedeltà agli ideali democratici, repubblicani in cui si riconoscevano quei giovani irrequieti, insoddisfatti della politica della Sinistra come di quella della Destra e sempre più interessati alla questione sociale e al socialismo. Legandosi a Arcangelo Ghisleri, repubblicano ma non socialista, e al suo coetaneo e compagno di studi Bissolati, Turati, che. come egli stesso confessò più tardi a Prampolini, era stato monarchico fin circa a vent’anni, aveva iniziato, oltre che di poesia e di letteratura, ad occuparsi di “studi positivi” e proprio nel 1882 apparve a puntate sulla “Plebe” di Enrico Bignami l’importante saggio su Il delitto e la questione sociale. Le sue idee erano dunque notevolmente cambiate, ed erano state notevolmente influenzate da quelle, federaliste e repubblicane, di Ghisleri. Turati, però, pur credendo nel federalismo e nella repubblica, repubblicano non si considerava e non aderì mai alle associazioni repubblicane. Già nel 1878 aveva fatto cenno ad un “socialismo graduale” come proprio ideale e, da allora, il socialismo lo attrasse sempre di più, fino a farlo diventare uno dei maggiori artefici della costruzione e della crescita del partito e quindi dell’affermazione compiuta di un socialismo democratico e riformista. Una tappa importante di questo percorso verso il socialismo fu proprio quel soggiorno parigino. Durante la celebrazioni di Garibaldi conobbe infatti di persona Benoît Malon, uno dei maggiori esponenti del socialismo francese, che aveva grandemente influenzato il pensiero dei socialisti italiani, tra cui Bignami, fornendo loro le armi ideali per resistere all’avanzata dell’internazionalismo anarchico che dilagò nella penisola negli anni Settanta. Turati prese poi le distanze dal pensiero di Malon, ritenendo più matura e utile all’affermazione del movimento operaio l’elaborazione di Marx e di Engels, ma rimase sempre in lui l’impronta di un socialismo fortemente umanistico, quale era stato quello del pensatore francese. Allo stesso tempo Turati non abbandonò CRITICAsociale ■ 11 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia ■ LA COMMOZIONE DI FILIPPO TURATI DURANTE LE ONORANZE PER GARIBALDI DELLA CITTÀ DI PARIGI IN UNA LETTERA ALLA FARFALLA “UN POPOLO ENTUSIASTA MAI SAZIO DI UDIRLO...” C Parigi, domenica 11 giugno. Ma imaginati lʼeffetto che dee produrre in orecchie italiane, uscito a un tratto da diecimila bocche francesi, imaginati i brividi di emozione, i sudori freddi e le vertigini di compiacenza, di gratitudine, di tenerezza che mi scossero tutto, mentre lʼinno garibaldino, il nostro vero e solo inno nazionale, il simbolo di tutta lʼepopea italiana, fu accolto, fu accompagnato, fu coperto dagli hurra! dagli evviva! di tutto questo popolo entusiasta, non mai sazio di udirlo... Ma ci amano dunque davvero! E le rivalità mai gli ideali risorgimentali e anche se non sentì più il bisogno di richiamarsi espressamente a Garibaldi e al Risorgimento, appare evidente come considerasse sempre il socialismo come l’erede dei democratici che avevano combattuto per l’Italia. Ne è una prova lampante il suo comportamento nel corso della Grande Guerra. Egli, contrario come tutti i socialisti all’entrata dell’Italia nel conflitto e convinto dei valori di pace e di fratellanza dell’internazionalismo socialista, fu in prima fila nell’opporsi fin dall’inizio all’idea che i socialisti potessero boicottare la guerra e sostenne che, se l’Italia fosse stata invasa, la difesa del territorio nazionale sarebbe stato dovere comune di tutti i cittadini. Non esitò, quindi, dopo Caporetto, a incitare alla resistenza, come fece del resto nella sua Milano la Giunta Caldara, che fece affiggere sui muri della città un manifesto che ricordava, nei toni e nello spiri- to, le gloriose Cinque Giornate. La stessa politica di “Croce rossa civile” esercitata durante la guerra dalle grandi Amministrazioni socialiste era indubbiamente un’opera patriottica, che non rinnegava la ricerca della pace e l’auspicio di un nuovo ordine mondiale non basato sull’imperialismo, me nello stesso tempo gettava un ponte verso un dopoguerra di riforme ardite e di collaborazione tra tutte le forze politiche e sociali desiderose di rendere migliore quell’Italia, che aveva superato una grande prova ed aveva finalmente completato, con Trento e Trieste, la sua unità. Gli avvenimenti volsero poi in un’altra direzione, e prevalsero lo stolto massimalismo filosovietico e poi la reazione fascista, ma questo nulla toglie alla grandezza e alla nobiltà di quei progetti, che si collocavano nel solco della tradizione democratica e socialista dell’Italia liberale. s Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale arissimo, se avessi tempo e non dovessi fra unʼora partire per lʼInghilterra ti scriverei la descrizione per la Farfalla della festa funebre franco-italiana da cui torno in questo istante. Una cosa grande — ti dico — una cosa smisurata, quale solo Parigi può dare, e che produsse in me la più grandiosa emozione chʼio abbia provato in mia vita. Quante migliaia erano? Non te lo so dire. Era tutta Parigi democratica, era tutta la Francia repubblicana. Ed io là solo, smarrito fra quel monte di teste e di braccia francesi, agitantisi in una tempesta dʼentusiasmo nel nome di Garibaldi, nel nome dʼItalia! Tʼimmagini? Dalla triste mattina che il Figaro mʼapprese la morte dellʼeroe smisurato, uno strano isterismo di malinconia mʼavea preso lʼanima, un sentirmi a disagio in paese straniero, in ambiente ostile, un parermi che gli amici lontani dovessero aver bisogno di me nella sventura che colpiva la patria, come io sentivo di aver bisogno di loro per espandere quel dolore improvviso e che lungi dʼItalia mi riesciva a mille doppi intollerabile. Ho avuto un impeto fanciullesco di torme fra voi: ma lo stesso intontimento in cui ero caduto mi trattenne - inerzia a Parigi. Ricordo che alla posta, quella mattina, al ricevere le lettere consuete, mi trovai dʼaccanto ad alcuni italiani, fra cui una coppia di sposi in viaggio di nozze. Avevo tra mani spiegato il giornale e, senza conoscerli, mostrai loro il telegramma fatale: « È morto Garibaldi! ». Rimasero come istupiditi, increduli, sbigottiti, quasi da un cattivo augurio: corrucciati della loro letizia di sposi novelli su cui quel telegramma spargeva tantʼ ombra. — E in Italia allora?... Anchʼessi parvero sospirare allʼItalia. Ma ora mi applaudo — oh se mi applaudo! — di essere rimasto. La giornata dʼoggi ha dissipato tutte le tristezze. Lʼentusiasmo di Roma, di Milano, non poteva avere rivelazioni per me : non ne può avere per un italiano. Era qui che bisognava essere. Ed era qui che bisognava trascinare oggi le vipere del giornalismo e della politica — i piccoli mettimale che schizzano il veleno dagli odii fra le nazioni sorelle. Che esempio, e che lezione per essi! «Viva lʼItalia» è un grido banale in Italia. dʼAfrica sono bisbeticherie di diplomatici, senza eco nel cuore dei popoli? E la diplomazia dovʼè, e perché non protesta? O vʼè dunque una diplomazia dei popoli mille volte più solenne di quella dei governi! E mentrʼio pensavo queste cose e si acclamava a me dʼintorno alla pace latina, agli stati uniti dʼEuropa, alla fratellanza umana, alla repubblica universale, io mi sentivo orgoglioso e commosso di essere italiano, e di ricevere da un popolo di stranieri una lezione di patriottismo. A un certo punto — non ti narro i discorsi, le bandiere italiane e francesi intrecciate, le coccarde quadricolori in seno alle donne, gli intermezzi piccanti che saprai dai giornali — a un certo punto, dal lato al presidente della festa, Giosuè Carducci si leva per leggere dei versi. Non ridere, proprio lui : la sua capigliatura arruffata, il suo tipo selvaggio, il suo atteggiamento leonino, la sua irrequietezza nervosa. Non riesco a spiegarmi Giosuè Carducci a Parigi, e mi impensierisco sul serio dellʼeffetto che produrrà sullʼuditorio la sua pronuncia incorreggibilmente etrusca — quandʼecco sento mormorare il nome di Clovis Hugues, il simpatico deputato di Marsiglia, il poeta della rivoluzione, e per più dʼun rispetto il Carducci della Francia. Nellʼatrio, a due palmi di distanza, ho poi constatata unʼaltra volta questa strana somiglianza fisica dei due poeti, le cui rassomiglianze intellettuali sono oggi curiosissimo di studiare pili a fondo. Per finire. Da più di quindici giorni calpestavo in lungo e in largo il selciato parigino, interrogandone con amore di touriste le persone e le cose, suscitandone le memorie, raccogliendone le impressioni, eppure, lo dovetti confessare scrivendone allʼamico Pessimista (uno degli pseudonimi di Felice Cameroni) malato lui, poveretto, di nostalgia parigina, finora, anche fra lʼammirazione, qualche cosa rimaneva in me di refrattario, di chiuso alle emozioni che questa grande metropoli ha destato in tanti visitatori. Dovevo confessarmi con non poco dolore del mio amor proprio, inetto a comprendere, a sentire tutto un ordine di grandezze. Lʼentusiasmo che mi desta in cuore ad ogni pie sospinto lo squallido paesaggio delle Alpi, non mʼaveva mai toccato né davanti al Louvre, é davanti allʼarco della Stella. Ero avvilito, ti giuro... Non so che sia. Ma la festa e la commozione di oggi mi pare che abbiano aperto nel mio seno una fontana di sensibilità nuova e più fresca, che abbiano sciolto quel ghiaccio, che mʼabbiano messo nuova lente negli occhi. Mi pare da oggi di capire Parigi! È forse perciò che la abbandono. Mia mamma picchia alla porta dice che è lʼora. s * Da La Farfalla, Milano, 18 giugno 1882. Il titolo era seguito dallʼindicazione (Nostra corrispondenza) 12 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia nche la rappresentazione dell’Unità d’Italia di riecheggia una sindrome antica, mai debellata, quella dei vinti, cioè della Chiesa (e direi dei cattolici non liberali) e dei contadini meridionali. Sull’onda ancora emotivamente sollecitata di questo stato d’animo si arriva a ridurre l’unificazione nazionale alla politica annessionistica della corte dei Savoia (definiti “franco-piemontesi e massoni” con uno stile da suddito-pago-di-sé dello Stato pontificio), e i costi della creazione e del consolidamento dello stato unitario a pura “conquista regia”. Sintetizzando un meno perentorio Banti, da parte di Banfi si è parlato di una sorta di pulizia etnica, in cui Vittorio Emanuele II, Cavour e Mazzini “confiscarono con la violenza, uccisero, giustiziarono, imposero le loro leggi con la forza delle armi”. Come in una camicia di forza, in questa sintesi è segregato il grande afflato europeo, il disegno europeistico, lo spirito universalistico di difesa dell’indipendenza nazionale e dei diritti dei cittadini che fu proprio del nostro liberalismo. Il silenzio su Cavour è, a questo proposito, assai sintomatico al pari della concentrazione del fuoco ritorsivo su Mazzini, che è una figura diversa, cioè a rischio di fanatismo e di nazionalismo. Purtroppo, grazie al clima da guerra civile permanente in cui si di batte la politica attuale, la storia viene letta in maniera unidimensionale. Se ne fa una clava facendo della parzialità un criterio euristico. Ma in questo modo si finisce per proiettare pari pari sul presente il passato. E il giudizio storico, consentitoci dalla distanza di ben 150 anni dagli eventi, finisce per assomigliare a qualcosa come un pregiudizio, un’ideologia dal gagliardo ritorno. Non credo che tanto Banti quanto Banfi vogliano questo. Pertanto, penso converranno con me -che cattolico non sono -su un punto: non si capisce nulla della grande influenza spirituale e quindi del maggior prestigio tra i credenti (e non) che fecero seguito alla spoliazione della Chiesa del potere temporale, né delle basi sociali e morali in cui si innervò il popolarismo di Luigi Sturzo (direi l’accesso dei cattolici alla politica), se non ci rendiamo conto che furono resi possibili dalla cultura politica liberale. I governi postunitari poterono eccedere in un surplus di “punture di spillo” verso i cattolici e soprattutto le loro gerarchie, come rilevò uno scrittore cattolico-liberale come Arturo Carlo Jemolo. Ma i papi, direi il fronte ampio della “resistenza” cattolica al fatto compiuto del 1861, non furono da meno sul versante opposto. Sul dovere dell’educazione dei cittadini/fedeli prevalse la preoccupazione del controllo. Dai sacri palazzi si rese tardiva, lenta e parziale la riconciliazione con i valori universali dello stato di diritto, dell’indipendenza nazionale, della cittadinanza. Furono invece proprio questi ultimi i tratti salienti del liberalismo fiorito tra le due sponde dell’Atlantico. Lì, tra la costituzione francese, quella americana e le varianti nei diversi paesi europei dal Congresso di Vienna in avanti, ebbe origine e prese forma quel mondo moderno che mi pare corretto identificare nell’Europa, nella civiltà cristiana e nel suo principio, la dignitas hominis. Dell’espansione del cristianesimo a Erasmo e Voltaire fino ad oggi, Roberto Vivarelli ci ha dato un quadro esemplare nel saggio I caratteri dell’età contemporanea (Il Mulino, Bologna 2005). Nella prassi politica, cioè nell’azione di governo, il liberalismo non ebbe lo stesso rango e livello che nella teoria. Ma né le reviviscenze neo-borboniche né lamentazioni e deplorazio- ■ MA ANCHE DAL PCI LA LIQUIDAZIONE DELLO SPIRITO LIBERALE DELL’UNITÀ DALLA NAZIONE AL “NAZIONALISMO” COSÌ IL FASCISMO HA STRAVOLTO IL RISORGIMENTO Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale A Salvatore Sechi ni del vecchio mondo cattolico (forse è meglio dire clericale) né le critiche della storiografia marxista (comunista) hanno potuto contestare il quadro che dell’Italia unita ci ha offerto Rosario Romeo, quando ha inquadrato il sottosviluppo meridionale così come il carattere pedagogico (cioè autoritario) con cui venne a lungo declinato il rapporto Stato-cittadini nella prospettiva dell’accumulazione capitalistica per l’industrializzazione e del rafforzamento dello Stato appena nato e quindi da più lati vulnerabile. Il problema storiografico più importante, però, è capire come mai il ceto politico liberale che aveva partecipato al Risorgimento, sia passato, con pochissime eccezioni (penso a Giustino Fortunato, per fare un esempio), al fascismo. Con la sua cultura non avevano nulla o ben poco a che fare Sonnino quanto Salandra, Crispi quanto Giolitti. E per stroncare rivolte e mettere a tacere oppositori e sovversivi (tale fu considerato fino all’ultimo lo stesso Giuseppe Mazzini) non si servirono di milizie private o di squadracce d’azione, come fecero i seguaci di Mussolini, ma dei corpi dello Stato, in nome (che era anche uno schermo) dell’interesse nazionale. Alla fine il fascismo ha imposto al Risorgimento la sua caratura. L’idea di nazione è stata trasformata in nazionalismo. L’idea del “primato morale e civile degli italiani” è stata trasformata in diritto al colonialismo e all’imperialismo, coinvolgendo in questa logica infame anche l’emigrazione che nasceva da un bisogno, quello di sfuggire alla miseria in patria. Attraverso la scuola, i musei, l’edilizia celebrativa, la mobilitazione di un passato magniloquente in funzione del presente, la centralità di Roma, il fascismo prosegue, e si illude di completare, la retorica del Risorgimento sulle origini di esso. È quello che viene chiamata l’invenzione della tradizione. In questo modo si è retrodatato di secoli, facendola risalire a Dante, Petrarca, Machiavelli ecc. la domanda (e la condizione) di unità. Essa è stata invece un valore limitato. Ha coinvolto piccoli gruppi ed élites, pezzi di gruppi dirigenti che invece il fascismo, proseguendo sulla strada della falsificazione della storia e della creazione di miti dei governi postunitari, ha enfatizzato, come se dietro Cavour, Mazzini, Garibaldi ci fossero grandi masse, anzi un intero popolo. Non fu così. L’unità d’Italia fu una costruzione retorica, frutto di un’euforia e tenacia propagandistica ad ampio raggio. Ci si servì di ogni ordine e grado dell’istruzione, dell’addestramento militare, delle feste nazionali, delle ricorrenze per popolarizzare un evento che di popolare ebbe assai poco. La realtà è che per un paese diverso e diviso, nelle tradizioni e nelle culture, la scelta più opportuna sarebbe stata non l’unità, ma il federalismo, un sistema di grandi autonomie per sperimentare nel lungo periodo un altro percorso. Invece del federalismo (Cattaneo fu un vinto del Risorgimento) come collante abbiamo avuto il centralismo e la burocrazia, gli alti comandi militari, la diplomazia ecc. tutta di estrazione piemontese. Ecco perché mi pare difficile dare torto alla cautela, alla sobrietà, al rifiuto di ogni enfatizzazione del passato ad opera della Lega. La Resistenza solo da sprovveduti cantori di partito può essere evocata come Secondo Risorgimento (il termine venne inventato dalla Dc e osteggiato dalle sinistre all’inizio degli anni Cinquanta). Si è arrivati ad abusi come quello di intitolare a eroi del Risorgimento (Pellico, Pisacane, Garibaldi, Mazzini ecc.) brigate partigiane dominate da comunisti disciplinatissimi nell’obbedienza a Mosca. Esse avevano in testa la missione di abbattere il regime fascista, non di continuare l’opera del Ri- sorgimento. L’obiettivo era di “fare come in Russia”, aprendo la strada alla rivoluzione socialista. Insomma sostituire una dittatura di destra con una dittatura di sinistra. Chi voleva riprendere l’opera dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, allievi di Gaetano Salvemini, e completare il Risorgimento combinando libertà e giustizia veniva trattato da Togliatti a metà degli anni Trenta come un comune fascista. Perciò l’avversione prima nei confronti di Giustizia e Libertà e successivamente del Partito d’Azione (che si ispiravano agli ideali del liberalismo risorgimentale, della costituzione americana, e dei socialisti inglesi) fu sempre condita di un’ostilità sprezzante. La lettura della rivista Rinascita offre un panorama emblematico dell’anti-Risorgimento comunista. La data del 1861 fu liquidata come un affare di agrari e industriali, con le masse popolari in ostaggio di un’oligarchia corporativa e di partiti degenerati in “cricche”. Né gli scritti di Gramsci, pur avendo elevato il livello del dibattito storiografico, sono andati mai oltre la considerazione dell’unificazione nazionale come di un’occasione perduta. Chiedo: si può davvero sostenere che il carattere “maltusiano” della base sociale del Risorgimento derivò dalla mancanza di un partito antesignano del Pci che guidasse il processo, e saldasse i contadini al nuovo Stato attraverso una prospettiva rivoluzionaria? Fu, però, attraverso lo schermo del Risorgimento che i comunisti italiani cercarono di definire la propria idea di nazione e di presentarsi come continuatori della principale tradizione nazionale. Si illusero che per diventare interlocutori e possibili partner di una nuova maggioranza bastasse definirsi anti-fascisti dal momento che anche Gramsci, e soprattutto Togliatti, proclamarono che il fascismo fosse il testimone naturale e il legittimo erede delle forze politiche e sociali che avevano animato la vicenda unitaria. Nel mio volume Compagno cittadino (Rubbettino, 2006) ho ampiamente documentato questa caricatura del processo storico e la conseguente riduzione della storiografia a strumento ancillare della manovra politica. G razie al controllo esercitato dalla Dc e in particolare da De Gasperi sul dopoguerra, e soprattutto grazie al rapporto di forza sfavorevole all’Unione Sovietica e ai disegni di Stalin determinatosi dopo l’abbattimento del nazi-fascismo, la psicosi sovietica dei comunisti è stata esorcizzata. Le loro domande radicali sono state parlamentarizzate e imbrigliate nella prassi malsana dell’esercizio dei poteri di veto. La Carta costituzionale ha avuto un carattere assai ambiguo, di compromesso e mediazione, se si esclude la parte programmatica. Proprio questo carattere ha consentito ai governi guidati dalla Dc un’applicazione moderata, ma efficace come quella che ebbe luogo negli anni del centrismo. La polemica del filosofo liberale Norberto Bobbio con Togliatti e altri segretari del Pci per quanto concerne la concezione marxista dello Stato e la confusione tra pluralismo ed egemonia hanno occupato l’intero periodo della guerra fredda e oltre. È quanto basta a mostrare come Togliatti e i suoi eredi non abbiano mai fatto i conti con la tradizione liberale e con quella socialdemocratica. Riconoscerlo equivarrebbe a riconoscere la loro sconfitta. Essa ha un vistoso prolungamento nell’incapacità odierna del Pd di proporre un’alternativa all’attuale coalizione di governo e allo stesso assetto istituzionale che blocca o frena ogni riforma e progetto di cambiamento. s Ordinario di Storia contemporanea Università di Bologna CRITICAsociale ■ 13 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia ■ A OGNI SVOLTA POLITICA, LA MESSA IN STATO D’ACCUSA DELLA PRECEDENTE IDENTITÀ NAZIONALE IL NOVECENTO E IL CASO ITALIANO DEI “PATRIOTTISMI” l “caso italiano” del Patriottismo è quello di una nazione in cui nel corso del Novecento, in ogni dopoguerra, il proprio passato è stato in blocco messo sotto accusa e la Patria precedente è stata processata, condannata e rifiutata con una radicalità che ha originato o ha sfiorato una “guerra civile”. Il Patriottismo italiano filiato dal Risorgimento animando la creazione di uno stato unitario - nel segno di fratellanza e libertà e sulla base di comuni radici passate e aspirazioni future - nel corso di un secolo e mezzo ha quindi conosciuto evoluzioni e diaspore che vedono oggi il Patriottismo nazionale con connotazioni del tutto diverse ed anche contestato o con proposte alternative: dal leghismo separatista al globalismo inclusivista (“mille patrie, mille etnie”). E’ il risultato di una vita nazionale particolarmente conflittuale che ha minato alla base una categoria centrale dell’originario Patriottismo Risorgimentale e cioè “la territorialità” come identità e patria comune, travagliata e contraddetta da un lato dalla “questione meridionale” fino alla “questione settentrionale” (che fanno maledire l’unificazione nazionale come entità matrigna) e dall’altro dalla controversa storia del confine orientale che – al centro delle guerre d’indipendenza e poi della partecipazione ai conflitti “mondiali” – ha vissuto un ingorgo contraddittorio tra irredentismo e autonomismo, esaltazione di identità nazionale e rivendicazione di irriducibile specifico “danubiano” e nostalgie asburgiche. Una impossibile memoria condivisa caratterizza l’Italia descritta da Piero Calamandrei (nel suo “Commentario sistematico alla Costituzione italiana” del 1950) come un Paese “a pareti elastiche e a temperatura variabile”, “destinato a vivere in una prolungata crisi di crescenza e a dilatarsi via via che sopravvengono le esigenze di diverse esperienze”. Al nostro Patriottismo manca un “minimum” di Memoria condivisa perché quella italiana è soprattutto una Memoria traumatizzata da tre dopoguerra non “gioiosi”. Nel primo dopoguerra, all’indomani della “Grande Guerra” è finita sotto processo l’Italia liberale e nel segno della “Vittoria mutilata” se ne è prefigurato il superamento violento poi sfociato nel Fascismo. Nel secondo dopoguerra a finire sotto processo fu sì l’Italia fascista, ma anche, nuovamente, l’Italia liberale e nel segno della “Morte della Patria” che vedeva come principale imputato la monarchia liberal-fascista si dette vita alla Repubblica. Nel terzo dopoguerra, quello della fine della “guerra fredda” dopo la caduta del Muro di Berlino è andata sotto processo l’Italia repubblicana e nel segno di “Tangentopoli” è nata la Seconda Repubblica con alle spalle una generale eccezione d’infamia su tutti i precedenti regimi: repubblicano, fascista e liberale. Abbiamo così avuto una evoluzione del Patriottismo italiano secondo quattro stadi: il Patriottismo Risorgimentale con al centro il Territorio attraverso guerre di unificazione poi venne poi traumaticamente commutato nel Patriottismo Fascista che trasformava la stessa centralità del Territorio sostituendo la categoria della “liberazione” con quella della “conquista” ed al binomio “Nazione e Libertà” preferì il “Impero e Popolo” secondo l’intento di Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale I Ugo Finetti allargare il consenso e di forgiare un nuovo modello italico. Nel terzo stadio, dopo il 1945, abbiamo avuto il Patriottismo Costituzionale, un Patriottismo non più di conquista territoriale, ma pacifista con come categoria centrale i Valori di un antifascismo che non ha tanto difeso un territorio, ma si è soprattutto smacchiato dei regimi passati. Infine, dal 1992, la nascita della Seconda Repubblica ha coinciso con lo sviluppo di un quarto stadio del Patriottismo italiano nel quadro di un contesto di “globalizzazione” inclusiva che ha al centro non il territorio né la condivisione di una storia passata di lotte e ideali, ma la legalità secondo parametri indipendenti dalla identità nazionale. Il passato nazionale è anzi considerato come un “handicap” da ripulire e riscattare portando “questo Paese” a parametri sovranazionali: la Patria come “format” secondo “standard” internazionali, un Patriottismo “politically correct” che è denominato Cittadinanza nazionale. Il Patriottismo Risorgimentale cresciuto come una riunificazione territoriale secondo gli ideali di fratellanza e di libertà fu minato da quattro “eccezioni”. La prima era la autonomia locale che poi prenderà la forma in particolare di “questione meridionale” in quanto si accuserà il governo torinese dell’ex re di Sardegna di non saper personificare l’unità nazionale introducendo una legislazione non di libertà, ma di vessazione. La seconda “eccezione” fu la sudditanza che era effetto anche di un contesto di internazionalismo massonico. Al Risorgimento si rimproverava una non granitica e limpida autonomia nel senso che per il raggiungimento dell’unità nazionale si pagarono però prezzi sul piano dell’indipendenza: dalla bandiera tricolore nata come vessillo collaborazionista che sostituiva il blu francese con il colore più ad esso simile all’ingresso nella Milano “liberata” di Vittorio Emanuele II a cavallo con a fianco Napoleone III, dalla acquisizione del Veneto in modo umiliante come “regalo” francese in quanto nel 1866 all’Italia, al tavolo delle trattative, non era riconosciuto lo “status” di nazione vittoriosa dopo le sconfitte subite da marina ed esercito fino alla occupazione di Roma sull’onda di manifestazioni in cui si gridava: “Viva la Prussia”, “Abbasso la Francia”. Lo Stato unitario - fallito il ‘48 italiano – prese forma esponendosi alla tesi di una rea- lizzazione straniera. Per chi ci studia dall’esterno come l’ungherese Istvàn Bibò (nel suo “Isteria tedesca, paura francese, insicurezza italiana”) è evidente che: “la causa principale del costituirsi dell’Italia unita non fu l’irresistibile movimento nazionale italiano, bensì la necessità di colmare in qualche modo un certo vuoto in mezzo all’Europa”, creare da parte inglese e francese uno Stato “cuscinetto” contro gli imperi centrali. Uno Stato unitario realizzato di fatto non attraverso un movimento popolare nazionale, ma una serie di conquiste militari dovute soprattutto a truppe e regìa straniere è pure uno Stato senza il mito di una spada nazionale. Le tre guerre di indipendenza possono essere infatti lette come tre sconfitte sul piano militare: nel 1849 Carlo Alberto lascia il trono dopo aver perso a Novara contro Radetzsky; nel 1859 Cavour si dimette: si è conquistata la Lombardia, ma gli italiani non sono stati in grado di assicurare ai francesi sul campo di battaglia il supporto necessario per proseguire la guerra anche per il Veneto di fronte alla minaccia prussiana; nel 1866 il Veneto è finalmente “conquistato” grazie esclusivamente ai francesi. Il sangue francese versato non fu all’epoca inferiore a quello italiano, ma come nel caso della Liberazione del 1945 l’Italia esclude sistematicamente dalle celebrazioni gli anglo-americani grazie ai quali furono sconfitti tedeschi e fascisti, così nelle celebrazioni del 150° vengono esclusi i francesi perché non siamo ancora in grado di ammettere la verità storica e cioè che a loro dobbiamo la caduta del dominio austriaco su Milano e Venezia. La terza “eccezione” che mina il Patriottismo risorgimentale riguarda la diaspora interna, la netta divisione in seno ai “padri della Patria”, il quadro di contrapposizione radicale e reciprocamente delegittimante. Non si tratta solo della divaricazione tra monarchici e repubblicani, liberali e democratici, ma l’aspro contrasto e l’aperta sfiducia che caratterizzarono la stessa fase “costituente” del Parlamento nazionale con la contrapposizione plateale tra i protagonisti, gli “eroi”, della conquista territoriale e cioè Garibaldi e Cavour. Una idealità e una Patria di diverso segno emergono nell’immediato dopoguerra “unitario” con Giuseppe Garibaldi, all’epoca deputato di Napoli, che diserta le iniziali sedute del Parlamento nazionale preferendo arringare gli operai genovesi definendo il ministero di Cavour un “governo di codardi” ed il nuovo Parlamento nazionale una “assemblea di lacché”. Quando Garibaldi finalmente mette piede nell’Assemblea parlamentare, il 18 aprile 1861, è per scagliarsi contro il governo tanto che il presidente Rattazzi dovette intervenire per censurare il verbale della seduta e non immortalare l’attacco di Garibaldi a Cavour. I numeri dello scontro tra i “padri della Patria” furono – con sdegnata astensione di Garibaldi - 194 contro 77. Un Parlamento che sin dall’inizio rispecchiava una patria neonata avvelenata. Particolarmente rilevante e inquietante fu poi la quarta “eccezione” e cioè quella della rappresentanza priva di un radicato e mobilitato consenso. Nel 1870 - rileva Ivanoe Bonomi in “La politica italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto” gli uomini politici si muovono “in mezzo ad un popolo indifferente od ostile”. “In tutti i discorsi dell’epoca – prosegue - si lamenta infatti l’esistenza di un paese legale quasi estra- 14 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia sentativa a regime parlamentare, economia di mercato, una unificazione territoriale secondo ammodernamento infrastrutturale (tra porti e ferrovie) e una legislazione di moderne garanzie. La classe dirigente liberale entrò invece in crisi e venne processata e delegittimata di fronte all’avvento di una nuova “platea politico-patriottica”. Una classe politica formata e cresciuta avendo come interlocutore un elettorato che rappresentava l’1,8 degli italiani e che solo nel 1912 aveva conosciuto un improvviso allargamento in seguito all’apertura di Giolitti verso i socialisti, ora si trovava di fronte venti milioni di italiani. L’Italia liberale come classe politica non era in grado di fronteggiare una simile rivoluzione della rappresentanza. Nell’immediato dopoguerra con il sistema proporzionale a suffragio maschile universale vi fu infatti la traumatica irruzione di un elettorato non più limitato e rappresentato dal deputato Ma rispetto alla polemica “pacifista” del socialismo, che si rifaceva agli ideali antipatriottici dell’internazionalismo proletario, si dispose in alternativa la prefigurazione della fuoriuscita violenta dall’Italia liberale impersonata da D’Annunzio che come novella “spedizione dei Mille” si ribellava allo Stato liberale ed occupava, alla testa dei reduci contro gli “uomini seduti” dell’Italia liberale, Fiume. “locale” secondo il maggioritario, ma rappresentato da masse organizzate in partiti ideologizzati antiliberali, inferocito da anni di guerra violenta e diviso tra chi metteva sotto accusa la classe di governo in nome dell’”inutile strage” e chi della “vittoria mutilata”. La “Quarta guerra di Indipendenza” decisa sulla base delle acquisizioni territoriali previste dai Patti di Londra si concludeva infatti con un ben misero bilancio rispetto a quanto stabilito dal momento che al posto dello zar c’era ora il presidente Usa che disconosceva quei Patti e patrocinava la nascita della Jugoslavia. Il “processo” al Patriottismo del Risorgimento liberale era peraltro già da tempo istruito sin dalla requisitoria dell’Oriani sulla “conquista regia” (che sarà ripresa da Gramsci) fino a quella di Piero Gobetti sul “Risorgimento senza eroi” e come “Rivoluzione fallita”. rio dei magistrati romani rieditato dai giacobini francesi. Il fatto nuovo e specifico del Patriottismo fascista che sfugge agli storici che sostengono la continuità tra Risorgimento e Fascismo è che Mussolini considerò una base fragile l’identificazione della Patria con il Risorgimento e lo scavalcò rifondando il Patriottismo sulla base della Roma imperiale. Mussolini è Dux, oltraggiando la Chiesa sostituisce - nella numerazione degli anni - “dopo Cristo” con “Era Fascista” ed anche fisicamente vuol evocare la figura del condottiero romano. I “Padri della Patria” con il Fascismo sono Giulio Cesare e Dante Alighieri. A “Nazione e Libertà” si sostituisce “Impero e Popolo”. Il Risorgimento fu quindi ripreso dal Fascismo riprese come “movimento” - “conquista”, “eroi” e “martiri” – contro il Risorgimento In quel primo dopoguerra la condanna sommaria dell’Italia liberale fu generale e condivisa e nello scontro tra fuoriuscita violenta e autoritaria da un lato nel segno dell’internazionalismo proletario e dall’altro ad opera del nazionalismo revanscista dei reduci prevalse quest’ultimo in una rifondazione del Patriottismo italiano che in modo giacobino collegava il Risorgimento alla Romanità riprendendo appunto come simbolo identitario il fascio litto- Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale neo al paese reale”. Le categorie sono quelle della pubblicistica cara alla Restaurazione francese, ma è comunque certo che il Patriottismo Risorgimentale dopo il 1861 si trova di fronte questione cattolica, questione meridionale, questione sociale. Con la progressiva uscita di scena dei protagonisti della conflittualità interna - Cavour (1861), Mazzini (1872) , Vittorio Emanuele II (1878), Garibaldi (1882) – il processo di unificazione territoriale trovò una lettura unitaria celebrativa di cui fu simbolo “Cuore” del socialista Edmondo De Amicis. Il Patriottismo Risorgimentale (territoriale) è ancora centrale nel 1915 per legittimare l’operazione della Corona volta ad imporre l’ingresso in guerra scavalcando il Parlamento in aperta violazione dell’art. 15 dello Statuto (“Senza la preventiva approvazione del Parlamento non vi può essere Dichiarazione di Guerra”). Si trattò infatti, in sostanza, di un colpo di stato da parte di Vittorio Emanuele III che cominciava a prefigurare la fuoriuscita autoritaria dall’Italia liberale. L’appello alle armi venne infatti presentato come Quarta guerra di Indipendenza, ripresa o ritorno alle origini “eroiche” della nascita della Nazione contro la “prosa” dell’Italia liberale e parlamentare che pur aveva promosso crescita economica e sociale, modernizzazione e presenza di primo piano sulla scena europea. Se nel 1914 le ragioni dell’interventismo erano state sostenute con la rivendicazione di Nizza e Corsica in quanto prevedevano il mantenimento dell’alleanza con Vienna, successivamente, nel 1915, l’interventismo crescerà rivendicando Trento e Trieste, Venezia Giulia, penisola istriana e parte della Dalmazia come convenuto nei Patti di Londra siglati con Francia, Gran Bretagna ed Impero russo all’insaputa del Parlamento Va comunque ricordato come gli ideali del Patriottismo Risorgimentale animarono l’interventismo democratico e socialista che vedeva la questione territoriale come movimento di indipendenza apportatore di liberazione ed emancipazione sociale: da Salvemini a Bissolati, da Battisti allo stesso Mussolini (che aveva l’appoggio anche finanziario non dei “francesi”, ma dei “socialisti francesi”: “Il popolo d’Italia” nacque con la dizione “quotidiano socialista”). Il Patriottismo Risorgimentale ebbe la sua eco anche nelle parole di Filippo Turati, che dopo essersi pronunciato contro l’ingresso in guerra nel maggio 1915, si unisce nel dicembre 1917 alla solidarietà ai soldati che difendono il territorio italiano dopo Caporetto. Nel 1917 si registra una sostanziale unità nazionale e unificazione popolare nella difesa patriottica. E’ nel primo dopoguerra del Novecento che si ha il teatro del primo grande processo che mise in stato di accusa la precedente storia dell’Italia unitaria e cioè la Italia liberale. La lettura classista del Novecento ha impedito una messa a fuoco della crisi dello Stato liberale in quanto ha confuso fascismo e liberalismo insistendo sul fascismo come strumento di “rinnovamento nella continuità” dell’Italia liberale. Ancora oggi quando si torna ad insistere sulla “continuità” tra Risorgimento e Fascismo si riprendono le tesi (e persino le parole, in particolare a proposito di Mazzini) che, come vedremo, furono quelle dei comunisti degli anni trenta. Si pensi in proposito a come la Patria del Risorgimento aveva trovato invece la sua rappresentazione “umanitaria” in Giuseppe Verdi come sofferenze comuni, ansia di libertà e odio contro la tirannide. In realtà con il fascismo si realizzò una profonda “discontinuità patriottica”. Il Patriottismo risorgimentale dopo il 1861 aveva preso forma come costruzione della Nuova Italia in quanto Stato liberale con democrazia rappre- “Stato” cancellando le idee di libertà, di pluralismo politico, di regime parlamentare. Il Fascismo si presentò come un ritorno alle origini risorgimentali contro “prosa” e “fazioni”, esaltando un Mazzini molto purgato in contrapposizione all’Italia liberale e, soprattutto, contro non solo l’Italia post 1861, ma soprattutto Cavour. La mazziniana ”Italia del Popolo” diventa un’arma di propaganda “antiborghese” e nel 1932, nel cinquantenario della morte di Garibaldi, si cristallizza il Patriottismo fascista neorisorgimentale come riedizione del binomio Re-Garibaldi ovvero Re-Mussolini, “camicie nere” novelle “camicie rosse”, espellendo l’Italia liberale, emarginando l’Italia cattolica, nazionalizzando l’Italia socialista. A sua volta, nell’esilio, anche l’antifascismo si divideva sul Patriottismo Risorgimentale per la forte pressione internazionalista, “proletaria” ed un naturale tifo disfattista. Patriottismo ed antipatriottismo sono al centro della polemica che vede le opposte letture del Risorgimento da parte di Carlo Rosselli e di Palmiro Togliatti. “Giustizia e Libertà” fa appello al Patriottismo definendo la lotta antifascista, democratica e repubblicana, come prosecuzione del Risorgimento coniando appunto l’espressione “secondo Risorgimento”, mentre il Partito comunista d’Italia teorizza la continuità tra Risorgimento e fascismo. “Il Risorgimento ebbe – scrive Togliatti in polemica diretta con Rosselli su “Lo Stato Operaio” del settembre 1931 - una impronta reazionaria … La tradizione del Risorgimento vive nel fascismo ed è stata da esso sviluppata sino all’estremo. Mazzini, se fosse vivo, plaudirebbe alle dottrine corporative. … La rivoluzione antifascista non potrà essere che una rivoluzione ‘contro il Risorgimento’”. Quindi Togliatti conclude: “Le fantasie sul ‘secondo Risorgimento’ sono fatte solo per nascondere questa realtà”. La lettura classista secondo lo scontro tra capitalismo reazionario e classe operaia rivoluzionaria nega ruolo positivo ai “vincitori”, a chi ha governato e svolto attività economica e indica come reprobi tutta la catena dei governanti e degli imprenditori della storia nazionale. Ha così inizio la diaspora tra Italia e AltraItalia con una eccezione di infamia che allunga la sua ombra su tutti i “vincitori” della storia d’Italia da Cavour a Mussolini (destinata a proiettarsi ad opera della storiografia classista successivamente anche sul dopoguerra repubblicano). Nella rottura con Mussolini, il re cerca di rieditare il Patriottismo Risorgimentale, ma quell’uso estremo da parte del Savoia lo trascina a una definitiva sepoltura insieme alla monarchia. Il Patriottismo risorgimentale nella catastrofe dell’8 settembre sopravvive invece negli strati subalterni. Ricorda Renzo De Felice: “Solo se si discende ai gradini ancora inferiori della scala gerarchica è possibile trovare un maggior numero di ufficiali che vissero il dramma dell’8 settembre senza mettersi sotto i piedi dignità nazionale, patriottismo, etica militare”. L a caduta di credibilità da parte delle autorità istituzionali, politiche e militari – la “Morte della Patria” - apre però la strada al prevalere della visione comunista sulla questione del confine orientale con l’accettazione o comunque la messa in sordina della eliminazione della Resistenza “patriottica-territoriale” che nella Venezia Giulia vedeva le brigate dei militari “legittimisti”, cattolici e azionisti combattere vantando l’intestazione a terre considerate invece dai comunisti italiani e jugoslavi non italiane. I sette battaglioni della Osoppo si chiamavano – fatto inviso ai comunisti jugoslavi CRITICAsociale ■ 15 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia Il Patriottismo Costituzionale basato sulla Resistenza riesce a limitare la “guerra fredda”, la contiene e sostanzialmente la supera dal ’53. Il Patriottismo Costituzionale mantiene viva una solidarietà trasversale ed una tenuta nazionale nei momenti di maggiore difficoltà interna, consente una unità nazionale in sede istituzionale vedendo la elezione condivisa del Presidente della Repubblica e la ricerca di nuovi equilibri che superino le divisioni della “guerra fredda” tra partiti di democrazia occidentale e PCI e PSI anche quando erano ancora stalinisti e filosovietici. Progressivamente dal 1955 (elezione “antifascista” di Gronchi) al 1960 (unità antifascista contro Tambroni) fino al 1968 il Patriottismo Costituzionale cresce nel rigetto insieme all’Italia fascista anche dell’Italia liberale e quindi della stessa Italia della ricostruzione democratica di De Gasperi in quanto prevale nel- L’Antifascismo diventa quindi un Valore senza limite di tempo e di spazio ed il Fascismo un pericolo permanente, sempre incombente secondo la cristallizzazione della assoluta inconciliabilità tra Antifascismo e Anticomunismo. Il Risorgimento viene quindi “cooptato” nel Patriottismo Costituzionale sulla falsariga fascista come Risorgimento “di lotta” (Garibaldi e Mazzini), ma non “di governo” (Vittorio Emanuele II e Cavour). L a “fortuna” del Patriottismo Costituzionale si basa sulla capacità di “chiamarsi fuori” di fronte al trauma della sconfitta militare e della umiliazione internazionale, offre le basi di una rifondazione senza pendenze passate sostituendo al Super Io territoriale un Super Io valoriale. La Carta si erge come “santa alleanza” originaria e “legge” inviolabile ed eterna: una ni politiche” prive di “quel grado di maturazione e di concretezza” per diventare “pratiche garanzie giuridiche”. Siamo di fronte per lo più ad ”una specie di enfatica ostentazione verbale di una maturità giuridica che nella sostanza ancora non c’è”. Non si esce – conclude Calamandrei – “dal campo puramente esortativo ed augurale, dei programmi di partito” per cui “numerose norme in questa Prima Parte della Costituzione (sono) soltanto una sostanza ancora politicamente fluida, fatta di aspirazioni insoddisfatte e di tendenze ancora in divenire”. “Si tratta soltanto – scrive Calamadrei - di speranze e tutt’al più di propositi volti verso l’avvenire, lontane mete”. Una lettura non acritica della Carta Costituzionale ed un recupero dell’Italia liberale e risorgimentale si avrà negli anni ’80 quando si registra – dopo la caduta dei governi di unità nazionale con il Pci in maggioranza e la fuoriuscita dall’emergenza terroristica ed economica – ad un tentativo di contrastare quel Patriottismo Costituzionale dell’”altra Italia”. Con Craxi l’esaltazione della storia della sinistra italiana e del socialismo prima della nascita del comunismo si traduce nella riabilitazione della tradizione riformista e quindi del Risorgimento non solo “di lotta”, ma anche “di governo”. Una rilettura storica che si intreccia anche con l’obiettivo di esaltare una sinistra di governo contro la sinistra antagonista e di valorizzare la competitività nazionale contro il disfattismo dell’”AltraItalia”. Il patriottico “Viva l’Italia” che nel 1981 concluse il congresso di Palermo rispecchiava un PSI che per la prima volta si dichiarava “riformista”, accettava l’economia di mercato ed il primato della democrazia occidentale e si dichiarava quindi “patriottico”. M Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale alle cui dipendenze nell’ottobre 1944 Togliatti aveva messo alle dipendenze i comunisti di quei luoghi – “Carnia”, “Tagliamento”, “Italia”, “Piave”, “Julia”, “Torre” e “Udine”. Porzus è il simbolo della sconfitta definitiva del Patriottismo risorgimentale-territoriale. Esso viene sostituito con il Patriottismo dei Valori antifascisti ovvero il Patriottismo Costituzionale. Ma è un “patriottismo” che deve cancellare pagine di storia. Il trattato di pace fu infatti sottoscritto dall’Italia come nazione sconfitta. Il 20 gennaio 1947 Pietro Nenni rileva che il trattato urta “contro la coscienza nazionale specie per le clausole territoriali”. E quando esso viene firmato in febbraio dai delegati dei 21 paesi che avevano dichiarato guerra all’Italia sanzionando la mutilazione sul confine orientale e la nascita del Territorio Libero di Trieste, il ministro della Difesa Cipriano Facchinetti annota che esso segna “la fine del nostro Risorgimento”. “L’Italia – dichiara de Gasperi - torna alle condizioni di prima del Risorgimento: le sue frontiere restano completamente aperte, suoi territori nazionali le vengono strappati”. La Resistenza ha però il potere di illudere gli italiani di essere stati nel 1945 tra i “vincitori”. Con il Patriottismo Costituzionale cade in disgrazia il 4 novembre ed il 25 aprile diventa la nuova Festa della Vittoria. Vengono estromessi gli Alleati dai festeggiamenti e si insegna che la Wermacht è stata messa in fuga dai “garibaldini”. Nel secondo dopoguerra viene quindi processata e condannata non solo l’Italia fascista, ma anche l’Italia liberale. Così ebbe a sentenziare Ferruccio Parri nell’Assemblea Costituente del 27 settembre 1945. “Prima del fascismo l’Italia non aveva avuto Governi democratici”. Al discorso di Parri reagì Benedetto Croce affermando: “Questa asserzione urta in flagrante contrasto col fatto che l’Italia, dal 1860 al 1922, è stata uno dei paesi più democratici del mondo e che il suo svolgimento fu una non interrotta e spesso accelerata scesa della democrazia”. Ma la condanna dell’Italia fascista e la difesa dell’Italia liberale fu voce isolata ed inascoltata. L’assemblaggio di Italia liberale e Italia fascista in una comune e drastica condanna sommaria è un giudizio storico destinato a cristallizzarsi fino ai massimi livelli istituzionali ed accademici come base del nuovo Patriottismo nato dalla Resistenza. Ancora il 25 aprile 2001 il Presidente della Camera, Luciano Violante, poteva ribadire: “Il 25 aprile è il giorno della nascita della democrazia. Dico nascita e non rinascita perché la democrazia, intesa come pienezza di diritti e di doveri, non c’era mai stata nella storia italiana”. Si assiste infatti dal secondo dopoguerra all’irrompere prepotente, all’ombra delle potenze vincitrici e della grande alleanza antifascista internazionale con l’URSS, nelle masse italiane di una patria “alternativa” che riassume identità storica e aspirazione messianica, un senso di appartenenza antagonista, un patriottismo che nel rigetto di Italia liberale e fascista e poi della scelta occidentale e atlantica diventa un neopatriottismo valoriale imperniato sulla mitologia della “diversità” rispetto all’Italia ufficiale ed istituzionale. Se dall’interno del corpo comunista viene coltivato il Patriottismo Costituzionale secondo una tradizione antagonista – ghibellin-giacobina (Dante-Machiavelli-De Sanctis-Gramsci) – è anche vero che il Patriottismo Costituzionale costituì una base di tenuta unitaria nel maremoto della “guerra fredda” che spacca e contrappone i protagonisti della grande alleanza antifascista internazionale. la cultura, nella storiografia, nella “vulgata” mass mediatica il disprezzo per aver scelto l’economia di mercato e l’alleanza atlantica. A guidare l’insegnamento di questo tipo di Patriottismo Costiituzionale è la storiografia dell’Insmli che ha come “credo” e “mission” quella che Giorgio Rochat definisce la “lezione” di Guido Quazza e cioè: “La sottolineatura della continuità della società e della politica italiana da Giolitti a De Gasperi attraverso Mussolini: una continuità tra scelte moderate e nazionaliste, in cui la Resistenza rappresenta un momento di rottura democratica”. Tesi sempre autorevolmente presenti anche dopo la caduta del Muro di Berlino. Ancora oggi nell’Insmli si teorizza la “continuità tra Risorgimento e fascismo” e “la frattura che si rivela ogni giorno più labile tra fascismo e democrazia repubblicana” (Alberto M. Banti) connotazione che è una armatura in grado di restituire certezza, orgoglio, solidarietà all’intera nazione. Il mito della Costituzione ed in particolare della sua Prima Parte come patto sacro richiede però un’opera di crescente amnesia storica ed una straordinaria mobilitazione e manipolazione storiografica per cercare di enfatizzare e rendere categorie universali ed eterne ciò che fu invece frutto di eterogeneità e vaghezza, convulsa stesura affrettatamente licenziata rinviando la sua autentica interpretazione al Parlamento a cui si era in procinto di passare la mano. Tutto ciò che è racchiuso e celebrato nella Prima Parte della Costituzione sotto il titolo “Diritti e Doveri dei cittadini” è in realtà, come mette in evidenza Calamandrei, solo un “contenuto eterogeneo e fluido”, “vaghe aspirazio- a di lì a poco venne ad incombere il terzo dopoguerra del Novecento con la nuova messa in stato d’accusa dell’intera storia nazionale precedente: dopo la “Vittoria Mutilata” del 1919 e la “Morte della Patria” del 1943, nel 1992, all’indomani della scomparsa dell’Urss, si ha “Tangentopoli” ed in Italia il dopo “guerra fredda”, come osserverà Lucio Colletti, vede “sul banco degli imputati i partiti democratici e sul banco dei giudici i comunisti”. La fine della “Prima Repubblica” si traduce in un giudizio negativo che allinea insieme Italia liberale, fascista e repubblicana. La contestazione globale della storia passata produce una vasta storiografia che sin dai manuali scolastici denigra la classe dirigente politica ed economica dell’Italia unita per contrapporle la maggiore modernità di una storia nazionale imperniata su lotte, movimenti, esperienze artistiche, inchieste giornalistiche e giudiziarie, libri, film e canzoni. E’ una modernità globalizzante che ridefinisce l’identità italiana irridendo le radici latine (come patria del “latinorum”) e le radici cattoliche (come patria della Controriforma) e additando come stella polare, nuova e vera patria, la cittadinanza, una cittadinanza inclusiva con echi di Rousseau ovvero la Cittadinanza come nuovo e vero patriottismo, un Patriottismo che non divide e non distingue, non contrappone, ma seleziona e affratella senza frontiere secondo un comun denominatore che nel segno salvifico di “Tangentopoli” è rappresentato dalla Legalità. Alla base di questa versione finale del Patriottismo italiano come “Cittadinanza Nazionale” vi sono ragioni profonde ancorché specifiche del caso italiano di post “guerra fredda”. A livello internazionale o comunque nel mondo occidentale all’inizio degli anni ’90 prevale infatti la tesi della “fine della storia”. Il dissolvimento del comunismo viene vissuto 16 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 120 anni di Critica Sociale in 150 anni di Unità d’Italia locali e nelle istituzioni è messa insieme, “a panino” tra bandiere locali – comunali, provinciali, regionali – e bandiera dell’Unione europea: il patriottismo locale e quello europeista sono a partire dagli anni novanta le “patrie” più forti, mentre il tricolore è declassato a patriottismo vecchio e retorico (ricordo di periodi tutto sommato squallidi, non rimpianti, tra “Risorgimento tradito” e “Resistenza tradita”: Italia liberale, fascismo e cosiddetta Prima Repubblica). Il fenomeno delle contestazioni delle basi Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale unitarie e le rivendicazioni scissionistiche hanno campo libero in una stagione di “fuga dall’Italia”, di retorica europeista che si rallegra della diminuita caratterizzazione italiana di ciò che si va privatizzando. Quale Patriottismo con un passato di cui vergognarsi? Da un lato fallimenti e illusioni, dall’altro spoliazioni e oppressioni. E’ il Patriottismo della legalità, la Repubblica dei virtuosi. Il nuovo Patriottismo della Seconda Repubblica postTangentopoli si farà chiamare Cittadinanza nazionale, un patriottismo senza frontiere teorizzato da un neogiacobinismo che celebra non radici, ma i “casi” in cui, a macchia di leopardo, in Italia ci sono state “avanguardie coscienti”, “élite consapevoli”. E’ in questo quadro che il Patriottismo Costituzionale viene riproposto con un sistema di Valori ruotanti intorno alla legalità in una dimensione morale che non ha frontiere né spe- Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale come il risultato di una pacifica e simpatica “autoriforma”. E’ generale la convinzione di avere di fronte la prospettiva di uno sviluppo unidirezionale, quasi automatico e senza alternative, in un mondo ormai pacificato secondo parametri comuni ed un indiscusso primato dell’economia occidentale. Quel che si deve fare non richiede particolari discussioni. Si afferma quindi in Italia una generale convinzione di essere di fronte ad una strada obbligata che tanto più agevolmente potrà essere percorsa con meno partiti, meno politica, meno Stato ed anche meno Italia e più Europa. Privatizzazioni e Moneta Unica si stagliano come una salvifica fuoriuscita dall’Italia, un’Italia in cui i partiti, la politica, lo Stato sono stati solo un peso, un freno, una entità burocratico-parassitaria. “Tangentopoli” celebra il processo che libera gli italiani dalla partitocrazia, dal regime dei partiti e dal primato della politica. La sepoltura della Prima Repubblica non è riabilitazione né dell’Italia liberale o dell’Italia fascista. La Seconda repubblica mette in una innominabile fossa comune l’intera storia unitaria precedente e nasce non solo come rifondazione, ma anche come de-italianizzazione in un quadro di desiderio di essere cooptati a livelli superiori. Leghismo ed europeismo si intrecciano. Sono gli anni del “gloLocal” ed il riferimento nazionale si sbiadisce sempre più. La stessa bandiera italiana è sempre più ridimensionata e finisce “ in un mazzo in cui nelle amministrazioni cifiche radici. Il Patriottismo Costituzionale vive così una profonda trasformazione con la scomparsa dell’”arco costituzionale” che viene sostituito dal “Partito della Costituzione”. Nell’Italia della Prima Repubblica, vigendo il sistema proporzionale, il Patriottismo Costituzionale era un appello all’unità nazionale originaria antifascista tra cattolici, socialisti e comunisti teorizzando la cristallizzazione di un “arco costituzionale” che abbracciava oltre il 90 per cento del Parlamento. Nella Seconda Repubblica - con il passaggio dal proporzionale al maggioritario - antifascismo, legalità, Costituzione non si spalmano più trasversalmente su maggioranza e opposizione, ma – secondo la maggior parte di storici, editorialisti ed istituzioni depositarie della “difesa della Costituzione” - finiscono in blocco da una parte sola dando legittimità agli uni e permanentemente delegittimando gli altri. Il Patriottismo generato da Tangentopoli nel quadro del bipolarismo della Seconda Repubblica si traduce in un “Partito della Costituzione” secondo cui il “patriota” è una sorta di “vigilante”. In “Principi e voti. La corte costituzionale e la politica”, l’ex presidente della Consulta Gustavo Zagreblesky ben teorizza questo nuovo Patriottismo Costituzionale come “Partito della Costituzione” che stabilisce unilateralmente di dover svolgere anche una “funzione antimaggioritaria”. Se a vincere le elezioni non sono i partiti del “Comitato Antifascista”, dell’Anpi e dell’Insmli, allora il “patriota” della Costituzione, a cominciare dall’uso della Consulta, “protegge la Repubblica”, “limita la democrazia”, ovvero “limita, per così dire, la quantità della democrazia per preservarne la qualità”. Questo tipo di Patriottismo ha partorito la Cittadinanza Nazionale che ci individua e regola come una patria di stampo giacobino richiamandosi appunto alla cittadinanza senza frontiere di Rousseau imperniata non sulla Storia, ma sulla virtù di quei cittadini che “accorrono alle assemblee”. Questa ultima forma di Patriottismo costituzionale si delinea come quel “ritorno a Rousseau” da cui Luigi Einaudi in una sua “predica inutile” metteva in guardia e cioè il prevalere demagogico e antidemocratico dell’idea secondo cui “l’uomo è veramente libero solo se si sottomette a quella volontà generale che egli non ha voluto ma ha semplicemente riconosciuto perché illuminato da coloro che sanno”. Il Patriottismo costituzionale - con questo suo Partito della Costituzione” e con questa Cittadinanza nazionale come novella Patria senza passato e senza frontiere - è il Patriottismo élitario di “quelli che sanno”. Sradicato, polemico e inquisitorio tale Patriottismo antirisorgimentale è alla base di un clima di contrapposizione e di divisione che non solo non ha pari in altro paese occidentale, ma che l’Italia non aveva mai conosciuto in forme così acute e devastanti nemmeno durante la “guerra fredda”. s Ugo Finetti CRITICAsociale ■ 17 1-2 / 2011 ■ LA AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA MEGLIO GARANTITA DA TOGLIATTI CHE DAL “GIUSTIZIALISMO” DEI NIPOTI DI BERLINGUER USO POLITICO DELLA GIUSTIZIA, ANOMALIA ITALIANA P Fabrizio Cicchitto ersino la componente migliore del ’68, quella che animò la trasgressione per la libertà dei costumi e che rappresentò l’elemento di liberazione di una società in parte bigotta, oggi è approdata ad una forma di moralismo e di bigottismo sulla vita privata di Berlusconi per una pulsione omicida di carattere politico-settario. Un approdo che dà anche il senso dell’attuale imbarbarimento. Ricordo che l’uso della vita privata nella lotta politica in Italia risale a due casi che riguardavano la DC e il PCI. Il caso più noto è il caso Montesi che Fanfani aveva alimentato per colpire Piccioni la DC a sua volta reagì con il caso Sotgiu per cui fu colpita la vita privata del presidente comunista della provincia di Roma dopodiché la partita si fermò lì e da allora la vita privata non è stata più utilizzata nello scontro politico, fino al 2008. Ricordo che ci sono stati presidenti del consiglio e ministri del tesoro democristiani notoriamente omosessuali, recentemente diventati senatori a vita che nessuno giustamente ha mai contestato. Questa “convenzione” ha caratterizzato la vita del nostro Paese, una consapevole scissione tra la vita privata, che ognuno vive come vuole, e la vita politica. Noi oggi siamo al rovesciamento completo di questo stile. Ma la china è destinata a peggiorare e l’imbarbarimento andrà avanti sia per ragioni tecnologiche sia per la forte probabilità del fatto che se oggi tocca a Berlusconi, domani a cascata toccherà ad altri. Tutto questo ha un retroterra che non dobbiamo mai dimenticare, un retroterra che a mio avviso rende l’Italia un Paese anomalo rispetto al resto dell’Europa. L’Italia è un paese anomalo e pericoloso per alcune ragioni di fondo che, tra l’altro saranno l’oggetto di un altro libro che ho quasi finito dal titolo “L’anomalia italiana”. L’anomalia italiana secondo me è fatta di più componenti. Essa inizia con il ritardo con cui è stata fatta l’Unità nazionale, con le contraddizioni di questa unità, che adesso si cerca di rappresentare in forme agiografiche, ma che invece ha avuto s contri politici durissimi. Poi siamo entrati con una operazione antidemocratica nella Prima Guerra Mondiale, mentre la maggioranza del Paese e delle forze politiche era contraria. Vinse una minoranza rivoluzionaria e reazionaria che ci portò in guerra. L’anomalia prosegue inoltre per quello che avvenne subito dopo la Guerra, dal biennio rosso all’avvento del fascismo. Questo è un Paese che ha avuto vent’anni di dittatura fascista ed è un Paese che dopo aver fatto una terribile guerra civile, quella del ’43-’45, terribile da entrambi i lati, sia dal lato dei comportamenti spesso esecrabili dei repubblichini di Salò una vicenda storico-politica da considerare organicamente negativa, ma terribile anche per quello che è successo dopo, come i libri di Pansa stanno a dimostrare. Un esempio dell’inciviltà in corso in questo Paese è, ad esempio, che i libri di Pansa hanno una difficile presentazione, al punto che io avendolo invitato a presentare con me ed altri questo libro, mi ha detto: “Non ci vengo perché se ci vengo succederà qualcosa sul terreno dell’ordine pubblico”. Perché? Perché Pansa è andato a toccare un pezzo di storia occulta, così come occulto è ancora il quadro del finanziamento irregolare del PCI e il fatto che il PCI ha avuto una componente armata di almeno 100.000 persone fino agli anni ’50, successivamente poi ridotto a nuclei di specialisti almeno fino agli anni ’70-’80, Berlinguer regnante, come dimostrano le lettere scritte da Cossutta e da Pecchioli al Partito Comunista dell’Unione Sovietica. I due dirigenti chiedevano l’innesto di un certo numero di trasmittenti segrete che poi sono state smantellate in parte – altra dichiarazione dei suddetti – durante il caso Moro. Inoltre del personale qualificato fu mandato dal PCI in Unione Sovietica per apprendere i rudimenti, gli elementi essenziali di attività riservate e segrete. Il punto più di fondo che rende questo un paese anomalo e pericoloso, è costituito dal fatto che quello di cui stiamo parlando – a noi sembra sempre di parlare di cronaca perché la cronaca ci insegue - è molto profondo, è nella storia profonda di questo Paese, attiene alla storia della sinistra italiana e attiene alla storia di una istituzione importante quale è la magistratura, ma non solo di essa. Rileggendo e riguardando i documenti, si scopre poi, paradossalmente, che la classe dirigente togliattiana del PCI aveva in sé la tabe del legame organico con Stalin, ma era migliore di quella che l’ha seguita, quella berlingueriana, perché i primi avevano il senso preciso del limite in quanto glielo aveva dato lo stesso Stalin. Nella storia vera dei documenti, di derivazione comunista, fortunatamente scritta in un libro di cui raccomando sempre la lettura, quello di Aga Rossi e Zaslavsky (purtroppo morto recentemente) “Togliatti e Stalin”, emerge che se in Italia non c’è stata una seconda guerra civile dopo quella tra partigiani e repubblichini, se non c’è stata una sollevazione comunista, preparata accuratamente al nord da Longo e da Secchia sul modello titoista (che essi non riuscirono a realizzare in quanto Tito e l’armata jugoslava combattevano sul campo alla pari contro l’esercito nazista, mentre loro ne diedero una traduzione terrorista con i gap), chi evitò quindi che la mattanza successiva al 25 Aprile e proseguita fino al ’47, chi evitò che tutto questo debordasse in una guerra civile, non fu il gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano (anche se personalmente Togliatti era più favorevole a una via pacifica) ma fu Stalin. L’Italia deve a Giuseppe Stalin se non c’è stata una guerra civile perché il 3-4 marzo del ’44 Stalin chiamò Ercoli e gli disse: “Torna in Italia e fai un’operazione entrista rispetto al governo Badoglio”. C’era stata un’operazione geniale di Prunas, Ministro degli Esteri del governo Badoglio, che aveva stabilito dei rapporti con l’Unione Sovietica. Stalin nel gioco dello scacchiere internazionale da un lato occupava e traduceva in potere quello che l’Armata Rossa aveva conquistato, ma dall’altra parte con un lucido realismo - Stalin sapeva di non potere rompere con gli Stati Uniti in un paese come l’Italia che era stato conquistato dagli 18 ■ CRITICAsociale anglo-americani, al prezzo di provocare una guerra civile che avrebbe avuto conseguenze negative su tutto lo scacchiere mondiale. Anche durante gli anni ’47-’48 Togliatti interpellò l’ambasciatore sovietico in Italia per chiedere chiarimenti sulla posizione dei sovietici rispetto alla possibilità di un’insurrezione. E i sovietici gli dissero di no. Quando Secchia nel ’47 andò a Mosca criticando Togliatti da sinistra, gli fu ridetto “non è il momento”. Cosa significa tutto ciò? Che in assenza della possibilità della traduzione automatica del leninismo nell’ ipotesi rivoluzionaria, allora fu recuperata da parte di Togliatti l’elaborazione gramsciana dei “Quaderni dal carcere”. In essi Gramsci, genialmente, aveva riflettuto sulla sconfitta della guerra di movimento - cioè della rottura rivoluzionaria armata nei paesi dell’occidente – e da non- staliniano qual era, (anche se ciò fu abilmente occultato da Togliatti) e si domandò come si poteva realizzare un’atipica, rispetto a Lenin, rivoluzione nell’occidente che ha lo spessore di una società civile che viceversa manca in Unione Sovietica. Gramsci delineò “la strategia dell’egemonia e della conseguente conquista delle casematte ideologico-culturali”. In sostanza Gramsci delineò la via di conquistare il cervello di una società che sul terreno dei rapporti di produzione è capitalistica e sul terreno della direzione politica è moderata conservatore, moderata riformista. La via indicata fu appunto quella della conquista del “cervello” di quella società attraverso la penetrazione nelle casematte ideologico-culturali di quella società al fine di passare da quel cervello allo Stato. 1-2 / 2011 il compromesso fu per la massima autonomia della magistratura perché nessuno allora sapeva chi avrebbe vinto: e il vincitore attraverso il Ministero di Grazia e Giustizia e il controllo sui pubblici ministeri, che avrebbe fatto? Quindi massima autonomia della magistratura. Ma anche massima autonomia alla politica con la salvaguardia dell’articolo 68. Questa operazione “entrista”, che il gruppo dirigente togliattiano del PCI interpretò in una chiave difensiva, è diventata successivamente un’altra cosa con Berlinguer. Egli ha certamente avuto più autonomia nei confronti dell’Unione Sovietica ma non nella chiave della socialdemocratizzazione del PCI, ma zionario-fascista. Nasce come movimento democratico liberalsocialista perché tale era Luigi Beria d’Argentine. Ma Magistratura Democratica in quattro anni, dal ’64 al ’68 diventa ciò che è anche attualmente: un soggetto politico. Un soggetto politico tutto spostato a sinistra, diviso fra chi si riconosceva nel PCI e chi nel movimentismo extra parlamentare. Le carte vanno lette. Se si legge quello che hanno prodotto culturalmente (Bruti Liberati in primo luogo) gli esponenti di magistratura democratici troviamo la teorizzazione di una organizzazione di magistrati come un soggetto politico a 360 gradi, che ritiene che la classe operaia non sia più un soggetto sociale rivolu- P Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale T ogliatti tradusse in pratica questa parte del lascito gramsciano, correndo anche un rischio perché in Gramsci c’erano tante cose eretiche che però non furono colte e che furono occultate fino agli anni ’60. Solo dopo c’è stata una lettura più autentica di Gramsci, si colse la sua estraneità eretica nei confronti di Stalin, il suo dissenso dalla svolta estremista del sesto congresso dell’Internazione Comunista. Del resto, con Togliatti, Gramsci ruppe sul piano personale fin dalla vicenda della sua famosa lettera al PC(b) del 1926. Che cosa vuol dire la conquista del cervello di una società e la conseguente conquista delle casematte ideologico-culturali? Vuol dire conquistare una fortissima influenza nelle case editrici, nella scuola, nella radio, adesso ovviamente nella televisione e inserirsi nella magistratura. Non è un caso che Togliatti nel governo di unità nazionale prese il dicastero della Giustizia. Intendiamoci. Allora fu un’operazione fatta fondamentalmente in chiave difensiva, essendo nel PCI così pessimisti visto il loro leninismo, da temere, tendendo conto della collocazione dell’Italia nell’area di influenza americana, che gli avversari li “avrebbero fatti fuori”, perché così loro avrebbero fatto, se ne avessero avuto la possibilità, come dimostravano le parallele vicende in quei paesi dell’Europa dove era arrivata l’armata rossa. I comunisti staliniani di allora vedevano quindi l’inserimento nella magistratura e il controllo del Ministero di Grazia e Giustizia in una chiave difensiva. In quella situazione nella quale i Costituenti non erano degli angeli, come ci vengono descritti, ma erano dei lucidi uomini politici. La costituzione è stata elaborata fondamentalmente da esponenti della DC e del PCI. Ora malgrado il Governo di unità nazionale i due partiti si temevano. Anche da qui derivò l’estrema autonomia della magistratura dall’esecutivo. Ci fu su questo terreno un compromesso di fondo buttato poi per aria nel ’93: l’articolo 68, l’immunità parlamentare. Allora la DC e il PCI si temevano reciprocamente e tra coloro che si richiamano al Partito Comunista e coloro chemilitano nei gruppi extraparlamentari. Questa divisione si verifica non soltanto sul piano culturale ma anche sul terreno della giurisdizione perché quando Calogero fece l’operazione 7 aprile e mise nello stesso sacco BR, Negri, Autonomia Operaia e così via, un pezzo di Magistratura Democratica si contrappose frontalmente a questo perché era legata a quei gruppi. Di questo la DC e il PSI non se ne accorsero, e ritennero che la magistratura potesse essere accarezzata con le due leggi Breganze e Breganzene con i loro meccanismi corporativi di carriera che avrebbe potuto tener buona la “bestia trionfante”. nella chiave dell’invenzione di un comunismo diverso dal comunismo staliniano, un comunismo per certi aspetti autonomo che accettava il pluralismo sociale e politico ma più spostato a sinistra. E qui veniamo alla questione morale, all’austerity, all’ occupazione della FIAT e via discorrendo. Ci fu anche il tentativo di un recupero dell’ estremismo del ’68, di quadri di quel movimento, recuperato poi per larga parte nel gruppo dirigente occhettiano del Partito Comunista. Intanto si realizzava un’operazione scientifica d’inserimento nella magistratura in parallelo anche con tendenze sorte dall’interno stesso della Magistratura. Magistratura Democratica nasce nel ’64 in polemica con una magistratura italiana per molti aspetti rea- zionario, che il Partito Comunista si è infilato nel compromesso storico e che a questo punto il magistrato può diventare il soggetto rivoluzionario a condizione che “superi” le teorie sulla “terzietà”. Ci sono due volumi pubblicati nel ’75 da Laterza: “L’uso alternativo del diritto”, che, partendo anche da pubblicazioni precedenti dei giuristi sovietici, dicono in sostanza che ci può essere un uso rivoluzionario del diritto, e poi della giurisdizione, per trasformare appunto in modo rivoluzionario il sistema politico e il sistema economico. Sul terreno del sistema economico pensiamo anche ai pretori d’assalto per quello che riguardava il diritto del lavoro. I congressi di Magistratura Democratica hanno visto uno scontro esplicito rogressivamente da un lato c’è una crescita in parte autonoma di Magistratura Democratica e dall’altro lato c’è un Partito Comunista che ha un rapporto dialettico con essa e che se ne occupa in modo “scientifico” con Pecchioli prima e con Violante dopo. Poi che cosa accadde? Due fenomeni che si intrecciano: uno è il crollo del comunismo. Col crollo del comunismo tutti pensano che il PCI diventarà un grande partito socialdemocratico. Lo pensa anche Craxi e questa è una delle cause della sua rovina. Craxi pensa che la logica delle cose porti il PCI a diventare socialdemocratico e che egli sarebbe diventato il Mitterrand italiano. Così Craxi aprì la guardia, non fece le elezioni anticipate nel ’91 perché glielo chiesero, nel famoso incontro del camper al congresso dell’Ansaldo, Veltroni e D’Alema. Loro glielo chiesero dicendo “facci guadagnare tempo e poi vediamo”, ma volevano guadagnare tempo per far fuori Craxi e il PSI e prenderne il posto. Questo è anche scritto nella biografia autorizzata di D’Alema fatta da Fasanella. Avviene quindi che, diversamente dalle aspettative, il PCI cambia nome ma non si trasforma in un grande partito socialdemocratico e riformista. Il senatore Pellegrino spiega gli elementi fondamentali di ciò che allora avvenne nel PCI-PDS: secondo lui, non è una citazione testuale, il vuoto di cultura politica che si determina a quel punto nel PCI venendo meno la storica e tradizionale cultura comunista viene riempito da personalità come Violante con la sua cultura giustizialista”. La classe dirigente del PCI non era pronta – tranne la minoranza migliorista ritenuta alternativa a Craxi, (Napolitano stesso, Gerardo Chiaromonte specialmente, Bufalini, Cervetti, uno dei primi colpiti non a caso da Mani Pulite a Milano) - a diventare socialdemocratica anche perché il retaggio del berlinguerismo su Occhetto, D’Alema, Veltroni era fortissimo al netto delle loro divisioni. Il PCI diventa PDS e scopre non la socialdemocrazia, ma scopre paradossalmente Karl Schmidt, la dialettica amico/nemico, scopre il giustizialismo di Violante e di Magistratura Democratica, e dall’altra parte diventa il partito etero - diretto dal giornale-partito di Repubblica, ispirata da Scalfari e dai progetti di Carlo De Benedetti e così via. Si saldano così una serie di anelli che costruiscono nel nostro Paese un meccanismo infernale. E poi – altro punto di crisi – arriva la scadenza di Maastricht. Credo che Andreotti e De Michelis, che hanno sottoscritto l’adesione dell’Italia al Trattato di Maastricht, non si siano resi compiutamente conto dell’operazione eversiva e rivoluzionaria che facevano. E qui c’è l’altra anomalia: l’anomalia del grande capitalismo italiano. Esso non ha mai saputo dove stessero di casa il libero mercato e la concorrenza e ha avuto con tutti i partiti politici, nessuno escluso, un rapporto di reci- CRITICAsociale ■ 19 1-2 / 2011 proca collusione. Tangentopoli non è un crimine di Craxi degli anni ’80. Tangentopoli è sistema organico costruito negli anni ’40 da Valletta per la parte economica e da Enrico Mattei. Un sistema fondato sul grande capitalismo italiano e sui partiti dell’”arco costituzionale”. DC, PSI, partiti laici, Ugo La Malfa e Partito Comunista Italiano che ne era coinvolto non solo con il finanziamento irregolare dall’Unione Sovietica, non solo con il finanziamento irregolare delle Cooperative Rosse: (non a caso l’unico reato derubricato dopo il ’92-’94 fu l’abuso in atti d’ufficio, che è il reato nel quale cadono gli amministratori comunali che devono favorire le Cooperative Rosse e non a caso l’ultima amnistia in questo Paese, fu quella del 1989 che ha chiuso la partita anche per quello che riguardava il finanziamento sovietico). Come dimostra la direzione del PCI citata da Crainz e da Galli della Loggia il PCI, nelle varie situazioni locali aveva anche un rapporto di scambio con imprese private, quello che da luogo al reato di corruzione. Ma nel momento in cui l’Italia entra in Maastricht il sistema di Tangentopoli diventò anti-economico e quindi va smantellato. Poteva essere smantellato con una grande operazione consociativa. Invece è stato smantellato con una operazione selettiva nella quale anche nel sistema industriale alcuni sono stati salvati, altri sono stati distrutti, altri colpiti e salvati. nel fatto che il centrodestra della DC venne massacrato, mentre la sinistra democristiana viene salvata. Da questo salvataggio la sinistra democristiana finisce alleata di chi l’ha salvata, fino a fare un partito insieme. Sfido chiunque a dimostrarmi che accostando De Mita con Scalfaro e Forlani, risulti evidente che Forlani sia un corrotto e gli altri due invece sono adamantini. Tutti e tre facevano politica nello stesso modo, ma uno è diventato Presidente della Repubblica ed era così protetto, e condizionato, da poter dire in TV anche “Non ci sto”; De Mita ha svolto la sua attività politica, mentre invece Forlani è andato a finire ai servizi sociali e Di Pietro lo ha massa- nere riguarda dieci, mille, cinquemila dirigenti politici, un partito è distrutto con la sentenza anticipata e l’operazione è fatta. Non bisogna mai dimenticare che a Milano c’era una perfetta sinergia tra il pool dei magistrati e il pool dei cronisti giudiziari che lavoravano praticamente assieme in una comunità politica che produceva i fatti che abbiamo visto. Questo è il retroterra che sta alle nostre spalle. Dopodiché Berlusconi che era sfuggito alla vicenda di mani pulite anche grazie alla linea delle sue televisioni, è entrato in politica e ha coperto lo spazio politico che era stato lasciato vuoto con la distruzione della DC, del PSI, dei partiti laici Di conseguenza Berlusconi ha im- Chi nel sistema industriale stava fino alla ci- Occorre spiegare questa situazione nei suoi Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale ma dei capelli nel sistema di Tangentopoli? La FIAT. La FIAT viene colpita marginalmente ma poi viene salvata, così come viene salvato il Partito Comunista Italiano che stava fino alla cima dei capelli anch’esso nel finanziamento irregolare compresi i rapporti con i privati. Il bellissimo libretto “Tre giorni di storia italiana” di Ernesto Galli della Loggia, appena uscito, riporta una citazione dal libro “Il Paese mancato” di Cranz di una direzione del Partito Comunista del ’74 in cui si esamina il problema del finanziamento pubblico. Vari esponenti del Partito Comunista si dichiarano colpiti dai rapporti malsani con i privati che aumentano la corruzione all’interno del partito. Anche il PCI quindi aveva un rapporto corruttivo con imprese private ( oltre a quelli con l’Urss e le Coop) e quindi era dentro Tangentolpoli fino alla cima dei capelli da tutti i punti di vista. Però nel ’92-’94 che cosa succede? Succede che la DC, il PSI e i partiti laici vengono massacrati – sulla DC però c’è da fare una riflessione – e nel Partito Comunista viene colpita la corrente dei miglioristi. Vengono lambiti i berlingueriani, (vedi Cappellini a Milano) ma l’attacco si ferma lì. La FIAT da una parte, De Benedetti dall’altra parte e il PCI da un’altra ancoravengono salvati dalla Procura di Milano, in primo luogo da Di Pietro che acquisisce quindi dei meriti sul campo. Tra tanti episodi ce n’è uno che è straordinario ed esemplare: Sama entra alla direzione del PCI con 600 milioni di lire, più - dico io per schierzare 600.000 lire – e ne esce soltanto con 600.000 lire. Siccome Di Pietro è un noto garantista dice di essere certo che Sama sia entrato con 600 milioni, però non avrebbe potuto accertare a chi li ha lasciati: quindi Cusani e Sama vengono poi condannati per aver fatto un’operazione di corruzione che però non ha il nome del corrotto. Insomma un modo di fare assolutamente discriminatorio, con due pesi e due misure. Due pesi e due misure che sono ancora più visibili nella DC. Mentre verso il PSI l’operazione è equanime, cioè il PSI viene smantellato completamente e anche chi avrebbe voluto “ridare l’onore ai socialisti” ad un certo punto prende una botta che lo mette fuori gioco, per quello che riguarda la DC la dimostrazione che l’operazione è tutta politica sta anni. Tutto ciò marca il drammatico periodo storico che ci costringe a parlare di giustizia: non è una cosa normale. Il mio libro sull’uso politico della giustizia è frutto di una situazione anormale. Dovrei scrivere libri di altro tipo, non sull’uso politico della giustizia. Ma questa è la realtà. Adesso di che discutiamo in televisione se non della vita privata di Berlusconi? Hanno provato a distruggerlo con la vicenda della corruzione e non hanno sfondato, poi hanno continuato con le accuse di mafia e terrorismo per bombe a Roma, a Milano e a Firenze (vedi Spatuzza). Nessuno ci ha creduto. Allora hanno studiato l’uomo anche nella sua singolarità. E si sono concentrati sulla vita privata, al punto tale che un prodotto del ’68 trasgressivo come Gad Lerner sventola in televisione l’ultimo numero di “Chi” che pubblica una fotografia di Berlusconi con 25 parlamentari donne. Siamo oramai alla barbarie totale. Questo è il punto a cui siamo approdati. Concludo per trarne delle conclusioni tutt’altro che piacevoli. Tutto questo ci dice che viviamo in un paese anomalo che ha un nucleo rivoluzionario-reazionario, nero-rosso, micidiale perché si sommano insieme spinte eversive di estrema destra e di estrema sinistra. Bersani bercia alla televisione sulla vita privata di Berlusconi? Non sa dire altro, ma reputa che forse così vincerà le primarie con Vendola. Se lui la spara più grossa su questo terreno, ritiene di poter vendere la partita interna alla sinistra. Siamo a questo punto. Siamo un Paese unico nel mondo occidentale quanto all’uso politico della giustizia e alla sua traduzione mediatica. Da noi il circo mediatico-giudiziario su cui hanno scritto due saggisti francesci è in azione dal 1992, anche, se ha cambiato i suoi bersagli in corso d’opera. crato sul piano mediatico nel processo Enimont, mentre il presidente di quel tribunale si rifiutava di ascoltare Occhetto e D’Alema malgrado che da essi si recò Sanna a Botteghe Oscure per quel famoso incontro. Contro la DC, il PSI, i partiti laici, svolse un ruolo fondamentale il meccanismo della sentenza anticipata. Il principio della sentenza anticipata fu teorizzato da Borrelli in un’intervista fatta a Bernardo Valli. In sostanza Borrelli così la descriveva: “Quello che conta è l’avviso di garanzia, l’eventuale custodia cautelare, il rilancio fatto dai giornali di tutto ciò a quel punto la sentenza è fatta”. Se poi dieci anni dopo l’imputato viene assolto, quello resta un fatto privato. Se un’operazione del ge- pedito che l’operazione giudiziaria trovasse l’atteso sbocco politico immediato, perché col 30% dei voti Occhetto grazie alla nuova legge maggioritaria uninominale avrebbe conquistato il 70% dei seggi. Berlusconi stava scendendo in campo, e subito iniziava le persecuzioni: e viene a sua volta sottoposto al bombardamento giudiziario: mi sembra che Paolo Berlusconi fu arrestato nel gennaio del ’94. Ad ogni modo dal 1994 ad oggi Berlusconi è oggetto dell’attacco giudiziario. Orbene fatto ciò non è un suo fatto privato, ma è un fatto politico di devastante rilievo: il fascismo è durato venti anni, e ora non è più questione di prima o seconda repubblica, ma si tratta dell’uso politico della giustizia che ormai dura da venti termini reali. Evitare le mistificazioni e evitare le manipolazioni. Ho l’impressione che l’apparato mediatico-giudiziario sia molto efficace. Altro che Berlusconi che controllerebbe la situazione mediatica del paese! Ma che cosa controlla Berlusconi? Le intercettazioni telefoniche chi è che le dà ai giornali? Riflette su tutto ciò anche Violante che ha fatto una parziale analisi autocritica nel suo interessante libro “I magistrati”, ma non c’è stato un caso in cui la magistratura sia intervenuta contro le violazioni del segreto istruttorio: sembra porprio che valga il motto: “cane non morde cane”. Ci troviamo di fronte, quindi, ad una situazione fra le più serie e drammatiche della vita di questo Paese perché - Dio non voglia: ci hanno provato nel ’94 e non ci sono riusciti ci stanno riprovando adesso e se salta questa resistenza che è stata impersonata fino adesso da Berlusconi ci verremo a trovare in una situazione con un monoblocco di potere in cui si possono saldare tanti nuclei significativi: quelli amministrativi, quelli finanziarii, quelli istituzionali, quelli mediatici ed editoriali. Quindi la battaglia che si sta conducendo è una elementare battaglia elementare, di tutela di quello che rimane (e non è molto) dello stato di diritto e di fondamentali diritti di libertà. Rispetto a questo dico che a livello parlamentare, a livello culturale, a livello giornalistico, anche tra la gente non impegnata in politica occorre condurre questa battaglia per preservare gli elementari diritti di libertà in questo paese. Questo libro è un minimo contributo a chiarire le cose perché oggi demistificare la manipolazione in atto è già di per sé un’operazione “rivoluzionaria”, una rivoluzione liberaldemocratica per il ripristino dello stato di diritto. s Fabrizio Cicchitto 20 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 MAGISTRATURA ■ IL COLORE POLITICO È STRUMENTALE ALLA DIFESA DEI PRIVILEGI DELLA CORPORAZIONE I NÉ ROSSE, NÉ NERE: LE TOGHE SONO GIALLE l tema della giustizia è talmente vasto che ogniqualvolta si affronta la questione sia pure in astratto, ognuno conduce questa astrazione alla concretezza della vita vissuta. “Il cittadino si imbatte con la giustizia perchè il bisogno di trovare un punto di equilibrio nelle controversie non trova altro luogo di ricomposizione se non nel ricorso alla giustizia: si tratta di vicende minime, dal condomino all’occupazione di uno spazio, all’incidente stradale, insomma il ricorso alla giustizia è il ricorso definitivo dei conflitti quotidiani, anche dei più piccoli”. Naturalmente le questioni che emergono quando si affronta il tema della giustizia, riguardano anche gli alti costi che si debbono sostenere, soprattutto da parte dei ceti più deboli. Tutto questo appartiene alla dinamica della società. Per Rino Formica, che è intervenuto nell’ultimo periodo con una accentuata frequenza in occasione della Riforma costituzionale della Giustizia, di cui ha criticato il fatto che sia stata presentata dal governo e non in Parlamento, “il dato socialmente rilevante nel rapporto con la Magistratura, ciò che crea il maggiore turbamento, è l’incognita se ci si troverà di fronte al “giudice giusto”. “Per affrontare la vera questione della giustizia - sostiene - occorre procedere con un metodo di distinzione logico-razionale degli aspetti prioritari: ci sono problemi di efficienza, ci sono problemi di durata dei processi, ci sono problemi di norme da adeguare ai mutamenti costanti della società, problemi di collegamento tra diritto nazionale e diritti di altri paesi, ecc. La sua stessa natura rende la giustizia ricca di problemi che non possono essere considerati risolti in assoluto una volta per sempre, ma necessita di correzioni ed aggiustamenti”. Recentemente è stato proposto un appello (sottoscritto anche dalla Critica Sociale) perchè la sinistra non sia più pregiudizialmente ostile a discutere finalmente del tema della Giustizia in presenza della Riforma costituzionale presentata dal Governo. “L’appello affronta una questione giusta in forma insufficiente ed alquanto elusiva. Conosco l’onestà intellettuale e la serietà e coerenza sul punto dei tre proponenti, ma ritengo che il loro invito resterà una esortazione perchè non incide su le ragioni politiche che impediscono alla sinistra ufficiale di uscire dal “voglio ma non posso”. Questa sinistra subisce da venti anni l’espansione politica del potere giudiziario. Alla sinistra non riuscì il tentativo maldestro di piegare la maggioranza della magistratura alle sue direttive e si rassegnò a subire il potere della corporazione. Errore fu quello di voler piegare la magistratura ed errore simmetrico è quello della magistratura che vuole piegare la politica considerata capace di produrre metastasi istituzionali. La rottura dell’equilibrio paritario tra Parlamento e togati nel CSM, come avevano ben visto i costituenti, da Calamandrei a Togliatti, da Dossetti a Ruini, da Targetti a Rossi, ha dato vita alla repubblica dei giudici. In uno Stato di diritto se una corporazione domina l’insieme tutto regredisce sino alle primitive regole delle tribù. L’appello evita di affrontare la questione della ineguale struttura del CSM perchè la sinistra alla quale si rivolge è affaticata, debole e subalterna. strata “in nome del popolo” e che i giudici sono soggetti “soltanto alla legge”. Questo articolo 101 va letto in connessione con l’articolo 1: la Sovranità appartiene al popolo che la esercita secondo le forme e i limiti della Costituzione, ossia attraverso le leggi nel rispetto delle norme costituzionali. Quindi c’è una connessione tra la Sovranità popolare e la Magistratura che non è un potere, perchè non discende dalla sovranità popolare, e pertanto non ha un potere autonomo rispetto agli altri poteri costituzionali. E’ una connessione in cui l’incontro tra la Politica (che è l’espressione della sovranità popolare attraverso gli strumenti della dialettica democratica) e la Magistratura, diventa il punto essenziale. I costituenti discussero dell’autonomia della magistratura, e non ci fu nessuno che ritenne che la magistratura non dovesse essere autonoma o che dovesse dipendere gerarchicamente da qualche potere, nè dall’esecutivo, nè da alcun altro potere. Avrebbe dovuto deliberare in assoluta autonomia e libertà. E qui sta il punto cruciale per ciò che intendiamo costituzionalmente per “autonomia” della Magistratura. Perchè essendo l’amministrazione della giustizia un’ ”attività umana” e non un’ attività divina - essa è esercitata dagli uomini, i quali possono agire al massimo “ad immagine e somiglianza” del divino, ma senza esserlo e quindi mai infallibili, con tutti i limiti di ciò che è umano rispetto all’ ”universalmente giusto”. Dunque “autonomia” nel vigilare, controllare, giudicare su qualcosa, come la Giustizia, che supera la sfera dell’umano, è tuttavia svolta nei limiti propri dell’ agire umano, e necessita quindi di una istituzione nella quale si ricomponga un equilibrio tra sovranità popolare e ordine giudiziario”. Rino Formica Tra il ’92 ed il ’97, fu modificato il confine tra potere politico rappresentativo ed ordine giudiziario. La rappresentanza elettiva ebbe la legittimazione popolare ma fu circondata da crescente discredito. L’ordine giudiziario non ebbe mai il formale consenso popolare, ma vide crescere intorno a sè la tolleranza dinanzi al suo sconfinare nell’esercizio di fatto del potere politico. Dal ’97 ad oggi il prestigio della politica non è cresciuto, ma si è anche affievolito il riconoscimento popolare al graduale e progressivo espansionismo politico dell’ordine giudiziario. Ecco dove è la ragione del blocco istituzionale. La magistratura ha invaso il terreno della politica ma è senza scettro anche se può fare del male. La politica è senza la spada, anche se può minacciare. Una stagnazione ribollente può durare, ma a lungo andare prepara il terreno della rivolta istituzionale. Tornare alla saggezza dei costituenti del 1946, trascurando gli adattamenti dei costituenti di fine 1947, è il terreno sul quale può avvenire il dialogo tra politica e magistratura. Questo è l’appello che mi sentirei di sottoscrivere. Il resto è esercizio muscolare che annuncia tempi oscuri”. Cosa accadde allora? “Quando si decise come intitolare il Titolo IV della Costituzione, ci fu una accesa discussione: ci furono i sostenitori dell’intitolazione “La Magistratura”, che indicavano l’ intenzione di affrontare l’ argomento così come nel Capitolo III, cioè come tema specifico, ma sempre relativo alla Pubblica Amministrazione per regolarne l’attività nel quadro dell’ equilibrio dei poteri dello Stato. Ci fu chi ritenne di mettere invece un titolo più vasto, per affrontare nel suo complesso il tema della “Giustizia”. E ci furono infine coloro che sostennero doversi intitolare,”Il Potere giudiziario”. Passò la soluzione di mettere il titolo: “La Magistratura”. Quindi non la “Giustizia”, per codificare una grande aspirazione umana, ma “Magistratura” per la regolamentazione di una “attività umana”. E si escluse che dovesse essere un “potere”. Le proposte avanzate dai costituenti Mastino e Persico di intitolare il capitolo “Potere giudiziario” furono accantonate. Cosa si voleva stabilire, quindi, nel momento in cui si escludeva che la Magistratura fosse un “potere”? Si fissò nell’articolo 101, il primo del Titolo IV, che la giustizia è ammini- Si tratta appunto del Csm. “Il punto di equilibrio si raggiunse attraverso l’idea che l’organo di controllo fosse paritario tra espressione del potere democratico, della sovranità popolare (quindi articolo 1) e un riconoscimento dell’autonomia della Magistratura (art. 101): parità nella composizione del Csm tra rappresentanza di origine parlamentare e rappresentanza dell’ordine giudiziario. Questo è il punto decisivo sul quale avvenne la composizione anche delle normative successive, tra le quali quelle relative all’interpretazione della distinzione delle funzioni tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, così come quelle relative a come interpretare la giusta norma dell’obbligatorietà dell’azione penale. In materia di giustizia non bisogna avere preconcetti, perchè la sua amministrazione è un campo soggetto al continuo trasformarsi delle dinamiche sociali. Del resto la tesi dell’interpretazione dinamica della legge è sempre stata presente nella cultura socialista. Proprio negli anni ’60 fu l’iniziativa socialista che sviluppò nel dibattito politico la necessità che il magistrato non giudicasse in termini cristallizzati, ma interpretasse le norme in relazione alla situazione sociale. Magistratura Democratica nasce da un’iniziativa dei socialisti; i “pretori d’assalto” erano nelle commissioni giustizia del partito socialista. Quindi non ci facciamo velo. Non siamo contrari all’autonomia della magistratura. Ma cosa avvenne nella fine di vita dell’Assemblea costituente. Perchè fai diffe- CRITICAsociale ■ 21 1-2 / 2011 renza tra i costituenti del ’46 e le conclusioni del ’47? Nel novembre del 47, pochi giorni prima della chiusura dei suoi lavori, questo equilibrio fu rotto con l’”emendamento Scalfaro”. Questo emendamento prevedeva la composizione del Csm in “due terzi/un terzo” nel rapporto tra toghe e rappresentanza parlamentare, e trovò l’ opposizione della parte più dinamica della Costituente, tra cui i democristiani Dossetti, Moro, La Pira, Perassi, i socialisti, i comunisti, i liberaldemocratici, compreso il presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini. Vi fu una votazione tormentata ed incerta che diede al blocco conservatore la maggioranza, con un’assenza del 40 per cento dei parlamentari costituenti, che furono presenti al voto in 315320 su 556 eletti. Con questo emendamento veniva depotenziata anche la funzione di arbitro del Presidente della Repubblica, che presiede il Csm divenuto ormai un organismo con una maggioranza precostituita, peraltro formata da una corporazione. Nei primi 20-25 anni di applicazione della Carta costituzionale, l’”emendamento Scalfaro” favorì la maggioranza dei togati di ispirazione conservatrice. La dinamica sociale successiva, dopo il centro sinistra degli anni ’60, gli scontri politici, il terrorismo, l’acutizzarsi delle lotte sociali e democratiche nel Paese, naturalmente influì nella formazione della nuova generazione dei magistrati. Ma con questo non si può dire che ci fu un passaggio dalle “toghe nere” dei conservatori, alle “toghe rosse” dei magistrati di nuova generazione: tutto questo sarebbe stato assorbito all’interno di una rappresentanza paritaria. Con la rappresentanza maggioritaria delle toghe rispetto ai “laici”, invece, la rappresentanza dell’ordine non fu più quella di un particolare colore interno alla corporazione, ma è la rappresentanza della corporazione ispirata dalle sue tendenze prevalenti: essa non privilegia “toghe nere” o toghe rosse”, ma la corporazione, le “toghe gialle”. Che possono essere in alcuni momenti di tendenza conservatrice o ribellistica”. modo assoluto: andremmo a ferire il principio del “libero convincimento” che ogni giudice deve avere. Se si dovesse decidere sulla base di “tabelle” prestabilite, per reati e controversie civilistiche, non ci sarebbe nemmeno bisogno del giudice. Il problema del giudice è il suo comportamento, non il suo convincimento. Se cioè un organo disciplinare equilibrato, composto in modo paritario dal potere democratico e dalla rappresentanza giusta dei togati, possa stabilire se un comportamento isolato o continuato di un giudice sia ispirato da tendenze estranee alle norme del diritto. A me ha fatto impressione il fatto che nell’ANM, quando si è discusso su che comportamento avere nei confronti della Riforma della giustizia, si è ricostituita una unanimità che non c’è nella Giunta esecutiva dell’Associazione, dove Magistratura indipendente è all’opposizione. In quella circostanza, proprio il rappresentante di quella componente moderata, il magistrato Ferri, ha sostenuto la necessità Quindi la questione è tutta squisitamente politica? Qui sta il punto dirimente per comprendere la situazione politico-storica che si è creata tra il 1990 e il 1997. Nella Bicamerale si cercò di scalfire una serie di eccessi attraverso la “bozza Boato”, ma si ridusse in maniera simbolica, e aggiungerei ridicola, la composizione del Csm da “due terzi/un terzo”, in “tre quinti/due quinti”. Tra il ’90 e il ’97 l’indebolimento del potere politico è stato così violento che permane ancora, e attraverso ulteriori circostanze si è aggravato, con leggi elettorali maggioritarie che hanno introdotto elementi di squilibrio e inquietudine. Nel Csm l’equilibrio basato sul principio di parità tra ciascuna delle due rappresentanze, togate e laiche, si formava sulla rappresentanza proporzionale. Oggi invece abbiamo una tendenza alla trasformazione delle minoranze in maggioranze: minoranze elettorali che diventano maggioranze parlamentari, che la corporazione fosse unita, e ha portato come argomento fondamentale proprio il pericolo che lo squilibrio all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura non verrebbe più tutelato, con la Riforma, a vantaggio della corporazione medesima. Sorge cioè un problema che non deve essere risolto dall’Associazione nazionale della Magistratura: ogni corporazione ed ogni ordine che si rispetti tende a tutelare l’espansione del proprio potere. Oggettivamente. Perchè oltre alla finezza dell’interpretazione della norma interviene un potere reale che consiste non nel giudicare se stessi, ma nel giudicare gli altri”. minoranze attive della corporazione che diventano tutrici della totalità della corporazione. Il discredito della politica che permane e si diffonde, non consente di affrontare con autorevolezza il problema del primato della rappresentanza popolare. Questo porterà alla conseguenza che le corporazioni si faranno partito a sè. Superando il partito politico. Del resto questo non è solo il caso della Magistratura. E’ anche il caso dell’informazione che è diventato potere politico. Nel mondo dell’economia c’è un potere che non è più nella Confindustria. Chi guida la danza sono due-tre grandi imprese. Nel campo del credito, sono due-tre Il “colore” diventa secondario rispetto al sistema complessivo dei rapporti tra poteri? “Sono rimasto colpito da una cosa, questa sì veramente incostituzionale: assegnare alla Magistratura un potere politico “di fatto”, quando i costituenti non vollero mai, nemmeno e soprattutto nel titolo del Capitolo relativo a questa materia, prescrivere un “potere giudiziario”, ma vollero scrivere “ordine”. E un “ordine” è qualcosa che sta all’interno di un sistema, l‘ “ordine” non ha una sua autonomia di potere, ma è all’interno di un più vasto potere che è il potere democratico. L’ordine non è una sorgente. Sta in un equilibrio delicato basato sul principio “di essere rispettato, purchè rispetti”. Perchè questo nodo non viene fuori? Perchè la discussione si è appassionata su questioni tecniche che sono risolvibili. La questione dell’obbligatorietà della azione penale da cosa nasce, se non dalla circostanza del sovraccarico di domande di giustizia non più gestibile dalla magistratura? Allora ci vuole qualcuno che dia un ordine a queste domande. Ma questo non può essere dato in modo “assoluto” da chi è ormai un potere politico autonomo di fatto. L’ordine alla domanda di giustizia deve essere stabilito all’ interno di un potere democratico, non autonomo e assoluto. La stessa separazione delle carriere, se funziona bene o meno dopo un periodo di prova, è tutta materia discutibile e risolvibile. Anche la responsabilità civile dei magistrati è risolvibile, perchè nessun giudice lo può essere in grandi banche che avendo incroci di interessi internazionali, sono in condizioni di poter fissare persino le politiche del credito. Oggi la politica può solo fare interventi di natura”ex post” solo quando vi sia una emotività pubblica che esplode. Se si guarda al piccolo caso Parmalat, mi stupisco dello stupore, perchè sono vent’anni che c’è shopping straniero nelle aziende italiane. Nessuno se n’è interessato sino ad oggi. O la politica recupera iniziativa sulle grandi questioni di squilibrio dei poteri, o altrimenti siamo destinati a una corporativizzazione selvaggia di qualsiasi attività umana”. Un risultato anti-nazionale nel 150 anniversario dell’Unità d’Italia. Paradossale. “Certo. E’ una tendenza anti-nazionale: questa è la vera secessione, non il federalismo fiscale”. Se il magistrato, nell’attuale squilibrio all’interno del Csm (a suo vantaggio rispetto alla rappresentanza parlamentare), diventa attraverso l’interpretazione della legge lui stesso fonte del diritto, non ci troviamo nella situazione capovolta in cui la magistratura diventa la effettiva titolare della sovranità, essendo la corporazione sempre in maggioranza nel Csm, ovvero nell’organo di controllo? Infatti essa può sempre stabilire in ultima istanza una norma extraparlamentare prevalendo nell’organismo di autogoverno in merito ai comportamenti che fondano questo tipo di norme. Leggi entro cui soltanto la “sovranità popolare” si può manifestare, e alle quali esclusivamente il magistrato è tenuto a rispondere. Non è un sovvertimento costituzionale? La domanda è esatta, ma bisogna prima cercare di capire un’altra cosa: ovvero, dal 1948 al 1992, queste norme come hanno funzionato? Hanno funzionato bene, perchè la forza, il prestigio e l’autorevolezza della politica, della rappresentanza politica, del Parlamento, dei partiti politici (sia di maggioranza che di opposizione), obbligavano tutte le componenti attive della società a trovare forme di collaborazione. Quando i magistrati oggi invocano il potere politico, affermano che la magistratura ha dato nei decenni un tributo di sangue nella lotta contro il terrorismo e la criminalità. Ma è proprio questo che dimostra come vi era una collaborazione tra politica e magistratura: non c’è stato nessun caduto nella magistratura durante la lotta alla corruzione politica. Pur avendo messo sotto tiro la politica, i magistrati non sono morti, i morti sono stati tra gli indagati. Dunque come i magistrati hanno titolo a dire, giustamente, che nella lotta al terrorismo e la criminalità hanno condotto una lotta eroica e sanguinosa, cosa verissima, proprio per questo le morti vere di persone, di partiti, di forze politiche, di aziende, di interessi, dimostrano che c’è stato uno squilibrio di ingiustizia da parte della magistratura. L’argomento del “tributo di sangue” è vero in entrambi i sensi, e non solamente a senso unico. C’è un censimento da fare: un errore giudiziario fa molto più danno di qualunque ingiustizia politica. L’ingiustizia politica è sanabile con la lotta democratica. Aggiungo poi la notazione che il vuoto tra politica e interessi legittimi, porta un vulnus anche all’interno degli stessi interessi legittimi. L’equilibrio politico democratico serve anche al complesso delle corporazioni e degli interessi, perchè evita che siano essi stessi preda di tendenze minoritarie. Perchè sono le minoranze attive che creano il patriottismo antidemocratico di gruppo. Ma prevalgono anche all’interno della corporazione e la sottomettono”. s 22 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 ■ LA ETEROGENEITÀ DI PARTITI SENZA IDENTITÀ È ALL’ORIGINE DELLA CRISI DEL BIPOLARISMO LA PRIMA PIETRA, UNA LEGA DEI SOCIALISTI? “PER UNIRE I RIFORMISTI NEL SOCIALISMO EUROPEO” La caratteristica dell’attuale sistema politico, dopo vent’anni di seconda repubblica, ormai invecchiata anch’essa, sembra es- Dalla mostra sui 120 anni di Critica Sociale I 120 anni della Critica Sociale, oltre che un anniversario per celebrare e per conoscere meglio il ruolo avuto dal socialismo riformista nella costruzione della società nazionale dopo l’Unità d’Italia, offrono anche l’occasione per un chiarimento non solo storico, ma politico, su ciò che resta dell’identità della sinistra italiana. Non fosse altro che per la coincidenza coi 90 anni dalla scissione comunista al congresso di Livorno. Naturalmente non è un confronto tra Pci e Psi, partiti ormai scomparsi. Ma il modo differente con cui le due storie sono terminate, l’intreccio conflittuale tra le sorti dell’uno e dell’altro partito, collocati su fronti opposti di fronte alla “rivoluzione giudiziaria” -l’uno tra le vittime, l’altro coi “rivoluzionari” - non solo ha lacerato una ferita già aperta, ma l’ha persino aggravata, nonostante le speranze dopo la fine dell’ Urss. Tutto questo potrebbe essere derubricato a “fatti vostri”, ad una questione, cioè, esclusivamente interna a una “vecchia sinistra”, già rottamata o da rottamare. Se non fosse che quello scontro all’ultimo sangue ha scardinato l’ intero sistema politico, ingessandolo per vent’anni in un bipolarismo artificiale ( la posizione della stragrande maggioranza dell’elettorato socialista nel centro destra ne è esempio paradossale, ma più che comprensibile), e nel disordine istituzionale. Alla fine occorrerà dare una coerenza ai progressivi interventi istituzionali con un piano di assestamento conclusivo del sistema politico e dello Stato. Dunque questa “vecchia sinistra” non passa, nè nel bene, nè nel male, perchè la sua vicenda passata e presente si intreccia con lo stato di salute del sistema politico odierno. La soluzione non è dunque questione di “volti nuovi”, ma è la soluzione di una questione “vecchia”, quasi marcita, senza la quale i “volti nuovi” di oggi sono destinati ad affollare la gerontocrazia dei decenni futuri (e i suoi medaglieri). La Critica Sociale ne parla con Emanuele Macaluso, direttore delle Nuove Ragioni del socialismo: entrambe le riviste (con Mondoperaio) sono significativamente animatrici del Comitato promotore per le Celebrazioni dei 120 anni di Critica Sociale, che si svolgeranno nel corso dell’anno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. “Penso che questo bipolarismo - dice Macaluso - sia entrato ormai in crisi non solo, come ha scritto Michele Salvati sul Corriere della Sera, perchè l’eterogeneità dei due poli non fa funzionare il sistema. E’ vero che nell’uno e nell’altro polo c’è di tutto. Ma la verità è che l’eterogeneità è già all’interno dei partiti. Ritengo che la sinistra - questa è l’opinione che ho espresso sulla mia rivista - debba far esplodere questa contraddizione attraverso una crisi costruttiva del Partito democratico con l’obiettivo di una grande forza che metta assieme tutti i “riformisti” e non tutti i “riformismi”, come dicono, di matrice diversa (cattolica, comunista, socialista, ecc). No. Il riformismo deve avere un proprio segno, una sua qualità distintiva, precisa: il riformismo socialista, quello del socialismo europeo”. Intervista con Emanuele Macaluso sere la divaricazione tra identità politiche e partiti politici, tra contenuti e contenitori, dove alla fine i contenuti, le culture politiche, sono in funzione del contenitore, che privo di un suo profilo, non può agire senza spaccarsi, non può radicarsi, essere luogo della partecipazione popolare alla formazione della politica nazionale, come dovrebbe essere il partito politico per vocazione naturale. Non credi? “Il Partito democratico è una coalizione tra la ex Margherita e l’ex Ds. Infatti non è un caso che questo partito non sia riuscito ad avere una sua base politico-culturale, ed ogni volta, quindi, che affrontano temi come quello del testamento biologico, si blocca e non riesce ad assumere una posizione propria come partito. Dall’altra parte è la stessa cosa: la scissione di Fini ha dimostrato che non c’era un partito e che anche nel PdL c’era e c’è di tutto: ci sono i socialisti, i democristiani, l’aziendalismo berlusconiano. Penso allora che il problema di og- gi sia quello della ricostruzione delle forze politiche, dei partiti politici. E’ una cosa a cui pensare già ora per uscire dalla crisi di questo bipolarismo ormai superato. Per il riformismo socialista l’approdo non può che essere un partito che abbia come riferimento il socialismo europeo, dove la storia dimostra che possono convivere anche forze cattoliche: Jacques Delors ha avuto un ruolo straordinario per il partito socialista francese, e non ha mai dovuto nascondere la sua fede cristiana”. Stai ipotizzando una sorta di associazionismo politico tra socialisti di ogni campo, una sorta di Lega dei socialisti? “La trasversalità va bene, ma a condizione che abbia un obiettivo e l’obiettivo deve essere la costruzione anche in Italia di una grande partito socialista come c’è in tutta l’Europa tranne che nel nostro Paese. Altrimenti l’associazionismo politico è un altro equivoco. Dunque una “lega dei socialisti” si può fare, sono sempre favorevole a mettere insieme delle forze che abbiano un obiettivo preciso. Sono sempre colpito dai socialisti che sono nel centro destra e che si esprimono ormai così: “la sinistra dice, la destra risponde”, come se anche loro fossero di destra. Non possiamo mettere insieme destra e sinistra, dobbiamo mettere insieme il riformismo socialista. Questa è la base: un socialismo liberale, democratico come è nella gran parte dell’esperienza del socialismo europeo. Per questo serve che in Italia ci sia un processo di revisione della storia della sinistra italiana una revisione socialista e una revisione comunista. In altri momenti con Rino Formica abbiamo sostenuto che il problema era di farsi carico di tutti gli errori e di tutti i successi delle forze della sinistra italiana, socialisti e comunisti. Se ognuno invece pensa solo di glorificare la propria parte e di mettere solo in evidenza gli errori dell’altra parte, si perdono di vista i nuclei vitali delle due forze. Bisogna ormai posare le armi se si vuole mettere assieme i nuclei vitali delle due storie e conseguire l’obiettivo di una grande forza riformista e socialista in Italia. Tutto questo finora è mancato, ma credo che anche nelle nuove generazioni stia maturando l’idea che una sinistra come quella che c’è oggi in Italia, non sia una sinistra credibile. Anche nelle sue punte più radicali, come quella di Vendola, si tratta di forze di piccola entità. Il partito socialista che sta nel centrosinistra raggiunge l’1 per cento, il 2 al massimo. Un partito socialista (come fu anche il partito comunista) non può non essere un partito di massa, un partito di popolo. Questa è l’esigenza che vedo. L’esigenza di una battaglia politica e culturale per mettere assieme tutte le forze che, comunque e da ovunque provengano, si pongano il problema di dare all’Italia una forza del riformismo socialista di stampo europeo”. Per chiarire eventuali equivoci: proponi una forma di associazionismo politico tra ex socialisti ed ex comunisti purchè si abbia chiaro lo scopo di ricongiungere identità politica e forma partito, superando la situazione di oggi in cui il contenitore si sostituisce ai contenuti? “Perfetto. Un’associazione di forze con l’obiettivo di un partito di sinistra riformista legato al socialismo europeo”. Un partito laburista? “Non ne farei questione di nomi. Il laburismo ha un riferimento nel lavoro e ha un riferimento nella storia del socialismo europeo. Io vengo dal sindacato dove sono stato dodici anni, è la mia prima grande esperienza. Dal ’44 al ’56 ho diretto un sindacato di categoria, quello dei minatori, ho diretto la Camera del Lavoro di Caltanissetta, ho diretto la CGIL siciliana dal ’47 al ’56 e quindi ho vissuto l’unità sindacale. L’unità sindacale si è rotta nel ’48. Ero segretario regionale della CGIL e stavo nel Direttivo nazionale. Partecipai alla riunione del comitato direttivo in cui si definì la rottura: fu una seduta molto drammatica e quindi ho presente questi problemi. La cosa che mi ha sempre turbato e sulla quale non riesco ancora a darmi una spiegazione, che non sia una spiegazione negativa, è che nonostante sia venuta meno la ragione della rottura (e la ragione della rottura del ’48 fu lo sciopero politico per l’attentato a Togliatti, il patto atlan- CRITICAsociale ■ 23 1-2 / 2011 tico, il mondo era diviso e ognuno pigliò la sua posizione), nonostante tutto questo sia finito, non si è tornati l’unità sindacale. La cosa veramente sorprendente è che tra il 1969 e il 1970 si stava definendo il processo dell’unità sindacale con Carniti, Benvenuto, Lama. Con Trentin i metalmeccanici fecero la federazione unitaria, sebbene ci fosse ancora la guerra fredda. Oggi che non c’è più l’Unione Sovietica, non c’è più il partito comunista, non c’è più il partito socialista, non c’è più la democrazia cristiana e non c’è più l’occidente diviso dall’oriente com’era prima, perché il sindacato non è unito? Penso che la responsabilità sia delle burocrazie sindacali, le incrostazioni dei poteri dentro il sindacato che hanno ormai raggiunto una specie di ossificazione in tutte e tre le centrali sindacali che non hanno più provato a mettere insieme un confronto vero. Bisogna vedere se è possibile, o meno, fare una riflessione sulle politiche sindacali, perché non c’è dubbio che oggi la forte divaricazione tra la CGIL e la CISL, tra la CGIL e la UIL è più profonda di quanto non lo fosse negli anni ’50. Siamo tornati indietro, ancora come se ci fosse un sindacato legato al governo, la CISL e la UIL, e un sindacato legato all’opposizione come la CGIL . Quindi siamo tornati a una situazione peggiore di quella degli anni ’50, perché dopo gli anni ’50 questa questione era stata superata sia con il travaglio della CISL e della UIL sia con il travaglio della CGIL: insieme si erano staccati dallo stretto cordone ombelicale che legava l’uno al governo e l’altra all’opposizione. Oggi siamo tornati al peggio del peggio. Il mondo del lavoro di oggi è radunato non in una forza politica con una sua identità ma nel sindacato – occorre quindi stimolare un riavvicinamento e una prospettiva di unità. Io penso che il nostro lavoro politico e culturale della sinistra deve tendere a questo processo”. Una profonda revisione della cultura sindacale potrebbe essere una delle priorità del dibattito di un ipotetico partito del socialismo riformista europeo? Un partito dei lavoratori senza sindacato è inimmaginabile. Del resto così nacque il partito laburista britannico: un’associazione (la Fabian society) e le Unions. “Non c’è dubbio: la questione sindacale è la questione prioritaria a mio avviso. Il socialismo separato dal sindacato non esiste. Il laburismo inglese si è un po’ staccato dai sindacati. Ma non è pensabile una forza socialista senza legami col sindacato, nè un sindacato che non abbia anche un orizzonte politico, non partitico”. ■ “A VOI LA RESPONSABILITÀ DI GUIDARE IL REVISIONISMO ISTITUZIONALE” AI COMPAGNI SOCIALISTI DEL PDL Rino Formica Tra poco si vota per il rinnovo di importanti amministrazioni comunali. Credi che dopo le elezioni dei consigli sia possibile iniziare a dar vita a quell’ipotesi di associazionismo dei riformisti, a quella sorta di Lega dei socialisti, nei municipi? “Penso che se si ricomincia a re-identificare la possibilità di una forza socialista, sia indispensabile partire da un coinvolgimento dei consiglieri comunali, che sono una parte importante, non possono essere lasciati fuori. Bisognerà vedere nel concreto cosa sarà possibile fare: non c’è dubbio che il peso della vicenda dei municipi significa tanto, anzi tantissimo. Vediamo cosa succederà alle elezioni, penso che una iniziativa in questa direzione bisognerà prenderla. Del resto siamo nel 120esimo anniversario della Critica Sociale e il terreno naturale su cui è cresciuto il socialismo italiano è stato anche nei municipi, prima ancora che nelle fabbriche. Il socialismo municipale, la democrazia come partecipazione all’esperienza dell’autogoverno. Non c’è dubbio. Ed è per questo, appunto, che il problema del Comune, della comunità, è stata una delle bussole del vecchio socialismo, ma anche del nuovo socialismo. E’ una strada che va percorsa”. Le riforme istituzionali non necessitano di un quadro più razionale in cui inserirsi? I cambiamenti in corso d’opera, al di là del merito, sembrano andare avanti in ordine sparso. Non è un cavillo, ma una questione di metodo relativa all’equilibrio finale dell’assetto dello Stato e della società. Riprenderesti l’idea della Costituente? La proposta di un’ Assemblea costituente è stata una battaglia che animammo anni fa Formica ed io. Ne scrivevo sulla Stampa di Torino, proponendo non un’assemblea di 600 persone, ma un gruppo ristretto di eletti, sul modello della Costituente del ‘46 composta da 75 membri. Non dovrebbero essere parlamentari, ma personalità elette per un incarico a termine, per un periodo di un anno e mezzo, ad esempio. Se un parlamentare volesse farne parte dovrebbe dimettersi. La Costituente dovrebbe consegnare un testo al termine dei suoi lavori contenente la proposta di riforma da presentare in una legge costituzionale da sottoporre al voto del Parlamento. E’ un progetto a cui si potrebbe lavorare, ma ormai siamo verso la fine della legislatura, se addirittura non si sciolgano le Camere anticipatamente. Abbiamo di fronte solo due anni, di vita politica accidentata, e con la riforma della Giustizia che rischia di non andare in porto per tempo. Aveva perfettamente ragione Formica, che, in un recente articolo, sosteneva che sarebbe stato più opportuno presentare la riforma da parte dei gruppi di maggioranza, piuttosto che dal governo. Il fatto che un potere, che non sia quello del Parlamento, indichi come riformarne un’altro, crea tensioni fortissime. In questo contesto chi propone una legge per andare ad una riforma costituzionale più razionale?”. Una legge istitutiva di iniziativa popolare, ad esempio. “Si può anche fare, ma pensiamoci bene perchè mi sono già battuto per queste cose. Oggi non so se siamo ancora in tempo, perchè la situazione mi pare molto deteriorata e la legislatura ormai è avviata verso la conclusione”. s Intervista a cura di Stefano Carluccio “C Roma, 17 febbraio 2011 ari Compagni, conosco la vostra storia, conosco i vostri tormenti, conosco il vostro orgoglio, ma conosco anche le ragioni profonde della ribellione che in questi diciotto anni di errante navigare vi hanno spinto ad essere fuori dal vostro campo tradizionale di partecipazione civile e di predilezione culturale. Creare un insieme di forze in unʼarea moderata e tollerante sotto la guida di un fruitore delle comodità del vecchio ordine, fu per molti una scelta obbligata. Chi ha resistito a queste tentazioni aveva due vie davanti: o consegnarsi ad una sinistra perdente in politica ma resistente nelle radici dei contropoteri, o lavorare nella semiclandestinità per aprire un varco nella continuità di regime truccata da rottura di ciclo. Coloro che hanno scelto la prima soluzione hanno sentito la mortificazione di essere rinchiusi in un protetto serraglio da circo itinerante, coloro invece, che hanno optato per la seconda ipotesi, hanno dovuto sopportare i colpi che i tempi lunghi di una transizione sanno infliggere ai sopravvissuti di una grande storia. Lʼeffetto congiunto della sterilizzazione del patrimonio socialista, consegnato alla sinistra antisocialista e del lento esaurirsi della vena culturale revisionista del socialismo sommerso, carica , voi socialisti nel centro-destra, di una immensa e, forse, imprevista responsabilità: dichiarare chiusa la fase della resistenza democratica allʼinterno di un contenitore che non ha risposto alla originaria speranza di poter garantire una dialettica nuova e costruttiva alle spinte plurime della società. Oggi il vostro immobilismo ci riproduce il film della timidezza di Craxi che non volle capire sino in fondo la “rottura dellʼ89”. Allora non si seppe costruire lʼalternativa ad una crisi istituzionale di sistema. Lʼimplosione dellʼ89 mise in luce lʼulteriore impoverimento delle “risorse naturali” della Carta Costituzionale (il ruolo dei partiti, il primato della politica, gli equilibri tradizionali dei poteri). La società si era fatta adulta e si era politicizzata liberandosi dalla mediazione dei partiti. Ma in quali forme ciò avvenne? Le ingenuità e le incertezze della società che voleva rappresentanza senza la mediazione dei partiti, ritenne che la sola riscrittura dei linguaggi politici e delle relazioni tra i gruppi facesse germogliare lʼidea, sbagliata ma suggestiva, di poter governare la complessità con la semplificazione delle formule politiche e con lʼaccorciamento della catena dei poteri. La crisi della politica produce il devastante fenomeno del capo carismatico, dominus di unica istanza e luogo esclusivo per la sintesi dei conflitti. Noi socialisti avevamo da tempo (dal Midas) maturato la consapevolezza che la rottura del legame politica-società-istituzioni, avrebbe prodotto una eccezionale domanda di nuovo riformismo che sarebbe entrata in drammatica rotta di collisione con una parte dei poteri strutturati e del ceto politico dominante e culturalmente ostile ad ogni forma di rottura revisionistica. Mani pulite è il momento catartico di questo groviglio e nello stesso tempo funziona da contrasto ad ogni svolta in versione revisionistica. Alle culture politiche si sostituiscono fulminanti intuizioni e narrazioni postideologiche; vecchi strumenti combinati con nuovi linguaggi vengono adottati per selezionare le classi dirigenti. Ma su tutto domina un imperativo: conservare il patto costituzionale, espellere i corpi estranei anticostituzionali, ricucire lo strappo costituzionale fissando, però, una nuova scala gerarchica tra i poteri nella quale la politica non sia più il dominus ma sia la forza servente di una logica extra ed ultra politica (le leggi regolatrici della moralità civile amministrata dalla giurisdizione e non dalla politica che si rinnova). Lo sconfinamento dei poteri al di fuori del quadro politico degli equilibri istituzionali, non fa solo vittime di prima linea, ma devasta e modifica la morfologia del terreno del gioco democratico. I socialisti che Berlusconi imbarcò nellʼArca di Noè, furono schiavi ai remi, ma siccome erano i più bravi salirono sul ponte di comando, ma non convinsero il capitano a capire che una rotta senza bussola porta nelle secche o su gli scogli. Così è avvenuto! Non vi chiedo di prendere la scialuppa e di abbandonare la nave, ma se volete salvare un popolo che deve sostenere la rinascita del Paese con la fine di una transizione tutta giocata allʼinsegna dellʼantipolitica, dovete mettere sottocoperta il capitano, curarlo e sbarcarlo in un porto sicuro. A voi tocca il compito di riprendere la guida delle forze del revisionismo istituzionale, politico e sociale. Voi potete farlo perchè venite da una scuola di liberi pensatori, di refrattari al dominio del potere, e di ribelli alla subalternità sociale. Non vi chiedo di passare con altri, ma di essere voi stessi sino in fondo. Berlusconi quando scoppiò mani pulite, rinnegò Craxi e si sentì sciolto da ogni vincolo di gratitudine. Voi invece, dovete essere riconoscenti per lʼospitalità accordatavi, ma non obbligati a masticare capsule di cianuro, perchè ciò che avete dato è molto di più di quanto vi è stato concesso. E non voglio ricordare che il Cavaliere spesso ha fatto finta di non conoscervi. Spero di rivedervi presto in campo. Con affetto fraterno Rino Formica P.S. Vedo che intorno al Pdl spuntano come funghi velenosi personaggi che in forme truffaldine si richiamano al socialismo. La precondizione per una ripresa della migliore tradizione dei socialisti italiani è disfarsi subito dei Lavitola e dei Graziani e del loro verminaio ” 24 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 ■ LA CHIUSURA NELLA LITIGIOSITÀ EUROPEA RESTA INCOMPRENSIBILE DOPO LA FINE DEL COMUNISMO IL SOCIALISMO ATTRAVERSO LE SUE CRISI N Enrico Landoni ella caduta del Muro di Berlino sono chiaramente individuabili la definitiva sconfitta del paradigma ideologico e politico del comunismo ed il crollo rovinoso del sistema statuale delle cosiddette “democrazie popolari”, la cui crisi drammatica ed irreversibile è in realtà coincisa, più in generale, con il complessivo fallimento di un immane e mostruoso progetto di ingegneria sociale ed economica, chiamato “socialismo reale”. Socialiste, d’altra parte, secondo la definizione delle stesse autorità comuniste al governo dei Paesi succitati e delle loro stesse Costituzioni, erano a vario titolo chiamate le repubbliche comprese tra la vecchia Prussia ed i Balcani.1 L’inesorabile smottamento di queste organizzazioni giuridico-statali, per certi versi, ha quindi finito per mettere in discussione la complessiva validità del socialismo, quale dottrina politica di libertà, emancipazione e progresso, non soltanto all’interno degli Stati del Patto di Varsavia, ma anche e soprattutto nei Paesi dell’Occidente sviluppato e capitalista, a dispetto delle colpevoli sottovalutazioni delle socialdemocrazie europee. L’Internazionale Socialista, che ha svolto un ruolo fondamentale a supporto delle forze del dissenso interno al blocco comunista,2 impegnandosi nello stesso tempo con grande vigore sul fronte del dialogo e della cooperazione con le stesse élite burocratiche al governo delle “democrazie popolari”, tra il 1989 ed il 1991 ha scelto infatti di non affrontare il delicatissimo problema delle profonde interconnessioni di ordine culturale esistenti tra il cosiddetto “socialismo reale” ed il modello socialdemocratico, che, pur incommensurabilmente distanti e diversi tra loro, sono stati per l’appunto legati in qualche modo dall’appartenenza storica ad una comune matrice ideologica e culturale. Agli occhi di quasi tutti i leader dei partiti socialisti dell’Europa occidentale, d’altra parte, in quello specifico frangente il crollo del Muro di Berlino rappresentò non tanto lo stimolo ed il punto di partenza per un complessivo ripensamento ed una profonda revisione ideologica e culturale del socialismo democratico, quanto piuttosto la conferma della sua definitiva vittoria sul comunismo e della scomparsa quindi di ogni reale ostacolo alla piena ed irreversibile affermazione dei suoi valori. Con un certa presunzione, in sostanza, quegli stessi dirigenti delle socialdemocrazie, che, a ragione e con successo, avevano ritenuto di poter in qualche modo contaminare il moloch comunista, disseminando all’interno del blocco sovietico proprio i germi del socialismo democratico ed occidentale e sostenendo coraggiosamente alcuni dei più autorevoli dissidenti, di fronte al crollo di quel complesso sistema, pensarono che il paradigma socialista, in quanto superiore al comunismo, sarebbe rimasto immune dagli inevitabili effetti collaterali di questa drammatica cesura storica. Nei principali Paesi dell’Europa occidentale andò così affermandosi l’idea secondo cui, dopo tutto, le conseguenze della caduta del Muro di Berlino e dell’ineluttabile crollo del comunismo, cui la stessa socialdemocrazia europea aveva contribuito in modo decisivo, avrebbero riguardato e coinvolto di fatto quasi esclusivamente gli stessi Paesi del blocco comunista, senza chiamare in causa, dal punto di vista po- litico e soprattutto culturale, anche le democrazie avanzate dell’Ovest.3 D’altra parte, pochi giorni dopo il fatidico 9 novembre 1989, intervistato dalla televisione francese, persino il grande Mitterand, faticando probabilmente a mettere a fuoco la reale portata dello storico evento che si era da poco consumato in Germania, dichiarò che la crisi irreversibile del modello comunista avrebbe dovuto trovare differenti risposte nazionali, rigorosamente dentro comunque il contesto geopolitico in cui le aberrazioni di quel paradigma erano andate sviluppandosi. Secondo l’allora presidente francese, in sostanza, come ha acutamente sottolineato Marco Gervasoni all’interno di una sua bella biografia politica, la caduta del Muro di Berlino avrebbe riguardato soltanto il comunismo, senza mettere minimamente in discussione l’identità dei socialisti né aprire la strada ad una facile vittoria del libero mercato.4 Anche Willy Brandt, allora Presidente dell’Internazionale Socialista ed indiscusso protagonista del socialismo internazionale, pochi mesi dopo, nell’ambito di un colloquio con Mario Telò per il quotidiano l’Unità, si dimostrò chiaramente di questo avviso, aggiungendo tuttavia di temere fortemente per le sorti del socialismo democratico all’interno dei Paesi dell’Europa orientale, con particolare riferimento all’Ungheria, dove stava montando una forte ondata nazionalista, xenofoba ed ultrareligiosa, alimentata da un vero e proprio furore iconoclasta nei confronti di qualsivoglia retaggio socialista, quand’anche di mera ascendenza semantica.5 Al di là di queste specifiche valutazioni, va più in generale ricordato che tra le file della sinistra europea quasi nessuno volle davvero tenere in debita considerazione il rischio di una possibile ricaduta negativa sulle sorti e le prospettive del modello socialdemocratico del processo di disfacimento del cosiddetto “socialismo reale”. Tra i pochi però che compresero con reale tempismo ed acuta lungimiranza l’assoluta necessità di una nuova piattaforma socialista, di fronte alla crisi irreversibile del comunismo, ed il pericolo di un’incipiente ed incontrolla- bile destrutturazione del solido impianto culturale ed etico della socialdemocrazia, in virtù proprio dell’inarrestabile disfacimento del modello sovietico, meritano una particolare citazione gli intellettuali francesi Gilles Martinet, terrorizzato dal vuoto ideologico e da un vero e proprio horror vacui venutosi a creare in seno alla sinistra europea,6 ed Alain Touraine. Quest’ultimo in particolare, sulle pagine di Le Monde del 23 gennaio 1990, ebbe ad esprimersi con assoluta chiarezza in merito alle possibili conseguenze negative dello smottamento comunista sulla tenuta complessiva del modello socialdemocratico: “La decomposizione dei regimi comunisti […] segna la fine non solo di un modello politico, ma, in senso più largo, di una rappresentazione rivoluzionaria della storia e della società, sulla quale una gran parte della sinistra, persino al di fuori dei Paesi del socialismo reale, si è costituita […]”.7 S econdo il sociologo transalpino, i socialisti democratici ed i comunisti, al di là delle loro profondissime divergenze, si erano trovati a condividere una cultura politica messa davvero a dura prova dagli eventi consumatisi a Berlino nel novembre del 1989 e dal vento di cambiamento che stava spirando di fatto in tutti i Paesi compresi tra il Danubio ed i Balcani. Con il disfacimento del modello comunista, a suo avviso, non sarebbe terminata la storia della sinistra, ma al cospetto dell’ubriacatura liberista che stava favorendo il trionfo del mercato, i socialisti avrebbero dovuto battersi per favorire “l’alleanza tra i nuovi movimenti di ispirazione morale e culturale, con una politica neosocialdemocratica, di lotta contro le disuguaglianze rafforzate dalla concorrenza internazionale e dall’accelerazione dei mutamenti tecnologici ed economici”.8 Dell’esistenza di un legame non tanto politico ed ideologico, evidentemente, quanto piuttosto storico e culturale tra socialismo democratico e “socialismo reale” aveva in realtà parlato, seppur in modo più sfumato e problematico, anche Craxi già in occasione della riunione della Direzione Nazionale del PSI del 29 novembre 1989, ritenendo altresì fondamentale un’ulteriore valorizzazione della vo- cazione internazionalista del partito, proprio nel momento in cui andavano profondamente modificandosi i rapporti di forza che fino a quel momento avevano caratterizzato lo scacchiere internazionale. “Il sistema comunista” - disse Craxi - “usava alternativamente e preferibilmente anzi il termine socialista rispetto al termine comunista: i Paesi socialisti, i regimi socialisti, il socialismo reale. Per noi tutto questo rappresentava un inganno, ma per loro rappresentava una pesante realtà. Sorgono movimenti democratici, di diritti civili, liberaldemocratici e affiorano dei gruppi socialdemocratici. C’è una situazione in movimento, complessa, nella quale naturalmente i socialisti democratici europei dovranno agire in modo tale da potere esercitare una influenza non solo generale ma anche rivolta a gettare le basi di capisaldi socialisti democratici in questi Paesi […]”.9 Anche alla luce di questa citazione, quella di Craxi emerge dunque come una delle coscienze più lucide del socialismo europeo di quel tempo, che, nel suo complesso però, in un momento di particolare difficoltà e di fronte soprattutto alla sfida del futuro e della globalizzazione, anziché recuperare lo spirito creativo e la visione mondiale che avevano indubbiamente favorito il rilancio dell’Internazionale Socialista, a partire dall’importantissimo congresso di Ginevra del 26-28 novembre 1976,10 finì per ripiegarsi su stesso, rinchiudendosi all’interno della litigiosa e disarticolata dimensione continentale, senza riuscire ad elaborare dei condivisibili ed al contempo vincolanti obiettivi per i vari partiti nazionali. Meno di quindici anni erano dunque trascorsi dalla pubblicazione di quello splendido volumetto dal titolo Quale socialismo per l’Europa, contenente l’assai interessante e prezioso scambio epistolare avviato da Brandt nel 1972 con il leader socialdemocratico austriaco, Bruno Kreisky, e con l’indimenticato Olof Palme,11 sulla base del quale era stata completamente riscritta l’agenda politica del socialismo internazionale, eppure il socialismo europeo, in quel frangente, sembrò aver completamente dilapidato e quasi rinnegato, per certi versi, questo inestimabile patrimonio programmatico ed ideale. Aveva dunque inizio, proprio a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, la crisi strutturale del socialismo, rimasto privo, in virtù delle miopi scelte compiute da numerosi leader europei, del suo tratto distintivo e della sua vera forza, ovvero della vocazione internazionalista. Nel momento stesso in cui andava rafforzandosi l’interdipendenza economica tra le varie Nazioni del mondo e le forze del capitalismo internazionale, sospinte dal trionfante verbo neoliberista, si dirigevano alla conquista delle terre vergini dell’Est europeo, la socialdemocrazia europea optò dunque per la definitiva rinuncia ad ogni progetto di trasformazione della realtà, scegliendo addirittura di accantonare irreversibilmente ogni possibile intervento correttivo nei riguardi delle numerose sperequazioni, determinate dall’incontrollata avanzata del mercato. La crisi strutturale del socialismo va tuttavia inserita nel più generale processo di involuzione della politica, che gli interessi economici organizzati sono riusciti a ridurre ormai ad un ruolo ancillare, a loro direttamente subordinato, all’interno delle differenti realtà statuali, peraltro dilaniate da rivendicazioni particolaristiche e drammatici squilibri economici, e CRITICAsociale ■ 25 1-2 / 2011 profondamente segnate da paure irrazionali.12 La globalizzazione economica, la progressiva scomparsa di confini materiali tra i Paesi e la loro crescente interconnessione ed interdipendenza, facilitata dalle nuove tecnologie, unite ad una drastica compressione del ruolo della politica e della sua prospettiva internazionale, hanno paradossalmente finito, d’altra parte, per rivalutare in qualche modo proprio questa dimensione nazionale e localistica.13 Il prepotente riemergere di questa istanza territoriale sembra in realtà aggravare ulteriormente la crisi del socialismo, che, rinchiuso all’interno di una visuale così angusta, fatica a dispiegare la propria carica creativa indissolubilmente legata ad una prospettiva internazionale e mondiale. Alla luce di questa ricostruzione, è dunque facile intuire come l’attualità della crisi socialista non dipenda tanto dalla presenza o meno al governo dei principali Paesi del mondo di forze politiche di ispirazione vagamente progressista e dunque da particolari contingenze, quanto piuttosto dalla perdita di un ruolo e di una visione culturale, prima ancora che politica, di rilievo ed interesse planetario, in virtù anche delle scelte totalmente divergenti assunte in tempi assai recenti, in mancanza di qualsiasi forma di coordinamento, da vari leader socialisti dell’Europa occidentale. Schröder e Blair in particolare hanno tentato l’opzione semplicistica della contrapposizione tra un cosiddetto “vecchio socialismo” ed una “nuova socialdemocrazia”, dall’inconsistente, per non dire impalpabile, impianto ideale e culturale, andando alla ricerca di una terza via tra lo storico paradigma socialdemocratico ed il liberismo dominante.14 A tal riguardo, con un po’ di vis polemica, ma soprattutto con vero spirito costruttivo, si potrebbe forse affermare: tertium non datur. Il socialismo è infatti tale oppure non è, non ha cioè bisogno di anodine aggettivazioni né di particolari specificazioni, come l’espressione “socialismo dei cittadini” utilizzata da Zapatero,15 e soprattutto deve assolutamente inserirsi all’interno di una prospettiva internazionale. Analizzando la sua storia, d’altra parte, emerge in tutta evidenza come i momenti di sua particolare debolezza e crisi siano sostanzialmente coincisi proprio con la perdita di questa visione d’insieme di livello mondiale, con lo sviluppo incoerente e disarticolato di proposte programmatiche profondamente diverse da Stato a Stato e conseguentemente con l’attuazione di politiche destinate ad anteporre gli interessi locali e nazionali ai valori senza frontiere, che stanno alla base dell’internazionalismo socialista. Non va infatti dimenticato che il fallimento della Seconda Internazionale si è tragicamente consumato nell’estate del 1914, con l’approvazione da parte di tutti i partiti socialisti d’Europa, ad eccezione di quelli italiano, serbo e russo, dei crediti di guerra, e con la liquidazione quindi, sull’altare della ragion di Stato, della solidarietà internazionale, che persino il Presidente di questo organismo, il belga Emile Vandervelde, leader del Parti Ouvrier Belge e Ministro del Governo De Broqueville, fu costretto a rinnegare, di fronte alla proditoria invasione del suo Paese da parte delle truppe tedesche.16 Né, a maggior ragione, possono essere tralasciati alcuni specifici riferimenti alla drammatica crisi dell’Internazionale Operaia e Socialista (IOS), che, alle soglie della seconda guerra mondiale, condannò di fatto all’impotenza i principali partiti del movimento operaio internazionale, dopo più di dieci anni di laceranti discussioni, polemiche divergenze ed egoistiche prese di posizione, dettate per lo più da interessi nazionali, di fronte all’emergenza nazifascista.17 La paralisi operativa e programmatica che impedì di fatto ai membri dell’IOS di assumere, tra il 1938 ed il 1939, qualsivoglia iniziativa unitaria, di fronte all’annessione tedesca della regione cecoslovacca dei Sudeti ed all’invasione della Polonia, rappresentò dunque lo sbocco inevitabile di quella che, a buon diritto, può essere considerata la più grave crisi della storia del movimento socialista internazionale, giunto infatti alla fine degli anni Trenta del secolo scorso in una condizione di assoluta prostrazione. Davvero rapidi furono però i tempi della sua ripresa, che culminò in una vera e propria palingenesi di un modello culturale, prima ancora che politico ed economico, destinato a diventare il vero propellente dello sviluppo complessivo dell’Europa occidentale per oltre quarant’anni, non senza, evidentemente, difficoltà o battute d’arresto. All’interno di questa importantissima stagione di pace, conquiste economico-sociali e progresso, il socialismo ha quindi potuto dispiegare il proprio disegno riformatore, conquistandosi, grazie all’impegno ed al contributo di uomini come Brandt, Wilson, Kreisky, Palme, Mitterand, González e Craxi, credibilità, simpatie e consensi in tutto il pianeta, e divenendo quindi un punto di riferimento impre- scindibile nella cultura di tutta l’umanità. Si è trattato ovviamente di un cammino piuttosto lungo, iniziato ufficialmente nel 1951 con la ricostituzione al congresso di Francoforte sul Meno dell’Internazionale Socialista,18 destinata a diventare l’ambasciatrice del socialismo nel mondo, che, proprio grazie al rilancio di questo organismo, letteralmente rigeneratosi nel corso degli anni Settanta, ha conosciuto forse nel 1980 il suo momento di massimo successo internazionale. Il socialismo è giunto al culmine della propria parabola evolutiva, dopo essere riuscito, da indiscusso protagonista, a condizionare l’agenda politica internazionale, assumendosi la responsabilità diretta di articolare proposte davvero attuabili su scala planetaria e capaci soprattutto di modificare, riequilibrandoli, i drammatici rapporti di forza economici esistenti tra nord e sud del mondo. Proprio nel 1980 veniva infatti presentato da Willy Brandt, a nome dell’Internazionale Socialista, il celebre rapporto North-South: a program for survival, che non solo resta di asso- luta attualità, ma sembra rappresentare ancora oggi l’analisi più lucida e completa di uno dei più gravi problemi dell’umanità, a dispetto del colpevole disinteresse attualmente mostrato nei suoi riguardi dalla politica internazionale.19 In questo stesso torno di tempo, inoltre, il gruppo di lavoro sui problemi del Medio Oriente costituito dall’ex borgomastro di Berlino all’interno dell’Internazionale Socialista, riusciva a ritagliarsi un ruolo estremamente rilevante sulla scena internazionale, divenendo un affidabile interlocutore delle parti in conflitto, sotto la guida del grande Olof Palme.20 Il leader della socialdemocrazia svedese, d’altra parte, era stato fino ad allora uno dei pochi statisti di rilievo internazionale ad essere riuscito a tener testa ad alcuni padri della patria israeliana, non senza usare l’ironia tagliente o lo spirito polemico, come quella volta in cui, accusato da Golda Meir e da Yigal Allon di aver avuto dei rapporti diretti con il terrorismo palestinese, osò rispondere a quest’ultimo: “E tu cos’eri, Yigal?”, con riferimento all’attività svolta da Allon contro le autorità inglesi, prima della fondazione dello Stato di Israele.21 Di fronte alla grandezza ed all’autorevolezza degli esempi prodotti da questi dirigenti della socialdemocrazia europea, attorno a due dei più drammatici problemi che affliggono l’umanità e la cui gravità purtroppo non è an- data affatto riducendosi nel corso degli ultimi anni, fa davvero impressione osservare l’imbarazzante titubanza e l’assordante silenzio che sembrano dominare l’azione politica dei socialisti europei. I relativi partiti nazionali, d’altro canto, sono molto divisi tra loro, mentre i rispettivi leader vagano confusamente alla ricerca di una scorciatoia politico-programmatica di mera utilità elettorale, di una terza via, oppure di un nuovo centro, dove poter produrre in vitro una nuova specie di socialismo, contenente una ridottissima quantità di cellule provenienti dal suo passato, depurato del suo pesante armamentario ideologico e culturale, ed un’interminabile serie di luoghi comuni più o meno validi per tutte le famiglie politiche. O ggi però il socialismo non ha bisogno né di apprendisti stregoni né di esperimenti di laboratorio. Necessita al contrario di certezze, storia, passato e tradizioni, la cui frettolosa dismissione sta provocando danni gravissimi a milioni di uomini, sfruttati, impoveriti, privati della libertà personale e messi l’uno contro l’altro dalla sbandierata modernità del capitalismo globalizzato, che sembra tuttavia ricordare molto il modello economico agognato da alcuni “illuminati” industriali di fine Ottocento, inclini a ritenere che i diritti dei lavoratori e la loro complessiva emancipazione rappresentassero un pernicioso ostacolo al libero dispiegamento delle forze del mercato, oltre che un pericoloso attentato all’ordine costituito.22 Al cospetto dunque di questo terribile passato, cui è stato consentito di ritornare sotto le mentite spoglie del futuro e della modernità, sembra francamente impossibile ritenere esaurita la missione storica del socialismo, a meno che naturalmente non se ne ignorino genesi e sviluppo e non si voglia soprattutto perpetuare la mistificazione della storia e della realtà, che ha reso possibile appunto la trasformazione in modernità e progresso della gretta e retriva visione della società sostenuta dai pionieri del capitalismo industriale e la metamorfosi del socialismo da messaggio di liberazione e rivoluzione a preziosa quanto inutile anticaglia. La nuova sfida del socialismo sembra essere dunque quella del ritorno al futuro, cui è possibile approdare solo tornando appunto a denunciare e a criticare le vere forze del passato e della conservazione e a studiare l’economia e la società con i nuovi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, ma con lo stesso approccio dei padri del socialismo internazionale e dello stesso Karl Marx, naturalmente. Il tema della continuità dinamica tra passato e futuro deve pertanto tornare al centro dell’azione politica socialista, come del resto indicato in termini estremamente chiari pochi mesi prima della sua morte da François Mitterand, all’indomani della sconfitta del PS alle presidenziali francesi del 1995: “Ogni debolezza del Partito Socialista nei confronti del centro lo conduce alla sconfitta e ogni volta che questa tentazione riappare finisce per indebolire il partito. Il PS non deve mai dimenticare che la sua battaglia, ben lungi dal trovarsi nel campo politico, è prima di tutto una battaglia contro le forze sociali, che, loro, determinano le condizioni della battaglia politica. Non c’è per i socialisti che questo ancoraggio a sinistra. Non ammetterlo significa solo perdere la propria forza e la propria identità e correre irrimediabilmente verso la disfatta. Per il futuro, come per il passato, la vittoria della sinistra è possibile a condizione che resti se stessa. Al di fuori del grande rassemblement delle masse popolari non c’è salvezza”.23 Facendo tesoro di questa lezione e ponendo fine soprattutto alla stagione delle pericolose alchimie politico-programmatiche ed elettorali, che tanto gli hanno nuociuto, a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, il socialismo può davvero tornare a svolgere un ruolo centrale nella definizione della nuova agenda politica mondiale, sulle cui priorità una gloriosa organizzazione come l’Internazionale Socialista, oggi presieduta da George Papandreou e assolutamente bisognosa di un complessivo riassetto, deve saper esprimere una posizione chiara ed utile in particolare alla causa del nuovo proletariato internazionale, al di là di ogni confine statale e politico. “Quali sono gli interessi che vogliamo difendere? Quelli delle classi operaie di un certo numero di Paesi, o quelli di tutto il genere umano? La storia dovrebbe averci insegnato che seguire il primo obiettivo, separatamente o decisamente contro il secondo, non solo è ingiusto, ma anche illusorio […]”.24 Lo disse Craxi a Ginevra nel 1976, al cospetto dei delegati al XIII congresso dell’Internazionale Socialista. Sarebbe davvero opportuno ripeterlo oggi, alla luce dell’assoluta attualità dell’impegno internazionalista. s Se lavori in proprio, possiamo fare business insieme. Oggi chi lavora in proprio ha un aiuto in più. È Business Insieme, un’ampia offerta di servizi e prodotti personalizzati per sostenere liberi professionisti, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori. Vieni in Filiale a parlare con uno dei nostri Gestori. Troverai la soluzione adatta alle tue esigenze. Massimo Corona, artigiano. www.smallbusiness.intesasanpaolo.com Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali consultare i Fogli Informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca. CRITICAsociale ■ 27 1-2 / 2011 NOTE 1 Sulle peculiarità politiche e giuridiche di ciascuno degli Stati appartenenti al blocco sovietico e sugli eventi che condussero alla loro liberazione dal comunismo si veda in particolare Bruno Bongiovanni, La caduta dei comunismi, Garzanti, Milano 1995. 2 Sullʼattività svolta su questo fronte da Bettino Craxi in particolare, che dal 1976 al 1992 è stato Vicepresidente dellʼInternazionale Socialista, si vedano soprattutto lʼintervento di Lech Walesa al convegno Bettino Craxi, il socialismo europeo ed il sistema internazionale, che è stato organizzato dalla Fondazione Craxi e si è svolto a Milano nel gennaio del 2005, pubblicato in Bettino Craxi, il socialismo europeo e il sistema internazionale, a cura di Andrea Spiri, Marsilio, Venezia 2006, pp. 219-222, e la relazione di Andrea Spiri e Victor Zaslavsky, I socialisti italiani e il dissenso nellʼEst europeo, pubblicato nello stesso volume, pp. 155-181. 3 Con particolare riferimento alla realtà italiana, davvero emblematica di questo orientamento apparve lʼintervista rilasciata da Biagio De Giovanni a Franco Cuomo e pubblicata con il titolo Il comunismo è una storia ormai conclusa sullʼAvanti! del 31 gennaio 1990. 4 Cfr. Marco Gervasoni, François Mitterand. Una biografia politica e intellettuale, Einaudi, Torino 2007, pp. 205-206. 5 Cfr. LʼInternazionale Socialista. Storia, protagonisti, programmi, presente e futuro. Colloquio con Willy Brandt, a cura di Mario Telò, lʼUnità, Roma 1990, pp. 22-24. 6 Cfr. Gilles Martinet, Vuoto ideologico nella sinistra, in Avanti!, 29 novembre 1989. Sulla crisi politico-programmatica della sinistra europea lʼex ambasciatore di Francia a Roma scrisse in particolare: “La cultura rivoluzionaria, che è sempre servita da stimolo allʼazione riformista, quando questa non si atteneva al puro pragmatismo, ha conosciuto un crollo pressoché completo. Siamo dunque in presenza di un encefalogramma quasi piatto. Finito il tempo dei miti, affrontiamo infine i problemi concreti, senza a priori e senza pregiudizi! A chi ragiona così, io consiglierei la prudenza, poiché la storia di questo secolo ha conosciuto periodi in cui si è creduto di poter annunciare la fine delle ideologie, e altri periodi in cui queste sono risorte maliziosamente al momento in cui meno ce lo si aspettava. Lʼumanità può difficilmente fare a meno di miti, siano essi religiosi o laici […]. Oggi si pongono mille problemi dei quali i più importanti per i socialisti […] sono lʼaumento delle ineguaglianze, la persistenza della disoccupazione, le minacce allʼambiente, lʼintegrazione dei lavoratori immigrati, e, ovviamente, anche il problema di unʼEuropa comunitaria che non si può limitare alla libera circolazione dei capitali [… ]. Gli obiettivi unificatori, globalizzanti del passato […] hanno dovuto essere abbandonati o ridimensionati […]. In mancanza di simili obiettivi e di un nuovo grande disegno, le divergenze di interesse aumentano, le ineguaglianze riemergono e i movimenti sociali assumono un carattere sempre più corporativo […]”. 7 Alain Touraine, Peut-on encore être de gauche?, in Le Monde, 23 gennaio 1990. 8 Ibidem. 9 Il testo dellʼintervento pronunciato da Craxi in occasione della succitata riunione della Direzione Nazionale del PSI è stato pubblicato sullʼAvanti! del 30 novembre 1989. 10 Sullʼimportanza del XIII congresso dellʼInternazionale Socialista si vedano in par- ticolare LʼInternazionale socialista. Storia, protagonisti, programmi, presente e futuro, cit., pp. 11-12; Gianni Finocchiaro, Una svolta dellʼInternazionale Socialista al 13° congresso, in Affari Esteri, a. IX, n. 33, gennaio 1977, pp. 115-130; Lucio Pesetti, LʼInternazionale Socialista dal 1951 al 1983, Marsilio, Venezia 1989, pp. 120-175. 11 Cfr. Willy Brandt - Bruno Kreisky - Olof Palme, Quale socialismo per lʼEuropa, Lerici, Cosenza 1976. Per un profilo politico e biografico di questi tre indimenticati leader della socialdemocrazia europea si vedano in particolare Peter Koch, Willy Brandt: eine politische Biographie, Ullstein, Berlin - Frankfurt 1988; Willy Brandt: ein politischen Leben, 1913-1992. Katolg zug einer Ausstellung des Archivs der sozialen Demokratie der Friedrich Ebert Stiftung, a cura di Werner Krause, Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich Ebert Stiftung, Bonn 1993; Barbara Marshall, Willy Brandt: a political biography, Macmillan, Basingstoke 1997; Gregor Schollgen, Willy Brandt. Die Biographie, Propylaen, Berlin 2001; The struggle for a democratic Austria. Bruno Kreisky on peace and social justice, edited by Matthew Paul Berg, Berghan Books, New York - Oxford 2000; Paolo Magagnotti, Il cancelliere man- stemi produttivi territoriali?, a cura di Marcello De Rosa e Domenico De Vincenzo, Liguori, Napoli 2002. Di fronte poi allʼemergere 14 Uno dei principali ispiratori della profonda revisione politico-ideologica, cui Gerhard Schröder nella seconda metà degli anni novanta ha sottoposto la SPD, è stato Ulrich Beck. Tra le sue opere si vedano in particolare Was ist Globalisierung? Irrtumer des Globalismus-Antworten auf Globalisierung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998, la cui traduzione in italiano è stata pubblicata da Carocci lʼanno successivo; La società del rischio: verso una seconda modernità, Carocci, Roma 2000; Anthony Giddens, come noto, è stato invece il principale punto di riferimento ideologico-culturale di Tony Blair, soprattutto agli esordi della sua esperienza di governo. Si vedano in particolare, tra le sue opere, Oltre la destra e la sinistra, Il Mulino, Bologna 1997 ed il celebre pamphlet La terza via, Il Saggiatore, Milano 1999. Sul New Labour e la figura di Tony Blair in particolare si vedano invece Jim Claven, The centre is mine: Tony Blair, New Labour and the future of electoral politics, Pluto Press, Annandale 2000; John Crowley, Sans epines, la rose. Tony Blair, un model pour lʼEurope?, La Decouverte, Paris 1999; Tony Blair in his own da a dire. Intervista a Bruno Kreisky, RBS, Trento 1980; Jan Bondeson, Blood on the snow. The killing of Olof Palme, Cornell University Press, Ithaca - Londra 2005; Aldo Garzia, Olof Palme. Vita e assassinio di un socialista europeo, Editori Riuniti, Roma 2007; Tra utopia e realtà: Olof Palme e il socialismo democratico. Antologia di scritti e discorsi, a cura di Monica Quirico, Editori Riuniti, Roma 2009. 12 Su questo specifico argomento sono usciti di recente numerosi lavori di taglio prevalentemente sociologico e psicologico. Si veda in particolare, tra questi, il volume collettaneo curato da Gioacchino Lavanco e pubblicato nel 2003 da Franco Angeli con il titolo Psicologia dei disastri. Comunità e globalizzazione della paura. 13 Soprattutto gli studiosi di economia, negli ultimi tempi, si sono trovati a riflettere su questo tema, riuscendo, in alcuni casi, a proporre delle stimolanti chiavi di lettura delle complesse dinamiche socio-economiche che caratterizzano la società contemporanea. Cfr. Glocalismo: lʼalternativa strategica alla globalizzazione, a cura di Jerry Mander e Edward Goldsmith, Arianna, Casalecchio di Reno 1998. Tra i più recenti lavori pubblicati a questo riguardo, con particolare riferimento però alla realtà italiana, si vedano invece Il sistema finanziario italiano tra globalizzazione e localismo, a cura di Pietro Alessandrini, Il Mulino, Bologna 2001; Tra globalizzazione e localismo: quale futuro per i si- words, edited by Paul Richards, Politicos, London 2004; Florence Faucher-King – Patrick Le Gales, Tony Blair 1997-2007. Le bilan des reformes, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 2007; John Rentoul, Tony Blair, Warner Books, London 1996; Id., Tony Blair. Prime Minister, Little, Brown and Company, London 2001; Andrea Romano, The boy. Tony Blair e i destini della sinistra, Mondadori, Milano 2005; Jonh Sopel, Tony Blair: the moderniser, Bentham Books, London 1995. 15 Sulla politica del PSOE e la figura di José Luis Rodríguez Zapatero si vedano in particolare Anna Bosco, Da Franco a Zapatero. La Spagna dalla periferia al cuore dellʼEuropa, Il Mulino, Bologna 2005; La Spagna di Zapatero, a cura di Anna Bosco e Ignacio Sanchez-Cuenca, Il Mulino, Bologna 2009; Alfonso Botti - Carmelo Adagio, Storia della Spagna democratica. Da Franco a Zapatero, Bruno Mondadori, Milano 2006, pp. 135-185; Marco Calamai - Aldo Garzia, Zapatero: il socialismo dei cittadini. Intervista al premier spagnolo, Feltrinelli, Milano 2006; Jorge Gutierrez Chavez, Zapatero. Il riformista che fa quello che dice, Editori Riuniti, Roma 2006. 16 Cfr. Franco Andreucci, 1899-1914. Il movimento operaio unito nella Seconda Internazionale, in LʼInternazionale Socialista. Storia, protagonisti, programmi, presente e futuro, cit., pp. 101-113. 17 Cfr. Leonardo Rapone, 1914-1945. Drammatiche scissioni tra due guerre mondiali, ivi, pp. 114-135. A tale riguardo si vedano inoltre LʼInternazionale Operaia e Socialista tra le due guerre, a cura di Enzo Collotti, Feltrinelli, Milano 1985; Patrizia Dogliani, La ricostituzione della Internazionale Socialista nel primo decennio postellico (19181928), estratto dagli Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 1983-1984, pp. 225277; Milos Hajek, Il fascismo nellʼanalisi dellʼInternazionale Operaia Socialista, ivi, pp. 389-430; Mario Mancini, LʼIOS e la questione del fronte unico negli anni Trenta, ivi, pp. 177-198. 18 Cfr. Antonio Missiroli, 1945-1990. Quando Brandt disse: “Ricominciamo da capo!”, in LʼInternazionale Socialista. Storia, protagonisti, programmi, presente e futuro, cit., pp. 136-153. Si veda inoltre Internazionale Socialista 1951-1974, a cura dellʼIstituto di Studi Socialisti, Società Edizioni Popolari, Roma 1974, pp. 10-35. 19 Cfr. Willy Brandt, Memorie, Garzanti, Milano 1991, pp. 395-400. 20 Cfr. Aldo Garzia, Olof Palme. Vita e assassinio di un socialista europeo, cit., pp. 173-177. 21 Cfr. Willy Brandt, Memorie, cit., pp. 449454. 22 Per oltre un ventennio in Italia, a cavallo tra gli anni Settanta e Novanta del diciannovesimo secolo, il fondamentale punto di riferimento per i sostenitori di queste posizioni assolutamente retrive dal punto di vista sociale ed ultraliberiste, sotto il profilo più squisitamente economico, è stato il vicentino Alessandro Rossi, nominato Senatore del Regno nel 1870. Il patron dellʼomonimo lanificio, nonché leader dellʼAssociazione Laniera Italiana da lui fondata nel 1877, si distinse in particolare per la vis polemica con la quale, nel corso della propria lunga attività politica, imprenditoriale e pubblicistica, continuò a sostenere un punto di vista assolutamente critico nei confronti di qualsivoglia intervento regolatore dello Stato nellʼeconomia del Paese, soprattutto sul fronte dei diritti dei lavoratori e delle tutele delle categorie più deboli, rappresentate dai fanciulli e dalle donne. Proprio a questo riguardo, dissentendo totalmente dalle proposte avanzate da Luigi Luzzatti e sostenute allora dal terzo Ministero Cairoli, il senatore Rossi ebbe infatti ad esprimersi con la consueta franchezza, soprattutto in ordine al problema del nascente conflitto di classe, finendo, tra lʼaltro, per utilizzare degli argomenti tuttʼaltro che avulsi dal corrente dibattito economico: “Eʼ tempo che si smetta da taluni intorbidatori della questione sociale di considerare come opposti gli interessi del capitalista e del salariato, affermando alla stregua di sofismi che i rapporti tra imprenditori ed operai sono divenuti cozzo e battaglia di due interessi egoistici ed escludentisi a vicenda. Lʼintromissione tra gli uni e gli altri del comando della legge non fa che rattizzare il veleno di questi sofismi, ed inoltre dà luogo ad una delle più strane contraddizioni ed ingiustizie umane […]”. Alessandro Rossi, Perché una legge? Osservazioni e proposte sul progetto di legge per regolare il lavoro delle donne e dei fanciulli, Tip. Barbera, Firenze 1880, p. 135. 23 François Mitterand, Mémoires interrompus, Odile Jacob, Paris 1996, p. 245. 24 Per un nuovo internazionalismo, discorso di Bettino Craxi al XIII congresso dellʼInternazionale Socialista, Ginevra 26-28 novembre 1976, pubblicato in Bettino Craxi, LʼInternazionale Socialista, a cura di Claudio Accardi, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1979, pp. 23-39. 28 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 ■ INADEGUATI I PARALLELI STORICI TRA LE “RIVOLUZIONI DEI GELSOMINI” E LA FINE DELL’EST SOVIETICO. UN ARTICOLO DEL PREMIO PULITZER NEL MONDO ARABO È IL 1848, NON IL 1989 “O Anne Applebaum gni rivoluzione va vista nel suo contesto, ognuna ha un impatto distintivo. Le rivoluzioni si espandono da un punto all’altro. Interagiscono all’esterno in modo limitato. Il dramma di ogni rivoluzione si svela separatamente. Ognuna ha i suoi eroi, le sue crisi. Quindi ciascuna di esse richiede un racconto a parte. “Questo potrebbe essere il primo paragrafo di storia del futuro sulle “Rivoluzioni arabe del 2011”. Di fatto, è tratto da una introduzione di un libro sulle rivoluzioni europee del 1848. Nelle scorse settimane, parecchi, inclusa la sottoscritta, hanno paragonato le folle di Tunisi, Bengasi, Tripoli, e Cairo con le piazze di Praga e Berlino vent’anni fa. Ma c’è una importante differenza. Le rivoluzioni di piazza che hanno posto fine al Comunismo ebbero esiti simili perché seguivano un singolo avvenimento politico: l’improvvisa mancanza di sostegno dell’Unione Sovietica al dittatore locale. Le rivoluzioni arabe, invece, sono il prodotto di diversi cambiamenti, economici, tecnologici, demografici, e si sono sviluppate su distinti significati e aspetti in ogni nazione. In questo senso, ricordano i moti del ’48 e non quelli del 1988. Anche se ispirate molto generalmente dalle idee di una democrazia e di un nazionalismo liberale, la maggior parte dei dimostranti appartenenti alla classe media del 1848 avevano, come i loro contemporanei arabi, diversi obbiettivi in ciascuna nazione. In Ungheria, chiedevano l’indipendenza dall’Austria asburgica. In quella che oggi è la Germania, puntavano a riunire le popolazioni di lingua tedesca in un singolo Stato. In Francia, la loro intenzione era rovesciare il sovrano un’al- I l Ministro degli Esteri, il socialista Franco Frattini, non ha “parlato a vanvera”. Evidentemente sa quel che dice, anche per il garbo con cui ha sopito sul nascere ogni polemica con la Lega Nord, fuori luogo in questa situazione. Il ministro semplicemente non è restato insensibile a ciò che il Presidente Napolitano ha richiamato pochi giorni fa durante le celebrazioni del 150 anniversario dell’Unità d’Italia al Teatro Regio di Torino. Principi già espressi nel discorso solenne di fronte alle Camere il 17 marzo e declinati concretamente in relazione alla crisi libica. “Non possiamo lasciare - ha detto il Presidente della Repubblica - che vengano calpestate le speranze del popolo libico”. Ci attendono ore difficili per le difficili scelte che abbiamo il dovere di compire: “Se pensiamo a quello che è stato il Risorgimento come movimento liberale e liberatore - ha detto Il Presidente Napolitano in sintonia col Presidente Obama - non possiamo restare indifferenti alla sistematica repressione di fondamentali libertà in qualsiasi Paese. Non possiamo lasciare che vengano distrutte e calpestate le speranze, che si sono accese, di Risorgimento anche nel mondo arabo, cosa decisiva per il futuro del mondo”. Il paragone che il Presidente Napolitano ha fatto tra quanto sta accadendo di straordinario (e di insperato fino a poco fa) nella sponda sud del Mediterraneo e il Risorgimento italiano, piuttosto che con l’89 dell’est europeo, è una lettura che, tranne in questo decisivo caso, non circola nella nostra sag- tra volta. In alcune nazioni, la rivoluzione portò a battaglie fra diversi gruppi etnici. Altre vennero fermate da un intervento esterno. La maggior parte dei moti del 48 fallì. Gli ungheresi riuscirono a cacciare gli austriaci ma solo per breve tempo. I tedeschi fallirono la loro unificazione. I francesi crearono una repubblica che cadde pochi anni dopo. Costituzioni vennero scritte e poi abrogate. I sovrani furono detronizzati e re-insediati. Lo storico A.J.P. Taylor definì il 1848 un momento nel quale la storia raggiunse un punto di svolta senza riuscire a svoltare. Comunque a lungo termine, i temi discussi nel 1848 si radicarono nella cultura, e alcuni dei piani rivoluzionari finirono per concretizzarsi. Alla fine del ‘800, il cancelliere Bismarck unificò la Germania, e la Francia vide realizzarsi la Terza Repubblica. Le nazioni un tempo governate dagli Asburgo guadagnarono l’indipendenza dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1849, molte rivoluzioni del 1848 possono essere sembrate disastrose, ma guardando indietro nel 1899 o nel 1919, saranno apparse come l’inizio di un successo. Nel mondo arabo di oggi, stiamo vedendo diverse popolazioni con obbiettivi diversi prendere in mano le dimostrazioni di piazza, ognuna delle quali va giudicata “nel suo contesto”. In Egitto, le decisioni prese dai militari possono aver avuto lo stesso peso delle azioni delle folle di civili. Nel Bahrain, il conflitto fra sunniti e sciiti è chiaramente il focolaio centrale. Il ruolo dell’Islam non è lo stesso in paesi diversi fra loro, come lo sono Tunisia e Yemen. In Libia, il regime ha già dato prova di voler ricorrere a repressioni violente, cosa che in altri casi è stata evitata. Nonostante la tentazione di accomunare tutti questi avvenimenti ■ LA POLITICHETTA DELLA LEGA E LE RIVOLUZIONI NEL NORD AFRICA TRA DITTATORI E IMMIGRATI gistica, mentre circola a livello internazionale ai più alti livelli tra gli studiosi, in particolare angloamericani. E’ il caso dell’articolo, uscito il mese scorso sul Washington Post, del premio Pulitzer, Anne Applebaum, che pubblichiamo in queste pagine. La Applebaum, è editorialista di politica estera, repubblicana, sostenitrice del principio che un intervento esterno, anche militare, debba essere offerto quando il moto democratico abbia un suo sviluppo autonomo nel paese e quando il popolo chiede un aiuto. E ciò che fece Giuseppe Maz- zini chiedendo agli inglesi di intervenire a difesa della Repubblica Romana nel 1849, la cui inaspettata mancanza di sostegno egli rimproverò aspramente. Nella lettera a Carlyle, teorizzò per la prima volta il primato dell’“l’internazionalismo democratico” sulla realpolik di allora che suscitò il suo disprezzo. In quella stessa circostanza, viceversa, una delegazione di ufficiali americani chiese al proprio governo di intervenire (lo testimoniava Margaret Fuller, corrispondente per la New York Tribune dalla Repubblica romana). Ma quando la de- e di discuterne sotto una singola denominazione quale “Le rivoluzioni Arabe” sia forte, le differenze tra le singole nazioni potrebbero rivelarsi più importanti delle loro similitudini. Allo stesso modo è vero che dal 2012, alcune o forse tutte queste rivoluzioni potrebbero sembrare fallite. I dittatori potrebbero tornare al loro posto, la democrazia cadere, i conflitti diventare guerre etniche. Come nel 1848, il cambiamento del sistema politico potrebbe richiedere molto tempo e potrebbe non arrivare affatto da un moto popolare. I negoziati, come ho scritto qualche settimana fa, sono in genere un canale migliore e più sicuro per il passaggio di potere. Alcuni dei dittatori regionali potrebbero addirittura accorgersene. Pensare al 1848 fornisce un utile metro di giudizio. Ci fu un momento, al culmine delle manifestazioni del Cairo, mentre sedevo nel mio salotto e guardavo in diretta Hosni Mubarak che si rivolgeva al popolo egiziano. Posso vederlo parlare, ascoltare la traduzione, osservare le reazioni della folla: per un momento, era possibile immaginare di assistere alla realizzazione in tempo reale di una rivoluzione. Ma di sicuro stavo vedendo solo quello che le telecamere mi mostravano e tanto di quello che era davvero importante non era visibile; gli uomini in divisa che negoziavano dietro le quinte ne sono un esempio. La televisione crea l’illusione di una narrativa lineare, dando agli eventi l’impressione di un inizio, di uno sviluppo e di una fine. La vita reale non è mai così; i moti del ‘48 non furono così. Possiamo aiutarci nel giudicare la confusione della Storia, di volta in volta, perché ci ricorda quanto non sia dissimile dal presente. s Washington Post, 21 febbraio 2011 Traduzione a cura di Ilaria Calamandrei cisione, sostenuta dall’opinione pubblica statunitense, venne presa, era ormai troppo tardi: Garibaldi aveva perduto a Mentana. La solidarietà internazionale verso la libertà dei popoli e i diritti umani è nel Dna dell’Italia che stiamo celebrando, è la “sua ragione sociale” di Nazione democratica e occidentale. Chi non apprezza il nostro Risorgimento, quindi, non può comprende il Risorgimento altrui ed è miope verso i grandi vantaggi che il successo di questi eventi porterà a tutti. Ai popoli del Mediterraneo e quindi anche al nostro Paese. Una miopia, quella leghista, che non si accorge di danneggiare se stessa: i popoli liberi non scappano a Lampedusa. La libertà è la soluzione al problema degli immigranti, il vero modo di aiutarli nel loro Paese. Senza internazionalismo democratico, il federalismo si metterà sotto assedio da solo, defluirà nei torrenti valligiani tornando alla sorgente, anzichè irrigare tutta l’Italia come potrebbe e come la Costituzione chiede di realizzare già dal ’47. Pietro Nenni, proseguendo nell’idea di Gaetano Salvemini (“Federalismo e Mezzogiorno”, Critica Sociale - 1900), proponeva una futura Repubblica basata sulle autonomie già nell’agosto del ’45 dalle colonne dell’Avanti!. Internazionalismo, federalismo, autonomismo sono tutti aspetti del principio di autogoverno e sono dunque nel Dna anche del socialismo democratico e liberale. Non c’è quindi un copyright, in proposito: ogni grave cade per la via più breve. s La Critica CRITICAsociale ■ 29 1-2 / 2011 ■ L’ISPIRAZIONE MAZZINIANA DELL’ART. 11. NO ALLA GUERRA, MA ANCHE LE ARMI A DIFESA DEI DIRITTI L’INTERVENTISMO È NELLA NOSTRA COSTITUZIONE S i può dire che la cultura politica democratica, dalla rivoluzione francese in poi, è interventista. Va poi giudicato se l’interventismo sui valori (“rovesciare i troni per rilanciare i popoli”, che è lo slogan di Napoleone) risponde a un effettivo processo di espansione della democrazia oppure risponde anche ad interessi politici, strategici, economici di potenza. Per esempio, nel caso di Napoleone è indubbio che egli rovesciò l’Europa e molti troni, ma poi diventò imperatore. Tuttavia nello stesso tempo mise in moto quello sconvolgimento delle idee che poi produrrà la primavera dei popoli, cioè quel fenomeno che nell’800 porta alla nascita delle nazionalità moderne, alla libertà e anche alle idee più radicali della democrazia. Allo stesso mazzinianesimo. Mazzini un democratico interventista: in che senso? Nel senso che avrebbe voluto che l’Inghilterra partecipasse al moto di emancipazione dell’Italia, dei patrioti italiani, perché erano oppressi da un sistema autoritario e centralistico (rappresentato dall’Austria), che negava le nazionalità e la libertà. Quindi, egli riteneva che l’Inghilterra, come paese liberale e democratico, dovesse sentire l’obbligo di aiutare co- intervista con Zeffiro Ciuffoletti loro che la libertà e la democrazia non l’avevano e non avevano nemmeno la propria nazionalità. Questo è l’elemento chiave del pensiero di Mazzini. In questo, il pensiero democratico americano è rimasto tributario di Mazzini. Nel corso della prima guerra mondiale gli americani intervenirono sul fronte europeo (nel 1917), rovesciando le sorti dello scontro – pochi lo ricordano ma si trattò di circa 900.000 soldati che sbarcarono nel Continente; un esempio di interventismo della democrazia statunitense. Il presidente Wilson, quando venne in Europa alla fine del conflitto, si recò immediatamente a Genova presso la tomba di Mazzini. Si trattò dell’unica cerimonia pubblica di cui vi fosse notizia sul giornale socialista “Il Lavoro” di Genova. Diverse università italiane chiesero poi di poter rendere omaggio a Wilson. Tanti atenei conferirono la laurea honoris causa al presidente Usa, che tuttavia considerò l’omaggio a Genova alla tomba di Mazzini come il principale evento della sua visita. A tal proposito, apro una parentesi con riferimento anche a un tipo di tradizione, a un filone della tradizione, socialista riformista della Critica Sociale: un discorso di Leonida Bisso- lati a Milano a favore della Società delle Nazioni durante il viaggio di Wilson in Italia. Si trattava già di un riformismo socialista che riassumeva in sé la tradizione mazziniana democratica, quella stessa tradizione a cui aderiva certamente anche Turati, ma nel quadro del pacifismo socialista che si tradusse, dopo Caporetto, in una salvaguardia del suolo nazionale. La centralità della salvaguardia del suolo nazionale. Turati sosteneva che il pacifismo come valore assoluto fosse negativo, ma limitava l’intervento armato solo alla difesa della Patria dall’aggressione. E’ il pensiero socialista della seconda internazionale, quello della pace a ogni costo. Sappiamo come finì. Sappiamo che molti partiti socialisti poi votarono le spese di guerra, cioè si allinearono alle politiche dei diversi Stati in conflitto tra loro. Come al solito, la politica è fortemente intessuta di elementi valoriali, ma anche di elementi di realismo e di cogenza storica, cioè di realismo politico in sostanza. Ritornando a Mazzini, la sua vis polemica sollevava a più riprese l’esigenza che l’Inghilterra si preoccupasse delle sorti di un paese che aveva né libertà né rispetto dei diritti elementari e che viveva in uno stato di subordi- nazione dal punto di vista nazionale. Si trattava quindi di una incitazione all’Inghilterra a intervenire nel continente dove invece, dagli accordi di Vienna in poi, dominava l’Austria. I suoi articoli in proposito sollevarono molta eco, sicuramente nella cerchia dell’entourage mazziniano a Londra. Nelle sue corrispondenze trovavano spazio anche gli Stati Uniti. Venivano trattati i problemi della schiavitù e della democrazia, questioni che poi la cultura americana farà proprie e che sfoceranno nella seconda guerra mondiale, un altro fenomeno di interventismo per conservare e salvaguardare la democrazia dall’attacco dei sistemi autoritari, del razzismo e del fascismo. Il fatto che della coalizione che vinse la seconda guerra mondiale in nome della democrazia facesse parte, dal ’41 in poi, anche la Russia rappresenta una delle tante circostanze storiche che inducono alleanze con chiunque pur di combattere il nemico comune. In altre occasioni ha avuto modo di sostenere come vi sia in proposito nella nostra Costituzione un’influenza diretta mazzianiana Sì. La Costituzione italiana del ’47 è un testo in cui viene bandita la guerra ma viene anche consentito che l’Italia si allei con tutti que- 30 ■ CRITICAsociale gli organismi internazionali che operano per la giustizia, per i diritti umani, la pace. L’articolo 11 della Carta si ispira a Mazzini e ai democratici del 1848 (“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”). E’ un articolo della nostra Costituzione dove c’è molto animo democratico e molto animo mazziniano. “L’Italia, l’Austria e il Papa”. E’ un saggio che raccoglie gli interventi di Mazzini nel momento in cui in Inghilterra furono aperte le lettere, cioè il famoso “affare delle lettere”: la corrispondenza di Mazzini che era un esule a Londra fu per ordine del Ministero degli Esteri rivelata. Il caso diventò di dominio pubblico perché denunciato nel Parlamento inglese e diventa un caso politico che occupa molte sedute in Parlamento in difesa della privacy perfino degli esuli sospettati di essere rivoluzionari, ma che doveva essere francamente rispettata. Il fatto che non lo fosse e che si scopre questa violazione delle lettere che viene denunciata portò alla crisi di un governo. Pensi un po’ che paese era l’Inghilterra del’800 rispetto alle attuali intercettazioni oggi in Italia! In quella polemica Mazzini solleva a più riprese l’esigenza che non solo questo è sbagliato ma il problema era quello che l’Inghilterra doveva preoccuparsi delle sorti di un paese che non aveva né libertà né rispetto dei diritti elementari degli uomini e che viveva in uno stato di insubordinazione dal punto di vista nazionale e quindi era una incitazione all’Inghilterra di intervenire nel continente dove invece dagli accordi di Vienna in poi dominava l’Austria. Questo libro fu molto letto all’epoca. Gli articoli sollevarono molta eco e sicuramente nella cerchia dell’entourage mazziniano a Londra e le corrispondenze che Mazzini aveva, c’era anche il rapporto con gli Stati Uniti. Il problema della schiavitù, il problema della democrazia, i problemi che poi la cultura democratica americana farà proprie e che sfocerà nella seconda guerra mondiale che è un altro fenomeno di interventismo per conservare e salvaguardare la democrazia dall’attacco dei sistemi autoritari dal razzismo e dal fascismo. Da queste problematiche poi nasceranno nella prima guerra mondiale al società delle nazioni e dopo nascerà l’organizzazione mondiale. Assistiamo a un Risorgimento arabo? Sarei cauto. Il fatto che stranamente non ci siano bandiere americane e israeliane che bruciano in questi giorni è interessante. Sarei tuttavia molto cauto. Vicende diverse non si possono assimilare l’una all’altra. Qualcuno ha assimilato i moti del nordafrica al Risorgimento, qualcun’altro al Muro di Berlino, ma è né l’uno né l’altro: è un fenomeno del tutto nuovo e la sincronia di quei movimenti può essere frutto anche dell’interferenza della comunicazione, un fatto che pochi hanno valutato. Molti hanno pensato ai computer, alla rete, a internet. In realtà, forse la componente più rilevante nell’universo islamico sono i network televisivi, che parlano di valori che spesso appartengono esclusivamente a quel mondo e che noi fatichiamo a comprendere appieno.. Forse la sensazione può sorgeredal fatto che stranamente non ci siano bandiere americane e israeliane che brucino. Questo è interessante però io sarei molto più cauto. Il fatto vero è che i fenomeni non si possono assimilare l’uno all’altro. Qualcuno ha assimilato il Risorgimento qualcuno ha assi- 1-2 / 2011 milato il Muro di Berlino, ma non è né l’uno né l’altro, è un fenomeno del tutto nuovo. Tornando al tema della Costituzione italiana. Lei sostenne anche sulla Critica Sociale che va considerata una sorta di armistizio durante il periodo della guerra fredda nel ’46-’47. Dopo la fine il crollo del Muro, vent’anni dopo, c’è l’esigenza di una sua revisione? La nostra Costituzione è frutto di un compromesso tra la cultura cattolica e la cultura social-comunista. Diciamo la verità: questa è la nostra Costituzione. E il primo articolo è lì a dimostrarlo. Fra l’altro il primo articolo ha un vaga assonanza con il sistema corporativo perché anche quello metteva in primo piano i posti di lavori. In generale le considerazioni liberali e democratiche mettono al primo posto esattamente la libertà, ma nella nostra Costituzione sono, proprio in forza di queste culture fondanti, fortemente tutelati i diritti sociali. Ora il problema della Costituzione italiana è semmai che avrebbe bisogno di un rodaggio dopo cinquant’anni. Ci sono molte procedure e molte istituzioni formalmente scritte nella Carta ma che hanno avuto con l’applicazione materiale in relazione ai rapporti di forza per i partiti e in relazione ai rapporti fra i poteri differente. Oggi per esempio nella nostra Costituzione c’è un istituto come l’immunità parlamentare che come lei sa è saltato in modo imprudente, in modo emotivo, in modo non serio dal punto di vista istituzionale-politico con l’affaire Tangentopoli. Quello era un elemento di equilibrio dei poteri che aveva un suono molto liberale. Saltando quello noi viviamo sempre una intrusione pesante della magistratura - giustificata o non giustificata secondo i diversi punti di vista - nel quadro della politica e questo è uno squilibrio che secondo me andrebbe risolto nella Costituzione. Così come nella Costituzine si voleva aggiornare l’articolazione dei poteri dello Stato con ciò che oggi viene chiamato federalismo: ebbene c’è bisogno di una messa a punto del sistema. Per esempio noi abbiamo due Camere identiche che fanno la stessa cosa. Quando le leggi oggi arrivano nella società italiana, arrivano già con molto ritardo rispetto all’esigenza iniziale perché abbiamo quei due passaggi, due Camere che sono un doppione. Se si voleva un’articolazione diversa dello Stato si poteva ovviare trasformando il Senato nel Senato delle Regioni e questo avrebbe dato già un’impronta di tipo tedesco al nostro sistema statuale. La Costituzione già prevedeva le Regioni. Si trattava soltanto di ridisegnare e questo avrebbe anche ridotto il costo immenso della politica. Poi probabilmente andrebbero razio- nalizzati i poteri territoriali: le Regioni, i Comuni, le Province e lo Stato non possono tutti fare le stesse cose, bisognerebbe dividere i compiti, quindi anche organizzare meglio il sistema fiscale Ma tutto questo senza un disegno di Stato coerente non si raggiungerà. Aggiungo ancora un’osservazione: che la nostra Costituzione sia democratica e che risenta moltissimo di Mazzini la si comprende nel metodo con cui nasce. Nasce con un’Assemblea costituente, dalla rappresentanza popolare. Noi dobbiamo riformare la Costituzione con una partecipazione del popolo al dibattito. Non bastano le tante fallimentari commissioni parlamentari che poi non hanno avuto esito ma hanno preso tantissimo tempo ai lavori del Parlamento e hanno prodotto molti documenti e molti progetti poi in gran parte vanificati. Il metodo mazziniano dell’assemblea costituente, al contrario, è un metodo che restituisce il potere delle regole fondamentali al popolo attraverso l’elezione dei suoi rappresentanti che formano l’assemblea costituente e che scrivono una Costituzione. In questo caso una Costituente non deve fare una nuova Costituzione, si tratta di rettificare o sistemare la Costituzione esistente, che è un ottimo testo, ma che abbisogna di una messa a punto. Le cose cambiano, la società cambia, le situazioni cambiano, la velocità del mondo di oggi è sotto gli occhi di tutti quindi bisognerebbe avere istituzioni snelle che governino i cambiamenti. E questo pone anche un problema, per esempio, che nella nostra Costituzione è frutto di un compromesso, frutto dell’antifascismo quindi del terrore di un governo forte. Abbiamo così creato un governo debole che è un’aspetto essenziale della ingovernabilità del sistema che è cosa a tutti nota. Mi permetto anche di dire, questo è un mio parere, che ha creato anche una magistratura ircocervo che è un potere ed è un ordinamento nello stesso tempo. Effettivamente è così ma la cosa più grave è che noi abbiamo preteso di fare un sistema processuale all’inglese senza avere la terzietà del giudice. Quando si adottò alla fine degli anni ’80 una riforma del sistema processuale bisognava prevedere una separazione delle carriere perché altrimenti questo non ha senso. Quando si istituì la prima costituente dei 75 di fatto non c’era ancora un Parlamento ma c’era un governo dei partiti, provvisorio. Ora come si foremrebbe una Costituente? Avremmo un doppio parlamento? L’assemblea costituente viene eletta direttamente dal popolo con il suffragio esteso alle donne. Anche questa è un’idea che Mazzini aveva già espresso ma la prima assemblea costituente è quella romana del ’49 ed è mazziniana come ispirazione. E’ dunque molto interessante la domanda che lei fa. Tecnicamente è molto semplice: c’è una elezione politica per il rinnovo del Parlamento e parallelamente si può eleggere anche un’assemblea costituente che abbia un mandato preciso, quello della revisione costituzionale. D’altra parte lei sa che si formò una commissione all’interno del Parlamento che lavorò proprio nella redazione del testo costituzionale, commissione di consulenza, commissioni tecniche. Quindi non è un’impresa da poco ma allora si trattava di creare ex novo una Costituzione mentre adesso si tratta semplicemente di prendere atto della maturazione di un dibattito che è ormai trentennale e ha portato a ipotesi di riforma costituzionali che hano registrato nell’opinione pubblica già un consenso molto vasto. Il metodo delle commissioni bicamerali purtroppo per ragioni di lacerazione politica, di dissenso politico – questo semmai è il vero problema – nel quadro politico italiano, è un rischio, c’è sempre questa biforcazione che ha reso vane le bicamerali. Ma una Commissione costituente eletta a suffragio universale ha una sua specifica sovranità. Chi può convocare la sua elezione? Sono uno storico e non un costituzionalista, però le posso dire che nella Repubblica romana il testo che doveva incardinare l’Assemblea costituente fu fatto da coloro che avevano nelle mani il potere quindi è il Governo. Poi il Parlamento deve ratificare una proposta di questo genere. Questa procedura ha una forza democratica incredibile. Vede, le Costituzioni spesso sono concesse dall’alto, mentre le costituzioni democratiche riconoscono che l’assemblea costituente è del popolo e quindi si tratta di restituire al popolo questo potere eleggendo l’assemblea che ha una specifica missione che è quella della costituente che si pone a latere del governo. s Zeffiro Ciuffoletti CRITICAsociale ■ 31 1-2 / 2011 ■ OCCORRE UNA PAUSA DI RIFLESSIONE. RESTA URGENTE UNA AGENZIA PER LA SICUREZZA COORDINATA A LIVELLO EUROPEO NUCLEARE, UNA MORATORIA NON È UN ABBANDONO Il governo ha deciso una moratoria di un anno sull’avanzamento del programma nucleare in Italia. Quali prospettive intravede per il futuro del nucleare nel nostro paese? E’ in atto una revisione generale che interessa l’intero continente europeo e che si focalizza su tre aspetti: le cause e le conseguenze dell’incidente giapponese, il destino delle vecchie centrali tuttora attive in Europa e le valutazioni sulle centrali di futura costruzione. Mi sembra normale e legittimo che ci si fermi a riflettere e credo che l’Italia possa approfittare della situazione per fare il punto sullo stato dell’arte e per agire finalmente di concerto con le altre nazioni europee. A questo proposito, non so spiegarmi per quale motivo non si dia vita a un’agenzia europea per la sicurezza nucleare, assimilabile all’esperienza statunitense. E’ un passaggio fondamentale che consentirebbe di attuare standard condivisi di sicurezza in tutti i paesi del Vecchio Continente. Non ha senso che la sicurezza continui a essere applicata in maniera diversa nei vari paesi dell’Unione. E’ una situazione anacronistica e pericolosa. Dal punto di vista economico, il nucleare presenta dei vantaggi decisivi rispetto ad altre fonti energetiche? Se diamo uno sguardo ai dati disponibili, scopriamo che l’energia elettrica nel mondo viene prodotta principalmente mediante i combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale). Il 67% dell’energia elettrica deriva infatti da essi, in particolar modo dal carbone (il 40%). Questa è una percentuale in costante aumento. Da un bilancio comparato che tenga conto degli ultimi quindici anni, si nota che il contributo dei combustibili fossili al fabbisogno globale passa appunto dal 62 al 67%, mentre quello delle fonti rinnovabili dal 19,7 al 20% con un aumento trascurabile. Io non ritengo che il nucleare rappresenti “la Soluzione”, ma sono convinto che sia un modo per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, poiché ne possiede le medesime caratteristiche. Le rinnovabili, invece, sono in gran parte intermittenti, cioè funzionano solo in presenza di particolari condizioni atmosferiche o geografiche. E’ un problema che accomuna solare, eolico e idroelettrico. I combustibili fossili possono vantare un grande vantaggio, ossia la continuità. Nella nostra vita quotidiana abbiamo bisogno di elettricità con intensità variabile, a seconda dei vari momenti della giornata e delle diverse stagioni dell’anno. Esigenza che può essere soddisfatta da fonti energetiche che funzionino sempre e che riescano a competere per taglia e continuità con i combustibili fossili, che è nel nostro interesse eliminare sempre di più dall’uso comune. Il nucleare risponde a questi requisiti. Innanzitutto, per considerazioni squisitamente ambientali. Dopo l’incidente nucleare di queste settimane, è facile prevedere che i giapponesi (ma anche i tedeschi) facciano un passo indietro e tornino massicciamente ad utilizzare petrolio e carbone. Nel frattempo, il prezzo della Co2 ha cominciato a salire. Non è un buon segnale. Non si tratta di esprimere una netta preferenza a favore del nucleare, ma solo riconoscere la sua potenziale importanza per la diversificazione energetica e per la riduzione della nostra dipendenza dai combustibili fossili. Un discorso che vale a maggior ragione per l’Italia. Un paese tradizionalmente povero di risorse come la Cina può perlomeno contare sul carbone (per quanto sia molto inquinante), Intervista con mentre l’Italia si trova a dipendere dall’estero per l’80% del proprio fabbisogno energetico. L’enfasi posta sul futuro delle energie rinnovabili pare dunque eccessiva e fuorviante? Le rinnovabili potranno sicuramente far la loro parte nel riequilibrio del fabbisogno energetico globale, ma la problematica dei costi e della quantità rimane ineludibile. La rinnovabile più importante in Italia è tuttora l’idroelettrico, un sistema costruito quasi interamente prima degli anni settanta del secolo scorso. Si tratta di una fonte energetica che non garantisce prestazioni stabili, ma che è soggetta a oscillazioni di diversi punti percentuali da un anno all’altro a seconda dei livelli di piovosità. Il solare rappresenta l’1% del totale ed è presumibile che nel futuro prevedibile possa raggiungere il 3%. Bastano questi dati per capire quanto sia improbabile che le energie rinnovabili risolvano a breve il dilemma energetico mondiale e nazionale. Da una recente analisi del Professor Bruno Coppi del Mit, pubblicata dal Sole 24 ore, emerge una preferenza, in termini di efficienza e sicurezza, per reattori nucleari di dimensioni contenute (Westinghouse). L’Italia sembra essersi indirizzata verso il modello francese (Epr), che prevede invece impianti più grandi. Qual è la sua valutazione? L’Italia ha adottato il modello francese soltanto per le quattro centrali che fanno parte dell’accordo concluso con Enel, ma l’obbiettivo è di realizzarne una decina. Siccome non sono un tecnologo, non voglio pronunciarmi a favore di una soluzione a discapito di un’altra. Teniamo conto che si parla comunque di impianti di notevoli dimensioni; la centrale che possiamo definire di ispirazione francese (Epr) supera di una volta e mezzo l’impianto americano (Westinghouse). La differenza non è considerevole. Segnalo piuttosto una linea di ricerca interessante, nella quale ha investito Chicco Testa molto Bill Gates, volta a realizzare reattori nucleari di piccola taglia (di dimensioni pari a un quinto/un sesto delle centrali francesi). Si tratterebbe di reattori con caratteristiche di costruzione standardizzate e pertanto molto meno costosi. Seguo questi sviluppi con interesse, ma non è il mio mestiere esprimere preferenze. Ciò che posso dire è che oramai ci confrontiamo con pacchetti tecnologici avanzati che hanno superato test probanti di ogni sorta. L’esempio giapponese è illuminante al riguardo. A Fukushima è andato in crisi l’impianto di raffreddamento poiché è venuta a mancare l’energia elettrica. Per quale motivo? Non tutti sanno che l’elettricità è venuta meno non solo per il black-out successivo al terremoto, ma anche a causa dell’onda di diciassette metri provocata dallo tsunami che ha investito i generatori di riserva poche ore dopo il terribile sisma. In una centrale di nuova generazione, prendiamo il modello Epr francese, esistono quattro sistemi di raffreddamento indipendenti l’uno dall’altro. Non c’è paragone. D’altronde, basti pensare che la centrale giapponese è stata progettata e costruita a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta. Aldilà dell’obsolescenza tecnologica, ha notato altre mancanze nella gestione della crisi giapponese? Probabilmente vi è stata una sottovalutazione da parte della Tepco, la società responsabile dell’impianto. Nella prima fase dell’emergenza, i tecnici forse speravano di poter salvare i reattori. Di conseguenza, invece di optare per un intervento deciso che avrebbe fermato (ma anche compromesso fin da subito) gli impianti, si è preferito attuare una scelta di compromesso che non li rendesse inservibili. La manovra purtroppo non ha avuto successo. Tornando all’Italia, l’umore dell’opinione pubblica è stato influenzato dai fatti giapponesi e sembra orientato a rifiutare nuo- vamente il nucleare, come nel 1987 dopo Chernobyl. Crede che la scelta governativa di una moratoria possa condurre a un rinvio del referendum sul nucleare previsto il 12 giugno? Non saprei, ma propongo una piccola considerazione laterale: sembra che in Giappone vi sia stato un incidente nucleare e solo secondariamente un terremoto e uno tsunami devastante, e non viceversa. Questo almeno è stato il taglio dato dai media italiani alla vicenda. Non voglio parlare di allarmismo eccessivo, i bilanci devono essere stilati a tempo debito, ma le informazioni che passano al pubblico vengono gestite in maniera quantomeno discutibile e fanno sì che la tematica della radioattività sia conosciuta superficialmente dalla stragrande maggioranza degli italiani. Si tratta di un argomento circondato da un alone magico, che evoca una minaccia oscura e imminente. E’ allora comprensibile che dopo ogni incidente si scatenino le paure che albergano dentro gli individui. Tuttavia, la paura non aiuta a prendere decisioni ponderate e lungimiranti. Invito ad allargare il nostro sguardo. Reagendo ai fatti di Fukushima, Obama ha dato disposizione all’agenzia statunitense per l’energia nucleare di rivedere i criteri di sicurezza, ma ha anche ribadito l’orientamento energetico del Paese, evitando bruschi ripensamenti. Se consultiamo i sondaggi negli Stati Uniti, rimane una maggioranza popolare favorevole al nucleare. Negli ultimi tempi si è discusso a lungo sulla capacità del sistema Italia di gestire tecnologicamente ed organizzativamente un complesso programma nucleare. Molti sostengono che le prove negative fornite davanti ad alcune recenti situazioni emergenziali dovrebbero scoraggiarci. E’ d’accordo? E’ un’obiezione che si ripresenta spesso e che mi lascia perplesso perché la dice lunga sul grado di sfiducia che gli italiani dimostrano nei confronti del loro sistema, delle loro classi dirigenti, dell’onestà dei controllori. Serve una riflessione seria per superare questa sindrome perché si rischia ormai la paralisi nazionale, non solo rispetto al nucleare ma a qualsiasi progetto di sviluppo e innovazione. Io piuttosto vedevo, e vedo, nel nucleare un’occasione per rilanciare e riaffermare le nostre competenze e risorse. Gli italiani danno grande prova di sé ovunque nel mondo, costruendo impianti favolosi ed efficienti, mentre in patria sembriamo incapaci di realizzazioni anche molto banali, come discariche o termocombustori. Intorno ad ogni progetto si addensano dubbi, sospetti e recriminazioni rispetto a eventuali infiltrazioni truffaldine o malavitose. Nel secondo dopoguerra e sino agli anni settanta l’Italia è cresciuta e progredita, mentre oggi appare un paese sfiduciato e annichilito, privo di autostima. Io vedo in tutto ciò un preoccupante disfacimento della coscienza nazionale, che deve essere superato. s Tra i fondatori di Legambiente, Chicco Testa attualmente è Managing Director di Rothschild, Presidente della Telit Communications PLC e Presidente di E.VA., Energie Valsabbia, società che sviluppa e costruisce impianti idroelettrici e solari. E’ stato membro del Parlamento italiano e Presidente di Acea e di Enel. Intervista a cura di Fabio Lucchini 32 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 ■ IL GIAPPONE DIMOSTRA LA SICUREZZA DEL SISTEMA LA PAURA DEL NUCLEARE Q Piero Risoluti uello che è successo alla centrale di Fukushima si presta a due chiavi di lettura: una tecnica ed una politica. Tecnicamente, è stato dimostrato che la cosiddetta difesa in profondità, realizzata attraverso l’interposizione di barriere protettive frapposte tra il nocciolo del reattore e l’ambiente esterno, ha funzionato. Infatti tali barriere hanno resistito ad un sisma che è risultato perfino tre volte superiore a quello di progetto, ed è stato per magnitudo il V° di tutti quelli finora conosciuti e registrati. Anche i sistemi di refrigerazione sono rimasti sostanzialmente funzionanti. Ciò fino a che non è intervenuta la colossale onda di maremoto, la quale però a sua volta non ha compromesso i sistemi di difesa dell’isola nucleare: semplicemente ha messo fuori uso i diesel di emergenza, ed è stato questo che ha determinato, con la mancanza di refrigerazione del nocciolo e delle piscine di stoccaggio, la crisi delle strutture ed i conseguenti rilasci all’ambiente. Sarebbe bastato che tali sistemi fossero stati collocati, come avviene nelle centrali di ultima generazione, in locali a tenuta stagna, perché inconvenienti molto gravi alle centrali sarebbero stati evitati. Siccome non c’è stata una defaillance attribuibile al sistema nucleare ed intrinseca ad esso, l’incidente giapponese non si presta certo ad una revisione critica della sicurezza delle attuali centrali nucleari, tanto meno ad un ripensamento sull’utilizzo della fonte nucleare. Sono abbastanza certo che questa verità si farà strada, anche se con lentezza, non diversamente da come le cose sono andate per Chernobyl, come racconto nel mio libro La paura del Nucleare. Da dove viene, quanto costa. In quel caso ci fu un attacco frontale e furibondo contro l’energia nucleare, al grido che le centrali nucleari potevano esplodere. Poi quando emerse, con il tempo e senza più titoli di prima pagina, che l’incidente non era figlio dell’energia nucleare ma del comunismo sovietico, cioè del degrado di quel sistema, allora gli oppositori hanno ripiegato sul solito problema delle scorie, dichiarando, come si continua a fare tuttora, che il problema non è risolto. Quando si saranno calmate le concitate corrispondenze dal Giappone e si comincerà a ragionare, succederà più o meno la stessa cosa. Il fatto che alcuni paesi si siano affrettati a prendere le distanze dal nucleare è frutto invece di un lettura esclusivamente politica. Intendo con questo che ciascun paese ha dato dell’incidente una lettura derivante dalla rispettiva situazione politica interna. Il caso più macroscopico è quello tedesco. La Merkel ha il problema dell’aumento considerevole, registrato nelle ultime elezioni parziali e previsto dai sondaggi, dei consensi del partito dei verdi, che come quelli italiani hanno fatto in passato la loro fortuna con al lotta al nucleare. Allora si è messa a fare l’antinuclearista. In Germania, inoltre, esiste una potentissima lobby sull’energia eolica, che vive e prospera sui contributi statali, anche se l’imbroglio di presentare l’eolico come conveniente e più rispettoso dell’ambiente verrà prima o poi svelato. I francesi almeno sono stati più coerenti e più prudenti: hanno subito criticato l’operato delle autorità giapponesi per come hanno dato le informazioni. A loro preme soprattutto di far sapere ai loro concittadini che in materia di trasparenza e di corrette informazioni sul nucleare non scherzano. Con il tutto-nucleare che li distingue, non possono permettersi distrazioni su questo punto. Ma sia loro che gli inglesi non hanno minimamente messo in discussione la sicurezza delle centrali nucleari, come del resto ha fatto l’Amministrazione Obama. Inoltre, i francesi hanno un’Agenzia per la Sicurezza Nucleare fatta di grandi competenti e di altissimo livello e prestigio nazionale e internazionale. (Per cui mai si metterebbero a dipendere da un’Autorità sovranazionale su questo campo: qui c’è da sorridere all’idea di Chicco Testa, non saprei se illuministica o ingenua, di chiedere un’Autorità di Sicurezza ■ IN ARRIVO LA “QUARTA GENERAZIONE” DI REATTORI DI DIMENSIONI RIDOTTE PICCOLO È PIÙ SICURO? L a recente intervista concessa al Sole 24 ore da Bruno Coppi, docente al Mit di Boston, solleva dubbi sul modello nucleare che il nostro paese, una volta superata la pausa di riflessione che passerà dal referendum e dalla moratoria di un anno appena decisa dal governo, dovrebbe seguire nel prossimo futuro. Come ha ricordato il professore, sostanzialmente esistono sul mercato due tipi di reattori: l’Epr, realizzato dalla francese Areva e l’Ap 1000 della Westinghouse. L’Italia ha adottato il modello francese soltanto per le quattro centrali che fanno parte dell’accordo concluso con Enel, ma il professor Coppi sospende il suo giudizio, ricordando come diversi colleghi del Mit e anche altri esperti non siano convinti che reattori di grande potenza posseggano effettivamente i migliori requisiti in termini di efficienza, economia e sicurezza. Il governo degli Stati Uniti, dichiara Coppi, si sta infatti orientando alla realizzazione di una serie di centrali di dimensioni relativamente piccole. Tra queste ci sono i modelli della Generazione 3+ progettati dal consorzio Iris, reattori di piccola taglia (335MWe contro i 1600MWe) per la produzione combinata di elettricità, calore, acqua potabile. Sono basati su una impiantistica semplificata: in sostanza sono centrali “plurimodulo” gestite da un’unica sala di controllo. Questa scomposizione consente di eliminare gran parte dei componenti del circuito primario da dove maggiori sorgono le possibilità degli incidenti e, per le piccole dimensioni, sono meno soggetti agli effetti sismici. I test terminano nel 2011 e la commercializzazione sarà nel 2015. Avremo un federalismo nucleare? L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha operato un confronto tra i due modelli, premettendo che le centrali ad acqua in pressione Epr e Ap1000 hanno entrambe co- europea. Tali autorità sono essenzialmente nazionali, a cominciare da quella USA. Lo stesso dicasi per l’invocato “concerto” con i paesi europei. ) Un certo coordinamento europeo tra le Autorità di sicurezza nazionali del resto esiste, e comunque in materia di sicurezza nucleare vigono criteri e standard internazionali condivisi, in termini di valori numerici, e sono quelli fissati dalla Commissione Internazionale di Radioprotezione. Come si applicano a livello nazionale, come vengono fatti rispettare e con quali organizzazioni è invece un’altra cosa. LE CONSEGUENZE IN ITALIA per cui si potrà ricominciare a parlarne, a seconda di come vanno le elezioni, non prima del 2014. Poi forse a quel punto si ricomincerà con lo sterile dibattito sul tipo di centrali da fare, e ci si chiederà se non è il caso di aspettare che maturino tecnologie nuove e tuttora non mature, come l’IRIS o i reattori di IV generazione, dibattito di cui ci sono già le prime avvisaglie. Non bisogna dimenticare che dopo Chernobyl ed il referendum del 1987 ci fu una moratoria, non una rinuncia definitiva immediata. Inoltre, in Italia come in Germania si è subito attivata una lobby agguerrita ed influente sulle energie rinnovabili, in particolare sull’eolico, che vive e vivrà su forti contributi dello Stato, quindi a spese dei contribuenti e con pochi rischi imprenditoriali. Sarebbe stato meglio difendere la scelta fatta, con le argomentazioni tecniche sopra viste, e cercare di spiegarlo alla gente con una convinta campagna di informazione, insistendo in particolare che in Italia si sarebbero realizzate solo centrali dell’ultima generazione, quindi più che sicure, e questo costituirebbe per l’Italia un indubbio atout, dato che non avremmo in funzione centrali della generazione precedente, sicure ma in via di invecchiamento. Siccome ho partecipato in passato ed anche recentemente a convegni con intervento del pubblico (non quelli con esperti, che ripetono sempre le stesse cose, tipo che nel mondo ci sono oltre 400 centrali), posso testimoniare che la gente è molto interessata ad avere conoscenze corrette sui rischi del nucleare e che posizioni pregiudiziali dipendono solo dalla mancanza di adeguate informazioni. Anche perché un tipo come Di Pietro sarà decisamente poco credibile come difensore dell’ambiente e come pubblico accusatore dell’energia nucleare. s La moratoria italiana (di per sé, appare già singolare il concetto di mettere in moratoria un’energia che nel paese non esiste) è anch’essa tutta frutto di un’esigenza politica. C’è il referendum, a proposito del quale si era chiaramente fatto il calcolo imprudente del non quorum, e quindi si cerca così di depotenziarlo. Con la moratoria si arriva inoltre a ridosso delle per molti versi decisive elezioni del 2013, Esperto nazionale nel Comitato Fissione Nucleare della Commissione Europea. Direttore in passato della Task Force dell’ENEA per il Deposito Nazionale dei materiali Nucleari. Autore dei libri I rifiuti Nucleari. Sfida tecnologica o politica? (Armando Editore, 2002) e La paura del Nucleare. Da dove viene, quanto costa. (Armando Editore, 2010). È Consigliere di Amministrazione della SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari). È membro del Comitato Scientifico della Fondazione ReL me base il tipo di reattore che ha dato nei decenni miglior prova di sé. La potenza elettrica netta degli impianti è di 1650 Mw per Epr e 1154 per Ap 1000, tra le massime mai realizzate, con vantaggi legati tanto alla fabbricazione modulare quanto alle economie di scala; le rese termico-elettriche rispettive sono del 35% e 37%, efficienze un tempo ipotizzabili solo per reattori oggi da considerarsi di IV generazione. Impianti che saranno disponibili in commercio solo fra alcune decine di anni, intorno al 2030/2040. Siamo dunque di fronte a sistemi in grado di fornire energia in sicurezza, con emissioni di Co2 per unità di energia prodotta seconde solo alla fonte idroelettrica. Altissimi gli standard di sicurezza per entrambi i modelli. Secondo l’analisi degli studiosi dell’Enea, i reattori Epr portano a massima compiutezza i tradizionali punti di forza dei reattori ad acqua in pressione, che li hanno resi molto affidabili, anche in termini di prevenzione dalle conseguenze di incidenti comunque altamente improbabili. L’Epr è caratterizzato dall’indipendenza di circuiti ed edifici, con progettazione nella classe sismica più stringente e previsione di un sistema di raccolta (core catcher) del combustibile nucleare fuso (corium) per il suo confinamento e raffred- damento. Nell’improbabile evenienza di una fusione totale del nocciolo, questo colerebbe come lava, ordinatamente, in una piscina sottostante che ne garantisce il raffreddamento. Gli Ap 1000 fanno della semplificazione progettuale il proprio punto di forza, insieme all’impiego estensivo di sistemi passivi (non necessitano cioè l’intervento umano per l’attivazione) al fine di conseguire un’affidabilità molto spinta. Non si richiede pertanto l’utilizzo di gruppi elettrogeni in caso di mancanza di corrente dall’esterno. Nell’eventualità di un incidente, non è essenziale l’intervento immediato di un operatore, circostanza che permette di ridurre la possibilità di errore umano nell’emergenza. Questa è stata la criticità verificatasi in Giappone. Infatti, negli impianti di vecchia concezione, come quello di Fukushima, solo con la ripresa dell’energia elettrica possono riattivarsi i meccanismi di raffreddamento. Tra i sistemi di sicurezza passiva ricordiamo la gravità e la convezione naturale dell’aria, che permettono di raffreddare il reattore naturalmente per molte ore dopo un inconveniente grave; questo sistema è denominato Pcss, acronimo di Passive Core Cooling System ed entra in funzione automaticamente. s CRITICAsociale ■ 33 1-2 / 2011 ■ RACCONTO DELLA VITA NEL “COLLEGE” DOVE SONO STATE GETTATE LE BASI DELLA SCUOLA LIBERALSOCIALISTA DI ECONOMIA PUBBLICA RICORDI DEL COLLEGIO GHISLERI DI PAVIA Francesco Forte mio arrivo, quel giorno, alla stazione di Pavia é stampato nella mia memoria; e lo rivivo, quasi con la stessa gioia sottile, ogni volta che mi capita di tornarci. Anche adesso, come allora, percorro a piedi tutta la strada, elegante e snella, che porta in centro, sino all’angolo, da cui snoda l’antica Strada Nuova, ove si allunga l’ edificio settecentesco dell’ Università. Sull’angolo, c’era, luccicante di specchi, il bar Demetrio, con un odore di paste fresche e di buon caffé. Ci feci una sosta, per un cappuccino bollente. L’Università, dal Demetrio, era facile trovarla: era, uscendo, sulla sinistra, a cento metri. Entrai dal grande arco del porticato principale. Eravamo, forse, una cinquantina, ci condussero in un’aula ove ci comunicarono due temi, uno umanistico e uno scientifico. 1. Di recente, Piero Melazzini, un mio antico compagno di studi, presidente della Banca Popolare di Sondrio che apriva filiali a Pavia e nel pavese, mi ha chiesto di rievocare, per la circostanza, le mie vicende dalla Valtellina all’Università di Pavia e al Collegio Ghislieri; e – ci tenne a precisarlo – al celebre Istituto di Finanza, fondato da Griziotti, ove si era formato l’altro mio maestro, Ezio Vanoni, di cui la Valtellina va fiera. Ho così scritto, nell’estate del 1999, queste memorie, che hanno avuto una circolazione molto fortunata e che ora, ripubblico qui Nel chiedermi di scriverle, Melazzini ha soggiunto, “non multa sed multum”: riprendendo un motto di Luigi Luzzatti, teorico delle Banche popolari, all’inizio dello scorso secolo. Mentre mi esponeva questo motto che riguardava la sua Banca, ma anche ciò che avrebbe voluto da me, con quella sua richiesta un po improvvisa, mi é venuto in mente il professore Balatti, che al liceo Piazzi di Sondrio, ci insegnava, nei lontani (per me straordinariamente presenti) anni 44-47, la storia e la filosofia e che aveva deciso che non ha senso studiare tutti i filosofi: perciò ci eravamo concentrati, nel 45-46 su Davide Hume: non multa, sed multum. Andare a fondo: era anche il principio didattico del professore di latino e greco, Albino Garzetti, celebre per le sue edizioni italiane di Tacito e poi del suo successore, il professor Massera. Non so di Balatti, ma Garzetti e Massera avevano studiato a Pavia, uno al Collegio Borromeo, l’altro al Ghislieri. Si stava laureando a Pavia, anche la professoressa supplente di matematica, Marisa Cantelli, che non mi interrogava mai, con grande invidia dei miei compagni, perché “lui é bravo, lo tengo per il giorno in cui viene il preside” (il professor Miotti, un burbero matematico). Da Sondrio, chi si conseguiva la maturità al Liceo Piazzi andava preferibilmente all’Università di Pavia, non a quella di Milano:perché Pavia era, come é anche ora, “una città universitaria.” E poi a Pavia vi erano i celebri collegi universitari: il Borromeo il Ghislieri, e i migliori aspiravano ai due collegi.La tradizione dei liceali valtellinesi al Ghislieri era particolarmente robusta e ricca di nomi importanti, nelle scienze, nelle discipline filosofiche e letterarie, nell’economia e nella giurisprudenza, nella politica. Io speravo di andare al Ghislieri, per fare l’economista, come Ezio Vanoni, di Morbegno, ghisleriano, allievo della celebre scuola finanziaria pavese di Benvenuto Griziotti. Nella biblioteca della Villa Quadrio di Sondrio, ove io andavo a compulsare i volumi della “Nuova Collana degli Economisti” aleggiava il ricordo di Maurizio Quadrio, braccio destro di Mazzini, in una quantità di vicende. E il “fiero valtellinese indomito, pur riboccante di affetti gentili”, come lo aveva definito Aurelio Saffi, iscrittosi, diciannovenne, a legge all’Università di Pavia era stato accolto – come diceva un suo biografo – “già a metà dell’anno nel Collegio Ghislieri, posto che si conferiva dagli stessi professori agli studenti più distinti”. Da Pavia, però il Quadrio era andato via presto, con un “battaglione Minerva” che, nel 1820, aveva partecipato ai moti del Piemonte. E poi era stato protagonista di epici eventi, del risorgimento. Al Ghislieri, per frequentare filosofia nell’ateneo pavese, vi era 2. stato, quasi un secolo dopo, anche un altro più pacato personaggio della Valtellina:Luigi Credaro, professore a 26 anni di storia e filosofia all’Università di Pavia, Ministro della Pubblica Istruzione, per quattro anni, agli inizi del 900 prima con Luzzatti, poi con il Giolitti, che aveva sviluppato il “Magistero”, la educazione pedagogica per i maestri e attuato vaste riforme scolastiche, rivolte a accrescere il livello di istruzione degli italiani. Suo nipote, il professor Bruno Credaro, anche lui ghisleriano era il nostro provveditore agli studi. Qualche decennio prima, di Credaro senior era arrivato alla facoltà di lettere di Pavia, come alunno del Ghislieri, un altro valtellinese, Pio Rajna, filologo celebre, titolare a Firenze della cattedra di lingue e letterature neolatine, capo scuola dell’indirizzo positivista filologico-storico della critica letteraria in contrapposizione con l’indirizzo estetico idealistico della scuola capeggiata dal De Sanctis. Il suo amico Giosué Carducci, nei suoi Levia Gravia, lo aveva preso un po in giro, ma gli aveva anche reso omaggio, dedicandogli con i versi “e ogni buon valtellinese giura: mi son tuscan”, per polemizzare contro il purismo filologico. Io ne ero edotto, nonostante si trattasse di controversie per iniziati, perché la mia professoressa di italiano apparteneva alla famiglia Rajna. Era stato alunno del Ghislieri, nella facoltà di medicina, Bruno Besta, di Teglio, che per qualche ragione, i miei genitori conoscevano, docente di tisiologia e microbiologia al Forlanini di Roma ed anche l’aristocratico avvocato Merizzi, la figura di spicco del foro giudiziario di Sondrio (ove mio padre era Procuratore della Repubblica), che, dopo la “liberazione”, era emerso come leader della sinistra locale, in contrapposizione a Vanoni. A me liceale, la prospettiva del Ghislieri a Pavia, per diventare economista appariva come una via luminosa. Ecco, dunque, che finiti, nell’estate 1947, gli esami di maturità, in autunno venne il giorno decisivo: l’esame scritto a Pavia, per la agognata ammissione al Ghislieri. Poi ci sarebbe stato l’orale, ma l’importante era passare lo scritto, ove avveniva la “decimazione”. Data la media molta alta, con cui avevo superato la maturità, in un liceo come il Piazzi, in cui il motto che Melazzini mi aveva menzionato, “non multa sed multum”, veniva applicato con puntiglioso rigore e dato che “scrivere” era comunque il mio punto di forza, mi sentivo abbastanza sicuro. Andavo a Pavia ferrato di studi e con una sorta di entusiasmo. I posti erano 21 per studenti lombardi o figli di lombardi, “di merito distinto” (era ancora usato, nel bando concorsualeil termine scritto nel curricolo di Maurizio Quadrio). Da Sondrio partii il pomeriggio del giorno prima per Milano, ove fui accolto nell’ospitale appartamento di mio zio, magistrato ma anche libero docente di filosofia del diritto, che mi aveva già magnificato l’Università pavese e la scuola di scienza delle finanze del professor Griziotti. Lui si era dato cura della mia iscrizione all’ateneo pavese, alla facoltà di legge Il mattino seguente presi il treno per Pavia: anche in terza classe le vetture erano confortevoli, mentre da Sondrio a Milano ancora si viaggiava in vagoni scalcinati. Il Essendo iscritto a giurisprudenza, potevo scegliere fra i due settori e optai per il gruppo scientifico, ciò che condizionava anche l’orale, essendo le commissioni esaminatrici distinte. Non c’era a Pavia, allora, la facoltà di Economia e commercio. C’era però, accanto alla celebre facoltà di Giurisprudenza, le cui radici affondano nel medio evo, un’ottima facoltà di Scienze politiche, con molti valorosi professori, i cui insegnamenti erano comuni anche a giurisprudenza. Io mi promettevo di diventare assiduo anche di Scienze politiche, ove c’erano molte materie che mi attraevano; ma desideravo, in primo luogo, corrispondere all’aspirazione paterna di avere almeno un figlio laureato in legge( mia sorella studiava lettere antiche a Milano, mio fratello minore, poi alunno del Ghislieri, aveva- da tempo- dichiarato la sua vocazione per la fisica, cui in effetti si é dedicato). La giurisprudenza era una tradizione familiare: anche mio nonno materno, che era stato magistrato, era, naturalmente, laureato in legge. E lo erano due fratelli di mio padre. I cugini di mia mamma, a Torino (lo zio Attilio, il cui figlio era stato ghisleriano) e Novara, avevano studio d’avvocato Il Maestro alla cui scuola di finanza pubblica ambivo specializzarmi, comunque, aveva la cattedra a giurisprudenza. Quasi tutti i candidati al Ghislieri, invece, aspiravano a medicina, per la efficienza e la celebrità della facoltà pavese, in cui avevano insegnato scienziati come il Golgi, il Forlanini, il Besta (ghisleriano Valtellinese, neurologo) e si erano forgiate figure mitiche, come Padre Gemelli (ghisleriano, neurologo, della scuola del Besta), iniziatore della scuola psicologica e fondatore dell’Università Cattolica.E poi, medicina, era, allora, la laurea più ambita. Un altro gruppo di aspiranti ghisleriani del settore scientifico era costituito dagli studenti di ingegneria: questa facoltà non esisteva a Pavia, ma ivi molti venivano a studiare, per il biennio propedeutico; in seguito la loro borsa di studio proseguiva, presso un Politecnico, di solito quello di Milano, (come il monzese Villoresi, che ideò e progettò l’omonimo canale irriguo) o di Torino (come il bergamasco Radici, creatore, con i fratelli Pesenti, della Italcementi). Riuscii, comunque, fra scritti, orali, media della maturità, primo del gruppo scientifico e secondo, dopo il primo del gruppo umanistico, Giancarlo Buzzi, un ragazzo timido, che aveva fatto il liceo a Como ed aveva parenti a Sondrio, con cui, entrato in Collegio, strinsi amicizia. Ricevetti, al sommo della felicità, la notizia, da un anziano 34 ■ CRITICAsociale filosofo e filologo, il professor Suali, che aveva presieduto la Commissione, almeno per la mia parte. Ero abbastanza sicuro di farcela, ma non con un successo così ampio. I primi cinque, al Ghislieri, considerati come i “bravissimi”, venivano fatti oggetto di attenzione particolare e destinati, se avessero corrisposto alle aspettative, alle varie borse estive per scambio con studenti esteri e poi a quelle postuniversitarie, nelle Università europee e americane. C’era, insomma, al Ghisilieri, una mentalità “meritocratica”, di allevamento dei migliori cervelli, simile, suppongono, a quella che alberga nei dirigenti delle grandi squadre di calcio per la formazione degli juniores. 3. In Collegio eravamo un centinaio soltanto, di età fra i 18 e i 30 anni (alcuni terminavano i corsi in ritardo perché erano stati militari) tutti maschi. Le donne non erano ammesse nei posti al Ghislieri. Vi era stata al riguardo una disputa giuridica nei primi decenni del secolo, in cui il Ministro Credaro aveva dato ragione a coloro che sostenevano che anche le studentesse in possesso di titoli adeguati avessero diritto ad accedervi. Ma poi non se ne era fatto più nulla. Analogamente nel secondo dopoguerra. Fu negli anni ’60 che la questione si risolse, grazie a una cospicua donazione della signora Mattei, vedova di un industriale valtellinese di Morbegno, ed ebbe inizio il Ghislieri femminile. Si usava, in Collegio, per le “matricole”, per una antica tradizione, l’iniziazione da parte degli anziani, composti da due gruppi ben distinti, i cosidetti “fagioli” ovvero gli studenti del secondo anno e i veri e propri anziani, cioé gli studenti degli anni successivi. Non si trattava, però, di prove crudeli, ma soprattutto scherzose, con minacce, generalmente non eseguite, di “condannare” chi non avesse superato le prove alla cosidetta “lavatio”, che consisteva nell’obbligo, per la matricola, di mettere “a bagno” il posteriore, nel lavabo della propria stanza, operazione scomoda, specialmente per l’altezza del lavabo dal pavimento. La mia “prova” fu nel dover bere un sorso d’acqua in un teschio, che uno studente di medicina, poi diventato mio grande amico, teneva in camera, lucidissimo, per studiarne le componenti. Prima di bere dovevo dire la frase “bevi Rosmunda nel teschio del padre tuo”. Io, dopo il sorso stabilito, per seguitare lo scherzo dissi “posso averne, un altro sorso, mio signore”?. Fui così “assolto” ed inizio la nostra amicizia. Gli scherzi a volte consistevano in quiz. Ne ricordo uno, che inventammo, quando io ero “fagiolo” e che, penso, sarebbe piaciuto ad Achille Campanile. Si trattava della domanda, “Dite chi era il padre della figlia di Jorio, il celebre dramma di D’Annunzio”. Il gruppo di matricole, cinque, che avevamo messo in una stanza di uno di loro, per poterne uscire, doveva dare la risposta. Tornati dopo mezz’ora, trovammo il gruppo in grave imbarazzo. Nessuno sapeva chi fosse il padre della figlia di Jorio. “Eppure é facilissimo”, disse il mio collega più anziano, ai cinque che si vergognavano di ignorare la letteratura del novecento, “si tratta del padre, non della madre, pensateci bene”. A sera ancora nessuno era riuscito a rispondere, e si scusavano, assurdamente, asserendo che non avevano studiato D’Annunzio al liceo. Finì, per esaurimento della nostra pazienza, in una grande risata. Nell’ambiente ghisleriano e all’Università, noi che venivano dalle varie province, avevamo voglia di capire come sarebbe andato mondo del dopoguerra, volevamo inserirci e progredire in quella realtà dinamica che si andava 1-2 / 2011 profilando, andando oltre la “ricostruzione” Eravamo perciò avidi di scambiarci le idee e le esperienze intellettuali, con i compagni più anziani e con quelli che facevano altre facoltà di assorbire, nello scambio, un po’ di ciò che loro stavano imparando, in particolare delle ultime novità intellettuali e scientifiche. Gli scambi di opinioni e informazioni, in particolare fra i più anziani, con maggiore preparazione ed esperienza e i neofiti o con gli studenti che venivano, con i “posti di scambio” dall’estero( come il tedesco Wolfgang Huber, reduce di guerra, laureando in legge a Munchen ove io poi mi recai, in contropartita) e la guida discreta ma attenta del Rettore professor Bernardi, ci consentivano un’apertura a tutto campo sul mondo di cui gli altri, anche nelle grandi città e nelle grandi università raramente usufruivano. D’altra parte, il Collegio Ghislieri, benché si potesse definire “elitario” non era un luogo di “cremini”. Alcuni anziani erano stati feriti in guerra, erano reduci di prigionia, i più giovani, ( la grande maggioranza), comunque erano passati sotto i bombardamenti, avevano subito il razionamento, avevano mangiato il pane nero della tessera, umido e duro erano stati privi del riscaldamento invernale. Alcuni come me, e penso altri, in province di montagna, avevamo vissuto da spettatori ravvicinati e, nell’inverno 44-primavera 45 eravamo stati coinvolti, nelle sparatorie della guerriglia partigiana. Nonostante le nostre storie personali spesso ruvide, per forza degli di noi, forse il Dossena, che é divenuto in seguito celebre per le sue limeriks) “Nel meo, nel meo lo prese il Borromeo”. Un giorno, mentre lo cantavamo, vicino al Borromeo, un funzionario di polizia ci si avvicinò e ci disse che il Rettore Don Cesare Angelini ( un fine letterato, autore di una raffinata edizione Einaudi degli Atti degli Apostoli) si era lamentato, sostenendo che si trattava di un “canto osceno”. Il funzionario ci chiese, perciò, di spiegare il significato della parola “meo”, riservandosi di vietarci di usarla in luogo pubblico, riferita al Borromeo o ad altri.. Soffocò a stento una risata quando gli spiegammo che non voleva dire nulla, essendo solo l’ultima sillaba della parola Borromeo. eventi, vi era, in Collegio, il massimo ordine, la pulizia più scrupolosa dovunque, anche le nostre discussioni sotto i portici non erano mai chiassose. Ciascuno rispettava le opinioni politiche e religiose degli altri. Non si notavano, come in anni più recenti é accaduto, “scamiciati” o mal pettinati o mal rasati. Queste forme di esibizione non erano “in” Si potevano cantare, talora, canzoni goliardiche un po’ sboccate, ma non s’usavano parole turpi o bestemmie. Una canzone che ricordo, era quella contro il collegio Borromeo, con cui eravamo tradizionalmente rivali. Consisteva, essenzialmente, nel ritornello, (escogitato da qualcuno per me impensabile, data la dimensione delle porzioni che dai camerieri ci venivano portate, sulla base delle nostre ordinazioni. Ma dovevamo serbare rispetto alle “regole del gioco”, scritte o meno. Ad esempio, ricordo che molti di noi, non immaginando che cosa avrebbero desiderato avere il giorno dopo per pranzo o cena, segnavano sempre 1, per le varie opzioni. Io ero uno di questi, non tanto perché mancassi di spirito programmatorio, quanto perché mi ero convinto, con ripetute osservazioni, che il numero 1 era, comunque, sempre la scelta migliore. Errore grave. Punto nel suo orgoglio, il capo-cuoco ci fece, un giorno, un tranello, 4. Eravamo molto gelosi dei nostri vari diritti, come quello di rientro serale sino a mezzanotte (sino alle undici, con il portone aperto, poi suonando: ci veniva ad aprire, assonnato, il portiere in uniforme) e quello di scegliere, il giorno prima, il menù preferito, fra tre primi, tre secondi e tre dessert (frutta, formaggio o dolce oppure latte).La verdura (di solito patate, cavolfiori e barbabietole rosse in insalata) si trovava in piattoni su un tavolo centrale e ciascuno ne poteva prendere a piacere. Anche dei primi, a mezzogiorno, si poteva fare il “bis” attingendo a zuppiere al tavolo centrale: cosa in cui io cascai in pieno: mise, per una cena, al numero 1 dei primi piatti il “ latte” con caffè o cacao (portato in voluminosa bustina a parte); anche al numero 1 dei “secondi” mise latte con caffè o cacao, però accompagnato da fette di pane tostato e burro; e al numero 1 del dessert, anziché mettere, come di solito, “frutta” oppure “dolce” aveva messo ancora “latte con biscotti”. Quando, quella sera, ricevetti, senza averlo previsto, come primo piatto, anziché una minestra, una scodellona di latte caldo con a fianco la spessa bustina di carta e, in caso di altra scelta, un bricco di caffé, ci rimasi male. Bevvi solo un po’ di caffelatte, pensando “mi rifarò con il secondo, sempre sin troppo abbondante”. Ma, con rabbia, anche il “secondo” che mi toccò era latte. I miei vicini di tavolo ghignavano. Dovetti contentarmi delle fette di pane imburrato, accompagnato da un piatto di verdura mista preso al tavolo centrale. Mentre contavo sulla frutta o l’eventuale fetta di torta, per rifarmi la bocca, mi vidi, ancora arrivarefra le risa dei compagni- ancora come dessert il latte: accompagnato da quei biscotti secchi a forma di ruota, che, inzuppati, diventano un cibo molle per bambini ancora poco avvezzi a masticare. Andai a protestare, il giorno dopo, dal capo cucina: con grande garbo questi mi disse che era nel suo compito farsi che la sera uno studente universitario potesse avere, anziché la solita minestra, di pasta o riso, una scodella di latte; e che, per secondo, potesse gradire, del semplice pane e burro, da accompagnare con una tazza di buon latte di fresca provenienza dalle stalle pavesi; e poi perché meravigliarsi se per dessert, quella sera, nel menù avevamo il latte con biscotti, dato che per fine cena era stato messo in tante altre sere? Quella volta, tanto per cambiare, lo avevano posto al numero 1. “Il ghisleriano, aggiunse, dovrebbe rendersi conto dello sforzo che noi facciamo, ogni giorno, di preparargli piatti diversi, avendo presenti le diverse condizioni di stomaco ed esigenze di dieta di chi sta tutto il giorno a tavolino a studiare oppure, invece, é andato nelle cliniche e nei laboratori, ove c’è cattivo odore ” Una lezione che mi meritavo. Avevamo, in effetti, molti più possibilità di un normale studente della nostra età, agli inizi degli anni ‘50. Avevamo, così, a disposizione nella sala musica, una ampia dotazione di dischi di musica classica, ma anche di musica leggera. Il jazz era particolarmente apprezzato, in quel dopoguerra, assieme ai cantanti americani più recenti e i musicofili ghisleriani attratti dal “mito americano” avevano provveduto a arricchire la nostra collezione di dischi, aggiornandola in modo selettivo. Gli studenti avevano diritto a dare suggerimenti per gli acquisti, ma entro un budget ragionevole, che l’amministrazione sorvegliava con la mentalità propria dei pavesi: che non é affatto avara, né gretta, e neppure severamente austera, ma é ben misurata. C’era la sala della radio, ove si ascoltavano, fra l’altro, la sera i notiziari e i dibattiti fra esperti sui fatti del giorno, ma in cui era anche possibile sintonizzarsi sui canali in altre lingue. Nella la sala di lettura vi era una ampia dotazione di riviste e giornali, basata anche essa sulla scelta degli studenti: sicché avevamo l’Unità, il Popolo e l’Avanti! perché gli alunni, avidi di dibattito politico, li avevano chiesti, assieme ai grandi quotidiani e alla Provincia Pavese, indispensabile per sapere che cosa c’era al cinema, di pomeriggio e dopo cena e per leggere le recensioni degli eventi locali. C’erano anche più di un giornale sportivo, date le diverse preferenze della tifoseria ghisleriana in fatto di calcio e ciclismo. Il giornale più compulsato il mattino, prima di far colazione, era la Gazzetta dello Sport, in particolare quando c’erano il giro di Italia e il tour de CRITICAsociale ■ 35 1-2 / 2011 France e il lunedì, con i risultati delle partite del campionato. Qualcuno- a me capitava spesso- arrivava tardi alla colazione del mattino e, magari, finiva per perderla( alle 9 in punto la porta di ingresso del refettorio veniva chiusa) perché si era intrattenuto a leggere articoli dei giornali. 5. Il Ghislieri non era solo “cultura”. Il Rettore del Collegio teneva molto alle nostre attività di sport e, comunque, di esercizio fisico.Vi erano, nel Ghislieri, anche la sala scherma, il campo di pallacanestro, e, sotto i portici, sulla destra, la stanza-deposito per le biciclette.Ciascuno di noi ne aveva una. Avevo preso, sull’esempio di qualche collega, l’abitudine di inserire sul portaoggetti fissato sul manubrio, un libro da studiare e facevo molti “ripassi”, pedalando e ripetendomi mentalmente ciò che vi era nel testo. Le strade di Pavia pianeggianti, fuori dal centro, allora non erano attraversate, se non raramente da automobili ed era una delizia pedalarvi, anche se non c’erano le “piste ciclabili”. Vi era, in Collegio, anche una biblioteca specializzata, nelle varie discipline dei nostri studi. Era, per me, una miniera preziosa, data la sua particolare ricchezza di libri d’economia, dovuta, in parte, a lasciti di ex alunni ma anche alle ordinazioni fatte, via via negli anni, dagli studenti. Vi si poteva entrare, praticando liberamente la lettura ai tavoli vicino agli scaffali. Solo per i prestiti “esterni” si compilava la scheda, da consegnare a un addetto, che però non si trovava necessariamente nella biblioteca. In effetti, il Collegio era ampiamente basato sulla fiducia: non si pensava che uno studente potesse portare via un libro abusivamente o spostarlo dal proprio posto, senza poi riporlo esattamente dove lo aveva preso. Anche la vita pavese, del resto, allora, era ampiamente basata sulla reciproca fiducia. La bicicletta potevamo lasciarla fuori dal bar, appoggiata la muro, chiusa solo con un piccolo lucchetto, per impedire alla ruota di scorrere, senza timore che qualcuno la portasse via. Gli studenti universitari, in ogni caso, erano circondati da particolare simpatia e rispetto. Quando poi si sapeva che uno era “del Collegio Ghislieri”, c’era sempre qualche po’ di ammirazione, da parte di tutti, in particolare delle ragazze del luogo. Ma la vita nel Ghislieri non era tutta rose e fiori. Ad esempio, per metà delle stanze, il riscaldamento scarseggiava. Io, da matricola, ne avevo scelto una all’ultimo piano, gelida, di inverno, ma- in compenso - molto grande e affiancata da uno spazioso corridoio silenzioso.E, naturalmente, le scale si facevano a piedi. All’ultimo piano, dove stavo io, lungo il soffitto del corridoio, quando la sera, a una certa ora, le luci venivano spente, volavano dei piccoli pipistrelli. La cosa, però, non ci impressionava. Non vi era niente di cupo, in quel loro volo notturno, nel piccolo mondo ordinato del nostro collegio, con il grande giardino, pieno di alberi, che io vedevo dalla finestra-balcone. Il mattino dopo, noi saremmo andati, allegri, nella sala di lettura, a discutere di politica e di sport e poi nel grande refettorio, spalancato per la colazione, spandendo odore di pane bianco fragrante e di latte e caffé bollenti. Ci attendeva- quando non eravamo in ritardo- un’altra chiaccherata, sotto i portici dell’Ateneo, con i colleghi studenti e studentesse, dopo la passeggiata, nella tranquilla mattina di Pavia, dalla piazza del Collegio all’Università. Anche questo percorso ho fra i ricordi che danno serenità dalla lunga Piazza di San Pio, si entrava in una via un po’ stretta, poi si passava davanti a un bar, ove spesso si entrava, per un caffé corretto, per togliersi di dosso i rimasugli di sonno ; e poi si arrivava nella grande pìazza, contrassegnato dalle alte torri di colore rosso e la Caserma Menabrea (adesso é una parte dell’Università), con un via vai di sfollati, che ancora in parte vi abitavano, si entrava infine sul retro del palazzo color giallo dell’Università (il cosi detto giallo Fraccaro dal nome del Rettore che aveva fatto riaffrescare gli antichi muri)e si arrivava nell’ala del porticato a destra, ove c’erano le aule di Legge. Le lezioni iniziavano alle 9.15. 6. Non multa sed multum. Il motto si addiceva bene, all’Università pavese, come la ricordo, nelle facoltà di legge e scienze politiche (ma penso anche in quelle di lettere filosofia e di matematica e fisica), basate sul “poco ma molto buono’ Non so quanti siano, oggi, gli studenti iscritti e quelli frequentanti, a giurisprudenza. Allora gli iscritti non superavano i 30 annui e in aula a diritto privato dal celebre professor Gorla eravamo in quattro, talora in sei. Il doppio, al terzo anno, nel corso biennale del maestro del diritto commerciale Mario Rotondi, ove avevo come compagno Guido Rossi, che era entrato al Ghislieri l’anno dopo di me e poi, dopo aver frequentato l’Istituto di Finanza, per addestrarsi nelle discipline economiche, optò per la carriera universitaria nelle materie del diritto privato su basi economiche, alla scuola di Mario Rotondi. Questi un giurista, con grandi interessi economici, collaborava anche alla Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze. Il volto pallido, affilato, vestito impeccabilmente di scuro, le mani di pianista che muoveva appena, il parlare sommesso, aveva una logica elegante quanto implacabile. Il diritto commerciale e soprattutto il diritto industriale, di cui era stato l’iniziatore (ho poi avuto a Milano, come collega ed amico, il suo allievo pavese, il ghisleriano, professor Remo Franceschelli, che ne fu il principale studioso sistematico), nel suo ragionare, apparivano come sequenze di sillogismi e corollari, desunti da poche premesse. Dietro il suo impianto giuridico vi era un acuto impianto economico. Si sentiva che aveva coltivato gli studi economici, una caratteristica che hanno, credo, i giuristi della sua scuola, che li rende particolarmente adatti a comprendere gli sviluppi delle isti- tuzioni in rapporto all’evoluzione del capitalismo. Nel primo anno, ad insegnare economia politica, c’era.Di Fenizio-un signore quarantacinquenne vivace, sorridente, vestito in modo sportivo, che faceva lezione camminando a destra e a sinistra della lavagna, su cui ogni tanto scriveva, con il gessetto, a grandi caratteri, una formula o un grafico, dichiarando, subito, con una erre tenue e un sorriso aggiuntivo che era “elementare”. Il Dife, come lo chiama- vamo noi studenti, era un “maestro” efficacissimo, di una chiarezza esemplare. Le cose più complicate, come l’oligopolio e gli incroci fra le varie forme di mercato sul lato della domanda e su quello dell’offerta, la teoria dell’equilibrio ottimale della produzione con gli isoquanti e gli isocosti, l’equilibrio economico generale di Walras-Pareto, la macroeconomia keynesiana (che egli per primo tratto, in Italia, nel suo manuale), con gli equilibri e squilibri di piena occupazione e di disoccupazione o inflazione, la propensione al consumo e il moltiplicatore, mediante le sue spiegazioni alla lavagna, con poche, formule e figure geometriche, disegnate con mano sicura, diventavano semplici e logiche. Ricordo, che all’esame, egli, dopo una domanda sulla concorrenza monopolistica (un’altra sugli sviluppi internazionali della scienza economica, su cui Di Fenizio era costantemente aggiornato e ci aggiornava), mi chiese le equazioni Walras-Pareto dell’equilibrio economico generale, che io gli esposi con estrema facilità, terminando con “spero di aver risposto giusto”.” Perché me lo chiede ?”, mi domandò il professor Di Fenizio, mentre mi dava la lode. “Perché, dissi io, mi sembrava così facile, che forse avevo dimenticato qualcosa”. Piuttosto compiaciuto, mi disse “in effetti non é complicato come sembra”. In realtà, il merito era del suo manuale. La statistica ce la insegnava Libero Lenti, che arrivava da Milano, in un’automobile, assieme a Di Fenizio e che, nella corporatura, era alquanto più grosso di lui sicchè usciva dallo sportello posteriore dell’auto (guidata da un autista) per secondo. Aveva sempre un mezzo sigaro in mano, lo fumava prima e dopo la lezione, il che dava a noi studenti un titolo aggiuntivo per fumarci, sotto i portici, la nostra sigaretta durante gli intervalli. Parlava molto più lentamente Di Di Fenizio e non faceva gra- fici o figure sulla lavagna. In compenso, ci forniva molti esempi concreti in collegamento con i gli articoli che aveva scritto o stava per scrivere su Il Corriere della Sera e su Mondo Economico. Questo fatto dava a noi studenti un senso di grande importanza, perché ci introduceva, in modo diretto, spesso in anticipo nei fatti reali della congiuntura economica e della finanza.Bruno Leoni, insegnava, con un rigoroso metodo positivistico, intriso di riferimenti e paradigmi economici, filosofia del diritto e, nella facoltà di scienze politiche, dottrina dello stato:questo era il vecchio nome della materia che ora si denomina “scienza politica” e che lui stava modernizzando. Appresi così, dal suo insegnamento, i primi elementi della teoria delle decisioni razionali. Raccolsi, ad uso di noi studenti, in dattiloscritto ( che redigevo con la mia Lettera 22), le sue lezioni introduttive di Dottrina dello Stato, che ho poi conservato in tutti i miei innumerevoli traslochi:qualche anno fa ho rilegate e mi riprometto di pubblicarle, dato che egli a suo tempo non lo fece (forse pensava di completarle, ma a causa della sua morte prematura a opera di un pazzoide la vita di questo grande studioso è stata stroncata prima che fosse al colmo della sua pienezza scientifica).Dopo superati i suoi due esami; e, ancora studente, egli mi chiese di collaborare, con recensioni, alla rivista di scienze politiche, “Il Politico”, che aveva appena fondato nella Facoltà di scienze politiche pavese, per rinnovare questo settore di studi. Il professor Leoni, in seguito, divenne celebre negli USA, ove i suoi libri sono molto noti. Lo reincontrai, nel 1960 quando ero associate professor nel Department of Economics Università di Virginia e lui ci era venuto come visiting professor. I nostri anni pavesi, avevano generato fra di noi, nonostante la differenza di età e di ruoli, e anche la differenza di idee in politica e in politica economica (lui liberale liberista puro, io liberal-socialista) una solida amicizia, che si protrasse in seguito, quando io divenni professore a Torino, ove lui risiedeva. Ricordo quando io e mia moglie visitammo la casa ove gli era appena nata una bambina, che si agitava nella culla: Didi Leoni, ora invece mi sorride, dal video di canale 5, ove presenta il notiziario politico. Mi affascinavano anche le lezioni di storia delle dottrine politiche di Vittorio Benonio Brocchieri, che, io andavo a sentire per puro diletto, in quanto non potevo inserirne l’esame nei corsi complementari fuori facoltà, avendoli già tutti impegnati con Dottrina dello Stato, Storia delle Dottrine Economiche e Politica Economica. Mi avvinceva anche la storia del diritto italiano, che veniva insegnata da Pietro Vaccari, un professore austero, massiccio, sulla sessantina, con una voce profonda, con cui ci guidava a spaziare nei secoli dell’epoca longobarda quando Pavia, con le sue cento torri, era la capitale dell’Italia e, perciò, ivi era sorto un gabinetto di studi giuridici, il preludio della futura Università, con il compito di comparare e integrare diritto romano e germanico. Pietro Vaccari o meglio il Vacarius, come noi lo chiamavamo, associandolo idealmente ai maestosi professori delle Università medievali, non era un puro giurista era in primo luogo uno storico, con interessi amplissimi. Così mi stimolò allo studio dei contratti con cui aveva avuto inizio, a Genova, il capitalismo, nel medioevo. Ed io durante il secondo anno, e poi ancora in parte nel terzo, mi immersi per molte ore pomeridiane, nella munitissima biblioteca centrale dell’Università di Pavia, ove erano conservati i preziosi manoscritti dell’epoca. E ivi, grazie a un personale efficiente e paziente, ne trovai e schedai parecchi di banchieri, che facevano contratti di finanziamento a operatori marittimi, mediante accomandite, che acqui- 36 ■ CRITICAsociale stavano e vendeva azioni della “compera salis”, una compagnia che gestiva il monopolio del sale della Repubblica Genovese: che dai proventi ricavava anche mezzi per pagare il servizio dei suoi prestiti. Schedai anche contratti di acquisto di terre e fabbricati e pagamenti mediante lettere di cambio. Conservo ancora questo materiale, che mi é servito per capire le origini del capitalismo industriale e finanziario, molto più degli scritti di Marx. A Vaccari sarebbe piaciuto che io facessi la tesi con lui sulle origini del capitalismo a Genova. Ma io oramai ero votato alla scienza delle finanze. Le discipline collaterali mi interessavano per gli intrecci con la “mia materia”. Così é stato anche con il professor Pietro Nuvolone, ghisleriano, allora molto giovane, che ci insegnava, con frequenti collegamenti alla filosofia, secondo un indirizzo positivista, aperto alla sociologia, diritto penale e procedura penale. Oltre al testo generale dell’Antolisei, studiammo così due sue monografie, sui reati di stampa e sui limiti taciti della norma penale, che ci introducevano in due temi ancora oggi scottanti: i diritti del giornalista alla libertà di cronaca e di pensiero e i suoi obblighi deontologici, sottilmente confliggenti, di non ledere l’onorabilità altrui, esondando dal diritto di cronaca; il limite agli obblighi dei funzionari e dei militari ad obbedire alle leggi e agli ordini ricevuti, quando violassero, come era accaduto negli anni della guerra, norme etiche condivise. Con lui elaborai uno studio, che portai poi alla laurea, come “tesina” sul reato di oltraggio all’incaricato di pubblico servizio, in cui cercavo di definire che cosa si potesse intendere per “pubblico servizio”. Nuvolone era stato allievo di Griziotti, il mio maestro nella scienza delle finanze e collaborava alla Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, per il diritto penale tributario. Un altro professore ghisleriano, collegato a Griziotti, con cui lavorai fruttuosamente fu Rodolofo De Nova, acutissimo docente di diritto internazionale..Mi interessava il fatto che si potessero tracciare, anche fra stati sovrani, delle regole per attivarne la cooperazione nelle relazioni finanziarie, , in un mondo che era appena uscito da grandi conflitti e in cui stavano emergendo i prime abbozzi di unità europea. Con De Nova feci una ricerca sulla “tutela internazionale delle pretese tributarie” di uno stato, in uno stato estero, che divenne la seconda tesina, per la mia laurea, che discussi in scienza delle Finanze, nell’estate del 1951, con Griziotti, sul principio del beneficio, le rendite fiscali e i tributi speciali, di cui ampie parti sono state successivamente pubblicate, in u a rielaborazione, in questa Rivista, con il titolo Teoria dei tributi speciali. 7. L’Università di Pavia non era solo un luogo ove si imparavano alcune materie, fra loro separate, era un luogo ove ci si apriva la mente, con lo studio interdisciplinare, con docenti fervidi, di diverse generazioni, usciti dai Collegi universitari pavesi o con essi profondamente legati. Docenti che si prendevano cura dei loro studenti, li indirizzavano nei loro interessi particolari, discutevano con loro, senza formalità, spesso sotto i portici, a volte anche al Caffé Demetrio, talora nelle conferenze che facevano al Ghislieri e al Borromeo. Un esempio tipico della fertilità di questo ambiente è la vicenda di Franco Tatò, entrato in Ghislieri nel ’50, quanto io iniziavo il quarto anno; dopo vari successi scolastici si laureò nel ’54 in filosofia con Enzo Paci, su Max Weber e il linguaggio della storiografia, ebbe due borse di studio in Germania ed una negli USA, poi fu accolto da 1-2 / 2011 Adriano Olivetti nella sua società di Ivrea, come già Giancarlo Buzzi. Il re delle macchine da scrivere assumeva ghisleriani con avidità, specie se laureati in filosofia, convinti che fossero utili a dar sprint alla sua impresa. L’ambiente pavese ha dato a Tatò una formazione che gli ha permesso di diventare uno dei maggiori manager dell’Italia di fine ‘900, allo svolta nel nuovo secolo: giungendo al vertice prima dell’Olivetti, poi della Mondadori, indi dell’Enel. Io invece, grazie al Collegio e all’Università di Pavia, ebbi prima tre borse di alcuni mesi in Austria e Germania, poi, dopo la laurea, una semestrale alle Università di Zurigo e di Berna. Negli USA ci andai nel ’59 con un posto di “distinguished postdoctoral fellow “, istituito presso il Department of Economics dell’Università di Virginia da una ricca vedova americana. Mi ci chiamò il capo del Dipartimento James Buchanan, ora premio Nobel, che aveva studiato l’italiano durante il suo dottorato di economia a Chicago, apprezzava la scuola economica italiana di scienza delle finanze, su cui stava scrivendo una elaborata monografia, che è alla radice della sua teoria di Public Choice ed era stato in visita, per le sue ricerche, come “tappa obbligata” all’Uni- l’Italia, oltre che la scienza delle finanze. La scuola di Benvenuto Griziotti non fu solo una fucina di studiosi, fu anche, forse in primo luogo, una scuola di etica dell’impegno civile : egli riteneva che il sapere dovesse essere messo al servizio della società, del buon governo, del progresso nazionale e mondiale. E la sua impostazione metodologica, rivolta a combinare economia, politica, diritto e tecniche operative nel campo della finanza pubblica traeva, in primo luogo, la sua ragion d’essere dall’obbiettivo di penetrare, in questo modo, a fondo nei dati della realtà e concorrere a migliorarne le istituzioni e le decisioni pubbliche. Questo impegno Griziotti seppe trasmetterlo a numerosi suoi allievi, fra i quali spiccano grandi figure :ho già ricordato il ghisleriano Ezio Vanoni, la cui grande statura morale oltreché scientifica non ha bisogno di sottolineature. Basterebbe, a testimoniare il suo senso di missione, al servizio del Paese, il modo come egli ha sacrificato la sua vita, per il rigore e l’equità del bilancio, recandosi al Senato, per il voto sulla sua legge finanziaria, contro l’avviso del medico, che aveva consigliato giorni di riposo, per il suo cuore. Il bilancio fu approvato, come lui chiedeva, mentre il suo cuore cedeva allo agile e multiforme dei fatti economico-finanziari che alle alte teorie), fu parlamentare per innumerevoli legislature, e insegnò, assiduamente, la scienza delle finanze all’Università di Pisa, poi in quella di Roma, alla Facoltà di Statistica, producendo un Manuale universitario di Scienza delle Finanze e vari contributi a questa disciplina. Lavorò sino alla morte prematura nel 1973 (la prigionia di cui narra nel bel libro Fra la cattedra e il bugliolo, ne aveva logorato la sua fibra) sempre con grande impegno, lucidità di pensiero e nobiltà di scelte di vita.Uomo di grande generosità, l’incedere, un po’ curvo, segnato dagli anni di carcere, il viso sereno, la folta capigliatura canuta ben ordinata, il parlare pacato, lo ricordo, in particolare, in una commissione di libera docenza, in cui ci trovammo colleghi esaminatori, negli anni ‘60: dopo una pessima lezione, fatta da un candidato, venuto dalla Sicilia, quando questi stava per esser bocciato, io feci notare che forse era stanco del viaggio ed emozionato, perché i suoi ascoltatori non erano studenti, ma professori importanti. Pesenti, allora, perorò così a fondo la causa del timido candidato, che decidemmo, sia pure solo a maggioranza, di promuoverlo. Un altro importante allievo di Griziotti fu il ghisleriano professor Gian Antonio Micheli, un fine giurista, con interessi scientifici a cavallo fra la procedura civile e il diritto finanziario, che dopo essere stato assistente di Griziotti nell’Istituto di Finanza, divenne professore di procedura civile, ma nella sua maturità, tornò alle origini, ricoprendo, a Roma, alla Sapienza, la prima, prestigiosa cattedra di diritto tributario alla Facoltà di Giurisprudenza: due dei Ministri delle Finanze degli anni più recenti, Franco Gallo e Augusto Fantozzi sono suoi allievi...nipotini della scuola pavese di Griziotti e un terzo Giulio Tremonti, fu suo discepolo, tramite una borsa di studio dell’Istituto di Finanza dell’Università di Pavia, in cui si stava specializzando. Contando assieme a Vanoni e Pesenti, anche me e il mio allievo Franco Reviglio ora professore a Torino, alla Facoltà di Economia, sono sette i Ministri delle Finanze, docenti di finanza pubblica, che, dal 1944, direttamente o indirettamente sono sbocciati dalla scuola griziottiana. 9. versità di Pavia nel ’55.Io gli feci da guida e scoprimmo di avere scritto entrambi, l’uno a insaputa dell’altro, su riviste diverse, saggi molto simili sulla possibilità di configurare la tassazione automobilistica in rappprto al beneficio dell’uso delle strade. Pavia. Fu per me, così, una Cambridge Italiana, meno snob, ma altrettanto raccolta, intrisa di senso empirico lombardo, ma alta, nella teoria, come nelle sue torri: il cui colore rosso, che si ergeva verso il cielo, era per me il simbolo di quel sapere. 8. Il mio principale interesse, a Pavia, sin dal secondo anno, fu, come ho detto, per l’Istituto di Finanza, diretto dal professor Griziotti e sostenuto, in modo efficaceze, con le risorse aggiuntive della Camera di Commercio. L’Istituto di Finanza di Griziotti, che tutt’ora ha un posto di grande rilievo nell’ateneo pavese e nella cultura economica italiana, é un centro di pensiero e di formazione civile, cui deve molto sforzo del suo discorso, volto a illustrarlo.. Ma bisogna aggiungere il borromaico Antonio Pesenti. Nel 1935, quando aveva pubblicato già saggi importanti di scienza delle finanze e di diritto finanziario, Pesenti venne condannato dal Tribunale Speciale a 24 anni di carcere, per la sua attività di propaganda contro la guerra in Etiopia, svolta Parigi- ove stava studiando. Dalla fede repubblicana, nella prigionia durata sino al 1943, quando cadde il regime fascista, passò a quella comunista. Ministro delle Finanze nel governo Bonomi, nel 44-45 successivamente diede notevoli contributi ai lavori della Costituente in materia economica, fondò la rivista Critica Economica, che sotto la sua guida elaborò gli indirizzi economici del PCI, secondo una linea moderna, che arricchitasi di nuove leve intellettuali, ha consentito a questo partito di qualificarsi come forza di governo dotata di una cultura economica capace di comprendere la realtà contemporanea e le sue istituzioni.Pesenti (che Griziotti con me, affettuosamente, chiamava “il pesentino”, forse per delinearne la duttilità del pensiero, più portato alla analisi Griziotti, con il suo esempio, nell’Istituto di Finanza pavese insegnava anche come si “fa scuola”, nella scienza. Così, Sergio Steve, asssistente di Griziotti a Pavia, poi professor a Venezia, indi a Milano e, in seguito, per molti anni a Roma alla Sapienza (ove dal 1986 gli sono succeduto) ha dato luogo, a sua volta, a una scuola numerosa di studiosi di elevata qualità ed impegno. Pur con le differenze di impostazione, questo Maestro ha ripreso da Griziotti il metodo di collegare teoria economica e dati istituzionali e fattori politici, che la scuola macroeconomica cosidetta keynesiana -(Steve ha spiegato molto bene che il pensiero genuino di Keynes non era quello poi stilizzato dai keynesiani)- aveva quasi distrutto, con un danno che ancora noi, nell’Europa continentale sopportiamo. Molte delle considerazioni che Steve ha elaborato nel corso degli ultimi decenni sono estremamente attuali per la revisione della politica fiscale dei paesi europei al fine di stimolarne la crescita e l’occupazione. A Pavia ci si preparava, all’Istituto di Finanza, ad essere economisti capaci di amministrare, nelle istituizioni. Fra i più giovani allievi di Griziotti, che sono emersi in questo campo, una menzione spetta a Mario Sarcinelli, che collaborava con me all’Istituto di Finanza, sotto la guida grizziottiana, nella redazione della Rivista di Diritto Finanziario e Scienza CRITICAsociale ■ 37 1-2 / 2011 delle Finanze, che Griziotti aveva fondato e dirigeva, con scrupolo tenace. Sarcinelli, poi, si laureò con Parravicini succeduto a Griziotti, suo allievo dal 1933, anche lui Ghisleriano e subito il pavese Paolo Baffi lo prese con sé all’Ufficio Studi della Banca di Italia. Da lì, Sarcinelli ha spiccato il volo per prestigiosi incarichi in istituzioni bancarie nazionali e internazionali. Marco Vitale, ghisleriano, venuto poco dopo all’Istituto di Finanza, é diventato uno dei maggiori esperti italiani nella finanza privata, ma spesso ricopre incarichi difficili nelle pubbliche amministrazioni ed é fra i fondatori dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza La scuola di Griziotti era una garanzia, un viatico di carriere brillanti, negli uffici studi, nelle pubbliche amministrazioni, nell’Università in Italia e all’estero. Sarebbe però riduttivo non menzionare anche il grande prestigio che godevano l’Università di Pavia e il Ghislieri., in Italia e a livello internazionale e di cui ho fatto poco sopra cenno, menzionando James Buchanan.. studenti dell’Ateneo pavese, di cui ero diventato il capo, avendo vinto alla guida dell’Unione Goliardica.(il cui segretario nazionale era Marco Pannella, che noi criticavamo perché troppo politicizzato, ma alla fine seguivamo) le contese elettorali con la Fuci. Lasciai il “testimone” a Saverio Venosta, mio compagno al Liceo Piazzi di Sondrio, che era allora al collegio Borromeo, come laureando in legge ed era il mio braccio destro nell’organismo studentesco. Saverio, di poche parole, era un ec- al pianoforte, si esibiva in pezzi di opera lirica. Oppure andavamo al Cinema d’essai, che, con un gruppo di amici, avevamo fondato e in cui si proiettavano film dell’epoca del muto e sonori degli anni prebellici. I miei redditi erano buoni, perché accanto allo stipendio avevo anche un fisso mensile, come redattore capo della Rivista diretta dal professor Griziotti. Migliorarono quando cominciai ad avere proventi di scritti vari, come quelli su “Automobilismo Industriale”, in cui pubblicai alcuni saggi bre- cellente organizzatore e godeva fra gli studenti una grande popolarità, per la capacità gestionale che metteva nelle iniziative a noi affidate dal rettore Fraccaro, come la mensa e la casa dello studente, ove avevamo organizzato, con scandalo della Fuci, ballo serali. Nell’ultima tornata elettorale in cui ci presentammo, io dimissionario dal presidente, con lui designato al mio posto, prese molti più voti personali di me e fece guadagnare alla nostra lista nuovo seguito. Saverio, che era per carattere molto modesto, disse a tutti che il successo era mio merito. In seguito è stato sindaco di Sondrio, poteva avere una carriera politica importante, ma è morto precocemente. vi, tratti dalla mia tesi di laurea sul principio del beneficio nella tassazione, riguardanti l’impiego dei tributi automobilistici per il finanziamento delle strade. Grazie a questi scritti e ad altri, più complessi, pubblicati sulla Rivista, su questi stessi temi, nel 1953 risposi a un bando dell’ENI, appena fondato, che cercava consulenti economici nel settore petrolifero.. Il mio ardimento fu premiato, fra le referenze avevo indicato anche Griziotti e Vanoni. Enrico Mattei mi prese, a tempo parziale, con obbligo limitato di recarmi a Roma, senza vincolo di tempi e di orario, in cambio di una ottima retribuzione. Cambiai la mia moto Gilera con una Topolino C di seconda mano e divenni, dal mio punto di vista, abbiente. Così presi ad andare, per i miei pasti, alla Croce Bianca, il miglior albergo ristorante di Pavia, di proprietà del commendator Sozzani, un grande albergatore che, per i menù, aveva creato gustosi incroci fra la cucina pavese e quella della Valtellina, grazie al fatto che un figlio e un nipote erano albergatori in Provincia di Sondrio.. Credo che il celebre Vissani, in confronto lui, risulterebbe come un nano della gastronomia. 10. In questo ambiente iniziai, nel luglio 1951, dopo la tesi di laurea con Griziotti, sul principio del beneficio e i tributi speciali e la nomina, pochi mesi dopo, ad asssistente ordinario nell’Istituto di Finanza, la mia carriera nell’ateneo pavese. Frequentavo, allora, Francesco Alberoni, allievo del Cairoli (il terzo collegio Universitario per studenti di merito distinto, da poco fondato per l’impegno del Rettore Plinio Fraccaro), che si stava perfezionando con padre Gemelli, a Milano, alla Cattolica in psicologia e Alberto Arabasino, assistente di diritto internazionale, che dopo qualche tempo avrebbe lasciato studi in cui già si era distinto, per dedicarsi interamente alla sua vocazione letteraria. Conobbi anche Carlo Maria Cipolla, assistente di storia economica, che in seguito diventò professore di questa materia all’Università di California a Berkeley. Un altro mio collega era Virginio Rognoni, detto Gingio, ghisleriano, assistente di procedura civile. Divenne, in seguito, una delle principali figure politiche italiane.Da Leoni, c’era Mario Albertini, che teorizzava il federalismo e creò l’Unione federalista italiana. Divenne, poi, professore di filosofia della politica nella nostra Università.Le sue teorie influenzarono il movimento italiano verso il federalismo, compresa la Lega di Umberto Bossi, nel periodo iniziale. Ma le idee di Albertini sono sopratutto importanti, per le basi teoriche dell’Unione economica e monetaria europea. I suoi saggi nel libro “Il Federalismo” che pubblicò, presso le edizioni del Mulino, venti anni fa, rimangono fondamentali per capire i problemi di fondo dell’Europa di Maastricht. A filosofia del diritto c’erano due ghileriani: Giacomo Gavazzi e Amedeo Conte, con i quali discutevo di logica simbolica e di teoria degli insieme applicate alle scienze sociali. Da Di Fenizio, ad economia politica, avevo come collega il borromaico Mario Talamona, ora professore a Milano e vicepresidente della Cariplo, con cui si discuteva dei cicli economici, su cui stava lavorando.Con Alberto Ferrari, un altro ghisleriano, assistente di diritto commerciale, che poi fece carriera nella Montecatini e nella Farmitalia Carlo Erba della Montedison, facevamo lunghe gite in bicicletta nell’Oltrepo. Dai bordi della strada, nei campi, si vedevano mondariso, che cantavano. Alcune ci salutavano agitando le mani, mentre continuavano a cantare “lo sai che i papaveri sono alti, alti... e tu sei piccolina”. Negli anni dell’Università di ero molto impegnato nell’Organismo rappresentativo degli 11. Nel mio primo anno di assistente ebbi diritto all’alloggio gratuito al Ghisilieri, grazie a una borsa di perfezionamento. L’anno dopo trovai un’abitazione in Via Garibaldi, presso una anziana signora, ex infermiera del Policlinico San Matteo, che affittava tre camere, di quel suo appartamento. Gli altri due ospiti erano un anziano farmacista a riposo, con cui facevo, la sera tranquille camminate per le antiche strade di Pavia sino al ponte Vecchio sul Ticino o a San Pietro in Ciel d’oro e una giovane straniera, che praticava ginnastica artistica, al suono di un disco e credo insegnasse questa nuova disciplina in qualche scuola privata d’avanguardia. Quella musica cadenzata, continuamente ripetuta m’ossessionava, disturbando la mia concentrazione, mentre con la piccola Olivetti, battevo a macchina i miei primi saggi per Riviste importanti.Ma l’affitto era basso e il luogo molto conveniente, perché la mia stanza, provvista di proprio bagno, dava direttamente sul cortile, con un ingresso autonomo. La sera, con amici pavesi, andavamo al Regisole, un antico, grande bar, in piazza del Broletto ove una matura cantante, accompagnata 12. Frattanto, a Pavia, a sostituire come docente di scienza delle finanze, Griziotti andato fuori ruolo( rimaneva però a dirigere l’Istituto di Finanza), venne, dall’Ufficio Studi della Banca di Italia, il suo allievo Giannino Parravicini, che era stato alunno del Ghislieri nei primi anni ‘30 e si era poi specializzato a Parigi in economia della moneta e del credito, condividendo con Pesenti, nel ‘34, la stessa pensioncina. Con Parravicini facevamo lunghe discussioni, sulle ultime tendenze della nostra disciplina e sul sistema finanziario italiano. La sua famiglia viveva a Roma, ove si era installato quando lavorava all’Ufficio Studi della Banca di Italia, e faceva la spola con Pavia. Noi due ed Emilio Gerelli, che ha poi diretto l’Istituto di Finanza di Pavia, per lunghi anni, vincemmo nel 1961 il concorso di cattedra. Parravicini si insediò come ordinario a Pavia, io fui chiamato a Torino da Einaudi, Gerelli andò a Venezia ove avevano insegnato Vanoni e poi Steve sulla prestigiosa cattedra di scienza delle finanze. Alla statale di Milano, al posto di Vanoni, che io avevo ricoperto transitoriamente, dal 195455, prima come supplente, poi, per breve tempo, come incaricato, c’era dal 1956-57, Sergio Steve. Questi nel 1964 passò a Roma. Così Parravicini gli successe alla Statale di Milano,.e Gerelli giunse a Pavia. Poi Parravicini ebbe la cattedra a Firenze, indi nella Facoltà di Economia di Roma, ove tornò all’economia monetaria e creditizia, con cui aveva iniziato le sue ricerche. Teoricamente, nonostante la differenza di età, Parravicini ed io eravamo rivali, per una futura cattedra universitaria, perché lui era tornato alla carriera degli studi solo da pochi anni e aveva passato un lungo periodo alle armi, come ufficiale. Ma Parravicini si comportava con me come un fratello maggiore. E mi portò con sé, alla fine del ‘53, al Ministero delle Finanze, ove dirigeva l’Ufficio Studi per il Ministro socialdemocratico Roberto Tremelloni. Così collaborai con lui al libro bianco sul Sistema Tributario Italiano, al quale per altro diedi un contributo minore: dovevo lavorare anche per l’ENi, che mi aveva prestato parzialmente al Ministro Tremelloni e, comunque, attendere ai miei doveri universitari a Pavia e alle mie ricerche. Mentre scrivevo, per Moneta e Credito, la rivista della BNL, diretta dal ghisleriano, allievo di Griziottti, Luigi Ceriani, due lunghi saggi sulla tassazione delle società, che poi raccolsi in un volumetto, Vanoni mi nominò, nel ’54, come ho eccennato, suo supplente alla cattedra di scienza delle finanze alla statale di Milano. 13. Presi alloggio nella capitale lombarda, ma con la Topolino facevo la spola con Pavia, ove Griziotti mi attendeva, per la Rivista ed ove avevo tutti gli amici. Nel febbraio 1956 Vanoni morì. Anche Griziotti, poco tempo dopo, ci lasciò. Io ero senza i miei Maestri, ma con l’appoggio di Steve ebbi dal 1966-67l’incarico di scienza delle finanze ed economia e statistica (tre materie) a Urbino. L’anno dopo per economia, chiesi che venisse dato l’incarico a Beniamino Andreatta, mio giovane amico, dai tempi della Cattolica, ove avevo fatto 54-56)i corsi serali di scienza delle finanze. Tenni per me la statistica, che, come ora, mi ha sempre affascinato, in quanto permette di quantificare i fatti e le qualità apparentemente meno P suscettibili di misura. Parravicini mi consentiva di assentarmi da Pavia, più di quel che, a regola, dovessi, come assistente ordinario. Io cercavo di ripagarlo, dando alla Rivista- per cui lavoravo ovunque avessi un po’ di tempo- il massimo dell’impegno, in modo che, anche dopo la scomparsa del Maestro, campeggiasse negli studi della finanza pubblica.. Operava, fra noi due, quell’amicizia discreta e quella fiducia fra compagni di collegio, sia pure di epoche diverse, che solo chi é stato al Ghislieri. può capire. E fu così anche con Franco Volpi, anche lui del Ghislieri, che ci aiutava nell’Istituto di Finanza. Io curavo i suoi scritti scientifici, assieme a Parravicini, lo guidavamo nella carriera universitaria, intanto per succedermi, come assistente ordinario a Pavia, appena io fosse stato sistemato altrove, poi per gli ulteriori sviluppi..E così accadde, Franco divenne docente della nostra materia, e, un gradino dopo l’altro, succedendo a Parravicini, ebbe la cattedra a Firenze, in cui dopo aver dato 38 ■ CRITICAsociale vita a una nuova scuola di finanza pubblica ora insegna, invece, economia dello sviluppo economico. E’ caratteristica degli studiosi usciti dalla scuola grizziottiana di non focalizzarsi solo su una materia, ma di “spaziare “ : del resto il Ghislieri ci stimolava a ciò, creando continue occasioni di contatto interdisciplinare. 14. Il professor Benvenuto Griziotti era un signore di alta statura, asciutto, atletico, con una elegante chioma bianca sul volto fiero, allungato, con un profilo di uomo assorto negli studi in cui i grandi occhi chiari si muovevano poco, quasi fermi in un pensiero lontano.Un gigante buono, così mi apparve la sua figura austera, quando, io matricola, lo vidi per la prima volta, mentre usciva da una lezione, nell’aule a fianco della presidenza, sotto il porticato e e si avviava al suo celebre Istituto al secondo piano. Vestito di scuro, con un doppio petto, i pantaloni con una riga impeccabile, il gilet dello stesso tessuto, con l’orologio a catena., la camicia bianca, con le punte sempre ben piegate, cravatta scura, con un nodo elegante, un po molle, che suscitava invidia per la sua perfezione, mi sembrava la figura mancante del “Quarto stato” di Pelizza da Volpedo: quella, cioé, che io mi figuravo, del saggio che, motivato da amore per “l’Italia e gli italiani” all’inizio del secolo, si era assunto il compito di dare ascolto alle esigenze del popolo dei contadini e degli operai, promuovendo nuove scuole, favorendo lo sviluppo delle leghe operaie, delle cooperative e delle Banche popolari. Questa, in effetti, era un po’ la storia di Griziotti e dei suoi familiari.. Suo padre, Antonio, era stato con Garibaldi nelle battaglie della terza guerra di indipendenza. Il fratello maggiore di questi, Giacomo, garibaldino di più antica data, aveva combattuto con Manin a Venezia, poi nella seconda guerra di indipendenza e nei “mille”. Una famiglia che, a parte il servizio patriottico, era dedita, per lo più all’avvocatura. Il fratello maggiore di Benvenuto, l’avvocato Brunetto aveva avuto un ruolo nel difendere i socialisti coinvolti nei moti di Milano repressi dal Bava Beccaris, poi era stato fra i fondatori dell’Azienda Elettrica Municipale di Milano, ai primordi del secolo. Di tutto ciò appresi direttamente dalle sue rievocazioni, quando, nei primi anni ’50, con una vecchia Balilla, con altoparlante, lo accompagnai nel pavese, nella campagna elettorale per il Senato, in cui egli – vecchia gloria riformista – correva per il Partito Socialdemocratico. Una piccola folla ci si avvicinava, quando arrivavamo, nelle piazze, con l’auto coperta di manifesti. Poi, quando Brunetto, che aveva ottenuto i primi applausi dagli anziani, cominciava a rievocare le sue battaglie politiche dell’inizio del novecento, era un mezzo disastro. Man mano la piazza si spopolava, mentre lui continuava a rievocare. Allora la socialdemocrazia non era di moda, Brunetto non fu eletto. Il comune di Milano, però, per riconoscenza della sua opera nella vita municipale, gli ha intitolato una piazza, vicino a Via Larga, ove egli abitava. 15 Benvenuto Griziotti è generalmente ricordato come un austero studioso. Ma la sua figura era più complessa. Da giovane era stato campione di scherma, aveva vinto trofei e coppe a Pavia, a Milano e nelle gare nazionali. Il mio amico Gianni Brera, di pura razza pavese, che si era laureato a Pavia in Scienze politiche, ed aveva avuto Griziottti come docente, sarebbe felice di sapere che quando il Maestro morì 1-2 / 2011 (accadde purtroppo, per un tumore cerebrale, quando era ancora nel pieno della sua attività), sul carro funebre, accanto alle corone di Università e accademie, vi era anche quella dell’Associazione Calcio Pavia, che ricordava una delle sue glorie: il terzino Benvenuto Griziotti. Piaceva molto al mio Maestro che io andassi al Ticino, ogni volta che mi fosse possibile.. Ignorava, però, che io ci andavo, per remare, non per nuotare, lo sport che lui più tenacemente sponsorizzava, con tutti coloro che avesse vicino. Aveva anche creato una piccola scuola di nuoto, al Ticino, per i più piccoli. Da assistente. lo accompagnavo, ogni giorno, dall’Università alla sua casa in Piazza Garavaglia. Era la pausa dedicata ai ricordi personali.Così mi raccontò di Luigi e Giovanni Montemartini, i due fratelli che avevano sposato le sue due sorelle. Il minore, Luigi, che si era accasato con la sorella più giovane, era stato professore di botanica poi onorevole socialista sino al delitto Matteotti, e all’apice della carriera universitaria era tornato a Pavia come cattedratico e direttore dell’Orto botanico annesso alla Facoltà di Scienze, viveva ancora a pianterreno, nella casa di Piazza Garavaglia. Il maggiore, Giovanni, che aveva sposato Aurora, la sorella più anziana, aveva avuto una storia molto più lunga da raccontare. Docente di economia politica all’Università pavese, ove Benvenuto da studente, lo aveva conosciuto, aveva dato inizio al movimento cooperativo, in agricoltura. Aveva poi promosso le imprese municipalizzate e scritto un celebre libro nuovo Istituto. La nuova sede fu poi inaugurato da Mussolini, con Lubin, nella villa sul Pincio, da lui donata, che tutt’ora porta il nome del milionario (in dollari) polacco-americano. L’Istituto si è successivamente trasformato nella FAO: che in omaggio a ciò ha conservato a Roma, la sede primncipale. La storia di Giovanni Montemartini, nei racconti che man mano mi faceva Griziotti, si intrecciava con quella del fratello prendeva forma di apologo. Nell’Oltrepo’ vi erano, nei primi del novecento, anni in cui i contadini se la passavano male, perché, per il tempo avverso, il raccolto delle uve era scarso e scadente, ma in altri anni, in cui questo raccolto si preannunciava come sovra abbondante, le cose potevano andare persino peggio. Arrivavano, allora, da lontano, la sera tardi, i n carrozze con le tendine abbassate, dei signori vestiti di scuro, che andavano, non visti, ad alloggiare nell’Albergo principale del paese e mandavano emissari, che spargevano la voce che i prezzi stavano scendendo, perché i compratori forestieri erano andati altrove, I contadini, temendo che il prezzo potesse crollare o che la grandine sopravvenisse, negli ultimi giorni, vendevano ai sensali le uve dai filari, per “un boccone di pane”. Luigi Montemartini aveva riflettuto su ciò e aveva promosso le prime cooperative di lavorazione, fra viticoltori, denominate “cantine sociali”. Quando, nei giorni festivi, venivo invitato a pranzo dal professore, a casa sua, egli, con orgoglio, mi mostrava il vino della Cantina Sociale di Santa Maria della Versa, fondata da sulla Municipalizzazione dei pubblici servizi in cui tracciava anche la teoria dell’imprenditore politico. Era così sorta la AEM. In seguito, divenuto direttore generale del Ministero dell’Industria e agricoltura, a Roma aveva sviluppato gli studi sui cicli agricoli. Il signor Lubin, un emigrato polacco, di umile origine, che aveva fatto fortuna negli Stati Uniti, con il commercio agrario, avuto sentore di questi studi, si era recato a Roma, proponendogli di creare, con il suo finanziamento, un Istituto Internazionale, con il compito di occuparsi dei problemi dell’agricoltura mondiale. Negli anni 10 sorse così l’Isituto in cui anche il professor Griziotti aveva lavorato. Montemartini nel dopo oguerra diventava assessore della prima giunta di centro sinistra del comune di Roma, guidata dal Nathan e dava vita alle aziende municipalizzate romane: ma poco dopo, stroncato dall’eccesso di impegni, moriva, nel 1921, lasciando incompleto lo aviluppo del Giovanni Montemartini. Il pranzo curato dalla signora Jenny Griziotti Kretschamn, moglie di Benvenuto, era servito con molta eleganza, ma era anche assai sostanzioso, spesso c’erano gli agnolotti con sugo di carne, seguiti da zampone con patate arrosto e lenticchie. Con la signora Jenny avevo sostenuto i due esami di politica economica e storia delle dottrine economiche, materie che essa insegnava con una metodologia “istituzionalista” a me non molto congeniale. Molto bella, anche in età avanzata, bravissima pianista, grande nuotatrice, di corporatura atletica, era originaria della Russia, ove era nata nel 1884 (lo stesso anno di Benvenuto) da una famiglia aristocratica; Benvenuto la aveva conosciuta a Berlino, ove era, dal celebre professor Adolf Wagner, a perfezionarsi nella scienza delle finanze;la aveva reincontrata a Ginevra, ove, successivamente, si era recato, alla scuola di Wilfredo Pareto. Presto si sposarono. Però Jenny, prima del ma- trimonio volle laurearsi, a Roma, in economia, con Maffeo Pantaleoni, il maggiore degli economisti italiani dell’epoca, da cui anche Benvenuto, si recava, di tanto in tanto, per consigli di studio. A proposito di Pantaleoni, Griziotti mi raccontò un’altra “parabola”. Loro due, camminavano per strada(presumo a Roma) come noi due, ( nel Corso di Pavia). Griziotti disse al grande economista che intendeva misurare la pressione tributaria del sistema fiscale, in Italia. Maffeo si fermò di colpo, estrasse dal gilet di Benvenuto l’orologio e vi alitò sopra, poi disse “ misuri il vapore acqueo sul vetro di questo orologio”. Anche Griziotti, mentre me lo raccontava, si fermò; mi prese il polso, a cui tenevo, il mio orologio di ordinario metallo e fece il gesto di alitargli sul vetro. L’apologo mi sovviene ogni volta che sento di studi econometrici con cui si cercano di quantificare effetti economici ad ampio raggio immisurabili. 16 L’Istituto di Finanza di Pavia, diventato Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale opera per le Facolta di Giurisprudenza e Scienze Politiche e per la Facolta di Economia istituita nel 1964. E’ un centro di studi vivo e vitale. Vi ha sede la Rivista fondata da Griziotti, diretta da Emilio Gerelli e Giulio Tremonti, professore di diritto tributario( valtellinese, anche lui, per un periodo Ministro delle Finanze, allievo dell’ateneo pavese, ove è stato alunno del Collegio Fraccaro, l’ultimo nato). Luigi Bernardi, Professore di Scienza delle Finanze a Giurisprudenza, figlio del mio rettore Aurelio, pubblica ogni anno un denso volume di ricerche sullo stato della finanza pubblica italiana con un gruppo scelto di collaboratori, di varie istituzioni. Un altro professore di scienza delle finanze pavese, titolare nella Facolta’ di Economia, Alberto Majocchi porta avanti gli studi sul federalismo iniziati da Mario Albertini. Ci sono molti altri noti studiosi di finanza pubblica, come Italo Magnani, che ha la cattedra di Economia di politica alla Facolta’ di Giurisprudenza, Franco Osculati, ordinario di scienza delle finanze alla Facolta’ di Scienze Politiche, e, Angela Fraschini, Michele Bernasconi (figlio di un mio compagno di collegio), fra i non cattedratici Anna Marenzi. Giuseppe Ghessi, che è redattore capo della Rivista e’ anche il segretario la Società Italiana di Economia Pubblica. Questa ha sede nel Dipartimento e ogni anno tiene, a Pavia, il suo convegno di studi, raccogliendo in volume i saggi sul tema centrale della riunione. Dal 1998 al 2000 ne sono stato Presidente e il convegno si svolge al Ghislieri. Ci vengono sempre più studiosi, dall’Italia e dall’estero, soprattutto giovani, che volentieri pagano le quote della nostra associazione, che si autofinanzia.. Oramai io sono l’anziano. Ma quando esco dal Collegio e faccio la strada acciottolata della Piazza di San Pio, camminando sulla striscia lastricata, passo per la via stretta che porta nella piazza delle torri rosse e giungo sotto i portici dell’Università, mi sento come 50 anni fa. s Francesco Forte Il presente scritto, con alcune varianti, è comparso con il titolo Sotto i Portici dell’Università di Pavia. Ricordi del Collegio Ghislieri e di Pavia, prima come fascicolo a sé stante, edito dalla Banca Popolare di Sondrio, nel settembre 1999, poi, arricchito di molte preziose fotografie, come articolo con lo stesso titolo, nel Notiziario della Banca Popolare di Sondrio n.81, del dicembre 1999: che nonostante l’understatement del titolo è una bellissima rivista periodica. 40 ■ CRITICAsociale 1-2 / 2011 ■ L’EDITORIALE NELL’ULTIMO NUMERO DI CUORE E CRITICA CON CUI FILIPPO TURATI ANNUNCIÒ IL 21 DICEMBRE 1890 LA SUA DIREZIONE C ol prossimo numero Arcangelo Ghisleri commette alle mie mani la compilazione di questo periodico, ch’egli creò e sostenne e riscaldò con tanto e cosi esperto amore per ormai quattro anni, e che ora — sopraffatto da altri impegni assorbenti — non gli pare di poter piti curare con la stessa assiduità di zelo. Egli pensa altresì che il viaggio di questo suo figliuolo — uscito ormai d’adolescenza — da Bergamo a Milano, debba vieppiù rinvigorirgli i polmoni e le gambe; e la vita intensa d’una capitale accelerargli il polso e stimolargli il pensiero. Nulla adunque di sovversivo nelle alcune modificazioni che furono annunciate e delle quali s’è tolto ad occasione il trasferimento di sede. A una certa età non v’è figliuolo affettuoso che non dissimuli un po’ il suo lato sentimentale, per effetto d’uno spirito critico più sviluppato. Questo è avvenuto già da tempo a Cuore e Critica, che oggi è conosciuto generalmente come un periodico — l’unico in Italia — di sociologia radicale; anzi, perché tale si annunciava fin dalla nascita, anche allora fra collaboratori vi fu dissenso sul nome di battesimo. Se dunque Cuore e Crìtica diverrà, col nuovo anno, il sottotitolo della Critica Sociale, non perciò penserete, o lettori — e voi neppure, o fide lettrici — che si abbia avuto l’inumano proposito di «strappargli il cuore». Oh! no; il generoso muscolo, propulsore al cervello di sangue caldo e nutrito, continuerà a battere vigoroso dentro i precordii. La Critica Sociale, senza l’alimento del cuore, sarebbe un lavoro negativo e dissolvente che — assolutamente — non può essere il nostro. (...) quand’anco fossero accessibili ai molti, poco aiuterebbero i giornali e le rassegne specialiste, di sola letteratura o di sola un’arte o una scienza, che del movimento intellettivo e morale riflettono un breve frammento, e si direbbe perciò che vivano fuori della vita. Né meglio si addice all’intento il giornale di partito, vincolato ad una scuola, che si fa propagatore di un verbo, banditore di un credo, fuor del quale non esiste salute; e combatte i vecchi dogmi con un dogma e le superstizioni col fanatismo. Ad altro e più complesso ideale s’ispirò Cuo- M i affido nella coopcrazione degli attuali abbonati. Nessuna Rivista, forse, quanto la nostra, può compiacersi di avere, nel numerato stuolo de’ suoi lettori, una vera famiglia di intelligenze generose e benevoli, congiunte al giornale e fra loro meno dal caso fortuito dell’abbonamento, che da una intima e vera similarità di ideali, di tendenze, di simpatie; onde il periodico riesce un po’, anzi moltissimo, il «giornale de’ suoi lettori»; fra questi e la Redazione non v’è distinzione recisa, e per poco non direi che formano una cosa medesima. Or io penso che se, ispirandoci alla suprema necessità del primum vivere, e volendo aiutare questo, dunque, figlio nostro comune anche sul terreno dei mezzi di sussistenza, ciascun di noi si proponesse di procurargli soltanto un nuovo abbonato — ciò che, volendo, non dovrebbe riuscirci impossibile — il duplice problema che accennavo più sopra sarebbe prestamente risolto. E gli attuali abbonati ed amici diverrebbero cosi il primo nucleo fondatore di quella Rivista Sociale, larga, varia, indipendente, della quale Cuore Critica fu come il felice embrione; di una Rivista, come n’hanno, almeno una, tutte le nazioni d’Europa, e della quale — senza impingere nella bolsa retorica delle solite lacune da colmare — non mi pare che l’Italia possa ornai rimaner priva più a lungo senza danno e vergogna. Il momento — non è chi non lo senta — volge intensamente sovrattutto alle questioni sociali e agli studi positivi che tendono a procacciarne, o almeno a rischiararne, il graduale scioglimento. Nel disfarsi sempre più ruinoso delle antiche fedi, nelle incalzanti delusioni della politica tradizionale, di fronte ai fatti che attestano, dovunque, l’affacciarsi, per quanto crepuscolare, di nuove albe sociali, non v’è alcuno, fra quan- “AGLI AMICI DI QUESTO GIORNALE” LETTERA APERTA DEL NUOVO DIRETTORE ti tendono lo sguardo un po’ sopra e d’intorno, all’infuori delle materiali preoccupazioni del giorno per giorno, che non sentasi tormentato come da un’ansia, che in taluni è speranza, in altri sgomento, che qua sembra religioso entusiasmo e altrove utopia di pensiero, e ci mette un po’ tutti fuori di posto, spingendo gli arditi all’intemperanza, alla pusillanimità i peritosi, i buoni talora allo sconforto, gli scettici al cinismo. Tutto, e non gli uomini soltanto, sente il contraccolpo della situazione penosa. La letteratura, l’arte, la vita stessa, dal salotto al tugurio, dal gabinetto del Ministro alla caserma, sono invasi, loro malgrado, anche riluttanti, dalla preoccupazione degli odierni problemi sociali, che s’affermano imperiosi eziandio, anzi tanto più, da chi s’affanna a negarli. La questione sociale — questa Sfinge — per la prima volta nella storia, ha preso intero possesso del cervello umano, così che vano sa- rebbe ogni sforzo per cacciamela fuori. Ma, di fronte a questo ospite inatteso e pieno d’esigenze, la coscienza dei più resta inquieta, incerta e confusa. Come l’antico filosofo errava alla ricerca dell’uomo, noi brancoliamo un po’ tutti alla ricerca, più o meno affannosa, della nostra coscienza; di una coscienza sociale che ci permetta di assistere, attori operosi e sereni — e non soltanto spettatori passivi o subbietti incoscienti — al dramma sociale che evolve sul teatro della storia. Al rintraccio, alla creazione, dirò meglio, di codesta coscienza, mal provvedono i fogli quotidiani che, sospinti dalla febbre dell’«attualità » fatua e fugace, frangono il poliorama dei fatti in briciole minute; mal provvedono i giornali ebdomadarii per le famiglie, antologie sonnacchiose e linfatiche, buone pei cervelli atrofici e pei cuori tisicucci, intese a dilettare col pretesto dell’arte o degli indovinelli; e, re e Critica, s’ispirerà la Critica Sociale; altrimenti essa intende di aiutare, nella sua formazione, la coscienza di chi vi scrive, e quella di chi la segue fedele, che è dire, in una parola, la coscienza di chi vi lavora; né io, scrivendo ai vecchi amici del giornale, vorrò dire di più, che d’un programma — e meno ancora di un nuovo programma — non v’è punto il bisogno. Basti che ci siamo intesi su questo: Cuore e Critica, mutando sede, non muta fede, non smentisce né abbandona se stesso. Rimane sempre l’albo di discussioni, sereno e modesto, il convegno in cui tanti eccentrici e solitari trovarono come un lor centro e parve loro di sentirsi men soli. Tribuna aperta a tutte le intelligenze oneste e sincere che, pervase dal soffio della vita e degli studi moderni, non seguono pecorilmente le orme dei trapassati e scevransi dalla folla anonima dei presenti che mai non fur vivi e mai nol saranno, se nei numeri venturi vibrerà anche più alta, che per l’addietro, la nota sociale, non sarà per proposito determinato di esclusivismo unilatere sarà segno dei tempi e merito dei nuovi e valenti che si aggiungeranno indubbiamente ai vecchi collaboratori, che rimangono ciascuno al suo posto, e dei quali sarebbe vano, e parrebbe pomposo, far qui la rassegna. La Critica Sociale tradirebbe lo stesso suo nome e immeschinirebbe di soverchio se stessa se escludesse dal suo quadro, non vasto ma vario, la critica letteraria, la artistica, la politica, e via via lo studio di quanti sono della storia e dell’evoluzione sociale coefficienti integranti e vitali. Solo, questi studi speciali, che altrove divagano sbrancati, infecondi, quasi fine a se stessi, coordinerà, per quanto riesca fattibile, come membra d’un solo organismo, al suo fine supremo, a quello che è, del periodico, carattere, ragione ed essenza: cooperare, sinceramente, assiduamente, alla elaborazione di una solida coscienza sociale, quale chiedono i tempi procellosi e l’ambiente moderno, informata ai bisogni della nuova vita e del nuovo pensiero. E poiché un tal fine, anche solo a tentarlo, sfida e sembra irridere la pochezza dei mezzi che sono in nostro potere, e la angusta cornice già sembra che minacci il disegno, è fra i sogni più fervidamente vagheggiati di chi scrive queste linee, di coadiuvare l’opera del giornale mercé il sussidio di pubblicazioni popolari accessorie che, trovando nel periodico la base e il punto di partenza, staccandosi mano mano da esso come gemme dal tronco, spargansi, fin dov’esso non può giungere, messaggere ed interpreti del suo spirito, del suo stesso ideale. Sol che il presidio della vostra simpatia, o amici del giornale, non abbandoni i nostri sforzi, non lasci sole le nostre speranze! s Milano, Dicembre 1890 Filippo Turati
Scarica