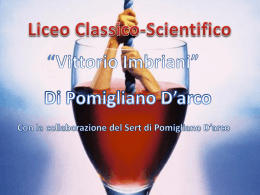Articoli Alcol e guida: altri dati sulle abitudini e le conoscenze degli studenti delle Scuole Medie Superiori. Analisi qualitativa Silvia Anfilocchi*, Andrea Noventa**, Marco Riglietta*** Riassunto L’articolo analizza i dati raccolti tra gli studenti delle classi 4ª e 5ª di 17 Istituti Superiori di Bergamo e provincia e tra i partecipanti a due classi di scuola guida attraverso un breve questionario, somministrato immediatamente prima che i soggetti partecipassero all’intervento di educazione alla salute su “Alcol e guida”, condotto dagli operatori dell’ASL. Si tratta di un’analisi solo qualitativa e i commenti, data l’esiguità e la particolarità del campione, non possono essere generalizzati all’intera popolazione studentesca. I ragazzi dimostrano di sottovalutare pesantemente i rischi connessi all’uso di alcol, soprattutto associato alla guida di veicoli; per esempio sono privi di alcune nozioni fondamentali, prima fra tutte il concetto di unità alcolica. Fino a che l’alcol verrà considerato una sostanza meno pericolosa e meno dannosa rispetto alle altre droghe sarà in realtà molto più temibile, gli interventi di prevenzione-educazione alla salute dovranno puntare sulla trasmissione di informazioni e conoscenze e solo in un momento successivo lavorare sulle motivazioni dei giovani. Parole chiave: Alcol, Guida, Studenti, Conoscenza dei rischi Abstract Drinking and driving. Data on high school students’ habits and knowledge The article analyses some information collected, through a short questionnaire, from high school students about their knowledge and habits regarding alcohol and drinking and driving. It was only possible to carry out a qualitative analysis, given the specificity and exiguity or the sample. The answers show that young people still lack important information about alcohol and its effects, for example they do not understand the alcoholic unit concept. This means that when discussing alcohol in schools and during any educational interventions it is important to inform young people in particular about this problem before working on motivation. Keywords: Alcohol abuse, Drinking and driving, Students, Knowledge of the risks Perché ancora materiale su Alcol & Guida Gli studi, le ricerche, i programmi di intervento e di educazione alla salute che prendono in considerazione il comportamento “assunzione di alcolici associato alla guida di veicoli” sono sempre più numerosi (vd. per es. Coacci A. et al., 1998). La ragione di tanto interesse è facilmente comprensibile, bastano infatti pochi dati per inquadrare il problema alcol e guida nel mondo: nei paesi sviluppati gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni (ACI-ISTAT, 1998); sulla popolazione complessiva di Stati Uniti e Canada le ferite riportate in seguito a incidenti costituiscono la 4a causa di morte, dopo le malattie cardiache, i tumori e i disturbi cerebrovascolari. In Italia sono ormai più di 10 anni che i morti e i feriti sulla strada richiamano l’attenzione, sia dell’opinione pubblica (i “maxi-tamponamenti”, le “stragi del sabato sera”, ecc. sono infatti tra le notizie che occupano spesso le prime pagine dei giornali), sia del mondo politico e sociosanitario, * Psicologa, Psicoterapeuta. Consulente Dipartimento delle Dipendenze ASL di Bergamo. Via B.go Palazzo, 130 - 24125 Bergamo tel. 035. 4531366-374 fax 035.4531372. ** Psicologo, Dipartimento delle Dipendenze ASL di Bergamo. *** Medico, Responsabile del Dipartimento delle Dipendenze ASL di Bergamo. 27 Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (1) 2001 che cercano misure per prevenire gli incidenti, o almeno per limitarne i danni. Soprattutto gli incidenti stradali alcol-droga correlati, quelli in cui restano coinvolti per lo più ragazzi sotto i trent’anni, colpiscono per la loro numerosità e drammaticità, per la loro “stupidità”, perché sarebbero i più facilmente evitabili, se solo si riuscisse a modificare almeno in parte le abitudini dei guidatori, o dei bevitori. Le dimensioni del problema I freddi numeri delle statistiche rendono ancora più evidente la gravità del problema: “si stima infatti che il 46% dei morti a causa di incidenti stradali sia attribuibile all’uso di alcol e il 50% degli incidenti stradali non mortali abbia una correlazione con l’uso di alcol” (Noventa, 1998). Come riconosce Antonio Molfese: “…non esistono in Italia dati affidabili per tracciare un reale quadro d’influenza dell’alcol nella genesi degli incidenti stradali…” (Molfese, 1995), perché la pratica di misurare l’alcolemia non è ancora diffusa dovunque e perché molti piccoli incidenti non vengono neppure denunciati. I dati riportati dai diversi autori e ricercatori a volte non coincidono perfettamente, soprattutto perché prendono in considerazione indicatori diversi per calcolare il numero e il tipo di sinistri correlati all’uso di alcol: un confronto immediato tra i vari lavori pubblicati risulta quindi impossibile. Per esempio, indagini condotte tra il 1995 e il 1971 in Italia sulle persone che sono rimaste coinvolte in incidenti hanno indicato che la percentuale dei soggetti con alcolemia superiore a 50 mg/100 ml andava dal 38% al 54% nei deceduti e dal 19% al 43% nei feriti (Molfese, 1995). Più recentemente Ferrara e Rozza hanno rivelato di aver riscontrato su 2000 soggetti traumatizzati, ricoverati nel periodo compreso tra il 1978 e il 1992, una proporzione di positivi all’alcolemia pari al 52,7% (da Molfese, 1995). Correra e altri (1995) riferiscono che “numerosi studi condotti all’estero, soprattutto nei paesi anglosassoni, indicano la presenza di significative concentrazioni alcoliche nel sangue di automobilisti rimasti coinvolti in incidenti, in percentuali che variano dal 39% al 46% dei soggetti. Le ripercussioni sulla comunità Secondo la ricerca ISTAT-ACI del giugno 1998 “Il costo sociale degli incidenti stradali” (Putignano Pennisi, giugno 1998), tra il 1980 e il 1995 in Italia si è verificato un incremento pari al 11,6% nel numero degli incidenti stradali, mentre in questo stesso arco di tempo sono diminuiti in Germania (-6%), Regno Unito (-7,8%), Paesi Bassi (-3,6%), Austria (-15,7), Lussemburgo (-38,2%) e Francia (-46,5%). La fascia di età più colpita è ovunque quella compresa tra i 15 e i 24 anni; gli unici paesi che fanno eccezione sono Paesi Bassi, Svezia, Finlandia dove risulta più a rischio la fascia d’età sopra i 65 anni. 28 Sempre tra il 1980 e il 1995 in tutti i paesi dell’Unione Europea il numero dei morti a causa degli incidenti è costantemente diminuito, in Italia per esempio la variazione è stata di -23,7%, grazie ai miglioramenti nell’assistenza sanitaria e ai nuovi dispositivi atti ad aumentare la sicurezza passiva di cui sono dotati i veicoli (ABS, sistema frenante, struttura del telaio, ecc.) Confrontando i dati del 1970 e del 1995 in Italia vediamo che: il numero complessivo di incidenti è aumentato (da 173.132 a 176.000), quello dei morti si è fortemente ridotto (da 10.208 a 5.890), ma è tragicamente aumentato il numero dei feriti, di circa dieci volte rispetto al numero degli incidenti (da 228.236 a 252.060). Il dato è preoccupante e conferma “il peso rilevante degli incidenti stradali come generatori di handicap” (Taggi, 1998) Perché rivolgersi soprattutto ai giovani Alcuni autori hanno tentato di spiegare perché il tasso di mortalità negli incidenti stradali è così elevato tra i giovani; Putignano individua i motivi soprattutto in aspetti socioculturali “…I giovani rimangono coinvolti in così tanti incidenti stradali perché: - i neopatentati hanno meno esperienza; - guidano più ore durante la notte, quando il rischio è maggiore; - più spesso commettono infrazioni per eccesso di velocità; - è più elevato il numero di incidenti dovuti a eccesso di velocità, guida contromano, guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze psicotrope, tutte circostanze che comportano un elevato rischio di morte (Putignano, 1994). L’aspetto più clamoroso è costituito dal già ricordato fenomeno delle “stragi del sabato sera”; le rilevazioni ISTAT mostrano come il numero di incidenti del sabato notte (tra le ore 23 del sabato e le ore 6 della domenica) sono raddoppiati negli ultimi 15 anni, passando dai 2.325 casi registrati nel 1980 ai 6.691 del 1995 (+ 108,1%), i morti sono passati da 290 a 483 e i feriti da 5.525 a 12.334. Inoltre il livello di incidentalità del venerdì notte è andato assumendo le stesse dimensioni del sabato notte (nel 1995 sono stati contati: 4.907 incidenti con 8.258 feriti e 329 morti). Limitatamente agli incidenti che avvengono durante le ore notturne del venerdì e del sabato, la percentuale dei conducenti che risulta aver assunto alcolici o altre sostanze che ne compromettono le capacità di guida è superiore al 50%, anche in questo caso però mancano dati precisi. Chi ci aveva già pensato Già nel 1987, l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggeriva alle autorità competenti di tutti i paesi di mettere in atto e sviluppare programmi e misure di prevenzione degli incidenti stradali secondari all’uso improprio di bevande alcoliche, non solo all’interno della problematica alcol e Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore Articoli guida, ma soprattutto nell’ambito del problema più ampio dell’alcolismo (Taggi, 1998). Il documento originale indica infatti che “I programmi per la prevenzione degli incidenti dove l’alcol è fattore di rischio, dovrebbero essere parte di una politica di controllo dell’abuso di alcol” (OMS, Alcohol and accidents, Report of a WHO working group, Reykjavik 1-3 September 1987, ICP/APR 117 0344J, 1988). In seguito, nel 1991 l’Ufficio Europeo dell’OMS ha approvato un Piano d’Azione che mira alla diminuzione dei consumi di alcolici del 25% entro l’anno 2000 in tutti i paesi membri (Scafato E. Cicogna F., 1998); tra le iniziative realizzate all’interno del Piano d’Azione Europeo sull’Alcol e nel rispetto dei principi della Conferenza dell’OMS a Reykjavik nel 1994 l’ex-Az. USSL n.12 di Bergamo ha dato il via alla campagna di prevenzione-educazione alla salute “L’alcol batte in testa, non fare il pistone”, che in questi quattro anni si è via via arricchita di materiali e dati e si è diffusa sul territorio nazionale (Zucchi S. Noventa A., 1995). La campagna si rivolge a tutti coloro che guidano un mezzo di trasporto, ed è stata studiata soprattutto per i giovani: viene infatti presentata ogni anno con grande successo agli studenti delle ultime classi delle Scuole Superiori. I dati recenti Durante l’anno scolastico 1997/98 gli operatori dell’U.O. Alcologia dell’A.S.L. di Bergamo hanno proposto il pacchetto di intervento “Alcol & Guida”, nei territori corrispondenti alle ex-USSL n. 11 e n. 12, raggiungendo circa 1500 soggetti, nelle classi 4e e 5e di 17 Istituti Superiori e in due scuole guida. In un unico Istituto è stato realizzato il progetto completo, consistente in tre incontri con gli operatori dell’ASL (medico e psicologo) e il rappresentante delle forze dell’ordine (vigile della polizia municipale) intervallati da discussioni in classe tra i ragazzi e con l’insegnante, e da lavori di gruppo. In tutte le altre scuole è stata effettuata una sola conferenza, consistente in un incontro tra un gruppo di 4050 ragazzi e gli operatori dell’ASL, con la collaborazione di agenti della Polizia Municipale e della Polizia Stradale. In entrambi i casi l’intervento del medico e dello psicologo venivano supportati dalla presentazione di materiale audiovisivo (il video “L’alcol batte in testa non fare il pistone” e un documentario realizzato da una TV privata sulle “stragi del sabato sera”, contenente la testimonianza di un giovane rimasto vittima di un drammatico incidente stradale). Erano inoltre distribuiti materiali informativi e gadgets: opuscoli, segnalibri, manifesti, adesivi, magliette, dischi orari riproducenti il logo e lo slogan della campagna. Prima dell’inizio dell’intervento veniva distribuito un micro questionario con 15 domande a scelta multipla; tale questionario era stato ideato allo scopo di verificare se le informazioni fornite durante gli interventi producono modificazioni a livello cognitivo: se cioè sentir parlare di alcolici, di effetti provocati dal loro consumo, di dati relativi a mortalità e morbilità alcolcorrelate, di risultati ottenuti nel corso di indagini epidemiologiche sulle abitudini dei giovani lombardi e bergamaschi quanto a consumo di alcol, può indurre cambiamenti nella percezione e nella sensibilità dei ragazzi rispetto agli incidenti stradali, alla pericolosità di certi comportamenti, alla diffusione dei problemi alcolcorrelati, ecc. La formulazione delle domande è stata guidata dall’idea che lo stesso questionario, o una versione leggermente modificata, sarebbe stato distribuito agli stessi soggetti a distanza di pochi mesi, entro la fine dell’anno scolastico. L’ipotesi che intendevamo verificare era se la maggiore informazione sugli effetti dell’alcol e sulla correlazione tra consumo di alcolici, malattie e incidenti avrebbe consentito ai giovani di identificare come alcolcorrelati eventi a loro vicini, che in precedenza non avevano messo in relazione con l’alcol; non ci aspettavamo cioè di rilevare cambiamenti nei comportamenti o nei consumi dei giovani, in accordo con gli obiettivi del programma che sono prima di tutto informare e sensibilizzare al problema. Alcune domande erano poi esclusivamente dirette alla verifica dell’acquisizione di quelle informazioni ritenute di utilità pratica (per esempio il limite di alcolemia consentito dalla legge a chi guida, in Italia e all’estero). La seconda parte della ricerca non è stata effettuata, quindi l’analisi della prima somministrazione ci potrà fornire indicazioni solo a proposito delle conoscenze precedenti l’intervento e delle esperienze dirette dei ragazzi oltre che delle spiegazioni e interpretazioni che circolano tra loro su questi temi. Hanno risposto al questionario complessivamente 1.406 ragazzi, di cui 780 femmine e 626 maschi, oltre la metà residente a Bergamo, città e periferia, circa un terzo residente in diversi paesi della Val Brembana e meno del 2% in paesi della Val Imagna, reclutati tra le classi 4ª e 5ª di 17 Istituti Superiori della provincia di Bergamo, nei territori corrispondenti alle ex-USSL 11 e 12, e in due scuole guida1. Solo il 16,1% degli intervistati aveva superato la maggiore età, tra questi sicuramente i 54 frequentatori delle scuole guida, pari al 3,8% del campione totale, mentre gli altri soggetti erano compresi tra i 16 e i 18 anni. Cosa fanno e cosa sanno i giovani Per quanto riguarda le abitudini del campione rispetto alla guida dei mezzi di trasporto il 21,1% dichiara di guidare l’automobile (questo significa che una settantina di giovani guida prima di aver raggiunto l’età per la patente), più della metà dei soggetti usa la bicicletta o il ciclomotore, solo il 13% dei ragazzi e il 4,5% delle ragazze non guida nessun veicolo. I quasi tre quarti dei maschi (71%) e un quarto delle femmine (25,9%) affermano di aver bevuto birra prima di mettersi alla guida di un mezzo di trasporto, leggermente inferiori, e molto vicine tra loro sono le percentuali dei giovani che dichiarano di aver bevuto vino o superalcolici, rispettivamente 52% e 44,5% dei maschi e 14,4% e 13,7% Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore 29 Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (1) 2001 delle femmine. Non è stata prevista una domanda relativa alle quantità di alcolici assunti prima di mettersi alla guida; tenendo conto però della risposta data alla domanda numero 9 “Secondo te, quanti bicchieri di vino o di birra o bicchierini di superalcolico si possono bere prima di guidare, senza correre il rischio di fare incidenti?” possiamo ipotizzare che i ragazzi in questione bevano dosi molto superiori a quelle sufficienti a raggiungere il limite di alcolemia consentito dalla legge. Si può infatti notare come i soggetti sottostimino gli effetti prodotti dall’alcol: solo una percentuale molto bassa identifica la sicurezza con la sobrietà e sembra che siano solo i superalcolici a essere considerati pericolosi (fig. 1). Vediamo infatti (fig. 2) che per guidare sicuri non bisogna bere vino per il 4,1% dei maschi e delle femmine, birra per il 2,8% dei maschi e il 4,2% delle femmine e superalcolici per il 31,6% dei maschi e per il 44,2% delle femmine. È addirittura più alta la percentuale di coloro che considerano non pericoloso bere più di 4 bicchieri prima di guidare, precisamente il 12,3% dei maschi e il 5,1% delle femmine, se si tratta di vino, il 17,5% e dei maschi il 5,8% delle femmine, se si tratta di birra. Si conferma l’idea che i superalcolici siano i più temuti, infatti solo lo 0,5% delle femmine ma ben il 5,6% dei maschi ritiene che si possa guidare con sicurezza dopo l’assunzione di più di 4 bicchierini di superalcolico. Questo dato appare sconcertante e riteniamo altamente improbabile che tra la popolazione adulta una percentuale così alta di soggetti possa considerare sicuro guidare dopo avere bevuto quattro bicchierini di superalcolico. La fascia di consumo che la maggior parte degli intervistati valuta compatibile con la sicurezza sulla strada è di 1-2 bicchieri/ini dei tre tipi di bevande (oltre il 50% di maschi e di femmine) e un 30% circa dei ragazzi ritiene esente da pericoli anche guidare dopo aver bevuto 3-4 bicchieri di vino/birra, ma non di superalcolico. Gli incidenti stradali appartengono alla sfera di esperienza dei ragazzi: complessivamente, infatti, più della metà è rimasta coinvolta in incidenti stradali: il 29,6% dei maschi e il 9,8% delle femmine mentre guidavano, e il 37,4% dei maschi e 35,2% delle femmine come passeggeri (fig. 3). Quando si tratta di specificare la causa che ha provocato l’incidente in cui sono rimasti coinvolti la percentuale più significativa indica la distrazione (45,6% delle femmine e 33,3% dei maschi), seguono le infrazioni al codice della strada (18,6% delle femmine e 25,5% dei maschi) e la velocità (18,2% dei maschi e 17,3% delle femmine). I consumi di alcol, droghe, farmaci o psicofarmaci vengono indicati come cause dell’incidente da una bassa percentuale di intervistati; è significativo il fatto che l’alcol venga riconosciuto da un numero di ragazzi quasi 10 volte più alto (4,2% delle femmine e 4% dei maschi, rispetto allo 0,6% delle femmine e 0,3% dei maschi che indica il consumo di droghe) (fig. 4). Notiamo inoltre che questa è la domanda che ottiene il numero più elevato di “non risponde”, con una percentuale pari al 53,6. Sapendo che mediamente la metà circa degli incidenti stradali in qualche modo ha una relazione con il consumo 30 di alcol, possiamo supporre che i ragazzi non riconoscano il problema e che individuino solo la causa ultima dell’incidente, la velocità o la distrazione, senza rendersi conto del fattore scatenante e cioè del consumo di sostanze, alcol soprattutto, che diminuisce le capacità di concentrazione e attenzione e aumenta la tendenza a correre rischi. Questo dato corrisponde a quello sopra commentato sulla tendenza a sottostimare gli effetti provocati dall’alcol (figg. 1 e 2). Con così poche informazioni a disposizione sembra difficile poter affermare che i giovani siano consapevoli del rischio e lo corrano deliberatamente, lo cerchino e lo sfidino. Almeno quando si parla di alcol, pare che siano pochissimi i ragazzi che sanno per esperienza come assumere alcolici prima di guidare aumenti il rischio di fare incidenti, visto che solo il 4,1% l’ha potuto osservare nell’ambito familiare allargato e poco più del 20% ha un amico cui è successo (questo almeno è ciò che i ragazzi credono!) (fig. 6). L’ipotesi è avvalorata dal fatto che più del 90% degli intervistati conosce qualcuno che ha problemi con l’alcol tra familiari, amici, parenti o conoscenti (fig. 5), dato che ci indica quanto sia esteso il problema nel territorio in questione, e la totalità dei soggetti conosce qualcuno che ha avuto un incidente stradale; quasi la metà dei ragazzi dice però di non conoscere nessuno che abbia avuto un incidente stradale alcolcorrelato (41,1% del totale) (fig. 6). Le domande n° 5, 6 e 7 sono quelle alle quali maschi e femmine danno le risposte più simili tra loro, quasi a confermare l’uniformità delle esperienze (figg. 7, 8, 9) È da notare inoltre come alle domande 5 e 7, quelle relative ai problemi con l’alcol e agli incidenti alcolcorrelati, i soggetti indichino una percentuale significativamente inferiore tra parenti e familiari, rispetto ad amici e conoscenti, confermando le teorie secondo le quali quanto più prossimo è il problema, tanto meno risulta visibile, mentre viene notato e riconosciuto più facilmente in persone lontane da sé, o comunque esterne alla cerchia familiare. Come già segnalato da Monarca (Monarca, 1998) nei commenti ai dati della ricerca condotta sugli studenti lombardi, appare preoccupante l’alta percentuale di amici, che si suppone abbiano un’età vicina a quella degli intervistati, che vengono già identificati per avere problemi con l’alcol o per essere rimasti vittime di incidenti stradali alcolcorrelati (figg. 5 e 6). Oltre la metà dei ragazzi sa che il limite massimo di alcolemia consentito a chi guida equivale a 0.80 gr/100 ml di sangue e complessivamente più del 90% ha indicato un valore compreso entro questa cifra. Più dell’80% degli intervistati è inoltre al corrente del fatto che il limite non è uguale in tutte la nazioni. Le risposte alla domanda numero 12 “Quanti bicchieri di vino/birra/bicchierini di superalcolico si devono bere per raggiungere il tasso alcolemico consentito a chi guida?” confermano la tendenza dei giovani a sottovalutare gli effetti dell’alcol. Poco più del 60% indica infatti un numero di bicchieri di vino e di birra compresi tra 0 e 2, mentre quasi il 90% limita a un massimo di 2 i bicchierini di superalcolico tollerabili prima di superare il limite consentito dalla legge (fig. 10). Purtroppo, non avendo potuto condur- Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore Articoli re la seconda somministrazione del questionario, non abbiamo modo di verificare se grazie all’intervento i ragazzi hanno acquisito il concetto di unità alcolica e se sono in grado di rapportare le quantità assunte, la gradazione alcolica e gli effetti prodotti. A proposito degli effetti che l’ingestione di alcol produce su chi si mette alla guida di un veicolo sembra che la maggior parte dei giovani abbia le idee piuttosto chiare; superano, infatti, il 70% delle scelte le seguenti risposte: sonnolenza, annebbiamento della vista, incapacità di valutare i rischi, rallentamento dei riflessi e quasi il 50% degli intervistati indica anche la sopravvalutazione delle proprie capacità. Le femmine del campione appaiono più consapevoli dei rischi connessi al consumo di alcol, come indicano chiaramente due risposte tra tutte: il 5% dei maschi, ma solo lo 0,3% delle femmine sceglie come effetto dell’alcol la maggior prudenza e il 4,2% dei maschi ma solo lo 0,2% delle femmine sceglie la miglior concentrazione (fig. 11). La conoscenza delle malattie e dei disturbi provocati dal consumo di alcol sembra essere notevolmente più accurata di quella rilevata con gli studenti delle scuole superiori della provincia di Bergamo in occasione della ricerca condotta in collaborazione con l’Università di Brescia (Centro Studi Alcologia, 1997). Se confrontiamo le percentuali di studenti che hanno scelto i diversi items nella nostra ricerca e in quella regionale troviamo, infatti: Malattie o disturbi provocati dal consumo di alcol Dipendenza Tumori Danni all’apparato cardiovascolare Malattie del cavo orale Decalcificazione ossea Disturbi sessuali Disturbi cronici al SNC Danni al fegato Danni all’apparato digerente Danni al feto/aborto Incidenti, traumi Percentuale di soggetti, sul totale degli intervistati, che sceglie i seguenti items Ricerca 1993/4(2) Ricerca 1998(3) 10,4 2,1 1,3 0,1 0,1 0,9 4,4 22,1 5,4 0 1,6 80,3 18,9 53,6 6,8 5 33,9 45,7 93,6 28,4 28,9 53,7 Le differenze sono notevoli; è come se nel giro di due anni le nozioni in tema di alcologia dei ragazzi fossero notevolmente aumentate. Azzardiamo l’ipotesi che, così come molti studenti conoscevano già lo slogan della campagna avendo visto i manifesti e gli opuscoli che erano stati distribuiti tra i compagni più anziani durante gli anni precedenti, i nostri soggetti avessero anche già acquisito alcune tra le informazioni più “scioccanti” e le notizie più utili, rispettivamente i danni alla salute che derivano da un consumo “moderato” e il limite di alcolemia consentito dalla legge. Se questa ipotesi fosse corretta, dimostrebbe l’interesse suscitato dal programma e l’inizio di una trasmissio- ne di sapere; come sappiamo però, l’essere a conoscenza dei pericoli connessi a un comportamento raramente spinge a modificarlo, soprattutto se si tratta di adolescenti. Occorre anche tener conto della diversa composizione del campione rispetto all’età; se nella nostra ricerca andava mediamente dai 17 ai 20 anni (4° e 5° anno delle Scuole Superiori), forse qualcuno più anziano nelle classi di scuola guida, nella ricerca regionale i questionari erano stati distribuiti nelle classi 1ª e 5ª degli Istituti Superiori. I nostri soggetti erano quindi tutti giovani “in età di patente”, più interessati al problema, direttamente coinvolti e almeno in parte già informati proprio perché negli stessi Istituti erano già stati condotti i programmi, spesso coinvolgendo i loro insegnati. Queste spiegazioni possono rendere ragione anche delle differenze alla risposta n. 8 “Secondo te, qual è la percentuale di incidenti dovuta all’alcol in Italia?” Nella nostra ricerca sembra infatti che complessivamente i ragazzi abbiano molto più chiaro che l’associazione alcol e guida è pericolosa ed è la causa di molti incidenti: quasi tre quarti dei soggetti sceglie una percentuale compresa tra 30 e 72 e solo il 17% dei ragazzi ritiene che gli incidenti stradali provocati dall’alcol siano meno del 30% (fig. 12). Le statistiche ufficiali, che vengono presentate ai ragazzi durante l’intervento, comprese anche nel video “Alcol & Guida”, dicono che oltre il 30% degli incidenti stradali mortali è alcolcorrelato e che l’alcol è presente nel 52% degli utenti della strada coinvolti in incidenti; quindi sembra che ci sia stato un passaggio di informazioni. Come già rilevato per altre risposte si direbbe che le femmine siano più allarmate dagli effetti provocati dall’alcol rispetto ai loro coetanei maschi. Nella ricerca regionale la stima della percentuale di incidenti provocati dall’alcol risultava invece più bassa e così ripartita: il 31,1% dei soggetti indicava la fascia dall’1 al 30% di incidenti stradali come alcolcorrelati, il 57,7% sceglieva la fascia tra 31 e 70% e il 7% dei ragazzi quella oltre il 71%. Alla domanda “Cosa potrebbe rendere le strade più sicure?” più della metà degli intervistati risponde che occorrerebbero maggiori controlli da parte della Polizia Stradale (59%) (fig. 13) e tutte le altre opzioni raggiungono al massimo il 41% delle scelte. I giovani intervistati quindi sanno che le leggi non vengono rispettate e che il controllo da parte delle Forze dell’Ordine è insufficiente al punto che “è facile farla franca”. Dimostrano inoltre un ottimo spirito critico, infatti proprio l’intensificazione dei controlli casuali dell’alcolemia dei conducenti di veicoli è la misura preventiva suggerita dalla maggior parte degli esperti che si occupano del problema. Ancora una volta possiamo notare come le femmine sembrino essere più consapevoli dei rischi reali: esse scelgono in percentuali inferiori rispetto ai maschi proposte come: migliorare l’illuminazione delle strade, costruire automobili più sicure, migliorare le strade, mentre li superano nella scelta di quelle che sono le strategie riconosciute per la loro efficacia e adottate dai paesi più avanzati nella prevenzione degli incidenti stradali: aumentare i controlli da parte della Polizia Stradale (necessario affinché tutti gli altri provvedimenti possano essere efficaci), ridurre il livello di alcolemia consentito a chi guida, Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore 31 Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (1) 2001 vietare la vendita di alcolici in autostrada, abbassare i limiti di velocità. Complessivamente i 1406 ragazzi del campione che ha risposto al nostro questionario dimostrano di essere sufficientemente informati sugli effetti e le conseguenze del consumo di alcol. È certo che gli incidenti stradali appartengono alla loro esperienza, tutti loro infatti conoscono qualcuno che ne è rimasto vittima e più della metà ne ha fatto esperienza in prima persona. Oltre il 50% dei ragazzi inoltre conosce qualcuno che ha subito o provocato un incidente a causa del consumo di alcol; tutti sono informati sugli effetti a lungo termine che l’alcol provoca sulla salute fisica e psichica e a breve termine sulle capacità di eseguire una prestazione, sottovalutano però la pericolosità dell’alcol. Si può evincere che ci sia poca o nessuna consapevolezza del fatto che l’assunzione di anche minime quantità di bevanda alcolica interferisce con la capacità di guidare: i ragazzi conoscono le modificazioni su riflessi, attenzione, ecc. che insorgono dopo aver bevuto, ma ritengono che queste compaiano solo in seguito a un forte consumo. In particolare è completamente assente la nozione di unità alcolica, cioè della relazione tra gradazione alcolica di una bevanda e la quantità assunta: è importante che un giovane sappia per esempio che la birra ha mediamente 4 gradi alcolimetrici, mentre un superalcolico ne contiene dieci volte tanto, ma deve anche aver chiaro che una birra media (500 ml.) produce gli stessi effetti di un bicchierino di superalcolico (40 ml.). Come già commentato le risposte alle domande 9 e 12 mostrano invece che il nostro campione sottovaluta gli effetti del vino e soprattutto della birra, la bevanda alcolica più diffusa tra i giovani, e sono parzialmente consapevoli solo degli effetti provocati dall’ingestione di notevoli quantità di superalcolici, che comunque quasi un terzo di loro ha bevuto prima di guidare (fig. 14). In conclusione crediamo di poter affermare che il livello di conoscenza dei giovani che studiano nelle scuole in cui viene condotto da anni il programma “Alcol & Guida” si sia innalzato, ma che non sia ancora tale da consentire ai ragazzi una vera e totale libertà di scelta. Riteniamo che questo dipenda dalla diffusione che l’alcol conosce nella società occidentale, mediterranea soprattutto, la tolleranza di cui gode in tutti i livelli sociali, la valenza culturale assunta da alcune bevande. Mentre la conoscenza della pericolosità delle sostanze illegali, almeno per quanto riguarda le sostanze tradizionali, è assodata e diffusa, al punto che si può affermare che i rischi connessi al loro consumo vengano deliberatamente assunti in piena consapevolezza, le conseguenze legate al consumo di alcolici non sono ancora così note. Ecco perché crediamo che non si possano estendere all’alcol le spiegazioni usate per dare un senso ai comportamenti tossicomanici. Sembra soprattutto che siano state recepite le 32 informazioni sui danni legati a un uso massiccio e prolungato di alcol, e che siano molto meno chiari gli effetti prodotti dal consumo di ridotte quantità di sostanza. Riteniamo perciò che il primo passo da fare per aiutare i giovani a fare scelte in tutela e difesa della propria salute, sia quello di accrescere il loro livello di conoscenza. Note (1) Le due scuole guida si trovano nel territorio di un comune adiacente alla città di Bergamo che per l’anno 1997 ha aderito al progetto Città Sane e che pertanto ha attuato numerosi interventi di educazione alla salute sulla cittadinanza, per esempio, appunto, sono stati divulgati i programmi su alcol e guida. (2) Si trattava di una domanda aperta. (3) Era una domanda a risposte chiuse, senza limiti nel numero di risposte. Bibliografia 1) Centro Studi Alcologia e problematiche alcolcorrelate Az. USSL n° 12 (A cura di) (1997) Ricerca. Consumi, atteggiamenti e conoscenze degli adolescenti nei confronti di alcol, fumo e farmaci a Bergamo. Risultati preliminari (non pubblicato) 2) Coacci A. Di Tommaso L. Pani P. (1998) Campagna di prevenzione degli incidenti stradali Estate 1997. Prima analisi dei dati rilevati. Boll. Farmacodip. e Alcoolis., Suppl. al n° 1, 35-38 3) Correra M.M. Putignano C. Martucci P. (1995) Alcolismo e incidenti stradali. Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti – ACI n° 3 maggio-giugno anno XLIX 4) Molfese A. (marzo 1995) Alcol e sicurezza stradale. CISAS Periodico Mensile d’Informazione III n°3 5) Monarca S. (1998) Alcol e adolescenti. Vivereoggi n° 5, 2541 6) Noventa A. (marzo 1998): Alcol e guida: un intervento di comunità, p. 172-187. In: Noventa A. (A cura di) “Alcol e guida. Diagnostica, legislazione e prevenzione” Atti 7) Putignano C. (1994). Gli incidenti stradali e i giovani In “Atti della cinquantesima conferenza del traffico e della circolazione, Stresa, 5-7 ottobre, 1994” 8) Putignano C. Pennisi L. (A cura di) (1998) “Il costo sociale degli incidenti stradali - una ricerca ISTAT-ACI” Roma, giugno 1998 9) Scafato E. Cicogna F. (1998) I consumi alcolici in Italia e in Europa e l’intervento previsto dal piano sanitario nazionale 1998-2000 nel quadro dell’Obiettivo n. 17 del progetto O.M.S. “Health for All” Boll. Farmacodip. e Alcoolis., Suppl. al n° 1, 11-20 10) Taggi F. (1998) L’alcol come fattore di rischio negli incidenti stradali gravi e mortali, p. 17-46. In: Noventa A. (A cura di) “Alcol e guida. Diagnostica, legislazione e prevenzione” 11) Zucchi S. Noventa A. (1995) Alcol e guida. Un programma di prevenzione per gli studenti delle scuole superiori di Bergamo. Alcolismi 7, 3, 20-21 Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore Articoli Figura 1 Figura 2 Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore 33 Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (1) 2001 Figura 3 Figura 4 34 Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore Articoli Figura 5 Figura 6 Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore 35 Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (1) 2001 Figura 7 Figura 8 36 Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore Articoli Figura 9 Figura 10 Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore 37 Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (1) 2001 Figura 11 Figura 12 38 Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore Articoli Figura 13 Figura 14 Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore 39 Boll. Farmacodip. e Alcoolis., XXIV (1) 2001 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo QUESTIONARIO: ALCOL E GUIDA ISTRUZIONI: Il questionario è anonimo. Si prega di compilarlo personalmente e individualmente, mettendo una o più crocette per indicare la propria scelta. N. ____ Età ______ Sesso ______ Classe ______ Comune di Residenza ______________ Scuola ___________ 1) Quali di questi mezzi di trasporto guidi? ■ auto ■ motociclo ■ ciclomotore ■ bicicletta ■ nessuno 2) Ti è mai capitato di bere prima zo di trasporto? Birra ■ SI Vino ■ SI Super alcolici ■ SI di usare un mez■ NO ■ NO ■ NO 3) Sei mai stato coinvolto in prima persona in un incidente stradale? Mentre guidavi ■ SI ■ NO Come passeggero ■ SI ■ NO 4) Quale è stata la causa dell’incidente? ■ velocità ■ distrazione ■ cattive condizioni atmosferiche ■ consumo di alcol ■ consumo di droghe ■ uso di farmaci o psicofarmaci ■ infrazione al codice della strada ■ stanchezza 5) Conosci qualcuno che ha avuto o ha problemi con l’alcol? ■ familiari ■ parenti ■ amici ■ conoscenti 6) Conosci qualcuno che è rimasto coinvolto in incidenti stradali? ■ familiari ■ parenti ■ amici ■ conoscenti 7) Conosci qualcuno che ha avuto un incidente stradale alcolcorrelato? ■ familiari ■ parenti ■ amici ■ conoscenti 8) Secondo te, qual’è la percentuale di incidenti stradali dovuti all’alcol in Italia? _________________________________________ 9) Secondo te, quanti bicchieri di vino o birra o bicchierini di super alcolico si possono bere prima di guidare senza correre il rischio di fare incidenti? 0 1-2 3-4 più di 4 bicch. bicch. bicch. bicch. Vino ■ ■ ■ ■ Birra ■ ■ ■ ■ S. alcolici ■ ■ ■ ■ 40 10) Secondo la legge italiana, quale livello di alcolemia (grammi di alcol per ogni litro di sangue) ci può essere al massimo in una persona che guida? (indica il livello consentito mettendo una crocetta sulla scala) 0 0.50 0.80 1 2 | | | | | ___________________________________ 11) Il limite di alcol massimo consentito a chi guida è uguale in tutti i paesi della Comunità Economica Europea? ■ SI ■ NO 12) Quanti bicchieri di vino o birra o bicchierini di super alcolici si devono bere per raggiungere il tasso alcolico consentito dalla legge? 0 bicch. 1 bicch. 2 bicch. 3 bicch. 4 bicch. Vino ■ ■ ■ ■ ■ Birra ■ ■ ■ ■ ■ S. alcolici ■ ■ ■ ■ ■ 13) Quali sono gli effetti dell’alcol su chi guida? ■ sonnolenza ■ prudenza ■ più sicurezza ■ euforia ■ depressione ■ miglior concentrazione ■ rallentamento dei riflessi ■ sopravvalutazione delle proprie capacità ■ maggiore precisione nelle manovre ■ incapacità di valutare i rischi ■ annebbiamento della vista ■ altro _________________________________ 14) Secondo te, cosa potrebbe rendere le strade più sicure? (indicare tre scelte) ■ abbassare i limiti di velocità ■ ridurre il tasso alcolico consentito ai guidatori ■ migliorare la mavimentazione stradale ■ vietare la vendita di alcolici in autostrada ■ costruire auto sempre più sicure (air bag, …) ■ aumentare i controlli di polizia stradale ■ migliorare l’illuminazione 15) Quali malattie o disturbi sono provocati dall’alcol? ■ dipendenza ■ tumori ■ danni all’app. cardiovascolare ■ malattie del cavo orale ■ decalcificazione ossea ■ disturbi sessuali ■ danni al fegato ■ danni all’app. digerente ■ danni al feto-aborto ■ incidenti-traumi ■ disturbi cronici al Sistema Nervoso Centrale Grazie per la cortese collaborazione. Alcol e guida: abitudini e conoscenze degli studenti di scuola media superiore
Scarica