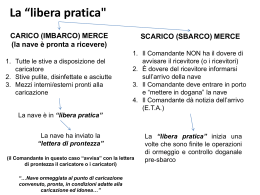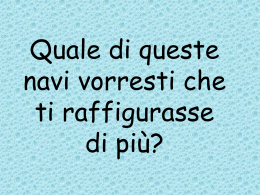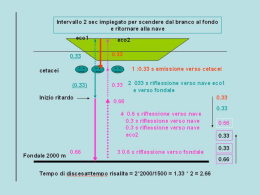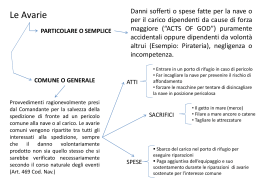Massimo Polidoro titanic Un viaggio che non dimenticherete Pubblicato in accordo con Grandi & Associati, Milano Redazione: Edistudio, Milano I Edizione 2012 © 2012 - EDIZIONI PIEMME Spa 20145 Milano - Via Tiziano, 32 [email protected] - www.edizpiemme.it 1 TUTTI A BORDO! Southampton, 10 aprile 1912 Joseph Bruce Ismay portò la tazza di tè alle labbra, poi si asciugò i baffi con un tovagliolo di lino. Dalla grande finestra della sala da pranzo del South Western Hotel osservava compiaciuto l’interminabile processione di fuochisti, stivatori, macchinisti, camerieri e altri membri dell’equipaggio che dalle prime ore del mattino aveva iniziato a snodarsi, alla spicciolata, lungo la strada che conduceva al porto. Era una bella giornata di sole, anche se un po’ fredda, quel mercoledì 10 aprile e Ismay non poteva sentirsi più soddisfatto. Era giunto a Southampton il giorno prima, dopo avere viaggiato da Londra con la famiglia a bordo della sua Daimler Landaulette guidata dal suo fidato chauffeur, e finalmente avrebbe mostrato a Florence e ai bambini l’opera di cui tutti i giornali parlavano e di cui era più orgoglioso, il Titanic. Da quando aveva preso il posto del padre alla guida della White Star Line, dodici anni prima, era riuscito a trasformare la compagnia nella più agguerrita concorrente della Cunard. Grazie al forte supporto economico del governo britannico, che intendeva contendere la supremazia navale ai tedeschi, la compagnia rivale era riu- 25 scita nel 1907 a creare due supernavi per la navigazione transatlantica, il Lusitania e il Mauritania, considerate le più grandi e veloci esistenti in mare. L’occasione di ribaltare la situazione giunse per la White Star con l’adesione all’americana International Mercantile Marine Company, fondata dal ricchissimo banchiere statunitense John P. Morgan. Era una fusione di più compagnie navali che, grazie alla grande disponibilità economica dei suoi soci, offriva il capitale necessario alla costruzione di un nuovo tipo di transatlantici giganti. Il primo era stato l’Olympic, presentato al pubblico nel 1908 e varato tre anni dopo, subito acclamato come «il prodotto più completo e raffinato della formidabile maestria della prima nazione marinara del mondo». Ismay ricordava ancora il giorno in cui, giunto a terra dopo avere accompagnato la nave nel suo primo viaggio fino a Liverpool, aveva telegrafato entusiasta alla moglie: «L’Olympic è una meraviglia!». Era un vero e proprio palazzo galleggiante e si era rivelato così richiesto dalla clientela abbiente, soprattutto tra i ricchi americani, che la prima classe non riusciva ad accogliere tutte le richieste. Per questo era stato necessario accelerare i lavori di una seconda nave che, pur riprendendo la struttura e i piani dell’Olympic, puntava a superarlo in lusso e sfarzo. Il nome era certo legato alla necessità della White Star di avere tutte navi che finissero in “ic”, come era stato per le precedenti Oceanic, Adriatic, Baltic, Germanic, Teutonic, Majestic e, naturalmente, Olympic. Ma Ismay aveva superato se stesso quando aveva proposto per il nuovo transatlantico il nome di Titanic. Era un nome perfetto, ripreso dai titani del mito greco, che riusciva 26 a trasmettere istantaneamente un’idea di superiorità e magnificenza. Non era riuscito a trattenere un sorriso di soddisfazione quando, qualche tempo dopo l’annuncio del nome della nuova nave, proprio quel termine era comparso in un discorso del ministro del commercio Winston Churchill. In visita a Manchester, Churchill aveva dichiarato che un’epoca era finita e ne stava cominciando una nuova: «E con questa nuova epoca strani metodi, forze enormi e più grandi unioni – a titanic world, un mondo titanico – si sono aperti intorno a noi. Le fondamenta del nostro potere stanno cambiando. Restare immobili significherebbe cadere e cadere vorrebbe dire perire. Dobbiamo andare avanti. E andremo avanti!». Il Titanic, dunque, era ben presto divenuto il simbolo di questa nuova era che, nessuno ne dubitava, avrebbe portato enormi progressi e benessere per tutti. Ismay poteva ben dire di avere raggiunto il picco della sua carriera. Solo a dicembre avrebbe compiuto cinquant’anni, ma quel giorno di aprile, il giorno della partenza per il viaggio inaugurale del Titanic, rappresentava per lui il più bel regalo di compleanno che avrebbe mai potuto desiderare. I quattro giganteschi fumaioli della nave torreggiavano in lontananza sovrastando gli edifici che ospitavano le compagnie di navigazione e gli spedizionieri. Lawrence Beesley, che li osservava seduto nella veranda del South Western Hotel, ebbe la conferma di avere fatto un’ottima scelta. Erano stati gli amici che avevano viaggiato magnificamente sull’Olympic a consigliargli quella nave. Non ci sarebbe stato modo migliore di iniziare la sua va- 27 canza se non a bordo di quella reggia galleggiante. Era rimasto vedovo, con un solo figlio che aveva lasciato a casa, e un viaggio che lo avrebbe portato a Toronto in visita a suo fratello era sembrato il modo migliore per riprendersi dalla stanchezza accumulata. I suoi studenti al Dulwich College di Londra sarebbero rimasti a bocca aperta di fronte a tanta imponenza ma lui, come loro insegnante di scienze, si sarebbe schiarito la voce e avrebbe colto l’occasione per raccontare come fosse possibile, secondo il principio di Archimede, che una nave tanto pesante restasse a galla. I giornali, che Beesley aveva praticamente divorato nei giorni passati, erano stati generosi di dettagli: 46.328 tonnellate lorde, 52.310 tonnellate di dislocamento. E poi le dimensioni: 268,83 metri di lunghezza, 28 metri di larghezza, 18 metri dalla linea di galleggiamento al ponte lance e 53 metri dalla chiglia alla cima dei quattro fumaioli. Come l’Olympic, il Titanic era una nave a tre eliche, dotata di due macchine alternative a quattro cilindri, ciascuna delle quali azionava un’elica laterale, e di una turbina a bassa pressione che comandava l’elica centrale. Una potenza da 50.000 cavalli che, spinta al massimo regime, poteva raggiungere i 24, forse addirittura i 25 nodi. Nonostante tanta grandezza apparisse senza precedenti, la caratteristica che la rendeva unica era un’altra: la sua costruzione stagna. Era dotata di un doppio fondo ed era divisa in sedici compartimenti stagni, formati da quindici paratie trasversali, a tenuta. È vero che non erano molto alte: le prime due e le ultime cinque raggiungevano solo il ponte D, mentre le otto centrali si fermavano al ponte E. D’altra parte, la nave era stata costruita 28 per poter galleggiare con due compartimenti allagati. Era la catastrofe peggiore che si potesse immaginare, una collisione alla congiuntura tra due compartimenti: se un’altra nave le fosse finita contro, i compartimenti si sarebbero riempiti d’acqua e non sarebbe successo niente. Il mastodonte avrebbe forse oscillato ma sarebbe rimasto tranquillamente a galla. Ecco perché in tanti avevano iniziato a definire il Titanic “l’inaffondabile”. «Vorrai scherzare!» esclamò una voce maschile alle sue spalle. «Ti dico che è così, niente potrebbe tirare giù quel bestione.» Beesley sorrise. Evidentemente il Titanic era l’unico argomento di cui fosse concepibile parlare in città quel giorno. «È troppo grosso» continuò la prima voce. «Può andare a sbattere da qualche parte. Come fai a fare una manovra d’emergenza con quel mastodonte?» «Se l’hanno chiamato l’inaffondabile ci sarà un motivo» tagliò corto il secondo interlocutore. «Per tutti i diavoli! Non esistono navi inaffondabili.» Beesley si guardò intorno e concluse che buona parte degli ospiti dell’hotel sarebbe salita sul Titanic quel giorno. Riconobbe l’armatore della nave, Bruce Ismay, un uomo alto, con un bel portamento, elegante. Sfoggiava due baffi neri impomatati e aveva una bella carnagione abbronzata. Si alzò dal tavolo della colazione seguito dalla moglie e dai suoi tre bambini. Sembravano una famiglia perfetta. La sera prima Beesley aveva notato nella hall dell’albergo un altro volto che gli era sembrato famigliare. Un uomo rossiccio, dalla fronte alta e dalla corporatura 29 esile. Lì per lì non lo aveva riconosciuto, ma quando poi si era ritirato in camera, sfogliando il «Times» di quella mattina, vi aveva trovato quello che si aspettava, un’illustrazione che ritraeva proprio il viso di quell’uomo. Si trattava di Thomas Andrews, uno dei direttori generali della Harland & Wolff, il grande cantiere navale di Belfast che aveva costruito tutte le navi della White Star Line. Il «Times» lo descriveva come la mente che, a soli trentanove anni, aveva concepito il Titanic dall’inizio alla fine. Una nave che lui stesso chiamava con affetto “la mia creatura”. Eppure, a vederlo mentre parlava con il concierge, togliendosi il cappello per salutare le signore e stringendo la mano con affetto a qualcuno che era andato a porgergli i suoi omaggi, gli era sembrato solo un uomo gentile e sorridente. Qualcosa nel suo sguardo gli aveva fatto pensare che nascondesse un’intima preoccupazione di cui però Beesley non riusciva a indovinare il senso. Era salito a bordo come gli altri membri dell’equipaggio alle 6 del mattino. In veste di architetto capo della nave, direttore dell’ufficio progettazione della Harland & Wolff e leader del Gruppo di garanzia, sarebbe stato più che naturale prendersela comoda e delegare ai suoi dipendenti i controlli e le formalità. Invece, per Thomas Andrews svegliarsi all’alba e seguire i lavori da vicino in prima persona era una regola a cui non intendeva sottrarsi. Lo aveva fatto sin da quando era stato varato lo scafo nei cantieri di Belfast il 31 maggio dell’anno prima. Certo, era il nipote del presidente della compagnia, l’augusto Lord Pirrie, ma nessuno poteva dire che per questo fosse stato privilegiato. A differenza di suo fratello John, che era sulla buona strada per diventare, 30 un giorno, Primo ministro d’Irlanda, Thomas amava più il mare e le navi della politica. E a quindici anni, anziché iniziare il college, aveva chiesto di andare a lavorare come operaio nel cantiere dello zio. Era stato accontentato. Per cinque anni fece la vita del manovale, una vita durissima. In cantiere alle 6 del mattino e avanti a lavorare fino alle otto e mezza di sera con una pausa per il pranzo e solo 7 minuti di tempo a disposizione in tutta la giornata per il gabinetto. Stessi orari anche il sabato. E poi c’erano i rischi che si correvano nel cantiere e la mancanza di qualunque tipo di protezione. Aveva visto più di un operaio lasciarci le penne dopo avere messo un piede in fallo ed essere precipitato da una delle gigantesche impalcature o perché era rimasto schiacciato da un pesante sostegno schizzato via durante il varo di un vascello. Ma era stata anche un’esperienza che gli aveva lasciato molto, piena di soddisfazioni e stimoli. Certo, Thomas non aveva mai pensato di fare l’operaio per sempre, aveva ben altre ambizioni, ma quegli anni passati a fissare piastre con la rivettatrice e ad avvitare bulloni furono essenziali per sviluppare e nutrire il suo talento per la progettazione. Così, mentre di giorno lavorava, la sera studiava e alla fine del suo apprendistato poté passare al reparto progettazione, dove ben presto iniziò a rivestire ruoli di responsabilità. A trentadue anni divenne capoprogetto e poi direttore dell’ufficio progettazione. Lord Pirrie finì per considerarlo il suo braccio destro e Thomas sapeva che, presto o tardi, sarebbe toccato a lui prendere in mano le redini della ditta. 31 Qualcuno avrebbe potuto bollare la sua ascesa come frutto di nepotismo, ma chi lavorava alla Harland & Wolff sapeva che non era così. Thomas Andrews riusciva a farsi ben volere da tutti, parlava con chiunque, dall’ultimo degli operai in su, e se c’era da sporcarsi le mani era il primo a farsi avanti. Il Titanic era la prima nave davvero tutta sua. L’aveva disegnata, aveva seguito la sua costruzione passo per passo, spesso lavorando gomito a gomito con gli operai e trascorrendo notti insonni quando qualcosa non funzionava a dovere. Lo zio voleva fossero tre le navi gemelle che avrebbero dovuto tenere alta la bandiera della White Star Line, privilegiando come sempre la comodità alla velocità. Dopo l’Olympic e il Titanic, sarebbe toccato al Gigantic e ancora una volta sarebbe stato compito di Thomas occuparsene. Lui aveva ritenuto quel nome, Gigantic, che all’inizio doveva essere attribuito a quello che sarebbe poi diventato il Titanic, esagerato e improponibile, ma ci sarebbe stato tempo per discuterne. I suoi pensieri, ora, erano tutti per il suo pupillo, il Titanic, e aveva dovuto sudare sette camicie perché tutto fosse pronto e in regola per la partenza. Alla fine, una volta completata, la nave aveva lasciato Belfast ed era stata condotta a Southampton, e Thomas Andrews aveva potuto telegrafare orgoglioso a casa: «Il Titanic è ormai quasi perfetto e credo che domani, quando salperemo, farà onore alla vecchia ditta». Nelle ultime quattro ore, Andrews aveva percorso la nave da cima a fondo, aprendo porte, accendendo interruttori, controllando le caldaie e i rifornimenti in cambusa, girando maniglie e aprendo rubinetti nelle cabine. Lo accompagnava il cosiddetto Gruppo di garanzia, otto 32 tra gli uomini migliori del cantiere che avevano avuto il privilegio di imbarcarsi e compiere la traversata insieme a lui. Il gruppo aveva il compito di annotare ogni possibile modifica e occuparsi di qualsiasi problema tecnico che si fosse manifestato. Niente, con una nave come il Titanic, poteva essere lasciato all’improvvisazione. La più grossa preoccupazione, fino a poche ore prima, aveva riguardato il carbone. Un duro sciopero nazionale si era protratto per sei settimane e si era temuto di dover ritardare la partenza del grande bastimento. Il 6 aprile, finalmente, era stato raggiunto un accordo ma non c’era abbastanza tempo per far giungere dalle miniere fino a Southampton il carbone necessario a nutrire le enormi caldaie del vascello. Così, era stato racimolato tutto il combustibile di cui la White Star poteva disporre nel porto, quello messo da parte per cinque navi appartenenti alla International Mercantile Marine Company e quello avanzato dal rifornimento dell’Olympic, salpato solo una settimana prima. Si trattava di 4.427 tonnellate di carbone che andavano ad aggiungersi alle 1.880 già stipate nei carbonili. Sembravano tante, ma da quando il Titanic era giunto a Southampton, il 3 aprile, se ne erano già andate in fumo 415 solo per far funzionare gli argani di carico e per fornire luce e riscaldamento alla nave. Tutto, dunque, sembrava a posto, ma mentre risaliva verso il ponte della nave per incontrarsi con Ismay e con il capitano Smith, Thomas Andrews non riuscì a scacciare quella sensazione di disagio che da qualche tempo provava. Tutto quel parlare di nave “inaffondabile” lo irritava. Sapeva bene che non esistevano navi del genere e, benché il Titanic fosse stato costruito con i criteri di 33 sicurezza più avanzati, c’era sempre la possibilità che qualcosa andasse storto. Forse, a infastidirlo di più era il pensiero che per lo scafo si era deciso di impiegare un rivestimento singolo, anziché doppio o triplo come era stato per il Cedric o il Baltic, riducendo così lo spessore da cinque o sette e mezzo, a circa due centimetri e mezzo. Certo, con tutti quei compartimenti stagni c’era poco di cui avere paura se anche si fosse prodotta una falla. Eppure, qualcosa continuava a tormentarlo. Quando giunse sul ponte di passeggiata della seconda classe, lasciando il calore dei piani sottocoperta, respirò l’aria fresca del mattino e lo sguardo gli scivolò sulla promenade. Sul pennone di prua sventolava la “Blue Peter”, la bandiera che indicava la partenza imminente. Sull’albero maestro c’era il vessillo della White Star Line e su quello di trinchetto la bandiera a stelle e strisce del paese di destinazione. Sotto gli imponenti fumaioli stazionavano le imbarcazioni di salvataggio. Il Board of Trade richiedeva per le navi con una stazza superiore alle 10.000 tonnellate la presenza di 16 scialuppe. Ed era esattamente quello il numero di barche presenti a bordo, a cui erano state aggiunte per buona norma quattro zattere smontabili. Però la legge risaliva al 1894, quando la nave più grande era il Lucania, di 13.000 tonnellate. Il Titanic era quattro volte tanto e poteva trasportare fino a 3.547 persone: 20 scialuppe non avrebbero mai potuto contenerle tutte. Il predecessore di Andrews, Alexander Carlisle, cognato di Lord Pirrie, aveva suggerito di dotare la nave di 64 lance di salvataggio, o almeno 48, capaci di trasportare fino a 3.120 persone, ma Lord Pirrie si era opposto. A che cosa sarebbero servite tante scialuppe? Se anche nel 34 Titanic si fosse prodotta una falla e per qualche motivo inimmaginabile ci si fosse trovati costretti a evacuare la nave, le barche a disposizione erano più che sufficienti. Avrebbero potuto fare tranquillamente la spola con una o più navi che fossero giunte in soccorso e avrebbero potuto metterci tutto il tempo che fosse stato necessario, perché lo sapevano tutti che il Titanic non sarebbe mai potuto colare a picco. E allora via tutte quelle scialuppe antiestetiche, che avrebbero ingombrato il ponte, ridotto lo spazio per le passeggiate e allarmato inutilmente i passeggeri. La sirena della nave lanciò un fischio potente, come aveva già fatto più volte quella mattina, per segnalare che quel giorno si salpava. L’eco delle vibrazioni disperse i gabbiani e sollevò grida di gioia dal pontile. Là sotto i passeggeri e i loro accompagnatori si stavano ormai raccogliendo a centinaia e presto sarebbe iniziato l’imbarco. Thomas Andrews sospirò. Forse si stava davvero preoccupando per niente, tutto sarebbe senz’altro andato per il meglio. Forse. «Non credo ai miei occhi, eccola là!» esclamò eccitato Eugene Joseph Abbott quando si trovò di fronte la sagoma maestosa del Titanic attraccato in porto. Lo scafo enorme faceva apparire minuscola ogni altra nave all’ancora. Eugene aveva solo tredici anni, ma non era la prima volta che andava per mare. L’agosto dell’anno prima era arrivato in Inghilterra a bordo dell’Olympic. La mamma si era separata dal papà e aveva, perciò, deciso di lasciare il Rhode Island e tornare alla sua St. Albans, nell’Hertfordshire, dove ancora viveva la nonna Sarah ormai vedova, portandosi appresso lui e suo fratello. 35 «Fai bene a non crederci perché sei strabico!» ribatté pronto Rossmore Edward, che di anni ne aveva sedici. «Guarda che ti do un pugno sul naso, sai?» «Vediamo se ne sei capace?» I due fratelli stavano già spintonandosi quando la madre si mise tra di loro. «Ragazzi, smettetela. Lo so che siete eccitati per la partenza, ma cercate di controllarvi.» Sia Ross sia Eugene abbassarono gli occhi. «Scusa mamma» mormorarono in coro. «Ci siamo un po’ lasciati prendere la mano» aggiunse il maggiore. Rhoda Mary Hunt sorrise e accarezzò loro i capelli. «Venite qui» disse stringendoseli al petto. «Siete la cosa più cara che ho. Vi voglio vedere sempre andare d’accordo e volervi bene, ci siamo intesi?» I ragazzi, abbracciati alla mamma, annuirono. Era stato un errore tornare in Inghilterra, Rhoda ormai se ne era resa conto. Eppure, l’anno prima le era sembrata la scelta migliore per i suoi figli. Era stata sposata con Stanton Abbott, il campione dei pesi medi, ma dopo la nascita dei bambini, mentre lei si dedicava a crescerli con tutto l’amore che una madre può avere per i suoi figli, Stanton si era focalizzato solo sulla sua carriera. Gli era andata bene, aveva avuto successo, ma il prezzo da pagare era stato il loro matrimonio. Alla fine, qualcosa si era spezzato tra loro e dopo una difficile separazione avevano divorziato. Rimasta sola, Rhoda aveva pensato che la cosa migliore fosse tornare dove era nata e dove viveva ancora sua madre. Una volta a St. Albans, non era stato difficile trovare lavoro per lei come sarta e per Rossmore come calzolaio. Eugene invece, che era ancora piccolo per lavorare, era 36 stato subito accolto alla Priory Park School. Ma per quanto avessero cercato di adattarsi al Vecchio Mondo, i ragazzi non erano inglesi e soffrivano di nostalgia. Alla fine, stanca di vederli sempre giù di corda, Rhoda aveva annunciato ai figli che avrebbero fatto ritorno in America. Era stata una serata di festeggiamenti e di lacrime per la nonna che tornava a essere sola. Poi, per un momento, Rhoda aveva quasi temuto che il loro piano fosse sul punto di naufragare, dopo che lo sciopero del carbone aveva reso impossibile la partenza. Ma quando le comunicarono che il suo biglietto per la piccola e vecchia nave su cui avrebbero dovuto fare la traversata era stato cambiato con un passaggio sul magnifico Titanic aveva accolto la notizia con sollievo e stupore. Certo, lei e i bambini avrebbero viaggiato in terza classe, ma da quello che aveva sentito dire la terza del Titanic era come la prima di una nave di vecchio tipo. E poi aveva voluto spendere un po’ di più per assicurarsi che dessero loro una cabina particolarmente buona. Era logico che i ragazzi fossero tanto emozionati. Avvicinandosi al pontile, affollatissimo, Rhoda alzò gli occhi verso l’immensa struttura nera ed ebbe quasi l’impressione di trovarsi di fronte a una scogliera che scendeva a picco in mare. Lassù in cima, sulla poppa, scintillava in lettere d’oro la scritta Titanic e, sotto, il nome del porto d’armamento, Liverpool. «Non voglio partire con quella nave!» protestò una donna a due passi da lei. Dal forte accento si sarebbe detta provenire dalla Cornovaglia. Il marito cercava di tranquillizzarla, ma senza troppo successo. «Ti dico di no» insisteva la donna. «È troppo grande!» 37 «Non tema, signora» disse sorridendo un giovane in divisa poco distante. Dalla bandierina con la stella che campeggiava sul cappello e sui bottoni dorati della giubba, Rhoda capì che doveva trattarsi di un membro dell’equipaggio del Titanic. «È robustissima. Nemmeno Dio potrebbe affondare questa nave!» Anche Rhoda aveva provato una sensazione simile a quella della donna arrivando sul molo: si era sentita un microbo in confronto a quel colosso. Anziché intimorirla, però, su di lei tutta quell’imponenza aveva avuto piuttosto l’effetto di rassicurarla. Come aveva detto l’ufficiale, che cosa mai avrebbe potuto rappresentare una minaccia per un gigante simile? Intorno a loro la gente scambiava saluti e abbracci, c’era chi piangeva e chi scoppiava in grasse risate. I bambini più piccoli correvano e i genitori faticavano a tenerli a freno. Qualcuno suonò qualche nota con un banjo e un gruppetto intonò una canzone popolare che Rhoda ricordava vagamente dalla sua gioventù. Uomini e ragazzi si erano arrampicati sui carrelli merci e sulle altre strutture del ponte per gustarsi meglio lo spettacolo. «Questa volta hanno battuto tutti i record!» esclamò un uomo dall’aspetto aristocratico. «Già con l’Olympic credevo avessero raggiunto il culmine» gli rispose un altro gentiluomo in guanti e cappello a cilindro. «Ma da quello che ho sentito il Titanic è qualcosa di ancora più straordinario.» «Sa, io ricordo ancora quando attraversai l’oceano a bordo del New York, allora lo si definì l’ultimo grido in fatto di costruzione navale. E ora la guardi laggiù quella barca, sembra un chiatta a confronto del Titanic!» L’uomo col cilindro scosse la testa. «Non so… La 38 White Star, la Cunard e anche la linea Amburgo-America sono ormai completamente assorbite da una lotta per la supremazia che sembra non avere limiti. Ognuno vuole la nave più lussuosa, la più veloce, ma verrà presto un tempo in cui il risultato di questa folle corsa sarà il più grande e devastante dei disastri marini. Glielo dico io.» Rhoda ebbe un brivido a sentire quelle parole e non volle ascoltare oltre. Prese i bambini per mano e si allontanò di qualche passo. Nell’aria si diffondevano gli odori più disparati, i profumi delicati ed esotici delle signore eleganti in attesa di salire sui ponti della prima classe si mescolavano all’odore di carbone e di sterco di cavallo delle carrozze. Via via che ci si dirigeva verso le passerelle per i passeggeri di terza, a poppa, gli aromi si facevano più forti e penetranti. L’odore di cibo si confondeva con l’olezzo di chi aveva bisogno di farsi un bel bagno. Poco più avanti, il medico di bordo passava in rassegna i passeggeri di terza prima di ammetterli sulla passerella che conduceva a bordo. Le leggi americane sull’immigrazione erano particolarmente severe, Rhoda lo sapeva bene. Quando toccò a lei e ai bambini se la cavarono in fretta. Il medico si limitò a chiedere loro se avessero contratto malattie contagiose, poi, considerato che erano cittadini americani, li lasciò passare senza altre domande. Gli immigrati, provenienti dai paesi mediterranei o dall’aspetto più dimesso, erano invece sottoposti a un esame più scrupoloso. Si controllavano i capelli in cerca di pidocchi o si rovesciavano loro le palpebre per scoprire tracce di tracoma e chi risultava affetto da questa malattia altamente infettiva era rispedito indietro. 39 Finalmente, Rhoda e i bambini si diressero verso la passatoia. C’era molta gente che saliva e da come parlavano quegli sconosciuti le sembrarono in gran parte scandinavi, probabilmente diretti in America in cerca di occasioni. Sopra di loro torreggiava il passaggio coperto che conduceva ai ponti di prima classe. Le parve tristemente simbolico che chi viaggiava in prima accedesse alla nave dalla parte superiore dipinta di bianco, mentre chi viaggiava in terza entrasse dal basso dove la nave era dipinta di nero. Il bianco e il nero, l’alto e il basso, i ricchi e i poveri. Era evidente che anche in pieno oceano quella separazione netta tra le classi che tanto ossessionava i suoi connazionali doveva essere mantenuta a tutti i costi. Quando aveva acquistato i biglietti le era stato consegnato anche un opuscolo in cui si descrivevano le caratteristiche della nave ma si specificava anche che ogni passeggero avrebbe dovuto scrupolosamente restare nei “confini” della propria classe. Sarebbe stato tanto disdicevole per un passeggero di terza varcare la soglia degli ambienti di seconda o di prima, quanto per uno di prima passeggiare sul ponte di seconda o incontrare un passeggero di terza. In certe cose, gli inglesi non sarebbero mai cambiati. Rhoda si girò ancora una volta indietro a guardare la città. Non era nata a Southampton, non la conosceva bene, eppure quella era ancora Inghilterra, la terra su cui era nata. Era praticamente certa che non ci sarebbe mai più tornata. Sua madre era anziana e quando fosse venuta a mancare non ci sarebbe stato più nulla che l’avrebbe legata a quell’isola. La sua vita era a Providence, negli Stati Uniti, accanto a Rossmore e a Eugene. Non sapeva che cosa 40 avrebbe fatto una volta là, ma di amici ne aveva ancora tanti. Qualcosa avrebbe certamente trovato, in fondo l’America era la terra delle opportunità. Poi, levò dalla borsetta il suo biglietto: era il numero CA2673. Venti sterline e cinque scellini, tanto costava cambiare vita. Quel biglietto le avrebbe portato fortuna, se lo sentiva. Mostrò dunque carta d’imbarco e tagliando all’ufficiale di bordo che controllò sul suo elenco. «Ecco qua, signora Abbott e due bambini» confermò l’uomo con un sorriso. «La vostra cabina si trova a poppa e i bagagli per il viaggio vi saranno consegnati non appena avremo salpato l’ancora. In cima alle scale troverete un cameriere che vi indicherà dove andare. Vi auguro un buon viaggio!» Rhoda Mary Abbott, nata Hunt, strinse forte le mani dei suoi ragazzi e con il cuore più leggero salì a bordo del Titanic. «Riferisco qui che la nave è carica e pronta a prendere il mare. Macchine e caldaie sono in perfetto ordine per il viaggio e tutte le carte e i portolani sono aggiornati. Vostro devotissimo Edward John Smith.» Il comandante Smith, o E.J. come lo chiamavano tutti ormai da una vita, firmò il Gran Rapporto del comandante alla compagnia e lo consegnò a Benjamin Steele, sovrintendente della marina a Southampton per la White Star Line. «Congratulazioni capitano» disse Steele. «Sta per portarsi in mare un’autentica bellezza!» Smith annuì soddisfatto, mentre le spire azzurrognole del sigaro che stringeva tra i denti salivano avvolgendogli il bel viso squadrato. Il comandante era un uomo massiccio, spalle larghe e barba bianca tipo generale Grant, 41 il perfetto ritratto del lupo di mare. Nella sua uniforme nera perfettamente stirata e con i galloni dorati sulle maniche emanava sicurezza, autorità e buon umore. Aveva un’innata attitudine al comando ed era benvoluto e popolare tanto tra gli ufficiali quanto tra i marinai. Lo chiamavano il “Capitano dei Milionari” perché era il preferito tra gli aristocratici che attraversavano l’Atlantico. Non era raro per un benestante informarsi in anticipo su chi fosse il capitano e, alla fine, rimandare la partenza pur di fare il viaggio con il comandante Smith. Questo attaccamento che l’alta società gli dimostrava, fruttava al buon capitano un salario che era più del doppio di quello di un comandante della Cunard. Con i suoi sessantadue anni sulle spalle, quarantanove dei quali trascorsi in mare, Smith poteva ben dirsi un marinaio “navigato”. Si diceva che il viaggio sul Titanic sarebbe stato l’ultimo, un modo perfetto per coronare una splendida carriera, ma altri sostenevano che avrebbe continuato ad andare per mare almeno finché il Gigantic, o come si sarebbe chiamata la terza supernave della White Star Line, non fosse stato completato. Era infatti tradizione che Smith, che dal 1904 era diventato comandante di tutta la flotta della White Star, fosse alla guida delle navi della compagnia nei loro viaggi inaugurali. E lui aveva piena fiducia nei colossi che era chiamato a manovrare. Appena sei anni prima, quando era salpato con l’Adriatic, aveva osservato con orgoglio: «Non riesco nemmeno a immaginare un incidente che possa causare l’affondamento di una nave. Non posso concepire un disastro per questo piroscafo. La tecnica di costruzione delle navi oggigiorno ci permette di abbandonare simili preoccupazioni». 42 Quella mattina, mentre il capitano Steele passava in rassegna il personale, Smith aveva osservato il capitano Maurice Clarke, l’ispettore del ministero del commercio, iniziare un controllo accurato della nave. Una nave che era due volte più grande, e dunque due volte più sicura, dell’Adriatic. Ma Clarke, che aveva fama di essere il funzionario più detestato dai marinai inglesi, non era il tipo da trascurare un controllo. Non si lasciava sfuggire nessun dettaglio e non si fidava mai della parola dell’ufficiale incaricato, voleva accertarsi di persona che tutto fosse in regola. Furono così ispezionate tutte le attrezzature di salvataggio, giubbotti, salvagente, razzi di segnalazione, luci intermittenti azzurre e naturalmente le scialuppe. Due di queste, la 11 e la 15 dal lato di tribordo, furono fatte calare in acqua da un gruppo di marinai per verificare che l’argano e la gru che le reggevano funzionassero alla perfezione. Le barche fecero un breve tragitto di una ventina di minuti in mare e poi furono di nuovo issate a bordo. Quando si ritenne soddisfatto, Clarke raggiunse il capitano Steele nella cabina del comandante a poppavia della plancia. Quindi, i due scambiarono con Smith le ultime formalità e i saluti di rito. «Faccia buon viaggio, comandante. E la riporti indietro sana e salva» si accomiatò Steele. Il comandante strinse la mano sia a lui sia a Clarke quindi congedò i suoi ospiti. Con quei saluti si concludeva l’agitazione e il tramestio che avevano regnato sulla nave da quando Smith vi era salito a bordo alle 7.30. C’era stato un rimaneggiamento tra gli ufficiali di grado superiore e non tutti l’avevano presa bene. 43
Scaricare