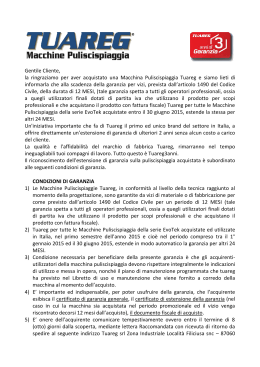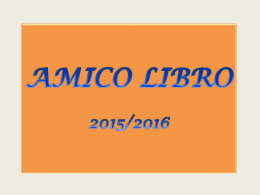numero due invasionecreativa.it erodotozerodue 06 · lo stato che non c’è // Guido Cervetti 18 · battifuoco a bamako // Andrea Semplici // Enrico Minasso 38 · I tuareg non avevano alternativE // Vermondo Brugnatelli e Marco Pinzani 42 · un anno vissuto pericolosamente // Andrea Semplici 44 · nessun gatto a varanasi // Valentina Cabiale 54 · aspettando il maha kumbh mela // Paola Pedrini 56 · al sicuro come in mezzo all’erba // Elena Dacome 70 · ognuno di noi è più di uno // Bruno Tigano 80 · la matita di stalin // Fabio Belafatti 96 · città visibili // Valentina Cabiale 106 · l’uomo che voleva la luna // Mario Dondero e Andrea Semplici 110 · le acciaierie di taranto // Carlo Gubitosa e Sergio Leone Fondatore: Marco Turini. Direttore responsabile: Andrea Semplici Advertising, below the line, marketing non convenzionale, new media. Qualsiasi siano le tue esigenze di comunicazione, Invasione Creativa risponde con un approccio totalmente nuovo rispetto allo stile canonico Redazione: Fabio Belafatti, Valentina Cabiale, Elena Cerretelli, Lorenzo Bernini, Sara Lozzi, Sergio Leone, Yuri Materassi Web designer: Allegra Adani. In copertina foto di Guido Cervetti delle classiche agenzie. Progetto grafico: Invasione Creativa Lasciati conquistare da un nuovo modo di fare comunicazione. © Erodoto108.it Registrata al Tribunale di Firenze Stampa Periodica al n.°5738 il 28/09/2009 Editoriale di Andrea Semplici [4] Erodoto108 è una piccola impresa collettiva. Di poche persone. Dalle idee diverse, dalle storie diverse, dall’anagrafe differente. La diversità, siamo ostinati a crederlo, è ricchezza. Ma questo non sempre è vero. Hanno incertezze, queste persone. E io non voglio nasconderle. Non avere chi ti paga uno stipendio è una schiavitù. È, a volte, anche una libertà. Perché posso scrivere un editoriale come questo. E raccontare una storiella e un desiderio. Forse, una volontà. Erodoto108 nasce dalla cocciutaggine di alcune persone dai buoni studi, lavori precari e una irrequietezza addosso. Il viaggio è metafora potente. Il viaggio emoziona anche ai tempi di Internet. Il viaggio permette di scrivere ogni cosa. Queste persone hanno interesse per la scrittura, la fotografia, i video, il web, la grafica… sono multimediali, insomma. Hanno anche la sventatezza di mischiarsi con chi è fermo in un mondo analogico. È così che è nata, attorno al tavolo di un bar, una rivista. Il viaggio, a volte, offre incontri che spiazzano. Che, se hai testa e cuore puri, mettono in discussione. Tre mesi fa, Erodoto108, il suo primo numero, ha mollato gli ormeg- gi, quasi per forza d’inerzia. Il suo naviglio ci è piaciuto. Ed è piaciuto. Pensavamo che ben pochi avrebbe seguito il suo viaggio e invece, in molti, si sono affacciati per salutare la sua avventura. Ne siamo rimasti sorpresi, compiaciuti. E, in qualche modo, prigionieri. Questo ci ha costretti a pensare (e a fare) un secondo numero. Discussioni infinite. Qualche sana baruffa, scambi di mail, bicchieri di vino e anche qualche tazza di tè per i più tranquilli. Dubbi profondi sui soldi. A volte ruga un pensiero: ‘Ma chi ce lo fa fare’. Fin dove possiamo arrivare? Dove vogliamo arrivare? Alla fine, il nuovo Erodoto108, il secondo numero, è questo che vi presentiamo. È un giramondo. È il viaggio che diventa tale, ma che vorrebbe essere anche altro. E allora ecco scrittrici che ci raccontano dei loro deserti. Archeologhe che rimangono in silenzio di fronte al rogo dei morti a Varanasi e sanno scriverne con emozione. Fotografi capaci di far sentire, perfino nel web, il clangore dei battifuoco di Bamako. Insomma, questo numero ha la confusione del viaggio. Nessuno di questi collabo- ratori potrà essere pagato. Non ne facciamo merito. Solo vorremmo che così non fosse. Benché in un mondo giusto dovrebbero esserci scambi più che soldi. Ma questo non è un mondo giusto. Anche questo vorremmo raccontare. Per due numeri, in fondo, ci siamo riusciti. E adesso? Tocca anche a voi. Il naviglio di Erodoto108 ha bisogno di compagni di viaggio. Che offrano vino e idee. Che ci diano appigli per sopravvivere. Che ci dicano: ma sì, navighiamo. Ci sarà un terzo numero? Ne vorremmo fare uno tematico. Difficile: questa volta vorrebbe dire ‘chiedere dei pezzi’. Non attenderli. Vuol dire domandare a un autore: ‘Puoi scriverci questo? In compenso avrai solo una pacca sulle spalle’. Vorremmo parlare di cibo, nel prossimo numero. O, forse, in quello dopo. Mica siamo così certi di noi. Vorremmo introdurre rubriche. Già accade nel blog. Sulle librerie, sul cibo, sulla musica, sulle archeologie, sull’arte. Perfino sui cimiteri. Purchè ognuno di questi luoghi sia centro di relazioni più che di mercato. Di indulgenza, non di business. Perché è l’uomo che viaggia, perché al centro di tutto c’è l’uomo. Conoscete luoghi come questi? Indicateceli, scrivetene, fotografateli, filmateli, disegnateli. Una mappa del mondo in cui incontrarsi per chi vuole incontrarsi. Anche questa è una ragione del viaggio. Vorremo costruire una vera redazione. Vorremmo avere più pagine, dare continuità al blog, avere sottoscrittori, amici, tifosi. Vorremmo aprire noi stessi luoghi in cui ritrovarci e ritrovarsi. Fate conoscere questa rivista, parlatene fra di voi, venite a trovarci (per lo più abitiamo a Firenze, ma ci spostiamo con infinito piacere se ci date un letto e un buon piatto cucinato da voi). Violate le regole del web e venite a toccarci. Fateci gli auguri. Anzi, no. Brindate a Erodoto108. Almeno ora che state per leggerlo. [5] Lo stato che non c’è Viaggio nel Kurdistan turco, tra guerra di strada, campi profughi e disperazione. Testo e foto di Guido Cervetti l Kurdistan è uno stato mancato. Un’aspirazione, una speranza incastrata tra Iraq, Iran, Turchia, Siria e Armenia. Popolato da un’antichissima etnia di lingua iranica, copre un vasto altopiano nella parte nord dell’antica Mesopotamia. La parte turca è da decenni insanguinata da un conflitto che oppone lo stato alle milizie indipendentiste curde. É una guerra di strada, di montagna e di informazione. Persino il numero esatto di curdi in Turchia varia a seconda di chi lo calcola: venti-venticinque milioni per i curdi, dodici milioni secondo il governo turco. É una guerra culturale: oggi, conoscere il curdo e specialmente le sue manifestazioni letterarie può essere di per sé un reato. Il semplice possesso di libri di grammatica e poesia in curdo sono stati in passato usati come prova penale a carico di attivisti curdi. Questa non è la storia di un viaggio: è una testimonianza, dovuta e necessaria, della tragedia curda. [8] Quella tra i curdi e l’esercito turco è una guerra, non un gioco di poliziotti e “terroristi” come vorrebbe fare credere Ankara. E qui a Yuksekova, una delle roccaforti del PKK, nel Kurdistan orientale, la guerra si vede. L’accoglienza non è delle migliori, e i presagi c’erano tutti. La strada per arrivare è piena di check-point. Blindati dell’esercito turco, soldati, mitra spianati. Per strada, un’enorme chiazza rossa, probabilmente sangue. Dei ragazzini ci scambiano per chissà chi e ci accolgono a sassate. Un’ambulanza corre a portare in ospedale un parlamentare rimasto ferito negli scontri della mattina. Questa non è una guerra tra eserciti. É una guerra tra popoli. Gli occhi che ti guardano dai passamontagna sono prima diffidenti, poi quando capiscono chi sei diventano amichevoli: i curdi, come tutti i popoli vittime di ingiustizie, vogliono che il mondo sappia. É come se gli uomini e i ragazzi coi passamontagna ci abbracciassero con lo sguardo. Ogni paio di occhi è un popolo intero che ti guarda e ti chiede “racconta, fai vedere, [9] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] fai sapere”. Solo finché l’esercito questo. E anche non si ritira e arLa quotidianità delle se i volti copercittà curde è fatta di vita riva l’ora dei balti, sai che quegli li, le danze del nei caffè. occhi sono gioNewruz, il capovani: ragazzi di danno persiano, quattordici, quindici anni. Sembra celebrato dai curdi ma non dai mancare una generazione, quella turchi. Per quanto possa sembradei ventenni e dei trentenni. Mor- re assurdo, è questo il nodo del ti, imprigionati o emigrati nelle contendere degli scontri di oggi. grandi città. Ovviamente i giorni prima del Newroz sono quelli dei rastrellaDentro le case la gente vive come menti: l’esercito turco cerca di meglio può. Fuori, però, ci si pre- arrestare preventivamente quelli para per gli scontri: i bambini che considera i promotori delle erigono barricate. Possono dei proteste e fin dalla mattina i bambambini essere terroristi? Può un bini iniziano a erigere barricate intero popolo esserlo? Nel buio lungo le strade principali, mentre delle case si tira il fiato, si aspet- nella città vecchia dove i blindata, ci si rifugia. Le donne della cit- ti non entrano si organizzano gli tà raccomandano di bussare alle scontri. Qui anche un solo limoloro porte se si mettesse male e ne trovato in tasca durante una avessimo bisogno di protezione. manifestazione comporta anni di Siamo un bene prezioso, da sal- galera. L’età minima per essere vaguardare: siamo quelli che pos- condannato come un adulto è sono raccontare. nove anni. Il bambino che ci guarUn uomo spinge il suo carret- da dalla finestra è un potenziale to, seguito a ruota da un blindato criminale per lo stato turco. turco. Sembra quasi impegnato a fare la sua parte per intralciare il Azadiya welat, (“libertà della panemico. Attorno è guerra. L’aria tria”), è il solo giornale in lingua inizia a farsi pesante: i lacrimoge- curda della Turchia. Pubblica con ni intorbidiscono il cielo, l’odore tiratura di 10.000 copie in un amdella benzina ti entra nel naso. biente tutt’altro che favorevole É quella usata per le molotov. e tenta faticosamente di tenere Gli scontri durano tutto il giorno il prezzo il più basso possibile [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] abbattendo i costi di redazione. Azadiya si occupa di cronaca e politica del Kurdistan, politica internazionale, cultura ed arte. Due volte a settimana pubblica un numero dedicato ai bambini. Non è facile essere un giornalista di Azadiya: la polizia turca sottopone lo staff del giornale a pressioni costanti. Decine di autori sono in carcere con condanne immotivate e sproporzionate. Nel 2010 Vedat Kursum, uno dei redattori del giornale, è stato condannato con la scusa delle leggi antiterrorismo ad una pena detentiva di 166 anni e sei mesi. Molti suoi colleghi vengono fatti sparire nel nulla. Azadiya welat ha 70 giornalisti incarcerati e 25 tra morti e fatti sparire. [ 16 ] In Turchia quasi ogni famiglia curda ha parenti in carcere, morti o partiti per far parte della resistenza sulle montagne. I prigionieri politici sono decine di migliaia e spesso sono incarcerati per condanne assurde, grazie all’uso strumentale delle leggi antiterrorismo. Le case curde abbondano di ritratti. Sono le foto, orgogliosamente mostrare, dei parenti in carcere o uccisi. I sopravvissuti le mostrano elencando il numero di anni di galera che ogni per- sona ritratta si sta facendo, o il modo in cui sono stati ammazzati. Con un numero così alto di uomini uccisi o prigionieri, la guerra si sposta anche sul piano demografico: le famiglie turche diventano numerosissime, fare figli diventa un modo per combattere lo stato turco. La quotidianità delle città curde è fatta di vita nei caffè, stanze sature di fumo denso che nasconde il cartello “vietato fumare”. I disoccupati curdi, tantissimi in questa terra di disperata mancanza di opportunità, affollano i caffè dove ammazzano il tempo fumando, giocando a carte o bevendo tè di contrabbando. Sono, questi, luoghi dove le donne non sono benvenute (o forse non vorrebbero neppure metterci piede). Gli anziani ci passano il tempo a parlare della loro vita a chi passa di qui. Intere esistenze raccontata dai segni profondi delle mani. Siamo in viaggio verso Van. Qui, alle 13.41 del 23 ottobre 2011, un violento terremoto squarciò la regione uccidendo 604 persone e ferendone 4.152. Le forti nevicate rendono ancora più dissestate le strade devastate dal sisma. Cinque mesi dopo il terremoto, poco sembra essere cambiato. Van, 300.000 abitanti, è uno dei cuori economici del Kurdistan. Ad oggi, è stracolmo di container dove vive parte della popolazione. Questi “villaggi” sono sottoposti a controlli strettissimi per decidere chi può entrare e chi no. Il governo non vuole che gli sfollati parlino della loro situazione. Il filo spinato che circonda tutti i villaggi-container rende l’immagine ancora più angosciante: campi ricoperti di neve e fango, vestiti appesi al filo spinato, squallore. A pochi mesi dal sisma, i palazzi restano decadenti. Tetti scoperchiati, case abbandonate. Ovunque, campi profughi. Tende dell’ONU, tende improvvisate, di ogni tipo, dappertutto. La sensazione è che non ci sia la volontà di ricostruire. La Turchia ha inizialmente rifiutato ogni aiuto offertole da altri stati, salvo poi fare marcia indietro rendendosi conto delle gravi inadempienze nei giorni immediatamente seguenti al sisma. Parlando con la gente, sembra che l’intenzione di Ankara sia proprio quella di non ricostruire per obbligare i curdi ad emigrare nelle città turche e lasciarsi assimilare. Perdere sé stessi, dopo avere perso le proprie case. Più che un campo per terremotati, quello di Van ricorda un campo di segregazione. Sono gli sguardi della gente a dirlo. E quando si chiede perché gli sfollati vivono recintati dentro al filo spinato, si rimane basiti a sentirsi dire che “è per la loro sicurezza, per evitare che gli estranei possano entrare”. [ 17 ] Guido Cervetti 33 anni è un fotogrtafo freelance, ha studiato fotografia all’istituto Marangoni di Firenze, specializzandosi in zone di conflitto all’istituto IEFC di Barcelona e in fotogiornalismo con un workshop presso l’agenzia Contrasto a Roma. Racconta principalmente di scontri sociali e zone di conflitto. Testo di Andrea Semplici Foto di Enrico Minasso evo cancellare ogni lettura. Ogni cosa che penso di sapere. Questo non è il luogo adatto, nessuna parola è capace di far immaginare o di raccontare un mercato africano. Se solo potessi, vorrei essere invisibile: accucciarmi in un angolo, sotto una bancarella, fra le donne dalle grandi veste e non essere visto. Vorrei avere il privilegio di guardare l’umanità in movimento, di ammirare lo spettacolo di uomini e donne che recitano su un palcoscenico di terra rossa e di polvere volante pronta a diventare fango alla prima pioggia. Qui, a Bamako, capitale del Mali, grande città di commerci, vorrei poter guardare, da dietro lo spiraglio di un sipario, un mondo che, ogni giorno, ci prova a vivere. Che se debrouille, che ‘se la sbroglia’ direbbe il ragazzo dai muscoli come nodi d’ebano che mi passa davanti lanciandomi addosso uno sguardo d’orgoglio e di fatica. [ 20 ] Ha in testa un carico di frammenti di auto. Pezzi portiera, mezzo parafango in bilico incerto, qualche coprimozzo di camion. Non so come faccia a trasportare quella discarica di ferro in equilibrio sulla testa. Il sudore annega il suo viso, gli occhi sono più tesi dei suoi muscoli. Il passo è svelto, come quello di un felino della savana nella tensione della caccia. Niente di così nobile, in realtà: il ragazzo sarà uno dei galoppini di un mercante di rottami e avrà appena finito il giro di meccanici che rivendono i resti di macchine accartocciate. Ma viene comunque voglia di seguirlo. Per vedere dove sta andando, dove è diretto. Per conoscere chi si comprerà quel metallo contorto. Mi muovo dal mio inutile nascondiglio anche perché la speranza di non essere visto è davvero vana. La mia pelle bianca è come un [ 22 ] semaforo acceso nella notte, ogni sguardo di chi scorre per questo vicolo polveroso è rivolto verso di me. Inevitabile: sono venuto nel brulichio incomprensibile del mercato Medina, nord estremo della capitale del Mali, solo perché sulla Lonely Planet avevo letto che pochi turisti si spingono fino sotto questa collina di terra riarsa. Diceva la guida: ‘Il mercato è usato dagli abitanti locali’. Una buona ragione per essere qui. Il più grande dei geografi italiani, Eugenio Turri, ha scritto: ‘Il mercato è bello, è la vita, è lo spettacolo delle ragazze, delle cose che si amano, in un’atmosfera di spensieratezza’. Abbiamo davvero occhi bianchi sull’Africa: il mercato di Bamako è un caos, un ingorgo di persone, di polli che volano sulle teste delle donne, di macchina da cucire che sibilano in continuazione, di contrattazioni che sono recite grandiose per chi ha tempo di fermarsi ad ascoltarle. Il mercato di Bamako contraddice chi sostiene che l’Africa sia lentezza: qui si va di fretta, le donne hanno passi veloci, gli uomini sembrano marionette mosse dalla frenesia di un burattinaio che vuole finire il prima possibile il proprio lavoro. Perfino i bambini slittano sotto le gambe [ 23 ] dei passanti come se sapessero benissimo dove andare. Posso dire che Bamako è una lentezza veloce? Inseguire il ragazzo dei rottami in testa non è stato facile: lui sembrava dribblare, con l’abilità di un motociclista ubriaco, ogni ostacolo. Il suo parafango non ha urtato nessuno, non si è infilato nella nuca di nessuna donna, non ha Periferia della sgangherato nesperiferia, quartiere suna bancarella. Come se il ragazzo di un quartiere seguisse, scarti impiù grande. provvisi compresi, una sua pista preferenziale, una corsia che lo lascia immune dai disastri che ciascuno di noi avrebbe provocato. Mulinelli di polvere rossa si alzano negli spiazzi liberi di gente: quando la folla si dirada il vento solleva questi tornadi in miniatura e li manda a sbattere contro muri sbrecciati o torrentelli di fogne imputridite. Oppure, dopo averli fatti volare [ 24 ] come giostre, li fa afflosciare dopo pochi metri di ebbrezza. Mi hanno sempre raccontato che questi spiritelli di sabbia e cartacce sono le anime degli antenati che si ostinano a volere vivere come se non fossero mai morti. Non danno fastidio, non chiedono nulla. Semplicemente vogliono che non sia- no dimenticati e anche loro, nelle ore del mercato, cercano di dare un’occhiata a mercanzie che non potranno comprare. Ma lo spiazzo percorso dagli spiritelli di sabbia è come un confine che io non riesco ad avvertire. Ho alle spalle una piccola corte di bambini e di venditori ambulanti e mi accorgo che le loro insistenze diventano meno pressanti, meno urgenti. Alcuni appaiono indecisi. Rallentano. Si controllano l’un con l’altro. Un bambino mi molla la mano che fino ad allora aveva stretto con forza e fa un’improvvisa retromarcia. L’ultimo dei venditori, un nero altissimo che offriva bibite colorate in sacchetti di plastica, ha un gesto di saluto: il gioco della contrattazione è finito e se ne torna indietro. Anch’io ho un momento di incertezza, non capisco la loro indecisione. Una nuvola corre veloce sopra la collina di Kolu, periferia di Bamako. Stanno cambiando anche le grida degli ambulanti, si azzittisce perfino il cicaleccio delle matrone sedute a vendere pesce del Niger essiccato. Mutano gli odori: diventa rarefatta e lontana l’aria che sa di frutta matura e cuoio appena bagnato che ti ha inseguito per i vicoli del mercato. Ora il vento porta con sè un sottofondo di brace e pelle bruciata. Se tu fossi [ 25 ] dalle parti dell’Etna, diresti che è un odore di lava che scorre e arrostisce gli alberelli che incontra nel suo cammino. E poi i rumori: niente più il brulichio delle chiacchiere e dei passi rapidi di uomini e donne, ma è come se qualcuno si sia messo a suonare rozzi tamburi di metallo, a percuotere gong artigianali di ottone scadente per avvertirti che stai per entrare in un mondo a parte. Sei ancora in tempo a voltare le spalle e ad andartene altrove. [ 26 ] Periferia della periferia, quartiere di un quartiere più grande, mercato dentro il mercato. Ma messo ai margini, lontano, quasi ignorato. Il ragazzo dei rottami ha trovato altri fratelli: qui si incontrano decine di altri uomini vigorosi che trasportano metalli e scarti ferrosi come se fossero gioielli preziosi. Tutti, a passo di marcia, stanno varcando la frontiera del ferro e del fuoco, stanno entrando fra le baracche dei fabbri, dei forgerons, dei ma- nipolatori delle fiamme. Anche noi stiamo entrando nel cuore fragoroso della siderurgia africana. Il ragazzo dei rottami si scarica dalla testa parafanghi e lastre metalliche. Non è un gesto disattento o stanco. In realtà ha già compiuto una selezione del suo carico. Ai nostri occhi l’antro in cui ha depositato il parafango è un ammasso di ferraglie arrugginite. Ma ogni collina ferrosa ha un suo significato. Ci sono i vecchi che, con gli occhi, osservano il lavoro dei ragazzi. Non dicono una parola, ma organizzano i mucchi di ferro. Queste non sono miniere, qui non vi è bisogno dello stregone che indica dove scavare, ma bisogna pur saper scegliere il pezzo di metallo per poter ottenere l’utensile che vogliamo plasmare. Anche questa è una maestria: non è da tutti trasformare un parafango in un colapasta, in decine di colapasta. Qual è il ferro migliore per farlo? Questa è un’industria e [ 27 ] [ 28 ] non c’è tempo da perdere: la prima sgargianti. Le donne sono poche: separazione dei metalli aiuta i fab- venditrici di mais o di zuppe che bri a compiere la scelta più giusta sfamano le legioni dei fabbri. Loro senza perdere tempo. Il ragazzo indossano abiti slabbrati, maglietincassa pochi spiccioli di Cefa per te strappate e lerce della fatica di il suo lavoro e riparte mille giorni, i pantaalla caccia dei rottaloni che sono una Tutti, a passo mi di Bamako. Ogni sola macchia bruna. di marcia, dialogo,ogni trattaI ragazzi dei mantici stanno varcando tiva qui è silenziosa sono a torso nudo. perché le labbra si la frontiera del aprirebbero inutilForgerons o maeferro e del fuoco. mente: il fragore dei stri del fuoco. Non martelli sugli incuoccorre saperne di dini, degli sfrigolii dell’acqua sul Africa o di lontano passato per fuoco, dei mazzuoli lucidi come il comprendere che i fabbri sono una marmo che picchiano sui metalli da casta. A volte maledetta:perché plasmare è più forte dello sferra- ha che fare con la magia e la fuglio di un treno in corsa o del de- ria del fuoco. A volte benedetta: collo di un boeing con i motori im- chi prepara le vanghe, le zappe, gli ballati. Le mani straniere si toccano utensili per la cucina? Chi forgia le le orecchie per capire se qualcosa spade? Casta sottomessa o casta non funziona. Qui bisogna urlare orgogliosa? In Mali raccontano che per farci sentire. Ma il fracasso non il primo uomo inviato dagli dei sulla è un rumore indistinto: il coro dei Terra sia stato un fabbro, un uomomartelli ha un suo ritmo, ci vorreb- artigiano, coraggioso al punto da be un musicista per esserne certi, poter controllare il fuoco e trasforma qui, a Medina, è come se un’or- mare la materia. Capace di estrarre chestra diffusa stesse suonando il ferro dalla roccia e di fabbricare una sinfonia atonale, una musica gli attrezzi necessari a lavorare la colta che solo i forgerons di Ba- terra. Nei miti africani sulle origini, mako conoscono. Fra le fucine e i il fabbro compare quasi sempre fra forni della Medina scompaiono an- i capostipiti di un popolo. La sua che i colori dell’Africa. Niente rossi figura sociale è unica nelle tradizioo gialli. Perfino il cielo, velato dal ni di un continente: i forgerons non fumo, è meno azzurro. Niente abiti lavorano la terra, non chinano la [ 29 ] [ 30 ] schiena nei campi, sono i guardiani del fuoco, una casta specializzata. Le mogli dei fabbri, spesso, sono le mammane delle escissioni delle ragazzine. I contadini provvedono al cibo per la famiglia del fabbro: sanno bene che gli attrezzi per coltivare la terra dipendono dall’abilità di quell’artigiano capace di cambiare la materia. Spesso, nelle savane del Mali, il primo atto di nascita di un villaggio è proprio la costruzione della forgia e della casa del fabbro. Eppure i forgeron sono guardati con timore, come eredi di poteri sovrannaturali, come stregoni troppo potenti. Ma anche esiliati, quasi diseredati, sicuramente malvisti: i loro quartieri sono ai margini dei villaggi e dei mercati. Una ragazza peul, in Mali, non potrà mai sposare un fabbro senza infrangere severi tabù familiari. Destino triste per il figlio di un fabbro: avete mai visto come sono belle le donne peul? Artigiano o stregone, dunque. Manipolatore del ferro o anche di forze sovrannaturali? Mi guardo attorno nel caos di Medina, siedo accanto a un uomo che picchia con forza su una piccolissima verga di metallo, vedo un ragazzo che, come un forsennato, agita un mantice di pelle di capra. I carboni si ravvivavano fino a diventare incandescenti. Il fabbro fa scivolare il pezzo di ferro sulle braci ardenti. È la ‘carburazione’ del metallo: bisogna pur donare al ferro quelle qualità (durata, elasticità, resistenza alle torsioni, agli attriti, ai colpi e alla corrisioni) che renderanno perfetto un utensile. È davvero uno stregone questo uomo dagli occhi intrisi di polvere di ferro e dal sudore che cola per ogni rivolo della sua fronte? Strano e ambiguo destino, quello dei fabbri: il dubbio che questi uomini (mai visto donne lavorare con il fuoco e il ferro) fossero dei maghi (a volte benigni, ma, a volte, anche maligni) ha sempre perseguitato i forgeron. Non solo in Africa Occidentale, ma quasi ovunque nel mondo. E nell’antichità: le tecniche di ‘riduzione del minerale’ (era ed è impossibile raggiungere, con i mantici la temperature di fusione del ferro a 1536 gradi) erano le sole impiegate almeno fino al XV° secolo. Chi era capace di strappare alle viscere della terra un metallo grezzo e impuro e, utilizzando il fuoco, riusciva a trasformarlo, finiva per essere sospettato di complicità con forze al di là dell’umano. Ferro e fuoco, due elementi che esprimono forza. In molti villaggi del Sahel se un fulmine colpisce un uomo, si manda a chiamare il fabbro, prima del guaritore. Solo lui, custode dei segreti di ogni energia, può salvare il malcapitato. [ 31 ] [ 32 ] Quanti di questi ragazzi che smartellano nel quartiere di Medina conoscono l’antropologia dei fabbri? Quanti conoscono il loro potere o la loro fama rurale? I ragazzini che pompano nei mantici sanno di essere gli assistenti di mille stregoni? L’Africa dei villaggi si è spostata in città. In cerca di lavoro. E i mestieri, anche nella baraondica Bamako, cambiano. Come cambia la vita degli africani. Anni fa a Mopti, altra città sfolgorante del Mali, mi sono trovato nel triangolo di un mercato fluviale dove l’attività dei fabbri è davvero specializzata: trasformano lattine per piselli o molle arrugginite in lunghissimi chiodi con i quali saldare le chiglie delle imbarcazioni del fiume Niger. Anche qui l’assistente del fabbro era un bambino sudato che si affannava attorno a un mantice costruito con pelle di capra. Era un lavoro di muscoli pompare aria sui carboni ardenti. La temperatura del fuoco, affinché il ferro dolce diventi malleabile, non deve mai scendere sotto gli 800 gradi. Provate a mantenere, per ore e ore, ritmo e forza nelle braccia mentre fate funzionare un mantice. Sono tornato in quel posto. Erano passati anni. Non potrei giurarlo, ma il bambino era diventato fabbro, aveva tagli ovunque e una pesante cicatrice su una guancia. Non mi rivolse un solo sguardo: era troppo attento al suo lavoro. Nel suo gabbiotto in riva al Niger era al lavoro un altro ragazzino. Non spremeva la sua adolescenza attorno a un mantice, ma pedalava una bicicletta tenuta fissa da due tiranti: energia dei piedi per azionare una grande ventola. Una fatica minore, una ‘modernità’. Sono ‘moderni’ anche i fabbri di Bamako? Il rumore si infittisce, dal caos delle fucine vedo uscire paioli, pentole, coltelli, lastre, forchette. Vedo depositi di manufatti aumentare fino a diventare magazzini imponenti di oggetti di ogni tipi. Qui alla Medina si vive già in una dimensione ‘industriale’ degli utensili. Queste sono officine professionalizzate. Mi dicono che una buona parte della produzione di questa fabbrica diffusa è destinata al ‘mercato internazionale’: la rivedremo sui treni per il Senegal o sulle grandi barche per Timbuctu, vedremo contrabbandi di zuppiere verso il Burkina-Faso o il Ghana. Mi chiedo di nuovo: ‘Cosa lega i fabbri della Medina ai racconti e ai saggi di antropologia sui forgerons delle Afriche occidentali?’. A volte, nella notte dei villaggi della savana, risuonano i colpi dei martelli [ 33 ] [ 34 ] sull’incudine. Noi stranieri ci sve- Cerchiamo, vogliamo souvenir, giogliamo con addosso qualche timo- ielli in metallo (che l’abile venditore re. Ci rassicurano: del negozio in alberi fabbri lavorano con go ci spaccia per Qui il mondo il buio più completo, argento), pendagli, è in bianco e nero. piccoli soprammobili. temono che qualcuno possa carpire i Il fabbro-stregone lo loro segreti. Mi guarsa e allora gioca con do di nuovo attorno: le tettoie del la sua tradizione, chiede consigli, quartiere dei fabbri fanno filtrare guarda, osserva, va per tentativi: pulviscoli di luce. Qui il mondo è in reinvesta il suo mestiere e rifornisce, bianco e nero: il sole è accecante con bravura, la bancarella per turisti quando può rimbalzare sulla polvere; che staziona sulle sponde del Niger, il nero, al riparo di un tetto di lamie- passaggio obbligato des blancs. ra, è oscurità totale fino a quando gli occhi non si abituano all’ombra. Le È lunga la strada per tornare verso fornaci sono lampi di fiamme in cui l’albergo. Mezza Bamako da attrai fabbri sorreggono, con pinze lun- versare. A sera è tempo di muoverghissime, pezzi di metallo. Il lavoro si. I fabbri sembrano non conoscere dei fabbri è fatica, occhi arrossati tempo. La produzione non si ferdal fumo e pelle lucente di sudore. ma. Arrivano i mercanti, i trasportaC’è il cuore dell’Africa, qui. Non il tori, le donne con nuovo cibo per la suo mistero. C’è il lavoro immenso notte. Mi servirà a casa questo rodi un continente che ci prova, ogni maiolo di stagno che mi sono comgiorno, a sopravvivere, qui alla Me- prato per due centesimi di euro? dina di Bamako. Non ci sono segreti Incontro lo stesso ragazzo che mi insvelabili. Le città africane hanno aveva, inconsapevolmente,guidato bisogno di oggetti in ferro: ringhie- verso il cuore nascosto della Mere, manufatti per l’edilizia, cancelli, dina. Questa volta ha una cassa di supporti metallici, serrature, cardini. molle sulla testa. Spero che anche Il fabbro, erede di un passato vena- la sua giornata sia a fine. Spero to di esoterismo, si piega ai nuovi che per i fabbri vi sia riposo dopo bisogni. Il fuoco non è più un sim- un giorno accanto alla forgia. Arribolo, ma uno strumento di un me- vo all’albergo, terra di bianchi e di stiere durissimo. Ci siamo anche noi stranieri. L’Africa cala nuovamente il in questo mercato: bianchi e turisti. suo sipario su un mondo che ci ha [ 35 ] lasciato intravedere. Nostalgia immediata, ma negata. Africa invisibile per chi passa in fretta per Bamako. Nella sala da pranzo dell’albergo la guida (bianca) di un gruppo di turisti parla, con passione, dei fabbri africani e della loro magia. Ha letto bene i libri, sa cosa sta dicendo. I turisti fanno finta di seguire il racconto. Alla fine appare il mercante del negozio all’ingresso dell’hotel: offre i suoi oggetti in ferro. Rivedo i ragazzi che fanno andare i mantici. Fermo, come nello scatto di una fo- tografia, il gesto dell’uomo che solleva il martello. E allora appoggio, senza una parola e senza sapere perchè, il romaiolo di stagno fra le statuette del negoziante. Se davvero volete lanciare uno sguardo sull’Africa, andate sotto la collina di Kolu, oltre l’ippodromo di Bamako, a Nord del centro della città. Fatevi guidare dai rumori e dall’aria infuocata. Varcate il confine fra i mercati: l’Africa, a volte, è generosa per chi ha occhi per guardare. Andrea Semplici. Dancalia. [ 36 ] Enrico Minasso, classe 1961. È un professionista che si occupa principalmente di fotografia pubblicitaria, architettura, ritratto, cerimonia e reportage industriale e antropologico. Costantemente impegnato nella ricerca attraverso l’utilizzo meno convenzionale dei materiali fotografici tra cui la tecnica del foro stenopeico. Tra le sue pubblicazioni vanno ricordati i libri fotografici “Luoghi d’ombra”, “Le fucine di Bamako”, “La valle di Sella”, “Le meraviglie in scatola”. enricominasso.it Andrea Semplici. Giornalista e fotografo (che smarrisce quasi ogni foto che scatta). I suoi ultimi libri sono ‘Gli anfibi slacciati di Ernesto Guevara’ e ‘L’isola lontana dal mare’. Infine: ‘Dancalia, camminando sul fondo di un mare scomparso’. Tutti e tre editi da Terre di Mezzo. Camminando sul fondo di un mare scomparso. (Terre di Mezzo) I tuareg non avevano alternative Colloquio con Vermondo Brugnatelli A cura di Marco Pinzani // Associazione Transafrica Foto di Andrea Semplici Vermondo Brugnatelli è uno dei più attenti studiosi del mondo berbero. La guerra in Mali, l’attacco dell’esercito francese alle bande islamiste nel Nord del Mali, lacerano la sua anima. Da anni, Brugnatelli cerca di far conoscere in Italia e in Europa la storia del popolo tuareg. Hanno sbagliato i tuareg a lanciare l’offensiva del gennaio 2012? Con il senno di poi, alcuni sostengono che quel sollevamento armato sia stato un errore. Non è così. Non avevano alcuna alternativa. La situazione nel Nord del paese stava disgregandosi, non poteva che peggiorare. I tuareg, un anno fa, hanno solo inciso un bubbone che già stava marcendo. Hanno cercato in tutti i modi un dialogo con Bamako, con il governo del Mali. Avevano più volte avvertito della presenza di bande islamiste che stavano insediandosi nei loro territori. Volevano aiuto per farle sloggiare. E invece Bamako ha risposto con il silenzio, con la complicità con i narcotrafficanti e peggio con arresti di esponenti dei movimenti tuareg. No, lo scorso anno non vi erano alternative. [ 40 ] Come è stata possibile la disattenzione della comunità internazionale di fronte al pericolo islamista? ‘Non è certo la prima volta che la comunità internazionale è sorda e cieca. Il colonialismo non è finito con la stagione delle indipendenze africane. Ci siamo illusi che bastasse creare a tavolino degli stati per garantire la stabilità dell’Africa. Quei confini statuali erano e sono ingiusti. E gran parte dei governi africani sono stati oppressivi, tribali, in mano a gruppi militari. Il malessere del Mali è cominciato subito dopo la sua indipendenza. I tuareg avrebbero accettato perfino di rimanere sotto la Francia pur di non essere governati da Bamako. Hanno subito mezzo secolo di angherie e sofferenze. Vi erano alternative all’intervento francese? No, credo che anche Parigi, al punto in cui erano arrivate le cose, non avesse altra alternativa che l’intervento militare. Gli islamisti stavano marciando verso Sud, avevano varcato le frontiere dell’Azawad. Loro non erano interessati alla causa tuareg. Volevano imporre la sharia a tutto il paese. Volevano creare uno stato islamista. L’esercito maliano non sarebbe riuscito a fermarli. Ma la Francia ha una colpa: non ha tenuto conto che i loro migliori alleati avrebbero potuto essere proprio i tuareg. Conoscono il loro deserto e vogliono solo cacciare dal loro paese narcotrafficanti e fanatici religiosi. Non si poteva ignorarli. Cosa accadrà ora? Cosa accadrà nei prossimi mesi’ Se vi fosse la saggezza di integrare le forze tuareg nelle truppe, francesi e africane, che combattono gli islamisti, io credo che potrebbe essere possibile liberare i deserti dell’Azawad dagli islamisti. Rimane, però, il pasticcio iniziale: i confini del Mali non hanno senso, basta guardarli, dovrebbero avere il coraggio di sfatare il tabù dell’intoccabilità delle frontiere coloniali e della integrità statale del Mali. Bisogna riconoscere diritti ai tuareg a un proprio territorio. Senza una partecipa- zione dei tuareg a questa sfida contro l’islamismo, non vi sono molte speranze. I giovani tuareg sono ostili al fanatismo religioso, ma vedono la Francia come expotenza coloniale e certamente non vorrebbero eserciti stranieri nei loro territori. Se non verrà riconosciuto un ruolo ai tuareg si va dritti verso una situazione afghana: forze straniere in una terra ostile. Questo è un conflitto che rischia di incancrenirsi. Ed è un dramma, il Mali e i deserti del Nord sono un paese splendido. Rischiano di diventare il santuario di un’altra guerra infinita. [ 41 ] Vermondo Brugnatelli, 60 anni, milanese è linguista all’università di Milano-Bicocca. Direttore del Centro Studi Camito-Semitici e presidente dell’Associazione Culturale Berbera. Si occupa soprattutto di lingua e letteratura berbera. Il suo ultimo libro è un diario saggio sulla rivoluzione libica: “Libia Inedita” (ed. L’asino d’oro). Marco Pinzani vive e lavora a Firenze. Tanti viaggi in Africa Occidentale. Tra i fondatori dell’Associazione di volontariato Transafrica che da oltre vent’anni realizza attività di sostegno per le popolazioni del nord del Mali. un anno vissuto pericolosamente di Andrea Semplici I confini coloniali del Mali sono assurdi. La sua geografia politica assomiglia a una clessidra rovesciata. Nel 1960, anno dell’indipendenza maliana, si sono voluto tenere assieme i tuareg del Nord con i popoli neri del Sud. Per oltre mezzo secolo i tuareg sono stati perseguitati, è stata negata la loro identità, sono stati condannati alla miseria. Per quattro volte, fra il 1962 e il 2006, hanno imbracciato le armi in una disperata ribellione. Un anno fa, è cominciata l’ultima battaglia. Per i tuareg, i territori del Nord del Mali sono l’Azawad. In lingua tamasheq, azawagh significa ‘regione di pascoli’ [ 42 ] Gennaio 2012. Scoppia la quinta rivolta tuareg in mezzo secolo. Nel Nord del Mali arrivano le armi degli arsenali libici. I tuareg colgono l’occasione di riaccendere la ribellione del deserto. L’esercito maliano abbandona il Sahara. Marzo 2012. Colpo di stato a Bamako. Estromesso il premier Amadou Toumani Traorè. È un giovane capitano, Amadou Sanogo, ad assumere il potere in Mali. L’esercito è allo sbando. Aprile 2012. Offensiva tuareg al Nord del paese. Il Movimento di Liberazione dell’Azawad (Mnla) e gruppi islamisti conquistano le tre città del deserto, Timbuctu, Gao e Kidal. L’Mnla dichiara l’indipendenza dell’Azawad. Giugno 2012. Guerra civile nel deserto. Gli islamisti (i gruppi al Qaeda, Mujao, Ansar Dine) si sbarazzano dei tuareg‘laici’ e impongono, con la violenza, la sharia nell’Azawad. Dicembre 2012. Dimissioni del primo ministro maliano. Risoluzione dell’Onu che autorizza un intervento armato in Azawad per fermare il terrorismo. 7 gennaio 2013. Interrotti i negoziati fra Unione Africana, Mali e islamisti. Offensiva di al- Qaeda e Ansar Dine verso il Sud del paese. 10 gennaio 2013. Aerei francesi attaccano i gruppi islamisti. La Francia lancia il contrattacco per la riconquista del Nord del Mali. È l’operation Sérval. In due settimane, i soldati francesi e lo sgangherato esercito maliano riprendono Timbuctu, Gao e Kidal. I giornalisti sono tenuti lontani dal fronte. Gli abitanti delle tre città accolgono festosamente i soldati di Parigi. Vendette dei soldati maliani verso i tuareg. Gli islamisti si rifugiano ai confini fra Mali e Niger. Molti risalgono fino in Libia. [ 43 ] Nessun gatto a Varanasi Testo e foto di Valentina Cabiale ei pressi del Mansarowar ghat un uomo mi si è avvicinato e ha fatto con me un pezzo di strada. Con i capelli quasi tutti grigi e ricci, una camicia bianca e un borsello di pelle, camminava con passetti rapidi nella notte, più avanti di me di qualche passo, senza guardarmi, ponendo ogni tanto qualche domanda. Gli ho mentito, dicendo che avevo un fidanzato in Italia; volevo scrollarmi di dosso un possibile corteggiatore. Ma mi sbagliavo. Mi ha detto: non sposarti mai, si sposano già tanti in India. Poi, sui gradini davanti al palazzo rosso dove nel 1781 il raja Chait Singh fu arrestato dagli inglesi, si è seduto a guardare il fiume, la striscia nera orizzontale e vuota sull’altra sponda. I ghat, le alte gradinate che precipitano nella Ganga (in hindi il Gange è femminile), sono di una bellezza devastante, irreale, ricoperti da uno strato di polvere che tutto uniforma; come se fossero lì da sempre, non costruiti da qualcuno ma esistenti sin da quando qualcosa esiste. [ 46 ] Cammini e ti viene voglia di non porti più nessuna domanda, di andare avanti continuando a inciampare nei fili degli aquiloni, la mente diventata inutilizzabile (potessimo pensare con i piedi, con una mano). Vista da una barca sul Gange, la passeggiata sui ghat è una linea orizzontale, linee verticali quelle delle gradinate che discendono al fiume e dei palazzi che si innalzano, un linguaggio non casuale, un lungo mantra che si snoda lungo l’acqua. L’alfabeto hindi ricorda la disposizione dei grappoli sui filari delle vigne. Oppure: una linea orizzontale, in alto, dalla quale discende a cascata tutto il possibile e immaginabile, la confusione, il groviglio sistemato in verticale, appeso come un filo a piombo incerto su dove sia la gravità. Poi vedi l’immondizia lungo le strade, la gente che a bordo strada vive, si lava, mangia, vende, gioca; [ 47 ] il traffico spropositato e spericolato, i clacson che non danno tregua. C’è chi si ferma qua, e non metterà mai più piede in India o lo farà soltanto per trovare conferma di vivere una vita migliore. Ma con un po’ di pazienza tutto può essere ribaltato, la sporcizia è insignificante, la povertà quasi indecifrabile: se, per magia o consapevolezza, i parametri culturali e sociali attraverso i quali filtriamo ogni cosa si dissolvono, il discrimine tra ricco e povero, tra triste e felice, bello e brutto, si sposterà, scapperà via. Non saprai più dov’è e imparerai a buttare una buccia di banana per terra senza sentirti in colpa. [ 48 ] Non so perché si pensa che si vada in India a fare un viaggio “spirituale”. Quello che lì si vede è disperatamente materiale. Forse solo un’esistenza spaventosamente nuda costringe, chi non fugge né impazzisce né si adatta, a fare un salto, entrare in una materia non conosciuta. Ho immaginato, camminando lungo la Ganga, che soltanto l’aderenza alla materia, alla terra, all’asfalto e, nello stesso tempo, una suprema indifferenza alla realtà, possano essere una via per l’autenticità: spirituale è la carcassa di vacca che galleggia tonda e rilevata sulla superficie dell’acqua, è l’immondizia a bordo strada dove scavano i cani, sono i rivoli delle fogne, le scim- mie che mangiano le corone di fiori arancioni offerte nei templi. Tutto il resto (fumare a gambe incrociate sui gradini, entrare in un ashram con abito appositamente confezionato e testa rasata) rischia di esaurirsi in pura esteriorità - gusci vuoti sulle gradinate, i sadhu allineati come soprammobili. Le condizioni di vita terribili o essenziali (dipende dai punti di vista) attenuano Nessuno vuole il distacco e le diffevivere sull’altra riva renze tra vita e morte. La vita ha un aspetto dove, secondo molto più crudo della la tradizione, chi non-vita, non è, come muore rinascerà da noi, pulita e lucidata come una stazione scimmia. della metropolitana. Morire a Varanasi significa morire davanti a tutti. Le pire funebri del Manikarnika ghat sono accese giorno e notte, triangoli di fuoco rossi e tremanti a pochi metri dall’acqua. Il rito è quasi esclusivamente di competenza maschile, in [ 49 ] particolare spetta ai figli maschi riconoscibili per una fascia bianca, colore del lutto, intorno al capo. Il cadavere viene portato su una lettiga a bordo fiume, immerso nell’acqua per purificazione, poi adagiato sulla catasta di legna, cosparso di polvere di sandalo e di ghi, un burro vegetale usato come combustibile. Altri pezzi di le- Everybody think of changing humanity And nobody think of changing himself (scritto col gesso sulla lavagna nera di una scuola a Varanasi, all’aperto) [ 50 ] gno vengono appoggiati sul corpo e la pira accesa. Brucia per ore, a volte per un giorno intero. Ci sono sensazioni ineliminabili, basta provarle una volta in una vita. Non è l’odore - la carne umana che brucia non è diversa da quella degli altri animali che normalmente grigliamo. Non è il fumo che bruciava gli occhi quasi facendomi un favore, perché mi permetteva di piangere un po’ e allentare il groppo in gola che mi vergognavo di avere perché loro, gli indiani, i figli che accendevano il fuoco sotto il cadavere della propria madre, non li ho visti piangere. Non sono il fumo e l’odore. È il calore che non potrò dimenticare, aderiva alla pelle, denso e costante, calore di uomini e donne che stavano bruciando, ed è il senso di riconoscenza che ho provato: grazie a chi è morto e ora è diventato combustibile che mi scalda. Quello che rimane del corpo, in genere le ossa del bacino per le donne e quelle dello sterno per gli uomini, viene gettato nel Gange, assieme ai corpi, legati a una pietra, di chi non viene cremato per tradizione (bambini, donne incinte, lebbrosi, santoni). Il fiume riceve e assorbe tutto, sorprendentemente senza restituire odori di nessun tipo, forse grazie all’incenso continuamente bruciato nelle puja che ogni giorno vengono celebrate, al calare del sole, lungo il fiume, for- se perché la città è soprannaturale. Ram nam satya et (il dio è verità), recitano gli uomini che trasportano le lettighe con il cadavere avvolto in un telo di seta giallo oro e rosso, giù per i vicoli di Godalia che portano al Manikarnika ghat. Camminano veloci, con una tale inesorabilità, senza esitazioni, un ritmo serrato come quello del mantra che recitano. Per chi abita a Varanasi probabilmente non è nulla; per me ogni corteo funebre era una sospensione, un’interruzione di vita e di giudizio, uno spazio bianco tra una porzione di quotidiano e un’altra: non sono abituata a considerare la morte come un dato (così!) acquisito. Loro non si vergognano di mori- re. Noi siamo impreparati e inadatti a tanta limpidezza, visibilità, evidenza della morte. Sarà per questo che i turisti si aggirano spaesati e frettolosi quelli in gruppo, spesso mano nella mano per non perdersi e rischiare di non ritrovare la guida o se stessi, mentre quelli solitari o in coppia ostentano una spavalderia che assomiglia a paura. E sotto alla superficie un senso di inadeguatezza, di fragilità, un’incapacità – tutta occidentale – di affrontare e vivere le cose per quelle che sono. Ti aspetteresti dei gatti, che riescono a sopravvivere con eleganza e non-chalance in ogni condizione. Invece mancano quasi del tutto, forse [ 51 ] [ 52 ] disertano un luogo dove non sono gli unici ad avere sette vite. Per quanto inizi a farsi strada l’idea che la vita di un uomo sia unica e non ripetibile, la credenza nella reincarnazione è molto radicata in India, e lo è tanto a Varanasi da aver sinora impedito la lottizzazione e costruzione sulla sponda del fiume opposta a quella della città storica: nessuno vuole vivere sull’altra riva dove, secondo la tradizione, chi muore rinascerà scimmia. Così l’altra sponda della Ganga è una striscia chiara di deserto che contrasta drammaticamente con l’accumulo di strade, pietre, persone, mercanzie e colori della città. Mi piace pensare che le due immagini siano in realtà speculari, che sia un modo per dire che il tutto è uguale al niente, che la città colorata e rumorosa non è così differente dalla città invisibile e silente, che le gradinate verticalissime e non umane assomigliano al vuoto. Why are you looking so sad? mi ha chiesto l’ultima sera una bambina mentre assistevo affascinata, per l’ennesima volta, alla puja aarti. Non ero triste, mi stavo ponendo delle domande paradossali, ad esempio come dev’essere innamorarsi di un pandit, oppure se, prendendo una barca e andando sul lato deserto del fiume, non vi comparirà improvvisamente una città con gli alti palazzi che furono dei maharaja, e guardando sull’altra riva non si vedrà soltanto una spessa linea bianca, punteggiata dal nero di qualche bufala. Quando la puja è finita ho passeggiato lungo il fiume fino al Manikarnika ghat e oltre, nella luce giallo-grigia opaca e calda della sera, incrociando qualche silhouette nera sottile e discreta. Un gatto tigrato magrissimo è sgusciato su un gradino alto del Lal ghat, nella direzione opposta alla mia. Ho pensato allora che fosse bene che tornassi indietro anch’io, e lasciassi l’ultima parte dei ghat per il prossimo viaggio, quando arriverò fino al termine delle gradinate dove dicono ci siano le scimmie, incauti umani che sono andati al di là del Gange e non hanno più fatto ritorno. Valentina Cabiale, archeologa, 31 anni. Laureata in Lettere all’ombra dei murazzi del Po torinese, specializzata in archeologia medievale sulle spallette dell’Arno fiorentino: ha bisogno di fiumi nelle città in cui studia, ma non ha mai fatto un buco nell’acqua. Ha scavato se non dal Manzanarre al Reno, da Chieri a Samarcanda, senza perdere la grazia che la contraddistingue. Nella sua valigia, sempre pronta per nuovi viaggi, trovano posto vestiti comodi, reflex e libri in parti variabili. [ 53 ] filosofici, rappresentazioni sacre, in cui tutti i pellegrini si bagnano insieme nelle acque dei fiumi sacri per celebrare l’universalità della vita spirituale. Fedeli e pellegrini giungono da ogni parte per partecipare a questa celebrazione e si riuniscono per un bagno nelle sacre acque del divino fiume Gange in quanto si ritiene che il bagno purifichi e “lavi via” i peccati e il male passato nella vita dell’individuo. Aspettando il Maha Kumbh Mela di Paola Pedrini [ 54 ] Il più affollato raduno religioso dell’umanità è il Maha Kumbh Mela. Mela sta per “festa” e la parola kumbha significa “vaso”, “contenitore” “brocca”, e si riferisce al contenitore del nettare divino dell’immortalità “amrita” dal quale, durante la contesa tra dei e demoni, caddero delle gocce sul pianeta Terra. Il Kumbha inteso come vaso simboleggia l’utero, la forza generatrice, identificata con le dee madri. Nella mitologia indiana diversi personaggi sono nati da un vaso, considerato il ricettacolo di ogni forma di vita. In questa occasione gli induisti dimenticano le caste a cui appartengono, gli stati di provenienza o il loro status sociale. I pellegrini vengono al Kumbh Mela pieni di questa grande devozione, e in un numero così schiacciante, che la mente vacilla. Sembra un oceano di esseri umani. Il Kumbh Mela è quindi un pellegrinaggio hindu di massa che si celebra in quattro luoghi principali: Prayag o Allahabad, Haridwar, Ujjain e Nashik. La Maha Kumbh Mela (“Grande” Kumbh Mela) si celebra ad Allahabad ogni 12 anni e dopo 12 cicli - e di conseguenza dopo 144 anni - si celebra il Purna Kumbh Mela (“completa” Kumbh Mela). All’ultimo Maha Kumbh Mela del 2001, parteciparono circa 60 milioni di persone, rendendo il rito il più grande raduno mai svolto nel mondo. Questo festival religioso vede riunirsi milioni di pellegrini, sadhu, e religiosi induisti di ogni gruppo. Lo scopo di questo incontro è squisitamente ecumenico: si tratta di 40 giorni di incontri, di musica devozionale, di mantra, di dibattiti Eserciti di asceti e pellegrini, appartenenti a oltre 8000 gruppi e istituzioni religiose, si mescolano spalla a spalla, tra il clamore di cembali, corni, conchiglie, invocazioni e preghiere, soprattutto nei momenti più cruciali del bagno rituale. È il governo indiano che organizza questo grandioso festival, costruendo circa 170 km. di passerelle sulla sabbia con piastre metalliche, altrettanti chilometri di tubazioni di acqua potabile e cavi elettrici, nove ponti e altre strutture e fornendo 1070 ettari di terra per centinaia di migliaia di pandal (grandi tende per incontri spirituali), templi (e altoparlanti!), tende da abitazione normali o di lusso, bagni, cucine, centri di pronto soccorso, mercati interni e così via. Il tutto viene rimosso al termine del festival. Giorno e notte si tengono rappresentazioni sacre e recitazioni delle scritture e delle avventure dei vari avatara divini, canti e cerimonie rituali ai quali tutti possono partecipare liberamente. Così, con il bagno nel fiume sacro, i peccati del passato vengono lavati via e l’anima raggiunge la Moksha, la liberazione dal ciclo di nascita e morte. Questo bagno nel fiume offre la purezza, la ricchezza e fertilità, e lava via i peccati di coloro che si bagnano in esso. Paola Pedrini. Giornalista, scrittrice e instancabile viaggiatrice, si dedica negli ultimi anni alla scoperta dell’Asia prima che la grande passione per l’India la porti a visitare cinque volte quel paese che ti entra nell’anima per non uscirne mai più. Con la casa editrice Polaris ha pubblicato “La mia India, pensieri in viaggio” (2011) e “Gli angeli di Calcutta, sguardi sulla città e sul volontariato” (2012). Dopo diverse esperienze di volontariato in Italia e all’estero decide di frequentare un corso professionale per Operatore Socio Sanitario per lavorare e scrivere per il sociale. AL SICURO COME IN MEZZO ALL’ERBA Testo e foto di Elena Dacome chad, zona di Dourbali a sud-est di Ndjamena. Inizio autunno. In lontananza: bianchissime, curve e larghe come lire si assottigliano all’apice appuntito e nero. Così galleggiano sulla vegetazione centinaia di corna di zebù. Da lontano si annunciano fremendo nell’aria caldissima del mezzo mattino. Il vago tremolio diventa una massa di innumerevoli zebù, un flusso ininterrotto di bovini affiancati da capre, asini, uomini e donne in transumanza. Molti animali sono scarichi e in gruppo, altri portano sottili rami curvi e calebasse impilate l’una dentro l’altra. Su alcuni siedono le donne con i figli più piccoli; altri bimbi si dividono lo spazio con agnellini di pochi giorni bianchi come neve. Gli uomini sono a piedi o a cavallo. Tutte le masserizie sono legate sugli animali e navigano tra i basti e il cielo come prive di peso. Il passo regolare della mandria produce un fruscio di erba calpestata. Gli steli freschi si spezzano sotto il peso degli zoccoli e l’umido si spande sulla terra: sottofondo continuo per questo inesausto avanzare. Così si muovono i Pheul Woodabe quando cercano un nuovo pascolo: un esodo di genti nomadi e corna ondeggianti. Più noti come Bororo, i pastori nomadizzano in tutto il Sahel dal Burkina al Tchad. Vivono durante l’anno in piccoli gruppi sparsi. Solo disperdendosi possono sperare di trovare minime risorse per la sopravvivenza dei loro animali. Stare insieme vorrebbe dire esercitare sul territorio arido una pressione che porterebbe in breve all’esaurimento di tutte le risorse. Solo in settembre, alla fine della stagione delle piogge, possono ritrovarsi e condurre i loro spettacolari armenti su terreni verdeggianti e ricchi di sale, prezioso per la loro salute. Questa circostanza vede le genti celebrare feste, danze e canti. Gli uomini si truccano vistosamente e danza- [ 59 ] no esibendo la loro straordinaria bellezza per alcuni giorni di seguito. Individuare i pascoli su cui si radunano i pastori in settembre, non è cosa facile. Si pongono domande, si cercano notizie utili per mettersi sulle loro tracce e trovare gli accampamenti. All’arrivo è uso presentarsi al capo del clan Woodabe Si vive nell’erba, detto Ardo. In quesull’erba, dell’erba. ste zone ci sono i sudo-sokai, i giptu e gli iakauà. L’Ardo rappresenta gli interessi del gruppo e li difende nei rapporti col mondo esterno. È consuetudine che gli esponenti di uno stesso lignaggio, i quali si riconoscono in un antenato comune, siano legati tra loro da vincoli di solidarietà. Se il mondo è un reticolo di pericoli, di angoli acuti, di spine e trabocchetti, l’unico posto in cui forse trovare pace è in mezzo all’erba, tra gli alberi. Così i Woodabe descrivono lo stare in [ 60 ] mezzo a loro, genti distratte nei confronti della religione e poco inclini ad assecondare interessi politici di qualunque colore. Lo straniero è al sicuro presso i loro campi come in un pascolo, nella brousse. Si vive nell’erba, sull’erba, dell’erba. Grazie ad essa, infatti, gli zebù producono il latte, kossa, base dell’alimentazione. Bianchissimi: gli uomini sfregano i denti con pezzetti minuti di corteccia e risciacquano. Inizia così, nel primo pomeriggio, la preparazione al trucco. I denti abbagliano e la regolarità delle arcate offre una superficie su cui la luce si infrange e rimbalza. I Woodabe vivono nel culto della bellezza. Si dice addirittura che allevino zebù, nagghe, perché grazie alle loro corna imponenti sono più eleganti di altri bovini. Sono gli uomini i veri interpreti di questo culto che si esprime in massimo grado durante le feste dell’autunno. Nei giorni in cui il clan si coagula e condivide il pascolo con altri clan, svolte le mansioni necessarie per la cura degli animali, gli uomini dedicano tutto il tempo a truccarsi e danzare. Li osservo per ore mentre muniti dei loro inseparabili specchietti, darògal, lentamente si preparano. La fronte è rasata fin quasi a metà cranio e i capelli corvini separati in trecce. Le disfano. Spalmano i capelli con crema di legno di sandalo e olio d’oliva per nutrirli e renderli lucidi e nuovamente intrecciarli. La pelle del viso viene ricoperta con cura certosina di ocra rossa o gialla a seconda degli accordi presi tra gli uomini e il tipo di danza. L’ocra, [ 61 ] nakkara, polverizzata normalmente con una lametta sulla suola di una ciabatta, è spalmata con cura sul volto con un dito e fissata con del nébban, una specie di burro. Con l’aiuto di un bastoncino di paglia rivestito in punta di un batuffolo di cotone si procede poi a tracciare minuziosamente il disegno sul volto: da ciuffi di lana colorata ciascuno spezza con i denti un microscopico frammento di filo e poi lo appiccica sulla pelle del viso creando disegni di puntini colorati. Altri tempestano il volto con cerchietti bianchi o brevi linee di latte cagliato disegnati con estrema accuratezza perché il se- [ 62 ] gno sia quanto più preciso possibile. Infine tocca valorizzare gli occhi col nero di antimonio e le labbra che parimenti si tingono di nero utilizzando carbone di legna o più spesso polvere, nociva, di vecchie pile. Dopo ogni mossa, spostando leggermente il viso da un lato e dall’altro ciascuno controlla l’insieme nello specchietto perché la simmetria sia rispettata e il tratto nitido. Passano ore. Gesti e movenze femminili si sovrappongono a corpi scuri e virili. Sulle braci dei fornetti la teiera borbotta tutto il tempo e ci si interrompe solo per mescere e sorbire il thé. Nere, sono tutte le vesti che indossano gli uomini nella danza. Spiccano solo il trucco, le collane e le spade ricoperte di perline che alcuni portano a tracolla. I pastori, belli come dei, si dispongono fianco a fianco, spalla contro spalla per le danze in linea, yaké. Cantano una nenia in cui la voce sale e scende all’interno dell’ottava rispettando intervalli simili. Camminano a piccolissimi passi in avanti e indietro. Uno di loro con brevi cenni dirige l’avanza- re o il retrocedere mantenendo compatta la fila. La danza è elementare perché nello yaké conta l’esibizione della bellezza di ciascuno: digrignano i denti, fanno smorfie, emettono strani suoni gutturali, fanno tremare le labbra, strabuzzano gli occhi secondo una sequenza precisa e sembrano uccelli impegnati in un corteggiamento. Al tramonto la luce dorata insiste per dieci minuti sublimi sui loro gioielli, sulle pupille, sulle dentature, sui volti allucinati [ 63 ] e surreali. Ad un gesto impreciso per me la linea si chiude in un tondo. Nella danza in cerchio, dossa, si valorizza il canto poiché i danzatori stanno di schiena e la loro bellezza s’intuisce da dietro. È l’imbrunire: un larghissimo cerchio di una trentina di uomini gira per via di microscopici passi che lo fanno sembrare il meccanismo di un ingranaggio gigante. Sono tutti vestiti con lunghe camicie nere che arrivano quasi ai piedi: i loro bacini oscillano all’unisono in su e in giù dentro le tuniche mossi dalle ginocchia che impercettibilmente seguono i passi. Le ossa lunghe sostengono cor- [ 64 ] pi esili; le vesti larghe seguono il movimento, quelle strette in vita si appoggiano sulle forme. Il ritmo del battito delle mani, a tempo singolo e doppio, delle voci, dei piedi anima il cerchio in modo crescente; i passi piccoli ma energici spinti contro il terreno lo fanno vibrare. La terra diffonde l’energia dei muscoli. Danzano, instancabili, cantano, senza pause. Mestre il cerchio gira lento ma inesorabile si colgono metà schiene e metà volti; la polvere sale dal cerchio come fumo mentre ad ovest striature arancioni liquefanno l’orizzonte. La danza diventa polvere e questa, risalen- do dai piedi, avvolge i danzatori odorosi di burro e indugia su di loro. Il tramonto infuocato, la terra che trema, il ritmo della danza. In cielo appare uno spicchio di luna allo zenit e sembra il perno intono a cui il cerchio gira. Nel buio della notte i canti continuano e rimbalzano nella brousse. La dote. Alcune donne arrivate col nuovo gruppo sono indaffarate nella costruzione della loro casa-cucina, un’impalcatura di pali su cui esporranno la loro dote: zucche svuotate e incise magistralmente, pentolame di smalto, vassoi decorati con specchietti, ceste ricamate con fettucce di plastica bianca e qualche intarsio colorato. La dote e ciò che la sorregge si dice worso ed intorno ad essa gravita tutta la vita della famiglia. Si girano al mio saluto e accennano una risposta. Resto immobile vicino al cespuglio basso vicino al quale mi pare di poter restare senza dare troppo [ 65 ] [ 66 ] disturbo. Una di coperte, tessuti. loro porta un paOsservo il corpo Danzano, reo nero stretto instancabili, cantano, della prima, la pelin vita. Accenna le dello stesso cosenza pause. a coprirsi portanlore del tabacco. do il telo più in su La schiena è attrama dopo qualche istante lo lascia versata da un cordino nero cui è scendere. È magrissima. La vita appeso un talismano nascosto: È è stretta come un tronco giova- come se quel filo nero fosse un ne; la schiena e le braccia nel sottile nervo scoperto, un disemovimento rivelano fasci di mu- gno sulla pelle. Bevo l’acqua più scoli. Sul cespuglio vicino a me è volte. Saprò solo il giorno dopo poggiato un telo leggero, di quelli che si chiama Mariama. Mi allonche poi dovranno essere siste- tano per un po’ e quando torno mati sulla struttura di legno. Ve- le donne sono intente alla mundendo che non mi muovo di lì, la gitura: gli schizzi finiscono dritti donna si avvicina con una stuoia. e sottili come fili nella calebassa La sistema alla base della pianta, allarga il tessuto che sta so- Riflessi di alluminio. La schiena pra e mi fa cenno di sedermi. Mi nuda, arcuata e magra di una sistemo all’ombra. Si allontana. giovane donna si veste di riflessi Tra le vettovaglie sparse a terra, metallici mentr’ ella, accucciata cerca e trova una piccola ciottola su un seggiolino di legno, mundi alluminio. La sciacqua, ci versa ge all’imbrunire. Il sole è sotto le dell’acqua, vi posa sopra un co- nubi. Una luce grigio- argentea si privivande di paglia e me la porge. spande sulle cucine poste a sePosso restare qui all’ombra a lun- micerchio su un terreno leggergo e dissetarmi. Una bimba con mente mosso e ricoperto d’erba la zappa ripulisce un rettangolo di e bassi cespugli, in prossimità di terreno su cui un’altra donna ini- uno stagno necessario all’abbezia a piantare pali percuotendoli verata. A quest’ora l’accampacol fondo dell’ultimo che pian- mento brulica di animali al ritorno terà. Legni alti e bassi a forcella dal pascolo. Gli zebù raggrupne sorreggono altri trasversali e pati ovunque in piccole mandrie lacci tengono uniti gli uni agli altri. stanno fermi davanti ai fuochi. Su tutto stendono grosse stuoie, L’odore della legna arsa li tiene [ 67 ] [ 68 ] vicini, le fiamme li rassicurano. Ovunque le donne, molte a seno nudo, procedono alla mungitura e sono indaffarate a montare le frasche per i letti e seguono le pentole sul fuoco. Ovunque gli uomini stanno seduti a terra sulle stuoie, intenti al trucco per le danze notturne. Il campo è vastissimo e in fermento: il fumo, l’odore delle braci, i bagliori delle fiamme, i muggiti degli animali…sembra un’enorme fiera d’altri tempi. La polvere ammorbidisce i contorni e su tutto oscillano centinaia di corna austere e imponenti. Una donna torna dalla mungitura con una calebassa piena di latte tra le mani. Ha un pareo nero stretto in vita e un telo scuro gira distratto sul capo. Una collana composta da decine di gri-gri di cuoio nero e lucido, come la sue pelle, gira intorno al suo collo, si stringe in mezzo ai seni e si riapre sopra lo stomaco in un’ampia goccia. Si ferma davanti alla sua dote e poggia il latte. Poi all’improvviso, messa in allarme da una voce torna di corsa verso gli armenti in un luogo che non so saltellando tra uno zebù e l’altro a piedi nudi e la intravedo balza tra le corna come se fossero queste a passarsi il suo corpo leggero e nero. Sembra una creatura senza peso: un tratto di penna a forma di donna, di seni e di talismani appare e scompare tra le alte corna. Si direbbe una scena in bianco e nero. Elena Dak, veneziana, è scrittrice e viaggiatrice. Dal '97 lavora come guida per Kel12. Laureata in antropologia. È tra le poche donne al mondo ad aver attraversato il Tenerè al seguito di una carovana del sale. Ha scritto "La carovana del sale" e Sana'a e la notte edito da Alpine Studio. Il suo sito, elenadak.it. [ 69 ] ognuno di noi E’ più di uno Testo e foto di Bruno Tigano gnuno di noi è più di uno, è molti, è una prolissità di se stesso. (“Il libro dell’inquietudine” Fernando Pessoa). Da questa frase e dalla passione per il suo autore e i suoi infiniti eteronimi nasce il mio personale viaggio a Lisbona. Il libro dell’inquietudine, rispecchia quella forza misteriosa che spinge ciascuno di noi a intraprendere un viaggio. Quel desiderio mai domo di incamminarsi per terre lontane, per sedare quella voce interiore che ci spinge a prendere uno zaino e andare. Un viaggio in quella terra, patria del grande viaggiatore immobile, che con la sua capacità d’astrazione è stato in grado di conoscere il mondo senza mai muoversi dalla sua amata Lisbona. Un viaggio attraverso i luoghi e le strade della capitale lusitana alla ricerca del fantasma dell’autore ancora presente in ogni angolo della città. [ 72 ] Ho portato fino a queste lontane terre i sapori e gli odori di Lisbona affinché tu, estraendo il sughero di questo contenitore privo di valore, ti possa perdere nei sapori ed effluvi di Augusta e del suo immenso fiume che abbraccia l’oceano. All’interno è contenuta la terra su cui i miei piedi hanno camminato, l’acqua che ha lavato le mie membra stanche e piccoli tesori che il mare mi ha donato e che adesso ripongo e affido alle tue pregiate mani, unitamente a un messaggio del fantasma che io stesso ho conosciuto: “ogni cosa che è stata nostra, anche se soltanto per la casualità della convivenza o della vista, perché è stata nostra diventa noi”. Lisbona é nelle tue mani mio venerato amico, attraverso questa bottiglia potrai coglierne il sapore e l’odore e finalmente Lisbona diverrà tua per sempre. Facciamo del nostro fallimento una vittoria. Bruno Tigano vive in Umbria, ma è nato a Palmi (RC) nel 1979. Di mestiere fa l’avvocato. Appassionato di viaggi, fotografia e letteratura. Ha viaggiato dal Sud America all’Australia, dall’Egitto all’India. È convinto che il viaggio sia un antidoto contro i pregiudizi e le intolleranze. Il viaggio aiuta le persone a sentirsi libere. Quanto era umano il rumore metallico dei tram! Che allegro paesaggio la semplice pioggia sulla strada resuscitata dall’abbisso! Oh, Lisbona mio focolare! [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] Quando i bimbi giocano e li odo giocare qualcosa nella mia anima comincia a rallegrarsi. [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] Quanta inerzia e falsità, quanto abbandono vi siano in questa Rua dos Douradores che per me è tutta la vita la matita di stalin Testo e foto di Fabio Belafatti e si dovessero elencare i singoli oggetti che più hanno danneggiato l’umanità, tra questi ce ne sarebbe sicuramente uno all’apparenza inoffensivo: una matita. La matita di Stalin. Questa è la storia di una regione messa in ginocchio da quella matita: la valle di Farg’ona. Il cuore dell’Asia Centrale si chiama Farg’ona. È la zona più fertile di un’area altrimenti arida. Per secoli è stata granaio d’imperi, regni, khanati, per poi diventare, sotto i bolscevichi, granaio dell’Asia Centrale Sovietica. Un granaio nei cui confini Stalin e i suoi compari dell’Ufficio Nazionalità dell’URSS misero una trappola. L’immensa valle di Farg’ona non aveva mai conosciuto confini moderni. Stalin e i suoi presero una matita, e costruirono muri di grafite dove non ce n’erano. Divisero la valle tra le Repubbliche Socialiste Sovietiche di Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan. In un gioco d’incastri, definizioni, limiti, Stalin e la sua matita spaccarono il Farg’ona mettendo un confine o un’alta catena montuosa a separare le capitali delle repubbliche dal loro polmone economico. [ 82 ] Sparpagliarono poi i popoli a cavallo dei confini, cosicché una manciata di kirghisi finisse in Uzbekistan, un po’ di uzbeki in Tagikistan e molti uzbeki in Kirghizistan. Finché c’era l’URSS, nessun problema: i confini erano solo tratti di matita, il paese unito, i popoli legati dalla “solidarietà internazionale”. Quando vent’anni fa tutto cadde a pezzi, però, scattò la trappola: i confini divennero muri di filo spinato e le catene montuose non potevano più essere aggirate passando dalle repubbliche vicine. Il Farg’ona ne uscì malconcio, isolato, catapultato in una decadenza economica mai vista. Parto da Dushanbe, la capitale tagika, un sabato di giugno. La mia destinazione è Khujand, la capitale economica del paese, nella valle di Farg’ona. La matita di Stalin [ 83 ] [ 84 ] aveva decapitato il Tagikistan in modo che il suo cuore politico e quello economico fossero separati da due immani catene montuose alte anche cinquemila metri, con passi oltre i tremilacinquecento, perennemente chiusi in inverno ed insidiosissimi d’estate: una follia di cui sperimenterò presto i risultati. Alla partenza, un imam benedice la nostra jeep. La cosa mi inquieta, ma i miei compagni di viaggio sembrano tranquilli. Con me viaggiano un ragazzetto appollaiato dietro tra enormi pacchi di giornali ingialliti, un professore dell’università di Khujand e alcuni personaggi poco loquaci che vogliono solo andarsene a casa. La strada, in rifacimento grazie a massicci investimenti cinesi, serpeggia tra rocce a strapiombo e montagne spettacolari per decine di chilometri. Qua e là, villaggi di una povertà sconvolgente, dove i soli segni di modernità sono i cartelli di propaganda. Viaggiamo a lungo prima di raggiungere il tratto di strada non ancora risistemato. La strada s’impenna, l’asfalto scompare e l’autista deve guidare sul bordo estremo della carreggiata per evitare i massi da sopra. Centinaia di metri sotto di noi, carcasse d’auto e camion giustificano all’istante le benedizioni dell’imam. Il professore mi vede pallidino e mi domanda sghignazzando se ho paura, salvo poi smettere di sfottere più [ 85 ] [ 86 ] ci avviciniamo al pasforse falsi. La gente so. Alcuni viaggiatori Khujand è la città passeggia sotto viali mormorano preghiealberati e sogna una più nostalgica re. L’auto viaggia prosperità perduta, o dell’Asia Centrale così all’esterno che una che non arriverà a guardar fuori semforse mai. bra siamo sospesi nel nulla. Inizio Resto a Khujand qualche giora pregare anch’io, riscoprendo una no, alloggiato in un albergo mezzo religiosità che credevo perduta. Le abbandonato dalla facciata rivesticarcasse delle auto si fanno sem- ta di quei pannelli di plastica dorata pre più piccole a fondovalle. Ci che in Asia Centrale piacciono tanmettiamo un tempo interminabile to. A gestire il posto è la donna più a valicare il passo e quando ci riu- grassa che si possa immaginare. Il sciamo, iniziando la discesa verso ristorante serve solo pessime salKhujand, è come se tirassimo il fia- sicce fritte nel grasso, il che spiega to tutti insieme. l’impressionante tonnellaggio della padrona. I cessi cadono a pezzi, Khujand è la città più nostalgica manca acqua calda e i letti sono dell’Asia Centrale: molti la chiama- tavoli coperti di lenzuola polverono ancora “Leninobod”, col nome se, probabilmente ricchissime di dato dai bolscevichi a questo anti- forme di vita. Tutto emana un’aria chissimo pezzo di civiltà. Appolla- di decadenza, di torpore povero e iata sul Sir Darya, sfoggia ancora sudicio. Da fuori arrivano la musiun mastodontico Lenin d’alluminio ca di una festa di matrimonio e lo e innumerevoli mosaici sovietici. schiamazzare di una folla di invitati. Isolata dal sud del paese, Khujand vive di vita propria: controlla gran La mattina della partenza trovo un parte dell’economia tagika e cam- taxi collettivo che mi porti al conpa ancora d’inerzia dell’agricoltura fine con l’Uzbekistan. Viaggiamo un tempo prospera del Farg’ona tra rigogliose coltivazioni, con sulla sovietico. Pian piano, però, i tempi sinistra l’enorme lago turchese del cambiano: la statua di Lenin è de- Kayrakkum e, sulla destra, brandelli stinata alla demolizione, Viale Lenin del confine kirghiso, nient’altro che è un succedersi di negozi di tec- un fosso. Al di là ci sono piccoli casinologia scadente, paccottiglia ci- nò dove qualche tagiko va a bruciarsi nese e vestiti sportivi forse originali, i risparmi, dato che qui il gioco d’az- [ 87 ] zardo è vietato. La mia destinazione è un valico di frontiera perso nella pianura, sulla strada per Qo’qon, centro spirituale della regione. La valle di Farg’ona è importante per l’Islam centroasiatico: molti giovani locali La matita di si rifugiano in forme Stalin scardinò più o meno estreme di religione per trodalle fondamenta vare consolazione l’economia locale. dalla mancanza di opportunità economiche. La matita di Stalin scardinò dalle fondamenta l’economia locale, quando i confini divennero reali. Il risultato sono tensioni che bollono sotto la superficie della società, rabbia repressa, paura e, come presto apprendo, paranoia. Ai doganieri tagiki sto simpatico perché parlo la loro lingua, ho passato vari mesi nel loro bellissimo paese e conosco un paio di funzionari ministeriali importanti. Mi salutano tra sorrisi ed inviti a tor[ 88 ] nare. Dall’altra parte del confine però sono solo: in Uzbekistan non ho agganci ufficiali, non parlo la lingua e, soprattutto, vengo dal Tagikistan, un paese temuto, un nemico non dichiarato: la parte est è terra di militanti islamisti e ai servizi di sicurezza uzbeki la cosa piace pochissimo. Ai doganieri, ancora meno. Quando mi perquisiscono il bagaglio e trovano libri stampati in alfabeto arabo, chiamano i superiori. Viene tutto requisito e mi ordinano di sedermi in disparte. Aspetto per un’ora stravaccato all’ombra di un gelso. Un soldato mi guarda con aria strafottente, appoggiato al suo AK-47. Ha l’aria di chi la sa lunga. Sorrido e mi risponde con un cenno della testa, un po’ di sfida. Suscita un’antipatia istantanea. Passa un’altra ora. Il caldo induce al torpore e favorisce l’attesa, ma dopo un po’ mi annoio. Entro nell’ufficio delle guardie per capire cosa succede. Salta fuori l’impensabile: il mio libro in “arabo”, che in realtà è una grammatica di persiano, è stato scambiato per un testo di propaganda islamista. Scoppierei a ridere se non fossi circondato da militari paranoici. L’attesa si prospetta lunga: in questa regione c’è chi s’è fatto ammazzare per la religione. Non posso cavarmela con sorrisi, mazzette e strette di mano. Dopo un po’ arriva da Qo’qon un anziano linguista: deve appurare che il libro sia effettivamente una grammatica persiana e non il manuale del giovane jihadista. Mi infligge un esame improvvisato di persiano in uno stanzino sudicio, fetido di sudore. Suggerirei di met- terci all’aperto sotto il gelso ma non mi sembra il caso. Seduto sulle brande scassate delle guardie, gli leggo il testo per dimostrargli che è innocuo. Non basta: il linguista se ne va, passano altre ore e arriva un funzionario di qualche servizio di sicurezza. Inizia a farmi domande e a prendere minuziosamente nota su cos’ho fatto in Tagikistan, chi ho incontrato, dove sono stato, perché, e poi ancora, hai mai avuto contatti con i terroristi (!), sei mai stato nelle zone sotto il controllo degli islamisti, nella valle di Rasht o al confine con l’Afghanistan? Il tizio ha l’aria simpatica e biascica battutine in inglese, ma mi sta pur sempre schedando, e la cosa non fa ridere. E così io, aspirante terrorista, trafficherei testi proibiti attraverso una frontiera ufficiale, quando potrei trafugare in Uzbekistan un’intera biblioteca islamista dalle migliaia di chilometri sguarniti di confine. Dopo sette ore, innumerevoli domande e raffiche di telefonate a chissà quale ufficio in chissà quale ministero, mi lasciano finalmente passare. Forse a convincerli è stato il santino che ho mostrato per fingermi cattolico. Devo ricordare di ringraziare mia nonna per questo. Ad ogni modo, ho l’obbligo di starmene a Farg’ona, capoluogo dell’omonima regione, e visitare le città vicine solo per brevi puntate quotidiane. Incredibilmente, nessuno mi ha perquisito la seconda borsa. Peccato, ci avrebbero trovato opuscoli di propaganda antiuzbeka scritti da politici tagiki, e lì sì che sarebbe stato divertente. Sarà per la prossima volta, ora me ne vado. Sono le sette di sera, un tizio mi offre un passaggio e mi verrebbe voglia d’abbracciarlo. Due ore dopo sono a Qo’qon. Qo’qon è una città-cantiere: per comprare la lealtà della popolazione, il governo ne sta costruendo interi quartieri. L’aria è resa quasi irrespirabile dalla polvere e dal caldo, fatico a godermi le moschee e i grandi palazzi dei khan e cerco rifugio altrove. Scopro un museo dimenticato, dedicato al primo drammaturgo comunista uzbeko. Trasuda decomposizione: fuori, fontane e decorazioni sovietiche perdono pezzi. Dentro, macchie di umidità rovinano i manoscritti. Le custodi sembrano ignorare lo stato d’abbandono dell’edificio. Deluso, forse rattristato, mi addentro nella città vecchia. Un’atmosfera di pace rimpiazza progressivamente l’aria di decadenza. Le vie sono strette, sterrate o mal asfaltate. In un cortile, [ 89 ] [ 90 ] degli uomini chiacchierano bevendo tè. Il guardiano della vicina moschea mi invita a visitare il cimitero dei khan. Appena scopre che sono italiano, va in estasi. Mi spiega, mescolando con disinvoltura russo, tagiko e uzbeko, che adora l’Italia di Bearzot, Rossi e Tardelli e si mette persino a mimare tra le tombe (con tanto di urla di giubilo) i leggendari goal che consegnarono all’Italia il mondiale dell’82. Sono senza parole. Attorno a noi, i visitatori del cimitero osservano perplessi. Quando si mette a spiegarmi la genialità delle formazioni di Arrigo Sacchi usando una decorazione geometrica della moschea a mo’ di lavagna, scoppiamo a ridere insieme. Nel cuore dei vecchi quartieri, la polvere se ne resta fuori. Altre moschee, altre case da tè. In una, poverissima e spoglia, una decina di anziani si rilassano e mi invitano a mangiare qualcosa. Hanno solo pane, pomodori e cipolle, ma il sapore degli ortaggi è celestiale. Resto lì un paio d’ore a godermi l’ospitalità e la frescura in perfetta pace, meditando su quanto sarebbe splendida questa regione se non fosse povera, isolata, trascurata. Il giorno dopo raggiungo Farg’ona, capoluogo della valle. È definita “la città più russa dell’Uzbekistan”, ma la popolazione è soprattutto uzbeka. I russi se ne andarono vent’anni fa, cacciati dalla decadenza della regione e, a volte, dall’ostilità dei locali. L’improvvisa povertà che colpì Farg’ona compattò le etnie l’una contro l’altra per un tozzo di pane. Una guerra tra poveri. Più ad est, nelle città kirghise del Farg’ona, questa guerra ha mietuto centinaia di vittime. Qui si vede però una città in lento risveglio, gioiosamente rilassata in un giorno di festa. Famigliole affollano un parco con giostre e banchetti di zucchero filato, mentre decine di poliziotti sorvegliano tutti. Forse le forze di sicurezza vedono islamisti barbuti nascosti anche dietro ai bambini coi loro gelati. A Farg’ona rincontro un amico conosciuto mesi prima a Tashkent. Gli chiedo come va il suo buon lavoro al Turkuaz, il più prestigioso centro commerciale della capitale. Brutta gaffe: il lavoro non c’è più. Qualche mese prima, l’affarista turco proprietario del Turkuaz deve avere fatto imbestialire il presidente Islam Karimov: immediatamente, furgoni pieni di poliziotti delle forze speciali sono piombati sul centro comerciale, hanno cacciato via i clienti, sequestrato tutto e informato i commessi che era tempo di aggiornare il curriculum. Tutti a [ 91 ] [ 92 ] casa. Il concetto di uzbeki furono di “precarietà del assassinati per Andijon è una città lavoro” mi si prestrada da bandi spettri. senta in una luce de di criminali tutta nuova. kirghisi inferociti Qualche giorno dopo sono ad contro un nuovo governo. Quello Andijon, vera meta del mio viag- di Andijon, Osh e Jalalabad è un gio. La città più orientale dell’Uz- triangolo di memorie lugubri, è il bekistan, la più famosa, la più cuore del problema, il frutto marintegralista, quella messa in gi- cio di questi confini. nocchio più di tutte dal declino della valle. Andijon è una città di Non potevo perdermi Anijon, sospettri. Sono quelli delle vittime prattutto dopo che i miei amici del massacro che avvenne anni doganieri-filologi me l’avevano fa a seguito di una manifestazione semi-vietata. Ci trovo delle grosse popolare. Gli eventi sono sigillati sorprese: mi aspettavo un luogo nella censura più ermetica; si sa cupo, decadente. Scendo dal bus solo che il 13 maggio 2005 le for- e sono catapultato in un’altra cittàze di sicurezza aprirono il fuoco cantiere. Qo’qon impallidisce: qui su una manifestazione indetta per il governo sta costruendo trecenchiedere la liberazione di alcuni tocinquantamila metri quadrati di imprenditori locali molto religiosi. nuovi edifici. Le vie che portano a Morirono centinaia o forse addirit- piazza Babur, luogo del massacro, tura migliaia di persone. Altre mi- sono state allargate, sicuramente gliaia fuggirono in preda al terrore. per render più agevole il percorso A milioni in ogni angolo del paese ai soldati in caso di sommossa. capirono la lezione e, da allora, tutto tace. Dei tanti che fuggiro- Ora sono lunghe strade a sei corno, molti andarono nel vicinissimo sie, troppo grandi per il numero di Kirghizistan, ad Osh e Jalalabad, macchine che vi circola. Ovunque, città etnicamente uzbeke separa- nuovi edifici: casette a tre piani, te dalle loro sorelle dalla matita di un ibrido di edilizia popolare e Far Stalin. Città di spettri anche quel- West, spesso foderate di pannelli le: già negli anni novanta vi scop- verniciati. È come un film con John piarono massacri etnici, e poi an- Wayne, ma di plastica. Il governo cora nel 2010, quando centinaia spera di comprare la fiducia della [ 93 ] gente con qualche decina di negozi e ristoranti e un posto di lavoro temporaneo nell’edilizia. Le vie brulicano di giovani e di operai edili, tutti indaffarati. Mi chiedo quante delle persone che incrocio abbiano avuto parenti ammazzati nel massacro e quanti dei loro cari siano sepolti nelle fosse comuni sulle colline brulle che s’intravedono dietro a questo set di plastica. Quanti perdoneranno il governo in cambio di un po’ di prosperità? [ 94 ] La città vecchia è più simile all’Andijon vista nelle foto filtrate dopo il massacro. Un aggrovigliarsi di vie polverose dove piccoli spiazzi si aprono qua e là a mostrare una vecchia moschea, una madrasa, una sala da tè. L’atmosfera è placida, la gente amichevole e cordiale. I bambini e gli anziani vogliono farsi fotografare, si mettono in posa come fosse la cosa più importante del mondo, senza sorridere, come facevano i nostri nonni. Per un attimo mi sembra di essere in un posto normale. Passo oltre un vivace bazar, il consueto ammasso di venditori di angurie, spezie e cellulari cinesi, e all’improvviso mi trovo su piazza Babur. Non me lo aspetta- vo ed è impressionate. Una distesa lastricata completamente deserta, nel cuore della città. Sembra che la gente la eviti di proposito, ma forse è solo suggestione. Scatto delle foto, quasi di nascosto, e mi defilo. Mi resta un senso di ansia addosso mentre rientro a Farg’ona su una marshrutka scalcagnata come i suoi passeggeri. Andarsene dal Farg’ona richiede qualche ora di macchina lungo una strada di montagna appena costruita coi soldi dei cinesi. A Pechino fa comodo per poter meglio trasportare prodotti in Uzbekistan mentre per gli uzbeki è un’efficiente soluzione al problema dell’isolamento dell’area. Prima la strada era pietosa e i collegamenti difficili. Anche questo era un risultato della matita di Stalin che si prese cura di separare Tashkent dal Farg’ona con un paio di bei confini ed una catena montuosa in mezzo al percorso. Ora i soldi cinesi scavalcano gli ostacoli. Che sia questo in fondo il destino del Farg’ona, cancellare i confini tracciati da un totalitarismo con i soldi di un altro? Fabio Belafatti, 26 anni, è un esperto di Asia Centrale. Specializzatosi all’Università di Londra in politica del Medio Oriente e Asia Centrale, collabora con vari siti internet di informazione italiani dove pubblica articoli e approfondimenti sulla politica della "Via della Seta". [ 95 ] città visibili Non è semplicemente un libro senza eguali – è un’ossessione. Da Le città invisibili di Italo Calvino viaggiatori e sedentari possono trarre, e di fatto traggono, ispirazione continua. Come nel bellissimo articolo Aleppo città invisibile di Amal Hanano (“Internazionale” n. 980, 21/27 Dicembre 2012), che ci spiega come la guerra possa rendere invisibile una città, la frantuma in pezzetti che occupano sì più spazio nelle strade ma i nostri occhi non possono più riconoscerla, ci siamo dentro e non la vediamo, come a Bauci. In occasione dei quarant’anni dalla pubblicazione di Le città invisibili l’ “Associazione Culturale 47 rosso” ha presentato a novembre 2012 nel complesso delle Ex-Murate di Firenze la mostra “Le visibili città invisibili. Un omaggio a Italo Calvino”, un tributo artistico a Calvino articolato in più direzioni, comprendente trenta illustrazioni originali, venticinque brani musicali inediti e una dozzina di installazioni che, visivamente o musicalmente, hanno rappresentano ciascuna delle cinquantacinque città. Le opere presentate raffigurano e interpretano in maniera personale ed originale le città, in uno sforzo di trasferire in immagine, in suono, in una forma, qualcosa di cui non abbiamo esperienza tangibile. [ 96 ] Testo di Valentina Cabiale Le illustrazioni, realizzate da Sara Vettori e Gabriele Genini, sono state eseguite con tecniche incisorie calcografiche e xilografiche, a tiratura limitata e numerata. Ne vengono qui presentate quattro, corredate da un estratto del testo. La mostra sarà replicata a maggio 2013 a Sesto Fiorentino (La soffitta - Spazio delle Arti, Piazza Rapisardi 6 Colonnata). [ 97 ] * ZAIRA // Sara Vettori (linoleografia 300 x 200 mm) … la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. [ 98 ] [ 99 ] * BAUCI // Gabriele Genini (linoleografia 300 x 200 mm) Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, che va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s’alzano dal suolo a gran distanza l’uno dall’altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. [ 100 ] [ 101 ] * ARMILLA // Sara Vettori (linoleografia 300 x 200 mm) Fatto sta che non ha muri, né soffitti, né pavimenti: non ha nulla che la faccia sembrare una città, eccetto le tubature dell’acqua, che salgono verticali dove dovrebbero esserci le case e si diramano dove dovrebbero esserci i piani: una foresta di tubi che finiscono in rubinetti, docce, sifoni, troppopieni. [ 102 ] [ 103 ] * EUTROPIA // Sara Vettori (linoleografia 300 x 200 mm) Entrato nel territorio che ha Eutropia per capitale, il viaggiatore vede non una città ma molte, di eguale grandezza e non dissimili tra loro, sparse per un vasto e ondulato altopiano. Eutropia non è una ma tutte queste città insieme; una sola è abitata, le altre vuote; e questo si fa a turno. Vi dirò ora come. [ 104 ] [ 105 ] una fot [o] una storia [ 106 ] una fot [o] una storia l’uomo che voleva la luna Testo di Andrea Semplici su una foto di Mario Dondero [ 108 ] L’ultimo atto della festa. Il momento del coraggio dopo i giorni della baldoria e della fatica. Leonardo, massaro e uomo dei boschi, afferra, a mani nude, il tronco privo di corteccia dell’albero e sale. Sale verso la luna che è apparsa nel cielo di Accettura, là nelle Dolomiti della Lucania. La luna guida l’uomo nella sua scalata. L’albero, alto quaranta metri, è figlio di un matrimonio: un grande cerro, il Maggio, della foresta di Montepiano, che, nel giorno della Pentecoste, è andato sposo alla Cima, un dolce agrifoglio dei boschi di GallipoliCognato. Leonardo raggiungerà le fronde della Cima, sfiorerà la luna e, orgoglioso, si alzerà in piedi sul ramo più alto. Lassù gli arriveranno gli applausi e gli evviva della folla del paese. Il Maggio di Accettura è uno straordinario rito arboreo che si svolge nei boschi delle Dolomiti Lucane. Il matrimonio degli alberi viene celebrato, con cerimonie infinite, nei giorni attorno alla Pentecoste. Quest’anno sarà fra il 18 e il 21 di maggio. La foto della pagina precedente è stata scattata nel 1993 da Mario Dondero, uno dei grandi fotografi del ‘900 italiano. Origini genovesi, nato nel 1928 a Milano, protagonista della leggendaria stagione del ‘bar Jamaica’, centro del mondo artistico italiano negli anni ’50. Ha lavorato per l’Unità e per Epoca, per Le Monde e per l’Espresso. A 85 anni (li compirà il 6 maggio) continua a viaggiare, con le sue vecchie Nikon e Leica analogiche, e a raccontare per immagini l’Italia e il mondo. La foto di Leonardo è un suo dono per Erodoto108. Leonardo Cafarella non scala più il Maggio, ma ancor oggi è fra i grandi protagonisti della festa di Accettura. le acciaierie di taranto Testo di Carlo Gubitosa Illustrazione di Sergio Leone [ 110 ] Tra le tante memorie della mia infanzia, ricordo quel cielo rosso e terribile. “Stanno lavorando all’Italsider”, mi spiegavano, e io da bambino mi chiedevo quale fosse il potere in grado di far cambiare colore al cielo. Oggi qualcuno sta cercando di far cambiare di nuovo colore a quel cielo, riportandolo al suo stato naturale, ma stavolta non è piu’ il potere dell’industria, ma quello dei cittadini ad essere entrato in azione. “Qui ci sono livelli di corruzione superiore a quelli di Tangentopoli” mi dicono i miei amici ambientalisti che mi fanno notare come le vicende giudiziarie nate attorno all’inquinamento dell’Ilva ormai non riguardano piu’ il solo livello manageriale, ma anche il livello politico e perfino la chiesa locale. Ma Tangentopoli è scoppiata nel cuore della “Milano da bere”, e la nostra “Ambientopoli” si è svolta per decenni nell’ombra, dietro le quinte, quasi che Taranto fosse in un altro paese. E quei ventimila che hanno marciato lo scorso dicembre nel silenzio dei media hanno voluto ricordare soprattutto questo: anche noi tarantini siamo italiani. Carlo Gubitosa, ‘Ingegnere delle telecomunicazioni, giornalista freelance e saggista, nel 2003 è caposervizio della sede milanese dell’agenzia ‘Redattore Sociale’. È direttore di “Mamma!” (www.mamma.am) la prima rivista italiana di giornalismo a fumetti. Sergio Leone è nato nel 1979 a Caltagirone e si laurea in architettura a Firenze. Ad oggi è assistente alla didattica presso la Facoltà di Architettura di Firenze. Nel 2012 espone la sua prima personale di fumetti e illustrazioni al Glue Alternative Concept Space di Firenze. Rimettiamo a posto la cultura. IdeaMuseo si occupa della ricerca, la progettazione e la realizzazione delle migliori soluzioni per il vostro spazio espositivo. Aiutiamo i musei a livello locale e nazionale a realizzare nuove idee e progetti che possano incrementare le visite ed a sostenere le proprie iniziative. ideamuseo.it
Scaricare