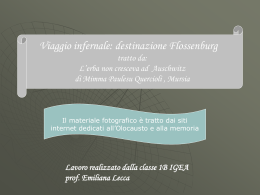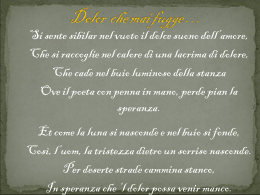UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Facoltà di Psicologia
Corso di Laurea in Psicologia Clinica e Neuropsicologia
IL DIALOGO, IL BUIO E LA GRUPPOANALISI.
Un incontro tra teoria, vita, pratica ed esperienza.
Relatore: Prof.ssa Silvia CORBELLA
Tesi di Laurea di:
Chiara SCHIROLI
Matricola 079647
Anno Accademico 2006-2007
Indice
Riassunto, V
Abstract, VI
Ringraziamenti, VII
Introduzione: Il dialogo, il buio e la gruppoanalisi, un incontro tra teoria, vita,
pratica ed esperienza, IX
Cap. 1: Il Dialogo, 1
Cenni storico-filosofici, 1
Antifonte e l’arte consolatoria, 10
Freud: la cura del parlare e il Dialogo Analitico, 11
Moreno e lo Psicodramma, 14
La Terapia della Gestalt e il dialogo con la sedia vuota, 16
Rogers: comunicazione autentica, Terapia centrata sul Cliente, Gruppi d’Incontro, 17
Lewin: dialogo nei gruppi e T-Group, 18
I Gruppi Balint e le professioni d'aiuto, 19
Foulkes e la Gruppoanalisi: comunicazione e costituzione relazionale-dialogica del pensiero
in gruppo e di gruppo, 21
Bateson e il soggetto contestuale, 33
La conversazione tra esperti e la Terapia Sistemico-Relazionale, 34
Watzlawick e la pragmatica della comunicazione, 34
Il dialogo nella Terapia Strategica, 35
Cap. 2: Il Buio, 37
Cap. 3: Dialogo nel Buio, 52
Premessa, 52
Introduzione, 53
Attraversamento del buio, 55
Breve storia del progetto, 56
Dialogo nel buio: quando il lavoro s’incrocia con la vita, 63
Dal Libro Degli Ospiti, 67
Cap. 4: La Gruppoanalisi e “Dialogo nel Buio”.
Dinamiche e parallelismi, 78
Conclusioni, 109
Bibliografia, 111
Riferimenti bibliografici in Internet, 118
Riassunto
Questa tesi vuole mettere in relazione concetti apparentemente molto diversi tra loro come il
dialogo, il buio, il progetto di “Dialogo nel Buio”, la Gruppoanalisi e le dinamiche di gruppo
che si osservano al buio e nei gruppi analiticamente condotti, evidenziando analogie e
differenze.
Nell’introduzione sono brevemente esposti i motivi che mi hanno portata a realizzare
l’elaborato.
Nel primo capitolo, dunque, si delinea un excursus storico sul concetto di dialogo. In
particolare, se ne approfondiscono l’uso e il significato che filosofi e psicologi, di
orientamenti differenti, ne fanno, con un'estesa sezione riguardante la Gruppoanalisi.
Nel secondo capitolo, si prende in considerazione il concetto di buio, argomento generalmente
poco affrontato, dando un breve sguardo a tutti i campi nei quali, realisticamente o
metaforicamente, si può ritrovare: alcuni, ad esempio, sono la letteratura, la mitologia, il
cinema, il teatro, la Psicoanalisi.
Il terzo capitolo è interamente dedicato al progetto di “Dialogo nel Buio”: se ne delineano una
breve storia, i suoi obiettivi, l’impatto che questa originale esperienza ha su guide e visitatori.
Sono riportate testimonianze personali.
L’ultimo capitolo, infine, rintraccia quegli aspetti della Gruppoanalisi che si possono
osservare anche a “Dialogo nel Buio”. Ognuno di essi è affrontato in modo teorico e pratico,
portando esempi concreti ed episodi realmente vissuti.
Nelle conclusioni sono delineate quelle che, a mio avviso, sono le potenzialità del progetto
che ancora non hanno potuto essere sviluppate, ed inoltre, ciò che andrebbe migliorato, o,
almeno in parte, modificato.
V
Abstract
The aim of this thesis is to establish a relationship between concepts that are seemingly quite
different. Such concepts are: dialog, darkness, the “Dialog in the Dark” project, the concept of
Group Analysis and the group dynamics observed in the dark and in the groups that were
analytically conducted, highlighting both their similarities and differences.
The reasons that led me to work on this piece of writing are briefly discussed in the
introduction to this document.
Thus, the first chapter will provide a historical chronology regarding the concept of dialog.
More specifically, this chapter will elaborate on the usage and meaning that psychologists and
philosophers from different orientations give to the aforementioned concept. In this respect,
there will be an extensive section on Group Analysis.
The second chapter will focus on a concept that is rarely dealt with. Namely, the dark. We
will take a brief look at all the fields in which the dark can be perceived, either realistically or
metaphorically. Some of these fields include literature, mythology, filmmaking, theater and
Psychoanalysis.
The third chapter will focus entirely on the project called “Dialog in the Dark”. A brief history
of the project will be outlined, along with its goals and the impact it has left on both guides
and visitors. Personal accounts from people who have attended the project will be included.
Finally, the last chapter will look at the Group Analysis aspects that can be observed at
“Dialog in the Dark”. Each of these aspects will be treated from both a theoretical and
practical perspective. Real life stories and concrete examples will be given, too.
In the conclusion to this writing I will outline the capabilities of the project that, in my
opinion, have not been fully developed. I will also look at the areas that should be improved,
or at least partially modified.
VI
Ringraziamenti
Sono tante le persone che vorrei ringraziare.
In primo luogo la mia relatrice, dott.ssa Corbella, per aver accettato di trattare con me
quest’originale argomento di tesi. Ha rischiato, dal momento che non conosceva nulla a
proposito del “Dialogo nel buio”; ha voluto comunque sperimentarlo in prima persona, così
da capirlo a fondo e aiutarmi nel modo migliore.
In secondo luogo tutto lo staff di “Dialogo nel buio”, in particolare la dott.ssa Laura Gorni,
che mi ha permesso di entrare a far parte di questo fantastico e interessante progetto a Palazzo
Reale, e poi l’Istituto dei Ciechi di Milano, per avermi dato l’opportunità di collaborare anche
alla seconda edizione milanese.
I colleghi vedenti e non vedenti, e i visitatori: grazie a tutti loro sono riuscita ad avere così
tanto materiale da poter scrivere un elaborato di questo tipo.
Poi, tutti gli altri.
I miei genitori, increduli del fatto che abbia impiegato solo due anni a finire la laurea
specialistica. E posso capirli! Quella di primo livello è durata cinque anni, come dar loro
torto? Grazie per essermi sempre vicini, aiutarmi in tutto, confidare in me e darmi sempre il
meglio che potete.
Tutti gli amici, dai quali mi sono temporaneamente un po’ staccata, ma che, nonostante
questo, mi vogliono bene e mi sono vicini con i pensieri e l’energia positiva. Tornerò presto
tra voi!
La mia psicologa, dott.ssa Faretta, che mi segue da ormai sei anni, e che mi ha aiutata ad
essere quella che sono oggi, certamente più matura e completa di qualche anno fa. Spero di
poter continuare a sentirla vicina come oggi, e di poter, un giorno, diventare sua collega.
Maria Teresa, la mia naturopata, che massaggia il mio corpo, cura la mia anima ed elimina gli
ostacoli emotivi che, a tratti, mi impediscono di camminare nel modo più sereno possibile.
VII
Il mio amico messicano Joaquín. Sei stato davvero gentile ad aiutarmi a tradurre in inglese il
riassunto di questo elaborato, ed in italiano uno stralcio di un’enciclopedia spagnola,
contributo prezioso per la parte filosofica.
Infine, ma non di certo per importanza, Elisa. Ci siamo conosciute a giugno e abbiamo vissuto
insieme quasi sei mesi a contatto ogni giorno, leggendo, studiando, scandagliando la rete alla
ricerca di materiale, correggendo e realizzando quello che, a mio giudizio, è davvero un
capolavoro! Grazie dell’energia, della pazienza, della disponibilità, dell’amicizia, della
volontà e dell’impegno che ci hai messo. Mi hai spronata, giorno dopo giorno, standomi
sempre a fianco e facendo diventare tutto il lavoro molto più leggero e divertente.
VIII
Introduzione
Il dialogo, il buio e la gruppoanalisi: un incontro tra teoria,
vita, pratica ed esperienza.
In questa introduzione, cercherò di spiegare per quale motivo, in una sola frase, sono stati
riuniti concetti così diversi come dialogo, buio, gruppoanalisi, teoria, pratica, vita ed
esperienza.
Partiamo dal principio e, cioè, dal fatto che sono una ragazza non vedente che si sta laureando
in psicologia.
Da quando sono nata ho sempre vissuto senza vista; qualcuno potrebbe dire “al buio”. Come
credo sappiano tutti, è difficile per i disabili di qualsiasi tipo inserirsi nella società dei
“normodotati”, a causa della presenza di molteplici barriere, architettoniche e mentali. Per
esempio, i mezzi pubblici non sono attrezzati in modo da permettere a chi non vede di
spostarsi in piena autonomia da un luogo all’altro; molte professioni ci sono precluse, più
spesso a causa dell’ottusità o dell’ignoranza dei più che per mancanza reale di capacità.
Inoltre dobbiamo fare i conti coi limiti oggettivi che il vivere da disabili inevitabilmente
comporta. Ma tutto questo non mi ha mai fatto perdere la voglia di vivere. Anzi.
Fin da ragazzina, ho sempre avuto la grande passione di ascoltare i piccoli e grandi problemi
di amici e amiche. Questo mio interesse ha avuto il suo naturale sbocco nel liceo
sociopsicopedagogico prima, e nella facoltà di psicologia poi. Finalmente, dopo molto
cercare, ho inserito nel mio piano di studi un esame sulle dinamiche di gruppo che, dopo
ormai 3 anni di università e una laurea di primo livello alle spalle, non ero ancora riuscita ad
incontrare.
Parallelamente, grazie ad un caro amico, nel 2002 sono venuta a conoscenza dell’esistenza di
“Dialogo nel buio”, “Mostra che non mostra”, nella quale chi non vede ha il ruolo di
protagonista. Titubante, ho accettato la sfida di diventare, anch’io, una guida a questo evento
culturale mondiale, con la speranza di poter far capire ai “normali” un po’ di più
sull’esplorazione del mondo con modalità diverse da quelle usuali. Senza dubbio, questa
nuova realtà ha accolto molti disabili visivi, che hanno così potuto svolgere più facilmente
una professione diversa da quelle classiche, cioè centralinista o fisioterapista. Qui non c’era
di certo il rischio di essere discriminati od ostacolati: al contrario! Questa esperienza, per me,
IX
non è stata solo lavorativa, ma un’occasione per capire tante cose di me stessa e, non ultimo,
per rafforzare la mia fragile autostima.
Col passare del tempo, la mia esperienza nel condurre i gruppi al buio aumentava e, sempre
più, mi rendevo conto dell’enorme potenziale di questa realtà, ma sono riuscita a diventarne
pienamente consapevole solo quando ho preparato l’esame relativo alla gruppoanalisi.
Ed ecco nascere l’idea per la mia tesi di laurea magistrale: far conoscere all’ambiente
accademico una realtà così arricchente, importante e con grandi potenzialità.
Spero che questo mio scritto possa essere un’occasione di dialogo e crescita per il maggior
numero possibile di persone: docenti, ricercatori, studenti e chiunque abbia voglia di
interessarsi alle tematiche qui trattate.
X
Capitolo 1
Il Dialogo
Il termine dialogo (dal greco dià, "attraverso" e logos, "discorso") indica il confronto verbale
tra due o più persone, una forma espressiva molto appropriata alla discussione di idee ed
all’espressione dei propri sentimenti. Come pratica sociale, modello ideologico e forma
letteraria, il dialogo appare caratteristico di società a larga facilità di comunicazione. Al tempo
stesso, il dialogo è forma espressiva funzionale a culture prevalentemente orali, e la sua stessa
utilizzazione come scrittura è una traccia manifesta di una situazione di oralità. In generale, il
dialogo è fenomeno tipico della cultura cittadina; in questa prospettiva si contrappone al
racconto monologo, prodotto di culture di tipo contadino-popolare o comunque a sociologia
poco sviluppata; il monologo, infatti, a differenza del dialogo, si presenta come il discorso di
una persona con se stessa, o con ascoltatori, anche immaginari, dai quali non aspetta risposta.
Cenni storico-filosofici
Nella Grecia antica, l'affermarsi della pratica del dialogo è favorita dalla particolare forma
sociale della comunità (polis), dall'esistenza di strutture come la piazza (agorà), o di luoghi di
scambio sociale più ristretto, come il convito aristocratico.
Presente già come elemento "mimetico" nell'epos (poema epico), il dialogo è un momento
essenziale nella genesi del dramma attico, e ha il suo luogo privilegiato, in età classica, nella
tragedia e nella commedia, dove costituisce lo strumento essenziale della mediazione scenica
dell'azione e della dialettica dei personaggi.
Protagora per primo, sofista presocratico del 400 a.C. - "l'uomo è la misura di tutte le cose" aveva inventato l'arte del dialogo per persuadere l'interlocutore della propria tesi, guidandolo
a scoprire le alternative attraverso domande sapientemente proposte.
Il dialogo verrà poi elevato a forma letteraria prosastica da Platone, che muove dall'esperienza
della pratica della conversazione socratica. Nel 387 a.C., egli è ad Atene; acquistato un parco
dedicato ad Academo, vi fonda una scuola che intitola Accademia, in onore dell'eroe, e la
consacra ad Apollo e alle Muse. Sull'esempio opposto a quello della scuola fondata da
Isocrate nel 391 a.C., e basata sull'insegnamento della retorica, la scuola di Platone ha le sue
radici nella scienza e nel metodo da quella derivato, la dialettica; per questo motivo,
l'insegnamento si svolge attraverso dibattiti, cui partecipano gli stessi allievi, diretti da Platone
o dagli studenti più anziani, e conferenze tenute da illustri personaggi di passaggio ad Atene.
E’ importante sottolineare come vi fossero, proprio in quegli anni, tutte le condizioni per la
particolare scelta stilistica del dialogo come forma espositiva: da una parte la sempre più vasta
popolarità e fortuna della tragedia e della commedia, dall'altra, il dialogare dei Sofisti e di
Socrate. È oggi ipotesi corrente che Platone abbia iniziato a scrivere i suoi Dialoghi già
durante gli otto anni in cui visse accanto a Socrate.
Se non è dunque possibile sostenere che Platone sia stato il creatore del dialogo come genere
letterario, è però verosimile che egli abbia colto la comune abitudine al dialogare e al porre
quesiti, iniziando a stendere dapprima semplici questionari senza personaggi, e affidando poi,
in una seconda fase, alla figura di Socrate, la funzione di protagonista di opere più strutturate
e complesse. A partire dal 395 a.C. Platone dovrebbe aver iniziato a scrivere i primi dialoghi,
nei quali affronta il problema culturale rappresentato dalla figura di Socrate, e la funzione dei
sofisti.
In particolare, il metodo socratico è un metodo dialettico d’indagine filosofica basato sul
dialogo, e descritto per la prima volta proprio da Platone nei suoi Dialoghi. Per la sua
intrinseca natura, è anche chiamato metodo “maieutico”. Il termine maieutica viene dal greco
maieutiké (sottinteso: téchne), e letteralmente, sta per "l'arte della levatrice" (o dell'ostetricia),
ma l'espressione comunemente designa il metodo socratico così come è esposto da Platone nel
“Teeteto”. L'arte dialettica, infatti, veniva paragonata da Socrate a quella della levatrice: come
quest'ultima, il filosofo di Atene intendeva "tirar fuori" all'allievo pensieri assolutamente
personali, al contrario di quanti volevano imporre le proprie vedute agli altri con la retorica e
l'arte della persuasione (Socrate, e attraverso di lui Platone, si riferiscono in questo senso ai
Sofisti).
Parte integrante di questo metodo è il ricorso a battute e domande brevi e taglienti, in
opposizione ai lunghi discorsi degli altri, ovvero la brachilogia, e la rinomata ironia socratica.
Quest’ultima consiste, storicamente, nella pretesa del filosofo Socrate di mostrarsi ignorante
in merito ad ogni questione da affrontare, il che costringe l'interlocutore a giustificare fin nei
minimi dettagli la propria posizione, finendo, poi, sovente per rilevarne l'infondatezza, le
contraddizioni interne ed il carattere di mera opinione. Ciò, coerentemente con il metodo
socratico, che conduce l'interlocutore a trovare da solo le risposte alle proprie domande,
piuttosto che affidarsi ad un’autorità intellettuale in grado di offrire risposte preconfezionate.
La parola greca eirōneía si riferisce appunto ad una tale dissimulazione, che Socrate eleva a
2
metodo dialettico; essa implica l'assunzione di una posizione scettica, un atteggiamento di
rifiuto del dogma e di ogni convinzione che non basi la sua validità sulla ragione. Socrate
quindi, conducendo per mano l’interlocutore, lo porta a dichiarare la propria ignoranza, a
riconoscere, cioè l'impossibilità di avere verità definitive. Il dialogo socratico ha un profondo
valore morale basato sul rispetto dell'interlocutore.
Per Aristotele, invece, la dialettica è la tecnica con la quale uscire vittoriosi da una
discussione, e questo successo deriva dal prevalere con la propria tesi su quella sostenuta
dall'avversario, nel rispetto di premesse su cui ci si è messi d'accordo prima dell'inizio del
confronto: difatti, la confutazione, e quindi la vittoria, si basa sul portare l'interlocutore ad
autocontraddirsi, mostrando come la sua tesi, se sviluppata, porta a risultati illogici rispetto
alle premesse iniziali, considerate vere da entrambi. Certo era necessario che queste fossero
considerate vere anche dal pubblico che assisteva al confronto, per poter influenzare, con la
propria vittoria, anche l'opinione altrui; pertanto non di rado si sceglieva di accordarsi su
premesse che fossero ritenute vere dai membri più influenti della società.
La tecnica dialettica necessitava di un'ottima conoscenza delle parole, dei modi di unirle in
proposizioni e in periodi, aspetti particolarmente approfonditi dal filosofo, che è anche stato il
primo ad analizzare il sillogismo, un particolare tipo di ragionamento dimostrativo di cui
faceva largo uso, ritenendolo centrale nell’ambito della logica. Egli si sofferma anche sulla
spiegazione dell'esistenza di parole univoche ed equivoche, ovvero con uno o più significati:
deve essere la loro conoscenza accurata il primo necessario requisito per il buon dialettico.
Il dialogo di tipo filosofico-letterario conosce poi una nuova fortuna in età romana, con Dione
Crisostomo, Plutarco, e soprattutto Luciano di Samosata.
Nella letteratura latina, esso vive nella satira drammatica delle origini, e diventa proprio della
filosofia con Cicerone, il più celebre oratore dell'antica Roma. Egli si ispirò al modello di
Platone, benché nelle sue opere manchi del tutto la mimesi drammatica, e la finzione dialogica
sia appena accennata; tuttavia, è per contro assai viva la partecipazione personale dell'autore.
Cicerone ha pubblicato da sé la maggior parte dei suoi discorsi; 58 orazioni; i testi si possono
dividere grossomodo tra orazioni pronunciate di fronte al Senato o al popolo, ed arringhe
pronunciate in qualità di - utilizzando termini moderni - avvocato difensore o pubblica accusa,
nonostante anche questi ultimi abbiano spesso un forte substrato politico. Il suo successo è
dovuto alla sua abilità argomentatoria e stilistica, che sa adattare perfettamente all'oggetto
dell'orazione e al pubblico, appoggiando appropriatamente diverse scuole filosofiche o
politiche al fine di convincere i contrari e raggiungere il proprio scopo.
I “Dialogi” di Seneca invece, a dispetto di tale denominazione (di certo molto antica perché
già utilizzata da Quintiliano), non sono veri e propri dialoghi, poiché il filosofo costituisce la
3
voce narrante in prima persona, senza che nella trattazione vi siano interventi diretti né di
sostenitori né di contraddittori delle tesi esposte; l'unica eccezione è rappresentata dal “De
tranquillitate animi”, in cui Seneca immagina un colloquio fra sé e l'amico Sereno.
Il confronto con il precedente letterario latino di dialogo filosofico, esemplificato dalle
“Ciceroniane tusculanae disputationes”, rende subito evidente la differenza tra la forma
dialogica pienamente rispettata dall'illustre predecessore, e la forma adottata da Seneca,
diversa perché diverso era il modello greco di trattazione filosofica cui Seneca si rifaceva.
Infatti, la classica forma dialogica presente in Platone era andata via via disseccandosi,
riducendosi in molte trattazioni filosofiche ad accenni ad un avversario ipotetico con
espressioni fisse quali «qualcuno dirà», «tu dici», «tu dirai», dopo cui, di solito, si esponeva in
breve e in modo più vivace, grazie all’artificio retorico del finto contraddittore, una tesi da
confutare. Questa forma riduttiva e schematizzata di dialogo troverà la sua espressione più
efficace nella diatribé cinico-stoica, sorta di predica o, più pacatamente, di conferenza
popolare, rivolta ad un largo pubblico inesperto di filosofia, in cui alla trattazione sistematica
d’un tema o di un problema filosofico-morale si sostituiva l’esortazione e l’invito ad accettare
o abbandonare certi comportamenti, che la sommaria dimostrazione di quel tema indicava
come buoni o come cattivi. Erano pertanto opere brevi, sciolte, e libere da una disposizione
rigorosa degli argomenti, opere vivaci, e addirittura, nei cinici soprattutto, violente
nell’esposizione del tema, che deliberatamente, piuttosto che alla ragione degli ascoltatori, si
rivolgevano di preferenza al sentimento, facendo appello alla natura umana, predisposta a
seguire presumibilmente il bene e a fuggire il male, con ampio spazio dedicato agli esempi da
seguire o da fuggire tratti dalla storia e dalla vita di uomini famosi.
Va aggiunto peraltro che questo stile filosofico greco di epoca post-classica incontrava
singolarmente quello tipico delle declamazioni retoriche dell'età imperiale, fino a Nerone, le
quali, abbandonata la concinnitas ciceroniana della perfetta disposizione degli argomenti e
dell’esatto equilibrio degli ampi periodi, preferiva invece una più libera disposizione degli
argomenti per associazione d’idee o d’immagini, e periodi più brevi e distaccati tra loro, dove
il chiaroscuro delle singole frasi che si susseguivano trovava la sua conclusione nella
sententia, la concisa e sentenziosa frase finale che illuminava e metteva in rilievo il concetto
principale da ritenere.
Ora non c'è dubbio che i Dialoghi di Seneca risentano fortemente di questa forma espositiva
della filosofia greca di mezzo – cioè dopo il periodo classico di Socrate, Platone e Aristotele –
e che molti dei dialoghi senecani siano delle διατριβή adattate a un pubblico e ad interlocutori
romani. Del resto, i circoli filosofici che Seneca frequentò da giovane coltivavano, nella loro
accentuazione dei problemi morali, soprattutto questo genere di trattazione filosofica, e spesso
4
in forma direttamente orale, come si addice ad una predica appunto. Il termine greco διατριβή,
però, si acclimerà a Roma nella traslitterazione latina di diatrĭba solo più tardi, e fu Seneca
stesso, probabilmente, a dare a queste sue opere il nobile termine di Dialoghi.
Del resto, l’uso e l’adattamento che Seneca ne fa comportano varie differenze rispetto alla
διατριβή greca: intanto egli utilizza come interlocutori reali, e non ipotetici, persone della sua
cerchia (in questo similmente alle lettere epicuree), per cui, oltre che esortarli, può cercare
sostegno e appoggio alle sue tesi morali, che spesso adombrano la giustificazione filosofica di
precisi comportamenti pubblici che il filosofo teneva in quel torno di tempo. Un po’ diverse,
avendo caratteristiche proprie, sono le tre “Consolationes”, che mantengono però la forma
schematica di dialogo nel rivolgersi alla persona che si cerca di consolare e confortare nel
dolore, e lo scopo principale d’esortazione ad abbandonare un certo comportamento
falsamente morale per un altro moralmente corretto.
La fortuna del dialogo non viene meno nei primi secoli del Cristianesimo. In quei tempi di
ardente proselitismo e di fervore apologetico di chiarificazione dottrinale, il dialogo doveva
riuscire la forma filosofico-letteraria più conveniente: abbiamo così una produzione di
dialoghi sia in latino, come "L'Octavius" di Minucio Felice, di evidente stampo ciceroniano,
sia in greco, come "Il Dialogo col Giudeo Trifone" di Giustino.
Si tratta di opere quasi tutte rivolte a suscitare la conversione degli infedeli, pagani o eretici,
ma non ne mancano altre di carattere più dottrinale, come i Dialoghi di Sant'Agostino, o "il
Simposio" di Metodio di Olimpo; le “Confessiones” di S. Agostino, ad esempio, sono un
lungo discorso che l’autore intrattiene con Dio. Il Santo, senz’altro anche a causa
dell'ammirazione verso Platone, da al dialogo grande importanza, concependo la vita
dell'anima come un dialogare con se stessa e con la verità, e fondando l’umano porsi in
relazione sulla somiglianza con la divinità, poiché sia la generazione che la processione divina
nella Trinità non sono altro che un dialogo, in cui Dio si conosce nel Verbo, e si ama nello
Spirito Santo (De Trinitate, IX, 7 , XV,14. Cit. in Gutiérrez, 1991).
Nella filosofia moderna il dialogo riveste un ruolo di rillievo soprattutto nella corrente di
pensiero detta appunto filosofia del dialogo, dove esso non è inteso solo e innanzitutto come
metodo euristico e critico, ma piuttosto come la condizione fondante persone autoconsapevoli,
capaci di conoscere sé stesse e il mondo. Spunti in tal senso si trovano nella filosofia tedesca
tra il XVIII e il XIX secolo, in J.G. Hamman, F.H. Jacobi, J.G. Fichte, Won Fon Humboldt, e
più tardi in L. Feuerbach.
Tuttavia, la filosofia del dialogo in senso stretto si è afferma dopo la fine della prima guerra
mondiale, ed è legata ai nomi di F. Ebner, F. Rosenzweig, M. Buber e G. Marcel, fra le cui vie
di pensiero, largamente indipendenti, si possono però distinguere due posizioni principali.
5
Secondo la prima, è solo nella relazione dialogica che l’individuo diventa realmente un sé,
una persona; secondo l’altra, più radicale, non si dà alcun Io, alcun individuo, fuorché nella
relazione: solo nel rapporto dialogico emerge l’Io, negando così, da parte di questi autori, la
priorità ontologica della coscienza, e assumendo invece come presupposto il fatto che solo
grazie al confronto con un Tu, l’individuo possa parlare come un Io.
Tali filosofie si presentano quindi contrarie alla tradizione monologica, in particolare alla
filosofia trascendentale, secondo cui l’altro andrebbe inteso a partire dall’Io, cioè solo come
un altro Io, o un Io estraneo.
Il pensiero epistemologico, per citare Binswanger (1955), ha quindi spostato l’attenzione
dall’homo natura all’homo persona, essendo ormai chiaro che il soggetto umano non può più
essere esaurito attraverso concetti riduttivi e solipsistici come "uomo", o peggio ancora,
"mente".
Sergio Moravia (1986) evidenzia come l’homo persona non è soltanto un essere, ma anche
una tensione verso un altro da sé; un essere nel mondo non solipsistico, ma dialogicamente
legato al suo ambiente, inteso come dimensione costitutiva del sé, prima ancora che come
spazio fisico-relazionale esterno.
Un ruolo fondamentale assume a questo punto il linguaggio; il rapporto dialogico fondante
sussiste infatti nel linguaggio, e attraverso esso. «Il linguaggio è dialogo»: con
quest’espressione, possiamo esprimere il nucleo della filosofia di Gadamer. Il famoso verso di
Hölderlin, “Da quando siamo un dialogo...”, viene interpretato da Gadamer in un senso
radicale. Non solo noi siamo già sempre nel dialogo, e parliamo da quel flusso infinito; di più:
noi siamo dialogo, esso è l'universo ermeneutico in cui respiriamo. Il parlare è sempre parlare
con gli altri, è cioè articolare la comunanza del mondo che è dato nella lingua comune.
Gadamer, rifacendosi esplicitamente a Heidegger, assegna all’ermeneutica il compito di
chiarire la struttura della comprensione, intesa non come semplice operazione conoscitiva
finalizzata a penetrare il senso di un testo, ma come quella "esperienza" e quel "sapere" che
connotano in generale l’esistenza umana, nel suo essere nel mondo e nella storia.
Secondo la regola ermeneutica, che origina nell’antica retorica, la totalità va compresa alla
luce del particolare, e il particolare in base alla totalità. L’ermeneutica contemporanea ha
trasportato questa regola dall’arte del discorso al campo ancor più ampio della comprensione
stessa, e quindi al rapporto con la conoscenza, col mondo e con l’altro da sé. Lungi dall’essere
una tabula rasa, la mente dell’uomo è abitata da una serie di attese o di schemi di senso,
ovvero da una molteplicità di "linee orientative provvisorie": ciò che si deve comprendere è
già in parte compreso. E non si deve credere che questa pre-comprensione, basata sul rapporto
circolare di significato esistente tra il tutto e le sue parti, implichi di per se uno stato di pre6
giudizio: si tratta piuttosto di un’anticipazione di senso che è il presupposto di base
dell’azione conoscitiva (Gadamer, 1952).
Questa scoperta Gadamer la attribuisce a Heidegger, che avrebbe avuto il merito di
riconoscere questo circolo ermeneutico e di non considerarlo vizioso, bensì appunto come una
parte positiva del conoscere. Anzi, Heidegger ci avrebbe fatto capire come il problema non sia
quello di sbarazzarsi del circolo, ma di acquistare coscienza di esso, mettendo "alla prova" i
pregiudizi che possono derivarne, e mostrandosi disposti a rinnovare le proprie
presupposizioni.
Ma in Gadamer, il dialogo che fonda la conoscenza non è il luogo dello scambio di idee già
formate; piuttosto, è il comune pensare che si sviluppa nel comune parlare. La disponibilità
illimitata al dialogo è perciò motivata dalla fiducia riposta nel linguaggio e nella sua capacità
di accomunare. Per ricercare un accordo occorre continuare a parlare, ma l'accordo non è mai
garantito. La comprensione non è appropriazione dell'altro. E l'ermeneutica ha mostrato che
ogni comprendere è sempre anche un non-comprendere.
Come non scontrarsi nei limiti di tutto quello che si vorrebbe dire, e non si riesce a dire, di
tutto quello che si vorrebbe comprendere, e non si riesce a comprendere? Per questo il dialogo
non può mai pienamente riuscire. Per questo il dialogo, sia quello tra un io e un tu, sia quello
interiore, tra l'io e il tu dell'anima, dovrà essere infinito. A questo proposito Derrida parla di
“supplementazione” (Derrida, 1967), facendo riferimento alla presenza di un quid di
irriducibilmente inconoscibile in noi stessi e negli altri che, mentre ci limita, al contempo, ci
“apre verso l'infinito”, in una stimolante e continua tensione relazionale.
Anche secondo Martin Buber, l'essere umano è per essenza dialogo, e non si realizza senza
comunicare con l'umanità, la creazione, nonché il Creatore. In questo autore, il dialogo ha una
forte dimensione religiosa, oltre che umana e filosofica. Infatti l'uomo, a suo avviso, è anche,
necessariamente, homo religiosus, perché l'amore dell'umanità conduce all'amore di Dio e
viceversa, ed è quindi impensabile parlare agli uomini senza parlare a Dio. Questo dialogo
avviene secondo un rapporto di reciprocità, poiché anche la Presenza divina partecipa ad ogni
incontro autentico tra gli esseri umani, e abita in quelli che realizzano il vero dialogo. Il
dialogo riposa sulla reciprocità e sulla responsabilità, che esiste unicamente là dove vi è una
vera risposta all’altro. Dialogare con l'altro significa affrontare la sua realtà e farsene carico
nella vita vissuta. Anche il dialogo con Dio non avviene differentemente, la Sua "parola" è
una presenza reale, alla quale occorre rispondere: la Bibbia testimonia questo dialogo tra il
Creatore e le sue creature, e Dio ascolta l'uomo che addita coloro sui quali la collera divina
deve abbattersi, o supplica il suo Creatore di manifestare la Sua provvidenza.
7
Nella sua opera più celebre (1923), Martin Buber sottolinea la propensione duplice verso il
mondo: la relazione Io-Tu e la relazione Io-ciò. Né l’Io, né il Tu vivono separatamente, ma
essi esistono nel contesto Io-Tu, antecedente la sfera dell’Io e la sfera del Tu. In modo simile,
né l’Io né il ciò esistono separatamente, ma esistono unicamente nel contesto Io-ciò. La
relazione Io-Tu è assoluta solo rispetto a Dio - il Tu eterno - e non può essere pienamente
realizzata negli altri domini dell’esistenza, comprese le relazioni umane, dove sovente Io-Tu
fa posto all’Io-ciò (Io-Tu o Io-ciò non dipendono dalla natura dell’oggetto, ma dal rapporto
che il soggetto istituisce con l’oggetto).
La realtà soggettiva dell’Io-Tu si radica nel dialogo, mentre il rapporto strumentale Io-ciò si
realizza nel monologo, che trasforma il mondo e l’essere umano stesso in oggetto. Nel piano
del monologo l’altro è reificato - è percepito e utilizzato - diversamente dal piano del dialogo,
dove è incontrato, riconosciuto e nominato come essere singolare. Per qualificare il monologo
Buber parla di Erfahrung (un’esperienza “superficiale” degli attributi esteriori dell’altro) o di
Erlebnis (un’esperienza interiore insignificante) che si oppone al Beziehung - la relazione
autentica che interviene tra due esseri umani. L’essere umano non può quindi trasfigurarsi ed
accedere a una dimensione di vita autentica senza entrare nella relazione Io-Tu, confermando
così l’alterità dell’altro, che comporta un impegno totale: “La prima parola Io-Tu non può
essere detta se non dall’essere tutto intero, mentre invece la parola Io-ciò non può mai essere
detta con tutto l’essere”. Io e Tu sono due esseri sovrani, e l’uno non dovrebbe cercare di
condizionare l’altro né di utilizzarlo. Secondo Buber, comunque, l’uomo può anche vivere
senza dialogo, però chi non ha mai incontrato un Tu non è pienamente un essere umano.
Tuttavia, al contempo, chi si addentra nell’universo del dialogo assume un rischio
considerevole, dal momento che la relazione Io-Tu esige un’apertura totale dell’Io,
esponendosi quindi anche al rischio del rifiuto e al rigetto totale.
La scoperta post-moderna del cosiddetto “dialogo dialogale", nota Gianangelo Palo,
rappresenta un’importante mutazione culturale. Il dialogo non vuole essere un "duo-logoi" ma
un "dia-logos". Il vero dialogo, la vera comunicazione, non è uno strumento della dialettica,
ma nemmeno un aiuto che viene da un altro, dall'esterno, per fortificare l’introspezione. “Non
è il rafforzamento del monologo, per il fatto che quattro occhi vedono meglio di due, non più
solo un nesso per conoscere l'altro o il suo punto di vista, ma piuttosto una novità, una
prospettiva diversa”. Questa prospettiva riconosce che l'altro non è solo un aiuto esterno e
accidentale, ma è indispensabile alla ricerca della verità, perché l’io non è più autartico,
autosufficiente, autonomo. “Il dialogo è la mia apertura all'altro affinché mi dica e mi sveli il
mio mito, quello che non posso conoscere da solo, quello che io considero come ovvio. E’
una maniera di conoscermi e di scoprire il mio punto di vista a partire da un’interiorità più
8
profonda, che restava nascosta in me, e che l'altro risveglia attraverso il suo incontro con me”
(Palo, 1999).
Il dialogo va alla ricerca della verità dando confidenza all'altro, mentre la dialettica va alla
ricerca della verità credendo nell'ordine delle cose, nel valore della ragione. Essa crede che ci
si può avvicinare alla verità appoggiandosi sulla consistenza obiettiva delle idee, mentre il
“dialogale” crede che si può avanzare sul cammino della verità appoggiandosi sulla
consistenza soggettiva dei dialoganti. “La dialettica è l'ottimismo della ragione. Il dialogo è
l'ottimismo del cuore” (Palo, 1999).
Attualmente, la riflessione sul dialogo, ed il dialogo stesso, appaiono sempre più importanti
alla luce delle particolari dinamiche socioeconomiche che caratterizzano il nostro periodo
storico. Siamo orfani da tempo di quell’ottimismo umanistico, di stampo classicorinascimentale ed illuminista, che sembrava prometterci certezza e fiducia in un legame e una
base di uguaglianza tra gli uomini, capace di dissipare pregiudizi e conflitti grazie al comune
possesso della ragione; le due terribili guerre mondiali, nonché il persistere di conflitti barbari
e fratricidi e l’incalzare di sanguinosi attacchi terroristici, e le più fredde e asettiche “guerre”
giocate sul piano economico, del controllo e del potere, hanno reso imprescindibile l’esigenza
di dare spazio di ascolto e pensabilità anche a passioni ed emozioni, esigenza peraltro
sottolineata da più di un secolo di psicoanalisi.
Del resto, viviamo in un mondo in cui i sentimenti di insicurezza, di precarietà e di crisi, di
impotenza e disgregazione tendono a imporsi fortemente attraverso un particolare senso di
disagio e sofferenza, sebbene la tentazione della fuga e della negazione siano sempre presenti,
favorite da un mercato del divertimento e dell’evasione, e del consumo ed intrattenimento
passivi. L’individualismo, assunto ormai a stile di vita, rende particolarmente complesso e
difficile trovare un equilibrio fra legami ed emancipazione. Come nota Silvia Corbella, “per
salvare la propria integrità individuale nel contesto iperveloce dell’economia globale e del
capitalismo flessibile, se viene considerato ancora necessario entrare in contatto con le altre
persone, viene però posta una grande attenzione a non sviluppare attaccamenti profondi o
appartenenze troppo forti che creino legami che potrebbero far soffrire e al contempo
ostacolare la possibilità di sperimentare realtà sempre nuove e mutevoli”.
In tal modo, le basi stesse di un dialogo autentico appaiono minate, e la possibilità di
apprendere attraverso la relazione con altre persone e di apprendere dall’esperienza è sempre
più compromessa, e forse nemmeno ricercata, in quanto “si evita di pensare a come affrontare
i complessi pericoli che minacciano il singolo individuo e il mondo”.
Recuperare la dimensione dell’incontro, del dialogo, della comunicazione e dello scambio
autentico appare quindi quanto mai necessario ed urgente, in un mondo che sembra starsi
9
avviando verso nuove forme, sempre più complesse, di disumanizzazione. Bisogna riuscire a
pensare, e a parlare, di noi stessi, e degli altri, di ciò che ci circonda o che ci appare lontano,
di ciò che è, o che sembra essere, o che potrebbe essere. Poiché, come ricorda la Arendt, “il
mondo non è umano essendo stato fatto dagli uomini e non diventa umano perché la voce
degli uomini risuona in esso, ma solo quando è divenuto oggetto di dialogo” (1968).
E, se al concetto di mondo, accostiamo l’aggettivo “interno”, emerge forse ancor più
chiaramente quella forma di vera libertà che solo dal dialogo e dal confronto può scaturire.
“Quando la propria storia è divenuta oggetto di dialogo si può ridurre l’area del destino e si
può assumere la responsabilità del passato che ci permette anche di scegliere cosa ricordare,
cosa dimenticare e cosa perdonare.” (Corbella, 2006).
Nessuno oggi si sognerebbe di negare la primaria importanza del dialogo (il linguaggio,
affermava Heidegger, è la casa dell’essere) sia nelle interazioni umane in generale che nella
psicoterapia in particolare. Siamo tutti ben consapevoli del fatto che i linguaggi hanno un
preciso potere generativo di esperienze e di emozioni e che sono inevitabili. Tutto ciò che noi
percepiamo è trasformato in parole. L’intero processo della percezione è totalmente
mascherato dalla parola ed è inscindibile dal pensiero.
Del resto, si sa che la psicologia è figlia della filosofia, scienza antica della parola: la valenza
persuasiva del dialogo nasce da molto lontano, nell'antica Grecia e anche dai Saggi cinesi.
Antifonte e l’arte consolatoria
Sembra che il primo ad esercitare qualcosa di simile alla psicoterapia sia stato Antifonte di
Atene, sofista vissuto nella seconda metà del V sec. a.C., inventore di un'arte "consolatoria"
capace di esercitare un'influenza sul prossimo.
Egli fondava il suo stile di vita sulla liberazione dal dolore e dalla sofferenza, tanto da
rimproverare Socrate, qualificato come maestro di infelicità, ed aveva aperto a Corinto una
sorta di ambulatorio, forse il primo studio di psicoterapia, ove curava i mali fisici con le
parole. A questo scopo, in primo luogo faceva parlare il malato della sua sofferenza e lo
aiutava poi con un tipo di retorica che utilizzava, sia nella forma sia nel contenuto, le
asserzioni dello stesso malato, e che dunque, in senso del tutto moderno, si poneva al servizio
di una ristrutturazione di ciò che il malato riteneva “reale” o “vero”, e dunque del
cambiamento dell'immagine del mondo per la quale egli soffriva.
10
Nei secoli successivi, invece, prevalse il pensiero di Platone, secondo cui la sofferenza
emotiva andava affrontata e gestita in maniera direttiva ed assai "assertiva". Il dialogo
psicoterapeutico, in questo nuovo contesto, scivola in secondo piano, e vi rimarrà molto a
lungo, fino al diciannovesimo secolo ed a tempi ancora più recenti.
Freud: la cura del parlare e il Dialogo Analitico
L’importanza del Dialogo è sostenuta da Freud, il quale affermava che “in origine le parole
erano magiche”. Egli in questo modo voleva sopratutto sottolineare il potere della parola e del
dialogo tra l'analista e il suo paziente, come strumenti di conoscenza e di cambiamento. E’
noto come il padre della Psicoanalisi, che operava nel pieno dell’epoca vittoriana, fosse stato
impressionato dalla forza curativa dell’espressione delle emozioni rimosse, forza che ritenne
fin da subito più efficace del metodo allora in voga per curare i mali psichici, l’ipnosi. Era “la
cura con le parole”, come la definì una sua famosa paziente, che poneva le basi di ciò che
oggi conosciamo come Dialogo Analitico.
L'analista-narratore sa che, nel rielaborare il discorso altrui, fa qualcosa su di esso, gli presta
nuova vita, nuovo senso. Restituisce alla parola, secondo Freud, "almeno una parte della sua
primitiva forza magica". E' consapevole che le parole si sviluppano sulla base della matrice
originaria dell'azione, e sono esse stesse "azioni attenuate", costituendo "la via attraverso la
quale possiamo influire sul nostro prossimo".
Ma la Psicoanalisi, che ha un secolo di vita, ha affrontato solo in tempi relativamente recenti
la totalità del Dialogo Analitico come oggetto d'indagine. Deve esserci stata, quindi, al
riguardo, qualche difficoltà interna alla teoria psicoanalitica o al suo originario impianto
epistemologico.
La differenza che si presenta fra tanta parte della Psicoanalisi contemporanea e la posizione di
Freud è che il Dialogo Analitico attualmente è concepito “come incontro fra due persone che
s’impegnano in una relazione dalla quale si attendono sviluppi creativi". C'è evidentemente
attenzione verso entrambi i membri della coppia, impostazione che si differenzia da quella di
Freud secondo la quale l'analista "osserva il paziente e lo disvela a se stesso, combattendo a
volte strenuamente contro le sue difese e resistenze”. A causa della necessità epistemologica
di separare nettamente osservatore e osservato, analista e paziente, Freud è costretto in un
certo senso ad idealizzare il primo e a penalizzare il secondo.
In effetti, nell'analista viene riconosciuta la capacità di entrare in contatto con l'inconscio
dell'altro mediante il proprio inconscio, capacità favorita da un ascolto caratterizzato
11
dall'attenzione fluttuante, dal non farsi ostruire la mente da ipotesi preconcette. Per
comprendere l’altro, l'analista deve essere in grado di comprendere se medesimo, essere in
grado di ascoltarsi, costantemente costruendo e allargando le vie di comunicazione coi propri
preconscio e inconscio. Tuttavia, Freud non riconosce l’aspetto simmetrico della relazione
analitica, consistente nel fatto che, così come l'inconscio dell'analista è in contatto con quello
del paziente, anche l'inconscio del paziente è in contatto con quello dell'analista; costituirebbe
un problema il riconoscere che il paziente è "interprete dell'esperienza dell'analista", ed è per
evitarlo, che quest’ultimo deve cercare di rendersi il più “invisibile” possibile, sul piano
emotivo, per il paziente.
E’ di rilievo, comunque, l’intuizione freudiana, ancora embrionale, ma notevolissima per le
concezioni dell’epoca, sul costituirsi intersoggettivo dell'Io, che emerge in particolare
nell'assunto che l'empatia - ossia il contatto con l'inconscio dell'altro - sia all'origine dei
legami di appartenenza gruppale.
A questa capacità empatica, o di percepire l'altrui inconscio col proprio, è stato recentemente
dato un fondamento biologico, da un'équipe di neurobiologi italiani guidata dal prof.
Rizzolatti (2006). Si tratta della scoperta dei "neuroni specchio", che si trovano in una sezione
della corteccia pre-motoria. Quando vediamo qualcuno che compie un'azione, vi è in noi
un'attivazione dei circuiti neuronali motori che si attivano quando noi stessi attuiamo
quell’azione. Inoltre, è stato osservato che il sistema neurale senso-motorio e quello emotivo
sono fra di loro coordinati. Ad esempio, fenomeni "a specchio" avvengono anche nei neuroni
connessi al dolore (nella corteccia cingolata): gli stessi neuroni, infatti, si attivano sia se il
soggetto riceve uno stimolo doloroso sulla mano, sia se egli vede tale stimolo applicato sulla
mano dell'esaminatore. Viene in tal modo descritta una modalità pre-simbolica di
rappresentarsi l'azione dell'altro e di sintonizzarsi con essa: ci sintonizziamo con gli stati
mentali dell'altro prima di avere una "teoria della mente" riguardo ad essi.
Nel passaggio dalle sensazioni grezze alla messa in forma nel discorso, vi è una
trasformazione resa possibile dal materiale linguistico circolante nel dialogo attuale, ma anche
dal contesto di tutta la tradizione personale precedente. In questo senso le parole non
costituiscono mai un elemento neutrale rispetto al contenuto cui si riferiscono, bensì
rappresentano un atto linguistico, un fare cose con le parole. Questo modo di intendere
l'efficacia operativa del linguaggio è particolarmente vero quando il linguaggio è riferito agli
stati mentali: le parole, gli schemi, i modelli teorici e ideologici con cui la realtà psichica
viene definita, influenzano gli stati del cervello, la regolazione emotiva, il senso di sé con gli
altri, i piani comportamentali. Analogamente, chi ascolta non è un ricettacolo passivo: ogni
comprensione è attiva ed è l'embrione di una risposta. Su ogni parola che comprendiamo è
12
come se depositassimo una serie di nostre parole di risposta. Ogni comprensione è dialogica.
Secondo la concezione del linguaggio introdotta nell'Ottocento da Humboldt, e che ha una
lunga storia che, passando per Vygotskij e Bachtin, arriva fino alla semiotica contemporanea,
nel linguaggio (di un'epoca, di un contesto culturale) è depositato un modello del mondo, e
chi lo assimila s’immerge in un modo di vedere e di pensare il mondo. Tale modello di mondo
è costruito in una moltitudine di dialoghi intersoggettivi.
Attualmente, è quindi chiaro che l'interpretazione non riproduce, come una copia, una realtà
preesistente nel paziente. L'inconscio si riconosce nella relazione analitica attraverso
operazioni che mettono in rapporto i dati osservativi con processi di natura ipotetica, e, come
nota Bordi (1998), oggi viene concepito soprattutto in modo dinamico, piuttosto che topico.
Non più crogiolo di passioni, ma “organizzazione che riflette i primi percorsi dello stare al
mondo, comprese le esperienze interattive e identificatorie strutturanti un mondo interno che
canalizza desideri, fantasie e pensieri che, proiettati poi all'esterno, costituiscono le esperienze
successive”. Il focus è quindi sugli aspetti rappresentazionali del sé, dell'altro e del sé in
interazione con l'altro, e la risposta dell'analista al paziente è un’interpretazione psicoanalitica
se ha il potere di organizzare in modo coerente, anche se provvisorio, il quadro del complesso
materiale percettivo, emotivo e cognitivo che si è andato accumulando.
Nella coppia analista-paziente (come nella coppia madre-bambino) può esserci, certo, una
profonda sintonizzazione, un campo percettivo-emotivo-cognitivo condiviso, all'interno del
quale si hanno momenti di incontro intimo pre-discorsivo; e tuttavia, quando poi l'analista
parla (come quando la madre parla), comprende l'altro dal proprio punto di vista. L'analista
cosciente di quest’inevitabile natura della sua comunicazione col paziente, pensa che quando
interpreta fa delle proposte congetturali. Di conseguenza, è propenso a considerare l'analisi
come processo collaborativo, in cui si ha la costruzione interattiva di significati. La
Psicoanalisi utilizza quindi, in modo sofisticato, specializzato e perciò particolarmente
consapevole, i poteri che sono insiti nel dialogo, dalla sintonizzazione senso-emotivo-motoria
(che costituisce una comunicazione in gran parte preconscia e inconscia), al primo baluginare
di
un
discorso,
fino
alla
negoziazione
di
significati
condivisi,
per
giungere
all'interiorizzazione di questo processo sotto forma di percezione discorsiva del sé.
Sebbene gli analisti si differenzino assai nello stile personale di porsi nel Dialogo Analitico,
tutti sono accomunati nell'accettazione di un provvisorio stato interiore di perplessità, quello
stato in cui si trova ogni persona che, non accettando di comportarsi in un modo impulsivo e
irriflesso, ma neppure inibendo minimamente la percezione interna della propria risposta, si
domanda quale sia il significato di ciò che sta capitando ... senza ancora averlo trovato.
Questo tempo di attiva attesa può essere lungo, pesante e penoso. Ma non sempre: in certi
13
periodi di certe analisi, soprattutto in fase avanzata, con un terreno comune consolidato, ci
possono essere anche scambi rapidi, scoppiettanti, quasi a testimoniare una conquistata
leggerezza.
In ogni caso, la capacità di acquisire, attraverso il dialogo, una miglior integrazione simbolica,
appare fondamentale per il buon esito della terapia. Bisogna considerare il fatto che, nella vita
della mente, costituisce un trauma non solo l'irrompere di eventi classicamente considerati
come traumatici, ma anche - e forse ancora di più - lo scarso apporto di strumenti che essa
riceve per lo sviluppo delle proprie capacità espressive simboliche. La povertà del gioco, la
scarsità dei dialoghi che abbiano una qualche caratterizzazione di schiettezza e di intimità; gli
interdetti che provengono, senza troppa consapevolezza del perché, dalle persone
significative, a loro volta gravate dal carico di norme transgenerazionali preconsce e/o
inconsce; le innumerevoli censure che il soggetto s’impone da sé per paura del proprio mondo
interno; l'abituale immergersi in attività le quali, indipendentemente dal loro valore oggettivo,
vengono usate dal soggetto come potenti anestetici, per evitare l'impatto con contenuti che
tuttavia continuano a chiedere ascolto, seppure in un'inquietante forma incarognita, primitiva
e bizzarra, insomma col furore di coloro a cui troppo a lungo è stata negata l'esistenza: tutto
ciò innesta un micidiale circolo vizioso. Infatti, la conseguente povertà delle capacità
simboliche rende traumaticamente intollerabili sensazioni, emozioni ed eventi che potrebbero
benissimo non esserlo (se venisse sviluppata la capacità di "digerirli"). Quest’abbassamento
della soglia del dolore mentale incentiva la spinta a liberarsi degli stimoli anziché considerarli
come il materiale da costruzione per il proprio spessore soggettivo. Attraverso il Dialogo
Analitico, l'analista cerca di innestare nella mente del paziente un'inversione di rotta. Rispetto
ai contenuti su cui converge l'attività referenziale dei due partner, egli è, infatti, il meno
spaventato, ma soprattutto è convinto che essi siano pensabili, e che attraverso il pensiero
possa altamente aumentare la loro tollerabilità.
Moreno e lo Psicodramma
Moreno fu allievo, piuttosto critico per la verità, di Freud; egli era convinto che non può
esservi terapia individuale se, al tempo stesso, non si modificano le condizioni relazionali
collettive. Per il creatore dello Psicodramma, tecnica terapeutica nata negli anni Venti e
ispirata al teatro, di cui era un appassionato cultore, l'uomo si realizza veramente solo quando
può esprimersi liberamente, nonostante le barriere sociali. Moreno, parlando delle sue
14
tecniche diceva, infatti, che "il vecchio divano dello psicoanalista è stato sostituito dal teatro
della spontaneità".
Nello Psicodramma si chiede ai pazienti non di parlare dei propri problemi e delle proprie
situazioni, ma di agirle, attraverso scene emotivamente significative per la persona, in un
clima privo di minaccia e di controllo sociale. I protagonisti devono improvvisare il loro ruolo
partendo da una situazione presente, passata, futura o immaginaria. Il regista, cioè il terapeuta,
mantiene il legame tra paziente e pubblico, intervenendo quando lo ritiene opportuno, senza
dimenticare che egli è parte integrante del gruppo e soggetto, quindi, delle dinamiche socioemotive che si determinano. Moreno prevedeva la presenza di un'équipe psicodrammatica i
cui componenti, denominati "io ausiliari" avevano la funzione di recitare quelle parti di cui il
paziente poteva avere bisogno per presentare adeguatamente la propria situazione, dando
corpo a persone reali dell'ambiente del paziente, o a figure simboliche. Gli altri protagonisti
della rappresentazione erano gli spettatori, che come il coro della tragedia greca facevano da
eco al protagonista, manifestando le proprie emozioni di fronte alle vicende rappresentate. Nel
palcoscenico il paziente agisce nei confronti del regista o del pubblico proiettando su di loro
le dinamiche che ha vissuto con altre persone; da questa situazione emergerà una nuova
consapevolezza di sé, che favorisce il ricomporsi e l'integrarsi nelle sue componenti e nel
sociale al quale appartiene. Recitando più ruoli, inoltre, egli realizza la possibilità di riportare
alla luce anche le sue fantasie più represse, offrendo un'occasione catartica a se stesso oltre
che al pubblico e recuperando una spontaneità perduta durante il cammino dell'adattamento
sociale.
Dagli anni quaranta in poi lo Psicodramma analiticamente orientato ha assunto via via una
impostazione più specificamente psicoanalitica; il dialogo al suo interno si fa meno "corporeo
(il contatto fisico fra partecipanti è vietato), e lascia spazio all'interpretazione simbolica dei
contenuti verbali e non verbali che emergono. Il gruppo dei partecipanti comunica sia a livello
intrapsichico sia a livello degli interlocutori interiori che, per ciascun individuo, sono
personificati dagli altri partecipanti. Il parlare di un membro del gruppo o del gruppo nel suo
insieme attorno ad un evento, questione, conflitto o sintomo viene costantemente riportato alla
rappresentazione, col metodo drammatico, di una scena concreta, riferibile ad un tempo e ad
uno spazio determinato della storia di uno dei presenti (che possono essere situati nel mondo
diurno della veglia, in quello del sogno o anche in quelli del delirio o delle fantasie del
protagonista purché tali fatti siano accaduti in un altrove e allora ben distinto dal qui ed ora
del gruppo). Tale drammatizzazione a sua volta, evoca sentimenti, ricordi, considerazioni,
associazioni negli altri presenti, da cui scaturiranno le scene successive, e ciascuna scena
drammatizzata costituisce, per così dire, un punto focale per mezzo del quale vengono
15
evidenziati sempre nuovi aspetti della rete di significati, rapporti, possibilità che
continuamente s’intesse tra i partecipanti, dentro di essi ed attraverso di essi. Nel gioco di
specchi che si crea, nel dialogo che prende vita, la messa in scena del corpo e dei sentimenti
aiuta a capire più profondamente se stessi e a fortificare la propria consapevolezza di sé.
Tale dialogo, per la sua specificità, può rivelarsi utile non solo a chi intende "fare chiarezza
dentro di sé", ma anche a quanti, per ragioni professionali, debbano prendersi cura degli altri.
La Terapia della Gestalt e il dialogo con la sedia vuota
Se in Psicoanalisi il dialogo col terapeuta e con gli altri è, implicitamente, un dialogo con le
parti del proprio se scisso o rimosso, nella Terapia della Gestalt, affermatasi verso la metà del
secolo scorso, questo dialogo viene esplicitato attraverso tecniche che si ispirano allo
Psicodramma, come quella della famosa "sedia vuota" (o sedia calda). Qui la persona
rappresenta un’altra persona o un ruolo, e improvvisa un dialogo da sola. Scindendo mediante
la drammatizzazione le parti del proprio sé in conflitto, questa tecnica tende a rimetterle in
contatto, promuovendone il dialogo e l’integrazione. Il fine della terapia è recuperare le parti
perdute della personalità, e dare impulso al processo di crescita interiore.
In quest'ottica, la relazione terapeutica é un incontro esistenziale tra due esseri umani reali che
mettono in gioco se stessi nel dialogo del processo curativo. Nella relazione Io - Tu, e anche
grazie all'uso, da parte del terapeuta, di strategie mirate alla focalizzazione e al
rispecchiamento, si apprende a riattivare il dialogo esistenziale e interpersonale, istaurando
una comunicazione efficace e in sintonia con il contesto, nel presente, nel qui ed ora. E'
evidente che il dialogo non può limitarsi al piano solamente intellettuale: in realtà, esso si
allarga a comprendere ed integrare corpo, mente ed emozioni. Noi viviamo nel corpo e le
nostre sensazioni, emozioni e pensieri passano dal corpo. Lo stato d’animo che si vive va al di
là della spiegazione razionale che se ne può dare; non interessa, nell’approccio gestaltico,
discutere di uno stato d’animo, ma piuttosto calarsi nella percezione di esso, in modo che
possa evolversi e trasformarsi. Il dialogo é quindi arricchito da esperienze corporee, scrittura,
disegno libero, utilizzo di racconti o visualizzazioni. Ciò non stupisce considerando che Perls,
il fondatore di quest'approccio, aveva una personalità eclettica che lo spinse ad approfondire
diverse discipline, dalla Psicoanalisi alle terapie psicocorporee, dallo Psicodramma ai Gruppi
di Incontro, dall'approccio fenomenologico a quello esistenziale, fino ad arrivare alle filosofie
orientali, integrandole nel suo modello di psicoterapia.
16
Rogers: comunicazione autentica, Terapia centrata sul Cliente, Gruppi
d’Incontro
Secondo Rogers un dialogo autentico, che esprima il vissuto e la soggettività degli individui, è
reso possibile a partire da un atteggiamento reciproco di ascolto, avalutativo e totalmente
accettante da parte degli interlocutori. Nell’ascoltare, messa da parte la propria particolare
visione del mondo, ci si mette nei panni dell’altra persona, cercando di comprenderlo
dall’interno. In terapia, ciò si traduce in un ascolto attivo, capace di restituire all’interlocutore,
come in uno specchio, i contenuti – cognitivi ed emotivi – della sua comunicazione, mediante
segnali facciali e rimandi verbali che dimostrano che quanto espresso è stato compreso. Ciò
consente a chi parla di prendere coscienza di quanto va esprimendo, e, man mano che la
comunicazione prosegue e la comprensione si fa più profonda, di chiarificare a se stesso il suo
pensiero, le sue articolazioni, le emozioni che lo colorano, fino a giungere, in maniera
autonoma, senza alcun suggerimento o condizionamento, a una sorta di “riorganizzazione
percettiva”, una modalità differente, più articolata, sfaccettata e ordinata, di “vedere” i propri
contenuti di coscienza.
È evidente che l'approccio Centrato sulla Persona, alla base della Terapia rogersiana centrata
sul Cliente, si fonda su una radicata e sostanziale fiducia di base nella Persona stessa. Rogers
è fortemente convinto che l'individuo possieda già dentro di sé ampie risorse per modificare
costruttivamente la propria idea del sé, le proprie qualità e il proprio comportamento; lo scopo
è, quindi, quello di creare delle condizioni che permettano, appunto, a questa forza di base di
agire, in modo che la Persona possa crescere verso la propria autorealizzazione.
Rogers, nella seconda metà del secolo scorso, si occupò intensamente anche di ricerche sulla
psicologia dei gruppi, e l’uso rogersiano terapeutico del dialogo trova un significato più
ampio nei Gruppi d'Incontro, esperienze intensive di gruppo che hanno lo scopo di favorire la
crescita psico-emotiva dei partecipanti e le loro abilità relazionali. E’ il gruppo che sceglie i
propri obiettivi e le proprie direzioni personali. Al conduttore o facilitatore viene data la
responsabilità di facilitare l'espressione di sentimenti e pensieri da parte dei membri del
gruppo, attraverso la creazione di un clima psicologico di sicurezza, in cui si realizza
gradualmente la riduzione dell'atteggiamento difensivo. In questo clima tendono ad essere
espresse molte reazioni emotive immediate di ogni membro, verso gli altri e verso se stesso, e
da questa libertà di esprimere i veri sentimenti positivi e negativi, si sviluppa un clima di
fiducia reciproca. Con la riduzione della rigidezza difensiva gli individui possono ascoltarsi a
vicenda e possono imparare maggiormente l'uno dall'altro. Da una persona all'altra si sviluppa
17
un feed-back, di modo che ogni individuo viene a sapere come egli appare agli altri e quale
impatto ha sui rapporti interpersonali. Da questa maggiore libertà e da questa migliore
comunicazione emergono nuove idee, nuovi concetti, nuove direzioni. L'innovazione può
diventare un'eventualità auspicabile anziché temibile. Il gruppo diventa così un "luogo"
speciale e protetto dove potersi sperimentare e rimettere in gioco, e offre molteplici
opportunità: riduce il senso di isolamento favorendo uno scambio di esperienze, attenua le
ansie legate ad un particolare evento grazie al dialogo con altri che condividono la stessa
condizione, dà la possibilità, grazie alla creazione di un clima amichevole e non giudicante, di
affinare la comunicazione e di riconoscere le proprie ed altrui capacità. L'utilizzazione di
"esperienze guidate" e di tecniche attive attribuisce una connotazione esperienziale al lavoro
terapeutico. Quanto viene sperimentato ed acquisito nell'esperienza di gruppo è facilmente
trasferito nella vita quotidiana, e il processo avviene rispettando i tempi ed il ritmo di crescita
della persona. Il Gruppo d'Incontro può essere, per molti che vorrebbero intraprendere un
viaggio all'interno di sé, ma sono in qualche modo indecisi ed intimoriti, un approccio
graduale al mondo psichico.
Lewin: dialogo nei gruppi e T-Group
Anche Kurt Lewin, con la sua formazione eclettica, che spaziava dal gestaltismo al
comportamentismo, fino alla Psicoanalisi, si è occupato di dialogo e comunicazione
nell’ambito dei suoi fondamentali studi sulle dinamiche gruppali. Nella sua prospettiva di
campo di forze psicosociale, l'individuo non può essere visto e considerato indipendentemente
dal suo spazio di vita, che include i gruppi di cui fa parte e il complesso delle relazioni
all’interno di essi. Questa prospettiva, pionieristica per gli anni Trenta del secolo scorso, si
distingue anche per il ruolo attivo e interattivo riconosciuto ai soggetti; non a caso, le ricerche
del “padre della psicologia sociale” sono spesso finalizzate anche all’intervento. Lewin aveva
in mente la complessità dei fattori che influenzano il comportamento, e mirava
all’integrazione dei contributi provenienti dalle diverse scienze sociali. Il campo, tuttavia, è
stato indagato nella sua dimensione essenzialmente mentale, perché ogni cosa è filtrata dalla
propria visione soggettiva della realtà. Nei gruppi, la condizione che rende possibile la
comunicazione è l’atteggiamento del dialogo (non critico-valutativo o di giudizio, ma di
comprensione dei motivi che spingono l’altro a parlare in un certo modo), è l’accettazione
dell’altro percepito come diverso, unico, e proprio per questo arricchente il gruppo con il suo
apporto personale. E’ necessario tornare coraggiosamente al "nolite iudicare" evangelico,
18
abbandonando l’esigenza individualistica che gli altri siano come i propri schemi dicono che
"dovrebbero essere" e smontando l’irrigidimento che si produce di fronte all’eventualità di
dover mutare qualche cosa di proprio. Quest’atteggiamento è strettamente dipendente dal
grado di "sicurezza di sé", e quindi dall’assenza del bisogno compulsivo di difendersi. Il
concetto che ognuno si è formato di se stesso rappresenta come un filtro attraverso il quale si
percepisce tutta la realtà, tendendo a deformare, negare, rifiutare quelle altre esperienze e
comportamenti che non sono immediatamente integrabili con tale schema. L’opposizione al
cambiamento si esprimerà allora con una serie di meccanismi di difesa che rappresentano dei
dispositivi di sicurezza per evitare di rendersi conto di aver bisogno di cambiare o per
allontanare l’ansia che il cambiamento comporta. Se non si realizzano queste due condizioni
subentrano nei membri del gruppo le condotte difensive che negano e deformano i contenuti
della comunicazione e la rendono impossibile ("parlare tra sordi").
Il dialogo è favorito da un tipo di conduzione del gruppo che Lewin definisce democratico:
non autoritario, ma nemmeno indifferente o libertario, in cui la guida (il facilitatore) è
amichevole, rispettosa delle persone, tollerante, delinea l’orientamento delle attività e
favorisce le discussioni e le decisioni. Il dialogo non è un pericolo per l’autorità, ma per
l’autoritarismo; non per le norme ma per la burocrazia. Questo stile appare anche il più valido
per la crescita umana dei membri, la loro soddisfazione, creatività, autonomia.
Il Training-Group, “scoperto” da Lewin e dai suoi allievi nel corso di esperimenti sulla
comunicazione, si basa appunto sulla conduzione non direttiva di piccoli gruppi, con
l'obiettivo di facilitarne la libera comunicazione creativa e restituendo l'apprendimento al
gruppo stesso. Il T-Group è uno strumento che, attraverso il dialogo, aiuta a prendere
coscienza delle proprie risorse relazionali, e a riconoscere e valorizzare la diversità degli altri.
I Gruppi Balint e le professioni d'aiuto
Nei Gruppi Balint, invece, l'affinamento dell'empatia e delle risorse relazionali è finalizzato a
scopi professionali. Questi gruppi, che prendono il nome dal loro fondatore Michael Balint,
noto psicoanalista di origine ungherese, nacquero a seguito della sua esperienza di conduzione
di seminari per medici generici e specialisti in vari rami alla fine degli anni 40. Egli si rese
ben presto conto della scarsa utilità di lezioni teoriche o di incontri di supervisione, in cui si
creava quella condizione sempre rassicurante, ma scarsamente proficua di maestro-allievo.
Per i suoi scopi, in particolare quello di sensibilizzare i colleghi alle componenti
interpersonali della terapia medica, arrivò a proporre il lavoro in piccolo gruppo eterocentrato
19
sulla discussione di casi clinici portati a turno dagli 8-10 partecipanti che si riunivano, per un
periodo di due-tre anni, settimanalmente in un’atmosfera di libero scambio in cui ognuno
potesse presentare i propri problemi coi pazienti, sperando di riuscire a chiarirli attraverso
l’esperienza degli altri. Nella tecnica Balint il gruppo vive la relazione medico-paziente
descritta dal collega, ascolta, interviene, chiede ulteriori notizie, evoca fantasie, associa
liberamente. Il conduttore, o i conduttori, con formazione psicodinamica, partecipano come se
fossero membri in più, favorendo la libera discussione ma garantendo anche il mantenimento
dell’impostazione e degli obiettivi del gruppo, contenendo e minimizzando le intrusioni
nell’intrapsichico dei singoli partecipanti e dando rilievo ai fenomeni relazionali non notati
dal gruppo ma importanti per la comprensione, la terapia o l’evoluzione della situazione
clinica. È capacità del conduttore identificarsi con la posizione del relatore di turno e
comunicare al gruppo questa possibilità di "immaginarsi al posto di", che diventa strumento di
lavoro. Si lavora insieme sul versante cognitivo, ma soprattutto emotivo, su due livelli: quello
del rapporto medico-paziente e quello tra il medico che relaziona il caso e il gruppo,
consapevoli che il gruppo facilita la meta-cognizione (cioè la capacità di pensare sul pensare).
La presenza, la regolarità e la ciclicità degli incontri si inscrivono nella mente dei partecipanti
come un rassicurante contenitore ed elaboratore di ansie che permette di evitare la fuga
difensiva nella routine lavorativa.
Diversamente dal tipico gruppo di discussione di casi clinici, i Gruppi Balint si concentrano
soltanto sul paziente e sul medico, senza indicare a quest’ultimo come curare o comportarsi
con il paziente ma solo per capire che cosa significano l'uno per l'altro e cosa significa ciò che
avviene tra di essi. In particolare i partecipanti cercano di concentrarsi sulle sensazioni destate
nel medico dal paziente, su ciò che il medico sente e prova verso di lui, solitamente a causa di
motivazioni prevalentemente soggettive e che possono interferire sia col rapporto che con la
finalità terapeutica stessa, influenzando negativamente non solo lo stato d'animo e
l'atteggiamento del paziente, ma anche offuscando o addirittura oscurando la mente dello
specialista riguardo alle giuste procedure diagnostiche e al successivo trattamento.
Non si tratta, quindi, di "terapia di gruppo" bensì di un lavoro comune operando
primariamente sulle componenti controtransferali del medico (cioè del modo "in cui egli
utilizza la sua personalità, le sue convinzioni scientifiche, i suoi modi di reazione automatici")
nei confronti del paziente. Attraverso il dialogo, ciascuno può approfondire e soprattutto
esplorare, con il contributo del gruppo e naturalmente del conduttore, i lati più controversi e le
interferenze ed intrusioni nel rapporto terapeutico. Il partecipante ai gruppi, sosteneva Balint,
rispetto alla Psicoanalisi individuale sarà non necessariamente meno nevrotico, ma
20
sicuramente più maturo, vale a dire più consapevole di sé, più avvertito dei bisogni dell’altro,
più attento agli effetti inintenzionali del suo agire.
Successivamente sono state fondate molte Società Balint per promuovere la formazione di
nuovi gruppi, non solo di medici ma anche di varie altre professioni, nonché di tipo
interdisciplinare. I Gruppi Balint si sono affermati in particolare come strumento duttile,
efficace e di facile attuazione per la formazione psicologica degli operatori d’aiuto e la
prevenzione del burn out. Come psicoanalista, Balint diceva che era necessario "ascoltare
attraverso tutti i pori della pelle" oppure "...come se avessimo un terzo orecchio", ma aveva
ben capito come fosse importante anche per gli operatori d’aiuto trovare la possibilità di
essere a loro volta ascoltati (Rovatti, 1992).
Negli ultimi anni però il metodo Balint è stato anche contestato per la centralità delle teorie
psicodinamiche
a
scapito
di
altri
orientamenti
(per
esempio
quello
cognitivo-
comportamentale), per la controversia sulla necessità di un training psicoterapico individuale
per i medici, e per il rischio che i medici formati con tale metodo focalizzino troppo la loro
attenzione sui fattori psicologici (nei paesi anglosassoni è stato coniato il termine "to balint"
per descrivere ironicamente i medici di famiglia che offrono interpretazioni psicoanalitiche a
pazienti che non ne hanno fatto richiesta; Garcia-Campayo et al., 1995). Un altro problema è
la costituzione dei cosiddetti gruppi "balintoidi", nei quali la diffusione del metodo avviene
secondo un filone d’improvvisazione, e senza una comunità d'intenti.
Ciò nonostante, questi gruppi restano un'importante testimonianza del valore del dialogo e del
confronto nei gruppi come strumento atto ad affinare il proprio stile comunicativo, e le
capacità empatiche e assistenziali, che in determinate professioni hanno un ruolo di primo
piano.
Foulkes e la Gruppoanalisi: comunicazione e costituzione relazionale-dialogica
del pensiero in gruppo e di gruppo
Gli studi di Lewin sul concetto di campo, riassumibili nella nota formula per cui "il tutto
contiene di più ed altro rispetto alla somma delle sue parti", ispirarono, all'inizio degli anni
40, anche lo psicoanalista Sigmund H. Foulkes, il quale si rese conto dell'insufficienza del
modello teorico freudiano di rete di legami libidico-affettivi, che appariva piatto e
bidimensionale quando applicato ai piccoli gruppi. Così, per descrivere meglio ciò che gli
appariva come una polidimensionalità caratteristica del pensiero e della comunicazione nel
gruppo, coniò il modello di rete matriciale, scelto per fare un chiaro riferimento al concetto di
21
mater. Foulkes intese sottolineare in questo modo l'aspetto specificamente originale e nuovo,
generativo, creato dalla situazione gruppale: la matrice manifesta una sua struttura ed
autonomia funzionale, che in qualche modo trascende gli individui, anche se è da essi
globalmente costituita e condivisa, ed è capace di condizionarne il pensiero, il linguaggio ed il
comportamento.
Tuttavia, il primo a formulare il concetto di matrice fu Trigant Burrow, che nel 1926 così
scriveva: “l’uomo non è un individuo, la sua mente non è individualistica. Egli è parte di un
continuum sociale che è lo sviluppo di un continuum primario o della specie”. Sostenendo la
continuità primaria dell'individuo con il gruppo d’appartenenza, ma anche col più ampio
genere umano, osservò che "la matrice filogenetica rappresenta la base della vita sociale
dell'uomo, così come l'identificazione primaria del bambino con la madre è la base
ontogenetica per il suo successivo sviluppo come individuo". Secondo Burrow esiste una
stretta interazione fra matrice ontogenetica e filogenetica.
Foulkes, che aveva interessi simili a Burrow nell’interrogarsi sull’applicabilità della
Psicoanalisi al setting terapeutico gruppale, ritenne che i concetti classici potessero si essere
vantaggiosamente utilizzati, ma che il grande numero di variabili presenti nel gruppo ne
modificasse inevitabilmente l’uso. Egli individuò, a questo proposito, anche una modalità
comunicativa che chiamò “discussione liberamente fluttuante”, caratterizzata dal susseguirsi
di frasi dette dai membri del gruppo in assoluta libertà e legate da un filo conduttore
riconducibile ad una logica propria del gruppo stesso. I contenuti che queste "catene"
esprimono, e i modi in cui sono strutturate delineano l'andamento della seduta e soprattutto il
"pensiero del gruppo". Queste "discussioni", che C. Neri definisce catene associative gruppali,
sono caratterizzate da un clima estremamente tollerante e permissivo, in cui è anche concesso
di allontanarsi in qualsiasi momento dall'oggetto della discussione, per esprimere i propri
vissuti personali. Naturalmente l'origine di questo "modus communicandi" risale al metodo
freudiano delle libere associazioni.
Ma l’originalità più grande dell’approccio foulkesiano, sta nel fatto che il dialogo di gruppo,
ed il gruppo stesso, diventano il principale strumento terapeutico. Foulkes (1975), infatti,
denominò come “Gruppoanalisi” quella che definì "una forma di psicoterapia praticata dal
gruppo nei confronti del gruppo ivi incluso il suo conduttore".
Va però a questo proposito ricordato che il primo a coniare questo termine è stato ancora una
volta, Burrow, già nel 1927. Dopo un percorso psicoanalitico individuale, consigliatogli dallo
stesso Freud in seguito al suo interrogarsi in merito alla possibilità di applicare la Psicoanalisi
ai gruppi, egli arrivò pioneristicamente a concepire l'importanza della condivisione e della
comunicazione nel risolvere i conflitti intrapsichici, nonché l'origine prevalentemente sociale
22
dei disturbi patologici. Ma il mondo psicoanalitico dell’epoca, sentendosi minacciato da
prospettive così originali e inconsuete, nel 1931 espulse Burrow dalla Società Psicoanalitica
Americana, e per lungo tempo sui suoi scritti scese il silenzio.
Fu dunque in ambienti europei che lo specifico gruppale fu riconosciuto come tale da più
ricercatori. Man mano che le ricerche e i lavori con i gruppi si moltiplicavano, a causa della
guerra e di altre contingenze storiche e pratiche, apparve infatti sempre più chiaro il fatto che
il piccolo gruppo si poneva come lo strumento privilegiato per comprendere il formarsi
dell'identità, nei suoi elementi costitutivi interpersonali. Rouchy (1998), a questo proposito
sostiene che esso costituisce proprio quell'anello mancante nel pensiero freudiano, necessario
per comprendere il passaggio dal singolo al collettivo e viceversa, nonché la loro reciproca
impregnazione.
L’apporto psicoanalitico alla comprensione delle dinamiche gruppali è legato soprattutto al
progressivo affermarsi di una sua corrente, la cui origine è riconducibile alla posizione
assunta da Ferenczi, che concepiva l’analista come una parte irrinunciabile dell’area tecnica.
Corbella (2003) osserva che “l'attenzione alle relazioni con gli oggetti interni presente nei
lavori della Klein (che cominciano a lasciar intravedere una dimensione sociale
dell'inconscio), modulatasi con un sempre maggior valore dato agli oggetti esterni negli scritti
di Bion”, e di altri ancora, “fa sì che questi autori vengano accorpati nella definizione generica
e un po' riduttiva di teorici delle relazioni oggettuali”. Secondo Ancona (1996), è Ferenczi
(probabilmente contagiato dall’incontro americano con Burrow) colui che ha ispirato il
pensiero di Balint, Fairbairn, Winnicott e degli altri Autori di questa corrente. Un importante
aspetto che accomuna il loro pensiero, modulandone al contempo le differenze, è il pensare
l'oggetto sia come una persona reale dell'ambiente di appartenenza sia come un'immagine
fantasmatica interna, accentuando ora l’una ora l’altra di queste due dimensioni.
I processi di dialogo e scambio tra l'oggetto interno e quello esterno e reale, come sottolineato
da Corbella, possono quindi essere considerati come i prototipi delle relazioni tra i
componenti nel processo gruppale. Infatti, nel divenire del gruppo, “gli aspetti intrapsichici si
rendono comunicabili attraverso le interazioni (che comprendono anche gli aspetti inconsci
arcaici della comunicazione) e in questo modo si trasformano in esperienze socialmente
condivise. Di converso l'esperienza e la storia del gruppo divengono individualmente e
internamente rappresentate in uno scambio di reciproca trasformazione” (Corbella, 2003).
Così, il paradigma relazionale di cui si è arricchita la Psicoanalisi, sottolineando l'aspetto
fondante delle relazioni oggettuali nella costituzione e nello sviluppo del sé, ha fortemente
contribuito alla consapevolezza della costituzione sociale dell’individuo.
23
L'interazione considerata dai teorici delle relazioni oggettuali è prima di tutto quella con
l'ambiente materno, inteso in senso lato e considerato determinante per lo sviluppo. A questo
proposito si ricorda l'importante contributo di Fairbairn (1952) il quale, pur nella sua fedeltà
ad alcuni aspetti della teoria pulsionale freudiana, concepì la libido fondamentalmente come
una ricerca d'oggetto, e sostenne che il vero obiettivo libidico è lo stabilirsi di relazioni
oggettuali soddisfacenti. Nella prospettiva gruppale è interessante soprattutto la sua ipotesi di
una presunta spinta intrinseca del sé ad organizzarsi in un sistema basato sulla comunicazione
tra le sue parti scisse, a loro volta derivanti dalle relazioni con gli oggetti reali; sistema che
finisce per regolare anche i rapporti sociali. Secondo Corbella, questo sistema appare
proiettato nella tendenza dei membri del gruppo nell'assumersi funzioni specifiche, ma con
valenze trasformative, dal momento che la gruppalità restituisce dopo aver trasformato. Nel
gruppo è quindi possibile rappresentare sia aspetti del sé e delle relazioni oggettuali interne,
sia l'interazione reale e attuale tra i singoli membri.
A questo riguardo, appaiono rilevanti anche gli spunti offerti dal pensiero di Winnicott. I suoi
concetti di oggetto e spazio transizionali “suggeriscono una matrice dove persona e cultura,
ambiente interno ed esterno, s’incontrano e dunque lasciano intravedere i molteplici livelli
possibili nell'interazione gruppale” (Corbella, 2003). Inoltre, la ricerca psicoanalitica sul sé ha
altresì arricchito l’importante funzione di rispecchiamento attribuita da Foulkes al gruppo:
infatti, Winnicott ha sottolineato come ciò di cui il bambino necessita sia proprio il
rispecchiamento e il riconoscimento della sua unicità, della sua capacità creativa, cioè del suo
vero sé, da parte di chi si prende cura di lui nei primissimi stadi della sua esistenza.
Ecco che quindi anche Di Chiara (1999), in tempi più recenti, ribadisce l'importanza
fondamentale dell'altro per la formazione dell'identità individuale, sostenendo che il sé non si
forma se non attraverso gli altri. “L’uomo deve imparare ad essere consapevolmente molti
uomini e a tenerli tutti insieme. Quest’ultimo e molto più difficile compito gli darà quel
carattere che egli mette in pericolo con la propria molteplicità” (Canetti, 1973).
Diventa quindi possibile affermare, con Corbella, che “se la singolare identità della persona
può essere considerata come risultante dalla graduale integrazione di molteplici sé e
rappresentazioni di oggetti, nello stesso modo il costituirsi dell’identità del gruppo può essere
visto come la risultante della comunicazione dell’interazione tra i suoi membri, terapeuta
compreso, nel divenire storico del processo gruppale. Così il pensiero del gruppo si
costituisce grazie all'interazione degli individui, e il pensiero dell'individuo si articola e si
modula grazie al lavoro di gruppo”. Del resto, anche le più attuali correnti di ricerca
neurofisiologica rilevano che cervello e mente si organizzano attraverso la relazione sociale.
Tuttavia il sé è al contempo sempre profondamente privato, e per certi aspetti, anche
24
inconoscibile; una dimensione caratteristica dell’animo umano ben espressa da Derrida (1967)
mediante il concetto di supplementazione.
Più o meno parallelamente a Foulkes, in Argentina Pichon-Riviere sottolineava anch’egli la
necessità di completare la ricerca psicoanalitica con quella sociale, considerando l'individuo
come costituito dall'interazione tra il soggetto e gli oggetti interni ed esterni, e concentrando
particolarmente la sua attenzione sullo studio delle relazioni interpersonali, che concettualizza
mediante la cosiddetta “teoria del vincolo”. I vincoli sono strutture dinamiche e complesse
che comprendono un soggetto e un oggetto in interazione dialettica, le quali, una volta
introiettate, acquisiscono una dimensione intrasoggettiva, e condizionano le modalità di
apprendimento della realtà. Se si pensa al contesto socioculturale argentino degli anni 40,
dominato dalla dittatura peroniana, in cui era estremamente difficile pensare e operare in
modo personale e creativo per chi, come quest’autore, non aveva la tessera del partito,
concetti così innovativi non possono che stupire.
Riflessioni interessanti arrivano anche da Puget, che si rifà alla scuola argentina nata sulle
orme di questo psicoanalista. Ella ha più volte sottolineato come spesso nel tentativo di
metabolizzare l'eccesso di informazioni che arrivano dall'altro si rischia di confondere il
diverso col simile e il simile con l'uguale; o ancora, aggiunge Corbella, accade che, in modo
difensivo e pericoloso, il diverso venga assimilato a qualcosa di inferiore. Da qui il valore del
gruppo: nel processo gruppale, infatti, è inevitabile confrontarsi col paradosso tipicamente
umano per cui la costruzione della propria identità necessita di altri che ci sono fondamentali
e familiari, ma al contempo, anche diversi e in parte inconoscibili. “Colpisce il fatto che
proprio ciò che è maggior fonte di timore e angoscia per l'essere umano, e cioè l'ignoto, viene
a esserne parte costitutiva e fondante”, nota Corbella (2003). A suo parere, l'esperienza di un
gruppo abbastanza buono “permette di arrivare a considerare proprio l'inconoscibilità
dell'altro, del diverso da sé, come un potenziale valore nell'ambito delle relazioni” poiché
“mantiene lo spazio per la curiosità e il desiderio”.
Nella Gruppoanalisi, quindi, la dialettica tra processi psicologici individuali e processi di
gruppo è continua, e tramite l'esperienza gruppale è possibile sperimentare ed osservare una
serie di complesse relazioni sociali. I membri del gruppo sono supportati dal conduttore, e si
supportano vicendevolmente, nell'esprimere ed esplorare i propri vissuti all'interno del gruppo
ed in merito allo stesso. Compito del conduttore è entrare nei processi e nei contenuti che si
svolgono nel gruppo, indirizzarli, contenerli, parteciparvi e costruire ipotesi condivisibili, sia
da solo che insieme al gruppo, stimolando i membri a porsi domande e a ricercare ipotesi.
Nella “scena” del gruppo, inoltre, grazie al transfert potenzialmente multiplo che, a seconda
dei casi, investe uno, più partecipanti, o l’intero gruppo, concorrendo alla costituzione di
25
dinamiche inconsce collettive risultanti da proiezioni e identificazioni incrociate e dalle
interazioni fra di esse, diventa possibile comprendere nell’hic et nunc dell’interazione il
mondo interno di ogni membro nella sua configurazione vincolare relazionale.
Il dialogo e il confronto gruppale agiscono in modo terapeutico attraverso varie modalità. Ad
esempio, contrastando le rigide dicotomie, favoriscono la transizione dalla logica dell’aut-aut
che caratterizza il circolo vizioso impotenza-onnipotenza-colpa alla logica dell’et-et e
dell’integrazione che sostiene la presa di coscienza dei propri limiti e al contempo anche delle
proprie potenzialità, base di un modo di porsi responsabile verso se stessi e gli altri. In gruppo
si sperimenta e s’impara che le contraddizioni e i conflitti possono essere una strada verso lo
sviluppo e il progresso.
Naturalmente, il pensare in gruppo e del gruppo non si riduce alla capacità elaborativa, ma si
svolge su diversi piani: razionale, della rêverie (Bion, 1962) e del sogno. Intrapsichico e
interpsichico s’intrecciano in forme di pensiero e di linguaggio che oscillano tra modalità più
evolute ed altre più arcaiche e si muovono su un duplice asse, sincronico e diacronico,
consentendo da un lato la ri-costruzione della storia di ogni membro, e dall’altra la
costruzione di una storia gruppale condivisa.
Anzieu (1994) distinguendo il pensiero dal pensare, così scrive: “I pensieri sono in espansione
illimitata come l’universo delle stelle (...) Pensieri nascono qua e là, brillano, si attirano, si
equilibrano, esplodono, si frammentano, si agglutinano. Il pensare li contiene, li trasforma,
dona loro forme o parole”, un’immagine poetica che possiamo allargare anche al pensiero di
gruppo.
Neri (1995) propone, come metafora per comprendere la comunicazione gruppale, l'immagine
del gruppo disposto come una stella. Tutte i membri si collegano, non lungo una catena, ma
rispetto ad un punto centrale, noto o in via di definizione. E’ rispetto ad esso che si attivano le
associazioni, ed anche l’analista appare come co-pensatore. “Il gruppo, come un prisma
diffrange il pensiero nelle sue componenti che diventano percettibili e comprensibili”, e la
catena associativa si organizza intorno ad essi, soprattutto a “ciò che nel gruppo sta per
divenire pensabile le che funge da raccordo e da centro” (Corbella, 2003).
Come osserva Corbella, il pensiero di gruppo si costituisce soprattutto sulla base dell’attività
preconscia e di uno stato di coscienza diverso da quello ordinario della quotidianità.
Attualmente è possibile concettualizzare il preconscio come “il sistema dell’apparato psichico
nel quale si effettuano i processi di trasformazione che sostengono alcuni contenuti e processi
inconsci perché possano ritornare alla coscienza. A questo sistema è legata la capacità
associativa, figurativa e interpretativa della psiche” (Corbella, 2003). E’ da qui che originano
le libere associazioni, e si genera la trama del processo gruppale.
26
Ma la cosa più interessante è che l’origine e il funzionamento del preconscio appaiono essi
stessi di tipo relazionale. Nei primi tempi di differenziazione dell’apparato psichico questa
funzione è sostenuta dalla madre, “che si costituisce come porta-parola di fronte alle
stimolazioni interne ed esterne dell’infante ”, afferma Kaes (1998), ed evidenzia altresì come,
anche con lo sviluppo, il funzionamento preconscio continua ad essere fortemente
intersoggettivo, attivandosi o inibendosi al contatto dell’attività psichica preconscia dell’altro.
A proposito delle origini del preconscio, Bion ha sviluppato un’affascinante teoria che
ipotizza come in origine, tramite quella che lui chiama “funzione alfa”, la madre
“preconsciamente” elabora, trasforma e riesce a dare accoglimento e pensabilità alle diverse
tensioni emergenti, trasformando le impressioni sensoriali, legate ad un’esperienza emotiva,
in elementi alfa. Essi, condensandosi, formano quella che chiama “la barriera di contatto”, la
quale, in un continuo divenire, segna il punto di separazione fra elementi consci ed inconsci.
Bion aggiunge altresì che “la natura della barriera di contatto dipenderà dalla natura del
rifornimento di elementi alfa e dal tipo di relazione che sussiste fra loro” (Bion, 1962).
Rifacendosi a queste ipotesi, Corrao (1981) ha definito “funzione gamma” l’equivalente
gruppale della funzione alfa, fornendo una valida ipotesi per la comprensione dei prodotti del
pensiero di gruppo, come i sogni e la memoria gruppali.
Per comprendere il formarsi dei processi di pensiero di gruppo e nel gruppo è utile riferirsi
anche alla possibilità di riattualizzare, nel setting gruppale, quella fase arcaica preoggettuale
definita da Abraham (1995) co-sé o sinteismo primario, le cui radici sono rintracciate da
quest’Autore “nel corpo uterino, embrionale”, “nella periodicità del passaggio del cibo e
dell'ossigeno”, nelle “forme primitive di percezione e di pensiero globale, indistinto”,
“corollari dell'assenza coseica di discriminazione e di delimitazione tra lo spazio interiore e
quello che è esteriore al corpo dell'infans”. Abraham quindi ricollega al co-sé i processi
primari di spostamento e condensazione, nonché il contagio gruppale. Le tensioni coseiche
influenzano la matrice gruppale, poiché ogni gruppo, a suo avviso, deve confrontarsi con esse
e organizzarle in qualche modo.
Di certo il linguaggio ed il pensiero derivanti dalla “mente” del gruppo appaiono legati a
variabili non facili da definirsi. Corbella a questo proposito sottolinea, in particolare, l’uso
accentuato della metafora, e la tendenza alla costruzione di “neoformazioni simboliche”. Si
tratta, come evidenzia fortemente quest’autrice, di aspetti tipici anche del linguaggio del
sogno, “caratterizzato da potenza plastica immediata e densità di significati”.Anche Bion
(1962), a suo modo, notava dei paralleli tra funzioni preconscie e attività sognante; infatti, la
funzione alfa si manifesta sia nel sonno che nella veglia, ed è collegata alla rêverie, termine
27
che sottolinea proprio la continuità fra il sonno e la veglia. Così, afferma Corbella, possiamo
collegare analogamente la rêverie anche alla funzione gamma.
Nel divenire gruppoanalitico, emerge il modo in cui il pensiero di gruppo si nutre di sogni e
contribuisce a crearli; i gruppi dialogano anche attraverso i sogni, e “sognano” insieme il loro
divenire e trasformarsi. E’ ormai chiaro che molti processi gruppali si fondano su uno stato di
coscienza che si avvicina a quello del sogno, ed è quindi interrogandoci sul sogno, che
possiamo capire meglio ciò che succede nel gruppo. A questo proposito, Lopez e Zorzi
(1999), utilizzando il paradigma della complementarità (paradigma fondante l’epistemologia
gruppale) da essi denominato dell’et-et, in contrapposizione a quello dell’aut-aut, riescono ad
integrare le posizioni classiche di Freud con quelle di altri Autori particolarmente significativi
nel panorama delle scuole di pensiero sul sogno. Questo soprattutto perché, malgrado Freud
abbia aperto nuove e fondamentali prospettive nella comprensione dei processi onirici, ha
però anche ridotto il sogno a semplice strumento, negandogli un suo intrinseco valore: ne ha
ipervalutato il contenuto latente, ma non ha valorizzato adeguatamente il contenuto manifesto,
ritenuto una mera distorsione e mistificazione.
Ad esempio, per Winnicott l’attività onirica si svolge in quella che lui chiama “la terza via
intermedia dell’esperienza”: uno spazio per la curiosità, l’esplorazione, il gioco. Le stesse idee
hanno ispirato gli psicologi del Sé kohutiani, che considerano il sogno come "una cosa in sé",
che comunica un significato che non ha bisogno di essere decodificato. Il compito principale
del terapeuta o degli altri membri del gruppo, a questo punto, diventa “amplificare e
delucidare i pattern di significati trasmessi dalle immagini del sogno” (Pines, 1999). Anche
Foulkes (1964), ha valorizzato il contenuto manifesto, sostenendo che i sogni riflettono la
matrice affettiva comune a tutti i membri, anche se possono includere aspetti transferali del
sognatore.
Nel setting gruppale si osserva, in realtà, come i pazienti siano “naturalmente” attenti al
contenuto manifesto, che diventa la base per le catene associative gruppali. Il terapeuta stesso
è portato a “co-sognare” (Corbella, 2003) con il gruppo. Si tratta di processi di importanza e
rilevanza emotiva tale che spesso il sogno arriva ad esser considerato come specchio del
rapporto fra il sognatore ed il gruppo, o addirittura una metafora della situazione gruppale del
momento. Spesso, a detta di Corbella (2003), esso è in grado di simboleggiare momenti di
crisi evolutiva e di passaggio per il gruppo, e a volte può addirittura contribuire ad
accellerarne lo sviluppo, fungendo da“avamposto esplorativo dei percorsi praticabili verso
nuovi luoghi di pensabilità non ancora pensati” (Gaburri, 2000).
Tuttavia, il ruolo del contenuto latente non dev’essere dimenticato, ma piuttosto considerato
nella logica dell’et-et, e contestualizzato. Già Locke (1961) vedeva essenzialmente il sogno
28
come una risposta alle relazioni e alle vicissitudini gruppali, di cui quelle più conflittuali, in
quanto residui diurni, favoriscono altresì l’emergere del contenuto latente, legato alle
dinamiche infantili e familiari profonde; un movimento onirico stimolato dall’equazione
gruppo terapeutico -gruppo originario familiare. Ecco che allora il sogno diventa un dialogo
sia con il mondo interno del sognatore, sia con il gruppo.
Nel mondo interno, il dialogo avviene con un incontro-scontro creativo e dinamico tra il
preconscio, che possiamo considerare come il “costruttore” del sogno, nonché come uno dei
due protagonisti principali, ed il sé sognante che, secondo i casi, assiste allo spettacolo, ma
anche reagisce, influenza o addirittura agisce sulla realtà onirica presentatagli dal preconscio,
il quale svolge anche opera di mediazione tra il sé nel suo insieme e la coscienza della veglia.
Più precisamente, questa funzione protettiva classica, freudiana, di “guardiano del sogno”
(funzione rimuovente presente anche nello stato di veglia) appartiene al livello superiore e più
evoluto del preconscio, identificabile con il pensiero empatico-sintetico, ed è la
manifestazione di un movimento libidico-emotivo sano; ma esiste anche un livello inferiore,
definito da Lopez e Zorzi (1999) anche preconscio luciferino (vampiresco), il quale disturba il
lavoro onirico, agendo in modo regressivo e distruttivo sul sé sognante. Secondo gli Autori, il
sogno consente, attraverso il superamento della scissione fra i diversi stati di coscienza, di
accedere alla totalità della persona; è quindi il luogo in cui l’inconscio e, soprattutto, il
preconscio esercitano al massimo le loro potenzialità comunicative.
Il preconscio, infatti, prima di tutto, insegna. Lo si può immaginare, come fa Corbella (2003),
come un maestro che “né dice, né cela, ma accenna!” Esso trasmette un messaggio, un sapere
profondo che può trasformarsi in consapevolezza al sé sognante, il quale conserva alcune
caratteristiche e capacità (il sentimento di sé, il modo di sentire e vivere, di orientarsi nella
relazione con gli oggetti interni, ecc.) che gli permettono di immergersi, vivere e reagire nella
realtà virtuale del sogno, ma in modo più ingenuo e disinibito rispetto allo stato della veglia,
poiché le sue capacità inibitorie, logico-razionali e spazio-temporali si riducono per poter
accogliere il messaggio del preconscio senza l’inevitabile stupore, accettando anche situazioni
incongrue e paradossali, grazie ad una sorta di dissociazione transitoria delle sue funzioni.
Il sogno, quindi, pone il sognatore dinanzi a sé stesso, esprimendo attraverso le immagini i
dilemmi e i conflitti, attuali e passati, che l’illuminante razionalità spesso non coglie, e
mirando all’integrazione consapevole, nella complessità della persona e nel suo universo
relazionale, della vita libidico-emotiva rimossa e repressa. Solo in questo modo può avvenire
la rigenerazione e la trasformazione della volontà e dei desideri immaturi in volontà adulta,
attiva e responsabile.
29
Raccontare i sogni è rigenerante anche per gli altri membri del gruppo, poiché, stimolando la
comunicazione fra i diversi livelli del mondo interno ed esterno, aiuta ciascuno a distinguere
ciò che del proprio passato può essere ancora una riserva di linfa vitale, da ciò che può essere
abbandonato.
Corbella nota quindi una continuità fra la funzione del sogno e quella del pensiero di gruppo,
in particolare con il processo di rispecchiamento caratterizzante la comunicazione gruppale.
Quest’Autrice nota anche come, a volte, la narrazione del sogno vada a riempire uno spazio
vuoto, “una sorta di terra di nessuno tra passato e futuro”: in queste occasioni i sogni
diventano come dei “miti” di gruppo, “veri e propri sistemi di spiegazione, comunicazione e
significazione dell’esperienza comune” (Zanasi, 1999) che facilitano la gestione iniziale degli
elementi caotici, analogamente ai miti e nelle religioni antiche, che ri-ordinavano l’esperienza
fornendo una spiegazione e un valore a realtà vissute come spaventose e incontrollabili.
Il lavoro onirico è anche fonte d’ispirazione per lo stile comunicativo-dialogico del
conduttore, specie nelle prime fasi di vita del gruppo. Egli, infatti, sostiene sempre Corbella
(2003) “dovrà fare propria la capacità di mediazione specifica del soggetto sognante fra stato
di sonno e stato di veglia per poter far comprendere ai singoli membri, ancora legati ad una
logica aristotelica razionalizzante dominata dal principio dell’aut-aut, nuove connessioni
creative e trasformative che nel tempo costruiranno le fondamenta per lo specifico della
cultura e del pensiero di gruppo”. Bisognerà trattare i partecipanti come il preconscio sano
tratta la coscienza, cioè “come un bambino da educare e da non traumatizzare” (Lopez-Zorzi,
1999), dato che la coscienza è un sistema fragile, che compare per ultimo nella costituzione
del Sé.
A questo proposito Corbella formula l’ipotesi che il pensiero gruppale si costituisca attraverso
una relazione dialogico-interattiva fra i ruoli di io sognante, preconscio superiore, coscienza e
preconscio inferiore, che vengono assunti nel tempo e nello spazio transizionale del gruppo
dal conduttore, dai singoli partecipanti e dal gruppo inteso come un tutto. E se, specie agli
inizi del lavoro di gruppo, il conduttore consapevolmente si alterna soprattutto nel ruolo di io
sognante e di preconscio, funzionale alla maieutica di un interazione gruppale non sono
razionale, ma più emotiva e profonda, può più avanti assumere anche il ruolo di coscienza
della veglia, e rischiare di fare proprio, in alcune particolari occasioni, persino il ruolo di
preconscio inferiore, soprattutto a causa della presenza dei tratti narcisistici suoi propri, mai
analizzati a sufficienza. Quando invece è importante stimolare un movimento verso
l’individuazione, e smascherare gli aspetti gruppali portavoce del preconscio “inferiore”, egli
esce dall’atmosfera dominante del pensiero gruppale per pensare “da solo” in gruppo.
30
La comunicazione gruppale può variare molto, in base al momento che il gruppo sta vivendo
(o ri-vivendo).
Ad esempio, l’acting out, come modalità espressiva, fa parte del primo sviluppo della mente:
essa “viene prima dell'azione, prima dell'attività e prima del pensiero” (Gaddini, 1981), e
corrisponde all'organizzazione mentale frammentaria esistente al momento cruciale della
separazione, della nascita psicologica. E’ proprio il bisogno di sopravvivenza che genera i
primitivi acting out, come difese dalla separazione. Ogni gruppo analitico e ogni partecipante
deve affrontare tale passaggio, ma ognuno lo fa con modalità e profondità diverse e variabili.
In questa fase il denominatore comune è l’angoscia legata alla perdita del sé, che comprende,
come nota Gaddini, due aspetti diversi e contrastanti: l'angoscia di non integrazione, legata
alla fragilità e all'inconsistenza del confine appena acquisito, e al timore che non riesca a
tenere insieme i restanti frammenti del sé, e l'angoscia di integrazione, che comporta un
cambiamento verso uno stato totalmente nuovo, una transizione verso l’ignoto, per cui può
essere ancora più intensa dell’altra. Ecco che quindi alcuni membri reagiscono con una fuga,
una o più assenze apparentemente “ingiustificate”, o altri agiti, la cui risoluzione verso la
funzionalità al processo evolutivo personale e gruppale, o il rischio di incistarsi come difesa
negativa dipende molto anche dal comportamento del conduttore e dalla cultura che sta
costruendo nel gruppo.
E’ importante, a questo riguardo, sottolineare il fatto che il sé non si fonda solo
sull’introiezione delle figure adulte significative, ma anche degli strumenti di pensiero
caratterizzanti l’ambiente di origine. Quando essi sono carenti, spesso l’espressione di un
affetto è travisata, rifiutata, negata o ridicolizzata, “con effetti non solo di vergogna e di
rabbia ma anche di perdita di riconoscibilità di quell’affetto stesso” (Corbella, 2003). Ciò
facilita il costituirsi di vicende traumatiche. E’ soprattutto in questi casi che il linguaggio
metaforico caratteristico del pensiero gruppale può aiutare le persone a raggiungere la
“pensabilità” delle emozioni e della comunicazione “agita”. Un gruppo ben avviato crea nel
tempo un suo proprio linguaggio all’interno di una storia condivisa: in tal modo chi agisce
l’angoscia della “nascita psicologica” può sentirsi accolto dal racconto di altri che hanno
precedentemente vissuto e superato la stessa fase.
E’ interessante notare che, quando si reagisce alle angosce più arcaiche con la fuga e
l’assenza, nel momento in cui i contatti vengono ripresi la comunicazione è soprattutto visiva,
un dialogo di sguardi che ricorda molto le interazioni visive fra il bimbo e la madre, sempre
più importanti man mano che il piccolo avanza verso l’autonomia e lo sviluppo emotivo e
cognitivo. Successivamente, i movimenti di consolidamento del Sé appaiono, secondo
Corbella, nel setting gruppale in modo ancor più evidente rispetto alla situazione duale. Ella
31
scrive che in momenti diversi, “i partecipanti alternano la partecipazione attiva al silenzio
partecipe. A volte intervengono dopo un numero considerevole di sedute in cui sono stati
silenziosi, evidenziando sia la loro empatica partecipazione sia la necessità di consolidare in
solitudine il loro punto di vista e di esperire fuori dal gruppo l'avvenuta trasformazione di
alcune loro modalità di relazionarsi con il mondo. In un secondo momento, garantiti dalla
possibilità più volte esperita (in un gruppo che lavora da tempo e che ha dunque superato la
fase dell'anch'io) di avere e sostenere opinioni diverse da quelle degli altri, si confrontano con
il gruppo con il piacere di aver potuto pensare "con la propria testa", di poter pensare nel
gruppo, oltre e grazie all'aver potuto, nell'interazione preconscia e conscia con gli altri,
pensare di gruppo” (Corbella, 2003). La crescita consapevole del sé tende così ad annullare
l’angoscia, permettendo il passaggio da pseudo-relazioni basate sul bisogno e sulle
identificazioni proiettive a un modo di rapportarsi all’altro più realistico e autenticamente
creativo, e quindi a un dialogo più autentico, all’interno e all’esterno del setting gruppale.
Naturalmente, l’interpretazione conserva una funzione importante anche nelle interazioni di
gruppo. Una proprietà fondamentale della comunicazione interpretativa, particolarmente
importante in questo setting, è il suo carattere insaturo: è indispensabile lasciare degli spazi
aperti per il pensiero gruppale, “indicando un possibile tracciato che permetta a ciascun
partecipante di aggiungere il proprio personale contributo che a sua volta potrà aprire la via ad
un’ulteriore comprensione” (Corbella, 2003). A volte basta semplicemente rivolgere un invito
ad esprimersi alla persona che sembra in grado di sentire con più chiarezza un qualche
significato celato nelle dinamiche gruppali, dando così inizio ad una produttiva catena
associativa.
Corbella ritiene che anche l’indirizzarsi dell’attenzione interpretativa ad un paziente specifico
piuttosto che al gruppo nel suo insieme non sia mai casuale: essa prende spunto
dall’intuizione preconscia della posizione occupata dallo specifico partecipante nella
situazione gruppale in quella precisa fase.
Quest’Autrice precisa altresì che in alcuni casi l’interpretare diventa un porsi come interprete
fra persone che parlano diversi idiomi per “tradurli”, e costruire un linguaggio comune,
sopratutto in un gruppo che inizia, dove ciascuno parla il linguaggio della propria nevrosi. E’
necessario cercare di comprendere non solo ciò che ognuno esprime ma anche ciò che
“sopprime”: Pines (1990), seguendo Foulkes, ricorda che “a volte il sintomo mormora
appena, ma sempre con la speranza di poter essere compreso” (Corbella, 2003). Tali
riflessioni portano a sottolineare anche un altro aspetto rilevante della comunicazione
interpretativa gruppoanalitica, vale a dire la particolare importanza della scelta delle parole
32
usate: in un gruppo consolidato esiste, infatti, un “lessico familiare” specifico, cui bisogna
attingere per far si che le parole possano essere accolte, utilizzate ed interiorizzate.
Appare quindi fondamentale la comprensione della fase che i partecipanti stanno
attraversando. Un’interpretazione inappropriata, o espressa prematuramente, provoca anche
nel setting gruppale un aumento delle difese e un arroccamento narcisistico, mentre la
sospensione interpretativa “stimola la produzione di ulteriori elementi chiarificatori o, in una
fase avanzata del lavoro, la comprensione degli eventi da parte di un partecipante o addirittura
del gruppo nel suo insieme, tramite una produttiva catena associativa”, nota Corbella,
precisando al contempo che comunque il gruppo tende a riproporre le tematiche irrisolte
finché non è in grado di affrontarle e almeno in parte di comprenderle.
Inoltre, in Gruppoanalisi, la stessa interpretazione non è esclusiva del terapeuta, ma viene
tollerata, ed anzi stimolata (malgrado l’eventuale ferita narcisistica del conduttore) anche
negli altri partecipanti e nel gruppo inteso come tutto: col tempo e col divenire gruppale, la
struttura verticale delle relazioni tende a mutale in una struttura orizzontale, nella quale la
responsabilità del pensiero è distribuita in modo sempre più paritario tra i partecipanti, di
modo che il gruppo possa svolgere pienamente tutte le sue potenzialità terapeutiche.
Bateson e il soggetto contestuale
Ma Lewin, Moreno e Foulkes non sono i soli a far spaziare la riflessione psicologicodialogica
al
di
fuori
dell’ambito
canonico,
focalizzato
sull’individuo.
Ciò
che
contraddistingue la tradizione psicoterapeutica sistemico-relazionale propria di Gregory
Bateson e della Scuola di Palo Alto (Haley, Weakland, Watzlawick e coll.) è l’idea di
“soggetto contestuale”, introdotta nelle scienze umane da Bateson stesso negli anni Trenta. E’
un’idea di persona che sfida una premessa per molto tempo rimasta indiscussa nel pensiero
occidentale: l’idea che la vera essenza dell’uomo s’identifichi con qualcosa di “interno” e di
separato da tutti gli altri uomini "all’esterno”. Bateson ribalta questa premessa individualista
per dar corpo alla tesi che i processi mentali siano costruiti nell’interazione. L’essere umano
non soltanto ha bisogno degli altri per vivere, crescere e riprodursi, ma non è in grado neppure
di pensare o di sentire in solitudine. Le emozioni, come i pensieri, i costrutti mentali sono
costruiti in un dialogo fatto di gesti, di contatti fisici, ancor più che di parole, con gli altri. La
mente non coincide con il cervello, i processi mentali, la conoscenza si sviluppano
nell’interazione e nel dialogo.
33
Le psicoterapie sistemico-relazionali sono state le prime ad aver posto al centro della loro
elaborazione il soggetto contestuale, e da quest’idea di persona in dialogo derivano ancora
oggi la propria specificità.
La conversazione tra esperti e la Terapia Sistemico-Relazionale
Quest’approccio, mettendo al centro dell’attenzione - sia che ci si occupi di un problema della
famiglia, della coppia, o dell’individuo - la rete di relazioni come risorsa principale delle
persone e come cornice che spiega e dà senso a quanto accade loro, rende possibile esplorare,
attraverso la narrazione e la conversazione, modi alternativi e creativi di affrontare un
problema o una crisi evolutiva. Nella seduta di consulenza o di terapia il professionista
utilizza, a fianco della propria esperienza e delle proprie conoscenze, il contributo del cliente
quale “esperto” della situazione che vive e del problema che sta affrontando: il dialogo tra
psicologo e cliente (o tra psicologo e coppia, o gruppo) diventa così una “conversazione tra
esperti”.
Watzlawick e la pragmatica della comunicazione
Paul Watzlawick e colleghi (1967) hanno introdotto una considerazione di fondamentale
importanza nello studio della comunicazione umana, mettendo in evidenza come ogni
processo comunicativo tra esseri umani possieda due dimensioni distinte: da un lato il
contenuto, ciò che le parole dicono, e dall'altro la relazione, ovvero quello che i parlanti
lasciano intendere, a livello verbale e più spesso non verbale, sulla qualità della relazione che
intercorre tra loro. La componente di relazione tende a definire la componente di contenuto,
poiché nessun’interazione può essere analizzata in maniera totalmente razionale.
Inoltre, Watzlawick ha sottolineato un fatto molto importante: è impossibile non comunicare.
Se si accetta che ogni comportamento in una situazione di interazione ha valore di messaggio,
ne consegue che comunque ci si sforzi, non si può non comunicare. Anche il silenzio
comunica.
Secondo questi autori, quindi, comunicare efficacemente significa tenere in considerazione il
punto di vista dell'altro e capire come i giudizi siano ancorati al sistema di rappresentazione
della realtà del nostro interlocutore. Ogni persona si orienta per mezzo di una mappa di
percezione della realtà. Di fatto, noi percepiamo ciò che coincide con i nostri ricordi, ciò che
34
si allinea con le nostre esperienze, il che rappresenta il nostro punto di forza, in quanto ci
permette di orientarci nella realtà, ma anche il nostro punto di debolezza, poiché non ci
permette di essere obiettivi (senza pregiudizi). Individui, gruppi, organizzazioni, società,
cultura e contesto sono dimensioni interconnesse dell’esperienza, che si influenzano
reciprocamente, dando ogni volta forma diversa al dialogo e alla comunicazione.
Il dialogo nella Terapia Strategica
Fu Paul Watzlawick che introdusse definitivamente il concetto di utilizzo strategico del
linguaggio per ottenere rapidi cambiamenti nella percezione e nella gestione della realtà delle
persone. Se è vero che “non possiamo non comunicare”, allora il Dialogo, inteso come
comunicazione, assume un significato fondamentale per“creare un territorio comune” in cui
far confluire le varie “mappe”.
Etimologicamente, il termine “dialogo” vuol dire “scambio tra intelligenze”, nell’accezione
più ampia del termine: non certo solo razionalità, ma un sapiente connubio tra ragione ed
emozione. Il Dialogo Strategico, affermatosi come tecnica psicoterapeutica verso gli anni
Settanta, consiste in un insieme di domande, ingiunzioni, suggestioni e stratagemmi
comunicativi proposti in modo da mettere il proprio interlocutore di fronte alla sua realtà.
Si tratta di creare un’esperienza emozionale forte, che serve a sbloccare le sue risorse, rimaste
invischiate nelle rigide e disfunzionali percezioni precedenti, inducendolo a sentire altre
prospettive. All'improvviso, tutto diventa chiaro nella mente ed è una scoperta, come una
combinazione vincente, l'inserimento di un codice segreto, il primo passo verso la guarigione:
quando le parole diventano magiche, convincono, curano e guariscono.
Va detto a chiare lettere che il professionista “strategico” non conosce a priori dove il Dialogo
porterà lui stesso ed il suo interlocutore. Si tratta di un percorso di conoscenza congiunto che
viene fatto insieme dai due partecipanti al Dialogo. Anzi, paradossalmente, possiamo dire che
è l’interlocutore stesso, attraverso le sue risposte, a definire il tenore ed il ritmo della
conversazione. Egli, accompagnato dalla guida del professionista strategico, costruisce la
propria realtà alternativa.
Nel Dialogo Strategico le raffinate tecniche della sofistica, quali l'uso di antilogie e paradossi,
e il ricorso a una logica non lineare e non ordinaria, vengono sistematicamente studiate e
sperimentate come efficaci strumenti comunicativi, ancorando saldamente il modello
terapeutico non solo ai principi filosofici di Socrate, Aristotele, Platone, ma anche alla
innovativa teoria cibernetica-costruttivista.
35
Esistono grosso modo due tipi di retoriche utilizzate dagli psicoterapeuti strategici: la retorica
cartesiana (l’ésprit de géometrie), e la retorica pascaliana (l’ésprit de finesse).
L’utilizzo della prima è tipico delle terapie razionalistiche, basate sulle logiche ordinarie e sul
pensiero causale-lineare. Esse antepongono la cognizione all’azione, devono scoprire la realtà
esistente a priori e indagare sul passato, dunque il linguaggio ha in esse un ruolo euristico,
volto a scoprire una chiave di lettura per capire il dominio cognitivo della persona. Esso
spiega lentamente, e aumenta la consapevolezza dell’individuo in maniera molto graduale.
La retorica pascaliana è utilizzata, invece, anche se non da sola, nelle terapie suggestive,
ipnotiche, strategiche, brevi (basate sulla causalità circolare e sulle logiche non ordinarie), che
antepongono l’azione all’apprendimento in quanto devono costruire una realtà nuova e più
funzionale. Ecco che il linguaggio assume un ruolo decisamente costruttivista, si volge al
futuro, è figurativo, ingiuntivo, suggestivo, ha la funzione di scardinare repentinamente il
sistema percettivo della persona agendo sull’attenzione e quindi sull'emozione, determinando
solo successivamente l’azione. La parola è qui “parte del mondo”, condivisa, emotiva,
dialogica: costruisce e unisce.
36
Capitolo 2
Il Buio
In un elaborato riguardante il dialogo nel buio, era impossibile non dedicare almeno un
capitolo al buio, inteso sia nel suo senso reale e concreto, sia in quello metaforico.
A destare il mio interesse sull’argomento c’è anche il fatto, interessante e strano allo stesso
tempo, che sul buio si è scritto poco, a differenza che sulla luce. Come sottolinea Paolo Mauri
nel suo libro sul buio, “Del buio sappiamo poco e, forse, desideriamo sapere poco. Ci
portiamo dentro segretamente, magari di nascosto a noi stessi, uno degli incubi infantili:
ritrovarsi soli in una stanza al buio. Un buio assoluto, senza scampo. Popolato naturalmente di
presenze incerte, paurose. Un buio dal quale ci sentiamo inghiottiti. Il buio è anche tutto ciò
che non vediamo e non sappiamo. Vivendo nella luce artificiale delle città noi ci
dimentichiamo del buio, che invece, per chi vive a contatto con la natura, ha ancora una
presenza concreta. Il giorno corto del pieno inverno pesa nelle campagne molto più che nei
centri urbani. Il benessere e la rapidità dei trasporti ci permette di vivere in modo meno
ineluttabile l'alternarsi delle stagioni. L'estate si può inseguire cambiando emisfero. Anche il
buio si può sconfiggere, ma in qualche modo con lui e con ciò che rappresenta, (dalla notte
alla morte), dobbiamo fare i conti. Non dimentichiamo che il buio è al principio delle cose: è
ciò che non sappiamo ed è ciò che non sapremo.” (…) “Nessuno pensa mai per troppo tempo
al buio dell'universo, sicché anche nel buio va distinto un buio piccolo, a misura d'uomo, e un
buio immenso, quasi inconcepibile.” (Mauri, 2007).
Qual è l’etimologia della parola buio? Deriverebbe dal latino burìus, che significa rosso cupo.
Da qui, i francesi optano per noir, gli inglesi per dark, i latini per tenebrae, gli italiani per buio
nel quale Mauri sente un effetto sinistro a causa dell’aggiunta della “u” in mezzo alla parola.
Cerchiamo, ora, di definirlo questo buio, iniziando con l’enciclopedia Wikipedia. “L'oscurità,
o buio, o tenebra (anche se usato più spesso al plurale) è l'assenza di luce. I sentimenti
dell'uomo in assenza di luce sono stati fonte di metafore nell'ambito della letteratura, e di
simbolismo nell'arte. In questo campo, con l'uso del chiaroscuro, l'oscurità enfatizza o
contrasta la luce. Generalmente l'oscurità viene abbinata al male o al peccato.”
Un’altra enciclopedia (De Agostini, 1988) aggiunge che, in senso figurato, buio sta per
accigliato o corrucciato; ancora, si può definire buio qualcosa di cui si ignora l’esistenza. Già
in questa definizione si evincono le molteplici sfaccettature che questa brevissima parola può
assumere per l’essere umano.
Il buio attraversa tutti i campi della cultura e diventa oggetto di trattazione anche in
psicologia, filosofia, cinema, musica, teatro e così via. Perché il buio desta tanto interesse
nell’uomo? E’ qualcosa che suscita spavento, è il perturbante, lo straniero, il nascosto che
affiora, il naufragio nella notte, la notte tempestosa dove l’uomo si perde.
Ma andiamo con ordine e partiamo dai miti dei nostri maestri greci e romani, la cui funzione,
com’è noto, è quella di dare una spiegazione e una direzione ai fenomeni naturali, agli
interrogativi sulla condizione umana e sul cosmo.
Nella mitologia greca, infatti, il caos è lo stato primordiale di esistenza da cui emersero gli
dei. Esiodo, nella sua Teogonia, racconta che Caos diede vita a Gea (la Terra), Tartaro (gli
Inferi), Eros (Amore), Nyx (l'Oscurità della Notte) ed Erebo (le Tenebre degli Inferi). Il
Tartaro indicava l’Inferno dove il dio greco Zeus (per i latini Giove), nipote di Gea, aveva
rinchiuso i Titani, mostruosa stirpe di esseri sovrumani (generati sempre da Gea) che avevano
tentato di spodestare gli dei dall'Olimpo (Titanomachia). Essi, sconfitti dai tre fratelli Zeus,
Poseidone e Ade, vennero confinati in un luogo inaccessibile, appunto il Tartaro, che secondo
la visione greca si trovava sotto terra, ma comunque distinto dall'Ade, l'Inferno dei defunti
umani. Nyx (ripresa dalla mitologia romana come Nox), invece, era la personificazione della
notte terrestre, in contrapposizione al fratello Erebo (dal Greco Ερεβος "tenebre"), che
rappresentava la Notte del Mondo Infernale. Da Notte ed Erebo nacquero molti figli, primi fra
tutti Etere ed Emera, la Luce ed il Giorno. Etere era la personificazione divinizzata
dell'atmosfera intesa come cielo più puro, l'aria superiore che solo gli dei respiravano, in
contrapposizione all'aria respirata dai mortali. Gli altri figli di Nyx ed Erebo non erano vere e
proprie divinità, ma personificazioni di comportamenti e paure umane: le Esperidi (ninfe
custodi di oggetti e segreti), le Moire (esecutrici del destino, al servizio di Ade, che ben
rappresentano la mentalità fatalistica degli antichi greci), Eris (la Discordia), Hypnos (il
Sonno, che assieme alla Notte, generò Morfeo, il dio del Sogno, e il suo gemello Thanatos, la
Morte), Nemesis (la Vendetta), Momo (il Sarcasmo cacciato dall'Olimpo per aver criticato
aspramente Zeus), e altri ancora. Da qui si evince come buio, notte, luce, giorno, morte e
sogno fossero da sempre riferimenti importanti, tanto importanti da essere generati tra le
prime creature dell’Universo, e l’uno in relazione all’altro. La notte, ad esempio, è il luogo del
male, tempo privilegiato nel quale sono ambientate leggende delle tradizioni più diverse: di
notte circolano spiriti maligni, vampiri, mostri, tutte creature che devono nascondersi e sparire
non appena si fa giorno. E’ come se la luce potesse annientare più facilmente il male
disvelandone la presenza. Potrebbe esistere un film dell’orrore ambientato alla luce del sole?
38
Il male richiede quanto meno la penombra! Non solo: la notte si associa anche a
comportamenti illegali, come i furti, oppure, peccaminosi, e gli orari notturni favoriscono
incontri illeciti: non a caso è di notte che si compiono i sabba con assunzione di alcol e
droghe; non è un caso, ancora, che i locali americani dove si consumano alcolici siano bui
anche di giorno, quasi a sottolineare il proibizionismo della cultura protestante e la
trasgressività dell’uso di certe sostanze.
Non solo gli antichi Greci, ma anche gli Accadici, i Semiti e i Caldei fanno risalire la nascita
di tutte le cose al caos. Una leggenda, riprodotta su una piccola serie di sette tavolette, narra
che all'inizio dei tempi vi era la dea Tiamtu o Tiamat (che significa "abisso", "profondità"),
raffigurata come il Serpente mostruoso, possente e maligno, che spazza il mare ed abita la
notte. Ecco, di nuovo, la notte, questa volta in relazione ad un abisso che, in ogni caso, ricorda
ancora il buio. Tiamtu genera poi una stirpe di creature mostruose. Curiosamente ella viene
vista sia come la fonte del male e del caos, sia come grande madre, origine di ogni cosa e
degli stessi déi. Tiamtu viene infine sfidata e vinta da Belus (detto anche Bel-Merodach), il
dio del Sole, che sconfigge le orde mostruose di Tiamtu formate da spiriti maligni e dragoni
che oscurano con la loro presenza la Luna. E in più, per assicurare che il Creato possa
prevalere sul Caos di Tiamtu, Bel chiede agli déi di tagliargli la testa, perché il suo sangue si
mischi al suolo della terra e crei la stirpe degli animali, che preserveranno quest’ultima dalla
distruzione. Qui è il giorno con la sua luce a sconfiggere il buio e i suoi fantasmi, a conferma
di quanto il buio stimoli una delle paure più radicate nell’uomo.
Anche la Bibbia parla del Giorno Uno dell’universo, dove viene creata la luce che sconfigge il
buio; non viene neanche presa in considerazione l’ipotesi opposta, secondo cui è il buio che
dà riposo ad un mondo eternamente illuminato da Dio.
Ma vediamo come prosegue la teogonia greca. Dopo la sconfitta dei Titani, Zeus, Poseidone e
Ade tirarono a sorte per dividersi il mondo in precedenza governato dal loro padre titano
Crono (per i Romani Saturno). A Zeus toccò il cielo, a Poseidone il mare e ad Ade il regno
sotterraneo delle ombre e del buio. Come signore della Morte e della Rinascita, egli quindi si
allontana dalla famiglia olimpica, anche se ne partecipa a livelli più profondi. E, come
guardiano delle Ombre, deve prendersi cura di tutto ciò che rimane represso nell'individuo e
nella famiglia: segreti, vergogna, passioni occulte, perdite e rimpianti inespressi, separazioni,
legami finiti o irrisolti, emozioni negative e velenose. Custodisce ciò che viene sepolto e che
diventa poi per le generazioni future l'insieme dei complessi ereditati ma mai pensati e dunque
mai resi parlabili. Ade è associato con un’oscurità temibile, segreta, intoccabile; simboleggia
le zone più buie della vita psichica i cui aspetti sono perdita, rabbia, gelosia, dolore e morte.
La cultura che nega Ade bandisce la morte, il buio, e le emozioni negative. Ma queste
39
emozioni represse emergono come disperazione, perdita di significato, instabilità, oppure
sensazione di essere perduti o invisibili agli altri (Clark, 2004).
Tuttavia, ciò che è buio non evoca solo angosce e fantasmi, ma stimola anche la nostra
immaginazione. “Non sappiamo nulla dell'aldilà e dunque, di epoca in epoca, di cultura in
cultura e di religione in religione, ci affanniamo ad “arredare”, questo regno. Le tenebre della
morte diventano luogo di luce (di vita e dunque di resurrezione) per i cristiani.” (Mauri,
2007).
Ma cosa è l’inferno ?
L’Inferno è il luogo metafisico (o fisico) che attende, dopo la morte, le anime (o i corpi) degli
uomini preda del peccato, e dunque malvagi. Più propriamente, il termine "inferno" deriva dal
latino "infernus", cioè "posto in basso", "inferiore", ed è quindi sinonimo di "inferus";
tuttavia, la parola "inferno" è da riferirsi con precisione solo al concetto cristiano, mentre
l’espressione "inferi" si può, più ampiamente, riferire ai luoghi analoghi, come appaiono
rappresentati da tutte le altre civiltà pagane, antiche e moderne. Nella quasi totalità delle
culture, l'Inferno è caratterizzato da estremo dolore, enorme disperazione e tormento eterno. È
solitamente identificato con un mondo oscuro e sotterraneo, collegato all'operato del dio o
della creatura superiore che ha originariamente introdotto nella Creazione l'errore, la
menzogna, il peccato, e, in definitiva, il principio distruttivo dell'ordine delle cose; tale
creatura, a seconda dei casi, si identifica nel Diavolo, nella divinità del Male o
nell'ebraico/cristiano Satana. In tal senso il concetto di tentatore, o demonio, di inferno, e il
concetto stesso di male, sono intrinsecamente legati. Il tentatore, o divinità negativa,
solitamente genera, con il suo operato, tanto l’Inferno, quanto le condizioni che vi trascinano i
viventi.
Ad esempio, per gli Accadici, i Semiti e i Caldei gli Inferi, luoghi tenebrosi e situati in
profondità, sono abitati da creature mostruose, sorde ad ogni ragionevolezza e ad ogni bene
così come è umanamente concepibile.
Nei culti egizi antichi, invece, l'Inferno, Amenti, ha una valenza duplice: da un lato è il luogo
di soggiorno delle anime vuote, malvagie, dall'altro, la sede di creature primordiali e
mostruose, prima fra tutte Apep, Serpente gigantesco. L’uomo, alla sua morte, scende in
questo mondo sotterraneo, passando l'orizzonte occidentale attraverso Atmu, il dio del Sol
Ponente. La salvezza della sua anima dipende dalla preservazione del suo "doppio", che
risiede nella mummia o in una statua del suo corpo. Ma all’universo tenebroso di Amenti si
contrappone, almeno in parte, Seth (o Set), il dio del deserto, "del sole che prosciuga", ma
anche del tramonto del giorno e della distruzione delle cose. Questa figura ha una valenza
duplice rispetto al concetto di bene e male, perché se da un lato è il dio della dissoluzione e
40
della consunzione del duplice della persona morta, dall'altro è uno degli dei che protegge la
barca di Ra, dio del Sol Levante, che, nottetempo, transita negli Inferi per risorgere
nuovamente il mattino dopo. Ra viene attaccato da Apep per impedire che sorga il mattino, e
Seth lo difende, gettando al collo del mostro una catena di ferro, che gli fa rigettare ciò che ha
inghiottito nella sua fame mostruosa (le rare volte in cui non vince, si ha un'eclissi di sole…).
Ecco, di nuovo, luce e buio che si contrappongono.
L’inferno è stato descritto anche dal poeta inglese John Milton nel suo "Paradiso Perduto".
Egli narra la caduta di Satana/Lucifero, dalla cui stessa iniquità nacque l'Inferno, per volontà
divina. Dio stesso, dunque, dispose la creazione di un luogo di eterna e totale oscurità e
sofferenza, nel quale poter esiliare gli angeli ribelli, che per Sua volontà non annichilì. La
descrizione che Milton dà dell'Inferno è una delle più spaventevoli ed impressionanti della
letteratura e dell'immaginario poetico: « (...) egli subito osserva quell'aspro e pauroso e
desolato luogo, quella prigione orribile e attorno fiammeggiante, come una grande fornace, e
tuttavia da quelle fiamme nessuna luce, ma un buio trasparente, una tenebra nella quale si
scorgono visioni di sventura, regioni di dolore e ombre d'angoscia, e il riposo e la pace non si
troveranno, né mai quella speranza che ogni cosa solitamente penetra; e solo una tortura senza
fine urge perenne, e un diluvio di fiamme nutrito di zolfo sempre ardente, mai consunto (...)
» (Milton, 1667). Si badi, per inciso, che il nome dell’angelo caduto all’inferno, Lucifero,
significa portatore di luce.
Si potrebbe continuare così per secoli e secoli, culture e culture, letteratura e letteratura, ma
mi fermerò qui. Luogo metafisico o reale, di ombre o anime, l’inferno è per tutti, “una selva
oscura”, nella quale, ovviamente, il sole non penetra mai.
Nei miti greci Ade è la personificazione di quel mondo sotterraneo e pieno di ombre che è
l’Inferno, ma anche di Plutone, dio romano della morte, che vi regna. La discesa agli Inferi
(catabasi), il passaggio tra questo e l’altro mondo, è molto ricorrente nel mito. In psicoanalisi
essa rappresenta un’efficace metafora della discesa terapeutica nel represso, nei tabù e negli
aspetti sconosciuti di se stessi. Lo psicoanalista Carl Jung (1944), nella sua autobiografia
scrive in proposito: "La paura e la resistenza che ogni essere umano prova istintivamente
quando incomincia a scavare troppo in se stesso è, in fondo, la paura della discesa agli inferi.
Se ci fosse soltanto resistenza non sarebbe poi troppo male. In realtà, invece, il substrato
psichico, l'oscura area dell'ignoto, esercita una fatale attrazione che minaccia di diventare
sempre più potente quanto più si penetra in esso." E in effetti, lo psicoanalista ha sperimentato
in prima persona una sorta di caduta negli inferi, dato che, a 38 anni, ebbe un incidente, una
frattura e un infarto, restando in coma e vivendo un'esperienza di pre-morte. Lui stesso definì
questo episodio la sua Nekyia, lo stesso rituale attraverso cui Odisseo convoca le ombre (le
41
anime dei morti) per ottenere consigli circa la fase futura del suo viaggio. Anch’egli, come
l'eroe greco, avrebbe trovato le ombre e le guide per la sua discesa nel mondo sotterraneo
(Clark, 2004).
In quanti sono scesi agli inferi? L’epica ci tramanda che Odisseo è sceso per incontrare
l’ombra dell’indovino Tiresia, Enea è sceso insieme alla Sibilla Cumana, Dante con la sua
guida Virgilio. E di nuovo la mitologia greca e romana ci illustrano alcuni dei viaggi.
Persefone, ad esempio, figlia di Zeus e di Demetra, venne rapita da Ade, dio dell'Oltretomba,
che la portò negli Inferi per sposarla, ancora fanciulla, contro la sua volontà. Una volta lì le
venne offerta della frutta, ed ella mangiò senza appetito solo sei semi di melograno. Persefone
ignorava però il trucco di Ade: chi mangia i frutti degli Inferi è costretto a rimanervi per
l'eternità. La madre, dea dell'agricoltura, che prima di questo episodio procurava agli uomini
interi anni di bel tempo e fertilità delle terre, reagì adirata al rapimento impedendo la crescita
delle messi, e scatenando un inverno duro che sembrava non avere mai fine. Con l'intervento
di Zeus si giunse ad un accordo, per cui, visto che Persefone non aveva mangiato un frutto
intero, sarebbe rimasta nell'Oltretomba solo per un numero di mesi equivalente al numero di
semi da lei mangiati, potendo così trascorrere con la madre il resto dell'anno. Demetra, quindi,
accoglieva ogni volta con gioia il ritorno di Persefone sulla Terra, facendo rifiorire la natura
in primavera ed in estate, e i Greci si spiegavano così l'alternarsi delle stagioni. La versione
romana della dea greca Persefone (o Kore) è Proserpina, il cui nome potrebbe derivare dalla
parola latina proserpere ("emergere"), a significare la crescita del grano. Infatti, in origine,
ella fu senza dubbio una dea agreste. Viene anche identificata con la dea Libera. Ecco
l’emergere, il crescere, alla luce, in contrapposizione al buio dell’Inferno nel quale era
costretta a vivere per sei mesi. E’ evidente, infatti, come i sei mesi autunnali e invernali siano
anche quelli più bui, mentre quelli primaverili ed estivi i più luminosi.
Euridice, invece, era una driade, una ninfa dei boschi. Sposò Orfeo, e morì per il morso di un
serpente mentre camminava in un prato. Secondo Virgilio e Ovidio, ella cercava di sottrarsi
alle attenzioni di un dio, Aristeo. Orfeo, disperato, cantò canzoni così cariche di disperazione
che tutte le ninfe e gli dei ne furono commossi. Gli fu consigliato di scendere nel regno dei
morti per tentare di convincere Ade e Persefone a far tornare in vita la sua amata; così fece e
le sue canzoni fecero persino piangere le Furie. Ade e Persefone si convinsero quindi a
lasciare andare Euridice, a condizione che Orfeo camminasse davanti a lei e non si voltasse a
guardarla finché non fossero usciti alla luce del sole. Quando però Orfeo non udì più i passi
della moglie, si voltò per guardare se lo stesse ancora seguendo, e vide l'anima di Euridice
sprofondare nell'Ade, questa volta per sempre. Ed ecco, questa volta, un non ritorno, ma un
permanere nel buio di qualcuno che comporta la sofferenza per qualcun altro, e per sempre.
42
Anche depressione e malinconia si possono spiegare con la metafora della discesa agli inferi.
Uno storico, conducendo un’indagine riferibile a 2500 anni sugli atteggiamenti verso la
malinconia e la depressione, ha concluso che le due immagini più ricorrenti che rinviano a
questi stati sono “essere immersi nell'oscurità ed essere oppressi da un enorme peso"
(Jackson, 1986). Il familiarizzarsi con l'atmosfera infera aiuta psicologicamente ad accettare il
mondo alieno in cui si precipita durante le fasi di depressione, disillusione, dubbi esistenziali,
o passaggi vitali importanti. Al riguardo, è emblematico il modo in cui Paolo Mauri spiega gli
stati depressivi. “Essere depressi è appunto una forma dell'essere sulla quale nulla incide. Il
depresso è lucido, sa che cosa sta attraversando. Si nutre di psicofarmaci nel tentativo di
uscire dall'impasse, vorrebbe trovare la ragione, ma la ragione non c'è. Se ci fosse una ragione
vera, la depressione sarebbe facilmente eludibile: basterebbe il buon senso, la consolazione, il
diversivo, ad abbassarne il tasso. Invece essa è un buio in presenza di luce. Il depresso vede
tutto, ma non sa che farsene. È morto mentre è vivo, lo sa e soffre terribilmente.” (Mauri,
2007).
Grazie al cielo, non esiste solo un buio terrificante, infernale, pauroso. C’è, ad esempio, il
buio che precede il mattino nel quale si immerge chi va a lavorare presto. Questo buio è
domestico, pieno di rumori e profumi famigliari, tipico di una città che si sta svegliando. Qui
si incontrano gli ultimi che vanno a dormire e i primi che si sono alzati. In questa oscurità di
certo non si incontreranno creature infere o mostruose!
E anche le tenebre, non sempre sono così oscure. La luce della notte, la luna, rende
l’atmosfera particolare, quasi magica, e l’oscurità esalta la profondità e le mille luci del
firmamento, che invitano al sogno, al desiderio, aprendo il nostro sguardo sull’Infinito.
Ma torniamo al “proserpere”. Uscire dal buio dell’Inferno è la metafora della nascita, della
rinascita, del venire alla luce o al mondo.
La luce è la "novità assoluta" in cui si imbatte il neonato: è stato ipotizzato, per primo fra tutti
da Otto Rank, che la prima fantasia neonatale sia proprio quella di farla sparire, di "fare buio",
di ritornare "al buio e all'acqua dello stadio intrauterino" (Galzigna, 1995).
E allora come mai in alcuni bambini si manifesta la paura del buio?
Innanzitutto, vediamo la definizione che la dott.ssa Oliverio Ferraris (2001) dà della paura.
“La paura è una delle emozioni fondamentali con cui noi nasciamo e che, come ogni
emozione, ci serve per strutturare il nostro mondo, la nostra vita. Non bisogna lasciare che
essa superi certi limiti e che diventi invasiva, perché la si contrasta individuando i modi per
fronteggiarla. Se noi pensiamo di poter avere un controllo su certe situazioni, la paura
diminuisce lasciando spazio alla razionalità che interviene per trovare possibili soluzioni.
Invece in certe situazioni la paura finisce per diventare terrore, soprattutto quando pensiamo
43
di non avere vie d'uscita. È importante dunque che si impari fin da piccoli a valutare i modi
per fronteggiarla, che sono tanti e diversi. La paura è sempre istintiva, poi si colora in base a
fattori culturali. Naturalmente ogni epoca ha le sue paure.” A suo avviso, inoltre, tutte le paure
originano dalla consapevolezza che noi siamo persone finite e che un giorno moriremo. Va
anche aggiunto che, per Oliverio Ferraris, “la paura è molto contagiosa, perché noi siamo
degli animali gregari che vivono in gruppo, e se qualcuno individua una minaccia, la trasmette
agli altri attraverso segnali specifici. Scatta l’allarme che, spesso, anziché venire elaborato al
fine di trovare una soluzione adeguata per fronteggiarlo, si trasforma in panico
incontrollabile”. Condividere le paure, parlarne con gli altri, può aiutare ad esorcizzarle. Tra
le cause della paura, c’è l’ignoranza: si ha paura di situazioni nuove, complesse, che non si sa
come risolvere, perché sin dall’infanzia non sono stati forniti gli strumenti adeguati allo
scopo. “Più si conosce, in genere, più la paura diminuisce. Maggiore è la conoscenza e minore
è la paura. L’esperienza insegna, anche se talvolta è traumatizzante”. Per contro, “più si lascia
passare il tempo, più c'è il rischio che s'ingigantisca a causa della nostra immaginazione”
(Oliverio Ferraris, 2001). Le paure sono, spesso, sane, perché aiutano a proteggerci dai
pericoli. Già a sei mesi i bambini sanno distinguere alcune situazioni pericolose. Osservando
l’ambiente circostante e le altre persone, i piccoli apprendono cos’è il pericolo e cosa non lo è.
In questo senso, è importante che chi si prende cura di loro non trasmetta i propri timori, se
ingiustificati. Osserva Oliverio Ferraris che “il neonato alla nascita ha paura dei rumori forti,
del dolore, ma non del buio, perché viene da un luogo buio. Avrà paura del buio intorno ai
due, tre anni, perché si sarà abituato alla differenza luce/buio, dunque capirà che al buio ha un
minore controllo della realtà. Quindi ha la paura non del buio, ma nel buio”. Un errore, ad
esempio, è far dormire il bimbo con la luce sempre accesa, anche se la situazione non lo
richiede: in questo modo, si altera una sua abitudine fino al punto che avrà paura se la luce
resterà spenta. Inoltre, quando i piccoli iniziano ad andare al nido, all’asilo, a guardare la
televisione, accedono ad altre possibili fonti d’influenza negativa. I mostri, ad esempio, che
per l’adulto sono creature inesistenti, sono considerate reali dai nuovi fruitori della tv. Per
questa ragione, quando di notte si percepiscono molto più forti dei rumori che di giorno sono
impercettibili, come cigolii o scricchiolii, i bambini, che non capiscono cosa sta accadendo
intorno, li associano a programmi televisivi spaventosi e si spaventano. Alcuni esperti
(Redazione di Universo Online, 2005) affermano che, in questi casi, non è auspicabile
combattere la paura portandoli nel letto dei genitori, ma è meglio che sia uno dei due ad
andare nella loro stanza spiegando da cosa sono provocati i rumori in modo che non li
associno a cose irrealistiche, e non temano che mostri spaventosi possano annidarsi nel buio.
44
Più i genitori si mostrano sicuri di sé, per niente spaventati, più il bambino riesce ad elaborare
la sua paura ed a cacciare i mostri della notte dalla sua vita.
In effetti, di notte, i più piccoli tendono a spaventarsi con facilità anche perché, vedendosi soli
e sapendo i genitori addormentati in un’altra stanza, non si sentono protetti da loro come di
giorno. A questo proposito, occorre capire con chiarezza anche di cosa hanno realmente
paura: è facile che lupi, mostri e fantasmi diventino i veicoli simbolici di angosce e timori che
un bimbo non sa rappresentarsi in modo migliore (Proietti, 2005). A questo riguardo è
importante ciò che i bambini vivono o vedono durante la “luce”, cioè il giorno. Ciò che
colpisce in maniera negativa durante il giorno, può portare ad avere paura della notte e del
buio, in quanto timori e paure si possono “materializzare” (Cavaliere, 2007). E poi, ci sono i
brutti sogni: i bambini che si svegliano dopo un incubo, con grande difficoltà capiscono che
quelle immagini, quelle storie che l’hanno spaventato sono solo nella loro testa e non nella
realtà (Proietti, 2005).
Inoltre, il Padre della Psicoanalisi ha, a suo tempo evidenziato che l'apparizione delle paure
notturne (e non solo), così come un certo tipo di incubi, tende a rafforzarsi solitamente con lo
sviluppo del complesso di Edipo, legato a sentimenti forti come amore, rabbia e colpa. La
violenza ad essi associata trova uno sfogo simbolico nell'apparizione dei mostri della notte.
Freud, com’è noto, non mancava di concettualizzare i complessi meccanismi di difesa tramite
i quali i piccoli trasformano la loro stessa aggressività in mostri dai quali devono difendersi. E
in più, a proposito dell’angoscia legata al buio, egli stesso precisa che i bimbi “hanno paura
del buio perché nel buio non possono vedere la persona che amano” (Baldini, 2004).
La paura del buio, che a volte raggiunge anche un’intensità fobica (tecnicamente
“acluofobia”, dall’antica parola achluo, tenebra, d’origine greca, o anche “scotofobia”, dal
greco σκότος, oscurità; la nictofobia è limitata alla paura del buio esclusivamente notturno), è
molto comune tra i due e i cinque anni, età in cui i piccoli accrescono la loro percezione del
pericolo. Col tempo, la maggior parte delle paure, comprese queste, vengono “esorcizzate” o
perdono d’intensità fino a sparire. Tuttavia, spesso i timori più grandi, razionali o irrazionali
che siano, continuano a rimanere nell’ombra, pronti a venir fuori nei momenti in cui si è più
vulnerabili, nei momenti bui della nostra vita, e a volte, magari…proprio quando siamo al
buio.
Ciò dipende, in parte, dal fatto che il buio può aumentare anche lo stress. Fa parte
dell'esperienza di ciascuno di noi il camminare in un vicolo buio e non sentirsi sicuri, oppure
il sobbalzare dallo spavento al più piccolo rumore! L'oscurità diventa ansiogena sopratutto in
condizioni che vengono definite di stress sociale, quali per esempio la percezione di vivere in
un luogo poco sicuro. Christian Grillon (1997), che si occupa da anni di studiare la
45
neurobiologia dell'ansia e i disturbi dovuti all'ansia, ha misurato, in uno studio condotto
assieme ad un gruppo di ricercatori americani del National Institute of Mental Health, quello
che in inglese si chiama "startle reflex", ossia la risposta con un sobbalzo a stimoli uditivi o
visivi. E' stato osservato che quando i volontari venivano stimolati con suoni, rumori o
immagini in condizioni di luce, essi avevano più controllo delle loro reazioni; al contrario,
sottoposti agli stessi stimoli ma in stanze completamente al buio, mostravano un aumento
significativo dello "startle reflex". Questi dati sperimentali, quindi, suggeriscono che
condizioni di stress psicologico, come quelle che qualcuno può sviluppare stando al buio,
aumentano l'ansia e alterano la risposta del sistema nervoso. In passato era già stata verificata,
in soggetti affetti da disturbi d'ansia, la presenza di una minore soglia di sopportazione di
stimoli esterni, che aumenta le reazioni emotive incontrollate come i sobbalzi; tuttavia,
l'importanza di questo studio sta nell’aver rintracciato una relazione tra stress-buio e startle
reflex proprio in soggetti sani.
Non a caso, quindi, l’ombra, l’oscurità, il buio, sono simboli così forti nel nostro
immaginario, da aver ispirato anche il pensiero di Carl Gustav Jung. L’Ombra era per lui
sinonimo di Inconscio, o meglio quell’inconscio personale freudiano che a suo avviso era solo
una parte di un più vasto mondo ai confini della nostra consapevolezza, un inconscio
collettivo e gruppale da cui emergeva e prendeva forma quello individuale. Gli archetipi che
abitano l’Inconscio Collettivo, tra cui appunto la stessa Ombra, rappresentano per questo
Autore le tendenze innate strutturanti la psiche stessa, le quali si rivestono delle immagini
assorbite dalla cultura dei popoli. Ogni archetipo ha una valenza dinamica, richiede
un’integrazione, un’evoluzione che concili delle istanze apparentemente opposte. Scrive Jung
(1938-40): «ognuno di noi è seguito da un'Ombra e, meno questa è incorporata nella vita
conscia dell'individuo, tanto più è nera e densa […] Se le tendenze dell'Ombra, che vengono
rimosse, non rappresentassero altro che il male, non esisterebbe alcun problema. Ma l'Ombra
rappresenta solo qualcosa di inferiore, primitivo, inadatto e goffo e non è male in senso
assoluto [...]”.E' chiara in queste parole la relazione tra Ombra e capacità creativa: nell'atto in
cui la coscienza si china sull'Ombra, ponendosi in dubbioso ascolto, assieme alle espressioni
inaccettabili ode anche la voce del creativo che sta in noi faticosamente facendosi strada.
Questo perché l’Ombra non si esaurisce nel rimosso e nell’inaccettabile, non comprende solo
la dimensione dell’inconscio individuale, ma abbraccia anche luoghi e funzioni che oggi
vengono attribuite al preconscio. Jung, infatti (1943), rintraccia in essa anche “percezioni
cosiddette subliminali, cioè percezioni sensorie che non sono abbastanza intense da
raggiungere la coscienza”, e “contenuti che non sono ancora maturi per la coscienza”,
identificando quindi nell’Ombra un movimento eruttorio dal basso verso l'alto, che porta
46
verso gli strati psichici superiori sino a fondersi con la coscienza dell'Io, allargandone
l'orizzonte attraverso molteplici nuclei luminosi di coscienza. Come fautore del dialogo tra
conscio e inconscio, essa appare un aspetto determinante del processo di individuazione.
Negare l’Ombra è negare quella parte di noi che esige un confronto dialettico tra le parti della
nostra psiche. Il rifiuto dell’Ombra conduce alla non crescita, verso ruoli rigidi della Persona
(il cui significato latino è maschera).
Viceversa, «il diavolo è una variante dell'archetipo Ombra, vale a dire dell'aspetto pericoloso
della parte oscura dell'uomo quando non è riconosciuta.” Il suggerimento "terapeutico" di
Jung , a questo riguardo, è ironico e amaro: «è sempre preferibile sapere cosa c'e nella nostra
Ombra, affinché il diavolo non si impossessi di essa» (Jung, 1943).
Ecco che quindi, le metafore della psicologia analitica junghiana ci aiutano a capire come ciò
che è nell’ombra, apparentemente oscuro e inaccessibile, sia fonte di possibili pericoli, ma
anche di nuove potenzialità da scoprire….
Un luogo buio ci aspetta. Letteralmente. Quali emozioni si risvegliano in noi?
I luoghi hanno un’anima, dice Hillman (2004), esattamente come le persone. Un tempo,
nell’antichità, le potenze apparivano in luoghi specifici: sotto un albero, presso una sorgente,
un pozzo, su una montagna, in un pianoro, all’ingresso della tana di un serpente. Gli uomini
circondavano il luogo di pietre, per proteggere la sua interiorità, e vi costruivano templi,
consacrati ad esse. Facendo sacrifici al Genius loci, si fondavano le città. Si pensava che
l’esercizio del pensiero non fosse indipendente dallo spazio/luogo in cui si abitava e che
determinasse gli atteggiamenti stessi dell’essere umano, un’idea che anticipa di molto le
moderne concezioni della psicologia ecologica.
Oggi, il funzionalismo razionalistico cela l’interiorità dei luoghi. Vediamo ciò che appare. Ma
nel buio, appunto, non possiamo vedere. Cosa resta allora?
Quasi tutto, e forse molto di più. Gran parte di ciò che esiste, del resto, si cela allo sguardo, è
nascosto, come confermano anche le più recenti ipotesi cosmologiche sulla materia oscura.
Gli scienziati si sono accorti che la materia che si «vede», che si percepisce attraverso qualche
forma di radiazione elettromagnetica, rappresenta solo il 4% dell’Universo stimato (Hack,
2007); il resto appare invisibile anche agli strumenti tecnologici più avanzati, ma fa sentire la
sua presenza e i suoi effetti in altri modi.
La profondità, quindi, contempla distanze che la nostra mente neppure immagina. E,
metaforicamente, conduce al mondo infero, il mondo dei sogni che Freud e Jung, sostiene
Hillman (1979), pensarono di poter interpretare col linguaggio della veglia. Volevano
spingere il sogno verso la luce del giorno, vedevano in esso il completamento archetipico
della personalità, l’appagamento dei desideri, le premonizioni, i «residui» della vita
47
quotidiana. Ma a volte, la luce del giorno è solo apparentemente chiarificatrice. I sogni, scrive
Hillman con un’immagine wagneriana seducente, «sono opera di gnomi che lavorano la notte,
fabbri del mondo infero che forgiano labirinti, artigiani che non smettono mai di creare
forme» (Hillman, 1979). Sovente, queste forme sono ambigue, indecifrabili, oscure.
L’oscurità s’introduce speculativamente nel profondo dei significati senza risolverli,
rimuovendoli e soggiacendo a quel buio nel quale stanno ancora acquattate le belve
mitologiche, le gorgoni, le sfingi, con le quali, fin dai tempi più antichi, gli uomini hanno
cercato risposte alle proprie inquietudini esistenziali, nel tentativo di costruire un mondo
rassicurante e opposto, luminoso, un mondo razionalmente comprensibile. Da qui si
comprende che l’uomo dal buio si ritragga sgomento: che la vita umana sia una disperata,
vana fuga dall’oscurità. E che i sogni, spesso, facciano paura. Ma non bisogna temere ciò che
ci costituisce. Non esiste giorno senza notte, e viceversa. E non sempre è utile, o positivo,
portare alla luce tutto ciò che in ombra. Come ricorda Mauri (2007), la psicoanalisi ci ha
insegnato che “la macchina umana poggia su un equilibrio fragile e portentoso al tempo
stesso: il disvelamento, o l'illuminazione integrale, non vuol dire affatto il raggiungimento di
un maggior benessere o di una maggior consapevolezza”. Troppa luce acceca e ferisce. Non
solo è necessaria cautela, nell’esplorare le nostre zone buie, ma non è consigliabile, e
nemmeno
possibile, comprendere ed analizzare ogni cosa (vedi paradigma della
supplementazione). Questo non solo per il fatto che certe rimozioni sono sane e necessarie,
ma soprattutto perché è dal mistero, da ciò che è indefinito, e indefinibile, da quel quid di
incomprensibilità irriducibile, che originano creatività e trasformazione. Psiche trovò l'estasi
con Amore (il dio greco Eros) nella notte più buia e più profonda. Quando volle guardare alla
luce la sua bellezza, una goccia d’olio dalla lampada cadde sulla pelle di lui, che, ferito, fuggì
via.
Del resto, più chiaramente vediamo qualcosa, più il nostro sguardo sfugge ed esclude il resto.
E’ il potere, ma anche il limite, della visione focalizzata, logica e razionale.
Come osserva in proposito Paolo Mauri, “sappiamo ormai da qualche secolo che non ci
possiamo fidare della cosiddetta esperienza, di ciò che solo in apparenza è ragionevole. Noi,
“vediamo”, il sole che gira intorno alla terra, ma in realtà accade il contrario. Dunque ciò che
appare chiaro è in realtà oscuro: un buio che non si vede è ancora più ingannevole del buio
che cade sotto i nostri sensi. Noi non possiamo dubitare di tutto ciò che sperimentiamo: non
vivremmo più. Ma dobbiamo essere pronti a rimettere in discussione le nostre certezze,
poiché potremmo essere, “al buio”, senza saperlo. Il buio metaforico è dunque più difficile da
dissipare del buio reale, poiché quest'ultimo si vede e in qualche modo si tocca, mentre il buio
metaforico ci avvolge senza che lo sappiamo.” (Mauri, 2007).
48
Il buio ci fa paura ma, al contempo, è anche necessario, tanto che, per dormire, siamo costretti
a chiudere porte e finestre per crearlo. In un luogo a noi familiare, muoverci al buio non
spaventa, ma in luoghi bui e sconosciuti, l’oscurità copre e nasconde ogni cosa, e noi
brancoliamo con le mani protese in avanti per orientarci. Mauri immagina un parallelismo tra
il buio reale e quello del cammino della nostra vita, un viaggio a tentoni durante il quale
illuminiamo, una dopo l’altra, le nostre giornate senza sapere dove questo viaggio si
interromperà.
Il buio, quindi, custodisce molte cose, ma non le rivela. Noi vediamo solo ciò che è
illuminato, senza renderci conto di quanto è sommerso perché dimenticato, o non ancora
conosciuto: religioni, libri, saperi. E’ a questo punto, ancora una volta, che intervengono i
miti: essi custodiscono tradizioni senza tempo, per le quali, in realtà, esiste anche una vera e
propria data di nascita. In fondo, è più facile credere che sapere. Pensiamo, ad esempio, a
quante informazioni sui nostri antenati, come bisnonni o trisavoli, ci sono precluse, ed a
quanta indifferenza c’è, spesso, verso queste parti della nostra famiglia, che, comunque, ci
sono abbastanza vicine. Non è anche questo un modo per circondarci di buio? Lo stesso si può
dire dei nostri gusti o inclinazioni personali, che portano ad accendere lucine solo su quanto è
di nostro interesse lasciando in ombra molta parte del sapere comune.
Del resto, al giorno d’oggi ormai, l’unica oscurita alla quale gli esseri umani sono abituati è
quella confortante della stanza da letto, e la notte sembra una prosecuzione ininterrotta del
giorno, poiché fanno da padrone le luci delle insegne, i lampioni e così via. Le tenebre delle
campagne di cinquanta anni fa, invece, potevano essere complete, totali, avvolgenti e
disorientanti. Il buio dell’interno, in casa, e quello dell’esterno, la città, sono molto diversi tra
loro. “Ogni sera noi sconfiggiamo il buio con la semplice pressione di un dito su un
interruttore. Il progresso tecnologico ha inventato il giorno artificiale, il giorno infinito. È
stata una battaglia lunga contro la tenebra, che prima era appena scalfita dalla fiamma del
fuoco o dalla luce esigua di una candela, che tremolando rendevano spesso ancora più
suggestiva e terribile la tenebra circostante.” (Mauri, 2007). Nelle favole, ad esempio, era
spesso salvifica un’unica e piccola lucina che faceva da guida al disperso nella buia e intricata
foresta, il quale, in questo modo, riusciva ad uscirne, e a farsi aiutare a trovare la strada di
casa. “Il buio interno rende il noto ignoto, specie se la casa è la nostra e cerchiamo a tentoni di
ristabilire distanze e misure per trovare magari una candela, una pila o l'interruttore della luce.
Da bambini il buio di una stanza ci incuteva un disagio terribile. Il buio esterno raramente è
così fitto, e anche la notte più cupa e nuvolosa lascia intravedere in lontananza qualche
spiraglio”. (Mauri, 2007).
49
Josè Saramago (1995), nel suo libro “Cecità”, realizza un’ottima apocalisse di quel che
potrebbe succedere se tutti, all’improvviso e inspiegabilmente, fossero colti dal “mal bianco”,
un latte che si posa sopra gli occhi e impedisce a chiunque di vedere qualsiasi cosa. Privati del
bene più prezioso, la vista, gli uomini non sono più in grado di far nulla. Così, piano piano,
parallelamente al diffondersi dell’epidemia di cecità, tutta l’energia elettrica sparisce, creando
un black out generale: nei frigoriferi il cibo si decompone, l’acqua corrente non esiste più (c’è
solo quella piovana). Le persone si riducono a selvaggi in giro per strada, nell’inutile tentativo
di trovare cibo; tuttavia, disorientati, non riescono più a ritornare a casa, e quindi dormono,
urinano, defecano e muoiono in qualsiasi punto del mondo, diventando prede succulente di
cani affamati. Ecco che però, d’improvviso, l’epidemia scompare e tutti riacquistano la vista,
ma questo che mi è parso un tragicomico e realistico romanzo mette in luce quanto siano
davvero importanti luce e tecnologia per la sopravvivenza degli uomini, che ne sono
condizionati. Per non andare troppo lontano immaginiamo, ad esempio, cosa succede ogni
volta che c’è un black out nelle nostre case. La società moderna è vulnerabile a queste
improvvise interruzioni di luce, perché si fermano le attività governate dall’elettricità che,
ormai, sono praticamente tutte: si bloccano gli ascensori che impediscono di arrivare
comodamente all’ultimo piano di un grattacielo, i mezzi di trasporto per la maggior parte si
interrompono, i telefoni cordless si disattivano, i frigoriferi si spengono, riscaldamenti e acqua
calda sono inutilizzabili, e i computer e gli archivi elettronici diventano inaccessibli, con tutte
le conseguenze del caso.
E cosa dire di cinema e teatro?
Entrambi presuppongono che lo spettatore guardi, dal buio, le azioni che si svolgono sullo
schermo o sul palcoscenico illuminati. Il cinema, in particolare, è una realtà a sé: spesso lo
spettatore si reca al cinema da solo, l’intervallo illumina la sala disturbandolo, ed egli spera
che il buio lo inghiotta nuovamente, per potersi sottrarre alla curiosità dei vicini di posto e
tornare alla realtà totale del film, che si può abbandonare definitivamente solo quando lo
spettacolo termina: a questo punto ci si sente autorizzati ad uscire dal buio, e a tornare alla
quotidiana realtà.
Inoltre, il buio favorisce l'equivoco che presiede alle situazioni comiche. E’ il momento più
propizio per infliggere ad altri ciò che non si aspettano, o per compiere gesti sbagliati,
credendo in buona fede di non averli affatto compiuti. Ma, spiega Mauri, in questi casi il buio
è soprattutto quello mentale, indotto dalla stupidità o scioccaggine di alcuni personaggi, fatti
apposta per essere oggetto di burle, anche pesanti. “La comicità usa il buio, (il non vedere, e il
non sapere per traslato), come un bersaglio facile. La risata che ne scaturisce si fonda sul
gusto della sorpresa fatta al malcapitato (lo spettatore o lettore è naturalmente in salvo, in
50
territorio neutro rispetto al luogo dell'azione), e sulla crudeltà di chi si gode le altrui sciagure.
Una crudeltà soft, s'intende, che tuttavia è necessaria per cogliere il senso delle beffe e gustare
il danno del beffato.” (Mauri, 2007).
Da queste poche pagine emerge chiaramente l'importanza del buio e di quanto ruoti attorno
all'oscurità, e la ricchezza dei suoi significati. Ritengo un peccato il fatto che non esistano
"buiologie" (Bonaviri, cit. in Mauri, 2007): a mio avviso, ciò rispecchia la difficoltà
dell’essere umano di approcciarsi a questa tematica. Sarà un caso che un simile capitolo sia
stato scritto da una persona non vedente?
51
Capitolo 3
Dialogo nel buio
Premessa
I cambiamenti economici, sociali e tecnologici hanno trasformato l’antica società solida in un
apparato liquido (Bauman, 2006). Oggi fanno da padroni sentimenti di insicurezza, di
precarietà e di crisi, di impotenza e disgregazione finora elusi o negati. L’essere umano ha
paura della relazione, preferisce evitare attaccamenti profondi o appartenenze troppo forti che
creino legami che potrebbero far soffrire e al contempo ostacolare la possibilità di
sperimentare nuove realtà.
Da questo stile di vita ha origine una nuova modalità difensiva socializzata, il non-gruppo
(Kaneklin, 2001) (nel privato vi è il rischio della non-relazione), nel quale prevalgono legami
sfuggevoli che possono essere interrotti a discrezione di ognuno, e dove prevale un’illusoria
tutela del sé. Il non-gruppo, dunque, ha come effetto l’impoverimento del sé e la riduzione
degli spazi di pensiero. Si sviluppa una sorta di“pensiero corto”, basato sulla rapidità delle
decisioni e delle reazioni, a scapito della profondità delle analisi, e ristretto su faccende
“private”. In questo modo, però, si perde la possibilità di apprendere dalle altre persone e dal
confronto con la loro esperienza.
Un altro limite di questa nuova società, così veloce e superficiale, è di non attribuire
importanza alle emozioni: l’infelicità, ad esempio, non va vissuta ed elaborata, ma
assolutamente evitata e considerata patologica. L’unico modo per arginarla, sembra essere
quello di inebetirsi con psicofarmaci (Ceronetti, 2006). A proposito della possibilità di
esternare le proprie emozioni, sono cambiati anche i mezzi per farlo. Il mondo è dominato dal
prevalere della schiavitù del tutto subito, un fast food che investe anche i sentimenti che si
consumano in fretta. Se prima, ad esempio, scrivere al partner delle proprie emozioni era
frutto di meditazioni, riletture e correzioni, l’avvento di cellulari e e-mail ha reso anche questo
processo rapido, quasi maniacale, senza che siano più considerate le ricadute che le parole
scritte continuano ad avere sui riceventi di questi flash emotivi.
In sintesi, come è ben esplicato in uno stralcio del discorso che la dott.ssa Corbella ha scritto
per un convegno de Gli Argonauti, dal titolo “Emancipazione e…”, “spesso il
bombardamento di informazioni, la rapidità delle innovazioni fanno erigere rigide barriere
difensive che impediscono la possibilità dello scambio e di un vitale ricambio. Così, a livello
personale e sociale, il nuovo, il diverso, sia esso un individuo, un progetto o un’idea vengono
avvertiti più come potenziali invasori che come potenziali apporti creativi.”
E’ in questa cornice che nasce Dialogo nel buio, un porto accogliente dove si incontrano gli
abitanti di questa enorme società: bambini e anziani, neri e bianchi, disabili e normodotati,
uguali e diversi.
Questo porto si contrappone a tutte le caratteristiche della società descritte finora: è un luogo
di lenta e attenta riflessione, un laboratorio dove vivere e sperimentare emozioni, sensazioni,
vicinanza e contatto fisico con gli altri.
E’ un luogo dove le barriere non esistono. Dall’incontro al buio il non-gruppo si dilegua per
lasciar posto di nuovo al gruppo.
E’ un luogo dove l’individuo può scoprire, tramite il dialogo nel e col gruppo, che parti di lui
rivivono in altri e viceversa.
Qui il diverso, l’anticonformista, non si sentono esclusi, perché tutti sono diversi rispetto agli
altri. Il diverso è semplicemente accolto come tale e non escluso o denigrato.
Introduzione
Per introdurre questo progetto vorrei prendere spunto da alcuni stralci del libro “Passaggi”, un
insieme di articoli che, partendo dall’esperienza di Dialogo nel buio a Rovereto, spaziano su
argomenti affini alla Mostra e al buio.
In particolare, in uno di questi saggi, è una delle guide a dare utili spunti di riflessione, Paolo
Ambrosi (2006).
“Questa mostra-esperienza impone ai visitatori di vivere per un’ora nel buio più profondo:
niente fughe di luce dall’esterno, niente fonti luminose a disposizione dei visitatori né delle
guide; alcune ambientazioni ricostruite artificialmente nelle quali perdersi e ritrovarsi,
percorsi entro cui orientarsi attraverso l’udito e grazie ad un bastone, piccole esperienze
pratiche da compiere con l’ausilio prezioso di tutti i sensi residui (quei sensi che non vengono
neutralizzati dal buio); alla fine del percorso uno spazio accogliente dove riflettere tutti
insieme sull’esperienza. Unico alleato, paradossale alleato, un cieco al quale è assegnato il
compito di guida.
Un’ora al buio, per chi vede ed usa abitualmente la vista, può rappresentare un’esperienza
davvero significativa: spesso l’emozione che durante quell’ora riaffiora tocca corde molto
53
profonde, richiamando vissuti rimossi da lungo tempo o proponendo insospettate sensazioni e
realizzazioni impreviste.” […]
Immersi nel buio, le certezze dettate dalle rassicuranti categorie del visibile e dalla
consuetudine a disporre e a utilizzare la realtà vengono meno. “Si realizza una perdita, si attua
un rovesciamento, una sorta di epochè di quel mondo garantito dalla visione e dalla
continuità. Si tratta di abituare al buio l’occhio assueto alla visione. Il buio allora non è uno
stato ma è locus originario, “passaggio”, quasi un rito di purificazione durante il quale, come
in una tempesta, viene abbandonato il pesante carico per salvare dalla rovina la nave e gli
uomini. E ciò che fino ad allora era così prezioso diventa improvvisamente superfluo,
dannoso e gettato come zavorra.” (Valentinotti, 2006b).
Ma diamo un’occhiata nel buio. Il buio non è la condizione reale dei non vedenti, e sarebbe
una semplificazione eccessiva credere che Dialogo nel buio possa simulare la cecità. Il buio è
una metafora dell’emarginazione e della discriminazione di cui i disabili sono tutt’oggi
vittima. Essere disabili significa soprattutto essere definiti a partire dai propri limiti e non
avere le stesse possibilità che hanno le persone senza disabilità.
Il buio rappresenta anche le paure che sono dentro di noi, poiché evoca spettri nell’inconscio
collettivo. E tuttavia il buio, come i molti anni di Dialogo nel buio ci hanno insegnato, può
anche essere uno straordinario strumento per comunicare e incontrarsi. Un luogo senza belle
apparenze, dove il pregiudizio e la rapida occhiata sono impossibili: qui contano la voce, i
contenuti, così come l’intuito e la disponibilità ad aiutare. Solo chi parla, esiste. Il visitatore
che non parlasse, non ascoltasse, non si fidasse, non accettasse di entrare in contatto anche
fisico con quanto lo circonda, con la guida e con gli altri membri del gruppo,
"scomparirebbe". Questa è la ragione per cui in Dialogo nel buio l’attenzione è sul dialogo e
non sull’esperienza del buio; dialogo con se stessi e con gli altri che ci hanno accompagnati
nel viaggio attraverso l’oscurità, e dialogo con persone disabili.
Un mondo immerso nella totale oscurità si offre al visitatore per un'ora, durante la quale
anche le semplici azioni che appartengono al vissuto quotidiano di ciascuno di noi, come
passeggiare in un giardino o bere un caffè, diventano un'autentica avventura. L'impressione
suscitata da un buio così profondo, sconosciuto ai vedenti, sconcerta in un primo momento i
visitatori. Man mano che il percorso si dipana, il visitatore, con l'aiuto della guida, impara a
muoversi in questo nuovo mondo e il suo orizzonte si popola di sensazioni: non si tratta di
scoprire un mondo differente, è piuttosto una riscoperta, con modalità diverse, dello stesso
mondo che già conosciamo. Questa Mostra può essere paragonata al teatro interattivo: gli
attori sono i visitatori; la guida, come un regista, dirige lo svolgersi della storia nel buio più
assoluto che rappresenta, per continuare la metafora, la scenografia. La successione delle
54
situazioni può cambiare: di solito il primo impatto con il buio totale è compensato da un
ambiente naturale rassicurante, con piante vere e prati, al quale segue la città con i suoi rumori
e odori tipici quanto fastidiosi, per terminare il percorso in un animatissimo bar. Una
scenografia assai semplice, dove grande importanza riveste l'audio: un sofisticato impianto
d'amplificazione riproduce con straordinaria verosimiglianza i suoni tipici di ciascuna
situazione, come il cinguettare degli uccelli nel parco o il frastuono del traffico cittadino, la
musica di sottofondo nel bar invisibile. Senza l'aiuto delle percezioni visive, sono i suoni, gli
odori, le sensazioni tattili a sollecitare ed amplificare i sensi attraverso un'illusoria imitazione
del reale.
Attraversamento del buio
Massimo Valentinotti (2006a) ci fa ben capire come, per il visitatore, l’attraversamento del
buio non sia solo reale ma, soprattutto, metaforico.
In una comunità di appartenenza, i riti originari di passaggio sanciscono un cambiamento di
stato, “intervengono e regolano i principali momenti di pericolo, tensione e crisi sociale. Nel
caso di forme rituali più allargate il passaggio garantisce l’ingresso ad una nuova comunità di
elezione.” Dialogo nel buio riprende forme rituali originarie in cui ritrovano una loro
contestualizzazione tematiche mitologiche, letterarie e filosofiche. Forme che si possono
riassumere nell’ “attraversamento del buio”.
Affinché la “caduta” e la “perdita” prefigurati dal termine buio diventino “discesa” e
“attraversamento”, bisogna affidarsi allo stesso filo che guidò i passi ciechi di Enea attraverso
l’Ade. Ecco il compito fondamentale della guida: soltanto superando la vertigine provocata da
questo eccezionale inoltrarsi nel buio in cui la paura di precipitare nell’abisso si ripresenta
come in un sogno notturno, è possibile procedere oltre ed iniziare il “vero viaggio” in un
atmosfera di ansia e ricerca. Perché «scendere nell’Ade è facile: la nera porta di Dite è
spalancata di notte e di giorno; ma ritornare nel mondo, questa è ardua fatica».
Se l’intenzione di chi ha progettato Dialogo nel buio era quella di mettere a confronto il
mondo dei normovedenti con quello della cecità e ipovedenza per produrre un’esperienza
forte di condivisione giocata attorno al ruolo della guida cieca, ciò può realmente ed
efficacemente accadere anche e soprattutto per il valore del contesto. Il percorso di Dialogo
nel buio sembra pensato non come una semplice esperienza di cecità temporanea, ma come un
balzo rituale totalizzante che richiama a sé i sensi e l’emotività con la potenza
dell’installazione artistica, nel segno della trasformazione radicale della propria esperienza e
55
del rapporto con la realtà sia in un senso percettivo, sia in senso esistenziale e simbolico.
Tutta la vita è in qualche modo “passaggio” segnato dal trascorrere del tempo e dalla sua
finitezza, ma è il rito che con i propri significati e riferimenti all’Eterno, al mitologico,
individua dei momenti cruciali che segnano una modificazione profonda e incancellabile.
Il buio, archetipo universale, non è soltanto simbolo di morte, poiché incessantemente, come
in un’oscillazione dei contrari, nell’immaginario avviene un’inversione di immagini e valori.
Uno dei passaggi fondamentali riguarda il rituale in cui, a partire dalla luce, si attraversa
l’oscurità per riemergere in una visione più limpida del reale. Nell’attraversamento si
manifestano le valenze simboliche e pragmatiche presenti nell’archetipo della notte e della
dimensione notturna del mondo. Il suo significato viene espresso in una molteplicità e varietà
di forme culturali, religiose e sociali e di elaborazioni mitologiche.
Si tratta quindi di ritrovare, al di fuori di tutto quello che è convenzionale nel suo processo di
continua autoriproduzione, una situazione esistenziale consapevolmente diversa, una nuova
dimensione dell’esistere. Questa diversità e novità dovrebbe condurre ad una fuoriuscita
preordinata da una condizione di vita frammentaria e dispersiva.
Entrare nel buio ritualizzato comporta dunque la sospensione della vita activa, del suo
turbinio di travagli e di impegni per riemergere in un nuovo inizio o in un tempo di festa, vale
a dire in un rigenerarsi della vita, del mondo e dei ritmi temporali.
Breve storia del progetto
Dalla prima edizione a Francoforte nel 1988, le 90 edizioni di Dialogo nel buio sono state
ospitate in cento città di 17 paesi del mondo, in Europa, Canada, Israele, Messico, Giappone e
Brasile: si sono svolte in teatri, musei, fiere, cinema, edifici storici, capannoni e altri spazi.
Più di 4 milioni di persone si sono lasciate condurre nel buio assoluto da oltre 4.000 guide non
vedenti e ipovedenti. Il progetto ha ovunque raccolto grandi consensi sia dai visitatori, sia dai
mezzi di comunicazione, che hanno riservato ampio spazio ad ogni presentazione. Le guide
più brave viaggiano molto, chiamate dagli organizzatori per formare i nuovi colleghi e
trasmettere loro l'esperienza acquisita. Alcune, poi, hanno fondato delle società o
associazioni, come è accaduto in Gran Bretagna e in Canada, per riproporre Dialogo nel buio
o promuovere altre iniziative culturali (rassegne musicali o teatrali al buio, mostre ed eventi...)
e di integrazione sociale.
Uno degli esiti più interessanti scaturiti da una presentazione di Dialogo nel buio è la
creazione del ristorante al buio Blinde Kuh (che letteralmente significa "mucca cieca" e allude
56
ad un gioco analogo al nostro mosca cieca), nato a Zurigo per iniziativa di cinque non vedenti
che avevano lavorato come guide al Museum für Gestaltung nella primavera del 1998. Il
ristorante serve sessanta coperti nell'oscurità totale ed il successo del locale è tale che occorre
prenotare con largo anticipo.
L'idea di creare un simile punto d’incontro si deve ad Andreas Heinecke, impegnato da anni
nello sviluppo di progetti che hanno come obiettivo il dialogo tra realtà sociali abitualmente
distanti tra loro. "L’unico modo di imparare è attraverso un incontro": così scriveva Martin
Buber, filosofo tedesco. E’ ispirandosi a questo pensiero che Andreas concepisce progetti
finalizzati ad inserire categorie sociali emarginate nel tessuto attivo della società,
valorizzandone le qualità nate proprio da quella diversità che sembrerebbe escluderle. Così, in
Dialogo nel buio, o in Scenes of silence, guide non vedenti nel primo caso e sordomute nel
secondo, accompagnano con sicurezza e talento alla scoperta di un altro modo di vedere oltre
le immagini e di comunicare oltre le parole.
Il buio e il silenzio diventano strumenti per comunicare, la diversità diventa un’occasione di
arricchimento.
Prima di dedicarsi a quest'attività, Heinecke lavorava come giornalista per un'emittente
radiofonica dove si trovò a stretto contatto con un cieco, affiancatogli per un periodo di
formazione professionale. L'esperienza fu decisiva, e lo condusse a rivedere il proprio
concetto di cecità. La vita del suo collega non era triste e priva d'interessi come si sarebbe
aspettato; era certamente diversa, ma ricca di sensazioni e di curiosità per il mondo
circostante.
Il percorso nel buio con la guida di un cieco era il risultato di lunghe ricerche, condotte
inizialmente con installazioni sonore e oggetti d'arte astratta, che intendevano ridurre le paure
e i preconcetti dei vedenti nei confronti della cecità. Fin dai primi esperimenti fu evidente
come le persone, se coinvolte in una comune e nuova esperienza sensoriale, fossero più
disponibili ad avviare un dialogo sulle proprie interpretazioni della condizione dei non
vedenti.
L'iniziativa ebbe subito un notevole successo.
Negli anni "Dialogo" è stato mostra-evento di pochi giorni, con il solo ambiente bar, luogo
privilegiato per il dialogo, oppure percorso con numerosi scenari, dal parco alla città, dal
mercato alla gita in barca, alla stanza del suono, per finire sempre con il bar al buio, per alcuni
mesi o addirittura per anni, come ad Amburgo, Holon (vicino Tel Aviv), Francoforte, Milano,
in Danimarca, a Vienna e presto a Londra.
In Italia, con l’edizione speciale per le Olimpiadi della Cultura Torino 2006, Dialogo nel buio
è alla sesta presentazione dopo Roma, EUR (1997); Milano, Palazzo Reale (2002-2003);
57
Rovereto (TN), MART (2003-2004); San Giorgio Piacentino (PC), Castello (2005) e Milano,
Istituto dei Ciechi (aperta da dicembre 2005).
Ma quali sono le sensazioni dei visitatori della Mostra? E che contributo riveste la guida non
vedente? A queste domande risponde bene un lungo stralcio di “Passaggi”, già citato prima,
che si riporta integralmente per la sua importanza.
“A gruppi di otto persone, cadenzati uno ogni quarto d’ora, si viene rapidamente introdotti,
quasi catapultati, verso il fondo di un corridoio oscuro. Qui, spaesati o più tranquilli, un po’
chiassosi (come per “sapere meglio” se stessi) o chiusi in un silenzio insospettito e con
l’attenzione allertata, si incontrano i due preziosi compagni di viaggio: la guida e il buio.
L’uno e l’altra, il buio e la guida, non abbandoneranno i visitatori nemmeno per un istante.
La voce rassicurante e, al bisogno, la mano amica della guida si offrono ai visitatori quali
elementi di contenimento dell’angoscia (o comunque del timore) che non di rado dentro il
percorso colgono di sorpresa, ma funzionano anche da veri e propri strumenti di orientamento
e di esplorazione, da occasioni di stimolo e di risposta ai mille interrogativi via via emergenti.
Dunque ecco le guide ad insegnare come muoversi senza correre rischi, a suggerire come
decodificare i messaggi sonori, a consigliare come sfruttare il tatto per capire, a sollecitare
l’atto di riassaporare un gusto o un odore. Ma eccole anche, le guide, pronte a sdrammatizzare
i momenti di tensione, a raccontare aneddoti su di sé o sul rapporto fra ciechi e vedenti, a
sciogliere dubbi, a sfatare luoghi comuni; o ancora a suggerire piccoli trucchi per contrastare
la paura, a sostenere chi somatizza più pesantemente il disagio, ad ascoltare chi attraverso il
buio riscopre una sofferenza, a riaccompagnare alla luce chi proprio non se la sente di
continuare.
Sì, tutto questo, perché i visitatori sono davvero assortiti per l’età, per le motivazioni, per i
vissuti personali.
Alla Mostra si presentano, infatti, famiglie con bambini od anziani, coppie, gruppi di amici,
addetti ai lavori, semplici curiosi, ma soprattutto scolaresche di ogni ordine e grado dalla terza
elementare in su. Le motivazioni degli ospiti sono le più varie, dalla voglia di fare
un’esperienza curiosa alla necessità di meglio comprendere la condizione di un congiunto o di
un alunno disabile visivo, dalla curiosità intellettuale verso un modo di conoscere il reale tutto
nuovo al semplice e sano impulso al gioco ed al divertimento in un anomalo scenario, dalla
raccolta di impressioni per un articolo di stampa al dovere di accompagnare qualche familiare
più motivato.
E lo stesso si può dire dei prerequisiti e dei bisogni: vi è chi ha più volte sperimentato
situazioni di limitazione sensoriale e cerca di mettere alla prova le proprie competenze in
58
materia, magari gradendo di essere lasciato solo almeno per alcuni momenti, desiderando
misurarsi a tu per tu con il percorso e con il buio; vi è chi si sente immediatamente perso,
partendo magari dalla consapevolezza di un proprio disagio che si manifesta puntuale in
presenza di ogni forma di oscurità, e desidera essere guidato nel buio con il massimo di
sicurezza e di gradualità; chi ancora ha accumulato, magari prendendo spunto dalla
conoscenza con qualche cieco, un’infinità di interrogativi pratici o psicologici inerenti la
condizione dei disabili visivi; chi, invece, esprime di continuo l’istanza di poter valutare la
veridicità delle immagini mentali che si va facendo in proposito degli ambienti oscurati,
auspicando (in realtà senza alcuna probabilità di venire accontentato) di poter rivedere il
percorso alla luce o quantomeno adoperandosi al fine di ottenere ogni possibile informazione
oggettiva. Vi sono gruppi che legano immediatamente fra loro cercando ed offrendo
manifestazioni di solidarietà e gruppi che mantengono un clima di maggiore distanza se non
di reciproco imbarazzo; gruppi interamente o parzialmente costituiti da persone che si
conoscono e gruppi composti da estranei; vi sono visitatori che abbandonano pudori e rigidità
per attivare circuiti comunicativi estremamente caldi e scoperti, e vi sono visitatori che nel
buio, privati della comunicazione visiva, non trovano strumenti efficaci per riprodurre i
messaggi emotivi non verbali che, nella comune comunicazione analogica, sono veicolati
attraverso la vista.
Compito della guida sarà quello di individuare in pochi istanti le principali caratteristiche del
gruppo e dei singoli, ingegnandosi nell’ideazione di stratagemmi che le permettano di
procurarsi informazioni preziose sul livello emotivo di ogni visitatore e di portare allo
scoperto la collaboratività ed i bisogni di ognuno. Ogni visita, pertanto, tenderà ad assumere
un profilo suo proprio, un carattere direttamente rispondente alle caratteristiche ed alle istanze
del gruppo di ospiti.
Talvolta sarà posto l’accento su dati pratici o su esperienze sensoriali, talaltra su questioni
psicologiche e su esperienze interiori; alcuni gruppi tempesteranno la guida di domande e di
osservazioni, mentre altri risponderanno a fatica alle sollecitazioni loro poste; certi visitatori
più esuberanti non perderanno occasione per sperimentare al limite massimo consentito la
sensazione del rischio e le incognite dell’esplorazione, altri accetteranno di muovere ogni
passo solo a seguito di infinite assicurazioni; con certi gruppi ci si potranno permettere giochi
e scherzi di ogni tipo, con altri sarà opportuno mantenere un clima serio e controllato; alle
volte si potrà puntare su dinamiche che attivino direttamente i visitatori, altre, infine, ci si
dovrà mettere al centro dell’attenzione e divenire protagonisti delle conversazioni.
Questo livello di individualizzazione delle visite, naturalmente, dovrà innestarsi con fluidità e
senza personalismi sull’impalcatura generale e sugli obiettivi dichiarati di Dialogo nel buio.
59
Sarà indiscutibilmente essenziale, in particolare, evidenziare temi quali il richiamo alle
funzioni archetipiche del buio, l’invito a recuperare il piacere derivante da un’osservazione
plurisensoriale della realtà, una migliore informazione sulla psicologia e sugli orizzonti
esistenziali dei disabili visivi, un richiamo alle principali norme comportamentali e civiche
che possano aiutare a mantenere gli ambienti ed i servizi quanto più possibile accessibili, e,
soprattutto, il valore di confronto e di reciproco arricchimento insito in ogni autentica
occasione di contatto fra realtà ed esperienze diverse.
Questo rovesciamento prospettico (che è poi lo stesso rovesciamento di ruolo che si viene ad
attivare nel momento in cui, al buio, chi vede cerca una guida e chi non vede offre un
soccorso) appare particolarmente interessante perché consente di mettere a fuoco i
meccanismi attivati da parte dei ciechi all’interno della relazione con i vedenti. Esso favorisce
una significativa riscoperta autoanalitica del proprio vissuto di disabile visivo che entra
quotidianamente in confronto con gli scomodi confini di un orizzonte di limitazioni e di
potenzialità non in tutto rispondente alle pur legittime istanze di autonomia e di
autorealizzazione. Permette, inoltre, una verifica dei meccanismi d’interazione con
un’organizzazione sociale plasmata intorno alle istanze del campione di cittadini
statisticamente più rappresentativo, quello dei normodotati.
Sotto la luce emanata dall’anomala modalità relazionale offerta da un’esperienza come quella
di essere guida a Dialogo nel buio, possono dunque essere riconsiderati con una inconsueta
serenità i punti di convergenza, le corrispondenze, le distinzioni, gli stereotipi, insomma, in
generale, le qualità e le contraddizioni caratterizzanti l’innesto dei disabili visivi gravi entro
l’insieme di chi vede.
Non è comune, tanto per cominciare, per molti ciechi, che qualcuno si fidi delle loro
competenze spaziali e del loro senso pratico: in generale, infatti, l’esperienza presenta episodi
di svalutazione di tali competenze. Ad un cieco, nel quotidiano, si offre (quando glielo si
offre) aiuto per il perseguimento dei suoi obiettivi pratici; gli si possono chiedere, magari,
pareri o prestazioni di tipo intellettuale o culturale, ma raramente gli si chiede quel tipo di
collaborazione che ne possa valorizzare le competenze operative e spaziali. L’occasione di
dare informazioni anziché riceverne, di aiutare e rassicurare anziché dipendere dall’aiuto
altrui o, peggio, sopportare i frequenti attacchi ed i dubbi insidiosi rispetto alla propria
capacità di muoversi autonomamente ed in generale di perseguire obiettivi pratici, è, dunque,
per un cieco, imperdibile.
Come non sarà difficile intendere, il ripetersi più volte al giorno per mesi interi
dell’esperienza di guida nel percorso di Dialogo nel buio, il susseguirsi, durante la conduzione
dei gruppi, di piccoli e grandi successi pratici, il vedere riconosciute le proprie competenze da
60
parte di molti visitatori vedenti (e conseguentemente, magari per la prima volta, da parte di se
stessi), il rafforzamento delle proprie conquiste sulla scorta di un’accresciuta fiducia nelle
proprie capacità e dell’incoraggiamento o dell’esempio di qualche collega, possono
occasionare un imprevisto rilancio dell’immagine di sé in tutti quei ciechi che, come troppo
frequentemente avviene, non hanno avuto modo di esprimere al giusto grado le proprie
potenzialità.
La possibilità di osservare le difficoltà di chi vede quando si trova al buio, la possibilità di
valutarne il diffuso disagio, di coglierne l’insicurezza nell’agire, ma soprattutto di
considerarne
l’effettiva
mancanza
di
strumenti
di
valutazione
della
realtà
ove
momentaneamente privato dell’uso della vista si rivelano preziose occasioni per riconsiderare
tutti quegli atteggiamenti che, giorno dopo giorno, per la strada, in casa, sul posto di lavoro,
sono stati subiti come umiliazioni e come mancati riconoscimenti della propria credibilità e
della propria dignità.
Solo riconoscendo l’effettiva inettitudine a muoversi, ad ascoltare, a toccare che colpisce ogni
vedente nell’impatto con il buio, solo scoprendo nella pratica l’imbarazzo di alcuni visitatori
nel riconoscere a partire dai sensi residui le caratteristiche di un ambiente, solo osservando la
scompostezza e la disorganizzazione del gruppo nello svolgere un facile compito come, ad
esempio, un girotondo, solo toccando con mano la rigidità che coglie più d’uno al semplice
atto di doversi sedere ad un posto assegnato, è possibile mettersi nei panni di chi, nella vita
fuori dal percorso, tenta di cogliere la condizione di un cieco che si accinge ad attraversare
una strada chiudendo gli occhi per pochi secondi e, sconvolto dal primo impatto con
l’oscurità, gli attribuisce il medesimo stato d’animo e le medesime difficoltà di decodifica del
reale da lui sperimentate in quei pochi secondi; solo così si impara a dare una spiegazione a
certi persino comici eccessi di cura che così bene si prestano ad essere letti come dichiarazioni
di disistima; solo così si possono perdonare quei vedenti che, scambiando un atteggiamento
simbiotico con un gesto di empatia, danno voce all’angoscia che li colpisce al solo pensare la
cecità, attribuendo ad ogni cieco lo stigma di un’esistenza intollerabilmente infelice e solo
degna di pietà.
Sotto un altro profilo, per quelle guide che scelgono di offrire ai visitatori interessati l’essenza
della propria esperienza di disabili, Dialogo nel buio può rappresentare un’occasione
esistenziale importante. La relazione con i gruppi, infatti, punta con una certa frequenza ad
aprire squarci entro il piano interiore delle guide: alle innumerevoli richieste di informazioni
tecniche (del tipo “Come fai ...?”), si alternavano domande più esistenziali volte a cogliere gli
stati d’animo inerenti il vissuto di cieco (del tipo “Come stai...?”). La Mostra, per parecchie
guide, si presta anche, così, a funzionare quale anomalo setting dove tornare e ritornare a
61
raccontare di sé, della propria storia, dei momenti critici, delle tappe della propria formazione.
Con il susseguirsi dei gruppi, giorno dopo giorno, come impara soltanto chi ha potuto
assaporare la potenza insita nel rivivere attraverso la memoria ed il ricordo ascoltato le
proprie esperienze più importanti, molti nodi dolorosi possono farsi via via meno sofferti,
molti temi da sempre associati a rabbia o a vergogna assumono un aspetto più pacato e più
tollerabile, qualche peccato imperdonabile finisce con l’essere rivisitato a partire da una
nuova clemenza. In una parola, qui come in pochi altri luoghi, molte guide possono
permettersi di raccontare la propria autenticità fino al punto di conoscersi un po’ meglio e di
amarsi un po’ di più.
L’esperienza, per le guide non vedenti, si dimostra importante anche per un’altra inattesa
ragione: l’organismo ed il sistema conoscitivo dell’uomo, al buio offrono un chiaro saggio
delle loro straordinarie capacità di adattamento ad una nuova situazione e di prontezza nel
preparare contromisure efficaci. Questo dato, che spesso viene disconosciuto, si impone
all’attenzione se solo si ponga mente agli inattesi cambiamenti che interessano i visitatori nel
corso dell’esperienza al buio. Molte delle persone che appena entrate nel percorso provavano
infiniti disagi e non riuscivano a rendersi minimamente conto di quanto li circondasse, in
meno di un’ora non solo si sorprendono in un’attitudine psicologica completamente diversa,
via via più a proprio agio, sempre meno intimiditi, più autonomi rispetto alla guida; ma
devono anche riconoscersi in grado di svolgere con una certa perizia operazioni di qualche
complessità. Non mi sembra di esagerare nell’affermare che diversi visitatori della Mostra alla
prima esperienza con il vero buio, in una sola ora, riescono a conseguire abilità il cui
raggiungimento costa alla maggior parte dei ciechi lunghi periodi di adattamento, ore di corsi
e non pochi momenti frustranti. Questo dato chiarisce sorprendentemente quanto l’elemento
psicologico ed il contesto ambientale riescano ad amplificare le indiscutibili difficoltà dei
disabili visivi.
Una simile scoperta, la scoperta che la gran parte del problema non sta nel deficit visivo, ma
nell’impatto che esso ha sull’esistenza di chi ne è portatore e nelle caratteristiche
dell’ambiente in cui la cecità viene vissuta, assume un’importanza decisiva nella vita di più di
una guida: questa scoperta diviene la chiave perché sia possibile spostare lo sguardo dalla
propria disabilità per puntarlo sulle potenzialità esistenti.
Essa può divenire, altresì, la chiave per riconoscere l’importanza di un’organizzazione degli
spazi e dei servizi pensata anche secondo i bisogni dei disabili e per un rinnovato impegno
verso una società più inclusiva.”
62
Ora preferisco dare la parola a fatti, vite reali. E’ per questo che riporto integralmente un mio
articolo realizzato dopo la chiusura dell’edizione di Dialogo nel buio di Palazzo Reale.
Dialogo nel buio: quando il lavoro si incrocia con la vita
E' passato ormai più di un anno dalla chiusura di Dialogo nel buio edizione milanese, ma il
ricordo di quei cinque mesi è ancora indelebile in me. Si sono scritti molti articoli sui giornali
in cui, per la gran parte, erano testimoniate le esperienze dei visitatori che entravano nell'ora
di buio, ne uscivano strabiliati e con un nuovo punto di vista. Il giornalista, che in genere
aveva fatto il giro con uno di noi, raccontava delle meraviglie di stare per un'ora con gli occhi
aperti e chiusi allo stesso tempo e di quanto, piano piano, gli altri sensi si acuissero per
esplorare gli ambienti bui in cui, nel gruppo con altre sette persone e accompagnato da una
guida non vedente, era immerso: il tunnel buio dalle pareti di velluto, stretto e opprimente; la
grotta, dalle pareti di roccia e i rumori cupi di acqua e sassi; il canneto finalmente aperto,
profumato di fiori, gorgogliante d'acqua e d'ogni sorta di animale; la tranquilla casetta dai
muri di tronco e ricca di oggetti nuovi da scoprire; la frescura, i profumi e i rumori del mare
che facevano da atmosfera ad un porticciolo scricchiolante presso cui era ormeggiata una
barca a motore sorvolata da stormi di gabbiani; la caoticissima città zeppa dei rumori di
traffico e persone, ma anche degli odori del mercato; e finalmente, prima dell'ultimo corridoio
che conduceva all'uscita, la tranquillità e il tipico aroma di caffè del bar dove bere, sedersi e
confrontarsi con la guida e gli altri visitatori sull'esperienza appena vissuta.
Ora, però, è giunto il momento di mettersi dall'altra parte e sapere qualcosa da chi nel buio ha
lavorato cinque mesi interi, non solo un'ora. Per noi guide questa esperienza è stata
importante, a tutti ha lasciato molto, non è stato solo un lavoro, ma qualcosa di più
arricchente. Credo che il modo migliore per spiegarvi il punto di vista di una guida sia quello
di partire dal principio.
Circa un anno prima dell'inizio della Mostra, ho iniziato a leggere e-mail che invitavano i non
vedenti con un buon grado di mobilità a partecipare alle selezioni per diventare guide
dell'edizione milanese di Dialogo nel buio. Ogni volta che leggevo frasi simili le cancellavo
ignorandole del tutto e dicendomi che, non essendo praticamente neanche in grado di
attraversare una strada da sola, non avrei mai potuto accompagnare delle persone lungo un
tragitto. Nonostante i miei genitori mi spronassero a tentare, mi schernivo sempre adducendo
questa scusa.
63
Poi qualcosa è cambiato. Il mio migliore amico mi ha chiesto se avessi sentito parlare di
questa Mostra, mi ha detto che aveva intenzione di presentarsi all'incontro e mi ha proposto di
seguirlo. Quando gli ho esposto le mie perplessità mi ha derisa dicendomi che muoversi al
chiuso, in un ambiente anche molto grande, non è come farlo all'aperto e che una volta
imparato a girare per i vari spazi, li avrei considerati come casa mia. E poi chissà, ha
aggiunto, "magari qualcuno ti conquista ed è la volta che trovi un uomo". Le sue parole mi
hanno convinta a tentare e ho telefonato. Ero arrivata in ritardo, ormai il primo incontro era
stato fatto. Pensavo che non avrei avuto più speranze, e invece ecco che le aspiranti guide
erano talmente tante da rendere necessaria una nuova riunione introduttiva. A quel punto il
gioco è stato fatto. Mi hanno presa alle selezioni, ho seguito il corso di formazione, ho
esplorato sommariamente i vari ambienti non ancora terminati e poi ho iniziato a lavorare.
A pochi giorni dal mio ingresso ufficiale nello staff è arrivata una e-mail in cui ci veniva
chiesto chi tra noi sarebbe stato interessato a girare gli spot per la Mostra in qualità di registi,
sceneggiatori e operatori. Ho risposto affermativamente e tra tanti hanno estratto anche me.
Ho conosciuto meglio un mondo al quale mi ero approcciata solo sommariamente fino a quel
momento, quello della televisione. Inventare lo spot, scegliere l'ambientazione, le immagini, i
dialoghi, i rumori, riprendere le scene e aiutare nel montaggio è stato incredibile e splendido.
Ancora più magico è stato vedere il mio spot vicino a quello degli altri su una videocassetta
con in coda il mio nome.
Ma ora veniva la parte più difficile: è stato bello pubblicizzare l'evento, ma come avrei potuto
arrivare da sola da casa mia a Palazzo Reale? Ricordo ancora il mio più grande timore: non
posso farmi accompagnare da mia madre fino a Duomo tutti i giorni, quindi devo
assolutamente imparare il percorso. Avevo fatto un corso di orientamento e mobilità un anno
prima, ma mi era rimasta una gran paura di muovermi da sola e non avevo più intrapreso
questa difficile attività. Quando ci è stato proposto un mini corso per imparare la strada dalla
metropolitana al Palazzo Reale ho accettato subito, anche se avevo poche speranze di riuscire.
Ho fatto le due ore di lezione con la mia istruttrice dell'anno prima, e lei ha notato grandi
miglioramenti nel mio modo di camminare, di usare il bastone e di approcciarmi
all'esperienza, anche se da un anno a quella parte non avevo più mosso un passo da sola. Il
percorso era semplice e l'ho imparato in fretta, non avevo neanche quell'enorme terrore che,
ero convinta, mi avrebbe attanagliata quando ci avessi provato, e quindi mi sono rincuorata.
Il primo giorno di lavoro effettivo lo ricordo ancora come se fosse successo ieri. Ho fatto da
sola il percorso da casa mia al Palazzo Reale col cuore che batteva all'impazzata e la gioia di
esserci arrivata senza intoppi. Dopo aver osservato un paio di colleghi alle prese coi visitatori,
mi è stato proposto di fare il mio primo viaggio come guida.
64
Ho chiesto che mi fosse affiancata una guida più esperta e sono stata accontentata. Non
smetterò mai di ringraziare questa persona il cui caldo abbraccio mi ha tranquillizzata. Sapevo
che se avessi avuto qualsiasi tipo di difficoltà lui sarebbe stato accanto a me. E' stato un giro
bellissimo a detta di visitatori, collega e della sottoscritta. Da lì in avanti le giornate si sono
susseguite una dopo l'altra, apparentemente tutte uguali, ma ognuna con qualcosa di diverso.
Io diventavo sempre più sicura delle mie capacità, sapevo di essere in grado di capire le
persone, metterle a loro agio, consolarle se piangevano o tranquillizzarle se avevano paura.
Era bello sapere che solo con una stretta di mano e qualche parola di conforto la gente
imparava a fidarsi di me, mi si appoggiava ed era pronta a lasciarsi guidare nel buio. La
conferma della mia abilità veniva anche da varie lettere che mi erano arrivate e da episodi in
cui, finito il percorso, venivo abbracciata e ringraziata di quanto ero riuscita a far
comprendere. Io, che non credevo in me stessa, sapevo che stavo insegnando molto, che solo
grazie a me i miei visitatori prendevano consapevolezza della situazione e vivevano
serenamente il buio: la mia autostima ha ricevuto una grandissima spinta verso l'alto.
Uno dopo l'altro, i gruppi entravano e uscivano, ma io restavo. Piano piano ho iniziato a fare
amicizia con chi lavorava con me: mangiavamo insieme, scherzavamo durante le pause,
facevamo agguati ai colleghi, mentre lavoravano, all'insaputa dei visitatori. La nostra intesa è
cresciuta a tal punto da riuscire a riconoscerci l'un l'altro solo con un rumore caratteristico, un
profumo particolare o un leggero tocco sulla spalla. In uno stesso ambiente, nel medesimo
istante, si sovrapponevano due realtà diverse che si incorniciavano e completavano l'un l'altra.
Quante volte, passando col gruppo da un ambiente all'altro, udivo di sfuggita le risate dei
colleghi che scappavano sentendoci arrivare; quante volte, mentre i visitatori ordinavano al
bar, scappavo a parlare con la guida del turno precedente o andavo velocemente a prendermi
il panino per il pranzo sapendo che nessuno del mio gruppo, tranne il barista che avvisavo, si
sarebbe accorto della mia assenza. E' affascinante pensare come convivevano realtà così
diverse in uno spazio così piccolo. Seguendo il viaggio di un gruppo si entrava nell'atmosfera
di quel viaggio, ma attraversando velocemente il percorso si passava da un gruppo all'altro, da
un'atmosfera all'altra, da un profumo all'altro e si coglieva il percorso nella sua globalità. Una
vita del genere è possibile solo al buio, dove si è in mezzo ad una stanza ma nessuno lo sa a
meno che tu non lo voglia. Il buio era il nostro mondo. Arrivavo sempre molto tempo prima
dell'inizio del mio turno e spesso andavo a casa quando ormai era sera inoltrata, solo per il
gusto di vivere quella realtà senza vincoli, solo per il piacere di stare con gli altri. Per molti di
noi quell'ambiente era diventato, ed è tutt'ora, punto di incontro per appuntamenti anche
diversi da quelli lavorativi. E' stata per cinque mesi la mia seconda casa, seconda famiglia,
ottimo trampolino di lancio per continuare la mia vita.
65
Oltre al lato ludico, però, non bisogna dimenticare la dimensione vera e propria della Mostra.
Col passare del tempo, confrontandomi con gli altri sul modo di portare avanti il viaggio al
buio, miglioravo sempre di più sia nel rapportarmi con la gente, sia nelle descrizioni che davo
o nel modo di far notare certe cose. Ho imparato che non basta essere non vedenti per
insegnare a chi vede ad essere cieco, ma che serve l'arte di saper teorizzare la pratica. Girando
per gli ambienti popolati di guide e visitatori, ho capito come potevo mostrare agli altri il
ruolo dell'udito in varie situazioni, molte delle quali anche per me inizialmente erano delle
scoperte. E' normale per me riuscire a capire la posizione di una persona dal suono della sua
voce, ma solo con l'aiuto dei colleghi sono riuscita a farlo notare anche ai miei visitatori,
perché ne ho preso consapevolezza io stessa. E questo è solo un esempio.
Attraverso le domande dei gruppi, ho imparato a capire meglio me stessa e ho scoperto qual'è
la rappresentazione sociale che i normo-vedenti hanno di noi. Le domande più frequenti
vertevano sul modo in cui sogniamo, andiamo in giro, leggiamo, percepiamo i colori e così
via. Mi sono resa conto delle difficoltà che incontra chi vede nell'approcciarsi a noi e sono
diventata più cosciente dei problemi che abbiamo noi nei loro confronti.
Mi sono ritrovata a sorridere di molti aneddoti raccontati al bar da altre guide che, ad
esempio, venivano fermate da un vedente che voleva a tutti i costi aiutarle ad attraversare la
strada quando, in realtà, loro stavano tenendo il ciglio del marciapiede come riferimento per
arrivare a buttare la spazzatura nel cassonetto. Quanti visitatori, vedendoci così esperti nel
muoverci al buio, ci chiedevano se stessimo guardando con i raggi infrarossi. La cosa bella
del buio era l'abbattimento delle barriere tra vedenti e non vedenti, guide e visitatori. Ci si
dava sempre tutti del tu, il contatto fisico era costante e pieno di energie, i discorsi anche
molto intimi in alcune circostanze, ma i ruoli si invertivano: al buio, io ero la vedente che
aiutava i non vedenti.
Credo che il messaggio della Mostra sia stato percepito dalla maggior parte del pubblico. Le
motivazioni che lo spingevano a visitarla erano le più disparate: il racconto dell'amico; la
curiosità; la voglia di saltare una lezione a scuola; l'affrontare la paura di essere colpiti dalla
cecità per capire se, una volta al buio per sempre, sarebbero morti o sopravvissuti. E,
nonostante qualche gruppo cacciato a forza perché troppo indisciplinato, al bar tutti mi hanno
detto cos'avevano capito di quell'esperienza. E' chiaro che un'ora non insegna la cecità, e noi
non volevamo neanche farlo, ma è altrettanto vero che si diventa più sensibili al problema, si
impara a osservare il mondo da altri punti di vista diversi da quello usuale, si scoprono i colori
del buio e cioè tutti i suoni, gli odori, i sapori e le varie sensazioni che lo popolano. Una delle
cose più magiche è stata vedere gli amici dello staff, tutti vedenti, diventare come noi, girare
66
velocemente nel buio carichi di scatole e sacchetti, aiutarci con i visitatori in difficoltà o, in
qualche caso estremo, fare in nostra vece una piccola parte del percorso.
La festa finale e l'ultima domenica sono state la fine perfetta di un periodo perfetto.
L'atmosfera triste si palpava tangibilmente, sapevamo di dover riprendere le nostre vite
normali, eravamo stanchi morti, ma sapevamo che quegli ultimi istanti avremmo dovuto
viverli a pieno per non perdere niente e fotografarci tutto nel cuore. Era finita: la luce delle
lampadine aveva disperso il buio, noi eravamo le stesse persone, ci saremmo incontrati ancora
ma mai più avremmo potuto rivivere quelle sensazioni intime di uguaglianza e appartenenza
che ci avevano accompagnati negli ultimi mesi.
E' passato un anno, ma spesso, ripensando a quel periodo, mi prende la nostalgia del luogo,
delle persone, dell'atmosfera, e anche i litigi che al tempo sembravano tragedie, ora li ricordo
tanto volentieri quanto tutto il resto. Ancora oggi, quando passo davanti alla porta chiusa che
immergeva nel buio, mi fermo e lascio vagare la mente oltre quella porta. Questa esperienza
mi ha fatta crescere in modo sorprendente e incredibile, mi ha permesso di raggiungere
l'autonomia e mi ha fatto scoprire un lato del mio migliore amico che ignoravo: è un
chiaroveggente. Ora, accanto al ricordo di Dialogo nel buio, c'è anche quello di una splendida
storia d'amore.”
Per concludere questo capitolo, vorrei riportare alcune testimonianze dei visitatori.
Dal Libro Degli Ospiti:
“[…] Poche parole lette su un opuscolo informativo mentre aspettavo di entrare alla MostraItinerario.
Mezz’ora di tempo per riflettere seduta in una saletta dai muri grigi con una luce soffusa.
Un tempo lunghissimo, in cui mille pensieri si affacciano alla mente e si accavallano: pensi
alla tua vita, al senso che per te ha il concetto di salute, malattia, diversità, limiti, risorse,
pensi a quanto nella tua vita abbia peso l’immagine, ciò che di te si vede e lasci vedere, ciò
che tu puoi cogliere nell’altro con lo sguardo, pensi a quanto sia prevalente la visione nella
vita dell’uomo e quanto poco si utilizzino gli altri sensi per conoscere se stessi, gli altri e
l’ambiente che ci circonda.
67
Fermarsi per mezz’ora a riflettere è stato per me un momento molto emozionante, ero sola,
non conoscevo nessuno, mi stavano per scendere le lacrime quando hanno chiamato il mio
gruppo per iniziare il percorso.
Entri nel buio con un bastone bianco in mano, il bastone che ti servirà per “vedere” dove sei e
dove vai. Entri nell’oscurità camminando lungo un corridoio facendo scorrere una mano
lungo una parete, poi il muro finisce e ti ritrovi nella prima stanza: il senso di disorientamento
è pazzesco, sei nel buio assoluto, in un luogo che non conosci, devi muoverti ma non hai punti
di riferimento.
Il tuo punto di riferimento diventa la voce della guida. Non la vedi, ma sentirla ti dà sollievo.
E’ rassicurante, ti indica la strada, ti fidi: per lei il buio è una condizione di vita, a te invece
evoca paura, freddo, morte. Per orientarti la sua voce nel buio è paragonabile alla luce di un
lampione che ti fa vedere dov’è la via da seguire. Se lei tace, tu ti senti smarrito.
Al buio l’unico modo per sapere dove sei e cos’hai attorno è utilizzare il maggior numero di
sensi possibili: con i piedi riesci a sentire cosa calpesti, con le mani tocchi gli oggetti, senti di
che materiale sono fatti, che forma hanno, col naso percepisci gli odori, le orecchie le tendi
per distinguere i suoni e la loro provenienza. Al buio ogni rumore, ogni suono, ogni
sensazione tattile è utile per riuscire a costruire un’immagine di te stesso nell’ambiente, per
sapere dove sei e in quale situazione ti trovi.
Ritornata alla luce, nelle sale iniziali ho subito sentito l’odore di quei locali, lo stesso odore
che entrando un’ora prima non avevo percepito.
Appena uscita da Palazzo Reale ho sentito l’aria fresca sul viso, il rumore della macchina che
lava le strade, il picchiettare di qualcuno che lavorava non so dove, forse dietro l’impalcatura
del Duomo, le voci lontane di persone che chiacchieravano fra loro; mentre camminavo
avvertivo sotto i piedi la differente pavimentazione, pavè, piastrelle di marmo, ghiaietta, un
tappeto di foglie bagnate, le grate.
Uscita da quella Mostra incredibilmente tutti i sensi sembravano essersi risvegliati! Mi è
sembrato di essere un bambino alla scoperta del mondo, dei suoi colori, delle sue forme, dei
suoi odori, dei suoi gusti, dei suoi suoni: gli uccellini che cinguettavano, le foglie che
rotolavano sull’asfalto trasportate dal vento, l’odore della città, il rumore dell’acqua delle
pozzanghere alzata dalle macchine, le finestre delle case che sbattevano dalla corrente creata
dal vento.. Insomma, una realtà sorprendentemente più ricca.
Quando ti manca qualcosa, o quando una parte di te funziona poco o male o per niente, ti
rendi conto della complessità del reale e del valore che può avere ogni più piccola cosa che
compone la realtà. Ed è forse grazie al senso di mancanza che puoi riconsiderare la tua scala
68
di valori, le tue priorità, a condizione che la mancanza tu la possa sentire come una premessa
alla costruzione e non una condizione di soffocamento.
Prima di entrare alla Mostra, nel corridoio, mi sono scontrata con una ragazza cieca, le ho
chiesto scusa, ho temuto di averle fatto male; quando mi è ripassata accanto ho prestato
attenzione a lasciarle la strada libera, a non ostacolarla. Nell'oscurità la mia preoccupazione
era opposta: non incontrare nessuno sul mio cammino, perdermi nel buio, andare a sbattere da
qualche parte. Scontrarsi con la guida era un piacere! Il contatto con una persona capace di
condurti era rassicurante, in quel momento non pensavo certo a scusarmi o a evitare di
ostacolarci: eravamo due persone diverse con abilità diverse, due persone che insieme stavano
costruendo un’esperienza.” (Livia)
“[…] Finalmente il nostro gruppo è formato, prima di addentrarci nel buio ci danno il bastone
bianco, ci spiegano come maneggiarlo, vietati borse, cellulari, orologi luminosi...accendini (da
non credere, qualcuno ha osato accenderlo rischiando i capelli del vicino) e ci raccomandano
di tenere in tasca qualche moneta per la consumazione al bar che troveremo alla fine del
percorso, ovviamente al buio.
Alessandra e Chiara ci sollecitano, domandano, rispondono. Ben presto la sensazione di ansia
e quella piccola paura infantile svaniscono, presi come siamo dal capire dove mettere i piedi,
indovinare cosa c'è sul tavolo, quale Nazione stiamo toccando sulla cartina geografica, tentare
di attraversare la strada (davvero terrorizzante!).
L'entusiasmo ci trasforma in bambini curiosi. O è la curiosità che ci rende bambini entusiasti?
Alla fine, nel bar, mentre siamo seduti intorno ad un tavolino le guide ci chiedono le nostre
impressioni e le traducono in ciò che è la loro vita. Imparo così che i non vedenti non hanno
"sviluppato gli altri sensi" come si suol dire. Semplicemente, li usano. Ed in modo differente,
da soggetto a soggetto.
Alessandra ci dice di usare molto l'udito, si basa molto sull'ascolto. Amici suoi usano
prevalentemente il tatto, altri l'olfatto. Si scambiano consigli, esperienze, fanno le prove.
Ci parlano delle diverse cecità, che non sono solo tra chi è nato così o chi lo è diventato in
seguito. (Se ci pensate, è vero... è come quando diciamo che i cinesi sono tutti uguali). […]”
(Rossana)
“[…] Dialogo Nel Buio è un’esperienza unica, che m’ha fatto provare una gamma infinita
d’emozioni: la gioia dell’esplorazione di un universo tutto da esplorare, il senso di solidarietà
che si era venuto a creare fra noi “viaggiatori”, la comprensione profonda (per quanto
possibile ovviamente) della condizione di una ragazza milanese non vedente, Chiara.
69
Condizione tanto differente e complicata ma anche tanto simile e vicina alla condizione di
un’altra ragazza milanese ma vedente, Giorgia. […]” (Giorgia)
“Spariscono anche le formalità: nel gruppo ci si dà del tu tra sconosciuti, di età e sessi diversi,
ci si tocca senza pudori, perché toccarsi e riconoscersi è indispensabile. Si scopre che una vita
senza luce non è vuota o triste: è differente, ma comunque ricca. Si impara a dipendere da chi,
fino a quel momento, si è considerato un «diverso […]” (Chiara)
“Ho visto ieri la "Mostra", sono stato colpito emozionalmente da Chiara, la guida di questo
viaggio, all\'inizio ho provato paura poi la sua voce decisa e rassicurante mi ha condotto nel
buio aiutandomi a trovare un naturale equilibrio negli altri sensi spesso oscurati dalla vista.”
(Francesco).
“Il mio pensiero va a Giuseppe. Grazie davvero per avermi regalato splendide emozioni, che
mai avrei pensato di provare. Curiosità, paura, voglia di rinunciare, entusiasmo, panico,
ancora curiosità in pochi secondi ho vissuto tante di quelle sensazioni ... E poi finalmente, la
voce calda, ferma, le mani rassicuranti di Giuseppe e allora ecco aprirsi un mondo nuovo, un
mondo che non avrei mai immaginato potesse esistere! Non svelerò le bellissime (a volte
anche "drammatiche") situazioni che sono state ricreate per darci solo un piccolo assaggio del
mondo che non siamo abituati a cogliere attraverso sensi diversi dalla vista, ma è
indubbiamente un'esperienza che consiglio a tutti, anzi non vedo l'ora di ripeterla! Perché la
prima volta ero talmente concentrata a cercare di vedere e riconoscere quale fosse il mondo
attorno a me, che sicuramente mi sono persa tante altre piacevoli sensazioni...” (Sara)
“Ho partecipato ieri sera al percorso, è fantastico e ti rendi conto di tante cose che finora...
non vedevo né capivo. Poi Gaetana è fantastica ti fa sentire a tuo agio e ti leva il disagio e la
paura di non poter vedere. Da ripetere assolutamente e da proporre a tutti gli stupidi che non
hanno rispetto.” (Giovanna)
“Voglio caldamente consigliare la Mostra "Dialogo nel buio".
La "Mostra che non mostra" apre a un nuovo modo di vedere e di sentire. La prima
sensazione che ho provato appena sono entrata in quel nero totale che mi ha fatto perdere
qualsiasi punto di riferimento, è stata di paura, come se stessi per annegare, lo spazio attorno a
me, compreso quello sopra la mia testa e quello sotto i miei piedi era immensamente dilatato,
l'impressione è stata quella di non essere più in un mondo solido, mi sono dovuta concentrare
70
sulle caratteristiche del pavimento su cui posavano le mie suole per rendermi conto che stavo
eretta su un normale pavimento. Mi ha stupito avere paura, ma l'ho superata nella solita
maniera: con la curiosità. Usando il bastoncino come un'antenna rilevatrice di ostacoli ho
attraversato la riproduzione di ambienti, che non starò a descrivere per non rovinare la
sorpresa a chi vorrà fare questa emozionante esperienza, divertendomi a riconoscere gli
oggetti al tatto, dal suono e dall'odore, da come questi si muovono, da dove sono collocati. E'
incredibile quante informazioni si possono raccogliere utilizzando i sensi diversi dalla vista.
Quello che mi è rimasto è la consapevolezza che le facilitazioni ambientali per i non vedenti
non sono mai abbastanza e che io dovrei imparare ad affidarmi meno al controllo esercitato
dalla vista e divertirmi a scoprire quel mondo di suoni, odori e sensazioni tattili che
generalmente passa inosservato. Ringrazio Raul, la guida dalla bellissima voce di cui non ho
visto il volto come lui non ha visto il mio.” (Silvia)
“Devo dire che sono entrato seguendo Danilo non senza un po' di preoccupazione: so
dominare le mie emozioni, però con gli occhi aperti!
Mi è stato chiesto di togliere gli occhiali, per comprensibili motivi di sicurezza, prima di
entrare nel buio e questo mi ha creato disagio perché sono ormai più di 30 anni che essi
alloggiano sul mio naso e sulle mie orecchie: dopo la prima testata nei pressi del rosmarino ho
deciso di rimetterli!
Tutto è filato liscio; l'ambiente protetto e ben organizzato ha consentito a tutti noi amici del
gruppo di brancolare nel buio come bambini curiosi che esperiscono l'ambiente circostante
con i sensi residui, usando meglio le mani, le orecchie, l'olfatto (la lavanda!) e la voce per
restare ancorati alla nostra certezza: Danilo!” (Alberto).
“Superati i primi attimi di contatto con il nero più nero mi è subito passato il senso
claustrofobico del buio e mi si è aperto un grande spazio come una sensazione di infinito. Che
piacere toccare e riconoscere tutto quello che c'era intorno a me ed ancora di più affidarsi alla
voce vivace e solida d'Ivano, guida del nostro piccolo gruppo. Grazie per questa esperienza,
Ivano.
Il mio vissuto è forse possibile perché ho la fortuna di poter vedere e fare un confronto tra il
vedere e il non vedere, io lo posso fare, non so è così per chi non ha mai visto, e di questo ne
sono rattristata al solo pensiero.
In ogni caso sono sempre più consapevole del fatto che quando voglio ascoltare/vedere
veramente qualcuno o apprezzare un evento qualsiasi, la prima cosa che faccio è chiudere gli
occhi.
71
Vi ringrazio per la possibilità che mi avete dato di avvicinarmi e "vedere" con il cuore la
vostra realtà.” (Francesca)
“In aprile ho portato una mia classe (prima superiore) e domenica 18 giugno tornerò con il
mio ragazzo ed alcuni amici. Cosa dire? Che è stata un'esperienza unica, bellissima,
affascinante quanto basta per farti venire la pelle d'oca al solo ricordo.
Credo che certe sensazioni siano difficili da descrivere con le parole. Le mie emozioni, le mie
sensazioni e il mio stato d'animo l'ho potuto leggere negli occhi dei miei ragazzi. Non li ho
mai visti così. Contenti, entusiasti di aver partecipato a questa grande "avventura". Ogni tanto
ne riparlano tra loro o a scuola con altri compagni, e posso dire che anche a loro è rimasta
dentro tanta dolcezza ripensando a quel giorno.
Che dire poi della guida? Assolutamente fantastica, coinvolgente. Un abbraccio e un sorriso.”
(Paola)
“Un grazie riconoscente alla guida Claudio per averci guidati con simpatia e gentilezza in un
percorso in cui viene messo in discussione il comune significato della parola "vedere", perché
la vista non è solo fatta di immagini come ci hanno abituati a pensare. Grazie di cuore.”
(Mariapaola)
“Ho visitato la “Mostra che non mostra”, ed è stata una esperienza unica.
La paura iniziale, il panico e la decisione di rinunciare sono state meno forti della dolcezza
sicura di Florinda, che con la sua mano mi ha incoraggiata e invitata ad entrare nel suo
mondo, a ribaltare per una volta i ruoli e a fidarmi di lei che quotidianamente si affida a chi,
come me, può vedere ciò che lei sente.
Perché questa Mostra per me è stato proprio questo, imparare a sentire ciò che ogni giorno
vedo, ma non "vivo". I suoni, i profumi, la scoperta degli oggetti che mi circondavano hanno
reso meno buio il buio e il mondo di Florinda è diventato per un'ora anche il mio. Superare
barriere strutturali grazie alla sua mano e abbattere quelle psicologiche grazie alla sua voce è
stata una esperienza che non potrò dimenticare. Così come il suo sorriso a fine percorso.
Grazie Florinda, perché grazie al tuo aiuto ho superato un disagio per me forte, la paura della
solitudine e la claustrofobia.” (Francesca)
“E’ stata un'esperienza magnifica e che voglio ripetere, c'è bisogno di tutto ciò e bisogna
anche incentivare sia i piccoli delle scuole che i giovani perché certe realtà si possano
72
conoscere e questo sia per stimolare una coscienza sociale sia per un percorso di crescita
personale.” (Rinaldo)
“Le emozioni che ha suscitato in me quel percorso non credo le dimenticherò facilmente;
prima la vertigine del nero totale, quasi la difficoltà a trovare il proprio equilibrio posturale
senza i rassicuranti punti di riferimento visivi, poi la strana sensazione di conforto nello
sfiorare mani e corpi di estranei cercando le pareti e i limiti degli ambienti, poi ancora la
consapevolezza della propria e altrui goffaggine nel pestare piedi e urtare mobili, e la
soddisfazione quasi infantile nel riconoscere le forme di oggetti noti e sentirsi allora un po'
meno al buio; e poi i rumori, soprattutto quelli assordanti delle città che, non "vedendoli",
sono terribilmente minacciosi...In tutto questo magma di emozioni, anche molto primordiali,
dominava forte, serena e luminosa una voce, quella della guida.
Quella voce gentile e sicura alla quale tutti noi ci appigliavamo, ci guidava con garbo nel suo
mondo, RISPETTANDO i nostri timori, le nostre esitazioni a fare un passo, temendo anche di
finire in acqua, dovendo fidarci solo di lei, di una voce di un'estranea, senza volto (solo a fine
percorso l'abbiamo potuta vedere, lei invece ci riconosceva già tutti) e per di più "non
vedente"...
Che sublime lezione di vita, quel labirinto buio ha davvero illuminato, e non è retorica, tanti
angoli oscuri della mia coscienza.” (Patrizia)
“Esperienza bellissima! "La Mostra che non mostra" ti coinvolge emotivamente, ti mette in
contatto con un mondo sconosciuto, ti obbliga a vedere ascoltando gli altri sensi; ma il
risultato più straordinario si è verificato al termine della Mostra.
Durante la Mostra l'impatto con un mondo che non ti appartiene è attenuato dalla presenza
rassicurante e protettiva della guida, oltre che dalla durata prefissata (un'ora) della visita.
Finita la Mostra e tornato a casa, la magia della notte e dell'immaginazione ha prodotto un
sogno. Mi sono sognato un mondo nuovo nel quale la "guida", guarita dalla sua malattia,
possa entrare senza traumi e senza bisogno della mia presenza rassicurante e protettiva.”
(Giovanni Battista)
E qualche commento dei numerosi piccoli visitatori.
Katia:
“E’ stato bellissimo!!
73
Finito il percorso avrei voluto rifarlo con la luce..Ho capito che mi posso fidare delle persone,
prima non ci avevo mai pensato.”
Erick:
“All'inizio ero convinto che Ciro avesse gli infrarossi. Non capivo come faceva a spostarsi
così facilmente.. mi muovevo io e se ne accorgeva subito! Anche quando stavo zitto zitto..
Però mi ha fatto toccare i suoi occhi, ho capito che non ci stava ingannando! Adesso so che
anche i non vedenti possono vivere quasi come noi.”
Denis:
“I ciechi sono uomini normali... Non ci vedono però sono contenti!
E’ stato bello stare con loro... io non ne avevo mai conosciuto uno.”
Debora:
“Grazie a Barbara ho conosciuto un mondo diverso dal mio. Mi è piaciuto tanto perché mi
sono fidata subito di lei.”
Eleonora:
“Sono felice! Mi dispiace solo un po' perché non tutti possono vedere i colori del mondo.”
Serena:
“Adesso il buio non mi fa paura! Voglio dire grazie a Barbara.”
Benedetta:
“Percorrere questa strada al buio mi ha fatto pensare alla loro vita. Ho capito che vivono bene!
Per me è stata un'esperienza bellissima.”
Alex:
“E’ stato bello perché ho provato a vivere in poco tempo quello che loro vivono ogni giorno.
Grazie a tutti quelli che me l'hanno permesso!”
Nicola:
“Ciro mi ha detto che devo ascoltare anche i rumori, è vero, prima non li ascoltavo tutti!
Adesso vedo tutto meglio e sento di più!”
74
Giulia:
“La Mostra “Dialogo nel buio” mi è servita per capire quanto sia difficile per un non vedente
vivere nella realtà quotidiana.
Mi immaginavo che ci avrebbero fatto toccare degli oggetti e noi avremmo dovuto
riconoscerli; non che fossimo privi della luce durante tutto il percorso. All’inizio quando non
vedevo niente mi sono spaventata, solo più tardi mi sono accorta che moltissime persone
convivono con questa situazione ogni giorno.
Quando finisci il giro ti senti spiazzato, catapultato in un’altra dimensione, totalmente diversa
da quella di prima.
La nostra è una vera e propria conversazione con l’ambiente circostante, hai
però la
possibilità di sviluppare gli altri sensi, che magari con la vista non ti sembravano così
necessari. Questo percorso ti aiuta a capire che al mondo ci sono persone molto ma molto
meno fortunate di noi che seppur non possiedano un senso così fondamentale, ti trasmettono
parecchio la gioia di vivere.”
Luca:
“La Mostra di Milano è stata estremamente interessante poiché mi ha permesso di percepire
ciò che mi circonda sotto altri aspetti e con altri sensi e mi ha permesso di vedere attraverso
altri mezzi che mi hanno permesso di esplorare ciò che mi circonda in modi nuovi.”
Giorgia:
“Sono gli occhi del corpo che sentono la realtà. Guarda i girasoli: i tuoi occhi li percepiscono
come reali, ma se tu potessi sentire il loro profumo, toccare i loro petali, avvertire la loro
consistenza, ti accorgeresti che non sono veri, ma semplici fiori di stoffa e plastica. La realtà
non è mai semplicemente ciò che appare ai nostri occhi.”
Gaia:
“Ho trovato molto interessante questa Mostra, perché mi ha dato la possibilità, attraverso altre
ed inusuali sensazioni, di vivere a pieno momenti di vita quotidiana. Escludere la vista è
molto difficile, ma schiude a noi un mondo fatto di forme odori e sapori!!!!!!!”
Silvia:
“Finalmente ho capito che tutto ciò che mi circonda, per quanto banale possa essere, può
suscitare in noi forti emozioni perché sono quelle che ci fanno sentire vivi.”
75
Rajif:
“Durante il percorso mi sono illuminato nel buio.”
Paolo:
“Una Mostra che non mostra, ma che mostra quanto una Mostra che mostri mi possa
mostrare. Un gioco di parole complicato come la vita di chi non vede. Alla fine si capiscono
le cose, ma per capirle il cammino è spesso complicato.”
Stefano:
“La "Mostra che non mostra” è un viaggio dentro noi stessi. Ci permette di chiudere gli occhi
e di guardarci dentro per poter vedere meglio il mondo che ci circonda.”
Arianna:
“Ogni tanto è bello vedere il mondo da un altro punto di vista; questo infatti mi ha permesso
di conoscere e sfruttare gli altri miei sensi che finora erano rimasti in me stessa.”
Stefano:
“La brezza dell’aria che mi accarezza il volto, il gusto dalla nocciola in bocca, il dolce suono
delle voci dei miei compagni e della natura, tutti piccoli grandi particolari che in questa
Mostra si possono vivere, apprezzare e riscoprire in tutta la loro pienezza.”
Chiara:
“Questa esperienza mi ha fatto capire quanto possa essere difficile vivere vedendo il mondo
con una diversa prospettiva, privi della vista.
Durante tutto il percorso ho avuto modo di “vedere” con il tatto e l’udito prevalentemente, ma
anche con l’olfatto e il gusto molte cose che appartengono alla mia quotidianità.
Per me la Mostra è stata come quest’alba: mi ha un poco illuminata su certi aspetti della vita
di cui non avevo la minima esperienza e di cui forse non mi sono mai interessata
particolarmente. Ho potuto così capire che anche la vista, per me una delle cose più scontate,
in realtà si può definire già una fondamentale conquista per un uomo. Grazie per questa
opportunità, ne farò tesoro!”
Alessandra:
“Questa Mostra mi ha aperto gli occhi.
76
Prima non vedevo, perché non avevo sperimentato, non avevo capito. Ora che ho una visione
più ampia della vita delle persone più sfortunate di me, ho capito che ho un dono, quello della
vista e solo ora capisco quanto è grande”
Federica:
“Per la prima volta ho visto veramente.
Non sono mai stata così felice di vedere.”
Daniele:
“Questa Mostra mi ha fatto capire che ogni realtà ha un suo profumo,un suo sapore, e che è
importate saper apprezzare tutti gli stimoli che essa può offrire; è proprio vero che
l’essenziale è invisibile agli occhi ”.
Sara:
“Ho provato un sentimento di paura all'inizio però mi sono sentita subito protetta, dalla guida
ma anche dai miei compagni.”
77
Capitolo 4
LA GRUPPOANALISI E “DIALOGO NEL BUIO”
Dinamiche e Parallelismi
Lavoro ormai da due anni alla mostra “Dialogo nel buio”, e ho guidato molti gruppi.
Parallelamente, il mio percorso di studi mi ha fatto incontrare l’affascinante capitolo della
Gruppoanalisi e delle dinamiche di gruppo che si osservano nei gruppi analiticamente
condotti. Mi sono resa conto, dunque, che ogni ora al buio conducevo un gruppo e che ogni
gruppo portava in sé caratteristiche, vissuti, configurazioni che potevo rintracciare anche nella
Gruppoanalisi. Da qui l’ipotesi di base per rileggere le dinamiche di alcuni gruppi di Dialogo
nel buio in chiave psicoanalitica.
In ogni piccolo gruppo umano, dalle 6 alle 20 persone, ci sono dinamiche ricorrenti.
Differente però è l’utilizzo che il conduttore fa della loro comprensione, osservandole dal
punto di vista gruppoanalitico. In questo capitolo, quindi, cercherò di delineare quelle
dinamiche della Gruppoanalisi che si rintracciano anche in queste esperienze gruppali al buio,
sottolineando omogeneità e differenze, e portando esempi pratici.
E’ opportuno notare, innanzitutto, come i paradigmi fondanti lo statuto epistemologico della
Gruppoanalisi siano rintracciabili anche alla base del progetto di Dialogo nel buio. Vediamoli
uno per uno.
Entrare al buio, privati di un senso, all’inizio crea caos e impone di ordinare, gerarchizzare,
porre un freno. Spesso l’impatto fa paura perché intorno c’è l’ignoto. Le persone non sanno
dove andare, a cosa prestare attenzione, non sanno se muoversi o camminare, chiedono se ci
sono pericoli, e via dicendo. Sta alla guida ridurre paure ed ansie e riportare la situazione alla
normalità. Piano piano, poi, ci si rende conto che, grazie all’uso degli altri sensi, il mondo
esterno che prima sembrava sparito, distrutto, lasciato fuori, si può esplorare di nuovo, è lì
davanti a noi; è “semplicemente” cambiato il modo col quale lo si approccia. Questo è lo
specifico della complessità del Dialogo nel buio. In Gruppoanalisi, analogamente, come nota
Morin (1982), la complessità si presenta con i tratti inquietanti dello scompiglio,
dell'inestricabile, del disordine, dell'ambiguità e dell'incertezza. Da cui la necessità, ai fini
della conoscenza, di mettere ordine nei fenomeni rimuovendo il disordine, di allontanare
l'incerto, selezionando gli elementi di ordine e di certezza, di togliere l'ambiguità, chiarire,
distinguere, gerarchizzare… Ma tali operazioni, necessarie all'intelligibilità, rischiano di
rendere ciechi, se eliminano gli altri caratteri del complesso. Roger Lewin (1993), del resto,
notava come ordine e caos non fossero che gli estremi di un universo la cui struttura è
estremamente complessa. Tuttavia, la complessità ci insegna anche che realtà molto diverse
possono coesistere insieme, senza escludersi, e che molteplici punti di vista possono
affiancarsi, poiché dipendono dalla posizione di chi osserva. Queste ragioni, ed altre ancora,
spiegano il fatto che la complessità può essere assunta come paradigma del gruppo stesso. Il
gruppo che si confronta con l’ignoto, e con l’angoscia che da esso deriva, si confronta
innanzitutto con se stesso.
Nella sua recente rilettura della tragedia di Edipo, Corbella ha preso in considerazione “i
primi momenti violenti fondanti il mito, in cui Laio e Giocasta rappresentano una coppia non
unita dall’amore ma accomunata dai bisogni narcisistici. Essi, non essendo in grado di
cogliere gli aspetti simbolici del discorso oracolare, temono la nascita del figlio come
distruttiva delle proprie rigide sicurezze. Edipo, all’inizio, appare quindi come il
rappresentante del nuovo, il portatore di morte di un primitivo narcisismo che non sopporta i
cambiamenti, vissuti come pericolosi. Allo stesso modo, inizialmente, i componenti di un
gruppo, per sfuggire all'angoscia dell'ignoto, negano la diversità unificandosi in un’appiattente
uniformismo, in cui ci si illude di riproporre un primitivo e superficiale modello di sterile
condivisione” (Corbella 2003). Come afferma Neri (1995), “alla minaccia al narcisismo
individuale, si risponde instaurando un narcisismo gruppale”. E’ alla guida, al conduttore, al
terapeuta, quindi, che ci si affida, per attutire l’impatto con l’ignoto, con le proprie angosce e
paure. A lui si richiede, più o meno esplicitamente, di indicare come procedere, cosa fare. La
sua figura è inizialmente, idealizzata; del resto, secondo Neri, “ogni gruppo si costituisce
intorno a un’idea messianica”. Per situarsi immediatamente oltre la richiesta normativa del
gruppo, è necessario evidenziare che uno stato d’animo di incertezza e confusione è da tutti
condiviso: ciò, attraverso il riconoscimento e l’esplicitazione del sentire del gruppo, stimola la
condivisione dei propri vissuti, e pone le basi per il dialogo e il confronto. Solo se si riesce a
tollerare l'ansia dell'ignoto, diventa possibile avvicinarsi all'altro con meno paura, perché si
riduce il bisogno di ricondurlo e appiattirlo sulle nostre aspettative, e lo si considera con meno
diffidenza e più rispetto delle infinite variabili inconoscibili che ogni incontro porta con sé.
Edipo quindi, in modo apparentemente paradossale rispetto al nucleo del conflitto edipico,
sembra rappresentare in un primo momento proprio quell’elemento di disturbo, quell’alterità,
con cui egli stesso dovrà confrontarsi crucialmente per il costituirsi della propria identità.
Per quanto riguarda il paradigma della supplementazione, c’è da dire che l’inconoscibile, il
buio, fa confrontare tutti col senso del limite, con quello che i non vedenti NON hanno o
79
NON possono fare. E’ molto importante il rapporto che si crea tra guida e gruppo e gruppo e
guida, quasi si venisse a creare una sorta di transfert e controtransfert, che influenza
l’atmosfera gruppale. Come osserva Corbella, il limite alle nostre fantasie di onniscienza può
essere assai difficile da tollerare. “E’ molto più semplice, di fronte allo smarrimento che
accompagna l’affacciarsi all’infinito, tacciare di inferiore, di indegno della nostra attenzione
ciò che non si riesce a comprendere od omologare al già noto. Quante potenzialità distruttive
siano presenti nel passare da un pensiero insaturo ad uno saturante, dalla tolleranza del
diverso all’integralismo che pretende la stereotipia condivisa, è purtroppo storia ormai
quotidiana” (Corbella, 2004). Tuttavia, la consapevolezza del limite in realtà rende liberi,
perché il limite viene scoperto attraverso la conoscenza, e la conoscenza ci libera dalle paure
più arcaiche e irrazionali., aprendoci verso quelle direzioni che realmente possiamo
percorrere, svelandoci possibilità inaspettate e sorprendenti. E in Gruppoanalisi, la
supplementazione fa avvertire in modo particolarmente forte la sua presenza, dal momento
che, per quanto il gruppo possa esplorare e riesplorare i propri vissuti, ed i membri possano
confrontarsi con la propria ed altrui interiorità, rimarrà sempre un di più, un quid più o meno
grande di inconoscibile, che permette di toccare con mano sia il senso del limite, sia il valore
della propria potenza reale.
L'accettazione
e
la
valorizzazione
della
diversità,
e
dell'ambivalenza,
ma
anche
dell’arricchimento che essa può comportare, appaiono fondamentali nel passaggio dalla logica
dicotomica a quella della complementarità, dall'intolleranza alla tolleranza, intesa come
apertura dialogica all'altro. Ma il confronto con l'altro non è solo quello con l'altro "esterno".
E', prima di tutto, un confronto con se stessi, con la propria conflittualità e ambivalenza, con
le parti più oscure, immature e distruttive. E' questo il lavoro d'impronta gruppoanalitica, un
lavoro che implica la riattualizzazione delle fasi di sviluppo del proprio sé, ed in modo
particolare, coinvolge anche la rimessa in discussione dei diritti e dei doveri. Questa, infatti,
stimola "il passaggio dalla logica dell’aut-aut che caratterizza l'area onnipotente della colpa,
alla logica dell’et-et che caratterizza l’area di potenza adulta della responsabilità, in una
costante dialettica fra sé e l’altro" (Corbella, 2004). La colpa, infatti, spesso riattualizza una
modalità arcaica del pensiero, che fissa il sé in una posizione rigida, autoreferenziale, tale da
non concedere alternative. Mentre invece, non esiste un solo punto di vista corretto: ciò che si
vede dipende strettamente dal vertice d’osservazione, dalla prospettiva, e ogni prospettiva può
arricchire la comprensione della realtà. A Dialogo nel buio, emerge con chiarezza il fatto che
la prospettiva è legata anche al canale, al mezzo, allo strumento. Bisogna che tutti capiscano
che vedere e non vedere non sono aut-aut ma et-et. Sono solo due modi diversi di “osservare”
la stessa realtà.
80
Vediamo ora quali sono le motivazioni che spingono una persona a partecipare ad un gruppo
analiticamente condotto, o a Dialogo nel buio. Per quanto riguarda l’analisi, “la proposta di
partecipare ad un gruppo, come ogni progetto di cura, può già contenere in sé delle
potenzialità terapeutiche. Questo, consapevoli del fatto che il gruppo innanzitutto si
costituisce come oggetto immaginario sia nella mente del terapeuta, sia in quella degli
individui a cui viene proposto, con caratteristiche diverse a seconda della loro struttura di
personalità” (Corbella 2003). Chi accetta di mettersi in gioco inizia già una riflessione ed una
ridiscussione di se stesso, anche se accettare non sempre vuol dire realmente “mettersi in
gioco”: gli individui che accettano immediatamente e con entusiasmo una terapia di gruppo
sono spesso persone con comportamento compiacente con tendenza a negare le difficoltà e,
quando costrette a confrontarsici, non di rado abbandonano il gruppo. Analogamente, quando
un amico propone ad un altro di partecipare a Dialogo nel buio e gli spiega cos’è, già ingenera
domande, o riflessioni e confronti, anche col suo mondo interno. Spesso le storie personali,
che mi vengono raccontate man mano che il percorso si snoda, spiegano le motivazioni che
hanno portato i visitatori ad arrivare a Dialogo nel buio. Alcuni hanno parenti o amici non
vedenti, e vogliono immergersi nel loro mondo e capire com’è la percezione di queste
persone. Altri hanno una malattia agli occhi, come ad esempio la miopia, e vogliono
sperimentarsi nel buio per vedere se potrebbero vivere anche senza vedere. Altri ancora hanno
subito traumi profondi e cercano, faticosamente, di combattere con essi e risolverli. Altri
ancora soffrono di claustrofobia, e vogliono cercare di sconfiggerla. Queste le motivazioni
razionali espresse, ma chissà quali aspetti inconsci e inconoscibili suppongono.
Ritornando ai gruppi analiticamente condotti, anche il rifiuto netto e deciso di una terapia di
gruppo, da parte di un paziente, va accolto. Nel corso del lavoro terapeutico individuale
emergerà che spesso, dietro il rifiuto della proposta di un setting gruppale, c’è una messa alla
prova del terapeuta. Il paziente sonda quanto il terapeuta vuole aver ragione ed esibire il suo
potere, o quanto è disponibile ad accogliere il rifiuto, anche se può sembrare un capriccio.
Così, può rimanere spiazzato dall’accoglimento del “capriccio”, e spesso, dopo alcune sedute,
è proprio il paziente stesso a riproporre il gruppo. E’ quindi importante che il terapeuta
mantenga l’alleanza con la parte “capricciosa” del paziente, e si dia il tempo per capire a
fondo le motivazioni che hanno portato al rifiuto. A Dialogo nel buio, spesso succede che
qualche persona, presa da un attacco d’ansia, panico o claustrofobia, chieda di uscire subito.
Per fortuna, in casi come questi, c’è a disposizione il jolly, una guida che non ha visitatori da
accompagnare, e che, quindi, è libera di girare tra un gruppo e l’altro, aiutando le altre guide
nelle situazioni più diverse. Qui, ad esempio, il jolly cercherà di convincere la persona a
restare al buio, e a continuare l’esperienza. In alcuni casi, l’opera di persuasione non ha luogo
81
perché l’emozione negativa è troppo intensa; più spesso, invece, i visitatori in difficoltà si
sentono rassicurati dall’avere a fianco una persona che darà loro la mano durante tutto il
percorso, e decidono di continuare. Forse si sentono anche accolti nella loro parte capricciosa,
ma in realtà chissà quali componenti inconsce vengono attivate. Sicuramente, in casi come
questi, sarebbe interessante poter analizzare l’esperienza in un’analisi individuale o di gruppo,
o almeno grazie a qualche colloquio analiticamente orientato. A Dialogo nel buio, però,
questo non può essere fatto e le motivazioni sono molte. Le guide non sono psicologi esperti
di terapie, ma solo persone non vedenti che insegnano, o cercano di insegnare, ai gruppi,
come valorizzare i sensi residui rispetto alla vista. Certo, al buio si sono acquisite delle
competenze tali per cui le guide sono in grado di rassicurare chi è a disagio o spaventato,
fargli passare la paura, e condurlo alla luce finale senza problemi, ma certo non possono avere
un rapporto uno ad uno con la persona in difficoltà e fare da terapeuta. A tal proposito, vorrei
riportare due episodi che mi sono accaduti e che mi sono rimasti impressi per la loro
particolarità.
In uno, ero jolly. Ad un certo punto, sento nel primo ambiente del percorso una persona che
piange, vuole uscire, proprio non riesce a stare lì. Accorro, mi presento e cerco di capire cosa
non va; nel frattempo il gruppo prosegue il percorso, e resto con lei nel primo ambiente. E’
una ragazza indecisa, bloccata, non riesce a proseguire nel buio, ma non vuole neanche uscire.
Utilizzando le mie poche competenze, l’aiuto a prendere consapevolezza del suo respiro,
l’aiuto a rilassarsi e finalmente riesce a raccontarmi cosa la sta assillando così profondamente.
Qualche anno prima aveva avuto un incidente che l’ha lasciata per alcuni giorni in uno stato
di coma pre-morte. Dal suo risveglio non si è sentita più la stessa persona; gli psicologi che
l’hanno visitata hanno continuato a dirle che stava vivendo una continua scissione tra mente e
corpo. Accolgo il suo racconto, e capisco di colpo cosa quel momento significhi per lei. Ha
paura di morire, di non vedere più la luce, ma capisce che di me può fidarsi, che deve provare,
anche se iniziare quel lungo viaggio la mette a disagio. Piano piano, dopo aver iniziato una
danza insieme, si rilassa, e riesco a farla entrare nel “parco”, e poi via fino al bar. Un ultimo
cedimento in “città”, ma poi capisce che deve riuscire a finire tutto il percorso, soprattutto per
se stessa.
Tornata a casa, ricevo questa e-mail: “Carissima Chiara, sono le 18.30 e sono ormai ritornata
a casa. Non ti so ben dire come mi sento, ma ci proverò. Penso al nostro incontro a quello
spazio/tempo senza tempo reale. E’ stata un'esperienza indimenticabile. Come avevamo
verbalizzato, l'esperienza del buio ha risvegliato in me dei vissuti traumatizzanti, ma stavolta
il destino mi ha giocato una bella sorpresona. Sicuramente dentro di me volevo vivere
l'esperienza del buio, ne sentivo una forte attrazione, ma in quell'inizio un po' incalzante sono
82
ripiombata nel baratro della paura. In effetti, senza nulla togliere all'affabilità del tuo collega,
aspettavo TE. Nella tua voce sicura e calda, nei movimenti del tuo corpo lenti e rispettosi,
quasi in un ascolto empatico, ho sentito una grande accoglienza e tanto, tanto amore. Come
non avrei potuto lasciarmi andare all'esperienza? Mi era capitata l'Angelo/guida per
eccellenza, come potevo rifiutare quel viaggio se per mano mi teneva un tale essere! Sono
felice di averti incontrata e spero vivamente di poterti rincontrare per poter conoscerti meglio.
Porterò nel cuore l'esperienza di oggi. Lascerò che faccia il suo corso ringraziando ancora una
volta la Vita.” Anche in questa situazione, come spesso accade nella terapia, un po’ di
idealizzazione iniziale è necessaria per potersi contrapporre ad esperienze traumatiche che
hanno evocato modalità arcaiche di pensare.
Con un’altra persona, ho fatto un viaggio particolare che, però, cercherò di riassumerere in
poche parole. Anche in questo caso ero jolly. Mi accorgo che una ragazza cerca di uscire. Di
nuovo, dopo vari tentativi, la convinco a restare. Non vuole altri vicino a sé, vuole stare col
gruppo ma in una zona spazialmente distante da loro, per vivere l’esperienza sia da sola che
con gli altri, in tutta la sua complessità. Piano piano mi racconta cosa si cela dietro la sua
paura: ha visto sua madre morire e poi l’ha vista chiusa nella bara. Da quel momento, ha
avuto sempre paura dei luoghi bui e chiusi. Anche con lei, il percorso è stato eccellentemente
portato a termine con un senso di realistica positiva potenza da parte di entrambe.
Abbiamo detto che il gruppo deve formarsi, prima di tutto, nella mente del terapeuta. La
stessa cosa vale per le guide di Dialogo nel buio. Mi rendo conto, infatti, delle differenze nel
mio stato emotivo a seconda che il gruppo sia presente nella mia mente come tale, o meno. Se
c'è questa consapevolezza, riesco a riconoscere le persone una ad una, ricordo i loro nomi, mi
interesso delle loro vite e, magari, delle loro storie personali. Se sono particolarmente stanca,
stressata, o se il gruppo non mi piace, questo non accade; mi sento estranea all'entità che sto
accompagnando, mi vivo esterna a loro, io da una parte e gli altri dall'altra, senza un minimo
di quell'empatia che sarebbe invece necessaria per far bene il lavoro di guida. Di tutto questo
probabilmente i partecipanti al gruppo non si accorgono, dal momento che io continuo
comunque a fare tutto quello che va fatto per condurre quel gruppo nel modo migliore. Sono
io a volte a sentirmi diversa, a riconoscermi come parte del gruppo, o come fuori da questo.
Vediamo, ora, quali sono le potenzialità del piccolo gruppo in Gruppoanalisi e in Dialogo nel
buio. Nel primo caso, il gruppo mette bene in evidenza che la rappresentazione del Sé risulta
da una costruzione dinamica di contenuti mentali propri e altrui. L’interazione nel piccolo
gruppo sembra l’unica struttura nella quale è possibile vedere l’intero Sé dell’individuo,
completo delle sue parti consapevoli, rimosse, proiettate e indotte negli e dagli altri. Esso
pertanto, attraverso il gioco multispeculare dei confronti e delle identificazioni-proiezioni,
83
favorisce “naturalmente” ed inevitabilmente quel processo di messa in gioco, di
rappresentazione
e
quindi
di
ri-cognizione
profonda
e
complessa
dell’abituale
rappresentazione di Sé e del mondo.
La finalità dei gruppi di Dialogo nel buio non può essere ovviamente così profonda ed
articolata, dato che ogni gruppo si forma e si scioglie nel giro di poco più di un’ora. Al buio
però, per ogni persona è rassicurante la presenza degli altri, ci si aiuta, si esplora insieme,
ovviamente tenendo la guida come quasi esclusivo punto di riferimento.
Per quanto riguarda la costituzione dei gruppi, invece, il gruppo terapeutico classico è ad
indirizzo analitico, misto, semiaperto; tuttavia, a diversi tipi di pazienti possono essere adatti
differenti tipi di gruppi, ognuno caratterizzato da fattori terapeutici specifici e dinamiche
ricorrenti. Si possono avere indicazioni per gruppi classici, ma anche per gruppi a termine,
oppure omogenei per età, sesso, patologia, o ancora gruppi a tema, o di autoaiuto. Per valutare
i criteri d’inclusione è importante comprendere i diversi benefici che il paziente può trarre dal
lavoro gruppale. Tra i principali, ricordiamo, con Corbella (2003), la condivisione dei propri
problemi con altri, e la possibilità di migliorare le capacità comunicative e relazionali; la
consapevolezza della distanza relazionale adeguata alle diverse situazioni, che nasce dalla
costante dialettica fusione-individuazione presente nel gruppo; lo stimolo al costituirsi di una
consapevolezza di sé come soggetto avente valore, ed il riemergere di ricordi individuanti,
entrambi favoriti dalla costituzione di una storia comune all’interno del divenire gruppale;
infine, l’effetto riparativo del e sul passato, facilitato dalla sperimentazione di nuove
esperienze affettive, cognitive ed emotive, all’interno della rete relazionale terapeutica. E’
fondamentale, in ogni caso, comporre il gruppo in modo corretto, per bilanciare aspetti di
omogeneità ed eterogeneità, ed escludendo chi è inadatto ad un percorso terapeutico di questo
tipo.
I gruppi di Dialogo, apparentemente, sono molto eterogenei; la loro composizione, infatti,
varia in base ai casi, ai periodi ed alle prenotazioni. Alla mostra arrivano molte scolaresche e
altrettanti gruppi di privati. Le scolaresche vengono divise in gruppi dai loro insegnanti,
quindi i membri si conoscono già tra loro, e condivideranno anche l’esperienza del buio. I
gruppi di privati, invece, si costituiscono in base alle prenotazioni, quindi possono esserci
interi gruppi di amici o famiglie, ma anche configurazioni differenti e variegate: coppie tra
loro estranee, una famiglia con figli e coppie che non si erano mai conosciuti fra loro, due
famiglie sconosciute, varie persone sole di diverse età, persone italiane e straniere, e così via.
Tuttavia, benché possa sembrare apparentemente scontato, tali gruppi sono accomunati da una
variabile fondamentale. Tutti i loro membri sono dei vedenti, e si apprestano ad affrontare lo
stesso percorso, un’esperienza completamente nuova, con la guida di una persona che, in
84
questa prospettiva, presenta la caratteristica opposta: è non-vedente. In tal senso, essi possono
essere considerati, di fatto, come gruppi omogenei.
Nel lavoro gruppale, l'omogeneità, seguendo Friedman (2004), si può definire principalmente
secondo i termini della composizione del gruppo e dei temi affrontati. Il gruppo terapeutico
omogeneo è legato ad ambiti specifici di ricerca, cura e sostegno, per lo più delimitati nella
durata e nelle finalità. Si tratta di pazienti con medesima diagnosi o condizione di sofferenza
interiore: malati mentali o organici, o portatori di handicap; familiari di malati, o di
tossicodipendenti; oppure anche soggetti non accomunati dalla diagnosi, o dalla parentela, ma
piuttosto da un tema, una finalità (per esempio la riabilitazione dopo un intervento) o una
condizione problematica (come ad esempio l’adozione o l'affidamento, il sostegno alle donne
in gravidanza, agli anziani, alle coppie in via di separazione, o a singoli individui che
attraversano fasce di età critiche, come l'adolescenza, o la menopausa per le donne). Al di là
del campo terapeutico e di sostegno psicologico, i gruppi omogenei sono utilizzati anche in
ambito formativo. E’ quindi evidente l’estrema flessibilità e utilità di questo strumento,
chiaramente dotato di grosso potenziale intrinseco.
Per Corbella (2004), le persone per cui è preferibile almeno un inizio di terapia in questi
gruppi, vivono situazioni patologiche o sociali-esistenziali legate a sentimenti di
inadeguatezza e vergogna, che inducono a circoscrivere la propria vita in ambiti sempre più
limitati, riducendo in questo modo le proprie opportunità, e quindi anche le capacità di
progettazione di investimento sul futuro e di integrazione nel sociale. “La solidarietà di un
gruppo che condivide situazioni analoghe può costituire un primo scudo protettivo contro tali
sentimenti di solitudine ed emarginazione, fornendo una prima possibilità di esprimere,
evidenziare e modulare i vissuti di impotenza” (Corbella 2003).
Non a caso, a Dialogo nel buio viene ricreata una situazione di disabilità a beneficio dei
vedenti, i quali, calati in una condizione simile a quella che permea la vita dei non vedenti,
possono in questo modo iniziare a comprenderla, non solo razionalmente ma anche “a pelle”,
supportati dal fatto di non essere soli nell’affrontare quest’esperienza, ma in un gruppo di
“pari”, e con la guida di chi già sa, e quindi, conosce il modo di gestire questa condizione.
L’omogeneità facilita l'uscita dalla solitudine angosciante e alienante, del sentirsi non umani o
mostruosi, (Neri 1995), e favorisce la certezza di venire accettati e compresi, in modo
profondo e immediato, sia a livello verbale, che non verbale (cosa che nei gruppi misti,
eterogenei, si realizza inizialmente soprattutto all'interno dei sottogruppi). I partecipanti, in
effetti, tendono a pensare che chi non appartiene alla popolazione del gruppo non riuscirebbe
a capire ciò che questa vive. Tuttavia, è bene altresì precisare che omogeneità ed eterogeneità
sono, in parte, anche questioni di sfumature e funzionamento dei gruppi, legate alla
85
personalità dei membri, nonché alla particolare fase vitale del gruppo stesso. Qualsiasi
cosiddetto gruppo eterogeneo può funzionare in maniera sostanzialmente omogenea, quando
gli aspetti in comune fra i partecipanti sono molto accentuati, o quando la fase di fusione è
molto profonda; così come molti gruppi cosiddetti omogenei possono funzionare in maniera
eterogenea nei momenti in cui le differenze fra i membri sono accentuate, o quando essi
attraversano un forte momento di individuazione.
Nel gruppo analiticamente condotto si intrecciano un set (caratteristiche, organizzazione
strutturale, tempi, luoghi, tutto ciò che è esplicitamente definito del gruppo) ed un setting
(l’impianto teorico personale del terapeuta che struttura il gruppo). Questi stessi concetti sono
rintracciabili anche nell’assetto di Dialogo nel buio. Il set è costituito dal percorso al buio e
dalle regole esplicitate all’inizio da chi accoglie i visitatori alla luce: lasciare negli armadietti
giacche, occhiali, qualsiasi oggetto che possa fare luce; portare con sé solo qualche moneta
per poter pagare la consumazione al buio nel bar, ultima tappa del percorso; tenere il bastone
in una certa maniera, e così via. Il setting, invece, è il modo individuale di ogni singola guida
di “condurre” appunto i gruppi, e dipende da molti fattori: la storia personale, il rapporto con
la disabilità, i tratti caratteriali più salienti. Così, ad esempio, una guida meticolosa e ansiosa
terrà sempre tutti i gruppi vicino a sé, avrà continuamente paura di perdere qualcuno, farà in
modo che ognuno esplori e tocchi tutto. Al contrario, una guida più tranquilla ed empatica
cercherà di far capire ai visitatori il reale scopo per il quale è stata creata questa Mostra, cioè
quello di imparare a vivere la realtà anche in un modo diverso da quello usuale; cercherà di
creare un rapporto empatico coi gruppi, preoccupandosi meno degli oggetti, e più delle
emozioni dei singoli.
Set e setting sono fondamentali per la definizione e il contenimento degli eventi che si
verificheranno all’interno del gruppo. In un contesto terapeutico, ad esempio, le principali
minacce alla vita gruppale sono caos e massificazione, vissute soprattutto a livello fantastico
nel corso delle fasi iniziali dell’esperienza di gruppo. Il timore dell’emergere di una situazione
caotica e insostenibile porta a chiedere, nelle prime sedute, regole e continuità, accentuando la
dipendenza dal terapeuta. Analogamente, anche nel primo ambiente di Dialogo nel buio, molti
gruppi fanno domande che presuppongono l’esistenza di regole, di procedure che diano
sicurezza, ad esempio su come dovranno tenere il bastone, se debbano camminare sempre in
fila indiana e vicini alle pareti, e così via. Per queste ragioni, è bene che, sia nei gruppi
terapeutici che in quelli di Dialogo nel buio, vengano esplicitate quanto prima alcune regole
ed indicazioni fondamentali.
Innanzitutto, l’importanza della puntualità, che va ribadita ancor prima dell’incontro fra i
membri, in quanto sottolinea la loro interdipendenza, un fattore la cui consapevolezza appare
86
fondamentale anche in Gruppoanalisi. Bisogna, a questo riguardo, considerare che il primo
ambiente del percorso è una stanza completamente vuota che io, e molte altre guide, usiamo
per conoscere il gruppo ed i sentimenti iniziali dei partecipanti, creando così una prima
condivisione, essenziale per la buona riuscita di tutta l'esperienza. A volte, ad esempio,
succede che le scolaresche arrivino in ritardo, quindi si è costretti, per non compromettere
anche i tempi del gruppo successivo, a velocizzare di gran lunga il percorso, facendo venir
meno quello spazio temporale iniziale molto importante per favorire la comunicazione nel
gruppo. Altre volte, coi privati, succede che alcuni ritardatari vengano condotti nel primo
ambiente quando la guida ha già iniziato il percorso con quelli puntuali. In questi casi, anche
se il ritardo è di pochi minuti, è sufficiente a turbare l’equilibrio del gruppo appena formatosi.
All’ingresso nel buio, poi, si scatenano le reazioni più diverse, e alcuni hanno una paura così
grande da voler uscire a tutti i costi e subito. Anche questo altera l’armonia del gruppo che,
essendo in fase iniziale, non è ancora veramente formato. Che si tratti di privati o di scuole, il
rischio è che la sensazione di paura che ha provocato l’uscita di un membro del gruppo faccia
diffondere la paura in tutto il gruppo. In questi casi, cerco sempre di parlare della paura, di
renderla “pensabile” e mentalizzabile invece di agirla. Ricordiamo a questo proposito che per
mentalizzazione intendiamo “la capacità di simbolizzazione, di collegare i propri sintomi a
trame di pensiero, di creare strutture mentali aperte a nuove significazioni” (Pontalti et al.,
2000). Per Corbella (2003), “ogni gruppo costituito in modo da permettere di prendersi cura,
aumenta la capacità di mentalizzare problemi, disagi e difficoltà di ogni partecipante”, nel
senso di rendere il gruppo “un luogo di incontro che attivi o ri-attivi, a diversi livelli, la
capacità di pensare e sognare di gruppo e in gruppo”. In particolare, l’obiettivo di qualsiasi
tipo di gruppo analiticamente orientato resta quello “di utilizzare il gruppo come campo
mentale che aumenti la mentalizzazione del paziente”. (Pontalti et al., Ibidem).
Una seconda importante regola anche del Dialogo nel buio è quella di dire tutto ciò che viene
in mente. Molti hanno pregiudizi, preconcetti, pensano che sia sbagliato fare certe domande;
per questo, da subito si esplicita che Dialogo nel buio si chiama così proprio perché si è liberi
di parlare con la guida, e di chiederle tutto quello che passa per la mente. E’ chiaro, però, che
questa stessa possibilità può all’inizio spaventare, perché comporta l’esporsi personalmente.
D’altra parte, la paura di parlare liberamente può anche riflettere timori più profondi, come
quello di confrontarsi anche dentro se stessi con ciò che si prova.
Una regola molto simile e fondamentale in Gruppoanalisi, è la richiesta di “esprimere
liberamente, a livello verbale, tutto quello che viene in mente, senza nessuna preclusione
logica o sistematica o conseguente alle regole di buona educazione” (Corbella, 2003). Per un
gruppo che deve ancora formarsi, questo sarà un risultato non immediato, da costruirsi nel
87
tempo. Non è semplice, anche perché i sentimenti devono essere espressi agli altri come
sentiti sul momento, nel qui ed ora di ogni seduta; non serve, ma anzi è nocivo, ricorda
Corbella, “prepararsi il compito a casa”. Esprimersi liberamente darà luogo a una libera
discussione fluttuante, che costituirà una sorta di “catena associativa gruppale”. Corbella nota
come quest'ultima definizione, utilizzata da Kaes, evidenzi il modo in cui ciascun partecipante
contribuisca col suo pensiero a formare un “prodotto” condiviso: metafora che può assumere
un significato rassicurante. E' chiaro, infatti, che, se si richiede ad una persona di mettersi a
nudo di fronte agli altri, bisognerà rassicurarla, darle delle garanzie. Ecco perché la regola
della riservatezza sui contenuti che emergeranno è in un certo senso implicita nella regola
fondamentale: ognuno tende a non fare agli altri quello che non vorrebbe fosse fatto a sé.
Come afferma Foulkes (1975), "in pratica i pazienti rispettano i reciproci segreti"; tuttavia, è
forse comunque preferibile che la regola della discrezione vada esplicitata.
Ovviamente, le regole ci sono anche perché la tentazione della trasgressione è sempre dietro
l’angolo. Per fortuna, a Dialogo nel buio, un discorso sulle trasgressioni è possibile solo coi
gruppi di scuole: la punizione più grave è di far loro interrompere il percorso prima della fine.
Ciò si realizza, solitamente, quando tutto il gruppo è totalmente disinteressato all’attività che
gli si sta proponendo, cosa che, a mio avviso, accade in primo luogo per ignoranza sugli
obiettivi e le modalità della Mostra.
Dialogo nel buio, in effetti, invia ai presidi delle scuole il materiale pubblicitario; poi sta ad
essi passare le informazioni agli insegnanti, i quali diventano gli informatori dei ragazzi.
Spesso, a mio avviso, gli insegnanti non comprendono a pieno i messaggi di questo tipo di
esperienza, e trasmettono ai loro alunni informazioni insufficienti, distorte o addirittura
incomplete. E’ anche per questo che, in genere, quando inizio i gruppi con le scuole, chiedo
sempre cosa sanno di Dialogo nel buio, cosa si aspettano da questa esperienza, e se secondo
loro chi li accompagna nel percorso vede o no. A queste domande, purtroppo, ottengo le
risposte più diverse: “Sì, tu vedi”; “Ma hai gli infrarossi?”; “Boh, non so niente!”; “Vorrei
imparare come vivono i ciechi”; “Bello, è una gita per saltare la scuola!”. E via di questo
passo. Ci sono dei gruppi che, quando capiscono i reali motivi della loro presenza lì, vengono
motivati e sono interessati a quanto gli si sta proponendo. Altri, però, per le motivazioni più
disparate, fanno continuamente confusione, non ascoltano la guida perdendo così
informazioni preziose su dove devono andare e sulle cose via via da toccare, continuano a
chiamarsi tra loro, a spingersi, a chiedere la posizione dell’uno o dell’altro compagno: tutto
questo rende il giro non semplice da portare avanti e forse nemmeno utile. Invece fermandosi
a ragionare con loro, aiutandoli a verbalizzare cosa non va, piano piano anche queste
situazioni possono tornare ad essere costruttive. Nei casi più gravi, però, l’obiettivo della
88
guida diventa quello di fare il percorso nel più breve tempo possibile e portarli fuori prima
che si facciano male davvero o combinino guai. Capita spesso, ad esempio, che i partecipanti
si facciano dispetti, lancino gli oggetti, tengano i bastoni con la punta in alto, rischiando di
fare danni seri e irreparabili ai compagni. In questo caso diventa davvero insostenibile la loro
permanenza all’interno del percorso. In alcuni casi, invece, è una sola persona, o due, a
disturbare, e quindi, per evitare che distraggano l’intero gruppo, si cerca di tenerli
costantemente sorvegliati, vicini alla guida, li si interroga spesso su cosa stanno toccando o su
cos’ha appena detto il conduttore, e se le cose non migliorano, si mandano fuori, riuscendo
così a far tornare il sereno nel gruppo. Per inciso, e per fortuna, ci sono invece dei gruppi da
subito interessati, bene informati e motivati. Secondo me, sarebbe auspicabile che fossero
direttamente le guide ad interagire nelle scuole con presidi, insegnanti e ragazzi, facendo
magari con loro delle attività propedeutiche al buon esito della permanenza al buio. Questa
possibilità è stata inizialmente presa in considerazione dall'amministrazione, e respinta a
causa di difficoltà di carattere economico. In ogni caso, data l'importanza che la motivazione
iniziale ha per chiunque partecipi (in particolare per le scuole) a un'esperienza di questo tipo,
saranno presto messe in atto altre modalità affinchè si possa effettivamente realizzare
un’adeguata preparazione al percorso. Ritornando al discorso sui trasgressori, essi potrebbero
essere i portavoce, per tutto il gruppo, dell’angoscia dell’ignoto, una dinamica esplicitabile
nella figura del capro espiatorio. Essa prevede l’utilizzo del meccanismo difensivo arcaico di
identificazione proiettiva, che, come nota Corbella (2003) è fortemente presente
nell’interazione gruppale, “scaricando” fantasmaticamente sull’altro, parti di sé vissute come
disturbanti, angoscianti, e quindi impensabili, soprattutto in momenti di passaggio e di crisi.
Quando il capro espiatorio è identificato all’esterno (ad esempio, nel buio), spesso il gruppo si
pone in assunto di base di Attacco-Fuga, a volte nel tentativo di ritrovare una certa coesione
indifferenziata di fronte al riattualizzarsi di movimenti evolutivi difficili e dolorosi. Non è un
evento pericoloso, se ben gestito e contenuto dal conduttore. Altre volte il capro espiatorio
può diventare l’istituzione che contiene l’esperienza stessa; è molto importante, in questi casi,
rendere pensabili e gestibili, da parte del gruppo e dei singoli, le angosce sottese. Tuttavia,
anche un membro interno al gruppo, qualora oggetto di attenzioni ostili, sadiche e offensive,
può essere “scelto” come capro espiatorio, col rischio di farsi espellere o di andarsene dal
gruppo, e riproponendo, come osserva sempre Corbella, al gruppo stesso vissuti di colpa,
impotenza, onnipotenza negativa e percezione della propria gruppalità come di un contenitore
fragile e inadeguato alla gestione di angosce e difficoltà. Si tratta della situazione più
problematica e pericolosa, tipica dei momenti di crisi trasformativa, che può minacciare
l’esistenza stessa del gruppo. La vittima è considerata come “diversa”, colei che incarna gli
89
aspetti disturbanti l’integrità e la presunta identità gruppale. Ma essa non sempre è innocente;
spesso trova nell’assumere questo ruolo una gratificazione narcisistica, mantenendo un ideale
di sé onnipotentemente distruttivo, e colludendo, quindi, col resto del gruppo. Questa condotta
si può collegare agli agiti adolescenziali: l’adolescente, non trovando collocazione né nel
mondo adulto né più in quello dell’infanzia, tende facilmente a vivere un senso di impotenza
che sfocia poi nella distruzione, mettendo in atto anche comportamenti antisociali. Secondo
Corbella, il conduttore può evitare l’uso distruttivo della costituzione del capro espiatorio
innanzitutto non rivolgendosi al gruppo come un tutto, ma sostenendo piuttosto i movimenti
di individuazione, e dunque offrendo un modello della possibilità di pensare non “di gruppo”
ma “in gruppo” fuori dalla corrente coercitiva. Bisogna cercare di comprendere perché
proprio in quella fase si stanno manifestando le dinamiche del capro espiatorio, e creare
all’interno del gruppo uno spazio mentale capace di contenere il significato delle esperienze in
atto. Si può utilmente evidenziare il fatto che spesso la causa della sofferenza è proprio il non
riuscire a comprendere il senso della sofferenza medesima, e manifestare la necessità di
tollerare anche il sostare nel non capire, nell’ignoto. La guida, analogamente a quanto accade
nei gruppi terapeutici, potrebbe anche spiegare che al vissuto di impotenza e fragilità,
generato dalla difficoltà e dalla paura del cambiamento, le persone spesso reagiscono con
azioni distruttive (sottese da fantasie di onnipotenza negativa).
Una figura particolarmente distruttiva per lo spirito di gruppo, che agisce anch’essa nei
momenti di passaggio e di trasformazione, è quella del Thanatoforo (in latino, portatore di
morte) così definita daDiet (1998). Si tratta di una persona che opera (solitamente soprattutto
nelle istituzioni) una silenziosa e criptica azione di distruttività, seminando dubbi e critiche
iperrealistiche e sprezzanti. Egli agisce da solo, o seducendo altri ad operare con lui in questa
stessa direzione, ma il suo stile, almeno inizialmente sempre mimetico, rende difficile sia
identificarlo che resistere al suo influsso. E’ più semplice riconoscerne gli effetti, cioè la
sfiducia e la perdita della speranza nel progetto condiviso, che a poco a poco si espandono,
come una macchia d’olio, in tutto il gruppo. Il conseguente sentimento di isolamento e la
perdita dei punti di riferimento rendono, quindi, “immediatamente persecutoria ogni alterità”
all’interno del gruppo (Diet, Ibidem). Diet definisce il thanatoforo “eminenza grigia delle
pulsione di morte”, ma Corbella (articolo dell’Ottobre 2004) non condivide tale visione. A
suo avviso, la patologia che lo caratterizza è piuttosto quella di un narcisismo della peggior
specie, dominato dall’insicurezza, dalla sete di potere, e spesso anche dall’invidia, tanto che lo
definirebbe “il miglior rappresentante del narcisismo luciferino, tante volte acutamente
analizzato da Lopez, che in una macroscopica collusione narcisismo-masochismo realizza un
suo personale: muoia Sansone e tutti i Filistei. Questo gli permette da una parte di sentirsi un
90
eroe, Sansone appunto, e dall’altra di accusare proiettivamente tutti di essere filistei, intesi
secondo la vulgata comune come ipocriti e falsi, nel loro tentativo di osare il cambiamento.”
In questi casi, per Corbella, “l’unico comportamento possibile è dare nome e parlabilità allo
stato delle cose ed evidenziare l’anonimo attacco in atto”, al fine di creare uno spazio che
renda possibile la sospensione dello stato di diffidenza all’interno del gruppo, e ponga le basi
per l’elaborazione dei problemi sottostanti”. Tuttavia, è molto difficile che figure come quella
del Thanatoforo possano esprimersi a Dialogo nel buio, così come anche, del resto, all’interno
dei gruppi terapeutici (queste persone, nota sempre Corbella, a causa della forma
estremamente maligna del loro narcisismo, difficilmente chiedono aiuto).
Ogni viaggio al buio ripercorre in parte, e ovviamente in maniera schematica, alcune
dinamiche che i gruppi analiticamente condotti vivono nell’arco di anni e anni di sedute. Si
tratta di qualcosa di cui ho iniziato ad avere consapevolezza mentre facevo da guida a dei
ragazzi di un liceo sociopsicopedagogico. Come faccio sempre all’inizio dei miei viaggi coi
gruppi di scuole, ho chiesto loro un aggettivo che descrivesse il buio. Contrariamente a quanto
succede di solito, mi hanno risposto che il buio era bello, come una nascita. E da lì la
riflessione, fatta tra me e me, e con loro, ma estendibile a tutti i gruppi di visitatori. Il percorso
è metaforicamente una nascita, anzi, una rinascita, una rinascita degli altri sensi. Entrate e
siete impauriti, impacciati, per muovervi e sopravvivere avete bisogno della mamma, la vostra
guida, con la quale instaurate un rapporto di simbiosi. E’ il momento migliore tra i membri
del gruppo, perché la prima reazione è di essere tutti compatti, chiamarsi, sapere dov’è
l’amico e avere un contatto con lui. Piano piano la guida, come una mamma, vi dà strumenti
per esplorare e conoscere e voi, progressivamente, iniziate a staccarvi. E interessante notare
come, in questa fase, si riattualizzino anche atteggiamenti di tipo ludico-infantile. Un esempio
è il modo in cui i visitatori adulti si comportano all’interno degli ambienti, nei confronti di
alcuni oggetti d’uso quotidiano: sembrano dei bambini alle prese col gioco simbolico che
tanto li diverte. Alzano la cornetta del telefono e fingono di parlare con qualcuno, fanno finta
di potersi guardare allo specchio, e così via. E, ogni volta, si legge chiaramente nei loro gesti
una gioia quasi infantile per ogni nuova scoperta. Questo tipo di comportamenti, di norma,
non potrebbe mai realizzarsi all’esterno e, se fosse compiuto da altri, molto probabilmente li
farebbe sorridere.
Nella casetta ormai siete adolescenti, vi muovete da soli, cercate ed esplorate, così come in
città. E finalmente al bar diventate adulti, bevete, consumate, pagate e vi sedete con la
mamma, pronti a capire di più, a fare domande, ad ascoltare e comprendere, con un nuovo
punto di vista, il mondo nel quale siete entrati.
91
Tutto questo, sotto alcuni versi, esemplifica sinteticamente quanto accade durante i movimenti
di fusione e individuazione tipici della Gruppoanalisi. Il piccolo gruppo analitico, in un
procedere adeguato, tende a raggiungere spontaneamente uno stato di “messa in sospensione”
degli abituali processi di funzionamento mentale, e dei conseguenti patterns cognitivoaffettivi dei singoli partecipanti. E’ la fase dell’inizio di movimenti di fusionalità che
sappiamo caratterizzare potenzialmente i gruppi umani. Come nota Corbella (2003), "l’orbita
simbiotica madre-infante costituisce la base rudimentale di "fantasticare il gruppo come un
tutto": é proprio questa possibilità che consente la dialettica, specifica del gruppo, fra fusione
e individuazione, nella quale avvengono trasformazioni positive, sia per i singoli membri sia
per il gruppo nel suo insieme”. Questo movimento dialettico, che si ripresenta varie volte nel
corso del tempo, è illustrato da Corbella con la metafora della spirale. In determinati momenti,
sostiene l’Autrice, nel gruppo si genera la riattualizzazione di livelli molto arcaici
dell’esperienza, di tipo fusionale, caratterizzati dall’assenza di distinzione tra soggetto ed
oggetto, in cui la sincronicità che dovrebbe caratterizzare la relazione madre-bambino diviene
il prototipo dell'interazione del gruppo stesso.
Attingere ad un livello così arcaico dell'esistenza diventa possibile grazie alla particolare
permeabilità che le frontiere dell'Io assumono in questo specifico setting; non a caso lo "stare
in gruppo" richiede il saper mettere in gioco le zone simbiotiche comuni. “In queste occasioni,
solitamente esiste un’atmosfera emotiva dominante nel gruppo, di grande intensità e fiducia.
Non è facile descrivere questo tipo di esperienza, situata ad un livello preverbale; in questo
contesto il linguaggio perde il significato convenzionale e le parole vengono usate come una
sorta di oggetto transizionale. Si partecipa tutti, compreso il conduttore, ad una specie di
immersione in una serena fusionalità" (Corbella 2003). Essa si costruisce progressivamente a
partire dai primi momenti di gruppo, momenti che potrebbero essere definiti come
“prefusionali”, ma in realtà sono un modo di negare la diversità, mediante un’uniformità in
cui ci si illude di ricreare una primitiva forma di condivisione, sfociando invece in forme di
comunicazione sterili e superficiali. Ad esempio, riferisce Corbella, si sente spesso usare il
pronome "noi", e l’espressione "anch'io", diviene una sorta di parola d'ordine. Tale fase è però
necessaria per la creazione di un senso di appartenenza al gruppo, ed è quindi fisiologica. “E’
da questo inizio di fusionalità "formale" presente in un gruppo che esiste da poco, dal
cominciare a star bene insieme, anche se in modo confuso, che nasce la base di una fusionalità
più autentica e profonda. Essa, nella sua forma più primitiva, consente ai singoli membri di
vivere insieme una regressione narcisistica riparatoria, nella misura in cui è sperimentabile un
senso di sé grandioso proiettato sul gruppo, e al contempo, la fantasia che il conduttore sia un
genitore onnipotente”( Corbella 2003). La formazione dello stato fusionale nel lavoro
92
analitico sembra “indipendente” dalla strategia del terapeuta, mentre il suo ruolo diviene
determinante quando è necessario indirizzare il gruppo verso momenti di individuazione.
Questo stato ricomparirà, con modalità sempre più evolute, nella vita gruppale, man mano che
l’analisi procede.
I momenti di fusionalità, vissuti in modo costruttivo, sono di fondamentale importanza, sia
perché migliorano la coesione del gruppo, e sia per il formarsi o il consolidarsi del sé
autentico, che potrà poi affrontare processi d’individuazione. L’individuazione è un momento
necessario di opposizione al passato, cioè alle modalità relazionali onnipotenti e simbiotiche,
è un atto di separazione che comporta l’inevitabile, terrificante e doloroso sentimento di vuoto
e solitudine. E’ in questa fase, ricorda Corbella, che il gruppo, per i suoi componenti, “fa da
specchio anche agli aspetti meno ideali e negativi di sé; compare il senso del limite che, se si
oppone alle fantasie di onnipotenza, comincia a essere compreso anche nei suoi aspetti
positivi di confine e di contenimento, rispetto alle angosce arcaiche di frammentazione”.
Nell’evolversi dialettico di questi due movimenti, fusione e individuazione, che si
riattualizzano più volte e in forme sempre più evolute, la comunicazione gruppale si fa sempre
più autentica e profonda.
Ciò che accade nel contesto di Dialogo nel buio, sia a causa della durata limitata
dell’esperienza, che per la variabile di fondo che accomuna tutti i membri del gruppo, vale a
dire il trovarsi nella condizione, temporanea per i visitatori e permanente delle guide, di non
vedere, si avvicina maggiormente, a quanto è possibile osservare nei gruppi omogenei a
tempo determinato. Infatti, data la specificità della sua formazione e finalità, il contesto
gruppale omogeneo si caratterizza per alcune funzioni sue proprie, identificate da Marinelli
(2004).
Innanzitutto, esso può essere descritto, ampliando una metafora bioniana, come “contenitore
specializzato”. Questo in primo luogo perché il gruppo omogeneo, “preconcepito” nella mente
del curante, del conducente o dell'istituzione che di volta in volta lo propone, funziona come
primo contenitore fondante, inizia a definire, rendendola esplicita, la patologia, la condizione
o il tema che intende affrontare, a volte fino a quel momento segreto, incerto o confuso. Mette
quindi in primo piano quello che sarà il “focus” del gruppo.
Inoltre l'omogeneità gruppale facilita l'emergere delle fantasie d'indistinzione connesse
all'elemento unificante, promuovendo fin da subito vissuti di fusione e condivisione. A questo
proposito, anche Corbella (2004), riferendosi ai gruppi terapeutici, osserva che “l’evidenziata
omogeneità nei colloqui di preparazione, utile a motivare la partecipazione al lavoro di
gruppo, stimolerà fin dall’inizio, almeno a livello cosciente, l’emergere del senso di una
comune appartenenza e processi di reciproca identificazione fra i membri. Nell’immaginario
93
collettivo prevarrà la fantasia del gruppo come un tutto indifferenziato, ma proprio per questo
immediatamente e naturalmente recettivo rispetto ai bisogni condivisi. Questa situazione
iniziale, se da una parte può rendere meno difficile il parlare di sé - perché proprio l’aspetto
che fa sentire isolati, diversi ed esclusi (sia questo una malattia, uno stato sociale od
esistenziale vissuto come emarginante, o un trauma subito) sarà in questo particolare contesto
l’elemento aggregante - dall’altra rischia di creare una situazione di stallo, un embrassonsnous mortifero dove chi tenta di differenziarsi viene sentito come un potenziale persecutore e
a volte reattivamente trasformato in capro espiatorio”. I processi di condivisione e fusionalità,
quindi, oltre ad essere precoci, tendono anche a protrarsi maggiormente, generando resistenze
nei confronti dei movimenti di separazione-individuazione, che maturano con particolare
lentezza. E’ soprattutto per questo motivo che i gruppi omogenei vengono spesso pensati
(diversamente dai gruppi psicoanalitici eterogenei) a tempo determinato. “La consapevolezza
del termine necessita dell’elaborazione della separazione e questo stimola il movimento verso
l’individuazione riducendo inevitabilmente la possibilità di stasi, a volte difensiva rispetto al
cambiamento, che caratterizza l’area della fusionalità” (Corbella, 2004). Perciò, secondo
Corbella, “ogni gruppo in cui vengono accentuati aspetti di omogeneità a scapito della
predominanza di una composizione eterogenea dovrebbe essere a tempo limitato, e viceversa,
ogni gruppo a tempo determinato dovrebbe essere caratterizzato da un aspetto omogeneo
pregnante”.
Le cose, infatti, nota Friedman, si fanno particolarmente difficili quando il gruppo omogeneo
è aperto, il che spesso non è consigliabile, a causa del difficile processo inconscio che ne
conseguirà. In questi casi, “l'incontro con l'individuale, con la differenza fra i sottogruppi e
con i cambiamenti, produrrà un conflitto interno al gruppo che sarà l'erede della scissione fra
"noi", e l'esterno al gruppo, "loro". Il conduttore, quindi, si trova a doversi confrontare con
una sfida, sulla base di processi distruttivi, che potranno essere superati proprio attraverso
l'alleanza di lavoro che si era stabilita più facilmente nelle fasi iniziali” (Friedman, 2004).
Il gruppo omogeneo a tempo determinato, invece, consente fin dai primi incontri il fruire
(anche se inizialmente in modo ancora superficiale) della condivisione e della coesione che
caratterizzano positivamente i diversi livelli fusionali, e pone al contempo le basi, fin dalla
prima seduta, per presentificare la separazione, e quindi l’individuazione, grazie al predefinito
limite temporale. Il tempo diventa esso stesso una variabile con immediate potenzialità
terapeutiche, per via del suo riferimento al concetto di limite. Tuttavia, per Corbella, è anche
importante aver chiaro che queste esperienze a termine non costituiscono una terapia
risolutiva, ma piuttosto episodi terapeutici e/o di sostegno, con un loro valore e significato, ed
uno scopo definito.
94
Se
all’inizio
viene
accordato
il
massimo
spazio
alla
composizione
omogenea,
successivamente si dovrebbe richiedere al conduttore un'attività più specializzata e più
intensa, che faciliti l'introduzione di un'ampia gamma di temi e punti di vista, per promuovere
un contenimento maggiore dei temi iniziali. E’ un po’ l’inverso di quanto accade nel caso dei
gruppi misti, dove è nelle prime fasi che il conduttore dev’essere più attivo: i partecipanti,
infatti, potranno sentirsi timidi, isolati, imbarazzati, poco propensi ad aprirsi e raccontarsi; il
gruppo non si forma subito. Nei gruppi omogenei, invece, almeno fino a che la
differenziazione non diventerà la problematica emergente, la comunicazione verbale e non
verbale sarà potenzialmente molto fluente fin da subito, ed i partecipanti si capiranno
intuitivamente. Come evidenzia Corbella (2004), “nel divenire del processo di cura sembra
essere importante da una parte mantenere l’aspetto propositivo di uscita dall’isolamento e
della condivisione, e dall’altra aiutare i partecipanti a raggiungere una visione più integrata di
sé, e a riconoscere il valore e la ricchezza dello scambio che solo la differenza rende
possibile”.
Nei gruppi in Dialogo nel buio, in effetti, solitamente non è difficile promuovere, ottenere e
mantenere un buon affiatamento gruppale, in tempi realmente brevi. Nelle fasi iniziali del
percorso, per favorire i processi di coesione dei gruppi, ed una prima condivisione al buio, io,
la guida non vedente, faccio in modo che i membri del gruppo collaborino nell’esplorazione
dei vari ambienti: se, ad esempio, uno di loro trova l’albero del parco, gli consiglio di
chiamare gli altri per condividere la sua scoperta. Questa condivisione (fusione indica una
fase di relazione molto arcaica, che non si può realizzare in così poco tempo) tra i membri
resta comunque fino alla fine, e si riattualizza nel corso del tempo del gruppo. Spesso, infatti,
al bar, le persone dicono che senza la guida o gli altri del gruppo, si sarebbero sentite perse.
Ed è proprio nel bar che partono interessanti conversazioni a proposito dell’esperienza appena
trascorsa insieme, e dei vissuti della guida che fino a quel momento ha accompagnato il
gruppo, e adesso siede lì con loro. E’ difficile spezzare quel clima, che ritorna ad essere di
forte condivisione, ma il tempo passa in fretta e la guida deve correre ad accogliere il gruppo
successivo. La luce torna a colpire gli occhi dei viaggiatori del buio e, quando la condivisione
è stata particolarmente forte, essi sostano alcuni minuti a chiacchierare tra loro nel luogo di
penombra adibito alla raccolta dei bastoni e alle riflessioni, che vanno scritte sul Libro degli
Ospiti.
In modo analogo, Corbella ha osservato che i pazienti gruppoanalitici, al termine di sedute
dove si condividono momenti di intensa fusionalità, sostano fuori dal portone dello studio
molto più a lungo del solito a chiacchierare tra loro, "come se attraverso una lenta e graduale
verbalizzazione, potessero ritrovare insieme il senso della loro quotidianità adulta" (Corbella,
95
2003). Ciò è anche un indice del fatto che la riattualizzazione simbolica, vissuta all'interno dei
gruppi e quindi condivisa, viene tollerata con maggior facilità rispetto a quanto accade, ad
esempio, nel setting individuale.
Più spesso, però, nell’ambiente di penombra del Dialogo nel buio accade qualcosa di
particolare e, allo stesso tempo, sorprendente. L’armonia tra il gruppo prima formatosi e la
guida, così come il meraviglioso clima che si respirava al buio, si spezza quasi subito. Le
persone si presentano alla guida, le danno la mano, e dicono il loro nome…come se la
vedessero per la prima volta! E in un certo senso per loro è così, la “vedono” davvero per la
prima volta; non si rendono conto, forse, che al buio l’incontro è già avvenuto, ed è stato
ancora più profondo e immediato di questo incontrarsi/reincontrarsi negli ambienti
tradizionali, per forza di cose illuminati.
O forse, ciò che accade realmente ha una natura più profonda, che riguarda il modo in cui i
visitatori vivono il loro sé. Il primo incontro con la guida, in fondo, è avvenuto nell’oscurità
più totale, un ambiente totalmente estraneo alla loro esperienza, che li ha immediatamente
posti in una situazione regressiva, di dipendenza ed asimmetria rispetto al conduttore, per il
quale il buio è una condizione naturale e abituale dell’esistenza. Essi, infatti, ed è bene
precisarlo, si erano già incontrati in biglietteria prima di iniziare il percorso, ma conosceranno
la guida solo al buio; e non tutte le guide, dopo il percorso, li seguiranno anche nel loro
ritorno alla luce. E’ quasi inevitabile che lì, alcuni di essi, riappropriatesi improvvisamente
delle loro abituali facoltà e capacità, sentano spontaneamente il desiderio di presentare anche
il loro sé “adulto” alla guida che si mostra loro; quel sé col quale maggiormente
s’identificano, almeno a livello “ufficiale”.
E anche il gruppo stesso, fondatosi nel buio e cresciuto in esso, per quanto abbia vissuto
qualcosa di forte ed intenso, col ritorno della luce sembra quasi dissolversi, poiché è nato ed
ha abitato in una sfera più simile al sogno che non alla realtà ordinaria.
A proposito dell’evolversi del gruppo e nel gruppo, Corbella spiega che tale setting consente
di muoversi "liberamente" nel tempo, “sia all'indietro che in avanti, in situazioni dove passato,
presente e futuro sono potenzialmente sempre fruibili e interagiscono fra di loro. Nel gruppo,
infatti, non solo è possibile riattualizzare la fase fusionale arcaica, ma anche riattraversare
tutte le tappe fondamentali della maturazione personale, e riaffrontare in modo costruttivo le
problematiche rimaste irrisolte”. In tal modo diventa possibile acquisire modalità nuove e più
evolute di essere e relazionarsi, il tutto ovviamente attraversando momenti di crisi, resistenze
e desideri di fuga. In effetti, il muoversi libero nel tempo “raramente può essere vissuto come
un gioioso fluttuare ma, viceversa, è spesso accompagnato da confusione, angoscia, senso di
perdita dei parametri di riferimento.” Questo fluttuare temporalmente all’interno del setting
96
gruppale è stato definito da Lo Verso e Papa (1995) come “spazio senza”. E’ il punto in cui
“l’asse mentale del passato, con le sue ferree e invisibili necessità, incontra l’asse del presente
con i suoi vincoli ineludibili, ma anche con le sue potenzialità inesplorate”. E’ in questo
momento, affermano gli Autori, che diventa possibile “riconoscere e svelare la ripetizione e
l’agire coattivo, pur percependosi ancora vincolati e incatenati ad esso; lo spazio senza è
quindi il momento in cui non è ancora possibile progettare e costruire il futuro: all’idea di
sbigottimento e di vergogna per il passato si associa quella di terrore per il futuro”. Corbella
chiarisce che questo spazio si presentifica anche nell’analisi individuale, ma nel setting del
gruppo assume una sua specificità, dal momento che non è attraversato contemporaneamente
da tutti i componenti. Così, “chi nel gruppo ha gia affrontato questa terra di nessuno, questo
pericoloso terreno minato, potrà fungere da valida guida per chi si trova in questo impasse,
diminuendone le ansie e le paure e permettendogli di provarsi in posizioni nuove e quindi di
progettarsi un futuro che inevitabilmente modificherà anche il passato, dal momento che
situazioni nuove conducono anche ad una ritrascrizione del ricordo in un differente contesto".
Questo fluttuare e ripercorrere più volte le varie fasi della vita personale all’interno del
gruppo si può ritrovare anche a Dialogo nel buio, ovviamente declinato in maniera diversa.
Succede spesso che i visitatori decidano di rifare il percorso più e più volte. Così, a loro
modo, vivono la metafora della spirale: si immergono ogni volta nell’oscurità con una
consapevolezza diversa del buio e di ciò che li aspetta, per cui rivivono le stesse esperienze in
modo più cosciente, e con una differente aspettativa rispetto ai precedenti passaggi. Al primo
passaggio, il problema più grosso è sconfiggere il “nemico buio”, capire cos’è e come
affrontarlo; tuttavia, man mano che si acquisisce familiarità con questo temibile nemico, le
sensazioni di paura e deprivazione passano in secondo piano, seppur presenti. Quindi, la
persona progressivamente è più disposta ad esplorare gli ambienti, cercare cose già
riconosciute e trovarne di nuove, riuscendo finalmente a crearsi una pianta mentale degli
spazi, e a considerarlo un luogo noto.
A questo punto mi sembra opportuno fare un breve riferimento alla figura del genius loci,
anche se si tratta di un ruolo difficilmente esprimibile in un contesto come Dialogo nel buio.
Secondo Neri (1995), il genius loci è colui (non necessariamente sempre la stessa persona)
che si fa portavoce dell’armonia del gruppo, e si prende anche cura del suo mantenimento. E’
qualcuno capace di capire, in ogni particolare fase, l’atmosfera emotiva dominante, e quali
siano i bisogni del gruppo, così da favorirne l’evoluzione evitando al contempo lacerazioni e
ferite nell’identità sincretica dei membri. Questa funzione viene assunta inconsapevolmente, e
portata avanti naturalmente, attraverso un’opera di tessitura interna e segreta che non deve
essere fatta oggetto di interpretazione da parte dell’analista, ma seguita e capita. Nel buio, un
97
ruolo simile, ma non coincidente, è svolto da chi ha già fatto il percorso, perché lo rende
manifesto al gruppo, e comunica ai non esperti cosa fare e come, favorendo la fruizione
dell’esperienza e la coesione gruppale.
Abbiamo parlato del tempo del gruppo: cosa dire a proposito dello spazio?
Il gruppo analitico, microcosmo complesso, definisce uno spazio circolare dove ogni membro
può porre la sua attenzione su un componente o dare uno sguardo d’insieme. Differente è
l’impressione data a seconda della modalità di occupare lo spazio, decisa di volta in volta dai
membri.
Anche a Dialogo nel buio c’è un rapporto importante tra il gruppo e la sua modalità di
occupare lo spazio. Ho già accennato come, all’ingresso nel buio, le persone tendano a stare
dove la guida vuole che stiano. Infatti, dato che ogni guida ha un suo personale stile di
conduzione, lo spazio occupato dai membri del gruppo è diverso a seconda di chi li conduce.
In questa situazione, ognuno tende a risolvere la sua personale paura dell’ignoto cercando di
avere attorno a sé, (se ci sono), coloro che già conosce, e che spera possano essere il suo
punto di riferimento. Tuttavia, le persone impiegano poco tempo a rendersi conto che in
quell’ambiente i membri del gruppo sono tutti uguali, che lo spazio occupato ha poca
importanza, e che devono prestare attenzione esclusivamente alla guida e alle sue parole.
Nonostante ciò, vengono poste in atto due modalità di agire. Può capitare che una persona ne
cerchi insistentemente un’altra, per mostrarle questo o quell’oggetto, ma può anche capitare
che qualcuno si isoli e resti sempre per ultimo e in disparte, rifiutando il contatto fisico sia con
la guida che con i compagni di viaggio. Nel passaggio tra i vari ambienti ci sono gruppi
fisicamente minuscoli, i cui membri stanno tutti vicini l’uno all’altro, tanto che a volte, nel
contarli, se ne perde qualcuno; altre volte, il fluire è lento, impacciato, sono tutti distanti e
sparpagliati. Ed è raro trovare un gruppo che assuma entrambi questi due flussi. C’è da dire,
ancora una volta, che anche su queste dinamiche influisce il tipo di conduzione.
Lo spazio del gruppo, consentendo una proiezione e riattualizzazione in un ambito dialogico
dello spazio interno di ogni membro, funziona (Rouchy, 1998) come “uno spazio
transizionale dov’è possibile metabolizzare la realtà psichica in rapporto alla realtà sociale”; è
una sorta di contenitore, per dirla con Bion, che consente di accogliere anche stimoli dolorosi
arcaici, e quindi impensabili, o rappresentazioni di contenuti psichici, fantasmi non ancora
pensati, e trasformarli in pensiero. Secondo Bion (1962), infatti, la funzione alfa è una
funzione relazionale che nasce dal rapporto madre-bambino: la madre elabora e trasforma le
angosce e il terrore del suo bambino, ed egli potrà poi reintroiettare l'esperienza trasformata (e
in questo modo la funzione alfa stessa). F. Corrao (1981), propone, in questo stesso senso, una
funzione gamma, che sarebbe per il gruppo l'analogo della funzione alfa dell'individuo. La
98
funzione gamma del gruppo potrà elaborare gli elementi sensoriali ed emotivi immessi nel
gruppo, generando elementi gamma, pensabili, necessari alla produzione di sogni, miti e
memoria di gruppo. Inoltre, la funzione gamma opera trasformazioni che alimentano
costantemente la funzione alfa individuale. Lo spazio gruppale, afferma Corbella, è “sia uno
spazio fisico reale che una rappresentazione consensualmente validata dai membri”, la quale
“rispecchia il mondo interno dei singoli componenti e i suoi confini, che possono essere
proiettati nel gruppo”. Ma, seguendo Bion, Foulkes e gli psicoanalisti della scuola francese,
Corbella sottolinea anche che “la realtà psichica che si produce nello spazio gruppale non è
riducibile alla somma degli apporti dei singoli membri”, ed “il gruppo come luogo di
risonanze inconsce stimola a presupporre l’esistenza di un inconscio collettivo caratterizzato,
tra l’altro, da meccanismi specifici di difesa”.
Marinelli (2004) considera il rispecchiamento come una dinamica tipica soprattutto dei gruppi
omogenei. La funzione rispecchiante fa indubbiamente parte dei sottosistemi di coppie interne
al gruppo; tuttavia trattandosi di una caratteristica tipica della relazione duale, gli autori che si
rifanno a Bion, considerando il gruppo come un organismo con dinamiche di tipo unitario,
preferiscono ricorrere a concetti affini, ma più specifici. Uno è quello di commuting, (Neri
1995), che descrive l'attività di trasformazione e coordinamento dei contenuti del campo
gruppale, dall'individuo verso il gruppo, e viceversa, dal gruppo verso il singolo. Similmente,
l'idea di risonanza (ibidem) si riferisce alla possibilità per il gruppo di organizzare la
comunicazione in modo analogo a quanto avviene nella fisica, in un sistema che risuona
completamente e armoniosamente con una configurazione data in un dato momento. Ancora,
l'idea di narrazione efficace, (ibidem), descrive la corrispondenza, in un determinato istante,
dei contenuti e del tono del racconto con gli elementi del campo emotivo e mentale del
gruppo.
I processi di rispecchiamento non solo rendono possibile la creazione di uno spazio in cui si
facilita la riconoscibilità e gestione delle situazioni problematiche, ma supportano anche
concretamente la speranza di apprendere da coloro che sperimentano le stesse difficoltà, o
vivono lo stesso dolore.
Tutto questo è alla base della Gruppoanalisi; il tempo che i membri del gruppo trascorrono
insieme permette, seduta dopo seduta, di creare e conservare tale spazio, e di muoversi
liberamente al suo interno. Il tempo del Dialogo nel buio è, come spesse volte sottolineato,
troppo poco per far sì che processi come questi possano realizzarsi nella loro interezza. Certo
è, comunque, che i vissuti interni dei singoli individui si riversano nello spazio del gruppo
attraverso le domande e gli atteggiamenti. Quando un partecipante mi chiede qualcosa in un
momento in cui gli altri stanno esplorando, cerco di attirare l’attenzione di tutti e rispondo alla
99
domanda mettendo questi nuovi contenuti in comune con tutto il resto del gruppo. La mia
risposta, a sua volta, ha una ricaduta anche nell’area preconscia degli astanti e il discorso,
spesso, rimbalza per associazione con altre domande e mie risposte, riflessioni del gruppo e
della guida, creando in questo modo un primitivo spazio transizionale.
La comunicazione arricchisce non solo lo spazio transizionale del gruppo, ma anche la
scoperta di oggetti nuovi. Succede spesso che qualcuno passi le mani su qualcosa, non la
riconosca e vada oltre. Poco più tardi, però, quella stessa cosa è riconosciuta da un’altra
persona e la prima, sentendo il nome dell’oggetto appena toccato, finalmente riesce a
collegare quella percezione tattile ad una mentale, già nota, costruita tramite la percezione
visiva, e associa l’oggetto col suo nome.
Nel gruppo è possibile distinguere un dentro da un fuori, stimolando la produzione di fantasie
derivate dalla riattivazione di rappresentazioni arcaiche in cui spazio fisico e emozioni e
oggetti sono fusi tra loro. A Dialogo nel buio, il jolly ha la fortuna di non avere gruppi da
accompagnare e riesce, quindi, a girare nel percorso immergendosi, di volta in volta, nelle
diverse atmosfere dei gruppi che occupano i vari ambienti della Mostra. Così, si può passare
dalla prima stanza vedendo un gruppo pauroso e in difficoltà, arrivare nel parco e trovare
ragazzi contenti di esplorare e in perfetta armonia con la guida, giungere in barca e fare il
viaggio con persone in contemplazione del mare, e via così. Il particolare clima emotivo che
si crea nei diversi gruppi dipende anche dai fenomeni transpersonali sincronici, legati alle
diverse modalità di funzionamento arcaico e preverbale dell’Io, che originano in una
situazione in cui non esiste ancora separazione fra il sé e gli oggetti. La loro ricomparsa nella
situazione gruppale ha scopo difensivo nei confronti dell’angoscia di frammentazione e di
separazione, ma rappresenta anche una potenzialità evolutiva per il soggetto e per il gruppo.
Neri (1995) li identifica non solo in generale nell’atmosfera e nel tono di fondo che
caratterizza i diversi incontri, ma anche negli effetti della mentalità primitiva e degli assunti di
base.
Per Bion (1961), gli assunti di base, derivanti dall’inconsapevole messa in comune di desideri
e impulsi altrettanto inconsapevoli, caratterizzano l’universo relazionale gruppale di tipo
protomentale, generando l’aggregarsi automatico dei gruppi sulla base di stati esclusivamente
emotivi, collettivi e non elaborati, comportanti schemi rigidi di reazione gruppale con
massima perdita dell’identità individuale. E’ facile osservarli, nei gruppi appena formatisi.
L’Assunto di base di Accoppiamento è la credenza collettiva protomentale NON inconscia
(ad un livello così arcaico non c’è stata ancora la differenziazione fra psiche e soma) che da
un accoppiamento idealizzato possa nascere una figura messianica da cui dipende la
possibilità futura di soluzione di ogni problema attuale. Questa figura potrebbe essere la guida
100
e l’atmosfera di festa dell’incontro paragonabile a quella della novità del posto in cui si è.
Napolitani (1987), che condivide le ipotesi di Bion relative agli assunti di base, relativamente
all’assunto d’Accoppiamento, che a suo parere occupa in modo centrale l’ambito
dell’universo protomentale, scrive: “L’assunto di base di Accoppiamento consiste in una sorta
di eccitamento condiviso col gruppo che dà all’incontro una qualità di festa: l’incontro è
pregno di una promessa, non definita per un qualsiasi impegno o traguardo concreto, ma
riverberata sull’incontro stesso, come a dire: "noi siamo per essere Noi"; la consuetudine degli
incontri seriali si lacera per dar luogo ad una visione insolita per la quale l’ambiente nel suo
complesso, i singoli oggetti, i volti e i gesti delle persone, i loro abbigliamenti si saldano in un
tutt’uno che contiene in sé un prodigio".
Non a caso, come osservato da Marinelli, nei contesti omogenei le aspettative di salvazione
hanno un valore più intenso, che tonifica le fasi più difficili della vita gruppale; “è come se si
fosse nati tutti come un sol figlio, un figlio unico, amato in modo esclusivo, per il quale
l'altro, il diverso, il rivale, è più difficile da riconoscere” (Marinelli, 2004). La differenza, e il
senso della differenza, qui non possono nascere e crescere in modo simile a come si
sviluppano in un gruppo misto, ma tendono a cercare rappresentazioni più ampie e teatrali,
quali i miti, i rituali, i cicli e le saghe, come orizzonti capaci di giustificare un evento tanto
imponente e sorprendente. A Dialogo, il percorso, nettamente strutturato e predisposto in
precedenza, appare in questa direzione come un rito di passaggio, e al contempo rappresenta,
nella particolare successione dei vari ambienti di cui è composto (dal vuoto iniziale
all’immersione in un bosco naturale, cui seguono il molo ed il mare, con un viaggio in barca,
l’esplorazione della casa, ed infine la vita in città), anche il ciclo evolutivo, con le sue diverse
tappe che portano dalla dipendenza all’indipendenza, dalla natura alla cultura, dal pregiudizio
all’esperienza e alla comprensione del valore che può derivare dalla differenza.
L’Assunto di base di Dipendenza nasce sulla base del bisogno di avere un leader, da cui
dipendere in modo totale e da cui avere la soluzione di ogni problema, e sul quale viene
proiettata la responsabilità della realizzazione di bisogni e desideri. Di nuovo, è sulla guida
che il gruppo realizza questo tipo di vissuto. Durante il tempo che si passa insieme, tutti non
smettono mai di dire che la guida è il loro unico punto di riferimento, che senza di lei si
sentirebbero persi; se per qualche momento non sentono la sua voce, la chiamano per
rassicurarsi sulla sua ubicazione o, forse, per accertarsi che non li abbia abbandonati; se non
riescono ad uscire da un “vicolo cieco” e sono in difficoltà, chiedono il suo intervento.
Un’altra figura importante in questo senso potrebbe essere anche la persona che il gruppo
identifica come suo leader, in quanto davvero più bravo degli altri, o vissuto come tale dal
gruppo stesso. L’indipendenza, di solito, è raggiunta negli ultimi ambienti, quando la gente
101
riesce ad esplorare non più in modo impacciato e sotto la supervisione della guida, ma in
modo più autonomo. C’è da dire, ancora una volta, che questo dipende anche dallo stile che la
guida adotta nel condurre i gruppi. Alcuni di noi, già dal primo ambiente, fanno muovere i
visitatori autonomamente e li lasciano scoprire tutto da soli. Io invece preferisco tenerli in una
sorta di evoluta simbiosi con me al principio e lasciarli poi soli più avanti.
L’Assunto di base di Attacco e Fuga è la fantasia gruppale che ci sia la necessità di attaccare
un ipotetico nemico o fuggire da lui. In Gruppoanalisi, a volte, il gruppo stesso è inizialmente
vissuto dal paziente come un’unità indifferenziata e monolitica contro cui potrebbe scontrarsi.
A Dialogo nel buio, invece, il nemico diventa subito il buio. La paura iniziale è molto forte, e
tra persone estranee c’è anche il timore di scontrarsi, toccarsi; ma la consapevolezza di dover
affrontare insieme il buio facilita un clima di condivisione e curiosità reciproca, e il cadere di
imbarazzi e pregiudizi. Allo stesso tempo, man mano che il gruppo si compatta, il buio inizia
a far meno paura.
Anche in questo senso, viene spontaneo pensare alle dinamiche tipiche dei gruppi omogenei, i
quali forniscono ai partecipanti anche un senso di sicurezza rispetto all'ansia di iniziare,
appartenere e partecipare ad un gruppo, evitando l'angoscia di sentirsi esclusi. Condividere la
stessa problematica, infatti, “riduce l'angoscia persecutoria e di frammentazione caratteristica
della presenza dell'estraneo" (Vasta, Caputo, 2004; cit. in Marinelli). In tal senso, la
comunanza dell'esperienza può unire i membri di un gruppo in modi che possono essere anche
difensivi. E’ interessante ricordare, a questo proposito, un’altra funzione dell'omogeneità
osservata da Marinelli (2004), quella di controcampo. In questi gruppi, infatti, la costellazione
degli elementi sentiti come comuni ed elettivi, rievocherebbe per contrasto l'insieme degli
elementi opposti, vale a dire tutto ciò che è esterno, diverso, mancante, non omogeneo con
l'interno del gruppo. Il controcampo, quindi, sarebbe anche un modo per vedere quegli
elementi che derivano dalla scissione, che cioè non sono stati adeguatamente sostenuti
dall'illusione e dalla elaborazione creativa, "transizionale", (Kluzer Usuelli et al. 2003), e
vivono solo come contrasto con i loro opposti. Queste dinamiche, naturalmente, se ben
gestite, aprono anche possibilità di dialogo, confronto e crescita per il gruppo.
A Dialogo nel buio, è evidente il riferimento alla dicotomia vedere-non vedere, che,
inizialmente, non solo è percepita come inconciliabile, ma attribuisce al secondo dei termini
un quid di ingestibilità e di profondo timore ed angoscia. Il che riporta ad un’ulteriore
funzione dell’omogeneità, identificata da Marinelli, “analoga a quella dell'oggetto mediatore,
di attrattore degli elementi primari, arcaici e indistinti, collegati alla condizione omogenea, e
all'oggetto configurato nel gruppo come omogeneo” (Marinelli, 2004). E’ quindi importante,
da parte del conduttore, promuovere l'immagine dell'entità gruppale come oggetto che
102
contiene, ma al contempo accettare il proprio ruolo di outsider (Kibel, 2004). Egli è di fatto
colui che si differenzia dal resto del gruppo, e che meno partecipa all’omogeneità, fosse anche
solo perché già possiede delle maggiori risorse nella gestione delle difficoltà, che mira a
trasmettere agli altri. Un transfert negativo verso il terapeuta, presente in certe occasioni e
momenti, deve poter essere accettato. In modo analogo, la guida di Dialogo nel buio diventa
portatrice di un sapere misterioso e diverso rispetto al resto del gruppo: la sua condizione
stabile di non-vedente, in quel contesto, si trasforma paradossalmente in una risorsa non
accessibile agli altri, rendendola, se vogliamo, due volte diversa. E’, infatti, il solo membro
del gruppo che alla luce non vede, ma è anche l’unico a saper “vedere” nel buio.
Tornando agli assunti di base, va precisato che Napolitani, differenziandosi da Bion,
considera l’assunto di Dipendenza e di Attacco e Fuga come derivati da quello di
accoppiamento e come ponti protesi verso gli altri universi relazionali, il relazionale e il
simbolico; per cui, non solo li considera come particolari sviluppi dell’assunto di
accoppiamento, ma ritiene anzi che si costituiscano “come fondamento protomentale
dell’esperienza stessa di sviluppo”.
In particolare egli considera che l’assunto di Dipendenza, dacché inizialmente tenda a
rivolgersi al gruppo nel suo insieme, molto spesso finisce però nel proiettare sul conduttore il
bisogno di un leader onnipotente, potendo così esser considerato una sorta di “scoperta di
dipendenza” come stato nascente di riconoscimento intersoggettuale: “.L’assunto di
dipendenza è esperienza nascente di sviluppo nel senso della storicità dell’esistenza,
attraverso l’apertura al riconoscimento confidente del mondo…Da ciò potrebbe derivare
l’ipotesi successiva che l’assunto di dipendenza sia origine dell’esperienza del tempo nel suo
specifico carattere di irreversibilità: tempo come prospettiva di mortalità, che trova proprio
nella dipendenza intersoggettuale la condizione fondamentale perché possa essere assunto
soggettivamente dall’uomo. L’assunto di dipendenza è dunque l’assunto di Cronos”.
L’assunto di base Attacco-Fuga, invece, inizia a manifestarsi nei gruppi attraverso una
sensazione diffusa che Corbella definisce “di mal-essere”. Le persone si sentono immerse in
una sorta di malessere di spessore corporeo, indicato da D. Napolitani come stato di
“bisogno”, inarticolato ed inarticolabile, per cui tende ad esprimersi anche come una sorta di
male psicosomatico, e può essere accompagnato dal sentimento dell’ira. Il gruppo si mostra
agitato, il parlare è concitato, i discorsi si sovrappongono gli uni agli altri, la gestualità è
sconnessa…è come se tutto parlasse di un evento catastrofico che preme e incombe sul
gruppo, e la partecipazione emotiva a questo stato di cose comporta una dolorosa sensazione
di spezzettamento di idee, emozioni, rappresentazioni, che investe anche il conduttore. Lo
103
stato protomentale può essere minacciato anche dalla riattivazione dei gruppi interni di
appartenenza, magari stimolati da fatti apparentemente trascurabili.
L’assunto di Attacco-fuga è, per Napolitani, declinazione dell’assunto di Accoppiamento
verso l’indipendenza. Sebbene egli sottolinei che anche quest’assunto, come gli altri, partecipi
della qualità (ri)fondatrice del Reale, è però caratterizzato da un’esperienza particolarmente
dolorosa, esprimibile nella separazione dall’origine e nell’origine della separazione, nel senso
della spazialità, come solitudine: un perdersi angosciato e angosciante, in un Noi frammentato
e insensato. Come osserva Corbella, l’assunto di Attacco-fuga è dunque da lui visto
“all’origine dell’esperienza di uno spazio diversificato, che una volta accettato come tale, non
ha però gli stessi caratteri di drammaticità del tempo: lo spazio diversificato infatti, é
reversibile (dentro-fuori)”. Bisogna infatti considerare che “rispetto allo spazio dell’origine
(metaforicamente spazio-prenatale), lo sviluppo verso lo spazio differenziato è precipizio,
catastrofe. Lo stesso riconoscimento nascente della propria corporeità, come spazio chiuso,
delimitato, irrimediabilmente solitario, può essere testimonianza insopportabile della perdita
dello spazio monadico dell’origine”. “Ciò perché lo spazio protomentale è lo spazio unico,
monadico, indifferenziato, ed è da questo spazio che nell’assunto di attacco-fuga si fa
l’esperienza di essere scagliati fuori”. (Corbella, 2003)
Corbella condivide con D. Napolitani il voler considerare l’universo del protomentale non
necessariamente come una regressione al livello più arcaico dell’infanzia, ma anche come una
potenzialità che l’individuo mantiene per tutto il corso della sua esistenza, una
riattualizzazione simbolica di quel particolare livello di esperienza che i gruppi non solo
rendono possibile, ma anzi facilitano. Tuttavia, se nell’esperienza di Napolitani gli assunti di
base occupano porzioni puntiformi nella vita di un gruppo, in quella di Corbella costituiscono
i temi dominanti di ogni incontro, e, in più, il presentificarsi più frequente di un aspetto
piuttosto che di un altro rappresenta una differenza quantitativa che tende a diventare un
differenziante qualitativo: a seconda degli scopi che il gruppo si propone, “il conduttore vedrà
emergere più spesso alcuni aspetti invece di altri e, all’interno della dialettica sempre presente
fra movimenti di fusione ed altri di individuazione, dovrà dare spazio a quelle dinamiche
maggiormente funzionali allo scopo che il gruppo specificamente si è prefissato” (Corbella,
2003).
A questo punto, vediamo che analogie ci sono tra i gruppi e le famiglie d’origine di ciascun
individuo. La Gruppoanalisi insegna che le persone sono portatrici di un gruppo interno, che
rispecchia in genere la famiglia d’origine e i rapporti con quest’ultima. Ciò non stupisce,
poiché “l’uomo nasce e pone le basi per la costituzione della propria identità nel gruppo
famiglia, gruppo di appartenenza primaria” (Corbella, 2004). Si tratta di un fenomeno
104
riconducibile anche al transpersonale diacronico: quello che del loro gruppo di appartenenza
primaria, cioè della storia familiare che si tramanda di generazione in generazione anche
inconsapevolmente, le persone portano con loro nel buio. “In senso diacronico la funzione del
transpersonale è una sorta di "precipitato" che contribuisce alla costituzione del sé” (Corbella,
2003).
Come ho già accennato, spesso arrivano a Dialogo nel buio intere famiglie che,
inevitabilmente, si mescolano col resto dei partecipanti. Ciò malgrado, emergono comunque
molte situazioni tipiche, che mi portano a riflettere sulle singole e specifiche dinamiche e
configurazioni familiari. In un gruppo, ad esempio, erano presenti un figlio quarantenne con
sua madre. Lui era abbastanza terrorizzato, impacciato, restava spesso l’ultimo del gruppo,
mentre la madre era curiosa, esplorava, e, di conseguenza, si staccava dal figlio. Ecco che,
quindi, lui reagisce dicendomi che sua madre è incapace di aiutarlo, anche in una situazione
difficile come questa.
In altri gruppi, invece, succede che le mamme arrivino con i mariti e i figli (di solito non oltre
i 10 anni). Inizialmente sembra siano i bambini, per lo meno alcuni, ad aver paura e a voler
fare tutto il percorso mano nella mano con la madre. Per questioni di sicurezza, preferisco
sempre sganciare le mani delle persone, per evitare che incidenti qualsiasi facciano cadere a
terra l’intera coppia anziché solo un membro. Così, prendo il bimbo per mano e lascio libera
la genitrice. Man mano che si snoda il percorso, mi rendo però conto che è la donna a
chiamare insistentemente il figlio o il marito, a preoccuparsi di dove sono e di cosa stanno
toccando, a voler stare col bimbo quando, invece, questi ormai non dà più neanche a me la
mano, ed esplora sicuro e felice l’ambiente circostante.
Altre volte ancora, vedo famiglie di seconde nozze con figli dell’uno e dell’altra. In questi
casi, mi capita di sentire frasi come: “Voglio stare vicino alla mia mamma, non a te!”, o
ancora, “Dov’è mia sorella, tu togliti!”
Dinamiche simili a quelle familiari si realizzano anche nei gruppi analiticamente orientati, in
particolare quando avviene la sovrapposizione transferale fra il gruppo e la famiglia di
origine. Questo in genere accade quando si è già entrati nel lavoro terapeutico vero e proprio.
Infatti, "a sedute in cui si partecipa a situazioni fusionali, che torneranno a livelli diversi nel
divenire gruppale (tempo a spirale), si alternano sedute in cui nel gruppo si riattualizza la fase
adolescenziale e il gruppo diventa un gruppo di "pari" con specifiche caratteristiche, fra cui la
rimessa in discussione dei modelli familiari e la possibilità di costruire nuovi valori e nuove
risposte". Nel gruppo, come afferma Corbella, i "conflitti inter e intrapsichici tendono a essere
presentificati e agiti in relazione a oggetti che possono rappresentare oggetti del passato o
anche oggetti-sé con il conseguente vissuto, tipicamente adolescenziale, di irrequietezza e
105
confusione”. Come ha fatto notare Rouchy, (1998) anche la cultura familiare viene
inconsciamente incorporata, fondando l’identità collettiva del soggetto e il sé non
individualizzato, e funziona all’insaputa del soggetto come automatismo, in condotte
programmate e non "mentalizzate", solitamente così profondamente radicate nella struttura
dell’io maturo da non poter essere riconoscibili. Spesso le persone sono eredi di cose mai
dette nella propria famiglia, che possono portare anche a somatizzazioni. Ma le condotte
familiari interiorizzate vengono rispecchiate nel e dal gruppo, e quindi, divenute coscienti,
possono essere integrate o rifiutate. "Negli spazi lasciati liberi dalla sovrapposizione fra il
gruppo della famiglia di origine e il gruppo terapeutico", ricorda Corbella, "si fa strada la
possibilità del cambiamento e dell’uscita dalla coazione; a volte infatti il ruolo richiesto al
soggetto in famiglia è diverso da quello richiesto dal gruppo terapeutico, non foss’altro per il
fatto che il ruolo abituale inconsciamente giocato in famiglia, nel gruppo terapeutico può
essere già occupato da un altro membro".
Tuttavia, l’elaborazione critica delle condotte familiari interiorizzate, in Dialogo nel buio non
può realizzarsi, dal momento che il tempo che si trascorre assieme è troppo poco, e il setting
non è adatto a favorire un cambiamento profondo, complesso e difficile come questo.
Ora vorrei dare uno sguardo al modo in cui la vista influisce nella formazione del gruppo
terapeutico e a come, invece, questa venga meno a Dialogo nel buio. Che canale è privilegiato
al buio se la vista è completamente annullata?
Nel gruppo analitico, è molto importante la circolarità; la vista è privilegiata, diversamente
che nella Psicoanalisi sul lettino. Concordando con Bion, l’analisi di gruppo, coinvolgendo il
corpo in modo diretto, stimola anche le aree più arcaiche dell’individuo in modo più
approfondito dell’analisi individuale.
Al buio, invece, il gruppo si costituisce anche in assenza di vista e quello che prevale è il
contatto fisico, corporeo, cosa che all’esterno si tende ad evitare perché, non facendo parte
della nostra cultura, è spesso temuto. Per far comprendere agli individui l’importanza
dell’utilizzo corretto degli altri sensi, spesso faccio fare un gioco ai gruppi che entrano al buio
conoscendosi già tutti, quindi amici o scolaresche. Chiedo loro di formare un cerchio e li
prego di stare in silenzio. Giro piano piano attorno al cerchio, scelgo due persone, le faccio
uscire dal cerchio e le metto una davanti all’altra. A questo punto spiego ad entrambi che
hanno di fronte uno dei loro amici: usando gli altri sensi, quindi annusando e toccando,
propongo loro di riconoscersi a vicenda e di parlare solo quando hanno riconosciuto il loro
compagno di gioco. L’esperienza normalmente va a buon fine: le persone sono contente e
stupite di essere riuscite a riconoscersi vicendevolmente, e capiscono che la vista non è
l’unico senso che va messo in campo nell’esplorazione del mondo. Lo stesso toccare, come
106
detto in precedenza, cambia di significato al buio, inteso nei due sensi del toccare e del
toccarsi.
Vorrei, a questo proposito, accennare brevemente alla prossemica, disciplina che studia la
natura dello spazio personale e sociale, ed il modo in cui vengono percepiti dagli esseri
umani. Il termine è stato introdotto dall'antropologo Edward T. Hall nel 1963, per indicare lo
studio delle relazioni di vicinanza nella comunicazione interpersonale. Hall, osservando che la
distanza sociale tra le persone è stabilmente correlata con la distanza fisica, ha definito e
misurato quattro "zone" interpersonali: la distanza intima (0-45 cm), in cui ci si abbraccia, ci
si tocca e si parla sottovoce; la distanza personale (45-200 cm), per l'interazione tra cari amici;
la distanza sociale (1,2-3,5 metri) per la comunicazione tra conoscenti; la distanza pubblica
(oltre i 3,5 metri), per le pubbliche relazioni. Nel libro "La dimensione nascosta" (1966), Hall
osserva che la distanza alla quale ci si sente a proprio agio con le altre persone vicine dipende
dalla propria cultura: i sauditi, i norvegesi, gli italiani ed i giapponesi hanno infatti diverse
concezioni di vicinanza. A Dialogo nel buio, tutto si riduce a distanza intima, innanzitutto
perché le cose da toccare sono l’una vicina all’altra e i visitatori sono tanti in un piccolo
spazio; ma un’altra ragione, e forse la più importante, è che le persone scoprono di aver
bisogno del contatto fisico. Succede, ad esempio, che un ragazzo tocchi il braccio, la mano, la
spalla o un seno di una ragazza per sbaglio e capisca che quella non è la sua partner. E’ chiaro
che arriva immediatamente la frase di scuse per il gesto compiuto, ma è altrettanto chiaro che,
in un contesto particolare come questo, nessuno si offende, nessuno sente minacciata la sua
“bolla protettiva”, nessuno si sente invaso o aggredito.
In Gruppoanalisi, l’essere nel gruppo consente anche di passare dal vedere ed essere visti
nella superficiale dimensione corporea, al vedere e vedersi come persone, sia nella globalità,
che con le proprie caratterizzanti articolazioni. Colpisce molto, e me per prima, il fatto che al
buio la dimensione del vedere il corpo scompaia completamente. In quest’atmosfera, nessuno
può accorgersi della presenza dell’altro, a meno che l’altro non desideri evidenziare il proprio
essere presente. In questo modo anche le persone più timide o normalmente più impacciate si
sentono più a loro agio, e si esprimono più liberamente. E’ anche vero, però, che alcuni
visitatori hanno verbalizzato la loro difficoltà di rispettare i turni conversazionali senza
l’ausilio della vista, a sottolineare proprio l’estrema importanza che ha per tutti vedere e
vedersi reciprocamente, ed il peso dei segnali comunicativi non verbali immediatamente
accessibili alla sfera visiva, come le espressioni del volto, la postura, la gestualità.
Lo scomparire fisicamente, tipico del Dialogo nel buio, può coincidere con lo sparire
metaforico di un membro del gruppo analiticamente condotto. Qui, infatti, si alternano fasi di
partecipazione diretta ad altre di silenzio partecipante, che permette al singolo di dosare il
107
livello del suo coinvolgimento. Poter osservare il conduttore in relazione costruttiva con gli
altri membri consente una compartecipazione che stimola processi maturativi personali. E’ già
terapeutico non solo rispondere realisticamente alle domande del paziente, ma valorizzare la
sua capacità di porsi domande ed esprimere perplessità. Anche a Dialogo nel buio, le persone
a volte partecipano attivamente chiamando la guida e facendo domande, e altre volte restano
in disparte e apparentemente invisibili. E sono proprio queste persone che vanno valorizzate
quando capiscono qualcosa o chiedono un’informazione.
Da queste pagine credo siano chiare le notevoli potenzialità di un’esperienza come Dialogo
nel buio, e gli interessanti parallelismi con la Gruppoanalisi. Sarebbe un’esperienza che tutti
gli psicologi, di qualsiasi orientamento, a mio avviso dovrebbero fare, in primo luogo per
riuscire a conoscersi sempre meglio e ad entrare in modo più profondo nei propri vissuti, ma
anche perché avrebbero modo di scoprire una miniera ricca di spunti e suggerimenti per il
pensiero, la ricerca, o il loro stesso lavoro.
Azzardo, a questo punto, che potrebbe essere interessante proporre ai gruppi analiticamente
condotti alcune sedute al buio, sia nell’ambiente di Dialogo nel buio, che in una stanza con
riprodotta l’oscurità. Non serve, credo, che mi soffermi ora sull’importante valore terapeutico
che un’esperienza di questo tipo potrebbe avere.
108
Conclusioni
Complessivamente, sono molto soddisfatta di questo originale elaborato. Sono contenta di
essere riuscita a diffondere sempre più un progetto così interessante come “Dialogo nel buio”,
ed aver lanciato all’ambiente accademico e agli psicologi in generale un’idea nuova per
condurre alcune sedute di psicoterapia. Non penso che un setting come questo potrebbe essere
fruibile da tutti i pazienti, com’è vero che non tutti i pazienti sono adatti allo stesso tipo di
terapia, quindi sarebbe, di volta in volta, compito del terapeuta valutare i tempi e le condizioni
per far sì che questo tipo d’esperienza possa essere utile e non, al contrario, distruttiva.
Credo che sedute al buio potrebbero essere pensate anche per l’analisi individuale perché, in
alcuni casi, catalizza vissuti individuali e profondi difficili da esprimere immediatamente alle
altre persone ma, in prima istanza, anche a se stessi.
Alla luce della nuova consapevolezza da me acquisita in campo gruppoanalitico, e delle mie
sempre maggiori competenze di guida, ritengo di poter fare alcune considerazioni riguardanti
il progetto “Dialogo nel buio”.
In primo luogo, sarebbe opportuno che tutte le guide potessero partecipare ad un seminario
che dia loro un’idea generale dell’enorme importanza che questo tipo di esperienza ha sulle
persone, e della maniera di affrontare le situazioni più diverse, in modo che nessuno sia
impreparato. E’ chiaro che, per una guida esperta, questa consapevolezza arriva col costante
lavoro e la sempre maggior pratica. E’ altrettanto chiaro, però, che l’avere prima certe nozioni
faciliterebbe di gran lunga il lavoro. Al buio arrivano le persone più diverse, anche disabili
gravi come, ad esempio, autistici o paraplegici. Sarebbe molto importante avere conoscenze,
anche limitate, sul maggior numero possibile di patologie, e sul modo migliore in cui far
affrontare l’oscurità a questo tipo di pubblico.
Sarebbe auspicabile insegnare al personale l’empatia, il modo più corretto di rispondere alle
domande, e tante altre cose che per un buono psicologo sono patrimonio acquisito.
Recentemente tale possibilità è stata ventilata dall’amministrazione. In questo modo,
“Dialogo nel buio” acquisterebbe una professionalità sempre maggiore.
Alla Mostra, come ho ampiamente spiegato in precedenza, lavorano insieme persone vedenti
e non vedenti. I primi costituiscono quello che noi chiamiamo “staff”, e si occupano di tutto
quello che si fa alla luce, come prendere le prenotazioni, fare i biglietti, e così via. I non
vedenti sono l'anima del progetto, le guide. Tutte queste persone nell’insieme formano una
sorta di grande équipe multidisciplinare, con competenze, esperienze e storie diverse. Di
questa complessità, però, non c'è in tutti piena coscienza. Considerando l'intero gruppo da
questo punto di vista, penso invece che sarebbe fondamentale un confronto costante in équipe
con un buon supervisore, che aiuti il gruppo a risolvere conflitti interni, o difficoltà di
relazione con alcuni visitatori.
In prima persona, ad esempio, noto che ci sono varie caratteristiche dei gruppi che mi
allontanano da quel tipo di empatia, che dovrebbe essere indispensabile: il troppo chiasso, il
disordine, la distrazione e così via. Alla luce della mia esperienza e dell’acquisita maggior
comprensione delle dinamiche gruppali mi sento di poter affermare che una adeguata
formazione al lavoro di gruppo e in gruppo, permetterebbe alle guide di gestire ed affrontare
con minor difficoltà e maggior consapevolezza anche situazioni vissute come difficili, o anche
oggettivamente tali.
Sarebbe molto interessante, infine, dare ai visitatori che lo richiedano, una possibilità di
elaborare con un terapeuta l’esperienza appena vissuta, in un setting adeguato. Chissà, forse in
questo modo alcune persone potrebbero migliorare la loro qualità di vita, o magari trovare la
spinta per intraprendere un percorso terapeutico vero e proprio. Così, “Dialogo nel buio”
acquisterebbe ancora più valore, e potrebbe diventare un punto di riferimento anche per
alcune situazioni terapeutiche e un momento importante di formazione personale e
professionale per le guide medesime e per tutta l’équipe.
110
Bibliografia
A.A. V.V., “Enciclopedia Garzanti di filosofia”. Garzanti editore SPA, 1993.
A.A. V.V., “Nuovissima enciclopedia generale De Agostini”. Istituto Geografico De Agostini
SPA, Novara, 1988.
Abraham, A., "Il co-sè o il sinteismo primario". In "Attualità in psicologia", X, 1995.
Ambrosi P., “Dialogo nel buio: le ragioni, i visitatori, le guide”. In “Passaggi: dialoghi con il
buio”, Valentinotti M., De Zambotti A., Bonaventura W. (a cura di), Mimesis-Interferenze,
Milano, 2006.
Ancona L., “Gli spazi della mente”. In “Gli Argonauti”, 63, 1996.
Anzieu, D. (1994), "Il pensare dall'Io pelle all'Io pensante". Trad.it. Borla, Roma, 1996.
Arendt, H. (1968), “L’umanità in tempi bui”. Trad. it. Raffaello Cortina, Milano, 2006.
Baldini M. (a cura di), “Aforismi e pensieri di Sigmund Freud”. Newton Compton, Roma,
1994.
Balint M. (1956), “Medico, paziente e malattia”. Trad. it. Feltrinelli, Milano, 1961.
Baratta S., Ermini F. (a cura di), “I nomi propri dell’Ombra”. Ed. Moretti & Vitali, Bergamo
2004.
Bateson G. (1973), “Verso un'ecologia della mente”. Adelphi, Milano, 1990.
Bauman Z., “I disagi della civiltà. La modernità liquida”. Intervista a cura di Andrea
Baldassarro, in “Psiche”, 1-2006.
Binswanger L. (1955), "Funzione di vita e storia della vita interiore". Trad. it. In "Per
un'antropologia fenomenologica", Giancanelli F. (a cura di), Feltrinelli, Milano, 2007.
Bion W.R. (1961), “Esperienze nei gruppi”. Trad. it. Armando, Roma, 1971.
Bion W.R. (1962), "Apprendere dall'esperienza". Trad. it. Armando 1979.
Bordi S., “La psicoanalisi alla fine del secolo: una rassegna". Lavoro presentato al Centro
Milanese di Psicoanalisi, 1998.
Buber M. (1923), “Ich und Du“. Trad. it. “Io e Tu”, in “Il pensiero dialogico e altri saggi”, a
cura di Andrea Poma. Edizioni San Paolo, Cinisello Balasamo, 1993.
Burrow T., “The laboratory method in psychoanalysis, its inception and development”. In
“American Journal of Psychiatry”, V, 1926.
Burrow T., "The group method of analysis". In “The Psychoanalytic Review”, XIV, 1927.
Canetti E., (1973), "La provincia dell'uomo". Trad. it. Adelphi, Milano, 1978.
Clark B., “Ade come luogo”. Tratto dalla rivista “Linguaggio Astrale”, CIDA, n. 137-2004.
Ceronetti G., “L’illusione di vincere l’infelicità”. Articolo pubblicato in “La Stampa”, 12-092006.
Corbella S., “Storie e luoghi del gruppo”. Raffaello Cortina, Milano, 2003.
Corbella S., “Il gruppo: ponte tra individuo e società”. Articolo dell’Ottobre 2004.
Corbella, S. “La modulazione del noi”. In “Gruppi omogenei”, Corbella, Girelli, Marinelli (a
cura di), Borla, Roma, 2004.
Corbella S., "Analisi individuale e analisi di gruppo: un confronto". Incontro scientifico del
Progetto “Psiche e Ricerca”, Bergamo, 9 novembre 2005.
Corrao F., "Struttura poliadica e funzione gamma". In “Gruppo e Funzione Analitica”, Centro
Ricerche di Gruppo "Il Pollaiolo", n° II – 2, 1981.
112
Derrida J. (1967), “La scrittura e la differenza”. Trad. it. Einaudi, Torino, 1971.
Di Chiara G., "Sindromi psicosociali". Raffaello Cortina, Milano, 1999.
Diet E., "Il Thanatoforo. Lavoro della morte e distruttività nelle istituzioni". In “Sofferenza e
psicopatologia dei legami istituzionali”, A.A. V.V., Borla, Roma, 1998.
Fairbairn R., "Psychoanalytic Studies of the Personality". Tavistock Pubblications, London,
1952.
Friedman R., "Intervista a Robi Friedman". In “Gruppi omogenei”, Corbella, Girelli,
Marinelli (a cura di), Borla, Roma, 2004.
Foulkes S.H. (1964) "Psicoterapia e analisi di gruppo". Trad. it. Boringhieri, Torino, 1967.
Foulkes S.H (1975), “La psicoterapia gruppanalitica”. Astrolabio, Roma, 1976.
Freud S. (1921), “Psicologia delle masse e analisi dell'Io”. OSF, vol. 9.
Gaburri E. (2000), "Gruppo e sogno". Lavoro presentato al CMP, Giugno 2000.
Gadamer H.B. (1952), “Verità e metodo”. Trad. it. Bompiani, Milano, 1983.
Gaddini E. (1981), "Acting out nella situazione analitica". In “Scritti (1953-1985)”, Raffaello
Cortina, Milano, 2002.
Galzigna M., “Il respiro dell'essere. Riflessioni sull'immagine". Tratto dalla rivista “Il sogno
della farfalla”, Nuove Edizioni Romane, n. 2 - 1995.
Garcia - Campayo et al., “Balint group training, "to balint", and detection of mental disorders
in primary care”. Acta Psychiatrica Scandinavica, 92, 1995.
Gasca G., “Lo psicodramma come analisi attraverso il gruppo”. Tratto dalla rivista
“Psicodramma Analitico”, Torino, n. 0, Dicembre 1992.
113
Grillon C., Pellowski M., Merikangas K., Davis M., "Darkness facilitates the acoustic startle
reflex in humans". In "Biological Psychiatry", vol. 42, Ed. John H. Krystal MD, 15 Settembre
1997.
Hack M. “L´energia del vuoto, un mistero universale”. Tratto dal quotidiano “L’Unità”, 21
Maggio 2007.
Hall E.T., “La dimensione nascosta”. Trad. it. Bompiani, Milano, 1966.
Hillman, J. (1979) “Il sogno e il mondo infero”. Trad. It. Adelphi, 2004.
Hillman J., Truppi C., “L’anima dei luoghi. Conversazione con Carlo Truppi”. Rizzoli, 2004.
Kaes R., “Contributo a un seminario dell'Associazione di Psicoterapia di Gruppo”. Atti,
Milano, Ottobre 1998.
Kaneklin C., “Lavorare in gruppo oggi”. In “Spunti”, Anno III, n. 4, 2001.
Kibel H.D., "Intervista a Howard D. Kibel". In “Gruppi omogenei”, Corbella, Girelli,
Marinelli (a cura di ), Borla, Roma, 2004.
Kluzer Usuelli A. et al., “L’illusione in Freud e in Winnicott: un valore controverso”. In
“L’illusione una certezza”, Saraval A. (a cura di), Cortina, Milano 2003.
Jackson S.W., “Melancholia and Depression: From Hippocratic Times to Modern Times”.
New Haven/London, Yale University Press, 1986.
Jung C.G. (1938-40), “Psicologia e religione”. Trad. it. in. “Opere”, Vol. XI, Boringhieri,
Torino 1979.
Jung C.G. (1943), “Psicologia dell'inconscio”. Trad. it. in. “Opere”, Vol. VII, Boringhieri,
Torino 1983.
Jung C.G. (1944), “Psychology and Alchemy”. In “The collected works of C.G.Jung”,
114
Princeton University Press, 1968.
Lewin K.(1951), “Teoria e sperimentazione in psicologia sociale”. Il Mulino, Bologna, 1972.
Lewin R., "Complexity: Life at the Edge of Chaos”. Macmillan, New York, 1993.
Locke N. (1961), "Psicoanalisi di gruppo. Teoria e tecnica". Trad. it. Guaraldi, Rimini, 1974.
Lopez D., Zorzi-Meneguzzo, L., "La sapienza del sogno". Dunod, Milano, 1999.
Lo Verso G., Papa M., “Il gruppo come oggetto di conoscenza e la conoscenza del gruppo”.
In "La psicodinamica dei gruppi", Di Maria F., Lo Verso G. (a cura di), Raffaello Cortina,
Milano, 1995.
Marinelli S., “Funzioni dell’omogeneità nei gruppi”. In “Gruppi omogenei”, Corbella,
Girelli, Marinelli (a cura di ) Borla, Roma, 2004.
Mauri P., “Buio”. Einaudi 2007.
Milton J. (1667), "Paradise Lost”. Trad. It. “Il paradiso perduto”, Centro Diffusione Cultura,
Milano, 1985.
Moravia S., "L'enigma della mente". Laterza, Bari, 1986.
Morin E. (1982), “Scienza con coscienza”. Trad. it. Franco Angeli, Milano, 1984.
Napolitani D., “Individualità e gruppalità”. Boringhieri, Torino, 1987.
Nardone G., Salvini A., "Il dialogo strategico". Ed. Ponte alle Grazie, Milano, 2004.
Neri C., “Gruppo”. Borla, Roma, 1995.
Nissim Momigliano L., Robutti A. (a cura di), “L'esperienza condivisa”. Raffaello Cortina,
Milano 1992.
115
Palo G., “La comunicazione nel mondo contemporaneo. Appunti per la riflessione etica”.
Tratto dalla rivista “Bioetica e cultura”, Palermo, VIII – 1999.
Perls F.S. (1968), “La terapia gestaltica parola per parola”. Astrolabio, Roma 1991.
Pines M., "I sogni sono personali o sociali?". Atti del Congresso Internazionale "Sogno e
gruppo", Roma, 4-5 giugno 1999.
Pontalti C., Costantini A., Sparvoli M., Pontalti I., Vincenzoni P: “Problemi nella fondazione
di un gruppo a tempo limitato”. In “Psicoterapia di gruppo a tempo limitato”, A. Costantini (a
cura di), McGraw-Hill, Milano, 2000.
Puget J., "Problèmes méthodologiques de l'interprétation". In "Revue de psychothérapie
psychanalytique de groupe", 15, 1990.
Puget J. (1994), "Il gruppo e le sue configurazioni". Trad. it. Borla, Roma, 1996.
Rizzolatti G., Sinigaglia C., “So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio”.
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.
Rogers C. (1951), "Terapia centrata sul cliente". La Nuova Italia, Firenze 1997.
Rogers C. (1962), “Psicoterapia e relazioni umane”. Boringhieri, Torino 1970.
Rogers C. (1970), “I gruppi di incontro”. Astrolabio, Roma 1976.
Rouchy J. C. (1998), “Gruppo spazioanalitico”. Trad. it. Borla, Roma, 1999.
Rovatti P., “L'esercizio del silenzio”. Raffaello Cortina Editore, Milano 1992.
Saramago J. (1995), “Ensaio sobre a Cegueira”. Trad. it. “Cecità”, Einaudi, 1996.
Skorjanec B., “L’evoluzione del linguaggio terapeutico”. Tratto dalla “Rivista Europea di
Terapia Breve Strategica e Sistemica”, Arezzo, n. 1 – 2004.
116
Stòccoro G., “Alla maniera dei Gruppi Balint. Una terza via?”. Relazione presentata al corso
“Diagnosi, percorsi terapeutici individuali e strumenti nella doppia diagnosi dei Disturbi da
uso di sostanze/altri disturbi psichiatrici", Pioltello, 18 novembre 2004.
Valentinotti M., “Attraversamento del buio: attualità di un mito”. In “Passaggi: dialoghi con
il buio”, Valentinotti M., De Zambotti A., Bonaventura W. (a cura di), Mimesis-Interferenze,
Milano, 2006(a).
Valentinotti M., “Introduzione”. In “Passaggi: dialoghi con il buio”, Valentinotti M., De
Zambotti A., Bonaventura W. (a cura di), Mimesis-Interferenze, Milano, 2006(b).
Vygotskij L. (1934), “Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche”. Laterza ed., Bari 2001.
Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson Don D. (1967), “Pragmatica della Comunicazione
Umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi.”. Astrolabio, Roma,
1971.
White M., “La terapia come narrazione”. Astrolabio, Roma, 1992.
Winnicott, D.W. (1965), "Sviluppo affettivo e ambiente". Trad. it. Armando, 2002.
Zanasi M., Pezzarossa B. (a cura di), "Psicologia analitica e psicologia dei gruppi". Borla,
Roma, 1999.
117
Riferimenti bibliografici in Internet
A.A.V.V., “Commenti dei visitatori alla mostra: DIALOGO NEL BUIO”.
www.passolento.it/dialogo_commenti.htm
Barrio Gutiérrez J., “Diálogo. Filosofia.”, Gran Enciclopedia Rialp, 1991.
www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=5680&cat=filosofia
Carnaroli Francesco, "Aspetti della ricerca sul dialogo in psicoanalisi", tratto dalla rivista
telematica PSYCHOMEDIA.
www.psychomedia.it/pm/modther/emozling/carnaroli.htm
Corbella Silvia, “Legami ed emancipazione”, dagli atti del Convegno de Gli Argonauti,
“Emancipazione e…”, Padova, 11-12 novembre 2006, pubblicato sul sito dell’associazione.
www.argonauti.it/convegni/emancipazione/corbella.html
Di Cesa Donatella, “Dialogo infinito tra Derrida e Gadamer”.
http://lgxserver.uniba.it/lei/rassegna/030219a.htm
Cavaliere Roberto, “Le paure: cosa sono, da che sono generate, come si possono
sconfiggere”. Intervista pubblicata sulla rivista online “Seven Magazine”, Febbraio 2007.
http://www.7magazine.it/new.asp?id=798
La Greca Fernando, “Il divano di Antifonte. Psicoterapia strategica nell'Atene del V sec.
a.C.”, pubblicato sul sito “Molise Psicologia”.
http://users.aliseo.it/angelo.vecchiarelli/il%20divano%20di%20antifonte_%20psicoterapia%2
0strategica%20nell'atene%20del%20v%20sec_%20a_c.htm
Oliverio Ferraris Anna, “Psicologia della Paura”. Rai Educational, intervista de “Il Grillo”,
Dicembre 2001.
http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=899
Proietti Giuliana, “La paura del buio”, pubblicato sul sito “Psicolinea”, anno 2005.
http://www.psicolinea.it/g_i/paura_del_buio.htm
Proietti Giuliana, “Psicodramma”, pubblicato sul sito “Psicolinea”, anno 2006.
http://www.psicolinea.it/t_t/psicodramma.htm
Redazione di Universo Online, “Paura del buio”, Giugno 2005.
http://www.universonline.it/_psicologia/psico_sessuologia/05_06_22_a.php
Schiroli Chiara, “Dialogo nel buio: quando il lavoro si incrocia con la vita”.
www.guciweb.org/dialogo_nel_buio.htm
“Wikipedia”, l’Enciclopedia libera del Web.
http://it.wikipedia.org
119
Scaricare