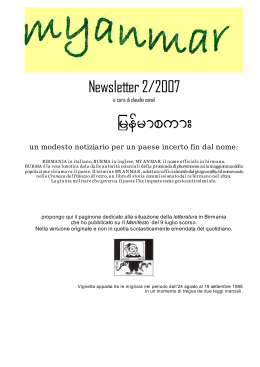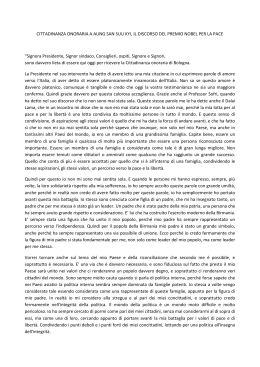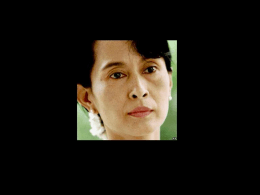NOSTALGIE BIRMANE “Lei non fa spesso meditazione, vero?” Mi sorride di sottecchi, con il capo leggermente piegato a sinistra, l’uomo che mi sta di fronte, camiciola color crema e longeve a quadretti verdi e neri, la lunga gonna birmana che qui tutti gli uomini, ad eccezione dei monaci e dei militari, ancora indossano. Senza attendere la mia conferma riprende: “Ed è un peccato. Vede, lei ha soggiornato nel nostro Paese abbastanza a lungo per aver toccato con mano la nostra povertà, per aver constatato quanto siano lontane dal nostro modo di vivere tutte le vostre comodità occidentali, per essersi fatto un’idea di questo schifo di regime” Si ferma un attimo, ma neanche il disgusto per il regime riesce a cancellargli il sorriso. Solo, assume un atteggiamento come di scusa, quasi che le nefandezze del regime e i disagi provocati al turista fossero colpa sua. In questo Paese in cui le orecchie del governo militare si nascondono anche negli anfratti dei muri -dicono le guide turistiche, e probabilmente a ragione- è la seconda persona che sento esprimersi liberamente contro il regime. La prima era stato un missionario italiano di 95 anni, Padre Angelo, ma la sua posizione era diversa: “E poi, dopo sessant’anni di Birmania in cui sono stati indicato come rivoluzionario (e in qualche occasione anche imprigionato) prima dai colonizzatori inglesi, poi dai conquistatori giapponesi, infine dai liberatori alleati - ci riferiva con una risatina chioccia il vegliardo appallottolato nella poltrona non vorrete che mi impressioni per questi pagliacci, anche se mi hanno fregato i soldi, requisito la casa e chiuso la scuola!” “Eppure, avrà notato con altrettanta evidenza riprendo il discorso dell’amico birmano - che la nostra gente è sempre sorridente, serena. Ecco, vede, il segreto è tutto nella meditazione. Non ci vuole poi molto: un paio di ore al giorno. Lei non ha mai partecipato alle nostre sedute di meditazione, o sbaglio? La inviterei volentieri, ma so già che mi risponderebbe che non capisce la nostra lingua, che non ha tempo... Soprattutto che non ha tempo. Voi occidentali non avete mai tempo. Anche quando siete in vacanza. Io sono stato in Italia, sa? Per lavoro: Fiera di Milano - lo dice in italiano,e ride - ah,ah! Bella Italia, belli Italiani. Ma non meditano. Correre, correre, sempre di fretta. Non avete mai tempo. Nemmeno per le cose importanti. Perché, mi creda, è solo grazie alla meditazione se noi riusciamo a vivere decentemente, accettando tutte quelle cose storte che ci sono nel nostro pur bellissimo Paese.” “Tra cui questo clima da bagno turco” penso io, nonostante dove mi trovi adesso sia relativamente fresco, rispetto all’abituale calura di Yangon. Della Birmania in queste settimane ho imparato ad apprezzare -e spesso ad amare- moltissime cose: dai paesaggi dolcissimi ai monumenti abbacinanti nel fulgore degli ori o nella preziosità degli intarsi; dalla cordialità di questa gente premurosa alle estrosità della cucina; ho perfino accettato (benché non proprio apprezzato) l’aleatorietà di un sistema di trasporti in stato di avanzata decomposizione (treni, aerei, auto o battelli, tutti sembrano sul punto di sfaldarsi sotto i tuoi piedi). Ma il clima, quello proprio no. Stagione secca, hanno il coraggio di chiamarla, a dimostrazione che tutto è relativo, perché il secco di Yangon è un vapore bollente e appiccicoso che ti avvolge all’alba e ti accompagna ben oltre il tramonto, con i vestiti che si amalgamano sgradevolmente alla pelle, facendoti sentire perennemente fuori posto. Questo almeno per noi occidentali, perché gli amici birmani, nei loro costumi tradizionali diversissimi da una regione all’altra, ma tutti accomunati dal longee maschile che ancora resiste con successo all’attacco dei jeans- appaiono sempre in ordine. Come appunto il mio interlocutore, Direttore Amministrativo di una delle due uniche Case di Riposo per anziani esistenti in Birmania - o Myanmar, come è chiamata oggi - nel cui ombroso ufficio stiamo dunque conversando, pur con qualche incertezza, dato il mio inglese alquanto primitivo (quello del mio interlocutore è invece ottimo). Case di riposo per anziani poveri, specifica l’intestazione, quasi che uno possa mai credere che in Birmania esistano anche anziani ricchi, almeno tra coloro che richiedono il ricovero a tempo indefinito. Non vengono di certo molti turisti – men che meno italiani - in queste case di riposo, benché la loro esistenza sia riportata da una guida per giramondo (è la prima volta che vedo una guida turistica riportare l’indirizzo di una casa di riposo). Successe così che durante i preparativi del viaggio (tra parentesi, uno dei viaggi più straordinari che abbia mai compiuto, a causa, più che della bellezza innegabile dei paesaggi o dei monumenti, della serenità, gentilezza, dolcezza di questo popolo) durante i preparativi, dicevo, mentre osservavo la mappa della capitale Rangoon - o Yangon, come preferiscono chiamarla oggi - ero stato colpito, nell’elenco riportante a piè di pagina i monumenti, gli alberghi consigliati e gli altri “principali indirizzi di comune interesse”, da un numero corrispondente a “Home for the aged poor”, “Casa per l’anziano povero”. Riguardo ad essa, nessuna ulteriore spiegazione. Ma un’altra delle mie guide (me ne procuro sempre almeno tre o quattro, specialmente per viaggi impegnativi come quello in Birmania), riferiva dell’esistenza di due case di riposo, in Birmania, di cui appunto la prima a Yangon, mentre la seconda era situata in una delle antiche capitali dell’ex regno, Mingun, piccolo agglomerato sito a poca distanza dalla seconda città del Paese, Mandalay. Bisogna sapere che in Birmania le ex-capitali, numerose quasi quanto le famiglie di nobili decaduti nel nostro Mezzogiorno, sono oggi spesso dei semplici villaggi, quando non quattro sassi in equilibrio precario (i terremoti sono una costante di questa terra); tuttavia anche quando paiono in sfacelo, contengono sempre almeno due o tre monumenti notevoli, delle straordinarie forme architettoniche di una bellezza - e talora anche di una ricchezza abbacinante, che risultano ancora più stupefacenti allorché spuntano in mezzo alla jungla, o al deserto o a quattro capanne di paglia. Bene, Mingun sarebbe oggi solo un paesotto abbastanza anonimo se non possedesse due pagode ( paya nella lingua locale), due “tesori da non perdere”, come dicono le guide. La prima è un’abbagliante, gigantesca torta nuziale a più piani, un’immensa meringa a forma di pagoda, che sorge nel bel mezzo di un prato rubato alla foresta, nel quale pascolano tranquille capre pezzate e vacche dalle lunghissime corna a mezzaluna, del tutto indifferenti ai rari visitatori. Ma quella realmente “da non perdere” è la seconda, una torre di Babele in rovina (dicono per ira divina contro la superbia del re costruttore, manifestatasi con due terremoti in rapida successione) e ancora più spettacolare perché attraversata da una profonda fenditura verticale che, partendo dalla base, si apre come una ferita nei muri color ocra, attraverso il leggiadro portale riccamente scolpito, sù sù fino alla piattaforma sommitale, conferendo al monumento perfetto nelle proporzioni, benché decapitato dal terremoto - un aspetto drammatico che contrasta con la dolcezza del paesaggio e l’allegria dei ragazzini. Questi infatti pullulano, come avviene nei dintorni di qualsiasi potenziale attrazione turistica, per offrirsi come guida alla scalata del monumento, alto una cinquantina di metri. In realtà non c’è bisogno di alcuna guida per raggiungere la cima, essendovi un’evidente, ancorché non proprio comoda, scalinata che si inerpica quasi in verticale su un fianco della paya terremotata. Ma qui le giovani guide improvvisate non chiedono niente per sè: al massimo dieci kyats (neanche cinquanta delle nostre lirette) come offerta per il tempio, da porre nella sporta di due sorridenti monache-bambine in tunica rosa, e magari ti danno in cambio un fiore, sicché è sciocco mostrarsi scontrosi. E se respingi il loro servizio di guida, hanno pronta una soluzione di ricambio, proponendosi come guardiani delle tue calzature: perché, essendo la pagoda un luogo sacro, la salita va affrontata a piedi nudi, il che non è il massimo dei divertimenti, come abbiamo sperimentato compiendo l’ascesa sotto il sole di mezzogiorno. Fortunatamente, una volta raggiunta la sommità, le estremità ustionate trovano sollievo nella frescura di qualche piccola zolla erbosa, dandoti così modo di gustare il premio del vastissimo panorama senza dover saltellare da un piede all’altro. Ecco quindi le svariate sfumature del verde dei campi coltivati alternarsi alle chiazze più cupe della foresta; ecco la grande distesa dell’abitato di Mandalay - capanne, palazzi, monasteri, guglie - cinta dalle anse del fiume che sfumano, con i porticcioli brulicanti di uomini, animali, carretti e imbarcazioni di ogni genere, verso la pianura; ecco infine, dall’altro lato, il profilo delle prime creste montuose, punteggiate da paya bianche, dorate, rosse, celesti, avamposti dei più alti monti che si intravvedono azzurrini nella foschia opaca della calura... “lusso”, se confronto le camerette in muratura corredate di armadietto e tavolino - di questi vecchi poveri con le capanne in legno pressocché prive di arredo della maggior parte della popolazione. Inoltre il complesso era dotato di un’ampia sala che i nostri canoni definirebbero “polifunzionale”, in quanto fungeva da sala-riunioni, sala da preghiera e, ovviamente, da sala da meditazione. In aggiunta dunque a queste meraviglie, la guida turistica riporta a Mingun l’esistenza di una Casa di Riposo per Anziani (anche qui rigorosamente poveri) di tale interesse, almeno per me, da giustificare il non agevolissimo viaggio in battello (un preoccupante residuato di quella che un tempo era stata l’imponente flotta fluviale di Sua Maestà Britannica), la salita a piedi nudi sui sassi arroventati e la ricerca della Casa in un labirinto di vicoli polverosi tra abitazioni in legno di teck, capanne a palafitte, recinti per capre e pagode di ogni dimensione; il tutto immerso in una vegetazione dirompente. Nei vialetti e nei prati ai piccoli gruppi di parenti e ricoverati, si mischiavano venditori di banane, pesci essiccati, spiedini, frittelle, tanto che era tutto un vociare e un rincorrersi di bambini attorno a focolari e pick-nick improvvisati, mentre i vecchi degenti ruminavano beati. Comunque la ricerca ebbe successo, anche perchè la Casa di Riposo - in realtà un vasto complesso di padiglioni, dormitori, giardini - era di dimensioni spropositate rispetto al villaggio e, a differenza della maggior parte delle altre costruzioni, sembrava tenere a bada con successo l’invadenza della vegetazione e il trascorrere delle stagioni. Qualche difficoltà semmai presentò la ricerca di informazioni sulla Casa. Dell’Infermiera Than Than Sue, “persona di riferimento che - secondo la già citata Guida - si esprime in ottimo inglese”, nessuna traccia; tuttavia il nostro timido accenno ad entrare fu subito incoraggiato da larghi sorrisi, quando non da aperte risate: mai come in Birmania il mio aspetto e verosimilmente anche quello di mia moglie è stato fonte di ilarità per gli autoctoni. Così potemmo girare liberamente tra i dormitori (stanzoni da una ventina di letti, ognuno protetto da zanzariera) e le camerette a due letti per le coppie, accompagnati da un incomprensibile vociare sommesso, dal quale emergeva di tanto in tanto la richiesta “pen, pen, candy, candy”, articoli che purtroppo avevamo quasi completamente esaurito nei contatti precedenti con i bambini. Tuttavia qualche penna a sfera riuscì ugualmente a saltar fuori, come pure qualche pacchetto di biscotti, sicchè assieme ai sorrisi fummo accompagnati da inchini e litanie di benedizione. L’impressione comunque fu di notevole ordine, pulizia e quasi di Molto diverso perciò da certe cupe atmosfere di casa nostra, in cui regole e limitazioni sembrano imposte più per la comodità (o l’indolenza) di chi vi opera che per il benessere degli ospiti. Mi colpì comunque l’assenza di vecchi con palesi segni di demenza, ma a causa del muro invalicabile della lingua, non potei avere ragguagli sullo stato mentale dei ricoverati e pertanto, nella nebbiolina purpurea del tramonto, salpai da Mingun con questa curiosità insoddisfatta. La ricerca della Casa a Yangon, impresa sulla carta assai difficile dato che gli indirizzi qui seguono una logica del tutto estranea alla mentalità occidentale e, spesso, anche a quella degli abitanti, fu più facile del previsto. Con mia sorpresa, il taxista conosceva l’esistenza e l’ubicazione della Casa (seppi in seguito che la stessa costituiva una specie di orgoglio cittadino) per cui eccomi qui a sorseggiare caffè assieme allo staff dirigenziale. “Così lei è stato anche a Mingun. Le è piaciuta vero? La città, intendo, ma anche la Casa di riposo è molto bella, non è d’accordo?” Il Direttore ha ripreso a parlare e a pormi domande di cui non attende la risposta. Tento d’interromperlo, questa volta con successo: “Davvero molto bella. Ma le spese chi le paga, visto che gli ospiti sono poveri?” “Donazioni, donazioni private. Lei si chiederà come faccia della gente povera come la nostra a mantenere queste istituzioni. Eppure, se c’è una cosa che funziona in questo Paese è proprio il sistema delle donazioni: il mantenimento dei monaci (che rappresentano una parte consistente della popolazione,N.d.R.), degli stessi monumenti, le statue ricoperte d’oro del Buddah, tutto è frutto di una tradizione di donazione che prosegue da sempre. La donazione per noi è una consuetudine naturale, come per voi pagare le tasse - ride divertito, è sufficientemente esperto di vita occidentale e italiana in particolare per conoscere quale sia il rapporto cittadino-tasse in occidente, specialmente in Italia. “Se poi qualcuno dei nostri vecchi si ammala seriamente - riprende - lo ricoveriamo in ospedale, che è qui a 200 metri, e paga lo stato, che almeno in questo caso qualcosa di buono lo fa.” Probabilmente è arcisicuro che tra i suoi collaboratori non sia infiltrato alcun amico del regime. “Ecco, guardi qui” e mi porge un opuscolo in cui sono spiegati - in inglese, oltre che in birmano - il funzionamento e il regolamento della Casa di Riposo. “Il candidato, di età superiore ai 70 anni, non deve possedere alcuna forma di sostentamento autonoma. Deve essere esente da lebbra. Deve essere di buon carattere e in armonia con il buon andamento della comunità. Deve essere in grado di rispondere alle questioni che lo riguardano. Deve potersi spostare autonomamente. (...) A ogni ospite, al momento dell’ingresso, vengono forniti tre completi di abbigliamento (che verranno periodicamente rinnovati)”. Il linguaggio è molto lontano dal distacco del nostro burocratese, nonostante la Birmania possegga una delle burocrazie più invadenti, corrotte e pasticcione del mondo, ma fortunatamente il burocratese non è ancora “entrato a far parte del tessuto sociale”, così si ricorre a questi lunghi e gentili giri di parole. annoiarmi.” A tempo pieno, perché per mandare avanti una struttura di 200 ospiti il tempo non basta mai. Certo, non dev’esser facile programmare dei bilanci contando solo su donazioni; aleatorie, variabili, gli faccio osservare. “Ah, voi occidentali! Credete che tutto il mondo si muova con il vostro sistema. Se qui c’è una cosa su cui possiamo essere sicuri, è che le donazioni continueranno ad affluire regolarmente. E magari aumenteranno, dal momento che adesso vengono a visitarci anche i turisti - ammicca, porgendomi la pergamena che attesta la mia natura di “benefattore” - Semmai non capisco come facciate voi, nelle vostre strutture, a fidarvi dei vostri sistemi di sovvenzione”. “Se è per quello non lo capisco nemmeno io”, considero, ma tengo il pensiero per me. La visita sta volgendo al termine, ma prima devo soddisfare la mia curiosità circa gli Alzheimer: la meditazione avrà molte ricadute benefiche, ma non credo possa eliminare l’Alzheimer dalla Birmania. Provo a chiederne all’amico Direttore, ma il termine Alzheimer non gli dice nulla; d’altronde non è un medico lui. “Demented, demented patients” insisto, ma senza successo. Pazienza, d’altronde non è questo l’unico interrogativo irrisolto che mi porterò a casa dalla Birmania. Un altro, più importante, è quello di come mettere in pratica i buoni propositi circa la meditazione. Apprendo, sempre dall’opuscolo, che qui operano un medico e un’infermiera a tempo pieno, ai quali si aggiungono volontari e personale del vicino ospedale. Il Direttore Amministrativo con cui sto parlando non è invece nominato. Gliene chiedo il motivo. Avrei lasciato la Birmania il giorno successivo e mi sarei rituffato nelle abituali occupazioni, non prima di essermi trascinato per due penose giornate a Bangkok, distante cinquecento chilometri e alcuni secoli da Yangon. Giornate penose a causa del traffico assurdo, del frastuono, dell’atmosfera inquinata, ma soprattutto per la visione di come un grande patrimonio di civiltà e cultura vada rapidamente sgretolandosi. “Donation! Anch’io sono una forma di donazione: posso occuparmi a tempo pieno di questa attività senza ricevere un soldo perché sono in pensione. Come mi pare di averle già detto, avevo un ottimo lavoro, grazie al quale ho girato il mondo come ben pochi dei miei connazionali. Lei crede che avrei potuto stare senza far niente, una volta in pensione? Va bene meditare, ah,ah, ma bisogna anche agire, non le pare? Per mia fortuna questa Istituzione ha accettato le mie competenze in fatto di finanza e commercio, così mi ha offerto la possibilità di non Giornate tuttavia istruttive: Bangkok oggi è la dimostrazione viva di come la smania del guadagno, del mito del “way of life” occidentale -trasportato da un turismo becero e straccione quant’altri mai- possa snaturare un popolo. Un popolo al quale abbiamo esportato Valentino, ma non Platone; al quale le rotondità siliconate di Demy Moore sono contrabbandate come l’ideale universale della bellezza, quasi che la Venere del Botticelli non fosse mai stata dipinta; al quale abbiamo fatto credere che per essere “un ragazzo come me” bisogna necessaria- mente amare i Beatles e i Rolling Stones, e non Mozart o Mahler. A questo popolo vendiamo tonnellate di videocassette, ma nemmeno una pagina di Shakespeare, gli compriamo orologi e T-shirts falsificati, ma non un pensiero vero. E poi ci lamentiamo: “Ah, dov’è finita la Bangkok di un tempo, il Siam delle favole e dei misteri?”. Dicono che trent’anni fa’ Bangkok non fosse dissimile dall’attuale Yangon, che i Tailandesi di allora non fossero dissimili dai Birmani di oggi: premurosi, sorridenti, affidabili. Poi sono intervenuti il “progresso”, il “tutto e subito”, lo “sviluppo”, che hanno regalato la televisione (a molti) e il benessere (a pochi). Ma, ancor più importante, che hanno sottratto a (quasi) tutti la capacità di chiedersi “dove mai sto andando?”. In altre parole, la consuetudine alla meditazione. Aveva ragione l’amico Direttore, non abbiamo mai tempo per le cose importanti. A Bangkok come a Milano. Eppure non si può procedere sempre alla cieca. Comportarsi in certi modi, compiere certe scelte solo perché “si è sempre fatto così” o all’opposto perché “è ora di cambiare”. “Non mi piace, ma mi adeguo”: è più semplice. No, non mi può bastare. Ormai sono giunto a un punto della vita in cui sempre più spesso si è tentati di volgersi indietro, non tanto per coltivare sterili rimpianti, magari nemmeno per impantanarsi in difficili bilanci, quanto per cercare di trarre indicazioni su come occupare al meglio il (poco? tanto?) tempo che resta. Correre, correre, sempre di fretta. Almeno non si ha tempo per pensare. “A me se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro (...) Che parrà di tal voglia? che di quest’anni miei? che di me stesso?” Leopardi se lo chiedeva a trent’anni. “Quando sarò vecchio avrò tutto il tempo per pensarci.” E anche la voglia? E se domani non potessi più pormi domande, se non potessi più rispondermi perché è venuto a mancarmi il cervello? Quanti dei miei vecchi dementi avevano messo in programma che un giorno gli sarebbe andato il cervello in pappa? Loro, se la saranno poste in tempo queste domande? E si saranno dati delle risposte? E soprattutto: è giusto, è opportuno , è utile darsi delle risposte? Non posso rispondere: “Forse”. Forse non lo so, forse non lo so ancora, ma insomma, prima o poi almeno questo quesito devo risolverlo: o sì o no. “Non ci vuole poi molto: un paio di ore al giorno...L’inviterei volentieri...” L’invito dell’amico birmano mi ha inseguito per mesi, poi finalmente mi ha raggiunto. Nel posto più insospettabile: in America – che con la Birmania ha proprio poco da spartire- dove mi trovavo in vacanza. In riva a un placido lago al confine tra USA e Canada, stavo trascorrendo una settimana di assoluto riposo, vale a dire non pressato da urgenze turistiche, da smania di visitare questo e quello, di ammassare quanto più possibile di ciò che mi circonda. Stavo inoltre leggendo un libro insopportabilmente noioso, ma dotato di un aspetto positivo: illustrava le elucubrazioni dell’autore - una persona egocentrica, insofferente, ipercritica, ripetitiva, insomma, ben poco attraente per i miei gusti - su fatti e circostanze della sua vita, obiettivamente poco significanti. Ma proprio questa sua capacità di scavare su cose da poco mi sembrava apprezzabile, mi induceva a tentare l’operazione anche su me stesso. E così, proprio nella terra ritenuta (secondo me a torto) come la quintessenza della supertecnologia, del nuovo a tutti i costi, della fretta, della competitività, ho iniziato a meditare. Non a inseguire qualche pensiero astratto, a sviluppare fantasie. No, proprio a meditare (benché per molto meno tempo che per un paio di ore al giorno). Ho incominciato a guardare la mia vita come ho tante volte osservato la mia casa, la mia città dall’alto di un monte, come ho osservato Mingun e Mandalay dall’alto della paya diroccata. Il solo modo per avere una visione d’insieme. Più reale, perché più distaccata. Vedo i particolari, so che mi appartengono - quella è la mia casa, quella è la mia città - però ne sono lontanissimo. E’ stato solo un inizio. Con quali risultati? Beh, questa è un’altra storia.
Scaricare