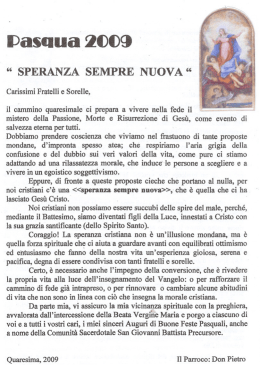XIV INCONTRO ESTIVO PER SEMINARISTI IL PRETE UOMO DELLA Andrea Pisano, La Speranza. Firenze, Battistero. SPERANZA Fraterna Domus - Sacrofano (Roma) 6 - 12 agosto 2006 PRESENTAZIONE Dal 6 al 12 agosto 2006 un nutrito gruppo di seminaristi maggiori si è dato appuntamento a Sacrofano, presso la Fraterna Domus, per partecipare al XIV Incontro Estivo per Seminaristi sul tema Il prete, uomo della Speranza. I partecipanti all’Incontro provenivano da varie regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ad essi si sono aggiunti anche seminaristi provenienti da altri paesi come Brasile, Croazia e Russia. Agli interventi, affidati a vescovi ed educatori dei seminari diocesani, si è affiancato il contributo di esperienze e di riflessione dei seminaristi. Le occasioni di approfondimento teologico e pastorale si sono intrecciate con momenti di preghiera, di convivenza fraterna e con visite guidate a monumenti significativi della storia religiosa e artistica di Roma. Momenti particolarmente significativi dell’esperienza vissuta sono stati la partecipazione all’Udienza Generale con S.S. Benedetto XVI, che ha avuto per i partecipanti all’Incontro espressioni di apprezzamento e incoraggiamento, la Concelebrazione Eucaristica nella Basilica di S. Pietro, all’altare della Cattedra, presieduta da S. E. Mons. Angelo Comastri, vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano e l'intensa preghiera, da Lui guidata dopo la Messa, sulla tomba del Servo di Dio Giovanni Paolo II. L’ Incontro di Sacrofano è stato organizzato da Iniziative Culturali Sacerdotali che nasce dal comune impegno di sacerdoti della Prelatura dell’Opus Dei e di altri sacerdoti di varie Diocesi italiane con il progetto di promuovere incontri di studio e di aggiornamento pastorale, occasioni di fraternità sacerdotale e corsi di spiritualità per sacerdoti diocesani. * * * Poche settimane dopo la partecipazione all’Incontro di Sacrofano, del quale ha curato la Prolusione di apertura dei lavori, il Signore ha chiamato a sé mons. Cataldo Naro. Esprimiamo un particolare sentimento di gratitudine per la cordialità e la disponibilità che manifestò nell’intera giornata che passò con noi a Sacrofano. Ne ricordiamo con stima e affetto la testimonianza di zelo per la Chiesa, la vicinanza umana del pastore e l'acutezza dello studioso. Ripensiamo ai suggerimenti che ci ha offerto nel suo intervento e trasformiamo la gratitudine per quanto ci ha donato in quell’occasione in preghiere per la sua eterna gioia e in richiesta di continuare a sostenere la nostra iniziativa al servizio dei seminaristi italiani con la sua preghiera ora particolarmente efficace. 1 “Domande acute sorgono dai mutati scenari sociali e culturali in Italia, in Europa e nel mondo, e ancor più dalle profonde trasformazioni riguardanti la condizione e la realtà stessa dell’uomo. Nel tramonto di un’epoca segnata da forti conflittualità ideologiche, emerge un quadro culturale e antropologico inedito, segnato da forti ambivalenze e da un’esperienza frammentata e dispersa. Nulla appare veramente stabile, solido, definitivo. Privi di radici, rischiamo di smarrire anche il futuro” (Traccia di riflessione in preparazione al Convegno Ecclesiale di Verona, 16 – 20 ottobre 2006, n. 1). In questo contesto culturale, la persona umana viene a sentirsi sempre più imprigionata tra le false attese di una pretesa pienezza di vita create dal progresso scientifico e tecnologico e il disorientamento, il vuoto, nel quale vengono a scoprirsi le sue aspirazioni più profonde - alla verità, alla bellezza, all’amore - sotto la spinta del nichilismo in cui versa la concezione dominante della persona umana. “Oggi che le promesse della libertà illimitata sono state gustate completamente, incominciamo a comprendere di nuovo l’espressione «mestizia di questo mondo » (…) Così oggi vediamo, spesso proprio sul volto dei giovani, una strana amarezza, una rassegnazione, assai lontana dallo slancio della spinta giovanile verso l’ignoto. La radice più profonda di questa tristezza è la mancanza della grande speranza e l’irraggiungibilità del grande amore” (J. Ratzinger, Guardare Cristo, Jaca Book 1989, pp. 59-60). La Chiesa Italiana, analizzando le attuali condizioni del contesto socio-culturale del nostro paese, vi ha colto l’urgente bisogno di far brillare - con particolare forza e nuovo slancio - la testimonianza della Speranza cristiana. Con il Convegno Ecclesiale di Verona, che si svolgerà nell’ottobre prossimo, essa intende suscitare tra i suoi fedeli un grande risveglio che li porti ad essere autentici testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo. Nel fermento di riflessioni che si stanno sviluppando in questi mesi per preparare le giornate di Verona, ci è sembrato particolarmente significativo e attraente, in una iniziativa che viene proposta ai seminaristi, futuri sacerdoti di questa Chiesa, poter mettere a fuoco quale deve essere la figura del presbitero, uomo della Speranza, primo testimone di Gesù Risorto, speranza del mondo e primo “comunicatore” della Speranza tra i battezzati e presso tutti gli uomini. Infatti l’auspicato risveglio di una testimonianza viva della Speranza cristiana da parte dei fedeli laici in tutti gli ambiti della nostra società non può che essere promosso attraverso la testimonianza dei presbiteri che alimentano, sostengono e orientano con la loro vita e il loro ministero la testimonianza dei fedeli loro affidati. “«È tempo di speranza mi dici, e vivo di questo tesoro. Non è una bella frase, Padre, è una realtà». Allora..., il mondo intero, tutti i valori umani che ti attraggono con una forza enorme - amicizia, arte, scienza, filosofia, teologia, sport, natura, cultura, anime...- , tutto questo riponilo nella speranza: nella speranza di Cristo”(Josemaría Escrivá, Solco n. 293). 2 Indice Prolusione I Relazione II Relazione Il prete uomo della speranza S.E. Mons. Cataldo Naro Arcivescovo di Monreale pag. 4 La spiritualità del prete, uomo della speranza S.E. Mons. Luciano Monari Vescovo di Piacenza - Vicepresidente della CEI pag. 19 Il contributo della formazione seminaristica nella maturazione della speranza don Romano Martinelli Seminario Arcivescovile di Milano III Relazione pag. 34 Il prete seminatore della speranza nella vita dei fedeli laici S.E. Mons. Agostino Superbo Arcivescovo di Potenza Conclusioni finali dei partecipanti pag. 44 pag. 53 3 Prolusione Il prete, uomo della speranza S. E. Mons. Cataldo Naro (*) O è piuttosto una pagina di pastorale, cioè di indicazione circa la prassi pastorale, con indicazioni anche concrete? Di che cosa si tratta in queste pagine? Ora la leggo, il titolo è: “Il prete, uomo della speranza” e la soluzione che dà l’autore, all’interno di tutta la sua trattazione, è che il sacerdote può essere uomo di speranza e portatore di speranza solo se è uomo di fede: se ha una buona relazione con il Signore Gesù. Questo modo di esprimersi, buona relazione con il Signore, lo trovate abbondantemente presente nel documento che sta guidando la Chiesa italiana verso Verona. Se voi avete un po’ di familiarità con i testi degli autori milanesi, ci si accorge subito che questo testo è molto presente nella Chiesa di Milano e nei discorsi che si fanno a Milano, nella facoltà teologica: questa dizione “buona relazione con il Signore Gesù” deriva da quella esperienza. Niente di male; è normale, in genere, quando si sceglie di fare un testo simile - che non è dell’episcopato, non è della Conferenza episcopale italiana: è di una commissione che prepara il Convegno di Verona - si incarica un teologo, in genere della Chiesa italiana, che fornisce il canovaccio di base e poi ci sono vari interventi; ma il canovaccio di base resta. Questa volta come voi sapete è stato incaricato di redigere questo canovaccio don Franco Brambilla, della Facoltà teologica di Milano e quindi si capisce. Così come un’altra volta, per un altro Convegno, fu incaricato don Coda e quindi dice molto della spiritualità focolarina, di Chiara Lubich. Quando si farà la storia, tra cento anni, emergeranno queste cose e tanto vale dirlo con chiarezza. Per questo la lettura del testo di don Pagani si ricollega in profondità con questo testo che sta guidando la Chiesa italiana verso Verona. Tenere la prolusione di un corso, per chi ne è incaricato, presenta dei vantaggi e degli svantaggi. Il vantaggio è quello di non dovere dire tutto poiché prolusione significa fornire delle chiavi di lettura che permettono di interpretare la tematica complessiva. Credo che sia questo il compito di chi tiene la prolusione. E sotto questo aspetto si tratta di un vantaggio. Lo svantaggio, direi, è che bisognerebbe conoscere quello che verrà detto dopo, quale impostazione viene data al corso, in maniera tale da poter fornire appunto delle chiavi di lettura. Chi inizia il corso ed è incaricato di tenere la prolusione, ma non conosce lo sviluppo che seguirà, certo si trova svantaggiato. C’è il rischio di fornire chiavi per un discorso che non sarà condotto. Probabilmente non si tratta così in questa occasione: la tematica è quella della Chiesa italiana, del convegno che si tiene ogni dieci anni per tutta la Chiesa italiana e quindi siccome c’è stato un dibattito in tutta la Chiesa italiana credo che la tematica sia abbastanza dissodata e le vie e i percorsi del discorso siano noti. In qualche modo ho sentito parlare mons. Monari alla CEI e penso di sapere, sostanzialmente, quello che potrà dire. Forse lo svantaggio può essere recuperato. Vorrei partire da una pagina di un libro di don Severino Pagani, un sacerdote della Diocesi di Milano, che ha avuto - e credo abbia ancora responsabilità educative nel Seminario maggiore di Milano. Il libro è intitolato così: “Fra Gesù e la gente: il prete, uomo per questo tempo”. Un capitoletto è dedicato al prete come uomo della speranza: il nostro tema. Vorrei leggere non tutto il capitoletto, ma solo l’incipit e porre una domanda. Anzi la domanda ve la pongo prima: è una pagina di spiritualità sacerdotale? Cioè, invita a vivere in una dimensione spirituale l’esercizio del ministero? (*) Trascrizione della registrazione dell’intervento e del dibattito, non rivista dall’Autore 4 dimensione spirituale mi pare prevalente, ci sono indicazioni pastorali ma molto generali, non si dice come organizzare una parrocchia; una metodologia di ordine pastorale non c’è. Ora se voi ci fate caso come parecchi documenti per il clero o, in genere, per la Chiesa italiana, lo stesso documento che ci guida per Verona e un testo prevalentemente di ordine spirituale, non pastorale. Infatti vi si dice in che cosa consiste la speranza cristiana: è la speranza del Signore, il Risorto, che vince il male del mondo, e spiega come si fa ad essere testimoni del Signore risorto. Alla fine ci sono delle indicazioni per così dire pastorali, i cinque ambiti, ma sono ambiti indicati a mo’ di esempio e la soluzione di ordine pastorale viene indicata in questi termini: si tratta di investire della speranza cristiana questi ambiti. Cioè il cristiano nella fragilità testimonia la forza che viene dal Risorto, nel lavoro la presenza del Signore e similmente negli altri ambiti. Sono indicazioni pastorali sì, ma il taglio è chiaramente spirituale. La domanda che ci dobbiamo fare è questa: se l’analisi è giusta. Poi potrete parlare e dire la vostra. Dunque a me sembra che prevalentemente questa pagina di Pagani, come l’intero testo del documento per Verona, è di tipo spirituale. Ora la domanda successiva che dobbiamo porci è questa: non è un limite? Che cosa si aspetta la Chiesa italiana, le nostre comunità, i sacerdoti, i seminaristi ? Chi opera nella Chiesa italiana che cosa si aspetta? Indicazioni di ordine pastorale pratico, come risolvere i problemi che ci angustiano, le difficoltà, oppure delle indicazioni un po’ aeree, spirituali appunto? Io ho trovato delle assemblee nelle quali si diceva: “ma insomma, i vescovi non danno delle indicazioni precise, vorremmo sapere cosa fare per risolvere le questioni …..”. Forse perché non si sanno trovare queste indicazioni, è difficile trovarle, allora ci si rifugia nella un po’ vaga tematica spirituale? Stanno così le cose? Questa è la domanda da farsi. Per rispondere a questo, applicando il tutto al tema di questo convegno “Il sacerdote, uomo della speranza”, vorrei proporvi una distinzione che aiuta a capire la figura del sacerdote nei suoi vari aspetti. Bisogna distinguere e considerare almeno tre livelli dell’esperienza del sacerdote o della figura del sacerdote. C’è un livello che direi di ordine dogmatico: è la dottrina sul sacerdozio, quale è stata fissata dal Concilio di Trento. C’è una dimensione spirituale, nel senso forte, nel senso di riferimento allo spirito del Cristo che vive Don Pagani dice così: “Il prete, uomo di fede, capace di speranza, per l’uomo, per la Chiesa e per il mondo. Non la speranza ingenua, ma la speranza di chi sa che esistono le difficoltà, che occorre misurare i tempi e calcolare i passaggi difficili; sa che il dolore è reale, sa parlare con sapienza, sa consigliare, sa tacere. Proprio attraverso questi linguaggi il prete è capace di speranza; anche quando gli altri sono disorientati, scoraggiati, scontenti conosce le misure estreme dell’amore che vanno fino alla Croce, per cui sa che può sempre amare un po’ di più, anche se gli sembra di avere già amato tanto e che fede, carità e speranza sono le esperienze fondamentali dell’esistenza cristiana. Un prete capace di infondere speranza è una grazia per la sua comunità: sarà la speranza di fronte ai disaccordi della comunità, alle polemiche, a un peccatore davvero pentito che fa fatica a credere realmente al perdono di Dio. Il prete è capace di infondere speranza all’uomo e alla Chiesa, alle comunità cristiane con le loro contraddizioni, con i loro piccoli o grandi scandali, con il peso delle situazioni che non funzionano e delle istituzioni difficili da gestire. In tutti questi contesti il prete dà speranza all’uomo, alla Chiesa e al mondo; in quanto tale ama anche i non credenti, ama anche coloro che non lo cercano. Il prete è un uomo di fede, responsabile della fede degli altri. Mentre altri uomini si preoccuperanno dei fratelli sotto diversi aspetti, il prete avrà sempre una particolare sensibilità che lo porta a sentirsi responsabile della loro fede, della loro preghiera, della loro vicinanza a Gesù. Si preoccuperà che siano in grazia di Dio, che abbiano l’intuizione del senso del peccato, della richiesta di perdono, della loro appartenenza alla Chiesa, della loro capacità di carità. Vivendo più di ogni altro la responsabilità per i fratelli, il prete li ama ed è in pace con sé stesso quando sa che sono vicini a Gesù”. Questa la pagina di Pagani. Prima di entrare dentro la pagina, perché ce ne sarà modo durante tutta la conversazione, la domanda – ripeto – è: “si tratta di una pagina di spiritualità o di un insieme di indicazioni pastorali?” Da un lato ci sono indicazioni pastorali: “ è colui che sa parlare, sa consigliare, sa tacere...”, ma ci sono anche, chiaramente, indicazioni spirituali: “ lui che vive un rapporto con il Signore, che ha una fede viva, e che si fa carico della fede degli altri”. Che cos’è questa pagina? Nel suo insieme, prevalentemente, per lo meno. Non so cosa rispondere. Certo la 5 Uno storico– si chiama Erba – ha scritto un bellissimo libro sull’esperienza dei preti sociali del Piemonte e l’ha intitolato “Preti del Sacramento, preti del movimento”. Ci sarebbero stati dei sacerdoti che continuavano ad esercitare il loro ministero tradizionalmente inteso come predicazione, amministrazione dei sacramenti, catechesi e così via, mentre c’erano altri preti “preti del movimento” che organizzavano casse rurali, partiti politici comunali, poi nazionali e così via. E non solo in Italia questo, ma in tutta Europa. Come valutarla dal punto di vista della storia della Chiesa, come giudizio secondo l’idea che la Chiesa ha del ministero presbiterale? Ho elaborato questa distinzione per capire proprio come questi preti sociali potevano vivere il loro ministero. Prima di tutto c’è la dimensione dottrinale: a Trento si stabilì che il sacerdote, colui che guida la comunità e celebra l’Eucaristia, è abilitato a tale esercizio in forza di una configurazione sacramentale a Cristo Pastore. Ed è una configurazione che non si lascia ridurre alla configurazione che il cristiano riceve nel Battesimo, ma è speciale. Ed è in funzione dell’Eucaristia e della guida del Corpo di Cristo che è la Chiesa. Questi preti avevano un’idea diversa? Ad esempio: pensavano il prete in funzione della realizzazione sociale dei valori evangelici, che so, un po’ nella linea della teologia della liberazione? Leggendo don Sturzo e tutti gli altri è chiaro che non avevano questa idea. Avevano un’idea che rimaneva ancorata saldamente al dato tridentino. Questo è un primo aspetto: quando si giudica e si valuta la figura del prete questo è un primo aspetto: l’ancoramento o meno alla dottrina di Trento. Ma c’è un secondo aspetto che è quello della dimensione spirituale - nel senso stretto del termine, come ho detto poco fa - cioè del rapporto di riferimento allo Spirito del Cristo che agisce nell’uomo e lo plasma. Ora, questi sacerdoti – faccio l’esempio storico per capirci meglio - come vivevano questa dimensione di riferimento allo Spirito del Cristo? E’ una dimensione che ha a che fare sempre con qualcosa di nuovo. Il cristiano viene plasmato dallo Spirito del Cristo e nella storia questo ha degli aspetti di novità, e si traduce in una capacità di attrazione. Quali sono le figure spiritualmente eminenti nella Chiesa? Sono i santi, coloro cioè che sono plasmati in una maniera tale che diventano esemplari per altri, capaci di suscitare attrazione. Quando si parla di spiritualità più o meno sacerdotale io sono sempre un po’ diffidente, nel il credente; non di spirituale, nel senso di interiore, semplicemente intimo e così via, ma azione dello Spirito di Dio sull’uomo. E c’è una terza dimensione che è quella pastorale, delle modalità cioè dell’esercizio del ministero. Mi sono trovato ad elaborare questa distinzione che non è ovviamente da intendere in maniera molto schematica, le tre dimensioni sono in correlazione l’una con l’altra, una non può stare senza l’altra - allorché per il lavoro che facevo prima di essere vescovo, nell’insegnamento della storia, dovevo spiegare l’esperienza dei preti cosiddetti sociali tra l‘800 e il 900: la figura di Sturzo per esempio, ma non solo. In tutta Italia e in tutta Europa ci furono preti che si dedicarono prevalentemente all’esercizio di attività che oggi diremmo politico-sociali - anche allora si chiamavano così - non strettamente ministeriali: non la catechesi, la predicazione, ecc. Sturzo, ad esempio, la figura in Italia più emblematica, decise, giovanissimo prete, allorché fu eletto per la prima volta pro-sindaco a Caltagirone, di non confessare e non confessò più per tutta la sua vita, perché riteneva che se la gente si andava a confessare qualcosa che aveva a che fare con l’amministrazione pubblica lui sarebbe rimasto come impedito di esercitare il suo ruolo di sindaco. Allora preferì non confessare, non predicò più, mentre all’inizio del sacerdozio si era distinto anche come oratore sacro; lo chiamavano in vari posti per delle novene, un pellegrinaggio: allora si usava così. Poi, lui non usò più predicare. E però intendeva l’esercizio dell’attività politico-sociale come una naturale e spontanea espansione del suo ministero sacerdotale; si ritenne sempre prete, anche con un qualche dramma interiore. Pensate, nel giorno in cui - 18 gennaio 1918 - fu emanato il famoso proclama “Liberi e forti”, la fondazione del Partito Popolare, abbiamo la testimonianza che dopo il proclama, lanciato dall’albergo Santa Chiara vicino a Santa Maria sopra Minerva a Roma, una ventina di persone lui solo era prete gli altri erano laici – si spostarono di sera nella Chiesa dei Dodici Apostoli, che era aperta anche di sera e fecero mezz’ora di adorazione. Don Luigi Sturzo per tutto il tempo pianse e all’uscita gli domandarono: “Don Luigi, ma perché ha pianto tutto il tempo? Ha fondato una cosa bella, con grandi speranze per l’Italia”. “Ho pianto il mio sacerdozio!”. Ecco mi sono trovato di fronte al problema storiografico di come valutare l’esperienza di preti come don Sturzo, come don Murri e tanti altri di quel tempo. 6 predicatori itineranti, le missioni popolari, che non erano tenute solo da sacerdoti religiosi cappuccini, gesuiti, ecc. - ma prevalentemente da sacerdoti diocesani. Una pluralità di forme nell’esercizio del ministero. Poi c’è stata come una concentrazione di queste forme dell’esercizio tipicamente ministeriale, perché? Cerco di spiegare questo fatto di una certa riduzione dell’esercizio del ministero alla forma più strettamente catechetico-sacramentale. Risponderò ora a questa domanda, ma prima vi faccio un’altra domanda: sulla distinzione dei piani. Perché questo documento sulla speranza? Perché la Chiesa italiana ha scelto questo tema per Verona? (Le cose che ho detto finora sono premesse per il seguito del discorso). Perché è stato scelto questo tema? Ciascuno di voi sicuramente avrà un’idea. Se avete letto il documento ci sono delle risposte nel documento stesso. Ad esempio c’è una pagina in cui si dice “Abbiamo trattato della fede inizialmente, nei primi due Convegni nazionali ecclesiali”, cioè Roma, il primo, nel 75-76 su “Evangelizzazione e promozione umana”; nel decennio che seguì fu scelta come tematica della Chiesa italiana “Evangelizzazione e sacramenti”; si è trattato della fede anche a Loreto: il tema fu “Il Vangelo della riconciliazione”. Poi a Palermo si è trattato della carità, “Il Vangelo della carità”: rimaneva da trattare la speranza. E quindi abbiamo completato la trilogia. All’inizio si dice che siccome nell’Italia attuale c’è la perdita del senso della speranza – non si vede un futuro percorribile – allora da parte della Chiesa sembra che si richieda una testimonianza speciale, particolare, sul tema della speranza. E questa è una risposta. Ma c’è un’altra risposta nascosta tra le pieghe di un numero che a me sembra indicativo, il numero 13. Si dice così: “Proprio attraverso la lettura dei segni dei tempi, che nei 40 anni del dopo-Concilio è stata un’attenzione viva della nostra Chiesa, si è cercato di superare la separazione tra coscienza cristiana e cultura moderna, favorendo un più stretto rapporto tra evangelizzazione e promozione umana, praticando il discernimento comunitario - questo fu il tema proposto a Loreto dalla relazione del Cardinal Martini che ha fatto entrare nella Chiesa italiana questa categoria del discernimento che, da personale e individuale quale era nella tradizione dell’Occidente, è passato ad essere un discernimento pastorale e storico; ed è significativo che sia stato un cardinale gesuita, con la tradizione gesuitica della discretio spirituum, a senso che storicamente, sul piano dei fatti, la spiritualità ha sempre a che fare con personalità spirituali eminenti, che riescono ad attrarre al loro seguito preti o laici, indipendentemente dalla loro condizione. Per esempio Josemaría Escrivá è prete, ma attira anche i laici. Chiara Lubich è laica, ma ci sono dei preti che vivono la spiritualità focolarina. Vedete come c’è l’emergere dello spirito appunto: una personalità che viene resa attraente perché realizza il rapporto con Cristo – attraverso il suo Spirito – in una maniera eccezionale. Ora questi preti tra l’800 e il 900, spiritualmente, a chi erano ancorati? Ai preti della controriforma: a Sant’Ignazio, a San Francesco di Sales, e soprattutto, per l’Italia, a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Era la spiritualità di questi santi, in una maniera anche un po’ a sintesi, ma era questa. Poi si potrebbero fare esempi anche per l’oggi: quanti di voi si stanno muovendo seguendo questa o quell’altra spiritualità. Questo, certo, è un livello, ma non è il tutto dell’esperienza sacerdotale. Poi c’è il terzo livello, quello appunto dell’esperienza pastorale: delle modalità concrete dell’esercizio del ministero. Io direi così: la dottrina resta immutabile – il primo livello - , il secondo livello dipende dall’incontro con una personalità spirituale più o meno eminente oppure dall’incontro con gli scritti di quella personalità, se è una personalità del passato. A meno che non sia il sacerdote stesso una personalità spiritualmente eminente e che porta a creare qualcosa di nuovo. Il terzo livello è quello più soggetto ai cambiamenti storici, ogni epoca ha delle esigenze e l’esercizio del ministero non può non confrontarsi con queste esigenze. E sono esigenze della trasmissione della fede, compito proprio della Chiesa, ma sono esigenze anche che derivano dalla volontà di Dio per quel tempo, quelle persone, quell’ ambiente; cioè sono modalità pastorali che esigono il discernimento, discernimento cristiano della storia lo chiamerei, e quindi cambiano. Per esempio prendiamo tutto il periodo della Controriforma: 500-600-700. Se vi domandassi: “sul piano storico la figura di esercizio ministeriale - quindi sul piano pastorale - prevalente qual era?” Quella del parroco, per esempio? No. La figura del parroco, come figura dominante e prevalente nell’esercizio del ministero è tipicamente novecentesca. Nel 600700 c’era una pluralità di forme di esercizio del ministero che per noi nel 900 sembra straordinaria. C’erano preti che per tutta la vita facevano i medici, i precettori di bambini delle famiglie aristocratiche; c’erano i parroci, ma pochi in confronto a quelli del nostro tempo. C’erano i 7 della separazione tra Chiesa e mondo moderno, c’è una diversità?” Io credo di sì, che c’è. Per esempio, se ritorniamo all’esperienza dei preti sociali, Sturzo e tutti gli altri, come pensavano di risolvere questa separazione e di superarla? Perché anche per loro si poneva lo stesso problema. Pensavano di risolverlo – allora si diceva – attraverso la conquista cristiana del mondo moderno. Si pensava cioè di poter ricondurre a Cristo e alla Chiesa il mondo moderno. E come? Alcuni pensavano secondo un ritorno a forme cristiane di organizzazione della stessa società precedenti la rivoluzione francese; altri, attraverso un adattamento. Ma comunque il superamento avveniva attraverso la creazione di forme del mondo moderno che però si potevano dire cristiane. Le Casse rurali, il partito politico per conquistare la società e fare leggi cristiane in maniera da dare un assetto cristiano alla società. Tutto questo certamente c’era nel movimento cattolico o nello sforzo che partì da Leone XIII, il progetto cosiddetto leoniano di riconquista della società alla Chiesa. C’era tutto questo. E allora, rispetto all’impostazione attuale, c’è una qualche diversità? Si. La diversità è data – da quello che capisco io - da una autocritica che nella Chiesa stessa si sta elaborando circa gli scarsi risultati di un impegno di riconquista del mondo moderno al cristianesimo. Il problema è rimasto, di fatto. Le percentuali si sono abbassate, il problema rimane. Il che significa che i cristiani misurandosi e mettendo in atto strategie diverse riflettono anche su questa esperienza e quindi elaborano una critica delle forme stesse messe in atto di riconquista del mondo moderno. Vorrei qui citare una pagina, secondo me straordinaria, di Mario Sturzo, fratello di don Luigi Sturzo e Vescovo di Piazza Armerina nel 1930 o 31. Scrisse una lettera, nel 1930, al fratello Luigi che era in esilio in America, ricordando la Rerum Novarum: erano passati 40 anni dalla Rerum Novarum. In questa lettera il vescovo fa un esame autocritico: “tutto quello che abbiamo fatto in rispondenza dell’Enciclica Rerum Novarum, creare Casse Rurali, cooperative, organizzazioni cattoliche di base e poi tentare addirittura la conquista del potere politico, dello Stato, è stata una buona cosa? Ha prodotto risultati?” Questa la domanda che si faceva il Vescovo. Guardate che cosa egli stesso rispondeva:“Leone XIII ebbe veramente teorie proprie, fu veramente innovatore? Ecco il punto. Allora pensavamo così. Era la poesia e l’azione. fare questo passaggio - e accogliendo le istanze del progetto culturale orientato in senso cristiano in connessione con l’urgenza della nuova evangelizzazione”. Si dice che in questi 40 anni dopo il Concilio - e questo è il 4° Convegno nazionale - si è cercato di superare la separazione tra coscienza cristiana e cultura moderna. Io credo che la chiave per intendere la scelta del tema della speranza sia proprio questa: si è cercato di superare la separazione tra coscienza cristiana e cultura moderna. Che cosa significa di fatto? Significa che viene considerato come dramma della presenza della Chiesa nel mondo moderno la distanza, la separazione, dice addirittura il testo, tra la Chiesa, l’esperienza dei cristiani e le forme della vita sociale moderna, della vita culturale moderna. Senza dubbio si è creato uno iato dopo la rivoluzione francese: bisogna superarlo, questo è il problema. E bisogna stare attenti anche alle parole. Non si dice separazione tra le forme dell’esperienza cristiana e le forme della vita moderna. Si dice separazione tra la coscienza cristiana e le forme della vita sociale-culturale. In altri termini già si dà una soluzione. Finché si parla di contrapposizione tra forme diverse è chiaro che l’unica possibilità di una soluzione del problema e di un superamento della separazione è quella che o le forme del mondo moderno conquistano quelle della vita credente, oppure avvenga il contrario. Qui invece si parla di coscienza, il che significa che ci può essere una coscienza credente che si misura con le forme della vita moderna. E già c’è una identificazione di soluzione del problema. Ma se il problema è questo, e in questi 40 anni dopo il Concilio il problema è stato questo, si può dire che prima di questi convegni e prima del Concilio, nella Chiesa italiana o tout court nella Chiesa intera, non si è avvertito questo problema della separazione tra coscienza credente e forme della vita moderna? Ho detto prima che no: che fin da dopo la rivoluzione francese c’è stato. E quindi certamente bisogna iscrivere questo testo e la scelta del testo e i Convegni stessi della Chiesa italiana nell’arco più vasto, nella parabola più grande, del rapporto della Chiesa con il mondo moderno. Io credo che qui bisogna portare il discorso, a questo livello. E se lo portiamo a questo livello, la domanda che possiamo farci è: “Tra questi 40 anni e questo convegno di Verona, in rapporto a ciò che avveniva prima del Concilio, al modo cioè con cui si affrontava lo stesso problema del superamento 8 Il vescovo – non so se conoscete la vicenda di Mario Sturzo – si impegnò ad elaborare un nuovo sistema filosofico che si confrontasse arditamente con le filosofie moderne, cioè con l’idealismo e chiamò questo suo sistema neo-sincretismo. Pur di elaborare e scrivere libri smise praticamente di fare il vescovo, anche le cresime: faceva il vescovo della diocesi più vicina che era Caltanissetta. Ma la conclusione fu triste. Si era messo a scrivere di filosofia a 60 anni e la Santa Sede, nel 1933 mi pare, lo condannò e mise la censura sui suoi libri di filosofia. Egli però diede un esempio grande di obbedienza. Apprese dall’Osservatore Romano ciò che era avvenuto e quella stessa mattina scese in seminario chiamò i seminaristi e in cappella disse: “Il vostro vescovo è stato condannato per le cose che ha scritto di filosofia, da oggi in poi non scriverà più di filosofia”. Aldilà degli aspetti tristi, questa vicenda dice di una sensibilità che andava oltre la speranza che nutriva Luigi Sturzo, cioè che attraverso l’impegno politico e sociale si potesse riconquistare la società alla Chiesa. Dice di una finezza maggiore: il problema era molto più complesso, questo voglio dire. C’è stato nel percorso della Chiesa italiana, o della Chiesa tutta, un filone di autocritica circa le forme che sono state messe storicamente in atto appunto per superare la distanza tra Chiesa e mondo moderno. Questo filone critico sfocia appunto, dopo il Concilio, nei quattro problemi della Chiesa italiana. C’è qualcosa che unisce questi quattro problemi: la promozione umana, la riconciliazione, la carità e la speranza? E’ il Vangelo. Evangelizzazione e promozione umana, il Vangelo della riconciliazione, il Vangelo della carità e il Vangelo della speranza! A me pare evidente che è maturata nella Chiesa italiana questa consapevolezza: che si deve superare lo scarto che c’è tra Chiesa e mondo moderno e che questo scarto non può essere superato se si presuppone che la Chiesa già è quella che è, strutturata per benino, e quindi si tratterebbe semplicemente di confrontarsi con le forme ….. o che lo si superi attraverso – e sarebbe la cosa peggiore, che è stata pure elaborata - un appiattimento delle forme della vita sociale moderna e della cultura moderna. Il primo problema è quello di superare lo scarto tra la Chiesa e il Vangelo. Cioè una Chiesa sempre più fedele al Vangelo, una Chiesa che riesce ad essere testimone della speranza del Risorto è l’unica Chiesa che solamente può superare la separazione tra la Chiesa e il mondo moderno. Ora io penso un po’ diversamente. Leone fu un gran Papa, comprese il momento, uscì dal vicolo chiuso della politica del Card. Antonelli - che fu il Segretario di Stato di Pio IX –, ma non fu un innovatore o un conservatore. Le sue Encicliche, che sono certo mirabili, nulla dicono di nuovo. La Rerum Novarum e la Gravis de communi hanno del coraggio, ma molto contenuto; affermano quel che palpitava nella società, ma non prevengono il tempo, né antivedono”. Un giudizio durissimo come voi vedete. Certo si scrivevano da fratello a fratello, era riservata la corrispondenza; tuttavia il giudizio è pesante. Il fratello infatti risponde dicendo che no, che non condivide questo giudizio. Perché questo giudizio così negativo di Mario Sturzo su Leone XIII? Perché secondo lui il problema del rapporto della Chiesa con in mondo moderno non si poteva porre a livello di una riconquista delle strutture della società. Il problema vero era il rapporto con il pensiero del mondo moderno, con la filosofia moderna. Diceva questo Vescovo: che vale che noi sottraiamo i figli del popolo, contadini, artigiani a un controllo delle autorità statali massoniche e poi, di fatto, se questi ragazzi vanno al liceo e poi all’università, vengono imbevuti di teorie anticristiane e perdono la fede? Bisogna misurarsi con la speculazione filosofica del pensiero moderno che è anticristiano: è a quel livello che si deve porre il problema. Guardate che cosa aveva già scritto nel ’25 al fratello: “Mi pento di non essermi consacrato prima alla filosofia; vedo, non dico la sua importanza in sé considerata, ma la necessità di trattazioni vive di attualità, perché - dicasi quel che si vuole - è proprio la filosofia che mena il mondo. E per nostra vergogna la filosofia che da secoli mena , agita, sconvolge e riordina il mondo non è nostra. La nostra s’è beata, e ciò non deve, contenta di stare in chiuse stanze come stanno le mummie nei musei archeologici.” Proprio la scolastica. In altre parti delle sue lettere polemizza aspramente, diventa ironico; per esempio scrive una volta al fratello: “La civiltà cattolica recensendo un opuscolo fa delle riserve per una frase dell’autore che suonava riconoscenza del contributo recato alla cultura moderna dagli idealisti nostri - Gentile, Croce,ecc.Così la civiltà cattolica ha salvato la fede”: ironia pesante. Questa è ancora più bella: “Il congresso tomistico di Roma ha concluso i suoi lavori deliberando un’edizione comparativa della Summa Teologica e di non volere dalle opere degli avversari nessun contributo nemmeno di critica. Va pensiero sull’ali dorate! “. 9 concretamente che ogni azione pastorale del presbitero da un lato esige la santità, ma nello stesso tempo produce la santità: la santità del ministro stesso che compie quelle azioni e quella delle persone a cui si indirizza. Il che significa prima di tutto il rapporto col Signore Gesù, con lo spirito del Signore Gesù e poi l’attività pastorale. Su questo il documento è molto chiaro. Però attraverso questa formula della carità pastorale emerge evidente una preoccupazione: la preoccupazione che è detta chiaramente nel documento è quella dell’unità dell’esperienza di vita del sacerdote: l’unità. Che cosa può produrre questa unità? Faccio tante cose, prego, faccio direzione spirituale, poi faccio quello, quell’altro…... Che cosa provoca l’unità? Chi può produrre questa unità? Solo la dimensione spirituale. Vedete, dunque, come di fatto avviene una sorta di riduzione della dimensione pastorale che prima era in qualche modo prevalente, su cui si appoggiavano tutte le speranze, al piano spirituale. Pur senza cessare la distinzione. Detto questo vorrei concludere con una domanda e una riflessione. La domanda è questa. Se è chiaro, il percorso – almeno secondo quello che ho cercato di dirvi – conduce alla scelta del tema della speranza e conduce difatti ad una accentuazione di una tematica spirituale a scapito della tematica pastorale: risponde tutto ciò all’esigenza del mondo a cui noi ci rivolgiamo? Questo testimoniare la speranza dell’uomo risponde alle esigenze della società attuale, della società italiana? Il documento si diffonde nel dirlo in una maniera eccezionale, solenne. Certo la risposta è questa, tanto che io ho cercato la risposta non nelle pagine iniziali – che poi si giustificano con la scelta del tema – ma in un elemento secondario. Quindi il documento lo dice certamente, però io credo che qui bisogna avere una certa finezza di interpretazione del reale, di ciò che ci circonda: l’assenza di speranza deriva dagli ultimi sviluppi della società contemporanea o c’è qualcosa nello sviluppo stesso della società contemporanea che porta ad una perdita della speranza? E che cos’è questa cosa? Secondo me, gli interpreti maggiori di una società e di una cultura non sono gli scienziati, ma sono i poeti, i letterati: riescono a cogliere, a dire. Ora, per esempio, qual è il più grande poeta italiano del 900 a cui possiamo andare per cogliere questa denuncia? Chi ha ricevuto il premio Nobel, oltre a Pirandello, è stato Montale: quindi si può dire Montale. Se voi la Solo superando lo scarto col Vangelo si può pensare di superare lo scarto tra coscienza credente e formule. Questa è la logica che sta sotto. A me pare fin troppo chiaro e fin troppo evidente. Per questo c’è stata come una graduale riduzione della tematica pastorale alla tematica spirituale. Non so se ora vi appare più chiaro. Questa è una convinzione che io ho maturato leggendo i testi, anche prima di essere vescovo, ma ora soprattutto partecipando, come è stato nel caso di questo testo, essendo vice-presidente del Comitato per Verona. Partecipando all’elaborazione del testo mi sono reso conto che la sensibilità dominante è appunto ora questa. Non si tratta di non avere ricette, ma si tratta invece di un’altra cosa: di avere la coscienza che non sono le ricette possibili, o quelle sperimentate nel passato, che possono risolvere il problema. Il che significa che si impone un rapporto del credente singolo, del singolo presbitero, della Chiesa tutta con il Signore Gesù. Un rapporto – ecco la buona relazione con il Signore, il termine che percorre queste pagine del documento per Verona - che sia la base di un’esperienza creativamente nuova del cristiano nel mondo moderno. Il problema resta quello. Questo che vi ho detto mi sembra un punto molto importante. Se poi leggete la Presbiterorum Ordinis – il documento del Vaticano II sulla vita dei sacerdoti anche qui si nota come una sorta di riduzione del piano pastorale al piano spirituale, senza tuttavia l’abolizione della distinzione dei piani, perché se si crea un corto circuito tra il piano dottrinale, il piano spirituale e il piano pastorale, ovviamente si blocca tutto. Quindi la distinzione va conservata, tuttavia c’è bisogno di una duttilità, di una creatività del rapporto tra i diversi piani; la pastorale è in rapporto al secolo e bisogna rinnovarla continuamente. Leggete in quel documento conciliare, per esempio, ciò che dice circa la carità pastorale, che è come la formula sintetica del documento. Che cosa vuole dire questa formula della carità pastorale? Che cos’è? E’ stata fraintesa molte volte, si intende forse che l’esercizio stesso del ministero è fonte della santità del sacerdote? O addirittura che per il fatto stesso - automaticamente - che si esercitano le attività proprie del ministero si diventa santi? Non è proprio questo: il documento parla di un esercizio pastorale della carità; il che significa che anche nell’esercizio della pastorale si tratta di vivere la carità che è lo spirito del Cristo. Si tratta di vivere con lo spirito del Cristo le attività pastorali e significa 10 conoscete un pochino, certo, la poesia di Montale è una poesia sconsolata, senza speranze. E’ vero quello che hanno detto i giornali: che sul letto di morte pare sia stato visitato dal Cardinal Martini e che, assieme al Cardinal Martini, abbia recitato poco prima di morire il Padre Nostro? Io non so se è vero, ma comunque la Grazia del Cristo può raggiungere l’uomo sempre, anche all’ultimo momento, è ovvio. Ma la sua produzione poetica certamente è la produzione di un uomo chiuso al trascendente, radicalmente chiuso ed io credo che in questa poesia possiamo trovare come l’espressione di una cultura, la cifra sintetica con cui occorre misurarsi. L’annuncio del Vangelo va fatto alle persone concrete, che sono immerse in una cultura e che vengono plasmate da quella cultura. Guai a non tenere conto di quella cultura, perché altrimenti non sappiamo nemmeno da quale lato cercare di entrare. Vorrei leggervi una poesia di Montale, anzi ve ne leggo due, che secondo me esprimono chiaramente questa chiusura al trascendente come affermazione dell’impossibilità per l’uomo di un incontro che gli dica qualcosa di più di quel che sa: è impossibile che l’uomo incontri qualcuno che gli dia una parola di salvezza; l’uomo è immerso nella storia, è prodotto dalla storia e non c’è via di uscita da quello. Certo, se questa idea diventa diffusa e diventa l’elemento che lega tutte le forze di una cultura, allora è chiaro che il Vangelo riesce con difficoltà ad essere letto. La prima poesia è intitolata: “Come Zaccheo”; è brevissima. franchi da escudos, rubli da copechi. prima del viaggio s’nforma qualche amico o parente, si controllano valigie e passaporti, si completa il corredo, si acquista un supplemento di lamette da barba, eventualmente si dà un’occhiata al testamento, pura scaramanzia perché i disastri aerei in percentuale sono nulla; prima del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che il saggio non si muove e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è O.K. e tutto è per il meglio ed inutile. ……… E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l’ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza. Ma mi dicono ch’è una stoltezza dirselo. Qui credo non solo che ci sia tutto Montale, ma buona parte del mondo moderno. E a questo mondo moderno così chiuso al trascendente, la testimonianza della carità risulta – guardate – qualcosa come uno spettacolo, non vera. C’è una poesia sempre di Montale: “Dove comincia la carità” Questa violenta raffica di carità che si abbatte su di noi è un’ultima impostura. “Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro per vedere il Signore se mai passi. Ahimé, non sono un rampicante e anche stando in punta di piedi non l’ho mai visto”. mai accadrà che si trovi nei libri di lettura. E non certo da te, Malvolio, o dalla tua banda, non da ululi di tromba, non da chi ne fa una seconda pelle che poi si butta via. Semplicissima e terribile; non vuole fare neanche lo sforzo di arrampicarsi, manco di stare in punta di piedi, perché il Signore non lo ha mai visto passare e non lo vedrà mai passare. Non appartiene a nessuno la carità. Sua pari la bolla di sapone che brilla un attimo, scoppia, e non sa di chi era il soffio.” Questa poesia è indirizzata a Malvolio e c’è un insieme di poesie di Montale degli anni ’70 tutte indirizzate a Malvolio, alla banda di Malvolio; chi è questo Malvolio, si sono chiesti i critici. E’ il gruppetto fiorentino attorno a La Pira, il sindaco La Pira. Parla di carità e La Pira aveva scritto quel libretto sui poveri – ricordate, si batteva per gli operai nelle fabbriche - si distingueva per una attenzione molto forte al mondo dei poveri. Eugenio Montale che in quel periodo stava a L’altra poesia è intitolata “Prima del viaggio”. “Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste, le pernottazioni, le prenotazioni (di camere con bagno doccia o letto o due o addirittura un flat; si consultano le guide Hachette e quelle dei musei, si cambiano valute, si dividono 11 pone ad esempio la questione storiografica di che cosa portò nei primi tre-quattro secoli della storia cristiana a una vittoria del cristianesimo. Certo ci fu Costantino, ma qual è il motivo fondamentale della conversione dei pagani al cristianesimo? Qui non finiremmo mai di discutere. Ma leggete il libro di Docks – un inglese - “Pagani e cristiani in un’epoca d’angosce”. Ciò che attrasse gli uomini al cristianesimo fu la testimonianza della gioia, cioè di una serenità che derivava dal rapporto col Signore Risorto, dalla certezza che il Signore Risorto è nella vita di ciascuno, questo solo poté provocare una conversione. E questo riguarda anche il mondo moderno; per questo io non valuto negativamente questa sorta di riduzione del piano pastorale al piano spirituale che ho cercato di dimostrare. Anzi, vi vedo l’unica via di soluzione del problema. E chiudo con una citazione del Papa, dalla Deus Charitas est. Alla fine, nei nn. 32-39, il Papa - si parla degli operatori di carità - si chiede: a che cosa conduce lo sforzo di fronte a problemi immensi, che cosa può fare il cristiano che cerca di portare un po’ la sua assistenza? Risolverà i problemi? Il Papa risponde così: “A volte l’eccesso del bisogno e il limite del proprio operare potranno esporlo – il cristiano – alla tentazione dello scoraggiamento”. Il Papa usa due parole: scoraggiamento e, poi, presunzione: sono i due peccati contrapposti alla speranza. Si può peccare e mancare di speranza sia scoraggiandosi - ma che possiamo fare? i problemi sono immensi, chi potrà portare il Cristo al mondo moderno? come potremo mai riuscire?- sia con la presunzione: una certezza che nasce, cioè, da se stessi, non dall’abbandono al Signore. E tutte e due – dice il Papa – sono peccati allo stesso modo contro la speranza.“Ma proprio allora gli sarà di aiuto il sapere che, in definitiva, egli non è che uno strumento nelle mani del Signore; si libererà così dalla presunzione di dover realizzare, in prima persona e da solo, il necessario miglioramento del mondo. In umiltà farà quello che gli è possibile fare e in umiltà affiderà il resto al Signore. E’ Dio che governa il mondo, non noi. Noi gli prestiamo il nostro servizio solo per quello che possiamo e finché Egli ce ne dà la forza. Fare, però, quanto ci è possibile con la forza di cui disponiamo, questo è il compito che mantiene il buon servo di Gesù Cristo sempre in movimento: «L’amore del Cristo ci spinge» (2 Cor 5,14). E con queste parole chiudo questa prolusione. Firenze dice “è una bolla di sapone”; è tremendo, a pensarci. C’è un’altra poesia e chiudo con le poesie di Montale:“Lettera a Malvolio”, ed è una poesia molto strana e difficile da intendersi, se non si sa lo sfondo della Firenze degli anni ’70 e anche un po’ prima, degli anni ’60. La poesia parla di una fuga immobile. Quest’anno è morto don Divo Barsotti e tutti hanno ricordato che una delle sue prime opere che impressionò molti è proprio intitolata “La fuga immobile”: è il suo primo diario. La fuga immobile vuole indicare l’atteggiamento del cristiano, fugge da questo mondo, ma resta nel mondo. La classica esperienza cristiana: cittadini del cielo e pellegrini sulla terra: fuga immobile. Montale ironizza su questa cosa: ma voi cristiani dove fuggite? State ben piantati: la città l’amministrate voi democristiani, trafficate.. E’ meglio prendere una rispettabile distanza da voi. E’ tremendo questo, veramente. “Non si è trattato d’una mia fuga, Malvolio, e neanche di un mio flair che annusi il peggio a mille miglia. Questa è una virtù che tu possiedi e non t’invidio anche perché non potrei trarne vantaggio. No, non si trattò mai d’una fuga ma solo di un rispettabile prendere le distanze. Non fu molto difficile dapprima quando le separazioni erano nette, l’orrore da un parte e la decenza, oh solo una decenza infinitesima dall’altra parte. No, non fu difficile, bastava scantonare scolorire, rendersi invisibili, forse esserlo. Ma dopo. Ma dopo che le stalle si svuotarono l’onore e l’indecenza stretti in un solo patto fondarono l’ossimoro permanente e non fu più questione di fughe e di ripari. C’è tutta una valutazione dell’esperienza del credente dal punto di vista dell’impossibilità di un intervento di Dio nella storia. E di fronte a questo che cosa? La ricerca del superamento dello scarto fra Vangelo e Chiesa o una testimonianza esemplare del credente circa la sua buona relazione col Signore può essere una risposta? La sfida è questa e credo che sia stata sempre questa: se ci si 12 * * * interpreti qualificati del modo di sentire della gente, come avviene che nella storia dell’uomo ci sono queste cadute di speranza? Dico questo reagendo anche ad un passaggio del documento in preparazione a Verona, al numero 13, dove si dice: Oggi siamo invitati a riconoscere che questo nostro tempo ha una grande nostalgia di speranza. E si rifà poi alle rapide trasformazioni culturali e in particolare: la deriva individualistica, la negazione della capacità di verità da parte della ragione, l’offuscamento del senso morale. Non per semplificare, ma mi viene di dire una espressione: si è molto preoccupati dell’effimero, di quello che dura un giorno e finisce presto, e non di quello che dura sempre; penso per esempio alle situazioni dei legami familiari, le amicizie, ecc. Mi viene in mente il passaggio di una canzone di Vasco Rossi - non per citare un poeta ma giusto quei poeti che i nostri ragazzi amano tanto e che fanno cultura quando ad un certo punto dice dei giovani che parlano di sé “noi siamo quelli che moriamo presto, ce ne frega”. Mi ha provocato molto questa espressione. Poi è chiaro passa, però la speranza dov’è? E’ una domanda aperta: dovrei elaborarla un po’ di più ma volevo anche condividere. Il Relatore ha poi risposto alle seguenti domande - C’è, accanto alla speranza cristiana, una speranza umana, quella attenzione verso il compimento delle mete più alte che però ha un andamento diverso rispetto alla speranza soprannaturale, mi sembra. La speranza soprannaturale non ha termine, ha una dimensione infinita, mentre la speranza umana ha come una curva; nei giovani è molto presente, negli anziani diminuisce, perché hanno davanti meno futuro e hanno più passato. A me sembra che una della chiavi personali di lettura di questa scelta della Chiesa italiana di concentrarsi sulla speranza sia proprio questa: che l’Europa, e l’Italia nell’Europa, presenta sintomi di vecchiaia culturale e quindi perde la speranza e la capacità di aspirare a qualcosa di grande e culturalmente ci si accontenta del frammento, del dato, del segmento senza alcuna prospettiva. Certamente, poi, nell’Europa il cristianesimo c’è ancora, nonostante tanti segnali di crisi o di arretramento, però mi sembra che l’Europa veda la speranza cristiana come qualcosa che non le interessi, perché appunto c’è questa situazione di rimanere nel frammento, non tanto come una situazione di fatto ma come una scelta. Non so se vuole dirci qualche cosa sui presupposti ideologici, culturali, filosofici di questa scelta minimalista della cultura europea: rifugiarsi e rimanere nel finito. La mia interpretazione è che le tendenze di un certo esistenzialismo oppure alcune correnti di ermeneutica si diffondono a livello accademico in un certo modo, a livello di vita vissuta in un altro modo, ma sempre in continuità e volevo chiederle se aveva qualcosa da dirci in proposito. Risposte Rispondo alla prima domanda. Questa chiave di lettura che dice lei è quella che il documento stesso presenta. Di fronte al cadere delle speranze, anche delle speranze umane in questa Europa, e anche da noi, la Chiesa risponde offrendo quello che ha: la fede, la speranza e la carità, certamente. Il mio problema è questo e non so se voi lo avvertite allo stesso modo; lo dico specialmente a lei che ha fatto la domanda. Il Cristianesimo si può presentare come portatore di una speranza, quella escatologica, diciamo, che sostenga le speranze umane in maniera immediata, che sia in grado addirittura di sostenere una civiltà e lo è. Noi parliamo di radici cristiane dell’occidente, dell’Europa e così via. Quindi significa che il Cristianesimo è riuscito a sostenere non solo speranze piccole, ma speranze nel senso di un progetto, di una civiltà, ecco. Ma nell’ immediato viviamo in un mondo privo di speranza sotto tanti aspetti; c’è una radice culturale che ha detto lei e ci sono anche gli atteggiamenti di ogni giorno. Il documento sinodale sull’Europa parla della cifra della perdita della speranza in Europa nella caduta - Mi ha colpito molto, e la ringrazio, la chiusura della sua prolusione. Un po’ perché mi piacciono le poesie e soprattutto perché ha sottolineato i componimenti del nostro grande Montale. Anche se non sono abituato a reagire subito: ho bisogno di lasciar decantare un po’ le cose. Mentre lei leggeva Montale mi tornava in mente quel passaggio di Dante che definisce la speranza “Attender certo” con un contesto che conosciamo bene, di un profondo cristianesimo che Dante testimonia, e anche un altro passaggio di “Canto notturno di un pastore errante” di Leopardi, che in un certo punto, contemplando la luna, dice “E io che sono?” e io lo lascio sempre riecheggiare “Che cos’è l’uomo?” Se è vero che i poeti sono 13 logica di dissoluzione di una cristianità sociologica. Se prendiamo la Chiesa francese e la Chiesa italiana per dirla in maniera essenziale, ma credo vera, dopo il Concilio nella Chiesa francese si decise che bisognava puntare alla nascita di una fede adulta. Sicché, se tante persone non sono in grado di capire che cos’è il matrimonio cristiano, non li sposiamo; di capire cos’è il Battesimo cristiano, diciamo che i loro figli non li battezzo, crescono nella fede e poi si vede. Una scelta che puntava, insomma, alla nascita di comunità cristiane consapevoli e adulte nella fede. In Italia non si fece questa scelta. I sacramenti vengono dati ancora a tutti coloro che li chiedono e questo ha permesso la persistenza, diciamo così è già un giudizio dire questa parola: persistenza di un Cristianesimo popolare. Si può discutere di questa scelta e non so voi che siete seminaristi e che fra poco avrete la responsabilità di guida di parrocchie e di comunità come la pensate. Se c’è questo Cristianesimo popolare è un palla di piombo al piede della Chiesa italiana di cui bisogna liberarsene, e finalmente creare comunità consapevoli, oppure è un compito che bisogna assumersi e la prima evangelizzazione bisogna completarla? Non so come la pensate. Mi sembra un punto essenziale ai fini di quella domanda. E il documento come la pensa su questo? Io credo che il documento la pensa nel senso che il Cristianesimo di popolo che ancora vige in Italia è una chance, non è una palla di piombo e non è neanche un peso da portarci dietro; è proprio invece una chance che la testimonianza della speranza si rivolge innanzitutto – e così rispondiamo sempre a quella domanda che ho sempre presente qual è - all’interno della comunità cristiana. Guardate, se leggete il documento al numero 10, 4° capoverso, vi si dice: “I primi destinatari della testimonianza sono i fratelli nella fede”. Non il mondo fuori della Chiesa. Lo dice il documento. Però voi potete sempre rispondere come la pensate, ovviamente. “Nella comunità cristiana infatti la testimonianza si fa racconto della speranza vissuta dei segni di resurrezione che essa ha prodotto nell’esistenza e per gli avvenimenti di vita rinnovata che ha generato. In tal modo, insieme alla predicazione e ai sacramenti la speranza viene accesa e accresciuta nei fedeli. La testimonianza cristiana, soprattutto dei genitori e degli adulti, propone il dinamismo di memoria presente e profezia che attinge ogni giorno la speranza alla sorgente zampillante del Risorto. La testimonianza autentica, infatti, appartiene alla tradizione entro cui ha preso corpo e che essa delle nascite: se non si vogliono fare più figli è chiaro che non c’è più speranza nel futuro; non si vuole, non c’è speranza. Se noi aggiungiamo a questo anche la destrutturazione addirittura del modello della famiglia, dove si fanno i figli, la coppia, allora questa Europa sembra culturalmente negata alla speranza, chiusa alla speranza. Culturalmente e, poi, di fatto storicamente: negli atteggiamenti concreti, nella legislazione, nelle prospettive politiche, l’Europa non sembra che riuscire ad avere un qualche ruolo: vediamo la crisi in Medio Oriente e tante altre cose. Ora, di fronte a questo quadro l’annuncio della speranza, della speranza cristiana, escatologica, è una ricetta per risolvere questo problema? E il problema lo possiamo impostare in questo modo? Dalle sue parole sembrava: ecco, siccome c’è, la Chiesa risponde. Lei ha posto il problema di una civiltà cristiana. Ora almeno una cosa è evidente: è un po’ una vulgata che nel Vaticano II si è esclusa la possibilità di una civiltà cristiana. Però non discutiamo di questo: se storicamente o nel futuro ci potrà essere una civiltà informata al Cristianesimo in una maniera analoga a quella del passato. Però è chiaro che innegabilmente non ci può essere un passaggio dalla testimonianza della speranza cristiana a un sostegno alle speranze umane; addirittura, per quanto riguarda l’Europa, all’assunzione di un ruolo, di una consapevolezza di una cultura specificamente europea e così via. No, immediatamente questo non ci può essere. E allora, se su questo siamo d’accordo, la proposta della Chiesa italiana ai preti e ai fedeli cristiani di essere testimoni della speranza a che cosa mira, immediatamente - non tra 100 anni, ora - se non mira immediatamente a questo? Lei poco fa ha fatto una distinzione, che mi pare preziosa, tra la situazione italiana e le altre. Una qualche diversità in Italia io credo che c’è, se per esempio prendiamo la situazione tedesca, olandese e la situazione italiana circa la presenza del cristianesimo nella società e nella vita della nazione. Per esserci, c’è. E’ storicamente visibile, quella che si percepisce, che fra 100 anni uno storico che farà la storia d’Italia potrà percepire, è che in Italia esiste ancora un cristianesimo di popolo. Alla Messa la gente ci va. Un Cristianesimo di popolo da noi esiste, altrove si è dissolto. Io credo che quando consideriamo queste cose bisogna valutare anche questa persistenza della chiesa di popolo in Italia. E valutarla secondo la logica che la gerarchia, i vescovi in Italia hanno cercato in questi 40 anni, con i quattro convegni, di far prima assumere e far penetrare, che non è una 14 parrocchia che se sono in rapporto con nostro Signore, che è l’eterno, che è Figlio di Dio, sono una sola cosa col Figlio di Dio e trascendono la storia; se si accorgono che sono con il Signore è ovvio che anche le speranze umane, la loro speranza è in Cristo e nella Chiesa. E se questo lo fa una Chiesa italiana che è di popolo è certo che forse l’Italia ritroverà una speranza. Quanto ai frammenti ecco allora che si parlava della cultura del frammento: la Chiesa italiana sposa questa cultura del frammento, ma appunto per capovolgere la cosa; si parte dal frammento positivo se c’è nel frammento della vita di ognuno, del credente che vive del rapporto con il Signore risorto, allora si può invertire e darle un segno cristiano. Continuo con il documento:“Ogni cristiano è chiamato a collaborare con gli uomini e le donne di oggi nella ricerca e nella costruzione di una civiltà più umana e di un futuro buono” sono parole misurate. Oggi non c’è più civiltà cristiana, non c’è più neppure una civiltà dell’amore (Paolo VI) i termini sono più sfumati, più modesti “deve collaborare” con gli altri uomini, quindi anche non credenti, “per la ricerca e la costruzione di una civiltà più umana e di un futuro buono”; sono speranze molto piccole. Questo comporta che significa di fatto dedicarsi ai frammenti positivi di vita custodendo però la tensione verso la speranza escatologica che non può mai essere del tutto esaudita; l’orizzonte resta escatologico, ma questo orizzonte può essere vissuto concretamente nel frammento. Non so se sono riuscito a dire almeno come la vedo io. trasmette a sua volta creando il nesso tra le generazioni dei fedeli”. E’ chiaro che la preoccupazione che sta dietro a queste frasi è la trasmissione della fede all’interno della comunità cristiana alle nuove generazioni. Tornando al discorso che abbiamo noi. Che cosa vuol dire questo invito dunque alla speranza, alla testimonianza della speranza? Fede, speranza e carità sono virtù teologali ci insegna il catechismo, vero? Virtù teologale significa esperienza stessa della vita di Dio nel credente. Il cristiano che crede, che ha fede, ha un rapporto con Dio, ma un tale rapporto con Dio, una conoscenza di Dio, è possibile solo se Dio ci partecipa la sua stessa conoscenza. Ricordate nel Vangelo l’inno di esultanza “Ti benedico o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli “. Ecco la fede è Rivelazione, è partecipazione alla conoscenza stessa che Dio ha, che il Figlio ha del Padre e che il Padre ha del Figlio; se dimentichiamo questo … E anche la speranza, come l’amore è partecipazione alla vita di Dio, è la conoscenza di Dio, la speranza di Dio e l’Amore di Dio. Detto questo testimoniare la speranza che significa? Testimoniare che tu hai la vita stessa di Dio in te e che la tua speranza è al di là di ogni cosa, è Dio stesso e questo lo testimoni in tutte le situazioni della vita. La fragilità, il lavoro, la festa , la trasmissione del sapere, la cittadinanza, tu li vivi e li investi in questo tuo rapporto con Dio. La Chiesa crede ai suoi cristiani: questo non è cosa di poco conto guardate. Immediatamente questo chiede, non altro. Questo solo e c’è un passo in cui questo appare con una chiarezza. Quando lo dico ai seminaristi e ai sacerdoti mi dicono: “ma questo dice il documento?” Si, rispondo, al numero 9: “la vita cristiana ha bisogno, come testimonianza, di essere riconosciuta e promossa dalla cura ecclesiale” - è terminologia milanese. Stanno dicendo che la Chiesa, i preti, i vescovi hanno questo compito di riconoscere la vita cristiana come testimonianza e curarla, questo devono fare. E questo che significa? ”La Chiesa lo fa se si prende cura della testimonianza e lo fa se si prende cura della qualità della fede dei credenti, prima che il loro impegno”. Questo solo chiede e anche i comportamenti morali sono solo conseguenza. Se c’è il rapporto con il Signore ha senso che tu ti comporti come dice e come vuole il Signore. Questo chiede il documento. Ma se questo viene vissuto dai cristiani in una chiesa di popolo, la sfida è questa, riuscire a far cogliere ai fedeli della vostra Domande - Le domande sarebbero tante e i temi da trattare sono molteplici. La prima cosa: non sono concorde sulla scelta della Chiesa italiana - cioè che già il documento base faccia una scelta precisa, in questo senso - per un cristiano adulto nella fede. Ho l’impressione che nella nostra Chiesa italiana permanga una sorte di anacronismo rispetto a tutte le situazioni di dialogo a cui si faceva riferimento prima, un Vangelo dialogante; anzi ho più l’impressione di un Vangelo apologetico che non dialogante. Anche il discorso della testimonianza: questa prevede sì che una generazione passi ad un’altra ciò che ha ricevuto, 15 escludere dalla Chiesa quelli che ancora non ci sono arrivati. Si può fare questa scelta. Il problema è a che cosa si mira immediatamente: se ad escludere, facendo un gruppo più ristretto - quelli che hanno questa consapevolezza - e gli altri, pazienza, restano fuori dalla Chiesa, oppure: sono dentro la Chiesa per il semplice fatto che chiedono di restare nella Chiesa e allora cerchiamo di farli diventare veramente cristiani! La scelta della Chiesa italiana è quest’ultima. E questo è molto importante per dei seminaristi che stanno per diventare preti e si incamminano in questa strada. Ora, secondo te, questa è una scelta contraddittoria; mi pare di capire dalle tue parole che c’è questa valutazione: si vuole la botte piena e la moglie ubriaca, tutte e due le cose. Se anche non tutti sono consapevoli, in gran parte della Chiesa italiana, tuttavia c’è il legame della tradizione che lega la gente alla Chiesa. Secondo te, nella tua diocesi la gente come vive il suo legame con la Chiesa? L’altro, poco fa, diceva che vive la speranza come aspettativa e non la speranza escatologica, in maniera più terra terra; non ha la consapevolezza di essere affidata a Dio, di vivere la propria vita con Dio, sicché ogni cosa che fa, ogni cosa che pensa, gli affetti che nutre hanno a che fare con Dio. E allora come vivono il legame? Ritengono di avere un legame: il legame è attraverso i santi. La Chiesa italiana è la Chiesa della devozione; tanta gente ha un legame con la Chiesa, il Papa, con il mondo di Dio - diciamo così - per i santi: il santo del proprio paese, la Madonna che si venera nella propria parrocchia; forse nel portafoglio, se voi lo aprite, c’è l’immagine di Padre Pio; in quanti paesi d’Italia c’è la statua di Padre Pio! Non è così? Questa è la prima forma di legame. Una seconda forma è quella del volontariato, dell’attivismo cattolico. Tanta gente partecipa alle iniziative caritative assistenziali, quelle del terzo mondo, le adozioni a distanza: e pensa di essere cristiana per questo; del resto la fa il parroco questa proposta: io partecipo a questa proposta ed esprimo il mio cristianesimo. Altri - ora è un po’ di meno - attraverso l’impegno politico: 50 anni di democrazia cristiana. Se uno si iscriveva e partecipava a tutti i convegni, questo è cristianesimo. E la Chiesa stessa non spingeva a votare perché è un dovere cristiano? Non è così in Italia? Perché bisogna cercare di entrare nelle cose, altrimenti tutto resta sfumato. L’Italia è fatta così: la sfida pastorale è far passare questi legami di appartenenza, che io non ritengo deboli; qualcuno la chiama appartenenza debole, ma che l’altra generazione la recepisca con canoni e situazioni proprie, cioè la assorba e la assimili con situazioni proprie. A me sembra che molto spesso manchi questo passaggio. Un ultimo riferimento lo farei anche al discorso pastorale che più volte è venuto fuori. Si parlava di indicazioni pastorali. Anche qui ho l’impressione che ci sia una eccessiva preoccupazione di “prassologia” più che di pastorale. Più sul che cosa e come lo devo fare – la ricetta pronta – anziché una pastorale intesa come un discorso di preoccupazione, di guida. Anche nelle nostre programmazioni si è più preoccupati nella preparazione di un calendario anziché di una programmazione vera e propria. Quindi per la questione del dialogo: se mancano queste premesse, cioè attenzione innanzi tutto alla società con cui si dialoga, penso che sia falsato il tutto. - Lei ha dato prima una bellissima definizione di speranza e del modo in cui il cristiano dovrebbe vivere la speranza. Io sono giovane e di pastorale non me ne intendo, perché non ne ho fatta molta, però dialogando con i giovani e i coetanei, e i genitori di ragazzi giovani, vedo che la definizione di speranza per loro è un po’ distante dall’espressione che lei aveva dato prima. La definizione di speranza per loro è molto più paragonabile alla parola aspettativa. La speranza intesa nel senso che lei diceva prima mi da l’impressione che sia per loro utopica e quindi se io devo mettermi in dialogo con delle persone che non hanno nella loro mente la definizione di speranza cristiana, ma hanno solo ed esclusivamente una questione culturale e sociale, e solo un’aspettativa, io uomo di speranza sono una persona folle. Quindi volevo capire se era possibile inserire in questo dibattito la consapevolezza che comunque la gente non intende la speranza come lei l’ha descritta, in maniera alta, ma la vive come aspettativa che è cosa ben diversa dalla speranza. Per me questa esperienza nel contatto con la gente è stata una delusione e quindi vorrei sapere come muovermi. Non c’era dialogo perché si parlava di cose ben diverse. Risposte La Chiesa italiana ha fatto la scelta delle fede adulta. Fare questa scelta significa cercare di promuovere il popolo e i credenti a una tale consapevolezza di fede adulta, senza però 16 Tu dici: un documento della Catechesi. Secondo te, da quello che sai, da tuo papà, dai tuoi zii, tuo nonno, c’è una maggiore consapevolezza cristiana in quelli che hanno avuto il catechismo di Pio X o in quelli che l’hanno avuto dopo il documento di base. Io non lo so; certo c’è stato un impoverimento del dato conoscitivo della catechesi. Io vado a fare le tesi, e qualche volta il catechista mi presenta come è fatto il catechismo e spiegano: “Abbiamo cercato di rispondere alle domande di senso, ma io dico: “Glieli hai insegnati i 10 comandamenti ?” No: che cos’è la vita, che cos’è l’amore e tutte queste cose. Una povertà conoscitiva grande; una debolezza per lo meno, ecco, questa c’è stata. Sono cose complesse: se si vuole far passare questa cristianità – diciamo così di ordine sociologico, deve essere fatto uno sforzo grande. Ma proprio avendo di mira che cosa? Io pure domando quando vado ad amministrare la Cresima - che è il momento per me di maggior contatto; il parroco dice: “Guardate che voi che ora avete ricevuto la Cresima dovete essere tutti partecipi della vita della comunità, domani venite tutti. Uno parteciperà al coro, una alla pulizia della chiesa, ecc. Questo è essere cristiani. E’ questo. Io non lo so se è questo: la cosa è per lo meno complessa. Io vorrei farvi riflettere sempre su questo tema. Perché secondo me la prima cosa è rendersi conto della complessità: gli schemini non servono a niente e istupidiscono: uno pensa di avere una verità, ma se vede una sola cosa …. Parlo di me. Chi mi ha trasmesso la fede cristiana? Perché io sono cristiano e addirittura ora sono Vescovo e devo trasmettere la fede, ne sono addirittura il garante; quando ci penso…! Quando mi elessero Vescovo, tra l’elezione e la consacrazione, andavo ancora qualche volta alla Facoltà: dovevo concludere le cose che avevo fatto perché la mia vita era cambiata. E un giorno c’era la presentazione di un libro e fra i relatori c’era il prof. Salvatore Natoli, ateo, anzi neo-pagano, siciliano, ma che insegna a Milano, il quale mi disse, con un’improntitudine eccezionale: “Circa la dottrina cristiana io penso di sapere non meno di lei, probabilmente anche più di lei. Mi scusi, però io conosco la dottrina, perché l’ho studiata, la tradizione cristiana, i dogmi, i Concilii, ciò che la Chiesa pensa di sé stessa; Gesù Cristo io lo conosco, ma lei ora che è Vescovo diventa testimone: che è diverso”. Quella cosa mi colpì e mi è rimasta. Comunque, stavo dicendo, come sono diventato cristiano? Tanto da essere ora testimone secondo Natoli e ma lo è fino ad un certo punto. E’ invece un’identità forte, perché identifica le persone con quel paese, con quella devozione alla Madonna, e questo resta e poi uno diventa professore universitario, vota, che so io, per un partito di sinistra eppure resta quella cosa. Mi ha impressionato un professore di Partinico, un paese della Diocesi di Monreale, che si professa ateo, comunista. Nel 2004 c’è stata la beatificazione di una ragazza di Partinico morta nel 1951, Pina Suriani. Questo tale mi avvicina, mi scrive pure una lettera e mi dice che lui ha una grande devozione per questa donna, perché fu sua maestra di catechismo e ricordava che quando la banda Giuliano - imperversava negli anni dopo la guerra, dal ‘43 al ’50 - gli aveva ammazzato il papà, in una Camera del Lavoro, questa ragazza, che faceva la maestra di catechismo, convinse la madre del bambino a togliere i vestiti del lutto perché quando morì suo padre lo vestirono a lutto. “Guardi signora io gli faccio il vestitino bianco”: glielo fece lei, glielo pagò lei e così lui fece la prima Comunione. Il ragazzo associò l’uscita dal lutto per la morte del padre ammazzato alla figura di Pina Suriani, e questo ricordo l’ha accompagnato per tutta la sua vita. Questo professore insegnava prima al nord, in Piemonte, e viaggiando sull’autostrada, all’altezza di Bologna un camion distrusse la sua macchina totalmente: lui in quel momento si affidò a Pina Suriani e ne uscì illeso. Questo ateo, militante, ecc. ha questo legame e me lo scrisse in una lettera; sono cose curiose, cosa fare? Ebbene, questo è legame debole? Non è debole io dico; certo non è la fede adulta di una consapevolezza cristiana. Che cosa fare di tutte queste cose: il legame devozionale, il legame caritativo-assistenziale, il legame politico che sono i tre grandi legami che caratterizzano la generalità degli appartenenti alla Chiesa in Italia, che cosa fare di questa Chiesa? Quando per esempio vengono a sposarsi, se chiedi: “ma tu hai la consapevolezza di che significa vivere di Gesù Cristo?” niente. Agli stessi ragazzi della Cresima io domando: “chi è lo Spirito Santo?” La risposta che si avvicina di più alla dottrina è: Gesù Cristo. Ma come li devo cresimare questi? Non sanno niente. Certo che se dico in quel momento, in cui già è tutto preparato, “Mi dispiace …” il parroco ci resta male: “Ma no, vede Eccellenza, sono commossi: per questo rispondono male”. Macché, questi veramente non sanno niente! Una catechesi fatta! 17 per quel che il cristianesimo è, cioè la assicurazione di un rapporto con Dio. Dio si è fatto uomo affinché noi siamo Dio, diventiamo Dio. Questa è una formula del II° secolo ed è verissima. Se non c’è un minimo di iniziazione alla fede cristiana, al rapporto con Dio, se non c’è la conoscenza con Dio, non c’è cristianesimo. La sfida è tutta qui. Se uno ha davanti la meta allora ognuno di noi si attiva creativamente, misurandosi con la realtà. Ci vuole una grande capacità di lettura della realtà concreta in cui si è e non tutta l’Italia è omogenea in questo. Una cosa è Mazzara del Vallo e altra cosa è la Valle d’Aosta, una cosa è Verona e altra è Ischia o Tricarico: sono tutte realtà diverse. Una grande capacità di leggere la realtà e poi di affinare degli strumenti per raggiungere la meta. Un grande studioso, uno storico della Chiesa, francese, vivente, si è posto questo problema: si può stabilire una sorta di paradigma della trasmissione della fede - come nei verbi greci che hanno le forme fisse - che per tutti i venti secoli della storia cristiana si ritrovano in ogni trasmissione della fede, in ogni secolo? Sì, tre sono le forme del paradigma. La testimonianza, l’arte e la dottrina. E lui intende per testimonianza l’esempio vivo, la testimonianza del credente, se manca questo non c’è trasmissione della fede. La seconda, prima ancora della dottrina, è l’arte lui dice il simbolo - cioè tutto ciò che ti dice sinteticamente il cristianesimo. Secondo lui anche la celebrazione della Messa, un insieme di gesti e di riti, è un simbolo, cioè ti richiama a qualcosa altro. L’arte, un quadro, un oggetto - oggi c’è tanta gente che non sa decifrare i quadri, i temi cristiani dell’arte o un dramma - è una socializzazione del cristianesimo in maniera tale che il cristianesimo ti giunge attraverso un canale sociale: l’arte è essenziale per tutto ciò. In terzo luogo e solo in terzo luogo la dottrina, la catechesi, la formula esatta per dire la fede. Io credo che sostanzialmente questo scrittore abbia ragione. non semplicemente un conoscitore della tradizione cristiana. Come? Io sono vissuto in un piccolo paese rurale dove – io sono nato nel 1951 – fino al ’64, fino alla grande svolta - intendo il neoconsumismo, l’emigrazione - tutto era improntato al cristianesimo. C’erano le feste popolari, le rappresentazioni sacre, io devo dire onestamente che quel che so del cristianesimo, l’iniziazione al cristianesimo, l’ho ricevuto in parrocchia, non dalla mia famiglia. Ho un grande rispetto, ovviamente, per mio padre e mia madre, ma mi insegnavano le formulette delle preghiere. Chi per esempio mi insegnò la meditazione fu una signorina del catechismo. Disse “Voi che siete chierichetti, fermatevi un quarto d’ora prima dell’inizio, venite prima”, e ci insegnò che cos’era la meditazione. L’ho ricevuto cioè dalle forme sociali del cristianesimo, direttamente pastorali, cristiane, ma anche civili: tutto il paese trasmetteva la fede. Ci sono varie vie per la trasmissione della fede. Noi forse dobbiamo rendercene conto: man mano che tanti canali di tipo sociale della trasmissione della fede si sono chiusi o si vanno chiudendo totalmente o parzialmente, si impone un’attivazione di nuovi canali che non possono che essere strettamente ecclesiali. Prima si andava alla scuola media - e poi al liceo cambiavano le cose - e l’insegnante faceva dire la preghiera; oggi è assurdo. Si faceva la Comunione a Pasqua, il precetto, tante forme. Ora tutto questo va crollando, o è crollato. Cioè la trasmissione della fede è una cosa complessa. Si può essere credenti in tanti modi. Si arriva al cristianesimo in tanti modi. Se le vie civili - diciamo così – sociali, tradizionali vengono meno, bisogna in qualche modo sopperire. Bisogna intervenire. Questa è la sfida che ci sta davanti, io credo, una sfida pastorale grossa. Ed è una sfida che può essere risolta positivamente, solo se si sa a che cosa si mira. Non si può mirare semplicemente ad un senso più vivo dell’appartenenza ecclesiale o sociologico; oppure a quelli che fanno delle cose in parrocchia. Così non si risolve il problema. Ciò a cui bisogna mirare è a una consapevolezza del cristianesimo 18 I Relazione La spiritualità del prete, uomo della speranza Mons. Luciano Monari come una serie ininterrotta di shoppings. Passo tra gli scaffali, guardo, lascio che i prodotti suscitino l’interesse e il desiderio, compero, provo… poi ricomincio daccapo: un secondo passaggio tra gli scaffali dove la merce è esposta nel modo più seducente. Ricompero gli stessi prodotti se sono stato soddisfatto; ma più facilmente ne provo dei nuovi, faccio il confronto, scopro nuove esigenze e desideri. torno a casa con la speranza che i prodotti acquistati si rivelino buoni, mi diano sensazioni o emozioni positive; e così di nuovo sempre daccapo, sempre con prodotti nuovi e con sensazioni inedite… Non è difficile immaginare che cosa questo schema di pensiero significhi quando lo applichiamo a esperienze come l’amicizia o l’amore umano. Significano che gli altri sono assimilabili a prodotti da provare: l’amicizia deve dare soddisfazioni (o no?); per questo ricerco qualcuno la cui presenza sia per me motivo di gioia, di soddisfazione: parlo, ascolto, dialogo, gioco, lavoro… insieme. Ma senza impegno: che senso avrebbe mantenere un rapporto quando la gratificazione è scomparsa, quando si rischia di annoiarsi ogni volta che si sta insieme, quando intravedo l’opportunità di nuovi rapporti, di nuove esperienze più gradevoli? Perché continuare a portare lo stesso tipo di scarpe quando il mercato ha prodotto nuovi modelli, più interessanti, che possono rendere interessante anche me? Così si cambiano facilmente gli amici, si lascia il partner per provare ebbrezze nuove, desideri nuovi. Questo modulo di pensare la vita la considera come un nastro vuoto da riempire di oggetti: i più belli, i più vari, i più gradevoli, il risultato, come ho detto, è un aggregato di cose, di esperienze, senza legame tra loro, semplicemente giustapposte. In realtà la vita umana è un processo di crescita biologica, psicologica, culturale, spirituale…, un lungo processo attraverso il quale la persona si arricchisce interiormente e diventa persona consapevole e capace di amare. Nel cuore dell’uomo c’è un desiderio innato, incoercibile, che lo porta a trascendere sempre di nuovo se stesso, a muoversi e correre verso mete ulteriori, Nella sua bella analisi fenomenologica della speranza Gabriel Marcel giunge alla conclusione che la formula corretta della speranza umana è: “Io spero in te per noi.” Partirei da questa definizione per cogliere alcuni aspetti che mi sembrano decisivi anche per la formazione del prete e quindi per la sua testimonianza. La prima osservazione è che la speranza apre e distende l’esistenza dell’uomo verso il futuro, verso un futuro che si presenta come salvezza, riscatto, pienezza. L’esistenza dell’uomo, di ogni uomo, si distende necessariamente nel tempo, ma questo distendersi può essere inteso in due modi diversi. Può essere solo un prolungarsi lungo il nastro inesauribile del tempo fino al momento della morte: un anno, due anni… venti... settanta… O può essere inteso, invece, come il dilatarsi della persona che, attraverso l’occasione del tempo, cresce verso una pienezza sempre più grande e profonda. Non c’è bisogno che dica che solo in questo secondo caso si può parlare autenticamente di ‘speranza’: non si tratta di aggiungere sassi a sassi fino a fare un mucchio; si tratta di maturare progressivamente fino a diventare liberi, responsabili, capaci di amare. La speranza suppone quindi una concezione della vita come compito, consegna, impegno, crescita, maturazione; o, detto nel modo forse più completo, vocazione. E qui troviamo il primo, fondamentale ostacolo, che la cultura d’oggi pone di fronte alla speranza: una concezione della vita ‘quantitativa’, pensata come un aggregato indigesto di esperienze che siano il più gradevoli possibile. Zigmunt Bauman ha fatto un’analisi straordinariamente fine della condizione dell’uomo d’oggi vista con gli occhi del ‘consumatore’. L’uomo d’oggi, dice, ha omogeneizzato sotto la categoria del consumo tutte le esperienze della sua vita, non solo quelle con cui compera prodotti necessari alla esistenza quotidiana (il dentifricio e le scarpe), ma anche quelle che coinvolgono rapporti interpersonali (come l’amicizia e la religione e l’amore). Il risultato di questo fatto è che l’uomo pensa il mondo come un grande supermercato e la vita 19 qualità nuova. Si pensi all’esempio più evidente, quello della famiglia. Un ragazzo e una ragazza si sposano e mettono insieme le loro esistenze. Quello che scaturisce dal loro dono reciproco è una famiglia che risponde ai loro sogni e desideri ma nello stesso tempo li trascende in un ordine nuovo, quello dell’amore e del dono di sé. Anche lavoro, casa, denaro, possesso acquistano un significato nuovo, come elementi di una nuova relazione; come l’anello che, acquistato e donato dallo sposo alla sposa, assume il valore della fedeltà. Rimane metallo con un suo valore commerciale, ma diventa affetto con il suo valore personale. II Posta questa premessa sulla struttura della speranza, facciamo un passo avanti con due affermazioni. La prima è che Dio spera nell’uomo e la seconda è che l’uomo è chiamato a sperare in Dio. Di questa due affermazioni la prima è quella più sorprendente, ma mi sembra necessario partire da lì perché la speranza dell’uomo ha la sua radice nella speranza stessa originaria, creativa, di Dio. Ma cosa può significare l’affermazione che Dio spera nell’uomo? Torniamo alla formula: io spero in te per noi. Applicata a Dio significa che Dio spera nell’uomo per quella realizzazione di bene che l’uomo, insieme con Dio, può attuare. Leggiamo nel libro della Genesi che Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, che lo ha collocato al di sopra di tutte le altre creature come ‘vicario’ di Dio, che gli ha comandato di generare alla vita e di riempire la terra. È interessante che il libro della Genesi faccia precedere l’atto creativo di Dio da una sua deliberazione: “Dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza…” E’ l’unico caso in cui, nel racconto della creazione, si parla di una simile deliberazione. Perché? Naturalmente perché l’uomo è chiamato a collaborare all’opera creatrice di Dio in un modo del tutto speciale. Se le altre creature sono poste da Dio nel mondo con una loro legge interna di vita, l’uomo è chiamato a una risposta libera. Dio liberamente pone l’uomo di fronte a sé come un ‘tu’, come un possibile partner, interlocutore, collaboratore. Risposta libera vuol dire necessariamente incerta; ma libera vuol dire anche piena di un valore nuovo di responsabilità, di amore, di fiducia, di obbedienza. Dio ha sperato nell’uomo; che l’uomo potesse, con la sua libertà, portare a compimento la creazione facendola essere risposta gioiosa alla creazione di Dio. all’infinito: non c’è termine alla capacità di capire e soprattutto non c’è termine alla capacità di amare. La speranza è quel desiderio, quel dinamismo che impedisce di fermarsi a godere semplicemente ciò che si è raggiunto; ogni momento è un rilancio; ciò che si è raggiunto viene rimesso in gioco per ottenere qualcosa di più. Quando mai possiamo dire di avere aperto del tutto la nostra vita agli altri? Di avere esaurito le possibilità dell’amicizia? [Io spero] Una seconda osservazione è che la speranza autentica è sempre speranza in qualcuno, non in qualcosa. È vero che posso dire anche “spero che domani sarà bel tempo”; desidero andare in gita e il bel tempo renderebbe molto più gradevole l’esperienza. E tuttavia, quando l’oggetto della speranza è una cosa, siamo solo alla periferia dell’esperienza umana autentica. In fondo, il bel tempo o il brutto tempo sono realtà che si trovano al di fuori della mia vita, della mia persona; posso desiderarli, ma non come qualcosa che mi stia davvero a cuore, come qualcosa da cui dipenda davvero il senso (positivo o negativo) della mia vita. La speranza trova invece il suo contesto più profondo e corretto quando si rivolge a una persona, a qualcuno che sta di fronte a me con la sua libertà e di fronte al quale io sono sollecitato a comprendere e vivere la mia stessa libertà. Le cose possono essere necessarie per vivere (ho bisogno di 2500 calorie ogni giorno, di una casa confortevole, di un’automobile…); senza queste cose l’esistenza umana sarebbe impedita in molte delle sue possibilità. Ma la vera crescita della persona è nella linea dell’essere, non dell’avere: essere intelligente, essere giusto, essere buono, essere responsabile, essere credibile, essere fedele, e così via. Ciò di cui ho maggiormente bisogno è ciò che non può essere ridotto a cosa da possedere, ma che mi si presenta come relazione da costruire con dedizione, affetto, pazienza. Solo questo mi arricchisce come persona e porta a compimento il dinamismo dell’esistenza. [Io spero in te] Terza cosa: oggetto, meta della speranza è una condizione nuova di vita che si esprime nella realtà del ‘noi.’ Non solo quindi quello che tu mi puoi dare, che da te posso ricevere, ma quello che insieme con te posso/possiamo diventare. La crescita verso cui sono indirizzato si compie nella realtà dell’essere insieme; nasce un ‘noi’ che non è solo la somma delle persone, ma è la creazione originale delle persone, quello che l’incontro tra loro produce come nuovo e straordinario. In questo ordine nuovo (e superiore) di esperienza sono coinvolte anche le cose, ma queste acquistano una 20 Gerusalemme a Gerico, incappò nei briganti che lo derubarono lasciandolo mezzo morto…” Il racconto lo conoscete bene. Come dicevo, l’interpretazione patristica – di sant’Agostino, ad esempio, vede in questa narrazione la storia della redenzione. L’uomo che incappa nei briganti è Adamo, l’umanità intera; il buon Samaritano è Gesù che, a differenze dei sacerdoti rappresentanti della legge mosaica, prova compassione, si ferma, cura. La redenzione, la guarigione dell’uomo ferito profondamente dal peccato e che solo la grazia di Do si mostra capace di sanare. Notate: il ferito viene lasciato ‘mezzo morto’, e cioè ‘mezzo vivo’, cioè in quel sottile crinale che separa la vita dalla morte. Coloro che passano sono chiamati a prendere posizione di fronte a questo uomo: farlo vivere? Lasciarlo morire? Il comportamento del sacerdote, del levita, del Samaritano sono una risposta, una presa di posizione. Il Samaritano s’impegna perché l’uomo viva. Non c’è bisogno di dire che un comportamento di questo genere suppone che l’uomo possa vivere, esprime quindi una speranza. Quell’uomo non appare spacciato del tutto agli occhi del Samaritano; in questo caso non ci sarebbe stato nulla da fare. È invece la speranza che mette in movimento l’azione, che coinvolge il Samaritano nell’avventura della vita del suo prossimo. Ebbene, proprio questo è il senso della redenzione: l’atto di speranza di Dio nell’uomo. Mandando il suo Figlio in una carne simile alla nostra Dio esprime la sua speranza nella nostra carne; è convinto che l’uomo possa collaborare con Lui, con Dio, per portare a compimento il mistero della creazione stessa. Potrei continuare facilmente ma non ce n’è bisogno. Quando dico che Dio spera nell’uomo intendo semplicemente questo: che Dio spera di poter portare l’uomo a condividere la pienezza della sua stessa vita. Questa speranza motiva la missione di Gesù, la sua vita e la sua morte. E questa speranza suscita nell’uomo il bisogno di rispondere con una libertà gioiosa e responsabile diventando anch’egli, l’uomo, protagonista della storia insieme con Dio. III Alla speranza di Dio l’uomo è chiamato a rispondere con la sua speranza. Speranza in Dio, certo. Proprio perché Dio è Dio la speranza in Lui è salda; la rende salda la potenza di Dio e soprattutto la rende salda la fedeltà di Dio che si esprime nel suo amore. Ma speranza ‘per che cosa’? Io spero in te ‘per noi’; per quello che insieme con te possiamo costruire. Ma che cos’è In realtà, se si può dire che Dio ha sperato nell’uomo, bisogna anche dire che questa speranza sembrerebbe mal riposta. I primi undici capitoli della Genesi, infatti, descrivono una impressionante serie di peccati che costituiscono una risposta stonata dell’uomo a Dio: il peccato di Adamo, quello di Caino, la vendetta senza limiti di Lamech, la violenza della generazione del diluvio, la torre di Babele… tutta una serie di disobbedienze che danno dell’umanità un’immagine tutt’altro che gradevole. Eppure Dio non ha smesso di sperare. La chiamata di Abramo e tutta la storia di salvezza che prende avvio con lui sono il segno di una speranza che, pur ferita, non si lascia annullare ma immagina e crea sempre vie nuove per la sua realizzazione: “In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra.” Questa la promessa ad Abramo. Potremmo dire: Dio proclama la sua speranza in Abramo; questa speranza si apre a una benedizione universale. Dio spera che la sua azione, passando attraverso la fede e l’obbedienza di Abramo, possa fare giungere a tutti gli uomini il dono della benedizione e cioè della vita. Dio vuole che l’uomo viva; e non solo di un’esistenza biologica, ma di quella pienezza di vita che è la vita etica della giustizia e quella religiosa dell’amore. A questa vita si può giungere solo attraverso l’uso consapevole della libertà e Dio spera nell’uomo proprio secondo questa prospettiva. Non posso naturalmente percorrere tutta la rivelazione biblica, ma una delle chiavi di interpretazione dovrebbe essere proprio questa: l’affermarsi di una speranza che assume forme sempre nuove di fronte alla poca corrispondenza dell’uomo. Mantenendo ferma la speranza nell’uomo, Dio gli insegna poco alla volta a sperare. Dico solo che in questa lunga storia Gesù è la professione di speranza definitiva e irrevocabile di Dio nei nostri confronti. “Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna.” Queste le parole di san Giovanni. Ma è evidente che l’atto di amore di Dio che manda il suo proprio Figlio può e deve essere letto anche come atto di speranza: Dio ha sperato così intensamente nell’uomo da mandare il suo Figlio perché l’uomo possa vivere. Nei primi secoli della riflessione cristiana ha prevalso, come forse sapete, un’interpretazione allegorica delle parabole del vangelo, un’interpretazione che scopriva in tutte le parabole la rivelazione del mistero di Cristo e della redenzione. A questa regola non sfugge la parabola del buon Samaritano: “Un uomo scendeva da 21 Tutto entra in questa prospettiva, tutto può farne parte. Il Nuovo Testamento offre numerose categorie e immagini per avvicinarci al mistero di questa trasformazione, divinizzazione. Si pensi, ad esempio, all’annuncio della risurrezione così come Paolo lo enuncia in 1Cor 15: “si semina corruttibile e risorge incorruttibile; si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge pieno di forza, si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale.” Proprio così: la risurrezione non è un prolungamento indefinito (infinito) della nostra esistenza terrena, ma è l’ingresso in un diverso modo di esistere nel quale la condizione umana diventa portatrice della bellezza e della gloria divina. Oppure si pensi al sacramento dell’eucaristia nel quale il pane e il vino – frutto della terra e del lavoro umano – vengono trasformati nel corpo e sangue di Cristo e cioè nel compimento pieno dell’amore di Dio in mezzo al mondo. Si deve chiaramente dire che l’eucaristia anticipa e compie la trasformazione del mondo così come Dio l’ha pensata e voluta. Si capisce che quanto abbiamo detto potrebbe essere espresso in mille altri modi. Uno, ad esempio, è l’espressione di Paolo VI quando parlava di civiltà dell’amore. Noi speriamo in Dio per una civiltà dell’amore. Se questa espressione viene intesa nel suo vero significato, stando lontano da immagini romantiche e illusorie, il contenuto è ricchissimo. Amore è la presa di posizione libera e consapevole a favore della vita all’altro; posso dire di amare quando le scelte che io faccio sono scelte che oggettivamente favoriscono la vita, il bene degli altri; e quando soggettivamente ciò che mi spinge è il desiderio che gli altri ‘vivano’ e cioè possano portare a perfezione la vocazione alla vita che hanno ricevuto. IV Con questo credo di avere risposto anche alla domanda che voleva dirigere la nostra riflessione: quale può/deve essere la spiritualità del prete, uomo di speranza? La risposta potrebbe essere articolata in due momenti: il prete come ‘uomo di speranza’ e cioè uomo che vive la distesa della sua esistenza come apertura verso il futuro promesso da Dio e che su questo futuro cerca di sintonizzare tutta la sua esistenza (pensieri, desideri, decisioni, comportamenti). In secondo luogo il prete come ‘ministro’ della speranza e cioè come persona impegnata con la sua attività a rendere salda la speranza dei credenti. questa speranza? Credo si possa rispondere molto semplicemente: Cristo. Cristo, lo abbiamo ricordato sopra, è la speranza di Dio nell’uomo; Cristo, aggiungiamo ora, è la speranza dell’uomo in Dio. Sperare in Dio significa sperare che, insieme con Dio, possiamo essere Cristo, corpo di Cristo, membra del corpo di Cristo. Sarebbe necessaria una intera cristologia per indicare compiutamente (o almeno seriamente) il contenuto di questa speranza, di questa ‘cristificazione’ dell’uomo. Non abbiamo evidentemente la possibilità di farlo ora. Possiamo limitarci a indicare alcune piste. La prima la prendo dalla lettera agli Efesini nella quale san Paolo indica il contenuto di ciò che egli chiama ‘il mistero’, cioè il disegno sul mondo che Dio ha custodito da sempre e che ora ci è stato rivelato: “Ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle della terra e quelle dei cieli.” Il senso di questa espressione dovrebbe unire due idee: la prima è che Cristo riassume, ricapitola l’intero universo e quindi che l’intero universo è spiegazione, distensione nel tempo e nello spazio del mistero di Cristo. La seconda idea è che Cristo viene dato da Dio come capo all’universo che viene così a trovarsi sotto la sovranità di Cristo. Questo dunque è la meta della nostra speranza e della nostra attesa: che il mondo intero, attraverso la libera dedizione dell’uomo a Dio nella fede, assuma i lineamenti di Gesù, si sottometta alla sua parola e alla sua vita. Insomma, la storia dell’umanità è un processo di metamorfosi nel quale l’umanità è chiamata ad assumere la forma di Gesù, una forma che è fatta di obbedienza fiduciosa nei confronti di Dio e di amore oblativo nei confronti degli altri. Questa è la nostra speranza. Noi speriamo in Dio per un’umanità rinnovata che abbia i lineamenti di Cristo, per un mondo risanato che abbia in Cristo il suo capo e che a questo capo si conformi. Vorrei solo aggiungere quello che è implicito in quanto detto finora, e cioè che questa speranza abbraccia tutta l’esistenza dell’uomo: la sua esistenza personale e anche l’esistenza delle strutture che l’uomo costruisce nella vita economica, ad esempio, o nella società, nella politica, nella cultura. Noi speriamo in Dio per un’economia che sia a misura dell’uomo, a favore della persona; noi speriamo in Dio per una politica che sia sorgente di liberazione dell’uomo e così via. Non si tratta solo di una speranza per l’aldilà; si tratta di una speranza che, aprendosi alla promessa della risurrezione, diventa sorgente di scelte corrette anche nella costruzione della società e del mondo. 22 la condizione umana nella su a fragilità e ricorre quindi a consolazioni trascendenti? E soprattutto: una speranza di questo genere rischia di allontanare dalla responsabilità per il presente e questo è un evidente peccato di egocentrismo. Non m’interessa la vita degli altri; opero semplicemente perché la mia vita possa raggiungere il massimo di realizzazione. Si pone allora la domanda: che tipo di vita scaturisce da una speranza di questo genere? Anzitutto un premessa: la vita eterna di cui parla il vangelo non è un dono che si aggiunga dall’esterno, è piuttosto la fioritura di un dono (la grazia) che nel presente comincia a operare nella vita del credente. Insomma la vita eterna è donata come compimento di un’esistenza nel tempo che sia segnata e animata dall’amore, che si presenti come obbedienza piena a Dio. Non si può dunque dire che la speranza cristiana allontana dalla responsabilità per il mondo; al contrario, essa rende l’esistenza nel mondo ancora più seria perché la riempie della promessa dell’immortalità e quindi fa dipendere da essa il bene definitivo. Per approfondire questa riflessione prendo un testo bellissimo e sorprendente della lettera agli Ebrei: 2,14-15. L’autore vuole dire che la condizione dell’uomo sulla terra è quella di chi si trova come schiavo a motivo della condizione fragile della sua esistenza. Egli vive inevitabilmente tra paura della morte e attaccamento ossessivo alla vita e rivela in questo modo di essere schiavo. I segni di questa servitù sarebbero tanti; ne enumero alcuni: - la riduzione dell’esistenza all’emozione dell’attimo presente (e fuggente). Lo ricordate bene: carpe diem. In questo messaggio sembra essere presente il desiderio di vivere, ma non è difficile riconoscere la paura di morire. Pensate ai versi spumeggianti di Lorenzo il Magnifico: “Quant’è bella giovinezza….” Bella… fugge… lieto… non c’è certezza! L’incertezza, il passare irrevocabile del tempo spinge ad attaccarsi al presente e a cercare di spremere dal presente il massimo di soddisfazioni. Vita intensa, dunque; ma intensità artificiale, provocata dalla paura della morte. - secondo sintomo: l’incapacità di rinunciare a qualsiasi cosa. È l’altra faccia della medesima medaglia. Se non c’è rimedio alla morte, tutto quello a cui rinuncio è perso per sempre. Ogni rinuncia, allora, mi sembra una perdita irreparabile; e ogni privazione una violazione del mio diritto alla vita e alla felicità. - terzo e ultimo sintomo: l’incapacità di assumere impegno duraturi. È solo un corollario dei due Insomma il prete come uomo e credente che spera e come uomo che vive al servizio della speranza degli altri. Credo che tutto si giochi sul primo aspetto. Cosa significa per un credente ‘sperare’? e quali conseguenze ha la speranza nella sua vita? Che cosa cambia nel suo modo di vedere e affrontare il mondo, di vivere i rapporti con gli altri? Partiamo da un semplice fatto. Per un bambino che nasce in Italia la speranza di vita è in media 74 anni se si tratta di un maschio e 80 anni se si tratta di una femmina. Speranza di vita: e cioè la lunghezza della vita biologica che le condizioni sanitarie in Italia riescono ad assicurare (s’intende: in media). In un libro recente (‘Verso l’immortalità?’) uno degli uomini di scienza più visibili oggi, Edoardo Boncinelli, s’interroga sul futuro e prevede la possibilità di raddoppiare o forse addirittura di triplicare questa misura: i trapianti, i sostituti meccanici di organi, la possibilità di operare a livello genetico aprono questa possibilità. Viene da dire: sia benedetto il Signore! E: Dio benedica gli uomini di scienza! E tuttavia: sono incontentabile se dico che anche questo non mi basta? Anzitutto perché duecentotrecento anni finiscono pur sempre e il limite della morte rimane sempre lì, all’orizzonte, con il suo carico di paura e di angoscia. In secondo luogo perché rimane aperto il problema della qualità della vita: duecento anni di gioia sono un bel patrimonio, ma duecento anni di angoscia sono un peso che rischia di diventare insopportabile. Dicono ci sia il boom della chirurgia estetica. Niente da dire; ma posso sospettare che dietro a questo boom ci sia una profonda insoddisfazione per ciò che siamo? Per la realtà effettiva della nostra esistenza? Senza svalutare ciò che di bello accompagna l’esistenza dell’uomo ricordo che il vangelo fa un’altra promessa: quella della vita eterna. E quest’aggettivo non ha solo un valore temporale quantitativo (cioè: un’esistenza che si distende nel tempo senza avere un termine), ma ha soprattutto un valore qualitativo (cioè: un’esistenza che ha qualità non mondana, ma divina; un’esistenza che partecipa della bellezza e della santità della vita di Dio). Prendete, ad esempio, i pochi versetti che si trovano all’inizio della prima lettera di Pietro: 1Pt 1,3-5. Ma mi torna inevitabile l’obiezione che viene ripetuta alla noia da tutti oggi: mi parli di una speranza futura della quale non ho prova alcuna; chi mi dice che non si tratti di un’illusione? Dell’illusione di chi è troppo debole per sopportare 23 vinto l’accusatore, il satana “per mezzo del sangue dell’agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio; poiché hanno disprezzato la vita fino a morire.” Il satana, secondo una famosa immagine del libro di Giobbe, è colui che accusa i fedeli di vivere una religiosità apparente, che vorrebbe essere amore di Dio ma in realtà è piuttosto difesa egocentrica del proprio benessere terreno. Ebbene, i martiri accusano l’accusatore, lo condannano perché scelgono di amare Dio più del mondo, più della loro stessa vita fisica. Chi agisce consapevolmente in questo modo testimonia in modo credibile (cioè in modo che non può essere considerato tattico) la verità della risurrezione e del mondo futuro. Accanto al martirio in senso stretto (perdita della vita per testimoniare Cristo e il vangelo) potete mettere tutti quei comportamenti che esprimono una dedizione autentica di se stessi. Pensate alle parole di Pietro nel vangelo: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito…” Chi lascia tutto per il vangelo rende evidentemente testimonianza al valore del vangelo stesso e si apre alla speranza di ciò che il vangelo promette e dona. Credo che si possa leggere in questa prospettiva il celibato ‘per il regno dei Cieli’, così come la povertà e l’obbedienza. Sono comportamenti che, in ottica cristiana, sono giustificati non da un’ascesi che afferma se stessa, ma da una dedizione a Cristo considerato come pienezza della propria vita. Come dice sant’Ignazio in una sua bellissimo preghiera: “…et dives sum satis nec aliud quicquam ultra posco” (“sono ricco abbastanza e non cerco nient’altro”). B. Diventa testimone del Risorto e quindi della speranza cristiana una comunità nella quale si viva con coerenza e intensità il comandamento dell’amore fraterno, quello che il NT chiama agàpe, cioè l’amore gratuito, oblativo. Parto da un testo famoso degli Atti degli Apostoli, il secondo ‘sommario’ che descrive l’esistenza della Chiesa di Gerusalemme: “La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che apparteneva, ma ogni cosa era tra loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano. Portavano l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno.”(At 4,32-35). Si noti la precedenti. Se lo stile della mia vita è l’attaccamento a ogni soddisfazione e il rifiuto di ogni privazione, sono costretto a non prendermi impegni irrevocabili; questi, infatti, mi condizionerebbero inevitabilmente, mi costringerebbero a rinunciare a possibili occasioni nuove e migliori. Debbo rimanere libero per poter cogliere al volo quello che futuro potrebbe offrirmi. Credo non sia difficile riconoscere in tutte queste dimensioni delle caratteristiche evidenti del nostro tempo: la ricerca incessante di emozioni sempre più forti, il rifiuto risentito di ogni rinuncia, l’incapacità di assumersi impegni a lunga scadenza. Tutti segni, se vale l’analisi precedente, di una crisi di speranza. L’uomo d’oggi fa fatica a mettere in gioco ciò che ha perché fa fatica a sperare nel futuro. Nel cap. 2 del libro della Sapienza c’è una delle espressioni più lucide e significative del dinamismo implicito in una concezione materialista della vita. Il materialismo non è una concezione filosofica senza impatto sulla vita di tutti i giorno; al contrario è un modo di vedere la realtà che incide pesantemente su pensieri, decisioni e comportamenti. Il libro della Sapienza lo dice formulando lo stile di vita ‘materialista.’ Ciò che lo caratterizza è la paura di perdere qualcuna delle tante occasioni che la vita offre; e da questa paura (ossessione) scaturisce uno stile di vita che non si prende cura alcuna degli altri. “Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore giovanile… perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. Spadroneggiamo sul giusto povero… la nostra forza sia regola della giustizia perché la debolezza risulta inutile.” C’è quindi una progressione logica: paura della morte – attaccamento ossessivo ai beni presenti – oblio della giustizia (dei valori umani) – comportamento egoista e criminale. A questo fa riferimento la lettera agli Ebrei quando dice che il diavolo si serve della paura della morte per renderci schiavi e cioè per bloccare l’impulso che ci porta all’amore e al dono di noi stessi per renderci invece schiavi dell’egoismo più vuoto. V Possiamo allora fare l’ultimo passo e chiederci in positivo le caratteristiche di un’esistenza aperta alla speranza. E per prima cosa metterei il martirio. Il martire testimonia la risurrezione perché ama Dio più che la sua vita, pone in Dio una fiducia maggiore di quanto sia grande la sua paura della morte. Nel libro dell’Apocalisse si parla dei martiri che hanno 24 quindi solo una forma di espressione del bisogno) siamo di fronte a un miracolo inspiegabile dal basso e che ha la sua luce nella rivelazione di Dio. Chi è chiamato a credere in Cristo deve poter trovare e sperimentare nella comunità cristiana l’amore fraterno. In caso contrario le parole che gli vengono annunciate avranno un suono poco credibile. C. Una comunità che viva del perdono di Dio e pratichi il perdono fraterno. Fa parte dell’esperienza quotidiana dell’uomo l’errore o, meglio, il peccato. Preferisco il tema del peccato perché richiama la profondità dell’errore che non è solo un incidente di percorso involontario ma è la manifestazione di un male che sta dentro di noi e che si oppone alla vita, all’amore. Ora, il peccato rimane come un inciampo inquietante sul cammino dell’uomo. Tanto inquietante che l’uomo ha la tendenza istintiva a rimuoverlo; a volte lo fa negando di avere peccato e cercando scuse, accusando con violenza gli altri; altre volte cerca semplicemente di rimuovere e dimenticare come se la cosa fosse trascurabile. Sono però entrambi atteggiamenti pericolosi perché non permettono di superare positivamente l’errore ma lo negano e in questo modo finiscono per conservarlo e renderlo ancora più pericoloso. La domanda è: come fare perché il peccato, l’egoismo che liberamente e consapevolmente abbiamo scelto producendo così del male e immettendolo nel mondo, come fare perché non diventi un ‘buco nero’ capace di corrodere e annientare i nostri progetti o le nostre speranze? Come fare per trasformarlo in esperienza positiva nel cammino della vita e della maturazione umana? Non c’è altra via che il perdono inteso nel senso più profondo: non solo, cioè, come esonero dalla pena, ma come ricupero del passato trasformato in occasione nuova di inizio e di realizzazione di sé. Ma chi può perdonare?. Dio solo può perdonare in senso vero perché il perdono vero dev’essere per forza creativo, deve produrre dal nulla quello che io ho volontariamente distrutto, deve aprire una possibilità dopo che io l’ho annientata. Il perdono di Dio non si limita a sospendere la punizione per il male compiuto; e d’altra parte non cancella magicamente il passato come se non fosse accaduto; piuttosto introduce il passato con la sua negatività dentro alla dinamica di un’esistenza in cui il peccato diventa opportunità di conversione e di rinnovamento. Il peccato, riconosciuto come tale (e quindi non scusato), compreso in tutta la sua negatività (e costruzione del testo: parte con la descrizione dell’amore fraterno che unisce la comunità (‘un cuor solo e un’anima sola’) e dell’espressione di questo amore fraterno nella comunione dei beni (‘ogni cosa era fra loro comune’); poi passa a parlare della testimonianza resa alla resurrezione di Gesù e dice che era resa ‘con grande forza’; poi sembra tornare indietro, al tema iniziale, e insiste sul fatto che “nessuno tra loro era bisognoso” proprio a motivo della condivisione dei beni. Credo non si potesse legare in modo più stretto la testimonianza di fede con la prassi di carità; se la testimonianza è forte, cioè credibile, questo non è per la coerenza interna logica del messaggio, ma per la trasformazione efficace operata nella vita della comunità. Che Gesù sia risorto, sia cioè un vivente, sia quindi ancora capace di agire nella storia degli uomini si manifesta nell’amore fraterno della comunità cristiana, un amore che ha in Gesù la sua origine e la sua spiegazione. L’amore fraterno non è solo un comandamento che viene consegnato ai singoli come criterio di valutazione etica ma è lo stile della comunità che il vangelo vuole creare. Basti pensare alle parole di Gesù: “Vi do un comandamento nuovo: che ci amiate gli uni gli altri. Siccome io vi ho amato affinché anche voi vi amiate gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.” (Gv 13,34-35) Credo non sia scorretto ricavare l’affermazione corrispondente: “Non si potrà sapere che siete miei discepoli fino a che non avrete amore gli uni per gli altri.” Il motivo di questa esigenza è chiaro: il vangelo annuncia l’amore di Dio per noi rivelato e donato effettivamente nella vita di Gesù. Dove questo amore giunge e dove viene accolto è in grado di cambiare la vita delle persone e la cambia ponendo nel cuore delle persone il desiderio e la capacità di amare i fratelli: “Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli.” (1Gv 2,14) Si può dire con verità che se manca l’amore fraterno l’annuncio dell’amore di Dio rischia di rimanere puramente verbale; e viceversa dove c’è l’amore fraterno c’è già una testimonianza dell’amore che scende da Dio. Si legge nella prima lettera di Giovanni: “Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi.” (1Gv 4,12) Come faceva notare von Balthasar, la mediazione della natura per trovare Dio ha perduto molto della sua forza per l’uomo d’oggi. Ma rimane, anzi ha acquistato ancor più forza e chiarezza, la mediazione dell’amore umano. Dove questo amore è autentico (non è 25 mitezza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall’alto: è terrena, carnale, diabolica; poiché dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene dall’alto, invece, è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.” I campi di attuazione di questo stile mite sono molteplici: la vita di famiglia, anzitutto, nel perdono continuo che gli sposi si cambiano; la vita nelle comunità cristiane; negli organismi di partecipazione (Consigli pastorali e presbiterali e per gli affari economici) e così via. D. Una comunità che crede nella resurrezione vive un’autentica esperienza di libertà. Vengono in mente quelle parole stupende della prima lettera di Giovanni: “Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede.” Parafrasi: tutto ciò che riceve la sua esistenza da Dio e si sa amato da Dio non è sottomesso del tutto ai condizionamenti del mondo e può muoversi scegliendo con libertà le vie di attuazione dell’esistenza. Attraverso la fede Dio con il suo amore viene accolto dall’uomo come fondamento della sua esistenza e diventa perciò quello che dà il colore fondamentale all’esistenza stessa. Su chi crede, perciò, il mondo non può più esercitare un dominio assoluto; non si presenta più come una ‘potenza’ che s’impone alla debolezza dell’uomo ma piuttosto come creatura da rispettare e accogliere con riconoscenza dalla mano provvidente di Dio. Questo discorso è comprensibile a partire dalla percezione del mondo come ‘potenza’ che chiude l’uomo in una morsa di paura e di desiderio e che lo costringe in questo modo a comportamenti superficiali, stupidi, irragionevoli, irresponsabili o egoistici. Mi spiego: noi viviamo in un mondo grande che esisteva prima di noi e che esisterà anche dopo la nostra morte. Da questo mondo ricaviamo il necessario per vivere (il cibo, ad esempio, ma anche gli affetti, le gratificazioni e così via). Possiamo considerare il mondo come una creatura e quindi usarne secondo le necessità rendendo grazie a Dio da cui viene ogni bene. Ma, a motivo del nostro egoismo, siamo portati a considerare il mondo come una potenza che può dare la morte e può dare la vita: può dare la morte con un semplice virus e quindi di fronte al mondo mi sento in una condizione di debolezza e quindi quindi condannato) per grazia di Dio diventa fonte di umiltà, di tolleranza, di carità creativa. Possiamo allora dire: testimonia la resurrezione di Cristo, la vittoria dell’amore di Dio sul peccato e sull’ingiustizia dell’uomo, una comunità in cui sia vivo l’atteggiamento di perdono. Il riferimento naturale è Mt 18 dove Pietro pone a Gesù una domanda: “Quante volte dovrò perdonare il mio fratello se pecca contro di me?” La risposta è : “Non ti dico fino a sette volte ma a settanta volte sette.” L’insegnamento è poi completato con la stupenda parabola del servo spietato con la sua durissima conclusione: “Così anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello.” Il discorso del perdono è uno dei più difficili e necessari insieme. Difficile perché sono più le contraffazioni del perdono che il perdono autentico; per di più negli ultimi anni si sono diffuse tante banalità sul perdono che è difficile recuperare il senso autentico senza uno sforzo consapevole. Nello stesso tempo il perdono è tra le dimensioni assolutamente indispensabili di una esistenza che voglia camminare verso la maturità. La comunità cristiana deve essere una comunità che offre sempre daccapo il perdono come grazia creatrice di Dio che permette al cristiano di ripartire ogni giorno con energia intatta senza essere impedito dai suoi errori e peccati passati. Naturalmente questo richiede un senso vivo del peccato, la confessione sincera dei propri errori, lo svilupparsi di un’autentica conversione con tutto quello che la conversione comporta. Naturalmente una comunità che riceve continuamente il perdono del Signore non può che introdurre questo perdono nel suo stile di vita. Capisco bene l’ambiguità di queste affermazioni: si potrebbe pensare, infatti, a una comunità che accetta tutto bene e male, che confonde giustizia e ingiustizia in una specie di colore grigio che toccherebbe alla grazia di Dio rendere magicamente bianco. Il rischio c’è; e tuttavia il rischio non è motivo sufficiente per negare l’esigenza del perdono. Vorrei dire così: una comunità che perdona è riconoscibile dallo stile di mitezza, di misericordia, di pace che caratterizza i rapporti tra le persone. Il contrario, quindi, di quella continua litigiosità che sembra dilagare nella nostra società, non solo a livello politico, ma anche a livello interpersonale; litigiosità che rischia, a volte, di debordare anche nel terreno ecclesiale. Penso a riflessioni come quella di san Giacomo: “Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri la buona condotta le sue opere ispirate a saggia 26 non fa altro che accogliere questo amore: “Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori….” Paolo enumera qui le ‘potenze’ che stanno dietro a quelle esperienze disorientanti di debolezza che abbiamo ricordato sopra. Col termine ‘potenze’ indico realtà mondane ma considerate e sperimentate nella loro capacità di impaurire e di sedurre. Ebbene, questa capacità è loro sottratta dalla forza della fede; la fede diventa sorgente di libertà, di una libertà profonda e invincibile. di paura; può dare la vita con la varietà e la bellezza delle cose e quindi, impaurito, mi rivolgo al mondo per chiedergli quella sicurezza di cui sento il bisogno. La considerazione del mondo come creatura mi permette di vivere nel mondo con piena libertà, mentre la percezione del mondo come potenza terribile o seducente mi priva della libertà e mi costringe a fare quello che il mondopotenza mi chiede ed esige da me. Ad esempio: quando il denaro da strumento di scambio si trasforma in potenza pone all’uomo delle richieste esigenti: può chiedergli di essere disonesto, o di tradire un amico, o di trascurare la famiglia. Lo stesso si può dire delle altre realtà mondane che assumono agli occhi dell’uomo dei tratti divini: il potere, ad esempio, o il sesso. Mi piace concludere con la citazione di uno stupendo testo paolino che può fare davvero da sintesi di tutto quello che abbiamo detto: Rom 8,31-39. È la conclusione di quel cap. 8 della lettera ai Romani che delinea l’esistenza cristiana come ‘vita secondo lo Spirito’ e lo si potrebbe definire come ‘inno alla libertà del cristiano.’ All’origine di tutto sta la presa di posizione di Dio a favore dell’uomo e della sua vita. A partire da qui Paolo può porre quell’interrogativo che fonda la sicurezza del cristiano: “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?” Ma come posso affermare che “Dio è per noi”? La risposta è chiara: “Egli che non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni altra cosa insieme con lui?” L’incarnazione è interpretata come ‘dono’ di Dio per gli uomini; la passione e morte di Gesù come il segno della serietà dell’amore di Dio che “non ha tenuto per sé, non ci ha negato nemmeno il suo proprio Figlio”, ma ci ha amato in modo così intenso da fare dono del Figlio. Di fronte a un amore così profondo che cosa può essere in grado di separarcene? Qui Paolo enumera sette esperienze di debolezza e di sofferenza dell’uomo che di per sé potrebbero avere la forza di far piombare l’uomo nella desolazione del sentirsi abbandonato, senza speranza: “la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada”. Di fronte a tutte queste realtà l’uomo non può che sentire la propria debolezza e insufficienza. Può accadere all’uomo che addirittura abbia da soffrire proprio per la sua fedeltà a Dio; non verrà meno allora, in questo caso la sua fede? No; e il motivo è chiaro: non viene meno l’amore di Dio per lui e quindi rimane il fondamento solido della fede che * * * Il relatore ha poi risposto alle seguenti domande (*) Domande - Innanzi tutto ringrazio mons. Monari per la relazione che mi è piaciuta molto. Il mio intervento vuole aggiungere un altro elemento di riflessione, preso dall’ufficio delle Letture, da S.Agostino, che dice: “ gli uomini privi di speranza quanto meno badano ai propri peccati, tanto più si occupano di quelli altrui”. In questa frase io vorrei sottolineare la prima parte, “quanto meno badano ai propri peccati”, come un elemento della speranza che mi interessa sottolineare; cioè la speranza è molto legata al timore di Dio, non quello servile,ma quello filiale:con lo stesso piede con cui vado incontro al Signore come mia speranza, mi allontano dal peccato. Mi sembra che questo sia uno dei segni di speranza e anche una descrizione del mondo contemporaneo: la perdita del senso del peccato. Poi la seconda parte “tanto più si occupano di quelli altrui”e poi illustra:“infatti cercano non che cosa correggere, ma che cosa biasimare”. Anche quest’altro aspetto mi sembra un segno di speranza e di disperazione. Il cuore pieno della speranza nel Signore bada più al bene da compiere nella propria vita, che alla critica verso il mondo, verso gli altri; viceversa l’atteggiamento ipercritico e pieno di malumore, è tipico della disperazione e anche questo mi sembra un segno presente nella nostra civiltà. - Vorrei dire due cose: la prima è una richiesta di chiarimento. Mi ha colpito che si sia partiti dalla speranza di Dio nei confronti dell’uomo, però a questo punto mi domando: si può dare una continuità alla speranza di Dio e alla speranza dell’uomo, senza dire prima che cosa significa per (*) 27 Trascrizione degli interventi registrati, non rivisti dagli autori scritturistico si evinceva che l’immanentizzazione della speranza equivale a una disperazione. Perché la speranza, allorché si lega alla materia, viene a decadere: è una speranza che non è tale, perché la speranza non può avere un orizzonte storico, immanente, ma deve avere una meta che è metastorica. Vorrei dunque chiederle una delucidazione su questo: mi sembra che l’orizzonte in cui si gioca la nostra speranza sia un orizzonte tripolare, quello delle virtù teologali, fede, speranza e carità. Grazie. Dio la speranza ? Perché la speranza dell’uomo è una speranza con compromessi notevoli: se è infondata, l’uomo perde la sua esistenza. Ho provato a darmi una piccola risposta: con l’incarnazione Dio si espone concretamente alla possibilità che la comunione trinitaria si interrompa: dal momento in cui il figlio associa a se la natura umana entra anche il rischio concreto di incontrare il male. E quindi se Dio anche per una volta sola ha incontrato il male, avrebbe sperimentato l’annientamento stesso di Dio. Questo darebbe la possibilità che il rischio di Dio divenga rischio per l’uomo, e la speranza di Dio sia come la speranza dell’uomo. La seconda cosa è che dal suo discorso emerge che il fondamento ontologico della speranza umana è la resurrezione di Cristo, e tante volte sembra che in modo generico la speranza sia un dogma di fede, una pacca sulla spalla, dicendo “dai, abbi fede che le cose andranno meglio!”, e invece la differenza tra la fede di Giobbe e l’Apocalisse mette in luce, che il cristiano spera in Dio aldilà della morte, perché il fondamento del cristiano è un fondamento irrinunciabile. Mentre con Giobbe Dio si mette d’accordo con Satana, dicendogli di non togliere la vita di Giobbe, nell’Apocalisse la speranza dell’uomo in Dio va anche oltre la morte. Secondo me il primato della speranza umana è la resurrezione di Cristo e la resurrezione della carne; io posso avere una vita tragica, avere una prospettiva di vita fino a 35 anni per malattia, come la silicosi, e sperare nella resurrezione della carne, è questo fondamento che tiene vive tutte le piccole speranza della vita quotidiana” Risposte Provo a dire qualcosa sulle prime domande, il discorso di San Agostino è molto bello e posso solo confermare le cose che sono state dette: il legame con il timore di Dio, non c’è dubbio. La differenza tra un credente che ha speranza e che ha, proprio per questo, la capacità di sopportare la percezione dei suoi peccati, perché spera in Dio e invece la condizione di chi non riesce a porsi di fronte al proprio peccato, è che corre il rischio di occuparsi dei peccati degli altri. Mi viene in mente una battuta del Card. Biffi, che è una persona arguta e ha sempre delle illuminazioni: “dicono tutti che l’uomo di oggi ha perso il senso del peccato, non è vero: l’uomo di oggi il senso del peccato ce l’ha tantissimo, solo che ha il senso del peccato degli altri”. Cioè, non ha il senso del suo peccato. Il motivo è la tendenza che abbiamo tutti a difendere noi stessi, ma il fatto è che l’uomo di oggi fa fatica a gestire il suo peccato, non sa cosa farsene, perché se non c’è un perdono la relazione con il proprio peccato diventa una relazione distruttiva: mi annulla, mi annienta. E’ solo la dimensione del perdono che mi permette di stare di fronte al mio peccato, con sincerità ma nello stesso tempo con speranza, con una possibilità di superamento, di conversione, di perdono, di ripresa. Allora credo che l’osservazione di S.Agostino sia acuta. Quando l’uomo non è capace di guardare i suoi peccati, inevitabilmente tende a costruire sui peccati degli altri, a badare a quello che può biasimare negli altri perché, come diceva il Manzoni nelle sue Osservazioni sulla morale cattolica, la critica degli altri ci fa sentire a posto; quando vedo e critico qualcosa di sbagliato negli altri, suppongo: oh, io son pieno di difetti, ma quel difetto lì io non ce l’ho, quell’atteggiamento non è mio: è di Tizio, di Caio e di Sempronio. E’ un modo, evidentemente, di giustificare se stessi. La - Chiederei un chiarimento sul rapporto tra martirio, perdono e libertà. Inoltre una mia domanda è questa: qual è la forma di martirio che nel ministero noi saremmo chiamati a vivere? Dobbiamo dare retta ai profeti di sventura che ci dicono che dovremo imbatterci nel martirio delle crociate;o dobbiamo dare più retta forse a quel martirio bianco fatto piuttosto delle piccole difficoltà di ogni giorno e donarle come offerte; o è prevedibile che ce ne saranno altri ? Grazie. Lei ha approfondito la connotazione relazionale. Nella filosofia contemporanea è stata data una rilevanza congrua alla relazione: pensiamo a tutto il personalismo, Marcel, Buber, Levinas, ecc. Ora la relazione è dimensione costitutiva della persona umana e la speranza si gioca nella relazione. Nel suo riferimento 28 molta timidezza lo dico, che dentro la struttura della speranza umana questa apertura alla trascendenza è presente, perché la speranza dell’uomo quando è autentica è sempre una speranza senza condizioni; non è condizionata dal fatto che io spero in te “purché tu non diventi isterica, – lo dico perché l’ho sentito – ti sposo, ma se diventi isterica, ti pianto”: cioè io spero in te, ma a queste condizioni. La speranza dell’uomo, come struttura, tende ad essere sempre senza condizioni. Io spero in te! Punto. E dove c’è una dimensione di questo genere, c’è evidentemente implicito il discorso che questa speranza rimane anche di fronte alla morte, misteriosamente, perchè la morte dal punto di vista dell’esperienza cancella la relazione, il rapporto, ma dentro allo “spero in te” implicitamente questo ci sta. Allora, il discorso della resurrezione del Signore ci sta dentro benissimo e si innesta, si armonizza con questa dimensione che fa parte della vocazione dell’uomo alla trascendenza, che sta dentro alla sua volontà di conoscere, di amare e quindi anche dentro alla volontà di sperare. Bisognerebbe che riuscissimo a spiegarlo, questo: che cosa cambia nel mondo per il fatto che Gesù Cristo è risorto? Che non venga pensato solo come una prova, una dimostrazione della divinità di Gesù e cose di questo genere, non è solo questo. E’ proprio la manifestazione dell’azione salvifica di Dio dentro al mondo, per cui un pezzettino di mondo viene introdotto dentro il mistero della gloria di Dio: e questo cambia tutto. Questo distrugge l’autosufficienza del mondo: c’è una crepa nel mondo e il corpo risorto di Cristo è una crepa del mondo; nel senso che il mondo non è autosufficiente, non è autonomo, c’è qualche cosa che è sfuggito, qualche cosa del mondo, ma che è sfuggito alla presa del mondo. Il senso sta dentro a questo. Adesso i teologi sono bravi; quando io ero ragazzo sulla resurrezione di Gesù si diceva pochissimo; ricordo il primo libro di Durvell, su la resurrezione del Signore, come fondamento di redenzione: ma era rarissima una riflessione di quel genere. Ora i teologi sono bravi e ci danno del materiale prezioso. Sono d’accordo con il discorso delle piccole speranze di tutti i giorni, questo è vero; ci stanno bene le piccole speranze, ma evidentemente il loro valore poggia solo sulla speranza grande che è quella della vittoria sulla morte; la speranza deve andare a finire lì, come la fede. La fede è sempre, almeno implicitamente, la fede in un Dio che resuscita i morti, altrimenti non è un Dio credibile. giustificazione o viene gratuitamente dal Signore o altrimenti, di dritto o di rovescio, ce la facciamo noi; nei modi anche più strani, perché l’attaccamento al successo, ai soldi, al potere è una forma di giustificazione della nostra vita: è misterioso, ma è così. Sul secondo intervento: che cosa rischia Dio? Lo accennavo prima, io faccio un po’ fatica ad entrare dentro ad una riflessione metafisica, coerente e piena, dal punto di vista di Dio, primo perché non sono un filosofo e non ho tutte le categorie che sarebbero necessarie e perché poi un pochino mi sento intimidito davanti al mistero dell’azione e dell’amore di Dio. E quando dicevo che Dio spera nell’uomo, l’ho detto nel senso che ho tentato di spiegare, ma non pretendo di sapere esattamente cosa significa esattamente la speranza per Dio. Posso ripetere che Dio ha fede nell’uomo, però mi rendo conto che è un modo di parlare molto povero e potrebbe anche diventare equivoco: il fatto che la Bibbia non usa mai questo termine qui è già significativo. Lo uso perché mi sembra che l’atteggiamento di Dio nei confronti dell’uomo sia davvero il fondamento della risposta dell’uomo nei confronti di Dio. Però di lavorarci sopra troppo non me la sentirei, io mi fermerei sulla soglia. Sono d’accordo sul fatto che il discorso del rischio di Dio lo ritroviamo nel modo più pieno nell’incarnazione, ma non lo metterei nell’ipotesi che il Figlio dica di no al Padre, perché questa è un’ipotesi contraddittoria in sé: se il Figlio è il Figlio, credo che il sì del Figlio al Padre sia pieno, perché questa è la sua esistenza, non esiste altrimenti che in quello. Lo metterei invece nel rischio dell’incarnazione in quanto tale, cioè nella crocifissione del Signore: è così vero il rapporto che Dio stabilisce con l’uomo, che in questo rapporto, in Gesù Cristo, Dio ci ha messo il dono di sé stesso. La croce, l’umiliazione, la sofferenza, la morte entrano dentro a questo rischio di Dio. Tornando però a quello che dicevo prima, cioè alla consapevolezza che un modo umano di parlare di Dio è necessario, altrimenti cosifichiamo Dio - ma è un balbettare - io non riuscirei ad andare più in profondità. Sono d’accordo sulla seconda cosa, che il fondamento ontologico è la resurrezione di Gesù Cristo; questo sarebbe da spiegare in un modo più diffuso, ma credo che sia verissimo. La resurrezione di Gesù Cristo vuol dire per primo che Dio opera e agisce dentro l’esistenza concreta dell’uomo e dentro l’esistenza del mondo. La resurrezione di Cristo vuol dire che Dio ha reso eterna l’umanità di Gesù e questo è il fondamento di ogni speranza. Credo che si possa dire, però con 29 comportamento concreto, nella carità; pertanto la carità le testimonia entrambe. Sono d’accordo anche sul fatto che l’esperienza della speranza sia sempre un’esperienza di liberazione, cioè l’uomo che spera alla fine sta lottando contro la schiavitù, la tenebra e la disperazione. C’è una logica di lotta dentro alla scelta della speranza, è una presa di posizione che non viene semplicemente dall’ottimismo nativo, è una cosa diversa dall’ottimismo di chi istintivamente pensa che comunque le cose vadano a finire bene; no, la speranza è una presa di posizione, è un atteggiamento consapevole, libero di fronte alla realtà e questo atteggiamento nasce sempre - almeno implicitamente - in contrasto con la tentazione della disperazione, con la tentazione della rinuncia, dell’abbandono della lotta. In questo senso la speranza suppone anche l’amore: si spera in qualcuno quando gli si vuole bene, la speranza è senza condizioni proprio perché gli si vuole bene; non posso mettere delle condizioni alla mia speranza in Dio o alla mia speranza nell’amico. L’ottica è: debbo andare, l’amore mi chiede di porla, questa speranza, questa presa di posizione, senza riserve. Sulle forme di martirio del prete, un pochino le ho accennate; ma io le riporterei al brano del vangelo che ho proposto prima: “ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito”. Lì, in questa scelta, c’è la testimonianza del valore di Gesù Cristo e del valore di quella speranza che il discepolato porta con sé. Se io vado dietro a Gesù Cristo, vuol dire che io spero in Gesù Cristo per quello che la sequela può produrre nella mia vita, sono convinto che andare dietro a Gesù Cristo non è una diminuzione della mia umanità, ma è la perfezione di quella vocazione all’amore e all’incontro, alla realtà e al mondo che io, in quanto uomo, mi porto dentro; cioè sono convinto, e il Papa lo ricorda tantissime volte, che in questa sequela c’è una crescita di umanità, non una diminuzione. Tutto si gioca in questo:“abbiamo lasciato tutto”: la famiglia, un possesso autonomo, però abbiamo bisogno di metterci dentro anche i beni spirituali: abbiamo lasciato il bisogno del successo, la gratificazione di essere il primo, la gioia di essere autonomi e autosufficienti. Dove c’è questo, non c’è dubbio, c’è la testimonianza della speranza, più o meno perfetta. Quando c’è la morte per il martirio questa testimonianza è piena, prima della morte no, prima della morte qualcosa ce lo teniamo in mano, però in quella direzione va tutta la vita del prete e tutta la vita del discepolo. Sull’ultimo intervento, di Davide, sono molto contento di tutto quello che ha richiamato. Attenzione, sono partito da Marcel perché è uno dei pochi che ho letto, io non sono un filosofo, ma mi piace da matti: tutto il discorso che ricordava Davide sulla relazione, tutta la filosofia di Buber, Levinas e tutte queste cose, penso che siano approcci alla realtà e all’uomo che dal punto di vista della fede e del vangelo sono preziosi e belli, sono proprio belli, e ci aiutano ad avere nei confronti dell’uomo una consapevolezza di stima, di rispetto, di gioia dell’identità e di quella libertà e coscienza che noi ci portiamo dentro. Così, non c’è dubbio, il discorso delle virtù teologali vuole che siano tenute insieme: fede e speranza sono alla fine lo stesso atteggiamento nei confronti di Dio, secondo dimensioni diverse: secondo la dimensione dell’affidamento totale e di quella del tempo e della storia, ma credo che la fede e la speranza siano strettamente legate tra di loro. E sono d’accordo sul discorso della carità come testimonianza dell’una e dell’altra: la fede e la speranza si esprimono, vivono, e diventano un Domande - Potrebbe mostrare delle applicazioni dei del discorso che lei ha fatto a quelle caratteristiche che sono forse più presenti nei sacerdoti dei primi anni di ministero: la ricerca dell’emozione, del successo, della autonomia, dell’indipendenza? Penso che sia una esperienza comune che questi elementi, benché possibilmente presenti in tutti, tuttavia si mostrino di più nella vita dei sacerdoti delle nuove generazioni. Quali possono essere i mezzi per alimentare quotidianamente la speranza teologale nella vita del sacerdote? - Dal discorso da lei pronunciato emergono due modi di relazione: la dipendenza e l’appartenenza, io ha in mente la parabola del figliol prodigo, con l’esempio dei due fratelli: il figliol prodigo si stacca dalla dipendenza e nella situazione in cui si era ritrovato avvertiva l’appartenenza al padre, mentre l’altro sotto la dipendenza continua avvertiva poco l’appartenenza al padre. Pensando anche quello che Gesù diceva ai suoi discepoli, che erano suoi e che erano per lui. Come coltivare l’appartenenza e la dipendenza a Cristo da seminaristi nella speranza? 30 stima degli altri ha bisogno. E’ vero che esiste lo stoico che dice di non aver bisogno di niente e di nessuno, “perché faccio da solo”, ma questa non è l’esperienza normale dell’uomo. A motivo dell’importanza della relazione, l’atteggiamento degli altri nei miei confronti dice qualche cosa, è per me stimolo, mi consola o mi mette in difficoltà e il cambiamento di status sociale del prete che è avvenuto, è un motivo di fatica. Così ancora, è vero che noi non seguiamo il successo, ma è anche vero che se io predico o faccio catechismo, lo faccio con la speranza che chi mi ascolta faccia un cammino di discepolato e quando questo non avviene è un aspetto di frustrazione inevitabile: non si può essere indifferenti rispetto all’accettazione o no del Vangelo di quelli ai quali lo annuncio. Di fronte a queste cose una percezione di piccolezza e fragilità ce la portiamo dietro: la percezione di non essere all’altezza del compito, all’altezza della missione e così via. Bisognerebbe riuscire a vedere queste cose come una sfida, sopportandone il peso: non facendo finta che non ci siano e nemmeno rifiutarle come se fossero percezioni non giuste, perché devo essere immune da queste dimensioni qui. No, bisogna sentirne tutta l’amarezza, perché è proprio lì che può scaturire la speranza: proprio quando percepisco tutta la mia insufficienza può nascere quel “io spero in Te per noi”. Quando San Paolo sperimentava la famosa spina nella carne, nel capitolo 12 della lettera ai Corinzi, arrivava a percepire questo: che quando sono debole è allora che sono potente. Questo passaggio non è spontaneo, non avviene inevitabilmente: tutte le volte che percepisco di essere debole è allora che mi sento forte! No. E’ vero il contrario. E’ vero però che l’esperienza della debolezza, proprio perché mi mette in crisi, mi obbliga ad approfondire il rapporto con il Signore e a trovare in questo – perché non ce n’è un altro. E’ sempre solo nel rapporto personale con il Signore che il cammino della speranza può consolidarsi. Quindi alla domanda di come alimentare la speranza: è uguale a come alimentare il rapporto personale con il Signore. Perciò tutto quello che entra dentro all’ascolto, all’amore del Signore, alla obbedienza a Lui, alla sua parola come sorgente di consolazione; “tutto quello che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra consolazione”, come dice la lettera ai Romani. Ci sta dentro anche la testimonianza di quelli che hanno vissuto la speranza prima di noi; le esperienze dei santi sono consolanti, perché ci - Quando parlava del ricapitolare in Cristo tutte le cose come una prospettiva di speranza per noi pensavo al lavoro del prete e alla prospettiva di un seminarista: una prospettiva missionaria, profetica. C’è qualche suo consiglio in questo: cioè come trovare un equilibrio giusto tra la speranza escatologica e quella, legata a questa, che ha un riflesso terreno, visibile e in fondo è una promessa del Signore. Lui ci ha mandato a portare frutto e che questo frutto rimanga; allora nella vita di un prete c’è sì questa speranza di santità personale, che può avvenire anche nell’insuccesso totale dal punto di vista umano, ma allo stesso tempo c’è la speranza che le persone si convertano, accolgano la parola di Dio e noi possiamo vedere questo frutto; ed è una speranza che ci lancia nell’azione – mi sembra. Se non l’avessimo ci potremmo rinchiudere in una situazione egoistica, che porta all’inazione, magari ammantata dalla speranza escatologica – penso che sia possibile questa deriva. - Vorrei fare una domanda provocatoria: io ho ventiquattro anni, mi sento dare consigli da quelli più grandi di me e per esperienza personale mi sento incitato continuamente a consumare esperienze della vita, come goliardie o cose che i miei conoscenti considerano proibitive per il cammino che sto facendo, prima di dare forma definitiva alla mia vita. Mi domando: nella speranza, questa esigenza che ti spinge a continuare è una risorsa per raggiungere la pienezza della vita e consumarla per ciò che vale? Risposta Per quanto riguarda il primo e il secondo intervento, sull’alimentare la speranza, ricordavo anche prima che la speranza viene sempre dalla risposta a una possibilità, ad una tentazione o ad una prova che accompagna la vita dell’uomo: la tentazione della disperazione è il rifiuto del senso della vita, del senso delle cose che sto facendo, delle relazioni che intrattengo, questa possibilità qui è una possibilità che accompagna l’esistenza dell’uomo. La speranza si afferma esattamente contro questa visione. Nella vita del prete non c’è dubbio che ci sono tutta una serie di elementi che fanno parte della tentazione, della sfida. Che dal punto di vista sociale la figura del prete non abbia oggi quel riconoscimento, quella stima che era comune qualche decennio fa, possiamo dire che non ci interessa ma, in realtà, questo pesa sul nostro vissuto: perché l’uomo poco o tanto della 31 l’ero pensato, la vita come l’avevo sognata, ai rapporti come li avevo programmati e prendo quello che il Signore quotidianamente mi dona. Questa libertà mi rendo conto che è una libertà difficile, ma credo che sia preziosa e che sia nella linea della crescita nella speranza. Sull’equilibrio tra la speranza escatologica e l’impegno - sono d’accordo che evidentemente ci deve essere un equilibrio -, teoricamente non dovrebbero esserci dei problemi, nel senso che non è vero che quanto più spazio prende la speranza escatologica tanto meno ce ne rimane per l’impegno quotidiano: dovrebbe essere vero il contrario. Cioè speranza escatologica e impegno quotidiano non sono due realtà che si contrappongono, sono collocate a livelli diversi e allora possono essere contemporanei in tutti i miei comportamenti. L’apertura, il desiderio, la speranza della piena comunione con Dio, la speranza di quella ricapitolazione di tutte le cose in Gesù Cristo, non sono solo cose che avverranno dopo l’istante della mia morte, per cui devo aspettare che passino x anni per arrivare al compimento di quella speranza; sono invece realtà che vivo oggi, in questa situazione in cui mi trovo: è qui che devo dare forma di Cristo alla mia vita e quindi al pezzettino di mondo che dipende da me. E’ qui che posso vivere la comunione con Dio, in quei rapporti che sto vivendo ora, nelle amicizie che vivo, nei compiti che mi assumo, nelle responsabilità che porto; è qui. Quindi le due cose dovrebbero andare insieme: quanto più forte è la speranza escatologica, tanto maggiore deve essere l’impegno nel presente. Quanto più è autentico l’impegno nel presente, tanto più è aperto alla speranza escatologica. Perché non mi accontento certamente della realizzazione del programma pastorale che sto facendo in parrocchia; ci mancherebbe altro che quello fosse lo scopo della mia vita: quel programma pastorale è il mio andare incontro al Signore con la mia comunità, è quello lo scopo, mica aumentare i gruppi di vangelo; ci mancherebbe altro. Ma il fare gruppi di vangelo è il mio andare incontro al Signore, è il mio desiderio, l’espressione di quel cammino che sono chiamato a vivere. L’unico problema è quello che si chiama la pazienza, è il cammino nel tempo; e il cammino nel tempo, se vuole essere esperienza di speranza deve portare con se la pazienza: la non pretesa di vedere tutto e vedere tutto e subito, l’accettare i limiti delle persone, l’accettare i ritmi delle persone. Faccio direzione spirituale e…”muoviti!”: ma il suo ritmo è lui; posso sollecitare, ma devo fanno sentire non soli in questo cammino: vediamo che altre persone lo hanno percorso prima di noi; cioè tutti questi elementi entrano dentro alla alimentazione della speranza, ma tutto si gioca nel rapporto personale con Gesù; e questo va legato al discorso fatto sulla resurrezione di Gesù, del Signore come vivente, del Signore come presente nella vita dell’uomo, del cristiano e quindi alla possibilità di un rapporto con Lui non come un rapporto mentale, per cui lo penso, ma reale, per cui la mia vita è inserita nel mistero del risorto, nel mistero della sua presenza nel mondo e nella storia. Sulla dipendenza e sull’appartenenza: la accettazione della dipendenza è una delle maturazioni necessarie per l’uomo: al di fuori di questo c’è solo l’illusione. Nessuno, per quanto sia intelligente o furbo o santo, si è dato la vita da sé. L’uomo non si è fatto da sé: la vita è un dono, un dato: un qualcosa che mi ritrovo, in modo gratuito, dato da qualcuno che non sono io, dai miei genitori e non solo: da tutta quella realtà umana, spirituale e culturale che mi precede. L’accettazione di questo è un atto di saggezza e di consapevolezza fondamentale e questo dovrebbe andare nella linea della fede e della dipendenza da Dio. Sulla questione dell’appartenenza aggiungerei una cosa. Se capisco bene, la mia speranza cresce, matura tutte le volte che riesco a regalare dei frammenti di tempo, dei frammenti della mia esistenza, della mia giornata. Sto leggendo un libro che mi interessa molto e viene uno che mi chiede di confessarsi: piantare lì e confessare vuol dire alla fine rinunciare a qualcosa che era un mio programma, un mio desiderio. Io credo che lì c’è un aspetto di speranza: metto in gioco un pochino del mio tempo, del mio programma, del mio progetto, per essere pronto a quello che mi si presenta come chiamata e vocazione del Signore in questo momento. Ricordo una relazione di don Dossetti il vecchio, che riflettendo sulla sua vita diceva: mi sono accorto che le scelte fondamentali della mia vita non le ho fatte io, me le ha messe davanti il Signore e in qualche modo mi ha chiesto di dire di sì a cose che non avevo pensato; non me la sono fatta io a mia misura. E credo che questo sia vero: il riuscire a cogliere quello che il Signore mi sta chiedendo in questo momento, per una persona che mi si presenta, per una situazione che mi mette in crisi, per un mio peccato che mi umilia, tutto quello che volete: lì c’è dentro il cammino della speranza perché rinuncio al programma come me 32 Se con il discorso del consumo si intende il consumo della propria vita, questo è esattamente il contrario del consumo, quindi questo va bene. Esattamente il senso della vita dell’uomo è quello del “consumarsi per”: se qualcuno tiene conto della sua vita la perde, ma chi dona la sua vita per me e per il Vangelo la trova. Ci potete mettere il verbo consumare: chi consuma la sua vita per me e per il Vangelo la trova; questo va benissimo. Questa è un’altra dimensione: perché è il dono di sé, il consumo di sé stesso, delle proprie capacità, tempo, energie per il Signore e per gli altri, questo non solo è lecito, ma è evidentemente il massimo di realizzazione. Allora in tutte e due le dimensioni c’è un aspetto positivo. Il consumo delle cose ci vuole, è inevitabile. E’ vero che Ghandi diceva che la civiltà non consiste nell’aumentare i consumi, ma nel diminuirli; forse non è esatto del tutto, però dice una libertà che bisogna avere nei confronti del consumo. Il problema sorge quando il modulo del consumo diventa onnicomprensivo. Dice sempre Bauman: siccome la nostra società riesce a inventare degli oggetti di consumo con una velocità immensa, può accadere, e accade spesso, che molti, riescono a vivere tutta la propria vita consumando, senza mai chiedersi il perché lo fanno e del perché sono in questo mondo; e siccome la vita dura settanta anni oppure ottanta, uno può arrivare a riempire la propria vita di prodotti da consumare - perché ogni giorno c’è una cosa nuova, una emozione nuova, qualcosa di nuovo da provare - e senza mai interrogarsi, e quindi diventa tutto un pasticcio. Ma niente da dire sul consumo in sé. avere una pazienza infinita, immensa, perché le uniche pere che maturano in fretta sono quelle bacate, le pere buone hanno bisogno di tempo per maturare. Allora mi ci vuole quella pazienza lì, questo è un segno della speranza: quando riesco a sopportare la imperfezione del tempo, del presente, dei risultati. Per cui rimescoliamo pure tutta l’iniziazione cristiana, ma senza illuderci di riuscire a fare una iniziazione cristiana perfetta. Ce la mettiamo tutta con la pazienza e con il senso del limite. Quindi lanciati nell’azione, senza fermarci nell’egoismo, ma con questa pazienza che dice il nostro giocarci in tutto quello che facciamo, ma nell’apertura al Signore, nel rapporto con il Signore. Sulla questione del consumo, posso dire due cose, la prima: il fatto che il consumo è parte fondamentale della vita dell’uomo: se no uno non sta in piedi, non prega, non incontra gli altri, ecc. Il pasticcio, di cui parlava Bauman, è quando lo schema di consumo diventa uno schema totalitario, per cui gioco tutto nel modulo del consumo. Il consumo è il mio modo di rapportarmi con le cose; quando il modulo del consumo lo introduco nei rapporti umani, per cui l’amicizia mi diventa una forma di consumo, o la religione - anche la religione può diventare una forma di consumo allora c’è inevitabilmente una deformazione delle cose, perché vuol dire che religione o persone le ho “cosificate”, le ho fatte diventare beni di consumo. Il consumo è una dimensione della vita dell’uomo, non tutta la vita e non tutto deve essere ricondotto a consumo: ci devono essere delle dimensioni in cui il rapporto personale di gratuità prevale e vince. In questo senso il discorso deve essere semplicemente riequilibrato. 33 II Relazione Il contributo della formazione seminaristica nella maturazione della speranza Mons. Romano Martinelli Ai seminaristi perché vivano della speranza e ad essa possano educare. Ho trovato alcune difficoltà nello svolgere una riflessione che avvii ad una risposta. La prima riguarda il profilo, il clima dei seminari. I seminari italiani sono una galassia in continuo movimento. Non solo perché esistono molteplici forme (regionale, diocesano e..) di diversa corposità (in Lombardia, la regione che meglio conosco, esistono ancora seminari quantitativamente distinguibili, in piccoli, medi e grandi seminari) ma la principale differenza è data dai diversi volti delle diocesi italiani, riflessi nei seminari stessi, (da Cefalù a Bressanone, da Alberga a Trieste…). Sarebbe interessante un Convegno di tutti i seminaristi sul tema: ci consentirebbe di ascoltare quei protagonisti della formazione che sono i seminaristi, in genere più accuditi che ascoltati. Tra l’altro questo aiuterebbe i giovani a guarire da un vizio troppo presto imparato dai loro preti, cioè a superare una lamentosità sterile o una visione troppo narcisistica, provinciale, dei problemi. Li aiuterebbe e passare dalla mormorazione all’iniziativa e alle proposte. (Come non ricordare l’osservazione che S. Benedetto rivolgeva ai monaci più anziani nella Regola invitandoli a mettersi in ascolto dei monaci più giovani?…)2 La seconda difficoltà è il persistere nell’immaginario di molti l’idea che il seminario sia un luogo e non un tempo e che di fatto venga a coincidere con la scuola di teologia e con l’anno scolastico. Si genera allora nella formazione quel fenomeno deleterio della formazione intermittente: si alternano momenti forti a periodi pedagogicamente deboli, ove l’esperienza spirituale e persino l’ardore apostolico vengono meno, con grande danno nella crescita… La speranza cresce solo nella perseveranza laboriosa e tenace, cioè nella continuità. Altrimenti è di corto respiro, rachitica! Infine, l’ultima difficoltà, è l’insieme delle precomprensioni capaci di condizionare lo sguardo con cui vediamo il nostro seminario. Questo pregiudizio contamina educatori ed alunni (Mi piacerebbe chiedervi come ciascuno di voi vede questa autorevole istituzione alla luce della vostra esperienza? Cosa pensate globalmente del vostro seminario, evitando il gossip per valutarne la proposta, con le sue ombre e le luci?). Per sé il seminario non è solo un’istituzione ecclesiale. Lo è se più in profondità è un tessuto di rapporti concreti cioè…nella Trinità un nodo di relazioni con il vescovo, i professori, i superiori propriamente detti gli stessi seminaristi tra loro, i laici presenti, i preti significativi la famiglia… L’attuale nostro modo di vivere questi rapporti (e contestualmente i climi di fiducia, di stima, di collaborazione, di attenzione) decide in concreto l’assimilazione o l’appropriazione della proposta e prima ancora lo sguardo che interpreta tutte le 1 2 Il senso del mio intervento è quello di aiutarci a vivere questa stagione della vita a diventare uomini, discepoli, presbiteri… forti nella speranza teologale, cioè appropriandosi sempre più di quegli atteggiamenti e virtù del Figlio, infuse in noi e che tuttavia, non senza di noi, possono diventare dono. Infatti siamo chiamati a diventare educatori della speranza nel popolo di Dio (vedi nella vita e nel ministero il senso della speranza teologale nell’accompagnamento della comunità).1 A. Parto da una domanda limpida: oggi il seminario educa alla speranza? Segreteria generale del Sinodo, Il vescovo per la speranza del mondo, Instrumentum laboris del X Sinodo dei vescovi, n. 13, Regno-doc. 11/2001, pag. 349. S. Benedetto Regola, capp. 3,3: “Abbiamo detto di chiamare a consiglio tutti i fratelli, perché spesso proprio al più giovane il Signore manifesta ciò che è meglio fare”. 34 esperienze educative. Quando si parla dunque di formazione seminaristica dialogano insieme il soggetto e l’istituzione: ciascuno deve fare la sua parte e prima ancora mettono in gioco non solo le proprie risorse ma anche le proprie fragilità e debolezze, da ammettere e tenere in conto. B. Per entrare in argomento vanno messi sul tappeto anche alcuni dati, credo, incontestabili. E un’ultima riflessione di fondo. Mentre i giovani valorizzano e apprezzano le vocazioni impegnative, “nello stesso tempo sono alla ricerca di progetti ‘minimi’ e ‘feriali’, cui ancorare la propria esperienza di vita… Dentro l’idea di vocazione prevalente tra i giovani d’oggi coesistono due orientamenti: da un lato all’autodeterminazione e all’autocostruzione, e dall’altro alla reversibilità delle scelte”.6 Il primo lo assumiamo dalla sintesi dei lavori di gruppo della CEI, curata dallo stesso autore della relazione fondamentale Mons. Monari. Leggo. “In molte diocesi si è impostata un’attività di accompagnamento per i preti dei primi anni di ordinazione. La percezione chiara è che la formazione del seminario, per quanto impostata con cura, non sia in grado di introdurre efficacemente nel ministero e tanto meno sia in grado di monitorare e risolvere i problemi che l’ingresso nel ministero offre” (n. 8). Un altro dato lo ricavo dall’inchiesta curata da don Luca Bressan sulla trasformazione in atto nel ministero presbiterale. Egli, ragionando sul seminario come luogo di formazione rileva che ‘il seminario sta diventando sempre più luogo e strumento di discernimento vocazionale, rimandando a poi, quando si è già ordinati, una ipotetica formazione al ministero, ai suoi compiti, alle sue richieste.’3 Poco più avanti lo stesso commentatore osserva che i preti intervistati ‘ritengono il seminario un buon luogo di formazione: soprattutto alla preghiera (più del 90%), al celibato (89%), alla liturgia (78%).4 Un terzo, in dialogo con i sociologi, (i preti si lamentano di non essere stati formati a sufficienza attraverso le scienze umane!) lo ricavo dall’inchiesta di F. Garelli ed équipe, che riguarda I giovani italiani di fronte alla vocazione. “La maggior parte dei giovani ha difficoltà a individuare nel proprio intorno immediato delle figure capaci di richiamarli a un’idea alta di vocazione, il cui stile di presenza testimoni una missione o un progetto da compiere… Più in generale la carenza di riferimenti è assai evidente neo rapporti sociali allargati , per la difficoltà da parte dei giovani di individuare delle figure vocazionali significative nei luoghi ordinari…”5. C. L’evoluzione di Orientamenti e Norme, codificate dalla CEI e a più riprese aggiornate. Il rigore della riflessione esigerebbe a questo punto che si analizzino insieme le norme recenti che i Vescovi hanno firmato e consegnato alla Chiesa italiana. Ma non sono ancora arrivate sui nostri tavoli nel senso che, mi dicono, necessitano di un’integrazione che riguarda la Ratio studiorum. Li attendiamo con desiderio. Infatti ricordo prima di tutto che questi orientamenti e norme da parte dei nostri Vescovi, rappresentano il discernimento ecclesiale sulla vostra formazione. Come cioè la Chiesa intende affrontare, nelle presenti circostanze, il suo futuro in quell’aspetto così cruciale che è la formazione delle sue guide in tempi difficili. Questi testi sono un esercizio di speranza dei responsabili della Chiesa. Non è poco. Ve lo dice un educatore che ha iniziato a ridosso del concilio avendo in mano solo la Optatam totius (1965) e il testo base per tutti i seminari del mondo detto Ratio Fundamentalis (1970). Per il resto dovevamo continuamente mediare tra la tradizione pedagogica trasmessa oralmente e le nuove istanze conciliari.Certo anche qui va ricordato che non sono le buone leggi a darci dei buoni cittadini, ma aiutano… Ci accorgevamo, con altri colleghi, lungo il cammino, che la legislazione successiva, mentre cercava di rendere sempre più adeguata la formazione, faticava a mettere a fuoco proprio l’immagine della comunità del seminario, come soggetto ecclesiale. Scegliamo un esempio7: ¾ In La preparazione al ministero presbiterale, (1972), firmato dal card. Poma , la 3 6 L. Bressan, Preti di quale Chiesa, preti per quale Chiesa, in La Rivista del clero italiano, 6, giugno 2006, pag. 415. 4 Pag. 419. 5 F. Garelli, (a cura di) Chiamati a scegliere, San Paolo, pagg. 9-10. Ivi, pagg. 12-13. Il Card. Ratzinger qualche anno fa in un’intervista su 30 Giorni lamentava il rischio che il seminario diventasse una sorta di condominio Aggiungo che il rischio non è superato: per alcuni è un alveare (pesante) oppure un contenitore di servizi. In alcuni piccoli seminari può diventare un club di liturgomani o altro 7 35 quale collocare le riflessioni, vera miniera da cui trarre autorevoli e importanti indicazioni). comunità era descritta in una ottantina di numeri, sullo schema del sommario di At 2. Particolarmente felice, per il nostro tema, il n. 234. Circa la comunità degli educatori in futuro sarebbe stato difficile dire meglio (271 – 276). IL SEMINARIO COME LABORATORIO DI SPERANZA ¾ In La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana, (1980), firmato dal card. Ballestrero, l’ottantina dei numeri sopra accennati diventano una trentina. Emerge una preoccupazione: ribadire la ecclesialità della proposta del seminario. E’ la stagione di espansione dei movimenti che sembrano mettersi in concorrenza con la pedagogia del seminario diocesano con metodi formativi alternativi. In questo testo compare un numero che molto ha fatto discutere circa i criteri di ammissione all’inizio della teologia. Si dice che nel candidato deve riscontrarsi la sincera disponibilità ‘ad impostare la propria vita con i criteri del vangelo nel solco di una scelta tendenzialmente definitiva per il ministero presbiterale (n.123). La celebrazione poi del rito di ammissione tra i candidati al presbiterato da compiersi entro il primo biennio, sarà il segno offerto al vescovo e alla Chiesa della personale maturazione di questa scelta…” In seguito il quadriennio teologico si confermerà un laboratorio in cui il punto di verifica di una vocazione riguarderà proprio questa coscienza ed esperienza della definitività. Con i giovani gli educatori tendevano a rimandare sempre di più la verifica di questo criterio: l’alunno oscillava tra la fuga irresponsabile in avanti e la paura che lo bloccava nel passato. ¾ In Linee comuni per la vita dei nostri seminari, (a cura della commissione episcopale per il clero della CEI, un testo di fatto non recepito, immeritatamente trascurato), cercava di raccogliere esigenze particolarmente vive nelle nostre comunità seminaristiche. La commissione tra l’altro era preoccupata che il cammino di formazione nella nostra Chiesa, avesse una sua continuità. Efficaci, in particolare, sono le indicazioni relative ai diversi livelli sui quali il giovane nella sua crescita deve affrontare la lotta per realizzare i propri desideri umani, quando la maturità non è ovvia né scontate sono le condizioni favorevoli. ¾ Nel frattempo si era celebrato un Sinodo, che riguardava tutti i seminari del mondo (1990) sulla formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali con la relativa Esortazione Apostolica postsinodale ‘Pastores dabo vobis’ (1992). (Quest’ultimo sarà lo sfondo, per nulla formale sul (esercizi quotidiani per liberare la speranza) 1. Voi siete un racconto di speranza. E’ importante mantenere vivo il senso di stupore per questa stagione, la cura per il frammento di futuro che vi è stato donato. Vivete una sorta di già e non ancora. Infatti contestate cupe e narcisistiche culture che intrecciano danze macabre all’inizio di questo terzo millennio. La cultura delle rassegnazione, della amnesia (rottura con il passato per l’attimo fuggente), cultura della depressione che si crogiola nelle proprie auto-squalifiche, cultura delle emozioni e dell’eccitazione estrema, cultura della tecnica (è vero ciò che funziona) e naturalmente le culture consumistiche, che enfatizzano il primato dell’immagine. Su queste cose rimando alle puntuali analisi nelle lezioni di teologia pastorale. Queste riflessioni non mancano all’inizio di documenti magisteriali come la Pastores dabo vobis, anche se espresse in termini di difficoltà che si incontrano nell’ingresso del ministero. Suggerisco un approccio diverso. Prima che addestrarsi nelle difficoltà occorre cogliere la chance di questa condizione. Vi invito a cogliere il valore di sfida che già ha la vostra vita vive nei confronti di ideologie e climi dominanti. Ad affrontarle con umile fierezza. E’ nella vostra scelta in controtendenza! Voi già virtuosamente vi addestrate a vivere nella sproporzione, dimensione tipica del ministero e della stessa vita cristiana. In questo senso pensavo agli anni di seminario di alcuni personaggi divenuti celebri nella Chiesa, anche come testimoni della speranza. La formazione dei seminari ai loro tempi era rigorosamente tridentina o assolutamente inadeguata per ragioni storiche. Penso a Karl Woityla, a Van Thuan8, (ordinato nel 1953) a Giussani (ordinato nel 1945), vissuti in seminari 8 Il corso di esercizi da lui predicato nel 2000, alla presenza del S. Padre è un testimonianza straordinaria sulla speranza e una pedagogia formidabile sulla stessa virtù teologale. 36 imperfetti ma generatori di personalità straordinarie. (R. Corti, vescovo di Novara, in una comunicazione fatta a Roma, ha scavato nella vita seminaristica di GPaolo II per scoprire nella formazione seminaristica le radici perenni di una vera preparazione). Occorre davvero che questa stagione magica della vostra vita, nonostante tutto, possa essere vissuta con limpidità e chiarezza, come ri-attualizzazione o meglio come l’affiorare e l’emergere dello stesso cammino di Emmaus. E’ singolare il rapporto con il futuro che la stagione del seminario comporta! La formazione è costruita in vista del futuro, dovendo insieme essere radicata nella chiesa locale ma insieme intuire e progettare in sintonia con il futuro della Chiesa e del ministero: una posizione francamente ‘sbilanciata’. Anche perché le sue sane radici affondano in grandi tradizioni pedagogiche che appartengono al vissuto ecclesiale. Ed il vissuto ecclesiale è diverso nei piccoli, medi, grandi seminari. Ma attenti a tenere insieme le due istanze tipiche del seminario dei nostri giorni. Esso è sempre più luogo di discernimento sulla definitività della vocazione e sempre meno luogo di preparazione al ministero. Occorre evitare insieme fughe in avanti o cristallizzazioni nel non definitivo. 2. Con negli occhi gli anni oscuri di Gesù. A Nazaret. Gesù ha consacrato la quotidianità rendendola tempo di fecondità e di speranza. Certo quegli anni ‘furono privi di racconto ma furono anche anni pieni di senso,’9 in una quotidianità e impegno feriale che sono canali attraverso cui la volontà del padre prepara al futuro ed educa a vivere il futuro, che inizia prima ancora che accada. Gesù ha vissuto tutte le ore del giorno nella luce della sua Ora. A me piace molto una definizione di Martini sulla speranza. “ La speranza è la condizione filiale vissuta nei riguardi dell’avvenire… e la vigilanza è l’atteggiamento di chi tiene salda la speranza…”10. Essi non furono anni di semplice preparazione ma di vera e propria Incarnazione. Il mistero di Nazaret, mai sufficientemente contemplato e indagato, illumina la stagione magica e complessa della vostra formazione. Scoprire come Gesù cresce negli affetti normali di una famiglia, diviene esperto dei limiti creaturali, vive la relazione, impara un mestiere, cerca la fedeltà al Padre nel quotidiano… In seminario si impara il Vangelo della quotidianità! 3. Il fuoco della Missione. Il seminarista trova in un forte spirito apostolico la sintesi felice e gioiosa di una formazione non generica. La speranza nel quotidiano si nutre della fede che ama della stessa carità di Cristo, carità che urge in noi. L’amore di Cristo plasma un’umanità che prolunga la compassione di Cristo e arde perché l’incontro con Lui sia la risposta alle attese della società e di ogni uomo. Il fuoco della Missione lo si vive in noi anche come sofferenza davanti al chiudersi di molti che non si fidano del Vangelo, sprecano giovinezza, talenti, salute nell’effimero. L’apostolo soffre per i giovani che puntano tutto su modi trasgressivi, estremi di soddisfacimento di sé, di ricerca parossistica di emozioni, che degenerano in depressioni conseguenti, in illegalità… (vedi i risultati di un’inchiesta sulla generazione Bancomat, curata dalla JOC, pubblicata in giugno su Avvenire). Nella formazione questo spirito apostolico fruttifica in unità di vita, in gusto della quotidianità, in un’umanità bella, capace di irradiare la sua Presenza. Evidentemente non faccio l’elogio dell’iperattivismo o dell’ingenua immersione tra la gente secondo criteri mondani. Non faccio l’elogio del sale che perde il suo sapore… E’ la forza di Dio che ci trascina verso il grido delle folle. Su questo tema con molta saggezza ed acume è intervenuto Mons. Corti, vescovo di Novara, non solo parlando in maggio ai superiori dei seminari lombardi ma anche al 50° convegno missionario nazionale dei seminaristi (26 aprile 2006)11. Chiede che la verifica della maturità apostolica sia criterio decisivo nel discernimento al ministero. Lo pone con questi interrogativi: - Con quali sentimenti sei partito da casa? Con quali sentimenti sei uscito dal seminario. Gli anni del seminario hanno spento il fuoco della Missione? E sono solo le prime domande, comunque fondamentali per chi entra nei sentieri della missione, se non si vuole che, di fronte alle sfide enormi che ci attendono, nel presbiterio non andiamo ad ingrossare le file dei delusi, afflosciati, disincantati. 9 11 Penetranti osservazioni di trovano nel libro di meditazione di P. Rattin, E’ disceso da cielo, EDB, 2001, in particolare le pagg. 65 – 85. 10 CM. Martini, Sto alla porta e busso, Centro ambrosiano, n.5. R. Corti, Preti per la ‘Missio ad gentes’, Rivista diocesana Novarese, maggio 2006, pagg. 330 – 335. 37 Avere un grande fuoco dentro, aperti ad un orizzonte ecclesiale che non può che essere a tutta la Chiesa! 4. In principio il presbiterio. Il seminario educa a maturare la coscienza del primato del presbiterio, sorgente della nostra consacrazione e missione, nonché luogo ove si condivide una lettura di fede del mondo contemporaneo e si pensa la comunità cristiana. Il presbiterio è luogo dove il prete trova la sua identità, luogo originario dell’esistenza del prete. (Vedi la sintesi dei lavori di gruppo, n.1). Da qui una spiritualità di comunione genera quella apertura agli altri, collaborazione, condivisione che sconfiggono ogni tentazione dell’individualismo e dell’autoreferenzialità. Lo Spirito provoca un continuo cammino di comunione. Essa è opera di Dio!. “Ricordarlo è un antidoto all’avvilimento e alla rassegnazione. Se la comunione fosse solo un’opera nostra, gli insuccessi provocherebbero un avvilimento; siccome è anzitutto opera di Gesù nello Spirito, e siccome quest’opera egli l’ha già iniziata, la speranza può rimanere salda”12. Vedo nei nostri seminari più una buona teologia che una prassi soddisfacente. Per questo aspetto siamo un poco in ritardo. Bisognerà rafforzare esperienze di condivisione, valorizzazione della vita comune, (sentita troppo come peso non come chance), tirocini pastorali, forme condivise per elaborare revisioni di vita, do programmi formativi, progettazioni, tempi anche di riposo. E naturalmente il riceversi ogni giorno dall’alto nella liturgia e nella preghiera. Come nel Cenacolo insieme a Maria. Si deve fare di più! Anche noi educatori dobbiamo offrire in seminario un modello plausibile di spiritualità di comunione! Al riguardo voglio richiamarvi che è educazione al presbiterio (e quindi alla speranza) un atteggiamento di lealtà, di non permalosità nel accettando la fatica del confronto e del rendere conto del vostro cammino nel dialogo con i vostri educatori. A proposito della fraternità un dialogo fecondo e positivo oggi - mi sembra - si apre nel confronti di movimenti, cammini, fraternità di laici, realtà associative. Educare al presbiterio comporta anche riconoscere il carisma dei movimenti e realtà associative che oggi arricchiscono la Chiesa. In passato erano problematici. I seminari lamentavano un rifiuto della loro linea educativa, negandone i movimenti di fatto l’ecclesialità. I movimenti lamentavano discriminazioni, esclusioni, pregiudizi. Anche nella fraternità si è passati da ritenere i movimenti e simili un problema, pur riconoscendone una supplenza preziosa, sino ad accoglierli come carisma prezioso e fecondo per lo stesso presbiterio. Non è il caso di citare i numerosi documenti del S. Padre o dei vescovi. Oggi il problema spero residuale è dovuto alla fatica concreta di camminare insieme persistendo atteggiamenti su tutti i fronti di inospitalità e di pregiudizi. 5. La formazione educa alla speranza se educa ad imparare dalla prova: in essa, ad alcune condizioni, si genera una speranza più viva. Nella formazione la si incontra nella fatica dell’apprendere. Se ne fa esperienza nei servizi più umili e necessari alla comunità. Ci tocca come fatica dell’accettare le condizioni della vita comune, la durezza dei caratteri, i vincoli degli orari, le laboriose metodologie dell’apprendimento, le solitudini affettive, la pazienza nei malintesi, la ripresa dopo le sconfitte, la dura ascesi dell’autoformazione. Non sempre abbiamo i superiori ideali… Siamo formati alla speranza riconoscendo i diversi volti della prova e della fatica (li uso come sinonimi!) . A quel futuro che non si può dominare né si conosce, ci si dispone attraversando la prova, senza perderne il senso, evitando di sfuggirla o di bloccarsi come davanti ad un’esperienza ingiusta o negativa. Questo ci prepara molto, già nei primi anni del ministero a passare dall’innamoramento per esso alla resistenza nella complessità. Ma la prova più seria rimane quello di accettare se stessi nella propria inadeguatezza di fronte ai compiti. 6. L’educazione dell’intelligenza. In seminario si potrebbe sviluppare molto il gusto del lavoro intellettuale: gli itinerari educativi di solito sono adeguati dimostrandosi molto attenti alla formazione dell’intelligenza. Di norma la proposta al riguardo è seria. Tuttavia oggi non pochi vescovi sono insoddisfatti, così come gli educatori denunciano una disaffezione negli alunni (vedi alcuni interventi di S. Dianich su Vita Pastorale). E gli alunni? Per un verso dichiarano la loro perplessità sulla loro formazione intellettuale per altri versi sembrano non investire molto in questo campo.13 Evitando l’errore di far coincidere il seminario con una scuola di teologia o una facoltà teologica, si può affermare che la speranza del giovane matura se maturo è il suo approccio allo studio della teologia, se è capace di una sintesi 12 13 Sintesi in testo citato di L. Manicardi, n. 2. 38 L. Bressan, Inchiesta citata in Rivista del Clero, pag. 417. personale oltre che attento ad appropriarsi degli itinerari metodologici nelle singole discipline. Ma tutto questo non basta. Occorre non solo acquisire competenze ma disporre di un’intelligenza che sappia capire, interpretare e decidere dentro una realtà complessa, sia essa la realtà dei problemi socio-politici, etici, sia il delicato discernimento dei cuori. Si può apprendere in seminario come fare dialogare i dati e risultati delle scienze umane con la teologia e con le proprie vicende personali. Già in seminario si aprono panorami affascinati per l’intelligenza. (Si pensi all’aiuto dato nell’interpretare sul senso della domanda di Dio oggi, piuttosto che all’approccio dato nell’affrontare problemi legati alla famiglia, all’area della fragilità e degli affetti…). Con forza poi va evidenziato il fatto che la qualità dell’esperienza spirituale, nonché la pratica delle virtù sviluppano con la sapienza la stessa capacità di penetrazione dell’intelligenza.14 In particolare ricordo il contributo relativo al rapporto tra ruolo e crescita personale. “Educare al ruolo non significa trasmettere istruzioni su cosa fare e neanche spingere una persona a entrare in una casella preconfezionata ma dare indicazioni su come il soggetto, servendosi della propria attività, dovrà definire se stesso, rappresentarsi il mondo e presentarsi agli altri”.15 7. Lo forza e lo spessore dell’esperienza spirituale (v. Fil 3). La pedagogia seria, vera, capace di introdurre alla carità dell’Amore Crocifisso e di radicare stabilmente in Lui, in ‘Cristo in voi, speranza della gloria’ (Col 1, 27) è la condizione fondamentale per formare alla speranza. Il cammino di formazione non può non essere il cammino di Emmaus, la via del discepolo, di quest’uomo che diventa prete. Questo incontro con l’Amore Crocifisso, quotidiano e prolungato per anni, genera gli apostoli. Da uomini in fuga, confusi, incapaci di vivere della Parola della Croce, si diventa compagni di viaggio di ciascuno, trasfigurati da una Presenza che scalda il cuore, capaci di un’amicizia e di una guida che accompagna i fratelli delusi a Gerusalemme, là dove nasce e rinasce la Chiesa. In genere in nostri seminari formano a questo. Certo si può fare di più nell’affrontare alcuni problemi. Integrare i limiti del metodo storicocritico. Introdurre alla conoscenza delle grandi figure spirituali (in particolare dei mistici, abbastanza trascurati). Affrontare il problema dell’intermittenza dell’esperienza spirituale stessa. Educare all’ascolto della parola del S. Padre, (il quale è più citato che seguito come si vede nella pratica della Lectio Divina). Mi piace collocare qui anche un cenno su l’itinerario penitenziale (il rapporto con il confessore e la guida in genere). Sbaglio o questo rapporto lo si cerca (e lo si relega) in una fase provvisoria della formazione? Quando si entra nel ministero… spesso non si hanno più riferimenti e non si rende conto a nessuno. Lo sperare è un arte che si apprende… continuamente da un uomo spirituale, che ci sostiene negli imprevisti, ci illumina nei passaggi delicati, ci educa a riconoscere le visite di Dio nella prova, ci trasmette l’arte di accompagnare gli altri! 8. Importanza di una formazione alla responsabilità. Il giovane prete viene spesso insidiato nella speranza quando non riesce a vivere con gioia e fervore la propria responsabilità . In positivo, nella inchiesta più volte citata, i preti nell’esercizio del proprio ministero, (la loro responsabilità!) dimostrano una buona dose di autostima e un discreto grado di soddisfazione. In sé il ministero, vissuto nella verità è sorgente di grande speranza, anche nella prova. Però bisogna entrarci collaudati. Il giovane deve essere abbastanza maturo nella responsabilità. Essere affidabili (L’amministratore deve essere fedele). Il seminario è graduale cammino di responsabilità, verso di sé, verso il proprio futuro; è preparazione alla corresponsabilità, affinamento di tutte quelle virtù che educano a portare il peso e la realtà dell’altro. Qui si impara una virtù molto importante: essere responsabili verso i climi della comunità, senza deleghe. Responsabilità è avere cura del cammino del fratello e di non essere causa di sofferenza o di testimonianza negativa per l’altro. Avere il senso di ciò che il Signore ci mette tra le mani. I beni più preziosi… i fratelli per i quali Lui è morto. E questo oltre le preoccupazioni narcisistiche della propria immagine, del quanto si vale e del quanto si è approvati… Il giovane impara a trattare con intelligenza, umiltà, rispetto le persone (le anime si diceva una volta). Le cosiddette esercitazioni pastorali vanno scelte con cura, amate, programmate in modo che vi sia una certa gradualità ed efficacia nell’introdurre alla responsabilità. 14 Suggestive annotazioni In S. Gregorio Magno, La Regola pastorale, L. 1,2. 15 F. Rinaldi, Quando si aprono gli occhi: dal seminario alla vita, in Tredimensioni, 3, (2006), pag. 197. 39 Il seminarista è già responsabile della fede dei fratelli, nell’animazione e nell’educazione alla preghiera, allo stare insieme, nella catechesi. Si prepara a divenire in seguito non solo pedagogo ma anche padre… Questo modo di prepararsi alla responsabilità e nella responsabilità fa assumere il ministero e lo fa vivere, anche nei momenti più trepidi, come un dono e una grazia. La stessa ‘conversione pastorale’, tanto conclamata, pur nella situazione di confusione e di smarrimento, ci apre ad ‘una pastorale che deve creare risposte sempre nuove a necessità mutevoli’16. C’è anche spazio dunque per la creatività, c’è una gioia e una pienezza umana nel ministero! Altrimenti, (e condivido la valutazione di Mons. Corti) è meglio non ordinare prete chi non dimostra un sufficiente senso di responsabilità. 9. La formazione del seminario favorisce l’apprendimento delle virtù, in particolare di quelle teologali. (Vedi anche le virtù teologali citate nella I lettera di Benedetto XVI, Deus caritas est ai nn. 38-39). Penso a quell’insieme di virtù dai molti nomi, che sono il terreno fertile in cui cresce e fruttifica la speranza. Penso alla fortezza, alla fedeltà, al coraggio e alla resistenza nelle difficoltà (pazienza), alla makrothumìa, il lungo respiro di cui la virtù teologale si nutre. Penso alla vigilanza, che sa cogliere i segni della novità e consolazione del Vangelo. Sono tutti aspetti della fede, che ci dona la lucidità dello sguardo di Dio sulla realtà, senza la quale la speranza non ha consistenza. Il seminario ci forma a decidere ‘diversa-mente’, (permettete il gioco di parole), apprendendo l’arte del discernimento, arte appresa gradualmente, prendendosi tempo per capire i propri e altrui desideri per sintonizzarsi su quelli di Cristo, distinguendo le vere e false attese, i buoni e cattivi maestri. Ricordate l’immagine agostiniana come ginnastica dei desideri? (Importanza di scoprire e valorizzare i desideri, aprendoli, alla scuola dei santi: maestri tra gli altri sono Agostino, e Teresa d’Avila). I desideri e i sogni ricchi e complessi (con qualche ambiguità) dei seminaristi sono custoditi e purificati dalle virtù. E variano a secondo delle diverse età dei seminaristi, che vivono diverse stagioni nella loro speranza. L’inchiesta curata da Garelli per i Paolini (ma anche quella curata da Bressan) urgono nel senso di rafforzare la speranza dei seminaristi formandoli alla conoscenza e all’esercizio delle virtù, per evitare che sentano la definitività solo come pericolo e la fedeltà come 16 scelta grigia e piatta. Così si può gustarla non come semplicemente un per sempre della libertà, ma come un orizzonte verso cui ogni giorno si cammina a partire da un legame amoroso con Colui, del quale nulla si ha di più caro! 10. Aver cura della propria umanità. Da ultimo, quasi come sintesi del nostro percorso di speranza, voglio richiamare la vostra attenzione sull’umanità del futuro presbitero. (Il tema meriterebbe un convegno a sé). In genere occorre dire che la spiritualità cristiana, germinata dall’Incarnazione, ha una tradizione molto ricca. (Penso alla Regola di S. Benedetto, n. 53. L’altro va accolto nella preghiera, umiltà, gentilezza. Penso all’elogio della mitezza). Giustamente siete esigenti verso l’umanità di educatori e preti. Cercate conferme per la vostra speranza! L’umanità del discepolo e del prete è terra di confine con la vita del non credente, luogo di evangelizzazione per contagio, terreno fecondo di pastorale vocazionale e, in negativo, causa di rifiuti e pregiudizi. La qualità dell’umano del credente è la prova concreta che il Vangelo non devasta ma salva e che la vita in Cristo è umanamente bella! E’Il seminario è in grado di preparare un’umanità ‘convincente’, così innovativa nel suo modo di essere e di comunicare, nello stile di vita del pastore così attraenti da provocare un interesse e in un secondo tempo predisporre al Vangelo. Si parla di virtù umane (vedi P.O. n. 3) come qualità virtuose dell’umanità del prete. Mi sembra che la proposta del seminario oggi sia molto più attenta a coltivare nei seminaristi un’umanità convincente, in grado di incoraggiare prima di tutto lo stesso giovane a fidarsi del Vangelo, alla sua capacità di generare una vita bella, vera, piena. Vale la pena di ricordare le occasioni formidabili, i mezzi, gli strumenti che fanno del seminario uno straordinario laboratorio di umanità, dove possono crescere uomini veri, alla maniera di Gesù. Anzitutto perché l’attenzione educativa si articola contemporaneamente sui tre piani (l’uomo, il discepolo, il prete) e poi perché libertà e grazia agiscono creando un circolo virtuoso, rafforzandosi a vicenda. Il Pane della Parola e dell’Eucaristia plasmano il noi il volto dell’uomo dandoci i contorni di Gesù, il suo Spirito. La Parola ci apre alla realtà, senza deformazioni e distorsioni. Il confronto con la guida e con i fratelli ci aiutano a conoscere e riconoscere e gestire sentimenti ed emozioni. Le esperienze pastorali e prima ancora la vita quotidiana ci preparano ad Relazione di Mons. L. Monari, n. 4. 40 accostare tutte le persone, a dialogare nell’ascolto, a prendersi delle responsabilità su di loro. Lo stare in silenzio con noi stessi agevola la conoscenza della propria interiorità e l’assunzione dei propri limiti. E poi c’è il costante lavoro su noi stessi… Sono cammini di autenticità, di gratuità, di vera e solidale condivisione… Non mancano aiuti psicologici e competenze pedagogiche. Così possiamo rispondere alla domanda esigente della gente. Certo la richiesta dei giovani preti certo incalzano: - Dovete prepararci di più! Talvolta ci preoccupa il fallimento di alcuni preti proprio a causa dell’impatto duro con la realtà (penso ai problemi connessi con il celibato e con il complesso mondo dell’affettività a cui lo stesso Convegno di Verona dedica un’area). Tramite i sondaggi un’ampia percentuale di futuri preti dicono di aver paura di non farcela nel celibato. Sempre secondo questi sondaggi si constata l’importanza crescente, significativa, delle relazioni amicali e fraterne nella nascita e sviluppo della vocazione al ministero. Anche la pastorale vocazionale urge nel senso di pretendere da noi un modo bello di vivere la nostra vocazione (L. Monari, Sintesi alla fine del n. 2). Il nostro modo di essere uomini è il primo strumento di cui la Grazia si serve per attrarre altri nel ministero. La Chiesa ci chiede di fare di più. Ci chiede, attraverso un nuovo patto educativo con i nostri responsabili, di avere fiducia nella proposta del seminario, collaborando e vivendo in prima persona la sua proposta educativa, anche per migliorarla. Ci chiede di cercare e di fare di più, raccogliendo la sfida lanciata dallo stesso Mons. Monari, a nome dei vescovi italiani nella sua relazione.17 * * * (*) Il relatore ha poi risposto alle seguenti domande - Io mi chiedo: i nostri ambienti di seminario, per certi aspetti, non sono forse ambienti un po’ troppo ovattati? Almeno da quello che ho potuto fare io esperienza. Una seconda domanda in relazione all’inserimento nel presbiterio: il Seminario come tempo e come luogo in cui si forma la sensibilità al presbiterio. Le mie due esperienze in Seminario sono state completamente opposte. Però più o meno qualche elemento costante c’è. Mi riferisco forse a un eccessivo psicologismo che oggi si vive nei seminari; per cui lì dove iniziano ad instaurarsi anche esperienze di amicizia significative - proficue anche dal punto di vista della crescita, nella dimensione del presbiterio, nella condivisione - forse con troppa facilità vengono tradotte come amicizie particolari. Grazie. - Prima parlava di spiritualità diocesana e mi sembra che abbia detto che è un argomento molto vasto. Volevo soltanto chiederle se magari c’è qualche linea un po’ più definita su questa spiritualità, dato che anche nella nostra Diocesi se ne sta parlando tanto di questo. Sono prete da due anni e quindi ancora soggetto a una formazione piuttosto forte. Poi volevo farle altre due domande. La prima: il nostro Seminario è organizzato in questa maniera; c’è il foro interno che è la direzione spirituale e il foro esterno che è un po’ più la parte inerente gli educatori, con il Rettore i Vice Rettori e così via. L’impressione che ho è che a volte si parla tanto di speranza, di una formazione spirituale e che però la comunità non rispecchi poi quello che si dice nella spiritualità, per cui se la speranza è quella di relazionarsi con Gesù Cristo, nel momento in cui vado dal Rettore a fargli una certa domanda spero che mi mandi al concerto di Vasco. Allora quello che volevo chiedere è che rapporto deve esserci tra foro interno e foro esterno in un Conclusione: non ho ritenuto interessante insistere sulle difficoltà che oggi il seminarista incontra nell’essere un uomo di speranza. Sono in proiezione le stesse difficoltà che incontra il giovane prete e in anticipo il candidato già respira. Molte di queste difficoltà travagliano la vita dei cristiani e non solo. I relatori che mi hanno preceduto, di sicuro hanno disegnato la mappa delle paure, delle resistenze interiori, dei climi epocali. A me interessava solo testimoniare a voi e ragionare con voi sulla bellezza di essere preti, oggi, controcorrente. Così la nostra speranza, pur piccola, diviene albero su cui molti troveranno rifugio. Per la vostra gioia, per la gioia di tutti. 17 (*) Trascrizione delle risposte registrate, non riviste dal Relatore Testo citato, in particolare la Sintesi n.5. 41 chiesto un sacerdote che venisse per la cura d’anime, perché pur avendo il nostro rettore maggiore dei grossi rapporti da tenere con la facoltà, con i centri universitari, però ci sembrava di privilegiare per la formazione questa esperienza pastorale di base; quasi tutti noi veniamo dallo studio o, diciamo, da posizioni di non parrocchia. Però c’è un rischio in questo, è facile da dire ma … Quando abbiamo tentato una volta, i seminaristi si lamentavano perché dicevano che il parroco, sarà persona bravissima, ma chi viene da questa esperienza non ha più un’idea di che cosa sia un Seminario e di che cosa voglia dire educare un prete in quanto lui si è plasmato su altre logiche. Quindi il parroco, e qui sono d’accordo, deve essere un tipo molto ricettivo, che si lasci educare dalla nuova realtà e che naturalmente non faccia coincidere la pastorale, come del resto noi non abbiamo fatto coincidere la pastorale e lo zelo apostolico, con un attivismo perché allora diseduco, anziché educare. Essere pastori oggi, quando ancora si è ancora più sovraccarichi di lavoro, domanda una capacità di pensare il futuro e di pensarsi preti in un certo modo, altrimenti si rincorre la mitezza e si finisce per non ascoltare colui che si indigna. Seminario e che ruolo ha quindi anche il Direttore Spirituale nei confronti della comunità. La terza domanda è: che rapporto c’è tra teologia e spiritualità; spesso magari è il professore che non condivide appieno le posizioni del Magistero o alcune forme di spiritualità e questo spesso influisce sulla formazione spirituale dei seminaristi e poi volevo appunto chiedere che ruolo ha la teologia nella formazione del seminarista e nella sua spiritualità. Spesso si sente dire che la formazione è legata a quello che si studia e quindi mi chiedo ad un certo punto anche che cosa si intende per formazione perché secondo me non è una domanda così scontata. Grazie - Sono due le domande. Mi chiedevo quanto la sobrietà fosse un ambito da toccare per una umanizzazione del seminarista e quindi del futuro presbitero. Le chiedo questo in base alla realtà della mia regione - penso anche della Calabria dove c’è un forte tasso di emigrazione, però di “cervelli”, cioè neolaureati e professionisti che emigrano, e un forte tasso di disoccupazione. Per alcuni versi il presbitero viene ad essere una delle categorie, tra virgolette, più sicure, perché a 25 anni si trova ad avere uno stipendio, un lavoro assicurato. Però si trova a vivere con questa realtà; quindi mi chiedo quanto io seminarista sono disposto magari ad essere sobrio, nelle piccole feste di ammissione al lettorato, nella stessa festa che si organizza per il presbiterato, ecc. Si dice, beh! si fanno le Prime Comunioni e si pensa solo alla festa! Ma quando io vengo ordinato che cosa faccio? Questa un po’ la domanda sulla sobrietà. E poi un’altra domanda: per quella che è la mia esperienza ho notato che quest’ anno è venuto un animatore con una esperienza di una ventina di anni di ministero in parrocchia. Credo che sia la soluzione che nel futuro debba sempre di più andare avanti, cioè l’animatore del Seminario non può essere uno che viene dallo studi: “dove lo dobbiamo mettere? lo mettiamo in Seminario, a fare l’animatore”. Credo che questi debba essere uno che è stato consumato dalla parrocchia e che ha dato la sua vita in una parrocchia. Sulla sobrietà, disoccupazione e quant’ altro. Se il punto di sintesi della formazione è la passione apostolica, allora qualcosa che tu cerchi prima di tutto è comunicare Gesù Cristo a quelli che incontri, a questa tua gente con cui vivi e che patisce queste situazioni; allora tu non puoi vivere come se fossi il medico del paese (chiedo scusa ai medici presenti) o il professionista, perché la passione ti spinge ad assumere da prete la loro marginalità, la povertà, la loro sobrietà. Se invece uno non ha una sintesi cosi, allora vive in mezzo agli altri come un sottomarino dentro nel mare. E allora fa la sua vita, fa le sue prediche, ripensa alle sue delusioni, e solitamente ecco che si crea un vallo, un abisso tra la gente e lui. E allora magari chiede di andare a fare gli studi perché la gente non lo capisce, oppure chiede posti prestigiosi di carriera perché non si sente di condividere quella vita. Quindi è lo zelo apostolico che ci rende – come dice Paolo – greco con i greci, pagano con i pagani e poveri con i poveri. Un cammino, che per esempio se non mi sbaglio e se non dico male, è la vicenda di don Sturzo a Caltagirone, quella che lui ha percorso; dove le sue RISPOSTE Comincio da Stefano. Quest’ anno noi abbiamo cambiato il Rettore maggiore e gli educatori hanno 42 Primo, una carta comune di intenti che abbiamo chiamato “progetto educativo” in cui si delineano bene figure e strategie. Secondo, creando a un certo punto dei costanti luoghi di dialogo e di monitoraggio mensili, in cui si affrontano assieme per maturare una valutazione comune a livello di formazione, monitorare i problemi e anche sentire le diverse sensibilità e far intervenire un responsabile che comunque dica “no”, su questo la proposta va rispettata. Terza iniziativa, all’inizio di ogni anno io con il Rettore, che adesso è cambiato, parlo con ciascun docente e fa una sorta di revisione dell’anno dicendo: ma si questa cosa va bene, però su questa cosa qui, … quali sono le tue esigenze? Quali sono i tuoi problemi personali o con gli alunni? E sempre nel dialogo, perché sono problemi connessi con la vita, però vanno affrontati, non vanno lasciati lì a marcire, sennò sono guai. Una formazione ovattata crea dei mostri, cioè crea delle persone che non si sentono servi inutili, ma si sentono dei leaders privilegiati: una formazione ovattata genera comunque dei preti narcisisti, indubbiamente. Però con due precisazioni: bisognerebbe vedere in che senso si intende l’ovatta e quando voi fate delle proposte che in alcuni seminari la vita sia meno ovattata non è che ci sia un grande consenso specialmente in mezzo ai seminaristi. Per esempio tu dici: “Senti mi pare che questi tre viaggi che fai in vacanza, la gente comune non può permetterseli; prova a vedere non so di fare una diaconia, di fare una settimana al Cottolengo”… non è che a queste proposte del Rettore o del padre spirituale corrono altissimi consensi. E’ importante che non siate educati in maniera ovattata, ma è importante anche che si collabori. Sullo psicologismo eccessivo bisogna fare un altro Convegno: “Rapporto formazione, scienze psicologiche, teologie spirituali”. Soprattutto voi del Triveneto avete dei padri spirituali che vengono dalla formazione psicologica e quindi certamente questo è un vantaggio, virgola, con qualche rischio. Un tentativo interessante in questa direzione a tre dimensioni, dove si cerca di comporre le diverse istanze educative sulla formazione e sul concetto di formazione, vi rimando alla lettera Pastores dabo Vobis, i quattro capitoli: intellettuale, pastorale, spirituale e umana: lì c’è tutto. invenzioni anche a livello socio-politico vengono da un contatto con la miseria della sua gente che non era allora minore di quella di adesso, e che però vengono dimenticate. A Michele. Io do, per educare alla spiritualità del prete, alcuni contributi di Erio Cappellucci, giovane promettente, oppure tutti quei testi che noi abbiamo fatto a Milano. Li cito qui non per dire che siamo bravi, ma perché li ho collaudati e sono strumenti tarati, a livello di formazione permanente: itinerari che si svolgevano intorno ad una figura spirituale come per es. Teresa, Ignazio, il Curato d’Ars, Francesco, Benedetto. L’anno prossimo andremo a Digione, dove a partire da un pellegrinaggio si fa un lavoro che dura tutto l’anno e si ascoltano pastori, l’arcivescovo, competenti su quel aspetto del clero diocesano. Sarà la spiritualità del prete, sarà la preghiera del prete diocesano, sarà la relazione del prete diocesano; c’è quindi tutta una collana, ci sono ottimi interventi di Martini e di Bonomelli sul Padre Nostro, punto di riferimento per la formazione del clero diocesano. Anche alcuni interventi dei convegni FAC sono tuttora in atto, sono interessanti anche quelli di un certo Dario Vitali …. E poi altri. Però io vado un po’ più su: contributi molto importanti sono quelli dei nostri Papi che hanno sempre degli aspetti di prima urgenza, di prima qualità, anche sulla spiritualità del prete diocesano. Il discorso del Giovedì Santo del Santo Padre è un gioiello e chi non l’ha ancora meditato va a confessarsi dal foro interno, peccato mortale! Voi avete questo problema. Effettivamente, però non è esportabile: quello cioè di una teologia che a volte - non drammatizziamo però - entra in rotta di collisione con la spiritualità, dove talvolta i docenti esprimono pareri anche interessanti ma improvvidi e impropri sulla proposta spirituale e via discorrendo. Lì il problema è che gli alunni, siccome parlano gli alunni, spingano a far emergere la dicotomia assurda, sia nel senso di farli dialogare tra di loro questo mi sembra importante - così come è importante che vi sia un dialogo tra Rettori e padri spirituali. Noi l’abbiamo cercato in tre modi, non so se va bene anche per te. 43 III Relazione Il prete seminatore della speranza nella vita dei fedeli laici Mons. Agostino Superbo (*) Il titolo che mi è stato presentato dice così: Il prete seminatore della speranza nella vita dei fedeli laici, cioè la caratteristica della speranza come dimensione della vita pastorale, dell’attività pastorale del sacerdote. Io vi faccio alcune considerazioni preliminari perché sono fatto a questa maniera e devo cominciare sempre dalle fondamenta ed è un po’ il ricordo del mio insegnamento di filosofia che mi dice di andare alle origini. In ogni modo sarò molto veloce. Che rapporto c’è tra pastorale e speranza? La risposta viene da alcuni brani della Sacra Scrittura,- non sono io a darla – Efesini 1,18 ( il saluto di Paolo): “Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi”. Sembra che con questo saluto Paolo rechi tutto il suo augurio verso la speranza, la chiamata alla speranza, alla gloria. Efesini 4, 4: “Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alle quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione”. La vocazione cristiana è vocazione alla speranza. E la Chiesa tutta, Corpo e Spirito, uno solo in Cristo, come sappiamo è unita da una sola speranza. Romani 12,12 “Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.” Il nostro mondo come si trova rispetto alla speranza? E la Chiesa, che siamo noi, in quale posizione si trova di fronte alla speranza cristiana? Due domande importanti: alla prima per noi è più semplice rispondere, perché guardare in faccia ad altri nel peggiore dei casi è sempre più agevole. Il mondo di oggi vive un momento che possiamo caratterizzare o chiamare come “oblio” della speranza.; lo dice il documento di preparazione al Convegno di Verona. (*) Oblio della speranza in un duplice senso: il primo è che non è chiara la dimensione escatologica della vita. Sembra che tutto si giochi qui sulla terra. Più o meno bene, più o meno ragionevolmente, ma sembra che tutto finisca qui. Tanto che si impedisce all’uomo anche la riflessione sui grandi perché della vita, perché alla ragione si sostituisce facilmente la ragionevolezza organizzatrice. Ma c’è anche un secondo aspetto: la speranza è insopprimibile nel cuore dell’uomo e allora questo mondo sembra aver arretrato gli orizzonti di speranza, orizzonti brevi, percorsi brevi di speranza, facili da controllare e da consumare. In questo mondo una forza propulsiva incredibile posta, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, da Dio stesso nel cuore dell’uomo, una sete di felicità come segno del suo atto creativo, diventa la molla per una economia materialistica, localizzata e consumistica. Quindi il nostro mondo fa fatica a capire la speranza cristiana. Però dobbiamo subito chiarire la differenza tra speranza cristiana e speranza pagana, perché anche i latini dicevano “spes ultima dea” e sembrava una frase abbastanza buona e bene augurante, ma non è così. La speranza pagana non esiste è un appiglio illusorio a cui agganciarsi per evitare la disperazione; non c’è niente di già realizzato, di già tangibile: è tutto da venire, è veramente un sentimento che ti permette di evadere da situazioni difficili e senza via di uscita. La speranza cristiana è già realizzata, perché è Cristo nostra speranza, venuto per noi qui sulla terra 2000 anni fa e che ora mantiene la promessa “io sarò con voi tutti i giorni fino alla consumazione dei tempi”. Abbiamo già tutto. Nella storia non ci manca nulla. Lui è la pienezza della divinità e la pienezza della Parola di Dio (cfr.Ebrei 1). Non ci manca nulla. Trascrizione della registrazione dell’intervento e del dibattito, non rivista dall’Autore 44 E’ la situazione che noi viviamo adesso, una situazione in cui viviamo “in enigmate” dice Paolo, che non permette alla speranza – questo non è un impedimento è la situazione storica – di svilupparsi e di fiorire e di esplodere in tutte le sue potenzialità. La speranza cristiana è il compimento di quello che già noi abbiamo avuto in dono: la vita eterna, che ogni giorno ci viene dall’Eucaristia, dalla Parola di vita, che è Cristo. Non è ancora rivelato (cfr. I Giovanni) quello che siamo, ma già lo siamo: figli di Dio, e per l’umanità la speranza è in questa chiamata ad essere figli di Dio, la vita eterna che è estesa a tutti. Quali sono i conti che la Chiesa fa con la speranza cristiana? Quale importanza ha nella vita cristiana, nella formazione alle varie vocazioni nella Chiesa, laicali, religiose e sacerdotali? Quale forza di identificazione ha? In modo che i cristiani possano essere diversi da coloro che non hanno la speranza? Ecco le domande che ci facciamo. Domande che riguardano la nostra vita di fede in Gesù Cristo, con la consapevolezza che la pastorale della speranza, prima che esprimersi in un modo di agire, si esprime in un modo di essere. La prima pastorale siamo noi, così come ci collochiamo nella comunità cristiana e con la comunità cristiana nel mondo. Come si colloca la Chiesa rispetto ad un mondo che pare abbia aver dimenticato la speranza, di fronte all’oblio della speranza? Può ritenersi una specie di giardino privilegiato, una specie di orto botanico dove si coltiva questa pianta preziosissima, disinteressandosi di quello che avviene intorno, cioè di un mondo senza speranza? La Chiesa, che insieme è società visibile e comunità spirituale, cammina insieme con l’umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena: essa è come il fermento, è quasi l’anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio. Non può disinteressarsi di un mondo senza speranza, contenta di coltivare nel suo giardino la speranza cristiana. E’ destinata a condividere. Giovanni Paolo II (Redentor Hominis n. 15):”La Chiesa, che è animata dalla fede escatologica, considera questa sollecitudine per l'uomo, per la sua umanità, per il futuro degli uomini sulla terra e, quindi, anche per l'orientamento di tutto lo sviluppo e del progresso, come un elemento essenziale della sua missione, indissolubilmente congiunto con essa. Ed il principio di questa sollecitudine essa lo trova in Gesù Cristo stesso, come testimoniano i Vangeli. Ed è per questo che desidera accrescerla continuamente in Lui, rileggendo la situazione dell'uomo nel mondo contemporaneo, secondo i più importanti segni del nostro tempo”. La fede escatologica la spinge ad interessarsi dell’uomo, perché tutto il mondo è chiamato a rinnovarsi in Cristo. E allora il prete in questo mondo è chiamato ad assumere tre doni da Dio, tre carismi che sono dentro al suo ministero, a cui corrispondono tre impegni. Primo, essere uomini di speranza. Secondo, essere educatori alla speranza. Terzo, essere coltivatori di speranza. Alla base di tutto è l’essere uomini di speranza. Presbiterorum Ordinis n. 13: “Reggendo e pascendo il popolo di Dio, i presbiteri sono spinti dalla carità del Buon Pastore a dare la loro vita per il gregge pronti anche al supremo sacrificio, seguendo l’esempio di quei sacerdoti – parlate di don Francesco (si è proprio consumato e io l’ho conosciuto) – che anche ai nostri tempi non indietreggiarono di fronte alla morte; e poiché sono educatori nella fede avendo anch’essi ‘fiducia di poter entrare nel santuario grazie al sangue di Cristo’ (Ebrei 10,19), si rivolgono a Dio ‘con cuore sincero, nella pienezza della fede’ (Ebrei 10,22); si ergono in una speranza incrollabile al cospetto dei loro fedeli, in modo da poter consolare coloro che sono in qualsiasi tribolazione, con la medesima consolazione con cui essi stessi sono consolati da Dio”. Incrollabile speranza di fronte al destino. Come è la speranza incrollabile del prete? E’ quella di un superuomo? Un uomo straordinario? Che per magia che viene dal rito dell’ordinazione ha una potenzialità che gli altri uomini non hanno? O è la speranza di un uomo fragile come tutti, bisognoso di consolazione. Noi sappiamo e abbiamo ascoltato adesso la citazione del Concilio, che il prete può essere uomo di speranza, in quanto lui stesso è consolato da Dio. Vuol dire che ha bisogno di consolazione. Mettiamo tra parentesi adesso – perché non è in argomento, ma sarebbe interessante parlarne - la vita cristiana, ciò in cui noi abbiamo più bisogno di consolazione da parte di Dio è proprio la nostra vita cristiana, la vita evangelica, diciamo. Nel momento in cui tu l’assumi pienamente si complica la tua fragilità, con le contraddizioni interne ed esterne, per cui hai bisogno di essere consolato da Dio. Ma rimaniamo nelle consolazioni di cui abbiamo bisogno nel nostro ministero nell’esercizio della nostra vocazione, nell’assumere quei deliberata 45 della speranza. Sapendo che la vera speranza cristiana, la vera consolazione passa attraverso le tribolazioni, quelle legate all’annuncio dell’Evangelo, quelle che ha esperimentato l’apostolo Paolo. II Lettera ai Corinti 1-2,7 “Sia benedetto il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione”. Da un lato ricorrere a Cristo, speranza nostra, per farci consolare, dall’altro è segno di speranza affrontare le tribolazioni necessarie per il Vangelo. Affrontare le tribolazioni necessarie interne a noi stessi, evitando i riadattamenti del Vangelo alle nostre esigenze, ma adattando le nostre esigenze a quelle del Vangelo e quindi sfrondandole non poco. E anche le tribolazioni dall’esterno. Nella pastorale non bisogna trovare le vie del consenso; è la politica attiva che cerca il consenso, è la via della pubblicità consumistica che cerca le vie del consenso, cercando di attenuare la forza liberante della responsabilità umana, ma non il Vangelo. Altro è pensare le vie culturali più buone, più sante e più efficaci, altro è adattare il Vangelo ai gusti del mondo contemporaneo per evitare le tribolazioni. Quindi primo, farsi consolare da Dio, dare a Dio il tempo e il modo di consolarci perché ne abbiamo bisogno. Terzo perché la consolazione sia vera e venga da Cristo saper affrontare le tribolazioni per il Vangelo. Io credo che ogni presbitero dovrebbe dire alla propria gente e presentarsi ai propri amici così come si presenta lo scrittore Giovanni dell’Apocalisse: cioè presentarsi come compagno nelle tribolazioni per il Vangelo. Potete pensare a quante forme noi troviamo per evitare le necessarie tribolazioni per il Vangelo. Ma evitando le tribolazioni noi evitiamo, primo di farsi consolare da Dio, secondo di annunciare veramente il Vangelo. Quindi farci consolare e affrontare le tribolazioni; secondo non avere paura delle sfide del nostro tempo, le sfide contro la speranza; saperle conoscere, saperle esaminare, saper essere presenti, saper dare le risposte giuste. Giuste e credibili, non solo giuste a livello intellettuale, questo è abbastanza non dico facile ma si può farlo, ma credibili, dentro le sfide del nostro tempo, dentro il crocevia del nostro tempo con l’annuncio della speranza santa e credibile. La Chiesa non fa mai mancare l’annuncio della speranza. Ma oggi le profonde trasformazioni in cui siamo immersi, mettono in discussione valori fondamentali: il valore della persona, lo vediamo nella guerra in Medio Oriente di questi giorni, con la vocazione. Io mi ricordo che un anno stavo predicando un corso di esercizi spirituali a Montecatini, nel santuario della Pace; non so se lo fanno ancora, e a un certo momento ricordo l’argomento di cui parlavo, dell’Eucaristia, del prete che agisce “in persona Cristi” e lo stile della vita quotidiana. Mi raggiunse un prete ottantenne che mi disse “Vieni qua, - dite Monsignore - se noi pensassimo queste cose dovremmo scappare di fronte al Vescovo che vuole ordinarci. Dovrebbero venire a prenderci per forza, come è avvenuto per sant’Agostino, niente di strano, che fu preso di peso e portato dal Vescovo Valerio; non voleva, piangeva sul serio perché non voleva, sentiva la responsabilità: poi interpretarono male e pensando che volesse diventare Vescovo, gli dissero “fra poco ti facciamo Vescovo” ; e lui piangeva ancora di più. Abbiamo quindi bisogno proprio di consolazione nel ministero. Sant’Agostino Lettera 21: “Abbiamo bisogno di considerare che in questa vita e soprattutto in questo tempo non vi è nulla di più facile e gradito agli uomini della dignità di Vescovo, di prete e di diacono” - perché erano un titolo di onore, un ruolo dignitoso - diciamo, “ma nulla di più miserabile, funesto e riprovevole davanti a Dio se lo si fa negligentemente e con vile adulazione e che parimenti non vi è nulla in questa vita e soprattutto in questo tempo così difficile e faticoso, ma nulla è più gradito agli occhi di Dio della dignità di un prete, di un Vescovo e di un diacono se questi assolva a questa milizia nel modo prescritto dal nostro Capitano”. E’ ambivalente il ministero sacerdotale. Di fronte agli uomini è tutto onorato, ma di fronte a Dio nulla di più miserabile … e più dolce se lo fai secondo Dio. Ed in questa ambivalenza c’è necessità della consolazione di Dio. Per questo diceva il Signore: “Non vi chiamo più servi (…) ma vi ho chiamato amici , perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” e poi “voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove”. Allora, l’esercizio pastorale della speranza cristiana consiste – permettetemi questa banale espressione – nel farsi consolare da Dio, proprio come i bambini che piangono e si fanno consolare dalla mamma. E’ il primo fondamentale gesto di speranza, questo. E in tutte le difficoltà, quelle di vita cristiana, di itinerario vocazionale e di vita sacerdotale. L’intensa preghiera quotidiana, la sosta davanti al Santissimo Sacramento, l’Eucaristia celebrata come mistero di speranza. E’ un ricorrere a Cristo per ricevere per noi, nel concreto della vita, il dono 46 prete uomo di relazione, a partire dalla relazione fondamentale con Cristo. Quindi non un’antropologia di isolamento, di autoreferenzialità, ma di comunicazione del Vangelo, certamente, non di noi stessi; per questo si parte dall’esperienza fondamentale del Vangelo per aprire delle relazioni con tutti, con tutti. L’essere uomo di relazione implica l’importanza delle virtù umane. Virtù umane che ci permettono di essere ponte e non diaframma tra Dio e gli uomini. Una umanità di relazione, una umanità/ponte – pontifex – costruttori di ponti tra Dio e gli uomini. E ciò significa che devi essere ancorato come ogni ponte saldamente sulle due sponde: la sponda di Dio, fortemente, e la sponda degli uomini. Niente per le nostre comunità è più disperante di un prete astratto. Che significa astratto? Nell’etimologia tomista: tirato fuori dalla porta – abstract. Terzo punto: uomini che portano speranza nella Chiesa. La Chiesa che è fatta da noi. La speranza nella Chiesa è data da Cristo stesso, è dono suo, è Lui la speranza nostra, però deve essere coltivata. Come coltivare la speranza nella Chiesa? Portare la fiducia nella indefettibilità di questa speranza. “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa”. E poi portare nella Chiesa segni visibili di speranza. Posso fare degli esempi un po’ banali. Una sacrestia disordinata, non curata, dove nessuna cosa sta al suo posto, una sala di catechismo non pulita significa mancanza di speranza, perché? Io sono figlio di artigiani e ho lavorato nella bottega, con mio padre, anche da prete, quando andavo in vacanza, lui aveva bisogno e andavo a lavorare. La bottega, quando la chiudi alla sera, e pensi di riaprirla al mattino, ha bisogno di un ultimo gesto: di mettere tutti gli attrezzi al loro posto, di modo che al mattino puoi riprenderli per bene. Se invece un artigiano pensa ormai che deve chiudere, non mette niente a posto. Ciò che ti colpisce quando vai in una chiesa, in una sacristia, in un’aula di catechesi di un Oratorio e vedi le cose in disordine: ti sembra che sia una bottega in chiusura, cioè che manca la speranza. Gli spazi, piccoli o grandi che siano - quello dipende dalle possibilità economiche -, ma che siano curati: è segno di speranza. Segno che non siamo - noi preti - una specie in estinzione, ma che ci sarà qualcuno dopo di noi, e che dobbiamo trasmettere qualcosa agli altri. Segno di speranza nella Chiesa è la cura delle vocazioni sacerdotali e religiose; come obbiettivo specifico del prete, sì del prete, non del responsabile quanto vale una persona? Bambini innocenti, donne, che c’entrano? Il valore della vita: manipolazioni genetiche; il valore della famiglia, che sembra un incidente di percorso nella mentalità di oggi. “Mi è capitato di mettere su famiglia… Non so nemmeno io stesso come ho fatto”. E lo stesso senso della società e della storia umana, che sembra più giustificarsi ogni giorno come una gestione di affari e non come una comunione di persone e una linea di sviluppo tra persone che hanno un destino eterno dentro il loro cuore e nella loro stessa carne. L’aborto, il non riconoscere il primato della vita, mille ostacoli alla vita debole, nascente e al tramonto, ma anche nel suo pieno sviluppo. Non riconoscere il diritto al lavoro, alla serenità, alla libertà. Come essere testimoni di incrollabile speranza: prima di tutto scegliere di stare dentro i crocevia del nostro tempo. Non ci sono isole. Perché anche con un bambino di 7-8 anni devi starci bene. Stare dentro come? Che significa stare dentro i crocevia e le sfide del nostro tempo? Dentro, con la cultura innanzi tutto. Capire, studiare. Dentro con la vita. La vita delle nostre parrocchie non può essere una vita astratta dal territorio. Lo stesso nome di parrocchia e di diocesi, nella sua etimologia, dice una presenza nelle case degli uomini. La pastorale del “recinto”, ce lo diceva Giovanni Paolo II, a Palermo, non esiste più. Non è mai esistita nella Chiesa. La pastorale della Chiesa è quella del buon pastore che va alla ricerca della pecorella smarrita, non è quella del guardiano che conta le pecore. Nei primi anni di sacerdozio la nostra grande attività esterna era quella di contare il numero di persone che venivano in chiesa, ogni hanno si faceva una specie di censimento. Si distribuivano quattro specie di immaginette all’ingresso della chiesa giovani, ragazze, donne e uomini e tu avevi così il numero delle persone in base a quante immaginette avevi distribuite e questa era l’attività esterna; a un certo momento ci siamo ribellati. Ma questa non è pastorale: questa è essere guardiani del museo. E quindi la vita delle parrocchie deve essere dentro alla realtà. Questi problemi che si dibattono in televisione, nei forum televisivi, sono dentro le famiglie, vivi, a volte in maniera normale a volte in maniera esasperata. Il prete semina la speranza, se sta accanto agli uomini e alle donne del suo tempo. Questo, scusate lo dico per me, veramente, implica una antropologia diversa (che è richiamata nella Pastores do vobis ) un’antropologia di relazione: il 47 voci dai pergami ... persuadono a fatica e altro vento spira la più efferata barbarie …. Torniamo all’amore pur se anche … familiare il dubbio ti morde e la solitudine pare invalicabile”. Bellissima esortazione. Pensate al Libano in questo momento, che deve subito ricostruirsi! Allora – ripeto – piccoli segni di speranza nella Chiesa. Primo: curare le nostre chiese, piccole o grandi, povere o ricche non fa niente, ma curate. Io ho ammirato – ve lo posso dire – in alcune nostre borgate della Basilicata qualche casa che non ha ancora i mattoni per terra, ha ancora il cemento liscio, eppure c’è una grande pulizia, una povertà dignitosa. Curare le vocazioni, come segno di speranza – l’ha detto padre Turoldo – e curare l’accoglienza alla vita. La denatalità italiana è segno di mancanza di speranza, è segno che stiamo diventando una nazione di disperati. E si cura l’accoglienza alla vita in una forma educativa che va dall’educazione all’affettività, fino alla preparazione al matrimonio. Una delle forme antiche di eresia che derivava dall’agnosticismo era quella che separava la sessualità dalla procreazione. Perché secondo alcuni gnostici demiurgo aveva messo l’istinto sessuale come trucco, come trappola per gli uomini e le donne, per far procreare, perché diceva: se no questi non procreano; allora ci metto l’istinto sessuale. E prendevano demiurgo in giro; fanno lo stesso adesso. L’educazione all’accoglienza e alla affettività è educazione alla speranza, l’educazione all’accoglienza e alla vita, l’educazione prima all’amore familiare e poi l’educazione alla vita, perché devi creare alla vita un luogo giusto, altrimenti non puoi, perché è come se procreassi delle persone che poi non sai a chi affidare, bisogna avere questa fiducia: affettività, amore familiare e accoglienza alla vita. In questi tempi – diceva il beato Giovanni XXIII°: “assistiamo a una crisi in atto nella società; l’umanità è ad una svolta di una nuova era, e alla Chiesa spettano compiti di una gravità e di un’ampiezza immensa, ma come sempre – aggiungeva – la Chiesa può contare sull’aiuto di Gesù Cristo”. La fede nella indefettibilità della Chiesa deve esserci non con un senso trionfalistico, ma per mettere segni di speranza in tutto quello che noi facciamo. Un grande teologo dei nostri tempi scrive così: “Le forze del male potranno tentare di distruggere la Chiesa, forse persino seminare in essa fermenti di morte, ma essa compirà – malgrado tutto – la sua missione di salvezza, non a motivo dei suoi meriti ma per la fedeltà di Dio”. Nel giorno della parusia ci sarà diocesano delle vocazioni. Io per 14 anni ho fatto questo lavoro, ma ho sempre preteso di lavorare sul lavoro dei parroci, altrimenti non ci andavo. Ho visitato le parrocchie della mia diocesi quasi tutte le settimane, a tappeto, e ringrazio il Signore che nella mia Diocesi in ogni parrocchia c’è il vice parroco. Quando si lavora per le vocazioni il Signore premia e dà i suoi frutti, perché ci tiene Lui alle vocazioni ed è un incoraggiamento a lavorare molto per le vocazioni, tutte le vocazioni, non solo quelle della propria bottega, ma per tutte quante. Quando sono andato a fare il Rettore del Seminario minore e l’animatore vocazionale, in Teologia della mia diocesi c’erano due seminaristi; quando sono passato a Molfetta i seminaristi in Teologia erano 15, frutto certo non solo mio ma di chi collaborava con me. Quindi curare le vocazioni e poi curare gli spazi sacri, gli spazi di catechesi, gli spazi di cultura; curarli materialmente, gli spazi della liturgia. Curare le vocazioni perché saranno quelli che prenderanno il posto dopo di noi. Terzo. Di fronte a momenti decostruttivi, materiali o spirituali, sempre riprendere daccapo il cammino, con entusiasmo e fiducia. Qui c’è la basilica: terremoto dell’80. Io dico che ci sono due terremoti: uno si chiama incuria e l’altro si chiama sisma e non si sa quale dei due faccia più danni. C’è da ricostruire: voi sapete che alcune chiese non sono ancora aperte? Io ho una cattedrale e due concattedrali: le due con-cattedrali sono ancora chiuse dopo 26 anni. Quella di Potenza per fortuna è stata colpita poco, ma le altre due sono state colpite prima dall’incuria e poi dal sisma: non si sono ancora riaperte. Pensate a quanta fatica hanno fatto i nostri per ricostruire, dopo la seconda guerra mondiale, le case, le chiese, instancabilmente, di ricostruire un gruppo che si è disperso - dicevo momenti di ricostruzione materiale e spirituale - un gruppo qualunque di Azione Cattolica, Apostolato della preghiera; fenomeni di dispersione: ricominciare daccapo, instancabilmente. Certamente la ricostruzione più forte è stata quella che interessò l’Europa dopo la II Guerra Mondiale. Leggevo una poesia di Davide Maria Turoldo, molto interessante, una poesia scritta da prete. “Torniamo ai giorni del rischio, quando tu salutavi a sera – sotto il nazismo – senza essere certo domani di vedere l’amico, il mattino, e i passi della ronda nazista dal selciato ti facevano eco dentro il cervello nel nero silenzio della notte. Torniamo a sperare come primavera torna ogni anno a fiorire che i bimbi nascano ancora, profezia e segno che Dio non si è pentito. Torniamo a credere, pur se le 48 veramente un segno di speranza; sappiamo che i giovani sono a rischio e allora noi li mandiamo agli altri giovani che sono assieme a noi a portare la speranza di Cristo: ecco questa è la dinamica della pastorale giovanile. Mai fare una pastorale di gruppo fine a sé stesso, ma di gruppo che evangelizza, che testimonia, di gruppo che ha cura dei luoghi dedicati alla speranza. E infine, come pastori del nostro popolo siamo chiamati a dare alla nostra guida pastorale l’esatta e precisa configurazione di pastori di un popolo di pellegrini, un popolo pellegrinante come dice il Concilio, stranieri e pellegrini (cfr. I Pietro 2-11). La comunità cristiana si caratterizza – lo dice il Concilio – per la sua dimensione escatologica. Non un popolo stanziale, non un popolo che si difende, non un popolo che si costruisce la sua patria, addirittura dentro una patria terrena. No, non è questa la Chiesa. E’ un popolo che cammina (lettera a Diogneto, lo ricordate) nella patria terrena, verso la patria celeste. Ogni patria e luogo straniero è patria per loro, purché si impegnano a fondo. Il pellegrinaggio oggi si esprime si vive e si manifesta soprattutto con una vita povera. Proprio povera, quella del Vangelo, quella di Gesù Cristo, quella di San Francesco, senza fare i voti. La povertà cristiana: anche quella francescana… le modalità sono diverse dipende dalle diverse vocazioni: anche i ricchi sono chiamati ad essere poveri. Noi abbiamo avuto un industriale, Falk, Presidente dell’UCID per tanti anni (Unione Cattolica Imprenditori Dirigenti), che era un uomo che viveva da manager la sua povertà. Lui diceva a tutti i suoi consociati: “Il manager vero non deve mai accumulare denaro, ma deve investire per creare lavoro” – vedete la povertà di un uomo. Noi siamo chiamati a vivere la povertà, prima di tutto come fiducia nella Divina Provvidenza, e dobbiamo superare l’ostacolo che si chiama “IDSC”, l’Istituto Diocesano Sostentamento Clero; questo è un ostacolo alla fiducia nella Provvidenza. Dobbiamo accoglierlo con libertà come dono della Chiesa per la nostra sicurezza e la nostra serenità e soprattutto per la sperequazione. Chi di noi ha vissuto prima dell’Istituto sa bene che c’è una sperequazione enorme nel clero, tra chi aveva in abbondanza e arricchiva la famiglia e chi, come il sottoscritto e molti come me, andavano a casa a chiedere i soldi per comprarsi le scarpe, perché non bastavano i soldi quando dovevi cambiarti le scarpe. Poi c’è stata una forma di perequazione meravigliosa, che non deve però essere una forma che ci porti a dimenticare che bisogna fidarsi della Provvidenza e quei soldi che ancora perché l’amore di Dio per l’umanità non sarà estinto. Attraverso di essa il Vangelo continuerà ad essere proclamato e i mezzi di salvezza non cesseranno di essere offerti. Il responsabile di questa continuità è evidentemente lo Spirito Santo ed ecco il quarto segno di speranza: a noi tocca di essere docili all’azione dello Spirito che è l’autore della indefettibilità della Chiesa. Docili alla sua potenza, nella preghiera, nel sacrificio e nella sofferenza in tutto quello che di spirituale avviene dentro di noi. Il più grande segno di speranza che avviene nella Chiesa e nel mondo è la celebrazione eucaristica. Non per niente noi proclamiamo “annunciamo la Tua morte Signore, proclamiamo la Tua risurrezione, nell’attesa della Tua venuta”. La celebrazione eucaristica va impostata e celebrata proprio come luogo di partenza del cammino di speranza della comunità. E già meditarlo è un passo avanti. Porre segni di speranza nel mondo. Dovunque ma in particolare dove la speranza può diventare debole, dove ci sono persone più esposte alla fragilità e alla disperazione. La Presbiterorum ordinis ci ricorda che sono affidati in modo speciale ai presbiteri i poveri e i più deboli, ma anche i giovani e le famiglie. E’ lì che la speranza deve diventare continuamente forza per agire. I poveri, i giovani e le famiglie sono le persone più esposte e più sensibili all’oblio della speranza. Qualche volta ci scusiamo: “ma la povertà diciamo - è colpevole, se c’è un problema è perché qualcuno non ha saputo gestirsi” e poi c’è un asintoto che dice che è una malattia che passa. Ma fratelli miei se i giovani non sono - come ci diceva Giovanni Paolo II° - la speranza e il futuro dell’umanità è perché non li curiamo. Questi giovani a rischio di droga, a rischio di deviazioni, a rischio di illusioni e di inganni, questi giovani sono il futuro della Chiesa e dell’umanità. E quindi è segno di speranza una pastorale giovanile realistica, non di tipo dualistico. Il dualismo sapete che cos’è? E’ la maestra che chiama il capoclasse e gli dice “Io mi devo assentare 10 minuti: metti buoni e cattivi e tira una linea al centro per distinguere gli uni dagli altri”. I giovani che noi coltiviamo nelle nostre comunità hanno diritto – questo lo dicevo quando ero viceparroco – di consumare l’annuncio della Chiesa, perché devono andare a portare l’annuncio poi fuori, altrimenti non hanno questo diritto; i soldi che risparmio li porto ai poveri. Dobbiamo coltivare i nostri giovani come base missionaria, punto di partenza per la testimonianza di Gesù risorto. Allora la pastorale giovanile diventa 49 sono uomini maturi, così come lo è il nostro Signore Gesù Cristo. Chiudo con un brano molto bello del cardinal Suenens: “Sono un uomo di speranza perché credo che Dio è nuovo ogni mattina, sono un uomo di speranza perché credo che lo Spirito Santo è ancora all’opera nella Chiesa e nel mondo; sono un uomo di speranza perché credo che lo Spirito Creatore dà all’uomo che lo accoglie una libertà nuova, e una provvista di gioia e di fiducia. Sono un uomo di speranza perché so che la Chiesa è piena di meraviglie; sperare è un dovere, non un lusso, sperare non è sognare ma è la capacità di trasformare un sogno in realtà. Felici coloro che osano sognare, che sono disposti a pagare il prezzo più alto perché il loro sogno prenda corpo, perché il sogno di Dio, l’umanità”. abbiamo servono per noi e per le comunità; non voglio entrare più profondamente in questo discorso. Il pastore di un popolo pellegrinante è un pastore povero, cammina leggero sulle vie della vita, non può essere pesante, avere difficoltà a camminare, un po’ di bagaglio lo deve lasciare da qualche parte e deve educare il popolo alla povertà e alla sobrietà. Allora Giuseppe adesso viene ordinato prete e si fa una casula di 2.000 euro e un calice da 2.000 euro: va bene, a gloria di Dio? Ve lo dico sul serio. Questa è la celebrazione della prima Messa, la celebrazione di un popolo pellegrinante? Sono esempi, prendeteli proprio con estrema libertà e non voglio insistere più di tanto. Che celebrazione è quella? Mi capite? E così via. Un prete deve essere povero e deve educare un popolo di poveri, perché solo i poveri coltivano la speranza nel cuore. Beati i poveri perché di essi è il Regno di Dio. Speranza del Regno e povertà sono legati strettamente. E infine, il prete deve essere un uomo coraggioso; anche di fronte alle difficoltà deve essere capace di educare al coraggio cristiano. Abbiamo un buon libro del II° secolo, Il pastore di Erma. In una di queste visioni, una donna anziana ben adornata e ben curata, che rappresenta la Chiesa, dice ad Erma un giudizio severo a chi cade nel vizio, ma un incoraggiamento verso chi è fedele. C’è bisogno di coraggio per vivere da cristiani, c’è bisogno di coraggio per vivere da preti veri. C’è un nostro beato della Basilicata, il Beato Lentini, che diceva “essere prete prete” e lui per essere prete nell’800 non ha mai fatto il canonico o il parroco perché era troppo assicurato: lui ha fatto il prete senza titolo però ha fatto un sacco di bene; prete prete. Ci vuole coraggio fratelli miei. E allora voglio leggervi questo brano del pastore di Erma: “ Non appena finì di leggere si alzò dalla cattedra e vennero quattro giovani, presero la cattedra e si allontanarono verso oriente, la cattedra dove stava questa donna anziana: ella mi chiama e mi dice: Ti è piaciuta la mia lettura? Signora, mi sono piaciute le ultime parole, le prime sono state difficili e dure, quelle di condanna; essa poi soggiunse: le ultime sono per i giusti, le prime per i pagani e per gli apostati. Mi stava parlando quando apparvero due uomini, la presero sulle spalle e si allontanarono verso la cattedra d’Oriente. Se ne partì lieta e andandosene disse “Coraggio, coraggio”. “Coraggio” in greco sapete che cosa vuol dire? Sii uomo: è una virilità propria dei figli di Dio, che * * * Il Relatore ha poi risposto alle seguenti domande - Come sensibilizzare i fedeli alla speranza nei carcerati? - Lei diceva che la prima cosa che deve fare il prete, prima di educare alla speranza, è che deve viverla. E in particolare ha parlato di godere della consolazione che viene da Dio, specialmente nella Eucaristia. Mi domando: in che rapporto stanno nella vita di un fedele, in particolare nella vita di un sacerdote, l’azione di Dio nella vita spirituale, nella vita di preghiera e la consolazione di Dio attraverso la comunità cristiana? Perché una della mie paure, guardando un po’ la realtà dei sacerdoti intorno a me, è che c’è il pericolo,mi sembra abbastanza reale, di solitudine, di essere lasciati soli dalla propria comunità, ecc. In che misura va ricercata questa forma di coltivare la speranza, anche nel calore umano? Risposte La speranza dei fedeli riguardo ai carcerati. Per i fedeli, riguardo al loro rapporto con i carcerati, l’educazione è alla dignità dell’uomo. Vi racconto un fatto che di cui avete sentito parlare certamente perché è di don Tonino Bello. La chiesa, il santuario della Madonna dei Martiri, era stata appena riconosciuta come Basilica minore. Don Tonino, come faceva sempre dopo la 50 Direbbe S.Tommaso: nego suppositum. Il Signore non ci chiama ad essere mezzi uomini, per essere preti: ogni vocazione è data all’uomo e alla donna, per esaltare al meglio la sua umanità, quindi una vocazione pienamente realizzata non ha bisogno di integrazioni, perché il Signore ti dà qualcosa che ti riempie completamente, ti dà la pienezza di vita, nel momento in cui tu l’assumi totalmente. E quindi la comunità è il luogo del servizio di carità; e se il Signore vuole, sarà anche il luogo della tua consolazione, che viene da Lui: se Lui vuole, ma non lo sappiamo. Non possiamo pretenderla. La comunità non è “per forza” il luogo della consolazione, può essere invece, a volte, il luogo della tribolazione; quindi la consolazione ti viene direttamente da Lui. Quale è il problema? C’è un problema però. Il problema riguarda la maniera in cui si concepisce il celibato del sacerdote diocesano, non quello religioso. Spesso il celibato sacerdotale – e ciò che dico adesso a voi l’ho detto all’ultima assemblea della CEI a maggio, davanti a tutti i vescovi – è concepito in negativo: come una scelta di non sposarsi. Secondo voi, uno può scegliere di non sposarsi, secondo la natura umana? Perché uno deve scegliere di non sposarsi, se il Signore stesso ha voluto il matrimonio? Invece il celibato non è scelta di non sposarsi, ma scelta prioritaria di consacrare tutta la propria vita, in maniera totale, integra e di fare di Dio – Salmo 15 – l’eredità e il calice. Primariamente questa non è una scelta: primariamente è un dono, un carisma. Nel sacerdozio di rito latino noi abbiamo due realtà che si fondono insieme, ma che logicamente sono distinte: il celibato, cioè vita totalmente consacrata a Dio e il ministero sacerdotale, che la Chiesa dona a chi ha già questo dono del celibato. Il celibato non è la “condizione” per diventare prete: è il carisma su cui la Chiesa latina pianta il ministero sacerdotale. Che significa questo? Significa che il carisma del celibato esige: primo, un proprio discernimento, proprio, che appartiene al carisma del celibato; cioè non basta chiedermi se sono chiamato a fare il prete: devo chiedermi se il Signore mi ha dato questo dono del celibato. Richiede quindi un discernimento appropriato, richiede una cura appropriata, richiede uno stile di vita appropriato per coltivare il carisma, una spiritualità appropriata, una relazionalità appropriata, che non è la relazionalità dello scapolo, ma dell’uomo che è “più che accasato”, perché è totalmente impegnato con Dio e funzione, si mise in macchina con dei giovani per andare fuori città in una casa dove c’era un tale, Giuseppe, che si ubriacava continuamente e veniva fatto ubriacare dai giovani di Molfetta per divertirsi e vederlo ubriaco: e poi lo trovavano lì, al portone dell’episcopio. Durante il tragitto i giovani avevano discusso con don Tonino: “che significa Basilica minore o basilica maggiore?” Don Tonino non sapeva rispondere e se ne uscì con questa risposta: “guardate questo non è importante, quello che è importante è sapere che la Basilica maggiore è l’uomo, perché è veramente la casa di Dio, e in questo è la sua dignità”. Allora trovarono Giuseppe e chiesero : “don Tonino e quello che è? Basilica minore o Basilica maggiore?” Giuseppe era lì, ubriaco fradicio, con gli occhi stralunati… E don Tonino disse: “No, Basilica maggiore!” Poi riportò questo episodio in un suo libretto quaresimale, che ha come titolo un brano dell’inno quaresimale Non togliere da noi il segno della tua gloria. Lì non è propriamente educazione alla speranza, ma alla dignità dell’uomo, a riconoscere la dignità dell’uomo in ogni persona, in qualunque condizione sia, che il Signore non toglie mai il segno della sua gloria nemmeno dall’omicida, ricordate Caino. E questa deve essere una prolungata educazione delle nostre comunità: poi viene la speranza. La consolazione di Dio nella preghiera e la consolazione della comunità. C’è stato un periodo in cui si faceva un gran parlare e scrivere della integrazione affettiva del prete. L’ipotesi era questa: l’uomo che vive il celibato non è integro…gli manca un pezzo! E’ da integrare, gli manca un qualcosa. Allora bisogna dargli la “moglie” che è la comunità. La comunità deve prendere il posto, nell’affettività sacerdotale, di quello che fa a livello affettivo la donna nella vita di un uomo sposato: quindi, consolazione da Dio nella preghiera e consolazione della comunità nella vita comunitaria. E se non c’è? Ho conosciuto un missionario del Pime, che è stato 36 anni in Bangladesh, che non ha mai avuto una comunità! Perché il paese è a prevalenza musulmano; lui dava la sua testimonianza di cristiano, serviva nella carità i fratelli, ma la comunità vera e propria, gruppi di fedeli, non ne ha mai avuti. La comunità non può essere la moglie del prete. E dov’è la moglie del prete: in cielo? Non c’è. E’ il presupposto che è errato, secondo me. E’ errato il presupposto che il prete che vive il celibato, come il religioso che vive la sua consacrazione nella castità, nella verginità, sia un uomo non completo. 51 totalmente da Dio si aspetta le sue consolazioni, che può darle anche attraverso la comunità. Questo è quello che io penso. Come preti di rito latino, abbiamo da cercare le consolazioni soltanto da Dio e dire grazie a Dio se abbiamo una comunità accogliente, una comunità che ti gratifica, perché siamo deboli e abbiamo anche bisogno di quel sostegno, ma sempre se viene da Lui. Scusate la chiarezza dell’impostazione, ma questo è un punto decisivo per il ministero sacerdotale nella Chiesa di rito latino. Per il rito greco è un altro modo di vivere. Ma a noi la Chiesa prima di darci il sacerdozio ci chiede: il Signore ti ha dato la grazia, la chiamata specifica al celibato? Naturalmente la formazione prosegue insieme, ma la priorità logica e pedagogica viene sul celibato. Logica e pedagogica. Perché se so che il grano lo posso seminare solo su un certo tipo di terreno, prima vedo se il terreno è adatto e poi semino il grano; non faccio il contrario; seminare il grano per vedere se il terreno è adatto. E’ chiaro? Priorità logica e pedagogica: il primo discernimento, la prima cura, è sulla consacrazione a Dio, totale. Vi ho detto solo i principi, ma voi comprendete bene come sia feconda questa impostazione, anche nelle relazioni con gli altri. Nelle relazioni con gli altri, per il cristiano, ancor più per il prete, c’è il libro del dare e non dell’avere: c’è una sola colonna nel registro che è l’agape di Dio, che è solo dare e non avere. Per il matrimonio è un altro discorso. E allora la consolazione non è quella che mi viene dall’umano, che d’altra parte non devo mai disprezzare: dire al Signore “dammene, perché sono fragile” e poi ringraziare quando mi arriva. Ma come qualcosa in più che il Signore mi dà nella sua benevolenza, non è l’essenza di tutto; la consolazione è quella che viene da Dio: lo dice chiaro l’apostolo Paolo. 52 Conclusioni finali dei partecipanti Moderatore: Don Giacinto Danieli Ci sono state tre essenziali figure che hanno caratterizzato la nostra nozione di speranza: la morte, l’amore e l’esperienza di Dio. Morte e amore diciamo in qualche modo caratterizzanti la dimensione umana dell’uomo. Infatti tutti noi conosciamo, veniamo in contatto con queste esperienze forti: la morte è un’esperienza negativa ma un cristiano sa che la morte c’è però porta alla gloria; l’amore è anche un’esperienza forte che consente di poggiare su un fondamento. La cosa che è molto importante a mio avviso, e che spero che anche i miei amici del gruppo possano condividere è che morte e amore si richiamano inevitabilmente alla figura di Dio. Dio incarnato, Gesù Cristo, Dio con noi, che è morto e che è risorto. E questo ci permette di mantenere e di ricollegarci giustamente all’intervento e alla prolusione di Mons. Naro e al buon rapporto con Gesù, perché è Lui il fondamento e credo che sia il termine ultimo e primo su cui andare a fondare le riflessioni che adesso spero di poter enucleare brevemente in modo da creare un po’ di chiarezza in voi e anche in me: ce n’è sempre bisogno. Come ho detto: Dio Padre come fondamento, Dio come rapporto di amore che in Dio può essere riassunto, ma certamente questo rapporto Diouomo che è inevitabile nel cristiano comporta anche una prassi, e da quello che è uscito anche nelle nostra verifica comunitaria e di gruppo, porta inevitabilmente a misurarsi nell’ambito pastorale. Tant’è che la seconda domanda del nostro gruppo è stata: quali sono i mezzi con cui la speranza che noi cerchiamo di vivere, con cui cerchiamo di relazionarci, entra nella nostra vita – e qui viene specificato: sia da seminarista, sia da prete. I mezzi sono, come ho detto prima, un buon rapporto con Dio, ma poi una cosa bella che è uscita dalle nostre riflessioni è una visione ordinaria della vita del cristiano. Non sono uscite delle idee fuori della norma, ma semplicemente il riprendere in modo serio e approfondito, e soprattutto vedendolo nell’ottica di Dio, quelle cose che compiamo quotidianamente. Soprattutto nell’ambito pastorale è venuto fuori in modo più marcato il vivere bene il discorso della vita sacramentale. Attraverso il rapporto con i sacramenti il Cristo morto e risorto viene presentato e parla a noi nel nostro tempo. Per cui è il sacramento dove questo Gesù è luogo di speranza: in qualche modo è presenza di Gesù in Si tratta di raccogliere il lavoro che è maturato durante i lavori di gruppo. Richiamo in modo telegrafico un idea per ciascuno dei quattro relatori; ve ne sarebbero molte altre, ma é solo per richiamare un contesto per gli interventi dei tre segretari che tra poco condividono. Mons. Naro partiva da un’affermazione: la speranza nasce e matura dentro una buona relazione con il Signore Gesù. Mons. Monari, rifacendosi ad una espressione di Gabriel Marcel definiva la forma della speranza come “io spero in te, per noi". Don Romano Martinelli, esordiva dicendo che ognuno di noi è un racconto di speranza. Quindi bisogna partire dal nostro vissuto, dalla nostra fatica, e anche dalla gioia di vivere. Mons. Superbo raccoglieva e poi approfondiva, documentando, una ulteriore sottolineatura che in qualche modo ritornava all’inizio del discorso: una buona relazione con il Signore, essere consolati da Dio, lasciarsi consolare. Da questa esperienza viene un desiderio e un impegno di testimonianza della speranza. Detto questo lascio la parola al segretario del primo gruppo che viene a relazionare. Primo gruppo di studio Il nostro gruppo ha avuto come specificità il modo di strutturare il momento formativo di condivisione, con una libertà di intervento di fondo, in modo che le cose che venivano suscitate dalle domande potessero trovare una risposta efficace, in un momento preciso, per potersi aiutare nella riflessione di tutti. Tant’è che cercherò di essere il più schematico possibile, pure mi rendo conto che avendo questa possibilità di intervento libero, le cose si richiameranno l’una con l’altra e permetteranno di concatenarsi. Il nostro gruppo è partito da una domanda di base che ci aiutava ad introdurci in questo discorso: sul fatto che viviamo in una cultura e in una società liquida, nel senso che vi è una forte presenza di effimero, cioè tutto quello che in qualche modo dura un giorno, che non è eterno, quello che travalica la nostra possibilità temporale. La domanda iniziale che è anche il fondamento sulla speranza è: quali sono le certezze di base che consentono ad un cristiano battezzato, che cerca di vivere la fede, di appoggiarsi in questo millennio, in questo periodo particolare della nostra vita sia umana che ecclesiale. Una base su cui fondare la speranza 53 una frase di San Josemaría Escrivá citata da Simone; egli diceva “la nostra gioia ha le radici a forma di Croce”, quindi la nostra speranza è radicata nella Croce. Nella Trasfigurazione Gesù mostra ai discepoli quella che sarà la sua Gloria, mostra la sua Divinità. E tuttavia a Pietro dice “Lungi da me Satana” perché Pietro voleva distoglierlo da quella che era la sua missione reale, per cui Gesù mostra a Pietro sì la gloria, però nota anche qual è la via per giungere alla gloria: la via della Croce. Quindi la testimonianza più forte che il cristiano possa dare della speranza è quella di un amore vissuto fino al dono totale, all’oblazione totale della Croce, “fino alla morte e alla morte di Croce” – come dice San Paolo – e quindi testimoniare la gioia nonostante tutte le difficoltà. Ora provo ad enucleare quali sono stati i vari pareri benché, vuoi per la sistematicità del dibattito e del collage, vuoi per la difficoltà del tema, non so se riuscirò a compaginare in modo compendioso e sintetico i pareri. Siamo entrati a tema sull’espressione cultura liquida, intesa come cultura relativistica e consumistica (liquido indica qualcosa che non è stabile, qualcosa di fluttuante, qualcosa che non è fermamente radicato, di aleatorio e che quindi può cambiare da un giorno all’altro). Quindi ciò che ci preoccupa è il fatto che ci sia un attaccamento quasi morboso a quel paradiso godereccio offerto dai beni effimeri e che quindi, come i beni effimeri, è anch’esso effimero, cioè non dà all’uomo quelle certezze di cui l’uomo ha bisogno ma lo precipita in situazioni angosciose e deprimenti. Basti poi pensare alla situazione talvolta disastrosa della nostra società, il valore che viene dato al matrimonio, i giovani che sembrano non credere più in alcun valore. Ora tuttavia anche noi siamo figli di questo tempo e essere apocalittici non conduce a nessuna soluzione, perciò bisogna partire da quanto c’è di positivo anche nella nostra cultura e su questo imperniare la nostra azione pastorale e di annuncio, per poter testimoniare la nostra speranza. I beni effimeri allora assumono un’altra connotazione, un’altra configurazione: possono essere strumenti. Ci seducono senz’altro, possono affascinare, possono essere strumenti di male, e quindi nocivi, ma i beni effimeri possono essere anche strumenti di evangelizzazione. Quindi i beni effimeri possono essere strumenti. Il problema è quando questi beni diventano il fine. Invece no; essi devono essere finalizzati all’uomo che se ne serve. Il problema è che talvolta i giovani non avvertono neanche il bisogno di avere delle certezze perché con questa continua acquisizione noi e questo avviene in modo mirabile. Un secondo apsetto che è stata evidenziato come mezzo per poter vivere di speranza e avere questa consapevolezza forte di Gesù in mezzo a noi, è il rapporto umano che si intesse con le persone, sia a livello pastorale, sia a livello seminaristico e nelle nostre piccole attività. Nelle nostre attività ci possono essere delle possibilità di rapporti: anche lì c’è bisogno di rivalutare il fattore umano come fattore fondativo dell’amicizia di Gesù. Il rapporto con Gesù non è preconfezionato e predeterminato, ma passa sempre attraverso una mediazione umana: oltre alla vita sacramentale, nella vita di tutti i giorni passa anche nel rapporto che abbiamo con le persone. Per cui un mezzo importante per rivalutare la speranza sono i rapporti con cui viviamo le nostre relazioni quotidiane . Terzo punto: ci viene anche chiesto di saper scorgere i segni della speranza nella cultura di oggi. Noi li abbiamo trovati negli avvenimenti che sono accaduti sia nell’ambito ecclesiale, sia nell’ambito puramente umano della nostra vita e sono: la moltitudine di persone che si sono mosse con Giovanni Paolo II per andare a incontrarlo nella sua morte, persone che prendono sul serio la vocazione, persone che amano ritornare alla vita sacramentale e alla vita di fede attraverso la Confessione e anche attraverso la formazione che, come è abbiamo colto noi, è stata presa seriamente. Ci veniva chiesto nell’ultimo punto della nostra riflessione: se si ha ancora la possibilità di portare speranza. Il mio pensiero, e quello che è uscito dal nostro gruppo, è sì, perché avendo Gesù Cristo, crocifisso e risorto, in mezzo a noi presente, questa speranza non può morire, ma continuamente può essere alimentata dalla sua volontà di essere in mezzo a noi. Secondo gruppo di studio La prima delle domande che ci introducevano al tema era sul rapporto tra la Croce e la speranza, la seconda poneva il rapporto della contro testimonianza dei credenti e la terza poneva il problema del rapporto tra speranza e testimonianza. Rileggendo quella che è stata la nostra comune riflessione penso di poter dire che essa si è mossa attorno alle tre virtù teologali; siamo giunti alla comprensione non tematica che le virtù teologali sono inscindibili. Vale a dire che la testimonianza della speranza nasce da un qualcosa in cui si crede, quindi da una fede forte e retta e quindi viene poi testimoniata nella carità e anche nella Croce. Ora io partirei proprio dalla fine, da 54 Terzo gruppo di studio di beni effimeri sono quasi narcotizzati per cui questa situazione viene a soffocare la domanda e il bisogno di certezze, domanda che comunque alla fine è insopprimibile. Allora, in questa situazione, è necessario da parte nostra testimoniare con la nostra gioia, anche nelle sofferenze; che questa gioia a noi deriva da qualcuno e che quindi c’è Qualcuno che è a fondamento della nostra vita e della nostra speranza e che questo Qualcuno è Dio. Talvolta anche dare un sorriso – diceva Giuseppe in un mondo nel quale il sorriso non si vede tanto è una grande testimonianza cristiana, una testimonianza di speranza. Abbiamo accennato al valore e all’importanza delle radici cristiane e dell’importanza che una famiglia sia cristiana e che introduca in un ambiente cristiano i figli. Poi abbiamo parlato della ricerca del religioso e della domanda religiosa che non riesce ad essere soffocata e che talvolta trova degli sbocchi che sono devianti per esempio la new age o forme spiritualeggianti che non conducono a nulla ma solo ad esaltazioni. Giovanni Paolo II diceva che laddove c’è la domanda religiosa ma manca la verità, allora lì nascono le forme religiose. Allora a questo punto è necessario ricentrare l’annuncio sulla verità del Vangelo; del resto spesso capita che anteponiamo la nostra parola alla Parola di Dio. Questa può risuonare quando è detta nel nostro cuore ma va detta con verità, secondo la retta fede della Chiesa. Solo così è possibile la conversione, metànoia (dal greco si intende cambiamento del pensiero), il pensiero può cambiare in meglio se questo pensiero è santo. Però dobbiamo essere consapevoli che in ogni modo il nostro annuncio – con la nostra fede – si inserisce nell’azione della grazia di Dio: non siamo noi ad operare la conversione, ma è la grazia di Dio che opera in e attraverso di noi e negli altri. Ora la speranza – dicevamo prima – che in prospettiva cristologica ha il suo compimento escatologico, la nostra speranza realizzata, ma che già viviamo in questa vita, la nostra speranza è tanto più forte, più evidente, più visibile quanto più noi siamo attaccati a Cristo e quindi l’unica certezza che noi possiamo dare al mondo, la testimonianza più forte che noi possiamo dare è l’amore e l’amore che non disdegna neanche di salire sulla Croce e che quindi testimonia la gioia anche nelle sofferenze. La prima domanda era uguale per tutti:. Le certezze sono l’accettazione dell’uomo, in quanto uomo; l’identità dell’uomo in Dio è la certezza di Dio. In un mondo dove l’immigrazione e l’emigrazione creano incertezze e instabilità nelle persone, la Parrocchia e la tradizione del santo patrono e le feste sacre restano e sono il punto di riferimento per i cristiani di quella comunità. Ci sono famiglie che litigano tutto l’anno e quel giorno si trovano assieme a portare la portantina del Santo e sorridono. Il dato comune è riassuntivo della presenza della Chiesa: in ogni momento della vita c’è la Chiesa, è lì, e la certezza è nella presenza del prete. Tutti lasciano le loro abitazioni per recarsi al lavoro, ma quando rientrano vanno in chiesa a salutare Gesù Cristo, anche se in alcune diocesi ci sono chiese che sono chiuse perché mancano i preti. La seconda domanda: come seminaristi conosciamo diversi sacerdoti, educatori del seminario, in parrocchia e in diocesi, quali esempi di speranza vissuta impariamo e cerchiamo di imitarli. Si può vedere la speranza vissuta nel prete, uomo di Dio, perché riesce a rifletterla nell’amore. Questo lo si vede nella sua gestualità, serena, felice, sorridente, che ti sa rapire senza capirne il perché; uno del mio gruppo diceva che è bastato il sorriso del suo parroco a farlo rientrare nella comunità: una botta di spalla che dice che qui c’è qualcosa . Non bisogna prendere in considerazione i profeti di sventura, picconatori della speranza dei giovani; preti e seminaristi che creano negatività e che attentano all’azione dello Spirito Santo. Si può essere preti che manifestano la speranza anche nel saper ascoltare e creare ponti interpersonali con gli uomini. Lo diceva un Vescovo, in Germania, che la sua vocazione è nata vedendo una prima Messa di un giovane prete del suo paese, quello è importante, io ho tanti esempi di preti santi, anche nella mia diocesi, come quello che è morto ultimamente, un sant’uomo che aveva 90 anni e che non voleva lasciare la parrocchia. Diceva, “Dio ci ha dato la vita e fino a che ce la faccio, voglio rimanere, perché loro mi hanno dato tutto e io voglio essere tutto per loro”. Anche questo è un esempio per tutti noi. Poi – è la terza domanda – chiunque spera non dice “io spero" perché sperare è confidare in un essere che si può chiamare Dio. La speranza non può non essere comunione. Abbiamo visto nelle nostre varie realtà che si 55 Moderatore formano gruppetti all’interno della comunità e gli educatori che non sono in comunione tra loro danno alla loro comunità esempio di spaccatura e di insicurezza; danno un senso di angoscia e di solitudine. Anche nelle nostre realtà occorre eliminare la visione dell’altro come qualcosa o qualcuno da sfruttare, creando invidie e gelosie e superbia. Da noi avevano scelto un prete per fare la pastorale giovanile, ma quando i parroci hanno visto che attira tanti giovani e che gli vogliono bene, hanno detto: “calma, questi qui sono i miei”e salta fuori anche fra di noi la gelosia, anche in seminario, a volte, siamo in nove e facciamo i gruppetti da tre e questo è una cappa pesante. Nella luce della speranza, come nell’esempio di Cristo che testimonia l’amore di Dio bisogna cominciare da ora subito la comunione con le persone che incontriamo e bisogna vedere nell’altro il Cristo, l’abitazione della Santissima Trinità. I due discepoli di Emmaus, "Noi speravamo...": solo la compagnia del Risorto apre a speranza nella vita del seminarista e del presbitero. Nella vita del seminarista e del prete si apre la speranza nel Cristo, vivendo nel reciproco ascolto e nella stima reciproca e nella carità evangelica, praticamente vivendo da uomini e presbiteri forti in Cristo per il bene della Chiesa perché si lavora tutti per la stessa vigna e per lo stesso padrone. E qui è l’esempio che faceva don Giuseppe di un prete di Napoli che era parroco nel tesoro di San Gennaro che è la chiesa più importante. Lo chiama il Cardinale e gli dice guarda che mi piacerebbe mandarci un altro al tuo posto, e lui “Eminenza, noi siamo nella stessa barca, un tuffo un po’ di qua e un po’ di là, noi lavoriamo per lo stesso padrone, nella stessa barca. * * Raccolgo con due sottolineature. Una domanda che mi è rimasta, e che volevo proporre a Mons. Superbo, che diceva del rapporto del sacerdote con la comunità. Ascoltandolo mi veniva spontaneo aggiungere una dimensione che è evangelica: la fraternità sacerdotale come luogo dove anche gli affetti del seminarista e del prete si integrano, per usare un termine nostro, si completano. La fraternità sacerdotale fa tutto questo perché Gesù è dentro l’anima della vocazione. Vi ricordate che salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle e ne costituì dodici – una piccola comunità – che stessero con Lui, per poi mandarli. E’ costitutivo, é il primo luogo dove c’è stata una fraternità sacerdotale e che si impara su di noi, fin dal seminario, ci si esercita, ci si allena, ci si esige. E allora è facile proprio fare dei passi? A me ha sempre colpito, ed è anche un’indicazione di metodo pastorale, soprattutto nelle relazioni con i sacerdoti curare un rapporto di confidenza e di amicizia: non di compagnia - la pacca sulla spalla – e poi magari alle spalle parlare male. La cosa che fa più male è proprio questo parlare alle spalle il mormorare: non crea speranza, ma mortifica. La seconda cosa che mi pare importante è una consegna che mi è stata fatta dal mio Patriarca, Marco Cé. Quando quattro anni fa lasciava il governo della Diocesi sono stato a salutarlo e a ringraziarlo, anche se continua il rapporto di amicizia e filiale che mi ha unito per 23 anni di presenza, e gli ho chiesto che consiglio mi dava per il mio ministero di padre spirituale. Mi disse “Giacinto, contentati che lascino il seminario convinti che bisogna avere un padre spirituale, che è necessario avere una guida”. E ho trovato conforto in un passaggio della relazione di mons. Monari all’assemblea della CEI nel maggio scorso: “Naturalmente queste riflessioni non tolgono, anzi rendono ancora più chiara l’importanza di verificare il proprio cammino con una guida spirituale; l’autenticità infatti è sempre precaria, è sempre una uscita dall’inautenticità, è un cammino che va fatto con un fratello. Bisogna valutare sempre daccapo la propria decisione e naturalmente questo non è facile senza un confronto costante con un’altra persona, una persona che ci aiuti a vedere le nostre incoerenze, a riconoscerle umilmente e a cercare di superarle”. * (ndr. Generoso è l’applauso a tutti e tre i segretari di gruppo: è un compito che si vorrebbe evitare, e per questo chi lo accetta merita davvero la gratitudine di tutti) 56 C’è l’intervento del Santo Padre, la relazione di Mons. Monari, una sintesi dell’intervento del Card. Ruini e anche la sintesi dei lavori di gruppo. Una miniera su cui fare meditazione; il titolo è “Lettera ai sacerdoti italiani”. Mi permetto di consigliare, come ulteriore riflessione di questo straordinario convegno ricordando anche le buone suggestioni che sono maturate nel lavoro di gruppo: questa pubblicazione che raccoglie alcuni interventi nell’Assemblea della CEI del maggio scorso. 57
Scarica