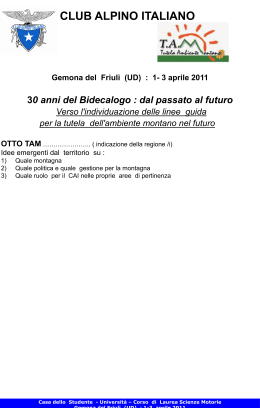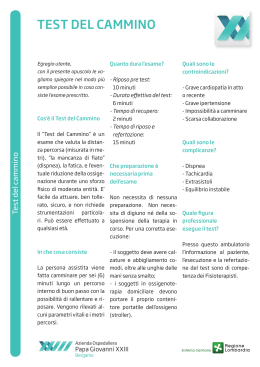ProsPettIve antImoderne n. 01/2011 Il pensiero in cammino Il camminare nelle sue valenze spirituali, filosofiche e metafisiche Il pensiero in cammino Il camminare nelle sue valenze spirituali, filosofiche e metafisiche n. 01/2011 pag. 4 La montagna come esperienza del limite di Francesco Tomatis pag. 5 Editoriale: metafisica del camminare a cura della Redazione Antarès, Prospettive Antimoderne RIVISTA TRIMESTRALE GRATUITA pag. 8 Direttore editoriale: Andrea Scarabelli Direttore responsabile: Gianfranco de Turris Redazione: Rita Catania Marrone, Francesca Noemi Coscia, Emanuele Guarnieri Hanno scritto: Rita Catania Marrone, Igor Comunale, Emanuele Guarnieri, Mitsuharu Hirose, Andrea Marini, Gianpiero Mattanza, Marco Molino, Mauro Scacchi, Andrea Scarabelli, Francesco Tomatis Illustrazioni di: Alessandro Colombo, Irene Pessino Progetto grafico e AD: panaro design Impaginazione: Studio Caio Robi Silvestro Edizioni Bietti - Società della Critica srl, Sede legale: C.so Venezia 50, Milano www.edizionibietti.it Saggi: Alejandro Jodorowsky: La Montagna Sacra di Mitsuharu Hirose pag. 11 Strada a senso unico, molte destinazioni di Igor Comunale pag. 15 Spiritualità della strada di Emanuele Guarnieri pag. 20 Il camminare come gesto e disobbedienza civile di Andrea Marini pag. 25 E la verità si fece pietra di Marco Molino In attesa di registrazione presso il Tribunale di Milano Stampa: ProntoStampa srl, Via Redipuglia 150, Fara Gera d’Adda (BG) pag. 28 Il cammino spirituale nella Tradizione di Mauro Scacchi [email protected] www.antaresrivista.it Antarès è anche su Facebook, alla pagina “Antarès Rivista”. pag. 35 Ascesa e ascesi – la vetta come conquista interiore di Andrea Scarabelli Recensioni: pag. 39 Nicolás Gómez Dávila: Pensieri antimoderni di Gian Piero Mattanza pag. 41 Andrea Colombo: Il Dio di Ezra Pound di Andrea Scarabelli pag. 43 Fernando Pessoa: Economia & Commercio di Rita Catania Marrone pag. 46 Francesco Tomatis: Filosofia della montagna di Emanuele Guarnieri n. 01/2011 I L PROGETTO che presentiamo si rivela, al contempo, conclusione di una serie di riflessioni svolte dalle personalità che vi ruotano intorno e come periplo intellettuale e filosofico, atto a favorire lo sviluppo di tematiche la cui urgenza DEVE impensierire chi ha a cuore la cultura di questo ateneo, di questa città, di questo nostro tempo. Da siffatte preoccupazioni nasce questa associazione, la quale si prefigge, come scopo da conseguire, una riflessione costante e puntuale su quei DOGMI in nome dei quali il mondo moderno – nonostante la sua apparente avversione per ciò che è dogmatico – miete le sue vittime. Riflessioni, queste ultime, il cui contenuto è stato abbozzato nell’opuscolo diffuso, in cinquanta copie – tiratura limitatissima dovuta alla natura stessa del progetto, il quale è interamente autofinanziato – tra il 18 e il 19 ottobre, nel nostro Ateneo. Proprio in merito a quanto trattato in esso, Antarès, nella forma della sua redazione e dei suoi collaboratori, accusa tutti i SISTEMATISMI, volti a cristallizzare in forme costituite il divenire multiforme e metamorfico di una vita che assai malvolentieri accetta la prigionia, che sia museale, analitica o da catalogo. E ciò, sulla scia di un Goethe, che lesse piuttosto svogliatamente la kan- al cristallizzato, ma ad un divenire che, come spartito, ritorna, seppure con variazione, come inedita – e, al contempo, ancestrale – configurazione storica e destinale. Non occorre cercare in altre epoche le soluzioni alla crisi che attanaglia la Modernità – come la fiamma che, accarezzando la carta, ne rivela i caratteri occultati, così la decadenza produce, al contempo, anticorpi che IN NESSUN ALTRO MODO avrebbero potuto essere generati. Curare la modernità CON la modernità stessa. Questa è la scommessa intellettuale che anima le presenti ricerche. La QUANTITÀ, in tutte le sue configurazioni epocali. Dall’industria culturale, che seleziona il valore delle cose e degli uomini secondo i dettami della tirannia del danaro, a certo égalitarismo incapace di generare uguaglianza se non attraverso la massificazione selvaggia delle genti, l’inaugurazione di una inaudita NOTTE DEI POPOLI. Dalla tecnocrazia imperante, che strangola i domini della cultura, costringendo questa ultima, nella migliore delle ipotesi, a farle da supporto teoretico, ad un individualismo che mutila l’uo- n. 01/2011 e quegli altri principi che fondano il nostro esserci odierno non possano, per nessuna ragione, essere ridotti ad UNA delle loro dimensioni, quale che essa sia. Innanzi agli scempi perpetrati dalle filosofie ANALITICHE – sia d’oltreoceano che nostrane – l’UNITA’ METAFISICA DI OGNI ENTE IN QUANTO TALE, secondo il precetto olistico per il quale un tutto è alcunché di QUALITATIVAMENTE superiore alla somma aritmetica e dunque QUANTITATIVA delle sue componenti. Il MOVIMENTO in luogo della quiete, il sentiero di montagna in luogo della pianura che tutto livella. Il pensiero libero, vivo e pulsante, che ha in odio la clausura dell’uomo entro schemi architettati da certo pessimo razionalismo che altro non vede se non ghiaccio, forme morte e immobilità. Antarès reclama Eraclito in luogo di Parmenide. Un ANTIMODERNISMO che non si risolva in una sterile critica del presente ma che sia in grado di fornire a questo ultimo strumenti che, invero, sono GIA’ in suo possesso. Dotare la modernità di una metafisica alla sua altezza: questa la celebre scommessa tra Faust e Mefistofele, della quale il presente progetto si sente erede. L’ARTE, il Grande Stile, uniche fonti dalle quali, secondo la lezione nietzschiana, può abbeverarsi quell’uomo che ha vissuto sino in fondo la bancarotta della razionalità – o meglio, del culto di essa, secondo le riduzioni anzidette. Giacché disponiamo dell’arte per liberarci dal dispotismo della razionalità. IL PRIMATO DELLA DOMANDA SULLA RISPOSTA. Ciò, nella persuasione che la modalità di formulazione della prima determini attivamente il configurarsi della seconda e che una adeguata impostazione del domandare, secondo la lezione heideggeriana, possa fungere da scanda- Il manifesto di Antarès tiana Critica della ragion pura entusiasmandosi invece per la Critica del Giudizio. mo di quelle dimensioni aliene dalla RATIO calcolante – autentico MITO della Modernità. Certe forme di popolarismo selvaggio le quali tendono a porsi come condizione normalizzata di una politica che ha abdicato al suo compito di formare lo Stato e non, meramente, di amministrarlo. E, così, certo apparente anticonformismo, che, sovente, oltre a spartire i medesimi principi che vorrebbe ardere, si dimostra essere il migliore alleato dei Leviatani, di ieri e di oggi. Un MODERNISMO che reinterpreta e riscrive gli albori e i destini planetari per porsi quale stadio definitivo e conclusivo di quelle istanze che altre culture – lontane da noi tanto spazialmente quanto temporalmente – non sarebbero state in grado di compiere. Come se gli Antichi, loro malgrado, non fossero che Moderni imperfetti! Una precisa collocazione tanto ideologica quanto religiosa e fideistica, non intravedendo nelle usuali definizioni legate a questi domini – con scarsissime eccezioni – che simulacri e parodie. Dove la religione si esaurisca in certo moralismo, senza un minimo supporto di ordine spirituale, il presente progetto si dichiara ARELIGIOSO. Dove le categorie politiche consuete, alle soglie della postmodernità, abbiano perso la loro forza centripeta e propulsiva, Antarès si dichiara APOLITICA – purtuttavia, in senso stoico e non passivo, vale a dire come rifiuto ideale di falsi ideali. Il mito del PROGRESSO il quale, livellando le specificità delle culture, le consegna in catene all’altare della Modernità totalitaria. E così il materialismo, ancella del progressismo, del quale prepara l’avvento, in quanto suo elemento costitutivo e complementare. Solo attraverso la riduzione della storia intera a dinamiche di ordine materiale, infatti, è possibile costruire ponti ideali tra culture NATURALMENTE differenti. Materia e progresso sono i figli gemelli della Modernità. Ma un’indagine morfologica e destinale non può che avere in odio ogni qualsivoglia Storia Mondiale. Il PASSATISMO, rivelantesi alla stregua di supina denuncia di una umanità incapace di produrre forme e condannata al TRAMONTO, secondo la lezione di certa eretica filosofia della storia. Non al passato occorre guardare, non al divenuto, RECLAMA la MOLTEPLICITÀ in luogo della riduzione, la PLURALITA’ in luogo dei martirii dell’univocità. Afferma che la storia, la scienza, l’uomo, la politica, la cultura 2 Pensatori messi al bando dalla cultura ufficiale – e da ampie sezioni del panorama accademico all’interno del quale ci troviamo ad operare – in quanto contraddicenti i DOGMI DELLA MODERNITA’, in quanto ingiurianti i suoi altari secolarizzati. Maestri del progetto saranno intellettuali del calibro metafisico di Nietzsche, Spengler, Jünger, Benjamin, Huizinga, Baudelaire, Evola, Heidegger, Guénon, Schmitt, Stirner, de Benoist, Trakl, Kafka, Thoreau, Yeats, Eliot, Pound, Cioran, Huxley, Orwell, Pessoa, Céline, Tolkien, Borges, Anders, Eliade, Michelstaedter e altri che hanno combattuto e combattono tuttora sul fronte antimoderno. Voci stonate, fuori dal coro e ampiamente inascoltate, forse proprio in quanto valide alternative alle aporie di un sistema la cui precarietà è oggi sotto gli occhi di tutti. glio tra le innumerevoli soluzioni, tanto artificiose quanto fallaci, con le quali la modernità omaggia le coscienze. Giacché è lo stesso domandare la via maestra per raggiungere quelle oasi che ancora costellano il deserto che cresce, in misura sempre maggiore, nel cuore dell’uomo moderno. LA RIFLESSIONE in luogo dello studio passivo, la proiezione in luogo della rifrazione, la filosofia della storia in luogo della storia della filosofia. Le rovine in luogo delle biblioteche, la ricerca in luogo dell’accumulo, il dialogo in luogo del monologo libresco. Il pro-getto in luogo dell’ansia di esattezza che caratterizza una cultura monopolizzata da un positivismo che va dispiegandosi, in misura sempre maggiore, strangolando intere sezioni del panorama culturale a noi contemporaneo. Un pensiero, per usare il celebre motto spengleriano, che non si limiti a cadere all’interno di un’epoca ma che accolga la sfida di determinare, di FARE epoca. Il dibattito, la polemica, la scrittura e l’espressione artistica, questioni di VITALE importanza all’interno di un’epoca nella quale le riflessioni sono schiacciate dalla tirannide degli slogan. Il progettarsi, l’aprire nuovi sentieri alle idee, in un ciclo storico nel quale ogni originalità si risolve nel rimescolare vecchi principi, ormai arrugginiti. Un futuro vivo e creativo, contrapposto alle distopie escatologiche, di cui il progressismo vive per perpetuarsi. 3 n. 01/2011 n. 01/2011 La montagna come esperienza del limite Editoriale: metafisica del camminare di Francesco Tomatis a cura della Redazione N in montagna ad un’esperienza ancora più costitutiva, pericolosa e meravigliante, stupefacente e vertiginosa. Si tratta dell’esperienza della verticalità del limite, dell’esperienza di trascendenza, di costitutiva trascendenza che noi a noi stessi siamo, aprendoci nel nostro stesso orizzonte finito esistenziale e autorelativo ad un’alterità ulteriore a noi, precedente, incostruibile e impensabile, eppure verissima e per noi decisiva. Ad ogni nostro passo, in ogni nostra ascesa o discesa, l’esperienza vera, dei nostri limiti, del nostro esser definiti da un orizzonte e da un ambiente circostante pericoloso, mortale, si staglia su di una verticalità non solo geometricamente perpendicolare. Ascoltando il silenzio di essa potremmo continuamente, ad ogni parola o passo, movimento o stasi, moto o indugio, ristabilizzare il nostro orizzonte sempre in cammino. el cammino sulla via della montagna come esperienza del limite occorre fare innanzitutto due passi. Il primo consiste nel comprendere cosa significhi profondamente esperienza. Lo può indicare già, semplicemente, l’origine etimologica del termine. Infatti esperienza, esperto, esperire derivano dal latino experior e peritus, a loro volta derivati dal greco πεῖρα, prova, esperimento. Tuttavia dal greco πεῖρα deriva anche il latino periculum. Esperire e pericolo, divenir esperti, periti e far esperienza del pericolo sono, originariamente, due aspetti dello stesso. Senza esperienza del pericolo non c’è dunque vera esperienza. L’esperienza del pericolo non può d’altro canto far venir meno la possibilità di esperire. Esperire il pericolo significa rasentare la negatività, la corruzione, morte, distruzione, senza però soccombervi. L’esperienza di ciò che è pericoloso comporta quindi esperire il limite, secondo passo montano, in un doppio significato di esso. Innanzitutto il limite oltre il quale il pericolo si fa non solo mortale, ma morte, annihilimento, dissoluzione. Inoltre, attraverso tale esperienza pericolosa del limite mortale, anche, e soprattutto, il limite a chi esperisce costitutivo, definitorio, benché sempre in movimento, come un peculiare, singolare orizzonte esistenziale, vivente, in camminante riorientazione. Non si tratta di un’esperienza direttamente conoscitiva e fondativa, superstiziosa o positiva, sublime e oggettiva. Piuttosto è un’esperienza in negativo, ma altamente istruttiva, riconvertente il nostro sguardo ascendente a radicazioni nuove, continuamente e ciclicamente rigenerative in modo rinnovato. È l’esperienza del limite propria alla montagna, esperienza alpi-mistica, che esperisce il vuoto intorno a noi, il nulla della cima, il mero “che” al fondo vuoto del nostro respiro senza fiato e dell’esistere umile, paziente, nel poco rasserenato. Esperienza che del poco, quasi nulla, un mero “che”, farà l’orizzonte possibile di una vita eccelsa e variegata, ricca e raffinata, proprio nell’affinamento della capacità di ascolto, ricezione, elaborazione di poche note, di elementi essenziali, di fugaci tempi e stagioni, difficoltosi terreni e sempre straordinarie, fra terra e cielo, divini e mortali, interrelazioni. La montagna per eccellenza è dunque esperienza del limite. Sia perché la montagna è quella dimensione fisica e spirituale, meta-fisica, nella quale ogni esperire è intrinsecamente pericoloso. Sia perché esperire il pericolo, in montagna, è umanamente possibile, comporta un approccio graduale ad esso, tale da non farcene morire e quindi consentendo una vera esperienza, benché talvolta da sopravvissuti, ma appunto viventi ancora. In montagna si è costantemente esposti al pericolo, tuttavia il pericolo benché mortale può non diventarlo realizzativamente, grazie all’avvicinamento continuo e graduale ad esso che la montagna stessa impone. Data la necessità di procedere, abitare, vivere sempre singolarmente in montagna, senza grandi aiuti esterni, con le proprie forze, le proprie gambe e la propria testa, allora l’accostarsi imprescindibile al pericolo, all’esposizione, alla mortalità sarà in essa sempre personale (nonché comunitario assieme) e quindi discreto, graduale, misurabile, più o meno lentamente assimilabile ed esperibile. Francesco Tomatis, nato a Carrù (Cuneo) nel 1964, è professore ordinario in filosofia teoretica all’Università di Salerno e istruttore di Kung Fu classico cinese della Scuola Kung Fu Chang. Collabora con “Avvenire”, “La Rivista del Club Alpino Italiano”, “Ousitanio Vivo”. Ha curato l’edizione di opere di Schelling, Nietzsche, Pareyson, pubblicato i volumi: Kenosis del logos (1994), Ontologia del male (1995), L’argomento ontologico (1997), Escatologia della negazione (1999), Pareyson (2003), Filosofia della montagna (2005), Come leggere Nietzsche (2006), Dialogo dei principi con Gesù Socrate Lao Tzu (2007), Libertà di sapere. Università e dialogo interculturale (2009), Verso la città divina. L’incantesimo della libertà in Luigi Einaudi (2011). Vera esperienza, dunque, quella montana, personale ed estraniante assieme, vero confronto con ciò che sta oltre di noi, ulteriore al nostro orizzonte singolare. Ma allora il nostro limite esistenziale, fisico e spirituale, viene esposto 4 L rio. Un’altra era ha allora inizio. E, con essa, un’altra “storia”. Perché questa digressione, a proposito del camminare? Proprio perché quanto descritto accade parimenti a livello antropologico, tra il microcosmo umano ed il macrocosmo universale essendovi una intima analogia. Tanto nel caso dell’universo quanto in quello dell’uomo, condizione necessaria del movimento è che vi sia qualcosa di perduto da cercare, verso cui tendere. Singolare coincidenza: ciò che va cercato è stato smarrito all’origine. Il suo ritrovamento avverrà alla fine del percorso – percorso la cui ragion d’essere altro non è che la perdita anzidetta. Nella mitologia biblica, ad esempio, è la scoperta che l’uomo fa del proprio corpo come supporto materiale e mortale a costituire le premesse del suo essere disposto al movimento. Avvertendosi nudo, avvertendo il proprio essere corporeo, il nostro progenitore è costretto a vagare e vagare, avendo ormai perduto la propria ragion sufficiente edenica (Genesi, 3, 1-24). Il suo cammino è dunque il risultato di una profanazione e, allo stesso tempo, un pellegrinaggio che si concluderà allorché riceverà un nuovo corpo, una nuova sagoma di pura luce (Corinzi 1, 15, 35-38). Irradiante, ritroverà la quiete, alla fine del suo percorso mortale. Il cammino, dunque, come stigma di una quiete perduta e promessa di un equilibrio, da realizzarsi attraverso l’integrazione totalizzante di tutti i propri stati terrestri e spirituali, fisici e metafisici, umani e sovraumani (sottolineeremo, en a prima osservazione che ci coglie laddove consideriamo il gesto del camminare è che si tratta, in fondo, di una delle più antiche attività dell’uomo. L’uomo nasce in cammino, su due gambe. È un essere intimamente deambulante. Senza cammino, insomma, non si può – ancora – parlare di umanità. Ciò può essere descritto in una prospettiva più ampia. Il cammino è connesso al movimento, è evidente. Il movimento, a sua volta, è la rottura di una quiete originaria, di una stasi primigenia. Dove si incontra il movimento, insomma, qualcosa è andato perduto. Come descrivere ciò che si è perso? Si tratta di uno stato nemmeno collocabile all’inizio dei tempi, dalla sua rottura nascendo a tutti gli effetti il tempo stesso. Non si può cogliere questa situazione originaria in termini cronologici. Essa non si situa migliaia di anni fa ma in un ordine diverso di realtà. L’unica cosa che se ne può dire è che tra la realtà statica e quella cinetica si situa una frattura, una lacerazione, che le rende incomunicabili. Ebbene, la caduta di livello determinata da questa frattura conduce al movimento, alla ricerca, ad una quêste. Alla infrazione della quiete segue il movimento. Alla immobilità del Sé originario subentra l’arcolaio delle stagioni, dei secoli e delle ere. Ha inizio ciò che usualmente chiamiamo “storia”. La ruota inizia a girare, sempre più vorticosamente, fino al suo arresto, che sancisce la chiusura dei cicli. Dopo un istante di immobilità, che nel pensiero indù corrisponde al sonno degli Dèi, essa si rimette in moto, in senso contra- 5 n. 01/2011 passant, come anche presso la moderna escatologia darwinista sia il camminare a fare da cerniera tra il passato ed il presente della stirpe umana – peccato che, in questo caso, non siano gli Dèi i progenitori degli uomini ma le scimmie. D’altra parte, ognuno sceglie gli antenati nei quali preferisce identificarsi). Abbandonata una perfezione originaria statica, l’uomo si pone in cammino, si dinamizza. E il pensiero si mette in cammino, insieme al corpo. Ciò spalanca possibilità inaudite: il cammino dispone di una sapienza assai peculiare. Questo è il carattere proprio di ogni crisi: se recepita e vissuta correttamente, può condurre l’uomo a ridestare possibilità che giacciono usualmente allo stato latente. Questo l’insegnamento che solo i periodi di declino possono fornire, secondo il vecchio adagio di HÖlderlin, secondo il quale laddove è il pericolo, cresce parimenti ciò che salva. Ogni veleno cela in sé il proprio antidoto; è la duplice valenza del greco pharmakon, al tempo stesso intossicante e medicinale. Se il cammino nasce da un gesto che separa ciò che pertiene alla mera natura da ciò che rimanda a una dimensione spirituale, resta pur vero che è lo stesso cammino ad unificare le due dimensioni – fisica e metafisica – altrimenti irrimediabilmente scisse. È il movimento a riunificare tempo e spazio, dilacerati a seguito dell’uscita dallo stato ancestrale di compiutezza. Il gesto del camminare unifica Dèi e mortali, mondo e sopramondo, in una comunione perpetua costantemente rinnovabile. Ciò che il cammino ha separato, il cammino può riunificare. Esso ricompone un mosaico ormai infranto, ridestando le possibilità superiori dell’umano, sopite durante la vita quotidiana, alienata nei luoghi di aggregazione deputati a raccogliere le risorse umane della modernità. Da marchio di una perdita, il gesto del camminare si tramuta in metafisicizzazione dell’esistenza, sacralizzazione assiale e plenaria di ciò che l’uomo ha profanato emancipandosi dagli Dèi. Il cammino infatti fluidifica quelle istanze superindividuali che il materialismo illuminista dei nostri tempi ha relegato ad appendici della ragion pura o a sovrastrutture della materia. Colui che cammina, laddove ovviamente sappia trarre giovamento da questa pratica in senso autentico, comprende che la meta del percorso non è fisica, ma anzitutto metafisica. Ci si mette in cammino per trascendere il proprio Io, realtà tanto artefatta quanto fallace, per identificarsi e congiungersi al proprio Sé superiore. Chi cammina è più che un uomo. I piedi piantati per terra, le braccia volte al cielo, realizza la sua antica funzione di copula mundi. Questa la portata di quel gesto che, inconsapevolmente, pratichiamo quotidianamente. Ridestarne le potenzialità, fondando una metafisica del camminare – questo lo scopo che si propongono le pagine a seguire. Nel superamento delle fatiche che la terra oppone al viandante, questi realizza il suo Opus, alla stregua del demiurgo platonico che, lottando contro la resistenza coatta della chora, dell’imponderabile e dell’informe, mette in forma l’esistente, strappando dal caos primordiale un cosmo ordinato gerarchicamente. Il camminare come demiurgia, come autoformazione, come conferimento di un ordine a se stessi ed al mondo, secondo quella legge di analogia che regola i contrari all’interno del gioco archetipico. Sempre l’umanità, come verrà illustrato nelle colonne di questo fascicolo, avvertì l’intimo bisogno di trasfigurare se medesima all’interno di siffatta pratica. Sempre comprese che la duplice funzione del cammino, girovago o pellegrino, ricalca il volto bifronte dell’uomo, il suo doppio movimento, discendente e ascendente: morte di Dio nella materia e, al contempo, trascendenza immanente. Da fuga, esilio, il cammino diviene pellegrinaggio, santificazione dell’uomo e del suo ambiente circostante. Queste le possibilità offerte dal prendere il passo. Ciò pertiene al retaggio tradizionale di un gran numero di civiltà, spesso assai lungi le une dalle altre. In svariate tradizioni infatti l’ascesi venne presentata alla stregua di un cammino e il cammino venne rivestito di valenze spirituali. Milarepa, il saggio tibetano, fece del percorrere sentieri una componente essenziale del suo insegnamento. E così Cristo, che percorse la sua via verso il Calvario, per essere infine crocifisso, fissato all’axis mundi, realizzazione plenaria di tutte le sue possibilità umane e divine. Iniziato dal cammino, sottoposto alle prove della strada, il Cristo fece di essa il medium per giungere all’indiamento. Il cammino del Cristo sul Golgota, il suo itinerario verso il sacrificio, fu propedeutico alla sua realizzazione trinitaria. La “ Tanto nell’universo �uanto nell’uomo, condizione necessaria del movimento è l’esistenza di �ualcosa di perduto da ricercare, verso cui tendere ” 6 n. 01/2011 Croce, come argomenta Guénon ne Il simbolismo della croce, è più di un simbolo sacrificale. Esso è l’unione dell’asse verticale dell’essere, dei principi, della pura attività, e di quello orizzontale delle possibilità. All’intersezione dei due assi corrisponde l’esistenza individua, che nasce dall’incontro di attività e passività, essere e possibilità. La crocifissione è l’identificazione dell’uomo allo stesso Essere. Realizzazione, morte iniziatica e resurrezione. Ebbene, questo stato può essere conseguito solo attraverso un pellegrinaggio che purifica il viandante, bruciandone le spoglie mortali. Il cammino di Cristo e di Milarepa. Nicholai Roerich, il celebre artista russo, ben comprese l’analogia tra queste tradizioni, allorché dipinse il Cristo in pellegrinaggio sull’Himalaya. Ogni cammino è un pellegrinaggio, una crocefissione all’asse del mondo, realizzazione della divinità nella propria corporeità, risveglio e attivazione delle facoltà superindividuali. Crocefisso alla ruota cosmica, il viandante diviene asse, principio immutabile, mozzo immobile di una ruota che non cessa mai di muoversi convulsamente. Egli si trova nell’occhio del ciclone, dove regna una singolare quiete. In numerose tradizioni chi consegue questo stato è paragonato al cardine della porta, che si mantiene anche laddove questa sbatta. La stabilità del suo Sé lo condurrà a superare quelle crisi che per altri risulteranno fatali. Nemmeno mancano esempi contemporanei – ad esempio, letterari – di un percorso inteso non come mera percorrenza fisica ma come viaggio anzitutto metafisico, come esplorazione di regioni sconosciute alla quiete – profana – che tutto fossilizza e livella. Così, in Cuore di Tenebra, Conrad invita i lettori a percorrere un viaggio a ritroso, per comprendere il fondo abissale dell’uomo moderno. Questa sorta di controiniziazione ha luogo attraverso una percorrenza fluviale, che si articola dai panorami assolati dei litorali africani alla notte interiore di Kurtz. Caso analogo è riscontrabile nel Viaggio al termine della notte di Céline. Per poi non parlare del capolavoro di Daumal Il monte analogo, nel quale il percorrere i misteri di una montagna invisibile ai più diviene uno strumento di catarsi e realizzazione metaindividuale. Ne Il signore degli anelli, il cammino, che assorbe l’interezza della narrazione tolkieniana, altro non è se non una lunga iniziazione, che si conclude presso il Monte Fato, presso il trono di Ananké, la Necessità, all’interno dei cui domini il Male si distrugge, il serpente morde se stesso e un nuovo ciclo può finalmente iniziare. Il veleno si tramuta in farmaco, negandosi. Per il tramite della creatura Gollum – proprio uno dei servi del Male – che precipita assieme all’anello nel magma vulcanico di Amon Amarth, lo scorpione rivolge il suo pungiglione verso se stesso e si dona la morte. Il lungo cammino che i protagonisti della saga compiranno li condurrà alla consapevolezza che l’anello non può essere utilizzato secondo finalità contingenti ma che deve essere distrutto in quanto tale. E, ancora una volta, è il percorso a donarci la consapevolezza di questo aspetto. Echi di questa funzione realizzativa del camminare – seppure, spesso, tra mille fraintendimenti – sopravvivono anche oggi. Nelle metropoli contemporanee, i luoghi nei quali, come ebbero a scrivere altri, i popoli si recano per morire, il movimento è amministrato in maniera sempre più capillare. La gestione biopolitica delle popolazioni non ha mancato di mutilare il camminare dai suoi frangenti superiori, renden- dolo strumento accessorio a movimenti di tipo meramente funzionale. Il camminare si traduce in andare-presso, la meta dello spostamento assorbendo interamente il senso del movimento stesso. Ebbene, anche in questo caso un camminare diverso può rivelare altri volti delle metropoli, usualmente occultati da quelle decine di slogan che, come osservò brillantemente Simmel, inibiscono le capacità ricettive delle masse cittadine. Si fa necessaria, tuttavia, una duplice rettificazione. Anzitutto, dal punto di vista qui adottato, il motto corrente “riappropriarsi delle strade” appare del tutto insensato, le strade di cui si vorrebbe prendere possesso essendo forme morte, limbi saccheggiati dal commercio biologico. Occorrerebbe, piuttosto, elidere una simile immagine in quanto tale, in luogo di “prenderne possesso”. Se la funzione del camminare, nel nostro presente, si esaurisce, da una parte, nella gestione schizoide del commercio umano e dall’altra nelle marce politiche o nei revival post-sessantotteschi, resta pur vero che nessuna di queste tipologie di cammino – intimamente complementari e per nulla contrapposte – coglie la sapienza autentica che questo può donare. Esso può insegnare all’uomo moderno la propria essenza intimamente ambientale, ponendosi quale base di una nuova geofilosofia e di una nuova responsabilità geologica. A partire dal camminare può instaurarsi una nuova comunione tra l’uomo e il pianeta che ne ospita l’incedere storico. Nella percorrenza pedestre, l’uomo celebra nuovamente il suo sposalizio con le divinità del paesaggio, tornando ad inscriversi all’interno delle sue figure. In secondo luogo, simili osservazioni nulla hanno a che vedere con quelle concezioni evasive, irrazionali e sovversive del camminare che tanto pullulano tra le nuove – e le vecchie – generazioni. Il camminare di cui qui si tratta non indica una romantica evasione dal presente, un “ritorno alla natura” o una fuga da una realtà verso la quale si prova insoddisfazione. In troppi hanno fornito un’immagine esotica del viandante, come passivo “ribelle” un po’ sbarazzino, che si fa beffe di responsabilità e doveri, per tornare alla propria “vera” natura. Queste impostazioni, d’altra parte, non sono che sintomi di un movimento molto più ampio – tra i cui promotori possiamo annoverare Freud, Rousseau, Hobbes e troppi altri – che vede la riduzione di tutte le facoltà umane alla mera materialità, sia essa biologica – Darwin – psicologica – Freud – o politica – Marx. “Scoperto” l’inconscio, non si poté far altro che ridurre tutte le dimensioni dell’uomo, del mondo e della storia, ad esso. Il gusto “primitivo” del camminare fu un capitolo della valorizzazione acritica della fanciullezza delle civiltà, dell’uomo e del mondo – capitolo che peraltro non si è ancora chiuso. Questo basti a stabilire la distanza che intercorre tra un vagare inteso alla stregua di una “seconda religiosità” ed un muoversi secondo direttive essenzialmente metafisiche. Il camminare di cui trattiamo non spinge a regressi animali ma presso gli Dèi. Di questo e altro ancora si occupa il presente numero di Antarès, all’interno del quale la pratica del camminare è declinata nelle sue sfaccettature filosofiche, metafisiche ed esoteriche. Si tenta qui di recuperare quelle possibilità che una diversa esperienza dello spazio può fornire, a patto, ovviamente, che ci si liberi da quelle valenze che il pensiero moderno ha legato a questa pratica. Con queste osservazioni, la Redazione augura ai lettori un buon cammino, tra le pagine che seguono. 7 n. 01/2011 Alejandro Jodorowsky: La Montagna Sacra di Mitsuharu Hirose U n cammino iniziatico, che porta un reietto dal fango di un’esistenza comune e degradata fino alla vetta, inviolabile dai profani, della Montagna Sacra, attraverso un percorso di ininterrotta ri-creazione e trasmutazione interiore, allo scopo non solo di dominare la morte e diventare uno dei Nove Saggi, ma anche di venire a conoscenza del segreto della vita. Un itinerario attraverso simbologie esoteriche, religioni sia occidentali sia orientali, unico mezzo di creazione ed elevazione dell’Anima in un mondo distopico e grottesco, dove regnano fanatismo, edonismo, povertà materiale e spirituale. E non solo: La Montagna Sacra – lettera aperta contro la Modernità – è inoltre un percorso cinematografico, dove ogni fotogramma è una metafora, una citazione, uno spunto di riflessione su politica, morale, sulla distinzione tra sogno e realtà. 8 n. 01/2011 fissano in una pepita d’oro che emerge da un liquido rosso (opera al rosso o rubedo). Accanto al marchingegno si trova un pellicano, animale capace di lacerarsi il petto per nutrire i suoi piccoli, che veicola il profondo significato allegorico di passaggio dell’essenza vitale tramite il proprio sacrificio, nonché simbolo della trasmissione del sapere iniziatico. A procedimento completato l’Alchimista consegna la pepita al reietto ma, irritato dall’avidità che quest’ultimo dimostra, lo invita a guardare oltre la mera ricchezza materiale, offrendogli di tramutare in oro l’intero suo corpo. Attraverso un ulteriore processo di “ricreazione dell’anima”, Il Maestro dona al neofita quattro oggetti, corrispondenti ai semi dei tarocchi tradizionali: un bastone, una spada, una coppa e un medaglione d’oro. Essi simboleggiano rispettivamente i quattro doveri dell’iniziato secondo Eliphas-Lévi: sapere, osare, volere, tacere, nonché gli Elementi fondamentali, Acqua, Aria, Fuoco e Terra. Dopodiché l’iniziato viene introdotto al cospetto di sette personaggi, ognuno associato ad un pianeta del Sistema Solare, che si uniranno a lui nella scalata. Il primo di essi è Fon (Venere), edonista impresario di protesi anatomiche, cultore dell’apparenza a scapito dell’essenza. Marte è simboleggiato da Isla, produttrice di armi. Klein, creatore di opere d’arte costituite da corpi umani, rappresenta Giove. Il corpo e il sesso sono da lui ridotti ad oggettistica, produzione di massa di una sorta di pop art vivente. Saturno è identificato da Sel, incaricata dal governo di plasmare le menti dei bambini in accordo alle previsioni politiche di un misterioso computer. Urano è Berg, consigliere di un presidente-dittatore di stampo sudamericano, mentre Nettuno è Axon, tirannico comandante di polizia, i cui seguaci sono paramilitari castrati. Plutone, infine, è Lut, un architetto che concepisce la casa ideale come una bara, spazio di soggiorno puramente temporaneo, da utilizzare durante le pause del lavoro. La scalata, con l’aiuto dell’Alchimista, può finalmente iniziare. Il ladro, simbolo dell’Io primitivo ed egoista, si unisce spiritualmente ai compagni, oltrepassa i limiti imposti dalla corporalità individuale, rinnega (con dolore) le convinzioni errate che gli erano state imposte e che si erano impossessate della sua mente. Il gruppo, nel suo percorso, supera delle prove e viene iniziato all’utilizzo di erbe e funghi allucinogeni, sulla scia delle pratiche sciamaniche sudamericane, grazie alle quali impara ad ascoltare la voce della Natura. Sbarcati sull’Isola del Loto, il Maestro e i Discepoli raggiungono il “Bar del Pantheon”, luogo di perdizione che raccoglie coloro che, a differenza degli altri uomini, partirono alla ricerca dell’Isola stessa ma, credendo di essere arrivati a destinazione, rinunciarono a procedere fino alla Montagna. Uno di essi, forse parodia di Timothy Leary, sostiene che la Verità si trovi nelle droghe (“La Croce è un fungo!”), un altro crede nella possibilità di attraversare la materia in senso orizzontale. Il gruppo non bada ad essi, li disprezza e non si lascia intimorire: ormai è pronto per avviarsi con decisione verso l’ultima parte del tragitto. Il raggiungimento della vetta, con tanto di sconvolgente colpo di scena metacinematografico, non è la meta di questo viaggio ma l’inizio di un nuovo ambizioso percorso, che il regista ci invita a seguire anche dopo aver lasciato la sala cinematografica: “Noi non siamo che immagini, sogni, fotografie. Non dobbiamo restare qui, prigionieri. Romperemo l’illusione. Questa è Maya. La vita reale ci attende.” Il regista, Alejandro Jodorowsky Prullansky, nato in Cile nel 1929 da una famiglia ebrea di origini ucraine, dagli anni ‘50 vive a Parigi, dove ha fondato assieme a Roland Topor e a Fernando Arrabal il movimento di teatro panico, corrente di ispirazione post-surrealista, che suggerisce una nuova ma indefinita idea di uomo. Nel saggio Panico e Pollo Arrosto del 1964 (incluso in Panico! di Arrabal, Jodorowsky e Topor, Giunti Editore, Firenze, 2007, p. 173), il regista stesso afferma: “L’uomo panico, dato che pensa strutturalmente, che sostiene una logica di eliminazione di possibilità e dato che è capace di vivere molte idee contraddittorie allo stesso tempo, ripartisce il calore secondo la molteplicità dei suoi principi, in modo tale che ogni sua idea-azione venga portata a una normalità sopportabile e benefica […]. L’uomo panico non fa né economia né progetti, produrrà un’architettura instabile (luoghi di aggregazione metropolitana come il celebre fiume di Eraclito; l’uomo non abiterà due volte nella stessa città), opere d’arte non conservabili e teorie in continua trasformazione, dato che tutto il suo sistema ideale si fonda su una metamorfosi di se stesso e degli oggetti che lo circondano”. La stessa idea di contraddittorietà, indefinitezza, molteplicità dei principi, costituisce la base della fondazione della casa cinematografica Producciones Panicas, con la quale Jodorowsky trasferisce nel cinema i suoi ideali di teatro surrealista, culminanti proprio nel film La Montaña Sagrada, presentato al Festival di Cannes del 1973 e realizzato grazie ai finanziamenti di John Lennon e Yoko Ono. Il film è suddiviso in tre momenti, identificabili come “Smarrimento”, “Iniziazione” e “Scalata”. Un ladro senza nome, dall’aspetto fisico riconducibile all’iconografia occidentale del Cristo, senza una ragione apparente viene crocifisso e lapidato da un’orda di bambini macilenti, incitati da un nano senza braccia. Il ladro/Cristo si libera, allontana i piccoli carnefici con un urlo e, impietosito dal nano mutilato, stringe amicizia con lui fumando marijuana, in una scena che pare un piccolo tributo a Freaks di Tod Browning. Qui comincia il suo cammino disperato che, senza la presenza illuminante di una guida, lo trascina privo di meta per le strade di una Città del Messico grottesca, degradata e militarizzata, come in una sorta di caotica distopia. Il ladro si ritrova tra parate di soldati che portano in processione pecore scuoiate e crocifisse, come a simboleggiare una percezione fanatica e tribale di Cristianesimo, fucilazioni di massa riprese con le telecamere da ricchi e perversi turisti nordamericani, e spettacoli surreali, tra cui quello memorabile della conquista del Messico, dove un plastico pieno di iguane adornate con ornamenti aztechi viene preso d’assalto da un esercito di rospi armati di lance e corazze, mentre una marcetta nazista suona in sottofondo. Il cammino del reietto prosegue confusamente, portandolo ad imbattersi in un’altissima torre, dove l’Alchimista (interpretato da Jodorowsky in persona), gli chiede se ciò che stia cercando sia l’oro. Il reietto, schiavo della sua animalità e del suo materialismo, non può che rispondere affermativamente. L’Alchimista rinchiude quindi il nuovo discepolo in una grande ampolla, l’atanòr alchemico, alla cui base viene acceso un fuoco, ed a cui viene collegata un’ampolla più piccola, contenente le sue feci e i liquidi corporei. Essi, simboleggianti l’opera al nero (nigredo) dell’alchimia occidentale, vengono sottoposti a un trattamento di purificazione tramite cui, sublimandosi in un gas bianco (opera al bianco o albedo), si 9 n. 01/2011 che gli attori raggiungessero l’Illuminazione. Non stavamo facendo un film, stavamo filmando un’esperienza sacra. Ma chi erano quei commedianti che, vittime anch’essi dell’illusione, avevano accettato di essere miei discepoli? Uno, un transessuale, l’avevo scovato in un bar di New York, un altro era un attore di telenovela, e poi mia moglie, con le sue nevrosi da fallimento, e un ammiratore americano di Hitler, e un milionario disonesto che era stato espulso dalla Borsa, e un omosessuale che era convinto di parlare in sanscrito con gli uccelli, e una ballerina lesbica, e un comico da cabaret e un’afroamericana che, vergognandosi dei suoi antenati schiavi, diceva di essere pellerossa. L’idea di scritturare quell’accozzaglia di persone mi era stata ispirata dall’alchimia: il primo stadio della materia è il fango, il magma, la “nigredo”. Da esso, per successive purificazioni, nasce la pietra filosofale, che trasforma il vile metallo in oro. Queste persone prese nel mucchio, in nessun caso artisti teatrali, alla fine del film avrebbero dovuto diventare monaci illuminati”. Queste sorprendenti parole ci dimostrano l’intenzione di Jodorowsky di compiere sugli attori un processo alchemico di purificazione interiore, scegliendo deliberatamente degli scarti della società e facendo emergere il “panico” annidato dentro di loro, cioè il pensiero imprevedibile, multiforme, illuminato, che si adatta ad ogni situazione e che si libera dalle convenzioni. La materia grezza, cioè il cast del film, attraverso questo cammino intriso di arte e spiritualità, sarebbe stata trasformata in oro. Sempre ne La Danza della Realtà, Jodorowsky descrive come effettivamente ogni attore (incluso egli stesso) abbia subito una trasformazione, si sia identificato nel personaggio interpretato anche durante la vita reale, lontano dai “ciak”. Il film è di conseguenza una dimostrazione di come ogni uomo, anche il più abietto, sia in potenza “panico”, e che possa effettivamente diventarlo, perché anche il mondo, in sé, è “panico” (per ulteriori approfondimenti, dello stesso autore, si vedano anche Psicomagia – Una terapia panica, Feltrinelli, Milano 2005 e Le pietre del cammino, Giunti Editore, Firenze, 2009). Maya nient’altro è che che il velo illusorio della filosofia Vedanta, metafora delle limitazioni imposte dalla nostra condizione di uomini, che ci avvolge impedendoci di percepire il mondo nella sua interezza, o facendoci pervenire ad una visione distorta di cui dobbiamo liberarci se vogliamo comprendere la realtà. Liberamente ispirato alla Salita del Monte Carmelo di San Giovanni della Croce ed a Il monte analogo di René Daumal, La Montagna Sacra offre una moltitudine di riferimenti a diverse credenze elencateci dall’Alchimista stesso poco prima dell’ascensione: “La montagna Meru, dell’India. La montagna Kuen-Luen dei Taoisti. Il Karakorum dell’Himalaya. La montagna dei Filosofi. La montagna dei Rosacroce. La montagna cabalistica, di San Giovanni della Croce. Vi sono molte altre montagne sacre, la leggenda è sempre la stessa”. Il film condensa queste leggende, così come il libro di Daumal, secondo il quale il “Monte Analogo”, alto fino al cielo, si trova su una grande isola, invisibile ai più; chiunque riesca ad individuarla può già essere considerato un vero e proprio “iniziato”, in quanto si è dimostrato in grado di rompere le barriere della fisica, ottenendo l’accesso ad un’altra dimensione. Legato indissolubilmente al monte sacro di ogni tradizione troviamo proprio il cammino spirituale, o pellegrinaggio, elemento comune ad innumerevoli religioni. Il film stesso può essere considerato il punto di arrivo di un altro cammino, questa volta reale, che Jodorowsky organizzò e compì assieme a quello che sarebbe stato il cast del suo film. Il parallelismo di questa esperienza con l’esito cinematografico finale è evidente: nella sua autobiografia, intitolata La danza della realtà (Feltrinelli, Milano 2006, p. 179), Jodorowsky ebbe a dichiarare: “Dopo due mesi di preparazione chiusi in casa senza mai uscire, dormendo soltanto quattro ore al giorno e facendo esercizi iniziatici per il resto del tempo, più altri quattro mesi di lavoro intenso viaggiando per tutto il Messico, avevamo perduto ogni rapporto con la realtà. Il suo posto era stato preso dal mondo cinematografico. Io, posseduto dal personaggio del Maestro, ero diventato un tiranno. Volevo ad ogni costo “ Liberamente ispirato alla “Salita del Monte Carmelo” di San Giovanni della Croce ed a “il monte analogo” di René Daumal, “La Montagna Sacra” offre una moltitudine di riferimenti a diverse tradizioni ” 10 n. 05/2011 Strada a senso unico, molte destinazioni di Igor Comunale N egli anni ’20 del XX secolo, in Germania si sta preparando l’ascesa del nazionalsocialismo. L’Europa sta per piombare verso l’incubo di una nuova Guerra Mondiale. Ancora non si è spento l’eco della Grande Guerra, sebbene le ostilità siano cessate da qualche anno. Benjamin si trova non solo in una Germania avvilita e in piena crisi economica, ma anche ad un importante bivio di vita: sono gli anni decisivi in cui, avvicinatosi al comunismo, sceglie di intraprendere quello che egli stesso definisce un serio impegno politico. Sebbene l’autore non si possa certamente annoverare tra i più fanatici sostenitori di tale dottrina, ponendone spesso sotto esame critico le idee, è in Strada a senso unico che si palesa il percorso delle sue simpatie politiche. Tuttavia, relegare quest’opera a una mera dichiarazione di intenti politici vorrebbe dire sminuirne il significato filosofico e biografico. 11 n. 01/2011 Strada a senso unico non si presenta dotata di una struttura rigidamente stabilita, ma assomiglia maggiormente ad un dedalo che si dipana in direzioni sempre nuove e impreviste. La scelta di presentare questa raccolta di idee, sogni e ricordi in un modo così anticonvenzionale sembra essere dovuta principalmente all’intento di Benjamin di sfruttare un’architettura liquida, ad imitazione dei processi associativi del pensiero. Strada a senso unico delinea i contorni di una città costituita di parole, con i suoi titoli a caratteri cubitali risonanti di influenze urbane. I testi presentati attirano lo sguardo anzitutto proprio grazie ai loro titoli, di volta in volta somiglianti alle indicazioni stradali, agli annunci rumorosi degli strilloni di strada e agli slogan ad effetto delle pubblicità. La lettura di questo libro assomiglia al processo evocato da Rousseau insito nell’atto del camminare. Tra descrizioni di luoghi e persone, rappresentazioni oniriche e reminiscenze del passato, si mette in moto quel processo riflessivo privo di un unico filo conduttore, tipico del pensare libero e non costretto lungo binari prestabiliti. Questo tipo di struttura riporta alla mente l’Ulisse di Joyce, con quel flusso di coscienza riversato sulla carta direttamente dalla penna dello scrittore. Benjamin sembra aver voluto utilizzare una tecnica simile ma, dove lo scrittore di narrativa tende a rappresentare le proprie idee tramite personaggi creati a questo scopo, egli non si serve di alcun intermediario. Benjamin stesso è il protagonista di questo flusso, immersovi poiché parte di esso. L’autore fa di sé stesso il proprio personaggio, la scrittura diviene veicolo di riflessione. Il testo muta in specchio e rivela l’intimità dell’autore senza ricorrere al facile filtro di un personaggio “altro” da sé. –Benjamin si confessa senza temere di comparire nudo e indifeso innanzi al giudizio altrui. La natura stessa della composizione lascia alla fine della lettura un senso di non finito, come se successive integrazioni ed aggiunte fossero sempre possibili. Questa forma è stata espressamente voluta da Benjamin, non si tratta di una casuale circostanza. La conferma di ciò è ravvisabile nelle successive riflessioni che l’autore avrebbe voluto aggiungere all’opera. In questo Strada a senso unico somiglia molto sia all’atto del pensare che ad un’opera di urbanistica. Nel primo caso, prende in prestito la struttura aperta delle associazioni, nel secondo la tendenza della città a fagocitare lo spazio libero per ampliarsi. Strada a senso unico si presta a numerose interpretazioni ma il paragone più calzante rimane forse quello con la città. Il leggere diventa un vagare della mente. E non solo. Si tratta di un libro che non fa rimanere fermi, come se il movimento del pensiero dovesse riflettersi anche nella realtà tramite un medium fisico. Affrontare questo testo significa leggerlo in qualunque luogo della città, stabilendo con esso uno stretto legame di intimità. La staticità della lettura sedentaria mal si adatta a quest’opera. Chi scrive si è ritrovato a reprimere a stento (persino a casa propria) l’istinto del movimento e del camminare ispirato dalle parole di Benjamin. La staticità del movimento e del pensiero sono escluse da Strada a senso unico. La causa di ciò non può che essere lo stile utilizzato dall’autore, a volte altamente evocativo, altre formale, altre ancora simile ad un accorato appello ad intervenire per modificare la realtà. La valenza filosofica dell’opera è indubbia, evidenziata dalle sue potenzialità di far perdere il lettore in una spirale di pensieri e collegamenti che vengono a crearsi come tante vie secondarie che si dipartono lateralmente. Le riflessioni di Benjamin seguono un percorso definito di sua esclusiva proprietà ma all’interno di questa città immaginaria il lettore può inventare la propria strada. Il rischio di smarrirsi è elevato, ma soltanto per trovare infine una via personale da seguire. Benjamin ha sempre provato interesse per la figura e la visione del mondo di Baudelaire. Il poeta francese definisce i lineamenti del flâneur descrivendolo come un gentiluomo che vaga per le strade della città. Dinnanzi ai cambiamenti sociali ed economici dovuti all’industrializzazione, si richiede all’artista di immergersi nella metropoli per divenire “un botanico del marciapiede”, un conoscitore analitico del tessuto urbano. Tipico del flâneur è il comportamento pigro e senza urgenza, il suo vagare privo di meta non presuppone alcun luogo da raggiungere: il tempo si dilata infinitamente in questo camminare indolente. Questo modo di passeggiare viene definito flânerie. Apparirà evidente sin da ora come la flânerie si opponga in maniera quasi violenta alla frenesia delle metropoli. Baudelaire, flâneur per eccellenza, potrebbe essere un valido compagno di viaggio nel vagare di Benjamin nei labirinti della propria mente, in una città immaginaria composta soltanto di pensiero e inchiostro. Persino nelle rievocazioni di luoghi reali è ravvisabile sempre una componente surreale, spesso quasi onirica. Queste località hanno lo stesso rapporto che il reale ha con la sua rappresentazione pittorica: il luogo rappresentato è “ Strada a senso unico non ha una struttura rigidamente stabilita ma somiglia ad un dedalo che si dipana, sviluppa e snoda in direzioni sempre nuove e impreviste ” 12 n. 01/2011 “Se qualcuno li urtava, in preda alla confusione si inchinavano profondamente a chi li aveva urtati” (4). Questo si distacca di molto dalla riflessione pensosa, libera e vagante evocata in Strada a senso unico, dove il movimento del corpo e della mente si fondono e tutto è soggettivo, imprevedibile e non sottoposto ad alcuna regola ferrea. La città immaginaria di Benjamin non è però una città fantasma ma un luogo ideale dove le strade sono sempre libere e le possibilità di vagabondare alla ricerca di stimoli nuovi sono infinite. Alcune delle colonne portanti di Strada a senso unico sono le riflessioni e i ricordi di Benjamin attorno alla figura di Asja Lacis, a cui l’opera è dedicata. Questa donna ha avuto una forte influenza sull’autore, tanto che numerosi frammenti di loro conversazioni fanno spesso capolino nelle pagine del libro. La vicinanza e la relazione con la donna hanno contribuito sicuramente all’avvicinamento di Benjamin alle idee del comunismo, sebbene questi non abbia mai abbandonato il suo approccio critico e riflessivo intorno a siffatto movimento. Nel brano dal titolo Cineserie, Benjamin rievoca un luogo ora disabitato dove viveva l’amata. L’assenza della donna rende il vano del portone veicolo del vuoto che sente l’autore nel ritrovarcisi davanti. Il traslocare di Asja pare rappresentare per Benjamin la perdita di un orecchio amico che potesse ascoltarlo e comprenderlo. La donna si rivela non solo un punto di riferimento importante per la vita sentimentale dell’autore, ma anche contestuale alla sua riflessione politica e filosofica. La valenza simbolica del luogo è ormai irrimediabilmente perduta. Da questa affermazione si passa con un salto improvviso al ricordo del bambino in camicia da notte, con ogni probabilità un ritratto della figlia di Asja. Questa parte si rivela piuttosto interessante non soltanto per motivi biografici. La riluttanza del bambino a salutare la figura dell’adulto, investita da Benjamin di autorità morale, è stemperata solo in un secondo momento, al presentarsi del piccolo nudo e lavato. Ravvisare in questo passaggio soltanto un ricordo sarebbe riduttivo: anche la reminiscenza è trasformata in veicolo di pensiero. La natura surreale dello stile di Benjamin rende spesso difficile associare un significato certo alle molte immagini presentate ma, nonostante questo passo rimanga piuttosto criptico, vi è ravvisabile un senso nascosto, percettibile sotto forma di una vaga sensazione che non si tramuta mai in certezza. In questo ed in molti altri brani presenti in Strada a senso unico si entra nel reame dell’onirico. La realtà assume la stessa consistenza indefinita e plasmabile del sogno. Non è sicuramente casuale il fatto che accada spesso quando Benjamin scrive a proposito della Lacis. Reale e irreale si uniscono e si separano continuamente e senza preavviso: persino i luoghi vengono investiti da Benjamin di un potere evocativo peculiare. Come il vano del portone poteva rappresentare un orecchio ormai sordo, così in Pronto soccorso, “un quartiere quanto mai caotico, un intrico di strade da me evitato per anni, mi apparve di colpo dotato di un suo ordine quando un giorno vi si trasferì una persona amata. Fu come se alla sua finestra avessero installato un riflettore e questo fendesse la zona con fasci di luce” (5). La finestra si tramuta in un faro in grado di dare ordine anche al caos più totale. Rimane da domandarsi se Benjamin non alludesse con l’immagine dell’intrico di strade evitato per anni, ad un intrico molto più personale: quello della mente. La Lacis potrebbe essere vista come il faro che ha illuminato Benjamin, donando ordine al magma dei suoi pensieri. Ancora una volta le frasi si dimostra- lo stesso, ma il suo potere euristico è differente. Così è diversa la città ideale dalla città reale. Quella che Benjamin costruisce e descrive in Strada a senso unico potrebbe assomigliare ad una città realmente esistente, ma cristallizzata in momenti e immagini simili a dipinti o fotografie. Questo congelamento delle scene in istantanee allontana inevitabilmente dal reale la città per consegnarla al mondo del sogno. I paesaggi e le città reali sono in movimento, il tempo atmosferico muta, persone e animali entrano ed escono continuamente dalla scena. Non possiamo così parlare dell’evocazione di una città materiale, cosa che comunque non fu mai nelle intenzioni di Benjamin, ma della cristallizzazione di momenti e riflessioni consegnati ad un’eterna staticità che rimanda ad una realtà ultramondana. Chiamare in causa la figura del flâneur non può che rinviare ad alcuni saggi scritti da Benjamin e raccolti in Angelus Novus. In questi scritti si trovano importanti riflessioni sui rapporti dell’uomo con la strada, su Parigi e sulla folla delle città. Tali momenti possono apparire non immediatamente collegati a Strada a senso unico ma una più attenta lettura di alcuni passaggi riesce ad evocare numerose associazioni. Parigi era ed ancora é, come molte città europee, un luogo in cui camminare. La struttura delle capitali d’Europa, con il centro storico e le ampie aree pedonali, le rende decisamente più adatte ai vagabondaggi dei moderni flâneur delle grandi città degli Stati Uniti. Benjamin afferma come Baudelaire identifichi l’uomo della folla con il flâneur, ma si sente subito in dovere di dissentire da tale affermazione: “Baudelaire ha voluto equiparare l’uomo della folla […] al tipo del flâneur. Qui non possiamo seguirlo. L’uomo della folla non è un flâneur. In lui l’abito tranquillo ha lasciato il posto a un terrore maniaco; e da lui si può inferire, piuttosto, che cosa sarebbe accaduto al flâneur quando gli fosse stato tolto il suo ambiente naturale” (1). Emerge una concezione di flâneur come colui che non si muove con la folla ma che la rifugge. Lontano dalla concezione del navigatore della folla, egli necessita di spazio e non desidera mescolarsi alla massa senza volto, “ha bisogno di spazio e non vuole rinunciare al suo tenore privato” (2). Non per niente Benjamin descrive il disgusto e la ripugnanza provata da personaggi assai noti del calibro di Poe di fronte all’affollamento cittadino delle grandi metropoli: “Angoscia, ripugnanza e spavento suscitò la folla metropolitana in quelli che prima la fissarono in volto. In Poe essa ha qualcosa di barbarico” (3). Lo spostamento di massa si oppone con tutta la sua forza del numero e dell’impersonalità al libero movimento senza meta del flâneur. Suo unico rifugio divengono gli spazi artificiali delle gallerie e dei passages, dove ci si può muovere al passo della proverbiale tartaruga al guinzaglio, evitando lo scontro con la folla informe. Anche l’aumento del numero delle automobili trasforma le strade in un luogo ostile al suo vagabondare, rendendone inevitabile la fuga alla ricerca di spazi più adatti e sicuri. Non sembra quindi un caso che in Strada a senso unico compaiano decine di cornici popolate fugacemente da rare figure in attività, ma deserte e svuotate di quella folla che cominciava ad impadronirsi in maniera caotica delle strade. Il movimento evocato nella città immaginaria di Benjamin assomiglia in modo impressionante al suo concetto di flânerie; del resto, in Angelus Novus il filosofo sfrutta un’immagine di Poe descrivendo i singoli componenti della folla come automi che agiscono e reagiscono in modo meccanico in base agli eventuali stimoli esterni. Si tratta soltanto di mere reazioni a chocs: 13 n. 01/2011 Leggendo il titolo ad un secondo livello, questa strada di cui parla Benjamin potrebbe essere anche la vita. La sua vita, ma anche quella di tutti gli altri. Ogni vita singolarmente presa è una strada a senso unico, le sole certezze sono che si nasce e che si muore, quali che siano le scelte e le decisioni nel mezzo cambia poco. Ogni volta che si segue un corso di eventi, la decisione è presa e non si può tornare indietro. Un livello ulteriore potrebbe essere rivelato dalla collocazione di questa strada all’interno dell’urbanistica della città di pensieri costruita sapientemente da Benjamin. Tra le diverse strade di questa città una soltanto appartiene all’autore: le altre sono i vicoli e le svolte che ogni lettore segue nel suo vagabondare nei meandri delle riflessioni di Benjamin. Ci si potrebbe così facilmente inserire nel tessuto variegato e incompiuto di Strada a senso unico divenendo flâneur della mente, lasciando vagare i pensieri come si potrebbe fare con il corpo e trovare la propria direzione. Forse è possibile ravvisarvi l’invito a trovare una strada personale che si tramuti in un impegno reale per migliorare la sorte della società. Una via di fuga dalla crisi culturale: questa all’autore doveva apparire la scelta politica che si accingeva ad intraprendere. La strada percorsa dal lettore fra le pagine è del tutto personale, differente e irripetibile. Anche l’esperienza di Benjamin fu unica. È proprio la vicinanza tra le riflessioni dell’autore e quelle che potrebbe compiere l’uomo comune ad avvicinare questa opera all’esperienza di vita di chiunque. La lettura politica è solo la punta di un iceberg che può trovare il lettore d’accordo o in disaccordo, ma è ciò che si trova al di sotto della superficie che diventa esperienza condivisa. Nel profondo dell’opera, Benjamin sembra essere riuscito a depositare un sostrato di universalità che travalica la decisione irrevocabile della presa di posizione o le memorie di Asja Lacis. Il biografico scompare e si confonde con le tinte surreali di una città immaginaria e rimane solo l’ambito di tutti gli esseri umani: la vita. Si parla di una vita come di tutte le vite. no ambigue, prestandosi ad interpretazioni poste su differenti livelli. Vagare per un quartiere prima evitato può semplicemente essere interpretato nella maniera più ovvia, oppure condurre a digressioni che sottendono un differente tipo di vagare. Il movimento quindi si rivela in una duplice natura: fisica e psicologica. Le strade esistenti e le strade della mente divengono percorribili allo stesso modo, singolarmente o persino contemporaneamente. Corpo in movimento e pensiero in movimento si intersecano. È indubbio che Strada a senso unico debba molto alla relazione di Benjamin con Asja Lacis e al tumulto interiore generato nell’autore, sia dall’amore intenso che provava per lei che dal travaglio di una crisi esistenziale. Il titolo dell’opera è già di per sé emblematico in merito alla profondità dei livelli di lettura presenti nel testo. Strada a senso unico evoca l’immagine del tipico cartello stradale con la freccia e la scelta di certo non stupisce, vista la vastità di termini attinti dalla segnaletica. Un primo livello di lettura di questo titolo richiama sicuramente l’impegno politico che Benjamin aveva intrapreso, per il quale ringrazia Asja Lacis (definita “ingegnere” nella dedica). L’autore vede il nuovo percorso apertosi davanti a lui come l’unica via possibile, una via che una volta imboccata non permette di tirarsi indietro. Questa forte affermazione politica nasceva in un periodo oscuro di una Germania prostrata dopo la Grande Guerra e sofferente sia dal punto di vista economico che culturale. La sterilità intellettuale della Germania di quel periodo che Benjamin credette di rilevare emerge più volte nel testo, dovuta secondo l’autore, sia alle persone che ad una letteratura povera. Le indicazioni di Benjamin su cosa dovrebbero contenere i libri e su cosa essi siano sono molto chiare. Pare emergere da esse un senso critico ed una insoddisfazione verso una determinata letteratura considerata debole e inefficace. Al contempo, emerge l’amore per la lettura e un rapporto di forte dipendenza dai libri. In N. 13 essi sono accomunati alle prostitute, svelando il rapporto quasi carnale che ne garantisce la somiglianza. Questo però rivela come l’amore dell’uomo per il libro non sia mai ricambiato, proprio come può esserlo quello verso la prostituta. I libri sono fonte di delizia, di disperazione, di sconforto, ma anche motivo di biasimo, di discordia e di bugie. Questo rapporto conflittuale rappresenta il difficile momento culturale della Germania evidenziato da Benjamin. “ Ogni vita singolarmente presa è una strada a senso unico. le sole certezze sono nascita e morte; �uali che siano le scelte e le decisioni nel mezzo poco cambia ” (1) Walter Benjamin, Angelus Novus, Einaudi, Torino, 1995, p. 107. (2) Ivi, p. 107. (3) Ivi, p. 109. (4) Edgar Allan Poe, Racconti, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 20. (5) Walter Benjamin, Strada a senso unico, Einaudi, Torino, 2006, p. 8. 14 n. 01/2011 Spiritualità della strada di Emanuele Guarnieri I navigatori antichi usavano una frase gloriosa: Navigare è necessario, vivere non è necessario. Voglio per me lo spirito di questa frase, trasformata in una forma per raggiungere ciò che sono io: vivere non è necessario; creare è ciò che è necessario. Non mi aspetto di godere la mia vita, neanche a goderla ci penso. Voglio soltanto farla diventare grande, anche se per questo dovranno essere il mio corpo e la mia anima il legno di questo fuoco”. Sembra di buon auspicio avviare una conversazione circa una presunta spiritualità della strada sotto il segno della poesia del portoghese Fernando Pessoa Navigare è necessario. La lingua poetica pare infatti più prossima alla sfuggente nozione di “spiritualità” rispetto alla ragione metafisica, col suo atteggiamento definitorio. La poesia permette di accedere a quei recessi spirituali ai quali la ratio umana è interdetta. Non si tratta di ambiti differenti ma di modi diversi di vedere la stessa cosa. Lungi da noi, però, tentare qui l’ennesima critica della metafisica, disciplina estremamente fruttuosa in altre sedi e così ingiustamente maltrattata da chi non ne comprende la genesi e l’atteggiamento. Se tuttavia lo scopo del presente articolo è avvicinare il lettore al concetto di “spiritualità della strada”, imposteremo allora un percorso alternativo che, attraverso allusioni e metafore, permetta comunque alla parola “spiritualità” di esprimere il suo senso. Si scoprirà, in primo luogo, che la spiritualità è tutto, fuorché un oggetto che il pensiero possa afferrare in maniera definitiva: essa sta propriamente in tutte le cose, riveste tutto ciò che tocca di sé e da tutte le cose è rivestita, senza individuarsi mai, e proprio per questo la sua definizione risulta impossibile. Spiritualità è infatti, più che un oggetto, un’attività; e, propriamente, un’attività di “costruzione del mondo”, una pratica che tende a divenire una sfera di senso che inglobi le altre. 15 n. 01/2011 è fatta di esperienza e di azione, differentemente da quanto avviene con la contemplazione; trova il suo posto nel Mondo e nella Storia, con il deciso proposito di conoscere il primo e trasformare la seconda: “Il punto di partenza di qualsiasi spiritualità non sono le cose astratte o spirituali, ma il concreto della vita, il fatto, la realtà stessa [...]. L’anima [...] ha bisogno del corpo per conoscere e afferrare la realtà, darle un significato, sprigionando pian piano una spiritualità [...]. Senza spiritualità il “fatto” rimane chiuso in se stesso, impossibilitato a trasmettere un messaggio” (2). La spiritualità dunque abita il cuore stesso delle cose, allo scopo di investirle di senso, facendone esplodere i significati. Non vogliamo qui entrare impreparati nel merito della tradizione dell’estremo oriente, tuttavia l’essenza della spiritualità pare affine a quel peculiare atteggiamento del mondo orientale, consistente nel prestare massima attenzione a ciò che si sta facendo, illuminando l’azione e facendola risplendere. Tale atteggiamento è visibile, per esempio, in uno dei nomi che viene dato all’agglomerato delle discipline marziali cinesi nel suo complesso: Gong fu o Gong Fu, il cui significato è qualcosa di simile a “esercizio ben eseguito”. In ogni azione, che sia radicata nel quotidiano e nel concreto, e che voglia essere “ben eseguita”, dunque, si annida spiritualità. Lo spirito non si cela, dunque, tra le nebbie di un mondo dietro al mondo – al contrario, esso determina, peculiarmente, tutta la struttura dell’immanente. Ciò spiega la congiunzione che si sviluppa tra le etimologie di arte, ars, e rito. Qualsiasi tipo di atto diviene rituale se svolto a regola d’arte e qualsiasi arte è irrimediabilmente connessa ad una dimensione rituale. L’uomo spirituale svolge ogni azione secondo dettami di tipo artistico e spirituale. Non conosce uno spirito separato dalla materia ma vede nell’unione dei due il fondamento di qualsiasi tipo di ortodossia e ortoprassi. Egli accorda ogni suo atto ai dettami dello spirito, senza nemmeno concepire alcunché che ne sia sprovvisto. Eppure, pare inevitabile che lo spirituale segni un’inequivocabile frattura con il mondo: se così non fosse, ad essa ci riferiremmo con il semplice nome di “mondano”. Come si È quindi intrinseco alla nozione preliminare presentata che quanto chiameremo “spiritualità” non attiene in modo specifico ad alcuna tradizione religiosa – semmai, appartiene a tutte, dal momento che esse si configurano come “vie d’accesso” alla spiritualità. Tuttavia, a causa della formazione e dell’esplicita scelta di fede dell’autore del presente contributo, si farà un consapevole riferimento alla tradizione giudaico-cristiana. Il legame con i domini del sacro è essenziale, ovviamente. Un sacro, tuttavia, inteso in senso globale, come totalità. Dobbiamo sottolineare che l’immagine che solitamente viene associata alla “sacralità” non è molto adeguata ad intendere questa ultima in tutta la sua portata. Vale a dire che dove è la spiritualità a permeare interamente l’esistenza, non vi è posto nemmeno per il sacro, non essendovi un ambito profano da contrapporre ad esso. Un sacro opposto ad un profano non può che sorgere laddove il crisma spirituale sia già venuto meno. È detto che nella Gerusalemme terrestre non vi sarà tempio alcuno. Che bisogno può esservi, d’altra parte, di erigere luoghi di culto, laddove lo spirito non è stato ancora scisso da tutto il resto? Che bisogno può esservi di riti se la vita è in se stessa un rito? Persuasione di queste nostre righe è che l’esperienza del cammino dia la possibilità al viandante di ricomporre quella totalità che è andata perduta, con il solidificarsi e materializzarsi dell’uomo proprio dei tempi che corrrono. L’articolo è di conseguenza diviso in tre parti: nella prima si cercherà di accostarsi all’indefinibile spiritualità; nella seconda tratteremo invece di quella spiritualità propria del camminatore che è detta “spiritualità della strada”; infine, cercheremo di tirare le somme e faremo riferimento al pensiero di Fernando Savater per tematizzare l’eschaton dell’esperienza del cammino. Spiritualità è parola di antiche radici: è semplice infatti farla risalire la latino spiritus, soffio, respiro, alito, direttamente connesso a spirare (respirare) e analogo al greco pneuma. Spirito è ciò che, evangelicamente, “soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va”(1). Lo spirito pervade tutte le cose, per chi si mette nell’atteggiamento proprio della spiritualità: essa, più che di parole, “ più che un oggetto, La spiritualità è un’attività di costruzione del mondo, una pratica che tende a divenire una sfera di senso che ingloba le altre costellazioni esistenziali ” 16 n. 01/2011 bene ricordare che la strada è lunga e in salita. Ci chiederemo ora il come e il perché al camminare – alla strada – si possa assegnare un valore spirituale. Esercizio teoretico certo non vano ma al quale è opportuno affiancare la consapevolezza che forme di spiritualità della strada esistono e sono esistite in modo attuale: è per questo che, in primo luogo, descriveremo l’esperienza concreta di strada detta Goum, dalla quale cercheremo di trarre indicazioni preziose per la nostra riflessione. In cosa consiste, in sintesi, un Raid Goum? Negli anni 1969-1970, dietro la guida di Michel Menu (un ex soldato della resistenza Francese durante la Seconda Guerra Mondiale), alcuni gruppi di persone cominciarono ad organizzarsi per vivere delle esperienze di cammino nel deserto. La scelta del nome con cui designare quanto da loro vissuto ricadde sulla parola Goum. Dapprincipio, questo era il nome di quel che rimaneva delle antiche tribù berbere del Nord Africa, sfuggite alle influenze cristiane prima e musulmane poi, rifugiatesi sui monti dell’Alto Atlante durante il VII secolo d.C.. I colonizzatori turchi e francesi compresero la forza racchiusa in queste bande di predoni liberi, fieri e selvaggi; invece che sottometterli ad ogni costo, li fecero loro alleati. Fu istituito il corpo dei Goumier Marocains, che sempre rimase una forza a statuto speciale all’interno dell’esercito francese: la Gouma, nome della rete di bande pronta ad armarsi istantaneamente, restò infatti sempre sotto il diretto comando del capo tribale. Ispirati dallo spirito di indipendenza di queste popolazioni, i seguaci di Michel Menu decisero di mettersi alla loro scuola e presero a camminare nei deserti altipiani francesi, affiancando al cammino un certo tipo di spiritualità cristiana: quella dell’Esodo. Il Goumier è infatti colui che “abbandona la schiavitù della terra d’Egitto [...] per entrare nella terra Promessa dove scorrono latte e miele” (4). Il risultato finale del cammino consiste, per questi moderni pellegrini, nel cogliere i fiori dell’armonia personale e dell’autenticità e il frutto della grazia, ovvero la realizzazione del cristiano. Ricordiamoci di questa allusione all’Esodo, perché sarà importante allorchè tratteremo dell’eschaton del camminatore sulle tracce del pensiero di Savater. Grande fu la gioia dei Goumiers quando scoprirono, dopo qualche tempo dall’inizio della loro esperienza, che la parola Goum non era un’esclusiva della lingua berbera: la radice qama è infatti presente in tutto l’Antico Testamento, con numerosi significati: levarsi (del sole), alzarsi in piedi, risorgere, salire, camminare, ed anche insorgere, ribellarsi. Nel Vangelo di Marco troviamo l’espressione Talita Kum: “bambina, io ti dico, alzati!”(5). Alla parola attiene un insopprimibile dinamismo, la stessa forza che affiora dal greco physis o dal latino natura, contrazione di nascitura: ciò che è e sempre sarà in procinto di nascere, di fiorire. In fondo, per chi la pratica, l’esperienza dei Raid Goum è questa: insorgere, per salvare un’indipendenza minacciata dal caos del mondano, mettendosi in cammino per risorgere all’esistenza autentica. Occorre rilevare che lo stile col quale tutto ciò viene fatto è l’essenzialità. La povertà liberamente scelta è un punto di partenza fondamentale per il partecipante al Raid Goum: le comunità Goumier accettano che, per il periodo di viaggio attraverso il deserto, dormiranno sulla nuda terra, senza tenda; tutto ciò che mangeranno sarà un po’ di riso a colazione, pranzo e cena e niente altro, bevendo solo acqua compone dunque il paradosso? Come spiegheremo il contrasto tra la natura terrena e radicata della spiritualità e il suo distacco dal mondo? La spiritualità non è necessariamente contemplazione. È semmai il contrario, la contemplazione non essendo che una forma di pratica spirituale tra le altre. La contemplazione pone sé stessa in distacco dalle cose, gli occhi fissi al cielo; la spiritualità, invece, vive ed agisce nel mondo, senza rifiutarlo: essa intende scoprire, al fondo del mondo, la terra. Spiritualità è gettare un ponte tra la terra e il cielo, sarà pensarli uniti. Il suo carattere sarà affine a quella fuga descritta da Elèmire Zolla nella sua Introduzione a Il Signore degli Anelli: “Avvenne a Tolkien in un saggio sulla fiaba di replicare che, certo, una fiaba è un’evasione dal carcere e aggiunse: chi getta come un’accusa questa che dovrebbe essere una lode commette un errore forse insincero, accomunando la santa fuga del prigioniero con la diserzione del guerriero, dando per scontato che tutti dovrebbero militare a favore della propria degradazione a fenomeni sociali.”(3) L’autentica spiritualità non è pertanto una fuga passiva, né una scelta sentimentale compiuta innanzi ad una realtà che ci ha sconfitto bensì l’integrazione di questa stessa realtà all’interno di una costellazione qualitativamente elevata. Qualsiasi tipo di percorso spirituale non può che condurre allo stesso luogo dal quale si è partiti, il quale appare tuttavia sotto un’altra ottica, rinnovata dal cammino. Nulla hanno a che vedere con la spiritualità autentica quelle pseudodottrine che prescrivono l’alienazione supina dal mondo. Al contrario, l’uomo spirituale vive con i piedi ben piantati per terra. Conosce il mondo ma non si esaurisce in esso. Ecco il tratto di una spiritualità integrale: conoscere la fisica ma anche la metafisica, la materia ma anche lo spirito, ammettendo la loro perenne dualità quale cifra del reale. Misconosce la spiritualità sia chi esilia l’uomo nel mondo della materia sia chi prescrive fughe artificiali e fuorvianti. Non vogliamo discutere oltre quel che sembra ora chiaro: spirituale è ciò che parte dal concreto dell’esistenza, si stacca dalla caoticità mondana considerandola carcere dello spirito ed infine torna in essa, con l’intenzione di trovare l’autentico dietro il caos apparente e di trasformare il carcere dello spirito nel regno dello spirito. Pare inoltre opportuno rilevare che non è in nessun modo fondamentale alcun tipo di prospettiva oltremondana o dietromondista per vivere un quid di spirituale: la semplice consapevolezza che questa terra e questa vita siano le uniche a nostra disposizione può – e forse deve – ispirare il desiderio di ritrovare l’autentico nell’inautentico, il cielo ben stretto alla terra, la foresta nella città. In ultima analisi, è opinione dell’autore di questo articolo che si debba prestare attenzione alla tendenza contemporanea (e in generale, umana) alla semplificazione di chi propone facili forme di spiritualità homemade, promettendo un Nirvana facile come uno schiocco di dita. Sono da rifiutare allo stesso modo le superficiale visioni New Age e il bigottismo fariseo di chi vive di sola chiesa, perché spiritualità non significa rigetto, o paura, del mondo reale: al contrario, essa consiste nel vivere nel mondo presente la “Promessa del Regno dei Cieli” o “Promessa della Rivoluzione”, nelle parole di Fernando Savater. La spiritualità è fatta di cose semplici e quotidiane ma non è affatto semplice divenire semplice. È 17 n. 01/2011 assidua e costante, volta a far conflagrare il fuoco del quotidiano, è allora ciò che è necessario; dal che si deduce come lo spirituale sia lo stesso del necessario – almeno ascoltando le voci che qui vengono fatte dialogare. Non è certo un caso, infatti, che nel brano Os Argonautas del musicista brasiliano Caetano Veloso, ispirato a Navegar è preciso, il porto, ovvero il punto in cui la navigazione si spegne, sia paragonato prima al nulla (Nada) e poi al silenzio (Silencio): nient’altro che morte. La parte finale di questo contributo si propone di stabilire quali siano senso e direzione della spiritualità della strada. Lo faremo accostandoci al pensiero del filosofo spagnolo Fernando Savater espresso nel libro La missione dell’eroe. Elementi per un’etica tragica. Lo scritto, in breve, è il tentativo di dare un volto ad un’etica che abbia la capacità di superare l’eterno dissidio tra libero arbitrio e destino, proponendo la centrale figura dell’eroe: questi sa che il suo destino è conseguenza necessaria del suo carattere il quale, a sua volta, è frutto del volere. Ognuno di noi è dunque una volontà che non può non essere tale e che inevitabilmente conduce ad un destino; ognuno di noi vuole la sua condanna, o la sua redenzione, che è in quest’ottica il medesimo. Compito etico dell’eroe sulla Terra è “esemplificare attraverso la sua azione la virtù come forza ed eccellenza”(9), perché un giorno la Rivoluzione appaia sulla Terra. Cosa dovrà fare allora l’eroe, accortosi che la Rivoluzione è in realtà impossibile? Savater lo spiega nel capitolo intitolato Lo scetticismo davanti al mondo nuovo, introducendo l’emblematica figura di Mosè. È nota la storia raccontata dal libro dell’Esodo: dopo quarant’anni di viaggio attraverso il deserto, mentre il popolo ebraico è prossimo all’arrivo nella Terra Promessa, Mosè viene informato da Dio che non avrebbe mai visto la “terra dove scorrono latte e miele”; riceve cioè la funesta notizia che lui e il suo paradiso erano incompatibili. Perché Mosè continuò a camminare, a guidare il Popolo Eletto, come se nulla fosse? Sarebbe facile trovare la ragione delle sue azioni in un altruismo disinteressato, ma il racconto è ben più ricco di insegnamento, se proviamo ad immaginare che Mosè fosse tanto lucido ed egoista quanto tutti gli esseri umani. Scrive Savater che “in della borraccia; e non si laveranno, perché l’acqua nel deserto è troppo poca, così come l’intimità necessaria all’igiene. Sono scelte che indubbiamente appaiono estreme, ma sono giustificate per i Goumier dall’idea che questo tipo di esperienze sono tanto formative per il carattere, da essere insostituibili (6). Il riferimento appena fatto all’essenzialità è strutturale, perché in una sola costellazione ricadono l’essenziale, lo spirituale e il necessario. In cosa consiste essere essenziali? La riflessione di Francesco Tomatis nell’opera Filosofia della montagna allude esplicitamente allo stile di salita elaborato da Reinhold Messner, definito “filosofia della rinuncia”, per comprendere il concetto di essenzialità. Specie dopo la morte del fratello Günther, questi “è stato forse il primo alpinista in assoluto a divenir lucidamente cosciente, sino alla praticata teorizzazione, della rinuncia come conditio sine qua non – non meramente strumentale, ma essenziale e spirituale – dell’alpinismo”(7). Essere essenziali, abitare una forma di rinuncia strutturale, è necessario perché alla nostra pratica si apra l’orizzonte spirituale, dice Tomatis. Occorre fare a meno di tutto ciò che “ecceda la mera vita in soffio essenzializzata”(8), ogni apparato tecnologico che sia possibile escludere, tanto più se si considera che il pericolo – mai del tutto assente nell’ambiente di montagna – potrà anche essere temporaneamente esorcizzato dalla tecnica, ma non farà che ritornare ancora più terrorizzante qualora non ci si sia preparati spiritualmente ad esso. L’essenzialità, allora, è la porta d’accesso alla spiritualità della strada. Da ultimo, tentiamo di comprendere in che rapporto stiano tra loro lo spirituale e il necessario, prendendo in considerazione la poesia pessoana riportata al principio dell’articolo, nella quale lo stesso navigare è presentato come necessario, e ben più della vita. Possiamo stabilire una semplice analogia tra quel che la navigazione rappresenta per il portoghese e quel che il camminare significa per noi. Navigare, camminare, significa attuare in noi un certo tipo di dinamismo equivalente alla creazione, scopo stesso dell’esistenza e ad essa ontologicamente superiore. Non si dovrà allora godere semplicemente della propria esistenza: essa anzi, andrà potenziata, a prezzo della vita stessa. Una pratica dunque “ Ognuno consiste in una volontà che non può non essere tale e che inevitabilmente conduce ad un destino; ognuno vuole la sua condanna, o la sua redenzione, che è in �uest’ottica il medesimo ” 18 n. 01/2011 Forse solo a partire da una simile concezione è possibile fondare una nuova modalità di condivisione estetica, ossia esperienziale. In un tempo nel quale la sussistenza identitaria degli uomini è scissa tra un individualismo ed un collettivismo tanto artefatti quanto falsificanti, solo una Rivoluzione di questo tipo potrebbe costituire una nuova Umanità, atta a sopportare i compiti che ci attendono in un futuro sempre meno decifrabile con i caratteri del presente. Questa la scommessa proposta dai pensatori e camminatori qui esaminati. Dunque è questo il senso di camminare verso la Terra Promessa: essere scettici nella possibilità del suo raggiungimento non significa arrestare il cammino; significa, semmai, “che la virtù continuerà ad essere possibile perché continuerà ad essere indispensabile, perché nessuna istituzione immaginabile la renderà superflua una volta per tutte” (13). Conclude Savater: “I cristiani sostengono che è necessario agire come se la grazia fosse conquistabile, benché non ignorino che si tratta di un dono gratuito e che viene da una volontà tanto libera da essere equivalente al caso. Nello stesso modo, anche noi pagani compromettiamo il nostro giudizio e la nostra dignità nell’agire come se tutto dipendesse da noi, benché alla fine sia ugualmente un regalo e un’alea ciò che viene a chiuderci gli occhi per la notte” (14). Camminare, allora, perché sia possibile ancora camminare, consci del fatto che è il cammino, e non la meta, che trasformano: e che solo al viandante è aperta la visione della Città di Dio. Il cammino è essenziale affinché l’uomo possa divenire a tutti gli effetti ciò che autenticamente è. Ecco il senso nascosto in una pratica che svolgiamo quotidianamente, spesso in maniera inconsapevole. A chi non cammina, neppure gli occhi rimangono, perché navigare è necessario, è più di esistere. pratica, Mosè alla fine è stato informato su cosa significasse questa ‘Terra Promessa’ e ha capito che il segreto, affinché questa continuasse a essere promessa, consisteva nel fatto che lui non sarebbe arrivato a calpestarla, perché quando si entra nella Terra Promessa, questa cessa di essere tale e si trasforma in una terra comune e corrente, in un paese come qualunque altro, intercambiabile con quello, detestato, da cui era partito” (10). È la promessa a dar valore alla terra, e, anzi, la promessa svanisce nel momento in cui si compie, svanisce al punto che si arriva a dimenticare che una volta è esistita, tanto che il Popolo Eletto avrebbe dovuto scegliere tra la terra e la promessa – e ovviamente avrebbe scelto la terra. Mosè, allora, continuò a camminare, con più forza che mai, conscio che nulla al mondo gli avrebbe strappato ciò che davvero ha valore, ovvero la promessa. Certo, il Profeta dovette senz’altro iniziare la sua missione pieno di speranza per la ricompensa che alla fine sarebbe giunta, spinto dall’indubitabile fascino del futuro: ma, poco alla volta, maturò in lui la convinzione che il futuro altro non è se non un miraggio. Cosa distingue infatti il futuro dal presente, se non che il futuro è il giorno in cui il presente, con la sua promessa, muore? “Quando ha saputo finalmente di non dover arrivare nella Terra Promessa e che quel castigo lo avrebbe liberato dal futuro confinandolo per sempre nell’oggi e nella promessa, a Mosè si sono rinnovate le forze e il suo passo ha recuperato una nuova allegria” (11). Ora, il pellegrino e il Goumier vanno alla ricerca della Terra Promessa, il Mondo Nuovo portato dalla Rivoluzione per l’eroe savateriano. Di cosa parliamo, dicendo “Rivoluzione”? Ciò che si intende qui è la Rivoluzione, maiuscola, non una qualsiasi rivoluzione. Delle rivoluzioni, Savater afferma che, pur essendo queste non irrilevanti e nemmeno superflue, rivolgono restando all’interno di un’orbita inamovibile. La frittata, per usare un’espressione castigliana, viene fatta girare ma resta. La Rivoluzione è invece ciò grazie a cui sono avvenute tutte le rivoluzioni e che la farà finita per sempre con la frittata, portando a compimento il Mondo Nuovo, che millenarismi sacri e profani di ogni tempo hanno sognato. La Rivoluzione “annullerebbe la distinzione fra governanti e governati, abolirebbe la separatezza del potere e riconoscerebbe ad ognuno la libera specificità della sua stessa forza”(12). Tutto ciò può senza dubbio sembrare, ad un primo sguardo, un’utopia. Se è così, quale senso ha allora, nell’ottica di Savater, camminare verso il Regno dei Cieli? Questi risponde che non si tratta di una semplice alternativa, di una semplice scelta tra un piano realizzabile e un fantasma impossibile: le cose sono assai più complesse. In primo luogo, la Rivoluzione si presenta come l’orizzonte fondamentale dell’etica: abbandonare l’etica significherebbe consegnarsi allora all’inevitabile reificazione di se stessi, perché chi non è soggetto dell’azione, diviene soggetto all’azione. La Rivoluzione deve dunque mantenere il suo carattere onirico, ma pesante sul presente, sul tempo della promessa, perchè è nel presente che si pone la necessità di lottare per la propria libertà contro ciò che ingabbia e reifica, e allo stesso tempo si deve lottare per la libertà degli altri, necessaria hegelianamente al riconoscimento della propria. È oggi che si deve evadere dal tolkieniano carcere del mondo, dalla caverna platonica, insieme con tutti i prigionieri. (1) Gv, 3, 8. (2) Stefano Roze, Spiritualità dei Raid Goum nel deserto, Arca di Sant’Antimo, Castelnuovo dell’Abate (Siena) 2006, pp. 32-33. Padre Stefano Roze è monaco presso l’Abbazia di Sant’Antimo, nei dintorni di Siena. (3) Elemire Zolla, Introduzione a Il Signore degli Anelli, Bompiani, Milano 2000, p. 6. (4) Stefano Roze, op. cit, pp. 40-41. (5) Mc, 5, 41. (6) Non ci attardiamo a descrivere oltre una pratica tanto affascinante: chi volesse approfondire il tema si procuri l’interessante libro Spiritualità dei Raid Goum nel deserto, oppure consulti il Web agli URL www.antimo. it o www.goum.it . (7) Francesco Tomatis, Filosofia della Montagna, Bompiani, Milano 2005, p.53. (8) Ivi, p.54. (9) Fernando Savater, La missione dell’eroe, Nuove Pratiche Milano, 1998, p. 121. (10) Ivi, p. 161. (11) Ivi, p. 162. (12) Ivi, p. 164. (13) Ivi, p. 170. (14) Ibidem. 19 n. 01/2011 Il camminare come gesto e disobbedienza civile di Andrea Marini N el movimento si rende evidente l’eternità e la metamorfosi del Tutto. Nei gesti puri e liberi si evidenzia la libertà del divenire delle cose. Questo procedere altro non è che un continuo andare e tornare sui propri passi, interrompendo i propri sentieri in modo che ogni istante ed ogni luogo siano riplasmati. È “eterno ritorno”, in quanto tutto ciò che è stato ritorna eternamente in se stesso, modificandosi. La materia e il suo movimento sono costituiti da scambi di energia; questa ultima – così come la materia, come ci ricorda Lavoisier – non si crea e non si distrugge ma semplicemente si modifica. Qualsiasi tipo di movimento e cambiamento è quindi un procedere nel rimanere, un divenire, come si può osservare ad occhio nudo sulla corteccia di un albero: il suo cambiamento è un movimento statico all’apparenza e dinamico nella forma, ma non nella sua sostanzialità di corteccia e albero. 20 n. 01/2011 storia dell’umanità è stata un continuo spostamento; mai l’uomo si fece fermare. Cercò invece di espandersi sempre, di andare oltre. Spostare continuamente il confine del suo regno, del suo possesso – supremo esercizio di volontà. Questa condizione fu tale sempre e per sempre, basti pensare alle nostre società attuali che fagocitano ogni istante di spazio e tempo e ogni conoscenza affinché si possa ristabilire di continuo la sfera di possibilità umana. Questa corsa continua, però, porta a dimenticare, a volgere lo sguardo altrove rispetto al nostro essere, ai nostri piedi e al nostro sentiero, al nostro corpo, facendo sì che il movimento naturale – il camminare – venga abbandonato e depotenziato a favore di movimenti tecnici e meccanici che alterano il nostro esserci, trasformandoci in disumani schiavi della tecnica. L’uomo è così un prodotto tecnico dimentico del suo corpo; così ci dicono in primis Le Breton: “Sicuramente mai come nelle società contemporanee si è fatto così scarso uso della mobilità e della resistenza fisica individuale. L’energia umana in senso stretto, derivante dalla volontà e dalle risorse più elementari del corpo (camminare, correre, nuotare), viene stimolata di rado nel corso della vita quotidiana in rapporto al lavoro, agli spostamenti e così via. Il bagno nei fiumi, come ancora si usava negli anni Sessanta, non si fa quasi più se non in pochi luoghi autorizzati, non si usa la bicicletta (se non in forma quasi militante e non priva di rischi), né tanto meno le gambe, per andare al lavoro o svolgere incombenze quotidiane” (1). Successivamente, Thoreau osserva, portando un esempio calzante che sarebbe stato sicuramente caro anche a Rebecca Solnit: “Come possono le donne sopportare di essere confinate in casa ancor più degli uomini, io non lo capisco; ma ho motivo di ritenere che la maggior parte di esse non lo sopporti affatto” (2). L’immobilità e l’immobilismo tecnico avviliscono e fanno avvizzire corpo e mente, perché se il movimento è traslato dall’io alla dipendenza dell’altro, non può avvenire uno Così l’uomo, nel suo movimento essenziale – la vita –, cambia sempre, non nel suo essere uomo – essere in movimento ed essere cosciente di ciò. L’umanità ha sempre incarnato e sentito questa sua caratteristica essenziale, che è l’essere-in-movimento, come sentirsi parte di un fiume cosmico universale ed eterno, essere una goccia d’acqua in movimento nell’eternità. L’essere umano ha da sempre intrapreso il suo movimento, che è il cammino, accettando il suo destino di nomade tra i nomadi, di aggregato di energia in movimento, immerso in un quantum più ampio. Il cammino energetico dell’essere e del divenire si congiungono, imbrigliati e incatenati l’uno all’altro. Da ciò si deduce la necessità di una più ampia indagine sul senso del camminare. Esso è il gesto più naturale, spontaneo e puro, perché ci porta ad essere parte di questo movimento. Il deambulare coincide a ogni istante della nostra esistenza come a qualsiasi cosa sia, sia stata o sarà. L’uomo è tale in quanto appartenente al genere homo e si forma come essere evoluto e moderno per il fatto che fu homo erectus prima ancora di essere sapiens sapiens. Erectus, questa è la parte che ci interessa della nostra qualifica – definizione scientifica – in quanto ci racconta, nella sua sintesi, che l’homo, un giorno, nella storia della sua evoluzione, non si sa come e dove, non si accontentò del limite fisico che lo costituiva, ma cercò di superarsi, di andare oltre il suo orizzonte, ampliò il suo campo visivo, si alzò in piedi; si rese conto che là dove lo sguardo si fa incerto e impreciso, c’è altro, uno spazio più ampio e controllabile. Un’alterità, una distanza costitutiva da riempire. Un passo alla volta, prima a quattro zampe, poi su due, l’uomo si mosse per raggiungere quel sole, quelle stelle, quell’oggetto voluto, desiderato; quel qualcosa che gli fece compiere uno sforzo immenso: cambiare la sua forma e il suo stato, diventando bipede. Il limite in sé determinava la libertà umana, e quindi andava di volta in volta ristabilito, riposizionato. Da allora la “ L’UOMO HA DA SEMPRE INTRAPRESO UN MOVIMENTO CHE È CAMMINO, ACCETTANDO UN DESTINO DI NOMADE TRA I NOMADI, DI QUANTUM DI ENERGIA IN MUTAMENTO, IMMERSO IN UN AGGREGATO PIÙ AMPIO ” 21 n. 01/2011 vedo l’onde illuminate che carena non varcò (4) Similmente, la filosofia è un cammino, un continuo trascendimento del non plus ultra. Questo ci è confermato anche dalla definizione aristotelica di filosofia come meta-fisica, cioè tentativo di andare oltre la fisica e il sensibile. Si cerca di capire e conoscere ciò che sta oltre la sensibilità: vedere l’oltre e scoprire i sentieri che portano alle vette dell’essere. Questo infinito tendere, scoprire e riscoprire nuove vie, equivale a vivere la volontà di potenza che ci costituisce come esseri-in-movimento, camminatori di sentieri. In quanto viandanti, da sempre abbiamo fatto soste su questi percorsi, perché nelle pause possiamo guardare oltre con attenzione. La sosta è quindi naturale, ma l’epoca contemporanea appare come un canto retorico (5) entusiastico ed elogiativo della sosta perenne, della stasi ignara. Il nostro tempo è un movimento continuo nello stesso punto, un aderire alla stasi, un camminare sul posto, uno spreco di umanità in un ritornare non produttivo, l’epoca della tecnica come una corsa continua sopra un tapis roulant. Il movimento è bandito, non si cammina più, non è più lecita la riappropriazione del nostro corpo, non ne abbiamo più reale coscienza e non sappiamo più quali siano i suoi limiti. Le nostre vie conoscitive sensibili si sono atrofizzate. Nella stasi promossa dalla modernità, l’uomo ha smarrito irrimediabilmente la possibilità di fare esperienza in maniera autentica. Non usiamo più le gambe, sia quelle fisiche sia quelle del pensiero, la vediamo come fatica non utile, uno spreco di presupposte energie vitali, che non sappiamo nemmeno da dove arrivino, a cosa servano, eppure non vogliamo sprecarle. Nascondiamo a noi stessi il nostro quantum potenziale, come un bimbo cela il suo più bel segreto. Ci siamo seduti sul masso erratico della tecnica e qui ci crogioliamo, come lucertole, cercando di goderci il sole di mezza altura, accontentandoci del parziale panorama che riusciamo a scorgere; immobili respiriamo solamente, in vana attesa di domanda e risposta. Il muschio che ricopre queste pietre diffonde le sue spore in noi, incatenandoci come Prometeo alla montagna. Così facendo decretiamo la sconfitta del semidio e la vittoria degli dei. Ascensori, scale mobili, aerei, treni sono tutti mezzi necessari, negarlo sarebbe da sciocchi, ma noi ci immergiamo completamente in essi, negando a noi stessi la minima possibilità di andare a piedi. La tecnica ci costringe sul suo trono di velluto, così da non sprecare energie, annichilendo le nostre forze creatrici e poietiche. In questa maniera abbandoniamo il cammino della vita, citato dal Dante nella Commedia, per lasciarci andare trasportati dalle onde del mare, in un lento naufragare. Questo naufragio deve essere però vissuto in modo diverso, in esso va colta una allegoria dialettica, in quanto deve divenire attivo, come Leopardi suggerì nello Zibaldone. Dove si fa necessario un senso forte, attivo e creativo, noi annichiliamo la nostra volontà per una non-volontà negativa, senza scopi morali o gnoseologici. Il puro camminare è ora bandito, come un atto violento. La bellezza del camminare, la sua forza estetica e conoscitiva viene meno, si perde tra le spire del serpente moderno. Abbiamo detto forza estetica e conoscitiva, vale la pena di sostare su questo sentiero, o più propriamente bivio, e cercare di capire dove conduce. spostamento naturale del limite, un tendere oltre, verso l’altrove; viene meno il concetto di volontà e amore, il desiderio per mancanza e distanza, perché cancellando il corpo si annullano anche le dimensioni costitutive del nostro essere umani. In questa sede però vogliamo riportare la nostra coscienza alla brama e al camminare, al movimento umano: possiamo ricollegarci quindi a quanto detto prima, a proposito della volontà e del desiderio, elementi finalizzati al radicamento e alla definizione dell’uomo come essere-in-movimento, quindi come essere-volontà. Nella storia della filosofia e dell’umanità si è cercato di definire la volontà, ma a nostro giudizio solo con Nietzsche siamo arrivati a percorrere il sentiero che porta al centro del labirinto di acqua che compone questo concetto. Solo con il pensiero della volontà di potenza, siamo riusciti a capire senza analizzare, a sentire la volontà. Occorre percepirla come qualcosa che è in noi e ovunque, che muove il tutto, la spinta del divenire e quindi dell’essere. Infatti nella volontà di potenza, il filosofo di Röcken ci ricorda che la volontà è tutto e ovunque; tutto è un continuare a tendere oltre, un muoversi, un procedere, desiderio di cambiamento, tutto è volontà di potenza contro l’abitudine, che invece sembra abitare l’uomo della nostra epoca. Ogni passo nella storia è ricerca di brama e dominio, di conseguenza definizione di qualcosa, del tracciare continuamente limiti. Assegnare al divenire il carattere dell’essere – ecco la volontà di potenza, secondo Nietzsche. È detta volontà che ci spinge a tracciare quei confini che a noi appaiono come se fossero lì da sempre. È la volontà di potenza dell’uomo a condurlo a tracciare simboli e confini dove prima era l’indistinto, il senza forma, il senza nome. Questo tratto apre dunque l’era dell’uomo sulla terra. Da questo momento in poi, l’umanità non si confronterà che con le sue stesse tracce. Scrutando la natura, come ebbe a scrivere Ernst Cassirer, non incontrerà che se medesima. Di conseguenza, essa non potrà, in nessun modo, arrestarsi ai limiti già tracciati. Ogni limite sarà per l’uomo una soglia, da cui partire nuovamente alla volta di nuovi territori, di nuovi limiti, insomma. All’interno di questa circolarità, e in null’altro, risiede la ragion d’essere di ciò che siamo – o almeno di ciò che siamo diventati. Ci basti pensare, come ci ricorda Peter Sloterdijk (3), che gli esploratori e i colonizzatori si sono sempre mossi, spinti dal desiderio di conoscenza e di potere, verso nuove strade, sentieri, percorsi, rotte e tracciati. Ogni uomo ha sempre cercato di esplorare l’oltre-limite. Tutti i marinai che si avventurarono alla ricerca di nuove terre non tracciarono le loro rotte seguendo la mera casualità. Il loro incedere venne guidato, come scrive Fernando Pessoa, dalla voce di quell’altra schiuma che bagna le altre rive che l’orizzonte cela agli occhi. Ogni esplorazione marittima non è che una risposta a questo canto, che le onde intonano su scogliere che ancora non conosciamo: Altra voce dal profondo ho sentito risonare altra luce e più giocondo ho veduto un altro mare. Vedo il mar senza confini senza sponde faticate 22 n. 01/2011 che fece della perfezione della natura il motivo principale dei suoi componimenti. Egli, infatti, ricorda sempre con delicate parole, capaci di emozionare il lettore, il sottile canto con cui la natura ci parla e sussurra fragili verità, i sentieri nascosti in lei, le allegorie di cristallo. La sua biblioteca fu la natura incontaminata, le bellissime distese di prati del nord Inghilterra, erano gli steli d’erba, i ruscelli e le piante a parlare e non la polvere degli studi e dei gabinetti. Componeva poesie mentre camminava, per non perdere nulla delle infinite emozioni che lo accompagnavano nelle sue passeggiate: immortali sono gli splendidi versi che il poeta donò alla storia, riguardanti l’abbazia di Tintern o altre sublimi meraviglie che gli si manifestavano innanzi durante il suo vagare. Tolkien, come il poeta romantico, abitò in campagna, lontano dall’opprimente e caotica città che lo faceva sentire chiuso e schiacciato, impedendogli di scrivere i suoi canti d’amore per la vita e la natura e la sua poesia poetica (7). Lontano dalle “diavolerie” tecniche, tra il lavoro universitario e le tristi guerre, solcò sui fogli della storia della letteratura mondiale capolavori di bellezza incredibile e di grandissima apertura alla vita. Tra questi ricordiamo Albero e foglia e Il signore degli anelli, in cui si narra del viaggio di un piccolo essere attraverso le impervie vie della natura, un percorso iniziatico, verso l’uomo e la sua fragilità, verso la verità della natura. La bellezza della parola allegorica si disgrega di fronte al lettore e lascia così cantare la verità dell’esperienza naturale e della madre terra. É il cammino verso l’eternità, l’immergersi nel divenire (camminare) per rendere immortale se stessi e ciò che ci circonda; per dirlo in maniera nietzschiana, come già ricordato, imprimendo al divenire il carattere dell’essere. Ci hanno così raggiunto i due pensatori che attendevamo prima con impazienza, Heidegger e Thoreau. I sentieri che avevamo lasciato interrotti sono ora da percorrere, perché ora abbiamo la disposizione all’ascolto, essendo aperti alla natura e alla sua parola. Questi due filosofi, di culture e epoche, per quanto vicine, estremamente lontane, ci insegnano ad avventurarci per i sentieri allo stesso modo. Entrambi avevano cara la vita campestre e il perdersi tra i sentieri dei Il pensiero filosofico e nato in cammino, tanto che una nota scuola dell’antichità era detta peripatetica, in quanto svolgeva la sua attività riflessiva all’aperto, cambiando il luogo in maniera continuativa; solo con l’apertura di accademie e licei la filosofia ha iniziato a diventare sedentaria. La riflessione filosofica si è spostata così dalla natura e dai sentieri dell’essere alla pura attività mentale, diventando mera speculazione. Il limite labile è divenuto stabile e ha iniziato a muoversi come una bolla, chiudendosi in circoli, perdendo così la propria apertura. Dobbiamo però, a onor del vero, dire che non tutti i filosofi si sono formati in scuole. Le figure più vive e influenti sono sempre stati grandi camminatori, fisici e metafisici. Ce lo ricorda anche Claudio Bonvecchio (6) in un suo libro che si muove tra i sentieri e i pellegrinaggi che si sono visti nella storia della filosofia, passando da filosofo in filosofo, da tracciato in tracciato. Ci basti pensare ad alcuni pensatori tra cui Rousseau, Nietzsche e Heidegger. Essi hanno fatto del prendere passo la propria scuola, il loro libro aperto su cui studiare e pensare. Non a caso, Nietzsche teorizzò l’eterno ritorno a quattromila piedi di altezza, nelle terre dell’Engadina, passando e ripassando per i sentieri. Sentieri che si rinnovano nel loro essere ribattuti, che si snodano tra boschi e laghi, percorsi che sempre si ricongiungono con il loro inizio in maniera mutata, sempre nuovi nella loro identità. Il terreno ha così insegnato all’autore della Gaya scienza lo svolgersi degli eventi e dei mutamenti nello spazio e nel tempo. Anche altri, camminando, hanno ascoltato il canto del mondo: tra questi dobbiamo ricordare Martin Heidegger e Henry David Thoreau. Prima di continuare il nostro viaggio accompagnati da questi due pensatori, è bene raccontare in breve di due uomini di lettere inglesi che del camminare e dello scrivere hanno fatto la loro ragion d’essere. Stiamo parlando di William Wordsworth e John Ronald Reul Tolkien. Entrambi celebri per essere stati dei grandi ed instancabili camminatori, ricavarono dalla natura un profondo sentimento, che cercarono di trasmettere attraverso testi, idee e ricordi: una grande fede nella natura, nella sua bellezza e fragilità. Wordsworth fu un poeta “ Questo infinito tendere, scoprire e riscoprire nuove vie da sempre e�uivale a vivere la volontà di potenza che ci costituisce come esseri-inmovimento, camminatori di sentieri ” 23 n. 01/2011 Felicità raggiunta, si cammina per te sul fil di lama. Agli occhi sei barlume che vacilla, al piede, teso ghiaccio che s’incrina (10). Il viandante solitario è un respiro della realtà, è colui che conosce con il corpo e con la mente, perché il cammino è un viaggio iniziatico. Il camminatore è come un bambino che si apre alla molteplicità dell’esperienza, infantilmente gode di ogni battito d’ali di farfalla, del colore dei fiumi, del profumo della pioggia; sa perdersi, è in attesa della verità che scaturisce dalla fragilità di crisalide della bellezza. Ma camminare è anche disobbedire alla modernità, è vivere la fragilità e la caducità delle cose nel loro essere profonde e belle, è l’aurora del volere. Ogni passo compiuto è un’accusa profonda, una ferita inferta; è un canto che va a proseguire e continuare la sinfonia infinita dell’universo. Il cammino, pertanto, si configura come un’azione di disobbedienza civile. Richiede, infatti, l’infrazione deliberata della legalità mondana in virtù dell’adesione ad una giustizia superiore che, lungi dall’eclissare le scelte individuali, ne integra il tracciato in una geografia spirituale più ampia. Camminare è rispondere alla richiesta di essere fedeli alla terra e alla sua semplicità, alle leggi e al respiro cosmico. Il viandante è colui che sa che non c’è strada, che la strada si fa camminando, che si costruisce continuamente, perché i sentieri interrotti aspettano di essere percorsi. Camminare è rispondere all’invito delle speranze che esplodono, a continuare e tentare strade, leggere a fondo le domande e le allegorie (11). Camminare è metamorfizzarsi in stelle che danzano, secondo la definizione nietzschiana, nel fanciullo cosmico di Eraclito, che crea e distrugge in una magnifica assenza di fini. Ecce Homo. “Andiamo (…) per reconditi sentieri sconosciuti a liberare il verde caimano che tanto ami” (12). Camminiamo... boschi lasciando che la strada venisse a loro e non viceversa. Heidegger, infatti, pose notevolmente l’accento sul camminare come via filosofica e avvio alla filosofia. Egli riteneva che l’andare a piedi fosse metafora del procedere filosofico e viceversa. Era noto per le sue passeggiate nella Foresta Nera, dove possedeva una baita; amava camminare e pensare lasciando che i piedi lo guidassero verso la radura. Così faceva anche in campo filosofico e l’uso abituale di terminologia pedestre nei suoi scritti, polvere, scarpe, suole, sentieri, radure, pastori, ci conferma il fatto che ritenesse che filosofia e cammino fossero legati da un vincolo, un nodo metafisico. Camminare è “andare” lasciando che le cose ci si manifestino, il modo di conoscere è questo, un continuo essere aperti alla venuta della verità e dell’essere, vagando con passo sicuro tra i sentieri di campagna, percorrendo a volte tracciati non noti, dei sentieri interrotti – Holzwege – per raggiungere così la radura dell’essere. Il cammino, nel pensiero di Heidegger, si coniuga all’abbandono. Ma l’abbandono (Gelassenheit) non è un dimenticarsi delle cose, ma un lasciarle (lassen) avvenire. Chi cammina e pratica l’abbandono lascia che il mondo avvenga, accada nella sua spontaneità. Qui prendiamo il passo con Thoreau ed altri scrittori e pensatori che hanno fatto della loro esistenza una vita, sciolta dai gioghi della massa, per vivere da individui il rispetto di sé, dell’altro e della natura in quanto madre di tutto. Camminare è quindi un gesto puro, di apertura libera – verso la natura, il mondo e la conoscenza. Prendere il passo è lasciare che la vita viva, è il gesto di sfida verso un appiattimento totale, verso la tecnica. È gesto di amore, in quanto tendere verso, andare oltre e procedere. Amore spinto dalla volontà: la volontà è la legge che guida l’amore nella vita e nel movimento delle cose, l’aderire al motto pindarico divieni ciò che sei e all’ecce homo nietzschiano. Volontà è libertà e vita, voglia di vivere da uomini e non da schiavi delle macchine. L’uomo è in sé quindi un ribelle, un anarca che impara a muoversi tra le vie della modernità come tra i sentieri, perdendosi per poi ritrovare la strada che è a senso unico, una strada verso la profonda radicazione dell’uomo in sé e nel divenire. Goethe, Jünger e Benjamin ci ricordano questo quando, concordi, affermano che l’uomo deve imparare a smarrirsi in una città, simbolo moderno, come tra i sentieri di montagna e i boschi, simbolo di libertà e vita, lasciando che le strade e le vie ci parlino come rami spezzati e sentieri, come le foglie e i profumi della natura, con lo sguardo diritto al sole e alla sua luce allegorica (8). Camminare è il porsi sulla soglia in attesa, mentre questa si sgretola e ricostituisce ad ogni nostro passo. Dobbiamo essere aperti al mondo, al sublime che abita in noi e alla natura, come il viandante del famoso quadro di Friedrich, che si dispone alla verità della natura; conseguendo, con la pazienza del pellegrino, il Tao, la legge che regola lo svolgersi degli eventi, del divenire. Camminare è un’azione forte e viva ma al tempo stesso delicata e dolce, che chiede profondo rispetto di tutto ciò che ci si staglia di fronte: Ora sia il tuo passo più cauto: a un tiro di sasso di qui ti si prepara una più rara scena (9). E ancora: n. 01/2011 E la verità si fece pietra di Marco Molino (1) D. Le Breton, Il mondo a piedi – elogio della marcia, trad. it. E. Dornetti, Feltrinelli, Milano 2007, p. 10. (2) H. D. Thoreau, Camminare, a cura di M. Jevolella, Mondadori, Milano 2010, p. 21. (3) Cfr. P. Sloterdijk, L’ultima sfera, trad. it. B. Agnese, Carocci, Roma 2005. (4) C. Michelstaedter, I figli del mare, in Poesie, a cura di S. Campailla, Adelphi, Milano, 1992. (5) Cfr. C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, a cura di S. Campailla, Adelphi, Milano 1987, in particolare la parte del volume riguardante la “rettorica”. (6) Cfr. C. Bonvecchio, I viaggi dei filosofi, Mimesis Edizioni, Milano 2008 (7) Cfr. J.R.R. Tolkien, Albero e foglia, Bompiani, Milano 2006, in particolare la poesia Mitopoeia e il racconto Foglia di Niggle. (8) Cfr. a questo proposito, W. Benjamin, Infanzia berlinese, Einaudi, Torino 1988 e E. Jünger, Il trattato del ribelle, a cura di F. Bovoli, Adelphi, Milano 1990. (9) E. Montale, Ossi di seppia, Mondadori, Milano 1965, p. 39. (10) Ivi., p. 69. (11) Cfr. P. Sloterdijk, Sfere I – Bolle, a cura di G. Bonaiuti con un’introduzione di B. Accarino, Meltemi, Roma 2009, pp. 73 – 74. (12) E. Guevara, Canto a Fidel, in Breviario, a cura di G. Mattazzi, Bompiani, Milano 2003, retro copertina. 24 A l termine di una gara di arrampicata sportiva il vincente Martin Zedenmaier (Stefan Glowacz), intervistato e incalzato dalle domande provocatorie del giornalista Ivan Radanovic (Donald Sutherland), arriva a sfidare il famoso alpinista Roccia Hinerkofler che si sta preparando a scalare il Cerro Torre, una delle vette più inaccessibili del mondo, situato sul Campo de Hielo Patagónico Sur. Alla base del diverbio vi è il non riconoscere da parte di Roccia l’arrampicata sportiva all’altezza dell’alpinismo. I due partiranno subito per l’America meridionale con un piccolo seguito per dimostrare reciprocamente la validità delle loro ragioni. Grido di pietra è in primo luogo la cronaca di una sfida sulle suggestive altezze delle Ande meridionali. La sceneggiatura è redatta dal noto alpinista Reinhold Messner, con la regia di Werner Herzog. 25 n. 01/2011 Roccia, invece, perseguo un obiettivo molto diversoda quello del rivale incentrato sulla vita moderna e secondariamente focalizzato al cammino della scalata. In lui la preparazione all’ascesa è fisica e spirituale. È, pur nella sua specializzazione, un asceta che reca le doti e la sensibilità acuta del contemplatore solitario. La montagna ha uno strano effetto su di lui, rendendolo più distante e suscettibile a strani sogni profetici affini a quelli degli antichi stiliti. Corpo e spirito si integrano olisticamente e questo è difficilmente comprensibile per i suoi compagni di viaggio, abituati a scadenze e tempi prestabiliti dai ritmi lavorativi meccanici. In lui l’esigenza di preparazione non ha dei limiti ben definiti nel tempo. Prima di sfidare la potenza della montagna deve respirare, mangiare e in breve vivere a contatto e in stretta simbiosi con la terra. È un percorso lungo che però alla fine dà i suoi frutti. Con questo atteggiamento, l’alpinista aliena da sé ogni tipo di agio del vivere moderno, lascia i suoi affetti a casa, diventando folle ed egoista agli occhi dei suoi compagni. Tale comportamento non è compreso da chi gli sta intorno, certamente d’altra parte per colpa di una mancanza di comunicazione. Se avesse spiegato meglio le sue intenzioni, ben motivate, forse i giudizi sulla sua persona non sarebbero stati così duri. Ciononostante la responsabilità più ampia del fraintendimento, è da ricercarsi nel modo di sentirsi così affine alla montagna selvaggia e così estraneo al Mondo Moderno. A causa del suo atteggiamento, viene lasciato dalla donna che ama e forse proprio questo accende in lui la miccia per completare l’impresa. Si faccia attenzione alla parola completare, non casuale: l’impresa era infatti già iniziata nel momento della sua preparazione. Lo scalare la montagna non è altro che il coronamento e la parte finale della stessa. Nel momento in cui il percorso di preparazione è concluso rimane solo alla decisione personale lo stabilire le tempistiche dell’azione. Dunque si può affermare che in realtà la dialettica nel film si manifesta tra due visioni del tempo: una di tipo ascetico e l’altra tipica del Mondo Moderno e affine ai suoi ritmi lavorativi. Incarnate dai due attori sulla scena, sono forse le vere protagoniste del lungometraggio. Questi stili di affrontare la montagna – ma, più generalmente, la vita – agiscono indipendentemente dagli attori che ne sono le incarnazioni. Forse questi ultimi non sono nemmeno coscienti di ciò. Tuttavia, essi sono la dimostrazione vivente del fatto che ogni modus vivendi è strettamente legato al topos geografico in cui si manifesta. Roccia è l’unico a superare la prova, giacché conforma ogni fibra del suo essere alla montagna. Le altre comparse, incapaci di compiere questo mutamento esistenziale, vengono sconfitte dal Cerro Torre. L’uomo è un essere geografico e questo incide sul suo modo di comportarsi e pensare. Un atteggiamento ascetico a New York sarebbe fuori luogo quanto uno di tipo moderno in Patagonia. Non si può definire come giusta un tipo di sensibilità del tempo a prescindere da dove venga svolta. Sono tuttavia due realtà presenti nel mondo in maniera asimmetrica, poiché quella di stampo moderno oramai risulta sempre più vincitrice per diffusione e auspicabilità. Persino gli ultimi eredi del pensiero ascetico talvolta capitolano in favore del loro avversario ideale. La via di una produzione sconsiderata, senza un vero telos, risulta infine dannosa sia per chi la persegue sia per chi l’am- Il regista in questione raramente congegna una pellicola che non abbia alla base una sua sceneggiatura e infatti ha dichiarato che non sente il film propriamente suo. Ciononostante l’unione è fruttuosa: l’esperienza di Messner, coadiuvata dall’attenzione di Herzog per la “verità estatica”, ci garantisce un film estremamente interessante sotto molteplici aspetti e simboli nascosti. La vicenda narrata riprende in alcune sue parti le polemiche circa la prima scalata del Cerro Torre nel 1959, che si scatenarono nel 1968 e videro storicamente protagonisti Cesare Maestri, Cesarino Fava e Toni Egger. Tuttavia, la nostra analisi non può e non deve interrompersi a questo livello. Lo studio puntigliosamente analitico del record non è nostra materia né di nostro interesse. La sfida profonda che suscita il moto di indignazione in Roccia Hinerkofler, prima ancora dello stile di arrampicata di Martin, è il suo approcciarsi arrogante e supponente alla scalata; che in un ambiente non protetto e sotto controllo – come quello di un palasport – esige un criterio metodologico radicalmente diverso. Un approccio di cui certo non si può biasimare lo sportivo, in quanto non è che l’ultimo sottoprodotto di un sistema molto più ampio che avvolge l’intera Weltanschauung occidentale. Abbiamo quindi contrapposti nel film due modi di vedere, due diverse Weltbild, a confronto: quella del giovane arrampicatore e del vecchio scalatore. Il giovane, d’altra parte, è ben integrato nella sua epoca e pertanto si comporta esattamente secondo i pregiudizi del suo tempo. L’attenzione per la spettacolarizzazione della sua impresa, l’importanza degli sponsor e della fama e il voler prima di tutto produrre un qualcosa prima ancora di pensarla sono tutte maschere di questo. La produttività performante, scandita da ritmi meccanici, è l’obbiettivo che si prefigge il campione di questa determinata visione del mondo. Il produrre sempre qualcosa, quasi a prescindere dalla qualità del prodotto, è notevolmente manifesto in molti personaggi della vicenda. Si tratta, del resto, di uno dei nostri più gravi e insidiosi pregiudizi. Il capitalismo nella sua forma più spinta è solo un aspetto di questa realtà delle cose. In detto atteggiamento possiamo distintamente riconoscere un ossequio alla macchina. In Martin si può notare peraltro un vago moto di orgoglio che lo induce sempre e comunque ad accettare ogni sfida alla quale viene sottoposto. Nemmeno l’esito dell’impresa, probabilmente, muterà questo suo tratto. Tuttavia, non è del tutto un personaggio negativo: proprio in questo orgoglio forse c’é uno spiraglio di redenzione. C’è un altro personaggio nel quale questo moto di superbia non esiste più e la possibilità di redimersi è completamente sparita: è il produttore di New York, incaricato di documentare e registrare l’impresa, per gettarla in pasto a milioni di spettatori annoiati. In questo personaggio abbiamo la concretizzazione stratificata di quel modo di vita che da anni lo guida; nella sua persona, i pregiudizi appena elencati assumono tratti parossistici. È la sua stessa visione che gli impedisce di far fronte alle difficoltà oggettive anche nei momenti di crisi, credendo ancora di essere nella sua amata metropoli pur trovandosi sul Campo de Hielo Sur. Vuole telefonare al suo avvocato e denunciare chi di dovere. È un mondo che nella Wildnis non ha modo di sopravvivere. Ciò che nella metropoli, con i suoi ritmi, lo designa come un cittadino ben integrato, in alta montagna lo fa sembrare un pazzo. 26 n. 01/2011 Si potrebbe dire che il pazzo abbia sacrificato assieme alle dita della sua mano anche la sua sanità mentale. Ma non è così: infatti dimostra di avere un’ottima capacità di giudizio e osservazione dando alle cose il loro giusto valore; solo che la sua statura spirituale non ottiene riconoscimento, dal momento che, in realtà, il livello della sua comprensione è superiore rispetto a quello degli abitanti delle pianure. Quegli stessi abitanti che si pongono il problema del perché un uomo che dispone di mezzi tecnici che incrementano la sua potenza (come elicotteri e videocamere) debba spossarsi a scalare una montagna, quando con il minimo della fatica potrebbe farlo in metà del tempo, non comprendono né il pazzo né l’asceta che aspira alla vetta. I reciproci sistemi di valori sono discordanti e inassimilabili; non si può sperare di arrivare ad una sintesi. In questa nostra analisi recensiva, si è cercato di dare spazio alle metafore portate alla nostra attenzione dal film. Le abbiamo analizzate cercando di interpretarle in modo coerente con la nostra sensibilità e valutazione. Non bisogna però essere dimentichi del fatto che sono metafore e tali devono restare. Grazie alla metafora, abbiamo occasione di ragionare per analogia, il che garantisce un’amplificazione della percezione in vista di un fine di tipo critico. Ciononostante, è bene non confondere il significante con il suo significato. Sebbene nel regno della vetta, per sua stessa natura, questo confine sia labile, è bene saper discernere comunque le due parti. Nonostante in passato ci siano state figure storiche eccezionali in grado di racchiudere tutto nella loro persona, oggigiorno non è detto che un ottimo scalatore sia anche un esemplare asceta. Forse questa avvertenza peregrina può sembrare esagerata o superflua, ma in un mondo appianante e democratico in cui si è abituati a non discernere la paglia dal grano, è un pericolo ben presente in ognuno di noi; esso fa parte di un sistema più vasto ben al di là delle comuni possibilità di raziocinio. Del resto, se Grido di pietra vuole essere un impulso per la riflessione personale, allora è bene tenere presente l’avvertimento che comporta. Dopotutto, chi di noi non vive nel proprio tempo? mira. Senza finalità chiare, l’azione perde senso. Il prodotto che ne consegue non è che un aborto, in qualità ed essenza, rispetto a quello generato in modo tradizionale; perciò non ha una vera efficacia sebbene sia un processo molto efficiente nel suo complesso. Sono questi i due metodi con i quali ognuno di noi si confronta e, forse troppo spesso inconsapevolmente, compie una ineluttabilità. Nondimeno il riconoscimento di tale scelta è già il primo passo verso la consapevolezza; non è del tutto fuori luogo pensare che uno dei fini del regista fosse il porre l’accento e sottolineare il riconoscimento di questa direzione. Un’ultima figura assai significativa del film è il pazzo senza dita interpretato da un ottimo Brad Dourif, ben noto per le sue performance in Qualcuno volo sul nido del cuculo, Ragtime, Il signore degli anelli, Dune e Velluto blu. È un chiaro riferimento alla maschera del pazzo che, quasi come un moderno satiro delle vette ghiacciate, guida e consiglia occasionalmente i protagonisti della vicenda. Il percorso d’ascesi è lungo e pericoloso. Per chi trova il coraggio e la forza di arrivare in alto, la ricompensa è enorme – allo stesso tempo, grande è il pericolo dell’abisso. Chi conosce le vette deve conoscere anche gli abissi, diceva un filosofo: il pazzo senza dita probabilmente conosce bene entrambi. È una figura liminale che inquieta e affascina allo stesso tempo: in lui forse il demone della montagna si manifesta per diffondere il suo verbo silenzioso. Sul suo cammino di hybris ha sacrificato le dita della mano pur di riuscire nella sua impresa e quindi il sacrificio è evidente sulla sua persona. Perché di sacrificio qui si tratta, essendo il cammino, in questo caso ascendente, un qualcosa di affine al rito di passaggio. Coloro i quali non si sacrificano, per paura o per egocentrismo, non ottengono niente. Nonostante sia stato il primo ad aver scalato il Cerro Torre nessuno lo sa nel mondo civilizzato: la montagna si presume ancora essere inviolata. Il personaggio ha compiuto l’impresa per ottenere una Überwindung personale, un autotrascendimento; nulla importa a lui degli onori della cronaca o della fama imperitura di alpinista. “ Il percorso d’ascesi è lungo e pericoloso. Per chi trova il coraggio e la forza di arrivare in alto, la ricompensa è enorme – allo stesso tempo, grande è il pericolo dell’abisso ” 27 n. 01/2011 Il cammino spirituale nella Tradizione di Mauro Scacchi I l verbo «camminare» desta subito l’idea di movimento, dello spostamento fisico da un luogo ad un altro effettuato per mezzo delle proprie gambe. La radice sanscrita gam richiama più genericamente il concetto di «movimento», di «andare da qualche parte» (1). È in questa sua accezione più ampia che il termine «camminare» è stato da sempre utilizzato nei molteplici campi di studio in cui l’elemento d’interesse non fosse propriamente di natura fisica, concreta, quanto piuttosto di natura, per così dire, spirituale. Si dice, infatti, il «cammino dello spirito» e, partendo dalle medesime posizioni, altre espressioni similari, altrimenti associabili al vero e proprio deambulare, si ritrovano in ogni tradizione. Valga per tutte il giapponese Budo, o «Via che conduce alla pace», in cui l’ideogramma che si pronuncia do ha esattamente il significato di percorso, di «via» in senso spirituale. 28 n. 01/2011 stro essere. Ci soffermiamo così a lungo sulla volontà poiché è fondamentale comprendere che essa può agire tanto internamente quanto all’esterno. E onde evitare fraintendimenti, sia l’azione esterna sia quella interna possono egualmente compiersi tanto al livello fisico quanto a quello non fisico, appartenendo entrambi i livelli allo stesso ordine. Intendiamo dire che trattasi sempre e comunque di possibilità «a portata di mano», peculiari della natura umana. In tal senso non sono soprannaturali, anche se così potrebbe apparire a un meno attento indagatore. Nel campo fisico, la volontà spinge il corpo ad interagire con ciò che lo circonda, ma certuni possono allo stesso modo costringere il cuore a rallentare i propri battiti, cosicché l’interazione avviene internamente. Nel campo non fisico, la trattazione richiede maggiori dettagli. Andiamo ad esplorare perciò, più dappresso, il «cammino dello spirito». Lo «spirito», citando Evola, è «termine vago e indifferenziato, dato che spiritus etimologicamente esprime il soffio, rimanda ai termini ào, aeni, soffiare, ad ànemos, che sta alla base tanto di animus che di anima, antecedendo, per così dire, la precisa differenziazione dei due» (2). L’anima, a dispetto di quel che si crede a causa dell’utilizzo romantico e filosofico che ormai di tal vocabolo viene fatto, rappresenta l’impulso vitale, l’istinto, la passione, le emozioni in genere, tra cui la rabbia, la frustrazione, l’invidia, la gelosia, ecc., insomma tutte quelle pulsioni che ci legano alla terra e che ci fanno bramare cose terrene. In questo senso l’anima è connessa all’«inferiore» (3). L’animus invece è ciò che, promanando da noi stessi, esorta e smuove la volontà e dunque l’azione conscia, è ciò che, a cavallo tra interiore ed esteriore, dà impulso agli ordini e consente ogni movimento consapevole. Il «cammino dello spirito» ha come meta finale l’ascesi, cioè la «comunione mistica» (o «matrimonio», secondo la dicitura alchemica) tra anima e animus, in cui però la prima deve, per così dire, soggiacere al secondo, pena la perdita di controllo e l’incapacità di procedere in successive evoluzioni. Tra la volontà e l’azione vera e propria, sia quella muscolare e fisica sia quella spirituale, è posta una «scintilla di attivazione» che può assumere nel Non ci soffermeremo ancora a lungo su questo ordine di idee, tranne che per evidenziare come ogni parola che faccia riferimento, anche indiretto, al camminare, si trovi perfettamente a suo agio anche nel descrivere stati e situazioni che rientrano nella sfera del non fisico, del non visibile. Ecco dunque che termini come strada, via, sentiero, salita, discesa, scala, ecc. trovano agevole utilizzo nel trattare argomenti correlati alla incorporeità. Si noti, infatti, che non solo è possibile traslare dal campo terreno a quello sovraterreno verbi atti a comunicare un comportamento, bensì pure vocaboli che nell’uso quotidiano indicano tutti quegli oggetti con i quali il corpo fisico viene a trovarsi in contatto e con i quali interagisce. Proseguiremo ancora su questo crinale, lasciando però sempre più indietro il versante tipicamente terricolo, volgendo lo sguardo principalmente a quello privo della vile materia. Si potranno continuare a notare, comunque, somiglianze di significato tra le due sfere per nulla accidentali. Innanzitutto il «camminare», come s’è detto, presuppone uno spostamento, dunque una «azione». A sua volta questa deve, per necessità, presupporre una volontà di azione e una attitudine ad essa. Devo prima volere, poi potere, e solo in seguito sarò in grado di compiere lo spostamento voluto. La volontà, di per sé, a sua volta altro non è che una manifestazione impalpabile della coscienza che, già desta, esprime come per mezzo di un «comando» il desiderio di movimento. In altre parole la volontà è il catalizzatore, il giunto cardanico attraverso cui si connettono due mondi, quello visibile e quello non visibile, entrambi naturali, cioè dello stesso ordine, come si spiegherà in seguito. Ma è pure elemento di connessione tra l’Io individuale, inteso come riconoscimento di sé stessi operato dal pensiero cosciente (cioè dal processo logico-razionale che si svolge nella nostra mente), ed il Sé (Selbst), inteso come la parte primigenia e quel nucleo non oltre valicabile del no- “ La volontà, di per sé, altro non è che una manifestazione impalpabile della coscienza che, già desta, esprime come per mezzo di un comando il desiderio di movimento ” 29 n. 01/2011 entità sovrannaturali ma lo scopo fosse di natura terrena e materiale, non più di Tradizione si tratterebbe ma anzi di Controtradizione (come nel Satanismo e in ogni altra contraffazione dell’idea tradizionale). L’Antitradizione è invece tutto ciò che nega il trascendente. Il Neospiritualismo e la New Age in generale sono forme particolari di Controtradizione. Esse infatti il più delle volte promettono metodi per elevarsi spiritualmente e in questo processo non negano, anzi spesso auspicano, rapporti con entità altre, ma l’eccesivo sincretismo, la faciloneria e l’ignoranza che ne permeano le dottrine sono indici di una degenerazione della Tradizione. Ciò avviene quando il vero sapere si è perduto e dunque si colgono frammenti sparsi della conoscenza antica di modo che, coniugandoli tra loro, essi assumano una loro intrinseca validità, che però è sempre di natura differente da quella che si crede. Lo Spiritismo ne è un valido esempio. Allan Kardek, ma prima di lui Emanuel Swedenborg in certa misura, parlava con gli spiriti, o così asseriva, ma nessuna Tradizione può esplicitamente indicarci la vera natura di quegli esseri invocati (tanto meno se evocati); pertanto ciò che gli spiritisti in genere presuppongono di sapere altro non è che una loro ipotesi affatto personale. Queste nuove correnti di pseudoreligiosità (che tali sono specialmente quando si arricchiscono di cerimonie, riti e simboli mutuati da organizzazioni regolari con alle spalle però, queste ultime, secoli di esperienza) confondono in maniera esasperante ogni insegnamento degno di questo nome, alterandone e sovvertendone i significati tradizionali. Il dramma reale, in ciò, è che spesso queste nuove dottrine sono spiegate in termini all’apparenza logici: per quanto astruse possano essere si fondano sui più disparati ragionamenti e su descrizioni talmente evocative che è difficile per l’uomo comune coglierne l’inganno. Più facilmente l’uomo medio farà di «tutta un’erba un fascio» bollando come idiozie tanto i neospiritualismi quanto gli insegnamenti davvero tradizionali. Si vede bene, allora, come tra i presunti insegnamenti di queste nuove religioni, di questi nuovi spiritualismi, vi siano mischiate conoscenze proprie della Tradizione, la cui portata è però compromessa dallo stesso calderone di nozioni in cui sono immerse. Ecco che, in questo senso, il «viaggio astrale» non può che essere criticato dal Guénon. Infatti, l’esperienza che con esso si avrebbe, non differirebbe in sostanza da quella vissuta al termine di percorsi e vie davvero tradizionali, ma in quel caso ci si arriverebbe per gradi, sostenuti da una vera conoscenza preparatoria e da una giusta predisposizione spirituale. È deludente, in parole povere, pensare che chiunque possa illudersi, per mezzo di soli esercizi reiterati nel tempo e magari letti su un libro New Age, di compiere balzi improvvisi coprendo distanze spirituali che la Tradizione insegna volerci anni e tutto un cammino articolato di conoscenza per arrivarvi. La strada lunga e quella corta, quella irta di pericoli e quella erroneamente ritenuta facile, la porta stretta e la porta larga. Di questo si tratta. Della via umida e della via secca, qualcuno direbbe a ragione. Tanto che, infine, i pericoli da cui lo stesso Guénon mette in guardia sono tanto più veri quanto più si semplifica il processo di elevazione spirituale, poiché esso si compirebbe in fretta e furia senza l’adeguata preparazione. Invece bisogna procedere «pazientemente, tenacemente e sottilmente» (13). mondo manifestato il sembiante di trasmissione nervosa, e in quello non manifestato (nel senso, qui, di non fisico) di vibrazione o di altre sensazioni temporanee, sintomo di un qualche passaggio di stato. Si noti che la volontà, come comunemente viene intesa, è un «connettore» che risiede nella parte più superficiale della coscienza. Ma il luogo da cui la stessa volontà scaturisce è invero il nucleo senziente della persona, il suo Sé. Da lì proviene la volontà, la quale per proiezione ci appare scaturire dal pensiero razionale più esterno, quando invece è un’emanazione del nostro essere più vero. Ciò è possibile, come s’è detto, grazie all’intervento dell’animus che «invoglia» l’emanazione della volontà. Ecco dunque che la volontà può spronare tanto un’azione rivolta all’esterno quanto una interna, e nel caso corporeo e in quello incorporeo. La volontà, ormai è chiaro, è la prima leva attraverso la quale a tutti i livelli l’essere interagisce con altro da Sé, sia questo «altro» intelligibile o meno. Conviene subito specificare la distinzione tra ciò che è mistico, ciò che è psichico e ciò che concerne l’iniziazione (4). Il primo stato, tipico delle estasi di molte donne sante del Cristianesimo, ma non solo, richiede per esser raggiunto un atteggiamento passivo della coscienza (5). Epperò mantiene un certo grado d’interesse e di rispetto da parte nostra. Invece lo «psichico» è l’utilizzo di una facoltà comunque naturale, anche se non di facile assimilazione. Questo, al pari della magia (unica differenza è che il primo opera in assenza di strumenti, la magia – «alta magia» in primis – invece vuole opportune cerimonie, riti e Strumenti dell’Arte (6)), rientra nelle possibilità umane ed agisce nel mondo umano, perciò non produce mai un innalzamento ai livelli spirituali superiori (7). È interessante, sotto diversi punti di vista, approfondire un poco alla volta il tema del «viaggio astrale» (8), osteggiato tanto dal Guénon (9). L’«uscita da sé» mistica, di cui parla anche il Guénon, differisce dal viaggio astrale principalmente nella modalità di accesso, poiché laddove a questa si accede per via passiva tramite un indebolimento della coscienza, al secondo si accede per mezzo di una sempre vigile attività della coscienza (e dunque, in linea di principio, esso è più meritevole delle nostre attenzioni). In entrambi i casi l’operatore, salvo eccezioni, non potrà mai esser del tutto sicuro, nonostante ciò che potrebbe raccontare a sé stesso, di aver davvero «viaggiato» fuori da sé anziché dentro di sé (10). I richiami in molti testi al «dentro» o «interno» non devono comunque ingannare. Questo è un campo dove lo spazio, per come lo conosciamo, cessa di esistere, per quanto possa assomigliare ad esso. Per tal motivo concentrarsi su sé stessi cercando il proprio centro originario può essere il modo per uscire da sé, cioè dal proprio involucro fisico, tanto quanto il pensare con tutte le forze di uscire dal corpo potrebbe in realtà catapultare l’improvvido all’interno di un incubo privato, i cui limiti effettivi non varcano le soglie della mente fisica. Nulla è certo se non che esperienza, istinto e conoscenza garantiscono margini di maggior successo e comprensione del fenomeno sperimentato. Fatta questa necessaria premessa, va tenuta in serissima considerazione la distinzione tra Tradizione, Antitradizione e Controtradizione (11). Solo la prima ha l’apporto o l’influenza di un’entità trascendente (12), e consente di superare la condizione umana. Dove pure vi fossero rapporti con 30 n. 01/2011 comprendere quali siano le sovrastrutture dell’essenza di noi stessi, bisogna individuare tutte le convenzioni, le convinzioni ed i sentimentalismi ai quali di solito ci appoggiamo nel quotidiano per poi spogliarcene: ciò che rimarrà, che più non potrà esser grattato via, sarà il nostro nucleo, il Sé. A questo punto ogni cosa, che su di esso si deciderà di riporre, sarà, appunto, un’aggiunta, anche se non meno vera del nucleo, o almeno non meno vera nel mondo della manifestazione in cui si sceglierà (o si dovrà, secondo il concetto induista di Samsāra) di abitare, ad esempio quello corporeo (questa potrebbe definirsi anche «via di perfezionamento del carattere»). I vari corpi saranno fatti su misura per abitare l’ambiente in cui il nucleo verrà a trovarsi. Il cammino spirituale è dunque duplice. In primo luogo è un percorso che, grazie ad adeguate conoscenze, porta il nostro nucleo ad acquisire, o riacquistare, consapevolezza di sé per poi imparare dunque a spogliarsi delle illusioni che lo rivestono (ciò potrebbe visualizzarsi come il nucleo che abbandona l’illusione piuttosto che come l’illusione che scivola via dal nucleo, ma sono solo variazioni di prospettiva, la sostanza del discorso non cambia). In secondo luogo, il cammino sarà un vero movimento del nucleo, uno spostarsi che potremmo per analogia definire spaziale sulle tre dimensioni, effettuandosi però per un numero di dimensioni difficilmente calcolabile, per quanto quasi tutte le tradizioni e molti studiosi vi abbiano a più riprese tentato (si pensi ai sistemi religiosi che parlano di un certo numero di cieli, di inferni o di gironi di uno stesso inferno, ecc.). Appare chiaro come tutto il discorso fatto fin qui abbia avuto lo scopo di risvegliare quanto meno l’interesse del lettore a riaccostarsi ad alcune tematiche che oggidì l’essere umano scansa come scempiaggini ma che dovrebbero invece costituire l’obiettivo principe delle proprie ricerche, il primo obiettivo provvisto di senso della propria esistenza. Il cammino è azione. Vi è una via da percorrere – non sarà una strada asfaltata o un sentiero montano ma è comunque una strada. Infatti, si procede per passi, cioè l’azione è costituita da più azioni minori e va indirizzata, nel senso che deve avere direzione e verso. L’obiettivo deve invece esser chiaro Inoltre, quello che giustamente i tradizionalisti contestano a queste pseudoreligioni, è l’elemento di fascinazione attraverso cui esse fanno proseliti, poiché il loro scopo è vendere libri e promesse a caro prezzo il quale, peraltro, viene puntualmente pagato. Su queste basi si fondano le sette (le psicosette in particolare), i nuovi movimenti religiosi e insomma tutti quegli apparati il cui scopo esteriore risulta quello di arricchirsi sulle speranze altrui, a discapito di uomini e donne che sognano di divenire santi, acquisire poteri, in un mondo che non ha saputo valorizzarli abbastanza. Il campo, qui, è psicologico, in quanto trattasi di soggetti il più delle volte disturbati. Nel campo della Tradizione, come bene osserva Evola, «il processo iniziatico parte invece da un tipo umano normale e sano, per condurlo di là dalla condizione umana, avendo dunque per mero punto di partenza ciò che per la psicanalisi è punto di arrivo e meta faticosa da raggiungere, dati i “soggetti” con cui essa ha a che fare» (14). L’elevazione spirituale deve perciò partire da un tipo umano in cui risieda una sanità pressoché totale, la cui coscienza sia pronta e reattiva, senza alcun genere di devianza. Al di là dei termini usati, senza entrare nei meccanismi di procedura né sondare se provengano da insegnamenti regolarmente trasmessi da un’organizzazione depositaria della Tradizione (cosa cui tiene molto il Guénon), vediamo in cosa consiste il «cammino spirituale». Cammino spirituale che, in ultimo, deve condurre al Corpo di Luce, altrimenti detto Corpo Mistico o di Gloria o Bardo (15). Si dovrà pervenire cioè alla integrazione reale dell’inferiore col superiore, ma non solo in termini di coscienza (animus più anima) quanto addirittura del corpo fisico, poiché tutti questi elementi a un ordine più alto si fondono e non necessitano di separazione alcuna, essendo ognuno una singola manifestazione di un aspetto dell’unità che si raggiunge nell’integrazione (16). In questo senso l’alchemico «solve et coagula» viene spiegato. Per “ Si dovrà pervenire alla integrazione reale dell’inferiore col superiore, non solo in termini di coscienza �uanto addirittura del corpo fisico, compreso nella trasmutazione ” 31 n. 01/2011 da nessuno avrebbe ricevuto insegnamento. In entrambi i casi tali poteri sono deleteri perché di fatto si applicano ai fenomeni, cioè al mondo fisico manifestato e allontanano ancor più dall’elevazione spirituale, riempiendo di inutile e anzi pericoloso orgoglio chi li ha, con il rischio che ci si bei d’avere proseliti e seguaci ignoranti, rapiti in adorazione per il presunto manifestarsi di «miracoli». Ma tra i poteri, spontanei o ottenuti mediante allenamento, quello del «viaggio astrale» dove lo collochiamo? Anch’esso, come i poteri psichici, è in effetti una «facoltà», accessibile per vie naturali. Eppure, a differenza di questi, non presentando un’applicazione (almeno immediata) nel mondo fisico, e potendo usufruire di «guide spirituali» (sorta di maestri dell’aldilà, testimoniati anche da molte esperienze di pre-morte), in esso l’elemento trascendente compare sia nel mezzo che nel fine. Certo non può trattarsi di Controtradizione, sempre che non si presenti il caso di deviazioni d’intenti in corso d’opera. Tanto meno trattasi di Antitradizione. Potrebbe considerarsi un procedimento controtradizionale qualora non provenga da insegnamenti ricevuti da chi direttamente li abbia ereditati, e serbati attraverso un’organizzazione all’uopo preposta. Ma si torna qui al discorso della forma e non della sostanza. Vero è però che se la forma manca di una trasmissione tradizionale, il fenomeno stesso esperito potrebbe risultare distorto, corrotto, malato, e perciò sfociare di fatto nella Controtradizione. Il pericolo è un elemento che va tenuto presente ogni qual volta non vi sia un’organizzazione garante di insegnamenti regolarmente esperiti nell’arco di secoli o millenni. Ma poniamo il caso che, per capacità o per fortuna o per un connubio delle due cose, il pericolo sia scongiurato, che l’esperienza non sia dentro la testa del «viaggiatore» bensì di fatto reale. E poniamo che non s’incontrino ostacoli, né Guardiani di alcuna Soglia (la letteratura ermetica accenna a queste figure quasi mitiche, ben descritte in alcuni romanzi esoterico-iniziatici (20)) o che, se incontrati, essi vengano superati. Ciò che vogliamo dire è che, se mettiamo da parte i possibili pericoli, come quelli che incontrerebbe un uomo mai andato per nave d’improvviso ritrovatosi e gli sforzi vanno in quella direzione; il verso dipende dallo scopo. L’obiettivo è la conoscenza e la direzione è quella dell’asse verticale della Croce (17). Lo scopo è conoscere sé stessi o conoscere quello che c’è fuori, intorno al Sé, in un intorno chiaramente non fisico e non visibile per le normali leggi ottiche. Anche nel secondo caso, si conoscerà comunque sé stessi più di quanto non possa mai avvenire mediante le nostre normali esperienze terrene. Lo scopo richiede un percorso di «ascesi» e perciò tendente verso l’alto. Una questione che spesso si sottovaluta è che, se è vero ciò che la tavola smeraldina asserisce («Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso»), deve essere pure vero che, in certa misura, quel che vale per il mondo della manifestazione fisica deve valere anche per altre manifestazioni. Ciò detto, il non visibile potrà esser “visto” davvero da organi non visibili, in modo similare di come il visibile viene visto dagli occhi. Le Tradizioni fanno cenno ad esperienze particolari che oggi si definiscono «viaggio astrale» (18), pur suonando questo nome ai nostri orecchi non proprio esatto e comunque retaggio di pericolosi neospiritualismi, ché di esso si sono appropriati come fosse parte di un programma scolastico piuttosto che come tappa di un percorso tradizionale. L’iniziazione, come asserisce il Guénon (19), abbisogna di una struttura regolare in grado di trasmettere, per eredità secolare, la conoscenza; tra i poteri psichici che Guénon espressamente attacca non vi è però il viaggio astrale, che invece mette in relazione solo con l’uscita da sé propria del misticismo. Ciò vuol dire che il tradizionalista, pur contestando il viaggio astrale poiché preteso appannaggio di fanatici occultisti del suo tempo (ed oggi, la situazione non può dirsi migliorata), riconosce implicitamente di non poterlo includere tra i poteri psichici propriamente detti, dato che non può nemmeno negargli, tutto sommato, un posto nella Tradizione. Tra i poteri egli distingue quelli acquisiti per allenamento da quelli spontanei. I secondi più dei primi dovrebbero far capire a chi li possiede di non essere, egli, un iniziato, tanto più che “ L’obiettivo è la conoscenza METAFISICA e la direzione è �uella dell’asse verticale della Croce. Lo scopo è conoscere sé stessi o �uello che c’è fuori, intorno al Sé ” 32 n. 01/2011 Cristianesimo chiama Resurrezione, in cui spirito e corpo insieme possono viaggiare altrove. Anche se, a quel punto, il corpo come noi lo intendiamo non servirà più. E proprio perché non occorrerà più, lo si potrà dissolvere e ricomporre a piacimento, in quanto il Sé riunirà ogni propria manifestazione in un unico essere, circondato da tutti i suoi corpi e da nessuno. Il procedimento preciso e le tecniche di ascesi «alchemico-spirituale», noti entrambi, come s’è visto, a molte tradizioni (indiana, giudaico-cristiana, altaico-sciamanica ed altre ancora), non possono rientrare in questo studio che, ad ogni modo, si spera possa servire come indicazione di massima per l’approccio a discipline tutt’altro che futili; quelli che sono indotti a ritenerle tali, se non addirittura sciocchezze senza senso, sono coloro il cui «cammino spirituale» è lungi anche solo dall’iniziare ed al più vanno perciò compatiti, quando non scansati come la peste. a navigare su di un’imbarcazione in alto mare, ebbene se mettiamo per un momento da parte la «forma» che l’esperienza può prendere (dunque il procedimento adottato), la «sostanza» non rimarrebbe forse la medesima di un esperienza giunta per gradi, dopo un percorso di certo migliore e più sicuro, tradizionale? Noi pensiamo di sì. Il «viaggio astrale», pur quando non appreso mediante specifica iniziazione, risulta ad ogni modo tradizionale nella sostanza, essendo in esso presenti tanto l’elemento trascendente quanto quello fisico. Inoltre, questo è forse l’unico caso in cui l’«autoiniziazione», pur pericolosa, non deve essere demonizzata a priori. Volendo prendere a prestito l’Iperuranio del Fedro platonico, forse già troppo romantico per certuni ma di facile comprensione per tutti, chi dice che una Tradizione non si possa indebolire proprio durante la sua trasmissione, per poi riaffiorare in certi tipi umani predisposti ad accogliere in sé idee e concetti proprio dall’Iperuranio? Questi Uomini, a ragion veduta e per questo specifico motivo, sono stati detti «differenziati» (21) rispetto agli altri. Con ciò non stiamo qui a dire fesserie, come chi pretende che chiunque possa fare certe esperienze. Non crediamo nell’uguaglianza delle possibilità tra gli individui, almeno non in questa vita in cui alcuni sono più evoluti rispetto ad altri, spiritualmente parlando. Vero è, comunque, che in genere l’evoluzione spirituale della razza umana nel suo complesso, a questo stadio del suo ciclo, è pressoché la stessa per tutti gli individui, anche se pur lievi fluttuazioni parrebbero agli occhi dell’uomo medio come estremi ragguardevoli, da un lato il demente ritardato, dall’altro il santo o mago o semidio. Perciò non è mai privo d’interesse ricercare quale cammino gli spiriti possano fare per giungere a quel che può dirsi una «reintegrazione degli esseri» (22), laddove per spirito s’intenda per convenienza il Sé, oltre cui non si è in grado di descrivere ulteriormente il nucleo originario di una persona. Lasciamo fuori da questo breve saggio termini come Spirito del Mondo, Spirito Santo, ecc. che più propriamente si potrebbero assimilare all’Iperuranio già menzionato o all’Egregore (23), ma con gli opportuni distinguo che eventualmente in altro momento affronteremo. In poche parole, peccando di brevità e di necessaria incompletezza, possiamo dire che, come nella Grande Opera alchemica lo Zolfo dei Filosofi, volatile, deve fissarsi con il sale del bagno mercuriale posto al di sopra di esso, così anima e animus devono ricongiungersi integrandosi infine nello «spirito», nucleo superiore dell’uomo. Questo matrimonio mistico (24) consentirebbe di avere la piena consapevolezza del Sé e di conseguenza la capacità di interagire su diversi piani mediante la sola volontà. Per trasmutare sé stessi nella nuova forma, assunta dopo le suddette «nozze», bisogna operare con pazienza e rigore durante tutto il processo (25). Il cosiddetto Corpo di Luce è proprio il Sé completamente reintegrato, autocosciente e in grado di agire in ogni piano manifestato, e dunque trasversalmente lungo ogni punto dell’ascesi spirituale, simboleggiata dall’asse verticale della Croce (26). Vi è allora un cambio di ordine, l’ingresso del sovrannaturale propriamente detto ad opera di sé stessi senza interferenze di altre entità altre. Sarà dunque possibile addirittura prendere nuovamente possesso del corpo fisico trascinandolo su piani differenti: ciò che il (1) Deducibile già nel Vocabolario etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani (Società editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati, Roma - Milano 1907). (2) Julius Evola, Animus e Anima (Il Regime Fascista, martedì 2 novembre 1937 – Anno XVI). (3) Sempre Evola scrive: «La romanità conobbe il detto: sapimus animo, fruimur anima; sine animo anima est debilis. Ciò significa riconnettere all’animus, che viene evidentemente considerato come il vero centro dell’essere umano, la conoscenza in senso superiore, e all’anima, invece, l’affettività, l’appetire, il godere, il patire. Sine animo anima debilis – cioè: nell’animus sta la vera forza dell’uomo». Ibidem. (4) Per una trattazione esaustiva di questi argomenti si rimanda a René Guénon, Considerazioni sulla Via Iniziatica (1949; Gherardo Casini Editore, Lavis 2010). (5) Simile atteggiamento si ha nella regressione della coscienza richiesta da alcune tecniche psicanalitiche; non è dunque fuori luogo citare qui Evola (Spiritualismo d’oggi – Psicanalisi in L’Italia Letteraria, 16 agosto 1931 – Anno IX): «Nei riguardi del soggetto, la cosa si riduce invece all’allenamento di una facoltà di détente e di “regressione” che, acquisita, costituisce una condizione esattamente opposta a quella dell’innalzamento “ascetico” della coscienza in supercoscienza». In L’Esoterismo, L’Inconscio, La Psicanalisi (Introduzione alla Magia, Edizioni Mediterranee, Roma 1971, Vol. III, pp. 383-407), il Barone critica il «processo di individuazione» teorizzato dallo Jung. Così Evola definisce il processo suddetto: «quel che gli archetipi in via ordinaria vogliono, è che la persona cosciente riconosca l’inconscio vitale, ne accetti i contenuti e, inserendoli nella sua vita individuale, si “integri” con essi. A questo sviluppo lo Jung dà il nome di processo di individuazione». L’Io, però, al termine del processo, non si fonde con il Sé bensì gli ruota attorno, il Sé rimanendo un «ente indefinibile», come lo Jung stesso afferma in L’Io e l’inconscio (1948; Bollati Boringhieri, Torino 1985). Evola trae perciò la logica conclusione: «è ben evidente non esservi nemmeno una analogia di riflesso con quanto è proprio delle realizzazioni metafisiche ed iniziatiche, queste avendo notoriamente per caratteristica l’identità e la centralità. Invece nel termine finale di ciò che dovrebbe essere un processo di integrazione, come si è visto, il dualismo sussiste». Abbiamo insistito 33 n. 01/2011 su questo punto perché oggi più di ieri tanto la psicanalisi quanto altre tecniche neospiritualiste continuano a non centrare l’obiettivo che esse stesse dicono di prefiggersi, e pertanto bisogna riporre la massima attenzione di fronte ad ogni pretesa metafisica da parte di chi, invece, di Tradizione, Iniziazione e Metafisica non se ne intende minimamente. (6) Come si trova indicato nella Clavicula Salomonis; per un suo approfondito studio: La Chiave di Salomone a cura di Sebastiano Fusco, Venexia, Roma 2006. (7) Anche nella cosiddetta «alta magia», il fatto che entri in gioco l’intervento di entità non umane non deve distrarre dal suo scopo principale, ch’è sempre quello di acquisire poteri e conoscenze utili a dominare cose terrene. (8) Molti riferimenti ad esperienze assimilabili al «viaggio astrale» si trovano in tutti i testi delle maggiori religioni, nonché in quelle scuole di metafisica orientale quali, tra le altre, il Tantrismo ed il Taoismo. Basti qui citare un passo della Bibbia tratto da Qohèlet 12,6 (La Bibbia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1997), che esplicitamente richiama la cosiddetta «Corda d’argento», organo “eterico” di congiunzione tra corpo fisico e corpo astrale, cioè il corpo più denso tra i corpi non fisici: «Pensa al tuo Creatore… prima che si tronchi il filo d’argento». Finché il filo non si rompe, si rimane in vita. (9) René Guénon, Considerazioni sulla Via Iniziatica, cit. In particolare si veda la nota n. 21 a pag. 17: «Del resto, s’intende che questa “uscita da sé” non ha assolutamente nulla in comune con la pretesa “uscita in astrale” che rappresenta una parte così importante nelle fantasticherie occultistiche». L’«uscita da sé» cui fa riferimento è quella dell’estasi mistica. (10) Va chiarito subito che «dentro di sé», in questo caso come in altri, significa limitare l’esperienza entro i limiti del proprio cervello o comunque di una sfera del tutto personale. Altrove, ma sarà chiaro dal contesto, potrà trovarsi analoga definizione col significato però differente di ricercare il proprio Sé, il proprio nucleo, estraniandosi del tutto dalle illusioni e dalle circostanze fisiche del momento. In tal caso, pur volgendosi dentro di sé, di fatto si starà cercando di «vedere la verità di ciò che sta fuori». I due termini spesso possono confondere, l’importante è che sia chiaro l’obiettivo: scardinare dalla mente i costrutti materiali per sorpassarli e andare così oltre di essi. (11) I testi di riferimento sono molti, qui basti citare: René Guénon, Il Regno della Quantità e i Segni dei Tempi (1945; Adelphi, Milano 2009); Julius Evola, Rivolta contro il Mondo Moderno (1934; Mediterranee, Roma 2006); per una sintesi, Piero di Vona, Evola Guénon De Giorgio (SeaR Edizioni, Borzano 1993). (12) Si veda pure in Guénon, Considerazioni sulla Via Iniziatica, cit. (13) J. Evola in La Tradizione Ermetica (1931; Mediterranee, Roma 2009) nella parte Le operazioni ermetiche – La prova del vuoto. Si veda pure, per un consiglio analogo, Tommaso d’Aquino, Trattato intorno all’arte dell’alchimia (nel volumetto Della pietra filosofale – Dell’alchimia, Bastogi Editrice Italiana, Foggia 1997). Il «cammino dello spirito» è propriamente la Grande Opera alchemica. (14) J. Evola, L’Esoterismo, L’Inconscio, La Psicanalisi, cit. (15) Come descritto nel lamaico Bardo Tödol, meglio noto come Libro tibetano dei morti. (16) Non si può non citare la Tabula Smaragdina, famoso documento incluso nell’Amphiteatrum Sapientiae Aeternae di Khunrath, risalente al 1610: «Et sicut omnes res fuerunt ab uno, mediatione unius, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione» (Trad.: «E poiché tutte le cose sono e provengono da una, per la mediazione di una, così tutte le cose sono nate da questa cosa unica mediante adat- tamento»). La Tavola è detta «di Smeraldo» in quanto la Tradizione vuole che il testo sia stato in origine inciso su una lastra di smeraldo in caratteri fenici, trovata in una caverna e tenuta in mano dalla salma di Ermete Trismegisto. Lo smeraldo, di colore verde intenso, rappresenta per la Tradizione l’Anima Universale. Da notare la parola «adattamento», che bene spiega il motivo per cui il Sé, a seconda del grado di elevazione spirituale posseduto, sia costretto per interagire con il mondo manifestato a lui più vicino, cioè per lui più comprensibile, a “indossare” corpi inferiori. (17) René Guénon, Il simbolismo della Croce (1931; Luni Editrice, Firenze - Milano 2006). A questo simbolismo si possono affiancare altre simboliche, come il «terzo volto di Giano», l’asse centrale della scure bicuspide o quello del fascio littorio. In ogni caso il significato è quello di una progressione di stati in grado di congiungere il superiore con l’inferiore, la sfera celeste con quella terrestre, per accedere all’«eterno presente», luogo mistico sede della conoscenza pura. I tre simboli su richiamati sono tutti spiegati da Evola nei suoi articoli raccolti nell’antologia Simboli della tradizione occidentale (1977; Arktos Editore, Carmagnola 1988). (18) Come già accennato (nota n. 8), si può asserire che ogni tradizione che risalga, per vie più o meno dirette, alla cosiddetta Tradizione Primordiale, ha conosciuto e conosce il «viaggio astrale», variamente denominato, come parte essenziale dei propri insegnamenti. Si può senza tema individuare, in esso, il mezzo tramite il quale sono state ricevute, sin dai tempi più antichi, rivelazioni, visioni e quant’altro proveniente dalla sfera propriamente trascendente, come testimoniano tutte le grandi religioni del Mondo. (19) René Guénon, Considerazioni sulla Via Iniziatica, cit. (20) Edward Bulwer Lytton, Zanoni (1842; Tea, Milano 2006); Gustav Meyrink, L’angelo della finestra d’Occidente (1927; Adelphi, Milano 2005); per la convincente descrizione del «viaggio astrale» Jack London, Il vagabondo delle stelle (1915; Adelphi, Milano 2009). (21) Julius Evola, Cavalcare la Tigre (1961; Mediterranee, Roma 2009). (22) Val la pena ricordare che questo è anche il titolo della maggiore opera di Martinès de Pasqually, Trattato sulla reintegrazione degli esseri (1899; Editore Libreria Chiari, Firenze 2003). (23) L’Egregore, in esoterismo, può definirsi come «una forza di ordine sottile costituita in qualche modo dagli apporti di tutti i suoi membri [della collettività] passati e presenti, e che in conseguenza è tanto più considerevole e suscettibile di produrre effetti più intensi quanto più la collettività è antica e si compone di un più gran numero di membri». La citazione è tratta da René Guénon, Considerazioni sulla Via Iniziatica, cit. Da notare che gli Egregori (dal greco εγρεγοριευ, vegliare) sono pure gli «angeli caduti» della tradizione enochiana, il che porterebbe a riflessioni ulteriori che, però, esulano dal presente studio. Il significato più sopra riportato, inteso come «psichismo collettivo», appartiene alla tradizione rosacrociana. (24) I procedimenti per addivenirvi sono propri a insegnamenti molto antichi, si pensi al Rasāyana della tradizione indiana o al Neidan di quella cinese, entrambe «alchimie spirituali» che precedettero nel tempo quelle di laboratorio, comunque pregne di elementi trascendenti a differenza della «spagirìa», vera pre-chimica moderna. Per approfondire questi temi, cfr. Mircea Eliade, L’alchimia asiatica (1935; nel volumetto Il mito dell’alchimia seguito da L’alchimia asiatica, Bollati Boringhieri, Torino 2001). (25) Come già accennato in precedenza. Si veda in proposito la nota n. 13 e la parte del testo ad essa relativa. (26) René Guénon, Il simbolismo della Croce, cit. (vedi nota n. 17). 34 n. 01/2011 Ascesa e ascesi – la vetta come conquista interiore di Andrea Scarabelli A ndare per montagne selvagge è una via alla liberazione (1). Questo detto del Maestro tibetano Milarepa è assai significativo. Il sentiero apre il pensiero alla metamorfosi; la via fonde e confonde l’esserci dell’uomo e il suo territorio. Lo scenario naturale, dopo il transito del viandante, diviene luogo, a tutti gli effetti: lo stesso accade al paesaggio interiore. Il cammino fluidifica e mobilita quelle istanze che il culto moderno della ratio ha sclerotizzato in forme compiute. Camminando, orizzontandosi, l’uomo tratteggia tanto la sua corporeità quanto il nomos del proprio suolo natio (2). La nuda terra illimitata, caotica e selvaggia, diviene Heimat, patria. Il viandante si abbandona al cammino: qui viene celebrata una nuova comunione con le divinità protettrici della terra, dei boschi e delle vette. L’orizzonte dischiude i suoi tesori. 35 n. 01/2011 più il centro dell’azione. Ed allora guardiamo spiritualmente fuori di noi stessi. In quel particolare momento si scopre l’incantesimo. La montagna risponde ai nostri valori personali con l’immenso coro muto della realtà cosmica” (5). Entrambe le stratificazioni sono compresenti nella dimensione antropologica, ma la visuale dell’una esclude irrimediabilmente i precetti dell’altra. Il loro rapporto, tuttavia, non è dialettico ma gerarchico: “Non si può restare sempre sulle vette, bisogna ridiscendere... A che pro, allora? Ecco: l’alto conosce il basso, il basso non conosce l’alto” (6). Se qualità e quantità coesistono, tanto nell’uomo quanto nel suo cosmo, resta pur vero che, se la prima conosce – e assume – la seconda, questo rapporto è ben lungi dall’essere reciproco. La montagna conosce la pianura che domina, ma a quest’ultima l’esperienza della vetta rimane inevitabilmente preclusa. Il sentiero, in un’ottica di questo tipo, diviene innanzitutto avventura – noncurante del non plus ultra che domina nelle metropoli. Laddove la Modernità installa i suoi dispositivi urbani nelle pianure livellanti e quantitative, proprio attraverso la montagna l’uomo può incontrare forze che, sebbene messe al bando dai Leviatani, ne assediano ininterrottamente gli alti cancelli. Là, l’uomo può a tutti gli effetti dialogare con gli elementi, esiliati dai domini metropolitani: “Allora comincia il gioco divino che disperde angosce ed emozioni, e la coscienza acquista una trasparenza ignota in cui si riflette una superiore volontà” (7). Anestetizzata dal culto della tecnica, essa si ridesta – ovunque, nell’uomo, si annunciano miracoli. Simili esperienze, evidentemente, non possono ricevere un adeguato riconoscimento, laddove collocate nel gruppo di quelle che vengono usualmente definite “attività sportive”. Dove l’esame sportivo tende, in misura sempre crescente, a quantificare le prestazioni umane con l’ausilio di chirurgici strumenti di precisione (8), l’alpinismo praticato dai maestri che analizziamo aspira a tutt’altro: “Quando l’attività alpinistica è tutta dominata dal tecnicismo strumentale della esecuzione, ed è questo il caso della maggior parte delle acrobazie sportive moderne in mon- Ciò può accadere anche oggi, dove i sentieri sono occlusi ad una modernità che, schiava della tecnica e della velocità, sradica gli uomini ponendoli su dispositivi meccanici, la cui accelerazione è sempre più vertiginosa (3). Il cammino riconduce l’uomo al centro del suo cosmo, al suo altare silvestre e stellare, restituendogli la sovranità che la Modernità gli ha strappato. Questo il senso ultimo, terapeutico e catartico del gesto del camminare. Nella costellazione che illustriamo brevemente in questo nostro contributo, il cammino raggiunge una nuova conformazione metafisica: da orizzontale si fa assiale. Da analogico, diviene anagogico, secondo la celebre dottrina dantesca (Convivio, II, I, 2-15). Percorsa la pianura sino in fondo, raggiunte le sue estreme propaggini, si staglia la montagna. Al suo cospetto, la percezione diviene verticale, trascendente, alpi-mistica, secondo l’incisiva formula di Francesco Tomatis (4). Ed è proprio del camminare in montagna, alla luce delle considerazioni di un novero di alpinisti mistici del calibro di Domenico Rudatis, Julius Evola e René Daumal, che parleremo in questa sede. Montagna e pianura: la loro contrapposizione non è geografica, economica o culturale ma, anzitutto, spirituale – esse si contrappongono in quanto diverse Weltanschauungen. Si tratta di ordini di realtà differenti, la cui opposizione è scandita tanto metafisicamente quanto analogicamente. Metafisicamente, in quanto assolutamente inconciliabili, incomunicabili. Analogicamente, in quanto presenti non solo nel mondo fisico ma, allo stesso tempo, nell’animo umano; esse si coagulano nell’uomo secondo leggi che assai malvolentieri si rendono disponibili al linguaggio. Il che conferisce loro un rango particolare. L’uomo, infatti, può essere considerato da un punto di vista orizzontale, quantitativo e analogico ovvero secondo una prospettiva verticale, assiale, qualitativa e anagogica. Mutano allora i suoi diritti e le sue facoltà nonché, inevitabilmente, il rapporto che questi intrattiene con il proprio Sé agente. Dove l’altitudine si fa elevata, “improvvisamente, non ci sentiamo “ L’ebbrezza dei domini elementari trasforma l’uomo moderno, strappandogli gli epiteti della decadenza e donandogli un nuovo corpo di luce cristallina, antico ricordo di ciclicità purificate dal fuoco ” 36 n. 01/2011 za. Simile perdita, dovuta alla rarefazione legata alla verticalità del cammino, genera una vertigine inaudita, sintomo dell’abbandono di strutture ingombranti ed antiquate: l’Io, esangue, giace alle pendici del cammino già percorso. Ma è questione di un attimo: il possesso del proprio Sé autentico, realizzato nel corso dell’ascesa, ha infine la meglio. Ciò che cammina, ora, trascende ed annienta il volgare Individuo e il suo corredo raziocinante – esso è un Io assoluto, sciolto, cioè, da ogni sua determinazione specifica. Spogliato delle proprie categorie, l’Io assiste, attonito, al destarsi al suo interno di forze apparentemente sopite che ne inondano le percezioni: “Qui, dove non vi è che cielo, e nude, libere forze, l’animo partecipa piuttosto ad una analoga purezza e libertà e per tal via si approssima a comprendere quel che sia veramente lo spirito. Esso percepisce ciò, dinnanzi alla cui calma e trionfale grandezza tutto ciò che è sentimentalismo, utilitarismo e retorismo umano scompare; ciò che nel mondo dell’anima ha gli stessi caratteri di purità, di impersonalità e di potenza propri appunto a queste altezze gelate, ai deserti, alle steppe, agli oceani” (15). Vetta esteriore e vetta interiore si sovrappongono. La diade si risolve nell’Uno. Se la pianura, nella sua incapacità di comprendere ciò che si staglia al di sopra di essa, conosce unicamente il Diktat dell’antinomia e del principio di non-contraddizione, proprio l’esperienza alpi-mistica può liberare il mondo moderno dal tiranneggiare di quelle false opposizioni che, lungi dall’esserlo effettivamente, non fanno che richiamarsi reciprocamente – traendo esse scaturigine, d’altra parte, dai medesimi fraintendimenti. Il mito dell’eterno ritorno, com’è noto, si ciba del principio aristotelico del tertium non datur est. L’abitante delle pianure non vede che divisione, opposizione dove vi è, invece, unità ed organicità. Dove tiranneggiano gli opposti domina il circolo, l’orizzonte che attanaglia la visione moderna – l’uomo di Leonardo imprigionato nel cerchio perfetto. Dalla vetta, tuttavia, si realizza la signoria plenaria sull’eterno ritorno del medesimo. Il cerchio cede il posto all’asse verticale. Il distacco con la pianura e con il suo formicolare puntiforme diviene totale: “É l’ora delle cime e delle altezze, qui dove lo sguardo si fa ciclico e solare; dove, come larva di febbre, svanisce il ricordo delle piccole preoccupazioni, dei piccoli uomini, delle piccole lotte della vita delle pianure (…). «Molti metri sopra il mare, molti più sopra l’umano» – fu già scritto da Federico Nietzsche”(16). L’ebbrezza dei domini elementari trasforma l’uomo moderno, strappandogli gli epiteti della decadenza e donandogli un nuovo corpo di luce cristallina, antico ricordo di ciclicità ormai purificate dal fuoco. L’ascesa diviene metamorfosi interiore. Mettendosi in cammino per alpeggi e crinali, l’alpinista mistico non si limita a muoversi fisicamente ma il suo ascendere è, allo stesso tempo, collegamento e redenzione: ciò che conosce solo il basso, la quantità, la pianura, viene ricondotto alla vetta e reintegrato in essa. La tantrica Kundalinī si dispiega, in tutta la sua forza, ascendendo, nel suo fiammeggiante potere serpentino, la colonna vertebrale (17), riproduzione microcosmica di quell’axis mundi che sostiene le montagne. Questo il dono che la solitudine siderale delle vette può fornire all’uomo moderno, intrappolato tra le spire delle metropoli, nelle pianure. In esso, ha luogo una liberazione integrale: tramite la montagna, “la liberazione viene riportata ad un livello comprensibile e possibile (…). La vetta della liberazione tagna, l’artificialità chiude sempre di più l’azione nei ristrettissimi limiti di un processo meccanico e materialistico” (9). Approssimarsi alle ebbrezze alpine facendo riferimento esclusivamente a strumenti tecnici preclude la possibilità di intendere il senso metafisico dell’ascesa. Questa richiede, invece, la nudità più totale dell’Io, il suo radicamento immediato. Abbandonato alla roccia, ai crinali, alla corda e ai chiodi, l’uomo si trova in uno stato metafisico estraneo ma, allo stesso tempo, singolarmente familiare. Nelle cime, obelischi titanici, non intravede che la trasfigurazione di se stesso: “Sentirsi lasciati a se stessi, senza aiuto, senza scampo, vestiti soltanto della propria forza e della propria debolezza, senza altro che sé a cui chiedere (…) e il senso dell’altezza e del pericolo imminente, inebriante, e il senso della solitudine solare, e il senso di indicibile liberazione e di respiro cosmico alla fine, all’attingere alle vette, quando la lotta è vinta, l’affanno domato e si schiudono orizzonti voraginosi di centinaia di chilometri – tutto più in basso di noi – in ciò vi è veramente una catarsi, uno svegliarsi, un rinascere in qualcosa di trascendente, di divino”(10). La purezza delle vette seleziona e scandaglia i suoi visitatori, premiando coloro che riescono a vincerne la furia e la durezza elementare, assegnando loro un Io nuovo ma, allo stesso tempo, primitivo, originario e ancestrale. La direzione assiale e polare della montagna, legame tra terra e cielo, uomini e dei (11), offre all’umanità decadente delle Abendlandes la possibilità di accedere a regioni spirituali superiori alla mera razionalità. Questo, forse, è il più prezioso contributo che i demoni delle vette possono offrire ai Moderni. Liberandosi dalla pianura, chi percorre pendii si libera, al contempo, da se stesso. L’assioma fondamentale della Modernità – vale a dire la risoluzione di tutto l’essere tra le maglie di un Io tanto artefatto quanto falso – sfuma laddove l’orizzontalità della pianura, dominio delle masse e pascolo degli ultimi uomini nietzschiani (12) delle metropoli, ceda il posto ai domini verticali di crinali e vette: “Dopo queste lunghe ore, in cui una volontà tenace si è imposta alla fatica, all’inerzia, alla oscura paura del corpo, non solo svanisce come l’eco di un sogno vano il ricordo di ogni cura e opera delle pianure, ma si realizza anche un senso mutato di se stessi, si realizza l’impossibilità a percepirsi ancora come quella cosa rigida, chiusa ed effimera che, in fondo per i più, è l’«Io»”(13). Questo nodo è fondamentale. Se l’ego cogito ha ormai dichiarato la propria bancarotta filosofica e metafisica, secondo gli autori trattati proprio i sentieri di montagna sono atti a fornire ai figli della Modernità un nuovo corredo spirituale. Attraverso la rottura volontaria della propria individualità, realizzata durante l’ascesa alpestre, l’uomo è in grado di attingere a risorse perlopiù rimaste celate: da essere razionale diviene nucleo pulsante di una volontà che intende trascendersi continuamente. Allora, come un serpente, cambia la sua pelle: le sue squame d’argento restituiscono l’incendio che il sole dispensa alle vette, al tramonto. Dove la ratio crea antinomie e limiti, l’ascesa, superandoli, si tramuta in ascesi, esercizio di un Io superiore e trascendente la sua mera rappresentazione logica. Il conato di ascesa pare celare una superiore geometria: “La montagna è uno specchio della spiritualità umana talmente limpido che nel riflettersi in esso la nostra intima umanità, nei sensi e nel volere, tutta si risolve e traspare fino al proprio superamento” (14). Il linguaggio, ridotto ad un silenzio abissale, rivela la propria insufficien- 37 n. 01/2011 era lontana, ardua, oltremodo difficile ma è diventata visibile ed accessibile. Non è più soltanto un sogno ed una speranza più o meno illusoria. Bensì una impresa che si deve e si può affrontare colla necessaria determinazione”(18). Il viandante, rincorrendo il proprio Sé superiore “cavalcando le vette”, compie, allo stesso tempo, un cammino a ritroso, ribattendo le tappe già percorse per potersi reinscrivere all’interno di esse in maniera più autentica. Il suo sognare è più vero, come direbbe Nietzsche. Ascendendo, di quota in quota, l’uomo moderno si volge ai gradi della sua progressiva materializzazione, partecipando al sempiterno gioco degli archetipi i quali, esiliati dal Mondo Moderno progressista e scientista, nelle loro forme più pure, abitano le vette celate dalle foschie. Trascendendo la pianura, il viandante crocifigge l’Io al Sé. Azione e contemplazione entrano in una singolare e originaria congiunzione: “Azione – attraverso la responsabilità assoluta, l’assoluto sentirsi soli, lasciati alla sola propria forza, al solo proprio ardire, cui il più lucido, il più chirurgico controllo deve unirsi. Contemplazione – come il fiore stesso di questa vicenda eroica, quando lo sguardo diviene ciclico e solare, là dove non esiste che il cielo, e nude libere forze che rispecchiano e fissano l’immensità nel coro titanico delle vette”(19). L’occasione che la montagna può offrire al mondo moderno è quella di una genealogia tramite la quale questo ultimo può giungere ad identificare quei caratteri episodici che ne determinarono l’emergenza (20). É la montagna in quanto simbolo incarnato a destare siffatte prospettive. La sua semplice esistenza è atta a testimoniare la possibilità di considerare l’uomo, il suo mondo e la sua storia, da un punto di vista qualitativo e non quantitativo, spirituale (21) e non materiale, verticale e non orizzontale, antimoderno e non moderno. Allora, la rivelazione prende il posto della storia: “Nell’ascesa noi ci avviciniamo al mistero che la polvere della pianura ci nasconde: fra i monti, ad ogni nuovo passo il sembiante ingannevole dell’orizzonte si tramuta e svanisce, ma quando infine siasi giunti abbastanza in alto, dovunque si sia, il puro anello, che è promessa dell’eterno, ci attornia”(22). Una promessa epifanica e teofanica che, laddove accolta in tutta la sua gravità, potrebbe restituire all’anima dell’uomo il suo rango specifico, persino in epoche nelle quali esso non appare che un greve ricordo, come quella che ospita queste nostre parole. (5) D. Rudatis, Liberazione. Avventure e misteri nelle montagne incantate, presentazione di G. Rossi, Nuovi Sentieri, Bologna, 1985, p. 28. Ricordiamo che Evola e Rudatis ebbero a lavorare insieme in una duplice occasione, negli anni Trenta. L’alpinista collaborò ai progetti evoliani de La Torre e Diorama Filosofico. Per gli articoli di Rudatis sul primo – vale a dire La grande solitudine e Il senso della natura nella vita moderna – cfr. J. Evola, La Torre, a cura di M. Tarchi, Il Falco, Milano, 1977, pp. 143-146, 335-340. Cfr. anche L. Pignatelli, Sport, cultura, Tradizione. Domenico Rudatis collaboratore del Diorama Filosofico evoliano, in Futuro Presente, numero 6, primavera 1995. (6) R. Daumal, Il monte analogo. Romanzo di avventure alpine non euclideee e simbolicamente autentiche, a cura di C. Rugafiori, Adelphi, Milano, 2005, p. 135. (7) D. Rudatis, Liberazione, cit., p. 94. (8) Cfr. E. Jünger, Sul dolore, in Foglie e pietre, Adelphi, Milano, 1997, pp. 139-186; J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, cit., pp. 377-378. (9) D. Rudatis, Il sentimento delle vette, in AA. VV., Il regno perduto. Appunti sul simbolismo tradizionale della Montagna, a cura di E. Longo, Il Cavallo Alato, Padova, 1989, p. 36. (10) J. Evola, Dove regna il demone delle vette, in Meditazioni delle vette, cit., p. 43. (11) Cfr., in merito al simbolismo analogico della montagna, Note sul simbolismo orientale della montagna, ne Il regno perduto, cit., pp. 66-82; R. Guènon, La montagna e la caverna e il capitolo Simbolismo assiale e simbolismo del paesaggio, in Simboli della Scienza sacra, a cura di F. Zambon, Adelphi, Milano, 2006; D. Rudatis, Liberazione, cit., pp., VIII, 20, 135, 339, 343, 346. (12) Cfr. F. Nietzsche, Cosi parlo Zarathustra, a cura di G. Pasqualotto, BUR, Milano, 2000, pp. 292-297. (13) J. Evola, Meditazioni delle vette, cit., p. 161. (14) D. Rudatis, Il sentimento delle vette, cit., p. 26. (15) J. Evola, Meditazioni delle vette, cit., p. 162. (16) J. Evola, La parete nord del Lyskamm Orientale, in Ivi, p. 124. (17) Cfr. J. Evola, L’uomo come potenza, Mediterranee, Roma, 1988, pp. 281-291. (18) D. Rudatis, Liberazione, cit., p. 332. “È il linguaggio affascinante delle altezze (...). in tutta la storia umana non si verifica una situazione in cui l’uomo abbia considerato la via con uno spirito più coraggioso e nello stesso tempo più ottimista, conservando il suo sguardo fisso alla vetta della liberazione e la sua mente attiva nel superamento delle difficoltà dell’ascesa”. Ibidem. (19) J. Evola, Verso il deserto bianco, in Meditazioni delle vette, cit., p. 50. Secondo analoghe considerazioni, il già citato Daumal ebbe a scrivere: “L’alpinismo è l’arte di percorrere le montagne affrontando i massimi pericoli con la massima prudenza. Viene qui chiamata arte la realizzazione di un sapere in un’azione”. Il monte analogo, cit., p. 135. (20) Solo in un’ottica del genere, acquisisce senso la storiografia – a siffatte altezze, la storia della filosofia diviene filosofia della storia. Cfr., in proposito F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, traduzione di S. Giametta, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano, 2006. (21) É evidente che simili considerazioni nulla hanno da spartire con certe forme di devozionalismo selvaggio che imperversano nel nostro tempo. Chi ascende in montagna, compiendo una autorealizzazione attiva ed eroica, non abbisogna di divinità estrinseche, realizzando la trascendenza in sé e per sé. Adora un dio fuori di se solo chi non ne ha uno interiore. Questa la sapienza pagana dell’alpinismo. In merito a questi nodi metafisici, tra gli autori più incisivi ricordiamo, ovviamente, Meister Eckhart, Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano, 2007. (22) E. Jünger, Sulle scogliere di marmo, introduzione di Q. Principe, traduzione di A. Pellegrini, Guanda, Parma, 2007, pp. 20-21. (1) Un mistico delle altezze tibetane, in J. Evola, Meditazioni delle vette, a cura di R. del Ponte, saggio introduttivo di L. Bonesio, Mediterranee, Roma, 2003, p. 58. (2) In merito a queste osservazioni, cfr. F. Careri, Walkscapes. Camminare come pratica estetica, prefazione di G. A. Tiberghien, Einaudi, Torino, 2006; C. Schmitt, Il nomos della terra, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano, 2006. (3) Tra gli autori che inquadrarono l’accelerazione come tratto peculiare della modernità, ricordiamo E. Jünger, Lo stato mondiale. Organismo e organizzazione, a cura di Q. Principe, Guanda, Parma, 1999; J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, a cura di G. de Turris, introduzione di C. Risé, Mediterranee, Roma, 2006; R. Guénon, Il regno della quantità e i segni dei tempi, a cura di T. Masera e P. Nutrizio, Adelphi, Milano, 2006. (4) Cfr. F. Tomatis, Filosofia della montagna, prefazione di A. Torno, postfazione di R. Messner, Bompiani, Milano, 2005. 38 n. 01/2011 Nicolás Gómez Dávila “Pensieri antimoderni” di Gian Piero Mattanza P classiche) dice molto sulla concezione che questi ebbe di sé e della propria opera: necessità della brevitas, costante lavoro di limatura per rendere la parola un’arma capace di ferire l’intelletto del lettore, mettendone in moto i meccanismi più occulti. Ma anche atto di coraggio, perché “tra poche parole è difficile nascondersi, come tra pochi alberi” (p. 22). Cinque furono le raccolte di scoli composte: Escolios a un texto implicito I e II, Nuevos escolios I e II, Escolios sucesivos. Ci si chiede, leggendo il titolo della prima raccolta, quale sia il “texto implicito” da immaginare scorrendo gli scoli. La risposta dell’autore non è chiara e va cercata negli aforismi stessi: alcune verità, sembra suggerirci il colombiano, non devono essere esplicate attraverso una prosa ampia, ordinata. La filosofia si nutre di evidenze contrarie che non vanno assimilate razionalmente, ma grazie ad un’intuizione fedele all’ordine assoluto, stimolata da una scrittura breve ed ellittica (Cfr. F. Volpi, Un angelo prigioniero nel tempo, in N. Gómez Dávila, In margine a un testo implicito, Adelphi, Milano, 2001, p. 159). Il pensiero di Gómez Dávila deve molto alla lunga tradizione reazionaria europea, di cui divenne acuto interprete e fedele conservatore. Finalità suprema del reazionario, secondo il Nostro, è combattere, in un’epoca in cui a livello sociale non c’è più nulla da conservare, contro il disordine: fine più alto, questo, dello stesso mantenimento dell’ordine. Non vana nostalgia del passato ma consapevole e perpetua lotta da portare avanti con le armi dell’intelligenza, dell’ascesi dalla realtà corruttrice e degli insegnamenti della tradizione greco-romana e cristiana: “Il reazionario non aspira alla vana restaurazione del passato, ma all’improbabile rottura del futuro con questo sordido presente”(p. 57). “Colacho”, cosi chiamato dagli amici, nutrì la propria visione arlando di alcuni intellettuali, talmente originali da essere estranei ad ogni categoria, si cade a volte nell’abisso del dubbio: come esprimere l’essenza della loro opera senza mettere in discussione la volontà di non sottostare a classificazioni? Questo dilemma si fa più che mai vivo analizzando gli aforismi che compongono l’opera di Nicolás Gómez Dávila (Bogota, 18 Maggio 1913 – 17 Maggio 1994), gemma sconosciuta a molti ma definita da Franco Volpi come “la più luminescente e scandalosamente trascurata” del panorama filosofico-letterario dell’America latina. Pensatore antimoderno, ricevette un’educazione di prim’ordine quando la benestante famiglia si trasferì dalla Colombia a Parigi, dove il giovane frequentò un collegio benedettino. La sua formazione fu prettamente umanistica: nel corso del soggiorno europeo, che durò fino ai suoi ventitré anni, ebbe la possibilità di acquisire una formidabile familiarità con la tradizione letteraria occidentale. Tornato in Colombia, gettò le basi di un’esistenza totalmente votata alla lettura, alla meditazione ed alla scrittura: monumentale la sua biblioteca personale, provvista, si può dire, di tutto ciò che l’intelletto europeo (ma non solo) incise sulle pagine dell’umanità. Asceta di un’aristocrazia spirituale, Gómez Dàvila visse senza sostanziali contatti con la realtà a lui contemporanea, nonostante le numerose offerte, da parte delle alte sfere politiche colombiane, di incarichi culturali e diplomatici di primo livello. Presentiamo qui Pensieri antimoderni (a cura di Anna K. Valerio, Edizioni di Ar, Padova, 2007), crestomazia di aforismi di Gómez Dàvila, con cauto rispetto nei confronti della volontà del colombiano, cercando di evitare inappropriate forzature. L’aspetto formale dell’aforisma, o scolio (annotazione posta dagli antichi studiosi in margine ai manoscritti delle opere 39 n. 01/2011 consumismo sfrenato e dal culto di un’individualità malata e disorganica: “Dove a ognuno è lecito aspirare al vertice, tutto il resto della piramide è un coacervo di frustrati” (p. 48). La teoria gerarchica va declinata secondo precise leggi eterne: durante il Kāli-yuga democratico, infatti, anche l’ultimo dei servi può essere aristocratico, spiritualmente superiore al proprio “signore”. Non si tratta di linee guida economiche, perché l’aristocrazia vissuta dal colombiano (fra l’altro di famiglia altoborghese, non nobile) non ha nulla a che vedere con esse: “Né povertà né ricchezza sono categorie dello spirito. La ricchezza dell’anima decorosa e la povertà dell’anima decorosa si equivalgono, come la povertà e la ricchezza dell’anima volgare” (p. 77). Leggendo gli scoli è evidente la visione di una fratellanza tra simili nello spirito, tra coloro che, pur vivendo nella desolazione dell’“uguaglianza”, sentono il richiamo del trascendente e dell’eterno: “Nostro fratello è non chi ci somiglia nel fisico, ma chi sfiora il medesimo nostro mistero” (p. 37). I quesiti metafisici che, da sempre, occupano le menti degli uomini migliori non devono essere risolti, ma vissuti: l’auspicio di Gómez Dávila è quello di aver composto un libro non lineare, ma concentrico. Opposto alla visione positivista, per lo scrittore l’esistenza è “fare ciò che deve essere fatto”, secondo la norma eterna. In questi termini, la società generata dal pensiero moderno ha perduto ogni ragion d’essere, essendo venuto meno il fine aristocratico che era alla base delle antiche civiltà. La pressione demografica, il pensiero democratico e la rivoluzione industriale sono le bestie nere di questo pensiero: “Non possiamo sperare che la civiltà rinasca finche l’uomo non si sentirà umiliato nel darsi a opere economiche” (p. 33). Pensieri antimoderni è un testo permeato, in ogni sua parte, dal più ricorrente quanto inattuabile insegnamento dell’autore: è necessaria l’eliminazione del compromesso con la modernità attraverso l’ascesi, che prevede la pratica della sola speculazione, sempre alimentata da un’incrollabile fede. “Supremo aristocrate non è il signore feudale nel suo castello, ma il monaco contemplativo nella sua cella” (p. 16). Nicolás Gómez Dávila, Pensieri antimoderni, a cura di Anna K. Valerio, Edizioni di Ar, Padova, 2007, pp. 124 € 11,00. della realtà di un pessimismo totalizzante nei confronti della capacita umana di “fare da sé”, di portare avanti il proprio vessillo di progresso sottraendosi alla morsa invincibile dell’eternità. L’austero cristianesimo della gerarchia, instillato nella mente dello scoliaste colombiano sin dalla giovinezza, si sviluppò in seguito secondo direttrici che potremmo definire antiantropocentriche e regressive. Una regressione da non intendersi come mero ritorno ad un’età ormai morta, con il suo carico di superstizioni, ma come totale adesione ad un modello esistenziale purificato, grazie allo studio dell’antichità, da ogni forma di pensiero avente come fine l’uomo. Durissimo, infatti, l’antiumanesimo del colombiano (“L’umanità è l’unico dio totalmente falso”, p. 78): nessun uomo potrà mai, se non con il consapevole abbandono di sé all’ordine cosmico (che esiste ed è eterno, anche se nell’immanenza lo stolto non se ne rende conto), raggiungere la Verità. Il reazionario disprezza ogni corrente di pensiero che veda nell’uomo un fine: da qui una feroce critica all’ideologia progressista, ma anche all’utilizzo della tecnica come unico mezzo per “vedere oltre”. L’essere umano che si è allontanato dalla religiosità mistica dell’ “intelligente” è destinato alla perdizione ed alla dannazione esistenziale ancor prima che metaumana. Intelligente è colui che osserva la realtà non con la sterile lente dello scienziato, ma con l’eroica volontà del monaco che si abbandona alla contemplazione dell’Eterno, che è contemporaneamente fine ultimo e motore di ricerca interiore. Centrale la credenza in un ordine naturale delle cose voluto da Dio e pervertito dalla democrazia dell’uomo moderno. Questa visione si avvicina molto a quella fondante la struttura sociale del Medioevo, regolata dai vincoli del vassallaggio. La nobiltà è, in questi termini, una libera sottomissione a chi è più vicino alla Verità, a chi pratica con la propria esistenza la pura reazione:“Nobile è non chi crede che ci siano persone inferiori a lui, ma chi sa di averne di superiori” (p. 88). La democrazia, eliminando questa prospettiva, genera individui infelici perché perduti in una multiforme e caotica massa priva della tradizionale spinta religiosa, annientata dal “ Intelligente è colui che osserva la realtà non con la sterile lente dello scienziato ma con l’eroica volontà del monaco che si abbandona alla contemplazione dell’Eterno ” 40 n. 01/2011 Andrea Colombo “Il Dio di Ezra Pound” di Andrea Scarabelli I fabbro” viene sviluppata in modo molto puntuale. Pound, argomenta Colombo, intravede nel cristianesimo una forma di politeismo, la quale – sulla scorta delle analisi di Zielinski, il quale, assieme a Frazer, rimarrà un costante punto di riferimento del poeta – si declina nel culto dei Santi e in quello della Madonna, nella compresenza di dottrine cristiane e taluni motivi pagani, soprattutto a livello popolare. Nel retaggio tradizionale è possibile riscontrare una stratificazione spirituale, nella quale i valori del cristianesimo e quelli precristiani si collocano in un’unica armonia, che li trascende entrambi. Essi sono momenti di un unico movimento, non di certo realtà contrapponentisi. Assieme alle dottrine dei due studiosi menzionati, i motivi che determineranno la presenza di sfumature cristiane e cattoliche all’interno del corpus poundiano, specialmente nei Cantos e in Guide to Kulchur, sono anzitutto certe tinte neoplatoniche – maturate nelle opere di intellettuali come Gemisto Pletone, Scoto Eriugena, Roberto Grossatesta e Marsilio Ficino – e la dottrina sociale della Chiesa, legata a San Francesco d’Assisi. Tra le tematiche proprie a questa straordinaria figura che dovettero affascinare Pound, Colombo annovera “ecologismo, pacifismo, neoplatonismo [e] lotta all’usura” (p. 109). Aspetti, questi ultimi, che furono parimenti costanti spirituali del poeta americano, sicché, a tutti gli effetti, non sconcerta per nulla l’interessante confronto tra le condizioni esistenziali di San Francesco e Pound, avanzato da Colombo (p. 113). Tra le altre influenze religiose Colombo annovera il pensiero di Riccardo di San Vittore, nella sua distinzione tra cogitatio, meditatio e contemplatio, i tre gradi della conoscenza umana. n che misura il pensiero di Ezra Pound può essere accostato al cristianesimo e, in particolare, al cattolicesimo? In che misura possono riscontrarsi delle eco di natura cattolica nell’opera del poeta ed economista eretico americano? Risposte assai persuasive a detti quesiti sono contenute nel volumetto di Andrea Colombo, Il Dio di Ezra Pound. Cattolicesimo & religioni del mistero (introduzione di Mary de Rachewiltz, Ares, Milano, 2011), quinta pubblicazione della collana “poundiana”, dedicata all’approfondimento di tutte le sfaccettature che caratterizzarono questa complessa personalità novecentesca. Attraverso uno studio molto puntuale di taluni testi che influenzarono l’opera poetica poundiana, Colombo si mette alla ricerca delle convergenze ideologiche tra il corpus poundiano e le dottrine cattoliche. Chiarendo, tuttavia, che “nel prendere in considerazione l’ipotesi di un Pound «cattolico», bisogna precisare che il poeta è attratto più dagli elementi estetici, filosofici e di politica sociale del cristianesimo, che dal messaggio religioso in sé” (p. 119). Gli elementi menzionati sono, infatti, i termini di un sismografo che per Pound misura la sanità di qualsiasi tipo di fenomeno. Seppure non si possa parlare di un Pound cattolico, è pur vero che tematiche di ordine religioso compaiono ovunque nella produzione del poeta americano, sin da Grace before Song, il componimento che apre la compilazione poetica A lume spento, pubblicata nel 1908, fino ai Cantos: “Nel lungo poema che intende riprendere lo schema dantesco (inferno, purgatorio, paradiso) attualizzato nella modernità, la religione gioca un ruolo fondamentale” argomenta Colombo (p. 20). L’analisi delle suggestioni cristiane nell’opera del “miglior 41 n. 01/2011 arte, il Grande Stile di Nietzsche e Spengler, che può mettere definitivamente al bando quel modus operandi che costruisce e crea con usura. Nel Canto LXII, ricorda Colombo, a Satana, prototipo archetipico dell’usuraio, si oppone Dio “il grande esteta” (pp. 98-99). La critica verso il mondo usuraio si coniuga, nel poeta americano, alla riscoperta dell’arte medioevale, in particolare romanica e gotica, sulla scorta dei pensieri di Ruskin e dei preraffaeliti. Ciò rende Pound, a detta di Colombo, “un antimoderno affascinato dal Medioevo” (p. 64). E questa fascinazione, ancora una volta, accade sotto il segno del cattolicesimo. Pare che questa peculiare visione religiosa segua Pound, in maniera carsica, riemergendo continuamente, fino alla fine dei suoi giorni. A seguito delle drammatiche vicende degli Anni Quaranta e Cinquanta, che valsero a Pound l’internamento nel manicomio criminale St. Elizabeth's, questi entra nella stagione conclusiva della sua esistenza terrena. Al tempus loquendi dei tentativi di riorientare le linee politiche ed economiche del suo tempo segue il tempus tacendi. Come obbedendo ad una specifica mistica, l’attenzione del poeta si volge all’interno. È ora l’occhio interiore a scandire la sua attività poetica. In quest’ultima fase, come ricorda Mary de Rachewiltz, il poeta americano era solito ripetere: “Non sono stato io a scegliere il silenzio, il silenzio si è impossessato di me” (p. 121). A questo silenzio si lega immediatamente il riemergere di influenze di ordine spirituale. Negli ultimi Cantos paradisiaci, il tema religioso ritorna in tutta la sua eloquenza, tradotto, in particolare, nella ricongiunzione di paganesimo e cristianesimo. “Lo spirito illuminato ora sa che esiste un «Dio di tutti gli uomini, nessuno escluso» (Canto CXIII). Tutto è Uno. Non sussistono più divisioni, contese, razze e neanche, verrebbe da dire, religioni. Nella visione di Pound il platonismo diventa confuciano. Il cristiano si trasfigura nell’uomo universale. Un uomo universale che accetta le forme di devozione popolare che si sono sviluppate lungo i secoli” (p. 124). Si realizza così l’uomo autenticamente cattolico, universale, secondo l’etimologia del termine, alla fine di un lungo cammino tormentato e folgorato da improvvise illuminazioni. Il volumetto poundiano in questione, insomma, è del massimo interesse e permette di stilare un bilancio critico dei rapporti tra il modernismo poundiano e il cattolicesimo. Se tali ambiti appaiono apparentemente piuttosto lungi, in realtà la loro convergenza è tutt’altro che accidentale. Il volume contiene, in appendice, una conversazione dell’autore con Mary de Rachewiltz, figlia del poeta, le lettere a don Tullio Calcagno, direttore di Crociata Italica, delle missive dirette a Monsignor Pietro Pisani, un appunto confuciano indirizzato ad Aloysius H. Vath, il cappellano del campo di detenzione americano nel quale Pound venne internato a seguito della caduta del Fascismo e una raccolta effettuata da Pound stesso di pensieri di Riccardo di San Vittore. Materiali atti a gettare una nuova luce su una delle intelligenze più brillanti – e scomode, secondo la celebre formula di Giano Accame – del Novecento, secondo il compito che la prestigiosa collana che lo ospita ha assunto. Andrea Colombo, Il Dio di Ezra Pound. Cattolicesimo & religioni del mistero, introduzione di Mary de Rachewiltz, Ares, Milano, 2011, pp. 162, euro 14. Comune ai due autori è la convinzione che non la sterile razionalità ma l’amore garantisce una conoscenza effettiva dei principi. L’ascendente di Riccardo è parimenti ravvisabile nelle esperienze avanguardistiche giovanili del poeta: “L’ascensione alla fonte, indicata da Riccardo, ritorna nel Vorticismo (1914) con il simbolo del cono scuro di metallo attraversato da un filo elettrico, dove l’oscurità rappresenta l’universo non illuminato dal raggio della contemplazione e l’elettricità coincide con i pensieri immediati di Pound, guidati dalle intelligenze celesti” (pp. 115-116). Ma il suo lascito fondamentale si traduce nella necessità di accordare la chiarezza del linguaggio ad istanze più alte, percepibili solo attraverso il medium del cuore. Se gli influssi appena menzionati sono di ordine speculativo, è bene ricordare che l’interesse di Pound verso il cattolicesimo fu anzitutto mediato da una decisa presa di posizione di ordine socio-economico. Già nel celebre Canto XLV, ricorda Colombo, “Pound aveva intuito che poteva trovare nel cattolicesimo un fedele alleato contro l’usura” (p. 47). Numerose furono le ragioni di questo auspicio, che vanno, argomenta l’autore, dal gesto di Sant’Ambrogio, che ebbe in più occasioni a scagliarsi contro gli accaparratori di grano, alla celebre enciclica Quadrigesimo Anno, nella quale Pio XI, “sicuramente il pontefice preferito da Pound” (p. 63), progettò una socializzazione delle imprese di matrice cattolica molto simile a quella che venne poi assunta a modello dalla Repubblica Sociale Italiana, secondo il principio del distributivismo. E ciò a seguito della tragedia finanziaria del 1929, che sciolse definitivamente il legame tra la ricchezza economica e la felicità dei popoli. Nemmeno è da trascurare il fatto che Pound ricevette da Piero Pisani, nel 1936, Il giusto prezzo medievale, la tesi di laurea discussa nel 1913 dal sacerdote Luigi Pasquale Cairoli. Nel testo, si discute il legame tra autorità statale, dottrina della chiesa e regolazione del prezzo della merce – tematiche che non poterono che destare l’interesse del poeta, assai sensibile a questioni di questo tipo. Una visione siffatta del cristianesimo sarà uno dei retroscena di quella “economia sacra” che Pound tenterà di realizzare alla fine degli anni Trenta, contestualmente, in particolare, ad una serie di articoli usciti sul Meridiano di Roma. Qui i rapporti con il cristianesimo – sempre filtrati da una griglia di lettura più sociale che teorica – si fanno più stretti: “Anche se non si può parlare di adesione al cattolicesimo, che sarebbe una forzatura ermeneutica impropria, nel suo caso c’è un interesse che va a volte al di là della mera curiosità intellettuale” (p. 73). Il cattolicesimo entrerà, in misura sempre maggiore, nella Weltanschauung del poeta, o meglio, per usare un termine di Leo Frobenius molto caro a Pound, nel suo paideuma. Un ulteriore nodo teoretico vede, nell’opera poundiana, entrare in congiunzione arte, studio delle civiltà e religione. Si va delineando, attraverso queste considerazioni, l’estetica peculiare di Pound, nella quale l’arte è il segnale più eloquente della sanità di una civiltà. Pound intravide in tutta l’arte ecclesiastica un antidoto contro quella forma di arte valutata in base al mero denaro. Si può ben dire che la lotta all’usurocrazia è anzitutto di natura estetica. È la grande 42 n. 01/2011 Fernando Pessoa “Economia & commercio” di Rita Catania Marrone D questione economica e commerciale con l’immagine classica dello spersonalizzato poeta multiplo? Si tratta, forse, di un’altra finzione del poeta fingitore? Ebbene no, in questo caso pare esserci di più. In questo testo si avrà modo di scoprire un personaggio immerso nella vita sociale, lontano dall’immagine kafkiana dell’impiegato medio-borghese che ha legato ineluttabilmente Pessoa al semi-eteronimo Bernardo Soares, autore de Il libro dell’inquietudine. Se Soares osserva il mondo dalla finestra della sua mansarda, senza aspirare ad entrare a farvi parte, Pessoa intraprende, sin da giovanissimo, una carriera che lo porta ad addentrarsi nel mondo del commercio e dell’economia, senza scadere però nella passività e torbidezza esistenziali che trapelano dagli scritti del semi-eteronimo. Se una somiglianza fra i due vi è, ovvero che entrambi non possono essere letterati “di professione”, poiché la società del lavoro richiede una disgiunzione fra un’anima estetica geniale – e per questo inutile, improduttiva – e il cittadino operoso – maschera da “uomo qualunque” –, bisogna chiedersi se Pessoa fu davvero, per i suoi contemporanei, un personaggio senza volto. Scrive Margarido: “abbiamo la possibilità di affermare che Pessoa oltreché un creatore di eteronimi è stato un uomo impegnato in molteplici attività. Nel mentre seminava in fogli e carte di tutti i formati e colori la poesia che lo avrebbe reso giustamente celebre, fu in successione: redattore politico in «Accão» – l’organo, fondato da Geraldo Coelho de Jesus, del Núcleo de Acção Nacional, gruppo facente parte del vasto ventaglio delle organizzazioni volte a preservare l’eredità e, soprattutto, la continuità del sidonismo; innamorato appassionato della giovane Ofélia Queiroz; creatore e tuttofare della Olisipo; condirettore della sua «Revista de Comércio e Contabilidade»; fondatore e collaboratore di «Orpheu» e «Athena» (e con tutto questo vi è ancora qualcuno che continua a insistere sulla sua abulia!). Sebbene l’aspetto più rilevante risieda sempre in questa impos- opo la ristampa del poemetto di Fernando Pessoa Alla memoria del PresidenteRe, le Edizioni dell’Urogallo ripubblicano, nella collana Pessoana e in edizione riveduta, Economia & commercio. Impresa, monopolio e libertà, già dato alle stampe nel 2000 per i tipi di Ideazione. Questo è il secondo capitolo di un più vasto disegno editoriale il quale permetterà ai lettori italiani di conoscere altre sfaccettature – meno considerate rispetto a quella meramente letteraria – del poeta portoghese dai mille volti. In particolare, sono qui raccolti gli scritti del Pessoa economista, certamente uno dei più tralasciati e sottovalutati (insieme a quello esoterico e politico) dalla critica letteraria italiana. Da questo volume (il quale mai fu pensato e strutturato come tale da Pessoa, ma risulta essere frutto del lavoro di assemblamento, ricostruzione, curatela e notazione di Brunello De Cusatis) e grazie alla esaustiva postfazione dello studioso portoghese Alfredo Margarido, emerge un Fernando Pessoa che il lettore italiano faticherà a riconoscere: un Pessoa non alieno dalla società che lo circonda, come spesso hanno voluto mostrarlo i suoi esegeti italiani, ma un individuo attivamente inserito nella propria collettività nazionale. Lungi dall’essere quel “poeta maledetto” che vive per scelta incompreso al di fuori dei confini della civiltà, Pessoa si dimostra, in questi scritti, un intelligente economista e un fine sociologo, diagnosta rigoroso dei problemi del mondo contemporaneo. Come sottolinea lo stesso Margarido, il lavoro di Brunello De Cusatis è “teso a mostrare, soprattutto ai non portoghesi, la trama di un’esperienza esistenziale di Pessoa in cui quasi sempre la vita pratica e la pratica della poesia sono tra di esse inseparabili” (p. 277), e non, come siamo soliti ritenere, fonte di una schizofrenia che si palesa in una vita nevrotica, scissa irrimediabilmente fra i suoi frangenti reali e quelli letterari. Il lettore italiano non potrà non incuriosirsi di fronte ad un volume di questo genere: in quale rapporto può infatti stare la 43 n. 01/2011 dello stesso Pessoa, il quale, moltiplicato in differenti personalità letterarie, costituiva una fetta non indifferente del patrimonio culturale della casa editrice. Fra queste iniziative, quella che potrebbe destare più scalpore è la prevista traduzione dei Protocolli dei Savi di Sion, ai quale Pessoa si dimostra particolarmente interessato. Troviamo la stesura di un possibile piano dell’opera, che sarrebbe stata composta da un’introduzione al testo, un commento storico ed esplicativo atto a dimostrare la autenticità del falso storico e un saggio, pubblicato in un volume a parte, dal titolo O Judeu, Sociologicamente Considerado firmato dallo stesso Pessoa. Insieme a quest’ultimo, il poeta prevede la pubblicazione di un altro suo testo intitolato Aviso, avvertimento, che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di forze occulte che operano alle radici della società europea, le une atte a sostenerla, le altre a dissolverla, secondo il noto sistema della “guerra occulta”, tematizzata da Malinsky e de Poncis. A tale proposito è importante tenere conto di una serie di frammenti contenuti nel Fondo Pessoa, raccolti sotto il nome di “300”, in cui, come ricorda De Cusatis, il poeta sostiene che l’Europa sarebbe stata governata da trecento uomini i quali “servendosi del «basso giudaismo» («rozzamente materialista, spregevolmente umanitario ed entusiasticamente democratico») cercavano di dominare il mondo, attentando alla «civilizzazione europea» tramite la distruzione dei suoi tre «elementi fondamentali»: «la cultura greca», «l’ordine romano», «la morale cristiana»” (p. 117). Oltretutto, si può supporre che, nel progetto editoriale della Olisipo, il curatore dell’edizione di Protocolli, indicato con le iniziali A. L. R. sia Pessoa stesso, in quanto, come sostiene De Cusatis, le iniziali non corrispondono ad alcuno degli amici – reali o immaginari – del poeta. O almeno, di quelli di cui abbiamo notizia. Non si può non ritenere curioso questo interesse di Pessoa – il quale discendeva da una famiglia di ebrei convertiti – per una questione che, in Europa, si faceva in quegli anni sempre più scottante. Bisogna, tuttavia, tenere conto che il Pessoa che qui consideriamo non è solo il poeta degli eteronimi, ma un attento sociologo, economista e uomo politico, il quale non teme di prendere in considerazione tutti gli aspetti peculiari della sua epoca, anche quelli che noi oggi riteniamo scomodi, trattandoli con acume critico, precisione intellettuale e, talvolta, anche con una non troppo velata ironia. A questo proposito, le note esplicative del curatore non potranno che permettere al lettore di entrare nel merito di determinati argomenti, donando spunti di riflessione e di approfondimento nient’affatto scontati. Oltre a Sull’industria, l’editoria e la pubblicità, il testo è stato suddiviso da De Cusatis in altre due sezioni: Sul commercio, teoria e pratica e Sull’economia: teoria e pratica. Vi è, alla base del discorso sul commercio e sull’economia, una premessa fondamentale: non bisogna mai commettere l’errore di ritenere separate teoria e pratica. “Per un uomo sano di spirito e d’intelligenza equilibrata” questa disgiunzione è “impropria”, in quanto “nella vita superiore la teoria e la pratica si compenetrano” (p. 30). Sembra possibile notare qui una eco della passione esoterica del poeta: se nel mondo del divenire e dell’apparenza esistono due realtà separate e contrapponentisi, ad un piano superiore questa separazione non si dà: esse appariranno, pertanto, come le due metà di un intero. Pratica e teoria sono dunque la medesima cosa; ma allora “la teoria non è altro che una teoria della pratica e la pratica non è altro che la pratica della teoria” (ibidem). Le riflessioni del poeta risultano essere, in questo modo, di una chiarezza teorica cristallina e perfettamente in consonanza con sibilità di separare, l’una dall’altra, tali attività, collocandole in angusti angoli dell’immenso parcheggio esistenziale della vita del poeta” (p. 243). Pessoa passa gli anni dell’adolescenza (dal 1896 al 1905) a Durban, in Sudafrica, dove il patrigno, João Miguel Rosa, era stato nominato console. Qui frequenta la Commercial School, dove ha modo di studiare i pensatori della scuola liberale inglese, quali Adam Smith, Stuart Mill e Herbert Spencer (quest’ultimo, in particolare, influenzerà in modo decisivo le sue teorie) e di studiare quelle dottrine commerciali che, come il lettore apprenderà dagli articoli pubblicati in questo volume, avrà modo di criticare, perfezionare e mettere in pratica nel corso della sua vita. Una volta tornato in Portogallo, il tentativo di portare a termine il corso di laurea in lettere all’università di Lisbona naufragherà. Egli preferirà intraprendere la carriera imprenditoriale: già alla giovanissima età di 19 anni, nel 1907, rileva i macchinari di una ditta di Portalegre con l’intento di fondare una tipografia, che chiamerà Empresa Ibis. Si noti, en passant, il riferimento, certamente non casuale, come sottolinea Margarido nella sua postfazione (p. 246), all’ibis egizio il quale simboleggia il dio Theut, ritenuto, come ci insegna il mito platonico, il padre della scrittura. La Empresa Ibis non avrà però molta fortuna: sarà costretta a chiudere i battenti pochi mesi dopo l’apertura. È da ricordare anche l’esperienza da pubblicista del poeta che, a dire il vero, risulta piuttosto traumatica: tra il 1927 e il 1928, viene incaricato di ideare uno slogan per publicizzare l’esordio della Coca-Cola in Portogallo. Questa la frase da lui ideata che ne sancirà l’indimenticabile incipit: “Primeiro estranhase. Depois entranha-se”, Prima sorprende. Poi si manda giù. Il direttore dell’ufficio della sanità a Lisbona, ritendendo che lo slogan somigliasse troppo alla pubblicizzazione degli effetti di uno stupefacente, ordinerà immediatamente il fermo della distribuzione del prodotto e il suo ritiro dal mercato portoghese. A causa di questo fraintendimento, la Coca-Cola potrà tornare in Portogallo quasi cinquant’anni dopo. Pessoa troverà il suo impiego definitivo come corrispondente in lingue estere presso alcune ditte commerciali, fra le quali la Olisipo Lda (ditta commerciale di Agentes, Organizadores e Editores), fondata proprio dal poeta, insieme all’ingegnere Geraldo Coelho de Jesus e all’amico, scrittore e giornalista Augusto Ferreira Gomes. Nel 1926 è animatore, insieme al cognato Francisco Caetano Dias, della Revista de Comércio e Contabilidade, della quale questo volume raccoglie tutti gli undici articoli scritti da Pessoa. Secondo Margarido, essa rappresenta, “pur avendo avuto vita breve […], ancora oggi in Portogallo uno dei rari momenti di riflessione sistematica consacrata all’organizzazione economica e, in maniera particolare, al suo versante commerciale, seppur non sia trascurato quello industriale” (pp. 231-232). Di vivo interesse è anche la pubblicazione del piano editoriale della Olisipo, il quale contiene una serie di traduzioni di Shakespeare – La Tempesta, Amleto, Re Lear – e di altri scrittori inglesi fra i quali Edgar Allan Poe e Coleridge, tutte a cura di Pessoa stesso, accanto a numerose traduzioni di classici (Eschilo, Saffo, Aristotele) da parte dell’eteronimo Ricardo Reis, alcune poesie dell’eteronimo futurista Álvaro de Campos, le Trovas del Bandarra con commento interpretativo del “più esoterico” degli eteronimi, Rafael Baldaia. Si può facilmente notare come buonissima parte di questo piano editoriale fosse tutto a carico 44 n. 01/2011 che» – che la schiavitù è uno dei fondamenti della vita sociale. E sta ancora in piedi poiché non c’è modo di buttarla giù” (pp. 128-129). Al di là, dunque, di ogni giudizio morale, poiché l’etica è un artefatto che non fa parte di alcuna legge di natura, di per sé spietata. Se è vero ciò che ritiene il poeta, cioè che ogni civilizzazione si basa sul lavoro, allora anche la schiavitù è parte di essa. Emerge, come sostiene Margarido, “non il cinismo della scrittura pessoana, come sarebbe troppo facile e automatico concludere, ma il tentativo di definire, in modo lucido, la brutalità delle situazioni provocate dal binomio civilizzazione/lavoro” (p. 262). Una volta entrati in contatto con il Pessoa economista, sarà ben difficile mantenerne l’immagine classica, ovvero quella di un poeta totalmente estraniato dal mondo che lo circonda. La chiarezza con cui Pessoa tratta certi argomenti ci porterà a comprendere che, come scrive lo studioso citato poc’anzi, “non siamo al cospetto di uno specialista del commercio che a un tempo scrive poesie, ma piuttosto di un poeta geniale in possesso della capacità teorica che gli consente non solo di analizzare i fatti economici ma, soprattutto, di proporre soluzioni a livello nazionale e perfino mondiale” (p. 278). Il poeta portoghese si inscrive, insomma, in quella lunga tradizione di letterati che si occuparono di economia che annovera, come Accame ricorda nel suo Ezra Pound Economista – Contro l’usura (Settimo Sigillo, Roma 1995), intellettuali come Dante, Tasso, Shakespeare e Pound. L’incursione di questi “non addetti ai lavori” può condurre a soluzioni che dovrebbero oggi, in un momento di inaudita crisi economica mondiale, essere perlomeno riprese in considerazione con più serietà di quanto non sia stato fatto fino ad ora. Per concludere, possiamo certamente dire che, dopo la lettura di questo volume, il lettore che ancora non è a conoscenza del Pessoa politico e sociologo non potrà che attendere con estrema curiosità i prossimi volumi in ripubblicazione presso la collana Pessoana delle Edizioni dell’Urogallo: Scritti di sociologia e teoria politica e Politica e profezia. Certi che anch’essi ci procureranno non poche sorprese. Fernando Pessoa, Economia & commercio. Impresa, monopolio e libertà, introduzione, traduzione e note a cura di Brunello De Cusatis. Postfazione di Alfredo Margarido. Nuova versione riveduta, Edizioni dell’Urogallo, Perugia 2010, pp. 286, euro 18. una loro attualizzazione pratica. Di particolare interesse è l’articolo – intitolato, non casualmente Le manette – che analizza le Leggi di Difesa del Regno, promulgate dall’Inghilterra durante la prima guerra mondiale, e il proibizionismo americano. Come scrive Margarido, “assimilando la lezione di Spencer, quella del saggio The man versus State (1884), Pessoa sottolinea la natura dannosa di qualsiasi intervento da parte dello Stato nell’organizzazione economica. Con tali presupoosti risulta chiara la sua fedeltà a una certa concezione del liberalismo economico: l’affidare alle forze del mercato tutto ciò che riguarda il funzionamento regolare delle attività economiche” (p. 257). Con lo humor e l’ironia che lo contraddistinguono, Pessoa ci dà un quadro critico delle leggi proibizioniste, portandole sino all’estremo e mostrando le falle costitutive e i paradossi insiti nei suoi stessi presupposti. La conclusione dell’articolo porta direttamente ad una visione organicista della società: “nessuna legge è benefica se attacca una qualunque classe sociale o ne limita la libertà. Le classi sociali non vivono separate, in compartimenti stagni. Vivono in perpetua interdipendenza, si compenetrano costantemente. Quel che lede una, lede tutte le altre. La legge che attacca una, attacca tutte le altre” (p. 60). Come un corpo umano si mantiene perché ogni organo ha il proprio ruolo, così anche nella società ogni classe deve avere un compito specifico e peculiare, il quale non deve essere modificato da alcuna legge artificiale. È chiaro come questa teoria si basi sul presupposto che la costituzione di una società avvenga, almeno in un primo momento, su basi naturali. Lo scoinvolgimento della classi significherebbe il ribaltamento dell’ordine naturale delle cose. Quando la legge umana si pone contro la naturalità della vita, è destinata a fallire. Pessoa arriva così alla conclusione che anche la schiavitù potrebbe avere un ruolo determinante all’interno della società: “nessuno ha ancora dimostrato, ad esempio, che l’abolizione della schiavitù sia stato un bene sociale. Nessuno l’ha dimostrato perché nessuno lo può dimostrare. Chi ci dice che la schiavitù non sia una legge naturale della vita delle società sane? […] Si può dire che stia ancora in piedi la vecchia affermazione di Aristotele – peraltro così poco propenso a soluzioni «tiranni- “ Una volta considerati gli studi economici di Pessoa, sarà ben difficile mantenerne la classica immagine di poeta totalmente estraniato dal mondo circostante ” 45 n. 01/2011 Francesco Tomatis “Filosofia della Montagna” di Emanuele Guarnieri L lire e ridiscendere gli innumerevoli sentieri montani, è individuata da Francesco Tomatis in Filosofia della Montagna (Bompiani, Milano, 2005). La peculiarità dell’intero libro è dovuta all’analogia che l’autore instaura tra pensiero e cammino: se il primo richiede infatti la fatica e la preparazione necessarie ad una salita in montagna, il secondo ha come esito terminale l’acquisizione di una sapienza sovrumana, vale a dire lo scopo stesso di gran parte della filosofia e della mistica. Tale scelta teorica si ripercuote sulla struttura stessa dei capitoli, che sono infatti costruiti ispirandosi all’intrinseco ritmo, fatto di soste e accelerazioni, che il cammino in montagna deve assumere per essere fecondo: nella trama del testo, estremamente densa e concentrata, Tomatis inserisce infatti frequenti punti di riflessione che permettono al pensiero di cogliere i frutti del proprio sforzo ascensionale. In nove capitoli, nove sentieri ascensivi e discensivi, l’autore tratta numerose tematiche, strettamente connesse fra loro e care alla riflessione filosofica e religiosa, quali “la libertà e il rischio, la pace e il rapporto con gli altri, l’origine del linguaggio e il futuro della vita, il perchè del male e l’esperienza del nulla (eppure anche del divino) tangibile attraverso ogni minima creatura” (p. 11); temi sviluppati mettendo a fuoco aspetti di volta in volta diversi. Precisa Tomatis, nell’introduzione all’opera, che affinchè si compia questo cammino duplice, assieme fisico e mistico-metafisico, occorrerà la pratica di un doppio passo, uno negativo, consistente nella rinuncia, nel fare a meno di ogni superflua strumentazione tecnica, nonché di ogni armamentario concettuale pregresso. Bisogna giungere ad abbandonare perfino il proprio ego ed ogni sua divinità, fino al passo ultimo sulla cima, “punta certissima eppure inspaziale, salda e intangibile, reale ma stupefacentemente immemorabile” (p. 13). Da qui si potrà intraprendere il secondo passo, discensivo e positivo, solare: giungendo alla vetta, si avverte infatti il libero donarsi e montagne sono inafferrabili allo sguardo: è impossibile coglierne un’unica immagine, in grado di mostrarle nella loro totalità. Un’istantanea presa frontalmente impedirà necessariamente infinite altre prospettive, mentre fotografie scattate dall’alto ne appiattiranno la fondamentale tridimensionalità. Essa non può che continuare a sfuggire alla nostra pervicace volontà di conoscenza, opponendo alla sfida della nostra hybris la sua ineffabile e maestosa complessità. Quali soluzioni restano, allora, quali strade percorrere, qualora si voglia disporre delle risorse conoscitive che la montagna può offrire? Come comprendere l’importanza che essa, quale massiccio centrale teoretico, riveste in tutte le culture? Non rimane che accettare con umiltà la nuova posizione nel cosmo in cui il monte, nella sua sublimità, collocherà coloro che vorranno mutare la loro natura per rendersi più simili a chi per millenni ha conosciuto le montagne. Occorrerà, dunque, che ci si faccia alpinisti, disposti a percorrere con fatica i sentieri che la montagna generosamente concede e svela; e se le permetteremo di svolgere un ruolo tanto significativo nel nostro percorso esistenziale, alienandoci positivamente dalla nostra quotidianità, essa sarà in grado di ripagarci ben oltre i nostri sforzi, quale grazia sovraceleste che concede più di quanto prometta, aldilà di ogni possibile umano bene e male. Dalla vetta infatti – e solo dalla vetta – è possibile, come avendo sguardo d’aquila, vedere e reinterpretare la nostra quotidianità sotto una prospettiva superiore e ulteriore. Infine, la cima del monte offrirà l’estrema possibilità contemplativa dell’ intelletto umano: come sommità di quanto è terrestre, punto ultimo di contatto con la dimensione celestiale, è sede privilegiata del palazzo delle divinità, dunque sola posizione dalla quale sia possibile fissare lo sguardo nella Divinità iperuranica, ben al di sopra di qualsiasi dio dell’idolatria umana. Questa modalità, umilmente alpi-mistica e impegnata a sa- 46 n. 01/2011 ti di mostrare quel che la montanità può fare per la nostra civiltà. Anzitutto, però, occorre saper guardare panoramicamente alle città e individuare quali dinamiche abbiano presieduto alla loro istituzione ed al loro sviluppo, e per quali ragioni la nostra prima impressione è quella di “una civiltà abitata da muto dolore anonimo” (p. 158). Occorre dunque ipotizzare quel che successe al tempo del passaggio dal mondo dei cacciatori-raccoglitori a quello delle città. Il mutamento fu drammatico, e caratterizzato dal congelamento del movimento, spirituale oltre che fisico, che contraddistingueva le pratiche di vita nomadica: in particolare, il “libero spirito vocalico e sonoro” (p. 162) dell’oralità venne imprigionato nell’astratta cultura scritta e, ben più gravemente, il cacciatore di animali si fece soggiogatore e sacrificatore di uomini. Tale fu anche l’origine della guerra, dice Tomatis sulla scia dell’autorevole sociologo statunitense Lewis Mumford, ragion per cui “pólis e pólemos, città e guerra vivono, sperabilmente forse anche muoiono, inscindibilmente assieme” (p. 163). Ma la città porta con sé anche un’altra caratteristica, che è forse infine in grado di redimerla. Tale caratteristica va ricercata nell’originario solco (hóros), che nei miti di fondazione delimita la città nascitura. Hóros è infatti etimologicamente connesso con óros, vale a dire montagna: e i teritori montuosi sempre si dimostrarono liberi dall’influenza cittadina, territori inviolati in cui mai si riuscì davvero ad imporre qualsivoglia legalità esterna a quella più antica: “Solo l’uso comune del territorio e la condivisione delle gioie e tristezze della vita ha preso dimora” (p. 164). Se è utopico credere che la semplice contemplazione della naturalità sia da sola in grado di redimere e consolare il dolore delle nostre città, è pur vero però che essa può risvegliare la sete di liberazione dell’uomo contemporaneo. Il giardino celeste che la montagna è, ed il suo tempo extratemporale, governato da leggi proprie, infatti, suscitano e susciteranno per sempre in noi la coscienza di non appartenere a questo presente, suggerendoci piuttosto che la nostra patria spirituale si situa tanto nell’irrecuperabile ed originario Eden, quanto nell’impossibile futura Città di Dio. Francesco Tomatis, Filosofia della Montagna, Bompiani, Milano, 2005, pp. 222, 8,00 euro. di una realtà ulteriore ed ineffabile, trascendente ogni umano desiderio e progetto. Si darà allora, da parte del camminatore, una ridiscesa al mondo simile a quella dell’uomo che, visto il sole, ritorni alla caverna platonica; e si comprenderà il senso del detto eracliteo: ascendere e discendere, in fondo, è il medesimo. Quasi a scopo propedeutico e pedagogico vengono dunque discussi, all’inizio dell’ascesa, i temi intrecciati della rinuncia, della tecnica e del pericolo. Quali accorgimenti occorrerà adottare allorchè si voglia intraprendere il cammino? Tomatis osserva che quanto più si cerchi di neutralizzare ed esorcizzare il pericolo tramite accorgimenti tecnologici, tanto più facilmente esso si abbatterà su chi non abbia imparato ad avvicinare con pazienza il rischio e persino la morte, così come, nella ben nota prospettiva heideggeriana, è necessario progettare la propria esistenza conoscendo il proprio ultimo orizzonte, l’essere-per-la-morte. Lo stile individuato dall’autore è quello denominato alpino, fatto proprio sino alle estreme conseguenze da Reinhold Messner, capace di scalare gli 8848 metri del Monte Everest senza bombole d’ossigeno, contando solo su piccozza e ramponi, tenda, fornelletto e sacco a pelo. Una sobrietà estrema e monacale, insieme alla capacità di convivere con la morte, sono dunque le forze educative che forgiano l’uomo della montagna, che Tomatis vede piuttosto originalmente come un potenziale erede della tramontata cultura classica. La parola cultura deriva infatti da colo, vale a dire letteralmente “coltivare”. E’ infatti dal gesto del contadino di montagna, che con amore cerca di dissodare e rendere fruttifera la sua povera terra, che può nascere, come già nacque, l’uomo classico, integrale, e la sua “cultura durata un momento cronologicamente effimero, eppure eternamente vera” (p. 34). Tale esemplare di umanità si mostra come termine di paragone dell’uomo cittadino e fonte di ispirazione per un differente modello di convivenza. Nelle pagine finali, Tomatis cerca infat- “ Se è utopico credere che la sola contemplazione della natura sia capace di redimere il dolore delle nostre città, essa può PURTUTTAVIA risvegliare la sete di liberazione dell’uomo contemporaneo ” 47 ARRETRATI n. 01/2011 N. 0/2011 H.P. LOVECRAFT Filosofia, creature, misteri e sogni del demiurgo di Providence LIBRERIE FIDUCIARIE TORINO: Libreria Setsu-bun – Via Cernaia, 40/m ✻ Comunardi libreria – Via Bogino, 2 ✻ Libreria Genesi Universitaria – Via Verdi, 39/b ✻ Libreria Stampatori – Via Sant'Ottavio, 15 ✻ Libreria La Bussola – Via Po, 9/B MILANO: Libreria Cortina – L.go Richini, 1 ✻ Spazio Ritter – Via Maiocchi, 28 ✻ Bistrò del tempo ritrovato – Via Foppa, 4 ✻ Fiera del libro – C.so XXII marzo, 23 ROMA: Foro 753 – Via Beverino, 49 ✻ Melbookstore – Via Nazionale, 254 CREMONA: Libreria del convegno – Corso Campi, 72 48 in questo numero: sPIrItUaLItÀ deLLa strada Terra Promessa e Rivoluzione nellÕ esperienza di cammino nel deserto asCesa e asCesI L’alpinismo metafisico di Julius Evola e Domenico Rudatis La montaGna saCra L’alchimia cinematografica di Alejandro Jodorowsky IL CammInare Come Gesto e dIsoBBedIenZa CIvILe Per una filosofia del camminare: da Wordsworth a Tolkien e Thoreau e La verItÀ sI FeCe PIetra La sfida alla modernità in Grido di pietra di Werner Herzog IL «CammIno sPIrItUaLe» neLLa tradIZIone Il valore iniziatico della pratica del camminare strada a senso UnICo, moLte destInaZIonI La vita, la strada, il bivio: il labirinto di Walter Benjamin neL ProssImo nUmero: moderno e antimoderno. articoli su Yukio mishima, Fernando Pessoa, ernst Jünger, rené Guénon e molti altri.
Scarica