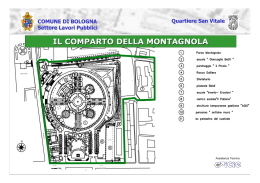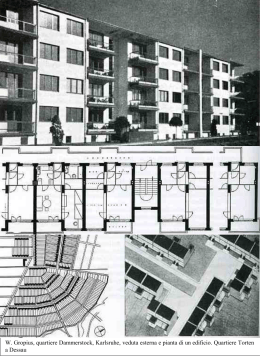Diario d’autore (9) AL CAIRO, TURISTA PER CASO (E PER CURIOSITÀ) Un lungo, prezioso racconto di una visita nella capitale egiziana, che si trasforma anche in un incantato viaggio nelle mille realtà di una megalopoli da 20 milioni di abitanti. Dai grandi alberghi più sfarzosi e spettacolari agli slums più degradati dove vive un popolo-spazzatura la cui realtà supera ogni possibile immaginazione, ai quartieri-suk dove perdersi in una sterminata, caotica rivendita di ogni tipo di merci. Facendo poi diretta esperienza dei complicati, trasversali, ma anche seduttivi rapporti tra gli uomini islamici e una donna occidentale, finendo per ricevere una seria proposta di matrimonio da un aiuto muezzin. _________________________________________________________________________________________ di Simona Cigliana Giugno 2009. Sicuramente già in molti lo hanno notato e scritto – ma è pur vero ed è una tra le prime impressioni che colpisce il viaggiatore che arriva qui: per quanto estesa, il Cairo non è una metropoli, è un agglomerato caotico di tante città che convivono a fianco a fianco, un contenitore di molte etnie che intrecciano scambi, commerci, traffici ma che rimangono sostanzialmente distinte e riconoscibili. Fin dall’aereo, osservandola prendere forma dalle sabbie del deserto, si ravvisano le prime macroscopiche differenze: Moqqatan e le casupole color fango delle vaste periferie senza nome, dove vivono migliaia di reietti che si nutrono di rifiuti; gli enormi palazzoni popolari in cui si ammassano le nuove generazioni di operai, artigiani, piccoli impiegati con le loro debordanti famiglie; il dedalo di stradine del quartiere musulmano, dominato dalle guglie traforate e panciute di innumerevoli moschee; le vie più rettilinee e chiare del quartiere copto; i giardini lussureggianti di alberi flamboyant che circondano le ville eleganti dei quartieri residenziali europei; i grattacieli abbacinanti di marmi e vetrate di Al Azbikya, il centro commerciale, con gli alberghi le cui terrazze offrono allo sguardo dall’alto roof garden, piscine e campi da golf e, di notte, insieme al riconoscibile gioco di luci offerto dalla torre Nasser, una fantasmagoria di insegne rutilanti. Tra un quartiere e l’altro (lo potrò constatare tra breve, percorrendo le sopraelevate della strada che dall’aeroporto conduce in città), estesi agglomerati di case anonime e improbabili, cresciute le une sulle altre e mai finite, distese di abitati che mantengono l’aspetto di ruderi, di stanziamenti provvisori, pieni di buchi e di voragini, rattoppati con lamiere e cartoni, puntellati di assi e svolazzanti di tende, assediati da torme di bambini bianchi di polvere, e sovrastati, sui tetti, dalle baracchette di sudici pollai, dove, sotto il sole implacabile, razzolano galline non più grandi di piccioni. Asse di questo dedalo, centro di questa babele, si snoda pigro in ampie anse il vecchio padre Nilo. Vedere per la prima volta dal cielo le sue acque fangose, alle quali si sono abbeverate le più antiche culture e almeno due grandi civiltà, l’egiziana e l’ebraica, mi suscita una grande emozione, che cresce quando il velivolo, prima di imboccare la dirittura di arrivo, si inclina sulle ali e, in una prospettiva sbieca e capovolta rispetto all’orizzonte, inquadra nei finestrini la sagoma delle piramidi, le loro facce triangolari colpite con diversa luminosità dal sole basso. Allora, ecco l’intermittenza del cuore: quel lieve capogiro che si accompagna alla intuizione dei secoli e dei millenni che si sono sgretolati su queste pietre. 1 Il tumulto che ci accoglie all’aeroporto non appena lasciamo l’asettica accoglienza delle sale di sbarco internazionale, ci conferma nelle precedenti impressioni. Una calca di uomini diversamente abbigliati si affolla agli sportelli dei visti e delle tasse d’ingresso, di fronte a funzionari sudati che esaminano a capriccio i documenti. Borse, valigie, buste, masserizie e bambini restano affidati alle donne. Ve ne sono di interamente velate, racchiuse nei loro burka funerei e anche di quelle vestite all’europea, con tailleur e camicette dal taglio un po’ severo. Quasi tutte hanno i capelli nascosti sotto ampi foulard: chador nero per le oltranziste, colorato fin nei toni più sgargianti per le più emancipate e civettuole. Le ragazze indossano i pantaloni – ma sotto ampie casacche che ingoffano la figura fino alle anche. Qualcuna osa T-shirt a maniche corte e un accenno di scollo: ma salva la creanza indossandole sopra aderenti maglie color carne, che coprono tutte le braccia. Non si pensi tutavia che le integraliste rinuncino per obbligo di fede alla armi della seduzione: un poco in disparte, isolata nella sua conturbante bellezza, una giovane donna si guarda attorno nerovestita, spandendo inquietudine: gli abiti che la avvolgono dalla testa ai piedi, foulard e guanti compresi, sono vistosamente istoriati d’argento, e i suoi occhi febbricitanti, sottolineati dal kajal, spiccano nell’ovale del volto, il cui pallore è messo in risalto dalle pieghe del tessuto scuro, che le fascia il capo con arte sapiente. Attorno a lei, costose valigie scarlatte e una cornice di vuoto: nessuno la guarda; nessuno oserebbe farlo. Ma si percepisce che i cuori di tutti i maschi presenti le palpitano attorno, guardinghi, come uno stormo di uccelli spaventati e prigionieri. Si ha da subito l’impressione che questi uomini, i quali castigano quotidianamente le proprie donne, temano soprattutto il loro stesso desiderio, che siano tanto più arcigni quanto più ne sentono l’urgenza, appassionati e crudeli come tanti adolescenti. Anche il loro modo di cercare la compagnia o l’amicizia di una donna straniera è tinto di una specie di soave imbarazzo e orchestrato come una pantomima amorosa che ricalca i rituali delle Mille e una notte. Le occidentali, in questa caotica città che a certe ore sembra popolata di soli maschi, non devono temere aggressioni, a meno che non si caccino in situazioni rischiose, che il semplice buon senso sconsiglia. Tuttavia, sono esposte, loro sì, agli sguardi e all’aperto corteggiamento degli uomini. Se non fosse perché costituisce il rischio di un intralcio continuo al libero andare e venire, non sarebbe affatto sgradevole. A differenza dei nostri latin lover di lontana memoria, spesso cafoni nelle loro avances verso le donne del nord, i giovani levantini spiegano infatti nei tentativi di rimorchio delle belle infedeli tesori di tatto, tenerezza, sapienza e seduzione. La turista che non inalberi segni di riconoscimento che la iscrivano tra le seguaci di Allah, può essere legittimamente guardata: e loro sgranano i loro grandi occhi sentimentali, neri di pece. La avvicinano in modo discreto, cogliendo il minimo pretesto. Sanno conversare in inglese, e con garbo si informano: Sei sposata? Quanti figli hai? Perché tuo marito non è con te? Siete felici? Che lavoro fai? Lavora molto tuo marito? Perché avete solo due figli? A che età ti sei sposata? – e possono andare avanti per ore. Non si lasciano seminare: sono così compiti, cortesi, premurosi; si prestano a far da guida, da interpreti, da accompagnatori nei musei, nelle moschee, nell’intrico delle strade e delle lingue. Ti mostrano le vie più suggestive che il baedecker ha tralasciato di illustrare, ti suggeriscono i migliori rivenditori di spezie e di tessuti, mercanteggiano per te. Infine, vedendoti stanca, ti conducono verso il caffè o il ristorante più affidabile e più a buon mercato: tu entri, ordini, consumi, pensi a loro come ad una simpatica storiella di viaggio già conclusa. Ma quando esci sono ancora lì, con l’aria di volerti fare una sorpresa, pronti a raccontare una infinità di storie, di cronache cittadine e di aneddoti locali, prestandosi a fare i pagliacci pur di farti ridere. Poi, a poco a poco, sembrano immalinconirsi, cominciano a sospirare e si fanno cupi. Chiedono a un passante di scattarvi una fotografia, si mettono al tuo fianco e ti appoggiano sulla spalla una mano leggera, un po’ esitante, come quella di un ragazzo al primo appuntamento: e mentre siete in posa, quella mano cerca un ubi consistam, scende verso il 2 braccio, tenta, nei brevissimi attimi dell’inquadratura, di cingerti, leggerissima, la vita: niente che non sia corretto. Quando non trovano proprio più alcuno stratagemma per non doversi allontanare, prima della separazione, comprano una cartolina, un gingillo, e ti pregano di conservarlo come loro ricordo; in cambio vogliono qualcosa di te, da portare via: l’accendino bic, il fazzoletto, un pacchetto di caramelle, non importa. Ti danno il loro numero di cellulare, dicono di essersi innamorati; ti chiedono un appuntamento, ma senza neanche aspettarsi che tu glielo conceda. C’è ancora qualche risata, uno scambio di battute sulla porta del taxi, il tuo sorriso un po’ condiscendente mentre pensi di saperla lunga e pregusti il momento in cui racconterai la tua piccola avventura alle amiche. Ma quando il saluto diventa definitivo, è incredibile: sembrano diventare davvero pallidi e ti guardano andare via come se tu portassi con te un pezzo della loro esistenza, un poco delle loro speranze, del loro sogno di poter vivere un’altra vita. Perché le prospettive che si intravedono da questo angolo di mondo e che si intersecano dando le vertigini sono tante, troppe forse, e si estendono dal più lontano passato verso un iperbolico futuro, toccando in entrambi i sensi gli estremi della ricchezza e della povertà. Ci sono da una parte gli arredi funebri di Tutank-Amon: immensi saloni di oro e lapislazzuli, sarcofaghi e maschere, pettorali e diademi, e bracciali, pendenti, collane, anelli, decine di letti funebri, di lettighe, di scranni e troni di splendida fattura e di incommensurabile valore; vetrine che espongono schiere di schiavi e servi e concubine e guerrieri di terracotta destinati a servire fin nell’oltretomba il signore che rappresentava Ra, il figlio di dio in terra. Dall’altra, imperversano oggi i nuovi faraoni, discesi dal cielo con le loro macchine volanti, che si aggirano invisibili da un resort all’altro, chiusi nelle loro chilometriche vetture superlusso dai vetri oscurati, seguiti da un corteo di auto che trasporta decine di mogli e figli e servitori. Per loro, e per i ricchi stranieri che spesso giungono ad Alessandria sui loro panfili, sorgono residenze come l’Oberoi Mena House, costruito dal 1869 dal Kedivé Ismail a poca distanza dal sito in cui Cheope, Chefren e Micerino edificarono qualche millennio prima la loro casa dell’eternità. Splendido trionfo di architettura ottomana, con arredi in legno intagliato e madreperla, soffitti in marmo lavorato a nicchie e a cassettoni, tappezzerie pregiate, soprammobili di antiquariato e spazi dimensionati su una dimora principesca, l’Oberoi Mena House vanta cinque ristoranti, tra cui l’esotico Moghul Room, considerato uno dei migliori ristoranti indiani al mondo, numerosi bar, due campi da tennis, uno splendido parco-giardino con un campo da golf a 18 buche e una piscina che sembra un lago, in cui si rispecchiano piramidi e palmizi. Gli sceicchi degli emirati, quando vengono qui con la numerosa famiglia a fare spese, prenotano di solito più di una suite deluxe, preferendo quelle dove soggiornarono Churchill e Montgomery; ma nell’ala meno nobile dell’edificio, quella più moderna, da cui non si gode la vista delle piramidi, si trovano belle stanze a meno di 200 euro a notte, che sono prese d’assalto dai commenda del varesotto. Alcuni turisti, in piccolissima scolta silenziosa, visitano l’hotel come un museo (e lo merita) e dopo il breve tour consentito agli estranei si siedono sotto l’ampia volta del Mamlouk Bar a piano terra, e ordinano quawa con kahk (caffè e pasticcini), ammirando lo sfarzo sofisticato della hall e la magnificenza del lampadario di ottone, le cui dimensioni superano certamente quelle della sala da pranzo della maggior parte dei mortali. Ma se il viaggiatore ama lo stile moderno, potrebbe forse preferire il Grande Hyatt, smisurato grattacielo sulle rive del Nilo, sull’isola di Roda, che rispecchia perfettamente lo spirito di questa capitale dove passato e futuro si sovrappongono di continuo creando stridenti contrasti. L’ingresso del Grande Hyatt è spettacolare, fiancheggiato da enormi colonne di marmo nero ed oro. Superata la vetrata che introduce nella hall, ci si trova come sull’orlo di una caverna artificiale che sprofonda 3 verso il basso: si scendono scale di cristallo e, nella luce soffusa, si intravedono fontane, bacini d’acqua, pesci tropicali che nuotano dietro invisibili pareti; si oltrepassa una rotonda sospesa nel vuoto, da cui un pianista diffonde jazz sincopato, si scende ancora attraversando su vari livelli balconate, salottini, privé, salette nascoste da discreti paraventi, e si plana infine su una piattaforma che si sporge, all’aperto, sulla riva del Nilo. Qui si può cenare nel Nubia Village, uno dei dieci ristoranti, ciascuno caratterizzato da una diversa cucina tipica, che l’hotel offre ai clienti. I camerieri, solo uomini, sembrano essere stati scelti in base alla loro avvenenza: sono tutti splendidi ragazzi, che indossano farsetto e fez cremisi sui candidi burnus. Invitati per un pranzo ufficiale, ci accomodiamo sulla terrazza che sovrasta di pochi metri la corrente, illuminata dalle torce e dai riflessi confusi e cangianti delle acque. Soffia una leggera brezza e davanti a noi si stende, nella luce del tramonto, lo skyline della metropoli: grattacieli e minareti, piramidi e ripetitori satellitari. Il fiume è solcato da giunche e caicchi, dove cenano, a coppie o a piccoli gruppi, turisti e famigliole di cairoti abbienti che per una sera possono permettersi di affittare imbarcazione e staff di cuoco-cameriere-marinaio. Un servizio del genere è offerto anche dal nostro hotel: uno dei suoi ristoranti, il Baccarat, situato sul Marquise Grand Hyatt Cairo’s Private Yacht, propone suggestive crociere serali con raffinato menu in stile etnico. Noi ci accontentiamo della terrazza sul Nilo: e mentre una orchestrina di suonatori in costume intona le nenie del deserto, mentre tre donne berbere accucciate a terra a poca distanza da noi impastano su grandi assi e cuociono negli sferici forni di terracotta le focacce di pane, osserviamo la bella gioventù che ci circonda. Evidentemente i cairoti-bene usano incontrarsi qui: ragazzi e ragazze conversano in un’atmosfera allegra e rilassata, sorseggiando coca cola e aranciate, perché gli alcolici sono rigorosamente vietati. La cena è un trionfo di sapori delicati e di profumi, e quando cala definitivamente l’oscurità e l’acqua comincia a baluginare di mille luci riflesse, ci sentiamo quasi un po’ ebbri, come se avessimo bevuto champagne. Eppure, soltanto stamattina, grazie all’aiuto e all’intercessione di un sacerdote comboniano, abbiamo conosciuto l’altro volto della megalopoli: l’inferno di spazzatura degli zabbaleen, i raccoglitori di rifiuti che vivono nel quartiere Mansheya, schiacciato tra le colline di Moqqattam, che segnano il limite della periferia del Cairo, e la Cittadella, il cuore islamico della capitale. La realtà degli abitanti della Città dei morti, dove migliaia di senzatetto vivono a fianco dei cadaveri nei mausolei delle famiglie ricche, un po’ custodi, un po’ becchini, è senza dubbio raccapriciante: ma è già una condizione più umana, nella sua abiezione, di quella del popolo-immondizia di Mansheya, il cui degrado sociale sorpassa ogni immaginazione. Nella Città dei Morti, una delle più estese necropoli del mondo, che si estende per chilometri quadrati, vi sono i piccoli catafalchi di pietra della gente semplice e mausolei grandiosi, dove riposano emiri e sultani, vegliati oggi, secondo un rituale ereditato dai faraoni, da coloro che in vita non hanno i mezzi per permettersi una vera casa. Gli inquilini di queste ville funebri e lussuose, che vivono nel silenzio e nella marmorea bellezza del sito, godono a modo loro di una condizione privilegiata rispetto agli abitanti dei quartieri sovrappopolati di Imbaba o di Shubra e sono mille volte più fortunati degli abitanti di Mansheya. A Mansheya vivono circa 60mila persone, quasi tutte emigrate dai villaggi dell’Alto Egitto, poveri fellah giunti fin qui seguendo il miraggio della capitale. Le strade sono sterrate, coperte di fango, di liquidi organici, di uno strato compatto di rifiuti putrescenti che oltrepassa la soglia delle abitazioni e si accumula in montagne inimmaginabili fin dentro le case, asfissianti cubi di cemento grezzo con un paio di aperture al posto di porte e finestre. In questo sobborgo, arrivano circa mille tonnellate di spazzatura ogni anno, raccolte dagli uomini e dai ragazzi dagli immondezzai cittadini e trasportate qui su muli e scassatissimi carretti. Per tutta la giornata, giorno dopo giorno, questa gente, comprese le donne, anche incinte, i bambini, anche piccolissimi, e gli anziani, smista i rifiuti del mondo civilizzato, a contatto con germi, gas, 4 sostanze tossiche, lamiere, acidi. Nei vicoli, nei cortili, ovunque, in mezzo ad un odore nauseabondo, esseri umani come me e come voi, separano per ore e ore carta, plastica, vetro, ferro, alluminio e residui organici, particolarmente ambiti perché il concime è molto richiesto, e li stipano dentro enormi sacchi di iuta che poi vengono rivenduti ai grossisti. «È il nostro oro», dicono qui, consapevoli del fatto che al Cairo, incredibile ma vero, ci sono se possibile quartieri ancora più poveri, che non possono neanche contare sull’«oro» della spazzatura, come ad esempio la baraccopoli di Duwe’a, poco distante da qui, senza acqua né corrente elettrica. Ma i poveri di Duwe’a sono islamici, e godono di una loro forma di miserabile dignità. Qui, a Mansheya, sono al 90 per cento cristiani copti, «trash people» in tutti i sensi. E rivendicano la loro religione e il loro status: la spazzatura è il loro business, che permette, quando va bene, di stare sopra la soglia di povertà, di guadagnare tra le 300-400 lire egiziane, circa 50 euro al mese. E poi, dicono gli zabbaleen, cercare tra la spazzatura è come fare i cercatori d’oro: si narra di incredibili ritrovamenti, come quello dell’inestimabile diamante del Topkapi, 86 carati di luce purissima, rinvenuto da uno spazzino in un bidone di immondizia. Certo sono casi rarissimi e non sempre fanno la fortuna del cercatore. L’uomo che trovò il Topkapi, credendolo solo un bel pezzo di vetro, lo scambiò con due cucchiai, con i quali avrebbe potuto finalmente mangiare in maniera decente la sua zuppa: il volere di Allah è imperscrutabile, sia fatta la Sua volontà. Però una moneta in fondo ad una tasca, una posata d’argento, perfino un cellulare vecchio possono rappresentare un mese di relativo benessere. Ne consegue che gli abitanti di qui hanno sempre rifiutato di andarsene e si sono opposti ad ogni bonifica del quartiere. Vivono da paria, tollerati dalle autorità cairote, le quali sono ben consapevoli che, se si affidassero solo all’azienda comunale di smaltimento, non riuscirebbero mai a far fronte a una città di 20 milioni di abitanti. Per il Cairo, il quartiere rappresenta una risorsa, che ricicla manualmente il 90 per cento dei rifiuti della città, mentre le compagnie industriali, con tutti i loro mezzi meccanici, arrivano sì e no al 60 per cento. Forse anche per questo il governo ha creato tanti ostacoli a Luciano Verdoscia e a tutti i padri comboniani, che, come lui, cercano da anni di portare un aiuto ai «più poveri tra i poveri». Li accusano di voler fare proselitismo cristiano e intralciano costantemente ogni loro tentativo di aprire scuole e ambulatori. Temono di vedervi accorrere anche una parte di musulmani e di dover assistere alla loro trasformazione in marrani. Il nostro albergo, pur non essendo lussuoso come quelli sopra descritti, sorge a Gezira, sull’altra isola del Nilo cairota, nel cuore di Zamalek, il quartiere diplomatico, delle ambasciate e dei centri culturali stranieri. Si chiama Flamenco e curiosamente inalbera come insegna una danzatrice spagnola, con tanto di mantilla e gonna a balze. Dalla mia finestra al secondo piano intravedo una strada sconnessa e polverosa, ingombra di una lunga fila di taxi in attesa e le stanze di un Internet point che occupa tutto un piano dello stabile di fronte. Le sue vetrate sono sempre illuminate: giorno e notte ai minuscoli tavoli si assiepano, anche a tre e a quattro, uomini di tutte le età – ma soprattutto giovani. Assetati di immagini e di notizie sull’altrove, si sporgono da questa finestra per spiare la vita del mondo occidentale. Condannano i nostri costumi, la nostra way of life, le nostre donne – ma si nutrono dei nostri stessi miti: il benessere, il progresso, il guadagno, il sesso facile, ingigantendoli attraverso il filtro del senso di colpa che l’islam più bacchettone inocula in loro fin dalla nascita. Sereni, fatalisti e cordiali negli incontri casuali al caffè, nei taxi, per le strade, assumono di fronte allo schermo un’aria infelice e malata, intenta, quasi feroce. Li vedi come loro non possono vedersi: prede fin troppo facili di un sistema molto più viziato e perverso di quanto non possano immaginare, pronti a farsi illudere, a prendere un aereo, una nave, un mezzo qualsiasi e a catapultarsi verso l’ignoto per tentare la grande avventura. 5 Gli amici del Centro Culturale Italiano del Cairo ci accompagnano oggi in visita al quartiere di Shari Es Siyufiyah, che sorge alla fine di el Azam, la strada che anticamente portava dalla città fatimida di el Kahira alla moschea di Ibn Tulun ed al Fustad, area dove sorse, attorno al 641 d.C. il primo insediamento urbano del Cairo. Ora la zona, ai piedi della Cittadella, è inglobata dalla capitale moderna e ne rappresenta il cuore più antico e affascinante. Proprio qui, la cooperazione italoegiziana, capitanata dal prof. Giuseppe Fanfoni, è riuscita a condurre a buon fine l’opera di restauro della Sama ‘Khana dei Dervisci Mevlevi, un particolare edificio a impianto teatrale dove i mistici danzanti cadevano roteando in estasi per l’edificazione del pubblico dei notabili ottomani. Il complesso della Sama ‘Khana, sorto sulla base di una più antica madrasa (scuola coranica), comprende, per averli incorporati nel corso del tempo, il mausoleo di Sunqur Sa’di e l’enorme palazzo dell’emiro Yasbak, più, naturalmente, il convento e il vero e proprio “Teatro dei Dervisci”, costruiti probabilmente nella prima metà del Seicento, qualche tempo dopo la conquista ottomana dell’Egitto. La confraternita islamica dei Mevlevi, originaria di Konia, in Turchia, godette di particolare considerazione nell’ambito dello stato religioso ottomano, poiché al capo dell’ordine era conferito il privilegio di sancire l’investitura del sultano. Anche per questo, oltre che per il fascino esercitato dalla loro cultura musicale e dal significato religioso e filosofico della loro danza mistica, i Mavlevi attrassero tra le loro fila facoltose personalità, che contribuirono con cospicue donazioni alla costruzione della Sama’Khana, la quale raggiunse, alla fine del Settecento, il massimo del suo splendore. Splendore al quale oggi è davvero tornata, dopo un decennio di pazienti restauri che hanno condotto anche ad importanti ritrovamenti. Nuovi dervisci torneranno ad esibirsi sulla pista circolare, sotto le lucenti travature di legno di cedro intarsiato, a beneficio dei turisti e della confraternita, che potrà così raccogliere fondi per la propria sopravvivenza. Uomini – e donne confinate dietro i florilegi delle fitte gelosie – occuperanno ancora le balconate istoriate, seduti nella penombra raccolta della cupola ottagonale, per osservare i corpi magri ed eleganti, i volti barbuti dagli occhi sempre serrati dei sufi. E quando le gonne dei dervisci, allargandosi come corolle, riempiranno di cerchi ondeggianti la pista, anche loro si sentiranno turbati dalla potente corrente di energia che si sprigiona dalla danza e che, per pura forza di fede, trasforma l’impeto orgiastico in contemplazione estatica. La ripetizione del nome di dio e l’intercessione della scala musicale compiono il miracolo dell’ascensione nell’uomo che si abbandona senza riserve alla vertigine del movimento. E tuttavia questa danza rimane un rito primitivo, che mette in gioco forze ancestrali; una liturgia sensuale che sfida la castigatezza delle tonache, talmente intimo nella sua spettacolarità che sembra blasfemo poterlo celebrare in pubblico. Ma il derviscio che danza insieme ai suoi confratelli è un solo corpo con loro, cancella il proprio io nella trance e si sprofonda nella preghiera. Lo scandalo della sua innocenza è in quel momento pura testimonianza della sua fede in Allah. Alle undici, Silvia Contarini ed io salutiamo Francesca Corrao – che ci è stata in questi giorni guida e interprete di lingua e di cultura – e Remo Ceserani – inesauribile conversatore e impareggiabile compagno di vagabondaggi notturni – e proseguiamo alla scoperta della città islamica, dirigendoci verso el Azam. Qualche giorno fa, abbiamo esplorato Misr el-Qadima, il quartiere copto. Eravamo al Cairo da poche ore e pensavamo di trovare laggiù un ambiente più famigliare, da cui apprendere usi quotidiani, regole di comportamento spicciolo, codici e sottocodici che ci avrebbero introdotto in maniera soft nel vivo della vita cittadina. Non era andata proprio così. Benché prima di uscire avessimo curato con particolare scrupolo l’abbigliamento, qualche nota stonata richiamava inesorabilmente l’attenzione su di noi. C’erano prima di tutto i capelli di Silvia, una massa di riccioli frisé che lei, per non dare scandalo, aveva legata con un nastro: la sua voluminosa coda suscitava però un generale fastidio, soprattutto tra le donne anziane, e più di una volta gruppi di monelli aveva cercato di tirarle una ciocca. Anche nel mio abito c’era qualcosa che non andava: il mio lungo e largo vestito di tela verde scuro, con le mezze maniche e un accenno (veramente un accenno) di scollatura 6 riscuoteva riprovazione, e contribuiva a creare attorno a noi un’atmosfera di ostilità. Ne avevo avuta la prova al ritorno, quando, terminate le visite al Convento di san Giorgio e alla sinagoga di Ben Ezra, alla fine della via attorno alla quale sorge la maggior parte delle attrazioni turistiche, trovataci la strada sbarrata da un posto di blocco che impediva ai visitatori (o a noi in particolare?) l’accesso al cuore del quartiere, avevamo preso, sole europee, la metropolitana, per dirigerci, seccate e un po’ turbate, verso mete più distensive. Allora, un giovane uomo, scambiandomi a causa dell’ampio vestito per una donna incinta, mi aveva ceduto il suo posto a sedere accanto alla compagna, un’esile ragazzina infoulardata e intenta a intrattenere un pargoletto vivacissimo. Il ragazzo si era quindi sistemato in piedi di fronte a noi, attaccato al corrimano. Ben presto aveva cominciato però a dare segni di disagio. Infine, con il tono di chi si sente addolorato e offeso nei sentimenti, aveva accennato, gentile ma fermo, al girocollo del mio vestito, che, scostatosi un pochettino, lo tentava a lanciare occhiate nel cupo. Quando, strettami con una mano l’abbottonatura, mi ero guardata attorno, avevo colto nella gente – che aveva seguito con partecipazione la scena – una espressione di vero sollievo. Era dunque con una certa prevenzione e con tutt’altro abbigliamento (pantaloni, larghe bluse e scialle a portata di mano) che ci accingevamo ora a visitare la parte islamica del Cairo, che si stende tra le due porte monumentali di Bab Zuweila e di Bab-el-Futuh, davanti alla quale si apre Muizz el-Din Allah, la via che, fiancheggiata da magnifici monumenti, costeggiando per un tratto la Beit el-Suhaym, antica dimora di uno sceicco del tempo dei Mamelucchi, porta alla moschea el-Alqmar e alla madrasa del sultano Barkuk. Dirette verso el Azam, ci siamo inoltrate senza pensarci troppo e con l’intenzione di comprare un po’ di frutta in un popoloso vicolo ingombro di derrate ortofrutticole. Si era fatto ormai quasi mezzogiorno: non lo sapevamo, ma stavamo per entrare nello sterminato suk di Khan el Khalini, da cui non saremmo riuscite ad uscire che molte ore dopo, a tarda sera. Khan el Khalini è un intero, affollato quartiere consacrato ai commerci e ai traffici, che comprende numerosi isolati di mercati grossolanamente distinguibili secondo le diverse categorie merceologiche. C’è il settore in cui si vendono principalmente cibo e alimenti (per uomini e per animali), che si snoda in strade, vicoli e cunicoli dove si assembrano gli spacci di carni e le macellerie, equine ed ovine; i forni del pane e le pasticcerie; i venditori di uova e latticini; i rivenduglioli di ortaggi e di legumi e i negozianti di bevande. C’è il settore delle merci che una volta si chiamavano “coloniali”, dove si trovano le botteghe delle resine e degli incensi; i trafficanti di spezie e di profumi; i depositi di cere e di saponi. Il bazar del tessile si distribuisce nel dedalo delle rivendite di filati e di stoffe; nei negozi di biancheria e di tessuti; nelle mercerie e negli empori di abbigliamento; nei magazzini di tappezzerie e di tende; nei fondachi degli arazzi e dei tappeti. E poi le vie degli artigiani, dei falegnami e dei fabbri; le strade di libri, manoscritti, stampe e pergamene; gli anditi del bric-à-brac, del piccolo antiquariato, dei rivenditori di cose vecchie e di seconda mano. E così via, fino al mercato degli orefici, che riluce di argenti, ori e pietre per tutte le brame e per tutte le tasche, dove si contratta fino all’esaurimento e chi compra deve sedurre il negoziante non meno di quanto il venditore riesca ad abbagliare l’acquirente. Man mano che ci addentriamo in questo sterminato cafarnao, timore e diffidenza cedono il passo all’entusiasmo; presto possiamo verificare sino a che punto lo spirito pratico del mercante sia un ottimo antidoto contro fanatismi e preclusioni di principio. Ovunque troviamo buona accoglienza e, con pochissime eccezioni, atteggiamenti rilassati e cordiali. È così anche nella zona meno turistica e più povera del suk, dove si cammina su un impiantito di fango e terra battuta, tra rivoli di sangue e sterco di animali, e dove ci si imbatte in cenciosi offerenti che tentano di smerciare risibili merci (quattro porri, poche uova esposte su un fazzoletto), negli ambulanti che spacciano mele sbucciate a spicchi e ciambelle al sesamo esibite in schidionata sui bastoni, e nell’uomo con la bilancia, che, per una monetina, presta il suo pesapersone al passante. 7 Divertite dalla varietà e dalla ressa, esaminiamo sconosciute mercanzie, chiacchierando e scambiando opinioni in un imbastarditissimo ed estemporaneo esperanto fatto di molte lingue e tanta buona volontà di comprendersi; prendiamo un infuso alla menta sotto la tettoia di un caffè frequentato soltanto da locali: e ce lo offrono, senza sovrapprezzo, nelle “tazze buone” ben diverse dai bicchieri un po’ sbreccati da cui lo sorbiscono gli altri avventori. Quando abbiamo bisogno di una toilette, e non ce ne sono vicine, ci propongono semplicemente di servirci di quella loro privata: una dubbia latrina che serve almeno tre famiglie… Insomma, rassicurata dal clima disteso, mi risolvo a mettermi in cerca delle due cose che mi sono ripromessa di portare a casa dall’Egitto: mutande e asciugamani da hammam. Prego il lettore di non ridere, perché non c’è in questo niente di strano: in Turchia, che è il Paese medio orientale dove ho più viaggiato, i tessuti e la biancheria di cotone sono di ottima qualità. Nella mia idea, l’Egitto, che è il maggior produttore di cotone del Mediterraneo, avrebbe dovuto offrire a questo proposito il meglio. Mi sbagliavo. Per ciò che riguarda il primo articolo (mutande) non se ne vendono né di bianche né di nere, ma solo a fiorellini, quadratini, pupazzetti; rosate, celestine e gialline; molli, informi e decisamente oversize: tanto che mi sono fatta l’idea che tra la mutanda ascellare e monachesca e il tanga peccaminoso tutto pizzi e lustrini, griffato dai produttori francesi di lingerie, non trovi luogo in Egitto alcuna via di mezzo; e anche questo mi sembra rappresentare in fondo una riprova della polarizzazione socio religiosa della maggioranza di questo Paese. Per ciò che riguarda gli asciugamani da hammam, quei teli che si usano nei bagni turchi per cingersi le reni durante il bagno di vapore, che sono leggeri e consistenti, prendono poco posto in valigia perché arrotolati hanno sì è no le dimensioni di una bottiglietta d’acqua da mezzolitro ma sono molto meno pesanti; che asciugano senza lasciare pelucchi, seccano all’aria in un baleno, costano due soldi e sono anche molto belli... ebbene per gli asciugamani da hammam la cosa si rivelava un po’ complicata: i negozianti sembravano non comprendere, tiravano fuori grandi lenzuoli di spugna e, alle mie insistenze, cominciavano a mostrarsi infastiditi o a nominare strade ed indirizzi con aria imbarazzata. Mentre, aiutata da Silvia, cercavo di spiegare all’ennesimo mercante che cosa davvero desiderassi, passando dall’italiano, all’inglese, al francese, ecco fermarsi vicino a noi un cortese omettino, abbigliato all’europea, con un’aria da banlieu parigina e due simpatici baffetti all’Arsenio Lupin, che, in un francese fluente e con fare da uomo di mondo, ci offre i suoi servigi di interprete quale insegnante arabo di madrelingua in Francia, rientrato pro tempore in patria. È proprio lui, Aziz, a spiegarci l’arcano: in Egitto, gli hammam sono caduti in disuso. Queste isole di igiene e di benessere, sollievo alla calura e alla fatica, rifugio per uomini estenuati da plurime mogli e numerosi figli – ma soprattutto per tante donne che se ne servivano come di salone di bellezza, parrucchiere, sala da thè – sono stati abbandonati tutti o quasi ormai da tempo: quelli che sopravvivono sono diventati e sono considerati luoghi equivoci, dove una donna perbene non si sognerebbe mai di entrare, la cui frequentazione è caldamente sconsigliata anche ad ogni buon credente. Non sono una esperta di culture arabe ma mi sembra un vero peccato, anzi: una perdita culturale di proporzioni epocali. Gli hammam, infatti, solitamente aperti a uomini e donne a giorni alterni, svolgevano in seno a queste società una funzione importantissima, per gli uomini, certo, ma soprattutto per le donne. Nelle sue sale calde e nebbiose, tra una secchiata di acqua gelida e un’altra, giovani, vecchie e bambine usavano da secoli prendersi cura di se stesse, corpo e spirito: usavano sottoporsi a massaggi e a depilazioni, tingersi i capelli e disegnarsi mani e piedi con l’hennè, ma anche chiacchierare, suonare, cantare in a solo e in coro, bere e mangiare, intrecciare amori, festeggiare ricorrenze e matrimoni, lontane dai mariti, dai padri, dai figli e dai fratelli – insomma da tutti quelli che esercitano autorità su di loro –, narrandosi storie private e vicende collettive, trasmettendosi l’un l’altra, nell’intimità dei volti e dei corpi senza veli, usanze, segreti, tradizioni. Insomma, l’hammam ha rappresentato nel medio oriente mediterraneo il salotto semiprivato di cui le donne, generazione dopo generazione, si sono servite per edificare e mantenere spazi di dignità, serenità, separatezza, per 8 salvaguardare la propria identità e coltivare la complicità con altre donne. Ma ad un certo punto, non saprei dire la data precisa, le grandi aule degli hammam del Cairo, preziose di marmi e di stucchi, sono state abbandonate: silenziose e deserte, hanno cominciato a essere frequentate da bande di teppisti, di malavitosi e di topi. Se ne vedono i ruderi qua e là nel tessuto urbano, per lo più mucchi di rovine che solo recentemente cominciano ad essere restaurate a fini museali. Sono lontani i tempi in cui i sultani legavano la loro fama di buoni regnanti, devoti all’Altissimo, non solo facendo a gara nel costruire le più splendide moschee, ma nel provvederle di scuola coranica, di mensa per i poveri, di ospizio per gli orfani, di bagni pubblici e di hammam, e nel fornirle anche di una ricca dote che avrebbe assicurato nel tempo il funzionamento di questi complessi, per il bene dei sudditi, a lode e gloria di Allah. Ma Aziz continua a cicalare, disinvolto e mondano, ostentando la sua conoscenza della lingua e della cultura francese. Vorremmo liberarci dalle maglie della sua premurosa gentilezza ma ci accorgiamo che nell’ansia di esserci utile, fiero di mostrarsi in compagnia di due straniere, ci guida negli angoli più antichi e remoti del suk, dove, a case fatiscenti e a caterve di mercanzie versicolori, si alternano caravanserragli, vecchie moschee, fontane di marmo rabescato, archi, tracce di arcaiche fortificazioni. Quaggiù, dove le vie sono particolarmente anguste e riparate dal poco sole che vi penetra da ampie tende aperte a fare cielo, quasi dimentichiamo la calura che incombe sulla città. Di fronte alla nostra meraviglia, Aziz sprizza soddisfazione da tutti i pori, si capisce che il suo cervello gira vorticosamente per trovare luoghi e situazioni interessanti per noi. Ci conduce da certi suoi conoscenti per l’acquisto di zafferano e pepe, ci consiglia di assaggiare un doner kebab in un oscuro bugigattolo dove non saremmo mai entrate (delizioso!) e quando gli proponiamo di bere qualcosa insieme, dopo il quale dovremmo proprio lasciarci, perché – gli diciamo- siamo attese altrove, ci porta in un smisurato caffè piastrellato di mattonelle cilestrine e completamente aperto sulla strada, dove, tra il fumo dei narghilè, si gioca a tric-trac e a domino, sorseggiando karkadè sotto le grandi pale dei ventilatori che girano pigramente. È un bel momento, e quando giungiamo ai saluti, quasi ci vergogniamo della diffidenza che abbiamo nutrito in cuor nostro nelle ore trascorse con lui. Svoltato l’angolo, ci nascondiamo allora tra i tavolini d’ottone e gli specchi del caffè Fichawi per sorbire un delizioso, fresco, nutriente romman a base di succo di melograno. Solo quando siamo certe che Aziz si è allontanato, torniamo indietro per dirigerci verso le vicine moschee di Sayedna elHusseyn e di el-Azhar, ben decise a goderci in solitudine la visita. Tiriamo fuori dalle borse foulard e calzini, ci togliamo le scarpe disponendole nella rastrelliera apposita ed entriamo nel cortile di elAzhar, immenso e abbacinante nel suo lindo biancore, racchiuso da alte mura merlate i cui stucchi a conchiglia ricordano un poco il decoro di certe nostre chiese rinascimentali. Chiudo gli occhi – e mi fa un certo effetto provare a immaginarlo gremito di fedeli prostrati, raccolti in preghiera e disposti fittamente l’uno accanto all’altro come le tessere di un puzzle vivente. Mentre sono assorta in questa fantasticheria, un giovane barbuto, smilzo e molto serio, che si presenta come aiuto muezzin, ci avverte che non è possibile visitare l’interno senza una guida, dichiara di essere lì per questo e si offre per soli 5 euro a persona. Abbiamo poca scelta e dunque va bene: ma scopriremo che non potevamo trovare di meglio perché Hasan – così si chiama il nostro mentore – ci condurrà fin nelle cappelle sotterrane di el-Azhar e, soprattutto, ci illustrerà i segreti dell’Islam, la sua forza di persuasione e la suggestione della sua carica mistica. Si comincia da alcuni precetti fondamentali. La purezza, innanzi tutto, della mente, del cuore e delle membra: e dunque le abluzioni rituali che ogni musulmano deve compiere prima di raccogliersi in orazione. A questo sono adibiti i fontanili monumentali di ogni moschea, dove i credenti si detergono le mani, la bocca, le braccia, il viso e il capo, le orecchie e i piedi, onde accostarsi mondi alle cose 9 sacre. Poi, l’abbandono alla volontà di Allah, «che è sapiente e ben informato»: ed ecco la navata interna, coperta di tappeti, dove i fedeli si rifugiano nei più diversi momenti della loro giornata, per pregare, riflettere, conversare, riposarsi e finanche dormire, cercando sollievo e illuminazione in quel sonno vegliato dall’occhio dell’Onniveggente. Terzo: la castità dei pensieri e dei costumi, e a questo si deve principalmente la separazione tra i sessi e lo spazio riservato alle donne, sul fondo della navata o sul matroneo. Quarto: la devozione alla preghiera, che si respira principalmente nella parte vecchia della moschea, che fa da fondamenta alla nuova. Lì sono le tombe dei santi, le loro reliquie terrene, presso le quali ci si raccoglie a meditare, rammentando le eccezionali vicende di abnegazione e testimonianza che vi sono legate. Quinto: la dottrina, allo studio della quale sono destinati i locali della madrasa e della biblioteca, che troviamo affollati di ragazze e ragazzi intenti a compulsare il Corano. Queste virtù, tra i pilastri fondamentali della fede, hanno pure svolto un importante ruolo secondario per il popolo musulmano, spiega Hasan, indirizzando ricchi e poveri, sultani e semplici fellah all’igiene e all’istruzione. Sesto comandamento, affatto secondario rispetto ai precedenti è quello della Jihad, l’obbligo al proselitismo. A questo fine, Hasan ci mostra, sul fondo della biblioteca, una parete dove sono allineati in bell’ordine, suddivisi per lingua, Corani e opuscoli divulgativi sulla fede musulmana e su alcuni suoi aspetti particolari. Ce ne sono in indostano e in giapponese, in tedesco e in finlandese. A me e a Silvia, che cominciamo ormai a smaniare per il caldo sotto i nostri foulard, vengono donati un cd e un opuscolo su «Le donne nell’Islam e le donne nella tradizione giudeo-cristiana. Mito e realtà». Lo apro a caso e vi leggo un brano dalla lettera di Paolo ai Corinzi (11, 3-10): «Voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo e che il capo di ogni donna è l’uomo. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al proprio capo… mentre manca di riguardo al proprio uomo ogni donna che prega o profetizza senza velo… L’uomo non deve coprirsi, perché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell’uomo… Per questo deve portare sul capo un segno della sua dipendenza». Il velo islamico, continua l’autore dell’opuscolo, Sherif Abdel Azeem (Ph.D. alla Queens University di Kingston, Ontario, sottolinea la copertina), non è un segno dell’autorità dell’uomo sulla donna, né della sottomissione della donna al marito o al padre: è soltanto un aiuto al pudore, adottato allo scopo di celare gli «ornamenti» femminili agli sguardi e di proteggere così le donne, tutte le donne, dalla violenza (p.74-76). Hasan ci raccomanda di leggere attentamente il libretto, accalorandosi (in inglese) contro i pregiudizi che infangano la sua fede: riguardo alla condizione delle donne, dice, il Corano esprime ideali di molto superiori alle concezioni della Torah e della Bibbia. Sfortunatamente quasi tutte le società musulmane hanno deviato, preferendo continuare a seguire arcaiche tradizioni ereditate dagli antenati, assai dure a morire. C’è oggi – e c’è sempre stato – un profondo divario tra ciò che si può leggere nel Corano e ciò che, magari illegittimamente divenuto oggetto di fede, viene realmente praticato. Proprio questo distacco dagli insegnamenti del Profeta ha conseguenze disastrose in molti campi: tirannie politiche, arretratezza economica, ristagno intellettuale e oppressione femminile. La condizione di tante donne musulmane oggi non è che un sintomo di una malattia più profonda, si accora Hasan. Noi che siamo il popolo di Allah e che dobbiamo essere critici nei confronti del materialismo e dei modelli consumistici dell’Occidente, dobbiamo anche avere il coraggio di correggere errori del passato che sono contrari ai veri insegnamenti del Corano, dice. Ma i non musulmani, devono comprendere che le azioni degli integralisti non hanno alcun riscontro nel credo islamico, aggiunge: identificare la condizione di tante donne del mondo musulmano con la pratica dell’Islam è lontano dalla verità quanto il qualificare come cristiani tanti comportamenti aberrati che caratterizzano la vita privata e pubblica dell’Occidente. Non ha tutti i torti il nostro Hasan e anche se ci sarebbe ancora molto da dire, io, che alcune di queste riflessioni sono andata facendole da tempo, torno con il pensiero agli insegnamenti dei Padri della 10 Chiesa che negavano un’anima alle donne, alla caccia alle streghe e alle cliniche per isteriche, ai dodici figli e nove aborti della mia bisnonna e alle più recenti lotte per la riforma del diritto di famiglia in Italia. Parlando di queste cose, mentre si accalora, freme e si intristisce, Hasan ci ha condotto sulla terrazza della moschea, dalla quale si spiccano alti i due minareti. Neanche a farlo apposta, è ora di preghiera e da questi e dalle analoghe torri che svettano sopra il quartiere, comincia a innalzarsi il canto appassionato e forte che chiama alla devozione. Il sole si è abbassato sull’orizzonte, i minareti, le cupole, i merli delle balconate mandano lunghe ombre cilestrine sulle mura dorate. Qui all’aperto possiamo toglierci i foulard finalmente e liberare i capelli madidi al vento fresco della sera. Sarà questo? sarà l’incanto dell’ora? sarà stato il turbamento della vicinanza e il ricordo della mano che mi ha stretto a lungo, cavallerescamente, per guidarci nel buio pesto delle scale a chiocciola non illuminate e senza finestre che conducono fin quassù? O forse, più banalmente, è un semplice calcolo del tipo “tentar non nuoce, non si sa mai”, e il desiderio bruciante di inventarsi un’altra vita lontano? Fatto sta che Hasan si commuove, si confonde, vorrebbe ancora tenermi per mano. Dopo una qualche titubanza, si decide a propormi una corrispondenza scopo matrimonio: mi giudica una donna onesta, sinceramente curiosa della sua religione e senza grilli per il capo; lui afferma di essere un uomo responsabile e animato da serie intenzioni. E allora perché no? Già, perché no? Inutile obbiettargli che sono fidanzata, anzi ho marito, cinque figli, genitori e gatto a carico: il mio fidanzato o marito sarebbe con me se mi volesse bene, dice. E pare che le famiglie numerose gli piacciano tanto. Come ogni donna che voglia rifiutarsi senza offendere, rispondo dunque «vedremo» e accetto il suo biglietto da visita. È un modo carino per separarsi, dicendosi, senza esprimerlo, che curiosità, rispetto e attenzione hanno creato un ponte, quale che sia: un legame tra due mondi lontani che pure sanno di essere destinati a non incontrarsi mai più. Ultima mattinata al Cairo. Sono rimasta da sola a prendere congedo: il mio aereo parte alle 17 e ho qualche ora davanti a me. Decido di fare una passeggiata nei dintorni dell’hotel prima di dirigermi verso el Qalaa, la Cittadella, colle panoramico dove sorge la Moschea Bianca di Mohammed Ali e la più antica di Suliman Pasha. Lungo questo tratto di fiume, si susseguono da un lato night, ristoranti, locali, circoli sportivi; dall’altro belle villette e case circondate da parchi e giardini. Vedo cameriere che rientrano con la spesa, mamme con carrozzine, un signore che lucida il parabrezza della sua macchina e che nel bel mezzo dell’operazione decide di pulirsi le unghie con il tergicristallo. C’è un palazzo in ristrutturazione, ma tutti gli operai del cantiere, saranno almeno una ventina, sono scesi in strada, hanno steso sacchi di iuta e teli di plastica sul marciapiede e si accingono a inginocchiarsi per pregare sotto la guida del capomastro. Battelli vanno e vengono lungo la corrente, un ragazzo biondo corre in tuta da ginnastica. Ieri sera abbiamo cenato al Naghim Mafusi, un ristorante molto “in”, che dev’essere segnalato dalle guide perché vi abbiamo trovato molti turisti. Non è stato facile scovarlo, nascosto com’è dietro un pesante portone, senza insegna né alcun distintivo che consenta di ravvisarlo dall’esterno. Vi si mangiano cibi egiziani: foul, hummos e baba ganoog (antipasti a base di fave, ceci e melanzane), molokia (minestra di verdure e pollo), keshk (risotto alle cipolle), hamam mahshy (piccioni ripieni), seduti ai tipici tavoli bassi, in una sala a volta che ha qualche pretesa di eleganza alternativa, zeppa di oggetti di artigianato e candele. Vi si possono bere anche birra e long drink, piacevolmente osservando tipi umani che paiono uno spettacolo vivente delle contraddizioni e della crisi di identità che attanaglia i giovani musulmani. Ricordo in particolare una coppia: un ragazzo in jeans e maglietta americana coi buchi di ordinanza, abbigliato un po’ punk, con tanto di cresta ingelatinata, bracciali chiodati e pacchetto di Malboro in tenero colloquio con una fanciulla in pantaloni alla zuava, col capo racchiuso 11 da una mantiglia nera che dalla fronte scendeva a coprirla fino ai fianchi, con guanti neri, occhi bistrati e audaci sandaletti col tacco a spillo. Mah!... Adesso, il tassista – che vedendomi sola ha tentato di chiedere un prezzo maggiorato per la corsa – ciacola allegramente, sottoponendomi al solito interrogatorio sulla mia vita privata e lavorativa, nel bel mezzo di un ingorgo surreale, di una folla pullulante di pedoni e veicoli di tutti i generi, dal carretto a mano alla bicicletta alla carrozzina, che si spintona sulla sede stradale già congestionata di auto strombazzanti. Parla pure delle difficoltà del suo Paese, il tassista, di quanto è duro tirare avanti per la gente comune. Lui ha sei figli, tra i venticinque e i quattro anni; ne è molto fiero e me li nomina tutti, raccontandomi quanti anni hanno e che cosa fanno nella vita. Mi rimprovera anche, serafico e incurante del caos, perché sbadatamente gli ho detto che ho solo una figlia e a lui sembra sciocco non approfittare della giovinezza per mettere al mondo tanti bambini, a prescindere dal reddito e dallo status sociale: i figli, dice, sono un dono di Allah. Se hai tanti figli, c’è più gioia attorno a te – e il tuo nome vivrà più a lungo dopo che sarai morto. Ride e ride: dà l’impressione di un uomo felice. Quando mi lascia, ai piedi di el Qalaa, sfolgorante nelle sue cupole d’argento e nelle sue mura di alabastro, è proprio soddisfatto e si capisce che avrà qualcosa da raccontare stasera, a cena, ai suoi tesori. Io, attraversata la barriera d’ingresso sorvegliata dai militari, entro ora nel recinto del complesso fortificato. Un gran fermento mi accoglie: chi pota i cespugli, chi pianta fiori, chi rattoppa la strada, chi lucida le ringhiere in mezzo a torme di giapponesi e di spagnoli che vanno e vengono. Capisco il motivo: il Cairo attende Barak Obama, che sarà qui dopodomani. Un po’ dappertutto nella città ferve il restyling, è chiaro che ancora non devono aver deciso il percorso esatto della visita ufficiale. Ma certo una tappa deve essere stata prevista quassù: dentro la moschea, si fanno le grandi pulizie: tre operai stanno spolverando le modanature e i cornicioni interni: uno di loro, issato su un trabattello, e munito solo di una lunga direzzola, fa cadere cumuli di polvere centenaria, alzandosi in punta di piedi là dove la sporgenza è al limite della sua portata; altri due, seduti per terra, lo guardano, assentono e danno consigli. La penombra è fresca: le pareti sembrano assorbire magicamente la luce e la vampa bollente che entra a folate dai quattro portali spalancati. Anche le voci delle guide si smorzano risucchiate dall’altissima volta e benché frotte di persone entrino una dopo l’altra, l’immensa moschea continua a sembrare semideserta. Resto a lungo in un angolo a osservare divertita la punizione inflitta alle turiste sventate che si presentano in short e magliettina: per loro sono a disposizione informi sacchi di pesante tela grigia con cappuccio, lunghi fino ai piedi, che si calzano dal capo e le trasformano in ridicoli pupazzi. Fuori, il vento spazza la spianata e la città si stende tutt’ intorno a 360 gradi. La giornata è limpida: laggiù, verso la piana di Giza, piccole piccole si intravedono le piramidi. Ci siamo andate subito, il primo giorno: Saqquara, la piramide a gradoni, la più antica del Cairo, costruita da Imhotep per il re Djoser; le celeberrime piramidi di Khufu, Khafre e Menkaure; la Sfinge dal naso mozzo, così familiare, che mi fa sempre pensare alle Giubbak col filtro che fumava mio padre; e la mastaba di Akhuthotrp e Ptahhtep, con i commoventi affreschi del congedo e tutte quelle disincarnate figure che raccontano il loro mondo e i loro sentimenti in astrazione e per simboli. Ormai in aeroporto, mentre scorro un settimanale europeo zeppo di foto e di immagini pubblicitarie, penso a quanto è povero il nostro iperrealismo, che misera misura sia quella che riduce la descrizione del mondo alla sua piatta fotografia. Non c’è ombra di verità se non nell’enigma, rifletto. Tutto ciò che vi allude esercita un invincibile fascino, è una interrogazione che ancora dopo millenni ci sfida a crescere. Il resto, ahimè, somiglia troppo spesso ad un imbonimento o a una sterile chiacchiera. 12
Scarica