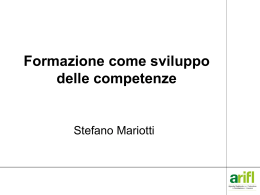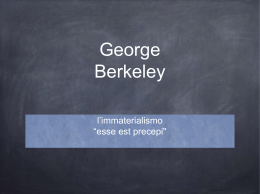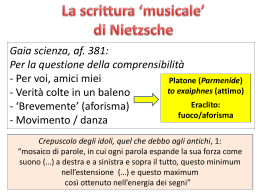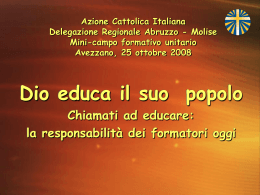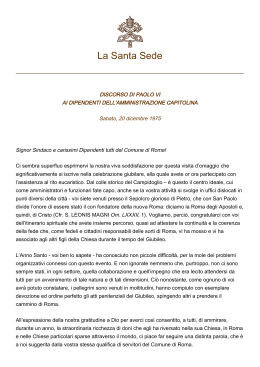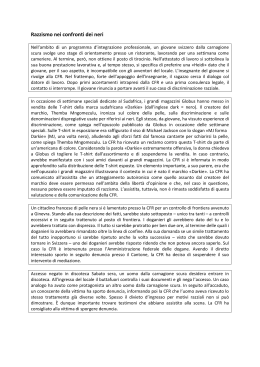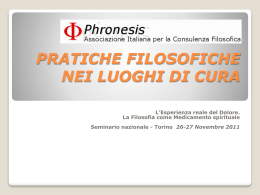LE POESIE DI FOLCHETTO DI MARSIGLIA Edizione critica a cura di Paolo Squillacioti Nuova edizione riveduta e aggiornata Nota alla seconda edizione Questa versione approntata per il «Corpus des Troubadours» riproduce con alcuni interventi e note di aggiornamento quella del 1999, pubblicata con lo stesso titolo dall’Editore Pacini di Pisa, nella collana «Biblioteca degli Studi Mediolatini e Volgari» (nuova serie, XVI) diretta da Valeria Bertolucci Pizzorusso. In particolare, il testo dei componimenti è stato adeguato a quello adottato nell’editio minor, uscita nella «Biblioteca Medievale» dell’editore Carocci (Squillacioti 2003) e a quello disponibile online in Rialto (www.rialto.unina.it/FqMars) e nelle due banche dati in CD-ROM, la COM 2 di Peter T. Ricketts (Concordance de l'Occitan Médiéval, Turnhout, Brepols 2005) e TrobVers di Rocco Distilo (anche online all’indirizzo http://trobvers.textus.org, cui rinvio per i dati bibliografici). Ripeto per comodità l’elenco degli interventi (tra parentesi la forma sostituita): I 34 aflebit (afleblit), III 47 deia (deja); X 57 els (e·ls); XI 6 alre no m’ave (al re no·m ave), 8 Per (per), 25 pel (pe·l); XV 22 el (e·l); XVII 30 qu’el (qu’e·l); XVIII 44 el (e·l); XXII 3 no m’aguda (no·m aguda), 16 no m’ausi (no·m ausi), 17 e l’autor (e·l autor); XXVI 3 que m’essenha (que·m essenha), 40 ni m’engane (ni·m engane); XXVII 100, 105, 128 el (e·l). Le note di aggiornamento sono collocate alla fine di ciascun capitolo dello Studio introduttivo e dell’edizione di alcuni componimenti, introdotte dall’indicazione «Postilla 2009»; correggo invece senza alcun avviso refusi ed errori puntuali. La bibliografia è stata aggiornata e corretta; rinuncio invece ad adeguare le citazioni dei componimenti trobadorici alle edizioni uscite nel frattempo. Ho tenuto presente per questo aggiornamento le recensioni di Francesca Gambino nei CCM (Gambino 2001), Max Pfister nella ZrPh (Pfister 2002), di Marta Rovetta in CrTesto (Rovetta 2002), nonché le recensioni e le segnalazioni dell’editio minor di Lorenzo Tomasin sul «Sole-24 ore» del 4 maggio 2003 (p. 30), di Walter Meliga nell’«Indice dei libri del mese» del dicembre 2003 (p. 20), di Alberto Varvaro in MR, XXVIII (2004), p. 167, di Francisco J. Rodríguez Risquete in «Mot so razo», IV (2005), pp. 94-95; e soprattutto l’articolo di Fabio Zinelli in Rom (Zinelli 2003), dedicato a entrambi i volumi. Un ringraziamento particolare, fra i molti amici e colleghi cui ho discusso in questi anni le questioni affrontate nel libro, va a Gabriele Giannini: gli devo la segnalazione di errori ora rimossi. Questa nuova edizione riveduta del libro è dedicata al piccolo Pietro, che ha rimesso a nuovo la mia vita. Paolo Squillacioti, dicembre 2009 Premessa Il nome di Folchetto di Marsiglia, trovatore provenzale attivo negli ultimi decenni del XII sec., è strettamente legato a quello del suo unico editore, il filologo polacco Stanislaw Stroński 1: la nota biografica, che rende solo in parte 1 Nato a Nisk nad Sanem il 18 agosto 1882, avviò gli studi universitari a Leopoli per concluderli a Vienna, come allievo di Wilhelm Meyer-Lübke e Adolfo Mussafia; si perfezionò in séguito alla Sorbona dove sotto la guida di Antoine Thomas conseguì il dottorato nell’aprile del 1906: la tesi, l’edizione critica delle poesie del trovatore Elias de Barjols, venne pubblicata nello stesso anno. Nei mesi successivi produsse alcuni articoli nei quali grande spazio ha il vaglio delle fonti documentarie, operazione che darà i suoi frutti maggiori e a tutt’oggi insuperati proprio nell’edizione folchettiana; segnalo fra gli altri quelli più legati alla prima esperienza editoriale, Recherches historiques sur quelques protecteurs des troubadours. Les douze preux nommés dans le ‘Cavalier soisseubut’ d’Elias de Barjols, AdM, XVIII (1906), pp. 473-93 e Notes sur quelques troubadours et protecteurs des troubadours célébrés par Élias de Barjols, RLR, L (1907), pp. 5-44. Nel frattempo portò a compimento la sua opera maggiore, presentando all’Università di Cracovia prima un’Étude preliminare sul canzoniere folchettiano (marzo 1909), poi l’edizione critica vera e propria (giugno 1910): il tutto confluì in un volume pubblicato nello stesso 1910. L’edizione gli valse l’incarico di docente di Lingue e letterature romanze presso la stessa Università di Cracovia; continuò a mantenere rapporti con la Francia dove pubblicò alcune note negli «Annales du Midi» fra il 1911 e il 1913 e l’importante volume La légende amoureuse de Bertran de Born (Paris, Champion 1914). L’unico lavoro scientifico in polacco di questo periodo a me noto è Wplyw Dantego w «Grobie Agamemnona» Slowackiego [L’influsso di Dante ne «La tomba di Agamennone» di Slowacki], Leopoli 1909. L’attività accademica venne interrotta allo scoppio della prima guerra mondiale, quando fu internato nella Stiria dalle autorità austriache: già da un anno era deputato alla Dieta galiziana, eletto nelle liste del filo-russo Partito Nazional-Democratico; l’uscita della Russia dal conflitto nel 1917 coincise infatti con la fine della sua condizione detentiva: potè riprendere l’insegnamento e ritornare all’attività giornalistica esercitata sin dal 1901. Alle prime elezioni della Repubblica polacca, nel 1922, venne eletto deputato, mentre era direttore del giornale Rzeczypospolita [la Repubblica], cofondato con Paderewski nel 1920; nel 1924 fondò il giornale Warszawianka [la Varsaviana] di cui fu direttore fino al 1928; numerosi furono i periodici che fondò e diresse durante la sua vita. Dopo il colpo di stato del generale Pilsudski del maggio 1926, Stroński tornò all’insegnamento che svolse all’Università di Lublino dal 1927 al 1939, pur continuando l’attività politica nelle file dell’opposizione e come membro della L. N. Union. L’invasione tedesca lo costrinse all’espatrio, prima a Parigi poi a Londra, dove fu ministro dell’informazione e della documentazione del governo polacco in esilio; testimonianza del suo ininterrotto ruolo pubblico sono i numerosi libri e opuscoli che dedicò in principal modo alla questione polacca. Né venne meno la sua attività di studioso, che sfociò in una serie di lavori nella sua lingua madre: Goethe i Polska (Londra 1950), Zamoyski i Zborowski (Londra 1951), Tristan i Iseut (1952-53), oltre alla ‘Taylorian Lecture’ La poésie et la réalité aux temps des troubadours (Oxford, The Clarendon Press 1943). Nel 1951 fondò a Londra l’Università polacca per stranieri dove insegnò le lingue romanze da sempre praticate; morì nella capitale inglese settantatreenne, il 30 ottobre 1955. (Ricavo le notizie da Antoni Jan Boguslawski, Stanislaw Stroński w 50-lecie pracy pisarskiej [S. S. per i 50 anni di lavoro da scrittore], Tunbridge Wells, Kent, Oficyna Poetów i Malarzy na Emigracji w Anglii 1954, oltre che dal ricordo di Mario Roques, pubblicato nella Chronique di Rom, LXXVI, 1955, p. 546, da The International Who’s Who, London, Europa Publication LTD, s. d., p. 999, ed anche dalle premesse ai libri dello studioso e dalle recensioni agli stessi). giustizia del ruolo dello studioso nella provenzalistica di inizio secolo e della sua attività pubblica, valga come preliminare tributo: altro si potrebbe aggiungere, soprattutto con riguardo ai molti pregi dell’edizione di cui qui si propone una revisione e che perciò verrà talora radicalmente criticata; credo tuttavia che l’entità e la qualità del debito contratto con il lavoro di Stroński emergano con evidenza dal frequente ricorso all’enorme massa di dati e interpretazioni che vi si trovano: si può dire infatti che quasi ogni testo citato, ogni trovatore menzionato, ogni problema affrontato abbia ricevuto il massimo dell’approfondimento possibile con gli strumenti dell’epoca e non c’è questione posta che non abbia trovato una risposta, un’ipotesi di soluzione o una motivata rinuncia. Di qui giudizi autorevoli come quello di István Frank, che ne parla come di un’edizione «considérée à juste titre comme un modèle et qui a fait époque», o di Martín de Riquer, che la definisce «una pieza bibliográfica fundamental para los estudios trovadorescos» 2; oppure di Aurelio Roncaglia, che arriva a dichiarare che «Les éditions de Folquet par Stroński (1910) e de Bernart de Ventadorn par Appel (1915) restent aujourd’hui encore des modèles inégalés» 3. Tale valutazione retrospettiva si accorda solo in parte con le indicazioni dei recensori. Molto positive sono quelle di Henry J. Chaytor («M. Stroński has produced an excellent and most interesting edition of a most interesting troubadour»), di G. Huet («[le volume de M. S.] n’est pas seulement une édition de texte mais [...], en étudiant sous toutes les faces l’oeuvre d’un troubadour célèbre, peut servir d’introduction à l’étude des troubadours en général») e di Joseph Anglade («n’hésitons pas à féliciter chaudement le jeune savant étranger qui a consacré à un des noms intéressant de notre ancienne poésie provençale un monument aussi remarquable. Il y a là beaucoup de travail, beaucoup de méthode, beaucoup de connaissances et d’ingéniosité»), appena sfiorata quest’ultima da qualche nota critica: «Il y a là quelque abus: des différences purement graphiques ne sont intéressantes que pour des études de langue»4. Così anche Edmund Stengel, che nel descrivere il contenuto sottolinea gli aspetti più rilevanti e innovativi dell’edizione, segnalando al contempo alcune lacune, e in particolare il mancato utilizzo del ms. di Copenhagen (Kp) che lo stesso studioso aveva edito diplomaticamente già nel 1877; questa la conclusione: «Ich vermisse endlich eine Konkordanz der Liedernummern mit den Nummern in Bartschs Grundriß, sowie ein Verzeichnis der herangezogenen Literatur und der dafür gebrauchten Abkürzugen, will aber nicht mit so kleinen Ausstellungen schließen, sondern mit lebhaftem Danke für die schöne Gabe» 5. 2 Frank 1952, p. XXI, n. 32; Riquer 1975, I, p. 583. Au. Roncaglia, Rétrospectives et perspectives dans l’étude des chansonniers d’oc, in Atti Liège 1991, pp. 19-41, a p. 28. 4 Chaytor 1911, p. 553; G. Huet in MA, XXIV (1911), pp. 219-21, a p. 221; Anglade 1913, pp. 71-72. 5 Stengel 1911, col. 244. 3 Ugualmente consapevoli dell’importanza del lavoro, ma più critici gli altri recensori. Giulio Bertoni esordisce affermando: «L’edizione critica di tutte le liriche di Folchetto di Marsiglia, preceduta da un’ampia e solida introduzione storica e seguìta da note abbastanza copiose e da un glossario diligente, sarà salutata con gioia da tutti gli studiosi», per poi concludere: «Insomma, diligenza, studio e amore traspaiono da tutto il libro. Sarebbero desiderabili soltanto maggiore sobrietà e anche maggior sicurezza nella costituzione del testo». Dello stesso tenore la recensione di Alfred Jeanroy, che all’esordio elogiativo: «La très remarquable ouvrage de M. Stroński, qui témoigne non seulement d’une connaissance aujourd’hui bien rare de la poésie des troubadours et de l’histoire méridionale, mais aussi d’une singulière vigueur d’esprit, a enfin obtenu de la critique l’attention qu’il méritait», fa seguire, a qualche rigo di distanza, il pendant critico: «C’est évidemment sur l’établissement du texte et les traductions (plus littérales que vraiment fidèles et d’un style très contourné) qu’il reste le plus à dire et je me rends bien compte que les quelques observations qui suivent, n’épuisent pas le sujet». Ambivalente anche la valutazione di JeanJacques Salverda de Grave: «M. Stroński joint à une connaissance profonde de la poésie des troubadours une grande indépendance d’esprit, et, par là, il réussit plus d’une fois à renouveler des questions qu’on croyait définitivement résolues. D’autre part, sa crainte de marcher sur les traces d’un devancier donne parfois à ses explications un tour paradoxal et, si je ne me trompe, c’est surtout dans son interprétation des textes que ces tendances se font jour. Si nous ajoutons que la langue et le style de M. S. ont une certaine fraîcheur et de la hardiesse qui, malheureusement, dégénère trop souvent en inexactitude, je crois avoir dégagé l’impression générale qui nous reste de la lecture de la publication importante que nous annonçons»; a ciò lo studioso fa seguire, dopo una descrizione del contenuto dell’edizione, una serie di rilievi a singoli passi delle poesie 6. Lascia invece poco spazio agli elogi di rito Kurt Lewent, che inizia in medias res: «Die Benutzung dieses mit grosser Stoffbeherrschung und allem Rüstzeug philologischer und historischer Detailforschung verfassten Buches wird erheblich erschwert durch die Art der Anordnung, die in seiner Entstehung wohl eine Erklärung, aber kaum hinreichende Entschuldigung findet». L’esordio annuncia una severità di cui il recensore darà prova in una serie di contestazioni che spaziano dalla pratica attributiva alla stessa recensio di Stroński, della quale viene dimostrata l’incompletezza; una serie di osservazioni puntuali chiude l’intervento. E solo di osservazioni puntuali, per lo più critiche, si compone una delle Textkritische Bemerkungen zu Trobador-Ausgaben che Oskar SchultzGora dedica alle diciannove poesie ritenute da Stroński di sicura attribuzione 7. 6 99. 7 Bertoni 1911b, pp. 115 e 118; Jeanroy 1913, p. 259; Salverda de Grave 1911, pp. 498- Lewent 1912, col. 328; Schultz-Gora 1921 (a Lewent risponde Stroński 1913, pp. 28897 sulla questione dei senhals reciproci, e comunque ringrazia lo studioso tedesco, insieme con Salverda de Grave e Jeanroy, per la qualità delle osservazioni critiche all’edizione); nulla più che una segnalazione quella di V. Crescini in RBLI, XIX (1911), pp. 64-65. Al di là dei singoli problemi, si può notare come una certa tendenza alla sistematicità, ammirevole e oggi difficilmente eguagliabile, stia al fondo di alcune scelte problematiche dell’editore, per le quali si è proposta una soluzione alternativa. Partendo dall’analisi dell’ordine dei testi nella tradizione manoscritta [§ 1.1], va in primo luogo ridisegnato il canone folchettiano, in quanto la sua definizione [§ 1.2] e la cronologia assoluta e relativa dei testi [§ 1.3] presentano aspetti di dubbia validità, che pregiudicano la stessa valutazione della fisionomia poetica di Folchetto. In secondo luogo, vanno sottoposti a una profonda revisione i risultati del lavoro ecdotico di Stroński, condizionati in partenza da una recensio codicum [§ 2.1] incompleta e talora mediata da riproduzioni fotografiche, edizioni diplomatiche o collazioni fornitegli da altri studiosi [§ 2.1.1]: alla base del mio lavoro c’è invece, oltre alla considerazione di testimonianze dirette e indirette ignote o trascurate [§§ 2.1.2 e 2.1.3], il controllo diretto sui manoscritti della quasi totalità di trascrizioni da microfilm e fotografie. Anche la pratica editoriale di Stroński va totalmente ripensata: al vano tentativo di una ricostruzione stemmatica di ascendenza lachmanniana, che, basandosi prevalentemente su varianti adiafore e non sugli errori-guida (di cui peraltro la tradizione manoscritta folchettiana è assai avara), lascia largo spazio all’opinabilità, va opposta un’ipotesi di ‘restauro conservativo’ della tradizione manoscritta [§ 2.2]. Mantiene al contrario una grande utilità la ricostruzione del contesto storico operata da Stroński a partire da un vaglio diretto e minuzioso dei documenti d’archivio: i capitoli storici dell’Étude sur Folquet de Marseille premessa all’edizione e il Commentaire historique che la segue, costituiscono un’ottima base di partenza per un profilo biografico di Folchetto di Marsiglia, soprattutto nei venticinque anni in cui sedette sullo scranno vescovile di Tolosa [§ 3.1], e per ripercorrere e integrare i dati sui suoi rapporti diretti con i trovatori coevi [§ 3.2.1] e sulla sua presenza nelle letterature medievali che ricevettero influssi dalla poesia occitanica [§ 3.2.2]. Il discorso preliminare si arresterà infine sulla soglia di una ridefinizione delle qualità poetiche di Folchetto, oggi eccessivamente limitate da una tradizione critica di cui verranno abbozzate le linee portanti e nella quale si scorge qualche tentativo isolato di revisione [§ 3.3]. L’edizione critica delle ventisette poesie del corpus folchettiano occupa la seconda parte del lavoro. Iniziato come tesi di laurea all’Università di Pisa (1990-91; rel. prof. Pietro Beltrami), il presente lavoro ha come tappa intermedia la mia tesi di perfezionamento alla Scuola Normale Superiore (febbraio 1998; rel. prof. Valeria Bertolucci Pizzorusso): ringrazio per il loro decisivo contributo i proff. Stefano Asperti e Alberto Varvaro, co-relatori della tesi di prefezionamento, e il prof. Alfredo Stussi, per la fiducia concessami negli anni di Normale. E fra i tanti amici che mi hanno aiutato nella mia ricerca vorrei ricordare, e ancora ringraziare, Sergio Vatteroni, che ha letto con generosa competenza molte pagine del dattiloscritto, Claudio Giunta e Elena Pistolesi. Dedico il libro a mia moglie Bernadette. Tavole di concordanza BdT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Amors, merce: non mueira tan soven A pauc de chantar no·m recre Ai! quan gen vens et ab quan pauc d’afan A vos, midontç, voill retrair’ en cantan Ben an mort mi e lor Chantan volgra mon fin cor descobrir Chantars mi torna ad afan En chantan m’aven a membrar Fin’ amors a cui me soi datz Greu feira nuills hom faillenssa Ja no·s cuig hom qu’ieu camje mas chansos Ja non volgra q’hom auzis Meravill me cum pot nuills hom chantar Molt i fetz gran pechat Amors Oimais no·i conosc razo Per Dieu, Amors, ben sabetz veramen Pos entremes me suy de far chansos S’al cor plagues, ben fora oimais sazos Senher Dieu[s], que fezist Adam Si com sel qu’es tan greujatz Sitot me soi a tart apercebuz Tant m’abellis l’amoros pessamens Tan mou de cortesa razo Tostemps, si vos sabetz d’amor Vermillon, clam vos faç d’un’ avol pega pemcha Vers Dieus, el vostre nom e de sancta Maria Us volers outracuidatz n° ed. Stroński V XIX VI XXII I XVII XIV XI XV XII XIII XXIII XX IV XVIII VIII XVI III XXVII XXI VII II IX XXIV XXV XXVI X IX XX X XXII I VI XVIII V XXIV XIII XIV XXIII XXI VIII XIX XII XXV VII XXIX XVII XI II III XV XVI XXVIII IV n° ed. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII BdT 5 22 18 14 1 3 21 16 23 27 8 10 11 7 9 17 6 15 2 13 20 4 12 24 25 26 19 Stroński I II VII VIII IX X XI XII III IV V XIII XIV XVIII XXIV XXV VI XIX XX XXI XVII XXII XXIII XV XVI XXVIII XXIX Stroński I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX BdT 5 22 23 27 8 6 18 14 1 3 21 16 10 11 24 25 20 7 15 2 13 4 12 9 17 370,9 9,10 26 19 n° ed. I II IX X XI XVII III IV V VI VII VIII XII XIII XXIV XXV XXI XIV XVIII XIX XX XXII XXIII XV XVI — — XXVI XXVII Sigle dei testimoni 8 Tradizione diretta A Aa Ab B C D Da Dc E F Fa G H I J K Kp L M N N2 O Ol P Pe Q R S Sg T U V VeAg 8 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 5232 c. 269 del ms. M [con Ab parte del ms. che Zufferey 1987 sigla A’] Ravenna, Biblioteca Comunale Classense, 165 [cfr. Aa] Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 1592 Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 856 Modena, Biblioteca Estense, . R. 4. 4 cc. 153-216 del ms. D [copia del Liber Alberici] cc. 243-260 del ms. D [florilegio di Ferrarino da Ferrara] Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 1749 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi L.IV.106 Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2981 Milano, Biblioteca Ambrosiana, S.P. 4 [già R 71 sup.] Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 3207 Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 854 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Sopp. F. IV. 776 Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 12473 København, Kongelige Bibliothek, Thott 1087 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 3206 Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 12474 New York, Pierpont Morgan Library, 819 Berlin, Staatsbibliothek, Stiftung Preussische Kulturbesitz, Phillipps 1910 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 3208 Olot, Arxiu Històric Comarcal, Fons notarials, Santa Pau, 2 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. XLI, 42 Sarrià, Monestir de Sant Pere de les Puel·les, ms. literari Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2909 Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 22543 [ms. La Vallière o canzoniere d’Urfé] Oxford, Bodlerian Library, Douce 269 Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 146 [ms. Gil y Gil] Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 15211 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. XLI, 43 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 278 [già fr. App. cod. XI] Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 7 e 8 [ms. Vega-Aguiló] Per l’indicazione dei testi folchettiani tràditi e altre note si veda il § 1.1; e inoltre il § 2.1.2.1 (su a), il § 2.1.2.2 (su S), il § 2.1.2.3 (su Y). Per ulteriori indicazioni sulla tradizione indiretta (edizione da cui si cita, modo della citazione, testi o parti di testo citati, ecc.) si veda il § 2.1.3. W X Y Z a a1 b c ca e f g g1 ls Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 844 [= canz. oitanico M] Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 20050 [= canz. oitanico U] Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 795 Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 1745 Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2814 [= sigla per tutto il canzoniere di Bernart Amoros; cfr. a1 e il § 2.1.2.1] Modena, Biblioteca Estense, Càmpori . N. 8. 4; 11, 12, 13 [‘complemento Càmpori’ al canzoniere di Bernart Amoros; cfr. a e il § 2.1.2.1] Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 4087 [diviso in due parti: bI, cc. 1-8, e bII, cc. 9-53] Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. XC inf., 26 Codice di E. Stengel già all’Università di Lovanio [cfr. § 2.1.2.1] Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 4087 [antologia di Gioacchino Pla] Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 12472 [canzoniere Giraud] appendice di g1 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 3205 [descriptus di M] lezioni del canz. di Bernart Amoros apposte a ca [cfr. § 2.1.2.1] Tradizione indiretta 1 citazioni nel Breviari d’Amor di Matfre Ermengaud citazioni in So fo el temps qu’om era gais di Raimon Vidal de Besalú 3 citazioni nelle Razos de trobar di Raimon Vidal de Besalú citazioni nei Documenti d’Amore di Francesco da Barberino citazioni in Dell’Origine della Poesia rimata di Giovanni Maria Barbieri citazioni nella Doctrina d’acort di Terramagnino da Pisa BdN citazioni nel Mirall de trobar di Berenguer de Noya JSJ citazioni in Cant vey li temps camgar e·mbrunusir di Jordi de Sant Jordi Regles citazioni nelle Regles de trobar di Jaufre de Foixà PARTE PRIMA Studio introduttivo CAPITOLO PRIMO Il canone 1.1. Ordinamento del corpus. I componimenti poetici attribuiti a FqMars sono ripartiti come segue nei canzonieri trobadorici 1: A Ab B C D [61v] [88r] [39r] [1v] [40r] vida 21 7 10 22 1 16 11 18 5 14 6 3 17 8 23 27 20 15 13 2 6 3 17 vida 21 7 10 22 1 16 11 18 5 14 6 3 8 23 27 20 15 16 21 3 10 1 18 14 5 22 27 23 7 11 370,9 8 15 26 22 2 10 6 3 13 5 15 21 [165v] 18 1 16 11 27 14 8 7 20 23 17 167,27 [6v] [44r] [47r] ..... [88v] [114v] 2 (ArnMar) [115r] [68r] Da [164v] Dc [245r] 18 5 8 11 1 23 3 10 6 16 21 [246r] E Fa G H [1] [41] [1r] [49r] 16 22 15 23 10 6 11 1 14 17 27 8 5 9 2 18 1 16 22 21 11 3 14 23 16 1 18 22 21 14 3 5 8 23 11 27 6 10 1 16 [9] [47] [9r] [49r] IK [62r 46r] vida 1 21 14 2 5 18 22 6 16 23 7 20 8 13 3 10 11 15 27 [65r 50r] ..... [192r] 9 (GsbPuic) [192r] ..... [227v] 17 (FqRom) [228r] ..... [228v] 13 (FqRom) [229r] 1 I numeri rimandano alla BdT; quelli completi del numero d’autore (ma per praticità non della sigla del trovatore: si veda l’elenco completo al § 1.2.10) indicano i testi spuri con attribuzione a FqMars; aggiungo anche i testi 2 9 13 26 nei mss. CRV, sebbene siano in essi attribuiti ad altro trovatore (indicato fra parentesi): per ulteriori osservazioni (e per il testo 17) si veda infra la tavola nel § 1.2.8. Per la tradizione indiretta si veda infra il § 2.1.3. Segnalo sempre le carte in cui inizia e termina la scrittura di un testo o di un gruppo di testi; i puntini individuano una soluzione di continuità. J Kp L M N O P Q R S [67r] [104r] [12v] [25r] [54r] [5] [7r] [17r] [13r] [23] 16 10 1 14 18 10 30,16 1 16 16 [68r] ..... ..... [107v] [73r] 18 ..... 10 11 15 13 8 2 6 23 7 20 421,10 421,5 173,11 173,3 [56] [11r] 22 ..... ..... [57] [22r] [125r] [34r] 22 [125v] [64v] 16 18 1 22 14 25 3 5 8 21 10 7 20 167,59 27 11 15 13 6 9 15 1 5 14 8 3 12 168,1 22 1 5 16 18 23 14 8 3 21 10 11 15 27 13 6 7 20 2 18 3 16 [105v] 16 5 1 10 14 3 18 27 22 9,7 23 6 21 11 17 8 9 1 [73r] [108v] [13r] ..... [23v] [27v] ..... [117v] 6 [118r] [7] ..... [33] 10 14 [34] ..... [50] 21 [51] ..... 16 22 11 21 210,2a 18 27 3 [60] 1 ..... 5 [72] 14 13 [24v] [58] [24r] 16 22 ..... 21 [15r] 18 13 (FqRom) 3 [15v] 1 ..... 5 [15v] 6 26 (FqRom) 14 [16r] 23 ..... [39] [13r] [42r] 10 6 11 1 14 22 23 18 27 8 3 5 7 [43v] [72] ..... ..... [51v] [75] 16 21 370,9 20 106,14 vida 17 8 14 21 5 23 1 6 [81] [52r] ..... [52v] 2 (FqRom) [52v] ..... [75r] 24 [75v] ..... [131r] 19 [131r] U V VeAg W Y a b c f N2 [225r] [29v] [82r] [71] [188r] [1v] [112] [2r] [8r] [5v] [22r] 240,4 17 9 10 23 5 11 27 14 8 7 6 4 16 3 10 21 18 11 14 1 22 8 7 30,8 16 22 5 1 8 10 18 3 21 23 7 14 27 11 6 20 16 21 70,41 21 22 23 8 21 17 9 20 22 16 3 18 5 22 16,12 1 10 14 23 8 27 6 7 21 11 156,10 [16v] [39v] 23 1 14 2 5 18 22 6 16 7 20 21 8 13 3 10 11 .... 3 15 [17v] [39v] 27 17 ..... [23v] [18r] [41v] T [233r] [39r] [74] [1v] [114] ..... [189v] [229] ..... 13 [200v] [230] 10 ..... [200v] [578] [90r] ..... [107v] 2 (Perd) [108r] 24 [579] ls 8 14 21 5 23 1 6 27 18 10 16 22 3 11 7 [2v] ..... [6r] 23 [6r] [5v] ..... [19v] 26 [20r] ..... [23r] 370,9 16 [24r] ..... [32r] 30,3 [32r] ..... 21 [42r] ..... [49r] 22 18 1 11 [51r] ..... [72r] 17 2 [72r] A commento delle tavole osservo che: i) che la sequenza di D fosse originariamente 3 22 10 (come nella tavola) è ipotesi di 2 Giosuè Lachin ; sul motivo dell’utilizzo di Fa, descriptus di F, si veda infra il § 2.1.1; le due indicazioni nel ms. H riguardano gli incipit della cobla V di FqMars 155,1 (V) e delle coblas II-III di FqMars 155,16 (VIII): rimando alle edizioni delle due canzoni per ulteriori indicazioni. ii) il testo tràdito in J alla c. 73r è la cobla V (adespota) di FqMars 155,1 (V); i componimenti tràditi fra le cc. 33 e 72 di O sono adespoti: ho incluso nell’elenco anche GlBerg 210,2a nell’ipotesi che, considerata la posizione, sia stato creduto folchettiano 2 Cfr. Partizioni e struttura di alcuni libri medievali di poesia provenzale, in Strategie del testo. Preliminari Partizioni Pause, a cura di G. Peron, Padova, Esedra 1995, pp. 267304, a p. 274. dall’estensore del ms.; i primi due componimenti tràditi in P (10 11) sono attribuiti a GrBorn: si tratta di un mancato cambio di rubrica visto che i testi di GrBorn precedono quelli folchettiani. iii) il testo tràdito alla c. 200v di W è cobla II (adespota) di FqMars 155,10 (XII); l’indicazione nel ms. Y riguarda la cobla IV (non integrale e adespota) di FqMars 155,21 (VII): rimando per ulteriori indicazioni infra al § 2.1.2.3; per l’ordine dei testi di a non tràditi nel canzoniere di Bernart Amoros, ma noti attraverso le glosse apposte al ms. c a [= ls], rimando infra al § 2.1.3.1; il ms. f attribuisce all’ambiguo en folquet oltre a FqRom 156,10 e l’alba FqMars 155,26 (XXVI): cfr. per quest’ultima infra il § 1.2.4. L’indicazione in N2 concerne la successione degli incipit citati. Si noti inoltre che i mss. CEG si aprono proprio con il corpus folchettiano 3; lo stesso succedeva, secondo Lachin 4, anche in N, e lo stesso accade nella sezione P3 del ms. P, nella sezione R5 del ms. R e nella sezione T3b del ms. T (le partizioni sono quelle di Gröber 1877). L’analisi della successione dei componimenti permette di avanzare delle ipotesi sulle aggregazioni testuali anteriori all’assemblamento dei canzonieri, e quindi sui r a p p o r t i f r a i t e s t i m o n i (§ 1.1.1), secondo un’operazione di critica esterna la cui necessità è stata, com’è noto, sottolineata da Avalle 5; ma fornisce inoltre indicazioni sui possibili c a n a l i d i a l i m e n t a z i o n e (§ 1.1.2) dei canzonieri stessi. § 1.1.1. Quanto al primo ordine di indicazioni, si possono isolare un certo numero di componimenti che appaiono frequentemente attigui, o almeno ravvicinati, nei canzonieri. In particolare riconosco i seguenti insiemi 6: [I] 5 14 18 AB C IK N P S 18 5 14 18 14 5 14 2 5 18 5 16 18 23 14 18 3 1 5 14 18 3 1 5 6 14 D c ls c D J L U 5 21 18 ... 14 18 5 ... 14 14 13 5 ... 18 18 5 14 18 5 14 18 11 14 AB IK 21 7 10 ... 3 21 ... 3 10 [14] [5] [18] [5] [II] 3 10 21 C D 3 21 3 10 10 3 5 21 Di qui, com’è noto, il nome di Folquet-Sammlungen dato da Gröber 1877, pp. 545-95 ai canzonieri che presentano questa caratteristica. 4 Cfr. La composizione materiale del codice provenzale N (New York, Pierpont Morgan Library, M 819), in Atti Messina 1993, II, pp. 589-607. 5 Per il quale è necessario integrare i risultati della critica interna e di quella esterna (cfr. Avalle-Leonardi 1993, pp. 89 e 101); una chiara applicazione è nell’ed. di RmJord curata da Asperti 1990, pp. 113-18. 6 Utilizzo il grassetto per indicare gli elementi dell’insieme, sempre citati col numero della BdT, i puntini sospensivi nei casi in cui tra questi ultimi siano interposti un numero di testi superiore a 2, le parentesi quadre per racchiudere gli elementi dell’insieme assenti nel codice. c D N Q U V 3 10 6 16 21 3 21 10 3 5 8 21 10 3 10 21 10 18 3 21 M ls G P Fa S 10 14 3 ... 21 21 ... 10 16 22 3 21 14 3 ... 10 10 ... 21 18 3 21 11 3 21 18 3 [10] [10] Dei mss. restanti, AbDaHbI mancano dei tre testi, W tramanda 21 e, in altra parte del cod., 10 (parz.), JKpET tramandano solo il testo 10, L solo 3, VeAgY solo 21 (Y parz.), gli altri (ORcf) tramandano le poesie lontane le une dalle altre. Nei casi in cui non si verifica la contiguità di 3 10 21 (eccetto D) si registra un legame fra (3) 21 22: AB D Fa G P S 21 7 10 22 22 10 3 5 21 22 21 11 3 22 21 14 3 22 21 18 3 22 21 18 3 [III] 2 13 15 A a D P 15 13 2 2 6 13 15 15 13 8 2 N Q 15 27 13 ... 2 15 13 [2] Nei restanti mss. si verifica l’assenza contemporanea dei tre testi in DcFaGHJKpLMSTUWYbIc, di 2 15 in AbOa, di 13 2 B, di 15 13 in V (ma 2 è attrib. a Perd); CGIKR presentano i tre componimenti distanziati (ma 13 è attrib. a FqRom in CR, 2 è attrib. ad ArnMar in C, a FqRom in R). Si può concludere che, in linea di massima, quando i testi sono tutti presenti vengono tramandati congiuntamente. [IV] 7 8 20 23 D IK P 8 7 20 23 23 7 20 8 8 2 6 23 7 20 AB R C Q c 7 ... 8 23 27 20 23 18 27 8 3 5 7 ... 20 23 7 11 370,9 8 [20] 8 21 10 7 20 [23] 23 8 27 6 7 [20] G U T W 8 23 87 23 ... 8 7 23 8 Cfr. ancora (2 testi): N V C c D 23 14 8 ... 7 20 8 ... 23 7 ... 20 23 7 ... 8 8 11 1 23 [20] [7 20] [7 20] [20 23] [20] [7 20] Dei mss. restanti, AbDcHJKpVeAgYf mancano dei quattro testi, mentre L tramanda solo 8, FaSbI soltanto 23; EMOls tramandano infine 23 8 distanziati (separati da tre componimenti inOls). [V] 1 16 18 22 AB Fa G N P Q S V c ls 22 1 16 11 18 18 1 16 22 16 1 18 22 22 1 5 16 18 16 22 21 18 3 1 16 18 1 22 16 22 21 18 3 1 16 22 5 1 8 10 18 16 3 18 5 22 16,12 1 1 6 27 18 10 16 22 C D IK R f J 16 ... 1 18 14 5 22 22 ... 18 1 16 1 ... 18 22 6 16 1 14 22 23 18 ... 16 16 ... 22 18 1 16 10 1 14 18 [22] E H Kp 16 22 ... 1 1 16 1 16 ... 18 Cfr. ancora (2 testi): M O U 16 5 1 ... 18 27 22 18 3 16 ... 22 ... 1 16 ... 18 11 14 1 22 [18] [18 22] [22] Nei restanti mss. i quattro componimenti sono omessi in AbDaTY, mentre WbI tramandano solo 22, VeAg solo 16; i testi sono perciò trasmessi distanziati soltanto in Dc (dove è omesso 22) e in L (dove è omesso 18). Si noti che quelli indicati sono i soli testi tràditi da J (se si prescinde dalla cobla esparsa tratta dal testo 1, vergata in un’altra zona del codice) e che H tramanda solo gli incipit di 1 16. [VI] 1 10 11 16 AB c D U 10 22 1 16 11 11 1 23 3 10 6 16 16 3 10 21 18 11 14 1 E D M R V ls Fa J Kp 16 ... 10 6 11 1 10 ... 1 16 11 16 5 1 10 ... 11 10 6 11 1 ... 16 16 22 5 1 8 10 ... 11 1 ... 10 16 22 3 11 1 16 22 21 11 16 10 1 10 30,16 1 16 [10] [11] [11] Q V c H T f 16 18 1 ... 10 ... 11 16 ... 1 8 10 ... 11 16 ... 1 10 ... 11 1 16 10 23 5 11 16 ... 1 11 [10 11] [1 16] [10] Cfr. ancora (2 testi): C Dc G IK N P 16 ... 10 1 ... 11 11 1 ... 10 6 16 16 1 ... 11 27 6 10 1 ... 16 ... 10 11 1 5 16 ... 10 11 10 11 ... 16 ... 1 Dei mss. restanti, AbDaYbI omettono i quattro componimenti, mentre VeAg tramanda solo 16, W solo 10 (parz.); i testi sono trasmessi distanziati solo da LOS (LS non tramandano 10 11). Anche qui si noti che Kp oltre ai testi indicati tramanda, in altra zona del ms., soltanto 18, e che H trasmette solo gli incipit di 1 16. Come definire tali raggruppamenti? Secondo Antonio Viscardi, che ha esercitato la critica esterna sul corpus di GcFaid, a ciascun gruppo dovrebbe corrispondere un Liederblatt 7. Restano tuttavia aperti alcuni problemi: per esempio, nei casi in cui accanto ad un gruppo formato da n elementi se ne affianchino altri di n-1, n-2 testi, vanno considerati Liederblätter i raggruppamenti minori, cui s’aggiungono altri testi in alcuni mss., oppure il Liederblatt originario si è smembrato o ridotto nella tradizione manoscritta? E inoltre come spiegare la compresenza di alcuni testi in più gruppi (18 nei gruppi I e V e parziale sovrapponibilità dei gruppi V e VI)? Tutto ciò induce ad un uso non rigido del termine Liederblatt: se è probabile la non casualità dei raggruppamenti, la cui origine dovrebbe risalire ad una fase alta della tradizione manoscritta, anteriore all’organizzazione dei canzonieri, più problematico è stabilire l’esatta consistenza dei raggruppamenti stessi e a chi si debba la responsabilità della raccolta 8. Tali raggruppamenti coprono comunque quasi tutta la produzione di Folchetto: un metodo come questo, basato sul confronto delle serie testuali, impedisce infatti di determinare la collocazione in un eventuale Liederblatt dei testi a tradizione unica (4, 12, 25 e 19, prescindendo dalla tradizione catalana) e rende ardua la verifica per i componimenti tramandati da un numero esiguo di testimoni (24 26, rispettivamente in 2 e 3 mss.); oltre a questi, restano fuori da ogni raggruppamento solo 4 canzoni (6, 9, 17 e 27), due delle quali (9 e 17) di attribuzione controversa. Un raggruppamento di maggiori dimensioni, formato in larga parte dalla congiunzione dei gruppi I e V, è isolabile a partire dalla sequenza dei testi nella seconda sezione folchettiana di P, che tramanda nell’ordine i testi 16 22 21 18 3 1 5 14 9. Gli elementi della serie si ritrovano attigui o comunque vicini, benché in ordine diverso, nella gran parte dei canzonieri 10: 7 A. Viscardi, Studi sul testo di Gaucelm Faidit, «Atti del R. Ist. Veneto di scienze, lettere ed arti», anno acc. 1934-35, t. XCIV, parte II, pp. 425-42, poi in Ricerche e interpretazioni mediolatine e romanze, Milano-Varese, Cisalpino 1970, pp. 163-77 (col titolo: La successione delle poesie di Gaucelm Faidit nei canzonieri ordinati per autori); il lavoro di Viscardi è stato recentemente sottoposto a revisione da Vatteroni 1998, pp. 46-78. Per il concetto di Liederblatt, che risale a Gröber 1877, pp. 337-44, e gli altri aspetti della trasmissione della lirica occitanica si veda il terzo cap. di Avalle-Leonardi 1993. 8 Si conferma insomma la distanza fra i raggruppamenti isolabili nella tradizione manoscritta e i Liederblätter materiali come quello scoperto da Grattoni 1982 nell’Archivio Capitolare di Cividale del Friuli, contente un planh con notazione musicale, o, in àmbito galego, il Pergaminho Vindel latore di sette cantigas di Martin Codax, anch’esse, eccetto una, complete di musica. 9 Secondo Gröber 1877, che tratta del ms. alle pp. 442-58, il canzoniere lirico di P (cc. 138) si divide in tre sezioni: P1 (cc. 1-6) comprendente i testi 1-18, P2 (cc. 7-22r), che inizia con la prima serie folchettiana, comprendente i testi 19-67, P3 (cc. 22r-38), aperta dalla seconda serie folchettiana, comprendente i testi 68-123. Segnalo tuttavia che con i testi di PVid che, con RichCdeL 420,2, dovrebbero chiudere P 2, si apre il terzo fascicolo del ms. e che con una serie quasi uguale (il testo di Riccardo è però anteposto ai vidaliani) si apre il ms. S, stretto collaterale di P. In dettaglio: A B C D c D Fa G IK M N P Q R S U V c 21 7 10 22 1 16 11 18 5 14 6 3 21 7 10 22 1 16 11 18 5 14 6 3 16 21 3 10 1 18 14 5 22 22 10 3 5 21 18 1 16 11 27 14 18 5 8 11 1 23 3 10 6 16 21 18 1 16 22 21 11 3 14 16 1 18 22 21 14 3 5 1 21 14 2 5 18 22 6 16 ... 3 16 5 1 10 14 3 18 27 22 ... 21 22 1 5 16 18 23 14 8 3 21 16 22 21 18 3 1 5 14 16 18 1 22 14 25 3 5 8 21 1 14 22 23 18 27 8 3 5 ... 16 21 16 22 21 18 3 1 5 6 14 16 3 10 21 18 11 14 1 22 16 22 5 1 8 10 18 3 21 ... 14 16 3 18 5 22 16,12 1 14 ... 21 Da notare il fatto che Dc, Fa, S, U tramandano pochi altri testi oltre a quelli sopra indicati. Per di più, la quasi totalità dei mss. assenti dall’elenco sono in varia misura riconducibili alla serie: si vedano i due testi citati in H (1 18), quelli tramandati in VeAg (16 21), il frammento tràdito in Y (21); e ancora le raccolte di J (16 10 1 14 18 ... 1) e Kp (10 30,16 1 16 ... 18), nelle quali ai testi della serie si aggiunge il solo 10 (e in Kp il testo spurio ArnMar 30,16); e infine la raccolta di L (16 ... 1 5 14 8 2 12 168,1 ... 6 ... 22), dove ai testi della serie si aggiungono 8, 6, l’unicum 12 e il testo spurio GsrSt-Did 168,1). Gli altri mss. presentano una mescolanza fra i testi della serie isolata nella seconda sezione di P e gli altri testi (E, O, W) o sono, come T, quasi del tutto estranei alla serie; oppure sono difficilmente classificabili da questo punto di vista, come f, per la frammentazione del corpus folchettiano (il codice è classificato da Gröber 1877 fra gli «Zusammengesetztze Handschriften»). Le circostanze evidenziate consentono di ipotizzare che nella serie isolata nella seconda sezione di P si possa riconoscere un Liederbuch: il termine indica in questo caso i «raggruppamenti di poesie che ricorrono in modo abbastanza costante all’interno delle sezioni riservate a ciascun trovatore nei singoli P 20r [inizio fasc. III] S 1r [inizio codice] 61. PVid 364,46 1. RichCdeL 420,2 62. PVid 364,39 2. PVid 364,39 63. PVid 364,40 3. PVid 364,40 64. PVid 364,42 4. PVid 364,42 65. PVid 364,37 5. PVid 364,37 66. PVid 364,4 6. PVid 364,4 67. RichCdeL 420,2 (PVid 364,46 che apre P, è tràdito in S al 10° posto): cfr. Vatteroni 1998, p. 72, n. 133. Una sintetica descrizione del contenuto di P, con rinvio alla bibliografia precedente, è in Asperti 1995, p. 162. 10 Evidenzio col grassetto i testi della serie di P; qualora un elemento si trovi distanziato dagli altri, lo faccio precedere da tre punti. codici» 11, e non, secondo l’accezione gröberiana: «Sammlungen von Liedern eines und desselben Dichters, von ihnen selbst oder von ihren Bewunderern angefertigt» 12. Pur in assenza di elementi che permettano di determinare la responsabilità della raccolta, si può comunque affermare che il gruppo ha avuto una vicenda manoscritta comune e costituisce uno dei nuclei principali della tradizione folchettiana. § 1.1.2. I testi del gruppo sinora esaminato, per venire al secondo ordine di indicazioni ricavabili dall’analisi della tradizione manoscritta, sono collocati in genere nella parte iniziale della sezione folchettiana: così nei canzonieri ABCDFaGIKMNQSUVc (ma anche in f). Si può inoltre notare che i componimenti tràditi in T, della cui complementarità con la seconda sezione di P si è già accennato, sono generalmente collocati, sebbene con minore nettezza, subito dopo il primo gruppo: così nei mss. ABCDGIKMc (e cfr. SUV). Entrambe le serie, eccetto la canzone 6, sono assenti in Da, i cui componimenti (2 6 13 15) sono collocati in fondo alla sezione folchettiana in altri testimoni: così nei mss. ABCENQT (e cfr. IKOVf). Se la distribuzione non è casuale, ai tre gruppi di testi corrispondono altrettanti canali di alimentazione dei canzonieri: chiamo tradizione quella isolabile nella seconda sezione di P, tradizione quella che ha alimentato T 13 e tradizione quella che ha fornito i testi a Da 14. 11 Riprendo la definizione di Battelli 1992, p. 597; cfr. anche Brunetti 1990, p. 49, n. 5. Gröber 1877, p. 345; così definito, il termine Liederbuch andrebbe riservato a casi come quello di GrRiq studiato da V. Bertolucci Pizzorusso, Il canzoniere di un trovatore: il «libro» di Guiraut Riquier [1978] in Bertolucci 1989, pp. 87-124 o quello di PVid ricostruito da Avalle 1960, I, pp. XXXV-XXXIX (l’ipotesi di Riquer 1975, I, p. 17 sul libro di PoGarda è stata messa in discussione da Zufferey 1987, pp. 232-33; cfr. anche Bertolucci Pizzorusso 1991, p. 276, n. 6). Oppure a raccolte come quella di PCard messa insieme da Miquel de la Tor, su cui si vedano Zufferey 1987, pp. 293-309, G. Brunetti, Intorno al Liederbuch di Peire Cardenal ed ai ‘libri d’autore’: alcune riflessioni sulla tradizione della lirica fra XII e XIII secolo, in Atti Zurigo 1993, pp. 57-71 e ora Vatteroni 1998, pp. 7-45. Sull’argomento in generale hanno particolare rilievo le messe a punto di V. Bertolucci Pizzorusso, Libri e canzonieri d’autore nel Medioevo: prospettive di ricerca [1984], in Bertolucci 1989, pp. 125-46, di d’A. S. Avalle, I canzonieri: definizione di genere e problemi di edizione, in Atti Lecce 1984, pp. 363-82 e di L. Formisano, Prospettive di ricerca sui canzonieri d’autore nella lirica d’oïl, in Atti Messina 1993, I, pp. 131-52. 13 Nel ms. i componimenti folchettiani aprono la sezione siglata T3b da Gröber 1877, pp. 522-34, risalente a una fonte m+t3b, dove m corrisponde grosso modo a y: cfr. Avalle-Leonardi 1993, p. 90. Dell’influsso di , a cui risale la fonte k+t attiva principalmente nella prima sezione del canzoniere (siglata T3a da Gröber), anche su questa sezione, e viceversa di y su T3a, si occupa Brunetti 1990. 14 Questa fonte corrisponde all’originale del Liber domini Alberici, che Avalle sigla , e che costituisce una delle fonti di : cfr. Avalle-Leonardi 1993, p. 79-80 (dove si modifica parzialmente la ricostruzione di Gröber); M. L. Meneghetti, Uc de Saint Circ tra filologia e divulgazione (su data, formazione e fini del Liber Alberici), in Atti Treviso 1991, pp. 115-28 bipartisce Da in due sezioni, la prima delle quali (cc. 153-185v, comprendente dunque la sezione folchettiana) «mostra tratti di notevole organicità e connotati di tipo aulico», mentre la seconda (cc. 185v-211) «sembra più frammentari[a], come se si fosse costituit[a] a partire da 12 Esse coprono quasi l’intera produzione folchettiana; restano fuori dalla classificazione, oltre al planh 20, alcuni componimenti a tradizione ridotta o unica: il partimen 24 (Ra), l’alba 26 (CRf), il Bußlied 19 (R + Ol e Pe), le canzoni 4 (T) e 12 (L), e l’estribot 25 (Q). Anticipando che Asperti 1994 ha collegato 4 e 12 a una tradizione provenzale (in senso proprio) 15, si può notare una prevalenza di codici risalenti alla costellazione y di Avalle: si potrebbe pertanto pensare che questi testi siano relitti di una tradizione, che definisco (da R, ms. che attesta il maggior numero di poesie) non giunta nella sua integrità in Italia e un tempo più ricca. Diverso appare il caso del planh per la morte di En Barral, tràdito da ABDIKNPQRVa, la cui tradizione estravagante può essere dovuta al suo carattere di testo d’occasione: va notato infatti che l’unico Liederblatt occitanico materialmente sopravvissuto contiene, come già ricordato, proprio un planh per la morte (nel 1272) di Giovanni di Cucagna 16. La successione -- è riscontrabile, con gradi variabili di nettezza, in ABCDGIKMNPQSUVc, ma anche in codici meno ricchi di testi come W e Fa o in E, dove dopo due soli testi di sono tràdite solo poesie di e . Non è invece riscontrabile in DcN2Ra, perché i testi sono mescolati, in JKpLf per la presenza dei testi di una sola tradizione, oltre che in AbVeAgYb, mss. caratterizzati dall’esiguità dei pezzi tramandati. I testi 5 e 14, comuni alle tradizioni e , fanno talora da ‘sutura’ fra le due tradizioni stesse: il fenomeno è ben verificabile nei mss. ABCG (in P si trovano significativamente in coda alla seconda sezione folchettiana); altrove i due testi si trovano attigui o comunque ravvicinati: vd. i mss. IKLN2MOPQSTa (e cfr. anche N). La loro compresenza in due diverse tradizioni discende dal percorso comune nella tradizione manoscritta (cfr. gruppo I nel § 1.1.1), costituendo insieme con 18, a cui talora si accompagnano (mss. ABCIKNPS; vd. anche 18 5 in Dc, 14 18 in J, 18 14 in U), un residuo di Liederblatt. Fra le ‘intrusioni’ di testi di una tradizione in un’altra va messa in rilievo quella del testo 10 (di ) in : il fenomeno si registra nei mss. AB (con 7) e in CDJKpMOUac; d’altro canto 10 è presente sia nel gruppo II, sia nel gruppo VI definiti supra nel § 1.1.1. La frequente posizione incipitaria di 16 (cfr. i mss. CEGJMQ SUVeAgc; e inoltre apre la seconda sezione di P, è preceduto solo da un testo spurio in V, ed è, sebbene isolato, il primo testo tràdito nel ms. L) è segnalata dalla redazione del ms. R della vida, che così termina: Et aysi trobaretz de las suas chansos la qual es premieyra per dieu amors be sabetz ueramen. E in R il testo apre a c. 51v la sezione siglata R6 da Gröber. lacerti sparsi, quali fogli volanti o raccoltine d’occasione» (citazioni a p. 119, ma si vedano tutte le pp. 117-20). 15 Rimando alla Nota al testo delle rispettive edizioni. 16 Cfr. Avalle-Leonardi 1993, p. 62 (e l’edizione di Grattoni 1982). In DIKNPQ e N 2 il planh 20 segue, con inversione dell’ordine logico e cronologico, la canzone di crociata 7, nella quale viene ricordata la morte di Barral. La situazione si può descrivere con le parole usate da M. L. Meneghetti nella Discussion successiva all’intervento di Bertolucci Pizzorusso 1991: «L’impressione è quella di una doppia tradizione: gira il corpus compatto, girano le canzoni isolate» (p. 302). Ho cercato infine una verifica dei dati proposti attraverso un’analisi a campione delle 17 sequenze dei componimenti in altri trovatori , rintracciando una situazione analoga nella 18 tradizione di BnVent : anche qui il ms. P tramanda, oltre al testo isolato 15, otto componimenti, nell’ordine: 41 43 25 16 1 31 7 42, che si ritrovano sostanzialmente all’inizio delle sezioni dedicate al limosino; localizzati, come nella tradizione di a Folchetto, in fondo alla sezione sono i testi tràditi in D : 39 45 22 26 9 4 13 38 15 23 e GcFaid 167,49 ovviamente attribuito a BnVent. I due raggruppamenti sono complementari e distanziati nella collocazione, per cui posso individuare dietro essi le tradizioni e di 19 cui si è detto sopra. Rispetto a Folchetto, né T, che si limita a tramandare 5 testi , né altri singoli codici conservano le tracce di una terza tradizione; è possibile tuttavia scorgere qualcosa di simile a monte dei 14 componimenti comuni ai mss. ADCIKN 2R (in ordine alfabetico): 6 8 10 12 17 19 27 28 29 30 33 35 36 44: la serie si trova ridotta a 12 elementi in N (om. 6 e 35) e in a (om. 17 30), ridotta a 11 elementi in Q (om. 8 28 44) e ridotta a 10 elementi in G (om. 8 27 29 44). In linea di massima questa tradizione, che si può definire , alimenta la parte centrale della sezione bernardiana, pur togliendo più spesso che in Folchetto a il privilegio di aprire il canzoniere individuale. Esiste infine un’ulteriore tradizione costituita, come la tradizione ipotizzata per FqMars, da componimenti di attestazione esigua e imperniata su codici d’Oltralpe, soprattutto C e V: 5 (V), 11 (CE), 18 (Ca), 20 (V), 24 (CEW), 34 (Vf), 40 (C); si aggiungano inoltre: BnVent 70,3, tràdito da CMRSa e cit. in N2, anonimo in Si e attribuito a PVid in DaH; BnVent 70,21, tràdito in CGMNRSa, anonimo in O e attribuito a Salhd’Es da D aIK e a GlAdem da E; a questa tradizione risale anche BnVent 70,37 testimoniato da CGMNRVa e da A che lo relega significativamente in fondo al canzoniere bernardiano. Solo tre tenzoni restano fuori dai quattro raggruppamenti summenzionati, perché tramandate al di fuori delle sezioni dedicate al trovatore: BnVent-PAuv 70,2-323,4 (ADEGIKLW); BnVent-Lemozi 70,14-286,1 (LOa) e BnVent-Peirol 70,32-366,23 (ADIKN) . 20 Tracce della tradizione si trovano in BgPal : il ms. Da testimonia quattro testi: 326,1 9 1 2, che costituiscono l’intero corpus del trovatore in IK (vida 9 1 2 ... 326,1) e 3/4 del corpus di f (9 1 5 ... 326,1). Può essere significativo che tre dei quattro 21 componimenti di Da sia costituito da testi di attribuzione dubbia (2 9 326,1) : anche in Folchetto 2 poesie su 4 tràdite in Da (155,2 e 155,13) hanno attribuzioni non univoche. Anche nella tradizione di DPrad i tre testi di Da: 6 11 2 (trad. ) compaiono compatti alla fine di A (6 11 2) e, nel medesimo ordine all’inizio di IK; 6 e 11 costituiscono l’intero corpus del trovatore in G, mentre 6 2 10 11 sono gli unici testi tràditi in O (6 2 adespoti). § 1.1.3. Le osservazioni sin qui fatte consentono di stabilire l ’ o r d i n e d i s u c c e s s i o n e dei testi nell’edizione: in linea di principio, sarebbe stato 17 Ho preso in considerazione quei trovatori nelle cui edizioni fosse inclusa una tavola con l’ordine di successione dei testi nei singoli manoscritti: AimBel, ArnDan, BgPal, BnVent, BtBorn, Cercam, Gauvaud, GsbPuic, Perd, RmJord, RicBarb, ho ricostruito sui codici le sequenze dei testi di Palais, PMula e PVid, e ho usufruito, grazie alla gentilezza di Claudia De Vecchi, Silvio Melani e Sergio Vatteroni, delle tavole di Blac e Blacst, DPrad e PCard. 18 Utilizzo la tavola approntata da Appel 1915, p. CXLIII; indico i testi con il n° della BdT. 19 Ovvero 22 (in posizione isolata, risalente a ), Peirol 366,1 (spurio), 1 e 25 (risalenti a ) e 28 (anch’esso in posizione isolata, risalente alla tradizione ). 20 Cfr. la tavola di Beretta Spampinato 1978, pp. 53-54; indico i testi con il n° della BdT. 21 2 è attribuito a BgPal in DIK, a GlBerg in C, al MoMont in R e a AimBel in f (in E si legge solo magret); 9 è assegnato a BgPal in DIK, a Joan Aguila (altrimenti ignoto: cfr. BdT, n° 264) in CR, a ArnCat in E; 326,1, schedato da Pillet sotto PBarj, cui lo dànno DIK, è attribuito a BgPal in CR, a GlTor in M, a UcSt-C in T, a PoChapt in a, a ElBarj in f (anonimo in GLU). preferibile conservare l’ordine di Stroński, ma con ciò si sarebbe in qualche modo ratificato un itinerario poetico di Folchetto a mio parere del tutto infondato. L’edizione Stroński comprende ventinove componimenti fra autentici, dubbi e spuri, due in più rispetto alla scheda della BdT (che ripropone il canone di Bartsch 1872), dove vengono assegnati ai rispettivi autori Perd 370,9 Los mals d’Amor ai eu ben totz apres (I), attribuito da tre codici a Folchetto, e AimBel 9,10 Consiros, com partitz d’amor (I), ascritto al marsigliese dall’editore. Questo l’ordine dei testi 22: i = 5, ii = 22, iii = 23, iv = 27, v = 8, vi = 6, vii = 18, viii = 14, ix = 1, x = 3, xi = 21, xii = 16, xiii = 10, xiv = 11, xv = 24, xvi = 25, xvii = 20, xviii = 7, xix = 15, xx = 2, xxi = 13, xxii = 4, xxiii = 12, xxiv = 9, xxv = 17, xxvi = 370,9, xxvii = 9,10, xxviii = 26, xxix = 19. Stroński distingue il corpus in due gruppi principali: le poesie di attribuzione indubitabile (ni i-xix) e quelle di paternità dubbia (ni xx-xxix). All’interno delle due serie l’editore opera raggruppamenti per genere: fra i testi definiti di attribuzione sicura sono canzoni d’amore i testi numerati da i a xiv, il xv è un partimen, il xvi una cobla, il xvii un planh e sono canzoni di crociata gli ultimi due items (xviii-xix); fra i testi di attribuzione dubbia sono canzoni d’amore le prime sette (xx-xxvi), la xxvii è una canzone di crociata, i ni xxviii-xxix sono infine poesie religiose. L’ordinamento dei componimenti autentici è cronologico: secondo la ricostruzione di Stroński, Folchetto avrebbe scritto solo canzoni d’argomento amoroso dal 1179-80 fino al 1193-94, producendo bonas chansos, cioè poesie in cui parla positivamente dell’amore, fino al 1190 (testi i-ix); con la canzone x, datata 1190, il trovatore avrebbe cambiato maniera, scrivendo solo malas chansos con giudizi sfavorevoli verso l’amore (testi x-xiii). Il 1192, anno di morte del visconte di Marsiglia Raimon Jaufre Barral cui Folchetto dedica un planh (n° xvii), segna un passaggio ad argomenti più ‘impegnati’ e, dopo l’ultima canzone d’amore del 1193-94 (n° xiv), il 1195 vedrebbe la composizione delle due canzoni di crociata, a sostegno di una spedizione in Terrasanta la prima (n° xviii), per sollecitare l’intervento in Spagna dopo Alarcos la seconda (n° xix). Con il partimen con Tostemps (n° xv) e la cobla per Vermillon (n° xvi), composti durante gli anni della prima maniera, si chiude la serie dei componimenti autentici. Il 1195 è anche l’anno in cui Stroński suppone che sia avvenuta la monacazione di Folchetto, ampiamente preparata dalla produzione poetica precedente, e con essa l’interruzione di ogni attività letteraria. I testi considerati di dubbia paternità (ni xx-xxix) sono quasi tutti attribuiti dall’editore ad altri trovatori o, in mancanza di testimonianze alternative, sono semplicemente tolti a Folchetto; fa eccezione, come si vedrà, solo la canzone di crociata n° xvii. Una ricostruzione quella di Stroński fin troppo lineare e che insospettisce proprio in ragione della sua scorrevolezza. 22 Indico con il numero romano (in minuscolo per evitare confusioni con le mie numerazioni) l’ordine dell’edizione Stroński e con quello arabo il riferimento alla numerazione della BdT. All’ipotesi dell’editore se ne può opporre una alternativa fondata sull’esame della tradizione manoscritta, che mostra come le tradizioni , e si presentino in quest’ordine di successione nella maggior parte dei canzonieri; ai testi ivi compresi andranno aggiunti il planh 20, a tradizione estravagante, e i sei componimenti risalenti a quella che ho definita tradizione . i) La tradizione , composta di sole canzoni d’amore con notazione musicale, comprende infatti i due componimenti databili più antichi, 5 e 22 (cfr. infra i §§ 1.3.1.1-2) che, come nell’edizione Stroński, prenderanno rispettivamente i numeri I e II; e una serie di sei canzoni, 18 14 1 3 21 16, che Stroński numera progressivamente (vii-xii) e che quindi numero nello stesso ordine da III a VIII. Dell’analisi di Stroński, rigettate le conseguenze cronologiche 23, si possono recuperare le indicazioni sulle tornadas, che dalla canzone III in poi sono indirizzate ad Aziman e a Tostemps (solo al primo in III) che prendono «l’allure de petits propos sur l’amour et sur la poésie» (p. 69*) e le indicazioni sui tratti comuni fra i testi IV-VI e VII-VIII (pp. 72*73*: cfr. infra il § 1.3.2). ii) La tradizione riunisce sette canzoni d’amore (cinque con notazione musicale: ne sono prive 9 e 17, peraltro di attribuzione non univoca) e la canzone di crociata 7; anche qui non mancano simmetrie con la sistemazione di Stroński: sono riuniti infatti i tre componimenti del ‘ciclo dell’emperairitz’ (23 27 8) di data abbastanza alta, ma successivi alle canzoni I-II (cfr. infra i §§ 1.3.1.3-5), e perciò numerati rispettivamente iii, iv e v da Stroński; in maniera analoga li pongo in apertura di gruppo coi numeri IX, X, XI. Li faccio seguire dall’ultima mala chanso 10 e da 11, che risulta l’ultima canzone d’amore databile (cfr. infra il § 1.3.1.9), poste in successione da Stroński coi ni xiii-xiv (cfr. pp. 73*-74*), e così anche da me, ma coi ni XIIXIII. A quest’ultima faccio seguire, col n° XIV, la canzone di crociata 7, che è cronologicamente posteriore (cfr. infra il § 1.3.1.10); e quindi le due canzoni d’amore di attribuizione non univoca 9 (n° XV) e 17 (n° XVI). iii) La tradizione comprende la canzone 6 (come tutte le altre da qui in poi senza notazione musicale), la canzone di crociata 15 (sulla cui data si veda infra il § 1.3.1.11) e due altre canzoni di attribuzione controversa 2 e 13: le numero in quest’ordine, notando che anche nell’ed. Stroński 2 e 13 sono edite di séguito ai ni xx e xxi; quindi: 6 (n° XVII), 15 (n° XVIII), 2 (n° XIX), 13 (n° XX). iv) Dopo il planh 20 (n° XXI) presento i componimenti della tradizione , nella quale si raccolgono scampoli di una produzione folchettiana che parrebbe essere stata più ampia di quella conservata. Anche qui mantengo la successione, e in due casi la numerazione, di Stroński: le canzoni 4 e 12 mantengono i ni XXII e XXIII, il partimen 24 e l’estribot 25, numerati xvxvi da Stroński diventano XXIV e XXV, e infine i due componimenti 23 Di questo secondo gruppo solo FqMars 155,3 (IV) offre un appiglio storico per la datazione (cfr. § 1.3.1.6). religiosi 26 e 19 che chiudevano l’edizione con i ni xxviii e xxix, sono posti anche qui in posizione estrema con i ni XXVI e XXVII 24. 1.2. Poesie di attribuzione controversa. Lo «chansonnier authentique» folchettiano ricostruito da Stroński costituisce certamente il ‘nucleo’ del corpus poetico del trovatore; ad esso andranno però aggiunti alcuni dei dieci componimenti classificati come dubbi dall’editore; di altri è invece dimostrabile la completa estraneità al trovatore. Contro l’opinione di Stroński vanno riassegnati a Folchetto due componimenti a tradizione unica, ascritti dalle rubriche al marsigliese, ovvero le canzoni FqMars 155,4 (XXII) e 155,12 (XXIII); e, con qualche riserva, il Bußlied 155,19 (XXVII), che accanto all’unica versione occitanica, ancora ascritta a Folchetto, ne registra altre due catalane, ma adespote. Gli argomenti a carico dell’apocrifia non mi paiono infatti sufficienti a invalidare il dato positivo della rubrica: è possibile anzi offrire qualche indizio che conforti la paternità folchettiana 25. § 1.2.1. A vos, midontç, voill retrair’ en cantan. Il primo testo, FqMars 155,4 (XXII), noto per essere stato oggetto di traduzione da parte di Giacomo da Lentini 26, è attestato frammentariamente (due coblas, la seconda mancante di un verso) dal solo ms. T (c. 233r) che lo assegna a folcet de marseila; l’argomentazione di Stroński: «Cette attribution d’une pièce fragmentaire par un ms. unique et qui la met à la fin des chansons de Folquet ne saurait avoir une force probante bien grande» (p. 126*), ha l’aria di una petizione di principio (l’argomento della collocazione del testo a fine sezione sarà trattato complessivamente più avanti nel § 1.2.8). L’attribuzione a Folchetto è spiegata altrettanto debolmente con accenno nel testo all’«arguogll gran» di v. 3 che può ricordare la cobla d’avvio di FqMars 155,16 (VIII), costruita sulla contrapposizione fra Orgoglio e Umiltà 27. L’ipotesi di Stroński, già respinta da Monteverdi 1971, p. 285 e da Roncaglia 1975, p. 25 28, non si misura col fatto 24 Le ragioni della riduzione del corpus rispetto all’ed. Stroński sono ampiamente spiegate infra nel § 1.2 (per i testi esclusi cfr. §§ 1.2.5-6). 25 Al contrario, nel caso della cobla (o meglio estribot, come si vedrà) FqMars 155,25 (XXV), anch’essa tràdita nel solo ms. Q, è Stroński a difendere l’attribuzione della rubrica contro gli argomenti di De Lollis 1897, pp. 131-32 (cfr. p. 121*). 26 Rimando al Commento all’edizione del testo. 27 Dà invece credito all’argomentazione di Stroński Meneghetti 1994, pp. 170-71, per la quale il recupero sarebbe «troppo vistoso e goffo per essere un auto-recupero» (p. 171); tuttavia la studiosa, nel definire «esemplare» l’intera indagine attributiva dell’editore polacco, si limita a descriverla in generale, senza apportare ulteriori argomenti in suo favore (cfr. le pp. 169-175 e 177; per le singole considerazioni, talora ineccepibili, della Meneghetti si vedano qui sotto i §§ 1.2.4-5, 1.2.7-8). 28 La paternità folchettiana è data per scontata da Antonelli 1987, da Bruni 1988 e da Asperti 1994. che Folchetto è trovatore fra i più imitati dai poeti della Sicilia federiciana (si veda infra il § 3.2.2.4) ed è pertanto plausibile che proprio a Folchetto si sia indirizzato l’interesse del Notaro. È pur vero che Giacomo avrebbe potuto credere folchettiano un testo apocrifo, come il Petrarca di Rvf. 70 29, tratto in inganno dall’operazione di un imitatore: anche qui lo stile richiama quello tipico di Folchetto, basato sull’elaborazione retorica di pochi concetti, che amplificati da figure di antitesi, paradossi, espressioni proverbiali e gnomiche, arrivano a occupare e strutturare l’intero testo: si vedano i vv. 5-11 sulla morte per amore e i vv. 14-21 sull’ardore amoroso. § 1.2.2. Ja non volgra q’hom auzis. All’interno di questo gusto retorico, la canzone FqMars 155,12 (XXIII), tràdita dal solo ms. L (cc. 26v-27r, rubrica: folqet de marxella) pare quasi un corpo estraneo; almeno tale è considerato dagli estensori delle prime storie letterarie provenzali nel secolo scorso: già Fauriel 1846, vol. II, p. 73 la contrappone alle altre composizioni di Folchetto, per le quali il trovatore gli appare «outre mesure affecté et recherché», riconoscendo in questa poesia «un ton plus vif et plus léger, où la grâce touche bien déjà à la manière, mais ne s’y perd pas encore». La godibilità del testo ha poco giovato alla sua fortuna, se è vero che Meyer 1877, p. 474 nega decisamente l’attribuzione a Folchetto proprio per lo stile del componimento oltre che per la sua collocazione nel codice. Il testo si trova alla fine di un gruppo di poesie del marsigliese, tutte di attribuzione incontestata e a ridosso di GsrSt-Did 168,1 (Sakari 1963, p. 313), attribuita nel ms. a Folchetto. Paul Meyer ipotizza che il testo folchettiano sia appunto di Gauceran de SaintDidier (o di suo nonno Guillem de Saint-Didier, a cui i mss. CRT attribuiscono GsrSt-Did 168,1) e che il copista, dopo una serie di 5 testi attribuiti a Folchetto, abbia dimenticato di cambiare il nome nella rubrica. Meno perentorio nelle conclusioni rispetto a Meyer, Pätzold 1897, p. 70, n. 1, dubita dell’attribuzione ma, nello stesso tempo, rintraccia nel testo alcuni elementi che la confermano. Come elementi estranei a Folchetto Pätzold nomina l’esordio naturale, oltre allo stile dell’intero componimento 30; al testo manca il tono didattico peculiare del trovatore e i suoi senhals caratteristici, e la descrizione delle preferenze di chi dice io nel testo «ist sonst nicht Folquets Art». A conferma dell’indicazione della rubrica lo studioso nota che il sintagma «sa beltatz e·l dolz ris» (v. 28) si trova anche in FqMars 155,22 (II), 22 versione , e che dietro l’allusione al signore del Limosino si cela Riccardo Cuor di Leone, citato esplicitamente da Folchetto in 155,3 (VI), 33. Stroński ripete il ragionamento di Meyer, sottolineando il fatto che la canzone si trova in coda a testi di Folchetto, quindi, a suo dire, di per sé in posizione sospetta ai fini dell’attribuzione, e giustifica l’assegnazione al marsigliese con la presenza nel testo di elementi caratteristici del suo repertorio (cfr. p. 127*). 29 Che, com’è noto, credette arnaldiana la canzone GlSt-Greg 233,4 (Beltrami 1987, p. 13); diversa (GlMur) l’attribuzione di Perugi 1985, ribadita da ultimo in Perugi 1990b. 30 A supporto della sua affermazione, Pätzold utilizza il passo di Fauriel citato sopra. Gli argomenti proposti dagli studiosi summenzionati non mi sembrano sufficienti a mettere in dubbio l’attribuzione della rubrica. Per quanto concerne lo stile di Folchetto e l’utilizzo che ne fa Stroński in sede di attribuzione rimando al § 1.2.9; qui interessa discutere della posizione del testo nel ms. e delle sue conseguenze sulla paternità del componimento. La rubrica di GsrStDid 168,1 è in realtà doppia: al nome di Folchetto il correttore del codice fa seguire uel ioseram de sain desider 31, rubrica ricavata, secondo Sakari 1963, pp. 306 e 326, dal ms. S. Tuttavia la doppia attribuzione di GsrSt-Did 168,1 potrebbe rivelarsi piuttosto un indizio della paternità folchettiana di Ja non volgra, perché è ipotizzabile che il copista abbia dimenticato di cambiare il nome in rubrica dopo i testi di Folchetto (compreso Ja non volgra) o che – come ipotizza ancora Sakari 1963, p. 306 – si sia fatto ingannare dalla vicinanza in altri codici dei testi dei due trovatori, provocando così l’intervento integrativo del revisore. L’attestazione unica della canzone, elemento che di norma suscita il sospetto di Stroński, è ben spiegata da Asperti 1994 con l’appartenenza del testo a una tradizione provenzale (in senso proprio) cui risalirebbe anche FqMars 155,4 (XXII): si veda la Nota al testo di entrambi i componimenti per ulteriori specificazioni; dell’attribuzione Asperti scrive: «La parenté de tradition entre L et T ne constitue pas à elle seule un argument suffisant pour amener à une révision du jugement de Stroński, mais c’est pourtant une donnée à ne pas négliger a priori» (p. 59). Altro indizio a favore dell’attribuzione della rubrica può essere la ripresa dello schema metrico e delle rime del testo da parte di BtBorn 32, trovatore che ha stretti legami con Folchetto, e da Palais 33, che credo debba identificarsi con l’esecutore cui Folchetto affida la canzone 155,11 (XIII) (cfr. infra il § 3.2.1.2.2). Si esprime per l’attribuzione al marsigliese anche Beltrami 1989, pp. 21-22, n. 38, che, oltre a sottolineare la necessità di una fiducia metodologica nelle rubriche attributive dei canzonieri, fa intendere che l’affermazione del poeta, contenuta implicitamente nella tornada, di trovarsi a Sud del Limosino si accorda con la ‘geografia’ di Folchetto: quanto allo stile, Beltrami rileva che esso «è più semplice di quello usuale in Folchetto, ma tutt’altro che inelegante». § 1.2.3. Senher Dieu[s], que fezist Adam. La poesia religiosa FqMars 155,19 (XXVII), tràdita in occitanico dal solo canzoniere d’Urfé (c. 131r), è assegnata dalla rubrica, in accordo con la tavola (cfr. Tavera 1992, p. 92), a folquet de marsselha; sono adespote le due versioni catalane del componimento. L’attribuzione è rimasta incontestata sino al 1897 34, quando Rudolf Zenker ha proposto di assegnare il testo a FqRom (cfr. Zenker 1897, pp. 337-38); in 31 Lo rileva lo stesso Stroński a p. 122*, che tuttavia ha visionato solo una riproduzione fotografica del cod. (la mia visione diretta del ms. conferma il dato); sul correttore di L si veda la Nota al testo di FqMars 155,1 (V). 32 Nel sirventese BtBorn 80,8 (XXXV); cfr. Frank 1953-57, n° 541:2. 33 Nel sirventese Palais 315,2 (II); cfr. infra la Scheda metrica di FqMars 155,12 (XXIII). 34 Pertanto attribuiscono a Folchetto i due primi editori del componimento Raynouard nello Choix, IV, p. 394 (e quindi MW, I, p. 332), e Galvani 1829, p. 284. precedenza lo studioso aveva rispettato la rubrica facendo di essa un argomento per attribuire a FqMars anche l’alba religiosa FqMars 155,26 (XXVI), legata contenutisticamente al nostro testo e contesa fra quest’ultimo e FqRom 35: secondo Zenker la lingua del testo 36, il metro 37 e lo stile 38, e una somiglianza fra un suo verso e uno dell’alba, assegnata nel medesimo articolo a FqRom 39, inducono ad assegnare la poesia al trovatore di Romans. Tali argomentazioni, autorevolmente confermate da Paul Meyer e Joseph Anglade 40, sono state contestate da Stroński: oltre a ridimensionare gli argomenti linguistici, l’editore argomenta che gli octosyllabes a rima baciata sono usati dai trovatori «dans des cas spéciaux et [...] le rapprochement entre une épître d’amour et une poésie religieuse bien déterminée ne saurait être pris au sérieux» (p. 137*) 41; che il confronto fra i due testi concerne immagini le quali «d’ailleurs bien distinctes, remontent à la langue liturgique et ne sont pas surprenantes dans des poésies religieuses» (p. 137*); e infine, che la lontananza stilistica del testo dalle altre composizioni di FqMars non è maggiore rispetto a quella che registra il planh 155,20 (XXI), né Senher Dieu[s] rispecchia appieno lo stile di FqRom. Per Stroński l’autore è un poeta anonimo, «un vrai poète, qui sait trouver des expressions heureuses même pour les images qu’il imite et dont l’effet, souvent si puissant dans les hymnes latines, n’est pas diminué dans ce beau poème» (p. 139*). L’ascrizione a FqMars e quella congetturale a FqRom sono escluse in quanto nel testo è sistematicamente evitata l’elisione, normale nella produzione dei due poeti; Stroński ritiene, infine, che l’attribuzione del ms. R sia un riflesso della celebrità della carriera religiosa del marsigliese. Nella loro edizione delle poesie di FqRom, Raymond Arveiller e Gérard Gouiran hanno ripercorso la questione, centrando l’attenzione sulla lingua del testo, fatta risalire ad un’epoca tarda, posteriore a quella dell’attività dei due trovatori; nell’accettare la posizione di Stroński editano il componimento fra i 35 Zenker 1896, p. 6; per la questione attributiva dell’alba si veda il § 1.2.4. Alcune forme in rime, quali 21 malenconi (: demoni) e 113 clors (: mors) presenterebbero tratti tipici della lingua di Romans nel Delfinato, quali la caduta di -a finale, con ritrazione dell’accento, e la riduzione di AU > ò, assenti in quella di Marsiglia. 37 I distici di octosyllabes, mai usati dal Marsigliese, sono utilizzati da Falquet de Romans nel salut Domna, eu pren comjat de vos (Arveiller-Gouiran 1987, n° XIV). 38 «Der Stil des Gedichtes ist der des Folquet von Romans, nicht der des Folquet von Marseille; es ist, wie die Epistel, flott geschrieben, der Ausdruck frisch und unmittelbar; keines von den Liedern Folquet’s von Marseille bietet etwas Aehnliches» (Zenker 1897, p. 338). 39 FqMars 155,19 (XXVIII), 100: «met me e·l tieu sant habitacle» e 155,26 (XXVII), 67: «e·ns meta dins sa tenda»: in entrambi i casi il soggetto è Dio. 40 P[aul] M[eyer], nota firmata all’interno della rec. di G. Paris, al vol. XXI (1897) della ZrPh, in Rom, XXVI (1897), pp. 580-86, a p. 585; J. Anglade, rec. ai tomi XX (1896) e XXI (1897) della ZrPh, in RLR, XLII (1899), pp. 475-87, a p. 485; dà ragione a Zenker anche Pillet che scheda il testo sotto FqRom al n° 156,12a della BdT (155,19 è il numero assegnato da Bartsch 1872, p. 130). 41 A proposito del medesimo accostamento l’editore scrive poco dopo: «C’est traiter les problèmes des genres littéraire avec une désinvolture vraiment déconcertante» (p. 138 * in nota). 36 testi di dubbia attribuzione 42. Da ultimo Jean-Pierre Chambon, dopo un’analisi esclusivamente linguistica del testo, e senza conoscere la tradizione catalana, ha concluso che autore del testo è un catalano o, meglio «catalanophone écrivant en occitan» (Chambon 1995, p. 131), ma le sue interessanti osservazioni andrebbero ora vagliate alla luce di tutta la documentazione disponibile. Questi sono gli argomenti di chi ritiene falsa, o almeno dubbia, l’attribuzione della rubrica del canzoniere 43. L’argomento più rilevante si può considerare quello linguistico. Da un lato, Senher Dieu[s] smentirebbe l’ ‘orrore dello iato’ caratteristico secondo Stroński di FqMars, di FqRom e degli altri trovatori 44: ma mi sembra difficile poter sostenere ancora un’affermazione così recisa, dopo gli studi di Perugi 1978, che ha esaminato e documentato in un gran numero di casi le reazioni dei copisti che eliminano dialefi e dieresi, mal tollerate in certe fasi della tradizione manoscritta, ma evidentemente non dagli autori. Dall’altro lato, le irregolarità della lingua del testo sembrano deporre per un autore più tardo dei due proposti, e comunque di Folchetto: ma è possibile riferirle in massima parte alla tradizione manoscritta. Inoltre la data del testo ha il suo limite superiore nel 1276, anno della copia del più antico dei testimoni catalani, Ol 45 A fronte di questo, l’attribuzione fornita dal manoscritto (che, a mia notizia, è stata accettata, quando ciò è avvenuto, in forma apodittica e senza una discussione delle argomentazioni in contrario sopra esposte 46), potrà parere non molto autorevole di per sé, ma non merita nemmeno di essere rifiutata, come dato ‘positivo’ cui si contappongono argomenti tutt’altro che dirimenti. Un indizio si può anzi portare a sostegno: la localizzazione stessa di R nel Tolosano proposta da François Zufferey 47 in relazione all’attività episcopale che Folchetto svolse proprio a Tolosa fra il 1205 e il 1231: circostanza che acquista spessore se si considera che la sez. R13 in cui è vergato Senher Dieu[s] contiene altri 42 Arveiller-Gouiran 1987, pp. 205-20; dell’unico argomento di Zenker non contestato da Stroński i due editori scrivono: «on doit admettre que le dialectalisme clo(r)s dans un passage obscur ne saurait suffire, dès lors que l’argument sur le contenu perd beaucoup de sa vigueur, pour désigner Falquet de Romans comme auteur de ce poème» (p. 206). Fraintende i termini della questione Brunel-Lobrichon 1991, p. 251, n. 34, che coonesta l’attribuzione a FqRom con il rimando all’edizione di Arveiller-Gouiran; così come è falso che «Les arguments de Zenker ont convaincu les derniers éditeurs du troubadour de Romans» (Zufferey 1994, p. 28, n. 30). 43 Anche Asperti 1985, p. 91 afferma che «Il testo è indubbiamente duecentesco e con ogni probabilità provenzale – anche se certamente non di Folquet de Marseilla e verosimilmente neppure di Falquet de Romans». 44 Per Stroński sia Folchetto che Falquet, come «tous les troubadours, abhorrent l’hiatus et l’élision apparaît régulièrement dans toutes leurs poésies» (p. 139*). 45 L’altro, Pe, è datato dal colofone al 1378 (cfr. infra la Nota al testo della mia edizione). 46 Fra gli studi successivi a Stroński vd. Picchio Simonelli 1974, p. 201, n. 34 e ThiolierMejean 1978, p. 373. 47 Zufferey 1987, pp. 130-33; una conferma viene da Brunel-Lobrichon 1991, pp. 19-20 (cfr. Zufferey 1994, p. 1 e n. 1). componimenti di poeti tolosani o comunque linguadociani 48. Un secondo elemento emergerà nel paragrafo successivo. Tutto ciò considerato, e pur con le dovute cautele che in questi casi non possono essere abbandonate, mi sembra ragionevole dare fiducia alla rubrica attributiva e mantenere il testo entro il corpus delle poesie Folchetto di Marsiglia. Tuttavia, il recente intervento di Chambon 1995 induce a un supplemento di prudenza: al di là dei singoli tratti linguistici, che possono essere discussi sia in sé, sia in rapporto alla tradizione catalana 49, se resta escluso che il testo occitanico possa derivare da quelli catalani, è forte l’impressione che manchino alcuni anelli della catena che procede dall’inattigibile originale (occitanico con tratti catalani se ha ragione Chambon, occitanico tout court se ha ragione la rubrica di R) ai testimoni conservati, per lo meno una copia (ancor più) catalanizzata interposito di Ol e Pe. § 1.2.4. Vers Dieus, el vostre nom e de sancta Maria. L’alba FqMars 155,26 (XXVI) presenta problemi di altro tipo: il conflitto di attribuzione ancora con FqRom è in questo caso motivato dai manoscritti: le rubriche dei tre testimoni assegnano l’alba a folquet de mercelha (C 6v), a falquet de rotmans (R 15v) e all’anfibolo en folquet (f 19v), mentre la tavola di C contraddice la rubrica dando il testo a FqRom. Nelle grandi antologie ottocentesche il componimento è ascritto al marsigliese, ma già Pratsch 1878, pp. 39-40 ne contesta l’attribuzione. Il primo arbitro della questione è Rudolf Zenker che in un primo momento (cfr. Zenker 1896, pp. 5-6) esclude il testo dal corpus di FqRom confermando la tradizionale attribuzione a FqMars; poi, indirizzato da Carl Appel 50, il quale nota come la caduta di -d- intervocalico riscontrabile nell’alba (per es. via, complia, cria) si adatti meglio alla lingua di FqRom, rintraccia altri quattro argomenti per attribuirgli il testo 51. In sintesi Zenker afferma che: i) FqRom, contrariamente a FqMars, è autore di un altro testo in coblas doblas, 156,10 (IX), legato contenutisticamente all’alba; 48 Si pensi alle cinque epistole del tolosano AtMons, unica di R, che precedono il nostro testo (cc. 126v-131v); si vedano inoltre le considerazioni di Zufferey 1994, pp. 21 e 24-25. Riconosco tuttavia che l’indizio può essere rovesciato perché proprio la notorietà dovuta al vescovato può aver indotto l’attribuzione a Folchetto: a qualcosa del genere pensa evidentemente Zufferey nel lavoro appena citato, pp. 14-15. 49 Rimando infra al Commento dell’edizione, vv. 15, 21, 50, 75, 104, 113, 120. 50 Appel 1896, col. 166, che riprende a sua volta uno spunto di P. Meyer, Alexandre le Grand dans la littérature française, Paris, Vieweg 1886, II, p. 90 in nota; cfr. poi Appel 1915, pp. CXXXV-CXXXVI. 51 Zenker 1897, pp. 335-37. Anche per scartare l’attribuzione a PAuv della poesia religiosa Deus verais, a vos mi ren, assegnata all’alverniate dalla tav. C, Zenker aveva valorizzato il fenomeno del dileguo di -t- intervocalico in VITA > via, incompatibile a suo parere con la lingua del trovatore (cfr. R. Zenker, Peire von Auvergne, RF, XII [1900], 653924, a p. 664; e cfr. Fratta 1996, p. XXXVI). Per l’attribuzione a ArnCat (cui R assegna il testo) si veda F. Blasi, Le poesie del trovatore Arnaut Catalan (introduzione, testi, traduzioni, note), Firenze, Olschki 1937, pp. XXII-XXIII. ii) i vv. 19-21 dell’alba richiamano la descrizione della Passione di FqRom 155,11 (VII), 46-50: «per nos en fo en croiz levaz / et es totz hom desesperaz / qui no·i a ferm corage / qi ve com el fo clavellaz / per nos e battuz e nafraz»; iii) «der warme Ton, die frische kräftige Sprache, der schöne lyrische Schwung der Alba gemahnen viel mehr an die Gedichte des Folquet von Romans als an die des Folquet von Marseille» (p. 336); iv) l’attribuzione in C a folquet de marcelha dipende dal fatto che il copista, letta la prima parte della rubrica, ha creduto si riferisse allo stesso trovatore di cui aveva sino a quel momento copiato i testi. L’attribuzione di Zenker è in questo caso fatta propria da Stroński, che aggiunge altri argomenti a supporto: in primo luogo, nonostante la duplice attribuzione, definisce la testimonianza delle rubriche favorevole a FqRom poiché in C il testo si trova in fondo al corpus folchettiano. Non si tratterebbe tanto di un errore nella lettura della rubrica, quanto di una consapevole marginalizzazione da parte del copista di un testo che si sapeva di dubbia paternità, cosa di cui sarebbe un riflesso l’assegnazione a FqRom nella tavola di C. Corregge tuttavia l’argomento linguistico di Appel, riconoscendo che il fenomeno è tipico del Viennois, terra d’origine di FqRom, e di zone limitrofe (Provenza, Velay, Alvernia), osservando però che, oltre ad essere un elemento della scripta trobadorica, è particolarmente frequente nelle albas, dove spesseggiano rimanti come via e dia, e nelle poesie religiose in genere stante la rima con Maria 52; lo conserva ugualmente come «un indice sérieux». Da ultimo scrive: «L’argument le plus fort est, peut-être, celui que l’attribution fausse d’une chanson piuse à Folquet de Marseille, dont la carrière religieuse fut célèbre, s’explique facilment, tandis qu’on ne comprendrait guère pourquoi on lui aurait disputé une pareille chanson, si elle avait été de lui, pour l’attribuer à Falquet de Romans» (pp. 136*-37*). Le argomentazioni di Stroński non convincono Vincenzo Crescini 53, ma sono sufficienti a Martín de Riquer che, ribadendo l’attribuzione a FqRom, gli conferisce l’autorevolezza dell’antologizzazione in Los trovadores 54. La questione è ripresa da Maria Picchio Simonelli nell’edizione di BnVenzac 55: alla studiosa pare inaccettabile che un topos come quello delle pene di Cristo possa essere utilizzato, come fa Zenker, per un’attribuzione, osservando che anche BnVenzac propone nella sua alba 71,2 (VI), 29-32 una rappresentazione simile (altri riscontri del topos nel Commento a FqMars 155,26 [XXVI], 19-21). Ritiene invece che il testo sia da ridare a FqMars e vada ascritto agli anni successivi il 1195 se non al periodo di 52 Cfr. Boutière 1937, p. 109, oltre a Spaggiari 1977, pp. 135-36 e Brunetti 1993, p. 621, n. 21. 53 «Il problema potrebbe essere novamente esaminato» scrive in Crescini 1926, p. 216; precedentemente, in Crescini 1905, p. 254-55, non si era fatto convincere dalla tesi di Zenker, mentre in Crescini 1892, p. 52 si era limitato a menzionare la posizione di Pratsch 1878. 54 Riquer 1975, III, p. 1221; cfr. in precedenza dello stesso Riquer, Las Albas provenzales, «Entregas de Poesía» XVIII (1944), risultatomi irreperibile. 55 Picchio Simonelli 1974, pp. 184, n. 9 e 186, n. 16. monacazione del trovatore, dopo il 1200 56. Arveiller-Gouiran 1987, p. 143, ripercorrendo l’itinerario di Zenker e Stroński, senza però citare la Picchio Simonelli, ribadiscono l’attribuzione a FqRom, tentando per di più di trasformare il tratto dialettale del Viennois rintracciato da Appel da «argument d’orde phonétique douteux en argument d’orde stylistique sérieux» (p. 144): l’uso della rima in -ia (< -ITA), limitato in FqMars a un solo caso (155,21 [VII], 22, 46: via < VITA), sarebbe comune in FqRom. Alla stessa conclusione è giunta, indipendentemente dai due editori, anche Poe 1988, p. 334, la quale sottolinea la maggiore plausibilità di un’attribuzione al trovatore meno noto, FqRom, postulando l’esistenza di un «recueil d’albas», antigrafo dei tre mss. latori del testo, in cui la rubrica di Vers Dieus recava solo (en) folquet 57. A mio avviso, gli argomenti a favore di un’attribuzione a FqRom sono tutt’altro che solidi 58: in particolare non convince quello presentato da Stroński come probabilmente decisivo, così come mi pare discutibile il criterio della posizione del testo nei canzonieri nella discussione sulla sua paternità, soprattutto nel caso del nostro testo che in quanto geistliches Lied non poteva che chiudere la sezione di C 59. D’altro canto non ci sono argomenti dirimenti per assegnare l’alba a FqMars. Solo l’analisi delle rubriche ci offre una base di discussione se non oggettiva almeno storicamente fondata: da essa risulta una situazione di sostanziale equilibrio dal momento che nel ms. f en folquet è ugualmente usato per i due trovatori 60. Riservo la mia preferenza (ma i dubbi permangono) per un’attribuzione al marsigliese, stante il legame, già valorizzato da Zenker 1896, p. 6, col Bußlied 155,19 (XXVII). È quantomeno suggestiva l’ipotesi che Folchetto, abbandonato il secolo e la lirica profana, abbia composto due testi religiosi del tutto eterogenei rispetto alla sua precedente produzione, quasi a sottolineare la rottura con il passato. L’opinione di Stroński è decisamente contraria: «Aucune oeuvre littéraire de Folquet ne nous est parvenue du temps de sa carrière religeuse» (p. 100*), ma apodittica. Né 56 Picchio Simonelli 1974, p. 195; concorda con la studiosa Beltrami 1989, p. 14, n. 16. Secondo Allegretti 1992 il confronto con le rubriche attributive di Perd 370,9 (I) (cfr. più sotto il § 1.2.5) «conferma l’esistenza di un antigrafo [comune a CRf] con un’intitolazione ‘folquet’ che risulta però svincolato da un ‘recueil d’albas’» (p. 723, n. 4); e comunque anche la Allegretti ritiene che l’ascrizione a FqRom sia fondata «sulla base di solidi argomenti» (p. 723). 58 Mi trovo perciò in disaccordo con Arveiller-Gouiran 1987, p. 144, per i quali «ce débat [sulla paternità del testo] fait assez nettement ressortir que l’attribution de l’Alba à notre troubadour est la plus probable». 59 Cfr. Allegretti 1992 (e la Nota al testo di FqMars 155,26 [XXVI]); naturalmente non è, a mio avviso, provato che «Il ms. C si limita, sulla base di una falsa attribuzione a collocare BdT 156,15 [scil. la nostra alba] in posizione terminale» (p. 723, n. 4). 60 Cfr. Stroński a p. 135*; dei 12 testi attribuiti nel ms. a FqMars, solo due, 155,16 (VIII) e ArnMar 30,3 (IX), presentano nella rubrica la specificazione «di Marsiglia» (il secondo è evidentemente spurio): per il resto tutte le attribuzioni sono a (en) folquet. Anche Asperti 1995, che senza affrontare la questione attributiva cita l’alba col n° 156,15 della BdT, assegnandola quindi a FqRom, nota che folquet è «la rubrica sotto la quale il copista confonde Falquet de Romans e Folquet de Marselha» (p. 25), sebbene a p. 37 affermi che «la semplice rubrica “en Folquet” [...] è utilizzata di norma nel codice per Folquet de Marselha». 57 all’ipotesi si può opporre l’aneddoto riferito da Robert de Sorbon: «Folquetus, episcopus Tolosanus, cum audiebat cantare aliquam cantilenam quam ipse existens in saeculo composuerat, in illa die, in prima hora, non comedebat nisi panem et aquam» 61, in quanto è evidentemente riferito all’esperienza lirica amorosa. D’altro canto vorrei far notare che Folchetto poteva essere conosciuto come autore di albas in quanto l’alba Caden 106,14 (XIII) è ascritta a folquetz (cioè a FqMars) in R (c. 52r), in accordo con la tavola (cfr. Tavera 1992, p. 92) e nella tavola di C (mentre nel ms. è tràdita fra le altre poesie di Cadenet, a c. 156v) 62: in questo caso R e la tavola di C concorderebbero nell’errore di attribuzione. Già Zenker 1896, p. 6 aveva genericamente constatato che la tavola di C e il ms. R non sono molto affidabili, dal momento che assegnano a torto rispettivamente 2 e 5 testi a FqRom; posso ora corroborare l’osservazione con i dati ricavati dallo studio complessivo della tavola 63: i testi che presentano attribuzioni nella tavola sono 84, 52 hanno attribuzioni errate, solo 15 corrette, mentre per quattro testi la tavola dà un’indicazione corretta e una scorretta; 11 i casi dubbi, da sottoporre a un supplemento di analisi. § 1.2.5. Los mals d’Amor ai eu ben totz apres. Va invece eliminata dal canone folchettiano la canzone Perd 370,9: tràdita da 19 codici, è attribuita a FqMars solo in CRf 64, ed è adespota in O. Stroński stesso esclude recisamente la paternità folchettiana, supportata in CRf da una tornada ‘folchettianamente caratterizzata’ (cito dall’ed. Stroński [n° xxvi], vv. 51-54): Vas N’Aziman vuelh, chanso, que tengatz · et a N Tostems, car lur serez plazens, mas no tenhatz entre las avols gens, car qui val mais crei que mielhs vos entenda. Sottoscrivo pertanto la conclusione dell’editore (sospendendo tuttavia il giudizio sull’osservazione stilistica) 65: 61 Citato da Stroński a p. 112*. Il rilievo è già di Stroński (cfr. p. 122*) che però non trae nessuna ulteriore conseguenza; la circostanza è poi ricordata da Meneghetti 1994, pp. 171-72. Errata l’ipotesi di Zemp 1978, p. 250 per cui il testo andrebbe rubricato sotto FqRom i cui componimenti seguono l’alba: folquet è infatti la rubrica che in questa parte di R designa i testi di FqMars. 63 La trascrizione della tavola (intendo della prima tavola di C che Zufferey 1987, p. 135, n. 105 sigla t1 e che abbraccia le prime 17 cc. del ms.) e l’edizione della poesia di attribuzione controversa Longa sazon ai estat vas amor (attribuita dalla tavola a RostMerg e a un Escudier de la Ylha) saranno comprese in un articolo di prossima pubblicazione. 64 Anche in questo caso il ms. f reca in rubrica l’ambiguo en folquet, usato nel codice, come s’è visto, anche per designare FqRom; i tre mss. sono strettamente legati (cfr. peraltro le considerazioni esposte sopra al § 1.2.4). 65 Analoga sottoscrizione in Chaytor 1926, p. 54 e in Meneghetti 1993, p. 101 e 1994, pp. 170; scrive la studiosa in quest’ultimo lavoro, a p. 177: «Non è facile qui capire se il copista dell’esemplare da cui questi tre codici derivano abbia scrupolosamente adeguato la rubrica a un testo che già inglobava i versi apocrifi, o piuttosto si sia lui stesso impegnato ad “autenticare” con qualche décasyllabe nuovo di zecca un’attribuzione giudicata non troppo solida (non parlerei mai, naturalmente, di falso nel senso stretto del termine, tenuto conto della 62 On pourrait croire que Perdigon, qui a repris dans 370,14 le pseudonyme Rainier de Peire Vidal et de Bertran de Born [...], êut fait de même pour les sobriquets célèbres de Folquet. Mais il suffit de lire cet envoi, qui est la banalité même, pour voir qu’il n’est pas l’oeuvre de Perdigon. Il a été tout simplement ajouté pour appuyer l’attribution fausse à Folquet. § 1.2.6. Consiros, com partitz d’amor. Opposta la situazione della canzone di crociata AimBel 9,10 (I): Stroński dedica le pp. 131*-35* della sua edizione alla dimostrazione della paternità folchettiana del testo, contro la testimonianza delle rubriche dei due relatori C ed E, che lo assegnano entrambe a AimBel. La canzone è dedicata al «comte, mo senhor, / que es per Dieu servir crozatz» cioè a colui «qu’es coms et er reys appellatz» (vv. 4-5, 48): questi è tradizionalmente riconosciuto in Riccardo Cuor di Leone, conte di Poitiers e duca d’Aquitania, re d’Inghilterra dal 3 settembre 1189; Riccardo s’impegnò con l’arcivescovo di Tours a intraprendere la crociata nel novembre del 1187, primo fra i prìncipi occidentali. La canzone è dunque databile agli ultimi mesi del 1187 o al principio del 1188 e comunque prima del 3 settembre 1189. Due anni dopo, nell’estate 1190, FqMars compone per la canzone 155,3 (VI) una cobla politica dedicata all’ormai re Riccardo: si leggano i vv. 33-40, dai quali si ricava che Folchetto, nel momento in cui Riccardo prese la croce 66, deve aver scritto qualcosa che non ci è pervenuto. A partire da questi fatti, Stroński fa una serie di ipotesi concatenate per arrivare a identificare quel ‘qualcosa’ con Consiros, com partitz d’amor. Nella sua formulazione finale il ragionamento dell’editore è un vero e proprio entimema, non mascherato comunque da sillogismo: «l’attribution à Folquet de Marseille ne saurait être soutenue catégoriquement. Il s’en faut que nous ayons des preuves décisives. Mais les indices qui font penser à lui sont sérieux» (p. 134*) 67. Il recente studio di Andrea Poli, ultimo editore di AimBel, mi esime dal ripercorrere puntualmente l’argomentazione di Stroński: basti perciò un rimando alle pp. 114-119 di Poli 1997 (e cfr. pp. 7, 21-22) 68, dove si dimostra che il testo va assegnato al trovatore guascone 69. notoria mancanza di rispetto per l’integrita dei testi letterari che caratterizza in genere la cultura medievale)». Secondo Asperti 1990, p. 38, n. 49: «la canzone potrebbe in effetti essere del trovatore di Marsiglia, dal momento che gli argomenti stemmatici addotti da Stroński in favore di Perd non sono certi». 66 Prima di partire Riccardo intraprende, alleato di Filippo Augusto, la lotta contro suo padre Enrico che si conclude con la morte di questi (6 luglio 1189) e la sua incoronazione a re d’Inghilterra il 3 settembre dello stesso anno. Solo il 22 agosto del 1190 parte da Marsiglia per la Terrasanta. La canzone VI si può datare fra il 31 luglio, giorno d’arrivo a Marsiglia, e il 22 agosto; vd. infra, § 1.3.1.6. 67 L’editore ha poi ribadito la sua opinione in Stroński 1913, pp. 288-89, n. 2. 68 Discussione attributiva ed edizione del testo erano state anticipate in A. Poli, Aimeric de Belenoi. Saggio di edizione critica (BdT 9.5, 9.9, 9.10, 9.21 e 16.13), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 1992, pp. 1-32. 69 Segnalo inoltre l’opinione di Silvio Melani, che prenderà consistenza in un articolo, secondo cui il testo va riferito a Thibaut de Champagne e non a Riccardo Cuor di Leone: venendo meno i problemi cronologici della ricostruzione di Poli (e di Stroński), l’attribuzione a Aimeric ne risulterebbe rafforzata. Il richiamo alla canzone di Picone 1981-83, pp. 74-75 per il «Consiros vei la passata dolor», per le rime in -or e per altri elementi lessicali della sermocinatio di Arnaut Daniel in Purg. XXVI 140-47, potrebbe essere utilizzato per suffragare l’attribuzione a Folchetto, considerata la forte presenza del trovatore di Marsiglia nel passo della Commedia; ma, ripeto, si può pensare ad un modello folchettiano perduto imitato anche da Aimeric, oppure ad una fonte diversa per il passo dantesco, seguendo le indicazioni di Perugi 1978b, pp. 127-32 che valorizza il planh di GlBerg 210,9 (XIV), Consiros cant e planc e plor. § 1.2.7. Pos entremes me suy de far chansos. Nonostante la maggioranza dei testimoni sia favorevole a Folchetto (su 14 codici, 8 [ADEMOTaf] la dànno al marsigliese, 4 [DaGRS] a Peirol, 2 [Cc] a FqRom) 70 è opinione di Stroński che la canzone 155,17 (XVI) sia da escludere dal corpus del trovatore. E ciò nonostante il rilievo che i manoscritti favorevoli a Folchetto siano diffusi sui tre rami del suo stemma codicum: va tuttavia rilevato che essendo fondati su varianti adiafore più che su errori-guida, questo e gli altri stemmata di Stroński non offrono garanzie sufficienti per operare meccanicamente e pertanto tralascio da qui in poi tutti gli argomenti dell’editore fondati sulla classificazione dei testimoni. Comunque i mss. DaGS sono congiunti dalla comune lacuna della cobla VI, necessaria per la completezza dello schema in coblas doblas (schema che salta in S per l’anticipazione, comune ai mss. CEMT, al secondo posto della cobla V) e l’assenza della cobla IV; in suo luogo Da presenta due tornadas, la seconda delle quali è tràdita anche da G: la prima contiene un accenno a Héracle de Polignac (morto nel 1201), cosa che, a dire di Stroński, esclude l’attribuzione a Falquet de Romans, la cui produzione ha il terminus a quo fra il 1215 e il 1219 71 e rende invece probabile un contatto fra l’alverniate Peirol e un visconte del Velay. Ma proprio perché presente, oltre che in R, in tre mss. imparentati, e perché corroborata da un’allusione relegata in un solo testimone, l’attribuzione a Peirol perde il carattere di perentorietà («Cette chanson est donc certainement de Peirol») voluto da Stroński. Interessanti, e tuttavia non decisivi, gli argomenti di carattere metrico esposti dall’editore alle pp. 128*-29*, tutti favorevoli all’alverniate: l’assetto strofico in 70 La semplice maggioranza aritmetica delle attribuzioni è sufficiente a Picone 1981-83, p. 75 per assegnare il testo a Folchetto. 71 Premesso che niente si oppone alla possibilità che FqRom abbia scritto prima del 1215, il terminus a quo dipende dalla datazione della canzone di crociata Bernart, di me Folquet q’om tient a sage di Hughes de Bregi (R37a e n° 117,1 di Linker 1979) inviata al trovatore, come specifica il copista del cod. H, c. 46r: «N’Ugo de Bersie mandet aquestas coblas a Folquet de Rotinans per un joglar q’avia nom Bernart d’Argentau per predicar lui qe vengues con lui outra mar» (da Arveiller-Gouiran 1987, pp. 3-4, con ed. del sirventese da p. 4); il testo è variamente datato dagli studiosi: la data più alta è fissata da F. Lecoy, Pour la chronologie de Hugues de Berzé, Rom, LXVII (1942-43), pp. 243-54 al 1215, mentre Arveiller-Gouiran 1987, dopo una disamina delle varie posizioni, propongono il 1220-21 (cfr. pp. 6-9). Per i due editori il testo più antico del trovatore è FqRom 156,14 (III) datato 1219 (cfr. p. 41). coblas doblas, comune in Peirol, è totalmente assente in FqMars 72; le coblas di 7 versi sono presenti in otto componimenti di Peirol contro uno solo di FqMars 73; la sequenza rimica del componimento (abbaacc) è assente in FqMars mentre si trova in Peirol 366,5 (XXVI) e 366,28 (XXXII). Mi pare però supervacaneo affermare che Peirol abbia altri 22 testi con sei coblas, mentre Folchetto ne ha solo due, in quanto ciò deriva dal fatto che la canzone è in coblas doblas, struttura, si è già detto, estranea al marsigliese. Restano infine gli argomenti stilistici (su cui cfr. p. 129*), che spingono in direzione di Peirol: l’avvio del testo: «Pos entremes me suy de far chansos / ben dey guardar que fals motz no·y entenda» richiamerebbe Peirol 366,31 (XXII), 56: «et on hom plus mos chantars mi grazis / e mieils me dei gardar que no·i mesprenda», oltre agli attacchi di Peirol 366,3 (II): «Ben dei chantar puois amors m’o enseigna» e di 366,20 (XX): «M’entencion ai tot’ en un vers mesa / cum valgues mais de chant qu’ieu anc fezes»; l’invio a midons si ritrova in Peirol 366,2 (I), 366,18 (XXV), 366,22 (III), 366,26 (XVI); la 1 a sg. del presente indicativo in -i (cfr. 11 agradi e 45 dauri) è anche in Peirol 366,11 (IX), 14: «pensi» (ma cossir CMa); 366,22 (III), 26: «parli» (ma parlen RVa e parle N); 366,33 (IV), 18: «parli» (ma parlo PS); infine il v. 45 («de vos dauri mon chan») è messo in relazione con Peirol 366,31 (XXII), 14: «Me dauret gen so qu’aora m’estaigna», mentre il verbo 42 blandir è reperito in Peirol 366,8 (VII), 22-23; 366,14 (VIII), 19-20; 366,15 (V), 65-66; 366,16 (XVII), 42 74. Alla stessa conclusione di Stroński giunge indipendentemente anche Paul Meyer in Parducci-Meyer 1910, pp. 82-83 75, che adduce a prova la somiglianza della struttura metrica del testo con quella del sirventese Peirol 366,28 (XXXII) 76, il rilievo, uguale a quello di Stroński, che Peirol, a differenza di Folchetto, ha altri testi in coblas doblas, l’indicazione di genere «chansoneta» contenuta nell’ultima strofa rintracciabile anche in altri testi di Peirol e mai usata dal marsigliese 77 e, infine, la distanza stilistica della canzone dalla maniera di 72 I 7 testi in coblas doblas di Peirol sono 366,4 (XIX), 366,11 (IX), 366,12 (XII), 366,19 (XVIII), 366,22 (III), 366,26 (XVI), 366,27 (XI); una schedatura dei testi occitanici in coblas doblas è in Asperti 1990, pp. 84-86. 73 FqMars 155,1 (V) vs Peirol 366,1 (XIII), 366,3 (II), 366,12 (XII), 366,13 (X), 366,16 (XVII), 366,21 (XV), 366,31 (XXII), 366,33 (IV). 74 Ma cfr. FqMars 155,15 (XVIII), 27: «vol quecs gardar e blandir» e 155,24 (XXIV), 27: «mays val sela que·us tem e·us blan». 75 L’opinione di Meyer è riportata da Stroński fra le Additions et corrections (a p. 270) 76 Cfr. Frank 1953-57, n° 495 (abbaacc); lo schema di 155,17 (XVI) è il n° 495:9, coblas doblas di décasyllabes con la rima b femminile, mentre Peirol 366,28 (XXXII) ha lo schema n° 495:4 composto da décasyllabes con rima maschile. 77 FqMars 155,17 (XVI), 36-37: «Chansoneta, vai t’en tot dreyt cami / lay a midons en cuy ai m’esperansa»; per l’indicazione di genere Meyer menziona Peirol 366,15 (V), 73 e 366,12 (XII), 43, ma il termine si trova anche in Peirol 366,2 (I), 41 e in Peirol 366,14 (VIII), 53. Folchetto. Anche Stanley Collin Aston si dichiara d’accordo con Stroński e include la canzone fra i testi di Peirol 78. A mio parere invece non si può escludere la paternità folchettiana, anche se non ho elementi per corroborare il dato, comunque significativo, delle rubriche; fortemente sospetta mi pare, nonostante la grande quantità di argomenti, l’attribuzione a Peirol. Mantengo perciò il componimento, pur con lo statuto di testo di dubbia attribuzione, nel canone folchettiano 79. § 1.2.8. A pauc de chantar no·m recre e Meravill me cum pot nuills hom chantar. Per FqMars 155,2 (XIX) e 155,13 (XX), e inoltre per FqMars 155,9 (XV), Stroński esclude decisamente la paternità folchettiana, soprattutto in ragione alla loro collocazione nei canzonieri; l’editore dubita infatti per principio dell’autenticità di tutte le poesie che si ritrovano nelle ultime posizioni delle sezioni dedicate a Folchetto nei singoli canzonieri, tant’è che sottopone ad analisi (cfr. p. 120*) anche FqMars 155,6 (XVII), tràdita da 20 mss., tutti con attribuzione a Folchetto, solo perché si trova spesso tra le ultime poesie del trovatore. L’osservazione di Stroński presuppone che gli estensori di un codice, appurata o sospettata l’inautenticità di un testo, lo relegassero ‘in appendice’, congetturando talvolta il nome di un possibile autore in base a legami lessicali o tematici con le opere del poeta stesso 80. Il fenomeno ha un’effettiva consistenza 81, ma andrà messo in relazione con la trasmissione manoscritta: le poesie con attribuzione non univoca e quelle considerate di dubbia attribuzione da Stroński esulano infatti dal nucleo più attestato del corpus folchettiano, concentrandosi in quelle che ho chiamato tradizione e tradizione (cfr. § 1.1.2). La collocazione periferica non sarebbe insomma una conseguenza dell’apocrifia, ma, al contrario, è nell’estravaganza dal nucleo fondamentale del canzoniere folchettiano che va riconosciuta la causa della marginalizzazione e delle oscillazioni nelle attribuzioni. D’altronde la posizione nei canzonieri dei componimenti risalenti a e indica che la marginalità è un dato costante, si 78 Aston 1953, p. 117-20, note a p. 180 (n° XXI dell’edizione; il n° di Pillet attribuito è 366,27a). Stroński formula infine alle pp. 129*-30*, un’ipotesi sul motivo delle false attribuzioni a FqRom e a FqMars: il primo sarebbe stato chiamato in causa dal senhal «BellaGuarda», presente in una tornada tràdita dai soli mss. DaG (v. 45), che si ritrova anche nella varia lectio (mss. PSUc) di ArnMar 30,16 (I) che il ms. R e la tavola di C, in una tradizione di 11 mss., attribuiscono a FqRom (cfr. supra il § 1.2.4) e che Kp dà proprio a FqMars; mi pare tuttavia poco economico pensare che una tornada non tràdita dai mss. Cc, gli unici a dare il testo a FqRom, possa aver indotto l’attribuzione. FqMars sarebbe invece presente solo per la sostituzione del più noto al meno noto, oltre che per la consonanza, invero piuttosto vaga, del v. 15 «Luenh m’es dels huelhs mas del cor m’es tan pres» con FqMars 155,8 (XI), 9: «qu’inz e·l cor port, donna, vostra faisson». Accenna alla questione, concordando con Stroński, anche Meneghetti 1994, p. 169. 79 Diversamente in Squillacioti 1993, p. 585 e n. 14 davo maggiore fiducia alle tesi di Stroński e Meyer. 80 Il metodo è sostanzialmente accettato da Meneghetti 1994, p. 170; vd. anche Zufferey 1981, p. XXVIII (sulla tradizione di GlBerg). 81 Lo nota, per fare un esempio, anche Brunetti 1993, pp. 617-18. può dire strutturale, che mi pare difficile spiegare semplicemente in termini attribuzionistici: più arduo chiarire se la paternità dei componimenti fosse incerta già nella fonte o se venisse ritenuta falsa o sospetta proprio per l’estravaganza dalla linea principale di trasmissione e perciò sostituita con attribuzioni alternative all’altezza dell’inclusione nei canzonieri antologici. Comunque sia, le posizioni marginali vanno studiate per le indicazioni più generali sulla tradizione manoscritta che se ne possono ricavare. 155,2 A pauc de chantar no·m recre (XIX): ADaEIKNPf = FqMars; R tav.C = FqRom; C = ArnMar; V = adespota (folchet agg. da altra mano) 155,9 Fin’ amors a cui me soi datz (XV): EMQTa = FqMars; C = GsbPuic 155,13 Meravill me cum pot nuills hom chantar (XX): ADaIKNPQ = FqMars; CR = FqRom; a = PoChapt; O = adespota ms. C c. 107r .... c. 114v c. 116r c. 189v .... c. 192r c. 193v .... c. 227r c. 230r inizio poesie di ArnMar FqMars 155,2 (attr. ArnMar) ArnMar 30,9 ArnMar 30,10 ArnDan 29,15 (attr. ArnMar) fine ArnMar. .... inizio GsbPuic FqMars 155,9 (attr. GsbPuic) GsbPuic 173,9 GsbPuic 173,3 GsbPuic173,8 GrBorn 242,8 (attr. GsbPuic) fine GsbPuic. inizio FqRom FqMars 155,17 (attr. FqRom) FqRom 156,6 FqRom 156,14 FqMars 155,13 (attr. FqRom) FqRom 156,12 FqRom 156,11 FqRom 156,10 fine FqRom. ms. R c. 15r c. 15v .... inizio FqRom FqRom 156,6 FqRom 156,14 FqMars 155,13 (attr. FqRom) FqRom 156,12 GuiUss 194,11 AimPeg 10,4 GlCapest 213,1 FqMars 155,26 (attr. FqRom) c. 51v .... c. 52r c. 52v inizio FqMars fine FqMars, inizio FqRom FqRom 156,10 ArnMar 30,16 (attr. FqRom) FqMars 155,2 (attr. FqRom) FqRom 156,11 fine FqRom. ms. V c. 106r c. 108r ArnMar 30,9 (adespota ma attr. da altra mano a perdigos) BbPal 47,4 (adespota ma attr. da altra mano a perdigos) Perd 370,3 (adespota ma attr. da altra mano a perdigos) FqMars 155,2 (adespota ma attr. da altra mano a folquet) Perd 370,13 (adespota ma attr. da altra mano a perdigos) ms. c c. 16v c. 21v fine Fq Mars, inizio FqRom FqRom 156,10 FqMars 155,17 (attr. folchet) FqRom 156,11 FqRom 156,8 (rubr.: folchet de roman serventes) Domna, eu preing comjat de vos di FqRom fine FqRom (segue la c. 22r-v bianca). FqMars 155,17 (XVI), attribuito a Peirol in D aGRS, è collocato in GRS all’interno del canzoniere del trovatore, in Da alla fine della sezione dedicata al poeta, a c. 170r, dopo altri 5 testi. FqMars 155,13 (XX), attribuito a PoChapt, nella sezione Riccardiana di a, alla c. 230, è l’ultimo dei testi del canzoniere di Pons aperto a c. 214. La posizione in f dell’alba FqMars 155,26 (XXVI), ascritta a c. 19v a en folquet, non dà molte informazioni perché il canzoniere è uno dei gröberiani «Zusammengesetztze Handschriften» (sui quali cfr. Avalle-Leonardi 1993, p. 69). Scartata l’attribuzione a Folchetto, Stroński indica in FqRom il probabile autore delle canzoni 155,2 (XIX) e 155,13 (XX), in base a tratti di ordine stilistico per i quali Maria Luisa Meneghetti 82 ha richiamato la nozione continiana di ‘memoria interna’ 83 e ha definito di ordine stilematico, effetto di 82 Meneghetti 1994, pp. 172-75; l’analisi è limitata a FqMars 155,13 (XX). Su FqMars 155,2 (XIX) Stroński scrive: «Les vers courts qui constituent le trait caractéristique de la forme de notre pièce se retrouvent dans trois autres poésies de Falquet (156,2, 5, 13). Les vers 48-50: E sol qu’ilh agues lo mile De la dolor fer’e mortal Nos agram partit per egual peuvent être rapprochés des vers suivants de la lettre Domna de Falquet de Romans (qui y reprenait volontiers des motif tirés de ses propres chansons): E volgr’aguesses la mitat O·l ters o·l quart de mal qu’ieu ai Q’adonc sabriaz co m’estai (152-4)» (p. 125*); su FqMars 155,13 (XX): «Au vv. 17-18 le poète dit qu’il est loin de sa dame, trait qui ne se trouve nulle part dans les poésies de Folquet de Marseille, et qui est constant dans celles de Falquet de Romans (156,5 vv. 25-32 et 41-44, 156,8 v. 27, 156,14 v. 4). Et surtout, on trouve dans cette chanson une mention de Tristan et d’Iseut (v. 43), et Falquet se servit avec beaucoup de prédilection de l’exemple des deux amants célèbres qu’il nomma encore dans trois autres pièces (156,2, 156,11 et lettre), de même qu’il invoqua Floris et Blancheflor dans quatre poésies (156,3,8,14 et lettre)» (p. 126*). 83 rapporti intertestuali (o interdiscorsivi), gli elementi che avrebbero indotto le false attribuzioni ad ArnMar e PoChapt 84, e allo stesso Folchetto. Il nome di quest’ultimo sarebbe stato originato, in entrambi i testi, dalla notorietà della razo di FqMars 155,23 (IX) 85, cui Stroński accosta l’invettiva di FqMars 155,2 (XIX), 1-2 contro i lauzenjadors e i vv. 19-20 di 155,13 (XX). Arveiller-Gouiran 1987, pp. 195-203 nell’inserire FqMars 155,13 (XX) fra le poesie di dubbia attribuzione di FqRom, aggiungono agli argomenti di Stroński l’osservazione che il testo «semble répondre [...] à une poésie de Guillem de Cabestany; la dernière chanson de Folquet étant de 1195 et M. de Riquer [scil. Riquer 1975, II, p. 1064] situant l’œuvre de Guillem autour de 1212 [...], il est peu probable que le Marseillais ait pu imiter une chanson du Catalan» 86. § 1.2.9. Fin’ amors a cui me soi datz. Anche per l’ultima canzone, FqMars 155,9 (XV), la situazione delle rubriche è favorevole a Folchetto: cinque manoscritti la dànno al marsigliese (EMQTa), uno soltanto (C) a GsbPuic. 84 Stroński mette a confronto FqMars 155,2 (XIX), 26-28 e 51 con i vv. 59-60 della galleria del MoMont 305,16 (XVIII), «qui fut une des principales sources d’informations sur les troubadours»: «qu’ades clamon merce sey huelh; / on plus canta l’aiga·n dissen»; e FqMars 155,13 (XX), 19-20 con la razo PoChapt 375,14 (XIV): «Pons de Cabdueill amet [...] ma dona N’Alazais de Mercuer [...]. Et [...] ac volontat [...] de proar s’ella li volia be, qu’el no crezia a sos hueils ni als plazers plasens ni a las onradas honors qu’ela li fazia ni·ll dizia. E si acorda, en son fol cor, qu’el fezes semblan qu’el s’entendes en autra dona, en N’Audriartz, qu’era moiller del senher de Marceilla» (da Boutière-Schutz 1964, pp. 314-20). E commenta: «Folquet et Pons sont les deux seuls troubadours dont la biographie contient une histoire assez développe de l’ ‘amour feint’» (p. 126*); noto tuttavia che la razo di Pons è tràdita dai mss. EPRSgb mentre l’attribuzione è nel canzoniere a. 85 Boutière-Schutz 1964, pp. 99-100; ne riporto il testo confrontato con quello delle edizioni Stroński e Favati nel Commento all’edizione della canzone. 86 L’imitazione sarebbe di ordine metrico: lo schema strofico di GlCapest 213,6 (VI): a10 b10 a10 b10 c10’ d10 d10 a: en, b: er, c: eja, d: ar (Frank 1953-57, n° 418:1) sarebbe stato ripreso dall’autore di FqMars 155,13 (XX), che avrebbe sostituito il décasyllabe femminile in -eia con due versi o un décasyllabe con rima interna: a10 b10 a10 b10 c10 c4 d6 d10 a: ar, b: er, c: ens, d: an (Frank 1953-57, n° 418:1, che rimanda allo schema con rima interna [418:notes]: non ci sono elementi per scegliere fra le due alternative, come è invece possibile fare nei casi studiati da S. Vatteroni, Rima interna e formula sillabica: alcune annotazioni al Répertoire di I. Frank, SMV, XXIX [1982-83], pp. 175-82). Il trovatore avrebbe inoltre mantenuto due delle rime (ma solo una nella medesima sede) e modificato in -ens la rima in -en. La mancata corrispondenza delle rime rende meno sicura l’imitazione; scrivono in proposito i due editori: «On pourrait, il est vrai, objecter que le changement de rime risque de rompre le parallélisme; il semble bien cependant que nous nous trouvions en présence d’un cas de ‘sublimation intertextuelle’» (p. 197), e rimandano per il concetto a Gruber 1983, p. 98. Non è tuttavia ipotizzata la possibilità contraria, cioè che sia Guilhelm a imitare lo schema di FqMars 155,13 (XX) né, considerata la mancata corrispondenza delle rime, è prospettata l’eventualità che il parallelismo degli schemi sia meramente casuale. Comunque anche Arveiller e Gouiran considerano solo ipotetica l’attribuzione a Falquet: «ce sont là des éléments qui méritent considération, mais ils ne sauraient nous dispenser de le plus grande prudence. La paternité de Falquet est vraisemblable, mais non assurée» (p. 195). Questa volta è Stroński medesimo a togliere credito agli argomenti derivati dall’analisi della tradizione manoscritta 87; si limita a osservare che i codici che assegnano il testo a Folchetto, la collocano alla fine del suo canzoniere (EMQ) o a ridosso di testi dubbi (Ta) 88: quest’ultima osservazione, discutibile se utilizzata tout court per invalidare la testimonianza delle rubriche, può essere recuperata in una prospettiva più generale che coinvolga l’intera tradizione manoscritta. Il fatto che componimenti con attribuzioni disomogenee o stilisticamente extravaganti rispetto alle altre poesie di Folchetto si trovino ravvicinate e/o in posizioni marginali, oppure non siano testimoniati da manoscritti che tramandano tutto il cosiddetto corpus autentico 89, può dipendere, come ho già detto sopra, da una diffusione dei testi – in una fase anteriore all’organizzazione dei canzonieri – indipendente dal nucleo più attestato della produzione folchettiana. Lo stesso scarto stilistico che registra la canzone dalla media dei componimenti del trovatore non è ragione sufficiente per escluderne la paternità; tanto più che l’esordio primaverile Fin’amors a cui me soi datz · e l gens terminis amoros, cascuns d’aquetz m’es ochaizos don dei esser enamoratz «est absolutament étrangère au style de Falquet» solo se si è già esclusa l’autenticità di FqMars 155,12 (XXIII), di cui si è già detto al § 1.2.2, che presenta un inizio topico sugli uccelli, non lontano stilisticamente da quello della canzone in questione; d’altro canto quella era stata considerata spuria anche perché l’esordio sugli uccelli «n’a rien de comun avec l’art de Folquet» 90. Rintracciate le ipotetiche cause dell’attribuzione a Folchetto 91, l’editore conclude: 87 Si veda più sotto la Nota al testo della mia edizione. Il ms. T tramanda la canzone all’inizio della sezione dedicata a Folchetto dopo GrdoRos 240,4 (I), attribuita al marsigliese, e FqMars 155,17 (XVI); in a si ritrova la serie 155,17 - 155,9 (cui segue 155,20 [XXI]), le uniche poesie di Folchetto provenienti dal canzoniere di Bernart Amoros tràdite nel cod. (le altre ci sono note attraverso glosse interlineari nel ms. ca, il mio ls: cfr. infra il § 2.1.2.1). 89 Stroński osserva (cfr. pp. 123* e 125*) che FqMars 155,2 (XIX) e 155,13 (XX) sono omesse dai codd. BGc, che tramandano esclusivamente componimenti autentici, assumendo la circostanza come indizio dell’apocrifia dei testi: considerazione che si presta, così come quella che i mss. Ta tramandano FqMars 155,9 (XV) a ridosso di testi dubbi, all’obiezione di metodo che in sede di delimitazione del corpus autentico non è corretto considerare il corpus stesso già definito a priori, così da ridurre a corpi estranei tutte le composizioni non immediatamente riconducibili al gruppo meglio attestato. 90 Così Stroński a p. 127*; si consideri inoltre la ‘variazione’ del topos nella cobla V di FqMars 155,5 (I). 91 «Quant aux motifs qui auraient pu faire penser à Folquet, on s’arrête sur la strophe III où il y a des réflexions sur le dreit et la humilitat (grâce) comme dans la chanson VIII de Folquet [scil. 155,14 (IV)], ainsi que sur le v. 22: Qu’aissi m’es el cor sagellatz qui rappelle la chanson V de Folquet [scil. 155,1 (XI)]» (p. 127*). 88 Cette pièce peut bien être de Gausbert de Poicibot. Les idées qu’on trouve ressemblent à celles de son chansonnier, le début sur la belle saison se retrouve dans 173,9, une rimerefrain, comme ici aon, est amors dans 173,11, et p.ex. pour l’idée et l’expression: et am e dezir e reblan (v. 28) cf. Qu’enans deu trobar merce Paubres hom que blan (173,3) et · · Que no us tem ni us blan (173,6). Stroński non rileva però che il testo con l’attribuzione a GsbPuic si trova in C verso la fine del canzoniere del trovatore, immediatamente prima di GsbPuic 173,9 (IX) tràdito solo da CR, di GsbPuic 173,3 (III) che P attribuisce a un folket 92, di GsbPuic 173,8 (VIII) conservata in CEHV e attribuita ad Aimeric de Peguilhan dalla tavola di C e da GrBorn 242,8 (IX), attribuita a Gausbert 93, testo con cui si conclude la sezione dedicata al poeta: una situazione che in altri casi lo avrebbe insospettito. Inoltre i legami indicati con il canzoniere di GsbPuic mescolano tratti stilistici a elementi intertestuali ed è ben possibile rintracciarne di analoghi nei testi folchettiani 94: argomenti rovesciabili, dunque. Non trovo perciò ragioni per escludere la paternità folchettiana; al contrario è la testimonianza isolata di C ad avere valore inferiore, ma in definitiva il testo resta di dubbia attribuzione. Da parte sua l’editore dell’opera di Gausbert, William P. Shepard, nel confermare i legami fra la canzone e la produzione del poeta, aggiunge che la strofa III richiama i vv. 37-40 di GsbPuic 173,1 (I), ma ritiene che «ces ressemblances ne sont pas probantes, et il n’est guère possible de déterminer la paternité de cette chanson assez banale. Toutefois, je l’ai admise comme une des pièces douteuses» 95. § 1.2.10. C o n c l u s i o n i . Il capitolo su Les manuscrits et leurs attributions, è insieme tra i più ammirevoli e discutibili dell’edizione Stroński 96. La grande autorità e decisione con cui l’editore include e, più spesso, esclude le poesie «dubbie» dal corpus di Folchetto cela un atteggiamento pregiudiziale che di fatto ha contribuito a limitare il trovatore sul piano dei valori poetici; se è fuor di dubbio che la caratteristica peculiare del trovatore sia l’elaborazione retorica dei topoi più diffusi, con cui prepara e influenza l’ultima stagione trobadorica (cfr. infra § 3.2.2.1), non bisogna trascurare una serie di testi che contribuiscono 92 Cfr. infra § 1.2.10 e Stroński, p. 123*. Dei 4 mss. che tramandano la canzone (CEHSg), C la dà a Gausbert, H a guiellms de sainleisdier, gli altri due a Giraut: il testo è assegnato a quest’ultimo sia da Kolsen 1910-35 che da Sharman 1989. 94 Dell’esordio stagionale s’è già detto; quanto alla presenza di blandir in FqMars si veda supra il § 1.2.7; l’uso della parola-rima è presente in FqMars 155,14 (IV). 95 Shepard 1924, p. X; il testo è edito alle pp. 55-56, le note sono a p. 87. 96 d’A. S. Avalle nel notare che «La questione delle divergenze di attribuzione nell’ambito della lirica occitanica non è stata ancora affrontata metodicamente», rimanda con un «cfr. però» al lavoro di Stroński (Avalle-Leonardi 1993, p. 51); oggi disponiamo, oltre che dei lavori di Meneghetti 1993 e 1994 più volte citati, dell’intervento metodologico di S. Asperti, Répertoires et attributions: une reflexion sur le systeme de classification des textes dans le domaine de la poésie des troubadours, Atti Montpellier 1992, II, pp. 585-94; di prossima pubblicazione (cfr. RLR, XI [1992], p. 292, n. 40) un repertorio delle attribuzioni controverse curato da C. Pulsoni. 93 a rendere più variegata la sua attività poetica: una canzone di metro breve, scorrevole e di breve respiro come FqMars 155,12 (XXIII), cui andranno forse affiancate 155,9 (XV), l’alba religiosa 155,26 (XXVI) e il Bußlied in octosyllabes come 155,19 (XXVII), un frammento di grande importanza nella storia della poesia del Duecento come 155,4 (XXII), costituiscono insieme con l’estribot 155,25 (XXV) 97 un aspetto della poesia di Folchetto di Marsiglia poco rilevato nell’ed. Stroński e certamente da valorizzare. Propongo quindi di ritornare al canone di Bartsch, 27 testi di cui 22 di attribuzione sicura (BdT 1, 3, 4 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27) e 5 di attribuzione dubbia (BdT 2, 9, 13, 17, 26). Sono inoltre attribuiti a FqMars i seguenti componimenti (alcune ipotesi sui motivi che hanno indotto le attribuzioni sono in Stroński, pp. 121*-23*): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. AimBel 9,7 (XIV) in M 30 AlbSist 16,12 (XI) in C 11 ArnMar 30,3 (IX) in f 32 ArnMar 30,8 (XV) in V 82 ArnMar 30,16 (I) in Kp 104 BnVent 70,41 (XLI) in W 188 Caden 106,14 (XIII) in R 52 e tav. C (cfr. § 1.2.4) GcFaid 167,27 (XXXVIII) in D 44 GcFaid 167,59 (XXX) in Q 21 GsrSt-Did 168,1 (Sakari 1963, p. 313) in L 27 GsbPuic 173,3 (III) in P 10 GsbPuic 173,11 (XI) in P 10 GrdoRos 240,4 (I) in T 225 Perd 370,9 (XXII) in C 5, R 51, f 23 (cfr. § 1.2.5) RicBarb 421,5 (V) in P 10 RicBarb 421,10 (IX) in P 10, 234 [= canz. franc. C]. Per altre indicazioni si veda infra il § 2.1.3 sulla tradizione indiretta. 1.3. Cronologia del canzoniere folchettiano. Come ho già detto nel § 1.1.3, Stroński ordina i testi considerati autentici in successione cronologica: l’editore data più o meno precisamente le prime diciannove composizioni servendosi caso per caso di indizi «de force probante inégale, mais qui constituent tous ensemble un instrument d’orientation assez sûr» (p. 69*), ovvero le allusioni storiche, la bipartizione del canzoniere amoroso, i rapporti del trovatore con le corti, l’uso a partire da un testo dei senhals Azimans e Tostemps, gli accenni a questioni amorose e metatestuali nelle tornadas, i legami formali e contenutistici fra i singoli componimenti. 97 Sulla definizione di genere, mutuata da Vatteroni 1990, rimando al Commento alla mia edizione del testo. In base a questi criteri, Stroński elabora la cronologia del corpus folchettiano, riassunta in una tabella che è utile qui riportare 98: 1179/80: 1180/85: 1185/6-87: fin 1187: vers 1188: vers 1188-90: mileu 1190: 1190-92: extr.fin 1192: vers 1193/4: milieu 1195: sec.moit. 1195: i [I] ii [II] iii, iv, v [IX, X, XI] ch. crois (xxvii ou perdue) vi, vii, (?) [XVII, II] viii, cobla xvi, ix, tenso xv [IV, XXV, V, XXIV] x [VI] xi, xii, xiii [VII, VIII, XII] planh xvii [XXI] xiv [XIII] ch.crois.Or. xviii [XIV] ch. crois.Esp. xix [XVIII] In realtà soltanto una parte dei testi contiene riferimenti alla realtà che permettono di fissarne le coordinate temporali; i restanti componimenti sono datati attraverso gli altri criteri sopra indicati. Propongo pertanto di separare i testi in cui la datazione si appoggia a riferimenti al contesto storico (§ 1.3.1) o dei quali è possibile offrire una datazione relativa (§ 1.3.2) da quelli in cui non sono reperibili indizi cronologici (§ 1.3.3); e soprattutto, di discernere e gerarchizzare nei primi gli elementi di datazione precisi da quelli che indicano semplicemente un terminus ante o post quem e da quelli congetturali, così da fornire una serie di dati storicamente verificabili su cui impostare ulteriori ricerche. 1.3.1. Testi storicamente databili. § 1.3.1.1. Ben an mort mi e lor. In FqMars 155,5 (I) vengono nominati Alfonso II d’Aragona, I come conte di Provenza 99 (vv. 44-45) e «[e]N Raimon Berengier» (v. 52’) 100, identificabile con Raimondo Berengario IV, fratello cadetto di Alfonso: il suo vero nome era Pere, conte di Cerdagne dal 1162, ma intorno al 1170 aveva assunto il nome di Raimondo Berengario «pour faciliter son installation à la tête de la Provence gouvernée par des Ramon Berenguer ou 98 Cfr. p. 75*: i numeri romani in minuscolo rimandano all’ed. Stroński: intregro fra parentesi quadre i numeri corrispondenti nella mia edizione. 99 Nato probabilmente nel 1154 (secondo la proposta di Pirot 1972, pp. 159-63 che, a partire dalla data tradizionale [1152], discute le varie datazioni [fra il 1154 e il 1157] indotte dalle ambiguità nella documentazione), è conte di Barcellona nel 1162 (alla morte del padre Raimondo Berengario II e IV di Barcellona), re d’Aragona nel 1164 (ricevuta la corona dalla madre Petronilla, erede legittima) e quindi conte di Provenza nel 1166 (alla morte di suo cugino Raimondo Berengario III). 100 In una tornada tràdita dai soli ms. Ols e inviata a Trez: cfr. la Nota al testo della mia edizione del componimento dove si ipotizza che l’invio appartenga a una seconda redazione della canzone. des Berenguer Ramon depuis 1112» 101; già dal 1168 102 infatti Alfonso lo aveva associato alla contea di Provenza, tolta a Raimondo V di Tolosa nel 1166. Se il terminus ante quem si può fissare al 5 aprile 1181, data dell’assassinio di Raimondo Berengario 103, il terminus a quo può essere spostato in avanti tenendo conto che il primo atto provenzale di Raimondo Berengario è del luglio 1173 e soprattutto che l’atto ufficiale d’investitura come conte di Provenza è del dicembre 1178 104: questa data sarebbe inoltre prossima a quella indicata da Stroński (cfr. pp. 10*-12*), che riferisce il v. 50 («qu’alz enemics vei que ·s fai obezir») alle conquiste militari di Alfonso del 1179, momento culminante della disputa con il conte di Tolosa 105. § 1.3.1.2. Tant m’abellis l’amoros pessamens. La canzone FqMars 155,22 (II) è inviata (cfr. vv. 45-48) a tre donne di Nems (l’odierna Nîmes), città guidata dal visconte Bernart Athon (1159-1187), figlio postumo dell’omonimo Bernart Athon e della viscontessa Guillaumette, della casa di Montpellier, sua tutrice fino al 1174 e ancora vivente nel 1197; Bertrand era sposato con Garsinde, ventenne nel 1180. Stroński, dalla cui edizione ricavo le notizie qui esposte (cfr. pp. 12*-13*), suppone che le tre dame dedicatarie siano Guillamette, Garsinde e, forse, una sorella sconosciuta del visconte. Nel 1187 Raimondo V di Tolosa conquista la città per cui l’invio si giustifica solo anteriormente a questa data 106; 101 Aurell 1995, pp. 387-88. Cfr. Aurell 1989, p. 19; la datazione non è univoca negli studi: se Jeanroy 1934, I, p. 172, F. Lecoy nella rec. a Del Monte 1955 (Rom, LXXVII [1956], pp. 387-91, a p. 378) e Gouiran 1985, I, p. 472 confermano il 1168, Stroński, p. 10* arretra la data al 1166, mentre Kolsen 1910-35, II, p. 275, Sharman 1989, p. 409 e W.D. Paden Jr. et alii, The Poems of the Troubadour Bertran de Born, Berkley-Los Angeles-London, University of California Press 1986, p. 273 la pongono al 1167; si spingono più in là, al 1172, A. Cappelli, Cronologia e calendario perpetuo, Milano, Hoepli 19886, p. 467 e U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du Moyen âge (Bio-bibliographie), Nouvelle édition [...], New York, Kraus Reprint 1960, II, col. 3888, che tuttavia rimanda a luoghi non pertinenti della PL, CLV, col. 1268 e CCI, col. 1379, riferiti a Raimondo V di Tolosa. 103 Il racconto dell’imboscata mortale si legge in Milá y Fontanals 1966 [1861], p. 88. 104 Aurell 1995, pp. 388, n. 1. Naturalmente nell’ipotesi che l’accenno a Raimondo caratterizzi una seconda redazione della canzone è a questa seconda redazione che andranno riferiti i limiti temporali individuati; per quanto riguarda l’eventuale prima redazione non è necessario pensarla composta anteriormente all’investitura di Raimondo (quindi ante 1166) in quanto il testo potrebbe semplicemente essere stato ‘aggiornato’ e fornito di un nuovo invio in occasione di una esecuzione a cospetto di Raimondo: l’ipotesi di doppia redazione è insomma perfettamente compatibile con la datazione proposta, 1179-80. 105 Nel 1177 Alfonso aveva formato una lega con i viscontati di Nîmes e Narbona e col signore di Montpellier; il passaggio, nel 1179, di alcuni alleati dalla parte di Raimondo, provocò l’intervento di Alfonso che riuscì a sottomettere alla sua autorità i viscontati meridionali. 106 Per Zingarelli 1899, pp. 27-28, n. 32 la poesia va datata post 1187 in quanto la vida testimonia i rapporti di Folchetto con Raimondo V di Tolosa, non con Bernard Athon: Stroński rigetta giustamente il ragionamento chiedendosi: «quelles auraient été les trois dames à une cour qui, à vrai dire, n’existait plus après cette date, et qui aurait compris qu’une chanson envoyée vas Nems fut destinée au comte de Toulouse?» (p. 13*, n. 1). 102 d’altra parte solo dal 1179 il viscontato di Nîmes risulta alleato di Aragona e Provenza, per cui il testo risale al periodo fra il 1179 e il 1187. Solo in subordine si può considerare l’osservazione di Stroński che il componimento deve essere posteriore al 1179-80 e anteriore al 1185-86 perché in quegli anni Folchetto aveva relazioni rispettivamente con le corti di Provenza (cfr. canz. I) e Montpellier (cfr. il ciclo dell’emperairitz) 107. § 1.3.1.3. Tan mou de cortesa razo. La canzone FqMars 155,23 (IX), costituisce insieme con 155,27 (X) e 155,8 (XI) il cosiddetto ciclo dell’emperairitz 108, in cui Folchetto nomina Eudossia, figlia o meglio nipote, dell’imperatore di Costantinopoli Manuele Commeno, venuta in occidente per sposare Alfonso II d’Aragona, o piuttosto suo fratello Raimondo Berengario, e andata in moglie a Guglielmo VIII di Montpellier (1172-1202) 109, ma ripudiata nel 1187. L’assenza di accenni al ripudio data il testo ante 1187; Stroński ipotizza che il testo sia stato composto «vers la fin du séjour de celle-ci [scil. Eudossia] à Montpellier, en 1185/6 environ» (p. 14*), perché ritiene che l’intero ciclo sia stato scritto in breve tempo e quindi che il testo preceda di poco il successivo datato 1186-87, ma la prossimità temporale non è provata; a meno di non valorizzare l’accenno ai lauzengiers ai vv. 13-24, che potrebbe essere, invece di un motivo topico, un’allusione ai responsabili di eventuali maldicenze su Eudossia, fatte circolare da Guglielmo al fine di legittimare il ripudio: si tornerebbe, per altra via, a ridosso del 1186. § 1.3.1.4. Us volers outracuidatz. La cobla VI (vv. 51-60) di FqMars 155,27 (X) lamenta la mancanza di Eudossia senza accennare al successivo matrimonio di Guglielmo con Agnès, parente del re d’Aragona, contratto nell’aprile 1187: il testo risale quindi al 1186-87. 107 Va invece rifiutato il tentativo di Stroński di legare i vv. 26, 32-34, 35-36 rispettivamente a FqMars 155,5 (I), 2, 32-34, 40 al fine di inferire la successione immediata fra i due testi: dubito molto che sintagmi topici come quelli in questione possano essere usati allo scopo di datare una poesia. 108 Per ulteriori indicazioni sulla vicenda cui fa riferimento il ciclo si veda il cappello al Commento delle tre canzoni citate. 109 Sia il legame parentale di Eudossia con l’imperatore di Bisanzio (per il quale rimando al Commento a FqMars 155,23 [IX]), sia la persona del promesso sposo sono incerti per la non uniformità delle fonti: Stroński (p. 153 sgg.), seguendo il racconto del Libre dels Feyts di Jaume I d’Aragona, ritiene che Eudossia fosse venuta per sposare Alfonso e che abbia invece sposato Guglielmo poco dopo il 18 gennaio 1174, data delle nozze fra Alfonso e Sancha, figlia di Alfonso VII di Castiglia (cfr. HGL, VI, p. 62); tuttavia da Aurell 1995, p. 375 si ricava che il matrimonio fra Alfonso e Sancha era stato combinato già nel 1157 e che l’ ‘imperatrice’ era stata chiesta in moglie da Alfonso per il fratello Raimondo Berengario, per cui data di arrivo in occidente e matrimonio con Guglielmo vanno spostare al 1179-80 e al 1181 (data quest’ultima che si legge in alcuni studi fra i quali Diez 1882 [1829], p. 198): cfr. Aurell 1995, pp. 402-403. § 1.3.1.5. En chantan m’aven a membrar. Nella seconda tornada di FqMars 155,8 (XI) chi dice io nel testo chiede perdono a Guglielmo VIII di Montpellier per una colpa non specificata: «Chanssos, desse / vas Monpeslier vai de part me / a don Guillem dir, sitot no·il sap bo, / sos pretz, car creis, li·m fai querre perdo» (vv. 55-58): è certo fondata l’ipotesi di Stroński che FqMars si riferisca all’accusa di folor contenuta in FqMars 155,27 (X), 58-60; il fatto che non si nomini Eudossia fa pensare ad una data successiva all’aprile 1187 (nuovo matrimonio di Guglielmo), ma non troppo perché il probabile riferimento alla canzone precedente si giustifica solo dopo un intervallo di tempo non eccessivo 110. § 1.3.1.6. Ai! quan gen vens et ab quan pauc d’afan. FqMars 155,3 (VI) è una canzone d’amore chiusa da una cobla d’argomento politico che offre gli elementi per la datazione: Folchetto vi celebra Riccardo Cuor di Leone in partenza da Marsiglia per la III crociata; il re inglese, arrivato nella città il 31 luglio 1190, dopo essersi incontrato con le truppe francesi a Vézelay il 4 luglio, attende la sua flotta, che lo raggiunge il 22 agosto; prosegue il viaggio via terra sino a Messina dove arriva il 3 settembre; lascia la città solo il 10 aprile dell’anno successivo. La canzone (o meglio la cobla V: cfr. la Nota al testo della mia edizione) risale certamente al luglio o all’agosto 1190 111. § 1.3.1.7. Si com sel qu’es tan greujatz. FqMars 155,20 (XXI) è un planh scritto per la morte di Raimon Jaufre Barral, visconte di Marsiglia, deceduto alla fine del 1192: il testo sarà stato prodotto poco tempo dopo, quindi al più tardi nei primi giorni del 1193 112. § 1.3.1.8. Ja non volgra q’hom auzis. La canzone FqMars 155,12 (XXIII), esclusa da Stroński dalla produzione di Folchetto (ma vd. supra il § 1.2.2), non fornisce elementi oggettivi di datazione, ma la sua struttura metrica e le rime (Frank 1953-57, n° 541:2) si ritrovano in BtBorn 80,8 (XXXV), sirventese databile all’inizio del 1194; è probabile che il nostro testo preceda di qualche 110 Cfr. p. 15*; la composizione, aggiunge Stroński alle pp. 157-58, risalirebbe agli anni immediatamente precedenti al matrimonio fra Maria di Montpellier, figlia di Eudossia e Guglielmo, e Barral di Marsiglia, segno dei buoni rapporti fra le due corti che Folchetto poteva aver turbato con la sua accusa; sulla vicenda di Maria si veda il Commento a FqMars 155,23 (IX). 111 Runciman 1966, II, pp. 693-94 e 716-23 (con indicazione puntuale delle fonti medievali da cui sono tratte le notizie); Stroński offre date diverse: 3 luglio per l’incontro di Vézelay, 7 agosto per l’imbarco (ma Riccardo parte via terra) da Marsiglia per l’Oriente (cfr. p. 23*; l’editore utilizza una fonte ampiamente citata anche da Runciman, Itinerarium peregrinorum et gesta Regis Ricardi, edita da Stubbs, «Rolls Series», London 1864). 112 Il giorno della morte deve essere compreso fra il 10 novembre 1192, data di un atto di donazione promulgato da Barral, e il 28 dicembre dello stesso anno, data di un documento firmato da Hugo Gaufridi e Ramundus Gaufridi, signori di Tretz e visconti di Marsiglia (cfr. Stroński, pp. 166-67). tempo il sirventese 113. Ma poiché nella tornada viene nominato il «senhor de Limozis», ossia Riccardo Cuor di Leone, duca d’Aquitania sin dal 1169, occorre tener conto che dal 1192 sino al febbraio 1194 il re inglese era prigioniero dell’imperatore Enrico VI (come si vedrà in dettaglio al § 1.3.1.10); l’assenza di allusioni alla cattività o all’avvenuta liberazione fa ritenere la canzone anteriore al 1192, e anzi si potrebbe risalire al 1190 quando Riccardo, in partenza per la Terrasanta passò da Marsiglia (come visto al § 1.3.1.6) 114: lo stesso contrafactum di BtBorn, d’altro canto, è anteriore a quella liberazione che viene auspicata nella cobla IV (vv. 25-32) e al v. 37, almeno nella versione del ms. A, ms.-base di Gouiran: «pois q’er vengutz d’Alemaigna» (gli altri testimoni, DFIK, «semblent présenter une version modifiée à la suite de l’élargissement de Richard» 115, ossia: puois uenguz es dalemaingna). § 1.3.1.9. Ja no·s cug hom qu’ieu camje mas chansos. Folchetto accenna nella prima tornada di FqMars 155,11 (XIII) alla morte di Barral (cfr. vv. 4145) per cui il testo va datato post 1192; l’ipotesi verosimile che si debba collocare il testo dopo breve tempo dalla morte è però smentita da un’altra menzione del lutto all’inizio della canzone di crociata 155,7 (XIV), databile (come si vedrà al paragrafo successivo) alla metà del 1195. Stroński indica come terminus ad quem il 1195: la canzone sarebbe l’ultima canzone d’amore scritta dopo la morte del visconte (cfr. p. 74*); inoltre il 1195 è l’anno in cui si suppone avvenuta la monacazione di Folchetto. § 1.3.1.10. Chantars mi torna ad afan. Nella canzone di crociata FqMars 155,7 (XIV) il trovatore incita Riccardo Cuor di Leone e Filippo Augusto a seguire l’esempio dell’imperatore Enrico VI che a Bari, nel giorno di Pasqua del 1195 (il 2 aprile), aveva fatto voto di partire per una nuova spedizione in Terrasanta 116, in séguito alle rinnovate pressioni dei Turchi dopo la fine della III crociata 117. Terminus ante quem è il 19 luglio dello stesso anno, giorno della 113 Beltrami 1989, p. 21, n. 38; sulla data del sirventese di BtBorn vd. Gouiran 1985, II, pp. 695-97. 114 A rigore si potrebbe risalire anche a un periodo anteriore, posteriore soltanto all’assunzione del titolo di duca di Aquitania (1169): assumo insomma che il contrafactum di BtBorn sia stato realizzato a distanza di qualche anno dal modello, sebbene si conoscano casi di riprese della forma metrica a grande distanza dal modello; un caso è GlSt-Greg 233,1 Be·m platz lo gais temps de pascor (Loporcaro 1988, p. 53; BdT 80,8a come testo di BtBorn) scritto «sul finire del 1219 o in una data non di molto posteriore» (Loporcaro 1988, p. 68; e cfr. P. G. Beltrami, Remarques sur Guilhem de Saint Gregori, in Atti Torino 1993, I, pp. 31-43) che prende a modello GrBorn 242,51 (XXXVII), databile al 1191-92 (sulla ripresa si vedano le considerazioni di Loporcaro 1988, p. 64 e n. 66 e di Meneghetti 1992, p. 80). 115 Gouiran 1985, II, p. 697. 116 Il voto era già stato pronunciato in segreto il 31 marzo (cfr. Lewent 1907, p. 342, n. 3, e Stroński, p. 178). 117 Cfr. i vv. 33-36: «mas pero la deshonor / posc dir si·l turc entre lor / son vencut ni baissat jos, / pois tuich vencut venson nos»; in effetti, dopo la morte di Saladino (3 marzo 1193), si scatenarono lotte intestine fra i suoi figli: al-Afdal, primogenito e sultano di disfatta cristiana ad Alarcos: l’assenza completa di allusioni ad un evento che ha provocato un’eco rilevante fra i trovatori 118 fa ritenere il testo anteriore a quella data. Altro indizio dell’anteriorità al luglio 1195 è la mancanza di accenni alla guerra fra Riccardo e Filippo Augusto, che osservarono una tregua fra il novembre 1194 e il luglio 1195 119. § 1.3.1.11. Oimais no·i conosc razo. Dopo la sconfitta inflitta dal califfo del Marocco Abû-Jûsuf ad Alfonso VIII di Castiglia sotto le mura di Alarcos il 19 luglio 1195, Folchetto scrive la canzone di crociata FqMars 155,15 (XVIII) per incitare i signori cristiani a riconquistare la Spagna. Il terminus ad quem è fissato al 26 aprile 1196, data di morte di Alfonso II d’Aragona, nominato come «nostre reys d’Arago» (cfr. vv. 34-37), ma è probabile che la canzone sia di poco successiva alla sconfitta 120. Damasco, licenziò tutti i ministri di suo padre i quali si rifugiarono in Egitto presso il secondo figlio di Saladino, al-Aziz; questi invase la Siria nel maggio 1194 giungendo alla porte di Damasco; solo la mediazione di al-Adil, fratello di Saladino, riuscì a porre fine al contenzioso: la sovranità di al-Afdal fu riconosciuta in cambio di alcuni territori. Meno di un anno dopo, proprio nel periodo di composizione di Chantars mi torn, al-Aziz attaccò di nuovo Damasco e ancora una volta dovette intervenire al-Adil; al-Afdal riuscì a respingere in Egitto il fratello e si propose di attaccare il Cairo, ma stavolta al-Adil gli ingiunse di tornare a Damasco, minacciandolo di togliergli il suo appoggio. In effetti il cambio di alleanze avvenne, constatata l’incapacità di governo del nipote, nel luglio 1196 e al-Aziz potè impadronirsi di Damasco e del titolo di sultano (cfr. Runciman 1966, II, pp. 754-55, e Stroński, pp. 173-75). 118 La stessa canzone di crociata FqMars 155,15 (XVIII) origina da quella battaglia: si veda di séguito il § 1.3.1.11. 119 Espone i dati qui esposti, concordando pienamente, Hölzle 1980, I, pp. 436-37. Altre datazioni sono state proposte in base a interpretazioni diverse dei vv. 53-54 e 55-56: per i primi versi («s’il [scil. Riccardo] a fait la messio / et autre fai la preiso») Stroński riprende la lettura di Torraca 1897, p. 160: «‘egli ha fatto la spesa e un altro fa l’acquisto’, ovvero: ‘egli ha seminato e un altro raccoglie’», riconosce cioè l’allusione al riscatto pagato dal re inglese a Enrico VI per la sua liberazione: Riccardo era stato catturato presso Vienna al ritorno dalla Crociata nel dicembre 1192 e consegnato nel febbraio successivo dopo all’imperatore che lo libererà solo un anno più tardi, il 4 febbraio 1194 (assumo questa data già in Lewent 1907, p. 342, n. 3 e in Stroński, p. 176, ed ora confermata da Spetia 1996, p. 102, n. 2, avvertendo che Torraca 1897, p. 159 indica invece il 9 febbraio, mentre Runciman 1966, II, pp. 749-50 pone la liberazione in marzo). Diez 1882 [1829], p. 203 intende preiso ‘prigione’ e intende perciò Riccardo ancora recluso, per cui data il testo al 1193; lo seguono Pratsch 1878, p. 38 e Zingarelli 1899, p. 65. Lewent 1907, p. 342, pur ritenendo Riccardo ancora prigioniero, rifiuta la datazione di Diez e valorizza il riferimento di Folchetto alle lotte interne all’Islam del 1194, ma interpretando i vv. 55-56 come un’allusione ai tentativi di Enrico di conquistare la Sicilia, data il testo al principio del 1194. Infine Schultz-Gora 1906, recensendo il lavoro di Lewent, accetta le argomentazioni dello studioso, pur rifiutando la tesi della cattività di Riccardo; data perciò il testo «im Laufe des Jahres 1194»; lo stesso studioso, recensendo l’ed. Stroński, ha evidenziato alcuni problemi cronologici indotti dall’interpretazione di singoli versi: cfr. Schultz-Gora 1921, pp. 148-50 e infra la nota 45-46 del Commento alla mia edizione del sirventese. 120 Cfr. Lewent 1907, pp. 362-63; e Stroński, pp. 26*-27* e 183-84. Anche Hölzle 1980, I, pp. 438-39 accetta la data. 1.3.2. Testi relativamente databili. L’assenza di riferimenti al contesto storico rende assai difficile e talora impossibile proporre una datazione storicamente fondata, anche solo approssimativa, per gli altri componimenti folchettiani. Stroński, come ho già detto data tutti i componimenti del canzoniere ritenuto autentico, ma con l’ausilio di argomenti interni che lasciano largo spazio al dubbio. In primo luogo la raccolta in gruppi omogenei della produzione del trovatore in relazione alle corti cui ha inviato le proprie composizioni deve esser fatta con una certa cautela, perché non è dimostrabile che i poeti intrecciassero rapporti con una sola corte per volta o che dovessero necessariamente esaurire la propria esperienza con una corte in un unico periodo. Inoltre i rapporti contenutistici o metrico-strofici fra i testi, se individuano un legame fra loro, non dimostrano necessariamente eventuali rapporti di successione; allo stesso modo, la presenza costante di un senhal o il contenuto delle tornadas può implicare un legame fra i testi, ma non determina tout court una successione cronologica. Al contrario Stroński, rilevati rapporti contenutistici fra due testi, inferisce la loro contiguità temporale come se non fossero possibili riprese lessicali o tematiche anche fra testi cronologicamente lontani. Più delicato il problema delle due ‘maniere’ in cui Stroński bipartisce il canzoniere amoroso: alle bonas cansos, tipiche esaltazioni del servizio d’amore e del mai appagato desiderio erotico, farebbero séguito le malas cansos, in cui quel servizio e quel desiderio vengono rifiutati e l’amore stesso respinto 121. Ma nello spazio lirico trobadorico queste rappresentazioni opposte e apparentemente inconciliabili della fin’amor coesistono perfettamente: la frustrazione e l’appagamento, la rassegnazione e la ribellione sono alcune delle varianti del complesso sistema ricavabile dalle poesie dei trovatori, nel quale la centralità della metafora amorosa consente una completa riformulazione del contesto cui si fa riferimento. In questo senso la successione, se c’è, è logica più che cronologica: lo ha detto benissimo Leo Spitzer a proposito dello sviluppo in JfrRud del motivo dell’allontanamento: «luenh es lo castelh > amor de terra lonhdana > amor de lonh, ce seraient trois étapes possibles (je ne veux pas affirmer la succession chronologique des trois poésies qui contiennent ces expressions!) de la gestation intérieure dans l’âme du poéte» 122. Fatte queste 121 Un’analisi delle due tipologie liriche è nel capitolo «Bona canso - mala canso. Zum Abschiedslied der altprovenzalischen Lyrik» di D.Rieger 1976, pp. 303-18. 122 L. Spitzer, L’amour lontain de Jaufré Rudel et le sens de la poésie des troubadours [1944], in Romanische Literaturstudien. 1936-1956, Tübingen, Niemeyer 1959, pp. 363-417, alle pp. 394-95; applicabili al nostro caso le ancor più esplicite considerazioni di Guglielmo Gorni, che, nel dichiarare il proprio «radicale agnosticismo [...] nei confronti di una ricostruzione cronologica su basi stilistiche dell’esperienza guinizzelliana», afferma: «salvo l’accertamento di circostanze storiche inoppugnabili, a mio avviso è anche metodologicamente impropria ogni illazione diacronica sulle rime del Guinizzelli, presso il quale, come presso ogni altro autore eclettico o polimorfo, convive un’ideale sincronia di registri, e per cui vale, premesse, può essere posta in una luce diversa l’affermazione di AimPeg, che nel polemizzare a distanza di tempo con i contenuti anti-amorosi di FqMars 155,10 (XII), su cui si veda infra il § 3.2.2.1.1, afferma in 10,40 (XL), 29-30: «En lui par ver, qu’al comensar cantan / dis ben d’Amor, et al fenir mal gran». Se è arbitrario voler distinguere nettamente due ‘maniere’ poetiche, come fa Stroński che utilizza questi versi per dare sostegno alla sua tesi (cfr. p. 60*), è invece verosimile che gli elementi anti-amorosi si siano innestati su un terreno impregnato di ‘ortodossia’ amorosa e che insomma le malas cansos debbano, in questo caso, seguire un certo numero di bonas cansos. Alcune considerazioni, con conseguenze cronologiche, indirizzano in questo senso. § 1.3.2.1. Greu feira nuills hom faillenssa. FqMars 155,10 (XII) è una mala canso in cui vengono espressamente citate due bonas cansos: nella cobla II si legge infatti (vv. 14-17): «don, non aiatz mais crezenssa / qu’eu m’an, si cum suoill, plaignen / ni moira oimais tant soven / en mas chansos...»; il richiamo è a FqMars 155,14 (IV), 15-16 e 155,1 (V), 1 (cfr. Commento a FqMars 155,10 [XII], 15-17). Inoltre a questa mala canso ‘risponde’ PVid in 364,37 (XL), una canzone dedicata a Barral di Marsiglia (morto alla fine del 1192) che dev’essere posteriore al 1188-89, secondo la cronologia proposta da Avalle (cfr. infra § 3.2.1.2.4). La canzone folchettiana si può datare a qualche tempo prima della replica vidaliana e probabilmente a non molta distanza dal 1188 e non oltre il 1192: proprio quest’ultimo sarebbe, secondo Stroński, l’anno di redazione in quanto una canzone della ‘seconda maniera’ deve essere posteriore al 1190; in particolare perché in FqMars 155,10 (XII) si registra un primo accenno a quel riavvicinamento alla ‘prima maniera’ che culminerà in FqMars 155,11 (XIII), databile, come s’è visto al § 1.3.1.9, dopo la morte di Barral. Inoltre il fatto che la tornada riprenda «exactement» l’idea espressa in quella della canzone che la precede nell’edizione Stroński, FqMars 155,16 (VIII), datata 1191-92, è per l’editore sintomo di contiguità temporale. Di qui la proposta, a mio parere non incontrovertibile, del 1192 come «date approximative» (cfr. pp. 73*-74*). § 1.3.2.2. Sitot me soi a tart apercebutz. FqMars 155,21 (VII) è, secondo Stroński, la prima delle malas cansos e quindi databile al 1190 o all’anno successivo: effettivamente, dichiarazioni come quelle ai vv. 13-16: «mas eu m’en part e segrai altra via, / sos mal pagaz, qu’esters no m’en partria; / e segrai l’aib de tot bon sufridor / que s’irais fort si com fort s’umelia» lasciano intravedere un cambio di poetica; e, d’altro canto, un’affermazione come quella riferita ad Amore ai vv. 6-7: «c’ab bel semblan m’a tengut en fadia / mais de dez ans, a lei de mal deutor», senza volerne ricavare indicazioni troppo precise, può essere recuperata in senso cronologico per situare la canzone agli inizi degli anni ’90. Il terminus ante quem può in questo caso essere indicato con una certa almeno in teoria, la reversibilità delle esperienze» (Guido Guinizzelli e il Verbo d’Amore [1976], in Il nodo della lingua e il Verbo d’Amore. Studi su Dante e altri duecentisti, Firenze, Olschki 1981, pp. 23-45, a p. 27). sicurezza: come si vedrà meglio al § 3.2.1.1, alle richieste contenute nelle sue due tornadas rispondono PoChapt 375,20 (XII) e RmMir 406,21 (VIII): di quest’ultimo è contrafactum metrico BtBorn 80,5 (XXXVI), un sirventese databile con precisione al maggio 1194 123. Se il testo di RmMir va situato con ogni verosimiglianza nello stesso 1194 o l’anno precedente (così Riquer 1975, II, p. 988) e se la canzone di PoChapt «hubo de escribirse muy poco tiempo después de la de Folquet» 124, la data del 1192-93 per il componimento folchettiano dovrebbe essere verosimile. 1.3.3. Testi non databili. Le altre poesie, ovvero le bonas cansos FqMars 155,18 (III), 155,6 (XVII) e 155,4 (XXII), la mala canso 155,16 (VIII), le altre canzoni d’amore di dubbia attribuzione 155,9 (XV), 155,17 (XVI), 155,2 (XIX) e 155,13 (XX), il partimen 155,24 (XXIV), l’estribot 155,25 (XXV) e le composizioni religiose 155,26 (XXVI) e 155,19 (XXVII) non contengono elementi che consentano di datarle anche solo relativamente 125: per molte di esse, tuttavia Stroński offre indicazioni cronologiche fondate su ipotesi concatenate che fanno aumentare ad ogni passaggio il grado di opinabilità del discorso. § 1.3.3.1. Chantan volgra mon fin cor descobrir. «Cette chanson n’offre aucun point d’appui pour la datation»: così scrive Stroński a p. 71* di FqMars 155,6 (XVII); l’editore rileva comunque che la poesia appartiene alla ‘prima maniera’ ed è anteriore ai testi che menzionano i senhals Azimans e Tostemps in quanto «il est vrai qu’aucun envoi de cette chanson ne nous est parvenu 126 mais il est à croire qu’un envoi portant ces noms caractéristiques ne se serait pas égaré»; infine il testo è ritenuto successivo a FqMars 155,8 (XI, Stroński v), datato 1187, per la presenza in entrambe del motivo del fuoco. La conclusione non è, né potrebbe essere, perentoria: «Si la place de cette chanson est bien telle que nous le supposons elle serait de 1188 environ». § 1.3.3.2. S’al cor plagues ben fora oimais sazos. FqMars 155,18 (III) appartiene per Stroński al ciclo dei testi in cui vengono nominati due senhals caratteristici di FqMars, e lo apre perché vi compare il solo Azimans (v. 55): tuttavia che i componimenti che contengono i senhals debbano essere contigui è 123 Cfr. Gouiran 1985, II, pp. 695-97: si noti che i due sirventesi dedicati da BtBorn al ritorno di Riccardo Cuor di Leone dalla prigionia, appunto 80,5 (XXXVI) e 80,8 (XXXV), sono contrafacta di una canzone implicata in un dibattito con FqMars e di una canzone dello stesso FqMars (cfr. supra § 1.3.1.8), peraltro oggetto di una ripresa quasi parodica di Palais (cfr. infra § 3.2.1.2.2). 124 Riquer 1975, III, p. 1264. 125 L’alba religiosa 155,26 (XXVI) e il Bußlied 155,19 (XXVII), se composte da Folchetto, potrebbero appartenere agli anni di monacazione del trovatore, 1195 ca.-1205. 126 L’editore ritiene infatti spurio quello tramandato da GLSV: cfr. infra la mia edizione. di fatto indimostrato; vi si troverebbero inoltre accenni a motivi che verranno sviluppati nelle canzoni successive: in particolare, la personificazione di «Merces» al v. 31 anticiperebbe il dittico su Ragione e Mercé FqMars 155,14 (IV, Stroński viii) e 155,1 (V, Stroński ix); quest’ultima sarebbe inoltre anteriore a FqMars 155,3 (VI, Stroński x), databile con precisione al luglio-agosto 1190 (vd. § 1.3.1.6), dove si registra un nuovo accenno a «merce» (v. 2): ne consegue che le tre canzoni, tutte della ‘prima maniera’ risalirebbero nell’ordine al 1188, 1189, 1189-90, mentre quello che può dirsi con sicurezza è le ultime due, 155,14 e 155,1, devono precedere 155,10 (XII), come detto al § 1.3.2.1. § 1.3.3.3. Vermillon, clam vos faç d’un’ avol pega pemcha. L’estribot FqMars 155,25 (XXV) contiene un’allusione a FqMars 155,14 (IV) e a questa canzone dovrà essere di non molto tempo successivo: la data di Stroński, 118990, dipende da quella, come s’è visto poco fondata, della canzone IV. § 1.3.3.4. Tostemps, si vos sabetz d’amor. Il partimen con Tostemps FqMars 155,24 (XXIV) è considerato della ‘prima maniera’ e posteriore alla prima menzione del senhal in FqMars 155,14 (IV): di qui la datazione nello stesso periodo della composizione precedente, 1189-90. § 1.3.3.5. Per Dieu, Amors, ben sabetz veramen. Appartiene invece alla ‘seconda maniera’ FqMars 155,16 (VIII), dodicesima poesia dell’ed. Stroński: poiché condivide con FqMars 155,21 (VII) la struttura capfinida delle coblas e la rima ura, Stroński mette in relazione le due canzoni e, ritenendo quest’ultima la prima della ‘seconda maniera’ (cfr. § 1.3.2.2), data approssimativamente FqMars 155,16 (VIII) al 1191-92. § 1.3.3.6. Per le altre poesie, FqMars 155,9 (XV), 155,17 (XVI), 155,2 (XIX), 155,13 (XX) e 155,4 (XXII), l’editore non propone alcuna data in quanto sono classificate di dubbia attribuzione e in linea di massima ritenute estranee alla produzione del trovatore: in effetti mancano completamente elementi di datazione e potranno essere collocate in un qualunque momento della carriera poetica folchettiana, all’interno (o al di fuori) degli estremi cronologici accertati: 1179-1195. Riepilogando, risultano databili i componimenti: 155,5 (I) 155,22 (II) 155,23 (IX) 155,27 (X) 155,8 (XI) 155,3 (VI) 155,12 (XXIII) 155,14 (IV) 155,24 (XXIV) 155,1 (V) 1179-80 post 1179-ante 1187 1186 ?; comunque precede la canz. X primi mesi del 1187 poco dopo la canz. X (1187) luglio-agosto 1190 fra il 1190 e il 1192 ante canz. XII poco dopo la canz. IV ante canz. XII 155,10 (XII) 155,20 (XXI) 155,11 (XIII) 155,21 (VII) 155,7 (XIV) 155,15 (XVIII) ante 1192 (probabilmente non molto prima il 1188) fine 1192-primi giorni del 1193 post fine 1192 (forse ante 1195) 1192-93 (comunque ante maggio 1194) fra aprile e luglio 1195 post luglio 1195-ante aprile 1196. Postilla 2009 Le questioni attributive affrontate nel capitolo andrebbero ripensate alla luce del Repertorio di Pulsoni 2001 (si vedano in partic. le pp. 2-3 sull’attribuzione di FqMars 155,17 [XVI], qui al § 1.2.7; le pp. 26-27 sull’attribuzione di Perd 370,9, qui al § 1.2.5; le pp. 88-89 sull’attribuzione di FqMars 155,2 [XIX], qui al § 1.2.8). Sull’attribuzione di FqMars 155,17 (XVI) si veda Zinelli 2003, pp. 523-26, che rilancia con nuovi argomenti l’ipotesi di Stroński. Sull’attribuzione di FqMars 155,19 (XXVII) è intervenuto Di Girolamo 2005, pp. 396-97 valorizzando la tesi di Chambon. Segnalo inoltre che l’argomentazione di Poli 1997, pp. 114-17 in favore dell’attribuzione a AimBel di BdT 9,10 (qui al § 1.2.6), non ha convinto Asperti 1998, p. 202 n. 86, e che la ricostruzione della sezione vidaliana nel ms. P (e S) in nota al § 1.1.1 è stata criticata da Zinelli 2003, p. 503, n. 6. Lo stesso Zinelli (p. 505, n. 8) segnala che la sequenza di testi BgPal in f (9 15 5 .... 326,1), ricavata dalla tavola di Beretta Spampinato 1978, pp. 53-54 e riprodotta nel § 1.1.2, è scorretta (il testo BdT 47,9 non è tràdito in f), ma accetta la tesi di fondo lì proposta, accolta e generalizzata grazie alla BEdT anche da Stefano Asperti (come esposto nel convegno internazionale La tradizione della lirica nel medioevo romanzo. Problemi di filologia formale, Firenze-Siena, 12-14 novembre 2009; la relazione è in corso di stampa negli Atti). CAPITOLO SECONDO L’edizione 2.1. Tradizione manoscritta. § 2.1.1. L a t r a d i z i o n e d i r e t t a . Il mio lavoro ecdotico è fondato sulla collazione di t u t t i i testimoni dei componimenti folchettiani: con poche eccezioni le trascrizioni, effettuate su riproduzioni fotografiche e microfilm dei mss. 1, sono state verificate sugli originali 2. Lo stesso non si può dire per l’edizione Stroński: dalla p. VI dell’Avant-propos risulta che l’editore ha collazionato direttamente soltanto i manoscritti conservati nelle biblioteche fiorentine (FaJPQUac), alla Nazionale di Parigi (BCEIKMRTWf), all’Estense di Modena (Da1) e all’Ambrosiana di Milano (G); ha utilizzato le edizioni diplomatiche allora disponibili dei codici vaticani (AJO) 3 e del Chigiano (F) 4, del canzoniere della Marciana di Venezia (V) 5 e del ms. dell’allora Königliche Bibliothek di Berlino (N2) 6, mentre dell’allora inedito ms. vaticano L ha visionato una riproduzione fotografica 7. Per il canzoniere già conservato a Cheltenham (N, oggi a New York) e a Oxford (S) è dovuto ricorrere alle trascrizioni di C. A. F. Mahn 8 e di Delius 1853; ha utilizzato infine «pour les autres pièces une collation faite, sur les textes de Raynouard et de Mahn, par M. Chaytor pour M. Jeanroy, qui a bien voulu me la communiquer» (p. VI), collazione che non comprende le versioni contenute in N di FqMars 155,23 (IX) e 155,8 (XI), che pertanto mancano nella sua edizione. Altre lacune nella 1 Eccetto il ms. VeAg, di cui ho visionato il microfilm conservato presso la biblioteca del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento dell’Università degli Studi di Firenze, tutte le riproduzioni utilizzate sono custodite nella biblioteca del Dipartimento di Lingue e letterature romanze (seminario di Filologia romanza e italiana) dell’Università degli Studi di Pisa. 2 Le eccezioni riguardano codici ‘remoti’ come Kp (Copenaghen), N (New York), N 2 (Berlino), S (Oxford), VeAg (Barcellona), codici ‘riservati’ come IK, e il frammento A b, peraltro egregiamente edito con fac-simile a fronte da Zufferey 1987, pp. 324-25. 3 A. Pakscher - C. De Lollis, Il canzoniere provenzale A (Cod. Vat. 5232), SFR, III (1886-1891), pp. 1-670 e 721-22; P. Savj-Lopez, Il canzoniere provenzale J, SFR, IX (1903), pp. 489-594; e De Lollis 1886 per il ms. O. 4 E. Stengel, Die provenzalische Blumenlese der Chigiana, Marbourg 1878. 5 Grüzmacher 1864. 6 Oggi Staatsbibliothek: A. Pillet, Die altprovenzalische Liederhandschrift N 2. (Cod. Phillipps 1910 der Königkichen Bibliothek zu Berlin), ASnSL, CI (1898), pp. 111-140, 36589 e CII (1899), pp. 179-212. 7 L’edizione di Pelaez 1921 seguirà una decina d’anni dopo. 8 Non meglio specificate, ma certo quelle contenute in MG. recensio sono state indicate da Kurt Lewent 9; ripropongo quell’elenco aggiungendo ulteriori omissioni 10: J 73 an. (V, 29-35); Kp 104v; V 84r - 1 248 (8-14); 86r (29-30); 224 11 (10-11) . 155,3 (VI) Ab 88r - 3 412, 413-14 (1, 25-26); 648 (25-27). 155,5 (I) 29453 (I, 1-10). 155,6 (XVII) Ab 88r (III, 19-27) - BdN 383 (28-31), 602 (19-24). 155,8 (XI) N 58r. 155,10 (XII) Kp 104r; W 200v an. (II, 10-18) - BdN 343 (1, 28-34). 155,11 (XIII) 31081 (39-40). 155,14 (IV) O 33 an. - 29103 (II, 11-20); Regles 290-91 (9-10). 155,16 (VIII) Kp 105r; VeAg 71-72 - 31888 (10-11), 32316 (I, 1-8); 1 407 (VI, 4144); 39r (1-3, 8) , 62r (27-28), 63r (1-3). 155,17 (XVI) Ab 88v (1-41). 155,18 (III) Kp 107v; V 85r - 29027 (II, 11-20); 3 215 (1). 12 155,19 (XXVII) Ol 25v; Pe 101v · 155,21 (VII) O 50 an.; VeAg 73-74; Y 1 (26-30). 155,22 (II) O 56 an.; b 2 - 108. 155,23 (IX) N 57r; S 37; b 6 - 297 (1-3), 302 (13), 303 (25-28); 32 (I, 1-12). 13 155,27 (X) O 59 an. 155,1 (V) Il contenuto del ms. Ab, reso noto nello stesso anno dell’edizione Stroński da Parducci-Meyer 1910, è menzionato dall’editore nelle Additions et corrections (p. 270) 14; i testi trobadorici del ms. Kp erano invece stati trascritti da Edmund Stengel nel primo numero della «Zeitschrift» 15. Il ms. V non è utilizzato da Stroński per le canzoni 155,18 (III) e 155,1 (V) perché Grüzmacher 1864 lo 9 Lewent 1912, coll. 330-31 (nella recensione si troveranno anche osservazioni sulle edizioni diplomatiche non menzionate da Stroński). 10 Segnalo solo la carta (o il verso) in cui inizia la testimonianza; separo con un tratto la tradizione diretta da quella indiretta; se il testo non è riportato integralmente, per la forma frammentaria del supporto oppure per la natura stessa della testimonianza (citazione, strofa isolata, testo di florilegio, ecc.) indico fra parentesi i versi trasmessi, preceduti dall’indicazione dal numero della cobla quando è questa è tràdita integralmente; an. vale ‘testo anonimo’; indicazioni più precise sulla tradizione indiretta sono al § 2.1.3. 11 Inoltre l’incipit del testo conclude la quinta strofa della canzone à citations JfrFoixà 304,1 (I). 12 La data di scoperta dei testimoni giustifica in questo caso l’omissione di Stroński: Pe nel 1912, Ol nel 1953. 13 Per quanto riguarda 370,9 Los mals d’Amor di Perdigon, incluso da Stroński fra i testi dubbi (p. 101, n° XXVI), l’editore non utilizza i mss. N 205r e S 179r, oltre a 29776 (IV, 28-36). 14 Tuttavia, anche Parducci e Meyer, come risulta dalla Chronique di Rom, XXXIX (1910), p. 414, ignorano che i frammento era stato già ‘scoperto’ da Renier 1895, che aveva a sua volta ripreso le indicazioni di G. Mazzatinti, Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia, IV, Forlì 1894, p. 184. 15 E. Stengel, Studien über provenzalischen Liederhss. I. Die kopenhagner Sammlung provenzalischer Lieder, ZrPh, I (1877), pp. 387-96; sottolinea l’omissione lo stesso Stengel 1911, col. 244 nel recensire l’ed. Stroński. definisce «unleserlich» in quei punti: tuttavia i testi erano stati trascritti, pur con qualche lacuna, da Vincenzo Crescini 16. L’editore non segnala il fatto che una serie di incipit sono citati di séguito alla vida nel ms. N2 22r-v, codice che menziona a p. VI. Altra imprecisione sta nell’indicare costantemente con F quello che in realtà è un descriptus del ms., cioè Fa: una caduta intercorsa dopo la c. 22v in F ci ha conservato solo i vv. 1 e 31-39 di 155,18 (III), canzone che apre la sezione dedicata al trovatore nel florilegio chigiano; per il v. 40 della canzone e per tutti gli altri testi bisogna ricorrere al descriptus. Ininfluente invece la mancata utilizzazione di [= Vat. Barb. lat. 3986], segnalato dalla BdT nella scheda del sirventese 155,15 (XVIII), perché si tratta di un descriptus di K (per un testo di F): cfr. Zufferey 1987, pp. 10-11 e BdT, p. XXXV; priva di conseguenze anche l’omissione di e 238 per 155,21 (VII), perché deriva da U, come specificato nella Nota al testo della mia edizione. § 2.1.2. N o t e s u s i n g o l i t e s t i m o n i . Eccetto il primo paragrafo, in cui s’intende giustificare l’introduzione di una nuova sigla per una testimonianza, gli altri due vanno considerati semplici avvii di ricerca. § 2.1.2.1. I l c a n z o n i e r e d i B e r n a r t A m o r o s . La sigla ls sta a indicare la testimonianza relativa ad alcuni testi provenienti dal perduto canzoniere di Bernart Amoros, oggi noto attraverso una copia realizzata nel 1589 dall’amanuense francese Jacques Teissier de Tarascon per conto dell’umanista fiorentino Pietro di Simon del Nero; all’epoca, l’antigrafo era nelle mani di Leone Strozzi 17. La copia, siglata a da Bartsch, si presenta smembrata in due parti: il ms. 2814 della Bibl. Riccardiana di Firenze e il ms. . N. 8. 4: 11, 12, 13 della raccolta Càmpori (oggi nella Bibl. Estense di Modena con la medesima segnatura). Inoltre, le cc. 160v-172r del ms. riccardiano contengono le notizie preliminari su Bernart Amoros (le stesse che aprono il codice), un certo numero di vidas, la formula introduttiva alla sezione delle tenzoni e l’elenco dei poeti di cui si sono trascritti dei testi; questa parte è stata vergata da un altro copista che secondo Stengel potrebbe essere Antonio Martellino 18. Zufferey 1987 ha notato che le sigle di queste che non sono altro 16 Del canzoniere provenzale V (Marc. App. XI), AAL, s. IV, Rendiconti, t. VI/2 (1890), pp. 39-49, riprodotto poi, col titolo Il canzoniere provenzale della Marciana, in V. C., Per gli studi romanzi. Saggi e appunti, Padova, Draghi 1892, pp. 121-37 (155,18 alle pp. 134-35; 155,1 alle pp. 133-34). 17 Cfr. Bertoni 1911, curatore dell’edizione diplomatica, in partic. p. XXI. 18 Die beiden ältesten Provenzalischen Grammatiken Lo Donatz Proensals und Las Rasos de Trobar nebst einem provenzalisch-italienischen Glossar von neuem getreu nach den Hss. herausgegeben von E. Stengel, Marburg, Elwert 1878, p. IX: «Theil III der Hs. [scil. ms. a] zeigt eine selbständige Blattzählung und besteht aus 40 weitläufig geschriebnen Blättern. Die Schriftzüge scheinen dieselben zu sein, welche in einem Namens-Vermerk auf S. 166*** des ersten Theiles: Antonio Martellino vorliegen. Dies wird also der Name des Schreibers von Theil III unserer Hs. sein. Desselben Schreibers Hand verdanken wir die bereits erwähnten Copien von c und F (ca und Fa)». che parti di un unico lavoro di copia separate per ragioni a noi ignote, non sono univoche in tre importanti studi; riporto, con qualche ritocco, la tabella di Zufferey 1987, p. 80: Jeanroy 1916 cc. 1-132 Ricc. 2814 a1 a cc. 160-72 Estense a2 BdT Favati 1961 a a aII a" a1 a' Lo studioso ha proposto di ignorare la divisione in due sezioni e la sottodivisione del codice riccardiano e di utilizzare a come unica sigla. Tuttavia esistono, oltre a quelli copiati dal Teissier e dall’anonimo copista dell’ultima parte del riccardiano, 38 testi che ci sono noti attraverso le note interlineari apposte da Pietro del Nero a due manoscritti di sua proprietà, Fa (un descriptus di F, già appartenuto al Gaddi), e ca (un descriptus di c, già posseduto dall’Adriani, in epoca moderna ceduto da Pietro Fanfani a Edmund Stengel e quindi donato all’Università di Lovanio, dove un incendio l’ha distrutto nel maggio 1940: cfr. Avalle-Leonardi 1993, p. 206). Non avendo notizie dirette, non si possono fare che ipotesi sui motivi che hanno indotto la collazione. Secondo la ricostruzione di Bertoni 1911, l’umanista avrebbe avuto la possibilità di visionare l’originale del canzoniere di Bernart Amoros e quindi di collazionare le 38 poesie prima di affidare al Teissier l’incarico di copiarlo integralmente 19; al contrario, e indipendentemente da Bertoni, Santorre Debenedetti ha ipotizzato che Piero abbia disposto che venissero tralasciati i testi che si ritrovavano nei suoi due manoscritti o che risultavano illeggibili e che, a copia ultimata, avesse collazionato le varianti delle suddette poesie 20. L’essenziale non sta nell’individuare la successione cronologica esatta, quanto nel riconoscere il particolare statuto del testimone in questione; non credo sia corretta l’assimilazione, non dichiarata sebbene implicita nel lavoro di Zufferey, delle varianti di ca alla copia del canzoniere di Bernart Amoros, non tanto perché differisce il copista, quanto per il procedimento stesso di copia. Realizzare una copia sistematica di un testo non è equivalente a considerarne semplicemente le varianti rispetto ad un testo simile. In quest’ultimo caso si deve ipotizzare che la lezione di ca coincida con quella dell’antigrafo ogni qual volta non sia esplicitamente indicata una variante; inoltre il forzoso ricorso all’edizione diplomatica di Edmund Stengel 21, unico testimone di ca, costituisce un ulteriore filtro interposto fra noi e l’originale del canzoniere di Bernart Amoros. Ancora meno corretta sarebbe l’assimilazione al ms. ca, il cui testo 19 Bertoni 1911, p. XXI; concordano con lo studioso Stroński (a p. 116*) e Jeanroy 1916, p. 22. 20 Debenedetti 1995 [1911], p. 274. Pubblicata a puntate col titolo Le chansonnier de Bernart Amoros nella RLR, XLI (1898), pp. 349-80; XLII (1899), pp. 5-43, 305-44, 500-508; XLIII (1900), pp. 198-214; XLIV (1901), pp. 213-44, 328-41, 423-42, 514-20; XLV (1902), pp. 44-64, 120-51, 211-75. 21 costituisce semplicemente la base d’innesto delle varianti. Di qui la necessità di indicare con un’altra sigla la testimonianza costituita dalle varianti interlineari in ca; alcune delle soluzioni proposte dagli editori dei componimenti conservati nel testimone non paiono soddisfacenti: Avalle 1960 sigla ca, Kolsen 1910-35 sigla c’, e così Sharman 1989, ma solo per due poesie su quattro: per le altre due, GrBorn 242,59 (XXVI) e 242,1 (XVIII), utilizza semplicemente la sigla c; quest’ultima è adottata, senza alcuna specificazione, dagli editori di ArnDan e di Peirol. I più corretti sono in sostanza proprio Stroński, che nella scheda dei mss. utilizza la sigla a(var. ca) sebbene in apparato adotti semplicemente la sigla a, e Cavaliere 1938 nell’ed. di PRmToul, che sigla un po’ macchinosamente aI St (a’ St in apparato) per distinguere la testimonianza da aI B, cioè dal canzoniere di Bernart Amoros nella copia di Teissier (St sta evidentemente per Stengel, B per Bertoni). La scelta di una sigla doppia, ls (scil. Leone Strozzi, o Libro Strozzi), deriva dalla necessità di sottolineare la sostanziale diversità della testimonianza rispetto a quella usuale dei canzonieri e la giustificazione storica di essere simile a quella (L.S.) utilizzata dallo stesso Pietro di Simon del Nero per indicare la provenienza delle sue chiose 22. Nella mia edizione cito i testi provenienti da ca con il numero assegnato ad ogni testo da Stengel nella sua edizione diplomatica. L’ordine dei testi di Folchetto nel manoscritto è stato ricostruito da Stroński in base a un elenco di poesie trobadoriche annessa al frammento di un ulteriore descriptus di c scoperto da Pio Rajna alla Bibl. Nazionale di Firenze 23; la grafia della tavola corrisponde a quella delle liriche risultanti dalle note interlineari di ca, per cui l’editore conclude: «Il est donc certain que cette table nous offre la suite (avec l’indication des pages) des chansons de Folquet dans le ms. a, c’està-dire dans l’original du chansonnier de Bernart Amoros» (p. 116 in nota). § 2.1.2.2. U n a p o s t i l l a d e l m s . d i O x f o r d . Nel ms. S (c. 29) i vv. 9-12 di FqMars 155,3 (VI) «are bracketed to right and marked with No. Then the copyist has added this gloss: cato nô mnor ê ût»: così l’editore del canzoniere di Oxford, William P. Shepard 24. È necessario fare alcune precisazioni su questa e le altre glosse del codice. Innanzitutto, l’espressione «the copyist» può indurre a credere che la glossa sia opera dell’estensore del ms. mentre è l’editore stesso a distinguere (Introduction, pp. VIII-IX) il copista veneto di fine Duecento dal glossatore, anch’esso «evidently [...] an Italian» (lo conferma Folena 1990, pp. 17-18); non mi pare invece condivisibile la collocazione cronologica della mano del glossatore, definita «still later» di 22 Cfr. per es. RLR, LXIII (1900), p. 198, ma la sigla è assai diffusa. È un ms. cartaceo del sec. XVI, segnato Magl. Pal. 1198 e siglato c b da Jeanroy 1916, p. 22; l’elenco, limitato ai testi di Folchetto, è riportato da Stroński a p. 115*, n. 1; a ogni incipit segue un numero compreso fra 230 e 234. 24 The Oxford Provençal Chansonnier. Diplomatic edition of the manuscript of the Bodleian Library Douce 269 with introduction and appendices, NewYork, Princeton U. P. Paris, Les Presses Universitaires de France 1927, p. 27, n. 2. 23 quella, quattrocentesca secondo l’editore, che alle cc. 104, 109, 206 e 223 del ms. «has either supplied a few lines left blank in the original, or has inserted on the margin a verse omitted» (p. IX): la grafia del glossatore mi sembra invece piuttosto vicina a quella del copista del canzoniere, quindi non più che trecentesca. Molto affrettata è infine l’asserzione che tali glosse siano «of no importance in themselves» (p. VIII): una più corretta trascrizione dell’ultimo termine della glossa in questione: uit) consente in primo luogo lo scioglimento v(ir)t(us) e soprattutto l’interpretazione della seconda parte della glossa che, minimamente integrata, aquista un senso: no(n) m[i]nor e(st) v(ir)t(us), e una fonte: Ars Amandi, II, 13: «nec minor est virtus, quam quaerere, parta tueri». Quanto all’enigmatico cato è Stroński, che già aveva indicato nel passo ovidiano appena citato la fonte dei versi folchettiani (cfr. p. 79*), a fornire la chiave per l’identificazione: il v. 33 dei Monosticha, una raccolta di proverbi ispirati ai Disticha Catonis, recita infatti: «Acrius appetimus nova quam iam parta tenemus» 25. § 2.1.2.3. I l ‘ f r a m m e n t o ’ Y . Sono così denominate le prime 3 cc. del ms. fr. 795 della Nazionale di Parigi, contenente, dal secondo fascicolo in poi, due testi epici in lingua d’oïl: tramanda a c. 1v una parte (vv. 26-30) della cobla IV di FqMars 155,21 (VII); il testimone è nel complesso poco studiato 26 e meriterebbe maggiore attenzione. In via provvisoria, nel rilevare che per il testo folchettiano si riscontra un rapporto fra Y e i florilegi D c e Fa 27, noto che il ms. ha in un certo senso la struttura di un florilegio centrato su testi di Peire Cardenal. Questo in sintesi il contenuto (i testi sono tutti privi di rubrica attributiva): una prima mano trascrive ordinatamente sulla c. 1r [1] la prima cobla (vv. 1-8) di PCard 335,57 (LXXV), [2] i primi 4 vv. di PCard 335,62 (LXXVIII) e [3] i vv. 5-7 di PCard 335,66 (XXXV), senza soluzione di continuità (ma una croce è segnata sul marg. sn. a dividere [1] da [2]); dopo un rigo bianco [4] le prime due coblas (vv. 1-16) di PCard 335,5 (XLIV); quindi sulla col. b [6] una cobla (vv. 25-36) di PCard 335,25 (XVII). La stessa mano, ma con scrittura più corsiva, aggiunge [5] una cobla (vv. 41-48) a PCard 335,5 [=4] e verga [7] il primo verso e metà del secondo di PCard 335,62 [=2], arrestandosi appena notata la coincidenza (le differenze grafiche fra [2] Tont le mond ez uestic & en braxaz. De fauz engan... e [7] Tout le mond est uesiç & 25 Cito da Poetae Latini minores, recensuit et emendavit Aemilius Baehrens, III, Leipzig, Teubner 1881, pp. 236-40, a p. 238: indicato da Stroński fra le fonti del passo folchettiano, il verso viene fatto risalire ai Disticha Catonis; si aggiunga, sempre su indicazione di Stroński, Publilio Siro: «Fortunam citius reperias quam retineas». 26 Lo studio più completo è quello di Frank 1952b, da cui dipende la descrizione di Raupach-Raupach 1979, pp. 80-82; un accenno in Gröber 1877, p. 636; cfr. anche S. Vatteroni, Fragments of Provençal Lyrical Manuscripts: A Bibliography, Ten, XII (1996), pp. 14-30, a p. 17. 27 I tre testimoni tramandano solo la cobla IV e hanno in comune alcune lezioni (28 neis con DcFa e PSI e car pot esser, con DcFa e PS, 30 ni, con DcFa e PSMO’); per altre indicazioni cfr. infra la Nota al testo alla mia edizione. embragaç. De fals engan indicano chiaramente un cambio di fonte); una seconda mano aggiunge [8] alla fine della col. b sempre di c. 1r i vv. 17-18, 1113 e 15-16 di PCard 355,57 [=1] e, sulla col. a di c. 1v [9] la seconda strofa lacunosa (vv. 8-9, 11-14) della cobla dobla PCard 335,59 (XC). Quindi la prima mano, l’unica attiva da qui in poi, trascrive [10] i vv. 49-50, 4-6, 8 e 24 del sirventese RmCast 396,6 (Lavaud 1957, p. 388, fra le poesie di PCard col n° LX), che i mss. DbMT dànno a PCard, [11] i vv. folchettiani, [12] i vv. 1-8 della cobla RmRouss 395,1 (Lavaud 1957, p. 598), tràdita anche da FP, e da T fra le poesie di PCard (cfr. BdT, n° 461,182), e due unica di Y [13] 461,64 e [14] 461,235 (Appel 1890, pp. 321 e 331); la c. 2r-v è occupata dalla versione integrale di [15] FqRom 156,10 (IX) e [16] Pist 372,3 (IX); infine, dopo «un des intermèdes métriques du “Tristan” en prose» (Frank 1952b, p. 87, n. 49) a c. 3r, si leggono (parzialmente per un taglio della pergamena) [17] 5 coblas unica di Y tutte schedate dalla BdT al n° 461,251a (edite da Frank 1950, p. 75) e altre due tornadas di testi di PCard già trascritti sopra, [18] la prima (vv. 57-60) di 335,25 [=6] e [19] l’unica (vv. 36-38) di 335,66 [=3] 28: da un esame sommario della tradizione dei testi emerge in primo luogo il rapporto di successione fra il frammento folchettiano e la cobla [12], anch’essa tràdita in F e nella sezione delle coblas esparsas di P, oltre che in T; in secondo luogo la vicinanza di Y a M, come risulta dall’esame della tradizione di PCard 335,66 e 335,5 [3-4], gli unici testi di Y editi sinora da Sergio Vatteroni 29: cfr. inoltre, in FqMars 155,21 (VII), la lezione 26 fa(i) desmezura che Y condivide con Mf e il già analizzato v. 30. § 2.1.3. L a t r a d i z i o n e i n d i r e t t a . Indico in successione: l’opera cui si riferisce la sigla, edizione adoperata, eventuali altre edizioni da confrontare e/o altre note sul testo, testi folchettiani citati. 1 3 28 Breviari d’Amor di Matfre Ermengaud; cito da Richter 1976, pp. 243-53 (cfr. Ricketts 1976 e l’ed. completa del Breviari di Azaïs 1862-81): vv. 28181-88: 155,21 (VII), 33-40; vv. 28195-202: 155,21 (VII), 9-16; vv. 28217-24: 155,16 (VIII), 9-16; vv. 29027-36: 155,18 (III), 11-20; vv. 29087-94: 155,21 (VII), 2532; vv. 29103-12: 155,14 (IV), 11-20; vv. 29453-62: 155,5 (I), 1-10; vv. 3108182: 155,11 (XIII), 39-40; vv. 31888-89: 155,16 (VIII), 10-11; vv. 32316-23: 155,16 (VIII), 1-8; vv. 33514**-33514***: 155,1 (V), 34-35. So fo e·l temps qu’om era gais di Raimon Vidal de Besalú; cito da Field 1989-91: vv. 248-54 (mss. LNR): 155,1 (V), 8-14; vv. 407-10 (mss. LNRr): 155,16 (VIII), 41-44; vv. 906-907, 958-61 (ms. R): 155,3 (VI), 23-24, 9-12. Razos de trobar di Raimon Vidal de Besalú; cito da Marshall 1972: r. 215 (vers. CL): 155,18 (III), 1; rr. 412, 413-14 (vers. B) = rr. 238-39, 240-41 (vers. H) = rr. 380-81, 382-83 (vers. CL): FqMars 155,3 (VI), 1, 25-26. Inoltre nel trattato è L’analisi delle mani e la numerazione dei testi è derivata da Frank 1952b. Cfr. rispett. Vatteroni 1993, p. 126 e Vatteroni 1995, p. 180: in PCard 335,66 MY sono inseriti in un ramo isolato dello stemma (cfr. p. 128); in PCard 335,5 MY tramandano una cobla supplementare che Vatteroni pubblica in appendice, a p. 190; si noti poi che tutti i testi di Cardenal di Y sono tramandati in M, tranne [9] PCard 335,59, che tuttavia è aggiunta dalla seconda delle due mani attive nel ms. 29 falsamente attribuita a FqMars una citazione tratta da GcFaid 167,18 (LXII): rr. 444-47 (vers. CL). Documenti d’Amore di Francesco da Barberino; cito dall’edizione di F. Egidi (Roma, Società Filologica Romana 1902-27, 4 voll.) ricontrollata sul ms.: c. 39r: 155,16 (VIII), 1-3, 8; c. 62r: 155,16 (VIII), 27-28; c. 63r: 155,16 (VIII), 41, 1-3; c. 86r: 155,1 (V), 29-30. A quest’ultima citazione segue: et accedit illud aquel serven ai per leials driz [da intendere: druz] et feels ch [esp.] qua donna honor manten aquel es fols uils et quoars que mai desira qua donna conuen e mais e traitres ueramen qui non ben sap li don cobrir que ricepet et peis mentir, citazione non identificata. Dell’Origine della Poesia rimata di Giovanni Maria Barbieri; cito da V. De Bartholomaeis, Le carte di Giovanni Maria Barbieri nell’Archiginnasio di Bologna, Bologna, Cappelli 1927: p. 32: 155,23 (IX), 1-12; pp. 108-10: 155,22 (II), tutto il testo. Doctrina d’acort di Terramagnino da Pisa; cito da Marshall 1972 (e cfr. Ruffinatto 1968): rr. 224-25: 155,1 (V), 10-11; rr. 297-99, 302, 303: 155,23 (IX), 1-3, 13, 25-28; rr. 648-50: 155,3 (VI), 25-27. Inoltre nel trattato sono falsamente attribuite a FqMars alcune citazioni tratte da GcFaid 167,12 (XXXIII): rr. 57178; 167,18 (LXII): rr. 579-82 [e cfr. 3]; 167,51 (VII): rr. 583-86; e da Perd 370,13 (IV): rr. 624-28. BdN Mirall de trobar di Berenguer de Noya; cito da Palumbo 1955: vv. 343, 345-51: 155,10 (XII), 1, 28-34; vv. 381, 383-86: 155,6 (XVII), 1, 28-29; vv. 600, 602607: ancora in 155,6 (XVII), 1, 19-20, 22-24. JSJ Cant vey li temps camgar e·mbrunusir [= Passio amoris secundum Ovidium]; cito da Riquer 1955, p. 196 (n° XVIII): vv. 95-96: 155,5 (I), 1-2. Regles Regles de trobar di Jaufre de Foixà; cito da Marshall 1972: rr. 290-91 (vers. H) = rr. 200-201 (vers. R): FqMars 155,14 (IV), 9-10. 2.2. Criteri di edizione 30. È un problema ben noto dell’ecdotica romanza che la tradizione manoscritta trobadorica sia difficilmente razionalizzabile attraverso gli strumenti ecdotici lachmanniani: a fronte della rarità, e comunque dell’insufficenza, di lezioni di cui sia postulabile con un certo margine di sicurezza l’erroneità 31, si riscontra una grande abbondanza di varianti adiafore. La tradizione manoscritta folchettiana non fa certo eccezione: minimi gli errori, per la maggior parte 30 Rispetto ai Criteri anticipati in Squillacioti 1993, pp. 593-96, molte e sostanziali sono le differenze, ferma restando l’opzione per un ‘restauro conservativo’ della tradizione manoscritta: quell’ipotesi era però fondata su soli cinque componimenti pluriattestati, FqMars 155,5 (I), 155,8 (XI), 155,22 (II), 155,23 (IX), 155,27 (X), e comunque già allora si affacciava la possibilità (a p. 596) che nuovi elementi avrebbero potuto, com’è stato, modificare l’impostazione del lavoro. 31 Scrive Varvaro 1970, p. 94: «In campo romanzo [...] accade frequentemente che si debba constatare il presentarsi di tre circostanze: 1) relativa abbondanza di errori separativi; 2) relativa rarità di errori congiuntivi a livello di archetipo o di iparchetipi e soprattutto debole grado della loro forza congiuntiva; 3) contraddittorietà degli indizi» (cfr. anche le pp. 86-87); per il dominio occitanico può essere ancora più drastico Perugi 1990, pp. 525-26: «Nella pratica generalmente osservata sinora in filologia provenzale gli stemmi tradizionali non funzionano, e non solo per la loro natura più o meno bifida, ma soprattutto per l’inconsistenza del concetto di ‘errore’ tradizionalmente impiegato». limitati ai piani bassi del canone descritto da Avalle, che quindi finiscono per raggruppare solo i mss. di cui è vulgatissima la consaguineità; molto diffuse le varianti adiafore, spesso sinonimiche e difficilmente gerarchizzabili con l’ausilio di concetti come quello di lectio difficilior e usus scribendi; marcatissima la contaminazione che rende difficoltosi, e spesso vanifica, gli sforzi ricostruttivi. Ciò nonostante, è in direzione ricostruttiva che si svolge la prassi ecdotica di Stroński: il metodo utilizzato si richiama a quello lachmanniano, senza tuttavia rispettarne i presupposti indispensabili. Non che i risultati della critica di Stroński siano del tutto inutilizzabili 32: scorretto, in prospettiva lachmanniana, è il loro raggiungimento, fondato com’è su una mescolanza di errori, varianti adiafore, lezioni buone, grafie ritenute inusuali; equivoca la loro sistemazione grafica, lo stemma codicum, perché dà la falsa impressione che si possano effettuare scelte meccaniche; arbitraria la ricaduta editoriale di tale rappresentazione, il testo ricostruito, perché quelle scelte meccaniche di fatto si effettuano. Una razionalizzazione della tradizione s’impone comunque: gli studi ecdotici non mancano, e tuttavia non sono molti quelli che contengono indicazioni operative esplicite. Fra questi si segnala il saggio sulla Critica dei testi classica e romanza di Alberto Varvaro: la tradizione manoscritta folchettiana si situa fra le eventualità (a) e (b) distinte nel § 10 Codex optimus e manoscritto di base: a) può darsi che la tradizione sia così profondamente contaminata da escludere la possibilità di ricostruire l’archetipo, oppure che la tradizione comporti una tale incidenza di interventi attivi (ed es., ma non esclusivamente, a causa di tramiti orali) da rendere vani i concetti stessi di stemma ed archetipo. Non ci rimarrà allora che da stampare uno o più o al limite tutti i testimoni, limitando il nostro intervento ad una parca e prudente utilizzazione dei passi paralleli per sanare le corruttele intollerabili. [...]. b) se lo studio della tradizione permette di fissare i rapporti reciproci fra i testimoni senza però mostrare una tale omogeneità fra di loro od offrire tali indizi da guidare con sicurezza nella ricostruzione dell’archetipo (o dell’autografo), converrà scegliere come base il ms. più autorevole dal punto di vista della competenza, intervenendo sul piano della plausibilità ogni volta che la situazione lo imponga. Accadrà dunque che nel caso di varianti equipollenti la preferenza andrà sempre al ms. di base; perché prevalga la lezione degli altri mss. sarà necessaria la presenza di espliciti indizi contro la lezione del ms. di 33 base . Come si vede, le indicazioni operative di Varvaro coprono un vasto spettro di possibilità e di tipologie testuali: la specificità della tradizione e della trasmissione della lirica trobadorica, e di quella folchettiana in particolare, suggeriscono di adattarle a un procedimento che sulla scorta delle riflessioni metodologiche di Cesare Segre 34 chiamo di r e s t a u r o c o n s e r v a t i v o 32 Si vedrà più oltre quanto e in che modo potranno essere recuperati. Varvaro 1970, p. 107 (cfr. p. 96 per i concetti di competenza e plausibilità). In particolare Metodologia dell’edizione dei testi, in Due lezioni di ecdotica, Pisa, Scuola Normale Superiore 1991, pp. 7-32, alle pp. 30-32 (ora in Segre 1998, pp. 41-53, alle pp. 52-53); ma si veda anche Segre 1976. Sul rapporto fra critica del testo e restauro cfr. R. Antonelli, Interpretazione e critica del testo, in LIE, IV (L’interpretazione), Torino 1985, pp. 141-243, a p. 203, n. 91. 33 34 della tradizione manoscritta e che possa dar conto delle zone di più marcata oscillazione della lezione del testo. Fatta l’ovvia eccezione dei componimenti a tradizione unica e di quelli a tradizione ridotta (2-3 mss.), che presentano problemi diversi di cui si dà conto nella Nota al testo delle singole edizioni, ed anche del planh FqMars 155,20 (XXI), per il quale è possibile, con il vaglio di errori quasi tutti di natura metrica, tracciare uno stemma codicum e ricostruire un testo 35, a guidare tale restauro è negli altri casi una classificazione delle lezioni indifferenti principali, organizzate in una t a b e l l a d e l l e v a r i a n t i a d i a f o r e che le raccoglie insieme con i relatori. In dettaglio, va specificato che: i) con ‘lezioni indifferenti principali’ indico quelle varianti adiafore attestate normalmente da 2, 3 o 4 gruppi di codici, ciascuno, o una buona parte dei quali, costituito da un numero significativo di testimoni: la classificazione di tutte le adiafore, anche quelle singulares o quelle limitate a un numero ristretto di mss., sarebbe stata certo utile, ma del tutto antieconomica; ii) i testimoni di tali lezioni non vengono indicati, come negli apparati, in ordine alfabetico, ma disposti in un ordine tale da evidenziare i rapporti reciproci, e mostrare così la presenza di raggruppamenti di mss.; iii) oltre che alla selezione di cui al punto (i), i dati presentati nella tabella, sono quindi sottoposti ad un’analisi preliminare: di qui la suddivisione della tabella in fasce orizzontali, individuate da lettere maiuscole, in dipendenza dalla particolare conformazione della tradizione; la situazione ideale di un’unica fascia orizzontale che raccolga tutte le lezioni significative e quindi mostri nette divisioni della tradizione non si verifica nel caso di FqMars (si vedano tuttavia le tabelle delle canzoni FqMars 155,18 [III] e 155,6 [XVII] dove la fascia B è assai ridotta rispetto alla fascia A); iv) un’ulteriore selezione riguarda la lezione: un asterisco segnala la sua non omogeneità sostanziale nei relatori (ma le differenze non sono mai tali da non permettere di riconoscerla) e presuppone un rimando all’apparato; a questo si dovrà ricorrere per le varianti grafiche, fonetiche o morfologiche della lezione indicata; v) per ragioni pratiche si è limitata sempre a due lezioni concorrenti l’indicazione completa di relatori e lezione: eventuali altre lezioni sono raccolte in una terza colonna contenente solo i relatori, mentre le indicazioni complete sono relegate in un’apposita fascia in calce alla tabella; vi) questa fascia è preceduta da sintetiche indicazioni sulla tradizione manoscritta (relatori incompleti, lacunosi, omissioni eventuali delle tornadas ecc.) in modo da facilitare la consultazione; 35 Tale particolarità del planh potrà essere messa in relazione con la sua estravaganza rispetto ai canali di alimentazione della tradizione folchettiana descritti al § 1.1.2. vii) qualora un verso del componimento contenga più di una lezione classificata nella tabella aggiungo una lettera minuscola all’indicazione numerica del verso; viii) esemplifico per concludere il ‘funzionamento’ della tabella mostrando il rapporto fra i primi tre righi della fascia B della tabella di FqMars 155,5 (I) e le rispettive indicazioni dell’apparato: 1 3 10a 10b AB IK LNc AB IK N AB IKPS O Q CE TV CE RTV R 2 per ques taing * uol aizir 3 D PSG M Q R per quem platz Ols D PSG M Ols L c Q uolc G M ls LNc CE TV assir D Terza colonna: 3 Ols per ques dreitz. 10b D aussir. Si confronti l’apparato: 3 que·s] que ques IK, quem DGMPQRS; taing] plaz DGMPQRS, dreigz Ols. 3 qeis AB; tanh CE, tainh V, tang Nc, taign T, plaç Q. 10 volc] vol ABCEIKNRTV; aizir] assir CEGLMNTVcls, aussir D. 10 uolg c; aissir IKOPS, aisir Q, ayzir R, assir da affir G. L’asterisco nella prima casella del v. 3 implica un rimando all’apparato da cui si apprende che IK leggono per que ques taing, ma anche in questa forma la lezione è pienamente assimilabile a quella indicata nella tabella; non ho invece segnalato la correzione in G 10 affir > assir, perché la lezione corretta è un evidente errore del copista, ininfluente ai fini della classificazione della lezione. E sono state omesse, come detto, le varianti grafiche. Un primo risultato dell’elaborazione delle tabelle consiste nell’individuazione di un certo numero di v e r s i o n i del testo, che, secondo la chiara formulazione continiana, «non è lecito mescolare»; ho inteso quindi seguire l’indicazione conseguente: «Quando la recensione della tradizione manoscritta mette in luce solo opposizioni di varianti adiafore, sono da riconoscere più redazioni (di autore o no), che devono formare oggetto di altrettante edizioni» 36. Il secondo e più problematico passo è quello di ‘gerarchizzare’ tali versioni, in modo da privilegiare quella di cui si può, caso per caso e sempre con cautela, predicare la superiorità: la versione o le versioni alternative vengono edite in apparato o nella Nota al testo, le lezioni divergenti da quelle della versione messa a testo vengono marcate in grassetto. Gli strumenti per operare la gerarchizzazione, dovendo fare a meno di scelte meccaniche, possono essere indicati attraverso un vaglio delle cause che hanno determinato la situazione sopra descritta: alla proliferazione delle varianti potrebbe aver in qualche misura contribuito lo stesso dettato poetico 36 Contini 1977, pp. 7-8. folchettiano, le cui difficoltà sono prevalentemente d’ordine sintattico, mentre risultano assenti particolari asperità lessicali; le cause generali del fenomeno sono tuttavia di più ampia portata. Il quadro è sinteticamente fotografato da István Frank: La tradition que constituent les chansonniers lyriques du Moyen Age apparaît pour qui veut établir un stemma, comme grevée de tous les éléments de trouble: [1] original multiple (réel, virtuel ou possible), [2] variations et contaminations surgies de la transmission orale, [3] contaminations dues à l’utilisation par les copistes de plusieurs sources divergentes, [4] l’existence, enfin, dans les chansonniers mêmes, d’éditions résultant d’un travail réfléchi, usant de la conjecture. Que nous sommes loin de la 37 trasmission mécanique qui garantit l’efficacité du stemma! Sintetizzando ulteriormente, gli elementi che turbano la trasmissione verticale sarebbero [1] la presenza di varianti d’autore, [2] la trasmissione orale, [3] la contaminazione e [4] gli interventi di copisti-rifacitori. In dettaglio. [1] Nello specifico della tradizione trobadorica le varianti d’autore sono state individuate quasi soltanto nelle tornadas 38: anche nel corpus folchettiano sono ipotizzabili simili situazioni 39. Non si può inoltre escludere che la variazione testuale sia dovuta anche a un intervento d’autore, ma è non facile dimostrarlo; è certamente più agevole escluderlo quando si verifica che una redazione isolabile nella tradizione manoscritta mostra di semplificare i costrutti, appianare le difficoltà, banalizzare i concetti. [2] Un primo aspetto della trasmissione orale è quello della contaminazione mnemonica del processo di copia: senza entrare in una questione assai dibattuta, mi limito a ricordare con Contini che quest’aspetto non muta la sostanza del processo di trasmissione, aumentando soltanto la quantità degli interventi e le difficoltà nella ricostruzione 40. Ma è totalmente mnemonica la trasmissione cui pensa Martín de Riquer nell’introduzione a Los trovadores nel discutere delle frequenti alterazioni dell’ordine strofico41. Anche Cesare Segre ritiene 37 I. Frank, De l’art d’éditer les textes lyriques, in Recueil de travaux offert à M. Clovis Brunel, Paris, Société de l’École des Chartes 1955, I, pp. 463-75, alle pp. 472-73; il saggio contiene (alle pp. 473-75) delle eclettiche indicazioni operative che tuttavia pur presupponendo la conciliazione della «méthode combinatoire» (ossia la critica lachmanniana) con quella «sélective» (o bédieriana), nella pratica editoriale (ho presenti le edizioni di testi folchettiani contenute in Frank 1952) si riduce di fatto alla riproduzione di un ms. di base non sempre emendato dagli errori né dalle «leçons (valables) isolées du manuscrit de base, surtout si elles sont contredites par des témoins qui lui sont étroitement apparentés» (p. 473, n. 1); l’eclettismo di Frank è sottolineato da A. Stussi nell’Introduzione ai Fondamenti di critica testuale, Bologna, il Mulino 1998, p. 26, n. 35 (1 a ed. 1985; e cfr. Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, il Mulino 1994, p. 293, n. 14). 38 Basti un rimando a Avalle-Leonardi 1993, pp. 43-50. 39 Cfr. FqMars 155,5 (I) e 155,23 (IX). 40 Cfr. G. Contini, La critica testuale come studio di strutture [1967], in Contini 1986, pp. 135-48, alle pp. 146-47); altra e più sintetica formulazione in Contini 1977, p. 32. 41 Riquer 1975, I, p. 18: l’argomento è stato ripreso e sviluppato da Amelia E. Van Vleck, Memory and Re-Creation in Troubadour Lyrique, Berkeley - Los Angeles - Oxford, University of California Press 1991; cfr. anche Zumthor 1987, che a riprova della consistenza «verosimile la possibilità di contaminazioni fra tradizione scritta e tradizione orale per le canzoni dei trovatori (o per quelle degli italiani, dai siciliani agli stilnovisti), che possono bene essere state memorizzate dai giullari esecutori ed anche da amatori di poesia e copisti professionali, favoriti in più dalla musica»; ma aggiunge: «Tuttavia, che io sappia, a questa eventualità i provenzalisti non hanno dato molto spazio; comunque lascio loro il problema. Certo la memorizzazione di testi di poche decine di versi, e testi di successo, sembrerebbe proprio naturale» 42. Altro aspetto, altrettanto rilevante nello specifico della lirica trobadorica, riguarda l’esecuzione dei testi: sia che gli autori abbiano compiuto modifiche testuali in occasione di esecuzioni, sia che – come pare più probabile – gli esecutori stessi abbiano adattato o interpretato (nel senso che si usa in musica), oppure, più semplicemente, modificato il testo, il risultato è una situazione difficilmente riconducibile a un ‘originale’. È tuttavia assai dubbio che di qui si possa assumere la mouvance come condizione naturale del testo medievale ed elaborare un’ecdotica conseguente o arrivare a posizioni estreme come quelle espresse da Bernart Cerquiglini: «l’écriture médiévale ne produit pas de variantes, elle est variance», e quindi rivolgersi a soluzioni macchinose come «l’édition écranique» 43. [3] Sulla contaminazione (e sui rimedi da opporle) molto si è scritto: fra le modalità di contaminazione ha particolare interesse nella tradizione trobadorica quella che deriva dalla copia di esemplari dotati di varianti alternative sui margini o nell’interlinea. Questa procedura è infatti ricostruibile attraverso i ‘residui fossili’ di d o p p i e l e z i o n i , particolarmente abbondanti nel ms. D 44, ovvero di varianti marginali inglobate nel testo; si dà inoltre il caso di d o p p i e r e d a z i o n i n e g a t i v e ovvero di «luoghi in cui il copista, posto di fronte alla scelta tra due possibili varianti adiafore, apparentemente le rifiuta entrambe introducendo un’ipometria nel testo» 45. È noto che il sistema è alla base dei canzonieri risalenti alla famiglia di Avalle (definita appunto editio variorum) e di quelli della cosiddetta «terza tradizione», che lo stesso studioso fa risalire «ad un codice corredato di varianti alternative» 46; ma poiché il del fenomeno della mouvance nota come: «rares sont les chansons de troubadours dont tous les manuscrits présentent les strophes dans le même ordre» (p. 163). 42 C. Segre, Dalla memoria al codice, in Atti Messina 1993, I, pp. 5-13, a p. 10; ora in Segre 1998, pp. 3-9, a p. 7. 43 B. Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire critique de la philologie, Paris, Seuil 1989 (cit. alla p. 111 e proposta editoriale alle pp. 105-16). 44 Cfr. le indicazioni di Avalle-Leonardi 1993, pp. 37-43 e prima ancora gli esempi di «trasmissione per collazione» rintracciati nei mss. DR da G. Contini nella rec. alla Storia della tradizione e critica del testo di G. Pasquali, AR, XIX (1935), pp. 330-40, a p. 339; ed ora i ventuno casi studiati da Barbieri 1995. Nella tradizione folchettiana: 155,18 (III), 44; 155,14 (IV), 34; 155,23 (IX), 14; 155,10 (XII), 45. 45 Definizione di Barbieri 1995, p. 13 per una tipologia inaugurata da Maurizio Perugi (cfr. Perugi 1978, II, p. 27); segnalo nella tradizione folchettiana: 155,23 (IX), 9; 155,8 (XI), 50. 46 Avalle-Leonardi 1993, p. 98; per basti un rimando allo stesso volume, pp. 75-89. fenomeno si riscontra anche in mss. come CHR, esterni ai due gruppi, si può pensare con Luca Barbieri che «la presenza di varianti interlineari nei codici doveva essere ben più diffusa di quanto possa apparire ora dall’esiguo materiale sopravvissuto all’usura del tempo» 47. L’ipotesi permette dal punto di vista ecdotico di giustificare delle deroghe al principio restaurativo che presiede al mio lavoro, secondo il quale, come ho già detto, le diverse redazioni non vanno mescolate; in questo caso infatti le redazioni ci sarebbero state tramandate già ‘mescolate’ in quanto chi copia da una editio variorum può evidentemente sostituire a sua scelta le varianti alternative a quelle a testo, copiarle entrambe o evitare di scegliere. Si dà anche il caso di luoghi del testo in cui la varia lectio manifesti una frammentazione non riconducibile alla trasmissione verticale, né a una qualche forma di diffrazione; distinguo tre tipi fondamentali: [3.1] date in un verso due coppie di varianti adiafore (a vs a’ e b vs b’), i testimoni offrono tutte le combinazioni possibili: ciò accade, per fare un esempio, in FqMars 155,1 (V), 23: «poges el mieu tan lonc dezir assire», dove a = pogues e a’ = uolgues, b = el e b’ = al, cosicché si hanno le combinazioni: ab (pogues el mieu) in ABIKf + Ols, ab’ (pogues al mieu) in KpMUc + CQ, a’b (volgues el mieu) in DGLNPS, a’b’ (volgues al mieu) in EJ + R. [3.2] gli assetti testuali che si ricavano dalla varia lectio sono particolarmente numerosi rispetto alla consistenza della tradizione manoscritta; rimando, per esempio, a FqMars 155,18 (III), 41: «A so conosc qu’ieu sui nems paoros» dove i 21 relatori del v. presentano almeno 12 (ma si può arrivare a 15) assetti testuali: si ha un marcato isolamento delle coppie di mss. dei piani bassi, AB, PS, IK, Cf, Uc ecc.; [3.3] i latori delle lezioni sfuggono in quei luoghi alla classificazione ricavata dalla tabella delle varianti adiafore e magari confermata da errori congiuntivi: esempi in FqMars 155,22 (II), 14 e 22 e 155,21 (VII), 17-20. Come mostra quest’ultimo esempio il fenomeno, che è solitamente limitato a singoli versi 48, si può estendere a gruppi di versi sino a intere coblas; ha una distribuzione variabile nel testo, sebbene si noti un’accentuazione man mano che ci si avvicina al corpo centrale del componimento. [4] Quanto ai rifacimenti, infine, qualcosa si è accennato al punto [2] a proposito degli interventi degli esecutori: qui occorre ricordare le operazioni di vera e propria r i s c r i t t u r a che caratterizzano una tradizione attiva come quella trobadorica: esempio tipico e ben noto sono le versioni rintracciabili in canzonieri come C ed R . Se questo primo tipo di riscrittura investe il piano semantico, Maurizio Perugi ha richiamato l’attenzione su una forma di r i c o d i f i c a z i o n e linguistica percepibile, per es., nei codici di origine veneta, che intacca «sintagmi complessi, ‘ritraducendo’ interi versi nel generico 47 Barbieri 1995, p. 15 (e cfr. p. 24). Aggiungerei all’«usura del tempo» il fatto che la stessa scelta fra due varianti alternative non lascia tracce visibili nella copia, se non, eventualmente, nell’instabilità della tradizione. 48 Oltre ai casi citati a mo’ d’esempio, si vedano ancora: 155,22 (II), 29; 155,1 (V), 2425; 155,3 (VI), 23; 155,8 (XI), 49; 155,10 (XII), 14, 28, 38; 155,11 (XIII), 9. e incolore linguaggio letterario che connota il provenzale da esportazione, fatto apposta per accarezzare l’udito di un pubblico alloglotto, e in particolare italofono» (Perugi 1990, p. 515). Campione di questa ricodificazione sarebbe il canzoniere A, che nelle edizioni contende a C il privilegio di essere assunto come base per la veste grafica 49; ma se si deve giustamente rigettare una condotta editoriale «A-latrica» 50, e a fortiori ‘C-latrica’, occorre tener conto – per dirla con Perugi 1996, p. 27 – «della distribuzione ineguale di verità all’interno di qualunque tradizione». Restando ai due canzonieri sopra menzionati, si consideri con Avalle-Leonardi 1993, p. 91 che «si dànno comunque vari casi in cui il valore della testimonianza di C sembra in effetti dipendere dall’utilizzo di fonti molto alte»; e che lo stesso A fornirebbe sporadiche lezioni buone e addirittura la redazione migliore per il sirventese anche in una tradizione come quella danielina nella quale è in linea di massima svalutato da Perugi 51. Tenendo inoltre conto dei risultati dell’analisi linguistica di Zufferey 1987, pp. 33-66, secondo la quale A risalirebbe, insieme con B e al frammento siglato A’ (=Aa+Ab), a una tradizione alverniate, risulta evidente che un giudizio sulla bontà di un ms. o di una tradizione non si può dare una volta per tutte; utile in questo senso l’esortazione di Saverio Guida: «Le soluzioni operative non devono essere astratte e generali [...], ma pragmatiche, legate ai particolari problemi che ogni singolo canzoniere, e all’interno di questo ogni singolo elaborato rimico, presenta» 52: di qui l’invito ad una «filologia per componimento». Risulta invece troppo appiattita sul ms. C, a giudicare dalle opzioni preliminari esposte in Seto 1995 e nello specimen Seto 1995b, la proposta editoriale di Naohiko Seto: il filologo giapponese ha al suo attivo una non meglio precisata «thèse de doctorat à Paris dans les années 80 (sous les auspices de Madame Suzanne Thiolier et de Monsieur Jacques Monfrin)» 53 che consiste nell’edizione delle poesie attribuite a FqMars in C e su di esso fondata (ma con l’ausilio dichiarato degli altri mss. parigini BEIKMRTf: cfr. Seto 1995, p. 11). 49 E, come ho direttamente sperimentato sull’edizione Stroński, il passo fra assunzione della grafia e, quando le varianti alternative appaiano indifferenti, assunzione della lezione, talora singolare o comunque fortemente minoritaria, del ms.-base è davvero breve. Sulla normalizzazione attiva in A si veda l’analisi centrata su esempi danielini raccolti in Perugi 1994, in partic. pp. 135-52 (in relazione alla fortuna del ms. nell’ed. Canello), oltre alle indicazioni in Perugi 1990 e in Perugi 1978 (nell’Introduzione al II vol., in partic. le pp. XIIXVI); esempi del «dinamismo di B rispetto al suo ‘gemello’» ricavati dalla sestina arnaldiana sono in Perugi 1996, p. 27, n. 26. 50 Alla quale, a norma dei Criteri proposti in Squillacioti 1993, mi stavo io stesso riducendo. 51 Secondo lo studioso il ms. risulta prezioso anche per Marcabruno: si veda per es. il III saggio di Perugi 1995 (ed. di Marcabr 293,38); sulla ‘bontà’ di A oltre alla sintesi in Perugi 1994, pp. 140 e 142, si veda anche l’ed. di ArnDan 29,15 (I) in Perugi 1978, II, pp. 3-70 (la scelta di ADHIK a fronte del rimaneggiamento di CR è confermata da Eusebi). 52 S. Guida, Ecdotica delle più antiche liriche oitaniche ed occitaniche, in Atti Messina 1993, I, pp. 115-29, a p. 126. 53 Seto 1995, p. 10. Se la critica al procedimento editoriale di Stroński è pienamente condivisibile 54, la scelta di seguire «le texte de la base C dans toute la mesure du possible» 55 si espone al rischio di accettare non solo le lectiones singulares e le evidenti rielaborazioni di un copista notoriamente interventista, ma anche lezioni erronee: cfr. nell’edizione di FqMars 155,7 (XIV) in Seto 1995b le lectiones singulares 3 mais, 5 qusquex, 6 mas, 18 qui ni, 27 meins, 29 quieu nous aus ges, 31 uei, 32 nul dia si so, 35 e pausat, 39 que, 45 mains defenden, 46 na pres dieus e ses, 47 que ia tan cofessios, 53 na, 54 autren, 56 quab, 57 cug quel, 59 er 56; quanto alle banalizzazioni quella di v. 59 et ab tan < beis taing è riconosciuta dallo stesso Seto a p. 60; segnalo infine il rimante razo (condiviso con PRTUV; cfr. reiço cls), già a v. 6, messo a testo a v. 56. È probabilmente un refuso 46 lauzor (in luogo di labor), forse per influsso di 45 lauzor. Decisamente più interessante è la ricaduta editoriale delle più recenti ricerche di Maurizio Perugi 57: usando le parole dello studioso, il «modello a scarti ricodificativi» che viene utilizzato per la ricostruzione ecdotica si fonda sull’individuazione «dei tratti (prosodici, morfofonetici, lessicali) caratterizzanti» attraverso i quali si perviene a ricostruire un numero limitato di processi ricodificativi o redazioni, [...] ciascuna redazione è caratterizzata da una propria distanza rispetto all’originale, la quale varia in rapporto alle altre redazioni, ma anche in assoluto nel proprio interno, in base alle aree del testo che vengono più o meno radicalmente innovate secondo i parametri previsti dal singolo progetto, che oggi diremmo ‘editoriale’. [...] In questa ottica l’edizione critica diventa stratigrafia prospettica delle sistemazioni testuali in cui si articola e diffrange, in un arco cronologico abbastanza limitato, il singolo prodotto letterario nella trasmissione lirica trovadorica. Scopo primario dell’editore è definire e descrivere ciascuna redazione in sé e in rapporto alle altre, così da individuare il maggior numero possibile di elementi atti ad elevare la percentuale di garanzia del testo ricostruito. La distanza fra questa impostazione, che ricavo da Perugi 1990, pp. 526-27, e la mia proposta editoriale è tuttavia marcata, soprattutto perché mi pare che 54 Seto 1995b, pp. 62-66, in partic. pp. 64-65: si rimarca, fra l’altro, che quello delle «contaminations et coïncidences» che spesso chiude le discussioni stemmatiche di Stroński altro non è che un «phénomène commode pour expliquer les contradictions éparpillées entre la disposition des mss. de chaque vers et le stemma qu’on propose» (p. 65). 55 Seto 1995b, p. 66. 56 In due casi soltanto Seto corregge la lectio singularis ai vv. 27 aisso > so e 58 det > rent. 57 Dopo l’edizione di ArnDan Perugi 1978, lo studioso ha iniziato un’opera di revisione del metodo applicato e dei risultati ottenuti che ha un primo momento di sintesi in Perugi 1990 e ora in Perugi 1995 (l’elenco completo dei lavori si ricava da Perugi 1994, p. 137, n. 8, integrato da Perugi 1996, p. 21, n. 1). Ho comunque segnalato, e talora discusso, tutte le «soluzioni» proposte per FqMars nei due volumi di Perugi 1978: sulla metodologia ecdotica che presiede all’edizione danielina e ai suoi Prolegomeni si veda G. Chiarini, Prospettive translachmanniane dell’ecdotica, in Ecdotica e testi ispanici. Atti del Convegno Nazionale della Associazione Ispanisti Italiani. Verona, 18-19-20 giugno 1981, Verona 1982, pp. 4564, alle pp. 62-63 e C. Segre - G. B. Speroni, Filologia testuale e letteratura italiana del Medioevo, RPh, XIV (1991), pp. 44-72, alle pp. 57-59; cfr. anche la rec. molto critica di Speroni a Perugi 1995 in RPh, L (1997), pp. 315-27. nella tradizione folchettiana sia problematico, se non impossibile, riconoscere in tutti i casi la direzione dell’innovazione: la variazione testuale c’è, le versioni sono talora con nettezza isolabili, e tuttavia non si riesce nella maggioranza dei casi a dare le coordinate di un processo ricodificativo basandosi su argomentazioni non arbitrarie. Si può verosimilmente ipotizzare che ciò sia dovuto alla natura del tessuto poetico folchettiano: in ogni caso ho scelto di ‘restaurare’ la tradizione lasciando visibili le sue componenti, e di isolare e riprodurre 2-3 versioni testuali; con margini di ‘certezza’ che variano da testo a testo ho privilegiato una di queste versioni argomentando il carattere innovativo o corrotto dell’altra o delle altre. Riepilogo a questo punto le linee essenziali della pratica editoriale sin qui vagamente indicata con l’etichetta di ‘restauro conservativo della tradizione’. Basilare è la necessità di non mescolare tradizioni irriducibili a unità, senza tuttavia vietarsi né il «right to emend» 58, né l’intervento ‘migliorativo’ qualora si riconosca la presenza di uno o più dei fattori sopra esaminati: tutto nel segno del minor interventismo possibile sul testo della versione che si è scelto di mettere a testo. In linea di massima ho preferito infatti attenermi al precetto di Segre 1976, p. 68: «tutte le volte che non si può ricorrere all’opposizione errore/lezione corretta, anche l’operazione ecdotica dev’essere portata nell’ambito del virtuale. Si tratta di proporre correzioni, ma non attuarle, di abbozzare ricostruzioni, ma lasciarle nell’ipotesi, di segnalare connessioni tra varianti, ma non concludere drasticamente». Questa intenzione va coniugata con l’aspirazione a fornire col massimo di completezza possibile i dati sulla tradizione manoscritta, così da permettere un ulteriore esercizio della critica, e consentire verifiche e rettifiche del lavoro svolto: la scelta di redigere a p p a r a t i n o n s e l e t t i v i, suddivisi in due fasce, è motivata in primo luogo da questa esigenza. In particolare, la prima fascia raccoglie tutte le lezioni che modificano il senso, comprese quelle caratterizzate da assenza o presenza indebita della -s segnacaso; nella seconda fascia trovano posto, oltre a note paleografiche su aspetti che non influiscono sul senso, le varianti grafiche, quelle fonetiche, le forme verbali che a parità di modo, tempo, numero e persona, presentino, per attrazioni analogiche o altro, una diversa desinenza; e quelle forme che vengono usualmente confuse nella scripta trobadorica (per es. gli accusativi me < ME, te < TE, se < SE dei pronomi personali e del riflessivo e le equipollenti forme dativali mi < MIHI, ti < TIBI, si < SIBI; nonostante la confusione sia altrettanto diffusa, mantengo invece nella prima fascia le forme del relativo qui < QUI e que < QUEM). Comunque la seconda fascia registra tutte le varianti non segnalate già nella prima fascia che non apportano modifiche di senso rispetto alla lezione a testo 59; e nel dubbio 58 Cfr. T. B. W. Reid, The Right to Emend, in Medieval French Textual Studies in Memory of T. B. W. Reid, edited by I. Short, London, Anglo-Norman Text Society 1984, pp. 1-32. 59 Per quanto concerne le varianti grafiche, non segnalo le alternanze q-/qu-, e/et < ET (tranne quando segua vocale: nel qual caso segnalo anche le forme compendiate con il segno &); sciolgo di norma le abbreviazioni con tituli, eccetto i casi di possibile ambiguità (per es. che una variante possa essere sostanziale la si è inserita nella prima fascia 60. Gli apparati completi s’impongono anche perché Stroński, poco affidabile sotto questo profilo 61, segnala nei suoi apparati anche varianti non sostanziali: onde evitare una complementarità poco economica degli apparati, che avrebbe richiesto al fruitore una verifica sui codici per dirimere i dubbi in caso di discrepanza, ho deciso di segnalare tutti i fenomeni 62. Un accenno, per concludere, alla struttura formale dell’edizione dei componimenti poetici: all’indicazione dei testimoni aggiungo l’attribuzione della rubrica nei casi in cui il componimento non sia assegnato a FqMars, ma registro comunque l’indicazione della rubrica nei testi a tradizione unica o limitata a 2-3 mss. 63; indico di séguito le edizioni precedenti, specificando in caso di antologizzazione la fonte utilizzata dal curatore; nella Scheda metrica trascrivo la formula metrica indicando fra parentesi quadre il numero dello schema nel Répertoire di Frank 1953-57 e descrivo metricamente il componimento, indicando eventuali modelli e/o riprese metriche; segnalo l’ordine delle coblas nei mss. e nell’edizione Stroński solo nei casi in cui differisce da quello da me quando sono presenti alternanze di n/m): in questi casi esprimo il titulus con l’accento circonflesso o mettendo in corsivo la parte compendiata (que vale ‘q con titulus’, qua ‘q con a soprascritta’, ecc.); uso la tilde per l’abbreviazione di r, eccetto che in ‘ñ’ che vale ‘n con titulus’ (= non); uso il segno ‘9’ per la nota tironiana con valore cum/com. 60 Per quanto concerne le lezioni del canzoniere di Bernart Amoros ricavabili dal ms. c a (ls: cfr. supra il § 2.1.2.1) ne indico la grafia nella 2 a fascia soltanto quando si tratta effettivamente di una delle varianti segnate da Pietro di Simon del Nero: tali indicazioni valgono dunque solo in positivo, nel senso che nulla si può inferire sulla grafia di ls quando non vi è esplicita menzione. 61 Anche Avalle nota che l’apparato di FqMars 155,15 (XVIII) è «non sempre perspicuo» (La Critica testuale, GRLMA, I, pp. 538-58, a p. 541). 62 Un elenco esaustivo di errori, imperfezioni e debolezze degli apparati della precedente edizione è inopportuno: mi limito a proporre una sommaria tipologia degli errori più comuni riscontrati, non prima di aver segnalato un uso incoerente della parentesi quadra negli apparati che precede talora la lezione a testo, ma spesso una lezione rifiutata, di norma la più attestata. Fra i semplici e r r o r i d i l e t t u r a segnalo 155,20 (XXI), 36: Stroński corregge in sorcedor la lettura forcedor di Bertoni 1905 nel ms. Q, ma il codice legge chiaramente forcedor; lo scioglimento in 155,7 (XIV), 40 a granz per agra(m) con -m verticale nel ms. R (Stroński conosce quest’uso grafico come dimostra l’indicazione in apparato a p. 112); e come talora càpita ai copisti medievali, 155,27 (X), 46: esaen in luogo di escien. Fra le o m i s s i o n i d i l e z i o n e segnalo quella di rei di QRTUVcls al v. 50 di 155,7 (XIV), registrata peraltro nella precedente edizione di Lewent 1905 (= Lewent 1907). Fra gli e r r o r i n e l l a c o m p i l a z i o n e dell’apparato stesso segnalo ancora 155,7 al v. 28 dove l’editore indica la variante pron nei mss. CIKNPR, che è lezione dei soli CR, mentre IKNP leggono pron (invece di pro) al v. 29; e la cobla II di 155,14 (IV) dove si attribuisce sistematicamente a G la lezione di D e viceversa (tranne che al v. 20 dove G legge effettivamente me). Fra le i n d i c a z i o n i s u p e r f l u e segnalo solo in 155,21 (VII), 24 qi S accanto a qui Wf. Più rilevanti per le conseguenze sulla ricostruzione editoriale sono la dichiarazione che il v. 42 di 155,22 (II) è omesso in G e la mancata indicazione di varianti per l’erroneo cen messo a testo in 155,15 (XVIII), 66, per le quali rimando al Commento delle rispettive edizioni. 63 Trascrivo inoltre la rubrica che precede nel ms. P il planh FqMars 155,20 (XXI) perché non si limita a indicare l’autore del componimento. proposto. Faccio seguire nell’ordine: l’indicazione delle edizioni della melodia musicale, una Nota al testo, la tabella delle varianti adiafore, l’edizione critica corredata di apparati e traduzione (da leggersi come mero corredo al testo critico), e un commento, aperto, ove necessario, da un cappello in cui trova posto l’eventuale razo del componimento. CAPITOLO TERZO L’interpretazione storico-letteraria 3.1. Profilo biografico di Folchetto di Marsiglia. La carriera religiosa e il rilevante ruolo politico in un momento intenso e tragico per il Midi come la prima metà del secolo XIII, hanno fatto di Folchetto un personaggio storico abbondantemente attestato nei documenti, almeno negli ultimi 25 anni della sua vita: per gli anni precedenti, quelli dedicati alla poesia, dobbiamo rifarci quasi esclusivamente alle tradizionali, e infide, fonti per la biografia dei trovatori, la vida, le razos e i componimenti poetici stessi. § 3.1.1. A t t i v i t à p o e t i c a . Se la natura di queste testimonianze comporta l’esistenza di problemi aperti, e risolvibili solo attraverso nuove acquisizioni documentarie, l’ottimo lavoro storico di Stroński ha in primo luogo risolto un paio di questioni biografiche che avevano impegnato per anni gli studiosi, soprattutto nella prima fase della provenzalistica, quali la forma del nome, oscillante nelle citazioni fra Folco e Folchetto 1, e l’identità fra il trovatore e il vescovo di Tolosa. La forma occitanica del nome più comune, rintracciabile nella vida, nelle rubriche dei canzonieri, nelle citazioni di altri poeti, è Folquet 2, mentre il nome con cui è menzionato come vescovo, specie in testi latini, è Fulco 3; l’oscillazione ha creato problemi soprattutto agli studiosi italiani preoccupati di interpretare la menzione dantesca in Par. IX, 94-95: «Folco mi disse quella gente a cui / fu noto il nome mio» 4. Stroński ha definitivamente chiarito che «La 1 Alle due forme italiane, corrispondono quelle occitaniche Fólc, -cón e Folquet e le latine Fulco, Folcus e Folchet(t)us. 2 Non sistematicamente: si veda la forma Folco in PVid 364,2 (III), 91 e nella vers. M di MoMont 305,16 (XVIII), 73 (citati infra rispett. nei §§ 3.2.1.2.4 e 3.2.1.2.1). 3 Ma anche in questo caso l’uso manca di sistematicità: registro infatti la forma latina di Robert de Sorbon («Folquetus, episcopus Tolosanus...») e quella occitanica della prima parte della Chanson de la croisade albigeoise («L’evesques de Tholosa, Folquets cel de Maselha»); l’editore della Chanson annota «Son vrai nom était Foulque (en latin Fulco), d’où en provençal Folc, monosyllabe auquel on préférait substituer dans cette langue le diminutif Folquet, plus euphonique et d’un emploi plus facile dans la versification. Au surplus, l’évêque Foulque est appelé Fulchetus dans trois chartes écrites en 1206 et 1207 à l’abbaye de Grandselve (Archives nationales, L 1009B)» (Martin-Chabot 1931-61, I, p. 111, n. 3). 4 Si veda in particolare Zingarelli 1899, pp. 28-29 e n. 35 (cito la Commedia dall’ed. di G. Petrocchi, seconda edizione riveduta, Firenze, Le Lettere 1994). L’oscillazione era nota allo stesso Dante che in Dve II VI 6 scrive «Folquetus de Marsilia»: Picone 1981-83, p. 81, n. 55, riconosce nel «Folco» della Commedia «un’autopolemica» di Dante; sostiene per di più (pp. 82-83) la tesi, decisamente onerosa, che Dante, utilizzando nel poema lo stesso nome presente nella redaz. M della ‘galleria satirica’ del Monaco di Montaudon ricordata alla n. 2, abbia voluto rispondere alle ironiche accuse di spergiuro fatte a Folchetto dal monaco. L’onerosità aumenta notando che M non può più essere considerato un ms. «di ascendenza certamente lombarda», e perciò consultabile da Dante, essendo stata dimostrata la stesura nella Napoli forme latine Fulco correspond à la forme vulgaire Folc (c. s.) Folcon (c. o.) dont Folquet est un diminutif sans être un nom à part» (p. 5*) 5. L’identificazione fra il trovatore e il Folco vescovo di Tolosa, non è sempre stata, come oggi, scontata; lo rileva lo stesso Stroński («Tout le monde n’est pas d’accord sur cette question»), prima di affrontare e risolvere la querelle 6: il metodo probatorio, semplice quanto efficace, consiste nell’esposizione analitica e cronologicamente ordinata delle fonti da cui si induce l’identità fra i due Folchetto, ovvero la Chanson de la croisade albigeoise, la prima parte, redatta da Guillem de Tudele nel 1212-13, e la seconda, anonima, iniziata nel 1228 7, il De Triumphis Ecclesiae di Giovanni di Garlandia (cfr. infra § 3.1.2), la Summa de vitiis et virtutibus di Guglielmo Peraldo (m. 1260), il Tractatus de diversis materiis praedicabilibus di Stefano di Borbone, composto verso il 1250, l’opera di Bernardo Gui Nomina episcoporum Tholosane sedis, scritta al principio del XIV sec., un sermone di Robert de Sorbon (m. 1274) e, infine, la vida occitanica. Eccone il testo 8: angioina (cfr. A. C. Lamur-Baudreu, Aux origines du chansonnier de troubadour M [Paris, Bibl. Nat., fr. 12474], Rom, CIX [1988], pp. 183-98) a partire da un modello elaborato in Provenza ante 1266, attraverso la fusione di una fonte provenzale con una linguadociana orientale e una settentrionale (cfr. F. Zufferey, A propos du chansonnier provençal M [Paris, Bibl. Nat., fr. 12474], in Atti Liège 1991, pp. 221-43); si vedano in proposito le considerazioni e le correzioni di Asperti 1995, cap. 3 (in partic. p. 80 sgg.). 5 Il rapporto fra le due forme era chiaro già ad Angelo Colocci (appunti sui Trionfi di Petrarca nel cod. Vat. lat. 4832, cit. da Debenedetti 1995 [1911], p. 212) e a Giusto Fontanini, Della eloquenza italiana, Roma, Rocco Bernabò 1736, p. 43 (su quest’ultimo si veda ora la sintesi di E. Pistolesi, Giusto Fontanini nel dibattito sulla diplomatica e sulla nascita della lingua italiana, «Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di Messina» XI [1993], pp. 219-59). 6 Nel cap. XIV (L’identité du troubadour et de l’évéque) dell’Étude preliminare all’edizione; convinto sostenitore della diversità di persona è Pratsch 1878, pp. 47-52, mentre si limita ad esprimere dei dubbi De Lollis 1897, pp. 127-28: gli argomenti dei due studiosi, d’ordine negativo e di scarsa forza probante, sono sintetizzati e commentati da Stroński alle pp. 104*-105*, n. 2 della sua edizione. 7 Cfr. per la parte I: J.-M. D’Heur, Sur la date, la composition et la destination de la «Chanson de la Croisade albigeoise» de Guillaume de Tudèle, in Mélanges d’histoire littéraire de linguistique et de philologie romanes offerts à Charles Rostaing, Liege 1974, I, pp. 231-66; per la parte II: Martin-Chabot 1931-61, II, pp. XIII-XVI, che data la parte I al 1210-13 (I, pp. XI-XII). 8 Cito da Boutière-Schutz 1964, pp. 470-73 (la vida è conservata nei mss. ABEIKN2ORa+); segnalo le principali differenze delle edizioni di Stroński (pp. 3-4) e di Favati 1961, p. 174 (n° 14): § 1: «Folquetz de Marseilla si fo de Marseilla, fils» (Stroński e Favati: quest’ultimo argomenta a p. 393 che «s’impone la scelta della lezione di ABN2, che può spiegare le altre [folquetz si fo de marseille Oa, folquet de marceille si fo fils EIKR], ma non esserne spiegata», mentre Stroński aveva notato a p. 6*, n. 2 che le parole de marseilla «peuvent ne pas venir de l’original, car ils ne se trouvent que dans une seule branche des mss. (x [= ABOa] et N2 qui repose sur des contaminations); l’auteur de cette rédaction, troublé, de même que les critiques postérieurs à lui, par la mention de Gênes dans la suite, a probablement jugé utile, pour écarter le doute, de faire cette addition, en se fondant sur le nom seul de Folquet “de Marseille”»); § 3: «e mes se ad anar et a venir et a brigar ab les valens homes e servir los e fo fort grazitz» (lezione ricostruita di Favati e discussa alle pp. 14-15); § (1) Folquet de Marsseilla si fo fillz d’un mercadier que fo de Genoa et ac nom ser Anfos. (2) E quan lo paire muric, si·l laisset molt ric d’aver. (3) Et el entendet en pretz et en valor; e mes se a servir als valenz barons et als valenz homes, et a brigar ab lor, et a dar et a servir et a venir et a anar. (4) E fort fo grazitz et onratz per lo rei Richart e per lo comte Raimon de Tolosa e per En Baral, lo sieu seingnor de Marseilla. (5) Molt trobava ben e molt fo avinenz om de la persona. (6) Et entendia se en la muiller del sieu seingnor En Baral. (7) E pregava la e fasia sas chansos d’ella. (8) Mas anc per precs ni per cansos no·i poc trobar merce, qu’ella li fezes nuill ben en dreit d’amor; per que totz temps se plaing d’Amor en soas cansos. (9) Et avenc si que la domna muric, et En Barals, lo maritz d’ella e·l seingner de lui, que tant li fasia d’onor, e·l bons reis Richartz, e·l bons coms Raimos de Tolosa, e·l reis Anfos d’Arragon. (10) Don el, per tristeza de la soa domna e dels princes que vos ai ditz, abandonet lo mon; e si se rendet a l’orde de Cistel ab sa muiller e ab dos fillz qu’el avia. (11) E si fo faichs abas d’una rica abadia, qu’es en Proensa, que a nom Torondet. (12) E pois el fo faichs evesques de Tolosa; e lai el muric. Sono sostanzialmente corrette le indicazioni sul ruolo sociale, l’origine genovese, il nome di famiglia, e quelle sulla carriera religiosa 9: è stato Cornelio Desimoni 10 a collegare per primo Folchetto agli Anfossi di Genova, importante famiglia di banchieri «quasi certamente discesa di Anfosso bancherius» che «abbandonò [...] la banca per il commercio di Levante, nel quale si doveva illustrare alla fine del Duecento» 11. Stroński rileva giustamente che le indicazioni di Desimoni, per quanto preziose, sono tarde (XIII-XIV sec.) e non scevre di anacronismo visto che lo storico suppone padre o avo di Folchetto un 5: «Mout trobava [e mout chantava] be» (Stroński), «Mout trobava e chantava ben» (Favati, lezione di ABOa); § 12: «e lai el definet e moric» (Favati, lezione di AB; cfr. e lai el definet ER); sulla conclusione della vida in R si veda supra il § 1.1.2. 9 Si veda l’analisi di Stroński alle pp. 140-43. A lungo le biografie sono state ritenute fonti storiche del tutto esatte: negli studi storici e letterari sette-ottocenteschi (prime fra tutti l’HGL e l’HLF), fino al fondamentale lavoro di Diez 1882 [1829] e oltre, si è concesso un grandissimo spazio alle vidas e razos nello studio dei trovatori. Si deve proprio a Stroński l’elaborazione del criterio a tutt’oggi valido per valutare l’attendibilità delle informazioni biografiche; secondo lo studioso vanno prese per buone le notizie intorno al nome, al luogo d’origine, alla condizione sociale, alla professione dei poeti, mentre vanno rifiutate quelle sugli amori spesso romanzati con grandi nobili e mogli di protettori: si vedano le pp. 61*-68* e 140-152 dell’edizione e la sintesi discorsiva Stroński 1943. Tale criterio, accettato fra gli altri da A. Jeanroy, Les “biographies” des troubadours et les “razos”; leur valeur historique, AR, I (1917), pp. 289-306 (rifuso in Jeanroy 1934, I, pp. 101-32) e BoutièreSchutz 1964, pp. XV-XVII, ha trovato la decisa opposizione di Panvini 1952, pp. 7-11 (si vedano inoltre le pp. 27-39 su FqMars), per il quale non si possono discernere all’interno delle biografie le informazioni corrette dalle deformazioni della realtà e tutte le notizie vanno ritenute attendibili. L’isolamento della posizione di Panvini è rilevato da Meneghetti 1992, p. 178, n. 7. 10 Il Marchese Bonifacio di Monferrato e i trovatori provenzali alla corte di lui, «Giornale linguistico di Archeologia, Storia e Belle Arti», V (1878), pp. 241-71, alle pp. 25354 e cfr. la rec. a un lavoro di W. Heyd, in «Archivio storico italiano», s. IV, I (1878), pp. 297-310, alle pp. 305-306. 11 R. S. Lopez, I primi cento anni di storia documentata della banca a Genova, in Studi in onore di Armando Sapori, Milano, Ist. Edit. Cisalpino 1957, I, p. 221; e cfr. le pp. 218-22. «Anfosso Banchiere» attestato nel 1212. Tuttavia un Anfossus bancherius è annoverato fra i testimoni prima di un trattato di alleanza fra il Comune di Genova e il marchese Guglielmo di Massa del novembre 1173 (CDRG, II, p. 173, nota 1), poi dell’atto del febbraio 1188 in cui i genovesi giurano di osservare le condizioni di una futura pace con Pisa (CDRG, II, p. 325, r. 23) 12, e quindi di un atto del 28 agosto 1198 con cui Ugo di Bas conferma delle concessioni accordate in passato ai genovesi (CDRG, III, p. 136, r. 17) 13; un atto rogato il 20 luglio 1190 da Oberto Scriba de Mercato nomina infine un Anfoss(us) bancheri(us), proprietario di navi da commercio 14. Potrebbe pertanto apparire limitativo l’appellativo di mercante attribuito dalla vida a ser Anfos: ma nel XII secolo, come spiega Roberto S. Lopez, poteva esser presa alla lettera un’espressione come Genuensis ergo mercator, assurta poi quasi a proverbio: «Tout le monde, en ce siècle, s’adonne avec plus ou moins de continuité au commerce: hommes et femmes, riches et pauvres, mineurs et veillards, nobles et routiers» 15. L’origine nobiliare degli Anfossi, adombrata da Desimoni che sottolinea la parentela con i Doria e i Della Volta e il possesso di una Domus magna nella contrada degli Anfossi in Susiglia, e affermata con decisione («Foulque appartient sans doute à l’une de ces grandes familles de la noblesse génoise qui ne craignent pas de pratiquer le commerce») da Biget-Pradalier 1986, p. 351, è invece esclusa da Stroński (a p. 5*) che definisce «bourgeois marseillais» Fulco Anfos. Tuttavia, per quanto l’origine e la composizione della classe dirigente genovese prima del Duecento sia troppo poco studiata, l’affermazione di Biget-Pradalier va tenuta in giusta considerazione 16: ‘mercante’, va ribadito, in una repubblica marinara è mera denominazione professionale, non certo di classe sociale. Resta inoltre aperto il problema della possibilità di far risalire ad una sola famiglia i vari Anfosso attestati dai documenti: per esempio, degli Anfossi, da tenere con ogni probabilità distinti da quelli genovesi, sono attestati anche a Pisa, dove la famiglia si estinse prima della metà del XIII sec. senza riuscire a fissare un cognome 17. Nessun problema 12 Le due attestazioni sembrerebbero note allo stesso Stroński (cfr. p. 4*, n. 1) che tuttavia ritiene bancherius «plutôt un nom de famille que la désignation du métier». 13 Già nel giugno 1140 trovo attestato un Anfoss(us), proprietario terriero (CDRG, I, p. 127, r. 19) e quindi un Anfosso, teste in due atti rogati da Giovanni Scriba il 5 agosto 1158 e il 21 giugno 1164 (Il cartolare di Giovanni Scriba, a cura di M. Chiaudano e M. Moresco, Roma, R. Ist. Storico per il Medioevo 1935, rispett. nel vol. I, p. 223, n° CDXXI e vol. II, p. 208, n° MCCXX). 14 Notai liguri del sec. XII. I. Oberto Scriba de Mercato (1190), a cura di M. Chiaudano e R. Morozzo della Rocca, Torino, Editrice Libraria Italiana 1938, p. 210, n° 530. 15 R. S. Lopez, Aux origines du capitalisme génois, «Annales d’histoire economique et sociale», IX (1937), pp. 429-54, a p. 441 (trad. it. in Storia dell’economia italiana. Saggi di storia economica, a cura di C. M. Cipolla, vol. I, Torino, Einaudi 1959, pp. 285-312, a p. 299). 16 Tenendo presente, in ogni caso, che la tesi pare appoggiarsi soltanto al lavoro di Lopez citato alla nota precedente, dove gli Anfossi non sono nominati. 17 Cfr. M. L. Ceccarelli Lemut, Una famiglia di giuristi e armatori pisani del XII secolo: gli ‘Anfossi’, «Bollettino storico pisano», LXI (1992), pp. 83-94. solleva invece la presenza di un membro di una famiglia genovese a Marsiglia: all’origine dei ben noti e cospicui rapporti commerciali fra Genova e il Midi della Francia c’è proprio un trattato politico-militare con Marsiglia del luglio 1138 18. La data più alta riferibile direttamente a Folchetto è stata indicata da Stroński (cfr. p. 3*) nel 23 gennaio 1178: un Fulco Anfos è infatti annoverato fra i testimoni di un accordo fra i visconti e la Chiesa di Marsiglia 19. Non essendo documentato l’anno di nascita, va, al contrario, considerata mera ipotesi l’indicazione dell’HLF, XVIII, p. 589 («vers l’an 1160») ripresa da Paget Toynbee 20 e sfumata in avanti da Fauriel 1846, II, p. 70 («de 1160 à 1170») o all’indietro da Cabau 1986, p. 169 («V[ers] 1155/1160») 21. Tra i problemi lasciati aperti da Stroński c’è quello del luogo di nascita del trovatore: la vida, infatti, «ne nous permet point de d’établir avec certitude que Folquet naquit à Marseille et d’écarter l’hypothèse qu’il y fût amené en bas âge par son père» (p. 6*); né offre risposte definitive l’Ottimo, III, pp. 230-31, dove viene riferito un racconto biografico ricavato, secondo Suitner 1980, pp. 621-24, da una fonte parallela alla vida occitanica 22: 18 Edito in CDRG, I, pp. 102-104, n° 83; mi limito, data la vastissima portata dell’argomento, a rimandare alla sintesi di R. S. Lopez, Le relazioni commerciali tra Genova e la Francia nel medio evo, «Cooperazione intellettuale», VI (1936), pp. 75-86 e al ben più ponderoso lavoro di R. Pernoud, Le commerce de Marseille depuis le haut moyen âge jusqu’a la fin du XIIIe siècle, in AA. VV., Histoire du commerce de Marseille, I, Paris, Plon 1949, parte II, pp. 107-382 (su Genova in partic. le pp. 181-96); si veda inoltre, ma quasi solo per le ampie referenze bibliografiche delle pp. 530-38, G. Airaldi, Genova e la Liguria nel Medioevo, in Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, vol. V, Torino, U.T.E.T. 1986, pp. 363547, in partic. pp. 401-405. Altre indicazioni in V. Vitale, Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici e orientamenti bibliografici, Genova, Società Ligure di Storia Patria 1955, I, pp. 26-35 e II, pp. 23-27. 19 Il documento è edito da J.-H. Albanes, Gallia Christiana novissima. Historie des archevêchés, évêchés et abbayes de France d’après les documents authentiques recueillis dans les registres du Vaticain et les archives locales, complétée, annotée et publiée par U. Chevalier. Marseille (évêques, prévots, statut), Valence, Imprimerie Valentinois 1899, coll. 693-96; un Anfossus, è citato in un atto marsigliese del 1183 (ibid., coll. 699-700). La presenza ad Arles di un Bernard Anfos è menzionata da Stroński a p. 4*. 20 A Dictionary of Proper Names and Notable Matters in the Works of Dante, revised by Ch. S. Singleton, Oxford, Clarendon Press 1968, s.v. Folco (p. 286). 21 La notizia apre le informatissime, ma purtroppo prive di indicazioni delle fonti, Annexes biografiche al più recente, e forse migliore, profilo biografico di Folchetto. Si dovrebbe invece risalire al 1150 circa per Z. Oldenbourg, L’assedio di Montségur. La crociata contro i catari nella Francia del Medioevo [1959], trad. it. di L. Bianchi, Milano, Garzanti 1990, poiché Folchetto sarebbe morto a ottant’anni (cfr. p. 89): tuttavia le indicazioni relative al trovatore-vescovo non sempre sono corrette in questo lavoro. Curiosamente Maillard 1967, p. 16 riprende quest’ultima data, sia pure preceduta da un prudente «peut-être», ma definisce «inconnue» l’indubitabile data di morte. 22 Un racconto analogo, ma meno completo, si legge nel commento di Benvenuto da Imola (cfr. Benvenuti de Rambaldis de Imola, Commentum super Dantis Aldigherij Comoediam, Firenze, Barbèra 1887, tomo V, pp. 16-17). Trascurando il primo commento, Santangelo 1959, pp. 162-66 ha ipotizzato per il secondo la dipendenza da una fonte comune alla vida occitanica e al Novellino, come ha confermato prima Panvini 1952, pp. 30-31, e ora Suitner. Fu Folco di Marsilia, figliuolo d’uno mercatante genovese, nome Anfuso; altri dice ch’elli fu pure di Linguadoco; il quale morendo il lasciò molto ricco. Costui istudiò in ciò che appartiene a valore umano, e fama mondana; seguia li nobili uomini; e, come appare, trovò in provenzale coble, serventesi, ed altri diri per rima; fu molto onorato dal re Riccardo d’Inghilterra, e dal conte Ramondo di Tolosa, e da Barale di Marsilia, nella cui corte conversava. Fu bello del corpo, ornato parladore, cortese donadore, ed in amare acceso, ma coperto e savio; amò per amore Adalagia moglie di Barale suo signore; e per ricoprirsi, facea segno d’amare Laura di santa Giulia, e Bellina di Pontevese, sirocchie di Barale; ma più si copriva verso Laura, di che Barale li diede congìo: ma morta la moglie di Barale, doglia maravigliosa ne prese, e rendè sè con la sua moglie e due suoi figliuoli nell’ordine di Cestello; poi fu fatto abate di Toronello, e poi Vescovo di Marsilia, donde cacciò molti eretici. Oltre alla conferma dei dati della vida e alla contaminazione con materiali testimoniati dalla razo di FqMars 155,23 (IX) 23, il testo offre, con le parole anfibologiche «altri dice ch’elli fu pure di Linguadoco», l’attestazione della nascita genovese di Folchetto e quindi l’indicazione di una tradizione alternativa che lo vuole linguadociano (se «elli» si riferisce a Folchetto), oppure la semplice segnalazione di una fonte che nega la nascita genovese del padre (se il pronome si riferisce ad Anfuso) 24. Nel primo caso ci sarebbe un precedente della celebre indicazione petrarchesca nel Triumphus Cupidinis, IV, 49-51: «Folco, que’ ch’a Marsilia il nome à dato / et a Genova tolto, ed a l’extremo / cangiò per miglior patria habito e stato» 25, che resta all’origine dei dubbi manifestati in primo Nella nov. XXXIII del Novellino (cito dall’ed. Segre ne La prosa del Duecento, MilanoNapoli, Ricciardi 1959) è infatti messo in scena un Imberaldo del Balzo, che tuttavia è stato identificato con Barral di Baux, podestà di Milano nel 1266 (cfr. per es. G. Favati, Il Novellino, Genova, Bozzi 1970, p. 202, n. 1); tanto più che il titolo di signore di Baux non poteva appartenere al Barral protettore di FqMars, in quanto il nome Barral fu utilizzato dai membri della famiglia di Baux dopo il matrimonio fra Barrala, figlia del signore di Marsiglia, e Ugo di Baux, a partire dallo stesso figlio di Ugo e Barrala (cfr. Stroński, p. 167, n. 1): è vero che l’autore della novella poteva aver fatto confusione, ma occorre maggiore cautela di quella dimostrata da Panvini 1952, p. 31, n. 1 e poi da Segre nel suo commento (p. 826, n. 7) che identificano il personaggio con Barral di Marsiglia. Anche Anglade 1908, pp. 40, 161 e 169 chiama «Barral de Baux» il protettore di Folchetto e Stroński lo rileva ancora a p. 167, n. 1, ma l’errore di Segre passa a L. Battaglia Ricci, Il «Novellino», in Novelle italiane. Il Duecento. Il Trecento, Milano, Garzanti 1982, pp. 79-189, a p. 124 (che per di più unisce in una sola persona il visconte di Marsiglia e il podestà di Milano) e a M. L. Meneghetti, Una serrana per Marcabru?, in Atti Santiago de Compostela 1993, pp. 187-98, a p. 191; lo si ritrova, nonostante la correzione sia stata ribadita da Avalle 1960, I, p. 19, ancora in Asperti 1990, p. 166, n. 41 e in Seto 1995, p. 24. 23 In Boutière-Schutz 1964, pp. 474-77 (ne riporto il testo più avanti nel Commento alla canzone). 24 Cfr. Suitner 1980, p. 624 e n. 16; che l’Ottimo propenda per la nascita marsigliese si ricava dal commento alla perifrasi geografica citata più sotto che indicherebbe «il luogo della sua nativitade». 25 Cito dai Triunphi curati da V. Pacca, in Francesco Petrarca, Trionfi, rime estravaganti, codice degli abbozzi, a cura di V. Pacca e L. Paolino, Milano, Mondadori 1996, pp. 3-626, a p. 194; parafrasa il curatore: «Folco, il cui nome fu iscritto fra i cittadini di Marsiglia e tolto da quelli di Genova [oppure ‘colui che ha dato rinomanza a Marsiglia e ne ha tolta a Genova’]» (p. 195). Un tentativo di ricondurre a Marsiglia l’allusione petrarchesca («il luogo dagli umanisti italiani e di conseguenza dagli eruditi settecenteschi. Apre la serie Bembo, che nel primo libro delle Prose fa dire al genovese Federigo Fregoso 26: [tra gli italiani che poetarono in provenzale] tre ne furono della patria mia, di ciascuno de’ quali ho io già letto canzoni: Lanfranco Cicala e messer Bonifazio Calvo e, quello che dolcissimo poeta fu e forse non meno che alcuno degli altri di quella lingua piacevolissimo, Folchetto, quantunque egli di Marsiglia chiamato fosse; il che avenne non perché egli avesse origine da quella città, che fu di padre genovese figliuolo, ma perché vi dimorò gran tempo. Negli stessi anni, Mario Equicola nel suo Libro de natura de Amore si limita agli elementi ricavabili dalla vida provenzale: «Folquet de Marseglia, il cui patre fu Genovese» 27. Ma anche la perifrastica indicazione del luogo di nascita di Folco, spirito amante nel Cielo di Venere (Par. IX, 82-93): «La maggior valle in che l’acqua si spanda», incominciaro allor le sue parole, «fuor di quel mar che la terra inghirlanda, tra’ discordanti liti contra ’l sole tanto sen va, che fa meridïano là dove l’orizzonte pria far suole. Di quella valle fu’ io litorano tra Ebro e Macra, che per cammin corto parte lo Genovese dal Toscano. Ad un occaso quasi e ad un orto Buggea siede e la terra ond’ io fui, che fé del sangue suo già caldo il porto. è variamente interpretata dai commentatori: per citare soltanto i due più importanti dell’età moderna, Landino vi scorge giustamente un’allusione a Petrarca forse volle significare che la gloria venuta a Marsiglia dall’essere patria di Folchetto sarebbe stata di Genova se questi fosse nato nella terra dei suoi padri») è di Zingarelli 1899, p. 11 in nota. 26 Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, I, VIII (cito da Trattatisti del Cinquecento, a cura di M. Pozzi, Milano-Napoli, Ricciardi 1978, I, pp. 51-284, a p. 74); annota Pozzi: «è ovvio che il Bembo attribuisce al Fregoso i propri studi provenzali» (p. 72, n. 2). Ai lavori citati dallo studioso sull’importante ruolo di Bembo nella diffusione della tradizione trobadorica, si aggiungano ora, oltre a Folena 1990 (ma 1976), pp. 20-22, le indicazioni nel cap. I di Bologna 1993 e gli studi di C. Pulsoni in CN, LII (1992), pp. 323-51 e LIV (1994), pp. 185-87 e nella RLI, XI (1992), pp. 283-304 (cfr. anche «Aevum», LXVII [1993], pp. 50118, integrato da una nota nel vol. XVIII [1994], pp. 571-73). 27 Libro de natura de Amore di Mario Equicola [...] stampato in Venezia per Lorenzo Lorio da Portes, Adi 23 Zugno 1525, V, p. 194r; la versione della vida utilizzata dall’umanista è certo quella di N2 o, meglio, di una «copia approntata per lui ad opera dello stesso Camillo», secondo l’ipotesi di Bologna 1993, I, p. 19: questi rileva come l’Equicola «appena quattro anni prima (1521), nella Chronaca de Mantua (fol. 37), si mostrava francamente digiuno di letture dirette della poesia d’oc limitando i riferimenti alla tenzone di Sordello con Guilhem de Tolosa (e che nella prima redazione volgare del Libro, corretta a più riprese, verso il 1510-15, non conosce ancora i passi che riferirà nel ’25 [...]» (pp. 19-20). Marsiglia 28, mentre Vellutello ritiene che Dante voglia indicare Genova, sottolineando la novità della sua interpretazione rispetto a quella degli altri commentatori danteschi 29. Nel Cinquecento ribadiscono la nascita genovese Francesco Alunno, Benedetto Varchi, Uberto Foglietta, Ludovico Castelvetro, Vincenzio Borghini e Angelo Colocci 30; Giovanni Maria Barbieri si limita a citare i versi di Petrarca 31. Nel secolo XVII ho notizia della posizione di Francesco Redi: «e da Genova parimenti quel Folchetto, che Folchetto di Marsilia fece appellarsi» 32, e all’inizio del secolo seguente la messa a punto di Giovanni Mario Crescimbeni nei Commentarj alla sua Istoria della volgar poesia, che assume come auctoritas, oltre ai due poeti toscani, Jehan de Nostredame 33. Prima che Stroński manifestasse le sue perplessità la questione pareva risolta: Oskar Schultz-Gora, notando che, oltre a Petrarca «Keine der Biographien und keiner der alten Gewährsmänner giebt Genua als seinen Geburtsort an», aveva escluso recisamente la nascita italiana di Folchetto 34, cosicché Nicola Zingarelli poteva scrivere tredici anni più tardi: «Che la patria di Folchetto sia veramente Marsiglia e non Genova, è oramai fuori quistione» 35. 28 «Volendosi manifestare Folco, descrive la terra dove nacque, cioè, Marsilia...» (Dante con l’esposizioni di Christoforo Landino et d’Alessandro Vellutello sopra la sua Commedia dell’Inferno, del Purgatorio, & del Paradiso [...] in Venetia, appresso Gio. Battista & Gio. Bernardo Sasso, 1596, c. 316r). 29 «Comincia Folco, per satifar al desiderio del Poeta, a circunscrivere la sua terra di Genova, dove nacque, e non di Marsilia, come dicono tutti gli altri espositori, dove dopo la morte del padre andò ad habitare. [...] Costui adunque, come di sopra habbiamo detto, perché la sua habitazione dopo la morte del padre fu sempre a Marsilia, e quivi tolse donna, & habbe figliuoli, fu detto Folco di Marsilia, e non di Genova, donde gli altri espositori hanno preso errore. E questo mosse il Petrarcha nel quarto del Trionfo d’Amore a dir di lui, Folchetto, ch’a Marsilia... [segue la parafrasi dei versi]» (ibid., c. 316r-v; modifico la punteggiatura). 30 Vedi F. Alunno, La fabrica del mondo, Venezia, presso Paolo Gherardo 1557, c. 10r-v; B. Varchi, L’Hercolano, Edizione critica a cura di A. Sorella, Pescara, Libreria dell’Università 1995, t. II, p. 582; U. Foglietta, Clarorum Ligurum elogia, Romae apud Vincentium & Valente Panitium Socios, 1574, pp. 205-206; Le Rime del Petrarca, brevemente sposte per L. Castelvetro, in Basilea a istanza di Pietro de Sedabonis, 1582, parte III, p. 233; V. Borghini, Scritti inediti o rari sulla lingua, a cura di J. R. Woodhouse, Bologna, Commissione per i testi di lingua 1971, p. 266. Per Colocci si vedano gli appunti petrarcheschi citati supra alla n. 5. Altre indicazioni in Vincenti 1963, p. 48. 31 Dell’origine della poesia rimata, opera di Giammaria Barbieri modenese, pubblicata ora per la prima volta e con annotazioni illustrata dal cav. Ab. Girolamo Tiraboschi [...], Modena, Società Tipografica 1790, pp. 103-107. 32 Bacco in Toscana, ditirambo di Francesco Redi [...] con le annotazioni, Firenze, Piero Matini all’Insegna del Lion d’Oro 1685, pp. 100-101. 33 L’istoria della volgar poesia scritta da Gio. Mario Crescimbeni, [...] Venezia presso Lorenzo Basegio 1730-31, vol. I, p. 336 e vol. II, pp. 33-37; anche Jehan de Nostredame utilizza i versi dei Trionfi, affermando la nascita genovese del trovatore (Les vies des plus célèbres et anciens poètes provençaux, nouvelle édition [...] par C. Chabeneau, Paris 1913, pp. 34-36 e passim; nel vol. II dell’Istoria Crescimbeni traduce l’opera di Nostredame). 34 O. Schultz-Gora, Die Lebensverhältnisse der italienischen Trobadors, ZrPh, VII (1883), pp. 177-235, a p. 179. 35 Zingarelli 1896, p. 3, n. 1 (senza modifiche in Zingarelli 1899, p. 10, n. 6). Sono quasi tutte ricavate dalle poesie le relazioni intrecciate con i re e i grandi nobili nominati, con l’unica eccezione di Raimondo V di Tolosa, mai menzionato da Folchetto 36. Dall’analisi della cronologia dei testi, si ricava che: intorno al 1179-80 il trovatore inviò la canzone 155,5 (I) a Raimondo Berengario IV, fratello di Alfonso II d’Aragona, nella città di Trets (§ 1.3.1.1); qualche anno dopo indirizzò a tre donne di Nîmes la canzone 155,22 (II) (§ 1.3.1.2); che negli anni 1186-87 ebbe rapporti con Montpellier e il suo marchese Guglielmo VIII, inserendo in tre poesie (le canzoni 155,23 [IX], 155,27 [X], 155,8 [XI]) accenni all’emperairitz Eudossia (§§ 1.3.1.3-5); che nel luglioagosto 1190 dedicò una cobla della canzone 155,3 (VI) a Riccardo Cuor di Leone, che, in partenza per la Terrasanta, attese a Marsiglia le sue truppe (§ 1.3.1.6); e infine, che nel 1195 in due canzoni di crociata (155,7 [XIV] e 155,15 [XVIII]) incitò prima i re di Francia e d’Inghilterra a organizzare una nuova crociata (l’imperatore Enrico VI che aveva preso la croce il 2 aprile), poi, dopo la sconfitta dei castigliani ad Alarcos (19 luglio), chiese ai prìncipi cristiani di sostenere Alfonso VIII contro i mussulmani di Spagna. Viceversa, non vanno prese sul serio le relazioni amorose intracciate con Azalais, moglie di Barral, poi con le sorelle del visconte, quindi con la stessa Eudossia: capitoli di «romanzo d’amore» ricavato anche questo dalle poesie e che si sviluppa attraverso le razos delle canzoni 155,23 (IX) e 155,27 (X) e del planh 155,20 (XXI), per cui rimando al Commento alle edizioni). Infine, i rapporti molto significativi di Folchetto con importanti trovatori coevi saranno esemplificati nel § 3.2.1. § 3.1.2. C a r r i e r a r e l i g i o s a . Le indicazioni della vida coincidono in parte con quelle ricavabili dal De Triumphis Ecclesiae di Giovanni di Garlandia, l’altra importante fonte per questa fase della vita di Folchetto 37: Pravos extirpat et doctor, et ignis, et ensis; Falcat eos Fulco, praesul in urbe sacra. Hic dudum fuerat joculator, civis et inde 36 Riccardo Cuor di Leone è nominato in 155,3 (VI), 33 e, come «reys engles», in 155,7 (XIV), 50: cfr. 155,12 (XXIII), 33-37; Alfonso II d’Aragona è menzionato semplicemente come «reys d’Arago» in 155,5 (I), 44-45 e nella canzone di crociata 155,15 (XVIII), 37; al visconte di Marsiglia Raimon Jaufre Barral (morto nel 1192) Folchetto dedica il planh 155,20 (XXI), nominandolo esplicitamente in 155,7 (XIV), 2 e, come «mo senhor», in 155,11 (XIII), 43. Su Raimondo V scrive Stroński: «il est probable que le biographe ait ajouté le nom du “bon comte Raimon”, bien connu des vidas, pour ne pas omettre, à côté du roi d’Aragon, seigneur de Provence, et de Richard, signeur d’Aquitaine, le trosième grand prince du Midi à cette époque» (pp. 140-41). Guida 1997, pp. 37-38 che ritiene «ammissibile» la tesi di Stroński, nota come Uc de Saint Circ – giurisdizionalmente dipendente dalla casa dei conti di Tolosa – si sia comportato «da buon suddito ma da cattivo storico» (p. 38). Suitner 1980, p. 622, n. 9 ipotizza «in via subordinata» che in origine Raimon fosse semplicemente il primo nome del visconte Barral, elevato a conte da un compilatore. 37 Johannis de Garlandia, De triumphis Ecclesiae libri octo. A Latin Poem of the Thirteenth Century, edited by T. Wright, London, Nichols & Sons 1856, libro V, pp. 93-94; cito da Stroński, pp. 107*-108*. Marsiliae, clarus conjuge, prole, domo. Intrans coenobium Turoneti, veste sub alba Certat, ut interius albior esse queat. Factus de monacho fuit abbas, praesul et inde Tholosae, passus pro grege multa mala, Probra, minas, iter, exilium, suspiria, luctus, Raptus, contemptus, insidiasque graves. Abbates facti Fulconis sunt duo nati, Consecrat et matrem relligionis apex. Giovanni è un testimone diretto, avendo conosciuto personalmente Folchetto 38; così Stroński: «L’auteur de la vida, qui donne sur l’origine de Folquet des détails dont J. de Garlande ne parle pas, a sans doute connu sa carrière religieuse par d’autres sources que ce poème latin; mais, puisqu’il insiste sur les mêmes détails, il s’en est peut-être inspiré dans la rédaction de ce passage de son récit» (p. 142). Fra i dettagli comuni, la notizia dell’entrata in convento dei due figli (e della moglie) è confermata, oltre che dall’Ottimo e da Benvenuto, da un atto di donazione del 1210, che annovera fra i testimoni «frater Ildefonsus et frater Petrus, frater ejus, monachi Grandis Silve, qui dicti sunt filii Folquet de Massilia episcopi Tolose» 39. Per quanto riguarda l’entrata nell’ordine cistercense, la vida offre una motivazione convenzionale e poco verosimile 40, mentre i due commenti danteschi restringono la causa alla morte di Azalais 41: se è oggettivamente difficile, oltre che poco interessante, determinare tale motivazione, è possibile, con Stroński, ipotizzare la data di abbandono del secolo. L’editore indica il 1195, in primo luogo perché questo è l’anno in cui Folchetto scrive l’ultimo suo 38 Nato in Inghilterra fra il 1190 e il 1195, Giovanni è a Parigi probabilmente dopo il 1217; partecipa attivamente alla crociata e insegna all’Università di Tolosa (cfr. infra) dal 1229 al 1232: e durante il suo soggiorno in città redige i libri IV-VI del suo poema: si veda di Y. Dossat, Les premiers maîtres à l’université de Toulouse, Jean de Garlande, Hélinard, CF, V [1970], pp. 179-203, in partic. le pp. 179-90. 39 Del documento, edito nel Cartulaire de Bardones, publié et ann. par l’abbé Cazauran, La Haye, Martinus Nijhoff 1905, p. 289 sgg. (n° 435), l’editore dà notizia in Stroński 1913, pp. 274-78. La ‘conversione’ è ricordata anche in uno degli exempla (il n° 154) conservati nel ms. 1019 della Bibl. di Arras e studiati da Isabelle Rava-Cordier: si veda per ora La proximité comme élément de persuasion: les références géographiques, sociales et culturelles dans les exempla d’un sachet provençal au XIII e siècle, CF, XXXII (1997), pp. 225-48, in partic. pp. 238 e 242. 40 Barral muore nel 1192, Riccardo nel 1199, Raimondo nel 1194, Alfonso nel 1196. La data di morte Azalais va probabilmente collocata nel 1201, anno in cui la donna redige un testamento, riportato da Stroński a p. 170, n. 1: cfr. Aurell 1986, p. 159 . Il 1191 (prima del maggio) è l’anno del ripudio da parte di Barral, il quale probabilmente si aspettava un figlio maschio; il visconte si risposerà forse nello stesso 1191 con Maria di Montpellier (cfr. Stroński, pp. 168-70): l’estensore della vida può aver confuso la data del ripudio con quella della morte, anticipando il decesso di almeno dieci anni. Trascurando questo aspetto si può dire che per la vida l’entrata in convento deve seguire il 1199. Così solo sei anni separerebbero l’entrata in convento dall’elezione a vescovo di Tolosa (1205), ma la cosa non appare impossibile. 41 Commenta Benvenuto: «Mortua uxore Baralis amarissimum dolore concepit, sicut olim Dantes de morte suae Beatricis». testo databile, la canzone di crociata 155,15 (XVIII), probabilmente di poco successivo alla disfatta di Alarcos 42; in secondo luogo per una constatazione di ‘buon senso’: «si on considère que dix ans seulement séparèrent sa dérnière chanson (1195) de son élection à l’évêche de Toulouse (1205) et que son séjour dans le cloître devait être assez long pour qu’il fût nommé abbé, on est autorisé à supposer qu’il se fit moine peu de temps après cette chanson de 1195 qui paraît indiquer qu’il pense à “s’incliner devant Dieu”» (p. 90*). Per di più l’intera tornada della canzone di crociata è letta dall’editore come un invito ad Azimans (cioè a BtBorn) a seguirlo nella scelta di entrare in convento (cfr. infra il § 3.2.1.1.3). Con tutto ciò la data del 1195, per quanto verosimile, resta congetturale 43; altrettanto ipotetica la data di elezione ad abate del convento di Thoronet, nella diocesi di Fréjius 44: certamente è posteriore al 1199, anno di un documento redatto «in praesentia et testimonio Ugonis abbatis de Floreia» 45: Stroński la colloca posteriormente al 1201 46. Comunque sia, l’ordine cistercense era particolarmente impegnato nell’azione anti-eretica sin dall’epoca di Bernardo di Chiaravalle: ma è con Innocenzo III, che papa da quattro mesi designa il monaco cistercense Rainier quale suo legato allo scopo di avviare una campagna capillare di predicazione e di controllo del clero meridionale, che si apre la prima fase della lotta ai catari (21 aprile 1198); prima fase che terminerà drammaticamente il 14 gennaio 1208 quando Pierre de Castelnau, monaco cistercense di Fontfroide e sostituto di Rainier, viene assassinato: la data segna l’inizio della crociata contro gli albigesi, condotta all’inizio da un altro cistercense, l’abate generale di Cîteaux Arnaud Amaury, arcivescovo di Narbona dal 1212 47. Né va dimenticato il ruolo di Gui, abate del convento cistercense di Vaux-de-Cernay e vescovo di 42 Cfr. infra, § 1.2.1.11; non è detto comunque che si tratti dell’ultimo testo in assoluto come vorrebbe Stroński (p. 74*): a non voler considerare le due poesie religiose 155,26 (XXVI) e 155,19 (XXVII), ascrivibili al periodo di monacazione del trovatore, non si può escludere che qualcuno dei testi amorosi non databili possa essere posteriore al n° XVIII. 43 In base alla vida l’HGL, V, p. 91 indica il 1199, l’HLF, XVIII, p. 595 «vers 1196», mentre Jeanroy 1934, II, p. 148, n. 3, dà, senza specificazioni, il 1200. 44 Cenni sulla storia dell’abbazia sono in Cabau 1986, p. 156; cfr. anche Biget-Pradalier 1986, p. 369, n. 115. 45 Il nome originario, Sainte-Marie de Floreye, persistette al trasferimento del convento in località Thoronet; la carta, edita da L. Blancard, Les chartes de Saint-Gervais-lès-Fos, Marseille 1878, p. 32, è citata da Stroński 1910, p. 90*, n. 2. L’affermazione di Papon, ripresa anche dall’HLF, XVIII, pp. 595-96: «Je connois en effet une charte d’Alphonse II [di Provenza], datée du mois de janvier 1197, que Fouques signa en qualité d’abbé du Toronet» (Histoire générale de Provence, Paris, Montard 1772-86, II, p. 395), sarebbe invece senza fondamento: secondo Stroński Papon ha confuso i nomi degli abati. 46 Fauriel 1846, II, p. 71 indica il 1200. 47 Oltre alla sintesi di M.-H. Vicaire, Les clercs de la croisaide, CF, IV (1969), pp. 26080, sul ruolo dei cistercensi si veda il numero monografico Les Cisterciens de Languedoc (XIIIe-XIVe s.) dei CF, XXI (1986). Carcassonne dal 1212, predicatore attivissimo già prima dell’inizio della crociata e zio del cronista Pierre, anche lui appartenente all’Ordine 48. In un contesto siffatto si spiega perfettamente l’elezione di Folchetto a vescovo di Tolosa 49: ma potrebbe non essere peregrina l’ipotesi che la passata attività commerciale e la consuetudine con i fatti finanziari possa aver influenzato la sua designazione. La situazione economica della diocesi di Tolosa era infatti ben misera, se è vero che Raymond de Rabestens, il predecessore di Folchetto, deposto alla fine del 1205 con l’accusa di simonia e di collusione con gli eretici, aveva dilapidato per fini personali quasi l’intero patrimonio: quando, il 5 febbraio 1206, Folchetto prende possesso del soglio si ritrova, come ricorda lui stesso in una predica, con una rendita di soli 96 soldi tolosani (Puylaurens, cap. VII e cfr. cap. XXXIX): di qui la definizione, più volte ripetuta dal cronista, di «episcopatus mortuus». Tuttavia il nome del vescovo di Tolosa è ricordato dagli storici essenzialmente per il suo coinvolgimento nella crociata e viene intrecciato a quello di un altro protagonista della storia religiosa e politica del Midi, San Domenico di Caleruega. Coinvolgimento che è valso a Folchetto una fama un tempo molto negativa 50 e oggi, dopo le opportune considerazioni di Stroński, più equanime 51; resta comunque un’ombra su questa figura, non di rado definita ambigua, se non inquietante 52. E ciò per un’attività pastorale e culturale, oltre che per una certa generosità, che emerge dalle fonti accanto all’innegabile sostegno politico, ideologico ma anche militare, alle armate di Simon de Monfort prima, di Luigi VIII in séguito. 48 M. Zerner-Chardavoine, L’abbé Gui des Vaux-de-Cernay prédicateur de croisade, CF, XXI (1986), pp. 183-204. 49 D’altro canto, scrive J. Duvernoy, editore di Puylaurens: «le Saint-Siège avait déjà tenté, mais en vain, d’installer un cistercien sur le siège de Toulouse, l’abbé Henri de Marcy (ou Marciac), qui avait décliné ce désagréable honneur» (p. 45, n. 3). Della notizia, rilanciata da Jean de Nostredame ma, come visto, già presente in Benvenuto e nell’Ottimo, che la sede episcopale (la prima per Nostredame, l’unica per i commenti) fosse Marsiglia, discutono gli autori della GC, I, coll. 648-50: la communis opinio trae origine dall’errata identificazione fra il Nostro e un altro Fulco, vescovo di Marsiglia dal 1174; per l’indicazione di Nostradamus cfr. HGL, V, p. 91. La confusione si trova ancora in Picchio Simonelli 1974, p. 207: «Folchetto, cattolicissimo vescovo di Marsiglia». 50 Ancora in tempi recenti càpita di leggere che «F. de Marseille, pendant la Croisade albigeoise, s’est rendu tristement célèbre par sa cruauté à l’égard des hérétiques: on sait qu’il fut accusé par le comte de Foix de la mort de plus de cinq cents personnes» (Bec 1979, p. 202; «hérétiques» limita e in un certo senso attenua l’espressione «populations occitanes» che si legge nell’ed. precedente dell’opera, Bec 1970, p. 266). 51 Anche da parte cattolica si assiste ad una moderazione dei toni: a quello apologetico di G. Cayre, Folques, de Marseille, XLIe évêque de Toulouse, «La semaine catholique de Toulouse» V (1866), pp. 349-50, 361-63, 373-75 e Le bienheureux Foulques, évêque de Toulouse (1205-1231), ibid., XVI (1877), pp. 1128-40, si è sostituito un giudizio più sfumato, per quanto inevitabilmente di parte: si veda la voce Folquet ou Foulques de Marseille (a cura di M.-A. Dimier) nel Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, sous la direction de R. Aubert, vol. XVII, Paris, Letouzey et Ané 1971, coll. 777-80; e cfr. Pontal 1985, pp. 183-84. 52 A titolo esemplificativo si veda Cabau 1986, p. 151. È per di più notoria la parzialità più o meno accentuata delle fonti della crociata 53: se è scontato il giudizio positivo sul vescovo della cronaca di Pierre di Vaux-de-Cernay e quello negativo della seconda parte della Chanson de la croisade albigeoise, più interessante è la posizione, piuttosto benevola, dei cronisti più equilibrati, Guillaume de Puylaurens e Guillaume de Tudèle, autore della prima parte della Chanson. Anche Innocenzo III, all’atto di conferirgli un mandato speciale perché riporti l’unità nella Chiesa tolosana (cfr. Cernay, §§ 401-11), ha parole molto elogiative per il vescovo di Tolosa 54: Si vero iidem ad Ecclesiae redire desiderant unitatem, prout fuit a dictis nuntiis tuis proppsitum [sic] coram nobis, nos venerabili fratri nostro Fulconi Tolosano episcopo, viro integrae opinionis et vitae, qui testimonium habet non solum ab iis qui sunt intus, sed ab iis etiam qui sunt foris, nostris damus litteris in mandatis, ut adjunctis sibi duobus prudentibus et honestis, eos qui voluerint de corde puro et conscentia bona fide non ficta redire, sufficienti ab isdem cautione receptae, reconciliet ecclesiasticae unitati. Tuttavia, a causa dell’utilizzo prioritario da parte dell’Histoire générale du Languedoc, opera di riferimento fondamentale per lo studio della crociata, di un rimaneggiamento in prosa della Chanson 55 fortemente contrario a Folchetto, si è avuto un fenomeno simile a quello denunciato da Achille Luchaire per il ruolo delle milizie comunali nell’esercito francese del XII secolo: «C’est là une de ces traditions, qui, transmises sans contrôle de génération en génération, de manuel en manuel, sont entrées dans le courant des opinions reçues et finissent par s’imposer aux historiens» 56. Il vaglio costante delle fonti è pertanto in questo caso necessario più che altrove, per fornire di un qualche valore oggettivo il ritratto di un personaggio così controverso, fermi restando i limiti che la ricerca documentaria sempre presenta con le sue zone opache, le sue ambiguità e i suoi vuoti. Il rapporto con Domenico accompagna, come detto, l’intera carriera episcopale di Folchetto, sin dall’anno d’insediamento: nel 1206 il vescovo gli 53 Per una valutazione si veda Y. Dossat, La croisade vue par les chroniquers, CF, IV (1969), pp. 221-59, e, dello stesso, i due interventi su Guillaume de Puylaurens ora raccolti in Eglise et hérésie en France au XIII e siècle, London, Variorum Reprints 1982, capp. II-III. 54 Lettera del 1° giugno 1213 (Potthast, n° 4741); cito da PL, CCXVI, coll. 849-52, a col. 850. 55 La versione, pubblicata per la prima volta da Dom Vaissete nell’HGL, V, pp. 455-528 (e integrata dalle Additions et notes di Al. Du Mège alle pp. 107-61), con il titolo di Histoire de la guerre des Albigeois è stata riedita da Bouquet nei RHGF, XIX, pp. 114-92: si vedano le considerazioni e i confronti di Stroński alle pp. 97*-99*. 56 Cit. da Belperron 1942, p. I; dagli storici ai poeti e ai romanzieri il passo è breve: a parte Mistral che lo definisce «Fouquet l’abouminable» nel Calendau (canto I, v. 382; cito dalle Oeuvres poétiques dirette da P. Rollet, Aix-en-Provence 1966; cfr. t. I, p. CLXXII per un commento dello stesso Mistral), si pensi al collegamento fra Montségur, espugnato tredici anni dopo la morte del vescovo, nel marzo 1244, e il Folco dantesco operato da Ezra Pound: «O Anubis, guard this portal / as the cellula, Mont Ségur. / Sanctus / that no blood sully this altar / ex aquis nata / τά εκ των υδάτων γενόμενα / “in questa lumera appresso” / Folquet, nel terzo cielo» (Cantos, XCII); più esplicitamente W. Siti scrive: «e giù dalle mura di Montségur, quando sono entrati i soldati del papa, colavano gocce di sangue e Folquet lo chiamava dal pulpito il mosto della vendemmia del Signore» (Scuola di nudo, Torino, Einaudi 1994, p. 88). avrebbe donato la chiesa di Sainte-Marie de Prouille, nei pressi di Fanjeaux, città da dove il Santo aveva iniziato la sua attività di predicazione, ma i tre documenti che attestano la largizione sono falsi 57: è probabile che Folchetto abbia donato al Santo la chiesa, che dipendeva dalla sua diocesi, ma senza redigere alcun atto, e abbia autorizzato il convento femminile di Prouille di cui si hanno tracce documentarie dall’aprile 1207 e che costituisce il primo insediamento di quello che sarà l’Ordine Domenicano 58. Nello stesso anno insieme con Navarre, vescovo di Couserans, che sarà suo compagno di predicazione durante la crociata raggiunge Domenico a Palmiers, dove si svolge un dibattito dottrinale con gli eretici (Cernay, § 48) 59. Ma i dibattiti saranno presto abbandonati: il 14 gennaio del 1208 viene ucciso il legato pontificio Pierre de Castelnau; alla fine del mese Folchetto si reca a Roma insieme col vescovo di Causerans per chiedere l’intervento di Innocenzo III 60 che indice la crociata contro gli albigesi con la lettera del 10 57 L’inautenticità dei documenti, uno del 1206, due del 1211, è stata dimostrata da P. Mandonnet - M.-H. Vicaire, S. Dominique. L’idée, l’homme et l’oeuvre, Paris 1938, I, p. 105, n. 39 (il primo) e da R.J. Loenertz, Archives de Prouille, AFP, XXIV (1954), pp. 5-49, alle pp. 37-47 (gli altri due): cfr. Vicaire 1987, p. 229 e n. 44 (cui rimando per indicazioni ulteriori) e, dello stesso, Sources méridionales de l’histoire de Saint Dominique, nel volume monografico dei CF su Saint Dominique en Languedoc, I [1966], pp. 34-40, alle pp. 34-35. La donazione è affermata, ovviamente senza riserve, da Stroński a p. 91*. 58 Cfr. Vicaire 1987, cap. VIII e, dello stesso, Saint Dominique a Prouille, Montréal et Fanjeaux, CF, I (1966), pp. 15-33, alle pp. 27-32 e L’action de saint Dominique sur la vie régulière des femmes en Languedoc, CF, XXIII (1988), pp. 217-40 (sul problema della fondazione vera e propria del convento, che pare doversi attribuire al vescovo Diego d’Osma, compagno di predicazione di Domenico, si vedano le pp. 219-20). Comunque Folchetto si attribuisce la responsabilità in un docum. del 1230: «Quod a nobis aedificatum fuit et constructum» (cfr. Vicaire 1987, p. 250 e n. 170). Oltre alla donazione in favore della comunità di Prouille, Folchetto si fa fautore di altre iniziative religiose: sono infatti sotto la sua influenza (ma lo erano già della sua abbazia) i monasteri cistercensi femminili di NotreDame-de-Sion e Saint-Pons-de-Gémenos, alla cui fondazione, ancora abate di Thoronet, assiste a Marsiglia il 28 aprile 1205 (cfr. Cabau 1986, p. 174); di quest’ultimo, una volta diventato vescovo, è infatti uno dei principali promotori: è a lui, in quanto procuratore di Gémenos e accompagnato da monaci di Thoronet, che Sacristiana dei Porcelet dona nel 1208 la metà del villaggio di Mollégès, dove sorgerà il monastero di Santa Maria: cfr. Aurell 1986, p. 163 e dello stesso, Les Cisterciennes et leurs protecteurs en Provence rhodanienne, CF, XXI (1986), pp. 235-67, alle pp. 236 e 259. 59 L’ultimo di una serie di incontri su cui si veda Belperron 1942, pp. 129-35 (in partic. pp. 133-34) e Vicaire 1987, pp. 254-55. Negli stessi anni sono documentate le prime conversioni e riconciliazioni di eretici operate da Folchetto, in un paio di casi insieme con Domenico: si vedano le indicazioni di Cabau 1986, p. 178 e quelle meno ricche di Douais 1900, p. LXXV, nn. 3-4. 60 Cernay, § 67; Arnaud Aumary e Guy di Vaux-de-Cernay vanno invece in Francia per sollecitare Filippo Augusto e i suoi baroni: Cernay, §§ 72, 103 e 128. Il viaggio a Roma è ricordato anche dalla versione ER della vida di Pedigon (ed. Boutière-Schutz 1964, pp. 41215), scritta secondo Guida 1997, pp. 38-54 da Uc de Saint Circ, forse nel 1223-24 e comunque negli anni ’20, con un fervore antifrancese e una partigianeria nei confronti del conte di Tolosa che si sarebbe vietata nei primi anni ’30 redigendo la vida di FqMars; sempre agli anni ’30 risalirebbe la rielaborazione della vida di Perd, indotta da ragioni di opportunità politica o giudiziaria. marzo 61. Con l’inizio del conflitto le prediche di Folchetto s’infittiscono: «L’evesques de Tholosa, Folquets cel de Maselha, / que degus de bontat ab el no s’aparelha, / e l’abas de Cistel [scil. Arnaud Amaury] l’us ab l’autre cosselha. / Tot jorn van prezican la gent co no·s revelha; / del prest e del renou l’un e l’autre s’querelha» (Tudèle, 46, 1-5). Siamo nell’inverno-primavera 1209-10. Tolosa era sotto interdetto dal settembre 1209 (concilio di Avignone): Folchetto, che aveva partecipato al concilio, rientra in città dopo averla liberata dall’interdetto il 28 marzo 1210 (Cernay, § 162) installandosi nel castello Narbonese, fortezza del conte Raimondo VI (Tudèle, 44, 18-20); aveva quindi fondato la Confraternita bianca «ut per hoc devotionis eos Ecclesie aggregaret atque facilius per eos ut expugnaret haereticam pravitatem et fervorem extingueret usurarum» (Puylaurens, cap. XV), cui si contrappose presto una Confraternita nera composta da abitanti del borgo, tradizionalmente anticattolici, spesso in contrasto violento con la prima: d’altronde «venerat enim Dominus per ipsum episcopum servum suum non pacem malam, sed gladium bonum mittere inter eos» 62. È in questo clima che Domenico ottiene da Folchetto l’autorizzazione a predicare nella città, nello spirito delle disposizioni del concilio di Avignone del 6 settembre 1209 63. Nell’estate del 1210 il vescovo compare sul campo di battaglia, durante l’assedio di Minerve che, condotto da Simon de Monfort, si concluderà il 22 luglio con un rogo di almeno centoquaranta ‘perfetti’ 64. Il 10 luglio si apre il concilio di Saint-Gilles che deve discutere le responsabilità di Raimondo VI: è presente anche Folchetto (Cernay, § 164 e cfr. la n. 4), il quale partecipa inoltre ai concili di Narbona nel gennaio 1211 e di Montpellier dove il 6 febbraio il conte viene scomunicato per la seconda volta 65; il 26 febbraio chiede al conte di lasciare la città per poter fare le ordinazioni nella cattedrale: Raimondo rifiuta e ricambia l’invito, meritandosi la solidarietà dei tolosani su cui ricade 61 Potthast, n° 3323, cito da PL, CCXV, coll. 1354-58; sul ruolo del pontefice nella lotta antieretica si veda R. Foreville, Innocent III et la croisade des albigeoise, CF, IV (1969), pp. 184-217. 62 Puylaurens, cap. XV e cfr. Tudèle, lassa 47. È alla Confraternita di Folchetto che si riferisce Gavaud 174,1 (X), 15-16: «E vos, nescia gent blanca, / faretz vermelh so qu’es blanc»: cfr. Guida 1979, pp. 57-64 e ora Guida 1997, p. 36, n. 35. 63 Cfr. in partic. il I canone: Ut episcopi frequentius vel praedicent, vel faciant praedicari che si legge in J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio [...], t. XXII, Venetiis apud Antonium Zatta 1778, coll. 783-94, alla col. 785 (tradotto in francese da Cabau 1986, p. 163); sul concilio avignonese si veda Hefele-Leclercq 1913, pp. 1283-86. 64 Cernay, § 156: «Erant autem perfecti heretici centum quadraginta vel amplius. Preparato igitur igne copioso, omnes in ipso proiciuntur; nec tamen opus fuit quod nostri eos proicerent, quia, obstinati in sua nequicia, omnes se in ignem ultro precipitabant». 65 Così la fonte (Cernay § 212), mentre Tudèle, 59, 5 scrive, con incertezza eloquente: «Pois ne foro a autre [parlement], az Arles, mon escient»: l’erroneità dell’indicazione, dimostrata da Martin-Chabot 1931-61, I, pp. 144-45, n. 3, si è tuttavia diffusa sulla scorta di Labbe e Mansi negli strumenti moderni, come il Dizionario dei concili, diretto da P. Palazzini e G. Morelli, I, Ist. Giovanni XXIII nella Pontificia Università Lateranense 1963, pp. 88-89; in Hefele-Leclercq 1913 il «synode d’Arles» segue l’«assemblée tenue à Montpellier» (p. 1289). nuovamente l’interdetto 66; di conseguenza, alla vigilia di Pasqua, il 2 aprile, il vescovo abbandona Tolosa alla testa del clero, per raggiungere Simon de Monfort all’assedio di Lavaur (Cernay, § 222), dove intorno alla metà di marzo aveva inviato la sua Confraternita bianca (Puylaurens, cap. XVI). Il 3 maggio assiste alla presa della città (Cernay, § 226) 67: due atti di donazione al monastero di Prouille attestano la sua presenza, ma probabilmente anche di Domenico 68 nella città espugnata ancora il 15 maggio (MDD, ni 10-11). Nel giugno i due si ritrovano con Simon al primo assedio di Tolosa (Cernay, § 232): Folchetto impone con intransigenza l’ultimatum ai cittadini, ordinando nuovamente al clero, Domenico compreso, di abbandonare la città (Cernay, § 234). L’assedio dura comunque solo 12 giorni, dal 17 al 29 giugno, e si conclude col ritiro dei crociati: il vescovo non può riprendere le sue funzioni in città e la sua Confraternita, mero corpo militare dopo Lavaur, si scioglie. Guillaume de Tudèle sintetizza bene il rapporto conflittuale fra Folchetto e Tolosa: nell’estate 1210 il vescovo era stato accolto in città trionfalmente per aver tolto l’interdetto 69; «mas poi vi», aggiunge il cronista, «qeu·s mescleron per mot granda iror. / L’avesque anec en Fransa prezicar cascun jorn / e crozan se li princep, li baro e·lh comdor / e·l cavaler de lai» (Tudèle, 62, 10-13): il ricorso ai ‘barbari’ del Nord, che insieme con l’intransigenza nei confronti dei tolosani sta alla base dell’astio dell’anonimo continuatore della Chanson, va collocato alla fine dell’anno successivo o nei primi mesi del 1212. È probabilmente nel corso di questo viaggio in Francia (testimoniato anche da Cernay, § 286) che Folchetto si reca per la prima volta a Liegi, come documenta, fonte unica dell’avvenimento, il prologo della Vita Beatae Mariae Oigniacensis, che l’autore, Jacques de Vitry, dedica al vescovo di Tolosa 70: 66 La fonte (Cernay, § 221) indica come data «sabbato videlicet post media Quadragesima», ovvero il sabato delle Quattro Tempora, appunto il 26 febbraio nel 1211 (più genericamente indica le Quattro Tempora Vicaire 1987, p. 282); forse per l’apparente genericità dell’indicazione, la data è variamente indicata negli studi: per l’HGL, V, p. 168 è «[le] samedi avant le Dimanche de la Passion», cioè il 26 marzo, per Stroński quaranta giorni prima dell’uscita di Folchetto dalla città, cioè il 21 febbraio, per Cabau 1986, p. 174 il 19 marzo. 67 L’assedio si conclude come a Minerve: «innumerabiles etiam hereticos peregrini nostri cum ingenti gaudio combusserunt» (Cernay, § 227); la cifra è quantificata in quattrocento da Tudèle, 68, 19, in «circiter trecentos» da Puylaurens, cap. XVI. 68 Così ritiene Vicaire 1987, p. 283, n. 108. 69 «L’avesque de Tholosa (cui Dami-Dieus honor!) / en an dedins la vila receubut per senhor, / a gran profecio, com un emperador. / Del devet los absols, si qu’ieu cugé laor / que aguessan patz faita per totz temps, de bon cor» (Tudèle, 62, 5-9). 70 Acta Sanctorum, Iunii, t. IV, Anversa 1707, pp. 636-66, a p. 636 (D); l’opera agiografica e i viaggi a Liegi di Folchetto sono ben studiati da Lejeune 1979 [1958], che utilizza l’ed. Paris 18673, V (Iunii), pp. 547-72 (cit. a p. 547). Sulla Vita si veda André Vauchez, Prosélytisme et action antihérétique en mileu feminin au XIIIe siècle: la Vie de Marie d’Oignies († 1213) par Jacques de Vitry, «Problèmes d’Histoire du Christianisme», XVII (1987), pp. 95-110; cfr. anche G. G. Merlo, «Militare per Cristo» contro gli eretici [1992], in G. G. M., Contro gli eretici. La coercizione all’ordotossia prima dell’Inquisizione, Bologna, il Mulino 1996, pp. 11-49, alle pp. 21-23. Unde cum sanctus et venerabilis Pater, Ecclesiae Tolosanae Episcopus, a civitate sua ab haereticis depulsus, ad partes Galliae petiturus auxilium contra inimicos fidei devenisset, et tandem usque in Episcopatum Leodii, quasi tractus odore et fama quorumdam Deo in vera humilitate militantium, descendisset. La fama del fervore mistico di Maria d’Oignies e delle beghine pare non essere l’unica motivazione del viaggio: la Lejeune ipotizza che il vescovo, pensando intimamente di avocare a sé il potere politico di Raimondo VI, fosse molto interessato alle istituzioni di un principato ecclesiastico come Liegi 71. A metà marzo 1212 Folchetto è a Narbona dove assiste alla consacrazione ad arcivescovo dell’abate di Cîteaux Arnaud Aumary; il 30 aprile partecipa al concilio provinciale, trattenendosi in città fino al 2 maggio (cfr. GC, XIII, col. 23). Lo si ritrova al fianco di Simon de Monfort durante il Blitzkrieg di SaintAntonin 72 nella notte fra il 20 e il 21 maggio (Cernay, §§ 314-17). In novembre partecipa all’assise di Palmiers convocata dal Monfort (Cernay, §§ 362-66) e concorre all’elaborazione degli Statuti promulgati il 1° dicembre, assai importanti come documento giuridico 73. Non meno importanti i risultati del concilio di Lavaur (14-21 gennaio 1213), cui Folchetto ha parte attiva (Cernay, §§ 368-98): contro le intenzioni di Innocenzo III 74 viene decisa la continuazione della crociata e la spoliazione definitiva di Raimondo VI, il quale aveva tuttavia in Pietro II d’Aragona un potente alleato 75. Compensa le forze il principe Luigi di Francia, che, senza l’avallo del padre, prende la croce in febbraio; Filippo Augusto riunisce il 3 marzo a Parigi un parlamento, cui assiste anche Folchetto, per decidere riguardo l’intervento del figlio (Cernay, § 418). Fra febbraio e giugno, ovvero prima della morte di Maria d’Oignies (23 giugno 1213) cui assiste, effettua un secondo viaggio a Liegi, questa volta con più spiccate finalità di predicazione antieretica, senza tuttavia riuscire a ottenere risultati significativi in termini di adesione alla crociata, certo per la non pienamente ortodossa situazione religiosa del principato 76. Tutt’altro che fallimentari invece i risultati pastorali, fra i quali il concorso nell’insediamento nella città dei dominicani, il cui primo convento viene tuttavia autorizzato dal principe-vescovo Ugo di Pierrepont solo l’11 aprile 1229, in articulo mortis; ma 71 Lejeune 1979 [1958], p. 274, n. 16. «E no cug que aguessatz a lezer un ou coit / que ilh l’agon conquis meïsma sela noit» (Tudèle, 113, 4-5). 73 Si veda in proposito Belperron 1942, pp. 246-51. 74 Cfr. le lettere del 15 gennaio 1213 all’arciv. di Narbona (Potthast, n° 4648, in PL, CCXVI, coll. 744-45) e del 18 gennaio a Simon de Monfort (Potthast, n° 4653, in PL, CCXVI, coll. 741-43). 75 Figlio del «bon rei d’Arago» Alfonso II, tanto celebrato dal trovatore Folchetto ed eroe della cristianità dopo quella vittoria sui mori di Spagna a Las Navas de Tolosa (16 luglio 1212) che lo stesso Folchetto aveva auspicato nella sua canzone di crociata 155,15 (XVIII). 76 Lejeune 1979 [1958], pp. 277-82. 72 Folchetto stesso pare aver ricavato dal confronto con l’esperienza delle beghine una sorta di addolcimento dei suoi metodi 77. In effetti, tornato nel Midi tra luglio e agosto si adopera per ricucire il rapporto con i suoi fedeli (Cernay, § 443), dopo che il 1° giugno lo stesso Innocenzo III gli aveva prescritto di assolvere i tolosani 78: il 1° settembre scrive loro da Fanjeaux, dove aveva seguito Simon de Monfort, per ottenere la riconciliazione, ripetendo il gesto nove giorni dopo. Intanto raggiunge Saverdun col Monfort (11 settembre), e di qui Muret, dove tratta vanamente con Pietro II e i tolosani pronti ad uno scontro che li vedeva sicuri vincitori (Puylaurens, cap. XX). Il giorno della battaglia benedice i crociati: Dum igitur comes et milites nostri mutuo loquerentur et de bello tractarent, ecce episcopus Tolosanus advenit, habens mitram in capite, in manibus vero vivifice lignum crucis; mox nostri ceperunt descendere de equis et singuli crucem adorare. Episcopus autem Convenarum, vir mire sanctitatis, videns quod in ista adoratione crucis a singulis nimia fieret mora, arripiens de manu Tolosani episcopi lignum crucis ascendensque in locum eminentiorem, signavit omnes, dicens: «Ite in nomine Jhesu Christi! Et ego vobis testis sum et in die Judicii fidejussor existo quod quicumque in isto glorioso occubuerit bello absque ulla purgatorii pena statim eterna premia et martyrii gloriam consequetur, dummodo contritus sit et confessus vel saltem firmum habeat propositum quod, statim perfecto bello, super peccatis de quibus nondum fecit confessionem ostendet se 79 sacerdoti» . Dopo l’inattesa vittoria 80, e la morte di Pietro, si dimostra generoso con i tolosani; nel mese di settembre insiste per ottenere la definitiva riconciliazione che otterrà finalmente il 25 aprile dell’anno successivo (Cernay, § 484). Nel 1214 è nuovamente documentato il rapporto con Domenico: un atto del 25 maggio (MDD, n° 58), definisce il Santo «cappellani de Fanoiovis», titolo concesso da Folchetto forse durante lo stesso mese di maggio: ma il documento, che attesta inoltre la donazione di decime al monastero di Prouille, sarebbe 77 Lo rileva la Lejeune alle pp. 282-83; quanto all’esperienza mistica delle beghine, va notato che la piena ortodossia cattolica di questa fase iniziale scivolerà di lì a pochi anni nell’eresia, certo per il contatto con il movimento degli Spirituali francescani: sull’argomento basti un rimando a R. Manselli, Spirituali e Beghini in Provenza, Roma, Ist. Storico Italiano per il Medioevo 1959. 78 Si veda la lettera citata supra e la nota 54. 79 Cernay, § 461; ovviamente più sintetica la Chanson, 139, 55: «Ab tant Folquets l’avesques los a pres a senhar». 80 Di cui, fra gli altri, Folchetto informerà il papa, con una relazione che Cernay rimaneggia ai §§ 468-83 e che gli editori della cronaca, P. Guébin e E. Lyon, riportano integralmente nelle Annexes, n° 3 (vol. III, pp. 200-205 della loro edizione). falso 81. All’inizio di giugno assiste al matrimonio del primogenito di Simon, Amaury, celebrato da Domenico a Carcassonne 82. L’8 gennaio del 1215 Folchetto partecipa al concilio di Montpellier, che sancisce lo spodestamento da Tolosa di Raimondo VI e di suo figlio in favore di Simon de Monfort (Cernay, §§ 545-49); durante il mese lo si ritrova a Tolosa col Monfort e il principe Luigi (Chanson, lassa 141 e Cernay, § 549). Successivamente, fra gennaio e febbraio, prende possesso del castello Narbonese, dimora del conte di Tolosa, affidatogli dopo il concilio di Montpellier da Pietro di Benevento, cardinale di Santa Maria in Acquiro e legato di Innocenzo III: nel castello riceve dodici consoli tolosani, ostaggi del legato Pietro, e vi stabilisce una guarnigione militare (Cernay, § 549; Puylaurens, cap. XXIII) 83. Il 1215 è un anno cruciale per quello che di lì a poco sarà l’Ordo Praedicatorum: come primo atto Folchetto concede a Domenico un ospizio e i beni ad esso relativi perché vi possa impiantiare una comunità 84; quindi, nel giugno-luglio, nomina ufficialmente Domenico e i suoi compagni predicatori nel suo episcopato, stabilendo compiti e mezzi di sostentamento 85: In nomine Domini nostri Ihesu Christi. – Notum sit omnibus presentibus et futuris quod nos F(ulco), Dei gratia Tolosane sedis minister humilis, ad extirpandam hereticam pravitatem et vitia expellenda et fidei regulam edocendam et homines sanis moribus imbuendos, instituimus predicatores in episcupatu nostro fratrem Dominicum et socios eius, qui in paupertate euuangelica pedites religiose proposuerunt incedere et veritatis euuangelice verbum predicare. 81 Cfr. Vicaire 1987, p. 305, n. 246: solo nel 1221 Folchetto concederà le decime e Prouille; alcune decime di Fanjeaux vennero tuttavia concesse prima del 1215 essendo attestate in un documento dell’8 ottobre 1215 (MDD, n° 65); l’HGL2, VI, p. 645 menziona inoltre la concessione delle decime di tre parrocchie a un amico di Domenico, Jean abate di La Chapelle, prima del 5 luglio 1215, data di morte dell’abate. 82 Vicaire 1987, p. 273, che per la partecipazione di Folchetto rimanda a A. Rhein, La seigneurie de Monfort. Catalougue des actes, «Mémoire de la société archéologique de Rambouillet» XXI (1910), pp. 124-246, n° 122; cfr. Cernay, §§ 509-12. 83 Vicaire 1987 commenta: «Il problema politico della capitale era provvisoriamente risolto: ma il problema pastorale? Possiamo pensare che il legato abbia anche indotto Folco e Domenico a trasferire in Tolosa quella Predicazione da loro stessi appena ricostituita a Fanjeaux grazie all’appoggio del Monfort» (p. 308): l’argomentazione prosegue alle pp. 30810. La vicenda dell’estate 1215, raccontata aneddoticamente da Puylaurens, cap. XXIII, del rifiuto opposto al miles Raimond de Ricaud «petentem ab eo domum Hospitalis quod dicitur Mainaderie» (cfr. la n. 5 a p. 91 dell’ed. della cronaca), documenta peraltro il pieno reinserimento del vescovo nelle proprie funzioni. 84 Vicaire 1987, pp. 311-13, che data i documenti di donazione a inizio estate e «con ogni probabilità» allo stesso giorno dell’atto di cui alla nota seguente (cfr. in partic. p. 311, n. 23). 85 MDD, n° 63 e cfr. Vicaire 1987, pp. 319-29, che giudica particolarmente audace l’atto di Folchetto, in quanto la predicazione era stata sino a quel momento appannaggio dei vescovi: si veda anche p. 359; lo studioso nota inoltre a p. 322 che il programma riprende sino al calco la già citata lettera (cfr. supra n. 61) del 10 marzo 1208 con cui Innocenzo III indice la crociata: «...ad expugnandam haereticam pravitatem ac fidem catholicam confirmandam, extirpando vitia et seminando virtutes...» (PL, CCXV, col. 1356). I primi domenicani parteciparono, durante l’estate, ai corsi di teologia tenuti da Alexandre Stavensby nella scuola organizzata da Folchetto nella cattedrale di Saint-Étienne, secondo le prescrizioni del III concilio ecumenico lateranense del 1179 86: la scuola rappresenta il primo passo verso la fondazione dell’Università che sarà creata, come si vedrà, nel 1229 col concorso e per impulso del vescovo, al fine di contrastare l’eresia anche sul piano culturale. L’Ordine Domenicano necessitava tuttavia dell’approvazione papale: allo scopo di ottenerla Folchetto accompagna all’inizio di settembre Domenico a Roma 87, dove era stato convocato il grande IV concilio ecumenico lateranense: nei primi giorni del mese successivo (cfr. bolla pontificia dell’8 ottobre in MDD, n° 65) i due vengono ricevuti dal pontefice al quale chiedono la conferma ufficiale dell’Ordine e dei suoi beni materiali 88. L’11 novembre si apre il concilio lateranense: qui, secondo la II parte della Chanson de la croisade albigeoise, fonte unica dell’evento, Folchetto si scontra con Raimon Roger, conte di Foix e rappresentante di Raimondo VI, rinfacciandogli l’eterodossia di sua sorella Esclarmonde (Chanson, 145, 5-25); il conte avrebbe risposto con estrema durezza 89: E dic vos del avesque, que tant n’es afortitz Qu’en la sua semblansa es Dieus e nos trazitz, Que ab cansos messongeiras e ab motz coladitz, Dont totz hom es perdutz qui·ls canta ni los ditz, Ez ab sos reproverbis afilatz e forbitz, Ez ab los nostres dos, don fo enjotglaritz, Ez ab mala doctrina es tant fort enriquitz C’om non auza ren diire [sic] a so qu’el contraditz. Pero cant el fo abas ni monges revestitz, En la sua abadia fo si·l lums escurzitz Qu’anc no i ac be ni pauza, tro qu’el ne fo ichitz. E cant fo de Tholosa avesques elegitz, Per trastota la terra es tals focs espanditz Que jamais per nulha aiga no sira escantitz: Que plus de cinq cent melia, que da grans que petitz, I fe perdre las vidas e·ls cors e·ls esperitz. Per la fe qu’ieu vos deg, als seus faitz e als ditz Ez a las captenensa, sembla mielhs Antecritz Que messatges de Roma! 86 Si veda il XVIII canone (COD, p. 196), esplicitamente ripreso dall’XI canone (De magistris scholasticis) del Lateranense IV (COD, p. 216); e cfr. M.-H. Vicaire, L’école du chapitre de la cathédrale et le projet d’extension de la théologie parisienne à Toulouse (1072-1217), CF, V (1970), pp. 35-77, oltre a Vicaire 1987, p. 333. 87 Cfr. Giordano di Sassonia, Libellus de principiis ordinis praedicatorum, edidit H. Chr. Scheeben, Roma, Istituto storico dominicano - Santa Sabina 1935, n° 40. 88 Su questa fase si veda Vicaire 1987, pp. 354-61; sul concilio Hefele-Leclercq 1913, pp. 1316-98. 89 Chanson, 145, 60-78; al di là delle valutazioni, condizionate dalla già ricordata partigianeria dell’anonimo continuatore di Guillaume de Tudèle, i versi, spesso citati negli studi, sono importantissimi dal punto di vista biografico, costituendo la prima testimonianza della carriera religiosa del trovatore Folchetto. Oltre a spodestare e diseredare definitivamente Raimondo VI in favore di Simon de Monfort, i cui diritti Folchetto avrebbe sostenuto rivolgendosi direttamente a Innocenzo (Chanson, 148, 1-31), così da meritarsi la definizione di razonaire del conte di Leicester (Chanson, 150, 7-8), il concilio offre a Domenico la promessa di una prossima conferma dell’Ordine 90. Nel gennaio 1216 Folchetto e Domenico lasciano Roma, e in febbraio sono a Narbona (Cernay, § 573 e cfr. ed., p. 264, n. 2): il vescovo si trattiene a causa del contrasto che oppone l’arcivescovo Arnaud Amaury al Monfort 91, mentre Domenico riparte per Prouille. Si ritrovano a Tolosa in marzo, allorché Simon de Monfort prende possesso della città ricevendo il 7 il giuramento dei magistrati e della popolazione, e prestando il proprio il giorno dopo, alla presenza di Folchetto e di altri prelati 92. Intorno alla metà del mese il vescovo accompagna in Francia Simon de Monfort, che si accinge a rendere omaggio feudale a Filippo Augusto (Cernay, § 573): il 30 aprile i due sono a Parigi (Cernay, § 574). Tornato a Tolosa in giugno, Folchetto concede la cappella Saint-Romain a Domenico e ai suoi Predicatori (MDD, n° 73). Nella sua attività politico-pastorale ritorna presto il momento militare: il 19 luglio dello stesso 1216 partecipa all’assedio tenuto a Beucaire da Simon de Monfort 93; quindi, tornato nella sua città, cerca di mediare fra i tolosani ribelli e il nuovo signore 94. All’inizio di settembre prende parte al consiglio tenuto da Simon «en la tor antiqua», senza dubbio il Castello Narbonese di Tolosa (cfr. Chanson, 179, 13 sgg.), facendo in modo che i tolosani ribelli vengano condannati al solo pagamento di 30.000 marchi d’argento, cifra comunque enorme 95. In ottobre il vescovo concede al capitolo di Saint-Étienne le sei chiese restituite nel mese precedente dal Monfort alla diocesi tolosana (cfr. GC, XIII, col. 77) e ne elargisce altre due a Domenico 96. Fra ottobre e novembre chiede al papa il permesso di rimettere la propria carica o almeno di poter suddividere il suo troppo vasto episcopato (cfr. GC, XIII, coll. 23-24), proposte che Onorio III rifiuta il 28 gennaio dell’anno successivo 97; sette giorni prima era invece venuto l’atteso riconoscimento dell’Ordo di Domenico, da novembre a Roma per 90 Le disposizioni X-XIII e XXVII sono riprodotte in MDD, n° 67; e cfr. Vicaire 1987, pp. 369-73. 91 Cfr. HGL, V, pp. 253-56 (naturalmente sostiene il Monfort, come risulta a p. 254). 92 Cernay, § 573 e n. 2; cfr. Vicaire 1987, p. 374 per la presenza di Domenico. 93 Folchetto è uno dei testi di un atto emanato a Beucaire il 19 luglio da Simon de Monfort che si può leggere nell’HGL2, VIII, col. 688, n° 189. 94 Cernay, § 585 e Chanson, 172, 27 sgg.; 173, 64-5; 175, 1 sgg.; 176, 1 sgg. e 74 sgg.; 177, 49 sgg. 95 I fatti, raccontati da Puylaurens, cap. XXVII sono modificati dalla Chanson (lasse 17179) che propone un ruolo decisamente negativo di Folchetto (cfr. Stroński, pp. 94*-95*). 96 MDD, ni 74-76 e cfr. Vicaire 1987, pp. 396-97. 97 Lo attesta una bolla pubblicata da C. A. Horoy, Honorii IIIi opera omnia, II, Paris 1879, p. 179, n° 219; e cfr. Vicaire 1987, pp. 397 e 413, per il quale Domenico era a fianco del papa mentre questi redigeva la lettera. sollecitarlo: nell’indirizzare la bolla del 21 gennaio 1217 ai seguaci di Domenico, il papa stesso corresse con praedicatoribus il generico praedicantibus, autorizzando così implicitamente l’Ordine 98. Nel luglio-agosto viene la decisione di Domenico di trasformare la Predicazione di Tolosa in ordine universale, cosicché da quel momento in poi dei rapporti col vescovo non restano che un paio di attestazioni documentarie, concernenti decime concesse ai frati 99. Intanto la situazione politico-militare del Midi, e di Tolosa in particolare, si era aggravata: il 13 settembre 1217 Raimondo VI era riuscito a rientrare in città (Puylaurens, cap. XXVIII e Chanson, lasse 181-82), provocando la reazione del Monfort: mentre questi cavalca contro Tolosa, Folchetto cerca di salvaguardare il diritto d’asilo in chiesa per i Tolosani (Chanson, 186, 105-6). Lo ritroviamo nel campo del conte durante il secondo assedio di Tolosa, protagonista attivo dei consigli 100: in ottobre riceve l’incarico di predicare in Francia e di richiedere l’aiuto di Filippo Augusto (Puylaurens, cap. XXVIII e Chanson, 194, 28 e 42 sgg.); ritornerà nel Midi nel maggio 1218, a sette mesi dall’inizio dell’assedio (Cernay, § 606B), con un contingente di crociati francesi (Chanson, 196, 36 sgg.). «L’avesque felon», che non manca di partecipare ai consigli tenuti dal Monfort (Chanson, 200 e 202, 55), riceve, il 25 giugno, il corpo senza vita del conte (Chanson, 205, 143-44): ne tesserà le lodi il giorno successivo nel consiglio tenuto al Castello Narbonese (Chanson, 206, 33 sgg.). In luglio i crociati deliberano di levare l’assedio (Cernay, § 614): Folchetto esprime il suo disappunto davanti al consiglio che prende la decisione (Chanson, 207, 113); il 25 del mese segue i crociati e il vescovo Amaury a Carcassonne dove viene seppellito Simon de Monfort (Chanson, 207, 129-32 e 208, 1 sgg.): è qui che il cardinale Bertand di Saints-Jean-et-Paul, legato di Onorio III, gli chiede di tornare in Francia a sollecitare aiuti 101. Nel 1219 il vescovo riprende l’attività pastorale: in agosto consacra l’abbazia cistercense Sainte-Marie de Chaalis nella diocesi di Senlis e a metà settembre partecipa al capitolo generale di Cîteaux; infine, il 19 febbraio 1221 viene incaricato di riformare il monastero di Saint-Pierre de Lamanarre, nella diocesi di Toulon 102. Il 6 luglio 1223 partecipa al concilio di Sens; il 15 luglio è a Parigi dove assiste alle esequie di Filippo Augusto in Saint-Denis e il 6 agosto 98 Documento edito in MDD, n° 79; la correzione è illustrata da Koudelka nella prima delle Notes sur le cartulaire de S. Dominique, AFP, XXVIII (1958), pp. 92-114, alle pp. 92100 (cfr. MDD, Notes, I, pp. 95-100 e II, p. 98); si veda anche Vicaire 1987, pp. 406-13 e in partic. le pp. 409-10 e la n. 49. 99 Si vedano i documenti in MDD, n° 83 (Castelnaudary, 11 settembre 1217) e MDD, n° 153 (Roma, 17 aprile 1221). Il 6 agosto dello stesso 1221 Domenico muore: le sue ultime settimane di vita sono trattate da Vicaire 1987, pp. 638-46. 100 Cernay, § 602 sgg. e Chanson, 188, 1 sgg.; 190, 1 sgg.; 192, 41 sgg. 101 Chanson, 208, 32 sgg. (risposta affermativa da v. 61); la partenza avverrà poi in agosto. 102 Cfr. GC, XIII, col. 24, che aggiunge: «Occurrit anno 1222 in charta Bernardi comitis Convenarum pro abbatia Fuliensi». partecipa a Reims alla consacrazione di Luigi VIII, il re che segnerà col suo intervento una svolta decisiva nella crociata. Nel 1225 consacra un altare nell’abbazia Saint-Thierry di Reims (cfr. GC, XIII, col. 24) e il 30 novembre partecipa, insieme con tutti i prelati delle Gallie, al concilio di Bourges che doveva decidere se confermare i diritti sulla signoria di Tolosa allo scomunicato Raimondo VII o a Aumary de Monfort, ovvero a Luigi VIII, cui il figlio di Simon aveva ceduto tutti i suoi diritti nel febbraio 1224. A Palmiers, all’inizio di ottobre dell’anno successivo, presta giuramento di fedeltà a Luigi VIII, facendosi ricordare dal re per la sua generosità 103. Ritroviamo il vescovo nel marzo 1227 al concilio provinciale di Narbona, indetto fra l’altro per prendere misure contro eretici ed ebrei, accusati questi ultimi di praticare l’usura 104; infine, in due atti del mese di settembre (cfr. GC, XIII, col. 24), in cui conferma al monastero di Prouille il possesso della chiesa di Fanjeaux e all’abbazia cistercense di Boulbonne il possesso della chiesa di Tramezaygues. Il 1227 è l’anno in cui Folchetto ritorna sul campo di battaglia: partecipa con i francesi all’assedio di Labécède-Lauragais, dove si fa ricordare per aver fatto scampare alla morte le donne e i bambini della città capitolata. Nell’aprile del 1228 è a Lavilledieu-du-Temple mentre i crociati assediano Castelsarrasin. Ha poi l’occasione di esercitare ancora le sue doti di mediatore, ottenendo clemenza per i dodici giovani che avevano ordito un complotto per liberare Raimondo VII; poi, fra luglio e settembre, assiste alle distruzioni provocate dai crociati intorno a Tolosa. Dal gennaio al marzo 1229 prende parte al concilio di Meaux che deve decidere del destino di Raimondo VII e il 12 aprile è a Parigi dove il trattato viene ratificato e Raimondo, dopo una flagellazione pubblica, si riconcilia con la Chiesa. Diretta conseguenza del trattato di Parigi è la fondazione, probabilmente in maggio, dell’Università di Tolosa: una clausola prevedeva infatti l’obbligo per Raimondo VII di pagare gli stipendi ai professori 105: decisivo per l’organizzazione il ruolo di Folchetto. Nella città, riconciliatasi con la Chiesa in luglio, si svolge durante il mese di novembre un importante concilio che segna l’inizio dell’azione collettiva dei vescovi linguadociani nella lotta antiereticale e detta in ben 17 canoni le norme 103 «Transeunte quippe rege versus Apamiam cum legato, non erat immemor largitatis episcopus, panis et vini et carnalagii mittens exenia copiosa, postquam intrassent dyocesim Tholosanam. Erat quippe pro sue bonitatis fama et laboris quem pro fide sustinuerat omnibus reverendus» (Puylaurens, cap. XXXIV). Inoltre si legge in GC, XIII, col. 24: «Conventui Appamiensi adstitit anno 1226, et de suo quandiu rex in ipsius diocesi remansit, impensam fecit». 104 Cfr. Hefele-Leclercq 1913, pp. 1452-54; salvo avviso contrario, ricavo da Puylaurens, capp. XXXV-XXXVIII tutte le notizie riferite agli anni 1227-1229. 105 Cfr. Y. Dossat, L’université de Toulouse, Raymond VII, les Capitouls et le roi, CF, V (1970), pp. 58-91 (ma si veda tutto il fascicolo dedicato a Les Universités du Languedoc au XIIIe siècle). Ampie referenze bibliografiche sull’ateneo sono in S. Guenée, Bibliographie de l’Histoire des Universités françaises des Origines à la Révolution, tome II, Paris, Piccard 1978, pp. 423-56 (precedute da un sintetico profilo storico alle pp. 419-23); cfr. anche Histoire des universités en France, sous la direction de J. Verger, Toulouse, Privat 1986, pp. 46-48 (bibliogr. alle pp. 49-50). minuziose per il ristabilimento dell’Inquisizione 106. In dicembre partecipa al concilio d’Orange, diretto dal legato pontificio, col quale il giorno 29 si trova al castello di Mornas. Rientra a Tolosa nel gennaio del 1230, dove rende pubbliche le decisioni del legato sugli eretici. In luglio rimprovera a Raimondo VII di non garantire la regolare percezione delle decime e si dichiara pronto a un nuovo esilio (Puylaurens, cap. XXXVIII). Lo stesso Guillaume de Puylaurens ci dà un quadro delle sue ultime attività nell’anno della morte, il 1231: è costretto a transigere sul possesso del castello di Verfeil, che gli era stato donato da Simon de Monfort il 4 giugno 1214 e il cui possesso gli era stato confermato nel 1229; riceve l’approvazione di Raimondo VII per Fanjeaux; mette ordine negli affari della chiesa resuscitando un «episcopatum quasi olim mortuum» 107. Finalmente, dopo aver fatto delle donazioni al capitolo della cattedrale il 22 dicembre, muore a Tolosa il giorno di Natale (Puylaurens, cap. XXXIX) 108, e viene sepolto nell’abazia cistercense di Grandselve (Puylaurens, cap. XL) accanto a Guglielmo VIII di Montpellier 109. È del 3 gennaio 1232 l’inventario dei suoi vestimenti e degli ornamenti ecclesiastici. Al suo posto, il 20 marzo 1232, viene eletto Raymond du Fauga (o de Falgar) 110, priore provinciale dell’ordine domenicano, segno di un rapporto con 106 Cfr. Hefele-Leclercq 1913, pp. 1494-501: vengono in sostanza riprese e ampliate le indicazioni del III canone (De haereticos) del IV concilio lateranense (COD, p. 209). Ma il vero atto d’inizio dell’Inquizione, in Francia e in primo luogo a Tolosa, va posposto all’aprile 1233: basti un rimando a Y. Dossat, Les crises de l’Inquisition toulousaine au XIII e siècle (1233-1273), Bordeaux, Brière 1959, pp. 105-31 e a Douais 1900 (in partic. pp. XLVI-XLVII sul concilio tolosano e pp. LXXIV-LXXVI sull’azione antieretica di Folchetto). 107 Lotta all’usura e rigore nella riscossione delle decime le sue armi, con cui pone le basi per lo sviluppo finanziario dell’episcopato: a fine Duecento Tolosa, con una rendita doppia rispetto a quella di Narbona, sarà la diocesi più ricca del Midi: cfr. J.-L. Biget, Recherches sur le financement des cathédrales du Midi au XIII e siècle, CF, IX [1974], pp. 127-64, alle pp. 152-53. Ha così la possibilità di ricostruire la cattedrale di Saint-Etienne, il cui cantiere, già partito tra 1214 e 1216, risulta ancora attivo durante il secondo assedio di Tolosa (BigetPradalier 1986, pp. 352-53); a lavori conclusi (intorno al 1240) il risultato è notevole: essa «constitue le prototype du gothique méridional. [...] Sa nouveauté la plus grande réside dans l’application de la rigueur architecturale et de la sobriété décorative à un parti spécifique, celui de la nef unique hérité de l’époque romane» (pp. 353 e 356). Si veda ora Q. Cazes, La cathédrale de Toulouse et son environnement (XII e-XIVe siècle), CF, XXX (1995), pp. 31-59. Per altri avvenimenti degli anni 1227-1231 rimando a Cabau 1986, p. 117; per i rapporti fra il vescovo e l’abbazia cistercense di Boulbonne rimando a HGL2, VIII, col. 1889, n° XL; per le ultime concessioni all’abbazia di Prouille, nel 1230, rimando infine a HGL2, IV, p. 856. 108 Stroński segnala a p. 103* che la notizia è confermata da una cronaca provenzale dei conti di Tolosa (pubblicata, con qualche errore nei RHGF, XIX, p. 235) dove si legge che: «1231. Mori Folquets evesque de Tolosa lo dia de Nadal en dijous». Alcuni indicano il 1232 come anno di morte (per es. Douais 1900, p. LXXIV), ma c’è chi anticipa al 1229, come J.-L. Déjean, Les comtes de Toulouse (1050-1250), Paris, Fayard 19882, p. 361. 109 Essendo andato distrutto il monastero, dobbiamo a Catel 1633, p. 899 la preziosa testimonianza e due frammenti dell’epitaffio funebre: «Fouquet» e «Montpellie(r) per Mossen Guillem»; cfr. HGL, V, pp. 385-86. 110 Su cui Pontal 1985, pp. 185-91. i Predicatori che la morte di Domenico non aveva certo interrotto 111. Allo stesso modo la sua morte non coincide con la fine della crociata; anzi, è nell’anno successivo, che Montségur diviene il rifugio ufficiale della Chiesa catara 112: sarà la sua conquista il vero atto finale, non solo simbolico, di una vicenda nella quale Folchetto, pastore e beato per alcuni, lupo travestito e anticristo per altri, ebbe un ruolo di assoluta centralità. __________________ Fra i numerosi contributi biografici non citati esplicitamente in questo Profilo ricordo, oltre al GRLMA, II, t. I, fasc. 7, pp. 94-99, B. Bolton, Fulk of Toulouse: The Escape that Failed, in «Studies in Church History», XII (1979), pp. 83-93, le schede di Boni 1960, II, pp. 121-24 e Roubaud 1971, pp. 200-201, la voce Folquet de Marseille redatta da C. C[remonesi] e G. B[runel]-L[obrichon] per il Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age, Paris, Fayard 19942, pp. 455-56. Non ho invece potuto consultare J. Laffont, Le Neuvième prieur du Thoronet, Foulque, évêque de Toulouse, Cannes 1948. La scheda del GRLMA dà inoltre notizia di un poema epico di Nikolaus Lenau, Die Albigenser (1842) «évoquant la vie de Folquet» (p. 98). 3.2. Il contesto letterario. Le pagine che seguono non intendono certo affrontare tutti gli aspetti che il titolo del capitolo evoca, né esaurire gli argomenti effettivamente affrontati, ma piuttosto costituire un primo approccio a un’analisi complessiva del canzoniere folchettiano. Mi limito pertanto quasi soltanto a un censimento delle questioni che pone la poesia di Folchetto, in merito a quattro àmbiti fondamentali: i rapporti personali e/o intertestuali con i trovatori contemporanei, la fortuna in Occitania e nelle aree sottoposte all’influsso della poesia trobadorica, la valutazione critica della produzione folchettiana lungo l’arco dei secoli e le opzioni preliminari per un esame di quella produzione in una prospettiva rinnovata. 3.2.1. Rapporti poetici. § 3.2.1.1. I s e n h a l s . I tre senhals usati da FqMars si ritrovano insieme una volta soltanto, nelle tornadas della canzone rivolta contro Amore 155,21 Sitot me soi a tart apercebutz (VII), 41-44 e 45-48: 111 Nel settembre 1229 assiste alla donazione di Pons de Capdenier, ricchissimo borghese di Tolosa, ai Frati Predicatori; il 9 ottobre introduce i Frati Predicatori nel Jardin des Garrigues: vi celebra una messa, pianta una croce nel terreno in segno di presa di possesso del terreno, delimita il sito della futura chiesa, posa la prima pietra dell’abside, benedice il cimitero dei Frati e fa una predica: il 22 dicembre dell’anno successivo i Domenicani di Tolosa s’installano nel nuovo convento (cfr. GC, XIII, col. 24). 112 Già al concilio lateranense del 1215 Folchetto, nell’accusare il conte di Foix, aveva sostenuto che «e·l pog de Montsegur fo per aital bastiz / qu’el les [scil. gli eretici] pogues defendre, e·ls hi a cossentitz» (Chanson, 145, 11-12). Bels N ’ A z i ma n s , s’Amors vos destregnia, vos ni·N T o z t e mp s , eu vos consellaria: sol vos menbres cant eu n’ai de dolor ni quant de be, ja plus no·us en calria. En P l u s - L e i a l , s’ab los hueilhs vos vezia, aissi com fatz ab lo cor tota-via, so qu’ieu ai dich porri’ aver valor, qu’ieu quier conseilh e conseilh vos daria. Ai tre, evidentemente dei poeti, «Folquet chiede, e insieme offre consiglio» 113: ed è proprio partendo dalle risposte che il trovatore riceve che è possibile proporre delle identificazioni pressoché certe 114. § 3.2.1.1.1. P l u s - L e i a l . È Pons de Chapduelh, il quale risponde alle sollecitazioni di FqMars nella tornada di 375,20 Si com sellui c’a pro de valledors (XII), 41-44, indirizzata a sua volta a un Plus-Leial: Mon Plus-Lejal, s’ieu vos vis plus soven, miels m’anera mi e vos eissamen; qu’eu saubra vos conseillar e vos me, pero negus non sap a sos ops re. Il legame con la tornada folchettiana, nella quale si registra l’unica menzione del senhal e con la quale questa di Pons condivide la «pur più scettica, richiestaofferta di consiglio» 115, è evidente: l’uso del senhal reciproco, fatto notare da Stroński alle pp. 37*-39* della sua edizione 116, è poi la prova decisiva. PoChapt utilizza il senhal anche nella II tornada di 375,19 S’ieu fis ni dis nuilla saisso 113 Meneghetti 1992, p. 99: il volume si segnala, fra gli altri meriti, per le importanti integrazioni a questa questione. 114 Nella seconda tornada di FqMars 155,17 (XVI), testo di attribuzione dubbia, e non sicuramente spurio come vorrebbe Stroński (vd. supra § 1.2.7), compare anche il senhal Bella-Guarda di cui non si conosce il referente reale (l’ipotesi di Aston 1953, p. 180: «BellaGuarda = Marqueza de Polinac?» è del tutto arbitraria): Stroński nota a p. 128* che lo si ritrova in ArnMar 30,16 (I), ma solo nei mss. PUc: la maggior parte dei testimoni legge BelsEsgars (Jonhston 1935, non dà informazioni sull’identità e così Chambers 1971, p. 119); ma va tenuto conto che la tornada è tràdita da due soli mss. (DaG) che attribuiscono il testo a Peirol, oltre ad essere caratterizzati da molte lectiones singulares (cfr. la n. 43-46 del Commento all’edizione e supra il § 1.2.7). Non è invece un senhal, come riteneva Pratsch 1878, p. 46, ma nome proprio Na Ponssa: è la dama cui viene dedicata la canz. FqMars 155,11 (XIII) e non è stata identificata, sebbene Stroński abbia notato (cfr. p. 17*, n. 1) che il nome fu portato dai signori di Trets, città verso cui il trovatore invia un’altra canzone (cfr. Nota al testo di FqMars 155,5 [I]). 115 Meneghetti 1992, p. 100. 116 In séguito alle drastiche obiezioni Lewent 1911, coll. 328-30 l’editore è tornato sull’argomento in Stroński 1913, pp. 288-97, confermando quanto aveva sostenuto in precedenza. (VIII), almeno nella ricostruzione proposta da Stroński per una canzone a suo parere «mal publiée» da Napolski 117: D’En Plus-Leial, ves on q’el sia, pert sa coindans’ e sa paria e prec Deu qe mal los estre, totz cels q’an loignat mi ni se. Val la pena di citare integralmente l’elegante commento dell’editore: «Cet envoi exprime, croyons-nous, les sentiments de Pons de Chapdueil à la nouvelle que son ami, Folquet, s’enferma dans un monastère. Il parle de lui, mais il ne s’adresse plus à lui, car Folquet n’est plus du siècle. D’autre part, par ces paroles: “où qu’il soit”, Pons marque bien qu’il ne parle pas d’un ami défunt. Et comme le brave châtelain auvergnat n’a jamais été un ami de l’Eglise, ayant eu pendant toute sa vie maille à partir avec le clergé, il parle sans respect de ceux qui l’ont séparé de son Plus-Leial» (pp. 59*-60*). § 3.2.1.1.2. T o s t e m p s . È Raimon de Miraval: la dimostrazione definitiva si deve a Meneghetti 1992, pp. 100-101 che ha identificato la risposta alla tornada folchettiana nella canzone 406,21 Chansoneta farai, vencut (VIII), il cui tema appare alla studiosa: una sorta di contrappunto giocoso al tema proposto: alle sospirose richieste di pietà di Pons e alla risoluta intenzione di Folquet di abbandonare un servizio d’amore mal ricompensato, Raimon oppone una semiseria mala canso contro una dama che lo ha tradito con un altro per denaro. Così, dopo aver affermato di poter già sperare nella prospettiva di un nuovo amore più soddisfacente («Autra n’am ieu que mais mi guazardona», v. 13), Raimon propone scherzosamente a Folquet di metter fine ai suoi patimenti, divertendosi con la propria ex-innamorata, sensibile solo ai doni: Chanso, vai t’en a mon Plus Lial rendre, e diguas li qu’ieu sai dona a vendre. Anche qui un senhal reciproco, sia pure ‘indiretto’ 118, e quale «ulteriore prova» la presenza al v. 50 di un’espressione come «dona a vendre», che ne ricorda una analoga in un’altra mala canso folchettiana, 155,10 (XII), coinvolta peraltro in altri dibattiti (cfr. infra §§ 3.2.1.2.4 e 3.2.2.1.1). E tanto basta a svelare l’identità del Tostemps cui FqMars si rivolge nelle tornadas di otto 117 Nella cui edizione si legge nella forma: «De N’Odiart, ves on que sia, / voill s’acoindans’ e sa paria, / c’ab rics fatz enans’ e mante / tot so q’a valen prez cove»: rimando per l’argomentazione ecdotica di Stroński alla lunga nota fra le pp. 58*-60*. 118 Diversa l’interpretazione di Stroński: «Raimon de Miraval ne pouvait pas se servir du sobriquet Plus-Leial sans aucun rapport avec le même sobriquet réciproque de Pons et de Folquet: il donne certainement ce nom à l’un d’eux, naturellement plutôt à Pons de Chapdueil, pour lequel ce pseudonyme paraît avoir été inventé, qu’à Folquet de Marseille» (p. 39*, n. 1). Tuttavia l’editore, che «à défaut d’indices nets et décisifs» (p. 41*) rinuncia a identificare Tostemps, azzarda in nota l’ipotesi che sia RmMir, notando fra l’altro che il senhal testimonia comunque rapporti indiretti fra questi e FqMars. poesie 119, sempre in coppia con Azimans 120, e col quale tenzona nel partimen 155,24 (XXIV). Cosicché si può tranquillamente rinunciare, dando ragione a Cropp 1980, p. 93, alle considerazioni di Topsfield 1971, pp. 31-32 sulla predilezione di RmMir per l’avverbio tostemps. § 3.2.1.1.3. A z i m a n s . È Bertran de Born, l’unico a non rispondere alla richiesta di consiglio della tornada di FqMars 155,21 (VII) 121: l’identificazione passa anche questa volta attraverso un senhal reciproco: Stroński (cfr. pp. 39*41*) lo rintraccia nella tornada di BtBorn 80,12 Dompna, puois de mi no·us cal (VII), 71-74 122: Papiol, mon Aziman m’anaras dir en chantan c’Amors es desconoguda sai, e d’aut bas cazeguda. Per i due poeti si potrebbe parlare di vero e proprio sodalizio, come dimostra peraltro il frequente invio di testi poetici da parte di Folchetto al suo ‘magnete’ 123: d’altronde BtBorn frequentò la corte marsigliese di Barral ed ebbe, come in tono minore ebbe anche Folchetto, un leggendario rapporto con Riccardo Cuor di Leone; li divise il giudizio su Alfonso II d’Aragona, ma si ritrovarono insieme a metà degli anni ’90 del XII sec. nella scelta di abbandonare il secolo per entrare nell’ordine cistercense. Secondo Stroński fu Folchetto a maturare primo la decisione e a chiedere all’amico di seguirlo: lo si ricaverebbe dalla II tornada della canzone di crociata FqMars 155,15 (XVIII), scritta dopo la sconfitta cristiana ad Alarcos nell’estate del 1195 (vd. vv. 62-68). Rischia invece di restare una suggestione il legame istituito da Stroński fra i vv. 16-22 di questa canzone di crociata e la prima tornada di una poesia intessuta di elementi religiosi 9,19 Quan mi perpens ni m’albire, che l’editore toglie a AimBel, cui le rubriche l’assegnano, per attribuirla proprio a BtBorn 124: 119 Ossia: FqMars 155,14 (IV); 155,1 (V); 155,3 (VI); 155,21 (VII); 155,16 (VIII); 155,10 (XII); 155,11 (XIII); 155,7 (XIV). 120 La coppia di senhals è tanto tipica che la si ritrova anche nella tornada spuria di Perd 370,9 (I): cfr. supra § 1.2.5. 121 Almeno non direttamente, perché – lo nota Meneghetti 1992, p. 101, n. 104 – nel sirventese BtBorn 80,5 (XXXVI) il signore di Autafort riprende schema metrico, rime e qualche contenuto proprio dalla risposta di RmMir a FqMars. 122 Cito dall’edizione di Beltrami 1996 al cui commento rimando; sul senhal rileva che «la dedica ad un trovatore così versato nell’elaborazione retorica del discorso amoroso converrebbe bene al carattere di questa poesia» (p. 107); si veda ora sull’uso dei senhal, P. G. Beltrami, Per una storia trovatori: una discussione, ZfSL, CVIII (1988), pp. 27-50, alle pp. 40-41. 123 Ai testi già citati a proposito di Tostemps si aggiungano 155,5 (I); 155,18 (III); 155,23 (IX); 155,8 (XI); 155,15 (XVIII); per una possibile allusione di FqMars a BtBorn 80,15 (VI) si veda il Commento a FqMars 155,18 (III), 55-57. 124 Cito da Poli 1997, p. 389 (n° XVIII) che contesta l’attribuzione, peraltro assai fortunata, di Stroński (cfr. pp. 55*-58*, e poi Stroński 1913, p. 288, n. 2), per confermare il Folquet, si ses contradire crezetz so que·us auçi dire, no m’agra fag paor morz. Mas a sel en soi grazire qui per nostra mort ausire deignet esser en croç morz. Un’allusione diretta, dunque, quasi uno scoprire le carte a gioco finito, a uno scambio che, scrive Stroński, «nous revèl[e] un des moments les plus intéressants de l’histoire des troubadours» (p. 58*). § 3.2.1.2. L ’ i n t e r t e s t u a l i t à . Altri e rilevanti sono i rapporti e gli scenari che si possono, sempre sommariamente, indicare; nel rilevare in più d’un caso intenti polemici, talora accompagnati da accenti di esplicita oscenità, andrà sottolineato il carattere eminentemente ‘giocoso’ delle operazioni descritte, del tutto scevre (il caso di PVid lo dimostra) da questioni personali. § 3.2.1.2.1. I l M o n a c o d i M o n t a u d o n . FqMars è uno dei trovatori rappresentati nella cosiddetta ‘galleria satirica’ del MoMont 305,16 Pos Peire d’Alvernh’a cantat (XVIII), 73-78: E lo dotzes sera Folquetz de Marcelha, us mercadairetz, et a fag un folh sagramen quan juret que canso no fetz, ans dizon ben que fo per vetz, que·s perjuret son escien. Questa l’ed. Routledge; tuttavia Stroński ritiene che la versione originaria sia quella conservata dal ms. M: ne trascrivo il testo (c. 146vb): El doçen apellom folco. de marseilh un mercadairo. que fes un maluatz sagramen. qe non feçes uers ni canço. e di hom qe per auer fo. e periuret sazescien. Di questa versione l’editore propone (a p. 49*) una ricostruzione critica, in base a una serie di osservazioni ecdotiche contestate da Routledge 1977, pp. 163-65, ma parzialmente rivalutate da Asperti 1990, p. 18, n. 6 (e cfr. ora Asperti 1995, p. 53, n. 38): E·l dozen apell’om Folco de Marseill’, un mercadairo, dato delle rubriche, aimeric de belenuei in E, willems en aimerics in Da: cfr. Poli 1997, pp. 389-92. L’attribuzione a BtBorn era stata precedentemente accettata da Dumitrescu 1935, pp. 30-32 e dagli editori di BtBorn fino a Gouiran 1985, II, p. 799 sgg. (testo n° XLIII). Segnalo comunque che la II tornada di AimBel 9,19 è correlata da Stroński con i vv. 56-59 di FqMars 155,20 (XXI), mentre i vv. 1-5: «Quan mi perpens ni m’arbire / qui soi ni de qual part venh / meravill me molt e·m senh / com Dieus volc esser suffrire / tan longuamen dels mieus tortz» e i vv. 21-25: «e donx ricx per que si fenh? / es ricx? ans n’es trop a dire, / quar tant es freols l’esforz / lo iorn c’om passa los portz / on tug van ses contradire» sono connessi proprio alla tornada di FqMars 155,15 (XVIII), inviata come s’è visto ad Aziman. que a fait un fol sagramen quan juret que no fes chanso, et anz diz om, que per ver fo, que·s perjuret son escien. Al di là del problema filologico, quel che importa in questa sede è la replica che Folchetto avrebbe opposto al Monaco, nella II tornada di 155,11 (XIII), 4145: questa canzone, con cui avrebbe termine, secondo Stroński, la produzione amorosa del trovatore, segnerebbe, dopo tre liriche scritte contro Amore, «un retour sous de joug de l’Amour»; prosegue l’editore: «Folquet qui tenait à éviter tout reproche, comme le montre le début de cette chanson, sentait certainement qu’elle faisait penser à l’accusation du Moine, et il se décida à y répondre, au moins par une riposte vigoureuse à défaut d’arguments précis» (p. 52*). Per di più, è proprio dalla prima delle tre malas chansos, FqMars 155,21 (VII), che il Monaco ha ricavato l’immagine centrale del suo ironico rimbrotto: si ricordino i vv. iniziali: «Sitot me soi a tart aperceubuz, / aissi cum cel c’a tot perdut e jura / que mais non joc...» e i vv. 13-14: «mas eu m’en part e segrai altra via, / sos mal pagaz, qu’esters no m’en partria». Una ricostruzione quella di Stroński che non perde di validità se la si spoglia delle implicazioni cronologiche, viziate, come ho già mostrato, da una serie di pregiudizi. § 3.2.1.2.2. P a l a i s e V e r m i l l o n . È significativo che la replica al MoMont sia affidata al giullare Palais: credo infatti che questi vada identificato con il trovatore Palais, autore di cinque o piuttosto sei componimenti, tra i quali la canzone 315,2 Be·m plai lo chantars e·l ris (Ricketts 1986, p. 230), nella quale viene operata la ripresa parodica di FqMars 155,12 (XXIII) 125. Palais è inoltre autore di un estribot, ed è a questo genere, più che alla cobla esparsa, che andrà ricondotta la poesia stilisticamente meno elevata di Folchetto, 155,25 (XXV) 126; in essa il trovatore si lamenta con Vermillon di una «avol pega pemcha» che «s’es vanada et feimcha / q’eu l’appellei Aut-Ram don il s’es aut empencha» (vv. 1, 3-4). Facendosi cogliere in palese contraddizione dal recensore Salverda de Grave 1911, p. 500, Stroński (cfr. pp. 46*-47*), altrove reciso nel negare un referente reale agli amori trobadorici («ne cherchez pas de femme» consiglia, parafrasando Dumas padre), vorrebbe dare uno spessore di realtà alla donna qui oggetto del reclamo, distinguendola dalla dona mendia falsa di RmMirav 406,24 (XIV), 45-48: l’ipotesi ovviamente non è necessaria, come rileva anche Vatteroni 1990, pp. 66-67. Quanto a Vermillon, a tutt’oggi non si può andare oltre le parole dello stesso Stroński: «un personnage inconnu [...] qui pourrait être aussi bien un jongleur qu’un ami du troubadour» (p. 46*) 127. 125 Di tutto ciò mi sono già occupato in Squillacioti 1992, cui per economia rinvio. Ulteriori indicazioni infra nel Commento all’edizione del testo. 127 Oltre a Vermillon e Palais, FqMars affida una canzone, 155,5 (I), all’altrimenti ignoto giullare Marsan: cfr. la Nota al testo del componimento. 126 § 3.2.1.2.3. U n i n t e r p o l a t o r e . All’episodio precedente è stata collegata l’oscena allusione in una delle quattro coblas apocrife del ms. a dell’altra e più antica ‘galleria satirica’, PAuv 323,11 Chantarai d’aquestz trobadors (VIII): oltre che a Peirol, GcFaid e PVid, l’anonimo interpolatore dedica una cobla anche a FqMars: eccone la trascrizione (c. 129): E lai de marseillan folqet. qe chanta de fotre folet. per una butta cui saten. ca plus ample con dun cabes. e forail meils pesqes ab ret. en mar can nô la mouolo uent; la ricostruzione critica di Martín de Riquer 128: E lai de Marseilla·N Folqet qe chanta de fotr’e folet per una brutta cui s’aten c’a plus ample con d’un cabet, e fora·il meils pesqes ab ret en mar can non la movo·l ven. e l’interpretazione di Stroński (pp. 47*-48*): On a profité des deux pièces dont nous venons de parler: du partimen FolquetTotztemps et de la cobla à Vermillon. L’allusion: chanta de fotre est relative à l’attidude de Folquet dans le jeu-parti, et si l’auteur de cette strophe ajoute: e folet c’est qu’il s’empare des traits ironiques dont Folquet est accablé à la fin de partenaire. La caractéristique de la prétendue dame de Folquet (3-4) n’est que la répétition, en d’autres termes, de ce qu’il avait dit, lui même, dans sa “strophe” au sujet de la femme qui se ventait d’avoir été celébrée par lui. § 3.2.1.2.4. P e i r e V i d a l . «Peire Vidal fut le troubadour que Folquet rencontrait le plus souvent sur son chemin et dont les chansons croisaient continuellement les siennes»: così Stroński a p. 52*. Effettivamente entrambi i poeti frequentarono la corte marsigliese di Raimon Jaufre Barral ed ebbero rapporti con Alfonso II d’Aragona e Riccardo Cuor di Leone. È noto, in primo luogo, che PVid invia a FqMars la canzone 364,2 Ajostar e lassar (III), perché la canti in sua vece 129: A mon amic Folco tramet lai ma chanso que la chant en bon loc per me, al tenen on joi vai e ve. Si può aggiungere che questa tornada fa séguito a una cobla, la VI, che si chiude con un’allusione al ripudio dell’emperairitz Eudossia, vicenda che ha coinvolto Folchetto in prima persona: «...mas frairi / fals lauzengier gloto / m’an moguda tenso / e lunhat del Peiro, / e’N Drogomans no m’au ni·m ve, / quar 128 Riquer 1975, I, pp. 340-41 (il testo è più fedele al ms. rispetto alla ricostruzione di Stroński pp. 47*-48*; già portata alla luce da Appel in ZrPh, XIV [1891], pp. 166-67, la cobla si legge anche in Appel 1930, p. 119). 129 La tornada (vv. 91-94) è tràdita dal solo ms. c: per gli invii a tradizione ridotta rimando alla Nota al testo di FqMars 155,8 (XI). mon car Amic part de re» (vv. 85-90), dove En Drogomans è senhal di Guglielmo VIII di Montpellier e Amic è senhal di Eudossia 130. Ma il momento più studiato del rapporto fra i due trovatori è la replica alla mala chanso FqMars 155,10 (XII) di PVid 364,37 Pus tornatz sui em Proenza (XL), una «gaia chanso» (v. 3) peraltro dedicata a Barral 131, protettore di Folchetto: già per Stroński il testo vidaliano «paraît répondre à Folquet» (p. 52*, n. 1); poi Frank 1952, p. 167 conferma il rapporto di dipendenza; al contrario d’A. S. Avalle, in parte forviato dalla datazione del testo folchettiano (1192 ca.) proposta senza fondamento da Stroński, scrive: «Le analogie fra le due canzoni sono indubbiamente notevoli [una in più la nota lo stesso Avalle], ma nulla prova che la canzone del Vidal sia stata scritta dopo e non prima di quella di Folchetto» (1960, II, p. 366) 132: le analisi di Meneghetti 1992 [ma 1984], p. 97 e di Gruber 1983, p. 220-28 hanno invece dimostrato la fondatezza della timida proposta di Stroński. Ripercorro le argomentazioni, a partire dalla considerazione che lo schema metrico di PVid è in sostanza un’innovazione di quello di FqMars: FqMars PVid a7’ b7 b7 a7’ a7’ b7 b7 a7’ a7’ a7’ b7 b7 a7’ c7 d7 d7 c7 c7 a: ensa, b: en a: ensa, b: o, c: ar, d: or [477:1] [627:6] A una prima parte identica, con l’eccezione della rima b che è en in FqMars, o in PVid, corrisponde una seconda parte nella quale PVid introduce nuove rime rispettando però lo schema: a c e b d. Inoltre i rimanti in -ensa di PVid sono tutti presenti in FqMars, eccetto 4 reconoissensa (da confrontare però con 4 desconoissenssa di FqMars) e il rimante dell’incipit «Proensa», che introduce nell’analisi di Gruber 1983, p. 223 un modello comune ai due trovatori, PAuv 323,2 Ab fina ioia comenssa (I) 133. Venendo al livello testuale, Stroński nota che i vv. iniziali delle coblas II e IV di PVid: «E sel que long’atendensa / blasma, fai gran falhizo» (vv. 10-11) 134 e «Ses pechat pris penedensa» (v. 28) alludono e rovesciano i vv. 25-27 di FqMars: «e cill sofran lo tormen / que fan, per folla atendenssa, / anz del pechat penedenssa»; Avalle aggiunge che nella dichiarazione di PVid: «Que ses tota retenensa / sui sieus per vendr’e per dar» 130 131 Le identificazioni sono di Avalle 1960, II, pp. 221-22 e 228-29. Nominato col senhal Rainier: cfr. la vida di PVid in Boutière-Schutz 1964, pp. 356 e 361. 132 E prosegue: «Nel caso che si volesse dar ragione allo Stroński [...] i termini cronologici della nostra canzone si restringerebbero evidentemente al 1192 [perché Barral muore alla fine dell’anno]; se no, com’è più probabile dato che qui non si tratta di una risposta ma di un annuncio o se si vuole di una commemorazione, il termine a quo si sposterebbe a c. 1188-9, data in cui [...] il bacio non gli era stato ancora “donato”». 133 Si vedano i vv. 49-50: «Als comtes mand en Proenssa / lo vers e sai a Narbona»; inoltre, i vv. 33-34: «Ses pechat fis penedenssa / et es tortz qui no·m perdona» sono in chiara relazione con PVid 28-29: «Ses pechat pris penedensa / e ses tort fait quis perdo»; d’altro canto i vv. 9-12 di PAuv: «D’amor ai la sovinenssa / e·ls bels digz: ren plus no·m dona. / Mas per bona atendenssa / esper c’alcus iois m’en veigna» e il già citato v. 33 sono considerati un antecedente dei vv. 26-27 di FqMars. 134 Si noti che la mossa iniziale: «E sel...», è comune alla replica di AimPeg analizzata sotto al § 3.2.2.1.1. (vv. 49-50) si deve ravvisare una replica ai vv. 41-43 di FqMars: «mas voutz es en viltenenssa / vost’ afars et en nien, / c’om vos sol dar, er vos ven». A mia volta segnalo l’inizio della cobla III di PVid: «E quar anc non fis failhensa, / sui en bona sospeisso» (19-20) che allude, in qualche modo rovesciando la situazione, all’incipit folchettiano: «Greu feira nuills hom faillenssa» (e cfr. v. 5: «qu’ieu faill...»); l’inizio della cobla VI di PVid: «E pos en sa mantenensa / aissi del tot m’abando, / ja no·m deu dire de no» (vv. 46-48) che presenta analogie con l’inizio della cobla II di FqMars: «Car en vostra mantenenssa / me mis, Amors, franchamen, / e fora·i mortz veramen / si no fos ma conoissenssa» (vv. 10-13), distinguendosi per l’esito che l’affidarsi alla donna in un caso, ad Amore nell’altro, produce; e, per ribadire la frequenza quasi sistematica delle allusioni all’inizio delle singole coblas, il rimante guirensa in entrambi i testi al primo v. della cobla V. Per concludere va citata per intero la cobla IV di PVid, costruita su una serie di antitesi così tipicamente folchettiane (e quella al v. 34 anche in FqMars 155,5 [I], 22: «qu’arditz sui per paor»), laddove Peire pare prediligere piuttosto l’iterazione sinonimica 135: Ses pechat pris penedensa e ses tort fait quis perdo, e trais de nien gen do et ai d’ira benvolensa e gaug entier de plorar e d’amar doussa sabor, e sui arditz per paor, e sai perden gazanhar e, quan sui vencutz, sobrar. Un altro rapporto testuale fra i due trovatori è menzionato nel Commento a FqMars 155,7 (XIV). § 3.2.1.2.5. R a i m b a u t d e V a q u e i r a s . Nella III cobla di 392,25 No puesc saber per que·m sia destregz (VI), RbVaq nomina un En Folquetz che, dopo l’incertezza di O. Schultz-Gora, che riteneva plausibile anche un’identificazione con FqRom 136, e la scelta in favore di quest’ultimo di Zenker 1896, p. 15, Stroński ha riconosciuto essere il nostro trovatore (cfr. pp. 53*55*): E doncx que·m val lauzenjars ni abetz? Per l’oc reman e per lo non m’esmau; et er m’a far lo conort del bertau, cum selh que ditz en chantan en Folquetz, qu’a Tortona, lai part Aleixandrina, 135 Lo nota senza entusiasmo Avalle 1960, II, p. 365: «Questa canzone [...] non è una delle più franche e sicure del Vidal, tutta intessuta com’è sul tormentato gioco delle antitesi e delle reminescenze letterarie più trite»; cfr. Gruber 1983, pp. 225-26. 136 O. Schultz-Gora, Le epistole del trovatore Rambaldo di Vaqueiras al Marchese Bonifazio I di Monferrato, trad. di G. del Noce con agg. e corr. dell’autore, Firenze, Sansoni 1898, p. 155, n. 2. queyra merce, mas say no truep refuy; et er me grieu si·m part de lieys per bruy: sol o comens, qu’er dans si no s’afina. L’allusione di RbVaq è ai vv. 32-33 della canzone di crociata d’occidente FqMars 155,15 (XVIII): «e ja no·i gart paubreira nuills hom pros: / sol que comens, que Dieus es piatos», come hanno rimarcato F. Lecoy e V. Bertolucci 137 e infine Linskill 1964, p. 124. Questi ritiene inoltre a p. 137 RbVaq 392,17 (VIII), 44: «per qu’ieu soi ricx, quar ieu li soi estortz» una reminiscenza di FqMars 155,16 (VIII) 138. 3.2.2. Fortuna medievale. La scelta di tener distinti aspetti a guardar bene indistinguibili come la fortuna dell’opera folchettiana e la sua interpretazione critica, dipende dal fatto che il termine fortuna, appropriato per il Medioevo e in qualche misura per l’Umanesimo, andrebbe piuttosto mutato nel suo contrario una volta entrati nel recinto dell’erudizione settecentesca e della filologia romanza ottonovecentesca. Vedremo meglio nel § 3.3; per ora occorre sottolineare che i tradizionali giudizi critici sull’artificiosità e convenzionalità della poesia di Folchetto vanno rivisti proprio partendo dal valore di modello che il poeta assume per la generazione trobadorica successiva e per i continuatori di quella esperienza poetica, Siciliani e Dante in modo particolare. § 3.2.2.1. I n O c c i t a n i a . Non si esita a riconoscere in Folchetto uno dei principali fondatori della cosiddetta ‘vulgata cortese’: secondo Di Girolamo 1990, p. 199: sarebbe sbagliato considerare stereotipata o di maniera, come pure è stato fatto, gran parte della sua produzione: in realtà le generazioni trobadoriche anteriori a Folquet conoscevano assai meno stereotipi, a parte un canone formale e retorico sostanzialmente unitario e a parte l’identità di partenza [...] della situazione cortese. 137 F. Lecoy, Notes sur le troubadour Rambaut de Vaqueiras, in Études romanes dédiés a Mario Roques, par ses amis, collègues et éleves de France, Paris, Droz 1946, pp. 23-38, a p. 28, dove vengono superate le obiezioni cronologiche di De Bartholomaeis 1931, p. 32, che aveva inoltre spostato l’allusione su FqMars 155,11 (XIII), 25 sgg.; V. Bertolucci, Posizione e significato del canzoniere di Raimbaut de Vaqueiras nella storia della poesia provenzale, SMV, XI (1963), pp. 9-68, p. 10, n. 2, dove si aggiunge che «A Folquet [155,6 (XVII), 41] rimanda anche senza dubbio un caso di personificazione di Amore (come un dio armato che ferisce di lancia) che si trova nel discordo indirizzato a Engles», cioè in RbVaq 392,16 (XVII), edito ora da P. Canettieri, Il novel descort di Raimbaut de Vaqueiras (BdT 392,16), in Studi provenzali e galeghi, Romanica vulgaria Quaderni 13-14, L’Aquila, Japadre 1994, pp. 41-80. 138 Cfr. la n. 21 del Commento alla canzone; su questi richiami cfr. A. Sakari, L’influence des autres trouvadours sur Raimbaut de Vaqueiras, in Atti Vitoria-Gasteiz 1994, I, pp. 297306, alle pp. 301-302. Sono proprio le indubbie capacità nella costruzione dei testi che consentono a FqMars, attraverso l’abile tessitura retorica che avvolge elementi ricavati da esperienze poetiche anteriori (tra cui spicca quella dell’inimitabile BnVent) di offrire un modello pienamente imitabile ai poeti del XIII secolo 139. § 3.2.2.1.1. A i m e r i c d e P e g u i l h a n . In un caso, tuttavia, c’è nella ripresa un netto intento polemico. AimPeg, nel cui canzoniere lirico Mancini 1991 ha ravvisato una «tenace, esibita difesa del servizio d’amore, come attesa di felicità, come occasione e aizi, senza oscillazioni e senza palinodie» (p. 219), muta a tratti la difesa in offesa con accuse che «sembrano rimandare piuttosto a una vivace polemica tra scuole, poetiche, comportamenti contrapposti e rivali» (p. 221). Folchetto è uno dei bersagli: nella canzone 10,40 Per razo natural (XL), 21-30 AimPeg replica scopertamente alla IV cobla di 155,10 (XII) 140: E selh que ditz aital qu’elh avia crezensa que selh que mal comensa fenis be, digz error e parlet contra se. Doncx enaissi·s cove de bon comensamen aver mal fenimen? En lui par ver, qu’al comensar cantan dis ben d’Amor, et al fenir mal gran. Mancini va oltre, riconoscendo una tendenziosità anche alla ripresa della metafora del giocatore di FqMars 155,21 (VII), 1-8 nella cobla d’esordio di AimPeg 10,12 Atressi·m pren quom fai al joguador (XII): Atressi·m pren quom fai al joguador, qu’al comensar jogua mayestrilmen a petits juecs, pueis s’escalfa perden, que·l fai montar tan qu’es en la folor; aissi·m mis ieu pauc e pauc en la via, que cujava amar ab mayestria si qu’en pogues partir quan me volgues, on sui intratz tan qu’issir non puesc ges. soprattutto per il contenuto dei successivi vv. 9-12: Autra vez fui en la preizon d’Amor, don escapei; mas aora·m repren ab un cortes engienh tan sotilmen que·m fa plazer mo mal e ma dolor 139 Alcune riprese dei motivi folchettiani (soprattutto di GsbPuic) sono segnalate da Stroński a p. 85*, n. 1; per una evidente ripresa metrica da parte di BonCalvo vd. infra la Scheda metrica di FqMars 155,25 (XXV). 140 Il confronto era stato già istituito da Stroński alle pp. 60*-61*, ma l’editore pare mettere in relazione la polemica con l’origine di AimPeg, ossia con l’appartenenza di questi alla «bourgeoisie toulousaine qui n’aimait pas beaucoup l’évêque Folquet». coi quali viene ribadita la fedeltà ad ogni costo al servizio d’amore, diversamente da quanto scrive FqMars ai vv. 33-37 della sua canzone: «Amors, per so m’en soi eu recresuz / de vos servir, que mais no n’aurai cura; / c’aissi com mais prez’ hom laida pentura / de long, no fai cant es de pres venguz, / prezava eu vos mais can no·us conoissia». A rafforzare il valore palinodico contribuisce a mio avviso anche il raro sintagma «cortes engienh», di origine rudeliana ma che si ritrova in FqMars 155,7 (XIV), 41 (cfr. la relativa nota del Commento). § 3.2.2.1.2. G u i l h e m d ’ A n d u z a. L’unica canzone di questo poeta di pieno Duecento, Sens ditz que·m lais de chantar e d’amor (GlAnd 203,1; ed. Appel 1890, p. 121), è densa di elementi folchettiani. Si vedano i vv. 28-36: ...e son gualiador vas me mei hueill; e s’ill m’an galiat, ill prendon part en lur gualiamen, que tals traï qu’es traitz el traïmen; donx, s’ill m’an trait, ill compron la foudat. tenendo a mente i primi due vv. di FqMars 155,5 (I): «Ben an mort mi e lor / miei huoill galiador»; e poi i vv. 37-38 141: donx no mostretz encontr’umelitat, si·us platz, ergueill, quan plus bas deisen; costruiti sugli stessi elementi ancora dei primi vv. di FqMars 155,16 (VIII): «Per Dieu, Amors, ben sabetz veramen / c’on plus deisen plus poja Humilitatz / et Orgoills chai on plus aut es pojatz» (il testo di GlAnd prosegue al v. 39 con «pero em patz sufrirai lo turmen» che potrebbe leggersi come il risultato di un incrocio fra FqMars 155,20 (XXI), 59: «soffrist vos la vostr’, em-patz» e 155,10 (XII), 25: «e cill sofran lo tormen»). Riproduce il testo della canzone e colloca GlAnd nell’ambiente ricostruito nei Trovatori a Valchiusa, Perugi 1985, pp. 192-93, n. 1. § 3.2.2.2. N e l l a F r a n c i a d e i t r o u v è r e s . Partendo dai dati offerti dalla tradizione manoscritta si può assumere in primo luogo che FqMars, «largamente rappresentat[o] nei canzonieri oitanici» 142, ha goduto di certa una fortuna nel Nord della Francia: la frase citata è di Stefano Asperti 143, che nota come: «A partire già dagli inizi del Duecento si riducono con estrema rapidità per poi scomparire del tutto contrafacta francesi che assumono a modello canzoni cortesi di trovatori provenzali ancora in attività» (p. 45): anche da 141 Il v. 38 è ipometro: Appel lo segnala e propone di integrare ieu dopo «quan». Quattro testi (più uno spurio) in Kp, cinque testi (più uno spurio) in W, uno in Y: i componimenti sono indicati nella tavola generale al § 1.1, mentre notizie sui codici sono in Raupach-Raupach 1979, pp. 62-73 (W) e 82-84 (Kp); su Y si veda supra il § 2.1.2.3. 143 Contrafacta provenzali di modelli francesi, Mess, n.s., VIII (1991), pp. 5-49 (cit. a p. 47, n. 1). 142 questo punto di vista FqMars è rappresentato con 155,10 (XII) di cui la poesia religiosa anonima En la vostre mantenance 144 è un contrafactum (cfr. Battelli 1992, p. 602). Si noti che l’incipit riprende quello della II cobla della canzone folchettiana, e in particolare quello della cobla esparsa tràdita in W (En la uostra maintenence). Anche Thibaut di Champagne, allude nella canzone En chantant vueil ma dolor descouvrir 145 all’incipit di FqMars 155,6 (XVII): «Chantan volgra mon fin cor descobrir» 146. § 3.2.2.3. I n C a t a l o g n a . Indagare a fondo la fortuna di Folchetto in una regione così fortemente segnata dall’esperienza trobadorica richiederebbe uno studio specifico: mi limito pertanto a segnalare la presenza di una tradizione manoscritta catalana per tre liriche folchettiane 147 e a ricordare le citazioni sparse nelle opere di Berenguer de Noya, Jaufre de Foixà, Jordi de Sant Jordi 148 e Raimon Vidal de Besalú, già elencate al § 2.1.3. Dalla sintesi di Isabel de Riquer 149 ricavo l’indicazione che Jacme March cita nel suo Libre de concordances (1371-76) i vv. 31-32 di FqMars 155,18 (III). Segnalo infine che il primo trattato del ms. Ripoll 129 (Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón) attribuisce a FqMars il sirventese PoFabre 376,1 (si veda il r. 42 dell’ed. Marshall 1972, pp. 101-103). § 3.2.2.4. N e l l a S i c i l i a f e d e r i c i a n a . Il primo e più importante episodio della presenza folchettiana fra i poeti della Magna Curia è certamente quello della traduzione-rifacimento della canzone 155,4 (XXII) da parte del caposcuola Giacomo da Lentini nella sua Madonna, dir vo voglio: i riferimenti bibiografici sono nel Commento all’edizione. Qui vorrei offrire i dati essenziali di due operazioni non dissimili da quella del Notaro e di questa meno studiate, ossia i rifacimenti di due canzoni folchettiane effettuati da Mazzeo di Ricco da 144 R229 e n° 265,624 di Linker 1979, edita da E. Järnstörm, Recueil de chansons pieuses du XIIIe siècle, Helsinki 1910, p. 75. 145 R1397 e n° 240,25 di Linker 1979 (Wallensköld 1925, p. 51). 146 Cfr. inoltre il v. 26 «Et ne por quant je muir et nuit et jor» con il v. 35 della canz. folchettiana: «no·us oblit jes, anz i tenc nuoich e jor», soprattutto perché ciò che ‘si tiene’ sono «los huoills del cor», espressione ricalcata da Thibaut in R315 (cfr. Commento a FqMars 155,6 [XVII], 36). 147 Oltre a FqMars 155,16 (VIII) e 155,21 (VII) vergate nel canzoniere VeAg, va sottolineata la presenza di una tradizione catalana della poesia religiosa 155,19 (XXVII), per la quale rimando infra all’edizione. 148 Oltre ai vv. 1-2 di FqMars 155,5 (I) citati nella Passio amoris secundum Ovidium [= JSJ], Riquer 1955 segnala l’influsso dei vv. 17-18 della stessa canzone folchettiana sulla «canço d’opposits» Tots jorns aprench e desaprench ensemps, 7-8: «e ço que·m fuig incessantment acas / e·m fuig aço que·m segueix e m’afferra» (segnalazione a p. 61, ed. a p. 173, n° XV); e di FqMars 155,8 (XI), 9 e di 155,23 (IX), 21-22 sull’incipit di Jus lo front port vostra bella semblança (segnalazione a p. 38, ed. a p. 147, n° IX). 149 Poemas catalanes con citas de trovadores provenzales y de poetas de otras lenguas, in Atti Santiago de Compostela 1993, pp. 289-313, a p. 296 Messina e Rinaldo d’Aquino. Il primo traduce una buona porzione di FqMars 155,21 (VII) in Sei anni ho travagliato 150: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sei anni ho travagliato in voi, madonna, amare, e fede v’ho portato più assai che divisare né dire vi poria. Ben ho caro acat[t]ato lo vostro inamorare, che m’ha così inganato con suo dolze parlare ch’i’ già no ’l mi credia. Ben mi menò follia di fantin veramente, che crede fermamente pigliar lo sol ne l’agua splendïente e stringere si crede lo splendore de la candela ardente, ond’ello inmantenente si parte e piange, sentendo l’ardore. 19 S’eo tardi mi so’ adato 20 de lo meo folleg[g]iare, 21 tegnomene beato, 6 c’ab bel semblan m’a tengut en fadia 7 mais de dez ans... 3 ...a gran bonaventura 4 m’o dei tener c’ar me soi conoguz 5 del gran enjan c’Amors vas mi fasia, 10 s’atrai vas leis fols amanz e s’atura, 11 co·l parpaillos c’a tan folla natura 151 12 que·s fer el foc per la clartat que·i lutz; 1 Sitot me soi a tart aperceubuz, [...] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 150 Speranza m’ha ‘nganato e fatto tanto er[r]are com’omo c’ha giucato e crede guadagnare e perde ciò ch’avia. Or veg[g]io ch’è provato zo ch’aud[ï]o contare, c’assai ha guadagnato chi si sa scompagnare da mala compagnia. A meve adivenia como avene sovente chi ’mprota buonamente lo suo a mal debitore e scanoscente: imperciò ch’al malvagio pagatore vaci omo spessamente e non pò aver neiente, ond’a la fine ne fa richiamore. 2 aissi cum cel c’a tot perdut e jura 3 que mais non joc... 13 mas eu m’en part e segrai altra via, 14 sos mal pagaz, qu’esters no m’en partria; 7 ...a lei de mal deutor 8 qu’ades promet mas re no pagaria. Cito da Contini 1960, I, p. 150; è stato Torraca 1897, pp. 160-61 a mostrare il rapporto, ampliando l’indicazione di Gaspary 1882, pp. 114-15, limitata all’incipit (e cfr. Fratta 1996, pp. 63-64). 151 Già Torraca rilevava che il paragone con la farfalla è sostituito con quello del fanciullo ricavato da ElCair 133,1 (I), 33-34: «a lei d’enfan – cui la candela platz, / que s’art jogan, – sui trop entalentatz» (cfr. Fratta 1996, p. 54). Per parte sua Rinaldo d’Aquino rielabora FqMars 155,6 (XVII) in Poi li piace c’avanzi suo valore 152: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poi li piace c’avanzi suo valore di novello cantare, ònd’alegranza di gioi con paura, per ch’io non son sì sapio laudatore ch’io sapess’ avanzare lo suo gran pregio infino oltra misura; e la grande abbondanza e lo gran bene, ch’eo ne trovo a dire, mi fa sofretoso; così son dubitoso, quando vengo a ciauzire, chi nde perdo savere e rimembranza. [...] 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 sì, come dea tuttore laudar ben per megliore secondo dirittura, di lei vorrìa ritrarre meglioranza. 16 com ja pogues retraire sa valor, 17 que de bon pretz a triat lo meillor 153 e car li platz qu’ieu enans sa lauzor en mon chantar, don ai gaug e paor, car sos pretz vol trop savi lauzador. Per que no·m par qu’ieu pogues devezir son cortes pretz que tant aut es aders c’om no·n ditz ver que non semble plazers, e trob aitan en lieis de ben a dir que sofraitos m’en fai trop d’aondanssa; 3 ma per dreich gaug m’es faillitz mos sabers, 4 per qu’ai paor que no·i puosca avenir Se queste sono le punte emergenti, più ampio è il debito contratto dai poeti siciliani con il loro «interlocutore privilegiato» 154; attraverso il repertorio di Fratta 1996 è ora possibile, e agevole, una ricognizione sull’effettiva entità di quel debito: presento i dati, per ora solo quantitativi, partendo dai poeti coinvolti nelle operazioni di traduzione sopra mostrate 155: Giacomo da Lentini: 152 Cito da Panvini 1994, p. 154 (il v. 9 è ipometro per refuso: in Panvini 1962-64, I, p. 99 si legge: «mi me fa», altro evidente refuso per «mi ne fa»: cfr. apparato); il rapporto, segnalato ancora da Torraca 1897, pp. 162-63 (e cfr. Fratta 1996, pp. 80-81), è definito «allusione letterale [...] limitata all’esordio» da G. Folena, Cultura e poesia dei Siciliani, in Storia della Letteratura Italiana, diretta da E. Cecchi e N. Sapegno, vol. I, Milano, Garzanti 1965, pp. 273-347, a p. 285; segnalo inoltre l’analisi metrica di R. Antonelli nel Repertorio metrico della scuola poetica siciliana, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani 1984, p. LIX, n. 128 (e cfr. C. Bologna, Sull’utilità di alcuni descripti umanistici di lirica volgare antica, in Atti Messina 1993, II, pp. 531-87, a p. 558, n. 60). 153 Più vicina al modello la versione , qui («e puis li platz qu’eu enans sa valor») e a v. 16 («qu’eu ja pogues retraire sa lausor»), ma non a v. 8 («e mon chantar, dei n’aver gran lausor»). 154 Così Meneghetti 1992, p. 160, che aggiunge: «Non è neppure da escludere che [...] la sintonia sia stata determinata anche da una più o meno conscia “simpatia” dovuta alla prossimità delle situazioni sociali e delle attitudini culturali, dal momento che, come osserva Martín de Riquer, Folquet è stato il primo “dilettante” colto di estrazione altoborghese a cantare la fin’amor» (il riferimento è a Riquer 1975, I, pp. 584-85). 155 Per le postille di Torraca apposte all’edizione di A. D’Ancona e D. Comparetti del canzoniere Vat. lat. 3793 (Bologna 1875-88) e all’edizione di A. Bartoli e T. Casini del canzoniere Palatino 418 [oggi Banco rari 217] della Naz. di Firenze rimando all’introduzione di Fratta 1996 (si rinuncia a distinguere le due serie di postille, indicate rispettivamente con T1 e T2 da Fratta). A differenza che nelle altre pagine, e in considerazione dell’importanza di FqMars per i Siciliani, cito anche i vv. del trovatore, in modo da facilitare i confronti. i) Amando lungiamente (Antonelli 1979b, p. 137, n° XI), 27-30 «non posso dir di cento parti l’una / l’amor ch’eo porto a la vostra persona. / Se l’amor ch’eo vi porto / non posso dire in tutto»: cfr. FqMars 155,1 (V), 36 «Domna, ·l fin cor qu’ie·us ai no·us sai tot dire» (riscontro di Torraca nelle postille); ii) Ben m’è venuto prima cordoglienza (Antonelli 1979b, p. 81, n° VI), 27-28 «però non deggio planger penitenza, / ca nullo senza – colpa è penitente»: cfr. FqMars 155,10 (XII), 25-27 «e cill sofran lo tormen / que fan, per folla atendenssa, / anz del pechat penedenssa» (riscontro di Diez 1883, p. 254-55 in nota); 31-32 «ma vostr’orgoglio passa sorcoitanza, / che dismisura contr’a umilïanza»: cfr. FqMars 155,16 (VIII), 5 «qu’ancse·m mostres orgoill contra mesura» (riscontro di Torraca nelle postille); iii) Donna, eo languisco e no so qua·speranza (Antonelli 1979b, p. 97, n° VII), 9-10 «e s’altri m’adomanda ched aggio eo, / eo non so dir se non “Merzé, per Deo!”»: cfr. FqMars 155,8 (XI), 6-7 «ni ma boca en al re non ave / mas en: merce!» (riscontro di Torraca nelle postille); 21-30 «Donna, gran maraviglia mi donate, / che ’n voi sembrate – sono tanto alore: / passate di bellezze ogn’altra cosa, / come la rosa – passa ogn’altro fiore; / e l’adornezze quali v’acompagna / lo cor mi lancia e sagna; / [e] per mi sta asai plui, / merzé che nonn-è in voi; / e se merzé con voi, bella, statesse, / null’altra valenza più mi valesse»: cfr. FqMars 155,12 (XXIII), 28-31 «mais sa beltatz e·l dolz ris / mi tolon de lor bargaigna; / qar ill val tan, cho·us plevis, / qe si sol merces i fos» (riscontro di Torraca nelle postille); iv) La ’namoranza disïosa (Antonelli 1979b, p. 69, n° V), 1-2, 29-32 «La ’namoranza – disïosa / che dentro a l[o] mi’ cor è nata / [...] / ma tanto tarda la speranza, / solamente per [voi] dottare / o i malparlare, / Amor non vuol ch’io perda mia intendanza»: cfr. FqMars 155,22 (II), 1-2, 7: «Tant m’abellis l’amoros pessamens / que s’es vengutz e mon fin cor assire / [...] / que·m promet joi mas trop lo·m dona len» (riscontro di Torraca nelle postille) 156. v) Madonna mia, a voi mando (Antonelli 1979b, p. 157, n° XII), 17-24 «Ben vorria, s’eo potesse, / quanti sospiri getto, / c’ogni sospiro avesse / spirito e intelletto, / c’a voi, donna, d’amare / dimandasser pietanza, / da poi ch’e’ per dottanza / non vo posso parlare»: cfr. FqMars 155,27 (X), 66 «Que tans sospirs n’ai gitatz» (riscontro di Fratta 1996) e 155,1 (V), 18-21 «e quar plainhen vo·n pregon miei sospire; / que·l cor plora quan vezes los hueilhs rire, / mas per paor que no·us sembl’ enoios / engan mi eis e trac mal enperdos» (riscontro di Torraca nelle postille). vi) Meravigliosa-mente (Antonelli 1979b, p. 23, n° II), 4-12 «Com’om che pone mente / in altro exemplo pinge / la simile pintura, / così, bella, facc’eo, / che ’nfra lo core meo / porto la tua figura. / In cor par ch’eo vi 156 Il v. 30 è ricostruito a partire da un’ipometria: Antonelli riproduce la soluzione avanzata da G. Contini, ma meno oneroso mi pare l’intervento di Avalle nelle CLPIO: «solamente per [a]donare» (V 006 = L 111); sulla base dei riscontri Fratta 1996, p. 39 propone: «solamente per [gioi] donare». porti, / pinta come parete, / e non pare difore»: cfr. FqMars 155,8 (XI), 8-10 «per qu’es vertatz e sembla be / qu’inz el cor port, domna, vostra faisson / que·m chastia qu’eu non vir ma rason» (riscontro di Picchio Simonelli 1982, p. 225, in parte già nelle postille di Torraca) 157 e 155,23 (IX), 41-42 «qu’inz el cor remir sa faisso / e remiran et eu languis» (riscontro di Antonelli 1977, p. 62); 52-54 «sacciatelo per singa / zo ch’eo no dico a linga, / quando voi mi vedite»: cfr. FqMars 155,22 (II), 37-38 «per so no·us aus mon mal mostrar ni dire, / mas a l’esgar podetz mon cor devire» (riscontro di Torraca nelle postille). vii) Sì como ’l parpaglion c’à tal natura (Antonelli 1979b, p. 344, n° XXXIII), 1-3 «Sì como ’l parpaglion c’à tal natura / non si rancura – de ferire al foco / m’avete fatto, gentil crëatura»: cfr. FqMars 155,21 (VII), 1112 «co·l parpaillos c’a tan folla natura / que·s fer el foc per la clartat que·i lutz» (riscontro di Diez 1883, p. 254 in nota). Mazzeo di Ricco da Messina: viii) Lo gran valore e lo presio amoroso (Contini 1960, I, p. 153), 27-30 «e serete sicura / che la vostra bellezze mi ci ’nvita / per forza, come fa la calamita / quando l’aguglia tira per natura»: cfr. FqMars 155,22 (II), 8 «c’ab bel semblan m’a trainat longamen» e 155,20 (XXI), 16-19 «qu’eissamenz com l’azimanz / tira·l fer e·l fai levar, / fazi’ el manz cors dressas / vas pretz, forsatz e pesanz» (riscontro, un po’ ampliato, di Torraca nelle postille); 3740 «Però, donna avenente, / per Dio vo prego, quando mi vedete, / guardatemi: così cognoscerete / per la mia cera ciò che lo cor sente»: cfr. FqMars 155,22 (II), 37-38 «per so no·us aus mon mal mostrar ni dire, / mas a l’esgar podetz mon cor devire» (riscontro di Gaspary 1882, p. 59). Rinaldo d’Aquino: ix) In gioi mi tegno tutta la mia pena (Panvini 1994, p. 165), 1-2 «In gioi mi tegno tutta la mia pena / e contolami in gran bonaventura»: cfr. FqMars 155,16 (VIII), 39-40 «c’adoncs era marritz, ar sui joios; / per qu’eu m’o tenc a gran bonaventura» (riscontro di Torraca nelle postille). x) Venuto m’è in talento (Panvini 1994, p. 149), 46-47 «e lo mio allegramento / non si porrìa contare»: cfr. FqMars 155,13 (XX), 38-40 «car plus me vens / vostr’ amors sospiran / qu’eu no sai dir ni retraire en chantan» (riscontro di Torraca nelle postille). Le indicazioni del repertorio di Fratta sono come detto più ampie, ma data la natura delle postille riguardano anche poeti duecenteschi che non ebbero 157 Una sintetica ed acuta analisi del rapporto è in Meneghetti 1992, pp. 174-75; sul motivo J. R. Scheiddegger, Son image peinte sur les parois de mon cœur, in Le moyen âge dans la modernité. Mélanges offerts à Roger Dragonetti, Études recueillies et présentées par J. R. Scheidegger avec la collaboration de S. Girardet et E. Hicks, Paris, Champion 1996, pp. 395-409 (sulla canzone folchettiana le pp. 401-14; su Giacomo da Lentini le pp. 404-405) e, per l’ambito italiano, F. Mancini, La figura nel cuore fra cortesia e mistica: dai siciliani allo stilnuovo, Napoli, ESI 1988. rapporti diretti con la Magna Curia: pertanto, offro sinteticamente solo i dati relativi ai Siciliani: xi) Re Enzo, S’eo trovasse Pietanza (Contini 1960, I, p. 157), 37-40: cfr. FqMars 155,17 (XVI), 34-35 (postille Torraca). xii) Guido delle Colonne, La mia vit’è sì fort’e e dura e fera (Contini 1960, I, p. 102), 21-24: cfr. FqMars 155,1 (V), 26-27 (postille Torraca). xiii) Jacopo Mostacci, Amor ben veio che mi fa tenire (Panvini 1994, p. 209), 31 e 36: cfr. FqMars 155,16 (VIII), 40 e 35 (postille Torraca). xiv) Jacopo Mostacci, A pena pare ch’io saccia cantare (Contini 1960, I, p. 142), 26: cfr. FqMars 155,6 (XVII), 14 (postille Torraca). xv) Inghilfredi, Greve puot’on piacere a tutta gente (Marin 1978, p. 107), 34-37: cfr. FqMars 155,21 (VII), 11-12 (postille Torraca). xvi) Inghilfredi, Poi la noiosa erranza m’ha sorpreso (Marin 1978, p. 107), 26-27: cfr. FqMars 155,5 (I), 17-18 (postilleTorraca). xvii) Percivalle Doria, Come lo giorno quand’è dal maitino (Contini 1960, I, 162), B [= rifac. di Semprebene], 33: cfr. FqMars 155,16 (VIII), 8 (Fratta 1996, p. 70). xviii) Pier delle Vigne, Uno piasente isguardo (Contini 1960, I, p. 123), 10-15: cfr. FqMars 155,5 (I), 1-6 (postille Torraca). Poesie di dubbia attribuzione: xix) Allegramente eo canto (Panvini 1962-64, I, p. 419), 22-24 e 25-30: cfr. FqMars 155,3 (VI), 9-11 e 155,6 (XVII), 7-12 (postille Torraca). xx) Amore, avendo interamente voglia (Panvini 1962-64, I, p. 430), 2728: cfr. FqMars 155,6 (XVII), 6 (postille Torraca). xxi) In un gravoso affanno (Panvini 1962-64, I, p. 408), 5-7: cfr. FqMars 155,15 (IV), 1-2 (postille Torraca); 11-12 e 25-27: cfr. FqMars 155,27 (X), 1, 5-7 (Fratta 1996) e 26-30 (postille Torraca). xxii) Poi tanta caunoscenza (Panvini 1962-64, I, p. 412), 6: cfr. FqMars 155,16 (VIII), 2 (postille Torraca). xxiii) Vostr’orgogliosa ciera (Panvini 1962-64, I, p. 409), 14-15 e 65-66: cfr. FqMars 155,10 (XII), 14-15 e 10-11 (postille Torraca). Poesie anonime: xxiv) Amor voglio blasmare (Panvini 1962-64, I, p. 478), 33-36: cfr. FqMars 155,3 (VI), 9-12 (postille Torraca). xxv) Donna, lo fino amore (Panvini 1962-64, I, p. 497), 39-40: cfr. FqMars 155,13 (XX), 15-16 (postille Torraca). xxvi) Lasso, c’assai potrei chieder merzede (Panvini 1962-64, I, p. 499), 37-48: FqMars 155,14 (IV), 8-10 (postille Torraca). Aggiungo che i vv. 9-14 del son. anonimo Lo [mio] folle ardimento m’ha conquiso 158: «Ché similmente – vostra gran bieltate / seguir mi face la folle natura / del parpaglione che fere lo foco, / ché vede i·llui sì grande chiaritate / che girando si mette ’n aventura, / ov’ha morire credendo aver gioco» sono tradotti da FqMars 155,21 (VII), 9-12. § 3.2.2.5. N e l l a T o s c a n a d u e - t r e c e n t e s c a . Un poeta di cui la rubrica dell’unico relatore, il Vat. lat. 3793, non ci fornisce il nome (un «guittoniano fiorentino» per Contini 1960, I, p. 275) propone una tenzone a Bonagiunta Orbicciani, così blandendolo (vv. 5-8): Di ciausir motti Folchetto tu’ pari non fu, né Pier Vidal né ’l buon di ’Smondo: però m’inchino a te sì com’ fe’ Pari a Venùs, la duchessa di lor mondo. Bonagiunta restituisce il paragone (ancora vv. 5-8): Però, chi vol valer, da voi impari gli apari – che del mal fa[n] l’om rimondo, che ’n voi commendan li due che son pari, ma più che pari, – Folchetto né ’Smondo. dove, spiega Contini 1960, I, p. 276, 6 gli apari, deverbale da a(p)parare, vale «gli apprestamenti, le tecniche»; 6 rimondo «perfettamente scevro»; il v. 7 «I quali (la cui presenza), (lodati) in voi, lodano i due che (a voi) sono uguali» (la spiegazione è tuttavia ipotetica); 8 ma più che pari «anzi ugualissimi» (da Parducci, il quale interpretava 7 che son pari come «fra loro uguali»; Contini propone in alternativa di emendare in che [’m]pari «incomparabilmente inferiori»); 8 né «e» (cfr. apr. ni). Ma accanto a questa chiara testimonianza della fortuna di FqMars, si possono indicare altre e ben più rilevanti influenze sulle quattro grandi figure della letteratura volgare dei primi secoli. Completo prima il regesto delle indicazioni ricavate da Fratta 1996: i) Carnino Ghiberti, Luntan vi son, ma presso v’è lo core (Contini 1960, I, p. 371), 1: cfr. FqMars 155,17 (XVI), 15 (postille Torraca) ii) Neri Poponi, Poi l’Amor vuol ch’io dica (Panvini 1962-64, I, p. 259), 25-27: «Ubidir vince forza, / e l’agechir servendo / fa l’orgoglio bassare»: cfr. FqMars 155,23 (IX), 59-60 (postille Torraca). iii) Pietro Morovelli, Donna amorosa (Contini 1960, I, p. 377), 41-45: «ben par che voi vi dilettete / di me ch’avete, / como ’l zitello / che de l’ausello va dilettando / finché l’auzide, tanto lo tira»: cfr. FqMars 155,3 (VI), 13-16 (postille Torraca). 158 Edito fra i Sonetti anonimi del Vaticano lat. 3793, a cura di P. Gresti, Firenze, Accademia della Crusca 1992, p. 63; il riscontro è di P. Trovato, Dante in Petrarca, Firenze, Olschki 1979, p. 7. § 3.2.2.5.1. G u i t t o n e d ’ A r e z z o . L’influsso trobadorico, e in particolare quello di FqMars, sulla produzione lirica guittoniana è stato recentemente indagato, con esiti molto interessanti, da Lino Leonardi 159: fra i luoghi d’incontro segnalati ha particolare rilevanza la coppia formata dai sonetti 9 (Se Deo – m’aiuti, amor, peccato fate) e 10 (Amor, per Deo, mercé, mercé, mercede) connessi agli incipit del dittico folchettiano su Amore e Mercé, FqMars 155,14 (IV) e 155,1 (V): riecheggiamento che potenzia il «sistema allusivo» guittoniano allorché, nel son. 11 (Deo!, com’è bel poder quel di mercede), l’aretino polemizza «con uno dei testi centrali del Notaio, Amor non vole ch’io clami, il più esplicito forse nel sancire la chiusura dell’universo cortese attuata nella ricodificazione siciliana» (p. XLIV). FqMars farebbe in qualche modo da sponda a un superamento dell’esperienza siciliana e in particolar modo di quella di Giacomo da Lentini; una cosa analoga succede nel complesso sistema di rimandi allusivi che Leonardi ricostruisce a partire dall’incipit del sonetto esordiale: «Amor m’à priso e incarnato tutto», che rinvia per un verso alla già ricordata ‘traduzione’ del Notaro di FqMars 155,4 (XXII): «Madonna, dir vo voglio / como l’amor m’a priso», per l’altro all’inizio della canzone che apre il corpus guittoniano nel ms. Laurenziano: «Se de voi, donna gente, / m’ha preso amor, no è già meraviglia», la quale allude nello stesso tempo all’incipit della canzone di Giacomo, S’io doglio, non è meraviglia e a un celebre testo di BnVent, Non es meravelha s’eu chan (70,31 [XXXI]). Commenta Leonardi: «L’allusione esordiale al Notaio segnala insomma una contrapposizione e un superamento; e nella fitta trama di questo suo assoluto esordio Guittone sembra segnalare che il superamento avviene nel nome di Bernart de Ventadorn» (p. XXII). Si avrebbe così, proseguendo idealmente il ragionamento, in corrispondenza dell’affermazione della propria esperienza poetica a scapito di quella di Giacomo, una contrapposizione dei rispettivi modelli; e tenuto conto del fatto che FqMars, il modello superato, è una sorta di ‘imitatore-divulgatore’ di BnVent, il modello vincente, la proposta di Leonardi oltre che interessante appare aperta a stimolanti sviluppi. Un primo, parzialissimo passo in direzione di questa ricerca può essere l’osservazione che anche nel son. 11, dove la polemica con il ‘traduttore’ di FqMars è più scoperta, si scorge una traccia del modello del Notaro, e precisamente nel v. 3: «Ché mercé vince orgoglio e lo decede», dove avverto un’eco di FqMars 155,18 (III), 35: «que Merce vol so que Razos dechai» (miei i corsivi). Segnalo infine le altre risonanze folchettiane reperibili nel commento di Leonardi: i) son. 18.14 «ché ‘n pover loco om non po’ aricchire»: cfr. FqMars 155,16 (VIII), 35-36 («ma il tema è vulgato»); 159 Cfr. Guittone d’Arezzo, Canzoniere. I sonetti d’amore del codice Laurenziano, a cura di L. Leonardi, Torino, Einaudi 1994, in partic. l’Introduzione, alle pp. XIII-LIX; cito indicando n° del sonetto e verso. Si veda poi dello stesso Leonardi, Tradizione e ironia nel primo Guittone: il confronto con i Siciliani, in Guittone d’Arezzo nel settimo centenario della morte. Atti del convegno intern. di Arezzo (22-24 aprile 1994), a cura di M. Picone, Firenze, Cesati 1995, pp. 125-64. ii) son. 20.1 «E poi lo meo penser fu sì fermato»: cfr. FqMars 155,27 (X), 21 («Può non essere casuale che il v. 1, eco di 19.12, abbia andamento analogo all’inizio di stanza di Folquet de Marselha [...], forse con evocazione della conseguenza del v. 22 “que·l mensonja·m sembla vers”: si insinua assai indirettamente qualche dubbio sulla nuova sincerità protestata dall’amante?»); iii) son. 43.9-11 «Bene vegg’io che di partir potenza / darmi potete, s’a voi piace bene, / sol con disabellir vostra piagenza»: cfr. FqMars 155,22 (II), 1, 2124 (riscontro già di A. Pellizzari, La vita e le opere di Guittone d’Arezzo, Pisa, Nistri 1906, p. 92); iv) son. 48.12 «Or pensa di tener altro vïaggio»: FqMars 155,21 (VII), 13; v) son. 66.13 «ch’eo mi sento ver’ ciò tanto sennato»: FqMars 155,16 (VIII), 27. Cfr. anche il commento ai sonn. 4.1 e 56.9. § 3.2.2.5.2. D a n t e A l i g h i e r i . Folchetto è, com’è ben noto, una delle figure centrali del ‘provenzalismo’ dantesco; anzi per Picone 1981-83, p. 66 egli rappresenta «il massimo poeta della tradizione romanza col quale si confronta e nel quale si riconosce il Dante della Commedia». Un commento approfondito di questa affermazione implicherebbe un troppo lungo discorso e soprattutto la ripetizione di cose già dette in altra sede 160; qui basterà ricordare il valore emblematico che ha assunto per Dante la canzone folchettiana 155,22 (II) Tant m’abellis l’amors pensamens: annoverata in Dve II VI 5-6 (unica menzione per FqMars) fra gli esempi di gradus constructionis «sapidus et venustus etiam et excelsus», palese filigrana della sermocinatio occitanica di ArnDan in Purg. XXVI, 140-47 e, come s’è proposto nella sede sopra citata, possibile modello del sonetto Gentil pensero che parla di vui (Vita nuova XXXVIII). Un lungo itinerario, quindi, che attraversa le tre fasi del provenzalismo dantesco 161, ma che non oltrepassa il canto purgatoriale della palinodia, al di là del quale Dante, nel IX canto del Paradiso, celebra non più, o non più soltanto, il trovatore Folchetto, cantore di pensieri d’amore gioiosamente o oppressivamente pervasivi, ma il ‘predicatore’ di crociata 162, o piuttosto il vescovo impegnato in una decisa azione pastorale e politica contro i catari del Midi 163. Ma agli occhi 160 Cfr. Squillacioti 1993, pp. 583-90. I tre momenti, evocati in una densa e bellissima pagina di G. Contini nell’introduzione al classico commento delle Rime (cfr. p. LXVI della recente ristampa einaudiana del 1995, introdotta dal bel saggio di M. Perugi Un’idea delle rime di Dante, pp. VII-XLIII), sono stati analizzati nello strenuo, ma non sempre limpido libro di S. Santangelo, Dante e i trovatori provenzali, Catania 19592 [ma 1921] e poi meglio specificati da Perugi 1978b. 162 È la tesi di Picone 1981-83 che scrive a p. 85: «È infatti il poeta per antonomasia dell’idea di crociata che Dante vuole qui celebrare: Folchetto rappresenta il punto felicissimo di incontro della parola salvifica con la sua applicazione pratica, di poesia con peregrinatio. Qui sta, credo, la ragione più profonda della scelta di Folchetto come speculum nel quale Dante può più compiutamente contemplare la propria imago di poeta». 163 È la tesi tradizionale, proposta da Renier 1895, p. 287, n. 5 e da allora più volte ribadita; fra gli ultimi Suitner 1980, scrive a p. 633: «Ben conosciuto da Dante dovè invece essere l’impegno del vescovo di Tolosa contro gli eretici. La celebrazione dantesca di un uomo che tanto contribuì al trionfo di Simone di Montfort e alla rovinosa fine della civiltà del Sud 161 di Dante avrà soprattutto pesato lo strettissimo rapporto fra il vescovo di Tolosa e colui che «ne li sterpi eretici percosse / l’impeto suo», quel san Domenico protagonista poco oltre del XII canto del Paradiso 164. Questi gli episodi decisivi, ma altri, e non tutti infondati, rapporti intertestuali sono stati indicati dagli studiosi; fra quelli infondati, almeno a giudizio di Suitner 1980, p. 641, i due paralleli istituiti da Zingarelli 1899, pp. 22-25 fra l’immagine del «doppiar de li scacchi» di Par. XXVIII, 91-93 e FqMars 155,8 (XI), 53-54 165 e fra i vv. 9-10 di questa canzone e la canzone dantesca Amor, da che convien pur ch’io mi doglia (Rime, 53 [CXVI]). Comunque sia, è ancora la medesima canzone ad essere chiamata in causa da Jeanroy 1921 per «un rapprochement qui me paraît plus frappant que la plupart de ceux qui ont été faits» (p. 14), fra la sua cobla II e la II stanza de La dispietata mente, che pur mira (Rime 7 [L]), e in partic. i vv. 20-26: E certo la sua doglia più m’incende, quand’ i’ mi penso ben, donna, che vui per man d’Amor là entro pinta sete: così e voi dovete vie maggiormente aver cura di lui; ché Que’ da cui convien che ’l ben s’appari, per l’imagine Sua ne tien più cari. Lo stesso Suitner, meno scettico in questo caso 166, riconosce a sua volta nei vv. 46-50 di FqMars 155,18 (III) una sorta di ‘anticipazione’ del tema stilnovistico della «loda» della donna amata, e sviluppato da Dante nella Vita nuova: cfr. XVIII, 6: «E poi che alquanto ebbero parlato tra loro, anche mi disse questa donna che m’avea prima parlato, queste parole: “Noi ti preghiamo che tu ne dichi ove sta questa tua beatitudine”. Ed io, rispondendo lei, dissi cotanto: “In quelle parole che lodano la donna mia”» 167. della Francia ha suscitato in passato non poche perplessità, originando equivoci e tentativi di giustificazione che rischiano di distorcere la realtà dei fatti. Non vi è dubbio che l’idea della crociata anti-ereticale è per Dante perfettamente legittima e assimilabile a quella della crociata d’Oriente. Combattere l’eresia significava per il mondo medievale ristabilire l’ordine turbato, recuperare l’unità». 164 Anche su questo, oltre al § 3.1.2. del Profilo biografico, si veda Suitner 1980, pp. 63740, integrabile con Squillacioti 1993, pp. 586-87. 165 Cfr. la infra nota del Commento all’edizione. 166 Sull’«influence directe de Folquet» asserita da Jeanroy scrive infatti: «È possibile. Senza dubbio la discendenza provenzale del motivo è pacifica, e possiamo comunque limitarci ad osservare che l’accostamento è più preciso di quelli proposti nei nostri commenti alle Rime di Dante» (p. 642). 167 Cfr. Suitner 1980, p. 642, il quale conclude, dopo un ulteriore accostamento fra FqMars 155,20 (XXI), 5-9 e i vv. 9-11 del son. Tanto gentile (Vita nuova XXVI): «quest’ordine di osservazioni può interessare come sempre in funzione dello studio del linguaggio e dell’ideologia della tradizione lirica europea. Mentre pare impossibile ricavarne qualche indicazione sulla “lettura” di liriche di Folquet de Marselha da parte di Dante» (p. 643). Si possono infine ricordare qui, per lo stretto rapporto con l’episodio purgatoriale di Arnaut, i vv. dedicati a FqMars dal veneziano Giovanni Girolamo Nadal nel corteo trobadorico della Leandreride (completata intorno al 1381-82): «Qest es celuy qi se reclam de § 3.2.2.5.3. F r a n c e s c o P e t r a r c a . «Un Petrarca in embrione»: così, direi con più di «una qualche esagerazione, e senz’altro facendo torto in questo contesto al poeta italiano» 168, Thomas G. Bergin ha definito FqMars in una lectura dantesca 169. Se è del tutto inutile discutere questa suggestione, certamente meno inutile è raccogliere le indicazioni che l’imponente commento di Marco Santagata ai Rvf mette ora a disposizione 170: i) son. 19, 5-7 «et altri, col desio folle che spera / gioir forse nel foco, perché splende, / provan l’altra vertù, quella che ’ncende»: cfr. FqMars 155,21 (VII), 9-12 (il paragone è riproposto nel son. 141, 1-4); ii) canz. 23, 100 «Non son mio, no. S’io moro, il danno è vostro»: cfr. 155,22 (II), 31-32 (cfr. son. 221, 3-4, infra al n° x); 168-69 «...ché pur la sua dolce ombra / ogni men bel piacer del cor mi sgombra»: cfr. FqMars 155,22 (II), 1-3 («motivo topico della lirica romanza»); iii) ball. 55, 13 «Amor, avegna mi sia tardi accorto»: cfr. FqMars 155,21 (VII), 1 (il riscontro è di Agostino Casu, tesi di laurea, Univ. di Pisa, a.a. 1992-93); iv) canz. 71, 102-3 «onde s’alcun bel frutto / nasce di me, da voi vien prima il seme»: cfr. FqMars 155,2 (XIX), 37-39 (il riscontro è di A. Casu, che cita la redazione del ms. prov. R); v) son. 93, 4 «e ’n un momento gli fo morti et vivi»: FqMars 155,1 (V), 1; vi) canz. 105, 27-30 «Alcun è che risponde a chi nol chiama; / altri, chi ’l prega, si delegua et fugge; / altri al ghiaccio si strugge; / altri dì et notte la sua morte brama»: FqMars 155,5 (I), 11-20; 46-48 «Forse ch’ogni uom che legge non s’intende: / et la rete tal tende che non piglia, / et chi troppo assotiglia si scavezza»: FqMars 155,16 (VIII), 28; 80 «E ‘n bel ramo m’annido...»: FqMars 155,14 (IV), 19-20; vii) son. 134, 5-6 «Tal m’à in pregion, che non m’apre né serra, / né per suo mi riten né scioglie il laccio»: FqMars 155,18 (III), 15-17; viii) son. 140, 14 «Ché bel fin fa chi ben amando more»: FqMars 155,4 (XXII), 6 (filtrato da G. da Lentini, Madonna, dir vo voglio, 7-8); Spainna, / de Marseilla Folqet, qe se rancura / e pe.l’affan d’amors se ploura e lainna» (libro IV, canto VIII, vv. 10-12: da G. G. Nadal, Leandreride, ed. critica con commento a cura di E. Lippi, Padova, Antenore 1996, p. 132; trad. e comm. a p. 293: il v. 10 allude «quasi certamente» a FqMars 155,15 [XVIII]): l’edizione del canto era stata anticipata da Lippi ne Il tramonto del provenzale a Venezia: Leandreride, IV, 8, in Omaggio a Gianfranco Folena, Padova, Editoriale Programma 1993, III, pp. 655-76; si veda anche P. Canettieri, Un episodio della ricezione di Purgatorio XXVI: la Leandreride di Giovanni Girolamo Nadal, «Anticomoderno» II (1996), pp. 179-200. 168 Suitner 1980, p. 643. 169 Il canto IX del «Paradiso», Roma, Signorelli 1959, p. 20. 170 Francesco Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di M. Santagata, Milano, Mondadori 1996. Si ricordi intanto la menzione di FqMars nella sequenza dei poeti nel Triumphus Cupidinis IV 49-51, già citata nel § 3.1.1. ix) son. 171, 2-3 «...e s’io mi doglio, / doppia ’l martir...»: FqMars 155,1 (V), 4 («è formula provenzale»); x) son. 221, 3-4 «...et s’io ne scampo, / meraviglia n’avro; s’i’ moro, il danno»: FqMars 155,22 (II), 29-30; xi) son. 236, 8 «et l’alma desperando à preso ardire»: FqMars 155,5 (I), 28; xii) son. 273, 13 «ché mal per noi quella beltà si vide»: FqMars 155,4 (XXII), 11 («è espressione diffusa sia in ambito classico, sia romanzo»). Aggiungo al regesto un accostamento proposto da Zingarelli 1899, p. 26 fra la canz. 127, 43-51 «Qualor tenera neve per li colli / dal sol percossa veggio di lontano, / come ’l sol neve, mi governa Amore, / pensando nel bel viso più che humano / che pò da lunge gli occhi miei far molli, / ma da presso gli abbaglia, et vince il core: / ove fra ’l biancho et l’aurëo colore / sempre si mostra quel che mai non vide / occhio mortal, ch’io creda, altro che ‘l mio» e FqMars 155,14 (IV), 37-39. § 3.2.2.5.4. G i o v a n n i B o c c a c c i o . Di una presenza di Folchetto di Marsiglia nell’opera di Boccaccio non si trova traccia negli studi dedicati agli apporti della tradizione letteraria cortese alla produzione boccacciana: è mia opinione tuttavia che il Folco protagonista della novella IV 3 del Decameron, di ambientazione marsigliese, condivida con il nostro trovatore più elementi di quanto si ricavi dalla bibliografia a me nota 171. Un primo indizio che dà consistenza letteraria al personaggio di Folco sta nell’onomastica di evidente origine dantesca che collega Fo lco con N’Arnald Civada, padre delle sorelle di cui lo stesso Folco e i suoi amici Ughetto e Restagnone s’innamorano, e con B eltr amo , conte di Rossiglione e protagonista di un’altra novella d’ambiente provenzale, la III 9 (la terza novella ‘provenzale’ del Decameron è la IV 9, quella del ‘cuore mangiato’, protagonisti Guiglielmo Rossiglione e Guiglielmo Guardastagno): Bertran de Born, Arnaut Daniel e, appunto, Folchetto di Marsiglia sono, insieme con Sordello, i trovatori rappresentati nella Commedia. Altri elementi si ricavano dal confronto fra elementi narrativi della novella e aspetti della biografia di FqMars: per es. la condizione socio-economica di Folco e Ughetto: «morti i padri loro e essendo rimasi ricchissimi...» (IV 3, 10) richiama quella di FqMars secondo la vida: «Folquet de Marsseilla si fo fillz d’un mercadier que fo de Genoa et ac nom ser Anfos. E quan lo paire muric, si·l laisset molt ric d’aver» (§§ 1-2). Rimando per ulteriori indicazioni a un articolo di prossima pubblicazione, per la necessità, onerosa in questa sede, di contestualizzare il riscontro all’interno di un più ampio discorso sul riuso della tradizione cortese romanza da parte di Boccaccio. 171 In un passo del suo commento Vittore Branca parla di «chiaro calco letterario – certo anche per reminiscenza dantesca (De vulgari eloquentia, II vi, 6; Par. IX 37 sgg.) se non petrarchesca (Tr. Cupidinis, III 49-51)»; tuttavia Folco, così come gli altri nomi di origine occitanica, resta semplice macchia di colore locale, per «meglio ambientare la novella alla provenzale» (cfr. Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Torino, Einaudi 1992, p. 508, n. 1). § 3.2.2.6. N e l l a G e r m a n i a d e i M i n n e s ä n g e r . Mi limito a indicare i contrafacta medio-alto tedeschi e gli altri rapporti rintracciati da Frank 1952 172: i) 11c Friedrich von Hausen, Si darf mich des zîhen niet (MF 45,37): mod. FqMars 155,8 (XI); per la str. I cfr. c. III del modello 173. ii) 9a Rudolf von Fenis, Gewan ich ze Minnen ie guoten wân (MF 80,1): mod. FqMars 155,21 (VII); per la str. I cfr. c. II di FqMars 155,18 (III); per la str. II cfr. c. I di FqMars 155,21 (VII); per la str. III cfr. c. III di FqMars 155,22 (II). iii) 11f Rudolf von Fenis, Ich hân mir selben gemachet die swære (MF 83,11): mod. GcFaid 167,46 (29) oppure Gace Brulé, Tant m’a mené force de seignorage (R42 e n° 65,77 di Linker 1979; Rosemberg-Danon 1985, p. 139); per str. I cfr. c. II di FqMars 155,5 (I). iv) 11a Rudolf von Fenis, Mit sange wânde mîne sorge krenken (MF 81,30): stesso mod. di 11f (iii); per le str. I-II cfr. c. I-II di FqMars 155,8 (V); per la str. V cfr. c. II di FqMars 155,21 (VII). 3.3. La letteratura critica. Il fatto che FqMars sia un trovatore di prima grandezza è in qualche modo emerso dalle pagine precedenti: i rapporti intrattenuti durante l’attività poetica come nella vita pubblica e l’entità del suo influsso anche fuori d’Occitania ne sono un indizio preciso. Ma a scorrere la bibliografia critica, soprattutto dalla fine dell’Ottocento in poi, si ottiene un quadro in parte diverso. La conoscenza e lo studio del trovatore durante l’Umanesimo italiano dipendono essenzialmente dalla menzione dantesca e da quella petrarchesca: basterà qui richiamare i nomi già fatti nel § 3.1.1 e aggiungere che alcune poesie dei ‘trovatori di Dante’ ArnDan e FqMars sono state tradotte da Bartolomeo Casassagia, nipote di Benedetto Gareth, detto il Cariteo, e oggi conservate nel Vat. lat. 4796 174. In Francia, oltre a Jean de Nostredame, già menzionato nel § 172 Indico nell’ordine: n° del testo tedesco nello studio di Frank, autore e incipit, numero nella raccolta di testi di riferimento (MF = C. von Kraus, Des Minnesangs Frühling, nach K. Lachmann, M. Haupt und F. Vogt neu bearbeitet, Leipzig / Zürich, Hirzel 195030), modello metrico, rapporti fra i testi (con ‘str.’ indico la strofa del testo tedesco, con ‘c.’ la cobla del testo folchettiano). 173 Di questo e dell’altro contrafactum di FqMars 155,8 (V), Rudolf von Fenis, Mit sange wânde mîne sorge krenken, si veda l’analisi di S. Cain Van D’Elden, Diversity despite Similarity: Two Middle High German Contrafacta of an Occitan Song, in Misc. Remy 1986, I, pp. 323-37. 174 Cfr. Debenedetti 1995 [1911], pp. 122-25: di questa traduzione, esemplata su una copia del ms. M, si conserva anche una copia nel Vat. lat. 7182: si tratta, come scrive Debebendetti, delle «più antiche versioni a noi note d’un testo provenzale in prosa italiana» (pp. 124-25); cfr. M. Careri, Bartolomeo Casassagia e il canzoniere provenzale M, in Atti Messina 1993, II, pp. 743-52. 3.1.1, si interessa del trovatore-vescovo anche uno storico importante come Guillaume de Catel 175: è infatti l’attività pubblica successiva all’entrata in convento ad attirare l’interesse degli studiosi d’oltralpe, ed è proprio in relazione all’integrità religiosa di Folchetto, che s’intende così comprovare, che Catel trascrive alle pp. 899-901 l’alba religiosa FqMars 155,26 (XXVI), di cui le testimonianze antiche e, in principal modo, la biografia provenzale non facevano menzione 176. Per il resto sono vida e razos le fonti principali d’informazione; lo stesso accade, per venire al XVIII secolo, nell’Histoire génerale du Languedoc, almeno per quanto riguarda l’analisi dell’attività poetica del trovatore 177. Sin qui mancano, ed è ovvio che sia così, analisi specificamente letterarie sul trovatore: alla base di quelle che verranno nell’Ottocento, stanno due studi fondamentali pressoché contemporanei: il capitolo dedicato a FqMars da Friedrich Diez in Leben und Werke der Troubadours e il contributo di EméricDavid nell’Histoire littéraire de la France 178. I due lavori, strutturati in maniera abbastanza simile, integrano i dati ricavati dalle biografie con un’estesa analisi testuale volta per un verso a determinare in maniera particolareggiata le vicende biografiche di Folchetto 179, e per l’altro, soprattutto in Diez, a individuare le sue caratteristiche poetiche. Il giudizio letterario dell’HLF è quello che, corroborato da analisi o semplicemente sottinteso, si ritrova in gran parte degli studi successivi (cito dalle pp. 600-601): Si nous considérons uniquement Folquet sous des rapports littéraires, il ne saurait être placé au premier rang parmi les troubadours, dans aucun genre de poésie. Les Bernard de Ventadour, les Rambaud de Vachères, Bertrand de Born, Pierre Vidal, Faidit, lui sont bien supérieurs. On ne lui doit aucune de ces pastourelles où plusieurs de ses contemporains offrent tant de grace et naïveté; mais il a de la variété, des pensées heureuse, de l’énergie. La mancanza di naturalezza, che si ritrova anche fra i difetti attribuiti da Diez al trovatore, va ad intaccare una valutazione per altri versi positiva della sua poesia: «wir finden ihn [scil. nelle poesie d’amore] im Ganzen reich an feinen Wendungen, anschaulichen Bildern und ausgeführteren Allegorien, wiewohl nicht frei von Spitzfindigkeiten und Uebertreibungen» (p. 195). Altra caratteristica comune ai due lavori, rintracciabile anche altrove, è l’indicazione nella produzione di Folchetto dei componimenti esteticamente migliori: se nell’HLF viene sottolineata l’eccellenza dell’alba religiosa (p. 602), già messa 175 Cfr. Catel 1633, pp. 892-902. Il testo è ricavato dal ms. C che lo attribuisce a FqMars, ma si è già detto che la paternità è controversa (cfr. supra § 1.2.4). 177 HGL, V, pp. 90-91; poco di più è contenuto nelle integrazioni ottocentesche di Du Mège, nelle «Addition et notes» al vol. V, pp. 24-26 (molto più ricco è, come s’è visto nel § 3.1.2, il contributo alla biografia del vescovo) 178 Diez 1882 [1829], pp. 193-206 e HLF, XVIII, Paris 1835, pp. 588-603. 179 Entrambi i lavori presentano, per primi, indicazioni cronologiche precise riguardo ai testi contenenti allusioni al contesto storico. Non sono tuttavia assenti i tentativi di svelare l’identità del personaggio femminile rappresentato nelle canzoni d’amore: Eméric-David, per es., interpreta il senhal Azimans come un’allusione alla moglie di Folchetto (sul senhal, che cela invece BtBorn, cfr. supra il § 3.2.1.1.3). 176 in rilievo da Catel 1633, p. 899 e in séguito più volte ribadita, Diez valorizza piuttosto il planh FqMars 155,20 Si com sel qu’es tan greujatz (XXI), di cui propone anche una traduzione poetica 180. Non meno importante il contributo di Fauriel 1846, II, pp. 69-74 (e 149-52), e non tanto per l’informazione storico-biografica, ricavata prevalentemente dalle biografie provenzali, quanto per la valutazione stilistica della produzione poetica di Folchetto, sempre incerta fra il riconoscimento dell’importanza letteraria e il rilevamento nelle sue poesie di un’affettata monotonia (cito da p. 69): Parmi les meilleurs troubadours il n’y en a peut-être aucun qui surpasse Folquet de Marseille en délicatesse d’esprit, en élégance et en artifice de diction. Mais on voit déjà poindre, à travers cette élégance et cet artifice, des signes de décadence. A la simplicité monotone, mais enthousiaste et sérieuse, des premiers troubadours, on sent déjà succéder les raffinements du mauvais goût, les prétentions du bel esprit, la manière et les recherches d’un art qui s’épuise, et qui, distrait du but, s’égare à la poursuite des moyens. Anche Fauriel conferma la già ricordata tendenza degli studiosi di Folchetto a isolare un componimento particolarmente riuscito: la scelta cade (cfr. pp. 7374) su 155,12 Ja non volgra q’hom auzis (XXIII), un’agile canzone, stilisticamente così poco omogenea al resto della produzione del trovatore da aver fatto dubitare della sua paternità (cfr. supra il § 1.2.2). Nell’ultimo quarto del XIX sec. appaiono le due a tutt’oggi uniche monografie su FqMars: la Biographie des Troubadours Folquet von Marseille di Hugo Pratsch e il saggio di Nicola Zingarelli, La personalità storica di Folchetto di Marsiglia nella Commedia di Dante 181: il lavoro di Pratsch, pur ambendo ad un’analisi esaustiva della produzione poetica folchettiana e meritando per questo attenzione, non offre per la carenza di strumenti, ma anche per un’impostazione metodologica ampiamente superata, delle risposte soddisfacenti alle numerose questioni sollevate 182; al contrario il contributo di Zingarelli, che si può dire inauguri la voce preponderante della bibliografia critica su Folchetto, quella dei rapporti del trovatore con Dante, risulta 180 «Beklagt er den Tod seines Gönners, welcher im Jahre 1192 erfolgte, auf eine Art, wie nicht jeder Troubadours es vermochte» (Diez 1882 [1829], p. 201; la traduzione è alle pp. 201-202). 181 Il primo (= Pratsch 1878) riproduce il testo di una «Inagural-Dissertation» all’Università di Gottinga; il secondo (= Zingarelli 1899) accresce e corregge una prima versione pubblicata tre anni prima (Zingarelli 1896) e sottoposta a revisione in séguito ai rilievi dei recensori. 182 Basti citare l’ordinamento cronologico delle canzoni di Folchetto in base agli sviluppi del rapporto amoroso con Azalais, viscontessa di Marsiglia (p. 19 ss.) o il tentativo di separare le persone del trovatore e del vescovo di Tolosa (pp. 47-52). Sul piano della valutazione globale, Pratsch, pur sottoscrivendo il giudizio di Fauriel citato sopra, lo ritiene troppo severo: «Fauriel spricht zwar den unserm Dichter vom rein ästhetischen Standpunkte zukommenden Tadel bei weitem nicht so wohlwollend aus wir es thun zu müssen glaubten, aber auch er erblickt in Folquet von Marseille einen von denjenigen Troubadours, welche kurz vor dem Ausbruch der Albigenserkriege noch einmal herrliche Blüthen des provenzalischen Dichtergeistes entfalteten» (p. 58). particolarmente significativo per la gran mole di notizie fornite e la sostanziale correttezza delle informazioni. Il nucleo della valutazione di Fauriel e Pratsch è ripreso e argomentato da Pätzold 1897, p. 69, che offre inoltre un ricco repertorio di immagini convenzionali, sentenze, personificazioni che farebbero di FqMars un precursore della lirica convenzionale e manierata dei secoli XIII e XIV: Seine Kanzonen sind keineswegs ohne Geist geschrieben, aber er vergeudet diesen gar zu oft in geschmacklosen Spitzfindigkeiten. Vergebens sucht man bei Folquet den einfachen, ungezwungenen Ausdruck echter Liebesempfindung. [...] Die Lyrik wird, ein Exerzierplatz des Scharfsinns und des Witzes, in eine traurige Schablone gezwängt und entbehrt damit jedes freien dicterischen Schwunges. Sino al lavoro di Stroński, tuttavia, i giudizi oltre che generici e impressionistici, sono fondati su una conoscenza parziale e dispersa del canzoniere folchettiano: ben cinque canzoni, ovvero 155,5 (I), 155,27 (X), 155,10 (XII), 155,11 (XIII) e 155,9 (XV), risultano infatti prive di un’edizione che non fosse diplomatica 183. Si può dire che l’edizione Stroński segni una svolta anche da questo punto di vista, sia perché rende disponibili i materiali completi e affidabili da sottoporre ad analisi, sia perché vi si trova uno studio retorico-letterario ampio e dettagliato e per certi aspetti esemplare. Il cap. XII dell’Étude preliminare su L’art de Folquet contiene infatti un abbondante regesto di aforismi, sentenze, personificazioni, comparazioni, antitesi e paradossi che rendono «très artificiel» lo stile folchettiano (pp. 75*-76*); registra inoltre i motivi letterari e i luoghi comuni reperibili nei testi del trovatore (p. 77*), le riprese dalla tradizione classica (p. 78*-81*) 184 e dalla 183 Altre tre, cioè 155,16 (VIII), 155,17 (XVI) e 155,6 (XVII), si potevano leggere fra gli ungedruckte provenzalische Lieder di Delius 1853 nella versione del ms. S. 184 Questo aspetto merita un approfondimento: secondo Stroński la gran parte delle riprese da autori classici, fra i quali emergono i nomi di Ovidio e Seneca (ma il più citato è il sentenzioso autore di mimi Publilio Siro), provengono «d’un recueil d’aphorismes, d’un florilège tout prêt» (p. 81*), come mostra l’ultimo nome citato. In uno studio classico, Scheludko 1934 ha contestato a Stroński la scarsa valorizzazione dell’influsso ovidiano, assimilato a quello di altri autori classici, quelli sì fruiti attraverso raccolte di sentenze e florilegi: infatti, a un’ipotesi iniziale su una possibile lettura diretta di un autore ‘scolastico’ come Ovidio, fa séguito una sorta di omologazione: «Mais, une fois, avertis, nous sommes autorisés à supposer qu’il aidait sa mémoire, pour cet auteur comme pour les autres, de quelque recueil d’extraits» (p. 81*). Secondo Scheludko, per il quale l’influenza di Ovidio sulla tradizione trobadorica è imponente, «Dies wird besonders klar, wenn wir nicht amputierte Sentenzenteile, sondern ganze Texte beider Dichter miteinander vergleichen» (p. 167; cfr. l’analisi dei rapporti alle pp. 167-70). Lo stesso Stroński non mancherà negli anni dell’esilio londinese di far propria questa tesi: «Il connaît les écrivains latins, surtout leurs sentences recueillies dans les florilèges, et il connaît directement Ovide, dont le livres d’Amores et de l’Ars Amatoria n’ont pas de secrets pour lui» (Stroński 1943, p. 26). Resta il merito dell’editore di aver comunque valorizzato quella presenza: il nome di FqMars era infatti assente nel libro di W. Schroetter, Ovid und die Troubadours, Halle 1908 né lo si trova ancora in M. A.-F. Sabot, Presence d’Ovide au XIIe siècle: poesie latine elegiaque, lyrique provençale, in Colloque présence d’Ovide, édité par R. Chevalier, Paris, «Les Belles Lettres» 1982, pp. 241-60 (che tuttavia ignora anche il saggio di Scheludko). Apre una prospettiva più produzione trobadorica anteriore e coeva (pp. 81*-85*). Il tutto per confermare il giudizio vulgato sul trovatore, non senza una conclusione che introduce la questione nuova dell’originalità di Folchetto (cito da p. 85*): L’originalité de Folquet, qui lui a valu une renommée si considérable, en quoi consiste-t-elle? L’aphorisme et les reminiscences des auteurs latins, la personnification, l’antithèse et le paradoxe étaient connus dans la poésie des troubadours avant lui. Mais il fut le premier à les appliquer dans une mesure aussi large et à leur donner des développements aussi hardis. C’est pourquoi ses poésies se distinguèrent par leur empreinte savante et artificielle et marquèrent un tournant. Et il fit école. La manière simple et naïve de l’ancienne chanson provençale a vécu. Lo spunto è molto interessante ed è certamente da qui che bisogna partire per un’analisi della poesia folchettiana; esso non è stato evidentemente colto da Alfred Jeanroy, che col suo autorevole giudizio negativo ha posto un’ipoteca sul valore estetico della produzione di FqMars difficile da riscattare. Se nel 1903 Jeanroy poteva scrivere 185: le Seicento italien, dans sa fureur de concetti, n’a rien produit de plus laborieusement puéril [...] C’est un chapelet, une cascade d’arguties et de pointes: se fût-on attendu à trouver ici quelque chose comme la chute du sonnet d’Oronte [...]. Dans ce monstrueux amalgame de dialectique et de poésie, il ne reste plus ni poésie ni dialectique, ni sens commun, ni sentiment: ce n’est plus que vaine et glaciale logomachie dopo l’edizione Stroński non fa che ribadire, leggerermente attenuandolo, quel giudizio troppo severo 186: Il se plait à des concetti, dignes du pire seicento. [...] Ce logicien, et ceci est une nouveauté, se pique d’enchaîner ses idées; le lien est au moins formel, et des plus apparents: telle chanson n’est qu’une chaîne de syllogismes se faisant contre-poids. [...] [Le style] de Folquet est souvent plat et sec, et les images qui le traversent ne font qu’en rendre plus sensible le prosaïsme. [...] Je ne nie pas qu’il y ait, çà et là, quelques pensées fines, quelques vers faciles et agréables. Mais ces gracieuses fleurettes, s’épanouissent rarement dans ces terres arides où ne prospèrent que les chardons de la scolastique. Che l’adesione sempre più piena alle linee interpretative dell’editore 187 e la negatività del giudizio estetico siano alla base della limitatissima presenza di ampia il saggio di A. L. Rossi, E pos d’amor plus no·m cal: Ovidian Exemplarity and Folco’s Rhetoric of Love in Paradiso IX, Ten, V (1989), pp. 49-102, che a partire dalla comparazione fra il Folco di Par. IX con Didone, Fillide ed Ercole (vv. 97-102) svolge una densa trama di connessioni intertestuali al fine di mostrare che la posizione del trovatore nel sistema dantesco origina dalle basi ‘ovidiane’ del suo canzoniere. Si veda ora L. Rossi, I trovatori e l’esempio ovidiano, in Ovidius redivivus. Von Ovid zu Dante, hg. von M. Picone - B. Zimmermann, Stuttgart, M&P 1994, pp. 105-48. Non ho visto F. Jensen, Folquet de Marselha and the Classical Tradition, in The Influence of Classical World in Medieval Literature, Architecture, Music and Culture, ed. by F. Fajardo and A. Leviston, New York 1992, pp. 5465. 185 Ne La poésie provençale (la Chanson), «Revue de Deux Mondes», 1.2.1903, pp. 68182 (in cui confluiscono i materiali della tesi De nostratibus medii aevi poetis, Paris 1899). 186 Cito da Jeanroy 1934, II, pp. 150-51; si vedano ancora Jeanroy 1921, pp. 19-20 e 1927, p. 94. FqMars negli studi provenzali è peraltro la tesi espressa da Caroline Locher, in un saggio significativamente isolato sull’arte poetica del trovatore 188: Despite the availability of Stroński’s fine edition, Folquet’s poetry has been virtually ignored. He is poorly represented in modern anthologies. The one major study devoted to Folquet since Stroński’s dates back forty years and is historical rather than literary. Scattered remarks label his style “laborieusement puéril”, or find in it “rien de bien original”. Auerbach goes so far as to see “something tragic” in Folquet’s lack of “spontaneity and overflowing feeling” and his “hollow and blurred” metaphors. No recent studies have sought to correct these post-Romantic condemnations. Si sarà riconosciuta la voce di Jeanroy, mentre il giudizio sull’originalità è di Joseph Anglade 189; quanto a Erich Auerbach, il suo giudizio abbraccia collettivamente «Giraut de Borneill, Folchetto di Marsiglia, Arnaldo Daniello e altri poeti citati da Dante»: nelle loro «manieristiche» poesie viene rintracciato: uno spiritualismo di derivazione neoplatonica, un misticismo fortemente soggettivo, che nella reinterpretazione e sublimazione del fenomeno giunge all’idea, e che pur tuttavia si sforza di mantenere il fenomeno nella sua singola particolarità: nessuno di loro ci è riuscito; la loro spinta espansiva, che riguardava tanto la profondità dell’anima quanto la colorita ampiezza del mondo esterno, non trovò soddisfazione. Il loro metaforismo scivola continuamente, e diventa falso e inesatto, i loro pensieri rimangono nel generico oppure non trattengono l’oggetto particolare, diventano slegati e strani; la struttura, che tende all’unità interna, deve accontentarsi spesso di un surrogato esterno, del tutto superficiale. Tutti hanno una loro tragicità, e questo vale soprattutto per il poeta che Dante ammirava più degli altri, il “miglior fabbro del parlar materno”, Arnaldo Daniello. Ho citato con ampiezza questa pagina 190 per evidenziare il montaggio, un po’ tendenzioso e comunque semplificatorio, operato dalla Locher, nella convinzione che il pensiero di un maestro del rigore di Auerbach possa essere criticato solo se correttamente esposto. Definire poi «The one major study devoted to Folquet since Stroński» il lavoro di Antonio Ricolfi 191 è fin troppo generoso, nonostante le 49 pagine che lo compongono: Folchetto è ritratto come un fedele d’Amore, simpatizzante degli eretici, le cui liriche amorose rivelano il suo duplice volto «dell’innamorato (o del passionale che s’atteggia a tale), e 187 Paradigmatico in questo senso il cappello introduttivo di Riquer 1975 alle poesie raccolte nella sua antologia (cfr. vol. I, pp. 583-87). 188 Locher 1980, pp. 192-93. 189 Nell’Histoire sommaire de la littérature méridionale au Moyen Age (des Origines a la fin du XVe siècle), Paris, De Boccard 1921, p. 82: nelle poche righe dedicate al trovatore, quasi tutte di argomento biografico, si ritrova il giudizio assai positivo sull’alba religiosa «remarquable par l’élévation de la pensée et la simplicité grave de la forme», sebbene a p. 95, n. 4 (e poi a p. 163) pare accettare l’ascrizione a FqRom proposta da Zenker (cfr. infra § 1.2.4 e il Commento a FqMars 155,26 [XXVI] per altri apprezzamenti sul componimento). 190 Dalla trad. it. di Dante als Dichter der irdischen Welt, Berlin-Leipzig 1929 contenuta negli Studi su Dante, [a cura di D. Della Terza], Milano, Feltrinelli 1963, pp. 1-161, alle pp. 47-48; la Locher utilizza la trad. in lingua inglese di R. Manheim (Chigago U.P. 1961), pp. 52-53. 191 Il problema del servizio d’Amore provenzale studiato nelle rime di Folchetto da Marsiglia (I suoi amici, la sua conversione, il catarismo), «Nuova Rivista Storica», XXII (1938), pp. 183-99 e 307-37. quello dell’affarista procacciante» (p. 197); un ‘servente’ che alla sua prima esperienza lirica fa seguire una fase di ribellione ai troppo stretti legami con la setta catara, in cui compone poesie contro Amore, e poi, dopo la conversione, cerca di riscattare il suo passato predicando la vera fede e rendendosi talora complice degli eccidi di Simon de Monfort. Ciò nonostante la Locher ha ragione a lamentare la scarsa attenzione al trovatore: se si eccettuano alcuni lavori di argomento musicale 192 e qualche intervento autorevole, limitato però ad aspetti particolari 193, l’unica voce della bibliografia folchettiana in continua crescita concerne la presenza di FqMars nell’opera dantesca (cfr. supra il § 3.2.2.5.2). Oltre a uno studio di Glynnis M. Cropp sul partimen con Tostemps (= Cropp 1980) e alla relazione di Wendy Pfeffer al primo congresso dell’A.I.E.O., dedicata all’uso del proverbio da parte del trovatore (= Pfeffer 1987; cfr. ora Pfeffer 1997, pp. 44-52) c’è veramente poco altro. Per chiudere questa rassegna vorrei citare integralmente le sole parole spese per il trovatore FqMars da Lafont-Anatole 1970, I, p. 105 (qualcosa di più viene aggiunto altrove sul vescovo di Tolosa): Un homme curieux était ce bourgeois de Marseille, FOLQUET, immensément riche, qui se fit le protégé d’Alphonse d’Aragon, de Raymond V, de Richard Cœur de Lion, et qui entra dans l’ordre de Cîteaux. Il fut abbé du Thoronet et donna de belles chansons religieuses. Nous le retrouvons Evêque de Toulouse en 1205. e ricordare le secche parole di Salvatore Battaglia: «Si pensi [...] alla poesia studiata e arida di Folchetto di Marsiglia, anch’egli [come Peire Vidal] abile artefice di canzoni e lucido discettatore di concetti» 194 per mostrare che anche quando viene trattato il trovatore è tutt’altro che analizzato a fondo. Merita perciò la massima attenzione il lavoro della Locher che si apre con un’esplicita, e, dopo quanto si è detto, quasi sorprendente presa di posizione (p. 192): A figure essential for our understandig of the canso’s structure is Folquet de Marseille. In this paper I will argue that Folquet experimented with several techniques to link as well as subordinate individual stanzas in a carefully planned structure governing the entire canso. This study is intended to help further refine our conception of the canso, as well as to reevaluate a neglected troubadour. In questa prospettiva la tanto invisa propensione di FqMars all’uso di espedienti retorici cessa di essere motivo di svalutazione per costituire invece la ragione stessa della sua non secondaria importanza nella poesia trobadorica. La 192 Oltre a Sesini 1938 e Le Vot 1992, si vedano A. Ricolfi, Su Folchetto da Marsiglia musicista, Con, X (1938), pp. 329-32 (a proposito dell’art. di Sesini) e J. Klobukowska, Contribution à l’étude de la versification et du rythme dans les chansons de Folquet de Marseille, in Actes du 5e congrès international de langue et littérature d’oc e d’études franco-provençales, Nice, 6-12 septembre 1967, Nice, «Les Belles Lettres» 1974, pp. 414-19. 193 Penso all’articolo di R. Lejeune sul viaggio pastorale di Folchetto a Liegi (= Lejeune 1979 [1958]) e ai lavori di Au. Roncaglia, G. Folena e R. Antonelli sulla traduzionerifacimento di Giacomo da Lentini della canzone FqMars 155,4 (XXII) (= Roncaglia 1975, Folena 1991, Antonelli 1987). 194 La coscienza letteraria nel Medioevo, Napoli, Liguori 1965, p. 299. ripetizione morfemica 195 è il principale strumento della tecnica poetica folchettiana: la Locher analizza sei canzoni 196 nelle quali tale ripetizione assume un valore strutturante dell’intero testo, allo scopo di dimostrare che «It is the particular combination of these techniques – none of which is entirely original with Folquet – and their structural function which I believe distinguish Folquet and constitute his contribution to Provençal poetry» (p. 194). Nel rimandare al commento alle canzoni per ulteriori indicazioni, vorrei rimarcare che alla luce del lavoro della Locher la convenzionalità non può più essere assunta come cifra stilistica della poesia folchettiana: non è così, come la studiosa analiticamente dimostra, a livello di organizzazione del discorso, ossia di forma del contenuto, per usare la nota formula hjelmsleviana 197; lo è in parte a livello tematico, ma si è già detto, accogliendo una suggestione di Costanzo Di Girolamo, quanto proprio questo aspetto si riveli decisivo per il valore di modello assunto dal trovatore 198. Non lo è, infine, se si considera in toto la sua produzione poetica: se le mie ipotesi attributive sono corrette, il corpus del trovatore si rivela decisamente più vario ed eterogeneo di quanto sia il canone proposto da Stroński. Senza dire che l’estribot 155,25 (XXV) e i rapporti personali e intertestuali con un trovatore-giullare come Palais rivelano una vena ‘giocosa’ dell’altrove austero poeta che contribuisce non poco a variegare la sua personalità poetica 199. Un’analisi complessiva del corpus folchettiano, per quanto si è detto sinora, è un obiettivo che occorre raggiungere al più presto: il lavoro della Locher, che non poteva non essere limitato alle grandi canzoni d’amore, e gli spunti sparsi in questo Studio introduttivo e nelle note di commento ai testi editi qui di séguito possono costituirne il punto di partenza. 195 La Locher utilizza la definizione di morphemic repetition proposta da Smith 1976: questi individua anche tre sotto-tipi fondamentali (cito la sintesi della Locher a p. 193): «“composition” (“etymological figure by prefixation”), “morphological figure” (“different inflections of one word”), and “etymological figure” (“a common root in different words or parts of speech”)». 196 Nell’ordine di analisi: FqMars 155,14 (IV), in una sorta di prologo alle pp. 193-94, quindi 155,16 (VIII): pp. 195-97; 155,3 (VI): pp. 197-99; 155,1 (V): pp. 199-202; 155,18 (III): pp. 202-203; 155,8 (XI): pp. 203-205: i primi 4 testi, in décasyllabes, non presentano rilevanti variazioni dell’ordine strofico nella tradizione manoscritta, a riprova di una struttura sintagmatica forte, mentre «sequence variations for the fifth are rendered unimportant by a rime scheme which unmistakably dictates the correct order» (pp. 194-95). 197 L. Hjelmslev, I fondamenti della teoria del linguaggio, Torino, Einaudi 1968. 198 Si veda supra il § 3.2.2.1 sulla fortuna di FqMars in Occitania. 199 Per questi aspetti si vedano supra i §§ 3.2.1.2.1-3. Si ricordi che PVid invia la canzone Ajostar e lassar a FqMars perché «la chant en bon loc per me» (cfr. § 3.2.1.2.4 e Meneghetti 1992, p. 68, n. 164). Postilla 2009 Sulla questione dell’identificazione dell’Imberaldo del Balzo con Barral di Baux (§ 3.1.1) si veda Meneghetti-Segre 2000, p. 316 n. 11. Su GlAnd 203,1 (§ 3.2.2.1.2) Guida 2002, pp. 317 e 319. Numerosi e rilevanti sono ora gli studi sui rapporti dei Siciliani con i trovatori, e in particolare con Folchetto, sviluppati intorno alla nuova edizione delle liriche siciliane e siculo-toscane di AntonelliDi Girolamo-Coluccia 2008 e agli studi sui canzonieri lirici duecenteschi in Leonardi 2001: oltre a Squillacioti 2000 e 2005 e alla bibliografia in Squillacioti 2003, pp. 49-51 (in cui sono rilevanti per Folchetto i lavori di Ramazzina 1998, Brugnolo 1999 e 2000, Latella 1999, Giannini 1999 e 2000), segnalo ora Santini 2003. Sulle riprese folchettiane di Dante (§ 3.2.2.5.2), rinvio ancora alla bibliografia in Squillacioti 2003, pp. 51-53, a Beltrami 2004 e a Asperti 2004, in partic. pp. 74-81. Ho approfondito la proposta di vedere in Folchetto il personaggio della novella IV 3 del Decameron (§ 3.2.2.5.4) in Squillacioti 2000. Sulle riprese dei trovatori da parte dei Minnesänger si veda ora Meneghetti 2003 (su FqMars le pp. 381-82). Un primo accenno di quell’analisi della poesia folchettiana posta come obiettivo alla fine del capitolo è nell’Introduzione a Squillacioti 2003.
Scarica