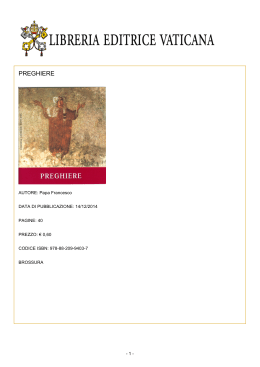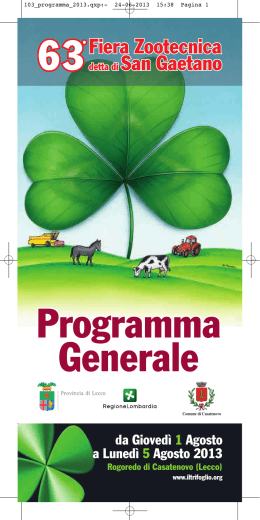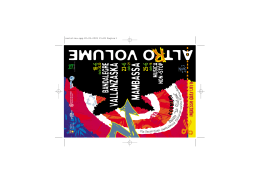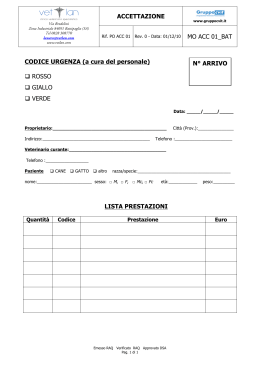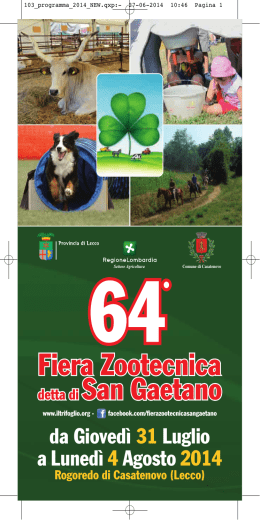Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 Saggi. Storia e scienze sociali 13:21 Pagina i Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina ii Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina iii PENSARE LA NAZIONE Silvio Lanaro e l’Italia contemporanea A cura di Mario Isnenghi Premessa di Carlotta Sorba Saggi di Giulia Albanese, Margherita Angelini, Giampietro Berti, Piero Brunello, Gian Piero Brunetta, Renato Camurri, Guido Crainz, Umberto Curi, Cesare De Michelis, Tommaso Detti, Carmine Donzelli, Enrico Francia, Emilio Franzina, Mario Isnenghi, Simon Levis Sullam, Salvatore Lupo, Rolf Petri, Maurizio Reberschak, Mariuccia Salvati, Carlotta Sorba, Gilda Zazzara DONZELLI EDITORE Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 © 2012 Donzelli editore, Roma via Mentana 2b INTERNET www.donzelli.it E-MAIL [email protected] ISBN 978-88-6036-742-6 Pagina iv Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina v PENSARE LA NAZIONE Indice p. IX Premessa di Carlotta Sorba Parte prima. I temi 3 Voci di uomini, sguardi di donne. Venezia, primavera 1848 di Piero Brunello 17 Predicare la rivoluzione. L’oratoria politico-religiosa nel Risorgimento di Enrico Francia 29 Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi di Rolf Petri 49 Delle emigrazioni e della loro diversa indole nella storia antica e moderna. Storiografia e ricerca storica «in movimento» di Emilio Franzina 77 Governare la trasformazione: il moderatismo riformatore di Fedele Lampertico di Renato Camurri 93 La Grande guerra e la crisi della civiltà europea. Riflessioni del tempo di Giampietro Berti 111 Alla scuola del fascismo: la Spagna dei primi anni venti e la marcia su Roma di Giulia Albanese 123 Gli italiani e il fascismo. Una testimonianza, un commento e… una dedica di Mariuccia Salvati V Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina vi Pensare la nazione 135 Contadini e, quindi, italiani: l’Enciclopedia Italiana (1929-1938) di Margherita Angelini 151 Internet e la globalizzazione contemporanea di Tommaso Detti 161 Over There di Gian Piero Brunetta Parte seconda. I libri 175 Rileggendo Nazione e lavoro di Salvatore Lupo 183 Nazione e regione. La Storia delle regioni Einaudi e Il Veneto di Silvio Lanaro di Carmine Donzelli 197 La storia della «prima Repubblica» riletta alla fine della «seconda» di Guido Crainz 207 Retorica e politica. I percorsi di uno storico di Carlotta Sorba Parte terza. Silvio 217 Lanaro, l’«impolitico» di Umberto Curi 225 Anni sessanta di Cesare De Michelis 233 Convergenze (e divergenze) parallele di Maurizio Reberschak 253 Pensare in grande: storia, politica, amicizia Conversazione con Mario Isnenghi di Simon Levis Sullam e Gilda Zazzara 267 Indice dei nomi 273 Gli autori VI Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 Pensare la nazione 13:21 Pagina vii Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina viii Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina ix PENSARE LA NAZIONE Premessa di Carlotta Sorba Ci sono storici che segnano con la propria produzione e le proprie interpretazioni una stagione storiografica e credo ci siano pochi dubbi sul fatto che Silvio Lanaro sia stato uno di questi. I suoi libri sono stati letti e ammirati, discussi e anche fortemente criticati, ma mai ignorati e sempre abbondantemente citati. Quale migliore occasione del settantesimo compleanno del loro autore per rileggerne i temi, le traiettorie, i passaggi? Questo volume vuole essere un omaggio allo studioso che ci ha regalato molte pagine importanti sulla storia italiana (e francese), ma è anche un modo di ripercorrere alcuni degli interrogativi che più sono stati presenti nei suoi studi, di rimetterne a fuoco le interpretazioni e in fin dei conti di iniziare a riflettere sui percorsi di quella generazione di storici il cui lavoro ha preso forma nell’Italia degli anni sessanta, cioè in un momento di trasformazione profonda della disciplina. A scriverlo, con il supporto prezioso dell’editore-autore Carmine Donzelli, sono stati alcuni amici, colleghi e allievi riuniti in questa impresa collettiva dall’amico di sempre Mario Isnenghi, che lo ha articolato lungo una traiettoria che va dal generale al particolare, dal sondaggio di alcuni terreni tematici da Lanaro prediletti fino alla scala personale dei frammenti di vita. La prima parte del volume si trova così a coprire, non a caso, un arco cronologico molto ampio. Come scrive Salvatore Lupo nel suo intervento, ben pochi storici hanno saputo come Lanaro ragionare su tutto l’arco della storia nazionale, dal Risorgimento fino all’Italia repubblicana. E farlo così lucidamente e fruttuosamente per periodi tanto diversi. Alla rilettura di alcuni dei suoi libri o dei suoi saggi è dedicata la seconda parte del volume, nella convinzione, condivisa dagli autori senza saperlo, che il tempo trascorso abbia fatto assumere una luce in parte nuova a molte di quelle pagine. A chiudere il quadro troIX Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina x Carlotta Sorba viamo infine una serie di contributi che del personaggio colgono i talenti particolari ma anche le idiosincrasie o i vezzi propri di una personalità indubbiamente non comune. A fungere da filo rosso del libro è la nazione, e non mi pare avrebbe potuto essere altrimenti. Intorno all’idea, alle pratiche e agli agenti della nazionalizzazione Lanaro ha in effetti articolato buona parte dei suoi lavori; lo ha fatto anticipando la grande stagione internazionale degli studi su nazioni e nazionalismi, e soprattutto distaccandosi dalla storiografia progressista italiana del secondo dopoguerra, che fino a quel momento aveva trascurato o visto con sospetto la messa a fuoco di quel tema. Con Nazione e lavoro, il suo libro più noto e più profondamente innovatore, alla fine degli anni settanta Silvio Lanaro sceglieva invece, con la risolutezza che gli è propria, di assumere nazionalizzazione e modernizzazione come perni di una lettura della storia postunitaria che rifuggiva dalla consueta ricerca delle «tare» nazionali per ricostruire le vie particolari allo sviluppo assunte e perseguite dalle classi dirigenti italiane. Una grammatica dell’egemonia che egli individuava lungo un percorso accidentato e complesso che collega protezionismo, nazionalismo e fascismo. I saggi che si presentano qui si soffermano su questa e su altre linee della sua produzione mostrando come uno dei suoi caratteri più forti sia stato quello di pensare in grande – uso le parole di Isnenghi nella lunga intervista finale – ossia affrontare domande di alto profilo non accontentandosi mai delle risposte consolidate o più ovvie o più «consolanti», per citare dal testo-dedica qui proposto da Mariuccia Salvati. Lo ha fatto come sappiamo utilizzando per lo più scale geografiche molto diverse: uno sguardo almeno virtualmente comparato con la Francia, ma anche e soprattutto una messa a fuoco specifica sul Veneto. La presenza di quest’area territoriale è ovviamente molto forte nelle varie parti del libro, sia come fucina di un’intellettualità in quegli anni straordinariamente vivace e produttiva, sul piano culturale e politico (e dai tratti, mi sia concesso, eminentemente maschili), sia come osservatorio privilegiato assunto da un intero gruppo di studiosi per capire le traiettorie complesse del caso italiano. Ci si può chiedere anzi se proprio la provenienza di Silvio Lanaro dalla periferia di quella periferia (tra Schio e Malo) abbia reso possibile o comunque agevolato la costruzione di quello sguardo acuminato e sottile che egli ha saputo rivolgere verso una realtà politica e sociale che sembra muoversi non in un percorso più o meno diretto verso la modernità, ma procedendo per vie tortuose, e conciliando l’apparentemente inconciliabile. Da qui X Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina xi Premessa forse anche la sua particolare capacità di comprensione del mondo cattolico, veneto e italiano; o di analisi del fascismo come fenomeno essenzialmente moderno; o di indagine del ruolo dello Stato come possibile agente di progresso; e al contrario la sua sostanziale presa di distanza dalle interpretazioni «trionfalistiche» del Sessantotto (un aspetto su cui si sofferma Guido Crainz per mostrarne gli aspetti lucidamente premonitori degli sviluppi edonistici degli anni ottanta). Il fatto di essere un intellettuale laico e progressista, dai tratti aristocratici e dall’ironia pungente, non ha in sostanza condizionato il suo tentativo di comprendere la società italiana nella sua estrema complessità, come sappiamo ben poco laica e progressista. Eppure non mancano certo nel suo lavoro le implicazioni forti sul presente, spesso nuovamente incentrate su quella nazione che nella sua produzione finisce per acquistare anche una rinnovata dignità politica. Se non esplicitamente, almeno sotto traccia vi ritroviamo infatti un sottile rimpianto per la perdita di un’idea nazionale nel secondo dopoguerra o quantomeno per l’incapacità dimostrata dalle élites dirigenti nell’attribuire alla cittadinanza repubblicana un valore nazionale. Ulteriore elemento di originalità del suo lavoro è un metodo di indagine e di analisi storica in cui hanno costantemente interagito punti di vista diversi: la cultura e il dibattito delle idee, ma anche il loro farsi sforzo pedagogico e normativo e immaginario sociale, in un impasto di storia sociale e storia culturale tanto attuale oggi quanto raro e anticipatore negli anni settanta e ottanta. Un approccio a più dimensioni che si coniuga, lo scrive Umberto Curi, con una rara capacità di andare al cuore dei problemi. Se è del tutto evidente che i suoi lavori hanno contribuito a rinnovare la storiografia italiana, rimane tuttavia l’impressione che molte delle suggestioni provenienti dai suoi libri siano state sviluppate in maniera settoriale e frammentaria. Le tante strade che ha aperto o ha sollecitato – con uno sguardo privilegiato sulle classi e le culture dominanti ma non dimenticando quelle popolari, come mostra qui il percorso di Emilio Franzina – raramente hanno trovato una ricomposizione in un’analisi d’insieme della cultura liberale e postliberale italiana1. Non possiamo infine dimenticare che Silvio Lanaro è stato anche un docente dalle notevoli capacità di fascinazione sui giovani e alla loro formazione si è dedicato con una generosità e un’attenzione tali da 1 Nel giugno del 2003 abbiamo dedicato un seminario padovano all’eredità di Nazione e lavoro. In quella occasione le relazioni di Michele Nani, Laura Cerasi e Simona Urso hanno fornito molte sollecitazioni importanti sulle diverse piste di ricerca aperte dal volume. XI Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina xii Carlotta Sorba meritare una notevole notorietà e un vero affetto da parte degli studenti, oltre che capaci di supplire alla sua congenita mancanza di organizzazione. All’ateneo di Padova, alla Facoltà di Lettere e filosofia e al Dipartimento di Discipline storiche ha insomma dato molto, in termini di prestigio intellettuale ma anche di intelligenza e di lungimiranza nelle scelte, da ultimo divenendo promotore di una rete di studiosi appartenenti ad atenei diversi ma uniti dalla volontà di promuovere e valorizzare gli studi di storia culturale2. È con un grazie convinto per tutto questo che il Dipartimento padovano di cui faccio parte (ora di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità) e il suo direttore Giovanni Luigi Fontana hanno voluto contribuire alla pubblicazione di questo libro. La cui realizzazione è stata resa possibile anche dalla partecipazione affettuosa di Emilio Franzina del Dipartimento TeSIS dell’Università di Verona. Padova, 2 giugno 2012 2 Nel marzo del 2009 Silvio Lanaro ha tenuto a battesimo con una giornata di studio intitolata Metonimie. La storia culturale in Italia il costituendo Centro interuniversitario di storia culturale (Csc) che da allora raccoglie in attività seminariali, convegnistiche e di ricerca numerosi studiosi appartenenti agli atenei di Bologna, Padova, Pisa e Venezia. XII Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp Parte prima I temi 7-06-2012 13:21 Pagina 1 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 2 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 3 PENSARE LA NAZIONE Voci di uomini, sguardi di donne. Venezia, primavera 1848 di Piero Brunello Alla domanda se i rapporti tra uomini e donne siano stati segnati dai moti rivoluzionari della primavera del 1848, risponderei di sì. Del resto i club politici – che ebbero un momento di grande sviluppo in Italia e in Europa proprio nel Quarantotto – sono «una forma di sociabilità esclusivamente maschile»1. Mi limiterò ad avanzare alcune ipotesi di ricerca relativamente al caso veneziano, concentrandomi sui processi di costruzione della mascolinità. Dopo aver accennato alle distanze socialmente codificate tra uomini e donne, e dopo aver preso a indizio dei rapporti tra i generi gli usi del canto all’aperto, suggerisco d’interpretare le manifestazioni di febbraio-marzo 1848 a Venezia come riti di virilità. Per quanto rozza, e in mancanza di meglio, utilizzerò la distinzione tra popolo e classi alte. 1. Usi dello spazio. A Venezia, attorno alla metà dell’Ottocento, i luoghi d’incontro tipicamente borghesi – come il Gabinetto di lettura, l’Ateneo veneto e l’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti – riuniscono uomini delle professioni, separandoli dalle donne. In alcuni caffè riservati a un pubblico d’élite le donne delle classi alte non mettono piede: per esempio al caffè Florian o al caffè Suttil, in piazza San Marco, le donne prendono il caffè o il gelato rimanendo sotto le Procuratie nuove2. In città 1 M. Agulhon, Il salotto, il circolo e il caffè. I luoghi della sociabilità nella Francia borghese (1810-1848), a cura di M. Malatesta, Donzelli, Roma 1993, p. 68. 2 Hand-book for Travellers in Northern Italy, Murray, London 18524, p. 299. L’abitudine è confermata da Effie Ruskin in Effie in Venice. Unpublished Letters of Mrs. John Ruskin Written from Venice between 1849 and 1852, a cura di M. Lutyens, Pallas Editions, London 1999 (1965), p. 65. 3 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 4 Piero Brunello funziona un istituto musicale privato che impartisce lezioni di pianoforte sia a ragazzi che a ragazze, ma in orari differenti3. E i bagni di mare, alla punta della Dogana e alle Zattere, sono distinti: uomini da una parte, donne dall’altra. Come racconta Camillo Boito nella novella Senso, un ufficiale intraprendente poteva nuotare sott’acqua e arrischiarsi nella vasca destinata alle donne: ma non viceversa. Nelle classi alte, gli uomini si muovono agevolmente in città, anche da soli; le donne passeggiano invece a braccetto del marito e tenendo per mano il figlio. Le donne giovani, anche quando sono assieme a un accompagnatore o con una domestica, sono seguite dai commenti e dagli sguardi degli uomini che incontrano. Effie Ruskin, che a vent’anni arrivò con il marito a Venezia nell’autunno del 1849, andava a passeggio in piazza San Marco con l’amica Charlotte e spesso con un veneziano che parlava un buon inglese, a cui talvolta si aggiungeva un altro uomo che faceva da segretario a John Ruskin. Anche così le due donne erano assillate da uomini che le seguivano con parole e con gesti che a Effie sembravano indice della scarsa opinione che gli italiani avevano delle loro donne (ma neanche lei sembra averne una migliore): secondo Effie, gli uomini a Venezia pensavano che anche le due donne straniere fossero poco serie come le italiane4. Quindici anni dopo, il console statunitense Howells osservò che una giovane donna non si sentiva mai del tutto protetta neanche dalla presenza della governante: «Una donna, a Venezia, nella pubblica strada, deve far fronte a sguardi talmente espliciti da parte di uomini di ogni età da considerarli poco meno di un oltraggio. Quando una giovane donna incrocia un uomo, lui la fissa. Ho visto uomini che si girano per osservarla, oppure che le si avvicinano di lato con passo tranquillo e non le staccano gli occhi di dosso»5. Uomini che importunano donne per la strada, insomma: ma non viceversa. Nelle case private borghesi o aristocratiche, dove si tenevano serate musicali, uomini e donne tendevano a rimarcare le reciproche distanze. Durante il carnevale del 1850, Effie Ruskin partecipò a un concerto privato in un palazzo vicino a Rialto. Alle otto di sera uscì di casa con un vestito di seta rosa, rose di velluto tra i capelli, un giacchino di velluto blu con guarnizioni di pizzo nero. Come arrivò, 3 Era l’istituto musicale privato aperto nel 1838 da Giuseppe Camploy in campo San Paternian. J. F. Lecomte, Venezia. Colpo d’occhio letterario, artistico, storico, poetico e pittoresco sui monumenti e curiosità di questa città, Venezia 1844, pp. 635-6. 4 Ruskin, Effie in Venice cit., p. 100; il veneziano si chiamava Carlo Blumenthal. 5 W. D. Howells, Vita veneziana. Diario di un giovane diplomatico americano nella Venezia di metà Ottocento, trad. it. di R. Pestriniero, Elzeviro, Treviso 2005, p. 327. 4 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 5 Voci di uomini, sguardi di donne. Venezia, primavera 1848 trovò gli uomini già sistemati nella sala del concerto. Le donne aspettavano invece sedute ai quattro lati di un salotto accanto, al di là di una tenda di seta. Terminate le presentazioni (Effie era arrivata a Venezia da soli due mesi), le donne si spostarono nella sala del concerto, e occuparono due file di sedie di fronte ai musicisti. Gli uomini rimasero in piedi dietro, parlando tra di loro. Tra un brano musicale e l’altro gli uomini andavano a fare conversazione con le donne che conoscevano: ma non viceversa6. Negli spazi urbani vediamo infine muoversi sia uomini sia donne del popolo: donne che portano secchi d’acqua, contenitori del latte, ceste di biancheria, gerle con oggetti di legno; impiraresse che infilano perle sedute fuori casa; facchini, barcaioli, artigiani, gondolieri, seggiolai, venditori di zucche o pere cotte; bambini che giocano o che nella bella stagione si tuffano e nuotano nei canali; cantastorie (spesso marito e moglie) che suonano sotto le finestre dei palazzi o nei luoghi di passaggio7. I caffè meno rinomati e le osterie popolari a volte erano gestiti da donne8. Gli uomini vi passavano il loro tempo alla fine della giornata o nelle pause del lavoro, mangiando, bevendo e chiacchierando9. Era lì che si davano appuntamento gli amanti10. In generale le classi alte ritenevano che nelle classi popolari i rapporti tra uomini e donne fossero meno rigidi. Effie Ruskin ebbe questa impressione assistendo alla scena della sua servitù che nella grande 6 Ruskin, Effie in Venice cit., pp. 121-2. Il concerto si teneva a casa del dottor Carlo Marzari. 7 Penso alle scene raffigurate nelle incisioni dell’epoca, in primo luogo di Eugenio Bosa e di Giovanni Pividor, su cui cfr. N. Silva, Frammenti di una società. Eugenio Bosa e Giovanni Pividor artisti e testimoni della Venezia ottocentesca, tesi di laurea, rel. P. Brunello, Università Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 2006-2007. Sul fatto che il limite tra pubblico e privato nell’ambiente popolare fosse «fluttuante» e segnato «dai confini della calle o della corte più che dalle porte delle singoli abitazioni» cfr., anche se relativamente al Novecento, N. M. Filippini, Storia delle donne. Culture, mestieri, profili, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, a cura di S. J. Woolf e M. Isnenghi, II, L’Ottocento. 1797-1918, a cura di S. J. Woolf, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 2002, pp. 1630-31. 8 Il caso di una caffetteria a San Luca, gestita da una giovane donna sposata, Domenica Veronese detta Cupido, che il parroco di San Silvestro fece diffidare dalla polizia perché accusata di attirare «giovinastri» e di traviare uomini sposati di buona famiglia, in F. Bortoluzzi, Il precetto politico (1813-1850), in Amministrazione della giustizia e controllo sociale nel Lombardo-Veneto, a cura di C. Povolo e G. Chiodi, Cierre, Verona 2007, p. 281. 9 Sebbene per un periodo successivo: cfr. A. Casellato, I sestieri popolari, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento cit., II, pp. 1593-4; cfr. E. Zorzi, Osterie veneziane, Filippi, Venezia 1928. 10 Un caso relativo alla vendita di vino del Leone alle Zattere, dove un orefice sposato con tre figli s’incontrava con una ragazza fino a tarda sera (sia la sorella di lei sia il parroco dei Frari si lamentarono con la polizia che diffidò la coppia dal continuare la relazione), in Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi Asv), Direzione generale di polizia, 1848, VII/2, Sorvegliati e sospetti, n. 6 [b. 126 in gessetto], n. 6080. 5 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 6 Piero Brunello cucina del palazzo dov’era alloggiata ballava la manfrina, in cui la donna appoggiava le mani sulle spalle del compagno11. 2. Canzonette, stornelli, inni. Quando cantavano, uomini e donne del popolo avevano un repertorio distinto. Per cominciare, l’abitudine di cantare in coro all’aperto era un’usanza soprattutto delle donne. Nelle loro canzoni, dette «canzonette», le donne parlavano d’amore, oppure prendevano in giro le donne degli altri sestieri: la lingua usata era il veneziano o un italiano modellato sul dialetto. Anche gli uomini potevano cantare in coro, per esempio per accompagnare il ritmo del lavoro, come conficcare pali nei canali. Alcuni rituali folklorici erano prerogativa di gruppi di giovani maschi: compagnie di giovanotti facevano la serenata sotto le finestre delle ragazze o giravano per la città suonando strumenti musicali per annunciare il nuovo anno. Ma, stando almeno ai primi raccoglitori di canti popolari, le voci maschili erano perlopiù voci di solisti. Cantava il pescatore, sia in barca sia sulla riva mentre aspettava di uscire in laguna o in mare; i gondolieri si sfidavano a stornelli, a una certa distanza l’uno dall’altro12. I canti popolari avevano spesso un registro basso, doppi sensi e allusioni sessuali. Il patriarca di Venezia non mancava d’intervenire presso il governo per far richiamare e punire i suonatori ambulanti che cantavano canzoni con allusioni oscene13. Ma anche le classi alte prendevano le distanze. «Parecchi i sudici e gl’impertinenti», avverte il primo studioso che proprio nel 1848 raccolse i canti popolari veneziani14. E pochi anni prima, due autori che avevano scritto sullo stesso argomento parlavano di «canzonacce», «vuote e licenziose», in cui la donna era «avvilita e vituperata»15. Se a Venezia di solito erano soprattutto le donne a cantare in coro all’aperto, con la rivoluzione – ecco una novità del 1848 – a farlo sono invece gli uomini. I repertori popolari non erano ritenuti adatti a Ruskin, Effie in Venice cit., p. 241. A. Dalmedico, Canti del popolo veneziano, Antonelli, Venezia 1848, p. 207. 13 Un esempio in Asv, Presidio di governo 1840-44, I 19/88. 14 Dalmedico, Canti del popolo veneziano cit., p. 207. 15 I. V. Foscarini detto El Barcariol, Canti del popolo veneziano, illustrati con note da G. Pullé, Venezia 1844, pp. VIII-IX. L’autore parlava di «disoneste e stonate cantilene, onde abbiamo nauseati e frastornati tutto il giorno gli orecchi» (p. XIV). 11 12 6 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 7 Voci di uomini, sguardi di donne. Venezia, primavera 1848 esprimere i sentimenti patriottici che si andavano allora diffondendo16, e vennero sostituiti da composizioni in un italiano colto, provenienti dalle classi alte. Gli inni e i pezzi d’opera soppiantarono le canzonette, e i cori maschili quelli femminili: in altre parole compagnie di uomini si ripresero lo spazio pubblico e relegarono le donne nell’ambito domestico. Divenuto ministro dell’Istruzione pubblica, Tommaseo suggerì di limitare il numero di ore di studio e di scuola per le bambine, evitando in particolare l’orario spezzato di mattina e di pomeriggio, che avrebbe obbligato «le fanciulle» a passeggiare in strada per quattro volte al giorno «non senza scapito, se non del raccoglimento e del pudore, almeno del tempo». Per i maschi, viceversa, il consiglio non valeva17. 3. Riti di virilità. Il tardo pomeriggio di un giorno di carnevale del 1848 un gruppetto di giovani che stava facendo il giro delle Procuratie in piazza San Marco si fece notare per il chiasso e perché molti di loro tenevano in bocca una pipa bianca di gesso rivolta all’ingiù. Da San Marco continuarono per le zone del centro, battendo il passo come militari. Chi non aveva una pipa se la comprò per strada. Faceva freddo, i ragazzi portavano il mantello. Gridavano: «Abbasso il sigaro!». In riva degli Schiavoni, dopo un battibecco con alcuni soldati, uno dei giovani, tenendo in mano un bastone, si mise alla testa del gruppo e gridò in tedesco: «Rechts um!», cioè «Fianco destro!». In fila per due, ripresero il passo di marcia, passando in mezzo alla folla che si aggirava tra i Casotti di carnevale. Altri ragazzi si aggiunsero ai primi. Di ritorno in piazza, da sette-otto che erano all’inizio, erano diventati una trentina. Si recarono in un’osteria nella vicina Calle del Ridotto e ordinarono da bere. All’uscita dal locale le guardie ne arrestarono diciotto: il più giovane di tredici anni, il più vecchio di venti. Gli altri riuscirono a non farsi prendere. 16 Il «Caffè Pedrocchi», un giornale padovano che sarebbe stato chiuso dal governo austriaco, suggerì di aprire scuole di musica la domenica per insegnare al popolo, a cominciare dai bambini, a cantare in coro, sostituendo il repertorio popolare, fatto di «vuote e licenziose ballate» e di «canzonacce oscene», con inni patriottici e religiosi. T. Z., Scuole festive di canto, in «Caffè Pedrocchi», III, 1848, 6 febbraio 1848, 5. 17 Lettera di N. Tommaseo all’ispettore delle scuole elementari, 6 giugno 1848, in Raccolta per ordine cronologico di tutti gli Atti, Decreti, Nomine ecc. del Governo Provvisorio di Venezia non che Scritti, Avvisi, Desiderj ecc. dei Cittadini privati che si riferiscono all’epoca presente, Andreola, Venezia 1848, II, p. 262. 7 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 8 Piero Brunello L’episodio era un rito di carnevale: pochi giovani partivano a braccetto e al grido «tacca, tacca» («attacca, attacca»), altri si aggiungevano in coda tenendosi uno al braccio dell’altro, di modo che il corteo andava man mano allungandosi. La pipa bianca chioggiotta, usata di solito da uomini di una certa età, faceva ridere: oltretutto era messa all’ingiù. Ma quella pipa messa all’incontrario e le grida «abbasso il sigaro» trasformavano un rito tradizionale in una protesta politica, perché alludevano chiaramente al boicottaggio del fumo che da Milano si stava diffondendo in tutto il Lombardo-Veneto. Inoltre i giovani cantavano quelli che la polizia definì «alcuni cori d’opera di un tenore equivoco». Si trattava di cori di tre opere di Giuseppe Verdi: il Va’ pensiero (Nabucco, 1842), O Signore dal tetto natio (I Lombardi alla prima crociata, 1843) e Si ridesti il Leon di Castiglia (Ernani, 1844). La polizia individuò nel corteo due gruppi di giovani: uno composto perlopiù da studenti del ginnasio-liceo di Santa Caterina, che abitavano nelle zone centrali della città e avevano avuto l’idea, e un altro, composto invece di «artisti», cioè artigiani e garzoni che abitavano alla Bragora, non lontano da piazza San Marco ma già nel sestiere popolare di Castello, e che si era unito al corteo in un secondo momento18. Se si leggono gli interrogatori di polizia19, si intuisce che fin dall’età di quattordici-quindici anni i giovani maschi crescevano in gruppi maschili, basati sul mestiere e sui legami di vicinato. Gli studenti del ginnasio-liceo di Santa Caterina – sui quali abbiamo più informazioni – erano soliti incontrarsi il tardo pomeriggio nei caffè. Ogni compagnia ne frequentava uno in particolare. Due fratelli potevano frequentare due caffè diversi, con rispettivi gruppi di amici. Lì giocavano a scacchi, a domino e a bigliardo, leggevano i giornali, bevevano e discutevano. Di solito i caffè avevano una stanza riservata, dove potersene stare indisturbati senza la presenza di altri avventori, e dove poter fumare. Fin dall’età del ginnasio i ragazzi cominciavano infatti a fumare il sigaro e a darsi arie da grandi. Se uno studente passa i pomeriggi al caffè, la sorella resta a casa. Le donne si adattavano alle esigenze della famiglia paterna. La coabitazione con i genitori dopo il matrimonio riguardava un terzo degli sposi, ma quando uno dei due genitori moriva era la donna a rimanere in casa: rinunciando a sposarsi quando moriva il padre, e sposandosi ma 18 A. Bernardello, Venezia 1847-1848: patria e rivoluzione. Gruppi dirigenti e classi popolari, in «Il Risorgimento», 2002, 3, pp. 373-416. 19 Asv, Direzione Generale di Polizia, 1848, VII/2, Sorvegliati e sospetti, b. 124, Atti 2 febbraio 1848-49 febbraio 1848; cfr. anche Asv, Presidio di governo. Geheim, b. 66, A 10/114; ivi, b. 65, A 10/95. 8 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 9 Voci di uomini, sguardi di donne. Venezia, primavera 1848 continuando ad abitare in casa quando moriva la madre20. Non ci sono ricerche sulle diverse opportunità di studio e di lavoro di fratelli e sorelle delle classi popolari, ma si può partire dalla vicenda raccontata nel romanzo di Seismit-Doda, I volontarii veneziani: il figlio maschio primogenito di un arsenalotto (un po’ gracile e malaticcio) si iscrive alla facoltà di Legge a Padova, il secondogenito va a lavorare all’arsenale come il padre e si arruola granatiere nell’artiglieria di marina, mentre la sorella impara dalla madre a «lavorare di bianco», cioè a confezionare camicie e vestiti su commissione, per poi finire in un negozio di abiti con la paga di due lire al giorno21. Si può cogliere nel corteo del 2 febbraio 1848 quello che è stato ravvisato in analoghi riti giovanili, e cioè «una clausola tragica, quella del tributo di sangue, del contratto che unisce lo Stato moderno alla sua gioventù»22: almeno tre studenti che partecipavano al corteo entrarono infatti qualche settimana dopo a far parte della guardia civica23. Ma quel corteo a passo di marcia era contemporaneamente un rito di virilità. Uno dei cartelli che giravano in quel periodo tra gli studenti del ginnasio-liceo di Santa Caterina contro le guardie di polizia (i «piantoni») diceva: «D’accordo ragazzi/ Peléve i cojoni/ Per farghe i penacchi/ A questi piantoni»24. 4. Sguardi di donne italiane. Se dovessi scegliere una metafora per illustrare l’ipotesi di ricerca che sto suggerendo, indicherei le riunioni del Circolo italiano a Venezia, aperte solo agli uomini, ma con una speciale piattaforma da cui le donne potevano guardare e ascoltare25. Il Quarantotto appare in questo modo un’occasione in cui gli uomini adulti stanno tra uomini e occupano lo spazio pubblico, ma in modo da essere visibili agli occhi delle donne26. 20 R. Derosas, Matrimoni e relazioni familiari nella Venezia di metà Ottocento, in «Popolazione e storia», 2002, 1, p. 47. 21 F. Seismit-Doda, I volontarii veneziani. Racconto storico, F. de Lorenzo, Torino 1852, pp. 30-1. 22 D. Fabre, Il paese dei giovani, in Storia dei giovani, II, L’età contemporanea, a cura di G. Levi e J. C. Schmitt, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 86. 23 Bernardello, Venezia 1847-1848 cit., p. 386. 24 Biblioteca Museo Correr di Venezia, Documenti della polizia austriaca, VII (1848), n. 871. 25 P. Ginsborg, Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49, Einaudi, Torino 20072 (Feltrinelli, Milano 1978), p. 308. 26 Questo rapporto tra i generi viene codificato nel corso delle guerre nazionali, che videro la partecipazione dei volontari. George L. Mosse ha portato a esempio la figura di Theodor Körner il quale «ammonì, in una poesia, che coloro che si fossero rifiutati di partire volontari non sarebbero mai più stati baciati da una ragazza tedesca né rallegrati da una canzone o dal buon vino tedeschi». G. L. Mosse, Sessualità e nazionalismo. Mentalità borghese e rispettabilità, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 26. 9 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 10 Piero Brunello Quali donne? La madre, anzitutto. Giuseppe Vollo, trentun anni, scrittore e insegnante supplente in una scuola tecnica, il 18 marzo si arruola nella guardia civica ed esce di pattuglia. E di che cosa si preoccupa? Di rassicurare la madre, tramite Tommaseo, un uomo che per l’età poteva essere suo padre27. Le sorelle, in secondo luogo. Emilia, figlia di Daniele Manin, assiste al canto del Te Deum nella basilica di San Marco il 23 marzo 1848, sentendo «un peso continuo […] sul cuore», senza saperne il motivo: forse per essere solo una spettatrice? Il giorno prima il padre era uscito per recarsi all’arsenale portando con sé suo fratello Giorgio, sedicenne, mentre lei, che aveva ventidue anni, era rimasta a casa con la madre. Finita la funzione religiosa, Emilia osserva dalle logge esterne della basilica di San Marco la sfilata della guardia civica (di cui faceva parte anche Giorgio) e prova ammirazione: «Saranno state parecchie migliaia, e pare impossibile come in sì poco tempo abbiano potuto apprendere tanta disciplina militare»28. Le mogli, in terzo luogo. Il 22 marzo l’avvocato Avesani, che rivestì un ruolo decisivo nella resa delle autorità austriache, tiene al corrente la moglie mandandole via via dei bigliettini per comunicarle i suoi spostamenti e le novità: «Se sentirai ventun colpo [sic] di cannone, sono di letizia per salutare la bandiera tricolore»29. Pochi giorni dopo un marinaio veneziano, imbarcato in una nave a Pola, deve decidere se rimanere al servizio dell’imperatore oppure tornare a casa, perdendo in questo caso ogni diritto, compresa la pensione fin lì maturata in trent’anni di servizio; mentre molti dei suoi compagni firmano, con il nome o con la croce, e tornano a Venezia, l’uomo decide di rimanere; ma dopo qualche tempo, sua moglie, stanca di essere criticata e malvista dai vicini per la scelta del marito, riesce a raggiungerlo a Trieste e lo convince a tornare a casa30. E infine le coetanee. Ricordando la propria esperienza, SeismitDoda racconta la scena in cui i giovani crociati entrano in piazza San Marco a tre a tre con il fucile sul braccio sinistro, cantando un inno il 27 Giuseppe Vollo a Niccolò Tommaseo, Torino 18 marzo 1855, in Biblioteca Nazionale di Firenze, Carte Tommaseo 145.2, n. 9. 28 M. L. Lepscky Mueller, La famiglia di Daniele Manin, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 2005, pp. 148-9. 29 Asv, Carte Avesani, b. 4, non inventariata, fasc. «Atti vari, per la maggior parte in copia, di natura politica». 30 Asv, Procura di Stato. Atti d’inquisizione e di purificazione degli Ufficiali, Impiegati ecc. 1840-1850, b. 10, istanza di Luigi Morandi al governo civile e militare, Venezia, 26 settembre 1849. 10 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 11 Voci di uomini, sguardi di donne. Venezia, primavera 1848 cui ritornello è «Guerra, guerra!», mentre le donne al loro passaggio lanciano dalle finestre ghirlande di fiori e agitano fazzoletti bianchi31. 5. Donne italiane e odalische. Fin qui ho parlato di donne, ma si dovrebbe precisare: donne italiane. Tutte le donne che compaiono sulla scena – madri mogli figlie sorelle – sono, o meglio diventano o si riconoscono, come italiane, sicché si dovrebbe precisare che nel Quarantotto un uomo diventa uomo e rimane tale finché resta sotto gli occhi di una donna italiana32. Di lì a pochi mesi l’esercito austriaco riprese possesso della terraferma. In un salotto aristocratico di Venezia, dove si stava festeggiando l’onomastico della padrona di casa, alcuni giovani ufficiali mostravano «una licenziosa allegrezza» che contrastava con il drammatico momento politico e militare. Un capitano dei volontari che difendevano Venezia e una giovane donna, seduti a conversare, deplorarono il loro comportamento. La donna disse: «Capitano, Venezia cadde cinquant’anni fa per la corruzione della sua gioventù: Dio non voglia che ora succeda altrettanto!». Poi la donna si alzò e si sedette al pianoforte. Si fece silenzio. La donna cantò una canzone allora in voga, su parole di Giovanni Berchet, che invitava le madri al loro ruolo di educatrici dei figli: «E voi madri crescete una prole/ Sobria, onesta, pudica, operosa:/ Libertà mal costume non sposa/ Per sozzurra non mette mai piè». Tutti applaudirono33. Sarebbe meglio specificare ulteriormente e dire: donne italiane e bianche. I modelli di comportamento della donna italiana si vanno costruendo infatti mentre la sensibilità maschile coltiva l’immagine della donna dell’harem: l’epoca, come sappiamo, è segnata dal movimento filellenico, dall’orientalismo e dall’inizio delle conquiste coloniali. Penso alla moda dei ritratti di odalische: Natale Schiavoni, il più celebre pittore veneziano di quel periodo, ne dipinse uno attorno al 184034. Per liSeismit-Doda, I volontarii veneziani cit., p. 226. È stato A. M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore all’origine dell’Italia unita, Einaudi, Torino 2000, a osservare che le donne «sono spettatrici partecipi e trepidanti dell’azione patriottica» (p. 104) e che «nella maggior parte dei casi il pubblico femminile fa solo da appoggio e da platea alle eroiche gesta maschili» (p. 190). 33 C. Agrati, Giuseppe Sirtori «il primo dei Mille», a cura di A. Omodeo, Laterza, Bari 1940, pp. 79-80. Una raccolta di poesie di Giovanni Berchet fu pubblicata a Venezia dalla Tipografia repubblicana di Teresa Gattei nell’aprile 1848. 34 Natale Schiavoni, in «La Favilla», 11 ottobre 1840. Cfr. L. Sernagiotto, Natale e Felice Schiavoni. Vita, opere, tempi. Col ritratto in eliotipia di entrambi, Venezia 1881. 31 32 11 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 12 Piero Brunello mitarmi a Venezia e agli anni quaranta, penso ai viaggi in Oriente (Egitto, Palestina, Siria, Istanbul) nel 1843 e 1844 di due pittori veneziani come Ippolito Caffi e Pompeo Marino Molmenti, e ai soggetti esotici – ninfe al bagno, carovane nel deserto, temi biblici – che nacquero da quell’esperienza35. 6. Ipotesi di ricerca. In conclusione, l’ipotesi di ricerca potrebbe essere così formulata: il Quarantotto è un’occasione in cui gli uomini adulti possono stare tra uomini e occupare lo spazio pubblico, in modo da essere visibili agli occhi delle donne italiane e bianche, e precisamente per ottenere comprensione dalle madri, ammirazione o invidia dalle sorelle, sostegno dalle mogli, e infine far colpo sulle coetanee. Si spiega così, per fare un solo esempio, l’abbigliamento ricercato degli uomini nel 184836, che dovrebbe essere visto come un segno del rapporto tra generi. Di solito invece, negli studi sul Quarantotto, i vestiti femminili rientrano nella voce «moda» e quelli maschili nella categoria delle «divise» (dei volontari, della guardia civica, dei diversi corpi militari): come se solo le donne si muovessero sotto gli sguardi maschili e quindi fossero implicate in un rapporto con gli uomini, e non viceversa. L’atteggiamento degli uomini fa i conti con le rivendicazioni di diritti da parte delle donne37. Il romanticismo, che permea la sensibilità risorgimentale38, «quando prese in considerazione la donna, contribuì a minarne gli ideali di emancipazione dell’Illuminismo, uniformando35 Per un primo approccio si veda M. Pittaluga, Caffi Ippolito, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1973, XVI, pp. 268-70, e M. G. Sarti, Molmenti Pompeo Marino, ibid., LXXV, 2011, pp. 437-41. 36 Sul cappello maschile con la piuma, di moda nel 1848, cfr. la voce Cappello «all’Ernani» o «all’italiana», in P. Brunello, Voci per un dizionario del Quarantotto. Venezia e Mestre, marzo 1848-agosto 1849, Comune di Venezia, Venezia 1998, pp. 39-40. Più in generale si veda C. Sorba, Il 1848 e la melodrammatizzazione della politica, in Storia d’Italia, Annali, 22, Il Risorgimento, a cura di A. M. Banti e P. Ginsborg, Einaudi, Torino 2007, pp. 481-508; C. Sorba, Ernani Hats. Italian Opera as a Repertoire of Political Symbols during the Risorgimento, in The Oxford Handbook of the New Cultural History of Music, a cura di J. F. Fulcher, Oxford University Press, Oxford 2011, pp. 428-51. 37 Per restare a Venezia cfr. saggi e bibliografia in N. M. Filippini (a cura di), Donne sulla scena pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento, Franco Angeli, Milano 2006; in particolare sul 1848 cfr. Id., Il Quarantotto delle donne. Patria e diritti, in La differenza repubblicana. Volti e luoghi del 1848-49 a Venezia e nel Veneto, a cura di E. Cecchinato, D. Ceschin, M. Isnenghi, G. Sbordone, Cierre, Verona 2011, pp. 63-72. 38 P. Ginsborg, Romanticismo e Risorgimento: l’io, l’amore e la nazione, in Storia d’Italia, Annali, 22, Il Risorgimento cit., pp. 5-67. 12 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 13 Voci di uomini, sguardi di donne. Venezia, primavera 1848 si alla nozione borghese della divisione borghese del lavoro»39: ma il rapporto tra i generi è segnato da ambivalenze, e anche in questo caso l’esito dipende dallo specifico contesto dell’interazione40. Il processo di ridefinizione della virilità non è minacciato solo dalla donna: è anche l’omosessuale a mettere a rischio il nazionalismo e la rispettabilità41. Si potrebbe quindi precisare che il Quarantotto consente agli uomini di stare tra uomini sotto lo sguardo complice di donne, e pertanto senza sentirsi addosso il sospetto di omoerotismo maschile42. Fin qui ho parlato del solo comportamento in pubblico. Pochi anni dopo il Quarantotto, il console americano Howells, partecipando a una festa da ballo in un palazzo veneziano, rimase colpito dal fatto che i giovani si separassero alla fine di ogni danza ritirandosi «nelle rispettive prigioni che sono state loro assegnate fino a che la successiva quadriglia offrirà un’altra parentesi di libertà», e concludeva che gli uomini si rilassavano solo nel demi-monde43: un eufemismo per indicare i bordelli e il mondo delle mantenute. Niccolò Tommaseo frequentava prostitute, tra continui rimorsi44: una volta la sua amica Hortense Allart gli rinfacciò di seguire la vecchia morale della castità che aveva inventato «les filles publiques»45. Pertanto, accanto al repertorio di scena dovrebbe essere esaminato il repertorio di retroscena: o meglio il rapporto tra pubblico e privato, ragione e sentimenti, dichiarazione di princìpi e sogni intimi. La nobildonna Felicita Bevilacqua rimproverò a Giuseppe La Masa, che sposò nel 1858 dopo oltre dieci anni di fiMosse, Sessualità e nazionalismo cit., p. 111. L. Riall, Eroi maschili, virilità e forme della guerra, in Storia d’Italia, Annali, 22, Il Risorgimento cit., pp. 253-88. 41 Ibid., pp. 34-5. 42 Riferendosi all’esperienza dei volontari garibaldini, Banti, La nazione cit., pp. 196-8, ha parlato di «un culto dell’amicizia ricco di palesi risonanze omoerotiche», ma credo che le sue osservazioni possano essere anticipate al Quarantotto. 43 Howells, Vita veneziana cit., pp. 333-4. 44 «22 [maggio 1836]. Pecco al numero 312. Prego con umiltà e con amore. Desidero riconfessarmi. […] 24. Pecco con la Sofia: affettuosa. Rimorsi […]. 27. Sofia. […] Sento messa». N. Tommaseo, Diario intimo, a cura di R. Ciampini, Einaudi, Torino 19463, p. 245. 45 A. Cremona, Politica e intimità domestica, misoginia e idealizzazione della donna. Niccolò Tommaseo e le sue corrispondenti epistolari, in «Annali 2000. Studi e materiali dalle tesi di laurea» («Annali del Dipartimento di Studi Storici dell’Università Ca’ Foscari, Venezia», II), Milano 2000, p. 130. Cfr. Id., Pagine inedite dall’epistolario di Niccolò Tommaseo. La donna tra protagonismo sociale e immaginario maschile, in Memoria, rappresentazioni e protagonisti del 1848 italiano, a cura di R. Camurri, Cierre, Verona 2006, pp. 345-81. Sulla «sensualità che trasuda» dall’esperienza letteraria di Tommaseo, «in una logorante lotta interiore tra il concedersi al peccato e la necessità di espiarlo», si veda F. Danelon, Amore e matrimonio nella narrativa di Tommaseo, in Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. Cultura e società nella Venezia del 1848, a cura di T. Agostini, in «Quaderni veneti», 2000, 31-32, p. 250; il saggio è alle pp. 243-72. 39 40 13 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 14 Piero Brunello danzamento, di sentirsi, nel profondo e nonostante tutto, il signore di un harem: «È forse amore quello che lega un signore turco ad una schiava che tiene chiusa con cento porte nel suo harem? Oh! non è amore, è brutalità. […] E pur troppo in te, Peppino, sebbene modificato dall’educazione, e dal tuo buon cuore, pure scorgo nel fondo dell’anima tua quella tendenza»46. Limitandoci comunque, come ho fin qui fatto, al repertorio di scena, dovremmo tenere almeno conto di due elementi. Come si è detto, vanno considerate le differenze di classe e di status. Gli uomini della rivoluzione sono i primi a prendere le distanze dal popolo. Quando il «Giornale della Guardia civica» si rivolge «alle Donne Veneziane», scrive: «Voi lasciaste i vagheggiati ricami per apprestare filacce e bende ai feriti, voi logoraste le mani delicate use ai velluti e alle sete, lavorando ruvide lane», e così via47. Le donne a cui il giornale si riferisce non sono di certo popolane. A Venezia girano stampe che raffigurano le eleganti divise degli ufficiali della guardia civica, che potevano permettersi di pagarsele di tasca propria: ma i popolani che prestavano servizio spesso non avevano né un berretto né un vestito, né scarpe48. In una società cattolica come quella italiana, infine, lo schema basato sul genere non è bipartito tra uomini e donne, ma tripartito: uomini, donne, uomini di Chiesa celibi49. Basti pensare ai riti di consegna delle bandiere: donne consegnano la bandiera, sacerdoti la benedicono, uomini la difendono combattendo. I sacerdoti parlano agli uomini tramite le donne; la rivoluzione politica accetta la superiorità morale del potere religioso su quello civile50. Scrisse Carlo Pisacane: «[Il 23 marzo 1848] la guardia nazionale sfilava in bella mostra in Piazza S. Marco ed applaudiva freneticamente alla proclamazione della repubblica. Ma era questa una rivoluzione compiuta, o una semplice insur46 Lettera di Felicita Bevilacqua a Giuseppe La Masa, s.l., s.d, in L’altra metà del Risorgimento. Volti e voci di patriote venete, a cura di N. M. Filippini e L. Gazzetta, Cierre, Verona 2011, p. 163. Sull’incontro tra Bevilacqua e La Masa cfr. E. Sodini, Le carte di Felicita Bevilacqua. Famiglia, nazione e patriottismo al femminile in un archivio privato (18221899), Cierre, Verona 2010, pp. XXV-XXVI. 47 G. Fantoni, I fasti della guardia nazionale del Veneto negli anni 1848 e 49. Memorie storiche, Venezia 18692, p. 90. 48 A. Bernardello, Da Bonaparte a Radetzky. Cittadini in armi: la guardia nazionale a Venezia (1797-1849), Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 2011, p. 157. 49 L. Accati, Il mostro e la bella. Padre e madre nell’educazione cattolica dei sentimenti, Raffaello Cortina, Milano 1998. 50 Per il caso veneziano rinvio ai documenti riportati alle voci Bandiera, Donne, Fratelli, Padre-padri, Sorelle, Uomini, in Brunello, Voci per un dizionario del Quarantotto cit., pp. 9-29, 81-8, 91-104, 263-6, 311-2, 347-50. 14 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 15 Voci di uomini, sguardi di donne. Venezia, primavera 1848 rezione, e quindi l’antica tirannia cambiata di forma? Un ministro cattolico benedisse la bandiera, ciò basti al lettore per giudicare»51. Nel Quarantotto il clero cattolico sacralizza l’appartenenza nazionale, legittima il potere politico, santifica la guerra52. Lo schema risale alla Controriforma, ma è rafforzato dal neoguelfismo e dalla rivoluzione del 1848 che, almeno nel Lombardo-Veneto, sostituiscono la figura paterna dell’imperatore con il papa nel ruolo di padre simbolico53. 51 C. Pisacane, Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49 [1851], Giuseppe Pavesi, Genova 1851, p. 47. 52 E. Francia, «Il nuovo Cesare è la patria». Clero e religione nel lungo Quarantotto italiano, in Storia d’Italia, Annali, 22, Il Risorgimento cit., pp. 423-50. 53 Accanto ad altre tendenze del Quarantotto italiano, Enrico Francia parla di «revanche cattolica di matrice guelfa» e del papato come «l’archetipo del principio di sovranità legittima» (ibid., p. 444). 15 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 16 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 17 PENSARE LA NAZIONE Predicare la rivoluzione. L’oratoria politico-religiosa nel Risorgimento di Enrico Francia Nel corso della prima metà dell’Ottocento italiano, le élites politiche rivoluzionarie cercarono con grande solerzia di coinvolgere, persuadere, spingere all’azione una popolazione che era in larga parte estranea – se non avversa – alle loro rivendicazioni. A questo scopo misero in campo un ampio spettro di strategie persuasive e comunicative: da un lato facevano leva sull’impiego di nuovi media (giornali, opuscoli, romanzi, melodrammi, immagini), sulla creazione di narrazioni e di miti che contraddistinguessero e legittimassero il nuovo corpo politico (il popolo sovrano, la nazione); dall’altro puntavano sull’utilizzo di simboli, rituali e forme comunicative che appartenevano al mondo religioso e che venivano debitamente risemantizzati e declinati in chiave politica e patriottica1. Ecco quindi i Te Deum, fortemente voluti dalle autorità rivoluzionarie – e financo imposti a vescovi riottosi se non ostili – per legittimare il nuovo ordine politico; il costante utilizzo di termini e figure della tradizione cattolica (crociata, martiri, apostoli, predicatori), nonché la trasposizione in chiave mondana di uno strumento di acculturazione religiosa popolare come il catechismo2; la costruzione dell’impianto narrativo dei testi patriottici sul modello della tradizione cristologica3. In particolare sul versante della 1 Sui rapporti tra religione e modernità politica nell’età delle rivoluzioni si veda M. A. Perkins, Word and Nation, 1770-1850. Religious and Metaphysical Language in European National Consciousness, Ashgate, Aldershot 1999; D. A. Bell, The Cult of France. Inventing Nationalism, 1680-1800, Harvard University Press, Cambridge (Ma) 2001. Per il caso italiano si veda M. Caffiero, La Repubblica nella città del papa. Roma 1798, Donzelli, Roma 2005, pp. 99 sgg.; E. Francia, «Il nuovo Cesare è la patria». Clero e religione nel lungo Quarantotto italiano, in Storia d’Italia, Annali, 22, Il Risorgimento, a cura di A. M. Banti e P. Ginsborg, Einaudi, Torino 2007. 2 M. Caffiero, Catechismi repubblicani. Riflessioni in margine a un libro recente, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 2002, 1, pp. 145-51. 3 Su questo specifico aspetto cfr. A. M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, Torino 2000, pp. 123 sgg. 17 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 18 Enrico Francia comunicazione politica, le élites rivoluzionarie e patriottiche attribuivano un ruolo decisivo all’opera di quei religiosi che dovevano salire sul pergamo non solo per spiegare il Vangelo, ma per predicare a favore della nazione, delle libertà, della democrazia. È soprattutto nei due principali momenti rivoluzionari – il 1796-99 e il 1848 – che si sviluppa questa predicazione politico-patriottica, sollecitata e guidata certamente dai nuovi governi sulla scia di antiche prassi giurisdizionaliste, ma favorita anche dalla lettura in chiave religiosa e provvidenziale della nazione e della democrazia fatta in alcuni ambienti cattolici4. Così ad esempio nella Napoli del 1799 frate Cicconi «sempre circondato da torme di Lazzari, li democratizzava con l’esempio del Nazareno, e con tutti giurava per la Madonna il Vangelo essere il vero libro dell’istruzione repubblicana»5. La forza di questo tipo di alfabetizzazione politica stava nell’utilizzo di figure tradizionalmente presenti nella vita sociale, nella possibilità di dare veste religiosa al messaggio politico e infine nella sua peculiare natura comunicativa. La predicazione politicoreligiosa appare infatti come una forma di «comunicazione ibrida» (McLuhan), nella quale scrittura, parola parlata, richiami visuali, gesti rituali si intrecciano ed entrano in circuito tra loro, al fine di rendere più fruibile ed efficace il messaggio all’interno di spazi sociali e mentali dove il parlato e il visivo occupano uno spazio predominante. L’analisi di queste pratiche chiama in causa temi e problemi che sono comuni tanto agli studi sulla comunicazione religiosa6 quanto a quelli (più recenti) sulla comunicazione politica: la costruzione del processo comunicativo; il rapporto tra oralità e scrittura; il ruolo performativo di linguaggi e rituali, non più considerati come tecniche neutre 4 Sul cattolicesimo democratico nel triennio repubblicano si vedano D. Menozzi (a cura di), La chiesa e la rivoluzione francese, Edb, Bologna 1990; V. E. Giuntella, La religione amica della democrazia. I cattolici democratici del triennio giacobino (1796-1799), Studium, Roma 1990. Sui rapporti tra religione cattolica e nazione nella prima metà dell’Ottocento, si veda l’efficace sintesi di G. Formigoni, L’Italia dei cattolici. Fede e nazione dal Risorgimento alla Repubblica, il Mulino, Bologna 1998, cap. I, e il volume di F. Traniello, Religione cattolica e Stato nazionale. Dal Risorgimento al secondo dopoguerra, il Mulino, Bologna 2007, pp. 59-157. 5 Cit. in D. Scafoglio, Lazzari e giacobini. La letteratura per la plebe (Napoli, 1799), Guida, Napoli 1981, p. 18. 6 Della sterminata produzione sulle diverse forme di comunicazione religiosa, utili per questa analisi, sono R. Librandi, L’italiano nella comunicazione della chiesa e nella diffusione della cultura religiosa, in Storia della lingua italiana. I luoghi della codificazione, a cura di L. Serianni e P. Trifone, Einaudi, Torino 1993; R. Rusconi, «Rhetorica ecclesiastica». La predicazione nell’età post-tridentina fra pulpito e biblioteca, in La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento tra Cinquecento e Settecento, Atti del X Convegno di studio dell’Associazione italiana dei professori di storia della Chiesa (Napoli, 6-9 settembre 1994), Edizioni Dehoniane, Roma 1996. 18 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 19 L’oratoria politico-religiosa nel Risorgimento e funzionali alla trasmissione del messaggio, ma come suoi elementi costitutivi7. Ed è proprio intorno a questi temi che sarà centrata l’analisi della predicazione patriottico-religiosa nelle fratture rivoluzionarie della prima metà dell’Ottocento. Nelle rivoluzioni della prima metà dell’Ottocento, dunque, chiese, piazze, circoli politici vedono sovente parroci, esponenti degli ordini regolari, famosi predicatori trasformarsi in oratori politici, che chiedono al «popolo» di partecipare alla «guerra santa» o provano a spiegare le parole nuove della rivoluzione o, ancora, a convincerlo del carattere provvidenziale della nazione. Scrive Colletta, a proposito del 1799 napoletano, che preti e frati […] parlavano al popolo di governo; e tirando dal Vangelo le dottrine di eguaglianza politica, e volgarizzando in dialetto napoletano alcuni motti di Gesù Cristo, incitavano e rafforzavano l’odio a’ re, l’amore a’ liberi governi, l’obbedienza all’autorità del presente […]; così messe insieme le profezie, la croce, l’eguaglianza, la libertà, la repubblica, mostrandosi con vesti sacerdotali, e parlando un linguaggio superstiziosamente credulo, insinuavano alla plebe sensi favorevoli al nuovo stato8. Mezzo secolo dopo, nel corso della rivoluzione nazionale, era frequente «vedere la piazza gremita di gente che pendeva dalle labbra di questo facondo oratore (Gavazzi)»9. Erano in primo luogo le élites rivoluzionarie a sollecitare l’intervento in pubblico degli uomini di Chiesa, nella convinzione che fosse necessario «usare in politica, a fini divulgativi e propagandistici, categorie culturali e materiali linguistici – quelli religiosi, appunto – noti e rassicuranti»10. A Napoli nel 1799, Eleonora de Fonseca Pimentel, particolarmente attenta ai rischi di una rivoluzione «passiva», suggeriva al governo di stabilire delle missioni civiche, siccome ve n’erano prima delle semplicemente religiose; invitiamo il gran numero de’ nostri non meno dotti, che civici e zelanti ecclesiastici, i quali han già la pratica della persuasiva popolare, a prestarsi a quest’opera anche senza l’ordine, ed invito del Governo11. 7 Per un’analisi della comunicazione politica cfr. J. Gerstlé, La communication politique, Armand Colin, Paris 1993; G. Fedel, Saggi sul linguaggio e sull’oratoria politica, Giuffrè, Milano 1999; G. Mazzoleni, La comunicazione politica, il Mulino, Bologna 1998. 8 P. Colletta, Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825, Paris 1835, I, p. 220. 9 C. Leoni, Cronaca segreta de’ miei tempi, 1845-1874, a cura di G. Toffanin, Rebellato, Quarto d’Altino 1976, p. 81. 10 E. Leso, Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico del triennio rivoluzionario (1796-1799), Istituto veneto di scienze, lettere e arti, Venezia 1991, p. 139. 11 In «Monitore Napoletano», 5 febbraio 1799, in Il Monitore napoletano. 1799, a cura di M. Battaglini, Guida, Napoli 1999, p. 111. 19 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 20 Enrico Francia Nel 1848 il governo toscano chiedeva ai vescovi che nelle loro diocesi «i banditori del vangelo» spiegassero dai pulpiti «la somma importanza e i vantaggi che provvedere possono dalle nuove situazioni»12. Come scrive un frate cappuccino veneto nel 1848, a proposito di un’analoga richiesta, «l’abito, la voce, la buona opinione dei cappuccini davano grandi speranze d’un felice riuscimento in tal genere di missione»13. L’intervento degli uomini di Chiesa era considerato decisivo soprattutto nei momenti in cui si doveva assicurare un’estesa mobilitazione popolare: è ad esempio il caso delle elezioni a suffragio universale nella Venezia del 1848, quando il governo chiedeva ai parroci non solo di consegnare gli stati delle anime per la redazione delle liste, ma anche di «illuminare» i fedeli sull’importanza delle elezioni «privatamente e anche con la viva voce dall’altare»14. Per diffondere e volgarizzare le idee dei tempi nuovi, le élites rivoluzionarie si impegnarono peraltro nella produzione e nella distribuzione di opuscoli, catechismi, manuali, esplicitamente indirizzati all’educazione politica e morale del popolo. Ma l’efficacia di questa stampa era strettamente legata alla possibilità di renderla accessibile a un pubblico in larga parte analfabeta o comunque incapace di attribuire il corretto significato a concetti e argomenti presenti in questi testi. Dunque, i catechismi, prodotti tanto nel periodo repubblicano quanto nel corso della rivoluzione del 1848, presupponevano l’esistenza di mediatori culturali e politici capaci di diffondere oralmente il testo, modificandolo, adattandolo, integrandolo con artifici retorici15. Come osserva Fruci a proposito del Quarantotto, nella maggior parte dei casi, il testo scritto fa da supporto all’oralità […]. In queste pratiche didascaliche un ruolo fondamentale è, infatti, affidato ai mediatori politici, incaricati di recitare i dialoghi a partire dalle parole stampate, che costituiscono un semplice canovaccio, aperto a molteplici adattamenti e riformulazioni16. In prima fila, in questa opera di predicazione controllata delle parole d’ordine della rivoluzione, erano ancora gli uomini di Chiesa. CoArchivio di Stato di Firenze, Ministero degli affari ecclesiastici, b. 363. A. Carmignano di Brenta, Padre Antonio Tornielli e altri cappuccini veneti durante i fatti del 1848-1849, in «Ateneo Veneto», VI, 1968, 1, p. 6. 14 Circolare ai parroci, 28 dicembre 1848, in Raccolta per ordine cronologico di tutti gli atti, decreti, nomine ecc del Governo Provvisorio di Venezia, Andreola, Venezia 1848, V, p. 392. 15 Cfr. L. Guerci, Istruire nelle verità repubblicane. La letteratura politica per il popolo nell’Italia in rivoluzione (1796-1799), il Mulino, Bologna 1999, pp. 17-70. 16 G. L. Fruci, La banalità della democrazia. Manuali, catechismi e istruzioni elettorali per il primo voto a suffragio universale in Italia e in Francia (1848-49), in «Dimensioni e problemi della ricerca storia», 2008, 1, p. 22. 12 13 20 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 21 L’oratoria politico-religiosa nel Risorgimento sì, ad esempio, nel 1797 la società di pubblica istruzione di Milano, dopo aver redatto un opuscolo sul «governo popolare», chiedeva all’arcivescovo «di spedirne copia a tutti i parrochi, non chè a tutti i così detti predicatori quaresimali della città e della campagna» affinché lo utilizzassero come base per «il discorso cui essi stessi recitare dovranno al popolo in chiesa adunato la seconda festa di Pasqua»17. La traduzione orale di catechismi, e più in generale la predicazione patriottica affidata agli uomini di Chiesa, evocava pratiche e tradizioni di evangelizzazione religiosa particolarmente forti nell’immaginario popolare, ma anche – in alcuni casi – oggetto di dure critiche da parte di quel cattolicesimo illuminato e riformista (i giansenisti, in primo luogo) che – secondo una canonica interpretazione delle origini del Risorgimento – costituiva uno degli incunaboli del movimento «risorgimentale»18. Così a Napoli, quelle missioni popolari invocate da Eleonora Pimentel come strumento di alfabetizzazione politica rimandavano a una pratica religiosa particolarmente radicata nell’Italia meridionale (Alfonso de’ Liguori), ma condannata ad esempio dal Sinodo di Pistoia qualche anno prima: lo strepito irregolare di quelle pratiche nuove che si dissero esercizi o missioni, […] forse non arrivano giammai, o vi arrivano ben di rado, a produrre una conversione compita, e quegli atti esteriori che apparvero di commozione, non furono che lampi passeggeri di un naturale scuotimento19. In ogni caso le élites rivoluzionarie e patriottiche, pur condividendo un giudizio critico su queste pratiche religiose, si rivolgevano, per fare breccia nell’opinione popolare, proprio a quel modo di predicare nel quale si faceva grande «uso di giochi di parole, di rime, e di allitterazioni, gridando e gesticolando, facendo riferimento ai racconti popolari per illustrare il proprio messaggio e componendo canzoni per le proprie congregazioni»20. Peraltro, se osserviamo più da vicino protagonisti e caratteri di questa predicazione, si può notare come il suo successo risiedesse, da un lato, nella «fama» dei predicatori costruita nel corso del loro apostolato religioso, dall’altro in uno stile oratorio nel quale l’amplificazione emoGuerci, Istruire nelle verità repubblicane cit., p. 35. Si veda soprattutto E. Rota, Il Giansenismo in Lombardia e le origini del Risorgimento italiano, Fusi, Pavia 1907. 19 Cit. in R. Rusconi, Gli Ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, predicazione, missioni, in Clero e società nell’Italia moderna, a cura di M. Rosa, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 271. 20 P. Burke, Cultura popolare nell’Europa moderna, Mondadori, Milano 1980, p. 78. 17 18 21 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 22 Enrico Francia tiva ed espressiva del discorso politico faceva aggio sul suo contenuto. Così nel Quarantotto, le vere e proprie star della predicazione religioso-patriottica sono alcuni esponenti del clero regolare – barnabiti, francescani – che negli anni precedenti avevano girato l’Italia come predicatori nei quaresimali, nelle missioni popolari, nelle predicazioni straordinarie, di nuovo rifiorite dopo l’arresto imposto dai francesi. Bassi, ad esempio, negli anni trenta aveva predicato in occasione del quaresimale a Bologna, Palermo, Trapani, Milano, Cesena, nelle Marche; Gavazzi si era spostato da Genova ad Alessandria, Bologna, Livorno, in Umbria. Nel corso di questa lunga esperienza il loro modo di predicare aveva suscitato entusiasmi e veri propri deliri, quanto feroci critiche e interventi delle autorità ecclesiastiche. Sotto accusa erano non solo i contenuti delle loro prediche, spesso caratterizzate da violente accuse contro la decadenza dei costumi dentro e fuori la Chiesa, ma soprattutto il modo in cui venivano presentate. Nel 1836 un anonimo autore dava alle stampe un opuscolo dal titolo L’eloquenza moderna del pulpito, nel quale denunciava che il gusto della predicazione moderna è ormai giunto a cambiare le chiese in teatri, ove senza rispetto al luogo santo e alla presenza reale di Iddio incarnato, si grida bravo, si battono le mani, si schiamazza il plateale evviva alle ipotiposi, alle antitesi, alla composizione poetica21. Le prediche di Bassi in effetti si presentavano come vere e proprie performance teatrali; scrive un cronista bolognese, a proposito della sua predica al quaresimale di Bologna del 1835: Talora lanciavasi di qua e di là, e con parte del corpo al di fuori e sollevandosi con tutta la persona sui due piedi così figurava le varie sue idee. Ora appressava gli occhi al fazzoletto, additando il lagrimare o cadevasi come svenuto sul sedile, sé dipingeva alcuno al suo estremo sospiro […]. Formava varie voci di vivace e compassionevole dialogo; talora figurava con la stessa il galante moderno e le sue sociali abitudini di conversare e di vestire22. Stile e contenuti delle sue prediche non appaiono corrivi o popolari: epiteti violenti, crudità del linguaggio e fantasiose immagini si affiancavano allo sfoggio di arte ed erudizione, all’utilizzo di un lessico che pescava a piene mani in voci trecentiste, a una ricercata attenzione alla parola. Si ha spesso l’impressione di essere di fronte a un pastiche oratorio, tanto dal punto di vista argomentativo quanto da quello sti21 L’eloquenza moderna del pulpito, opuscolo dedicato alla s. Sede apostolica ed ai vescovi cattolici, Modena 1836, p. 15. 22 Cit. in U. Beseghi, Ugo Bassi, Marzocco, Firenze 1946, I, p. 32. 22 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 23 L’oratoria politico-religiosa nel Risorgimento listico: un modo di predicare che sicuramente si allontanava dal modello di Segneri, ancora dominante nell’oratoria sacra ottocentesca23. Ma nonostante rimproveri e censure dei puristi e delle autorità ecclesiastiche, sono proprio le risorse recitative e oratorie messe in mostra da Bassi nella sua predicazione (intonazione, espressione del viso, posture del corpo) a decretare il suo straordinario successo popolare. Maria Mazzini a Genova ne è testimone: la folla è tale che per ben udirlo bisogna andarvi tre ore prima. Il bello è che anche le genti del popolo vi accorrono […]. All’uscire di chiesa v’era gran numero di villani, a cui disse se l’intendevano. Dissero di no, ma pur venivano, avendo udito che era tanto bravo24. Il passaggio dalla predicazione religiosa a quella politico-patriottica è certo facilitato dalla somiglianza dei registri retorici impiegati (l’uso della metafora, lo svolgimento di miti tragici, il frequente ricorso a categorie semantiche di tipo passionale e sentimentale)25 e dalla possibilità di legare la nazione alla religione, ma soprattutto dall’impiego delle stesse risorse scenico-drammaturgiche, che puntavano sul movere più che sul persuadere, sulla capacità di convertire commuovendo, sull’appello diretto alle emozioni dell’uditorio. Un esempio di questo modo di rivolgersi al popolo è offerto da Alessandro Gavazzi a Roma. Nel marzo del 1848 migliaia di persone si radunano al Colosseo, uno dei simboli della cristianità martire più densi di significato, per bandire la guerra santa contro l’Austriaco e per benedire le truppe romane in partenza. Dopo alcuni oratori, si presenta sul palco Alessandro Gavazzi: Un lungo mantello nero, artisticamente accomodato, ricuopre la sua veste nera cinta a vita da una larga correggia dello stesso colore. Una croce verde, rossa e bianca si disegna a grandi tratti sul suo petto; la sua larga fronte è al nudo, la di lui faccia porta l’impronta di un’espressione maschia e robusta, i suoi lunghi capelli neri gettati al vento ondeggiano lunghesso il suo collo, il suo sguardo ha dell’ispirato, armonioso è il suo gesto, drammatico il suo atteggiamento, la sua voce suonora; eccolo che predica la crociata dell’indipendenza26. Il discorso che pronuncia ha il suo acme in un serrato dialogo con il popolo-pubblico, una strategia retorica che è funzionale alla costru23 Si veda ad esempio quanto veniva scritto in uno dei più celebri trattati di eloquenza sacra di quel periodo: G. Audisio, Lezioni di eloquenza sacra, Torino 1839. 24 Cit. in Beseghi, Ugo Bassi cit., p. 75. 25 E. Martínez Garrido - M. Rodríguez Fierro, Il discorso fascista italiano e il suo debito all’oratoria romantica, in La «lingua d’Italia». Usi pubblici e istituzionali, a cura di G. Alfieri e A. Cassola, Bulzoni, Roma 1998, p. 175. 26 A. Balleydier, Storia della rivoluzione di Roma, Napoli 1852, p. 72. 23 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 24 Enrico Francia zione di una comunità coesa e unanime, e che sarebbe stata più volte riproposta da Gavazzi nel corso della sua predicazione a favore della guerra nell’Italia centrale. Romani! gli avi vostri conquistarono il mondo, volete voi esser degni di loro? rispondete – «Sì!» prorompe in una sola voce la folla entusiasmata da quelle trascinanti parole. – Romani! volete voi rompere i ferri della schiavitù, marciare alla conquista del più prezioso di tutti i beni, alla gloria, all’indipendenza, alla libertà? – «Sì! sì! sì! […] lo vogliamo» – Romani! volete voi ridivenire il popolo re? «Sì! sì! sì!» ripete una terza volta la massa elettrizzata. – Ebbene sia fatta la vostra volontà, Romani! in nome dell’Italia […] alle armi! la carriera è aperta […] Alle armi! la vittoria vi attende […] alle armi! […] Romani avanti! Dio lo vuole!27 Questa interazione tra enunciatore e destinatari, decisiva per il successo della predicazione patriottica, si manifesta anche attraverso una partecipazione attiva del pubblico alla performance oratoria. Vediamo ad esempio quanto succede a Bologna durante una predica di Ugo Bassi. Il teatino è sul sagrato di San Petronio, allestito come un palco: al suo fianco si vedono bandiere nazionali e tavoli con urne per la raccolta di offerte; nella folla che ascolta il predicatore vi sono mischiati giovanetti, uomini in divisa della guardia civica, popolani e uomini del ceto civile, molte donne. Tutti partecipano all’atto di adesione alla causa nazionale, donando denaro, gioielli, manufatti: donne d’ogni condizione; d’ogni età spogliarono in sulla piazza i propri ori e più cari ornamenti ed esse medesime recavanli sul palco, su cui predicava il Bassi […] vedemmo salire su quel palco il nobil signor […] versare il danaro non solo, ma spogliare l’ornato d’auree catenelle e far lo sproprio di preziosi orologi; vedemmo il cittadino recar contante, oggetti cari e preziosi, biancheria, armi, vestimenta, servibili al militare; vedemmo l’artigiano portare il prodotto della propria industria […]. Non era uno, uno solo che non piangesse di commozione28. La predicazione dunque si configura come un rito articolato, nel quale il discorso è solo una parte di una messa in scena che chiama in causa emozioni, sentimenti, e non certo raziocinio, e per questo è capace di «fanatizzare» la popolazione. Per descrivere questo tipo di performance oratoria, i contemporanei rievocano quei personaggi della tradizione predicatoria che si erano caratterizzati per tensione emotiva e partecipativa. Così il giornale «L’Alba» a proposito di una preIbid., p. 73. Cit. in Beseghi, Ugo Bassi cit., p. 245. La descrizione di questa scena deve molto anche al quadro di Napoleone Angioni, Ugo Bassi sui gradini di San Petronio (1850 ca.). 27 28 24 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 25 L’oratoria politico-religiosa nel Risorgimento dica di Giuseppe Lorini sottolineava che «forse il Duomo di Firenze dopo il Savonarola e il Forano non aveva udite parole né più evangeliche né libere»29; e secondo il cronista padovano Leoni ascoltando le prediche di Gavazzi «sembravamo essere trasportati a’ tempi delle prediche di S. Bernardo»30. Certo nel mondo patriottico, soprattutto quello più moderato, non mancavano critiche e giudizi severi. Un foglio romano particolarmente attento alle vicende della predicazione e dell’oratoria sacra attaccava duramente una predica di Gavazzi dell’agosto 1847, esortandolo a desistere una volta da quella pazza maniera di predicare […] a lasciare quelle stranezze che mutano il pulpito in un palco da saltimbanco, ad essere dignitoso non villano nel contegno, ad annunciare la parola di Dio non quella degli uomini31. Le annotazioni critiche si indirizzavano certo verso i contenuti «incendiari» delle prediche di Gavazzi («in alcuni luoghi non contento a predicare guerra allo straniero, predicava contro i ricchi, i preti, i sanfedisti; ministerio indegno d’ogni civile cittadino, non che d’un sacerdote»)32, ma soprattutto verso il suo stile «goffamente gonfio e di pessimo gusto»33, così che le sue parole hanno distrutta l’opinione di facondo oratore, colla quale era venuto tra noi, e le sue idee scucite e senza nesso tra loro non hanno potuto fare intendere il vero senso e lo scopo del suo discorso34. In ogni caso, comunque, anche le voci dissonanti dovevano riconoscere l’efficacia di queste prediche: così a proposito dei discorsi tenuti nella sua chiesa da Giuseppe Lorini, il curato di Santa Felicita ammetteva che fu tale il fanatismo dei fiorentini presso di lui che, oltre ai clamori a lui fatti come sopra ad una piazza, la terza domenica di quaresima i liberali si portano a udirla con le bandiere in mano35. 29 Cit. in F. Martini, Il Quarantotto in Toscana. Diario inedito del conte Luigi Passerini de’ Rilli, Marzocco, Firenze 1948, p. 5. 30 Leoni, Cronaca segreta de’ miei tempi cit., p. 81. 31 In «L’Educatore. Foglio settimanale», 21 agosto 1847. 32 L. C. Farini, Storia dello Stato Romano dal 1815 al 1850, Firenze 1850, II, p. 51. 33 G. Spada, Storia della rivoluzione di Roma e della Restaurazione del governo pontificio dal 1° giugno 1846 al 15 luglio 1849, Firenze 1869, II, p. 329. 34 Martini, Il Quarantotto in Toscana cit., p. 58. 35 P. Barbaini, Problemi religiosi nella vita politico-culturale del Risorgimento in Toscana, Marietti, Torino 1961, p. 270. 25 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 26 Enrico Francia Il curato notava inoltre come alcune «prediche vennero subito stampate e si vendevano fuori dai ragazzi per le pubbliche vie, gli si fecero ritratti in litografia»36. In effetti nel corso del 1848 la predicazione patriottica di religiosi conosce una rapida e tumultuosa traduzione scritta. È il successo della predica a determinare nell’uditorio un’ansia febbrile di stamparla e di diffonderla al di là delle persone che hanno avuto la fortuna di ascoltarla. Così Gioacchino Ventura nel quaresimale del 1847, predicando contro i cattivi consiglieri di Pio IX, diede una benedizione in termini poco prudenti; e questa accolta, dal caldo delle passioni che dominano, l’hanno scritta e stampata in ogni dove, variandola secondo le diverse intenzioni onde farla meglio valere allo scopo37. Gli estensori de «Il Contemporaneo» chiesero il permesso di inserire nel loro giornale le parole da lui pronunciate. L’ancor più celebre discorso funebre in onore di O’Connel circolò la sera stessa in forma di sunto dell’orazione e nei giorni successivi fu pubblicato sui giornali. È chiaro che quando la predica veniva tradotta in forma scritta perdeva i suoi elementi caratterizzanti – suoni, toni, gesti – e veniva meno quel fascino incantatorio delle parole che aveva assicurato il successo della performance oratoria38. D’altra parte questa versione della «parola biforme» (Giovanni Pozzi) diventava funzionale alla costruzione di un’opinione nazionale e all’edificazione di una sorta di biblioteca circolante della predicazione. Così ad esempio la predica di Ventura per la morte di O’Connel acquisiva maggiore rilievo nel discorso nazional-patriottico quando apparve stampata, sotto un unico ed eloquente titolo Tre apostoli, insieme ad altri due discorsi di religiosi: uno di padre Gavazzi (un panegirico pronunciato a San Francesco di Paola) e uno di Alessandro Lorini (La religione e i pontefici. Pio V, Pio VII e Pio IX)39. Nel Quarantotto però quell’ibridismo sincretico tra modernità politica e tradizione religiosa che aveva caratterizzato i linguaggi e le pratiche politiche nella prima metà del secolo, soprattutto nelle fratture rivoluzionarie, si interruppe drasticamente. Da quel momento la Chiesa diIbid. Costanza Corboli al padre, 19 aprile 1847, cit. in R. Quazza, Pio IX e Massimo d’Azeglio nelle vicende romane del 1847, Società tipografica editrice modenese, Modena 1954, p. 60. 38 Uno dei pochi esempi di analisi dell’oratoria politica quarantottesca è S. Covino, Manin, Tommaseo e l’oratoria politica del 1848-49 a Venezia, in «Quaderni Veneti», XXXI-XXXII, 2000, Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. Cultura e società nella Venezia del 1848, numero monografico, a cura di T. Agostini. 39 Tre apostoli. Il padre Ventura, L’arcidiacono Lorini. Il padre Gavazzi. Saggio del loro apostolato, Bastia 1847. 36 37 26 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 27 L’oratoria politico-religiosa nel Risorgimento veniva nemica senza appello del movimento patriottico, e anche se nel 1859-60 il governo piemontese e i governi provvisori dell’Italia chiesero che la guerra di liberazione fosse accompagnata da cerimonie e da parole del pulpito, gran parte del clero utilizzava il pergamo per rivendicare la sovranità temporale del pontefice e per attaccare le moderne libertà40. Ne è indiretta testimonianza un volume scritto nel 1860 dall’avvocato Luigi Priario, repubblicano, anticlericale. Si trattava di un «quaresimale politico», nel quale erano raccolte una serie di prediche che imitavano lo stile e l’argomentazione dell’omiletica religiosa, e che avevano però argomenti mondani e decisamente polemici verso la Chiesa e gli antiunitari. Nella prefazione Priario giustificava questa sua singolare pubblicazione, lamentando l’azione antipatriottica della Chiesa in quei mesi, ma nello stesso tempo riconoscendo il ruolo di quel tipo di comunicazione nel persuadere il popolo: Eccoci alla quaresima, e con essa alle prediche quaresimali. I preti ed i frati salgono sul pergamo, e in mezzo ai pochi che bandiscono la parola di Dio, i più bandiscono la parola di Roma; la parola dell’odio, della discordia, della schiavitù della gran patria italiana […]. Rari pur troppo oggigiorno sono gli Arnaldi da Brescia, i Savonarola, i Benedetti da Forano, ed i Bassi. […] È giusto pertanto che a tanta dose di veleno propinato da sante mani e vomitato da sacre fauci si opponga l’antidoto di un predicatore profano41. 40 Per un quadro generale, D. Menozzi, I vescovi dalla rivoluzione all’Unità. Tra impegno politico e preoccupazione sociali, in Clero e società nell’Italia contemporanea, a cura di M. Rosa, Laterza, Roma-Bari 1992. 41 L. Priario, Quaresimale politico del 1860, Genova 1860, p. 3. 27 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 28 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 29 PENSARE LA NAZIONE Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi di Rolf Petri In quello che anche a distanza di tanti anni ritengo un capolavoro, Nazione e lavoro, Silvio Lanaro ha dimostrato come tra fine Ottocento e Grande guerra nei gangli profondi dell’Italia liberale «una cultura tutta intera – egemone nel senso pieno del termine – sembra lentamente ma irresistibilmente avanzare verso l’approdo di concezioni totalizzanti della società e dello stato»1. L’autore evidenzia nello spostamento della cultura dominante inequivocabili tratti di specificità nazionale, ma anche come tale spostamento sia espressione di pulsioni teoriche e culturali diffuse nella società europea. Mi interessa qui approfondire una delle sue fonti, Il sentimento imperialista di Giovanni Amadori-Virgilj2. Per Lanaro il testo concorre a comprovare l’incedere di visioni totalizzanti: «Amadori tratta gli individui alla stregua di esseri decerebrati, e li considera segmenti infinitesimi della “coscienza di gruppo”»3. Attribuire alle eccitazioni collettive un valore di soggettività sembra essere per Lanaro un indizio della rottura che sta per compiersi con l’ideale di una borghesia autenticamente liberale che metta al centro l’individuo. Usa l’apparente ossimoro «socialismo della borghesia»4 per segnalare come in Italia, sotto l’urto della società di massa e del permeante influsso della cultura cattolica, quell’ideale sia venuto a essere messo da parte. Ma la filosofia politica e di Stato della borghesia europea e americana, le sue concezioni storiche e culturali di fondo, sono davvero scevre di elementi totalizzanti? Sono concepibili senza il loro originario carico trascendentale e sentimentale? Nelle pagine che seguono non posso condurre una dissertazione all’altezza di una simile enorme domanda. Ma abusando delle osservazioni di Amadori 1 S. Lanaro, Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925, Marsilio, Venezia 1979, p. 87. 2 G. Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista. Studio psico-sociologico, Sandron, Milano 1906. 3 Lanaro, Nazione e lavoro cit., p. 70. 4 Ibid., p. 285. 29 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 30 Rolf Petri per commentare eventi che attraversano i secoli, spero di poter almeno accennare ad alcuni aspetti rilevanti come la sacralizzazione del politico, rivenibile sin dalla Rivoluzione francese, e l’educazione sentimentale praticata dai movimenti e Stati nazionali. 1. Il sentimento imperialista secondo Giovanni Amadori-Virgilj. Nonostante l’esaltazione del carattere scientifico dell’indagine, che peraltro non gli si può negare data la sistematicità dell’approccio, Amadori-Virgilj evita di rivelare i riferimenti teorici del proprio pensiero. Lanaro ipotizza dietro alla gnoseologia percezionista di Amadori l’influsso dello psicologo e pedagogista Roberto Ardigò, e dietro alle disquisizioni sulle rappresentazioni psichiche interindividuali e coercitive «una lettura estremistica di Durkheim»5. A queste condivisibili ipotesi si potrebbe forse aggiungere il sospetto di qualche lettura di psicologia americana. Sempre priva di rimandi espliciti, ma lampante, è la presenza contestuale di Gustave Le Bon6. È su simili basi che Amadori-Virgilj sviluppa la sua originale teoria. All’autore preme spiegare l’imperialismo nei termini di «un fenomeno essenzialmente moderno»7 ed è proprio la modernità del fenomeno a fargli rifiutare modelli esplicativi impostati sull’interesse economico e razionale. Trattasi, piuttosto, secondo Amadori, di un fenomeno simil religioso alimentato da credenze e passioni collettive; di una religione quindi dei tempi moderni assimilabile all’idea di nazione che di fatto pone su un piano nuovo i rapporti di potere tra gli Stati. Fenomeno, questo, ingenerato da quattro «persone psico-sociologiche» che rappresentano gli «individui irriducibili del mondo sociale»: il gruppo, ad esempio un «popolo» o una «razza», che si configura come un insieme composito ed eterogeneo di uomini e donne esposti al contempo a una pressione unificante di fattori ambientali quali la discendenza, le tradizioni, i costumi, lo Stato, la religione, la geografia, la natura, la lingua; il pubblico, unito dalla consapevolezza di condividere la simultaneità dell’ascolto; la folla, unita da un contatto fisico che assorbe cancellandole le residue pulsioni di azione autonoma; infine, l’uomo dirigente, che acquista con la sua «esclusiva individualità un valore sociale». Quest’ultima figura tuttavia si suddivide negli uomini rappresentativi del gruppo-persona e nelle figure di meneurs funzioIbid., p. 70. G. Le Bon, Psychologie der Massen (Psychologie des foules, 1895), Kröner, Stuttgart 1922. 7 Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., p. 63. 5 6 30 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 31 Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi nali alla psicologia della folla descritta da Le Bon8. «E l’evoluzione mentale collettiva procede appunto dal lavoro psichico di queste quattro persone. Fra queste hanno un valore primario il gruppo e gli individui dirigenti; un valore secondario e derivato il pubblico e la folla. Perché un fenomeno psichico non può formarsi generalmente al di fuori del lavoro e del gruppo e degli individui, mentre può sussistere di solito senza ricorrere all’opera complementare, rafforzatrice del pubblico e della folla»9. Il fenomeno sociale a cui Le Bon attribuisce l’incontrastato dominio nell’«era della folla», per Amadori appartiene quindi solo a una casistica subordinata di una più generale fenomenologia della psicologia collettiva. Nella dinamica tra i componenti di un gruppo egli prevede dunque senz’altro anche momenti di complessità, frizione, pluralità e consapevolezza. Ma è altresì vero che degli unici tre gruppi, o popoli, o razze, ritenuti da lui imperialisti alla sua epoca – quello americano, quello britannico e quello tedesco – Amadori non rileva un comportamento molto cosciente. «Si riscontra soltanto uno stato di desiderio, che non richiede il concetto di un’esecuzione ordinata di atti per soddisfarlo»10. Sembra dunque valere per essi ciò che Le Bon sostiene per la folla: è l’incoscienza a dare loro la forza. Pertanto non è fuorviante sospettare, con Lanaro, che «Amadori giunge per sentieri diversi a sognare […] il grande demiurgo che indurisce i muscoli dei popoli molli»11. Però quel demiurgo non necessariamente dev’essere un duce in carne e ossa. Può ben essere anche la stessa fede fanatica da cui il gruppo si fa contagiare, come nell’enunciato del fondatore della psicologia americana, William James, secondo cui il pensiero è «esso stesso il pensatore»12. In definitiva, se l’opera di Amadori non è apertamente apologetica, la scientificità dietro a cui l’autore si trincera sta anche a significare che non si tratta di un pamphlet antimperialista. Nella prefazione il deputato Errico De Marinis sollecita l’autore a una maggiore chiarezza su questo punto, auspicando che «di fronte al progredire della vita imperialistica» anche l’Italia si doti di, e attui, un simile «programma»13. Ecco dunque fin qui accennate, per sommi capi, le coordinate politiche, teoriche, metodologiche e contestuali dell’opera. Coordinate che Le Bon, Psychologie der Massen cit., pp. 83-92. Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., pp. 30-47. 10 Ibid., p. 320. 11 Lanaro, Nazione e lavoro cit., p. 72. 12 W. James, Principles of Psychology, I, H. Holt & Co, New York 1890, p. 401. 13 E. De Marinis, Prefazione, in Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., pp. VIIXVII, qui XVI. 8 9 31 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 32 Rolf Petri senza dubbio ne rendono cogente la discussione in Nazione e lavoro, ma che al contempo meritano attenzione in un’ottica più ampia. Su alcune di esse sarà il caso di tornare, su altre, strumentalmente, sorvolerò, perché il contesto plurisecolare, europeo e occidentale, in cui inquadrerò il testo comporterà una parziale astrazione dal più ristretto periodo e assetto geopolitico da cui è scaturito. Ma perveniamo al nocciolo contenutistico dell’opera, efficacemente condensato in un brano chiave discusso anche da Lanaro. Cosa vuol dire «sentimento imperialista»? Teoriche d’espansione infinita, di predominio mondiale politico, idee di invasioni commerciali e coloniali, affermazioni di superiorità congenita di razza, razionalizzata deficienza di concetti inibitori di atti politici amorali, teoriche a legittimazione della violenza materiale nell’azione pubblica e privata – ma nel tempo stesso un immenso desiderio di bontà, di moralità pubblica e privata, di pace universale, pensieri altruistici, fede religiosa; e ancora l’azione concreta e varia del gruppo, la reale conquista coloniale, la conquista economica, armamenti colossali, la pericolosa e gravosa politica mondiale, la cura minuta di tutto l’organismo dello Stato per aumentarne la potenzialità morale, politica e militare; e infine l’azione dei filosofi e dei poeti che teorizzano e cantano, sublimandole, queste nuove correnti germinate nella collettività, costituiscono nel loro complesso gli elementi principali di questa trasformazione ed intensificazione intellettuale14. Questo tanto esteso quanto denso periodo racchiude in sé gli elementi più importanti del sentimento imperialista secondo Giovanni Amadori-Virgilj. Ce ne sarebbe per scriverci sopra un’altra dissertazione. In questa sede non resta che estrapolarne alcuni aspetti di particolare interesse. 2. «Teoriche di predominio mondiale politico». Come per conferma dell’attualità del testo di Amadori vediamo oggi, più di un secolo dopo, diffondersi e celebrare un libro come The Geopolitics of Emotion di Dominque Moïsi. L’autore dichiara di non proporre una «mappatura emozionale della globalizzazione»15, ma individuando le macro-aree odierne della speranza, del senso di umiliazione e della paura, si confronta con quanto ritiene essere una «crisi di identità» del Mondo Occidentale. Sotto il motto shakespeariano And make us lose the good we oft might win/ By fearing to attempt, l’autoAmadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., p. 54. D. Moïsi, The Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope Are Reshaping the World, Doubleday, New York 2009, p. 7. 14 15 32 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 33 Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi re lamenta la cultura della paura in preda a cui vede caduto l’Ovest. Non è un lamento estemporaneo, se la paura è quella di non poter più giudicare, educare, insegnare, aiutare, condurre, liberare e deliberare, in breve eseguire tutte quelle azioni in cui si sostanzia l’identità di un Ovest deputato dalla Storia ad anticipare e accompagnare, come scrisse il Marchese di Condorcet, il progredire di tutta l’umanità16. Osserva Moïsi: La crisi di identità in cui è caduto il Mondo Occidentale potrebbe essere riassunto nel concetto della paura. Ma una singola parola può stare per realtà diverse. La paura che oggi domina l’America è assai differente da quella che pervade l’Europa. Ciò nonostante non è una semplificazione eccessiva dire che ciò che unisce i due rami dell’Ovest, Europa e America, è la paura. Ed è esattamente il fattore-paura che ci potrebbe anche dividere se domani l’America, sotto la guida di un giovane presidente, si scrollasse di dosso la cultura della paura per ripristinare la sua tradizionale cultura della speranza, mentre l’Europa […] sprofonda sempre di più nella sua perdita di fiducia17. Nella primavera del 2011, in un discorso alla britannica House of Commons subito definito storico dalla stampa, un Barack Obama fresco di liquidazione del Principe del Terrore afferma come «dopo una decade difficile che iniziò con la guerra e finì con la recessione» l’economia globale si dimostri di nuovo «stabile e sulla via della ripresa»; per poi affermare che «in un mondo in cui il benessere di tutte le nazioni non è più districabile da quello di tutte le altre, vi è bisogno di una nuova era di cooperazione per assicurare all’economia globale crescita e stabilità». Il «giovane presidente della speranza» prende energicamente di petto la culture of fear, ingenerata dall’ascesa di nuove potenze economiche e politiche: In alcuni circoli è diventato di moda domandarsi se l’ascesa di queste nazioni andrà di pari passo con il declino dell’influenza americana ed europea nel mondo. Forse, così arguiscono, sono quelle nazioni a rappresentare il futuro, mentre il tempo della nostra leadership è scaduto. È una tesi sbagliata! Il tempo della nostra leadership è adesso! Sono stati gli Stati Uniti, il Regno Unito e i loro alleati democratici a plasmare un mondo in cui nuove nazioni potevano emergere e nuovi individui avere successo. E anche se più nazioni accetteranno le responsabilità della leadership globale, la nostra Alleanza rimarrà indispensabile per l’obiettivo di un secolo più pacifico, prospero e giusto18. 16 J.-A. de Caritat marquis de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1794), Ouvrage posthume, Milano 17985. 17 Moïsi, The Geopolitics of Emotion cit., p. 91. 18 B. Obama, Magna Carta. Full text of Obama’s speech to UK parliament, May 25, 2011, in «CNN Politics», pp. 2, 3, http://articles.cnn.com/2011-05-25/politics/obama.europe.speech_1_magna-carta-english-bill-uk-parliament/3?_s=PM:POLITICS. 33 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:28 Pagina 34 Rolf Petri 3. «Legittimazione della violenza materiale». Quello vissuto da Amadori, agli albori di un secolo prospero che di pacifico avrà poco, è un periodo che oggi viene talora ribattezzato «epoca prima della globalizzazione». E infatti già nel suo presente l’autore avverte che «il termine del pensiero è il mondo, questo è il campo d’azione e il risultato della lotta», un campo in cui si diffonde una «idea di bene mondiale». Ancora però non conosce le future istituzioni della comunità internazionale, come ad esempio il Tribunale penale internazionale dell’Aja, istituito di recente affinché vengano deferiti al suo giudizio ex dittatori, militari, primi ministri e altri autori e mandanti di efferati crimini di guerra e contro l’umanità – purché, pare, non siano liberamente eletti da quelli che Amadori chiama «popoli imperialisti». Ma già avverte che «l’idea della sovranità e della libertà degli Stati si attenua e sta per essere eliminata»19. Commentando la guerra mossa all’Iraq dalla Coalizione dei volenterosi nel 2003, Noam Chomsky sostiene che «non è controverso che Bush e i suoi alleati commisero il “crimine internazionale supremo”». Si tratta di un’imputazione della fattispecie mossa contro il regime nazista dal giudice Robert Jackson, rappresentante dell’accusa al Tribunale di Norimberga per conto degli Stati Uniti. «Un “aggressore”, propose Jackson al Tribunale nella sua arringa d’apertura, è quello Stato che per primo commette azioni come la “invasione delle proprie forze armate, con o senza dichiarazione di guerra, nel territorio di un altro Stato”». E a Chomsky piace «ricordare le eloquenti parole con cui Jackson si richiamò al principio dell’universalità: “Se certi atti di violazione di trattati configurano atti criminali, si tratta di crimini indipendentemente dal fatto che siano gli Stati Uniti o la Germania a compierli; non siamo disposti a muovere un’accusa di condotta criminale contro altri che non vorremmo veder mossa anche contro di noi”»20. Il 23 gennaio 2009 la Bbc lancia la notizia che «in due attacchi missilistici da parte di supposti droni Usa sono rimaste uccise 14 persone nel nordovest del Pakistan. […] Si tratta dei primi attacchi di drone da quando è stata inaugurata la presidenza di Barack Obama marAmadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., pp. 70-1, 106. N. Chomsky, The Imperial Mentality and 9/11, postato il 6 settembre 2011 su http://www.tomdispatch.com/blog/175436/tomgram%3A_noam_chomsky,_the_imperial_ mentality_and_9_11/; per un elenco degli interventi militari Usa tra il 1890 e il 2011 si veda Z. Grossman, From Wounded Knee to Libya. A Century of US Military Interventions, http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/interventions.html. 19 20 34 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 35 Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi tedì scorso. […] Seguendo fonti locali, il secondo attacco era diretto all’abitazione di un leader talebano situata a circa 10 chilometri dalla città di Wanna. Ma funzionari hanno riferito alla Bbc che in realtà il drone ha centrato la casa di un leader tribale filo-governativo uccidendolo insieme a quattro suoi famigliari, tra cui un bambino di cinque anni»21. Racconta ancora Chomsky che «il primo maggio 2011, Osama bin Laden è stato ucciso in un complesso abitativo virtualmente indifeso da un’incursione di 79 Navy Seals entrati in Pakistan in elicottero. Dopo una ridda di versioni rocambolesche prima diffuse e poi smentite dal governo, poco alla volta i rapporti ufficiali hanno fatto trapelare che l’operazione è stata un assassinio pianificato nonché una violazione multipla di svariate norme del diritto internazionale, a iniziare dall’invasione stessa»22. Ma è ammissibile equiparare atti pur materialmente simili nello svolgimento extra-giudiziario e identici nell’esito letale, essendo l’uno un «atto terroristico» e l’altro una «eliminazione mirata» eseguita da forze speciali di nazioni democratiche? L’uno un «barbaro assassinio» e l’altro un «intervento chirurgico»? L’uno un efferato crimine contro l’umanità e l’altro un deplorevole «danno collaterale» originato da un’azione compiuta a fin di bene? Amadori cita Theodore Roosevelt, presidente repubblicano Usa che nel 1904 dichiara al Senato: «Lo scopo di questa nazione, come di tutte le nazioni illuminate, dev’essere quello di avvicinare il giorno in cui su tutto il mondo prevalga la pace della giustizia»23. Scrive sempre Roosevelt in quegli anni che «la pace spesso non può essere ottenuta che a costo di una guerra […]. Ogni espansione (guerra) di una grande potenza civile rappresenta una vittoria della legge, dell’ordine, della rettitudine: quindi chi propugna l’espansione sostiene in verità la causa della pace»24. Parlando centosette anni dopo davanti al Parlamento britannico, Obama ribadisce che «le nostre due nazioni sanno cosa significa affrontare il male nel mondo. […] E proprio perché siamo pronti a farcene carico, conosciamo bene anche i costi della guerra. Per questo avevamo creato un’alleanza abbastanza forte come deterrente tale da 21 Deadly missiles strike Pakistan, «Bbc One-Minute World News», 23 gennaio 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7847423.stm. 22 Chomsky, The Imperial Mentality cit. 23 Messaggio di Roosevelt al Senato (1904), citato da Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., p. 108. 24 T. Roosevelt, Vigor di Vita (The Strenuous Life, 1899), Treves, Milano 1904, citato da Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., p. 108. 35 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 36 Rolf Petri poter difendere questo continente dai nostri nemici. […] Oggi combattiamo un altro nemico. […] Da questo nostro sforzo non desisteremo, come Osama bin Laden e i suoi discepoli hanno imparato»25. Commenta Amadori: Nella psiche popolare è quindi un dogma che l’impero parli a nome della civiltà, del bene mondiale: un dogma che si combatte o si accetta, ma che non si discute. Sicuri in esso, chiusi nella loro unilateralità, i popoli imperialisti non comprendono l’opposizione di attività contrarie, la rigida convinzione di doverle rovesciare anche coll’estrema brutalità in nome e pel bene della civiltà ne è il risultato immediato. La violenza, che spesso si riscontra nell’attività di tali popoli, oltre che dipendere in linea fondamentale dal trattarsi di sentimento collettivo, dipende anche da questi rapporti logico-dogmatici, che gli individui si imbastiscono nella loro costituzione psichica. Il popolo americano ha tollerato ed approvato le stragi alle Filippine, e quello inglese i massacri del Transvaal perché hanno anche considerato questi fatti, se non mezzi necessari, certo mezzi dei più speditivi per la vittoria decisiva della civiltà26. 4. «Idee di invasioni commerciali e coloniali». Ricordando i «rapporti logico-dogmatici che gli individui si imbastiscono nella loro costituzione psichica», Amadori-Virgilj solleva un aspetto centrale di quella faccenda che egli chiama «imperialismo» e che accosta in parte all’esperienza del colonialismo. Già il colonialismo portoghese e spagnolo, in cui sin dall’inizio la Chiesa cattolica ebbe un ruolo di prima linea come missionaria del Verbo del Signore e insieme portatrice di interessi economici propri27, è stato sovente raccontato come cinico tradimento, per avidità economica e brama di profitto, di un messaggio fondamentalmente buono. La stessa modalità di racconto si riscontra riguardo all’«imperialismo» dei secoli nostri. Se gli Usa hanno invaso l’Iraq non era per appendere a una corda il novello Hitler, scovare le sue armi di distruzione di massa e portare al suo popolo oppresso la democrazia e la libertà. È stata, continuano i critici, una guerra imbastita dalle cricche dell’aristocrazia petrolifera americana attorno a Dick Cheney e Donald Rumsfeld che per poter mettere le mani sui pozzi di petrolio tra Eufrate e Tigri, o impedire che vi mettessero le mani iraniani, russi e cinesi o al limite che Saddam Hussein mettesse le sue 25 Obama, Magna Carta cit., pp. 5, 6, http://articles.cnn.com/2011-05-25/politics/obama.europe.speech_1_magna-carta-english-bill-uk-parliament/6?_s=PM:POLITICS. 26 Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., p. 110. 27 Cf. ad esempio V. Magalhaes Godinho, The Portuguese Empire 1565-1665, in «The Journal of European Economic History», XXX, 2001, 1, pp. 49-104. 36 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 37 Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi quelli del Kuwait, hanno fatto cinico uso di un’intenzione fondamentalmente buona, quella di divulgare nel mondo democrazia e libertà («un dogma che si combatte o si accetta, ma che non si discute»). Amadori-Virgilj sostiene invece la futilità di simili ragionamenti: la bontà del messaggio gli è indistinguibile dall’azione e dall’intenzione che la muove ed è anzi essa il vero problema; ed è anche inutile eccedere nell’imputazione di cinismo ai leader o ai gruppi di interesse e di potere, perché «l’uomo dirigente» è tale solo in quanto capace di dar voce ai sentimenti collettivi. Come Obama, quando nel 2011 afferma di fronte ai rappresentanti del popolo britannico e ai telespettatori del mondo: In questo secolo la nostra comune leadership richiederà nuove alleanze e l’adattamento a nuove circostanze, e il rinnovamento di noi stessi per affrontare le sfide di una nuova éra. Questo a iniziare dalla nostra leadership economica. Rimane vera ancora oggi l’idea centrale di Adam Smith: non esiste un più potente generatore di benessere e innovazione di un sistema di libere imprese che sprigioni il pieno potenziale di uomini e donne. […] Altrimenti detto, viviamo in un’economia globale che è in massima parte opera nostra. E oggi la competizione per i migliori posti di lavoro e le migliori industrie favorisce i paesi del libero pensiero che guardano avanti; paesi con i cittadini più creativi, innovativi, intraprendenti. Ciò conferisce a paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito un vantaggio intrinseco28. La chiamata in correità di Adam Smith appare acuta, forse involontariamente, anche per un altro motivo: il filosofo scozzese riteneva che il proprio capolavoro fosse non tanto la Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) quanto la Theory of Moral Sentiments (1759), in cui aveva spiegato come la motivazione ultima dell’agire umano consistesse nel desiderio di riconoscimento. 5. «Un immenso desiderio di bontà». Le più accreditate teorie dell’imperialismo all’epoca di Amadori non ignorano l’importanza dei sentimenti morali, ma poco credito danno ad essi sul piano della spiegazione del fenomeno stesso. John Atkinson Hobson, nella sua opera, dà rilievo al fervore dei filantropi benpensanti. Riformatori e missionari mossi dall’ethos accompagnano con convinzione l’opera finanche dei più criticati imperialisti, come Leopoldo II del Belgio, che non esita a dichiarare, a proposito del 28 Obama, Magna Carta cit., p. 4, http://articles.cnn.com/2011-05-25/politics/obama.europe.speech_1_magna-carta-english-bill-uk-parliament/4?_s=PM:POLITICS. 37 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 38 Rolf Petri Congo, che «il nostro unico programma è la rigenerazione morale e materiale del paese». Ma tali ingenui, arguisce Hobson, «hanno in gran parte una pessima formazione in psicologia e storia, e quindi ritengono che la religione e le altre conquiste della civiltà siano beni trasferibili che è nostro dovere portare alle nazioni arretrate, e che nel caso di popoli troppo incolti una certa dose di costrizione, per apprezzare tali beni, sia giustificata. Può sorprendere che le forze egoistiche che guidano l’Imperialismo indossano le tute mimetiche di simili movimenti disinteressati? Politici imperialisti, soldati, dirigenti d’azienda […] semplicemente e istintivamente attribuiscono a sé stessi qualunque forte e genuinamente elevato sentimento che possa servire loro, lo eccitano e lo fomentano fintanto che non diventi fervore, per poi usarlo ai propri fini»29. Per Amadori, i veri ingenui sono invece i critici dell’imperialismo che come Hobson credono nell’uso strumentale e manipolativo dei buoni sentimenti da parte di individui e gruppi interessati al vantaggio economico e al potere militare e politico. È vero che esistono, e che «la dichiarazione di disinteresse, che il sentimento promuove, chiude il circolo giustificativo» loro, ma ciò non significa che il sentimento di bontà, nel concerto delle cause che spiegano l’imperialismo, sia un paravento. «Sulla lineazione generale del sentimento imperialista questo concetto altruistico» è «uno dei fattori, e non dei meno importanti, della fede e della sicurezza morale nei destini imperiali». Per questo Amadori denuncia «l’assoluta deficienza di tutte le definizioni che si sono volute dare al fenomeno come fatto di tendenzialità politico-economiche». Questo perché, in buona sostanza, per Amadori l’imperialismo «è un sentimento, un sentimento generale di popolo» e il concetto collettivo della dominazione «è quello della egemonia morale; cioè il popolo non identifica il suo predominio in un materiale impero politicomilitare od economico, ma piuttosto in un impero morale, che si deve espandere anche nel campo intellettuale, politico ed economico»30. 6. «Un apostolato da compiere». L’autore prosegue precisando che «nel sentimento imperialista vi è dunque profondo e preciso il concetto di un apostolato da com29 J. A. Hobson, Imperialism. A Study, James Nisbet, London 1902, citato dalla ristampa della Cambridge Library Collection, Cambridge University Press, New Haven 2010, p. 208. 30 Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., pp. 63, 70, 104-5. 38 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 39 Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi piere»31. A questo punto nasce il sospetto che Amadori stia parlando di qualcosa di più generale che non dei fenomeni che altri suoi coevi riconducono prosaicamente a un livello di accumulazione di capitale cui vanno strette le frontiere nazionali. Di quale apostolato si tratta? Il giorno 26 agosto 1789, su proposta dell’eroe dell’indipendenza americana, il generale Gilbert du Motier de La Fayette, l’Assemblea nazionale di Parigi vara la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nella convinzione di non fissare soltanto il preambolo della futura Costituzione francese. «La dichiarazione doveva essere parimenti il credo della nuova Francia e il catechismo di “tutti gli uomini, di tutti i tempi e di tutti i paesi”»32. Nei giorni successivi, a illustrazione dell’evento su un foglio dell’epoca, appare un anonimo disegno allegorico che mostra come due divinità, Ragione e Umanità, dopo aver scacciato gli spiriti maligni dell’oscurantismo religioso e del regime aristocratico, consegnano la Dichiarazione a un uomo in uniforme militare francese che la consegna a un altro uomo, forse uno schiavo, di pelle nera parzialmente coperta da un perizoma. Tutti gli uomini di tutti i tempi e tutti i paesi: forse l’approdo di concezioni totalizzanti non è proprio solo del momento in cui Amadori-Virgilj sviluppa una teoria dell’imperialismo. A buon diritto il testo può essere inserito tra i tanti prodromi della guerra e della dittatura a venire. Ma la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, come sta al terrore e alla guerra a venire? Quando nel 1792 la maggioranza dell’Assemblea guidata dalla Gironde di Brissot vota a favore, vi è chi sostiene che «hanno votato la guerra ai re e la pace alle nazioni»33 ubbidendo alla missione universale che ispira la rivoluzione. Ma i giacobini invitano ad attendere, scorgendovi dietro una mossa della reazione. Certo, la rivoluzione significa «guerra eterna agli oppressori» di tutti i tempi e tutti i paesi, ma prima di esportarla, ammonisce Robespierre, serve il suo consolidamento in patria. «La generazione nascente, più pura, più fedele alle sacre leggi della natura, comincerà a mondare questo suolo lordato dal crimine; porterà non la pace dei despoti né i vergognosi raggiri dell’intrigo, ma la sacra fiamma della libertà e la spada sterminatrice dei tiranni»34. Ibid., p. 111. La révolution française. Le 14 juillet, http://www.diagnopsy.com/Revolution/Rev_011.htm. 33 J. Michelet, Histoire de la Révolution Française, II, Hetzel, Paris 1853, p. 212. 34 Discours de Maximilien Robespierre sur la guerre prononcé a la société des amis de la constitution le 11 janvier 1792, The Project Gutenberg EBook of Discours par Maximilien Robespierre, 5, http://www.archive.org/stream/discoursparmaxim29775gut/pg29775.txt. 31 32 39 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 40 Rolf Petri Nota compiaciuto Novalis, scrivendo nel 1799 il suo manifesto del conservatorismo moderno, come la Rivoluzione, più che esserne la messa in pratica, segna la fine di molti propositi dell’Illuminismo. Ancorché ispirata a quei «nefasti» valori, manda tuttavia al mondo il segnale di una grande rigenerazione per aver riportato nell’agorà la fede, la passione, il sentimento, la sacralità – il Pantheon, i riti funebri, il falò della Libertà – e immerso i concetti di Umanità, Ragione e Natura in un’aura trascendentale. Pertanto anche un fiero oppositore cattolico del giacobinismo qual è Novalis può riconoscere come «storicamente notevole il tentativo di quella grande maschera di ferro che sotto il nome di Robespierre tentò di fare della religione il centro e la forza della Repubblica»35. Siglando, con simili gesti grondanti sacralità, l’atto di nascita della moderna cultura politica. Già nei giorni solenni della Dichiarazione dei diritti dell’uomo dentro l’Assemblea si sprecano le allegorie e le parabole bibliche nonché gli accenni al secolo dei Lumi i cui concetti filosofici si intendono portare all’apoteosi rivoluzionaria. L’Assemblea «attesta l’Essere supremo, garante della morale umana. Essa respira il sentimento del dovere»36. Deliberando sulle ultime verità, la Rivoluzione dei cittadini-borghesi chiude l’epoca dei Lumi eliminandone solo le espressioni più deresponsabilizzanti, dissacranti, disilluse, scettiche. Mentre quelle ritenute valenti vengono sottratte all’esclusività elitaria dei salotti per diventare materia di lotta politica per tutti gli uomini, inculcando loro un senso del dovere all’insegna di «un dogma che non si discute», talmente forte da sacrificare la vita, all’occorrenza la propria, altrimenti quella altrui. Il metodo politico cambia radicalmente, ma molte conquiste filosofiche dell’età dei Lumi non devono essere superate visto che già ricalcano esse stesse un preciso modello escatologico. Ricorda Löwith come dalle maggiori filosofie della storia, da Rousseau a Condorcet a Herder e altri, la missione cristiana sia stata tradotta in una missione civilizzatrice parimenti atta a redimere l’uomo. «Il fatto stesso che ci interroghiamo sul senso o non senso della storia nel suo insieme è un derivato storico: a far nascere tale domanda smisurata è stato il pensiero giudaico e cristiano»37. Nella prassi e nella retorica della Rivoluzione parole come catechismo, apostolato, fiamma sacra della libertà e dovere non risuonano 35 Novalis [F. von Hardenberg], Die Christenheit oder Europa (1799), in Id., Monolog, Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg 1963, pp. 35-52, qui 44-6. 36 J. Michelet, Histoire de la Révolution Française, I, Chamerot, Paris 1847, p. 202. 37 K. Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Zur Kritik der Geschichtsphilosophie (1949), in Id., Sämtliche Schriften, II, Metzler, Stuttgart 1983, p. 14. 40 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 41 Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi quindi a caso. È nata una religione nuova, politica, moderna, e non meno fanaticamente votata di quella antica all’apostolato universale. Nel giorno dell’Ascensione 2011 un prete della diocesi di Tolosa, tale René Belleme, ricorda come Gesù, nel prendere commiato dai compagni di vita terrena, afferma che «il testimone è passato nelle loro mani. Sono loro a essere i testimoni del suo messaggio che vuol essere la Buona Novella per tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i paesi, in tutte le epoche»38. Non sappiamo se padre Belleme abbia letto, oltre alla Bibbia, qualche testo sulla Rivoluzione francese, per esprimersi con tali testuali parole a favore di un apostolato da compiere in nome del Bene supremo. Ascensione, elevazione, sublimazione, educazione. Scrive Amadori: «sarà una ricostruzione educativa mondiale, basata su tali concetti, che costituirà il bene, i vantaggi apportati alla dominazione imperiale. Forza fatta di energia, ma nel tempo stesso di giustizia, vigoria di coscienza moralmente buona, volontà netta e decisa nell’eseguire i suoi doveri, e nel cercare il proprio benessere: saran questi i fondamenti dell’educazione dei popoli del mondo; mentre lo sviluppo immenso di tutte le energie materiali accompagnerà questa elevazione morale»39. Attraverso simili parole da un lato si esprime un «approdo di concezioni totalizzanti della società» sempre più vigoroso negli anni che precedono la Grande guerra; dall’altro, tuttavia, non si fa che ricalcare, sotto il nome dell’imperialismo, quanto sin dalla fine del Settecento appartiene al nocciolo concettuale più intimo della «cultura borghese» europea e occidentale. 7. «Un sentimento generale di popolo». Essendo quello imperialista, secondo Amadori, un sentimento di popolo, «in questa sua generalità sociale, nel suo carattere quasi passionale stanno le uniche peculiarità, che individualizzano attraverso la storia il fenomeno, lo rendono incomparabile alle conquiste che formarono gli imperi monumentali di tutte le epoche passate»40. L’autore sembra voler stabilire un legame tra il desiderio di bontà e dominio, e la forma stessa della sovranità politica; sembra inoltre voler accennare 38 R. Belleme, Homélie de l’Ascension du 2 juin 2011, http://www.doyenne-luchon.com/ index.php?mod=articles&ac=commentaires&id=262&PHPSESSID=3e9c649ad3abef5c1b05f 769750291cf (i corsivi sono miei). 39 Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., p. 106. 40 Ibid., p. 63. 41 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 42 Rolf Petri al fatto che con l’emergere dei moderni concetti di nazione, le legittimazioni mitologiche e trascendenti del potere subiscano, tra Sette e Ottocento, un radicale mutamento rispetto a quelle reggenti i poteri aristocratici, dinastici e imperiali precedenti41. E in effetti, poggiando il potere sovrano sul renaniano «plebiscito quotidiano», vengono direttamente chiamati in causa l’adesione, la coscienza e il senso del dovere di ogni singolo. Con una simile esigenza politica il ruolo della «religione civica», del patriottismo, del senso di sacralità della nazione e della sua missione universale è destinato a crescere. Come colto all’istante da un credente per consapevole scelta come Novalis, con la sovranità popolare il sentimento «torna» nell’agone politico. Eppure, i dogmi di fede e i sentimenti del sacro raramente nascono spontaneamente, così come raramente i relativi «rapporti logico-dogmatici» vengono imbastiti spontaneamente nella «costituzione psichica». In genere sono frutto di un costante indottrinamento impartito, generazione dopo generazione, all’infanzia e alla gioventù. Scocca quindi l’ora della pedagogia patriottica, del sacerdozio educativo nazionale, che anche secondo Amadori costituisce la base del sentimento imperialista. Sin dal tardo Settecento la pedagogia mette in raccordo l’esperienza percettiva diretta con lo sviluppo della personalità e il suo inquadramento in una comunità solidale, patriottica e di fede compatta. La «giusta comprensione di tutti gli oggetti del mondo esteriore» risale «dalla osservazione al concetto, dal particolare al generale, e da lì ridiscende, in un diverso relazionarsi, dal generale al particolare»42. Una strategia questa atta a rendere fisicamente sperimentabile il connotato comunitario e patriottico, etnico o nazionale, della propria esistenza attraverso l’appropriazione degli oggetti appartenenti allo spazio circostante: è da subito «folla», dunque, almeno «folla sentita» in senso metaforico. È un concetto che anche Amadori coglie quando dice che «così il patriottismo segue la sua trajettoria, la sua linea evolutiva ascendente: ristretto prima all’urbs, poi al comune, poi al principato, infine allo Stato politico ed alla nazione, si estende oggi ancora alla razza intera e la avvolge colla sua affettività»43. Per il coevo 41 Su questo passaggio si veda ad esempio l’utile rassegna di A.-M. Thiesse, La Création des identités nationales, Éditions du Seuil, Paris 1999. 42 F. Fröbel, Kommt, lasst uns unsern Kindern leben! Aus dem pädagogischen Werk eines Menschenerziehers, Volk und Wissen, Berlin 1989, I, pp. 207, 209; per una valutazione complessiva si veda R. Petri, Nostalgia e Heimat. Emozione, tempo e spazio nelle costruzioni dell’identità, in Nostalgia. Memoria e passaggi tra le sponde dell’Adriatico, a cura di Id., Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2010, pp. 15-45, qui 27-33. 43 Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., p. 79. 42 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 43 Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi Alfred Fried è soprattutto un meccanismo di inclusione sociale, poiché dato «l’insufficiente sviluppo di capacità razionali tra le classi subalterne, le classi dominanti si industriano a trasmettere il loro patriottismo stimolando una serie di percezioni sensoriali»44. Come in epoca contemporanea si intreccino l’idea di nazione e il senso di missione universale, lo abbiamo variamente accennato: nessuna nazione europea intende giustificata la propria esistenza solo in quanto tale né si sente soltanto di se stessa appagata; ognuna si sente invece incaricata di una missione universale che trascende la propria realtà e trova la sua originaria sistemazione nelle filosofie della storia umana forgiate dall’Illuminismo45. Volendo dunque tornare al «sentimento imperialista», è probabilmente giustificato rimarcare le differenze con «gli imperi monumentali di tutte le epoche passate». Ma qualche precedente storico – somigliante e al contempo diverso come tutti i precedenti storici – forse si trova. Ricorda Schachermeyer come nell’Atene di Pericle «non si volle introdurre una rigida disciplina e una cieca obbedienza; tutto il popolo doveva piuttosto dimostrare liberamente un ideale di virtù (areté). Ciò non significava altro se non che il popolo doveva rappresentare nella sua totalità una specie di aristocrazia elitaria». E una volta «considerata Atene una sorta di idolo posto al di sopra di tutto, si era pronti ad ogni sopruso, a qualsiasi azione di forza contro chicchessia; era infatti passata l’epoca della tolleranza di Cimone; Atene entrava sotto il segno del fanatismo». Siamo lontani ancora secoli dal senso di missione universale e redentrice dell’umanità, ma l’autore non ha dubbi «che il regime attico abbia introdotto non solo i benefici della democrazia, ma anche gli effetti negativi della violenza»46. 8. «Secondo la costituzione psichica che gli individui si sono formati». Lanaro vede Amadori trattare gli individui nella guisa di un «paretismo anticipato e capovolto», e colloca il suo ragionamento tra le «filosofie del numero» che in quel frangente «sono spie sicure di un’avvenuta obsolescenza delle nomenclature ideologiche liberali»47. Sotto A. H. Fried, Internationalismus und Patriotismus, Dietrich, Leipzig 1908, p. 8. Più particolari in R. Petri, Europa? Ein Zitatensystem, in «Comparativ», XIV, 2004, 3, pp. 14-49. 46 F. Schachermeyer, Pericle (1969), Salerno Editrice, Roma 1985, pp. 41-2, 55. 47 Lanaro, Nazione e lavoro cit., pp. 67, 72. 44 45 43 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 44 Rolf Petri vari aspetti si è trattato dell’obsolescenza effettiva di un modello che neanche nel prosieguo del Novecento si dimostrerà più ricuperabile. Le nomenclature ideologiche liberali (e cristiane) poggiavano classicamente su un concetto di coscienza autonoma intesa come prerogativa della persona che in ultima analisi trae origine dall’anima inspirata da Dio secondo la credenza religiosa, o dalla facoltà del dubbio rilevata da Cartesio; oppure, in sintesi, dalla capacità riflessiva di sé che scaturisce da una Ragione trascendente, come in Kant48. Accade così che ogni individuo umano sia considerato soggetto irriducibile e ogni soggettività umana riconducibile solo ad esso. Non si può certo dire che tale concezione sia divenuta ideologicamente obsoleta in campo etico e giuridico, ma le sue capacità di esplicazione dei processi sociali (dove si cerca di chiudere la falla con il termine «intersoggettività») hanno palesato limiti rilevanti. È con simili problemi che si vuole misurare Pareto quando concepisce la società umana come insieme di innumerevoli spinte dalla più svariata natura, comprese le più eccentriche e «irrazionali». Per spiegare che un tale insieme caotico sia in grado di generare un ordine che ne possa accrescere il potenziale e pervenire a strutture di volta in volta nuove, adotta un modello statistico probabilistico che spera essere all’altezza di siffatto grado di complessità49. In modo non dissimile Amadori ritiene il comportamento sociale un combinato di plurimi elementi percettivi e reattivi che poi si coordinano «secondo la costituzione psichica che gli individui del gruppo col processo di sedimentazione si sono formati»50. Senza andare qui oltre nella considerazione delle implicazioni teoriche ad esempio per il concetto di «soggettività»51, conviene almeno sbrigativamente accennare ad alcune riflessioni sociologiche e psicologiche che lungo il Novecento si spingeranno ben al di là di simili concetti, mettendo in dubbio l’individualismo metodologico dal lato dell’individuo stesso. Seguendo invece canoni più tradizionali, Amadori sostiene di muoversi «in un campo dove l’affettività predomina, dove la mente esce dalla sfera della logica razionale per entrare in quella del sentimento, e quindi della logica affettiva»52. La massa, tendendo ad agire «affettivamente», ricade quindi in uno stato di natura o infantile, guadagnando I. Kant, Kritik der Urtheilskraft, Lagarde und Friedrich, Berlin 1790, pp. 404-10. V. Pareto, Trattato di sociologia generale, III, Barbera, Firenze 1923, pp. 267-72. 50 Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., p. 68. 51 Rimando a R. Petri, Pamphlet per il tempo storico, in Velocità storiche, a cura di S. Bertelli, Carocci, Roma 1999, pp. 37-68. 52 Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., p. 97. 48 49 44 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 45 Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi da un lato il vigore vitale dell’incoscienza incolta e rischiando dall’altro di perdere le facoltà razionali della civiltà. Oggi, nelle scienze sociali e umane si incontra un’avversione quasi corale contro la dicotomia ragione/emozione, anche se alcuni autori sembrano faticare a uscire dai paradigmi dell’antropologia illuminista limitandosi ad affermare che ragione ed emozione «interagiscono»53. Mentre la neuroscienza conferisce alle emozioni un ruolo fondamentale nell’elaborazione dei dati sensoriali e nella predisposizione e messa a fuoco dell’attenzione di cui necessita l’intelletto per riflettere concettualmente la realtà circostante. Si parla di processi cognitivi, mentre l’idea di «ragione» acquista uno stato meno certo, per non dire obsoleto54. Non solo per Amadori, anche per il sociologo americano Mead è la configurazione sensoriale dell’ambiente a formare la mente. Anzi, secondo Mead la mente non va proprio concepita come interiorità isolata, ma come campo di interazione sociale per eccellenza. Di conseguenza il Sé inteso come ente della coscienza «non è tanto una sostanza quanto quel processo tramite cui la conversione dei gesti è stata internalizzata in una forma organica. Tale processo non è a sé stante e costituisce semplicemente una fase della organizzazione sociale complessiva di cui l’individuo è parte»55. Quindi la supposizione di Amadori secondo cui «l’idea, formatasi con rappresentazioni, è riproducibile essa stessa, può rinnovarsi senza alcuno stimolo esterno, favorita dal sentimento gradevole che suscita»56 e quindi acquisire una dinamica autonoma attraverso la dinamica sociale, trova importanti seppur differenti riscontri nelle scienze sociali dei secoli XIX e XX, da William James a Michel Foucault. Anche la «sedimentazione» menzionata da Amadori ricorda il carattere processuale esaltato da Mead. In questo caso l’angolo visuale andrebbe allargato alla memoria intesa come intreccio tra biografia e storia, nei termini ad esempio di Pierre Bourdieu che ricorda come l’illusione di unità e coerenza dell’identità personale si intrecci inevitabilmente con una memoria collocabile anch’essa nel campo sociale; l’i53 C. Larrington, The Psychology of Emotion and Study of the Medieval Period, in «Early Medieval Europe», X, 2001, 2, pp. 251-6, qui 252. 54 G. E. Marcus, The Psychology of Emotion and Politics, in Oxford Handbook of Political Psychology, Oxford University Press, Oxford 2003, pp. 182-211; Cognitive Neuroscience of Emotion, a cura di R. D. Lane e L. Nadel, Oxford University Press, Oxford 2000. 55 G. H. Mead, Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist (postumo, 1934), a cura di C. W. Morris, Chicago University Press, Chicago-London 1974, p. 178; Id., The Philosophy of the Present (postumo, 1932), Prometheus Books, New York 2002, pp. 54 e 93-4. 56 Amadori-Virgilj, Il sentimento imperialista cit., p. 59. 45 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 46 Rolf Petri dentità personale risulta, pertanto, un «assemblaggio di relazioni oggettive che hanno unito l’attore con l’insieme degli altri attori»57. Se infine ha qualche ragione la neurofisiologia58, pare lecito domandare perché proprio un «filosofo del numero» dovrebbe trattare gli individui come «esseri decerebrati». Nel cervello i processi cognitivi non avvengono forse sulla base di fenomeni di massa? Non è forse l’enorme numero di caotiche connessioni binarie la fonte della complessità sistemica e auto-organizzativa delle funzioni cerebrali, e della loro capacità di generare decisioni irriducibili a modelli deterministici, tanto che in gergo filosofico le potremmo anche chiamare, volendo, «soggettive»? 9. Conclusione. È dunque mia convinzione che non si possa liquidare la questione posta da Amadori-Virgilj con un rimando implicito a una concezione politica più autenticamente borghese. L’universo borghese europeo, se indubbiamente ha fatto proprio il concetto di autonomia personale, lo ha al contempo, sin dalle prime sue realizzazioni politiche, reso particolarmente obbligante come libertà di scelta a favore o contro «un dogma che non si discute». Un individualismo metodologico così congegnato talora si rivela essere più un catalizzatore di «concezioni totalizzanti» che non un antidoto contro di esse. L’appello all’adesione libera e fattiva del singolo, elementare nelle fedi religiose monoteistiche, è stato un tratto fondamentale anche dei moderni sistemi dittatoriali e dei grandi movimenti politici di massa. Anche oggi riemerge nelle retoriche di guerra e di lotta contro il Male. In modo convincente Nazione e lavoro ha condotto la prova che non ha senso de-italianizzare il fascismo. A mo’ di chiosa intendevo qui aggiungere che più in generale non ha senso de-occidentalizzare le «concezioni totalizzanti della società». In particolare emerge come concetti quali natura, umanità, civiltà, popolo e progresso, che ancora pervadono il nostro linguaggio politico quotidiano, siano stati estrapolati da una concezione escatologica della storia e tradotti nella realtà politica attraverso il mito, il sacro e il P. Bourdieu, L’illusion biographique, in «Actes de la Recherche en Sciences sociales», 1986, pp. 69-72, qui 72; similmente, D. P. McAdams, Personal Narratives and the Life Story, in Handbook of Personality. Theory and Research, Guilford Press, New YorkLondon 1999, pp. 478-500, qui 486. 58 G. Roth - U. Dicke, Evolution of the Brain and Intelligence, in «Trends in Cognitive Sciences», IX, 2005, 5, pp. 250-7. 57 XLII-XLIII, 46 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 47 Geopolitica dei sentimenti, ieri e oggi sentimento simil religioso. L’esigenza di porre questi concetti alla base della legittimità del potere sovrano ha conferito al sentimento e all’eccitazione collettiva un ruolo di medium centrale in tutta la moderna comunicazione politica. Credo che Amadori-Virgilj abbia colto con acume tale circostanza, errando però nel circoscriverla troppo nel tempo e nello spazio. Già oltre cento anni prima di lui Novalis, nel posare lo sguardo sulla Parigi rivoluzionaria, colse questi stessi tratti nella loro valenza generale. Il giovane poeta li salutò come segnali di un grande rinnovamento dell’Europa. 47 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 48 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 49 PENSARE LA NAZIONE Delle emigrazioni e della loro diversa indole nella storia antica e moderna. Storiografia e ricerca storica «in movimento» di Emilio Franzina Uno de’ primi grandiosi fenomeni che la Storia ci rappresenta sono le emigrazioni, questi movimenti provvidenziali di popoli che sovente risospinti dall’urto di altre nazioni, talora cacciati da avversari religiosi o politici; talaltra trascinati da istinti quasi fatali; in onta a temporanei travolgimenti cooperano da ultimo all’equabile diffusione della civiltà. Sembra che come un’arcana legge fisica comanda alle correnti marine un flusso regolare dal polo ai tropici e all’equatore, così pure una indeclinabile necessità tragga le razze del Settentrione verso il mezzodì. Infatti pochissime eccezioni si riscontrano a questo gran fatto, e non una di esse nei più grandi dislocamenti nazionali. Un desiderio continuo richiama forse l’uman genere verso quella natura ardente e vigorosa in grembo della quale ebbe primo nascimento. È questo per avventura il solo carattere generale d’ogni emigrazione di qualunque tempo, da qualunque causa abbia avuto principio. Del resto le varie condizioni del mondo antico e del moderno imprimono ad esse fisionomie tanto difformi da non poterlesi quasi significare sotto un solo vocabolo. Quando la società ancora bambina e perciò tiranna, non proteggeva colle leggi l’individuo, ma lo assorbiva in sè, soltanto per un atto volontario di tutto il corpo sociale nacquero quei sollevamenti repentini per i quali milioni e milioni di uomini passavano da regione a regione, e cacciati dalle proprie sedi spostavano alla lor volta le altre genti nelle quali s’abbattessero. L’avidità del bottino, la smania della conquista (passioni peculiari dell’epoca barbarica), la superba volontà d’un capo o la superstiziosa ubbidienza agli astuti responsi dell’oracolo (primo cemento di sociale convivenza), i cataclismi fisici, o l’irruzione d’orde più selvagge e boreali (avvenimenti storici de’ tempi primitivi) traevano dalle selve torme a torme i guerrieri; e dietro ad essi sui carri gli idoli, i bambini e le donne; e per lungo spazio di luoghi e di tempi, per grandissima diversità di siti e di clima trasmigrava a quel modo colla sua lingua, colle sue credenze un’intera nazione. La quale posta a contatto con società meglio incivilite si compenetrava in esse, e dopo avervi alle volte spento apparentemente ogni elemento di civiltà, finiva col rimanere incivilita essa stessa. Testimoni le immense trasmigrazioni del Quinto e Sesto Secolo, le quali posatesi sulle rovine della Società Romana furono origine agli splendori dei Comuni Italiani; e fondamento alla trasformazione completa dell’Umanità. Nell’Età di mezzo le emigrazioni ebbero specialmente a causa le passioni religiose e politiche, ma la unità sociale era già scaduta dall’antica rigidezza, e la conquista stessa di Costantinopoli per Maometto II° non generò guari la pro49 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 50 Emilio Franzina scrizione d’un intero popolo, ma solamente la fuga d’alquante migliaia di dotti e di magnati i quali coadiuvarono nell’Occidente i principi del Risorgimento. Quando il moderno sviluppo scientifico, giuridico ed economico ebbe sciolta la personalità dai legami dello Stato, cominciò quel quasi quotidiano passaggio alla spicciolata da paese a paese di individui e di famiglie, il quale sembra provvedere nelle condizioni moderne all’equilibrio della popolazione. Ecco come alluvione lenta e continua a terre deserte e sterili infonde i semi fecondi di civiltà recati dalla madre patria. Le emigrazioni antiche all’incontro erano violente avulsioni, dopo le quali il principio provvidenziale restava un qualche tratto offuscato e sospeso. Ma a lungo andare la mano di Dio si valeva pel bene dell’umanità di quelle tumultuanti valanghe di nazioni, come ora adopera per l’egual fine il volontario e periodico adagiarsi sopra rive lontane dell’eccedenza di popoli già civili. Quella prima maniera d’emigrazione si conveniva a tempi di barbarie, ne’ quali il procedimento dello spirito umano avviene a sbalzi e quasi per istinti; quest’ultima si confà meglio al secolo nostro, nel quale tutto sembra prepararsi se non senza lotte, almeno senza pericoli, a uno stadio di futuro e tranquillo miglioramento. Ippolito Nievo, Padova, 15 novembre 18551. 1. Riflessioni sull’emigrazione nel pensiero del giovane Nievo. Fra il 1850 e il 1858, durante quel decennio che gli storici del «patrio Risorgimento» avrebbero poi definito di «preparazione», mentre non si arrestava il flusso, intermittente ma tuttora forte, degli esuli diretti in Piemonte2 e, più di rado, in paesi anche assai lontani dall’Italia3, si susseguirono qui, su impulso diretto o indiretto di Mazzini e del suo movimento rifondato col nome di Partito d’azione, i principali tentativi per mantenere in vita la prospettiva rivoluzionaria e democratica tramontata nel sangue, a Roma e a Venezia, nella triste estate del 1849. Gli episodi e le tappe in cui si articolò una simile iniziativa di tipo sia cospirativo che insurrezionale, cui non arrise mai il successo sperato da chi l’aveva promossa oppure anche solo parzialmente ispirata, sono abbastanza noti: dalla fallita rivolta operaia di Milano all’attentato, nei voti «tirannicida», di Felice Orsini contro Napoleone III alla disastrosa spedizione a Sapri di Carlo Pisacane passando, peraltro, attraverso 1 Allegato al verbale del quarto esame rigoroso [Scienze politiche] per il conseguimento del grado di Dottore in ambe le leggi [sostenuto nello studio politico legale presso l’I.R. Università di Padova], li 15 del mese di novembre dell’anno 1855 alle ore 11 am., in Archivio antico (Archivio storico) dell’Università degli Studi di Padova (in sigla Asup), Facoltà Politico-Legale, Laureati dal 1847-48 al 1864-65; fasc. 794-804. Con quello di altre prove di cui diremo, il tema fu riprodotto come ultimo dei «sette quesiti inediti presentati dal Nievo per la laurea» una prima volta da Giuseppe Solitro nel suo Ippolito Nievo. Studio biografico con documenti inediti, esumazioni e 15 tavole fuori testo, Tipografia del Seminario, Padova 1936, pp. 186-8. 50 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 51 Storiografia e ricerca storica «in movimento» le durissime repressioni austriache di Este e di Belfiore protrattesi fino al luglio del 1855 con l’impiccagione di Pier Fortunato Calvi. Tali avvenimenti contrappuntarono, come pure si sa, l’incedere di ben altre strategie politiche e diplomatiche maturate invece, auspice Cavour, in Piemonte e in Francia (dalla guerra di Crimea con i bersaglieri di La Marmora alla fondazione della Società nazionale italiana di Manin e La Farina agli Accordi di Plombières). Sia come sia, furono essi, tutti insieme, a far da cornice allo svolgersi della vita ordinaria di molti patrioti italiani intenti all’elaborazione di un lutto più difficile da riassorbire, specialmente nel Lombardo Veneto, fra coloro che alla causa nazionale in chiave laica, progressista e repubblicana ancora serbavano fede, avendola fervorosamente già manifestata e sostenuta, in armi o col cuore, solo pochi anni avanti. Nella «vita ordinaria» dei popoli e degli Stati, frattanto, in quel decennio davvero cruciale dell’Ottocento, nuovi equilibri, nuove dottrine e nuove egemonie «occidentali», a cominciare ovviamente da quella imperiale britannica, si venivano delineando non solo entro i confini del vecchio continente, bensì pure nelle Americhe resesi infine indipendenti e proiettate, a spese degli «indiani», verso la definitiva conquista delle proprie «frontiere»4. Ad attirare l’attenzione dei contemporanei potevano già essere quindi, assieme agli eventi tumultuosi della politica interna e internazionale, anche molti e diversi fatti di cui davano notizia sempre più frequente giornali o riviste di grande tiratura e una editoria piuttosto vivace nonché seguita, a riprova del suo fascino, da stuoli crescenti di lettori. Viaggi, scoperte, invenzioni e fenomeni economico-sociali per molti aspetti inediti ma tutti, quale più quale meno, sorti dal grembo della rivoluzione industriale e tecnologica – in corso (e anzi quasi in corsa) dai primi decenni del secolo XIX –, occupavano ormai la fantasia delle classi colte e persino di quelle popolari urbane di 2 E. De Fort, Esuli in Piemonte nel Risorgimento. Riflessioni su di una fonte, in «Rivista storica italiana», 2003, 3, pp. 648-88 e A. Bernardello, Vite spezzate e contrasti ideali. Esuli veneziani negli Stati italiani ed europei (1849-1858), in Fuori d’Italia. Manin e l’esilio, a cura di M. Gottardi, Ateneo Veneto, Venezia 2009, pp. 191-222. 3 Cfr. ora A. Bistarelli, Gli esuli del Risorgimento, il Mulino, Bologna 2011; ma per il ruolo che molti esuli già durante la prima metà dell’Ottocento ebbero nella costruzione all’estero (o dall’estero) di un immaginario patriottico italiano all’interno di un più vasto contesto transazionale, anche S. Levis Sullam, Conflitti dell’esilio e immaginazione della nazione alle origini del Risorgimento, in Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, sotto la direzione di M. Isnenghi, I, Fare l’Italia. Unità e disunità nel Risorgimento, a cura di M. Isnenghi ed E. Cecchinato, Utet, Torino 2008, pp. 104-14 e, soprattutto, M. Isabella, Risorgimento in esilio. L’internazionale liberale e l’età delle rivoluzioni, Laterza, Roma-Bari 2011. 4 V. Blengino, Il Vallo della Patagonia. I nuovi conquistatori: militari, scienziati, sacerdoti, scrittori, Diabasis, Reggio Emilia 2003, pp. 22-8 e passim. 51 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 52 Emilio Franzina mezza Europa. Fra essi, inedite per le loro ricadute immediate nelle isole britanniche e in buona parte del Nord Europa, ma persino in alcune province del periferico Regno Sardo, spiccavano le migrazioni transatlantiche. Prima quelle degli inglesi, dei tedeschi, dei norvegesi, degli svedesi ecc. (iniziate già subito dopo la fine delle guerre napoleoniche) e poi, negli anni trenta e quaranta, quelle dei liguri, dei piemontesi e dei ticinesi5 (o degli stessi irlandesi all’indomani di una famosa e terribile carestia di patate) cominciavano infatti a ritagliarsi un posto di qualche riguardo nell’immaginario collettivo e, via via, anche nelle preoccupazioni degli statisti e delle loro correnti pratiche di governo. All’esodo ad esempio dei genovesi e dei biellesi, nonché degli italofoni svizzeri, si rifaceva esplicitamente più volte a Torino, nella sua qualità di ministro delle Finanze e di presidente del Consiglio, anche il conte di Cavour. Facendo approdare la questione emigratoria nelle aule del Parlamento subalpino sin dal 1852 egli promuoveva addirittura, l’anno successivo, con il sostegno di Luigi Torelli e degli ambienti armatoriali liguri «stretti attorno all’emergente Raffaele Rubattino», un progetto ambizioso (anche se poi presto rientrato) di «compagnia di bandiera» volto ad attivare, grazie al concorso di una Società transatlantica appositamente creata, una specifica «linea di navigazione a vapore tra Genova e le Americhe»6. Non è dato di sapere con precisione, ma forse non è nemmeno troppo difficile da ipotizzare, il motivo per cui, nel novembre del 1855, il ventiquattrenne Ippolito Nievo si risolse a privilegiare, quale ultimo banco di prova propedeutico al conseguimento del titolo di dottore «in ambe le leggi» presso l’Università di Padova7, l’argomento da lui 5 C. Vangelista, L’emigrazione ligure e piemontese nel Cono Sud all’inizio dell’Ottocento. Aspetti economici e sociali, in Migrazioni liguri e italiane in America Latina e loro influenze culturali, a cura della Fondazione Casa America, Aracne editrice, Roma 2005, pp. 37-52. 6 E. Franzina, Gli italiani al nuovo mondo. L’emigrazione italiana in America, 14921942, Mondadori, Milano 1995, pp. 137-40. 7 Per essere ammesso alla laurea e alla discussione, che il suo conseguimento prevedeva, di un numero variabile di tesi, il candidato doveva aver superato in precedenza le cosiddette «prove rigorose» che a Padova erano quattro e vertevano ciascuna, rispettivamente, sull’intera materia dei quattro anni di studio svolgendosi dinanzi a una Commissione composta da tutti i docenti della Facoltà. Per ottenere la laurea in Scienze politico-legali, oltre a quelli normali, gli esami «rigorosi», della durata di due ore, implicavano la verifica delle conoscenze su diversi aspetti dei corsi impartiti e su differenti, ancorché affini, materie: Nievo li sostenne in successione il 27 marzo, il 29 maggio, il 30 luglio e il 15 novembre del 1855 senza eccessivo entusiasmo se a proposito del secondo di essi, dopo averlo appena superato, scrisse ad esempio in scherzosa confidenza ad Arnaldo Fusinato (da Padova, il 30 maggio 1855, in I. Nievo, Opere, a cura di S. Romagnoli, Ricciardi, Milano-Napoli 1952, p. 1110) «A proposito – il mio esame raccolse i pieni voti – immaginati se fui sbalordito di questo trionfo – e sì ci ho detto tali castronerie da far drizzare i capelli in capo fino a Cicogna [sc. Giovanni Cicogna, l’ordinario di Diritto civile generale austriaco]». A differenza della laurea in teologia «quella in 52 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 53 Storiografia e ricerca storica «in movimento» sviluppato nel testo che introduce, in esergo, la nostra riflessione su storiografia e ricerca storica «in movimento» e che, rispetto alle migrazioni, costituisce spesso ancor oggi, per gli storici, un banco di prova stimolante e l’oggetto d’uno studio comparato benché ovviamente in diversa e ben più articolata prospettiva8. L’esodo oltreoceano dei contadini europei intorno alla metà degli anni cinquanta del secolo XIX era sotto gli occhi di tutti mentre quello dei contadini del Nord della penisola si profilava appena all’orizzonte benché si trovasse, in ipotesi, ormai alle viste di un’opinione pubblica per altri versi ovviamente distratta e pressoché magnetizzata, invece, dal perdurante dibattito sulle sorti politiche, auspicate o paventate che fossero in chiave unitaria, di un’Italia scossa ma tuttora in fermento. Sui caratteri delle migrazioni del passato messe a confronto con quelle del presente e sulla colonizzazione agraria delle Americhe o dell’Australia9, ad ogni modo, esisteva da tempo una letteratura economica abbastanza agguerrita non solo in Inghilterra e in Francia, grazie alle opere di Merivale e di Wakefield, di Garnier e di Legoyt, di Duval e di Wolowski ecc., bensì pure da noi in virtù dei sondaggi precocemente compiuti da Melchiorre Gioia e, dopo di lui, da una serie di giovani studiosi e cultori più o meno volontari d’economia politica. Alcuni di essi, in particolare, risultavano molto attivi già nella decade 1850 e si mostravano sin da allora disposti, da Maestri a Correnti a Minghetti, a scienze politico-legali presentava per certi versi una maggior difficoltà di conseguimento, nel senso che il suo esito positivo non sempre era scontato». Terminata la prova, consistente nella stesura di un breve saggio o come oggi diremmo meglio di un tema, il cui argomento era stato scelto dal candidato in accordo con il titolare della disciplina, seguiva la discussione e i professori abilitati al giudizio effettuavano la loro «segreta votazione». Nella prova rigorosa sulle migrazioni, affrontata da Nievo col testo piuttosto sbrigativo e assai scolastico che s’è visto, il 15 novembre 1855 erano assenti, tra i professori, il preside Cicogna e il supplente di Statistica e titolare di Diritto canonico Francesco Nardi, mentre diedero il loro assenso con «bene» Gianpaolo Tolomei, Giuseppe Dalluscheck, Filippo Salomoni e il decano della Facoltà Alessandro De Giorgi (del cui nome, semplificato dall’eliminazione del «de» gentilizio, Nievo si avvarrà per designare, nelle Confessioni d’un Italiano, il perfetto prototipo dell’esule «militare» italiano in Brasile, il maresciallo e Duca di Rio Vedras Alessandro Giorgi, da lui ritratto in azione nel Mato Grosso contro i «selvaggi» e fatto rientrare, alla vigilia del ’48, a Venezia). L’unico parere in controtendenza («sufficiente») venne espresso, nemmeno troppo sorprendentemente vista l’esilità dello svolgimento, dal professore di Scienze e Leggi politiche Barnaba Zambelli. Sull’Università di Padova a metà Ottocento si veda ora G. Berti, L’Università di Padova dal 1814 al 1850, Antilia, Padova 2011. 8 La bibliografia sul tema, dominato attualmente dal confronto fra le ultime immigrazioni (studiate ormai da un numero impressionante di sociologi, economisti, antropologi ecc., ma esposte sovente ai rischi, oggi maggiorati, dell’ambiguità (cfr. Il «discorso» ambiguo sulle migrazioni, a cura di S. Palidda, Mesogea, Messina 2010) e le migrazioni di massa del passato otto e primo novecentesco, è molto vasta ed è stata ben riepilogata da G. Gozzini, Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata, Bruno Mondadori, Milano 2005. 9 M. I. Finley - E. Lepore, Le colonie degli antichi e dei moderni, Donzelli, Roma 2000. 53 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 54 Emilio Franzina esaminare i rapporti, allora prevalenti, fra emigrazione transoceanica, colonie «penali» di deportazione o di colonizzazione agricola quale rimedio, in prospettiva, ai «guasti» indotti dal pauperismo (o dal «sovversivismo» politico) e ai rischi, malthusianamente intesi, di una temuta sovrappopolazione. Se questi ultimi pericoli non apparivano tuttavia ancora esattamente all’ordine del giorno da noi, i dilemmi scrutinati dal giovane Nievo si stavano già allora consolidando in vulgata nella pubblicistica e nella letteratura economica coeve e avrebbero continuato per oltre vent’anni a riprodursi quasi invariati confluendo nelle opere successive dei vari Carpi, Virgilio, Florenzano ecc. Ai quesiti sul carattere essenziale che avrebbe differenziato «le antiche dalle moderne migrazioni» si rispondeva di solito, come asserito più tardi in riepilogo dall’avvocato Giuseppe Scavia, sottolineando quanto alle prime, realizzate da «famiglie e tribù unite in nazione» si fossero via via sostituiti, «nei tempi moderni», gli esodi individuali o di gruppo di migranti in grado di portare con sé, all’estero, capacità, competenze e capitali («civiltà» in una parola) in un quadro di nuova mobilità territoriale che spesso avrebbe reso nondimeno «perpetue», come già in passato, le cosiddette «migrazioni coloniali»10. In Italia poi se ne segnalavano già talune sporadiche ricadute persino sul piano poetico dilatando così lo spettro delle relazioni fra letteratura ed economia moderna già avviate per alcuni versi durante la Restaurazione11, tanto che recensendo nel 1854 un’operetta giovanile di Fedele Lampertico – ch’era stato incoraggiato a stenderla da Giacomo Zanella12 (Dei vantaggi che la poesia può conseguire dall’economia politica e questa da quella)13 – un critico forse poco apprezzato da Nievo14, ma comunque del valore di Carlo Tenca, si spingeva sul «Crepuscolo» a tesserne entusiasticamente le lodi scrivendo: Se l’aspetto d’un intero popolo che muove animoso a sgombrare con la scure le foreste dell’America per conquistare allo spirito le sue mille città, non è atto a infiammare le menti più ancora che non fosse pei greci quello dei favolosi argonauti, non sapremmo ove debba trovarsi oggidì la materia della poesia. 10 Delle emigrazioni e delle colonie. Dissertazione di Giovanni Scavia, Tipografia e Litografia Foa, Torino 1869, pp. 49-56 e passim. 11 L. Derla, Letteratura e politica tra la Restaurazione e l’Unità, Vita e pensiero, Milano 1977. 12 E. Franzina, Vicenza italiana (1848-1918). Intellettuali, notabili e popolo fra Risorgimento e prima guerra mondiale, Agorà & Factory, Dueville 2011, p. 65. 13 Opuscolo in nozze Thiene-Bollina, Bianchi, Padova 1854. 14 Cfr. le allusioni alla sua «noiosità» contenute in una lettera ad Arnaldo Fusinato (da Modena, l’11 novembre 1859, in Nievo, Opere cit., p. 1169). 54 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 55 Storiografia e ricerca storica «in movimento» Più giovane di lui di due anni, ma laureatosi anch’egli a Padova nella stessa Facoltà e nello stesso anno dello scrittore (con una dissertazione di 90 pagine Sulla statistica in Italia prima dell’Achenwall, concepita già in partenza per essere data alle stampe), Lampertico – per censo, per attitudini psicologiche e politiche e per obiettivo moderatismo risorgimentale15 – si collocava, in Veneto, pressoché agli antipodi di Ippolito Nievo. Eppure, a riprova di uno stesso clima intellettuale e culturale che era poi quello del tempo e dei luoghi in cui entrambi vivevano immersi, qualcosa si trovarono entrambi a dover spartire o ad avere grosso modo in comune. Qualora si ponga mente agli argomenti di altre due «prove rigorose» scelte dal secondo di loro all’Università, oltre a quella comparativa sulle migrazioni, quale oggetto preliminare di discussione per avere accesso alla laurea, è possibile farsene un’idea più precisa. Nell’esame rigoroso di Diritto filosofico Nievo propose e difese, infatti, una tesi, assai ben scritta e intitolata Del nesso della Letteratura e della Filosofia colla Giurisprudenza, mentre in quello di Statistica si cimentò con un tema forse ancor più indicativo, e non a caso ripreso di lì a poco, in una prestigiosa sede accademica come l’Istituto Veneto, anche da Lampertico: Degli Istmi di Panama e di Suez e delle diverse condizioni geografiche, politiche, economiche che favoreggiano ed avversano il progetto di due canali attraverso ad essi16. La consapevolezza delle principali novità indotte dalla rivoluzione industriale, non solo nel campo marittimo o della modernizzazione tecnologica dei trasporti, suggeriva al giovane Nievo molte sensate osservazioni sull’ascesa, al di là dell’Atlantico, di un inedito «ceto commerciale» rappresentato al meglio, secondo il suo parere, dalla borghesia di New York e di Boston. Intravista qui come migliore e più compiuta espressione degli Stati Uniti e dunque come «impersonificazione attuale delle Americhe appetto all’Europa», più tardi essa sarebbe stata invece criticata abbastanza corrosivamente nelle pagine finali delle Confessioni con un giudizio che usciva decisamente da quel terreno economico concreto su cui insistevano invece le acerbe prove 15 A Lampertico, tra il primo profilo tracciato di lui da Silvio Lanaro (nel suo Società e ideologie nel Veneto rurale (1866-1898), Edizioni di storia e letteratura, Roma 1976, pp. 108-60) e gli ultimi realizzati da Giuseppe Monsagrati e, parzialmente, da Pier Angelo Passolunghi e da Alfredo Sensales, ho avuto modo di dedicare anch’io – oltre ai volumi dei carteggi e diari lampertichiani curati, dopo di me, anche da Renato Camurri e Giovanni Luigi Fontana (Fedele Lampertico. Carteggi e diari 1842-1906, 3 voll., Marsilio, Venezia 1996-2012) – non pochi lavori, fra cui il saggio Una Clio domestica e nazionale. Fedele Lampertico e la storiografia delle piccole patrie nel «nation building» italiano dell’Ottocento, Agorà & Factory, Dueville 2006. 16 Si vedano entrambi i brevi testi nieviani delle due prove in Asup, Facoltà Politico-Legale, Laureati dal 1847-48 al 1864-65; fasc. 794-804, e poi in Solitro, Ippolito Nievo cit., pp. 174-81. 55 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 56 Emilio Franzina universitarie del 1855. Non per motivi casuali, ad ogni modo, Nievo aveva scelto di soffermarsi e d’insistere allora sull’avvento del vapore quale spiegazione e premessa dei radicali mutamenti in atto nell’economia mondiale e nel complesso sistema degli scambi internazionali in cui infatti le migrazioni transoceaniche erano inserite («E questo complicato e provvido sistema mette capo d’ogni lato al mare, sicché pochi punti sono del nostro continente ove le manifatture inglesi e i cereali del Mar Nero e delle Americhe non vengano portati dalla barche»). Il che legittimava comunque anche l’idea da lui discussa, e plausibile al di là delle contingenti esigenze scolastiche, secondo cui «fra le più grandiose intraprese» dei tempi moderni fossero da considerare appunto i tagli progettati dei due celebri istmi. Sebbene poi, nelle 24 tesi difese a una settimana di distanza dalla discussione dell’ultima «prova rigorosa» intorno alle migrazioni non ne figuri che una di riferibile, e alquanto vagamente per giunta, a questioni economiche di analoga natura (la sesta di Statistica su «La Bassa Ungheria» come «paese più acconcio nell’Europa centrale allo stabilimento di colonie agricole»)17, lo scrittore figura insomma già impegnato, nel 1855, in una varietà di riflessioni in bilico fra economia, letteratura e politica. Solo apparentemente esse risultano scollegate fra loro o disgiunte dalle altre che nel frattempo il giovane studente universitario viene consegnando ai fogli delle proprie corrispondenze private e alle pagine delle sue prime prove pubblicistiche e letterarie. Fra i coetanei dello scrittore, classe 1831, o almeno fra quelli dai trascorsi patriottici ben noti, come i suoi, anche alla polizia asburgica, cercare rifugio in tal modo in una «pace artificiale» o, secondo l’opinione di Cesare De Michelis, in «una sorta di esilio in patria»18 dovette essere reazione abbastanza diffusa alle delusioni e al disincanto dominanti, da questo punto di vista, nel periodo immediatamente seguito alla troppo breve ancorché inebriante stagione del 1848-4919. Se Ippolito aveva vissuto quel biennio da ragazzo, peraltro del tutto in linea o meglio in sintonia con la media generazionale borghese della sua classe di età20, e se davvero la parte da lui presa negli eventi di 17 Tesi che Ippolito Nievo si propone difendere nella sua pubblica promozione al grado di Dottore in Ambe le Leggi nella Imp. Regia Università di Padova, [22] Novembre 1855, Dalla Tipografia Bianchi, Padova 1855, p. 5. 18 C. De Michelis, Introduzione, a I. Nievo, Le Confessioni d’un Italiano, a cura di S. Romagnoli, Marsilio, Venezia 2000, p. XIX. 19 F. Della Peruta, I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e contrasti politici all’indomani del 1848, Franco Angeli, Milano 2004 (1958). 20 A. Arisi Rota, I piccoli cospiratori. Politica ed emozioni nei primi mazziniani, il Mulino, Bologna 2010. 56 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 57 Storiografia e ricerca storica «in movimento» quel tempo rivoluzionario si era forse già consumata, lì e allora, «in un’appassionata adesione ideale», durante il decennio successivo invece, (quello dei suoi vent’anni) «il suo impegno civile – come nota di nuovo De Michelis in qualità di storico della letteratura – si concentrò in un’intensa e assai varia attività di scrittore, pronta a misurarsi nei generi più diversi […] ma decisa a tenersi lontano, persino idealmente lontano, dalla cospirazione con quel che ne veniva di conseguenza». Facile dedurne che sul piano professionale e degli studi ne potessero derivare assieme, per molti, uno sforzo di comprensione della realtà più variegato (e prudente) di quello immediatamente politico e il desiderio implicito, ma ancora tutto sommato coerente, di applicarne gli effetti a campi appena contigui ma pur sempre compatibili con il patriottismo (quantunque visibilmente orientati adesso, oltre al resto, da praticissime necessità). Anche così, ad ogni modo, non può sfuggire quanto potessero variare le risposte che vennero offerte in quei frangenti, come ad esempio nel «ripiegamento» in sede scolastica e universitaria, da parte di altri e in particolare di chi, uomo d’azione giovane ma già sperimentato, si fosse lasciato coinvolgere ancora per qualche tratto, diversamente da Nievo, in rischiose imprese o «mene mazziniane». A questa schiera – non sempre ben distinta da quella degli esuli e dei migranti in cui già abbondavano suoi coetanei21 per differenti motivi più «avventurosi» di lui, dal bellunese Carlo Camillo di Rudio al lavagnese Giovanni Garibaldi, dall’urbinate Raffaello Carboni al chietino Silvino Olivieri ecc. – apparteneva senz’altro il mantovano di adozione Luigi Castellazzo. Di quattro anni più vecchio del Nievo e protagonista (in negativo) di una delle più tragiche vicende del nostro Risorgimento, «Bigio», come lo chiamavano gli amici, si trovò infatti a far parte per sua scelta, fra il 1850 e il 1852, della «più grande con21 Con l’eccezione di Carboni, che era nato nel 1817 e che, rimpatriato dall’Australia dov’era approdato dopo la difesa di Roma nel 1849, fu l’ultimo dei garibaldini a parlare in Palermo, a bordo dell’Ercole il 4 marzo del 1861, con Ippolito Nievo durante le sue ultime ore di vita, si tratta di personaggi sui quali – tolto, e per giunta di sfuggita, il caso di Silvino Olivieri – non potrò intrattenermi in questa sede benché le loro biografie nel decennio 1850-60 (e oltre) gettino luce su un intero contesto «emigratorio» risorgimentale proprio di quegli anni a cui di recente ha fatto ampio e dettagliato riferimento Matteo Sanfilippo (nella sua relazione su L’emigrazione negli scritti di Ippolito Nievo, agli atti, in corso di stampa, del convegno Ippolito Nievo et le Risorgimento émancipateur, 150eme anniversaire de l’Unité d’Italie 1861-2011, Colloque international historique et littéraire, 23-25 giugno 2011, Nancy, Université Nancy 2) attraverso l’esame di tutti i passi delle Confessioni d’un italiano dove l’esilio e il trasferimento all’estero di patrioti e di altri personaggi fanno la loro comparsa precedendo quelli «americani», presenti nell’ultimo capitolo del romanzo, di cui avevo parlato a mia volta in una conferenza (L’ospite nemico) introdotta da Juri Meda e da me tenuta al Festival della Letteratura di Mantova il 12 settembre 2010. 57 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 58 Emilio Franzina giura del Lombardo Veneto contro l’Austria»22, ma per il comportamento che tenne dopo l’arresto venne considerato da molti dei suoi contemporanei – e poi da vari storici capeggiati da Alessandro Luzio – il responsabile primo, nel 1852, del tradimento di don Enrico Tazzoli, di Tito Speri e degli altri «congiurati mantovani», avendo ceduto alle torture della polizia ed essendosi prestato a fatali delazioni e forse, addirittura, a provocazioni funeste in combutta con l’avvocato veronese Luigi Faccioli23. Liberato di prigione nel marzo del 1853 – «per ricompensa» dissero poi sempre, con ottimi argomenti, i suoi detrattori – e restituito in fretta alla vita civile, «Bigio», unico fra i carcerati di Belfiore a godere per amnistia di una completa impunità, tornò a iscriversi nell’Università di Pavia, sua città natale, completandovi i corsi di diritto e laureandosi nel luglio dello stesso anno in legge. Anch’egli dovette superare l’ultima delle «prove rigorose» richieste (qui in numero di cinque) da quell’ateneo per l’ammissione all’esame finale e lo fece con uno scritto sulla Convenienza del diritto di grazia in cui difese posizioni di stretta osservanza politica e religiosa filo-asburgica spingendosi a condannare come «perniciosissimi», senza tentennamenti o riserve, tutti i delitti «antipolitici» commessi contro lo Stato24. Lasciamo a questa altezza ovvero al suo contraddittorio destino la tragica figura di Castellazzo evitando di soffermarci sugli sviluppi di una controversa esistenza e di una espiazione25 (che un po’ ricorda quella del nieviano Giulio Altoviti) protrattesi per lui dal 1858 alla morte, nel 1890, in veste dapprima di ardente patriota democratico, di coraggioso combattente e di alto ufficiale garibaldino (ferito in modo grave al Volturno) e poi di massone, d’internazionalista e di socialista, di pubblicista, di romanziere e di deputato ecc., e torniamo senz’altro all’ambiente culturale e studentesco padovano e a Ippolito Nievo. La cui vita, come si sa, fu fatalmente più breve di quella di «Bigio». Iscrittosi nell’ateneo patavino sul finire del 1852, provenendo proprio dalla 22 Secondo la definizione del medico-storico Albany Rezzaghi; cfr., assieme all’introduzione del curatore, pp. 13-62, il recente volume Dopo Belfiore. Le Memorie di Attilio Mori e monsignor Luigi Martini (edizione di Albany Rezzaghi e altri documenti inediti), a cura di C. Cipolla, Franco Angeli, Milano 2010, p. 65. 23 La ricostruzione più ampia, dettagliata e recente delle vicende mantovane sta in due volumi ancora di (e a cura di) C. Cipolla: Belfiore, I, I Comitati insurrezionali del Lombardo-Veneto (1852-1853) e il loro processo a Mantova del 1852-1853 e II, Costituti, documenti tradotti dal tedesco ed altri materiali inediti del processo ai Comitati insurrezionali del Lombardo-Veneto (1852-1853), Franco Angeli, Milano 2006. 24 G. Solitro, Dopo Belfiore. La laurea di Luigi Castellazzo, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1936, 4, pp. 455-64 (la riproduzione integrale del testo della prova è alle pp. 461-2). 25 Cipolla, Dopo Belfiore cit., pp. 32-8. 58 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 59 Storiografia e ricerca storica «in movimento» stessa Facoltà legale di Pavia, Nievo alternò in effetti fra il 1853 e il 1855, nella città del Santo dov’era nato, i ricordati studi giuridici e i connessi esami di prammatica a quella intensa attività artistica e giornalistica a cui si riferiva De Michelis e che lo vide intento a realizzare, fra racconti e poesie, saggi critici e articoli di rivista, drammi e commedie, opere già in qualche caso di valore e comunque premonitrici della sua genialità e dei suoi prevalenti interessi poi fatti convergere quasi tutti, fra il 1857 e il 1858, nelle Confessioni d’un Italiano. A parte le sintomatiche posizioni assunte nel 1853 in acre polemica col gazzettiere antisemita bresciano Luigi Mazzoldi e in risoluta difesa degli studenti universitari italiani26, basti ricordare, l’anno successivo, la sua prima raccolta di Versi e ancor più gli Studi sulla poesia popolare e civile massimamente in Italia27. In essi, a supporto di una propria romantica teoria sull’antica (o «pelasgica») tradizione poetica nazionale, Nievo sosteneva, com’è noto, l’opportunità, per la nostra letteratura, di riferirsi e rifarsi al popolo delle campagne con un linguaggio che tenesse conto delle diverse peculiarità regionali. Strettamente collegata a questa impostazione, in apparenza di carattere solo linguistico ma in una maniera che si spingeva ben oltre i confini di quella che era o sarebbe diventata la linea paternalistica prevalente e più congeniale, da noi, alla letteratura rusticale di metà Ottocento (quella delle Codemo e delle Percoto, per intenderci, ristretta anche solo all’area veneto-friulana), la novella su La nostra famiglia di campagna, ospitata a puntate a Mantova, nel 1855, dalle vivaci pagine de «La Scintilla»28, già documentava la discreta originalità dell’approccio nieviano al problema (e ai problemi concreti) delle popolazioni rurali, specie della vasta area padana da lui meglio conosciuta, secondo prospettive che, precisate e rafforzate, sarebbero confluite più tardi nel celebre Frammento sulla rivoluzione nazionale29. In effetti, nella «nutrita serie» di racconti rusticali avviata appunto nel 1855, ma portata avanti anche negli anni successivi tra Il Conte pe26 Cfr. I. Nievo, Scritti giornalistici, a cura di U. M. Olivieri, Sellerio, Palermo 1996, pp. 43-52 e E. Paccagnini, Letteratura e cultura a Brescia tra Otto e Novecento, in Istituzione letteraria e drammaturgia. Mario Apollonio (1901-1971), i giorni e le opere, a cura di C. Annoni, Vita e pensiero, Milano 2003, pp. 119-20. 27 Nievo, Scritti giornalistici cit., pp. 55-97. 28 M. Bertolotti, Le complicazioni della vita. Storie del Risorgimento, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 161-8. 29 Su cui cfr. almeno I. Nievo, Due scritti politici. Introduzione, testo e commento, a cura di M. Gorra, Liviana Editrice, Padova 1981, pp. 1-30 e 63-86 e F. Della Peruta, Nievo «politico» e la questione contadina, in Ippolito Nievo e il Mantovano, a cura di G. Grimaldi, Marsilio, Venezia 2001, pp. 361-406. 59 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 60 Emilio Franzina coraio e «diversi passi» delle Confessioni, Nievo avrebbe sempre denotato un profondo e per nulla epidermico interesse verso il mondo contadino. E aveva cominciato a darne prova accogliendo di buon grado, ma razionalizzandole, le raccomandazioni che nell’invitarlo a collaborare con la «Rivista Veneta» di Venezia30 gli avevano rivolto Saverio Scolari e alcuni amici della sua redazione chiedendogli di scrivere per loro delle novelle in cui – dicevano – «vorremmo […] che […] piuttosto che la vita intima e psicologica del contadino, tu ci mettessi in azione i contatti e le influenze vicendevoli fra questo stato fondamentale della società e le classi superiori»31. Lasciando alle fatiche imminenti di un Antonio Maria Gemma o del celebre Paolo Mantegazza (che pure era stato negli anni cinquanta per metà pioniere e per metà viaggiatore in Argentina) l’incombenza di ritrarre, come sarebbe avvenuto in un clima di positivismo arrembante, la mera «fisiologia», magari riproduttiva e sessuale, degli abitatori delle campagne del Nord, Nievo veniva sollecitato insomma a intraprendere – ovvero a perfezionare – una riflessione più ampia sui contadini, prossimi emigranti in pectore, a cui si rivolgeva, nelle fiere e nelle piazze, «il saltimbanco che spiega al villano il Nuovo Mondo»32. E tale riflessione non si sarebbe certo potuta esimere, per uno come lui, dal confronto con la realtà delle cose ovvero dall’analisi delle relazioni insorgenti, un po’ in tutta la penisola, fra la cosiddetta questione contadina e i problemi sociali sottesi a un processo non più solo vagheggiato bensì ormai in gestazione di unità nazionale, a partire, almeno nei suoi voti, anche dai bisogni e dalle condizioni in cui versavano quelle stesse masse rurali della penisola che quasi solo a Pisacane, entrato nella sua fase anarcosocialista, avevano dettato pagine memorabili e consonanti (ancorché all’epoca poco o punto conosciute). In Veneto e in Friuli, oltre a suscitare di fatto, nelle basse pianure, ricorrenti e indicativi fenomeni di ribellismo33, quelle «popolazioni agresti» stavano dando prova di avere messo a frutto, specie fra gli «alpigiani», un loro lungo apprendistato emigratorio abbastanza somigliante, in sostanza, a quello già intra30 I. De Luca, Ippolito Nievo collaboratore della «Rivista veneta» di Venezia e della «Rivista euganea» di Padova, in «Atti e memorie della Accademia patavina di scienze lettere ed arti», LXXVII, 1964-65, pp. 85-183. 31 M. Gorra, Per una «rivoluzione nazionale», in Id., Nievo e Venezia, Comune di Venezia, Venezia 1981, p. 102. 32 L’espressione è contenuta in una lettera di Nievo ad Attilio Magri (da Colloredo il 14 ottobre 1854) edita in Tutte le opere di Ippolito Nievo, VI, Lettere, a cura di M. Gorra, Mondadori, Milano 1981, p. 303 e citata in rilievo da A. Patat, Patria e psiche. Saggio su Ippolito Nievo, Quodlibet, Macerata 2009, p. 17. 33 P. Brunello, Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli, 18141866, Cierre, Verona 2011 (Marsilio, Venezia 1981). 60 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 61 Storiografia e ricerca storica «in movimento» preso da contadini e altri lavoratori nell’alta Lombardia, nel basso Piemonte e nel Genovesato ovvero, in modo più eclatante perché massicciamente orientato verso le Americhe a fini popolazionistici e di colonizzazione agraria, nelle campagne dell’Europa centro-settentrionale. Pur frequentando, per rigido debito scolastico, lezioni e studi che a Padova un po’ lo annoiavano, ma che nella Facoltà legale contemplavano anche, come s’è visto, la conoscenza di nozioni statistiche di base e l’apprendimento di concetti elementari di economia politica, pare abbastanza probabile che, entrato nel 1854 in contatto e poi in stretta amicizia con uomini e patrioti più anziani di lui come ad esempio Ferdinando Coletti, Osvaldo Monti o i fratelli Arnaldo e Clemente Fusinato (il secondo dei quali alcuni ne masticava abbastanza), Ippolito Nievo si fosse venuto formando un minimo bagaglio culturale in materia di scienza economica applicata o applicabile alle Americhe. Il che probabilmente avvenne, comunque, non già o non tanto mediante la semplice lettura dei trattati in adozione all’università, quanto piuttosto ascoltando «la voce» di poeti e scrittori come Chateaubriand e Byron i quali avevano recuperato alla cultura europea un interesse, appannatosi a tratti in età napoleonica, «per il Nuovo Continente»34, oppure attraverso la stessa familiarità con i romanzi più «avventurosi» da oltre vent’anni in voga35 e con i resoconti diretti e indiretti (saggi, articoli, recensioni a libri di viaggio ecc.) messi in circolo dalle riviste e dai giornali. Qui si divulgavano sempre più spesso, in Italia e all’estero, notizie e dettagli riguardanti l’assetto demografico del vecchio mondo in rapporto alla presenza degli «indiani» e alle migrazioni già di massa verso i paesi «nuovi» d’oltreoceano tutti o quasi tutti da «colonizzare» per la disponibilità laggiù crescente (e sanguinosamente indotta) di «terra libera»36. Assieme ai «bianchi coloni» rurali del vecchio continente molti di quei paesi stavano ormai accogliendo però, contemporaneamente, anche una parte non indifferente degli esuli e dei profughi dell’incompiuta rivoluzione democratica europea del ’48. Patat, Patria e psiche cit., pp. 20-1. Tra le letture giovanili di Nievo non mancano, com’è noto, quelle di autori come James Fenimore Cooper, l’autore de L’ultimo dei Mohicani – richiamato ad esempio nel passo di una lettera sua ad Arnaldo Fusinato da Palestrina, il 23 luglio 1854 dove il mittente riferisce d’essere ospite nell’isola lagunare di un vecchio marinaio «che coi suoi lunghi racconti mi torna a mente tutte le semplici bellezze e le ineffabili noie dei romanzi di Cooper». Nievo, Opere cit., p. 1102. 36 Nella stragrande maggioranza dei casi gli indiani in questione sono però solo quelli del Nord America, i «pellirosse»: cfr. G. Scuderi, Indiani d’America sulle riviste milanesi della Restaurazione e del Risorgimento, in «Archivio Trimestrale», 1983, pp. 159-74 e N. Clerici, I «selvaggi d’America» sui giornali italiani dell’Ottocento, in Gli indiani d’America, a cura di F. Giordano, I, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1997, pp. 103-13. 34 35 61 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 62 Emilio Franzina Ritiratosi dopo la laurea a Colloredo di Montalbano, Nievo vi attese l’avvento di tempi migliori per la causa nazionale, anche se continuò con ogni probabilità a tenersi informato sugli sviluppi delle migrazioni al di là dell’oceano – in Usa, in Brasile e in Argentina – meditando in forma più matura sulla nuova fase di un processo che si stava confermando di grande portata e d’inedita composizione non solo per ovvie ragioni economiche e demografiche, bensì pure per le sue implicazioni di carattere più squisitamente politico. Anche su tali implicazioni sarebbe interessante intrattenersi adesso come giustificherebbe – ma troppo tempo richiederebbe parlarne in dettaglio qui – la chiusa avventurosa e spesso fraintesa delle Confessioni37. In essa, infatti, Ippolito Nievo si ispirò, a mio avviso, da un lato alle ultime e assai poco note bandeiras pauliste e da un altro alla tragica vicenda del patriota abruzzese Silvino Olivieri, caro più tardi a Benedetto Croce38, ovvero al capo della italica Legion Valiente nella difesa di Buenos Aires minacciata da Urquiza nel 1853 che Mazzini, incoraggiato da Giovan Battista Cuneo, aveva addirittura pensato, a un certo punto, potesse prendere il posto, nell’immaginario e nei fatti, di Giuseppe Garibaldi. Scampato in Roma alle forche pontificie, dopo un breve rientro in patria con intenti cospirativi, per interposizione diplomatica della Repubblica Argentina di cui era divenuto cittadino, Olivieri era tuttavia stato ucciso nel settembre del 1856 dagli stessi soldati, in parte anche italiani, alla guida dei quali stava tentando di dar vita nei pressi di Bahia Blanca, su mandato governativo portegno, a una colonia agricolo-militare – da lui ribattezzata col nome di Nuova Roma –, in un cruento episodio d’insubordinazione di cui molto si parlò negli ambienti mazziniani e del quale si occupò, in Italia, quanto meno la stampa d’informazione genovese. Poiché si tratta però d’un tema che molto s’inoltra nella storia delle legioni militari italiane e soprattutto del mazzinianesimo nelle sue cangianti relazioni, al Plata, con le ideologie nazionaliste locali – meglio studiate sinora, dopo Salvatore Candido39, da vari 37 Su cui si è soffermato in forma stringata Alejadro Patat sia nel suo Patria e psiche cit., pp. 16-25 sia in alcuni convegni recenti a Padova e a San Paolo (nel quale ultimo – Os 150 anos da unificação italiana e as questões da identidade no Brasil e na Itália, Università di San Paolo, Facoltà di Filosofia, Lettere e Scienze umane, 8-11 novembre 2011 – abbiamo avuto l’opportunità di discuterne ampiamente assieme come risulterà, se saranno pubblicati, dagli atti della giornata conclusiva dei lavori). 38 Una ricostruzione molto accurata della figura e dell’impegno politico e militare dell’Olivieri sta ora in Bistarelli, Gli esuli del Risorgimento cit., pp. 236-43. 39 S. Candido, Appunti sull’apporto italiano alla storia delle emigrazioni politiche dall’Italia ai paesi iberoamericani durante il Risorgimento, in Aa.Vv., L’apporto italiano alla tradizione degli studi ispanici, Istituto Cervantes, Roma 1993, pp. 187-202. 62 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 63 Storiografia e ricerca storica «in movimento» storici latinoamericani come De Marco, Scheidt, Chiaramonte, Myers ecc. –, pur essendo da tempo indaffarato a lavorare sugli esuli, sui soldati «per scelta o per caso» e sugli sbocchi pratico-politici della prima emigrazione italiana in Argentina e Brasile40, rinuncerò a entrare ora nel merito, eccettuato ancora qualche fugace accenno all’ultimo capitolo del grande romanzo nieviano, di questioni tanto complesse rinviando l’analisi a una diversa sede, per passare invece qui appresso, in modo se vogliamo un po’ acrobatico, a tutto un altro tipo di riflessioni sulla «diversa indole» dei movimenti migratori internazionali, stavolta nella storiografia italiana dei tempi nostri. 2. Divagazioni su storici e storia in forma autobiografica. La storia delle migrazioni non ha mai goduto in Italia, fuori dall’ambito statistico e demografico, di vera considerazione fra gli storici, e si può dire anzi che risalgano appena all’inizio degli anni sessanta del secolo passato i primi studi destinati a costituirla in disciplina passabilmente a se stante nonché svincolata, come «specialità», dalle ipote40 Specialmente per l’età del Risorgimento a cui avevo riservato sin dal 1995 molte pagine (87-140) del mio Gli italiani al nuovo mondo (cit.), dov’erano appena accennate le già indicative e prefiguranti parabole degli ex ufficiali napoleonici alla Codazzi (su cui, per l’America Meridionale, s’intrattiene ora in prospettiva ampliata W. Bruyère-Ostells, La Grande Armée de la Liberté, Tallandier, Paris 2009, pp. 39-76), ma dove non avevo potuto d’altro canto soffermarmi più a lungo, come avrei fatto in seguito e tuttora sto facendo, sulla dimensione politica e militare del profugato politico italiano venuto in contatto, dopo il 1830, al cono sud, da un lato con le impostazioni ideali, le culture e le strategie dei maggiori «proceres» locali e da un altro, in modo più marziale, con le stesse popolazioni indigene del subcontinente. Il tutto in vista dell’evoluzione che conobbero e delle conseguenze che ebbero nel lungo periodo, sul terreno dell’emigrazione popolare di massa in Brasile e soprattutto in Argentina, i rapporti più che cordiali intrattenuti fra la metà degli anni trenta e la metà degli anni sessanta dalle nuove élites liberali sudamericane e i previous migrants politicizzati, gli esuli garibaldini e gli altri proscritti repubblicani originari della penisola e spesso seguaci di Mazzini, ma virati anche, sulla scia del Maestro (cfr. Giuseppe Mazzini’s International Political Thought, introduzione dei curatori all’antologia A Cosmopolitanism of Nations. Giuseppe Mazzini’s Writings on Democracy, Nation Building and International Relations, a cura di S. Recchia e N. Urbinati, Princeton University Press, Princeton 2009, pp. VII-XXIX) nei tardi anni sessanta e lungo l’intera decade seguente, così decisiva per l’ascesa dei nostri flussi immigratori in quasi tutto il subcontinente, in altre direzioni (cfr. E. Scheidt, Carbonários no Rio da Prata. Jornalistas italianos e a circulação de idéias na Região platina, 1827-1860, Scriptum, Rio de Janeiro 2008 e J. Myers, Giuseppe Mazzini and the Emergence of Liberal Nationalism in the River Plate and Latin America, in C. A. Bayly - E. F. Biagini, Giuseppe Mazzini and the Globalisation of Denocratic Nationalism, 1830-1920, Oxford University Press, Oxford-New York 2008, pp. 323-46) e, soprattutto, nell’impegno immigrazionista assunto da alcuni di loro, in veste ufficiale di consoli e rappresentanti del governo argentino, con in testa proprio Giovan Battista Cuneo (cfr. E. Franzina - M. Sanfilippo, Garibaldi, i Garibaldi, i garibaldini e l’emigrazione, in «Archivio storico dell’emigrazione italiana», 2008, 1, pp. 23-52). 63 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 64 Emilio Franzina che di antiche letture, massime d’impianto retorico e nazionalistico, che solo Gioacchino Volpe era riuscito a suo tempo a modulare con intelligenza e obiettiva conoscenza dei fatti41. Nel recupero continuo di «memorie» a cui è dato oggi di assistere per effetto d’un fisiologico anelito alla comparazione con quanto nel nostro paese sta succedendo ormai da oltre vent’anni in forza del continuo arrivo da noi di lavoratori e di immigrati provenienti dalle più diverse parti del mondo (e quindi a causa di una presenza straniera enormemente accresciuta e fattasi vistosa in molte zone della penisola), era quasi inevitabile che si dovessero a un certo punto «riscoprire», da parte di molti, le origini remote di un fenomeno a cui, circondati in sostanza da disinteresse e silenzio, avevano dedicato attenzione assai pochi specialisti nella seconda metà del Novecento e sul quale hanno continuato per fortuna a interrogarsi poi, in forma comparata e con assai più favorevoli riscontri, alcuni validi studiosi venuti dopo di loro. Su certi aspetti indubbiamente di rilievo di quel fenomeno (l’espulsione dalle campagne, il viaggio per mare, il meccanismo del push-pull, l’intolleranza e la xenofobia incontrate al di là dell’oceano, le vicissitudini iniziali del «trapianto», la costruzione in America di reti etniche di sostegno o anche di colossali fortune individuali ecc.) non hanno mancato tuttavia di pronunciarsi, sempre più spesso e per un vasto pubblico, ma in modo alle volte foriero di grossolane approssimazioni e di semplificazioni indebite, tra giornalisti e romanzieri, narratori e cineasti ecc., anche parecchi interpreti a dir poco sprovveduti o improvvisati. La circostanza è nota e io stesso mi sono premurato in più occasioni di rimarcarla deprecandone dolcemente gli eccessi42 quantunque ci sia da dire che, da ultimo, la storiografia più seria e appunto specializzata in emigrazione ha beneficiato di apporti innovativi e sempre più solidi, conoscendo un apprezzabilissimo incremento e aprendosi infine anche all’esame di arcate cronologiche diverse43 rispetto a quelle privilegiate, sin quasi allo scadere del secolo scorso, dagli esperti di cose emigratorie italiane. 41 E. Franzina, Politici, storici e migranti fra l’Italia e il mondo, in Storia d’Italia, Annali, 24, Migrazioni, a cura di P. Corti e M. Sanfilippo, Einaudi, Torino 2009, pp. 201-25. 42 E. Franzina, L’America gringa. Storie italiane d’immigrazione tra Argentina e Brasile, Diabasis, Reggio Emilia 2008, pp. 11-23. 43 Fra cui, e lo segnalo appena di sfuggita, il lungo e frastagliato periodo d’ancien régime quando non furono pochi né poco rilevanti gli spostamenti di carattere emigratorio e immigratorio in tutta Europa sui quali hanno richiamato l’attenzione Jan e Leo Lucassen, Klaus Bade, Donna Gabaccia ecc. e, da noi, Pier Paolo Viazzo, Raul Merzario, Giovanni Pizzorusso ecc., ma soprattutto, le stesse migrazioni interne alla penisola com’è invece ben spiegato ora in un ottimo saggio di Stefano Gallo (Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall’unità a oggi, Laterza Roma-Bari 2012). 64 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 65 Storiografia e ricerca storica «in movimento» Nel prendere in esame lo stato degli studi fioriti di recente appunto in questo settore, Roberto Sala44 ha elaborato una sua teoria sulle lacune, sulla ripetitività e sui «pericoli» di una ricerca accontentatasi troppo a lungo di ricostruire, nel caso italiano, la sola storia della «grande emigrazione» verso le Americhe lasciando colpevolmente in ombra o addirittura da parte la fase, non meno importante, dell’emigrazione postbellica verso i principali paesi dell’Europa continentale. A confronto di quella diretta al «nuovo mondo» dalla fine del XIX secolo in poi, secondo il suo parere, l’emigrazione italiana «nei paesi d’oltralpe» sarebbe, oggi, «paradossalmente, un ricordo sbiadito, quasi evanescente». E ciò costituisce un fatto tanto più grave quanto più sono ancora tra noi i protagonisti di quell’esodo e, in parte ormai naturalizzate all’estero, le prime generazioni che ne sono scaturite. Perché ciò sia successo è altrettanto facile, però, da intuire. Abbastanza assodato, in effetti, appare il carattere mitizzante e tendenzialmente «leggendario» nonché circondato da un’aura, a tratti esagerata già in partenza, di «eroicità», detenuto in origine, ma poi anche enfatizzato via via a dismisura da alcuni storici e ora da stuoli di giornalisti, dalle prime fasi del passaggio in America, soprattutto in America settentrionale, di milioni di contadini (e non solo di contadini) italiani: e ciò, magari, per l’apporto fornito, sin dagli anni venti del secolo scorso, dalla cinematografia hollywoodiana e, in genere, da un metaracconto imperniato su memorie avventurose, su narrazioni autogiustificative e su affascinanti rivisitazioni letterarie. Queste ultime furono quasi sempre stimolate, oltreoceano, anche dal bisogno impellente di aggiornare lì, in modo continuativo e depurato dai suoi aspetti più contraddittori45, l’immagine pionieristica e positiva dell’America e, assieme, dei flussi in entrata che plasmarono, a tutti i livelli, società divenute ben presto più «moderne» della nostra ma appena uscite dalla wilderness e cresciute, fra Otto e Novecento, anche grazie alla nostra immigrazione. Tali circostanze, assieme al progressivo allontanarsi nel tempo di quella stagione intravista come «favolosa» e che pure al di qua dell’Atlantico avrebbe contribuito al tentativo di rafforzare un particolare tipo d’«identità nazionale», incrinata e minacciata, per altri versi, dalle note debolezze del suo processo costitutivo, non sembrano revocabili in dubbio e si riflettono puntualmente nell’andamento esile ed erratico, sino a poco tempo addietro, delle indagini intorno al44 R. Sala, L’emigrazione nella memoria storica italiana. Una riflessione critica, in «Studi emigrazione», 2011, 183, pp. 427-41 (di qui tutte le citazioni successivamente nel testo). 45 Cfr. S. Luconi - M. Pretelli, L’immigrazione negli Stati Uniti, il Mulino, Bologna 2008. 65 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 66 Emilio Franzina le migrazioni dell’ultimo dopoguerra. Esse, estendendosi grosso modo dal 1946 al 1973, avrebbero inoltre avuto il «difetto», per Sala, di richiamare in vita polemiche e discussioni imbarazzanti, ossia riguardanti i nodi, i modi e i costi dello sviluppo economico italiano più recente. Tutte cose da evitare, insomma, per i benpensanti e da non far passare armi e bagagli all’interno di un «discorso pubblico» sulle migrazioni che, complice la persistente prevalenza nelle sue espressioni più correnti, non solo divulgative, «dell’America degli emigranti», ama tracciare di esse un profilo al tempo stesso prometeico e melodrammatico, incline al romanticismo d’accatto o al miserabilismo compiaciuto e, in definitiva, all’accoglimento passivo dei paradigmi irenici e autoassolutori applicabili alla «razza» degli uomini forti che si son fatti da sé e che hanno fatto altresì, con la propria, la fortuna dei loro paesi tanto di partenza quanto, soprattutto, di approdo. Certamente ha ragione Sala nel notare come la particolare considerazione accordata dalla storiografia italiana all’emigrazione in America potrebbe derivare, «almeno in parte», da un «effetto di ritorno» degli studi compiuti nei paesi d’immigrazione da specialisti di più e meno remota ascendenza italiana46, ma in via generale l’italianità degli 46 Il che era abbastanza noto benché sembri legato non soltanto ai presupposti «americani» dell’opera svolta dai vari Vecoli, Beretta Curi, Devoto, Gabaccia, Cannistraro ecc. bensì pure, come lo stesso Sala ammette di sfuggita, a un analogo impulso offerto da altri studiosi, stavolta «oriundi europei», come per la Francia Pierre Milza, per il Belgio Anne Morelli o per la Germania René Del Fabbro (a cui si potrebbero aggiungere per la Svizzera tedesca Ernest Menolfi ovvero anche molti italiani «trapiantati» altrove per tramiti accademici e non, come in Francia Marco Barnabà e Carmela Maltone, in Lussemburgo Maria Luisa Caldognetto, in Brasile Luigi Biondi ecc.). Appurata la genesi di vari altri apporti offerti fuori d’Italia alla storia della nostra emigrazione da ricercatori stranieri sicuramente non italo-discendenti (e della schiera semmai degli «italianizzanti», da Benedicte Deschamps a Peter Manz), la «dovuta cautela» con cui si può tuttora affermare che «oltreoceano gli storici di origine italiana abbiano coltivato con cura la storia del proprio gruppo nazionale di appartenenza» (Sala, L’emigrazione nella memoria cit., p. 432) incrocia anche ulteriori variabili e dovrebbe comunque tener conto, oltre che dell’ancestry e di un italico retaggio etnico, dei percorsi politici e culturali più complessi e compiuti, a casa loro ma anche a casa nostra, dai diversi autori. La maggior parte dei quali, infatti, potrebbero essere stati influenzati dalla propria collocazione appunto politico-culturale all’estero in quelli che restano pur sempre i «loro» paesi di nascita e poi dalle relazioni conseguentemente intrecciate, in Italia, con interlocutori e referenti accademici, editoriali e pubblicistici tutti ben connotati. Le trafile della sinistra radicale e persino classista in Usa s’intravedono, ad esempio, dietro all’arrivo da noi dei libri e degli studi di Donna Gabaccia o di Rudolph Vecoli, ma non certo di Philip Cannistraro che tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta del secolo scorso gravitava nell’area della rivista «Storia contemporanea» e della prima serie di «Studi Emigrazione/Etudes Migrations» (poi virata in «Studi Emigrazione/Migration Studies» ovvero nell’«International journal of migrations studies» dei giorni nostri) non diversamente del resto da Fernando Devoto il cui passaggio in Italia, tra il 1981 e il 1982, in prudente allontanamento dall’Argentina dei militari assieme alla sua prima moglie Maria Inés Barbero (anch’essa poi nota studiosa di storia economica «italo-argentina»), trovò una evidente 66 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 67 Storiografia e ricerca storica «in movimento» emigrati e dei loro figli, come ci insegna oggi, per tutt’altro dominio, la parabola di Sergio Marchionne – nato a Chieti nel 1952 da padre abruzzese e da madre istriana ed emigrato in Ontario nel 1966, affermatosi come dirigente aziendale in Nord America e ripiovuto in Italia, alla Fiat, nel 2003 con quel che ne seguì e che molti sanno – è stata più spesso, per essi, «tutto e niente», quasi una chimera cangiante e di sicuro duttile, o adattabile, ma rigidamente sottoposta, alla fin fine, a regole «indotte dai codici culturali del [rispettivo] paese d’immigrazione» talché, oltreoceano, l’identità italiana sarebbe «per molti versi più un qualcosa di americano che di italiano». Ma lo si sarebbe forse potuto capire sin dalle battute conclusive dell’invenzione romanzesca sull’esule Giulio Altoviti in Sudamerica congegnata da Ippolito Nievo, probabilmente nient’affatto a caso, per suggellare Le Confessioni d’un Italiano con una coreografica proiezione all’esterno modellata, almeno per la parte brasiliana, sulla scorta d’informazioni di seconda mano ma non tutte infondate47 anche se imperniate poi, nel racconto, su topoi letterari già tipici di molti testi dell’antica «disputa», per dirla alla Gerbi, «del nuovo mondo»48. Nell’impossibilità di analizzarla qui, come s’è detto che meriterebbe e come ancora, a mio avviso, non è stato fatto, occorre almeno soffermarsi in via sommaria sulla comparazione tra le differenti fasi e i più diversi risvolti dei processi emigratori. Essi mettono in moto così tante e tanto complicate dinamiche che gli storici chiamati a dipanarne le trame devono sforzarsi di ricostruirle con assoluta chiarezza onde non sottostare al condizionamento creato dalle formule e dalle definizioni normalmente in uso sin dall’Ottocento per banali motivi di comodità espositiva (e tutte provviste, nondimeno, di una loro forte carica simbolica e quindi «tendenziosa»: emigrazioni temporanee e permanenti, sponda sia nel Cser scalabriniano dei compianti padri Rosoli e Favero e sia negli ambienti universitari più vicini a Renzo De Felice e alla sua rivista «Storia contemporanea» (cfr. E. Franzina, Emigrazione transoceanica e ricerca storica in Italia: gli ultimi dieci anni, 19781988, in «Altreitalie», 1989, 1, p. 12) e così via puntualizzando. 47 Per il Mato Grosso, teatro nel romanzo delle prime avventure sudamericane di Giulio Altoviti e (anche nella realtà dei fatti) di molti episodi costellati da abbozzi di colonizzazione e di minerazione, di spunti d’evangelizzazione politica «missionaria», di scontri sanguinosi con gli indios «selvaggi» (Bororo Coroado e Paresis si potrebbe azzardare) ecc., si possono trovare intanto riscontri abbastanza puntuali nella più recente storiografia indigenista brasiliana ma anche, adesso, nell’opera di sintesi ampia e informata di Chiara Vangelista e specie nel primo volume – L’invasione (sec. XVIII-XIX) – del suo Politica tribale. Storia dei Bororo del Mato Grosso, Brasile, Il Segnalibro, Torino 2008, pp. 97-159. 48 B. Curia, Ippolito Nievo y un malón en el Mato Grosso, in «Hispanista-Primera Revista Electronica de los Hispanistas de Brasil», ottobre-dicembre 2004, 19 (http://www.hispanista.com.br/revista/artigo). 67 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 68 Emilio Franzina transoceaniche e continentali, stagionali e periodiche ecc.)49, cercando di descriverle, come furono, quali altrettanti aspetti di una storia al tempo stesso generale (sc. «globale») e transnazionale dei secoli XIX e XX. Da tale punto di vista occorre sì accogliere con favore l’auspicio che alla storia delle emigrazioni (e delle immigrazioni) più vicine a noi nel tempo ci si possa riaccostare, nella ricerca e nel «discorso in pubblico» che le riguarda, con uno sguardo scevro da rischiose enfatizzazioni «romantiche» destinate quasi sempre a sfociare, a propria volta, in fuorvianti letture, ora nazionalistiche e ora regionalistiche, di un passato che fu invece infinitamente più variegato, contraddittorio e complesso. L’aspirazione al recupero d’una «memoria civile» dell’esperienza emigratoria, valida tanto per l’emigrazione transoceanica fra Otto e Novecento quanto per quella in Europa dopo il secondo conflitto mondiale, non può essere tuttavia brandita come arma impropria e come strumento di svalutazione aprioristica nei confronti d’indagini che hanno tutto il diritto di continuare a svolgersi e a essere perfezionate a proposito dell’America quale terra d’approdo o d’asilo e quasi, appunto, come proiezione all’esterno dell’Europa otto e novecentesca, sebbene più d’uno ne abbia voluto fraintendere la valenza o il senso e quantunque siano (o proprio perché sono) molto lontani i tempi in cui, sul suo conto, quel tipo di ricerche, per dirla alla Bloch «embriogenetiche», presero avvio. Le osservazioni in base alle quali si dovrebbe privilegiare, anche qui senza idealizzarlo, il ricordo degli imponenti flussi postbellici (compresi peraltro quelli ancora diretti in varie parti proprio delle Americhe: Canada, Brasile, Venezuela, Argentina…) soprattutto perché essi intersecarono a un certo punto la strada delle grandi migrazioni interne all’Italia50 o perché, oltre a questo, una loro migliore conoscenza aiuterebbe ad affrontare con più efficacia e maggiore umanità il problema dell’immigrazione straniera da noi (tanto più quanto più essa dovesse risultare collegata, a parti rovesciate, con le antiche migrazioni in America secondo quanto sta accadendo nel Nord dell’Italia a 49 Sul lessico dei primi studiosi italiani d’emigrazione cfr. E. Franzina, Diaspore e «colonie» tra immaginazione e realtà. Il caso italo brasiliano, in Itinera. Paradigmi delle migrazioni italiane, a cura di M. Tirabassi, Edizioni della Fondazione G. Agnelli, Torino 2005, pp. 104-9. 50 E perché, a maggior ragione, furono coevi, anche oltreoceano, di una nuova stagione e di molte questioni solo oggi infine segnalate e studiate a dovere (ad esempio in un intero capitolo, il quarto, del bel libro di Matteo Pretelli, L’emigrazione italiana negli Stati Uniti, il Mulino, Bologna 2011) come quelle dell’evoluzione e delle inevitabili trasformazioni, dopo l’ultima guerra mondiale, delle maggiori «comunità» un tempo immigratorie e ormai solo «di origine italiana». 68 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 69 Storiografia e ricerca storica «in movimento» gran parte dei flussi in arrivo dal Brasile e dall’Argentina)51, sono in sé giuste e più che condivisibili. Dovrebbero far conto, tuttavia, della situazione esistente sull’aprirsi degli anni settanta del Novecento quando, anche per banali ragioni d’anagrafe, le scelte degli iniziatori di quel tragitto che portò alla «riscoperta» dei primordi dell’emigrazione al nuovo mondo – e «della loro indole» – si vennero formando proprio a ridosso del perdurare, e subito appresso del graduale estinguersi, nei fatti, delle nostre maggiori correnti emigratorie postbelliche dirette nell’Europa continentale. Tant’è che per un caso di studio come quello italo-tedesco, di cui Roberto Sala ben conosce la parabola anche grazie al recupero da parte sua di un patrimonio a me assai congeniale di lettere d’emigranti al passo coi tempi52, ho molto appoggiato io stesso le ricerche impeccabili condotte sugli italiani in Germania e in particolare ad Amburgo negli anni sessanta del Novecento da Elia Morandi, raccontando anche, en passant, nella prefazione a un suo bel libro53, come quella storia non mi fosse «personalmente» estranea per essere stato io, allora, in contatto diretto con l’universo sociale e lavorativo di cui quegli emigranti facevano parte. Un universo non del tutto dissimile eppure distantissimo dall’altro dell’antica emigrazione transoceanica molti dei cui componenti proprio da Amburgo o da Brema avevano del resto preso le mosse durante il secolo XIX, essendo partiti di lì, alla volta degli Usa o del Brasile, interi contingenti di emigranti e di futuri coloni anche italiani. Non per indulgere dunque agli allettamenti dell’egohistoire, ma per precisare appena il contesto – storiografico e al tempo stesso, per qualcuno, esistenziale – di quegli anni, sarei tentato di rievocare, adesso, le difficoltà e i problemi a cui si andava incontro nel momento in cui cominciò quella che non era ancora, grazie a Dio, una «moda» – o il tentativo di dar vita a chissà quale «saga» – ma che ugualmente spingeva alcuni isolati curiosi a intrigarsi di un passato allora sì rimosso o 51 All’interno di un nuovo filone di ricerca, che posso dire di aver contribuito a far lievitare in Italia e che annovera oggi alcuni studi di sicuro valore (come J. C. Tedesco, Estrangeiros, extracomunitários e transnacionais. Paradoxos da alteridade nas migrações internacionais. Brasileiros na Italia, Upf Editora-EdiPucrs-Argos, Passo Fundo-Porto Alegre-Chapecó 2010), cfr. almeno E. Franzina, Italianos no Brasil e brasileiros na Italia. Actualidade duma história, in Aa.Vv., L’ultima America. Emigrazione postbellica (Brasile e Argentina): studi provinciali di caso (Verona e Vicenza), Fondazione Cariverona, Agorà & Factory, Vicenza 2007, pp. 93-110. 52 R. Sala - G. Massariello Merzagora, Radio Colonia. Emigranti italiani in Germania scrivono alla radio, Utet, Torino 2008. 53 E. Franzina, Prefazione, a E. Morandi, Governare l’emigrazione. Lavoratori italiani verso la Germania nel secondo dopoguerra, Rosenberg & Sellier, Torino 2011, pp. 7-12. 69 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 70 Emilio Franzina malinteso. Per chi vi si avventurò, come me, con l’entusiasmo dei vent’anni nei dintorni del ’68 si trattava anche di una questione non disgiunta dai dibattiti in corso sull’evoluzione dell’Italia da liberale a fascista a repubblicana all’ombra, in tante zone della penisola ma in Veneto senz’altro, di una formidabile egemonia clericale. Non a caso gli studi aurorali che mi trovai a intraprendere nel 1970 sull’emigrazione al di là dell’Atlantico, in un’America che per me fu subito l’America del Sud fra Brasile, Uruguay e Argentina, si intrecciavano con quelli che un po’ all’Università di Padova e un po’ per mio conto venivo compiendo sul movimento cattolico e sulle origini dell’industria tessile nella mia regione natale. Alternando alcune indagini dedicate ad Alessandro Rossi e al notabilato cattolico liberale con altre ricerche finalizzate al conseguimento della laurea, su Vilfredo Pareto e gli economisti radicali di fine Ottocento, mi ero imbattuto più e più volte nel volto concreto delle vicende economiche e sociali di un periodo in cui dalle campagne del Veneto e del Friuli l’esodo dei contadini appariva diluviale e nel quale le loro corrispondenze dall’America o da altri paesi pervenivano ai parenti, ma anche ai giornali, cariche di speranze o di disperazione e soprattutto piene di descrizioni dal vivo e, come si cominciava allora a dire, «dal basso» che mi sembrarono meritevoli di essere meditate e descritte. Mentre consegnavo le prime acerbe prove del mio tirocinio di aspirante contemporaneista a riviste come «Critica Storica» di Armando Saitta o «Classe» di Stefano Merli, già stimolato dalla lettura di pochi libri quasi tutti freschi di stampa (di Grazia Dore, di Giorgio Spini, di Fernando Manzotti ecc.), l’incontro con Silvio Lanaro, di cui devo essere stato, atipico fin che si vuole, il primo se non anche l’unico vero allievo, mi rafforzò nei miei propositi. Il fatto che egli fosse da poco diventato uno degli assistenti alla cattedra di Storia moderna retta da Federico Seneca, con cui a Padova mi laureai, m’impressionava e mi interessava molto meno di quel che lui era venuto scrivendo, fra il 1967 e il 1972, in particolare su Rossi, sul Veneto e più in generale sull’Italia postunitaria in una prospettiva che oggi potremmo anche definire, in modo un po’ ardito (e limitativo) di cultural history. E basti, per farsene un’idea, andarsi a rileggere, sul senatore protezionista e imprenditore laniero di Schio, le pagine di un aureo saggio suo del 1973 su «Quaderni storici» ripubblicato ch’è poco da Donzelli: folgorante54. La folgorazione, a dire il vero, per me continuò anche negli anni successivi tra l’uscita di Nazione e lavoro (1979), de 54 Lo si veda ora in S. Lanaro, Retorica e politica. Alle origini dell’Italia contemporanea, Donzelli, Roma 2011, pp. 185-263. 70 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 71 Storiografia e ricerca storica «in movimento» L’Italia nuova (1989) e poi della Storia dell’Italia repubblicana (1992), sebbene non proprio sulla via di Damasco bensì al suo opposto o, meglio, in un’altra direzione rispetto a quella imboccata da Lanaro. Mi pareva infatti cosa degna e giusta – o almeno stimolante – cercar di competere, per integrarne le analisi, con chi tanto bene aveva saputo indagare il profilo delle classi borghesi in Italia dopo l’Unità e sino ai giorni nostri occupandomi, per lo stesso periodo, anche di classi subalterne e quindi, a seguire, di migrazioni popolari all’estero. Per più di dieci anni, comunque, non abbandonai nemmeno il campo di studi su politica e società in Veneto e in Italia che per impulso proprio di Lanaro e, assieme a lui, di Mario Isnenghi, avevamo cominciato a dissodare insieme dai giorni in cui si preparò e quindi si tenne a Padova nel 1973, con la «benedizione» di Marino Berengo, un memorabile convegno su Movimento cattolico e sviluppo capitalistico. Il convegno divenne ben presto un libro edito da Marsilio, ma in esso non mi occupavo ancora, ex professo, di emigrazioni in America, il tema che mi ero messo a indagare sistematicamente fra le perplessità di Silvio il quale mi avrebbe preferito di gran lunga ancora intento a scandagliare i carteggi di Pareto, di Papafava e di Pantaleoni o le figure di Lampertico e degli altri notabili clerico-moderati italiani. Nei luoghi ai quali avevo già accesso e in qualche altra rivista un po’ più periferica, come la «Rivista bellunese» di Bepi Pellegrinon, pur senza mai tradire cattolici e clericali o liberisti e socialisti, mi risolsi a pubblicare, un anno più tardi, i saggi preparatori d’una monografia che avevo già in mente di fare e che poi uscì per merito proprio di Lanaro. In coppia con Mario Isnenghi e in una collana che entrambi avevano allestito per Cesare De Michelis, nella veste qui di patron della Marsilio, fu così che un po’ bruciando le tappe diedi alle stampe, nel 1976, la mia prima «prova di polso», come amava ripetermi Federico Seneca, ossia La grande emigrazione, a cui feci seguire poi, da Feltrinelli, tre anni più tardi e con lo stesso titolo che non aveva convinto a suo tempo l’editore padovano, una raccolta più che fortunata di lettere dei contadini veneti e friulani dal Brasile e dall’Argentina intitolata Merica! Merica!. Come condirettore di collana ne seguì più da presso la gestazione Mario Isnenghi, di cui ricordo ancora i rabbuffi sarcastico-amichevoli che mi recapitava, ovviamente per posta, riguardo al mio pesante stile espositivo, da lui legittimamente definito «franzicocò». Ad essi si aggiungevano, a latere, le caute esortazioni alla misura che di tempo in tempo mi elargiva invece Lanaro, sempre preoccupato che troppo mi allontanassi dagli argomenti a lui più cari e sui quali del resto avrei avu71 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 72 Emilio Franzina to modo di ritornare, stavolta però assieme all’emigrazione, nel volume sul Veneto negli Annali della Storia d’Italia Einaudi, da lui stesso curato e diretto nel 1984. Da qui, senza particolare entusiasmo da parte di Silvio, nacque – ma questa in parte è un’altra storia – anche la prima serie di «Venetica» nella quale molto spazio veniva fatto su mio impulso ai ricercatori alle prime armi e agli «storici selvaggi» che Lanaro apprezzava un po’ meno di me o di Mario il quale, pur essendo più vecchio di entrambi, riponeva viceversa in essi una discreta fiducia. Da Lanaro, in effetti, mi separavano pochi anni di età, ma sufficienti perché la differenza si facesse sentire e il fatto che lui appartenesse, come a maggior ragione, del resto, Isnenghi, a una generazione vicina sì alla mia, ma formatasi diversamente55 e abbastanza estranea al clima tumultuoso del ’68 e dei primi anni settanta in cui mi trovavo coinvolto (a Padova per giunta!), potrebbe avere avuto un suo peso. Sta di fatto che continuando a coltivare una evidente passione per le storie minori, locali o regionali, delle classi subalterne, ma senza mai allontanarmi neppure da temi più apparentemente impegnativi (di storia urbana, dei gruppi dirigenti veneti, del movimento operaio e socialista nonché della cultura italiana fra Otto e Novecento ecc.), ero diventato un po’ per volta un «emigrantologo» a spiccata vocazione latinoamericana: a ripensarci oggi, nonostante i contrattempi e la faticosità di una ulteriore specializzazione che mi spingeva a occuparmi sempre di più, e sempre in parallelo con l’emigrazione, anche di scritture private e popolari, di autobiografie e di memorie «marginali» in sorte, non credo di dovermene affatto pentire benché non mancassero, ogni tanto, piccole trafitture e momenti in cui mi pareva insopportabile l’indifferenza per il mio lavoro quasi ostentata da parte di alcuni ambienti accademici infastiditi forse dal fatto che un docente di Storia del Risorgimento, quale ero allora e per molti anni rimasi, perdesse tempo a trastullarsi, e a quel modo poi, con piccole storie di povera gente. Cercavo sì conforto, talora, nelle parole d’incoraggiamento che mi prodigavano amici illustri e generosi come, per ricordarne con affetto solo un paio che non ci sono più, Mario Rigoni Stern e Gigi Meneghello (o, per qualche anno, lo stesso Neri Pozza assieme al quale avevo lavorato, persino da un punto di vista grafico e redazionale, alla realizzazione, nel 1977, di un volume premonitore curato per l’Accademia Olimpica di Vicenza da me e da Mario Sabbatini: I Veneti in 55 Si veda anche solo la testimonianza resa da Lanaro a Fabio Pelini in una delle interviste raccolte a cura di G. Orsina e G. Quagliariello nel loro volume su La crisi del sistema politico italiano e il Sessantotto, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 237-48. 72 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 73 Storiografia e ricerca storica «in movimento» Brasile). Non era infatti per la soddisfazione di poter avere da loro, che tanto stimavo come scrittori, un parere favorevole o, magari, una qualche prestigiosa prefazione, che mi battevo. Sentivo infatti che al tipo d’impegno civile da essi profuso in sede letteraria si doveva collegare anche qualche altro tipo di relazioni o di legami, estesi forse più indietro nel tempo e che avrei comunque ambito poter condividere con loro. Era stato così che grazie al mio interesse «professionale» per l’emigrazione m’era capitato di conoscere e di frequentare all’inizio Rigoni Stern col quale, complici altre vicende persino vacanziere, ci ritrovammo poi in tante occasioni ad Asiago, nella sua casa ai margini del bosco o in compagnia di Mario Isnenghi e di Gian Piero Brunetta, a discutere del passato d’una terra, la nostra, segnata dalle guerre del Novecento ma anche dalle vere avventure europee o americane dei suoi montanari e dei suoi contadini. E fu così, analogamente, che oltre alla Storia di Tönle, venni poi scorporando con naturalezza dalla stessa «roba» di Meneghello e dalle conversazioni avute con lui tutte le volte che tornava dal suo luogo di «dispatrio», l’Inghilterra56, gli episodi di vita familiare di questo grandissimo scrittore più legati all’emigrazione «temporanea» dei suoi parenti ch’erano andati, come lo «Zio Checco» di Libera nos a malo, in giro per l’Europa e per il mondo ai primi del Novecento57, convinto com’ero (e come son rimasto) che egli, mercé i suoi libri fuori dell’ordinario non solo per il Veneto, rappresentasse un ideale punto di riferimento, ma anche di raccordo, con un «altro» passato rimosso della mia regione. Quando, uscito il Veneto Einaudi, Meneghello si accorse che Mario Isnenghi lo aveva inserito in quel libro quale nobile terminale nella negletta «linea Nievo» del56 Non posso non lamentare, anche per tale motivo, che in un’opera per altri versi di buona fattura – ancorché in modo ostentato reticente nei confronti di chi bene o male aveva anche ad essa aperto la strada molti anni fa, se non altro perché facile est inventis addere (ma cfr., quasi alla stessa stregua, anche il libriccino di F. De Nicola, Gli scrittori italiani e l’emigrazione, Ghenomena, Formia 2009) – Gianni Paoletti, nel suo recente Vite raccontate. Emigrazione e letteratura italiana di Otto e Novecento (Editoriale Umbra, Perugia 2011, pp. 176-7), abbia pensato di dover dedicare al Meneghello del Dispatrio un’attenzione volutamente astiosa e poco condivisibile, escludendolo poi dal novero dei «nostalgici» veneti i quali scrissero di emigrazione, qui canonicamente circoscritto a Rigoni Stern, Piovene e Parise (e quindi soltanto ai vicentini ai quali allora, per coerenza territoriale, si sarebbero dovuti aggregare, come minimo e per la precisione, Neri Pozza, Renzo e Renato Ghiotto o Antonio Barolini, sempre escludendo, beninteso, i minori). 57 Alle citazioni dei passi d’interesse emigratorio continentale presenti nell’opera di Rigoni Stern o di Meneghello, ho fatto per la verità riferimento più spesso non già in sede saggistica quanto nella più collaudata e spesso imitata delle mie «conferenze spettacolo» musicali sulle migrazioni dal Nord-est dell’Italia, alla fine di una delle quali, a cui aveva assistito a Bassano con sua moglie Anna nell’aprile del 2002, il «vecchio» Mario venne sul palco a complimentarsi con me dicendomi – scherzoso o forse no – che essa, in un certo senso, valeva probabilmente molto più di tanti libri (anche, se non specialmente, miei). 73 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 74 Emilio Franzina la letteratura «veneta» e italiana – ad avviso nostro senz’altro la migliore – fu lui a sollecitare per primo un incontro fra noi che avvenne a cena in casa mia, nel 1985, con Gigi e Katia, sua moglie, quali ospiti d’onore, presente pure, naturalmente, oltre a Mario, Silvio Lanaro, il quale venne aggregato non solo in quanto curatore dell’opera, bensì forse, e ancor più, in quanto scledense vissuto da ragazzo di paese a Malo e ormai divenuto, a poco più di quarant’anni, uno dei maggiori storici italiani. Dall’impegno sia mio che di altri nascevano frattanto, in campo specialistico, ambiziosi progetti di ricerca e col tempo persino centri di studio originali, nuovi saggi e nuove riviste (da «Altreitalie», a cui fui io a trovare il nome, all’ultimo «Archivio storico dell’emigrazione italiana», che tuttora dirigo col mio vulcanico amico Matteo Sanfilippo): e tutti avevano al centro la storia dell’emigrazione – non solo in America si badi – con esiti alla lunga positivi per la ricezione anche all’estero di ciò che si è fatto e si sta facendo in Italia su tale argomento, benché al culmine di questa fase tanto produttiva e anche ricca di piccole soddisfazioni, intorno alla metà degli anni novanta del secolo scorso, i libri riepilogativi di vent’anni di attività che ancora considero più importanti per me continuassero a portare nel titolo, evidentissimi, i segni di un interessamento speciale nei confronti dell’emigrazione italiana in America dalle sue origini sino a quando, nel corso della seconda guerra mondiale, mi era parso che si potesse considerarne conclusa, in senso stretto, la parabola principale. Doveva averla pensata allo stesso modo anche Ercole Sori il quale aveva arrestato a sua volta un proprio fondamentale libro, coetaneo di Merica! Merica!, sull’emigrazione italiana nel suo complesso, giusto all’altezza degli anni quaranta del Novecento, quando cioè si sarebbe aperta la fase tolta a spunto da Roberto Sala per invocare quelle precauzioni di merito e di metodo che si son dette. Non è dunque per una banale impuntatura da pioniere il quale non si appaga nemmeno dell’onore delle armi resogli, nella perenne lizza pirandelliana fra vecchi e giovani, da chi si sia trovato a seguirne le orme ma che, insofferente, preferirebbe invertirne la direzione di marcia prevalente, se mi sono ritrovato a riflettere sui corsi e ricorsi di una storia «in movimento» – la storia in genere delle migrazioni – alla cui ricostruzione, facendo leva su qualche snodo cronologico cruciale, occorreva conferire o almeno riconoscere, a un certo punto, la rilevanza che ebbe e, in buona sostanza, tutta la dignità dovuta a un grandissimo tema di ricerca. 74 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 75 Storiografia e ricerca storica «in movimento» Che si sia trattato di una impresa voluta e per nulla casuale è dimostrato se non altro dal fatto che, accanto alle più scontate analisi di storia economica e demografica o politica e sociale sulle migrazioni, credo di aver poi dato il via per primo in Italia, per quanto mi riguarda, anche a tutto un filone – oggi fiorente ma abbastanza ignorato fin che non venne prospettato da me e da pochissimi altri58 – di indagini tese a perlustrare, per il caso italiano, i rapporti e almeno alcuni nessi strategici esistiti fra emigrazione, culture popolari e cultura letteraria del nostro paese59: sia sul versante «basso» per il quale mi proponevo di «distruggere» anch’io, nel mio piccolo, le perduranti «accuse d’ignoranza e di dappocaggine mosse da qualche saputello di mezzana coltura al nostro popolo campagnolo»60, e sia su quello «alto» (e della paraletteratura di consumo)61 verso cui, come che fosse, ancora mi inclinavano le reminiscenze di scuola, comprese quelle filologiche e universitarie «vecchia maniera» di professori miei come Paolo Sambin o Gianfranco Folena. Ed è questo un cantiere tuttora aperto a cui stanno mettendo ultimamente mano tanti studiosi, togati e non togati, attivi nei vari «archivi della scrittura popolare» o più modestamente nei piccoli musei dell’emigrazione sorti via via in Italia. Facilmente vi si rinvengono i riflessi prevedibili e le tracce vistose di alcune questioni, d’una certa rilevanza anche per gli storici «generalisti», come la lingua, i dialetti e la loro incidenza in Italia – e all’estero – fra analfabeti, colti e semicolti; la dimensione politica nel senso più ampio del termine delle migrazioni; il ruolo in essa giocato dalle classi borghesi e dalle loro ideologie nei cambi di fase dei flussi più significativi susseguitisi dal Risorgimento in poi ecc.: alcune delle questioni, insomma, che anche Ippolito Nievo negli anni cinquanta dell’Ottocento, più da scrittore che da studente, in qualche caso aveva nebulosamente intraviste e per le quali comunque, a rischio di passare (io, non lui) per un inguaribile «romantico», credo sia lecito nutrire ancora interesse, collegandole agli aspetti iniziali ma nient’affatto estemporanei e tuttora poco o mal conosciuti delle nostre prime emigrazioni in America. 58 Penso soprattutto all’opera vasta e ammirevole di Sebastiano Martelli o di Francesco Durante a cui si sono aggiunti di recente, con esiti davvero pregevoli, Martino Marazzi e Ambra Meda, autori rispettivamente, fra gli altri loro lavori, di Ad occhi aperti. Letteratura e mito americano, Franco Angeli, Milano 2011 e di Al di là del mito. Scrittori italiani in viaggio negli Stati Uniti, Vallecchi, Firenze 2011. 59 Ospitato da Mario Isnenghi in una sua collana («I fronti della storia»), bella ma editorialmente travagliata, cfr. il mio libro su L’immaginario degli emigranti. Miti e raffigurazioni dell’esperienza italiana all’estero fra due secoli, Pagus Edizioni, Paese 1992. 60 I. Nievo, Frammento sulla rivoluzione nazionale, in Id., Opere cit., p. 1079. 61 Franzina, Dall’Arcadia in America cit. 75 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 76 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 77 PENSARE LA NAZIONE Governare la trasformazione: il moderatismo riformatore di Fedele Lampertico di Renato Camurri 1. Il Lampertico di Lanaro: una lezione di metodo. Per molti decenni la figura del senatore vicentino Fedele Lampertico è stata legata al profilo che Silvio Lanaro ne tratteggiò nel 1976 in Società e ideologie nel Veneto rurale (1866-1898), libro importante che aprì una stagione di studi conclusasi con la pubblicazione del volume einaudiano dedicato al Veneto1 e intramezzata da molti altri significativi contributi2, tra i quali, senza dubbio, citerei Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia3 apparso nel 1979, a mio modo di vedere il libro più importante scritto da Lanaro. Ricollocato all’interno di questo percorso di ricerca, il Lampertico di Lanaro acquista un valore particolare che travalica il giudizio stesso espresso sulla figura del notabile veneto, su cui avremo modo di tornare più avanti: egli non è solo il «grande agrario paternalista, leader indiscusso dell’oligarchia moderata, discreto ma onnipotente dominatore della vita pubblica locale»4. Questo personaggio, che Lanaro salva dall’anonimato al quale era probabilmente condannato, emancipandolo dai ritratti caricaturali attribuibili alla penna degli eruditi locali, si rivela in realtà uno straordinario strumento per l’analisi storica, una sonda che lo studioso può usare per muoversi dentro un terreno al tempo in larga parte inesplorato come quello della cultura del moderatismo veneto e italiano e delle ideologie «protezioniste e social-conservatrici, 1 Cfr. S. Lanaro (a cura di), Il Veneto, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi, Einaudi, Torino 1984. 2 Alludiamo principalmente ai saggi recentemente raccolti dall’autore in Retorica e politica. Alle origini dell’Italia contemporanea, Donzelli, Roma 2011. 3 Volume pubblicato a Venezia per i tipi di Marsilio. 4 Cfr. S. Lanaro, Società e ideologie nel Veneto rurale (1866-1898), Edizioni di storia e letteratura, Roma 1976, p. 108. 77 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 78 Renato Camurri tradizionaliste e corporative, imperialiste e populiste, autoritarie e antiparlamentari, che nell’insieme si rivelarono adatte a sorreggere lo sforzo industriale di un paese agricolo arretrato come l’Italia»5. In queste prime pagine della sua opera di esordio Lanaro enuclea le linee guida di un programma che caratterizzò tutta la sua prima stagione di studioso. La scelta di puntare l’attenzione su un personaggio come il Lampertico è dunque congeniale a questo progetto. Ponendosi l’ambizioso obiettivo di studiare i caratteri di quello che un tempo nel linguaggio storiografico si chiamava «processo di modernizzazione», lo storico dell’Università di Padova enucleava anche un metodo di lavoro6. L’analisi dello sviluppo capitalistico e quella delle ideologie dell’industrializzazione richiedono un esame attento dell’azione compiuta da quegli uomini che a cavallo del processo di unificazione si pongono il compito di pilotare questo processo con l’obiettivo di neutralizzare qualsiasi tensione sociale. Determinanti appaiono, in questo schema analitico, lo studio delle biografie dei protagonisti del dibattito sulla modernizzazione capitalistica e sull’adeguamento della cultura politica del liberalismo italiano a una sfida così difficile e quello delle relazioni attraverso le quali si struttura il rapporto tra centro e periferia. In entrambi i casi il Lampertico appare figura capace di mantenere un ruolo di primo piano nella discussione politico-culturale e scientifica che si snoda nel secondo quarantennio dell’Ottocento. Ma cerchiamo di rivedere quali erano gli elementi su cui Lanaro aveva puntato la sua attenzione nel profilo del 1976. Cominciamo col dire che il Lampertico di Lanaro è senza dubbio più un conservatore che un liberale, un nostalgico del buon governo austriaco, critico nei confronti degli ordinamenti amministrativi dello Stato unitario, poco incline a confrontarsi con gli orientamenti costituzionali del liberalismo europeo: insomma, un conservatore che guarda più indietro, alle società di antico regime che in avanti, alle moderne monarchie costituzionali dell’Europa rimodellata dalle rivoluzioni liberali della seconda metà dell’Ottocento. Quest’impostazione naturalmente rispecchiava gli interessi dell’autore, le sue inclinazioni, le sue scelte, ma era anche il riflesso condizioIbid., p. 110. Faccio notare che contrariamente a quanto si potrebbe pensare conoscendo la sua passione per le ideologie e le culture politiche, Lanaro è stato molto sensibile anche alle questioni metodologiche e a quelle legate al mestiere di storico, come si evince dalla lettura di un libro passato quasi inosservato, ma colto e ricco di utili suggestioni per noi storici, quale Raccontare la storia. Generi, narrazioni, discorsi, Marsilio, Venezia 2004. 5 6 78 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 79 Il moderatismo riformatore di Fedele Lampertico nato di un particolare «clima» storiografico entro il quale si collocava quella fase del lavoro lanariano. Non possiamo nascondere che le velenose scorie della lunga «guerra» storiografica combattuta senza esclusione di colpi in Italia dopo il 1945 arrivarono a intossicare e a condizionare anche la ricerca sviluppatasi negli anni settanta; anni contrassegnati da nuove tensioni, da un rinnovato scontro ideologico e da forti contrapposizioni tra scuole di diverso orientamento7. L’interpretazione lanariana della cultura moderata ci sembra, almeno in parte, frutto del clima culturale sopradescritto: ciò pare particolarmente valido per l’esplicita influenza della lettura gramsciana del Risorgimento8 – percepibile in molti passaggi – che aveva, in sostanza, finito per considerare i moderati come dei conservatori costretti loro malgrado a fare la rivoluzione9. In realtà, già a partire dai primi anni ottanta questa lettura cominciò a essere messa in discussione da una nuova storiografia, che si accingeva a rileggere in profondità i caratteri del liberalismo ottocentesco europeo e italiano seguendo una linea di ricerca orientata allo studio del rapporto Stato-società10. In questa situazione la cultura politica del moderatismo cominciava a essere ri-studiata come quella componente del liberalismo che specificatamente aveva elaborato alcune delle soluzioni più avanzate nella cruciale fase in cui prendono forma i processi di State Building delle più giovani compagini statuali (Italia e Germania) e di ammodernamento dell’impianto politico-costituzionale dei regimi liberali già chiamati a dare risposte alle sfide poste dall’insor7 Il tema richiederebbe un approfondimento che in questa sede non è possibile sviluppare. Tuttavia la semplice lettura incrociata di alcuni lavori può fornire un’idea esaustiva circa le divisioni determinatesi nel dibattito storiografico italiano del secondo dopoguerra. Cfr. R. Romano, La storiografia italiana oggi, Espresso, Roma 1978; F. Barbagallo, L’azione parallela. Storia e politica nell’Italia contemporanea, Liguori, Napoli 1990, in particolare pp. 13-79; Id., L’Italia contemporanea. Storiografia e metodi di ricerca, Carocci, Roma 2002; E. Di Rienzo, Un dopoguerra storiografico. Storici italiani tra guerra civile e Repubblica, Le Lettere, Firenze 2004; A. d’Orsi, Piccolo manuale di storiografia, Bruno Mondadori, Milano 2002; e, soprattutto per il discorso qui evocato, G. Zazzara, La storia a sinistra. Ricerca e impegno politico dopo il fascismo, Laterza, Roma-Bari 2011. 8 Si allude alla rilettura della storia italiana postunitaria elaborata da Ernesto Ragionieri, uno storico a lungo frequentato dal giovane Lanaro, per il quale egli – assai parco nel dispensare elogi – non nascose mai la sua profonda ammirazione. 9 Sull’origine di quest’interpretazione si veda P. G. Camaiani, La rivoluzione moderata. Rivoluzione e conservazione nell’Italia unita, Loescher, Torino 1978. 10 Uno studioso che impresse una svolta significativa agli studi in questo settore fu Roberto Ruffilli di cui si veda almeno la raccolta di scritti Istituzioni, società, Stato, I, Il ruolo delle istituzioni amministrative nella formazione dello Stato in Italia, a cura di M. S. Piretti, il Mulino, Bologna 1989. Su di lui cfr. P. Pombeni, Roberto Ruffilli e la storiografia sullo Stato contemporaneo, in Roberto Ruffilli. Un percorso di ricerca, a cura di M. Ridolfi, Franco Angeli, Milano 1990, pp. 109-31. 79 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 80 Renato Camurri genza della questione sociale11. Entro questo nuovo quadro si collocò la ripresa di interesse che nella seconda metà degli anni ottanta si registrò attorno a personaggi come il Lampertico12, ritenuti espressione di una cultura politica che aveva profondamente cambiato gli «strumenti» e le «regole» della politica ottocentesca13. Essi, in altre parole, erano considerati prodotti tipici di quella fase – coincidente con della seconda metà del XIX secolo – in cui si era consumato il passaggio «dalla politica come decisione alla politica come mediazione»14. 2. La carriera politica di un moderato. Tra il 1988, l’anno della «svolta», e quelli a noi più vicini, la produzione scientifica dedicata alla figura di Fedele Lampertico ha fatto registrare ulteriori passi in avanti. È interessante notare che questi sviluppi hanno riguardato molteplici aspetti della variegata attività pubblica e scientifica del senatore vicentino. Possiamo registrare un ritorno d’interesse per il Lampertico economista15, e un’ampia rivisitazione 11 Su questo aspetto rimandiamo a P. Pombeni, La trasformazione politica nell’Europa liberale 1870-1890, il Mulino, Bologna 1986 e Id., Introduzione alla storia dei partiti politici, il Mulino, Bologna 1985; e per lo specifico riferimento al moderatismo, F. Cammarano, Il declino del moderatismo ottocentesco. Approccio idealtipico e comparazione storica, in Les familles politiques en Europe occidentale au XIX siècle, a cura di C. Brice, École Française de Rome, Roma 1997, pp. 205-17. 12 Un punto di svolta in questa nuova fase degli studi fu il convegno Fedele Lampertico tra mutualismo e sistema politico, svoltosi a Vicenza nel maggio del 1988, i cui atti furono pubblicati in R. Camurri (a cura di), La scienza moderata. Fedele Lampertico e l’Italia liberale, Franco Angeli, Milano 1992. Ricordiamo inoltre che proprio a margine di quel convegno prese corpo il progetto di pubblicazione del Carteggio Lampertico conservato presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza. Nel momento in cui licenziamo queste note, hanno visto alla luce i primi due volumi dei quattro previsti dal piano dell’opera: Fedele Lampertico. Carteggi e diari 1842-1906, I (A-E), a cura di E. Franzina, Marsilio, Venezia 1996, e II (F-L), a cura di R. Camurri, Marsilio, Venezia 1998; il terzo (M-S) a cura di R. Camurri e G. L. Fontana è di imminente pubblicazione. 13 Si veda a tal proposito P. Pombeni, Fedele Lampertico e la scienza politica dei moderati. Note di lettura, in La scienza moderata cit., pp. 287-307. 14 R. Ruffilli, Aspetti del rapporto tra Stato e società nell’età liberale, in La trasformazione politica nell’Europa liberale cit., p. 52. 15 Cfr. V. Gioia, Conservazione e cambiamento nel liberalismo «possibile» di Fedele Lampertico, in Gli economisti in Parlamento 1861-1922. Una storia dell’economia politica dell’Italia liberale, II, a cura di M. M. Augello e M. E. L. Guidi, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 179-203; M. E. L. Guidi, «Un mondo nuovo». L’Economia dei popoli e degli Stati di Fedele Lampertico, in L’economia divulgata. Stili e percorsi italiani (1840-1922), a cura di M. M. Augello e M. E. L. Guidi, I, Manuali e trattati, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 161-202; e da ultimo A. Sensales, Fedele Lampertico. Economia, popolo e Stato nell’Italia liberale, Manni, Lecce 2011. 80 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 81 Il moderatismo riformatore di Fedele Lampertico critica della sua produzione di grande erudito16. Si segnalano inoltre due interessanti carteggi con altrettante figure rilevanti della classe dirigente veneta del secondo Ottocento quali Paolo Lioy17 e Luigi Luzzatti18. Una citazione a parte meritano gli studi che sulla scia del lavoro avviato sul carteggio lampertichiano hanno indagato la dimensione informale (o non istituzionale) della sua attività pubblica. Mi riferisco in particolare alle ricerche che hanno analizzato la vasta e articolata attività di Lampertico come notabile dell’Italia liberale19. Personalmente, in diverse occasioni mi sono soffermato su questo tema. All’interno di un più ampio lavoro che sto conducendo sulla questione del notabilato in età liberale, e proprio partendo dal casoLampertico, ho tentato di mettere a punto un modello interpretativo adatto a decifrare su scala nazionale il funzionamento dei circuiti di potere notabilare e la persistenza nel tempo di questi meccanismi20. Il senatore vicentino si configura come modello del «grande notabile»: l’aggettivo serve in effetti a individuare una precisa categoria di notabile le cui funzioni nei processi di regolamentazione della legittimazione politica in età liberale vanno (ben) oltre quelli a suo tempo attribuiti da Gaetano Mosca alla figura del «grande elettore» ed essenzialmente circoscritti al controllo del mercato elettorale21. Al contrario, notabili come Lampertico agiscono contestualmente su più piani, quello delle reti clientelari di vario tipo, quello scientifico-culturale e quello politico-istituzionale a livello periferico e centrale. La dimensione della sfera privata non può, quindi, mai essere separata da quella pubblica. Paradossalmente, in questa nuova stagione di studi dedicati a Lampertico è ancora rimasta in ombra la sua attività istituzionale e parlamentare di senatore del Regno che invece costituisce il cuore della sua 16 Ci riferiamo alla raccolta di testi lampertichiani introdotta e curata da E. Franzina, Vicentinerie di storia e varia cultura. Saggi e studi di Fedele Lampertico (1858-1906), 2 voll., Accademia Olimpica, Vicenza 2006. 17 Si veda C. Sari (a cura di), Politica, fede, cultura. Un dialogo intellettuale nel carteggio Lioy-Lampertico (1861-1905), prefazione di I. Crotti, Il Poligrafo, Padova 2010. 18 Ci si riferisce in questo caso al piuttosto scolastico lavoro di P. A. Passolunghi (a cura di), Carteggio Luigi-Luzzatti-Fedele Lampertico (1861-1905), Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2010. 19 Il primo a esplorare questa pista di ricerca fu E. Franzina, Le strutture elementari della clientela, in La scienza moderata cit., pp. 386 sgg. 20 Cfr. R. Camurri, Tra clientelismo e legittimazione del potere. Il notabilato veneto in età liberale, in Le Italie dei notabili. Il punto della situazione, a cura di L. Ponziani, Esi, Napoli 2000, pp. 73-112. 21 G. Mosca, Sulla teorica dei governi e sul regimi parlamentare. Studi storici e sociali, Loescher, Torino 1884, pp. 298-9. 81 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 82 Renato Camurri azione di uomo pubblico. Lo studio dell’attività parlamentare di un esponente di spicco del moderatismo italiano come fu Fedele Lampertico consente di affrontare una serie di grandi questioni che riguardano il funzionamento della sfera politica nell’età liberale. Pensiamo in primo luogo al nodo del funzionamento del Parlamento22, tema questo che si collega tanto a una serie di aspetti «tecnici» quali l’organizzazione dei lavori parlamentari, ovverosia i ritmi, le modalità e i riti legati alla discussione in aula, al lavoro delle commissioni, quanto ad altri di carattere politico, come l’estrema fluidità dei gruppi parlamentari, la frammentazione e il peso dei gruppi regionali entro la componente moderata. In secondo luogo il problema dell’organizzazione politica in campo extraparlamentare dei liberali italiani, i rapporti tra le diverse componenti della galassia liberale23; e in terzo luogo la questione dei rapporti tra il centro e la periferia del sistema politico liberale e il ruolo dei gruppi dirigenti regionali. Ma vediamo da vicino le tappe principali della carriera politica di Lampertico. Cominciamo col dire che essa si presenta divisa in due fasi ben distinte: la prima coincidente con l’esperienza di deputato, iniziata nel 1866 e interrotta nel 1870 dalle dimissioni, e la seconda che inizia nel 1873 con la nomina al seggio senatoriale conclusasi nel 1906 con le dimissioni presentate pochi mesi prima di morire. Il 25 novembre 1866 Lampertico è eletto deputato nel collegio di Vicenza, ottenendo una votazione plebiscitaria (82,7%). Analizziamo in primo luogo il contesto in cui avviene questa candidatura: la lettura incrociata delle cronache dei giornali, dei carteggi e dei documenti prefettizi ci fornisce il quadro di una situazione di grande confusione, caratterizzata dalla nascita di circoli e associazioni politiche – sia in campo moderato che in quello democratico – che si propongono come primitivi strumenti di organizzazione della rappresentanza politica e di coordinamento della competizione elettorale. Un osservatore esterno – fuori dai giochi per la sua collocazione politica – così descrive, in una lettera indirizzata al garibaldino Francesco Molon, la situazione: 22 Su questo tema di fondamentale importanza per la storia politica postunitaria mi sembrano molto chiare e pertinenti le osservazioni di F. Cammarano, Storia politica dell’Italia liberale 1861-1901, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 19 sgg. 23 Tra i pochi lavori che hanno affrontato questi aspetti dell’organizzazione in campo politico-parlamentare dei liberali italiani si veda H. Ullrich, Ragione di Stato e ragione di partito. Il «grande partito liberale» dall’Unità alla prima guerra mondiale, in G. Quagliarello, Il Partito politico nella belle époque. Il dibattito sulla forma-partito in Italia tra ’800 e ’900, Giuffrè, Milano 1990, pp. 107-91 e Id., L’organizzazione dei liberali italiani nel Parlamento e nel Paese (1870-1914), in Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del ’48 alla prima guerra mondiale, il Mulino, Bologna 1980, pp. 403-50. 82 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 83 Il moderatismo riformatore di Fedele Lampertico A Vicenza i clubs sorgono come i funghi, senza dirti di alcuno in particolare il complesso dà per risultato la Babilonia solita ove gente vecchia e nuova, d’azione e retrograda, audace e timida si dimena nel caos senza principi o scopi ben definiti. In ogni associazione più o meno vi si rimarcano questi mosaici, poco alla volta le acque si rischiarano, gli uomini emergono o sommergono, separandosi a strati secondo la loro gravità specifica; così credo per te sia meglio la tua momentanea assenza potendo farne buon uso di questi amalgami e delle cappelle altrui24. In effetti, l’immagine usata da chi scrive fotografa alla perfezione la situazione vicentina, dove nei mesi che precedono il voto si mettono in moto i meccanismi per la selezione della nuova classe politico-parlamentare. Ciò che caratterizza queste prime esperienze associative e, più in generale, il confronto politico, è l’assenza di significative differenze programmatiche tra i due grandi raggruppamenti risorgimentali della destra e della sinistra: prevalgono, al contrario, le forti affinità riscontrabili anche nello stesso linguaggio politico usato dai protagonisti della campagna elettorale. Suo malgrado Lampertico è costretto a farsi largo tra la folta schiera dei parvenu della politica che si affannano a cercare un posto al sole nelle nuove istituzioni rappresentative del neonato Regno d’Italia. Al cospetto di dilettanti allo sbaraglio di siffatta taglia, il profilo di Lampertico svetta per il prestigio che si è conquistato in due ambiti precisi: la lotta contro l’occupante austriaco e l’attività in campo culturale e scientifico. Si è a lungo insistito sul suo tiepido impegno per la causa dell’indipendenza e sulle dubbie posizioni occupate negli organismi amministrativi (consiglio comunale e provinciale) durante l’ultima fase della dominazione austriaca. Che l’indole del personaggio non fosse quella del combattente è fuori discussione; tuttavia la chiarezza delle sue posizioni emerse in almeno tre interventi piuttosto noti: nell’anonimo opuscolo Urgenza della Questione Veneta del 1864, in occasione della commemorazione di Valentino Pasini, pronunciata sempre nello stesso anno in un Teatro Olimpico gremito di folla, come recitano le cronache del tempo, e da ultimo nella Relazione di uno statista Veneto, testo che gli procurò un processo per alto tradimento da parte dei tribunali imperiali25. 24 Biblioteca Civica Bertoliana Vicenza (d’ora in avanti Bcbv), Carte Molon, lettera di Nigretto a Francesco Molon, 30 settembre 1866. 25 Si veda rispettivamente: F. Lampertico, Urgenza della Questione Veneta, Botta, Torino 1864; Id., Commemorazione funebre di Valentino Pasini letta nel Teatro Olimpico il 5 maggio 1864; Id., Relazione di uno statista Veneto ad un Ministro Austriaco, Antonelli, Venezia 1865. 83 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 84 Renato Camurri Circa il secondo ambito, quello più propriamente scientifico, l’allora trentatreenne poteva già vantare, come ha puntualmente messo in evidenza Emilio Franzina26, un curriculum di tutto rispetto: è datata 1865, ad esempio, la pubblicazione della sua prima opera di un certo peso dedicata a Giammaria Ortes27, ma tutti questi anni a cavallo dell’unificazione del Veneto sono caratterizzati da una produzione che spazia in vari campi, come si deduce da una rapida scorsa ad alcuni repertori bibliografici28. Non solo, ma il giovane Lampertico aveva ormai intrecciato una fitta rete di rapporti culturali con gli ambienti del moderatismo toscano (Gino Capponi, il Vieusseux, il Lambruschini) e con gli ambienti eruditi lombardi (Cesare Cantù). Sulla scorta di queste considerazioni possiamo affermare che l’ascesa politica di Lampertico avviene essenzialmente in virtù della sua fama e del prestigio sociale che sono – secondo la nota definizione di Max Weber – i tratti distintivi del notabile e gli elementi che determinano il tipo di obbligazione politica che regola il rapporto tra il notabile stesso e la sua comunità di appartenenza. Questi elementi spiegherebbero la scelta compiuta dalle consorterie locali di puntare su una figura come quella di Lampertico; scelta che prescindeva da un qualsiasi tipo di appartenenza politica, come dimostrerebbe anche la sostanziale assenza di una vera campagna elettorale nel caso della sua prima elezione. La neutralizzazione di ogni tipo di contrapposizione politica si può inoltre spiegare anche con il fatto che era diffusa nella cultura politica del tempo la consapevolezza di assumere, una volta eletti, la rappresentanza di tutti gli elettori del proprio collegio e non solo della propria «parte» politica, come confermano molti testi dei leader della destra storica29. Non a caso, del resto, questo tema occupa uno spazio centrale nel famoso pamphlet con il quale Lampertico presenta agli elettori il suo programma politico: Sui doveri del deputato30. Come hanno avuto modo in passato di sottolineare prima Silvio Lanaro e poi Paolo Pombeni31, questo testo è assai importante per capire il punto di partenza da cui muove il giovane Lampertico e anche Cfr. Fedele Lampertico. Carteggi e Diari 1842-1906, I (A-E) cit., pp. 3-13. Si veda F. Lampertico, Giammaria Ortes e la scienza economica al suo tempo, Antonelli, Venezia 1865. 28 Ci riferiamo a S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Tipografia Emiliana, Venezia 1907, II, guida indispensabile per orientarsi nella produzione lampertichiana. 29 Si veda Cammarano, Storia politica dell’Italia liberale cit., p. 37. 30 F. Lampertico, Sui doveri del deputato. Pensieri, Tipografia Paroni, Vicenza 1866. 31 Lanaro, Società e ideologie cit., pp. 114-20 e Pombeni, Fedele Lampertico e la scienza politica dei moderati cit., pp. 288 sgg. 26 27 84 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 85 Il moderatismo riformatore di Fedele Lampertico la sua successiva esperienza politico-parlamentare. Alludo non tanto al famoso passaggio in cui l’autore – riferendosi al modello inglese – annuncia che «ove così netta e spiccata in Italia fosse la divisione delle parti parlamentari non dubiterei a pormi tra i wighs»32, quanto piuttosto ai passaggi del testo dove egli dimostra che il livello di elaborazione, suo e delle figure emergenti del gruppo di comando del moderatismo veneto con cui era in stretto contatto (Messedaglia e Luzzatti tra tutti), era già sintonizzato su una serie di grandi questioni al centro della discussione europea che ruotava attorno all’esigenza di elaborare «una nuova scienza politica», capace di stabilizzare i regimi liberali, di potenziare in chiave moderna le strutture statuali e di affrontare la grande questione dell’allargamento della rappresentanza, vero tallone d’Achille dei governi in carica in quegli anni su scala continentale. Un passaggio tra i tanti mi sembra particolarmente significativo: Raggiunto così pressoché interamente il comune intento dell’indipendenza ed integrità nazionale, non hanno più una ragione di essere le divisioni parlamentari unicamente o quasi unicamente occasionate per la discrepanza delle opinioni sul modo di conseguirlo. Andranno adunque rimutandosi e ricomponendosi diversamente, non più pigliando esclusiva norma da quegli avvenimenti straordinari, per cui sorge una nazione, ma bensì da quegli eminenti principii, che ad una nazione, sorta che sia, posson dare prosperità e benessere. Noi soliti quindi a qualificare i deputati con nomi dell’una e dell’altra delle parti parlamentari dobbiamo rinunciarvi oggidì che queste assai probabilmente prenderanno nuovo aspetto e andamento […]. Meglio il dire i nostri pensieri sulla cosa pubblica così come sono in sé stessi, e fuori affatto delle passate o possibili combinazioni parlamentari. Così almeno verranno almeno giudicati per quello che sono, senza equivoco od ambiguità33. Segue l’indicazione delle riforme alle quali «del tutto sgombra l’Italia delle antiche cagioni d’inquietudine e di pericolo deve attendere seriamente». Tra queste il Lampertico indica al primo posto l’ammodernamento della pubblica amministrazione: «nell’amministrazione – scrive – è urgente l’indagine se troppi non sieno gli ufficiali pubblici» e propone «per quanto fosse possibile la diminuzione degli impieghi ed invece vorrei che fossero rimunerati bene»34. Le parole del giovane deputato sono molto chiare: egli indica chiaramente che una fase storica è finita con l’unificazione del Veneto al Regno d’Italia. La mia impressione è che lo sguardo di Lampertico in quel preciso momento storico fosse rivolto alle grandi sfide che attenCfr. Lampertico, Su doveri del deputato cit., p. 13. Ibid., pp. 3-4. 34 Ibid., p. 9. 32 33 85 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 86 Renato Camurri dono la giovane nazione italiana e le sue ancora deboli classi dirigenti. Se scegliamo questa prospettiva di analisi e non ci fermiamo, com’è stato spesso fatto in passato, a interpretazioni in chiave intimistica della sua esperienza di deputato, immancabilmente accompagnate dagli stereotipati ritratti del Lampertico-mammone, questa stessa esperienza può essere letta in una chiave diversa. Le sue titubanze e il fastidio per la vita parlamentare che traspaiono in alcune lettere inviate da Firenze alla madre, la sua indecisione rispetto alla posizione in cui collocarsi all’interno dell’emiciclo sono con tutta probabilità reazioni alimentate dalla percezione che quella Camera è «vecchia», è la rappresentazione di un sistema politico che deve essere superato. Illuminante risulta in questo senso una lettera alla madre del 14 dicembre 1866: Ti chiederanno in qual posto io sieda alla Camera. I posti vecchi […] erano già belli e occupati; i nuovi son disposti a destra o a sinistra, mi manca quindi il posto che meglio conveniva: il centro, cioè un posto in cui attendere […] quando si ricompongano i partiti […]. Limitata così la scelta, scema assai anche l’importanza del posto; ad ogni modo io con Alessandro Rossi abbiamo preso quei posti nuovi, che sono gli ultimi della destra accennando così alla sinistra. Se vuoi, ciò significa che non si combatte il ministero a patto che esso inizii le riforme necessarie; sarebbe un centro-destro. Come ti ripeto del resto, nell’attuale incertezza del modo in cui si ricostruiranno i partiti, il significato del posto è poco35. Il riferimento al centro36 è particolarmente significativo: veniva comunemente usato dai liberali continentali per indicare un nuovo spazio parlamentare da creare attraverso una confluenza delle componenti moderate dei due maggiori schieramenti. Questo riferimento e la necessità di una lettura dell’evoluzione-trasformazione delle società europee che solo le nuove scienze sociali potevano fornire costituiscono le due stelle polari alle quali Lampertico guardò aggiornando costantemente, e in modo originale, il suo bagaglio analitico. Il bilancio dei quattro anni trascorsi alla Camera – Lampertico fu rieletto nella tornata elettorale del marzo 1867, convocata in seguito alla sfiducia votata al governo Ricasoli sul disegno di legge per la liquidazione dell’asse ecclesiastico37 – non fu negativo. Il deputato vi35 Bcbv, Carte Lampertico, CL 1, lettera di Fedele Lampertico alla madre, Firenze 14 dicembre 1866. 36 Sulla tematica del centro politico cfr. Pombeni, Fedele Lampertico e la scienza politica dei moderati cit., p. 290 e A. Cardini, Il grande centro. I liberali italiani in una nazione senza Stato: il problema storico dell’«arretratezza politica» (1796-1996), Lacaita, Manduria 1996. 37 Cfr. P. L. Ballini, Le elezioni nella storia d’Italia dall’Unità al fascismo. Profilo storicostatistico, il Mulino, Bologna 1988, p. 65. 86 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 87 Il moderatismo riformatore di Fedele Lampertico centino s’impose all’attenzione dell’aula per alcuni importanti interventi, tra i quali si possono citare la relazione sull’inchiesta parlamentare per l’abolizione del corso forzoso (novembre 1868), quello sul progetto di legge per il riordino dell’amministrazione centrale e provinciale (dicembre 1868), oltre a vari interventi sui bilanci dei dicasteri delle Finanze e dell’Agricoltura e su alcune questioni d’interesse veneto. Fu questo, infatti, della Camera l’unico periodo della sua carriera parlamentare durante il quale Lampertico si occupò di difendere e tutelare gli interessi regionali. Il 7 marzo 1870, cogliendo tutti di sorpresa, Lampertico presentava le sue dimissioni suscitando numerose reazioni da parte dei colleghi della Camera e di altri esponenti del mondo politico. 3. Lampertico e il Senato regio. Tre anni più tardi, nel novembre del 1873, il notabile vicentino tornava sulla scena parlamentare: per diretto interessamento di Luzzatti e Minghetti veniva infatti nominato senatore. Prima di analizzarne l’attività, è opportuno soffermarsi brevemente sul funzionamento del Senato regio, non senza aver ricordato che le conoscenze della storiografia su questa istituzione sono ancora piuttosto limitate38. La Camera alta è stata poco studiata per il periodo liberale; eppure molte sono le questioni interessanti collegate al suo ruolo nella vita politica e istituzionale delle prime decadi dopo l’unificazione. Ad esempio, di particolare importanza risulta il capitolo riguardante i criteri di nomina dei senatori e il rapporto tra essi e i governi in carica, ai quali, in un’ottica di «scambio politico», fornivano solitamente uno stabile appoggio. Altro aspetto di grande rilevanza che emerge dai primi studi condotti sulla struttura della rappresentanza nel Senato regio riguarderebbe la sua politicità, elemento questo che sarebbe in contrasto con il carattere di «Camera di riflessione» o «Camera di contrappeso» che gli aveva attribuito Cavour. Del resto è sufficiente compiere un’analisi circa il numero di senatori nominati sulla base della terza categoria (degli ex deputati con tre legislature o sei anni si servizio), entro la quale si colloca una quota elevata di «politici di 38 Citiamo a questo riguardo i lavori di N. Antonetti, Gli invalidi della costituzione. Il Senato del regno 1848-1924, Laterza, Roma-Bari 1992, e M. E. Lanciotti, La riforma impossibile. Idee, discussioni e progetti sulla modifica del Senato regio e vitalizio (1848-1922), il Mulino, Bologna 1993, ai quali non mi risulta si siano negli ultimi anni aggiunti altri studi degni di nota. 87 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 88 Renato Camurri professione», per mandare in crisi la definizione di assemblea di «tecnici» con cui spesso impropriamente si è parlato del Senato regio. Circa invece l’organizzazione interna della Camera alta, va preventivamente ricordato che essa si divideva in 5 uffici, formati per estrazione a sorte, e nominava 3 commissioni permanenti. L’iniziativa legislativa partiva in misura preponderante dai banchi del governo, come si deduce dal computo dei disegni di legge presentati alla Camera tra il 1861 e il 189039. Al Senato il numero disegni di legge fu molto più basso; esso mantenne tuttavia una forte prerogativa di controllo della produzione legislativa, come dimostrerebbe il numero dei progetti di legge addottati da questa camera sul computo di quelli presentati dai governi in carica nello stesso periodo. Mentre il Senato ne approvò il 58,2%, alla Camera tale percentuale sale al 65,5%. Entro questa cornice possiamo dunque collocare l’attività parlamentare del senatore Lampertico. I dati fornitemi dall’Archivio storico del Senato offrono, nell’arco di tempo coincidente con la carica ricoperta dal notabile vicentino (dalla XI legislatura del 1873 alla XXII del 1905), un quadro molto interessante. Cominciamo intanto col dire che negli Atti del Senato sono riportati circa 240 interventi di vario tipo: relazioni di legge, petizioni urgenti, interventi nel dibattito, commemorazioni. Non è possibile fare riscontri comparativi con altri dati che misurano la «produttività» parlamentare. Dopo aver ricordato che i lavori parlamentari erano concentrati in poche sessioni annuali, possiamo invece tentare un’analisi qualitativa dei provvedimenti che videro protagonista Lampertico. Oltre a interventi «tecnici» sui bilanci dei ministeri, gli argomenti rispetto ai quali egli ha svolto un ruolo decisivo nell’iter legislativo sono stati, tra gli altri, i seguenti: la legge forestale (1874) di cui fu relatore, la legge sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso (1874), la legge sulle società e associazioni commerciali (1875), la legge sul giuramento parlamentare (1876), la legge per il riscatto delle ferrovie dell’Alta Italia (1876), la legge sull’inchiesta agraria (1877), la legge sulle disposizioni penali per abusi del clero (1877), la legge di modificazione dell’imposta sul macinato e per il riordino del dazio sugli zuccheri (1879), la legge per la riforma elettorale di cui fu anche relatore (1882), la legge sul trattato di commercio tra Italia e Germania (1882), la legge sulla creazione di una cassa nazionale per l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro (1886), la legge sul riordinamento dell’amministrazione dello Stato (1888), la legge per la 39 Cfr. i dati riportati in Cammarano, Storia politica dell’Italia liberale cit., p. 45. 88 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 89 Il moderatismo riformatore di Fedele Lampertico revisione del fondo per il culto (1888) di cui fu anche relatore, la legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza (1890), la legge sulle pensioni civili e militari (1893), la legge per il riordinamento degli istituti di emissione (1893), la legge di previsioni di spesa del ministero dei Lavori pubblici (1895), la legge per gli infortuni sul lavoro (1896) di cui anche in questo caso fu relatore, la legge sui monti di pietà (1898), la legge sul risanamento della circolazione bancaria (1898), la legge sull’emigrazione (1901) di cui fu relatore, la legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (1903). L’ultimo intervento in aula risale al 15 aprile del 1905, quando parlò in merito alla revisione del trattato di commercio e di navigazione tra Italia e Germania. Prima di entrare nel merito di una valutazione su questo plesso di leggi, è necessario premettere che: a) quando venne nominato era appena quarantenne, quindi «giovane» rispetto alla media dei senatori in carica ma, come abbiamo visto in precedenza, già pienamente maturo sul piano della produzione scientifica. Gli anni settanta coincisero, poi, con la stesura definitiva dell’Economia dei popoli e degli Stati40 e di molti altri lavori di notevole importanza, che rafforzarono la sua posizione in campo accademico, pur non avendo lui mai ricoperto alcun ruolo nell’università italiana; b) sul piano politico la seconda metà degli anni settanta fece registrare, in Italia e nel resto d’Europa, una serie di importanti trasformazioni sia sul piano degli assetti politici (pensiamo per l’Italia al passaggio dalla destra alla sinistra storica e la «svolta» trasformistica)41 sia su quello dell’elaborazione teorica nel campo della scienza politica e della dottrina costituzionale42. La riflessione lampertichiana e tutta la sua attività parlamentare vanno pertanto collocate entro questo sforzo di ammodernamento degli strumenti analitici compiuto dalle classi dirigenti liberali nelle ultime decadi del XIX secolo. Lo Statuto e il Senato, il testo che anticipava i risultati di un’apposita commissione istituita dalla Camera alta43, appare come il punto più alto44 del tentativo compiuto da Lampertico e dalla scienza politica moderata di adattare le istituzioni «alle necessità dei tempi e alle Si veda al riguardo Sensales, Fedele Lampertico cit., pp. 107-315. Sullo specifico ruolo svolto da Lampertico nell’ambito del dibattito che accompagnò e seguì la svolta trasformistica, mi permetto di rimandare alla mia introduzione a La scienza moderata cit., pp. 7 sgg. 42 Rimandiamo per queste problematiche a Pombeni (a cura di), La trasformazione politica nell’Europa liberale cit. 43 Sulla genesi della commissione cfr. Lanciotti, La riforma impossibile cit., pp. 152-77. 44 Sull’importanza di questo testo si veda Pombeni, Fedele Lampertico e la scienza politica dei moderati cit., pp. 298-307. 40 41 89 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 90 Renato Camurri nuove condizioni, che sono un portato nell’immenso lavorio intellettuale ed economico che ferve nel consorzio sociale»45. Ora, partendo da queste considerazioni preliminari, è possibile provare a definire il ruolo politico-istituzionale svolto dal senatore vicentino avanzando qualche ipotesi e anche qualche interrogativo: 1) è indubbio che il Senato risultò lo spazio di azione più congeniale per un uomo politico come Lampertico: l’attività svolta in quest’ambito si configura come un prolungamento della sua attività di studio, e basterebbe rileggersi alcuni carteggi con i funzionari della Biblioteca del Senato presenti nelle carte del senatore. 2) Come si può qualificare questo ruolo che supera quello strettamente parlamentare? È quello di un tecnico? Quello di un economistaparlamentare?46 O ancora quello di un civil servant47 proposto da Gabriella Gioli a proposito dell’attività parlamentare di Antonio Scialoja? Posto che non bisogna a tutti i costi tentare di classificare il comportamento del genere umano e che Lampertico non è certamente l’unico senatore dell’Italia liberale a svolgere un ruolo di questo genere, mi sembra, tuttavia, che il suo caso sia sintomatico e rappresenti un modo particolare entro l’esperienza parlamentare del liberalismo italiano di esercitare una leadership forte (senza alcun tratto autoritario e cesaristico alla Crispi), autorevole per le basi scientifiche da cui muovevano tutti gli interventi in aula e le leggi promosse, ma anche investita di un’auctoritas, di una delega non dichiarata a rappresentare un certo patrimonio culturale, una certa cultura politica, una certa idea delle istituzioni largamente condivisa nella galassia del liberalismo italiano. Se non ho letto male gli atti parlamentari, tranne qualche raro caso, nella discussione in aula non si verificò mai uno scontro con altri prestigiosi senatori. Si potrebbe evocare la figura del ministro ombra. Da un altro punto di vista, questo suo ruolo potrebbe essere paragonato a quello del portavoce studiato da Roger Chartier per la Francia settecentesca e rivoluzionaria: una figura che è detentrice del potere della parola che utilizza per delimitare l’esistenza di gruppi distinti, ma anche per mettere in collegamento il politico, il livello istituzionale, con l’opinione pubblica esterna alle istituzioni48. F. Lampertico, Lo Statuto e il Senato. Studio, Forzani, Roma 1886, p. 46. Si veda M. M. Augello - M. E. L. Guidi, Gli economisti parlamentari dell’Italia liberale tra scienza e politica, in Una storia dell’economia politica dell’Italia liberale cit., II, pp. XVII-LXIII. 47 G. Gioli, Commercio, finanza e istituti di emissione nell’attività parlamentare di Antonio Scialoja, ibid., pp. 1-30. 48 Cfr. R. Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Albin Michel, Paris 1988, p. 169. 45 46 90 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 91 Il moderatismo riformatore di Fedele Lampertico È un po’ quello che fa Lampertico nel suo lavoro parlamentare; ascolta, raccoglie pareri e suggerimenti. Proverbiale, come dimostrano i documenti conservati nel suo fondo, è il lavoro preparatorio che accompagna tutte le grandi leggi da lui proposte: una sorta di consultazione permanente con gli altri membri delle commissioni o con altri esperti49. Alla fine il senatore vicentino media, prepara accuratamente i passaggi parlamentari e produce la sintesi finale. Nella sua figura si mescolano le capacità relazionali tipiche del grande notabile e le competenze del moderno uomo politico. 49 Si veda, ad esempio, lo scambio epistolare con Bodio e Valenti relativamente ai profili statistici dell’elettorato nella fase di preparazione della riforma della legge elettorale del 1882. 91 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 92 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:33 Pagina 93 PENSARE LA NAZIONE La Grande guerra e la crisi della civiltà europea. Riflessioni del tempo di Giampietro Berti È ormai unanimemente riconosciuto che il XX secolo ha avuto il suo vero e significativo inizio con la Grande guerra. Fu questa a conferire al Novecento quel carattere così duro e tragico che segnerà gli avvenimenti successivi al 1918, in modo particolare l’avvento dei regimi totalitari, rossi e neri. Il totalitarismo, infatti, è figlio della guerra, anche se i suoi incunaboli esistevano precedentemente. Va sottolineato il nesso immediato che corre tra la catastrofe della civiltà europea, travolta, appunto, dalla guerra, e la nascita di visioni del mondo ad essa radicalmente contrapposte. Queste risultano in profondo contrasto con l’ethos razionalistico della società borghese e dunque, più in generale, della civiltà liberale. Come è stato scritto giustamente, «la critica […] al pensiero progressista era destinata a diventare uno dei punti di forza principali di tutti i movimenti antiliberali, di tutte le ideologie autoritarie e totalitarie soprattutto dopo la prima guerra mondiale»1. La forza d’urto dell’antirazionalismo e dell’irrazionalismo, sottovalutata ugualmente dal razionalismo liberale e dal riformismo socialista, «stava tutta nella combinazione ambivalente e quasi inestricabile di elementi tradizionalistici e innovatori, nel gioco combinato di bisogni reazionari e rivoluzionari che non potevano essere semplicisticamente commisurati allo schema “progresso o reazione”»2. Reazionari e rivoluzionari sono prima di tutto accomunati da un odio radicale contro l’individualismo liberale, additato come la causa ideologica della legittimazione di una società, quella borghese, pervasa dal senso del limite e interessata soltanto al prosaico benessere, e quindi del tutto avversa a concezioni «eroiche» ed «estreme» del vivere sociale. Una società, ricordiamolo, che appare insignificante soprattutto agli occhi di moltissimi intellettuali, da sempre alla perenne ricerca di un senso forte e trascendente della vita. 1 2 K. D. Bracher, Il Novecento. Secolo delle ideologie, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 30-1. Ibid., p. 31. 93 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 94 Giampietro Berti Un’inquietudine, questa degli intellettuali europei, già manifestatasi da tempo con la crisi generale del positivismo e l’affacciarsi di correnti culturali tese a porre la centralità di un soggettivismo del tutto insofferente ai dettami razionalistici. Pervase di irrazionalismo e di vitalismo, esse avevano accentuato il rifiuto di una visione ordinata e pacifica del progresso umano. Nell’ambito di questa svolta culturale – un passaggio che non è esagerato definire epocale – si delinea anche il tramonto di quella concezione deterministica che per certi versi assegnava, nello sviluppo della storia, un ruolo subalterno all’arbitrio dell’uomo. Il declino del positivismo fa emergere con forza una nuova fede prometeica nella capacità umana volta a piegare il destino a proprio vantaggio. Ciò che appare subito evidente, in altri termini, è il venir meno di un’identità e di un comune sentire. Un generale smarrimento che può essere icasticamente rappresentato dall’angoscioso antinichilismo di Rudolf Pannwitz, secondo cui «l’europeo è senza cosmo, senza legge, non statico e non etico. Questo è il fondamento originario di tutta [sua] la metafisica»3. Fu questo il vero «male oscuro» che pervase la cultura occidentale, perché esso fu qualcosa di più di un rifiuto del razionale; tale rifiuto proruppe, infatti, in un’ineffabile tensione rivolta verso un assoluto che non aveva nome, manifestandosi come un inquieto divenire privo di direzione. Si trattò di una tipica fenomenologia prodotta dagli effetti del disincanto del mondo. Di qui il rigetto tardo-romantico dell’istanza a-razionale di una volontà senza senso perché intrinsecamente smarrita, in quanto compiaciuta soltanto di se stessa. A questo proposito non si può dimenticare la risposta di Croce a questo generale smarrimento, risposta «incentrata su di un modello umanistico, razionalistico e cristiano dell’uomo quale essere storico e insieme “istituzione” trascendentale dello spirito»4. Ciò è confermato dalle sue celebri osservazioni riguardanti la storia europea: dopo la guerra francoprussiana si scatenò il darwinismo sociale, la lotta del più forte5. «La coscienza morale d’Europa era ammalata da quando il bismarckismo e l’industrialismo avevano foggiato un torbido stato d’animo»6. Sottolineò: «screditate erano le “idee” e gli “ideali” [perché] l’uomo si senti3 R. Pannwitz, Die Krisis der europäischen Kultur, H. Carl, Nürnberg 1917, p. 203, citato in R. Cristin, La filosofia come lingua europea, in E. Husserl, Crisi e rinascita della cultura europea [1935], a cura di R. Cristin, Marsilio, Venezia 1999, p. 22. 4 C. Marco, Libertà e liberalismo. Pensiero e politica della ragione in Occidente, introduzione di E. Nolte, Marco, Lungro di Cosenza 2004, p. 156. 5 B. Croce, Contrasti d’ideali politici dopo il 1870, in Id., Etica e politica, Laterza, Bari 1945, pp. 304-6. 6 Id., Storia d’Italia, Laterza, Bari 1928, p. 250. 94 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 95 La Grande guerra e la crisi della civiltà europea va attaccato ai fatti, sospinto dai fatti, ma depresso nel sentimento della libertà, arricchito di cognizioni e leggi scientifiche, privato della legge sua spirituale, preclusagli la conoscenza del significato e del valore della vita umana»7. La fenomenologia della crisi si manifestava dunque nel caotico insieme di una trasformazione priva di direzione e di senso, la cui forza distruttiva era contraddistinta dall’evidente mancanza di fini oggettivi capaci di fornire significato e intelligibilità per tutti gli esseri umani. Così, quando scoppiò la guerra, il conflitto fu salutato da molti intellettuali come una giusta catarsi che finalmente avrebbe liberato l’umanità dalla sua insulsa quotidianità pantofolaia, priva di slancio corale e negatrice di ogni immediata e personale affermazione di sé. Perciò non si insisterà mai abbastanza nel sottolineare la loro enorme responsabilità nell’apologia del conflitto, concepito come una sorta di supremo cimento volto al riscatto della decadenza borghese e foriero, allo stesso tempo, della nascita di un «uomo nuovo», senza il quale non si riteneva possibile realizzare grandi imprese collettive. Thomas Mann, Max Scheler, Sigmund Freud, Max Weber, Stefan George, Ernst Jünger, Henri Bergson, Georg Simmel, Émile Durkheim, Charles Péguy, Giovanni Gentile, Gabriele D’Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti – per citare solo alcuni tra i molti uomini di cultura del tempo che esaltarono l’escalation bellica – intravidero nella guerra, a vario titolo e con motivazioni diverse, una benefica svolta rigeneratrice8. Stefan Zweig ricorda che chi allora sostenne l’impresa militare ebbe la convinzione di «vivere un istante unico, nel quale ciascun individuo era chiamato a gettare nella grande massa ardente il suo io piccolo e meschino per purificarsi da ogni egoismo. In quel primo mettersi in marcia delle grandi masse c’era qualcosa di grandioso, di trascinante, di seducente perfino, cui era difficile sottrarsi»9. Émile Durkheim, notoriamente pacifista, dichiarò tutto il suo orgoglio perché «aveva suo figlio, suo genero e ben cinque nipoti sotto le armi»10. Thomas Mann percepì la guerra addirittura come «una visitazione divina». Scrisse: «guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora! Era la guerra di per se stessa ad entusiasmare i poeti, la Id., Storia d’Europa nel secolo decimonono, Laterza, Bari 1965, p. 227. Per quanto riguarda l’Italia si veda l’opera fondamentale di M. Isnenghi, Il mito della grande guerra, Laterza, Bari 1970 (e successive edizioni). 9 S. Zweig, Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo, A. Mondadori, Milano 1946, pp. 234-5. 10 M. A. Toscano, Trittico sulla guerra. Durkheim, Weber, Pareto, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 13. 7 8 95 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 96 Giampietro Berti guerra quale calamità, quale necessità morale. Era l’inaudito, potente passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una volontà, una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva conosciuto»11. Giovanni Gentile celebrò la guerra come «atto assoluto [dove], attraverso il dolore, l’anima umana si purifica e ascende ai suoi destini di realtà spirituale»12. Sigmund Freud affermò che il conflitto riportava la morte al centro dell’attenzione umana, per cui la vita aveva «ritrovato il suo contenuto» ed era «nuovamente divenuta interessante»13. Il tema della morte segna anche il pensiero di Max Weber: la guerra aveva generato «pathos», suscitando «una dedizione e un’incondizionata comunità del sacrificio fra i combattenti», fino a creare «il sentimento di una consacrazione della morte». Nel campo di battaglia l’individuo poteva «credere di sapere che muore “per” qualcosa»14. Max Scheler mise in rilievo la «radice vitale» della guerra con argomenti di tipo nietzschiano attinti alla filosofia della vita: «la vera radice di ogni guerra consiste in questo che nella vita stessa si trova una tendenza al rafforzamento, alla crescita, allo sviluppo. Tutto ciò che è morto o meccanico cerca solo di “conservarsi” mentre la vita o cresce o si spegne»15. L’esperienza della guerra vide anche Georg Simmel in un atteggiamento nazionalista. A suo giudizio il conflitto poneva gli uomini di fronte ad una «situazione assoluta», che esigeva una «decisione assoluta», liberandoli dal «compromesso» della vita quotidiana16. Perfino un pacifista libertario come Martin Buber cavalcò l’onda dell’entusiasmo per la guerra, nella convinzione che essa avrebbe unito gli ebrei in una causa trascendente17. 11 T. Mann, Pensieri di guerra, in Id., Scritti storici e politici, A. Mondadori, Milano 1957, p. 40. 12 G. Gentile, La filosofia della guerra, in Id., Guerra e fede, a cura di H. A. Cavallera, Le Lettere, Firenze 1989, pp. 7, 13. 13 S. Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e la morte, in Id., Opere, a cura di C. Musatti, Bollati Boringhieri, Torino 1976, VIII, pp. 137-9. Ernest Jones, uno dei suoi maggiori biografi, ricorda che il fondatore della psicoanalisi perse il controllo di sé: disse di sentirsi tedesco «per la prima volta in trent’anni […]. Sognò la distruzione di Parigi. Totalmente inebriato, non poté più pensare ad alcun lavoro». E. Jones, Vita e opere di Freud, II, Gli anni della maturità (1901-1919), Il Saggiatore, Milano 1962, p. 95. 14 M. Weber, Sociologia delle religioni, a cura di C. Sebastiani, Utet, Torino 1976, p. 597. Importanti osservazioni in D. Losurdo, La comunità, la morte e l’Occidente. Heidegger e l’ideologia della guerra, Bollati Boringhieri, Torino 1991, p. 17. 15 M. Scheler, Der Krieg und die geistigen Entscheidungen, Duncker & Humblot, Leipzig 1917, p. 20. 16 G. Simmel, Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg, Weißen Bücher, Leipzig 1915, citato in Losurdo, La comunità, la morte e l’Occidente cit., p. 13. 17 A. A. Cohen, Martin Buber and Judaism, in «Yearbook Leo Baeck Institute», XXV, 1980, pp. 287-9. 96 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 97 La Grande guerra e la crisi della civiltà europea In realtà la guerra, seminando morte e orrori come mai l’umanità aveva fino allora conosciuto (dal 1914 al 1918 morirono ogni giorno, in media, circa 1300 soldati, senza contare i civili: «l’inutile strage» la definì giustamente Benedetto XV), dimostrò non solo quanto fossero lontani dalla realtà i deliri di questi intellettuali, ma anche come essi avessero contribuito ad affossare una linea di progresso e di benessere portando l’umanità in una direzione tutt’altro che eroica ed estrema. Il conflitto, infatti, dimostrò l’insignificanza pratica dell’azione umana, sia individuale che collettiva, perché a deciderne le sorti furono ben altri fattori, rappresentatati soprattutto dalla potenza industriale. Si rileva la svolta epocale della storia mondiale scaturita dalla Grande guerra nella profonda mutazione subita dalla cultura europea dopo il 1918. Molto schematicamente, la fenomenologia del mutamento può essere delineata in questo modo: autonomia dei governi da ogni ispirazione cristiana; critica al paradigma del progresso universale, lineare e irreversibile; abbandono del cosmopolitismo umanitario; trapasso da un’antropologia ottimistica a una pessimistica; ripudio definitivo della concezione positivistica; affermazione di un romanticismo mistico e di un vitalismo irrazionalistico; culto della forza e della violenza. Soprattutto emerge l’ambiguità politica dell’idea di progresso perché questa può essere riassunta nella formula: progresso come libertà o progresso come potenza (cioè o guerra o sviluppo pacifico della conoscenza)18. Di qui il nesso strettissimo tra l’avvento della modernità e la guerra stessa. Attraverso il conflitto si palesa la natura ambivalente del moderno rappresentato, appunto, dal suo simbolo più emblematico, la macchina, la cui potenza può essere indifferentemente asservita a progetti benefici o malefici. Nel caso della guerra, la sua forza distruttiva e spersonalizzante si era dimostrata terrificante. Grazie all’industrialismo e alla coscrizione obbligatoria, ovvero grazie all’unione sinergica fra il capitalismo e lo Stato nazionale, si manifestò per cinque anni nei campi di battaglia una vera e propria apocalisse. A questo punto non possiamo non menzionare Oswald Spengler perché le sue riflessioni, anche se non sono direttamente originate dal conflitto bellico (è noto che Il tramonto dell’Occidente era già stato concepito, e in parte scritto, prima della guerra)19, esprimono emblematicamente il clima pessimistico del tempo. La crisi europea trova la sua espressione più tragica proprio in quest’opera, la quale porta all’estremo limite concettuale la Kulturkritik scaturita dal relativismo 18 19 R. Nisbet, History of Idea of Progress, Basic Books, New York 1980, pp. 179, 273. D. Conte, Introduzione a Spengler, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 10. 97 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 98 Giampietro Berti storicistico, dando inizio così, in modo aperto ed esplicito, alla tormentata riflessione sulla finis Europae. Finis Europae che, per l’appunto, nel pensiero spengleriano coincide emblematicamente con la fine dell’Occidente e della civiltà liberale. L’irreversibile decadenza europeo-occidentale è l’approdo ultimo e obbligato di un percorso già prestabilito, che nessuna contingenza, grande o piccola che sia, può minimamente scalfire; nemmeno l’immane conflitto bellico, quindi, è la causa di tale risultato. Lo schema esplicativo fondamentale del ciclo vitale che presiede alla nascita, allo sviluppo e alla fine di ogni civiltà si rinviene, per Spengler, nel rapporto necessitante tra Kultur e Zivilisation, ovvero tra civiltà e civilizzazione. Esse rappresentano, rispettivamente, la spinta vitale e lo stadio terminale, «il corpo vivo di un’anima e la sua mummia»20: è il divenuto che succede al divenire. La storia di una civiltà è la progressiva realizzazione di ciò che ad essa è possibile. Il suo compimento equivale alla sua fine. Ogni civiltà ha la sua civilizzazione, ovvero l’esaurimento della sua vita, il suo approdo definitivo: «la civilizzazione è l’inevitabile destino di una civiltà»; con essa termina la fase creativa e inizia l’«inversione di tutti i valori», segno indubitabile del tramonto. Il destino è la «direzione senza scelta di un’esistenza», per cui la vita va considerata come qualcosa di irrevocabile in ogni suo tratto, «come qualcosa di soggetto ad un fato»21; è «l’imposizione di una possibilità univoca che deve essere realizzata infallibilmente»22. Poiché la vita si ripete continuamente, essa risponde in un certo senso alla teoria nietzschiana dell’«eterno ritorno». La storia-destino ha uno sviluppo cieco e necessario e dunque, agli occhi umani, un carattere irrazionale perché è animata solo dalla logica dell’ineluttabilità; ogni sua manifestazione «vale in maniera assoluta per un singolo momento […], il suo apparire non è altro che l’incarnarsi del destino [medesimo], nella forma infallibilmente adeguata a tale momento»23. Il tardo e morboso romanticismo di Spengler, ricollegandosi alla linea Herder-Schlegel-Bachofen-Burckhardt, linea che si risolve poi nell’idea di crisi della civiltà anticipata da Rousseau-Schopenhauer20 O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale, Longanesi, Milano 1957, p. 548. Cfr. pure D. Conte, Catene di civiltà. Studi su Spengler, Esi, Napoli 1994, pp. 23-4. 21 Spengler, Il tramonto dell’Occidente cit., p. 203. 22 P. Rossi, Lo storicismo tedesco contemporaneo, Einaudi, Torino 1971, p. 404. 23 Ibid., p. 391; S. Caruso, La politica del destino. Irrazionalismo politico e relativismo storico nel pensiero di Oswald Spengler, Cultura, Firenze 1979. 98 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 99 La Grande guerra e la crisi della civiltà europea Nietzsche24, è quindi molto lontano dalla razionalità dello spirito assoluto di Hegel. Il destino spengleriano, intrecciando vita e storia, riduce quest’ultima alla sua originaria forma prestabilita, la quale consuma la sua logica senza alcuna vera autocoscienza di sé. La civilizzazione segna dunque il momento della fine dei valori, in modo particolare la fine dello spirito religioso. La stessa fase imperialistica della civiltà occidentale espressa dall’immane conflitto bellico non rappresenta, come potrebbe sembrare, un segno di forza, ma di debolezza, o, meglio, un segno di esaurimento. Nell’attuale imperialismo «bisogna sapere vedere il simbolo tipico di una fine. Ora, proprio tale forma è l’ineluttabile destino dell’Occidente»25. A partire da Spengler, sulla crisi dell’Europa come crisi dei regimi liberali e, più in generale, come crisi di civiltà, le testimonianze si sprecano. La conseguenza più rilevante del crollo del liberalismo si evidenzia nella mobilitazione attivistica delle masse, che spingono per una partecipazione democratica alla vita politica; una politicizzazione, tuttavia, che creerà le condizioni obiettive per l’avvento dei regimi totalitari. Siamo all’inizio di quella cesura che subito aprirà le porte all’insorgenza totalitaria, la quale trascinerà l’Europa nella catastrofe della seconda guerra mondiale. Illustriamo dunque brevemente le riflessioni critiche di alcuni pensatori del tempo, fra loro anche eterogenei, ma comunque convergenti sul giudizio riguardante la decadenza europea e, proprio per questo, testimoni significativi della svolta apertasi con il conflitto bellico. Per molti le sue cause sono rintracciabili nello sviluppo dilagante del sentimento nazionalistico in concomitanza con l’affermarsi dell’idea di potenza all’interno degli Stati nazionali, idea emersa in modo particolare dopo la guerra franco-prussiana. Per altri il conflitto appare un evento inevitabile, dato l’insopprimibile carattere bellicoso della natura umana. Per altri ancora, infine, si tratta dell’offuscarsi del sentimento cristiano e cosmopolita, che sta alla base dell’unità spirituale dell’Europa. In tutti i casi ciò che emerge con forza è il generale disorientamento che pervade le loro analisi e il sostanziale pessimismo per l’avvenire, come è documentato dal comune scetticismo relativo ai trattati di pace stilati a Versailles, potenzialmente forieri di una nuova guerra, come, in effetti, sarà. Molti, tra loro, constatano con amarezza la fine dell’eurocentrismo e l’avvento della supremazia americana. Conte, Introduzione a Spengler cit., pp. 51-2. Spengler, Il tramonto dell’Occidente cit., p. 85; D. Conte, La morfologia storica comparata di Oswald Spengler, in La storia comparata. Approcci e prospettive, a cura di P. Rossi, Il Saggiatore, Milano 1990, pp. 5-31. 24 25 99 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 100 Giampietro Berti Così Georges Sorel a Daniel Halévy: il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson vuole un regime di «plutocrazia demagogica. Il grande problema del XX secolo è di trovare un modo per moderare il potere dei mercanti». Gli americani tendono a imporre la vittoria del capitalismo nel mondo, prescrivendo i diritti umani e dei popoli all’Europa, mentre non sono disposti a riconoscerli e ad attivarli nel loro paese26. L’idea di voler punire il popolo tedesco è «una puerilità di politici desiderosi di trovare i mezzi per giustificare annessioni e indennità in nome della Giustizia»27. Questi concetti sono ripetuti anche nella corrispondenza con Benedetto Croce: «noi entriamo nel periodo più detestabile della decadenza: quello della plutocrazia all’americana»28. «Tutto è marcio in Europa. Le previsioni che si sarebbero potute fare ispirandosi a Vico e supponendo un vero ricorso eroico, non contano più. Quel che è più triste è la decadenza delle intelligenze»29. «La guerra non ha reso gli uomini più seri. In nessuna parte d’Europa c’è riforma intellettuale. Quale triste avvenire abbiamo davanti a noi!»30. Dello stesso tenore risultano i giudizi di Adriano Tilgher, secondo cui la guerra ha ridotto l’Europa a una «colonia anglosassone»31. L’Alleanza Atlantica per mezzo degli Stati Uniti, della Francia, dell’Inghilterra, del Belgio e del Portogallo domina ormai tutto il continente americano, tutta l’Africa, tutta l’Oceania, cioè è padrona del mondo. La politica di protezione delle piccole nazionalità è stata lo strumento attraverso il quale si è costituita «la più vasta egemonia che abbia curvato sotto il suo giogo il mondo». «Il cadavere insanguinato dell’Europa gli spinge sul volto il miasma della sua dissoluzione»32. Tutte le idee sulle quali l’Europa si dirigeva come su tante stelle polari sono finite e «nessuna nuova è sorta a prenderne il posto, il cielo si stende sui nostri capi vuoto e nero». La civiltà borghese «s’avvicina all’abisso ove il fato la chiama». È declinato non soltanto l’ethos democratico, ma pure la religione positiva, per cui la maggioranza degli uomini vive «come se Dio non fosse e tutto finisse con la morte». La storia dimostra che grandi ci26 Georges Sorel a Daniel Halévy, 16 ottobre 1917, in Lettres de Georges Sorel à Daniel Halévy (1907-1920), presentazione di M. Prat, in «Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle», 1994, 12, pp. 219-21. 27 Sorel a Benedetto Croce, 25 dicembre 1918, in G. Sorel, Lettere a Benedetto Croce, a cura di S. Onufrio, De Donato, Bari 1980, p. 273. 28 Georges Sorel a Benedetto Croce, 6 dicembre 1918, ibid., p. 271. 29 Georges Sorel a Benedetto Croce, 13 agosto 1920, ibid., p. 290. 30 Georges Sorel a Benedetto Croce, 8 luglio 1920, ibid., p. 292. 31 A. Tilgher, La crisi mondiale e saggi critici di marxismo e socialismo, Zanichelli, Bologna 1921, p. 43. 32 Ibid., p. 42. 100 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 101 La Grande guerra e la crisi della civiltà europea viltà sono crollate in un batter d’occhio per colpa della guerra; perciò viene smentita la credenza che le conquiste del progresso siano irreversibili. In conclusione, «la società capitalistica volge al tramonto»33. Il conflitto europeo è la logica conseguenza della politica praticata dai grandi Stati d’Europa dal 1870 al 1914, politica fondata sulla diplomazia segreta, sull’equilibrio delle potenze, sulla pace armata. L’unità spirituale europea fu sottoposta a continue centrifugazioni con il rafforzarsi delle varie nazionalità. Lo Stato nazionale si venne svincolando da ogni autorità superiore alla sua, «cioè tale da non aver bisogno se non di sé per esistere e per agire, si sentì assoluto e infinito». Questo assolutismo «proruppe irresistibile ed acquistò piena coscienza di sé durante la guerra mondiale»34. Per Tilgher Versailles è un trattato di pace «che dispone di milioni di uomini senza domandar loro il permesso, e che sulle rovine di un imperialismo ne consacra il trionfo di un altro di gran lunga più potente del primo, così porta in sé i germi di una nuova guerra». L’ideale democratico, riassunto nei 14 punti di Wilson, serve solo per mitigare la vendetta dei vincitori. Occorre attivare un punto di vista realistico e domandarsi: «da quando in qua si fa la guerra per instaurare la giustizia e la morale nel mondo»?35 La pace è soltanto la risultante di un equilibrio di forze, quindi mutevole e contingente. L’interesse è l’unica molla degli individui e degli Stati. Gli uomini agiscono, il più delle volte, spinti «dall’impulso oscuro e confuso, ma efficace, delle passioni». Chi sono stati i veri vincitori del conflitto bellico? Il nazionalismo e il bolscevismo. La crisi mondiale si risolverà, infatti, nel trionfo di due princìpi opposti, ma di fatto convergenti: il principio nazionalista e il principio rivoluzionario. E con ciò, come si vede, Tilgher anticipa, sia pur confusamente, l’avvento del fascismo destinato a imporsi a fianco del comunismo: «in Europa vi sono oggi, in realtà, due partiti soltanto: bolscevichi e antibolscevichi». I nazionalismi vinti o delusi tendono «a fare blocco contro l’internazionalismo socialistico delle plebi in rivolta»36. Secondo Vilfredo Pareto il mondo occidentale è giunto ormai alla fine di un ciclo storico: questo ha trovato il suo culmine con la guerra. Il conflitto, originato dal contrasto fra la plutocrazia demagogica (Francia, Inghilterra e Stati Uniti) e la plutocrazia autoritaria (Austria e Germania), ha profondamente indebolito il quadro politico europeo Ibid., pp. 1, 13, 43, 114, 123, 117. Ibid., p. 68. 35 Ibid., pp. 25-6, 22. 36 Ibid., pp. 28, 72, 42. 33 34 101 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 102 Giampietro Berti perché le democrazie occidentali, distruggendo il militarismo tedesco, hanno finito con l’indebolire se stesse. Hanno infatti tolto ogni contrappeso conservatore alla pressione demagogica proveniente dal basso e rappresentata dalla lotta delle classi subalterne. Ne consegue, inevitabilmente, uno sviluppo dei regimi liberali in direzione autoritaria (è a partire da questa constatazione che Pareto cercherà di spiegare l’avvento del fascismo). In termini sociologici ciò significa che l’élite in ascesa verso il potere scalza quella che ancora lo detiene37; vale a dire, uscendo dalla terminologia paretiana, che la vecchia oligarchia conservatrice liberale sarà sostituita dall’avvento della piccola borghesia statale e delle professioni. È un tipico contraccolpo provocato dal conflitto, dato che la guerra – ogni guerra – è una potente causa di estinzione delle classi dominanti. Non si tratta, beninteso, di una svolta storica irreversibile, poiché la storia non segue una traiettoria prestabilita, non avendo scopo, né mete, essendo solo un eterno succedersi ciclico di forme sociali modellate dal vincolo fra i detentori del potere e la massa popolare38. Il suo processo si presenta come le onde del mare che si alzano e ricadono senza posa, secondo la sua nota e problematica concettualizzazione: «è tanto certo che la “storia non si ripete mai” identicamente quanto è certo che “si ripete sempre” in certe parti che possiamo dire principali»39. In tutti i casi, non vi sarà una risoluzione definitiva dei rapporti fra gli Stati perché il conflitto non si risolverà in una pace duratura. «Viene da ridere quando ci dicono che, ristabilito l’equilibrio europeo […], avremo una pace idilliaca»40. Nella ciclicità priva di senso della storia l’accento è posto sulla fase della disgregazione della civiltà che muore, non su quella positiva della nuova civiltà destinata a vivere. Pareto risulta più in sintonia con il pessimismo di Machiavelli che con il provvidenzialismo di Vico. La sua riflessione costituisce un significativo momento della dissoluzione dell’idea di progresso che attraversa tutta la cultura europea tra Otto e Novecento41. A giudizio di Guglielmo Ferrero la crisi dell’Europa ha trovato nella Grande guerra il suo momento cruciale perché questa ne costi37 V. Pareto, Trattato di sociologia generale, Barbera, Firenze 1975, parr. 2025-59, 217879, 2340-2341, 2386-87, 2392, 2480, 2553; H. S. Hughes, Coscienza e società. Storia delle idee in Europa dal 1890 al 1930, Einaudi, Torino 1967, p. 264. 38 Pareto, Trattato di sociologia generale cit., parr. 2166, 2330, 2352. 39 Ibid., par. 2410. 40 Id., Fatti e teorie, in Id., Scritti sociologici minori, a cura di G. Busino, Utet, Torino 1980, p. 641. 41 N. Bobbio, Pareto e il sistema sociale, Sansoni, Firenze 1973, p. 30. Cfr. pure Toscano, Trittico sulla guerra cit., pp. 123-84. 102 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 103 La Grande guerra e la crisi della civiltà europea tuisce la svolta decisiva, «un cataclisma storico»42. Da cinquant’anni «la civiltà occidentale s’è indebolita per la crescente confusione delle dottrine, dei costumi, delle classi, delle razze e dei popoli; per una specie di anarchia intellettuale e morale a cui nessuna istituzione o tradizione o dottrina ha resistito»43. Da tale gigantesco sommovimento è nato uno smarrimento generale e un vuoto pneumatico, una caduta generale di tutti i valori perché «un’epoca che accetta come equivalenti tutte le idee, finisce per non poter più pensare […]. Lo spirito umano, oggi, non ha più intorno a sé né resistenze né appoggi»44. L’eterna, latente e insuperabile precarietà della condizione umana, e dunque di ogni civiltà, affiora con evidenza negli esiti imprevedibili e incalcolabili conseguiti alla rottura della stabilità del XIX secolo: questo, che aveva avuto «il privilegio unico di godere insieme dell’ordine più perfetto e della più grande libertà», si è dissolto. Il suo ordine, «che pareva di bronzo», si è spezzato; e la sua libertà, «che sembrava immortale», ora agonizza45. Il mondo «si è capovolto. La faccia di tutte le cose è sfigurata. L’umanità non riconosce più se medesima»46. «Tutte le autorità sono cadute […], la libertà è morta insieme con il diritto divino»47. É lecito chiedersi: chi ha «assassinato la civiltà europea», chi ha provocato questa «immensa crisi storica»?48 È questo «l’enigma che occorre sciogliere»49. Il carattere epocale di questa svolta ha elementi di impressionante analogia con le cause della decadenza dell’impero romano. Il paradigma che Ferrero istituisce, in questa comparazione tra la decadenza di Roma e la decadenza dell’Europa, non si riferisce, naturalmente, ai contenuti storici dei due differenti eventi, ma all’interna logica che li ha mossi50. Come l’impero romano al III secolo, l’Europa si è trovata, specialmente dopo la guerra franco-prussiana del 1870, in analogo staG. Ferrero, La guerra europea. Studi e discorsi, Rava & C. Milano 1915, pp. 22, 77. Id., La rovina della civiltà antica, Athena, Milano 1926, pp. 38-40; cfr. pure Id., Ancient Rome and Modern America. A Comparative Study of Morals and Manners, G. P. Putnam’s sons-The Knickerbocker Press, New York-London 1914, pp. 91-6. 44 G. Ferrero, Discorsi ai sordi, Corbaccio, Milano 1925, pp. 13, 17. 45 Ibid., pp. 27-8. 46 Id., La vecchia Europa e la nuova. Saggi e discorsi, Treves, Milano 1918, p. 1. 47 Id., Memorie di un sovrano deposto, Treves, Milano 1920, p. 289. 48 Id., La vecchia Europa e la nuova cit., p. 5. 49 Id., Discorsi ai sordi cit., pp. 27-8. 50 Id., La rovina della civiltà antica cit., pp. 38-40. Cfr. pure G. Santonastaso, La notion de décadence chez les penseurs politiques de l’Italie au XXe siècle. Ferrero, Orlando, Pareto, Mosca, in Guglielmo Ferrero. Histoire et politique au XXe siècle, in «Revue européenne des sciences sociales-Cahiers Vilfredo Pareto», 1966, 9, pp. 63-82. Si vedano a questo proposito anche le osservazioni di D. Settembrini, Prefazione, a G. Ferrero, La rovina della civiltà antica, SugarCo, Milano 1988, pp. 7-24. 42 43 103 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 104 Giampietro Berti to di indebolimento interno e in tale condizione è sopravvenuta più tardi la guerra mondiale, i cui effetti sono stati la distruzione o la messa in discussione di tutti i princìpi di autorità o di legittimità che sostenevano il precedente ordine politico-sociale. Fondamentalmente erano due questi princìpi: «il diritto divino delle dinastie e la volontà del popolo nelle democrazie»; il mondo europeo sta dunque per trovarsi nuovamente senza un principio chiaro e preciso sulla base del quale riconoscere chi, e in che limiti, «ha il diritto di comandare e chi, in che limiti, ha il dovere di obbedire». In conclusione, la caduta del principio monarchico ha costituito «un avvenimento di formidabile importanza perché l’Europa rischia di nuovo, come nel terzo secolo, di trovarsi senza un principio di autorità»51. Il principio democratico e il principio monarchico, come «i due mezzi archi di un’ogiva», sostenendosi a vicenda, davano stabilità ed equilibrio a tutto il continente52. Dalla seconda metà dell’Ottocento, questo equilibrio si è via via dislocato nella coscienza europea in modo asimmetrico, nel senso che in alcuni paesi il principio democratico ha preso il sopravvento sul principio monarchico, mentre in altri non ha trionfato che in parte. Nasce da ciò «una interna ineguaglianza, tormentosa e continua ma diversa l’una dall’altra; perché in Europa la tradizione e l’autorità non hanno vinto e non hanno ceduto allo stesso modo». Ciò è evidente osservando le fondamentali caratteristiche delle tre maggiori nazioni che hanno partecipato al conflitto. In Germania, dove ancora il principio mistico dell’autorità era molto più forte che in qualsiasi altro paese, vi è stato un evidente squilibrio fra il mondo della cultura e quello della politica. Diverso è il caso della Francia e dell’Inghilterra che hanno mantenuto un equilibrio interno maggiore, per cui è giusto affermare che la guerra «non sarebbe scoppiata se il popolo tedesco fosse stato più savio»53. Tuttavia a queste ragioni che stanno a ridosso del conflitto occorre aggiungere quelle più profonde del nazionalismo e dell’idea di un progresso inteso come potenza; idee-forza molto più incisive di ogni sentimento internazionalistico e socialistico: una concezione del mondo presente in tutto il continente; perciò, in questo senso, le colpe tedesche vanno estese a tutte le nazioni entrate in guerra. L’industrialismo e la coscrizione obbligatoria, lo sviluppo economico e il dominio poFerrero, La rovina della civiltà antica (1926) cit., pp. 38-40, 168. Id., La democrazia in Italia. Studi e precisioni [1925], Rubbettino, Soveria Mannelli 2000, p. 36. 53 Id., La guerra europea cit., pp. 78-9, 91. 51 52 104 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 105 La Grande guerra e la crisi della civiltà europea litico, sono stati i «due ciclopi» generati dall’Ottocento54. Essi, sia pure in maniera diversa, hanno pervaso tutti gli Stati europei, pertanto le cause profonde del conflitto travalicano le immediate manifestazioni polemologiche dei loro partecipanti55. Ecco perché si può dire che «il secolo XIX incomincia a Waterloo e finisce alla Marna. Nasce e muore sopra un campo di battaglia»56. Ferrero ha piena e lucida consapevolezza che a Versailles non si giungerà a una vera pacificazione. La Germania non riconoscerà il trattato di pace come giusto e tassativo e tenderà perciò a metterlo in pratica solo «nella misura in cui sarà costretta dalla forza». Rabbiosa e fortissima sarà la volontà di rivincita da parte dei tedeschi perché alle amputazioni territoriali e alle taglie di guerra, «sono stati aggiunti anche il disarmo unilaterale e la sorveglianza»57. In conclusione, la guerra è terminata in un tragico groviglio di controsensi. Per molti versi l’analisi di Ferrero è accostabile a quella di Élie Halévy. Le cause della guerra furono sostanzialmente politico-culturali; precisamente, esse andavano rintracciate nel declino della centralità europea-occidentale e nel correlato processo di crisi che da Oriente si spostò progressivamente verso Occidente. Andavano rintracciate ancor più nella dialettica socialismo-nazionalismo, rivoluzione-guerra, come è dimostrato dal successo della rivoluzione russa. In questo senso si può dire che il socialismo, inteso nel suo complesso, presenta una strutturale ambivalenza perché è contemporaneamente pervaso da elementi autoritari e libertari58. Per Halévy in Europa non hanno vinto le forze che volevano la rivoluzione, ma quelle che volevano la guerra, cioè non ha vinto il socialismo ma il nazionalismo; basti pensare al caso della Germania. Quello che successe nel 1914 fu una guerra che, almeno provvisoriamente, relegò in secondo piano il pericolo rivoluzionario. «Da ciò possiamo concludere che, per quanto potenti fosseId., La vecchia Europa e la nuova cit., p. 242. Sul complesso giudizio di Ferrero relativo alle cause della prima guerra mondiale rimando alle esaurienti osservazioni di D. Cofrancesco, Tra conservazione e progresso (Guglielmo Ferrero dinanzi alla crisi di fine secolo e alla guerra mondiale), in Guglielmo Ferrero tra società e politica, a cura di R. Baldi, Ecig, Genova 1986, specialmente pp. 174-89. Cfr. pure D. Veneruso, Guglielmo Ferrero dall’ideologia alla scienza politica attraverso la storia. L’evoluzione del giudizio sulla prima guerra mondiale, ibid., pp. 281-96. 56 Ferrero, Discorsi ai sordi cit., p. 21. 57 Id., La tragedia della pace. Da Versailles alla Ruhr, Athena, Milano 1923, pp. 46, 89. 58 Cfr. G. Quagliariello, Introduzione a É. Halévy, L’era delle tirannie. Studi sul socialismo e la guerra [1938], Ideazione, Roma 1998, p. 28. L’interpretazione di Quagliariello è in contrasto con quelle di M. Chase, Elie É. Halévy. An Intellectual Biography, Columbia University Press, New York 1980, pp. 203-4 e M. Battini, Ripensando Halévy, in «Passato e presente», XV, 1997, 42, pp. 85-115. 54 55 105 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 106 Giampietro Berti ro le forze che operavano per la rivoluzione nell’Europa anteguerra, quelle che agivano in direzione della guerra lo erano ancor di più. Si potrebbe forse dire che la crisi mondiale non cominciò veramente nel 1914, ma nell’ottobre del 1912, con la prima guerra balcanica, e finì solamente nell’agosto del 1920, quando l’armata bolscevica fu sconfitta in Polonia. Da un capo all’altro, questa era stata una guerra di nazionalità, e la rivoluzione russa, «solvente» dell’imperialismo, si trovava ad aver agito non tanto a favore del comunismo o del socialismo, «ma dell’idea nazionale»59. Secondo Halévy la guerra provocò una generale statalizzazione della vita economica per tutte le nazioni impegnate nel conflitto. Il movimento operaio e socialista perse il suo afflato internazionalistico perché la guerra fece maturare in modo irreversibile la sua latente componente statalistica. In conclusione, comunismo, fascismo e nazismo nascono dalla statalizzazione imposta dal conflitto. La crisi europea e la crisi italiana si intrecciano nel pensiero di Francesco Saverio Nitti per il continuo parallelismo da lui operato fra queste due realtà. Emerge con forza, a suo giudizio, il significato del mancato incontro tra il liberalismo e la democrazia, tra la coscienza liberale e la coscienza nazionale, sullo sfondo dei rapporti ormai mondiali che condizionano gli Stati60. Nitti è l’uomo politico italiano che ha la maggior consapevolezza della necessità che il liberalismo si apra alle istanze democratiche, ma è anche colui che, pur pervaso da questa consapevolezza, fallisce nello scopo, come fallirà Giolitti con la sua illusione di assorbire all’interno dello Stato le forze antisistema, rosse e nere61. Il carattere drammatico della riflessione nittiana può essere compendiato nell’idea che la pace scaturita dall’evento bellico sarà preparatrice di un altro conflitto molto più tragico e devastante. L’Europa e con essa l’intero Occidente non riusciranno a evitare un’ulteriore guerra perché le cause del malessere europeo sono intrinseche al suo stesso sviluppo, sono, cioè, parte integrante della sua vita. Specialmente i vincitori, vale a dire i portatori della democrazia – in modo particolare Inghilterra e Francia –, non sembrano mossi da saggezza e moderazione, ma dalla vecchia logica dell’egoismo nazionale, tendente a ricostruire il nuovo ordine politico secondo i propri interessi. I trattati di pace firmati a Versailles sono 59 Halévy, L’era delle tirannie cit., pp. 255, 272. Cfr. pure R. Vivarelli, Elie Halévy e la Grande Guerra, in Id., Storia e storiografia. Approssimazioni per lo studio dell’età contemporanea, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2004, pp. 272-3. 60 F. S. Nitti, Bolscevismo, fascismo e democrazia, in Id., Scritti politici, II, Laterza, Bari 1961, p. 277. 61 C. Marco, La crisi della civiltà liberale, I, Nitti e la decadenza dell’Europa, prefazione di P. Craveri, introduzione di F. Grassi Orsini, Marco, Lungro di Cosenza 2010. 106 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 107 La Grande guerra e la crisi della civiltà europea ben diversi dallo spirito di equilibrio profuso un secolo prima nel Congresso di Vienna. Il nuovo principio di nazionalità, che dovrebbe essere fondato sulla vera autodeterminazione dei popoli, è pervaso da una logica di potenza che non tiene conto dell’effettiva situazione storica nella quale si trovano le popolazioni soggette ai nuovi mutamenti62. Nasce da qui il male che distruggerà l’Europa, vale a dire una diffusa incertezza, perché le nuove unità statali, scaturite dal collasso degli imperi austro-ungarico, russo e tedesco, sono prive di una vera legittimità; esse risultano deboli, essendo circondate da rivendicazioni e rivalse nazionalistiche di ogni tipo. Soprattutto la pace punitiva imposta dalla Francia alla Germania mostra per Nitti tutta la fragilità dei futuri rapporti internazionali. La pacificazione non è edificata sul terreno di un’intesa generale accettata senza riserve dai vinti e dai vincitori, perché condizionata da uno spirito vendicativo. A questo proposito Nitti ha piena e lucida consapevolezza che la Germania, alla lunga, si ribellerà al trattato di pace. Oltretutto, come non vedere che essa non sarà in grado di far fronte alle esorbitanti richieste delle riparazioni di guerra? Solo gli Stati Uniti potrebbero dare stabilità e sicurezza all’assetto internazionale, ma questo purtroppo non avverrà a causa dell’insorgente isolazionismo manifestatosi con la fine della presidenza Wilson. Anche Johan Huizinga formula un giudizio molto severo su Versailles, dove, a suo giudizio, i vincitori hanno ricostruito l’Europa con i criteri della «geometria descrittiva», cioè senza alcun senso storico. La Società delle nazioni, non avendo alcun potere, si è rivelata un deterrente privo di mezzi, dimostrandosi non la lega dei popoli, ma quella degli Stati. Per rifare la civiltà europea bisogna invece ritornare ai suoi valori universali e superare l’assolutismo nazionalistico, «maledizione del nostro secolo»63. Occorre sobrietà e senso del limite, cioè umanesimo, libertà, cosmopolitismo64. L’Europa si è avviata alla Grande guerra «sballottata come un’automobile sgangherata nelle mani di un conducente ubriaco», mossa da una crisi dovuta a «un processo morboso della civiltà»65. E sono stati proprio il nazionalismo e il militarismo che l’hanno portata a questa catastrofe. Il tema dell’intreccio fra umanesimo, libertà, cosmopolitismo, antinazionalismo si rinviene pure nella celebre Trahison des clercs, l’atto 62 F. S. Nitti, La disgregazione dell’Europa, in Id., Scritti politici, IV, Laterza, Bari 1962, p. 277. 63 J. Huizinga, Lo scempio del mondo, a cura di L. Villari, Rizzoli, Milano 2004, pp. 121, 123, 165. 64 Ibid., pp. 165-98. 65 Ibid., p. 102. 107 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 108 Giampietro Berti d’accusa di Julien Benda contro gli intellettuali europei, colpevoli di aver divinizzato lo Stato, la Patria, la Classe, enti che si presentano ormai come il vero Dio66. L’incoerenza di questi intellettuali è di coltivare la seguente contraddizione: esaltano contemporaneamente l’attaccamento al particolare e disprezzano il sentimento dell’universale. In tal modo si fanno portatori di un paradigma tipicamente totalitario, che consiste nel paradosso della perdita contemporanea dell’individualismo a favore del particolare, vale a dire nell’innalzamento totale del particolare a generale, come avviene, per l’appunto, con l’esaltazione totalitaria – o della classe o della nazione –, secondo i diversi orientamenti ideologici67. «La religione del particolare e il disprezzo dell’universale è un rovesciamento dei valori che caratterizza l’insegnamento del chierico moderno»68. La visione del mondo del «chierico moderno» deriva dal progressivo affermarsi del relativismo etico rispetto all’universalismo di segno cristiano, giusnaturalistico o illuministico; una tendenza, questa, iniziata con il romanticismo tedesco il quale, rivendicando il concetto di individualità e di diversità, sfocia inevitabilmente nel senso dell’instabilità e del mutamento di tutti i comportamenti umani e dunque, in sostanza, nel riconoscimento della supremazia del rapporto di forza rispetto a quello del diritto. Di qui la scomparsa dell’umanesimo. Tutta la filosofia contemporanea è debitrice di questa credenza, volta a respingere ogni idea di uomo intesa sub speciem aeternitatis. È questo lo scacco maggiore subito dalla civiltà liberale; una stroncatura, questa del liberalismo da parte di molti intellettuali, che «stupirà gli storici futuri»69. Solo un grande, esplicito ritorno all’intera tradizione culturale dell’Occidente, fondata sul valore della conoscenza in quanto tale, potrà salvare l’Europa (conoscere in quanto conoscere, come viene insegnato dalla filosofia greca). E qui non possiamo concludere queste brevi note senza richiamare una delle riflessioni più alte che hanno cercato di rispondere alla crisi della civiltà europea fra le due guerre, quella di Edmund Husserl; riflessione tra le più drammatiche, tra le più significative, tra le più profonde. Il senso tragico che pervade la sua consapevolezza circa il destino dell’Europa, e quello dell’intera civiltà occidentale, è ancora oggi una fonte di eccezionale decifrazione dei caratteri fondamentali del XX secolo. Nessuno più di lui ha delineato con straordinaria lucidità la logica di quel processo culturale caratterizzato dall’indissolubiJ. Benda, Il tradimento dei chierici, Libreria di scienze e lettere, Roma 1946, p. 34. Ibid., p. 62. 68 Ibid., p. 76. 69 Ibid., p. 80. 66 67 108 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 109 La Grande guerra e la crisi della civiltà europea le intreccio fra nichilismo e libertà che designa in modo ineluttabile l’avvento della modernità. Il pensiero filosofico di Husserl è centrale per capire le cause del crollo della società liberale di fronte alla barbarie totalitaria scaturita dal conflitto bellico, dato che il totalitarismo si configura quale risposta «religiosa» alla insignificanza del mondo generata dalla prosaicità dello spirito borghese. Egli ricorda innanzitutto che la guerra «ha mostrato l’impotenza e l’inautenticità di tutte le idee»70, per cui, per penetrare e superare il groviglio della crisi attuale è necessario tematizzare il problema della destituzione di senso provocata dal «cieco» sviluppo del razionalismo moderno. L’esclusività con cui, nella seconda metà del XIX secolo, la visione del mondo è stata determinata dallo sviluppo delle scienze esatte ha costituito la causa dell’allontanamento dai problemi decisivi e propri di un’umanità autentica. Di qui il rifiuto di tale pervasività da parte delle coscienze più inquiete, specialmente dopo che il conflitto ha mostrato fino in fondo tutta l’insignificanza della storia e il conseguente impasse dell’immanentismo. Di fronte alla catastrofe che incombe sull’Europa, la «scienza dei fatti» non ha più nulla da dire perché esclude per principio quei problemi che sono i più scottanti per l’esistenza umana nel suo complesso, la quale, perciò, «si sente in balia del destino; i problemi del senso o del non-senso, i problemi dell’uomo che deve liberamente scegliere, dell’uomo che è libero di plasmare razionalmente se stesso e il mondo che lo circonda»71. È indispensabile elaborare l’idea di un’Europa «in quanto teleologia storica» volta al perseguimento «di fini razionali infiniti, [onde] mostrare come il mondo europeo sia nato da idee razionali, cioè dallo spirito della filosofia». In tal modo la crisi può rivelarsi come un apparente fallimento del razionalismo perché la sua causa non sta nell’essenza del razionalismo stesso, «ma soltanto nella sua manifestazione esteriore, nel suo decadere a “naturalismo” e a “obiettivismo”»72. Questa idea di Europa intesa come «forma spirituale», come «teleologia storica di fini razionali infiniti», può rispondere – e qui Husserl sembra riprendere indirettamente le riflessioni di Benda – alla virulenza particolaristica dei nazionalismi, quali manifestazioni della rottura dell’unità europea. Solo un’Europa rinnovata può indicare la via di «un’etica universale» diretta a regolare «l’intera vita in 70 Edmund Husserl a Whintorp Bell, agosto 1920, in E. Husserl, L’idea di Europa. Cinque saggi sul rinnovamento, a cura di C. Sinigaglia, Raffaello Cortina, Milano 1999, p. X. 71 E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 1961, pp. 35-6. 72 Ibid., p. 358. 109 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 110 Giampietro Berti modo unitario»73. Nella lotta «tra la ragione ridestatasi e le potenze della realtà storica» è necessario rivendicare il diritto della riflessione filosofica di intervenire «nella concreta storicità dell’umanità» per conferirle una nuova spiritualità74. Parole, queste ultime, pronunciate nel 1934, che dimostrano come «la polemica con il nazismo» appaia del tutto «trasparente»75. Accennando alle tesi spengleriane, Husserl si domanda: «dobbiamo accettare il “tramonto dell’Occidente” come si trattasse di una fatalità, di un destino che ci sovrasta? Sarebbe un destino fatale se lo accettassimo passivamente […]. Ma questo non lo possono fare neppure coloro che lo annunciano»76. La crisi europea perciò ha solo due sbocchi: «il tramonto dell’Europa, nell’estraneazione rispetto al senso razionale della propria vita, oppure la [sua] rinascita dallo spirito della filosofia. Il maggior pericolo dell’Europa è la stanchezza. Combattiamo contro questo pericolo estremo […] in quella vigorosa disposizione d’animo che non teme nemmeno una lotta destinata a durare in eterno; allora dal fuoco soffocato della disperazione per la missione dell’Occidente, dalla cenere della grande stanchezza, rinascerà la fenice di una nuova interiorità di vita e di una nuova spiritualità, il primo annuncio di un grande e remoto futuro dell’umanità: perché soltanto lo spirito è immortale»77. L’umanità può vivere solo «nella libera costruzione della propria esistenza, della propria vita storica, in base alle idee della ragione, in base a compiti infiniti»78. Id., L’idea di Europa cit., p. 25. Losurdo, La comunità, la morte e l’Occidente cit., p. 72. 75 Ibid., p. 73. 76 Husserl, L’idea di Europa cit., p. 4. 77 Id., La crisi delle scienze europee cit., p. 358. 78 Ibid., p. 332. 73 74 110 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 111 PENSARE LA NAZIONE Alla scuola del fascismo: la Spagna dei primi anni venti e la marcia su Roma* di Giulia Albanese Nell’introduzione dell’ottobre 1922 a un libro lungamente meditato da Silvio Lanaro, quale España invertebrada, pubblicato nella prima edizione pochi mesi prima, l’intellettuale spagnolo José Ortega y Gasset scriveva: Al analizar el estado de disolución a que ha venido la sociedad española, encontramos algunos síntomas e ingredientes que no son exclusivo de nuesto país, sino tendencias generales hoy en toda las naciones europeas. […] Ciertamente que el tema – una anatomía de la Europa actual – es demasiado tentador para que un dia u otro no me rinda a la vuluptuosa faena de tratarlo. Habria entonces de expresar mi convicción de que las grandes naciones continentales transitan ahora el momento más grave de toda su historia1. La riflessione di Ortega y Gasset traeva origine dalla situazione spagnola degli anni venti, avendo però in mente una prospettiva europea, che nel corso degli anni successivi si sarebbe rivelata piuttosto rispondente all’evoluzione degli eventi. Quest’analisi, seguita alcuni anni dopo dal ben più noto saggio sulla ribellione delle masse, puntava il dito tanto sui particolarismi emersi nel paese, quanto sul potere e il ruolo delle masse, della nazione e della modernizzazione in Spagna e in Europa. Ortega y Gasset non era però il primo, nel mondo intellettuale e * La ricerca di cui presento qui un primo piccolo risultato non sarebbe stata possibile senza il sostegno di Silvio Lanaro, il quale mi ha dato, nel corso degli anni, la possibilità di svilupparla presso il dipartimento di Storia dell’Università di Padova. 1 «Analizzando lo stato di dissoluzione della società spagnola, incontriamo alcuni sintomi e ingredienti che non sono esclusivi del nostro paese, ma tendenze generali oggi in tutte le nazioni europee. […] Certamente questo tema – una anatomia dell’Europa attuale – è troppo allettante perché un giorno o l’altro non mi arrenda all’impegno voluttuoso di trattarlo. In quel caso dovrei dichiarare la mia convinzione che le grandi nazioni continentali attraversano il momento più grave della loro storia». J. Ortega y Gasset, España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos historicos, Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid 2006, pp. 14-5. 111 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 112 Giulia Albanese politico europeo, a vedere nella politica spagnola l’inizio di un’evoluzione, o di un’involuzione, che si stava diffondendo anche altrove. Nella primavera del 1921 anche Antonio Gramsci era arrivato a simili conclusioni proprio riflettendo sul caso spagnolo. L’intellettuale comunista affermava, nelle pagine del giornale «Ordine Nuovo»: Da tre anni la Spagna si dibatte in questa crisi: la libertà pubblica è sospesa ogni quindici giorni, la libertà personale è divenuta un mito, i sindacati operai funzionano in gran parte clandestinamente, la massa operaia è affamata ed esasperata, la grande massa della popolazione è ridotta in condizioni di salvatichezza e barbarie indescrivibili. E la crisi si accentua e si è arrivati all’attentato individuale. La Spagna è un paese esemplare. Essa rappresenta una fase che tutti i paesi dell’Europa occidentale attraverseranno se le condizioni economiche si manterranno come oggi, nelle stesse condizioni odierne…2. Le analisi di questi due intellettuali non erano però presenti nel dibattito pubblico dei due paesi nel momento in cui l’Italia realizzò la propria rottura definitiva con lo Stato liberale, con la marcia fascista su Roma dell’ottobre 1922, anche se l’ascesa al potere di Mussolini ebbe una grande e immediata eco in Europa, e nella stessa Spagna. Non ci furono, nella stampa italiana e spagnola, rimandi a queste analisi premonitrici neppure quando, ispirandosi piuttosto esplicitamente a Benito Mussolini, pur in un contesto piuttosto diverso, Primo de Rivera giunse al potere con un colpo di Stato militare nel 1923. In Spagna, come in tutta la penisola iberica, la marcia su Roma era stata oggetto di osservazione e riflessione – soprattutto dal mondo conservatore e dalla destra reazionaria – come una possibilità che apriva nuove prospettive politiche altrove e specialmente nei paesi dell’Europa meridionale. Certo, gli osservatori – tra i quali vanno ricordati almeno Ramiro de Maeztu, António Ferro e Homem Christo Filho – non sottovalutavano le differenze che la trasformazione politica avrebbe assunto, se realizzata, nel Regno di Spagna piuttosto che in quello italiano, e il diverso ruolo che avrebbero potuto svolgere in questo quadro soprattutto i militari; ciò nonostante molti sottolineavano l’importanza della lezione italiana per il contesto iberico3. Era in questo contesto, oltre che in una situazione di grande instabilità istituzionale e politica, che nel corso dell’estate 1923 fitte trattative diplomatiche si svolsero per organizzare una visita dei sovrani di 2 A. Gramsci, Italia e Spagna, in «L’Ordine Nuovo», 11 marzo 1921, ora pubblicato in Id., Sul fascismo, a cura di E. Santarelli, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 106. 3 Una riflessione su alcuni di questi articoli ho avuto modo di scriverla in Sguardi incrociati alle origini del fascismo: Italia, Spagna e Portogallo, in «Annale Irsifar 2009», Fascismi periferici. Nuove ricerche, 2010, pp. 25-33. 112 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 113 La Spagna dei primi anni venti e la marcia su Roma Spagna, Alfonso XIII e Vittoria Eugenia, sua moglie, a papa Pio XI e al re d’Italia Vittorio Emanuele III. Solenne fin dalla preparazione, la visita del re di Spagna aveva alcuni precisi obiettivi politici e religiosi di grande importanza non solo per i sovrani spagnoli, ma anche per quelli italiani, e per le loro rispettive nazioni4. Scopo principale del viaggio del sovrano spagnolo era di rafforzare, anche simbolicamente, il suo rapporto con il Papato in una fase complicata per il suo paese5. Questo obiettivo era sottolineato dalla solennità anche religiosa che Alfonso XIII aveva subito domandato che venisse attribuita alla visita, anche in risposta a chi nei mesi precedenti, in Parlamento, aveva chiesto con insistenza una maggiore autonomia dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, facendo temere ai cattolici più tradizionalisti una increspatura delle relazioni tra Stato e Chiesa6. La dittatura di Primo de Rivera era una risposta anche a queste tensioni, come lo era il viaggio italiano del sovrano. Alfonso XIII, inoltre, non aveva nascosto al nunzio apostolico a Madrid che tra le sue speranze vi era anche quella di agire per la soluzione del conflitto Stato-Chiesa in Italia, svolgendo un ruolo politico di mediazione. A questo proposito, egli aveva addirittura anticipato di voler fare dichiarazioni pubbliche in questa occasione, che però gli erano state nettamente sconsigliate7. Facendo riferimento a queste richieste, il nunzio apostolico a Lisbona aveva riferito, tra l’altro, in una 4 Sulle relazioni diplomatiche europee e in particolare i rapporti Italia-Spagna cfr. M. Mugnaini, Italia, Spagna e la formazione di un nuovo equilibrio mediterraneo (1923-1928), in «Spagna contemporanea», 1998, 14, pp. 53-77. Dello stesso autore si veda anche Le Spagne degli italiani. La «penisola pentagonale» tra politica internazionale e storiografia, Giuffrè, Milano 2002, in particolare pp. 29-54. Si veda inoltre G. Palomares Lerma, Mussolini y Primo de Rivera. Política exterior de dos dictadores, Eudema, Madrid 1989, pp. 40-2, 50-5, 61-3: l’autore indica chiaramente come il tema di un’alleanza mediterranea tra i due Stati sia all’ordine del giorno almeno fino al trattato del 1926. Sulle implicazioni politiche di questo viaggio nelle riflessioni socialiste si veda Coreografia italo-spagnola, in «Avanti!», 20 novembre 1923. 5 Sulla visita al papa in particolare si veda C. Adagio, Chiesa e nazione in Spagna. La dittatura di Primo de Rivera (1923-1930), Unicopli, Milano 2004, pp. 89-93. Per questa interpretazione della visita di Alfonso XIII e de Rivera si veda J. Moreno Luzón, Alfonso XIII. Un político en el trono, Marcial Pons Historia, Madrid 2003, in particolare p. 272. 6 J. L. Gómez Navarro, El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores, Cátedra, Madrid 1991, pp. 122-4. Il discorso di Alfonso XIII davanti al papa è riportato in Habla el Rey. Discursos de don Alfonso XIII, a cura di J. Gutiérrez-Ravé, Industrias gráficas Iruma-Ayala, Madrid 1955, pp. 248-52. 7 Archivio Segreto Vaticano (d’ora in poi Asv), Affari Ecclesiastici Straordinari (d’ora in poi Aes), Spagna, IV periodo, pos. 670-671, fasc. 60 (1923-1925), il nunzio apostolico al segretario di Stato Pietro Gasparri, 26 ottobre 1923. Il nunzio scriveva: «Tante volte, prima dell’avvento del fascismo al potere, mi aveva parlato di simile questione, ed io avevo sempre serbato silenzio, non vedendo la possibilità di discutere con un sovrano in cosa di cui egli era digiuno ed i cui criteri non coincidevano con quelli della Santa Sede e non ammettevano d’altra parte facile correzione. Anche questa volta tacqui sempre, e lo lasciai dire, supponendo che si trattasse anche ora di un pio desiderio di una mente fervida ed entusiasta. Ma, con mia 113 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 114 Giulia Albanese lettera a Pietro Gasparri, segretario di Stato vaticano, che l’interesse del sovrano spagnolo per la situazione italiana era una conseguenza soprattutto del nuovo regime instaurato in Italia e di una esplicita simpatia di Alfonso XIII per il fascismo. Per Mussolini la visita del sovrano spagnolo avveniva in un momento molto importante per la definizione di una nuova stagione nella collocazione internazionale dell’Italia. Nell’agosto 1923, infatti, in qualità di ministro degli Esteri, oltre che di presidente del Consiglio, il capo del fascismo aveva voluto enfatizzare il ruolo del paese nel Mediterraneo e la sua aspirazione a una politica di potenza, a danno in primo luogo della Grecia, attraverso l’occupazione militare di Corfù. Pretesto per avviare questa campagna era stata l’uccisione di vari membri della commissione internazionale per la definizione dei confini greco-albanesi, tra cui il presidente italiano Enrico Tellini. L’occupazione era stata tuttavia rapidamente revocata dal governo italiano grazie alle pressioni internazionali, ma non senza che Mussolini avesse minacciato l’abbandono della Società delle nazioni. Questa vicenda aveva comunque dato un saggio all’Europa e al mondo della scarsa considerazione di Mussolini per i principi di Versailles e per la Società delle nazioni, rivelando anche quale avrebbe potuto essere il tenore delle iniziative internazionali fasciste, una volta rafforzate le credenziali del regime8. La visita dei sovrani spagnoli si presentava in questo contesto come un’opportunità per proporre una possibile alleanza politico-militare, oltre che commerciale, tra Italia e Spagna, in un momento complicato nelle relazioni internazionali del paese e per reclamare inoltre un ulteriore ruolo da protagonista per la penisola nel Mediterraneo, area sulla quale si concentravano le ambizioni imperiali fasciste. In particolare, Mussolini sperava così di garantirsi la partecipazione alla conferenza di Tangeri di fine anno, nella quale si doveva risolvere il conflitto per il controllo del Marocco e a proposito della quale una eventuale partecisorpresa, vidi che chiuse il suo fervorino pro conciliazione dicendo d’essere ben lieto d’avermi parlato di questa questione, la cui felice soluzione costituisce suo affanno, e di aver ricevuto la mia approvazione. Dovetti perciò dichiarare, nel miglior modo che mi fu possibile, che la questione è riservata, come è noto, esclusivamente a Sua Santità, e perciò né io né altri si poteva dare approvazioni e suggerimenti». 8 La politica estera di quei giorni del fascismo con l’occupazione di Corfù conferma l’interpretazione di chi pensa a una discontinuità della politica estera fascista rispetto a quella liberale fin dagli anni venti; cfr. tra gli altri E. Collotti, Fascismo e politica di potenza. Politica estera 1922-1939, La Nuova Italia, Milano 2000, pp. 26-8. Per una disamina della crisi cfr. E. Di Nolfo, Mussolini e la politica estera italiana (1919-1933), Cedam, Padova 1960, pp. 79-98; R. Moscati, Gli esordi della politica estera fascista. Il periodo Contarini-Corfù, in A. Torre e altri, La politica estera italiana dal 1914 al 1943, Eri, Roma 1963, in particolare pp. 84-9; J. Barros, The Corfù Incident of 1923. Mussolini and the League of Nations, Princeton University Press, Princeton 1965. 114 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 115 La Spagna dei primi anni venti e la marcia su Roma pazione italiana non era considerata gradita né imprescindibile dalle potenze che fino a quel momento avevano controllato l’area9. Il colpo di Stato di Miguel Primo de Rivera, avvenuto a metà settembre 1923, pochi giorni prima del viaggio programmato dai reali spagnoli, aveva tuttavia messo a rischio la visita dei sovrani di Spagna. Al momento del golpe, era al governo una concentrazione liberale presieduta da Manuel García Prieto, giunta al potere con un vasto programma di riforme che andavano nella direzione di una maggiore democratizzazione attraverso la riforma agraria e fiscale, la messa in discussione della funzione e dell’efficacia dell’esercito in Marocco e del ruolo della Chiesa cattolica come Chiesa di Stato10. Questo governo non era riuscito però ad attuare una politica coerente, e si era rapidamente guadagnato la ferma opposizione dell’esercito, della Chiesa, della monarchia e della borghesia industriale oltre che quella dei partiti della destra spagnola11. All’inizio di settembre, a causa delle crescenti difficoltà militari in Marocco, la crisi di governo era quindi diventata inevitabile e definitiva. E in quel contesto era stato avviato il colpo di Stato militare. Gli ultimi momenti prima del passaggio all’azione dei militari furono piuttosto concitati e non privi di qualche imprevisto. Primo de Rivera, comandante generale della regione catalana, stava da tempo organizzando un colpo di Stato e si era coordinato nei mesi precedenti con diversi gruppi militari nel paese. Appena venuto a conoscenza della crisi, era partito per Madrid dove un gruppo di generali conosciuto come «il quadrilatero» stava tramando contro il governo, per verificare le possibilità di realizzazione del golpe. De Rivera aveva portato a Madrid la certezza dell’appoggio di una parte della borghesia catalana che sperava, attraverso di lui, di ottenere il ritorno alla pace civile, e un governo non ostile al particolarismo catalano12. Anche grazie a questo, egli era stato individuato come guida del movimento militare che avrebbe dovuto sollevarsi il 14 settembre. 9 Sulla politica mediterranea dell’Italia fascista, ma senza riferimenti ai rapporti con la Spagna, si veda Collotti, Fascismo e politica di potenza cit.; Di Nolfo, Mussolini e la politica estera italiana cit., p. 98. Lo scambio di comunicazioni diplomatiche su questo tema è riprodotto in Ministero Affari Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, I documenti diplomatici italiani (d’ora in poi Ddi), s. VII, II, 27 aprile 1923-22 febbraio 1924, La libreria dello Stato, Roma 1955; III, 23 febbraio 1924-14 maggio 1925, La libreria dello Stato, Roma 1959, passim. 10 Cfr. F. J. Romero Salvadó, The Foundations of Civil War. Revolution, Social Conflict and Reaction in Liberal Spain 1916-1923, Routledge, New York 2008, pp. 269-94. 11 Sull’azione di questo governo si vedano anche J. Tusell Gómez, Radiografía de un golpe de estado. El ascenso al poder del general Primo de Rivera, Alianza Editorial, Madrid 1987, pp. 15-28; M. T. González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera El Directorio Militar, Ediciones El Arquero, Madrid 1988, pp. 21-53. 12 González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera cit., p. 61; J. Termes, Història del catalanisme fins al 1923, Pòrtic, Barcelona 2000, pp. 783-4. 115 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 116 Giulia Albanese L’occasione per l’insurrezione e il golpe si presentò però prima del previsto: l’11 settembre, giorno in cui si celebrava il giorno della nazione catalana, nel corso di una manifestazione catalanista era stata fatta la richiesta di una maggiore autonomia; contemporaneamente furono cantati motivi antispagnoli e alcuni addirittura evocarono la solidarietà per i ribelli del Rif, che lottavano per la loro autonomia dalla potenza colonizzatrice in Marocco. Gli scontri che si verificarono in quei giorni a Barcellona provocarono trenta feriti. Le manifestazioni filocatalane contribuirono ad accendere gli animi e a convincere in favore del colpo di Stato il mondo militare centralista e centralizzatore, oltre che nazionalista, impegnato in quell’occasione nell’ordine pubblico e a disagio per la scarsa prestazione coloniale dell’esercito negli ultimi mesi in Marocco. Così, anticipando il colpo di Stato preparato da tempo, Miguel Primo de Rivera era passato all’azione13. Quello stesso giorno il governo veniva ufficialmente a conoscenza dell’avvio di un golpe senza riuscire però a prendere alcuna decisione in proposito, ma informandone il sovrano che in quel momento si trovava a San Sebastián in villeggiatura. Contestualmente l’esecutivo aveva provato a mandare un telegramma a de Rivera nella speranza di riportarlo a più miti consigli (come se un telegramma potesse riportare all’ordine un generale che stava da tempo pianificando un progetto eversivo contro il governo)14. Nel frattempo tuttavia a Madrid i preparativi per il colpo di Stato non stavano andando bene come i congiurati avevano pensato, e alcuni uomini erano in viaggio per Barcellona per informare Primo de Rivera, passando per Saragozza allo scopo di verificare quale fosse la situazione in quella città e scoprendo che tutto era fermo anche lì15. Il governo si era poi riunito nuovamente il 12 settembre senza riuscire a definire alcuna misura energica contro il movimento in atto, mentre Primo de Rivera, malgrado le notizie provenienti da Madrid, perseguiva con determinazione nei suoi propositi16. Questa determinazione era stata ribadita anche quando il ministro della Guerra, il generale Aizpuru, gli aveva esplicitamente domandato di interrompere il piano17. 13 Sull’occasione che genera il colpo di Stato cfr. A. Quiroga, Making Spaniards. Primo de Rivera and the Nationalization of Masses, 1923-30, Palgrave Macmillan, BasingstokeNew York 2007, pp. 32-3. 14 González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera cit., p. 65. 15 Cfr. Tusell Gómez, Radiografía de un golpe de estado cit., pp. 153-5. 16 Ibid., pp. 156-65. 17 Per la corrispondenza diretta tra il ministro della Guerra e Primo de Rivera, ibid., pp. 165-72. 116 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 117 La Spagna dei primi anni venti e la marcia su Roma Il 13 settembre, all’alba, le guarnigioni della provincia di Catalogna dichiaravano lo stato d’assedio e la legge marziale e bloccavano le comunicazioni telefoniche, scalzando il governo civile, senza che vi fossero particolari scontri o tensioni. Fatti analoghi si verificarono anche a Saragozza e Huesca, e grazie al sostegno influente ricevuto dalle borghesie locali e dal mondo militare: neppure lì vi fu alcuna opposizione né da parte dei civili, né dei militari non precedentemente coinvolti18. Non bisogna pensare però che il 13 settembre i militari fossero tutti dalla parte di Primo de Rivera. Nel corso di quella stessa giornata, in attesa della risposta del re, al di fuori delle tre regioni che avevano avviato la sollevazione, l’appoggio militare era tutt’altro che assicurato e vi era anche chi stava pensando a una controsollevazione a favore dell’ordine costituzionale19. Tuttavia, all’interno dell’esercito, l’ostilità a prendere le armi per una guerra civile era forte, e una parte consistente stava aspettando di vedere cosa sarebbe successo, in attesa di una reazione politica agli eventi che non arrivò né dalla politica, né dalla società e neppure, soprattutto, dalla monarchia. Anche il governo attendeva il re per intraprendere una controffensiva che, al suo ritorno da San Sebastián, il 14 settembre, il sovrano si rifiutava però di avviare, determinando le dimissioni del governo di García Prieto20. Successivamente, rompendo la tradizione parlamentare che prevedeva la convocazione delle maggiori forze politiche di fronte a una crisi di governo, il sovrano incaricava il capo del colpo di Stato militare di divenire capo del governo. Miguel Primo de Rivera giungeva a Madrid il 15 settembre, dopo aver lasciato Barcellona da trionfatore e aver ricevuto ampi sostegni nel corso del suo viaggio fino alla capitale21. A Madrid era stato accolto da molti militari, tra i quali i generali del «quadrilatero». Dalla stazione di Atocha si era recato dapprima alla Capitanía General per incontrare i colleghi con i quali si produssero le prime tensioni, dal momento che questi ultimi non avevano previsto un governo militare o una rottura esplicita delle regole costituzionali, ma solo l’occasione per costringere il governo alle dimissioni. 18 S. Ben-Ami, Fascism from Above. The Dictatorship of Primo de Rivera in Spain, 19231930, Oxford University Press, Oxford 1983, pp. 54-5. 19 Ben-Ami, Fascism from Above cit., pp. 60-1. 20 González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera cit., pp. 72-3. Sulla mancanza di risposta da parte del governo cfr. anche Tusell Gómez, Radiografía de un golpe de estado cit., pp. 184-7. 21 Sul viaggio e le varie tappe di Primo de Rivera da Barcellona a Madrid, cfr. Tusell Gómez, Radiografía de un golpe de estado cit., pp. 242-4. 117 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 118 Giulia Albanese Primo de Rivera era in seguito giunto al ministero della Guerra, per poi essere ricevuto in udienza dal sovrano. Lì era stato deciso che avrebbe guidato un direttorio militare, dopo avere però giurato come presidente del Consiglio e mantenendo quindi una parvenza costituzionale al cambio di potere22. Il proposito di de Rivera, concordato con il sovrano, era comunque di esautorare completamente da ogni incarico la classe dirigente politica e procedere alla nomina di un direttorio militare provvisorio, che nelle intenzioni iniziali non sarebbe dovuto durare più di un mese. Anche qui, come in Italia, sotto una patina di legittimità istituzionale, si avviava una trasformazione profonda dell’assetto politico e istituzionale, che sarebbe continuata anche nei mesi successivi. Il generale proclamava quindi lo stato di guerra in tutte le città e in tutto il paese e i presupposti della dittatura militare erano immediatamente esplicitati. La scelta del re aveva contribuito a ridurre al minimo i conflitti e le possibilità di una reazione al colpo di Stato, e la sostanziale calma che era seguita aveva permesso di riprendere i piani precedenti senza preoccupazioni, tanto più che il golpe era risultato gradito – non inaspettatamente, visto l’esplicito sostegno monarchico al regime mussoliniano a cui abbiamo accennato sopra – al sovrano spagnolo ed era stato da lui immediatamente legittimato (oltre che probabilmente sostenuto in fase di preparazione)23. La situazione in Spagna all’indomani del colpo di Stato veniva considerata talmente tranquilla, per l’assenza di un’opposizione risoluta e credibile, che il sovrano aveva anche stabilito che Primo de Rivera avrebbe accompagnato lui e la regina in questa occasione ufficiale24. Tra gli oppositori, l’ex ministro Santiago Alba era andato immediatamente e volontariamente in esilio; un unico sciopero generale unitario era stato tentato a Bilbao, ma senza troppa determinazione, e il movimento socialista e operaio era così diviso sulla posizione da assumere che in alcune frange accettò perfino di collaborare con la dittatura25. I colloqui tra Spagna e Italia circa il carattere che avrebbe assunto il viaggio reale erano quindi ripresi nelle settimane immediatamente sucIbid., pp. 244-53. Su questo si veda González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera cit., p. 63 e BenAmi, Fascism from Above cit., p. 54. 24 Sull’accordo tra Alfonso XIII e Primo de Rivera nel corso della visita cfr. anche M. C. Hall, Alfonso XIII y el ocaso de la monarquía liberal 1902-1923, Alianza Editorial, Madrid 2005, pp. 367-8. 25 Quiroga, Making Spaniards cit., pp. 32-3. Per le reazioni socialiste cfr. P. Heywood, Marxism and the failure of organised Socialism in Spain 1879-1923, Cambridge University Press, Cambridge 1990. 22 23 118 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 119 La Spagna dei primi anni venti e la marcia su Roma cessive alla conquista del potere da parte di de Rivera e si erano fatti via via più intensi. Per de Rivera la visita costituiva un’ottima occasione per presentarsi all’estero, e guardare di persona, e da vicino, quel governo italiano cui – con il pieno sostegno di Alfonso XIII – si ispirava26. Nei primi giorni di governo, de Rivera aveva infatti sottolineato decisamente le analogie tra il regime da lui instaurato e quello mussoliniano affermando: trovo che la somiglianza e orientazione dei propositi dei due governi, decisi entrambi a mantenere i loro paesi in un ambiente di moralità austera e d’ordine severo, facilitano un accordo in tutti i sensi27. Stimolato da questo gradimento nei confronti del suo governo, Mussolini aveva quindi spinto sulla richiesta di un accordo commerciale e di navigazione tra i due paesi come presupposto della visita. Questo trattato avrebbe costituito infatti un importante banco di prova per verificare se la concordanza ideologica tra i due regimi potesse essere una base per formulare intese sia economiche che militari, dal momento che de Rivera aveva parlato, fin dai primi giorni dell’ascesa al potere, di un suo caloroso appoggio a un’eventuale alleanza italo-spagnola28. Con l’ambasciatore italiano, il dittatore spagnolo si era dichiarato «entusiasta» di questa possibile alleanza «che interpreta[va] suoi antichi intimi desideri»29. Sul conto di de Rivera, Mussolini era stato tuttavia più cauto, limitandosi a manifestare all’ambasciatore la sua «simpatia personale e politica» per il generale spagnolo. 26 Cfr. F. Sacchi, Il nuovo governo e l’Italia. Un’intervista con De Rivera, in «Corriere della Sera», 18 settembre 1923. Sul sostegno entusiastico di Alfonso XIII a Primo de Rivera, ma anche al fascismo, fondamentale è l’episodio notissimo in cui, appena arrivato in Italia e presentato ad alcuni fascisti, il re presenta a sua volta de Rivera come «il suo Mussolini»; cfr. Luzón, Alfonso XIII cit., in particolare p. 272, ma anche Coreografia italo-spagnola, in «Avanti!», 20 novembre 1923. Su questo tema si veda anche Ben-Ami, Fascism from Above cit., p. 71. 27 Ddi, s. VII, II, p. 287. 28 La sequenza dei dispacci tra Paulucci di Calboli e Mussolini è pubblicata in Ddi, s. VII, II, pp. 281-338. Cfr. in particolare Mussolini a Paulucci di Calboli, 17 settembre 1923, in Ddi, s. VII, II, p. 249. Non erano passati neppure cinque giorni dal colpo di Stato e la situazione spagnola era ancora molto incerta, ma Mussolini diceva all’ambasciatore: «È necessario che un conveniente trattato commercio preceda qualche giorno visita Alfonso XIII. Voglia se lo ritiene opportuno significare nella forma che VE crederà la più conveniente e appropriata che il governo fascista non sarebbe alieno dal considerare la possibilità di stabilire intese ordine politico militare con Spagna». Cfr. anche Palomares Lerma, Mussolini y Primo de Rivera cit., pp. 79-81 e J. Tusell Gómez - I. Saz Campos, Mussolini y Primo de Rivera: las relaciones políticas y diplomáticas de dos dictaduras mediterraneás, in Italia y la guerra civil española, a cura di M. Espadas Burgos, Csic, Madrid 1986. 29 Paulucci di Calboli a Mussolini, 10 ottobre 1923, in Ddi, s. VII, II, p. 281. Un accenno a questi trattati è presente anche in E. González Calleja, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930, Alianza Editorial, Madrid 2005, p. 123. 119 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 120 Giulia Albanese Le affinità tra il regime spagnolo appena instaurato e quello fascista venivano smorzate anche sull’organo di stampa del Partito nazionale fascista, di proprietà di Benito Mussolini, il «Popolo d’Italia», che nei giorni di instaurazione del direttorio militare in Spagna si era mantenuto molto cauto nella presentazione e nella valutazione degli avvenimenti. Due giorni dopo le espressioni di simpatia di Mussolini a Primo de Rivera, inoltre, il quotidiano fascista giudicava prematuro qualsiasi paragone tra i due regimi, criticando l’«Avanti!» per aver voluto enfatizzare indebitamente le somiglianze tra le due esperienze30. Il giornale di Mussolini si riservava infatti di capire meglio gli eventi spagnoli ed era piuttosto restio ad attribuire patenti di riconoscimento ad altri regimi e a possibili imitatori. La visita dei sovrani spagnoli e di Primo de Rivera, iniziata il 18 novembre 1923, diede, tuttavia, al capo del fascismo l’occasione per riconsiderare le sue posizioni iniziali, forse anche come segno di cortesia nei confronti degli ospiti iberici31. Con un discorso ufficiale a Palazzo Venezia, ampiamente ripreso sul «Popolo d’Italia», il 21 novembre 1923 Mussolini affermava: Quando, nel settembre scorso, noi avemmo notizie del vostro movimento, pensammo che pure essendo diverso il metodo corrispondente alla diversità del clima politico dei due paesi, l’obiettivo poteva considerarsi identico: liberare le forze vitali del popolo dall’influenza nefasta di dottrine politiche sorpassate e da uomini incapaci di assumersi la dura responsabilità del comando […]. Pure essendo il fascismo un fenomeno tipicamente italiano non vi è dubbio che taluni dei suoi postulati sono di ordine universale poiché molti paesi hanno sofferto e soffrono per la degenerazione dei sistemi democratici e liberali. L’amore della disciplina, il punto [sic] della bellezza e della forza, il coraggio della responsabilità, il disprezzo di tutti i luoghi comuni, la sete della realtà, l’amore pel popolo, ma senza cortigianerie grottesche, questi capisaldi della concezione fascista possono servire anche ad altri paesi32. Interessante notare come in Mussolini l’elemento nazionalista rimanesse più forte dell’esigenza di riconoscere l’impatto anche internazio30 A proposito di paragoni, in «Popolo d’Italia», 19 settembre 1923. L’articolo dell’«Avanti» è Coreografia italo-spagnola, 20 novembre 1923. 31 Cfr. il dispaccio di Benito Mussolini all’ambasciatore italiano a Madrid Raniero Paulucci di Calboli, 17 settembre 1923, in Ddi, s. VII, II, p. 249. 32 Una colazione a Palazzo Venezia offerta dal Presidente del Consiglio al generale De Rivera, in «Popolo d’Italia», 22 novembre 1923. De Rivera rispose dicendo che ciò che aveva fatto in Spagna era «qualcosa di simile a quello che Mussolini ha fatto in Italia cioè una comune opera di salvezza nazionale ispirata da identiche passioni per la patria. Se vi sono differenze, esse dipendono dall’ambiente diverso». Ulteriori dichiarazioni in questo senso, e sottolineando l’importanza e le «ripercussioni mondiali» del fascismo, in un articolo del giorno successivo; cfr. L’ammirazione di De Rivera per il Duce e per l’Italia fascista, ivi, 23 novembre 1923. 120 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 121 La Spagna dei primi anni venti e la marcia su Roma nale della rottura politica da lui operata, anche se non era possibile in quella sede – e forse neppure in assoluto – negare le affinità tra i due eventi. Nell’autunno 1923 sia Mussolini che de Rivera erano dotati di un potere provvisorio per la trasformazione e la riforma dello Stato, ma la libertà di movimento e la natura della rottura politica effettuata da Primo de Rivera erano, dal punto di vista legale e costituzionale, maggiori di quelle ottenute e realizzate da Mussolini, che in quel momento era a capo non – come de Rivera – di un governo militare al di fuori delle regole istituzionali, ma di un governo di coalizione con altre forze politiche. Non si conoscono, tra l’altro, dichiarazioni di Vittorio Emanuele III simili a quelle che Alfonso XIII rilasciava all’ambasciatore italiano a Madrid, di essere cioè egli «meravigliato molto di vedersi da quattro giorni re assoluto. Ma egli anelava tornare al più presto re costituzionale in un ambiente politico differente da quello in cui aveva regnato fino a ieri, ambiente più forte e più sano»33. Né, del resto, la situazione italiana avrebbe potuto giustificare una posizione del genere, malgrado il ruolo fondamentale che anche Vittorio Emanuele III aveva avuto nell’andata al potere di Mussolini34. In più, con l’affermazione di Primo de Rivera e del direttorio militare erano stati presi una serie di provvedimenti di carattere autoritario che non avevano eguali rispetto a quelli in vigore in Italia al momento dell’ascesa al potere di Mussolini. Tra questi bisogna ricordare almeno la dissoluzione del Parlamento, la censura preventiva della stampa, la sospensione delle garanzie costituzionali e del diritto di riunione, assemblea e libera espressione delle idee. Ciò nonostante, Mussolini appariva l’innovatore tra i due, quello che aveva avviato una trasformazione profonda dello Stato italiano e il più stabile al potere, e questo avveniva prima che in Italia fosse pubblicato il decreto sulla censura della stampa, prima delle leggi eccezionali e del Tribunale speciale, e quando solo la riforma elettorale, conosciuta con il nome di legge Acerbo, era entrata in vigore (il decreto sarebbe stato votato dal Senato il 14 novembre e sarebbe diventato legge proprio nei giorni della visita dei sovrani spagnoli)35. 33 Paulucci di Calboli a Mussolini, 18 settembre 1923, in Ddi, s. VII, II, p. 251. I discorsi di Alfonso XIII nel corso del viaggio sono riportati in Gutiérrez-Ravé, Habla el Rey cit., pp. 248-56. 34 Alcune osservazioni di notevole interesse in S. Lanaro, La monarchia, in Id., Retorica e politica. Alle origini dell’Italia contemporanea, Donzelli, Roma 2011, pp. 36-42. Per un’analisi sintetica si veda P. Colombo, Monarchia, in Dizionario del fascismo, a cura di V. De Grazia e S. Luzzatto, Einaudi, Torino 2003, II, pp. 149-53. 35 Cfr. A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino 1965, in particolare p. 38. Per un’analisi del primo anno di governo fascista e la bibliografia relativa, mi permetto di rimandare a G. Albanese, La marcia su Roma, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 173-203. 121 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 122 Giulia Albanese L’aspetto del fascismo che aveva senz’altro colpito di più l’attenzione di Primo de Rivera era stata la capacità di Mussolini di costituire un proprio esercito personale paramilitare e di averlo fatto riconoscere come una forza armata dello Stato: era, insomma, il radicamento e l’ampiezza di forze dello squadrismo prima, e della Milizia poi, a rendere innovativa agli occhi di de Rivera la «rivoluzione» di Mussolini; questo fenomeno indicava una strada da imitare, nonché un punto forte di contatto tra le due esperienze, come sottolineava esplicitamente de Rivera in un’intervista pubblicata sul «Corriere della Sera» a soli cinque giorni dal proprio colpo di Stato36. L’ascesa al potere di Mussolini e de Rivera, personaggi così diversi sia dal punto di vista della formazione che del contesto dal quale provenivano e da cui erano appoggiati, rendeva evidente, in Italia e in Spagna, e probabilmente anche nel resto dell’Europa, che qualcosa stava cambiando – o, piuttosto, era già definitivamente cambiato – nella gestione dell’ordine pubblico, nel rapporto tra potere politico e potere militare, tra violenza e società civile. Malgrado le grandi differenze tra i due colpi di Stato – al punto che, nel caso di Mussolini, neppure la definizione degli eventi che ne avevano segnato la conquista del potere era condivisa –, era evidente che entrambi i dittatori avevano potuto godere dell’appoggio di una parte consistente della classe dirigente politica (ed economica), che i governi in carica non erano riusciti a reagire neppure di fronte a evidenti prove dell’azione sovversiva in corso e che soprattutto si avvantaggiavano di una forte legittimazione monarchica: questi governi non rappresentavano, tuttavia, un ritorno all’antico regime o a una tradizione ormai scomparsa, ma l’ambizione di conciliare una nuova idea di politica con un blocco sociale solo in parte tradizionale. E in questo senso il fascismo sarebbe stato – e in parte lo era già, fin dall’andata al potere – assai più efficace del primoderrivismo. La lezione di questi avvenimenti, come anticipato da Ortega y Gasset e da Gramsci prima ancora che entrambi i regimi vedessero la luce, ma quando erano già presenti tutte le condizioni che li avrebbero generati, sarebbe stata presto accolta in altri paesi d’Europa. 36 F. Sacchi, Il nuovo governo e l’Italia. Un’intervista con De Rivera, in «Corriere della Sera», 18 settembre 1923. 122 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 123 PENSARE LA NAZIONE Gli italiani e il fascismo. Una testimonianza, un commento e… una dedica* di Mariuccia Salvati 1. Testimonianza, di Pfc. Dopo quattro mesi di corsi di italiano (mai avuto contatti prima con la lingua o la cultura italiane, eccetto che per la solita via della cultura umanistica) dell’Astp (Army Special Training Program – Programma speciale di formazione per l’esercito), ho passato 3 mesi qui con prigionieri italiani, per formarli a servire come battaglioni «co-belligeranti» di lavoro. Per quanto posso capire, la principale ragione di questi battaglioni è quella di disporre di una risorsa di lavoro a buon mercato. Naturalmente, può anche darsi che qualche liblabs di Washington nutra la mistica dell’«educare i fascisti alla democrazia», o altre simili sciocchezze, ma ho visto ben poco che possa supportare tali speranze. Tutto al contrario: i quadri americani tendono ad adattarsi fin troppo facilmente alle forme meno democratiche dell’esercito italiano (uso di soldati semplici per servizi agli ufficiali ecc.); e i soldati italiani, che in gran parte disprezzano i loro ufficiali e li sopportano solo nella misura in cui gli americani li difendono, protestano giustamente che ai loro ufficiali sono riservati indebiti favoritismi, per quanto riguarda la paga, privilegi ecc. Molti dicono che obbediscono ai loro ufficiali solo perché dietro di loro c’è l’ufficiale americano – e davvero, per mancato rispetto a un ufficiale italiano, un soldato semplice può essere rimandato indietro ai Campi per prigionieri di guerra. E se è vero che il nostro ufficiale comandante è estremamente restio a rimandare qualsiasi uomo al Campo di prigionia, è anche vero che è pronto a dedicare una quantità sproporzionata di attenzione a recuperare un «caso difficile» tra gli uf* Nel fascicolo di settembre 1944 (pp. 232-34) la rivista «politics. A Monthly Review», diretta da Dwight Macdonald, pubblicò, con il titolo Italians and Fascism: Testimony and Comment, la Testimonianza di un soldato (Pfc.) americano con il Commento di Nicola Chiaromonte. Pubblico qui la traduzione integrale di quei due testi, seguita da un mio commento in forma di dedica. 123 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 124 Mariuccia Salvati ficiali italiani – e quanto «difficili» siano alcuni di loro è forse noto solo ai soldati americani che parlano italiano… Ma quello di cui voglio scrivere sono soprattutto i contatti personali, non molti in realtà, che ho avuto con i prigionieri di qui. E devo confessare che, da un punto di vista progressista, non è per niente consolante parlare con loro o conoscerli. La piacevole personalità italiana, con il suo senso di dignità e di onore individuale, è altrettanto inadatta a conseguire un successo di prim’ordine nel mondo odierno quanto lo è la nazione italiana dal punto di vista economico per diventare la nazione di prima classe che Mussolini voleva che fosse. Sono troppo sentimentali, hanno un senso della giustizia troppo immediato e personale per il mondo in cui vivono – io e i miei amici ci deprimiamo tantissimo se paragoniamo le loro speranze e i loro sogni alla realtà che devono fronteggiare. Anche se collocati nel contesto latino di cinismo (da un punto di vista anglo-sassone) verso la politica e tutto ciò che concerne il denaro, ufficiali e soldati sono ancora alla ricerca di un buon padrone, anzi del Salvatore, anche se il profilo Cristiano cambia da uomo a uomo (questo è qualcosa che ho scoperto, non qualcosa che mi è stato detto di cercare nell’Astp). Non ho incontrato un solo ufficiale o soldato che trovi qualcosa di sbagliato in Mussolini prima del 1936 (a meno che abbia combattuto in Etiopia o in Spagna, e anche allora solo in termini di errore di giudizio – il punto di svolta essendo rappresentato dal momento in cui, dopo essersi scontrato con Eden, si è alleato con Hitler). Di fronte a un’osservazione da parte nostra del tipo: «Beh, naturalmente a noi sembra che voi avevate perso il controllo del vostro stesso governo, il problema cominciò allora», loro reagiscono con stupore, sembrano davvero non capire. Hanno una voglia così acritica di accettare ciò che sentono come il nostro «aiuto», sono così emotivamente e intellettualmente centrati sull’Italia come loro casa e famiglia. Uno dei giovani ufficiali più sensibili (uno per cui l’America è davvero la Terra Promessa) ha confidato timidamente – dopo che gli avevo chiesto di dirmi se Umberto era diverso dai suoi predecessori – «Oh – ma noi possiamo anche fare a meno di un Re, se voi ce lo chiedete!». Gli ufficiali di carriera sono molto delusi dal nostro trattamento di Badoglio, ma sono troppo educati e inoffensivi per confessarlo, forse lo farebbero solo con un soldato semplice. Secondo loro i Fascisti sono dei criminali, e Mussolini ha sbagliato sia nel mettere dei criminali nell’Esercito che nel non dare retta a Badoglio, che sembra sia davvero un buon generale, almeno tecnicamente. Quelli che non sono criminali non sono Fascisti (tutti concordano sul fatto che i Tedeschi sono dei criminali, e anche peggio). I soldati fir124 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 125 Gli italiani e il fascismo matari, come sono chiamati i prigionieri che firmano una carta per lavorare per l’US Army, sono estremamente ambigui nel definire che cos’è un Fascista: era la roba che firmavi per avere un lavoro e il pane: la confessione è invariabilmente accompagnata da un gesto eloquente che combina cinismo mondano e giustificazione. Il ragazzo che mi ha fatto da autista la scorsa notte (due medaglie in Nord Africa, ne ha rifiutata una Tedesca, è sotto le armi da 5 anni – nato nel 1917, come me) è stato operaio in fabbrica a Milano e ha fatto il servizio militare rinforzando la linea di fortificazioni lungo il confine austriaco. Attribuiva grande importanza alla chiusura, voluta da Mussolini, dei confini italiani, che aveva reso impossibile per gli operai cercare lavoro in Francia o in Svizzera. Così la sua critica almeno andava oltre quella, solita, della serie di disastrose avventure militari di Mussolini, il limite normale per questo tema. Ma politicamente che cosa pensava? Esattamente ciò che per tutta la sua vita gli era stato permesso di pensare: che il leader aveva commesso un errore, questo è tutto. Più errori ed è provato che è un cattivo leader. Troppa gente muore e il paese non diventa più ricco (nel 1936 sembra che tutti stessero meglio) – l’implicazione è che se il paese diventasse più ricco, anche la morte andrebbe bene. Beh, forse gli Alleati saranno di aiuto. Certo, i film di Hollywood sono pieni di promesse, e loro li guardano ogni sera. Ragazzo, questa è la vita! Tre mesi così e ti senti come se fossi nel fondo di un pozzo, un pozzo della storia. La luce del giorno sopra la testa è molto lontana. Come il tizio che io conosco della Marina Mercantile che ha raccolto il quadro di un antico Maestro vicino alle rovine del Museo di Napoli – l’ha tenuto troppo a lungo e ora ha paura che se lo restituisce gli toccano dei guai. E poi a chi dovrebbe restituirlo? Sorta di Prometeo frustrato. 2. Commento, di Nicola Chiaromonte. È con riluttanza che aggiungo una nota a questa lettera. Un commento scritto può così facilmente assomigliare a una discussione; invece con questo giovane soldato americano vorrei piuttosto avere una conversazione, porre delle domande, essere interrogato a mia volta. In ogni caso, penso che sarà contento se gli dico che a un italiano i pochi schizzi che egli tratteggia dell’atteggiamento di ufficiali e soldati italiani appaiono assolutamente realistici. Per esempio, io sarei molto sospettoso di qualsiasi testimonianza sull’esistenza di un numero considerevole di italiani che dichiarino che 125 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 126 Mariuccia Salvati la maggioranza di loro, o anche una larga minoranza, era consapevole che le loro disgrazie erano cominciate con il furto costituzionale dell’ottobre 1922. Disgrazie e maltrattamenti sono stati il destino della schiacciante maggioranza degli italiani a partire da una data ben più lontana. Inoltre, preso come gruppo, il popolo possiede un empirismo del vecchio genere san Tommaso che dubita: fino a che l’evidenza obiettiva non copre almeno la gran parte del campo di qualunque affermazione generale che essi possano sentire (del genere «Il Fascismo è male»), essi rimangono non convinti e, essendo non convinti, applicano il metodo raccomandato da Descartes nel campo della morale: si attengono provvisoriamente alle convenzioni esistenti. La sola scusa che hanno per essere così lenti è che, dopo tutto, loro (cioè, la maggioranza numerica di loro) sono sempre i primi a patire le conseguenze di qualsiasi cosa facciano o non facciano. Il che è più di quanto si possa dire della minoranza più sveglia. Ciò che voglio dire è questo: il 1936 fu davvero la prima data in cui il popolo italiano, nell’insieme, poté rendersi pienamente conto che il Fascismo era un affare maledettamente insensato. E questo per la semplice ragione che solo a quella data il Fascismo venne allo scoperto. Fin allora, per molti aspetti, si era dato da fare a ingannare e a confondere le idee il più possibile sfruttando soprattutto la disintegrazione delle ideologie opposte: il Fascismo era giustizia sociale e corporativismo, il Fascismo era vera libertà, il Fascismo era costruzione pacifica, il Fascismo era rispetto per il calpestato popolo italiano. Il Fascismo era tutto il possibile, e intanto era in realtà solo dedito a perseguitare una piccola minoranza di gente ostinatamente deduttiva, che aveva deciso che il Fascismo non poteva essere realisticamente buono perché le sue idee erano troppo distorte e i suoi metodi troppo corrotti. Tuttavia per la maggioranza, per quanto insoddisfatta a causa dell’atmosfera generalmente oppressiva e dell’impoverimento collettivo, anche se abilmente distribuito, questo genere di situazione non poteva fornire un quadro chiaro. E questo era soprattutto vero per coloro che erano stati bambini o adolescenti all’epoca della grande crisi politica, tra il 1919 e il 1924. Ma, nel 1935, il Fascismo si compromise in una maniera definitiva agli occhi della massa del popolo: ingaggiò la guerra. E non solo ingaggiò la guerra, ma lo fece sulla base della presunzione proclamata che la guerra avrebbe fornito la giustificazione completa di tutti i sacrifici passati, come pure la smagliante rivelazione di ciò che il Fascismo era realmente: gloria alla Nazione, terra ai contadini e profitto per ciascuno, senza distinzione di classe. E lo disse non perché Mussolini 126 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 127 Gli italiani e il fascismo amava la magniloquenza, ma perché era vero. Dal 1934 la guerra era diventata una necessità materiale per la dittatura, che altrimenti avrebbe dovuto sistemare i conti in casa, dove la gente stava diventando pericolosamente sospettosa. Con una certa dose di approssimazione, si potrebbe dire che il popolo italiano prese Mussolini in parola. D’accordo, quello sarebbe stato l’esperimento cruciale. E nel 1936 il significato della guerra era diventato perfettamente chiaro: era solo guerra per amore della guerra (e, presumibilmente, del Fascismo), nient’altro. Il contadino italiano vide il deserto di Dankal ed ebbe la prova completa e irrefutabile che coloro che l’avevano spinto fin lì erano degli idioti bestiali. Tra questi idioti bestiali c’era non solo Badoglio, il «generale tecnicamente bravo» così caro agli ufficiali di carriera italiani, ma il grosso delle classi alte e medie, che vedevano in Hailé Selassié il nemico ereditario e sinistro della nazione italiana e in Mussolini il vendicatore della bruciante vergogna di Adowa e – cosa ancora più elettrizzante – il grande genio che sfidava l’Impero britannico. Spinte da emozioni antico-romane, le loro mogli andarono all’Altare della Patria a sacrificare gli anelli nuziali, mentre loro, più sobriamente, discutevano di geopolitica e speravano per il meglio. C’era, è vero, qualche sfumatura di opinione più sottile tra di loro: come, per esempio, quella del senatore Albertini (un «gran liberale») che si oppose alla guerra d’Etiopia, ma approvò l’intervento Fascista in Spagna, perché era diretto contro il Bolscevismo. I risultati della convinzione definitiva raggiunta nel 1936 dal popolo italiano circa la natura non solo del Fascismo (che è un termine vago e ingannevole, uno dei molti termini ingannevoli correnti ai nostri tempi) ma della sua classe dirigente come pure della sua organizzazione di Stato, si sarebbe potuto osservare su larga scala durante tutta la guerra e infine nel gigantesco sciopero militare del giugno-luglio 1943, per non parlare di ciò che venne dopo. È da osservare che fu precisamente nel 1936, mentre il popolo italiano si stava rendendo chiaramente conto che il Fascismo era una bugia assassina, che le classi dirigenti d’Europa e di altri paesi cominciarono a muoversi sempre più freneticamente a sostegno di Mussolini, il «dittatore saggio». Ma questa è un’altra storia. Il punto che voglio sottolineare è questo: quando i prigionieri italiani spiegavano al soldato americano che i guai con Mussolini erano cominciati circa nel 1936, a me sembra che cercassero di trasmettere, sotto forma di opinioni personali sparse ed espresse vagamente, un fat127 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 128 Mariuccia Salvati to semplice e importante relativo alla loro storia sociale. Penso che sia più importante interpretarlo come tale piuttosto che prenderlo come un’opinione politica da esaminare alla luce dei generali principi della coscienza politica. È, tra le altre cose, il genere di fatto che i vari partiti antifascisti hanno tenacemente omesso di comprendere, precisamente perché non era «consolante» per loro, così come non è consolante ora per questo giovane americano. Quanto al resto, io non posso essere sicuro di ciò che era nella mente del giovane ufficiale che, alla domanda sul Principe Umberto, ha risposto: «Possiamo anche fare a meno di un re, se voi volete che lo facciamo». Ma mi viene da pensare che l’implicazione potrebbe essere qualcosa come: «Possiamo fare a meno di molte cose, se la sola domanda rimasta è di fare quello che voi volete che facciamo». Oppure semplicemente intendeva essere cortese. Ma la testimonianza di gran lunga più significativa è quella del giovane operaio. Qui c’è un perfetto esempio di vita sotto il Fascismo. Quest’uomo aveva 5 anni nel 1922. Nessuna meraviglia che non sapesse nient’altro eccetto che in Italia c’era un «leader» che faceva tutto per il meglio. In ogni modo, che cosa poteva importagli della politica, quando non c’era traccia di politica attorno a lui, se si esclude qualche amaro ricordo di fallimenti tra i più vecchi? Ben più importante era la chiusura dei confini, che impediva a lui (come lo aveva fatto a suo padre, e molto probabilmente a un gran numero dei suoi compagni operai, dal 1926 in poi) di andare altrove a cercare una vita più decente. Questo era decisamente pessimo, per quanto lungimirante fosse il Leader. La vita in generale non era piacevole per questo giovane, immagino. Altrimenti egli non avrebbe «attribuito grande importanza» a questo fatto. «Nel 1936 sembra che tutti stessero meglio», grazie agli inganni del Leader. Ma andò male. Nel 1939, era nell’esercito. Si trattava probabilmente del secondo richiamo alle armi: deve aver fatto il servizio militare regolare (18 mesi) nel 1937, quando aveva 20 anni. Circa sei mesi di libertà, e poi ancora la caserma. La chiamata non sarà certo stata accolta con gioia, anche se non è improbabile che, nell’insieme, la vita nell’esercito, con la sua assenza di preoccupazioni, non apparisse molto peggio di quella a casa. Venne la guerra, lui era un buon soldato e gli hanno dato delle medaglie. Poi venne il momento in cui apparve chiaro che «il Leader aveva fatto un errore». In realtà, si scoprì che gli errori erano stati tanti, abbastanza da fargli decidere che il Leader era decisamente un cattivo leader. Conclusione: «Troppi uomini muoiono e il paese non diventa più ricco». 128 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 129 Gli italiani e il fascismo In tutto questo, l’implicazione non è – come il giovane americano pensa – che «se il paese diventasse più ricco, anche la morte andrebbe bene». Questa è semplicemente una deduzione logica che un ascoltatore (persino un ascoltatore simpatetico, presumo) è indotto fin troppo facilmente a fare. Le implicazioni sono molte e complesse. Quanto numerose e quanto complesse quest’uomo evidentemente non lo sa, avendo un disperato bisogno dell’aiuto di amici in compagnia dei quali reimparare a esprimersi in un linguaggio articolato. Ma, come punto da cui iniziare una conversazione, io non sarei così disperato sulla sua conclusione. Dopotutto, è chiara, semplice, e molto umana. Invece mi sentirei davvero preoccupato se qualcuno iniziasse facendogli un discorso sul suo «aver perso il controllo del governo» o, in quel campo, sulla sua coscienza di classe. Per non parlare di quello che sta ricevendo ora: film di Hollywood e l’insolenza dei suoi ufficiali sostenuti dall’autorità americana. Spero che tutto questo non sia in alcuno modo sospettato di essere una «difesa» del popolo italiano. Io sono fermamente convinto che i popoli non hanno bisogno di avvocati: sono loro stessi i propri giudici e vendicatori. Non c’è alcun altro tribunale. Volevo solo insinuare un paio di dubbi circa l’aspettarsi che le persone diano risposte che corrispondono alle domande che noi abbiamo in testa. 3. Dedica, di Mariuccia Salvati. Il saggio di Chiaromonte, perché di questo si tratta, cioè di un saggio, non ha bisogno di commenti per gli studiosi del fascismo. Non ne ha bisogno soprattutto in una dedica a Silvio Lanaro. Ma qualche piccola chiosa servirà a segnalare al lettore perché questo testo stia così bene in una Festschrift destinata a lui. È un testo scritto di getto eppure chiaramente meditato. Scritto con la speranza (l’illusione?) di far comprendere al pubblico americano, persino al nucleo di intellettuali che costituiva il cuore della rivista «politics»1, qualcosa di più circa l’intricata storia italiana. Quale storia? 1 «politics» (febbraio 1944-inverno 1949) fu fondata e diretta da D. Macdonald, che aveva lasciato nel 1943 la «Partisan Review» per un disaccordo sulla necessità di proseguire un discorso critico sulla rivista nonostante lo scoppio della guerra. Il circolo di «politics» cercò «un’alternativa comunitaria allo stato di guerra generalizzato»: di questo circolo e della rivista Chiaromonte fu uno dei membri più autorevoli e contribuì a far conoscere intellettuali europei come Albert Camus, Hannah Arendt, e l’ultima Simone Weil (G. D. Sumner, L’intellettuale newyorkese dimenticato, in «Lo Straniero», agosto-settembre 2011, 134-135, pp. 129 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 130 Mariuccia Salvati La storia sociale. La storia umana, sociale, dei singoli individui, non la loro adesione all’una o all’altra opinione politica. È questa non «consolante» riflessione che i partiti antifascisti non avevano voluto capire. Ma come, ci si chiederà, Chiaromonte, che ha alle spalle una biografia all’insegna di scelte radicali, di militanza intellettuale, di coerenza etica (la collaborazione negli anni venti alla rivista «Conscientia» di Gangale, negli anni trenta Parigi e l’adesione alle posizioni di Giustizia e Libertà, la guerra aerea in Spagna, Malraux, il Marocco e l’incontro con Camus, l’arrivo a New York nel 1941)2 pone qui l’accento più sulla società che sulla politica, più sulle forze economiche che sulla scelta morale? Le sue frasi fulminanti ci riportano al nucleo profondo delle sue riflessioni negli anni trenta e che in parte troviamo sviluppate sul giornale di Giustizia e Libertà nel dibattito sulla forma partito e il socialismo: la ricerca cioè di una via politica al di fuori dello Stato, quando lo Stato si chiama fascismo, è uno Stato informe, strumento di forze senza legge3. L’analisi della – chiamiamola così – intervista del soldato americano all’ex operaio prigioniero italiano (ma anche quella all’ufficiale filobadogliano) dovrebbe trovare posto in qualsiasi antologia dal titolo Fascismo e società italiana: per una serie di intuizioni folgoranti di Nicola Chiaromonte sullo stato del suo paese – che pure egli aveva dovuto lasciare fin dal 1935: intuizioni che trovano sempre maggiori conferme negli studi storici recenti. Proviamo a elencarle. Innanzitutto la periodizzazione del consenso o non consenso al fascismo: non illudiamoci, osserva Chiaromonte, che il 1922 abbia rappresentato una cesura per la massa degli italiani. Lo fu per un nucleo di testardi «deduttori», in grado di cogliere le conseguenze inevitabili di quel gesto di rottura istituzionale. Ma le generazioni successive? Quelli che avevano 83-5). Sumner è l’autore della monografia Dwight Macdonald and the politics Circle, Cornell University Press, Ithaca-London 1996. 2 Per la sua biografia intellettuale, si veda G. Bianco, Nicola Chiaromonte e il tempo della malafede, Lacaita, Manduria 1999. 3 «Si tratta di essere e volere integralmente fuori dallo Stato. Cioè fuori dal terreno schematico e semplicistico della politica (il quale, giova ripeterlo, non esiste letteralmente più). Volere, contro lo Stato non quelle cose astratte che sono una “organizzazione” e un “ideale politico”, ma quel fatto complesso che è un’“esistenza”, un mondo di rapporti concreti e determinati» (La riforma socialista ovvero alla ricerca della vera questione, in «Giustizia e libertà», 15 marzo 1935, a. II, 11). Ma si veda anche Sincero [N. Chiaromonte], La morte si chiama fascismo, in «Quaderni di Giustizia e libertà», gennaio 1935. Su quest’ultimo saggio è stata richiamata l’attenzione, tra gli altri, in Bianco, Nicola Chiaromonte e il tempo della malafede cit., cap. IV; V. Giacopini, Nicola Chiaromonte: una solitudine senza isolamento, in Scrittori contro la politica, Bollati Boringhieri, Torino 1999, e, di recente, M. Bresciani, Cassandra a Parigi, in «Lo Straniero», 2011, 134-135, pp. 57-72. 130 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 131 Gli italiani e il fascismo cinque anni nel ’22 ed erano adolescenti quando, dopo il chiudersi della grande crisi politica del 1924, non c’era traccia di politica attorno a loro, «se si esclude qualche amaro ricordo di fallimenti tra i più vecchi»? Le generazioni che sono cresciute dentro la propaganda omnipervasiva fascista? Sarà solo la guerra a costituire il fatto concreto che pone l’individuo di fronte alla necessità di giudicare. Dunque, la vera svolta nel rapporto degli italiani con Mussolini è davvero il 1936, come racconta l’operaio milanese, cioè l’avvio di un’avventura militare iniziata con baldanza, affrontata come un dovere nel 1939 e via via vissuta con disincanto crescente, anche da parte di coloro che vi avevano creduto e si ritrovavano ora prigionieri, guarda caso, in un paese tanto più ricco e vitale4. Intanto in Italia cresceva il distacco e poi l’opposizione aperta, come segnalano gli scioperi industriali e gli eventi politici che ne seguirono. Così in questo testo il tema delle generazioni si intreccia con quello dell’abilità politica del leader Mussolini. La capacità obnubilante di una propaganda innovativa e moderna intenta a dividere, a nascondere, a sedurre ed esaltare, potrà essere sconfitta solo dallo scontro con la realtà dei fatti, i duri fatti della realtà della guerra. Se la tematica delle generazioni succedutesi tra gli anni venti e trenta e del diverso tipo di antifascismo che connota la seconda rispetto alla prima trova sempre nuove verifiche mano a mano che l’analisi biografica dei protagonisti si estende e si approfondisce5, la rottura culturale, prima ancora che politica, rappresentata dalla guerra – che ha in Giaime Pintor il testimone più consapevole della sua generazione – trova già qui, fuori 4 Non sappiamo di preciso da quale campo scriva il corrispondente di «politics». Sappiamo però qualcosa dei campi per WP (prigionieri di guerra) dalla testimonianza di Gaetano Tumiati (Prigionieri nel Texas, Mursia, Milano 1985) che a Hereford, Texas, rimase cinque anni e che narra tra l’altro dell’arrivo negli Usa e dello stupore abbagliante provocato dall’abbondanza di cibo e comodità, a disposizione, naturalmente, di coloro che «firmavano». Molto interessante lo sguardo di E. Lorenzon, Le memorie dei prigionieri di guerra nel campo di Hereford, in «Snodi. Pubblici e privati nella storia contemporanea», 2007, 1, pp. 106-12. 5 Mi permetto di rimandare ad alcune riflessioni che ho svolto a proposito della biografia di Antonio Giolitti, in un volume a lui dedicato, a cura di G. Amato, in corso di pubblicazione presso Viella: per questo mi sono stati particolarmente utili i ricordi di A. Galante Garrone: «noi – i più “vecchi” – avevamo fatto in tempo a incuriosirci e appassionarci per gli scritti – circolanti a fatica – di Piero Gobetti e, in seguito, per i primi messaggi di “Giustizia e Libertà”. Nostro nume tutelare era ancora Benedetto Croce; e livre de chevet la sua Storia d’Europa […]. La generazione di Giolitti, invece, fu costretta, per esempio, ad indossare la camicia nera, per frequentare i corsi obbligatori del servizio premilitare. E si trovò ad essere adolescente in pieni anni trenta: gli “anni del consenso” in cui – nella scuola, nell’università e in tutta la società – l’aria si era fatta opaca e stagnante: quando sembravano ormai spenti, o ridotti a cerchie sempre più ristrette e clandestine, i fermenti di un combattivo spirito antifascista» (A. Galante Garrone, Il mite giacobino. Conversazione tra libertà e democrazia raccolta da Paolo Borgna, Donzelli, Roma 1994, pp. 65-8). 131 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 132 Mariuccia Salvati d’Italia, un analista attento, in grado di avvertire con grande sensibilità, nonostante la distanza, lo strappo rappresentato dall’arrivo della violenza militare e civile nelle case degli italiani. A proposito di violenza, di fronti contrapposti, di socialismo e marxismo, va ancora ricordato che vi è Chiaromonte dietro la decisione di pubblicare su «politics» i saggi di Simone Weil, Riflessioni sulla guerra e L’Iliade, o il Poema della forza, ma soprattutto la sua influenza è molto forte nella costruzione di una rubrica dal titolo «Ancestors» (Antenati), di cui troviamo pubblicati solo cinque capitoli (Proudhon, Tocqueville, Tolstoj, Godwin e Herzen, tra il 1945 e il 1949) e che prevedeva una lista più lunga. Ecco come si spiegava la scelta nella Nota editoriale pubblicata sul numero di ottobre 1945 (p. 297), che precede il saggio su Proudhon di J. Hampden Jackson: Nota dell’Editore: Questo è il primo di una serie di articoli di e su pensatori politici del passato, come Diderot, Condorcet, Tom Paine, Saint-Simon, Fourier, Herzen, Kropotkin, Tolstoy, Daniel De Leon, e Rosa Luxembourg. I nomi, si noterà, sono in gran parte di non-Marxisti. E questo perché: 1) Il Marxismo è già ampiamente diffuso tra gli intellettuali americani (forse anche troppo); 2) la crisi contemporanea del socialismo richiede che noi integriamo e riformuliamo l’eredità marxista con l’aiuto del socialismo «utopico»; il liberalismo del XVIII secolo, l’anarchismo e il pacifismo. Chiaromonte in particolare si impegna nella riflessione su Proudhon e Tolstoj, ma è l’intero canone del circolo di «politics» che trova nell’esule italiano uno dei suoi massimi ispiratori. Non a caso si è parlato per questa rubrica di un certo «eurocentrismo», mentre Macdonald ebbe a dire della rivista che si trattò di una «coproduzione italoamericana»6 pensando proprio al suo legame con Chiaromonte (che a sua volta aveva coinvolto Andrea Caffi). Ma torniamo all’intervista tra il soldato americano e l’operaio italiano e alla sua conclusione: «Troppi uomini muoiono e il paese non diventa più ricco». Davvero, si chiede Chiaromonte, di fronte a questa riflessione si può solo ragionare in maniera deduttiva: se… allora? Troppe sono le implicazioni di questa frase, certo molte di più di quante siano contenute nelle lezioncine sulla democrazia impartite nel campo e implicite nelle domande rivolte agli intervistati: è il 1922 l’inizio della svolta, è la lotta di classe la spiegazione del fascismo? Fulminanti e da meditare le ultime frasi sul pericolo contenuto ne «l’aspettarsi 6 Sumner, L’intellettuale newyorkese dimenticato cit.; sui riferimenti intellettuali del gruppo cfr. il cap. «Ancestors» nell’opera di Sumner, Dwight Macdonald cit. 132 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 133 Gli italiani e il fascismo che le persone diano risposte che corrispondono alle domande che noi abbiamo in testa». Chiaromonte diceva che in America aveva imparato a scrivere in maniera chiara, ma che questo non lo aiutava a fare chiarezza nei suoi pensieri. Per fortuna, aggiungiamo noi. Non saprei dire come, ma questo mi fa pensare ai saggi di Silvio. 133 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 134 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 135 PENSARE LA NAZIONE Contadini e, quindi, italiani: l’Enciclopedia Italiana (1929-1938) di Margherita Angelini La pubblicazione dell’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, diretta da Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert e Denis Diderot, segnò la nascita dell’enciclopedia moderna. Le numerose riedizioni e gli adattamenti garantirono una vasta circolazione dell’opera e fecero sì che nel corso del XVIII secolo sorgessero iniziative analoghe come l’Encyclopaedia Britannica e la Brockhaus Enzyklopädie, in Germania: nella prima le voci ebbero un carattere monografico e molto ampio, nella seconda, invece, furono brevi e di carattere prettamente informativo. Il XIX secolo vide un vivace sviluppo dell’editoria enciclopedica in quasi tutta Europa, dalla Russia alla Spagna e anche nelle Americhe, in Australia, e verso la fine del secolo in Cina e nel mondo arabo. In questo quadro si inserì anche l’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti che rappresentò la prima opera originalmente italiana e non compilativa, a differenza dell’Enciclopedia popolare illustrata (1896-99 in 4 volumi) e della Grande enciclopedia popolare (1913-29 in 22 volumi) entrambe pubblicate da Sonzogno. Nel primo quarto del secolo erano falliti diversi tentativi di creare un’opera enciclopedica nazionale; solo grazie all’imprenditore Giovanni Treccani e a Giovanni Gentile, nominato direttore scientifico, l’Enciclopedia italiana poté essere data per la prima volta alle stampe nel marzo del 1929. I suoi volumi uscirono in ordine alfabetico, senza interruzione, per otto anni, uno ogni quattro mesi, fino al 1937, e la prima Appendice fu edita nel 1938. L’impresa rientrò nella vasta opera gentiliana di organizzazione della cultura, iniziata con la riforma della scuola e andata accrescendosi negli anni seguenti1. 1 L’articolo è tratto da un paragrafo della tesi di laurea Romanità, Risorgimento e Grande Guerra. I miti fondativi del fascismo nelle voci dell’Enciclopedia Italiana (1929-1937), che ha seguito Silvio Lanaro nell’anno accademico 2000-2001. Tra i tanti e piacevoli ricordi che ho di quel periodo, non dimenticherò mai i mercoledì mattina quando a ricevimento una lunga fila di studenti attendeva nello stretto corridoio davanti al suo studio. E non era un affollamento casuale. Le lezioni di Silvio, colme di suggestioni storiche, letterarie, artistiche, 135 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 136 Margherita Angelini Impostata sull’esempio della Britannica, l’enciclopedia ebbe carattere monografico e fu scritta da collaboratori scelti innanzitutto per le loro eminenti qualità intellettuali e culturali. Per le voci dedicate all’agricoltura, furono chiamati autori eterogenei per età e vocazione professionale: da tecnici agronomi come Arrigo Serpieri – il sostenitore della piccola proprietà – a storici, come Raffaele Ciasca, che si era avvicinato a posizioni fasciste per la promessa di interventi al Sud e per i proclami in materia di politica agraria2. È possibile pertanto tracciare, attraverso la lettura di questi lemmi, un sintetico saggio delle reazioni sul piano culturale al programma politico, ideologico ed economico dell’Italia fascista. Una riforma che fu inaugurata prima con i piani per la bonifica integrale poi con la battaglia del grano, la quale riuscì a promuovere l’immagine del paese anche all’estero, tanto che nel 1927 il congresso internazionale di agricoltura fu celebrato a Roma3. In questi anni fu insediato, presso il ministero della Guerra, un Ufficio di propaganda granaria e fu promossa nelle scuole, nei cinema e nelle trasmissioni radiofoniche la campagna agraria. La battaglia del grano svolse una funzione di rilievo anche nella messa in scena del culto del duce accentuando le metafore belliche nei discorsi sull’Italia rurale4. Anche se il tentativo di inventare una tradizione fu sostanzialmente fallimentare5, la campagna fascista raccolse successi: l’Italia, pur rimanendo dipendente da altri paesi per le importazioni, salì da una produzione intorno ai 50 milioni di quintali l’anno dei primi anni venti, a 70 milioni verso la metà degli anni trenta. L’estensione della superficie coltivabile contribuì a questo incremento, come anche il massiccio impiego di concimi e mezzi tecnologici moderni6. economiche e politiche, ci aprivano a un mondo nuovo e, per tanti versi, sconosciuto: quello del mestiere di storico inteso nella sua natura più intima e globale. Per uno sguardo sull’opera di Gentile in questi anni, si veda A. Tarquini, Il Gentile dei fascisti. Gentiliani e antigentiliani nel regime fascista, il Mulino, Bologna 2009, e sul ruolo come direttore dell’Enciclopedia Italiana, G. Turi, Il mecenate, il filosofo e il gesuita. L’«Enciclopedia Italiana» specchio della nazione, il Mulino, Bologna 2002. 2 A. Monticone, Ciasca, Raffaele, in Dizionario biografico degli italiani, XXV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1981, pp. 224-7. 3 A. Nützenadel, Landwirtschaft, Staat und Autarkie. Agrarpolitik im faschistichen Italien, 1922-1943, M. Niemeyer, Tübingen 1997. 4 Id., La mobilitazione dei rurali nella battaglia del grano, in Il Ventennio fascista, I, Dall’impresa di Fiume alla Seconda guerra mondiale (1919-1940), a cura di G. Albanese e M. Isnenghi, in Gli Italiani in guerra, a cura di M. Isnenghi, IV, t. 1, Utet, Torino 2008, p. 610. 5 S. Lanaro, Retorica e politica. Alle origini dell’Italia contemporanea, Donzelli, Roma 2011, pp. 117-45, in particolare p. 142. 6 Nützenadel, La mobilitazione dei rurali nella battaglia del grano cit., p. 610. Per un confronto con il contesto internazionale cfr. J. Burchardt (a cura di), Rurality, Modernity and National Identity between the Wars, in «Rural History», XXI, 2010, pp. 143-50. 136 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 137 Contadini e, quindi, italiani: l’Enciclopedia Italiana (1929-1938) 1. Tecnocrazia agraria e modernizzazione. I tecnici agronomi che si avvicinarono al fascismo provenivano da un retroterra culturale comune, la cui formazione fu l’esito dell’iniziativa privata e del volontarismo di alcuni agricolturisti. Molti ritennero che il nuovo governo dittatoriale potesse realizzare, attraverso il primato della politica, il loro progetto tecnocratico, consapevoli che la forza delle idee si impone con efficacia solo in strutture capillari7. Arrigo Serpieri, ad esempio, aderì alle riforme non per una romantica visione ruralista, ma per un più realistico richiamo al progetto di modernizzazione che il fascismo si proponeva di realizzare, il quale avrebbe potuto concretizzare il rinnovamento delle campagne attraverso l’intervento diretto dello Stato nel finanziamento e nell’attuazione della bonifica. L’autore della voce dell’Enciclopedia Italiana dedicata a Serpieri annotò come egli ebbe costante cura di «mettere in rilievo i particolari caratteri, economici e sociali, del mondo rurale in tutte le loro conseguenze di ordine politico»8. La realtà delle campagne prima dell’intervento di tecnici quali Serpieri era rimasta in ombra a causa dello «sviluppo dell’economia capitalistica», ma ora, come scrisse l’estensore della voce, «viene valorizzato, per ristabilire fra vita rurale e vita urbano-industriale quell’equilibrio che era stato rotto»9. In questa voce del 1936 vi è un evidente sforzo di riduzione delle distanze createsi nell’attuazione della politica agraria, in quanto non vi è alcun accenno al forte dissenso che divise Serpieri e il governo a causa del rifiuto del suo progetto di impronta corporativa, una pianificazione che si sarebbe scontrata sia con l’interpretazione politica della bonifica sia con gli interessi dei possidenti del Sud10. Il piano delle bonifiche del fascismo fu in realtà una continuazione e un ampliamento di una serie di progetti avviati dai governi liberali 7 F. Marasti, Il fascismo rurale. Arrigo Serpieri e la bonifica integrale, Settimo sigillo, Roma 2001; M. Stampacchia, «Ruralizzare l’Italia!». Agricoltura e bonifiche tra Mussolini e Serpieri (1928-43), Franco Angeli, Milano 2000; A. Marinelli - P. Nanni (a cura di), Arrigo Serpieri e la sua costruzione teorica fra economia politica e realtà settoriale. Atti del Convegno (Firenze, 22-23 aprile 1993), Stianti, San Casciano 1995; C. Fumian, I tecnici tra agricoltura e Stato, 1930-1950, in «Italia contemporanea», Le élites in Francia e in Italia negli anni Quaranta, numero monografico, 1983, 153, pp. 209-17; Id., Modernizzazione, tecnocrazia, ruralismo. Arrigo Serpieri, ivi, 1979, 137, pp. 3-34. Più in generale cfr. Id., Possidenti. Le élites agrarie tra Otto e Novecento, Meridiana Libri, Roma 1996. 8 Voce redazionale, Serpieri, Arrigo, in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, XXXI, Roma 1936, p. 451. D’ora in poi l’Enciclopedia sarà citata come Enciclopedia Italiana, volume e, tra parentesi, anno di edizione. 9 Ibid. 10 P. Dogliani, L’Italia fascista (1922-1940), Sansoni, Milano 1999, p. 200. 137 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 138 Margherita Angelini del primo dopoguerra11. Nonostante questi antecedenti, la politica agraria fu presentata nel ventennio come un movimento profondamente innovatore rispetto alle inadeguate politiche precedenti12. Enrico Fileni, ad esempio, nella voce Agricoltura descrisse le leggi dei governi postunitari come «inefficaci perché non aderenti alla realtà e soprattutto non adeguatamente finanziate». Il governo fascista con la sua politica aveva, secondo il direttore dell’Ente nazionale delle cattedre ambulanti di agricoltura, interpretato correttamente le reali esigenze del paese e con la sua forza propulsiva le aveva messe in atto, cogliendo così la vera natura dell’anima italiana13. La legislazione attuata dal governo è minuziosamente delineata nella voce Bonifica14, in cui gli autori Antonino Buongiorno e Achille Donato Giannini conclusero che il «potente sforzo» fatto dall’Italia non fu solo nel campo della tecnica idraulica ma «in quello delle maggiori realizzazioni umane, della utilizzazione cioè di ogni lembo del nostro territorio», a cui il governo – consapevole del «grandioso programma» – non aveva «esitato un istante ad apprestare gli idonei mezzi finanziari»15. Anche nella chiusa della voce Agricoltura – scritta da Fileni insieme a Ugo Spirito16 – emerge molta fiducia nella gestione della riforma che aveva esaltato l’anima rurale della penisola: grazie al «miracolo» attuato dal governo fascista – attraverso lo «slancio concorde» di scienziati, tecnici, proprietari e coltivatori – si preparava così «un periodo di splendore di cui i 11 G. Barone, Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica nell’Italia contemporanea, Einaudi, Torino 1986, pp. 5-99 e Id., Per una storia della bonifica integrale fra le due guerre, in A. Arcomano e altri, Campagne e fascismo in Basilicata e nel Mezzogiorno, a cura dell’Istituto Alcide Cervi e della Regione Basilicata, Lacaita, Manduria 1981, pp. 301-9. 12 L. D’Antone, Politica e cultura agraria. Arrigo Serpieri, in «Studi Storici», 1979, 3, pp. 610-3. 13 E. Fileni, Agricoltura, in Enciclopedia Italiana, I (1929), p. 961. 14 In termini quantitativi gli autori dedicarono all’illustrazione dei decreti: dall’Unità alla legge del 1923 due colonne; dal 1923 al 1926 quattro colonne; dal 1926 al 1928 e oltre quattro colonne; cfr. A. Buongiorno - A. D. Giannini, Bonifica, in Enciclopedia Italiana, VII (1930), pp. 413-23. 15 Buongiorno - Giannini, Bonifica cit., p. 418. Nella voce Agricoltura vi è una dettagliata analisi degli investimenti in questo campo fin dal 1862, con la constatazione che dal 1928 i soldi spesi erano aumentati considerevolmente; cfr. Fileni, Agricoltura, in Enciclopedia Italiana cit., p. 966. 16 La voce Agricoltura fu firmata nell’ultima parte da Fileni e nella sua prima parte, Agricoltura. Le origini e lo sviluppo, da Spirito. La parte iniziale della voce è siglata con l’asterisco redazionale: Spirito affermò che questa parte era di suo pugno; cfr. U. Spirito, Un capitolo di storia. La grande Sansoni, in Testimonianze per un centenario, Sansoni, Firenze 1974, p. 171 e V. Cappeletti, Ugo Spirito e l’Enciclopedia Italiana, in Il pensiero di Ugo Spirito. Atti del convegno, Roma 6-9 ottobre 1987, I, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1988, pp. 7-20, con appendice di documenti. 138 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 139 Contadini e, quindi, italiani: l’Enciclopedia Italiana (1929-1938) primi esempi e i primi risultati sono già manifesti»17. L’opera di rimessa a coltura delle terre fu, quindi, un’iniziativa che aveva portato alla «redenzione» dell’Italia, la quale poteva senza alcun dubbio ora considerarsi di «esempio al mondo»18. Per tutti questi motivi la legge Mussolini fu considerata anche da Ciasca nella voce Latifondo come organica e, sebbene fosse più onerosa per la società rispetto alle precedenti, essa fu l’unica che tenendo conto «delle condizioni naturali e climatiche, oltre che di quelle storiche in cui si è formato il latifondo e lungi dal combattere direttamente e rivoluzionariamente» lo stesso, tese a modificare profondamente l’ambiente sia bonificandolo da un punto di vista «idraulico ed igienico, sia costruendo strade, case, centri rurali cui appresta acqua potabile, scuola, chiesa, medico ecc.; sia anticipando capitali ai coloni, dirigendoli nella parte tecnica e aiutandoli ad un organico smaltimento più rapido dei prodotti»19. Dalla lettura integrale di questa voce si può intuire il problema spinoso di fronte al quale si trovò il governo negli anni di stabilizzazione del regime fascista: da una parte la necessità di ottenere il consenso tra i nazionalisti e i grandi proprietari terrieri, dall’altra quella di avviare un programma di trasformazione dello Stato e dell’economia tramite l’aiuto dei tecnocrati e dei sindacalisti passati al fascismo. Il governo fascista, cercando di evitare l’inurbamento di molti contadini causato principalmente dalla diminuita emigrazione all’estero, dalla crisi agraria del 1926-27, dall’urto che la deflazione monetaria ebbe sulle campagne con l’aumento dei prezzi agricoli e dal conseguente aumento della disoccupazione e della bracciantizzazione agricola, dovette muoversi nella direzione della «bonifica integrale» già indicata dai governi liberali. La politica del fascismo deve essere inquadrata partendo dalla reazione squadrista del primo dopoguerra e arrivando alla nota situazione di grave tensione sociale causata dell’occupazione delle terre in seguito alla disattesa realizzazione della promessa di «terra ai contadini» formulata dopo la rotta di Caporetto. Con l’autorizzazione del decreto Visocchi, che concedeva ai contadini la permanenza nelle terre occupate, il governo liberale volle evitare ulteriori disordini. L’«estrema legalizzazione» di questo «metodo disordinato e violento di presa di possesso delle terre», Fileni, Agricoltura cit., p. 962. Ibid. 19 R. Ciasca, Latifondo, in Enciclopedia Italiana, XX (1933), p. 579. 17 18 139 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 140 Margherita Angelini secondo Raffaele Ciasca autore della voce Latifondo, «molto di rado portò al dissodamento delle terre incolte e all’effettiva trasformazione del latifondo». Le leghe rosse e i «socialcomunisti» crearono solo tumulti «sovvertendo le abitudini casalinghe dei contadini», incitando a rivoluzioni che avrebbero messo in subbuglio le gerarchie e, gridando «che la terra era esausta dalla guerra, che tutto il capitale era distrutto e si correva al fallimento nazionale, inculcava la necessità di una trasformazione nazionale circa l’appartenenza della proprietà»20. Le leghe rosse «imponevano» scioperi e «ostacolavano la trebbiatura e disperdevano i prodotti»21. Solo grazie all’ascesa del fascismo si ridiede «ordine rispetto alle gerarchie, fiducia a chi lavora e risparmia e produce», in modo da «esaltare tutte le forze produttrici della nazione» dando preminenza «nell’indirizzo generale della politica economica e sociale ai fattori rurali» e revocando tutte le occupazioni di terre22. Con l’avvento del fascismo si era avuta difatti la revoca del decreto Visocchi, la cancellazione della diminuzione dell’orario di lavoro e degli aumenti salariali ottenuti in alcune aree e l’abolizione delle provvidenze contro la disoccupazione. Nel momento in cui si consolidò il regime dittatoriale furono siglati contratti molto onerosi per i coloni, come la Carta della mezzadria del 1933; questa legislazione avrebbe avuto una caratterizzazione reazionaria sia nei termini che legavano il mezzadro al conducente, che nelle clausole che definivano la forma del contratto e le caratteristiche dell’unità familiare23. Giuseppe Tassinari, autore della voce Mezzadria (1934), evitò qualsiasi conclusione che mettesse in luce il carattere oppressivo e prevaricatore di questi contratti: dopo aver confutato le tesi socialiste e marxiste, e aver definito senza alcun fondamento le opinioni secondo cui il colono non sarebbe stato stimolato né al miglioramento del fondo, né al progresso dell’agricoltura, l’autore rifiutò anche la tesi secondo cui, a causa dell’irrigidimento dei contratti, la forma di retribuzione mezzadrile non fosse da considerarsi equa. Tassinari evidenziò sinteticamente le migliorie apportate dal fascismo, la cui politica corporativa aveva contribuito alla larga partecipazione del mezzadro ai risultati dell’impresa. Il fascismo aveva infatti «esaltato questo tipo di conduzione che ha in sé il contenuto principale del prinIbid. Ibid. 22 Ciasca, Latifondo cit., p. 580. 23 A. D’Alessandro, La politica agraria del fascismo, in Arcomano e altri, Campagne e fascismo in Basilicata e in Meridione cit., pp. 207-41. 20 21 140 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 141 Contadini e, quindi, italiani: l’Enciclopedia Italiana (1929-1938) cipio corporativo, perché associa nei risultati produttivi i due fattori principali, lavoro e capitale»24. In realtà anche se l’accordo stipulato stabiliva che i prodotti maturati nel suolo e soprasuolo dovessero spettare ai contraenti nella misura della metà della vendita comune, sul colono gravavano tutta una serie di oneri che riducevano sensibilmente la sua quota; su di lui si era addossato il totale carico del lavoro del fondo; inoltre al proprietario era data la facoltà di utilizzarlo per lavori straordinari. Il colono era sottoposto, per contratto, al dominio economico del padrone in caso di debito contratto con quello precedente, ed era legato con tutta la famiglia alla terra, pena l’escomio. Il carattere vessatorio appare anche in altri contratti agrari fin dai primi patti colonici stipulati dai sindacati fascisti25. Tuttavia l’esemplarità dell’organico intervento del regime fascista fu tesa a dimostrare una compresenza di molte politiche parallele: dal «riscatto» delle terre fino alla trasformazione fondiaria del Mezzogiorno. 2. L’unificazione dell’Italia e la scomparsa della questione meridionale. Il governo dittatoriale evitò di sollevare la questione meridionale e nel periodo di riforma dell’assetto agrario l’insediamento agricolo fu reso possibile solo in alcune limitate aree bonificate. Giovanni Giuriati, allora ministro dei Lavori pubblici, elaborò un progetto, segnalato anche da Anna Maria Ratti nell’Enciclopedia Italiana, per la colonizzazione del Mezzogiorno allo scopo di eliminare contemporaneamente squilibri demografici ed economici, in una visione del Sud d’Italia rimasto «svuotato» e «indebolito» dall’emigrazione. In una serie di studi di commissari tecnici ministeriali si evidenziò la mancanza di sfruttamento delle risorse del Mezzogiorno, suggerendo il loro potenziamento tramite la creazione di infrastrutture per poi poter procedere all’emigrazione e alla redistribuzione della popolazione locale grazie alla nascita di nuovi settori industriali. Questa proposta fu bocciata sul nascere, perché toccava il problema principale del Mezzogiorno: la produttività delle terre dei possidenti agrari. Si aggirò quindi il problema, dovendo venire incontro a due esigenze contrastanti: da una parte accontentare i proprietari terrieri 24 25 G. Tassinari, Mezzadria, in Enciclopedia Italiana, XXIII (1934), p. 147. D’Alessandro, La politica agraria del fascismo cit., p. 226. 141 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 142 Margherita Angelini che fin dalle origini erano la base del movimento, insieme alla piccola borghesia cittadina e rurale, dall’altra venire incontro a tecnici come Serpieri e alla Confederazione dei consorzi agrari, che sostenevano trasformazioni fondiarie di pubblico interesse. La problematica emerge in tutta la sua complessità nella voce Latifondo di Ciasca. L’intero lemma è indicativo delle oscillazioni a cui fu soggetta la politica agraria durante il ventennio: da un lato si volle dare ascolto, con il ritorno dell’egemonia del blocco agrario, alla richiesta di difesa degli antichi privilegi dei possidenti che originò una serie di provvedimenti, attuati dopo il 1925, che misero a tacere braccianti e mezzadri, consolidandone i legami con la terra; dall’altra si volle attuare la trasformazione del latifondo in consonanza con le idee dei tecnocrati attraverso una riforma più organica e complessiva. È noto come riconoscere apertamente l’esistenza della questione meridionale avrebbe potuto mettere in forse l’appoggio e il consenso dei ricchi proprietari terrieri del Mezzogiorno. La sua ammissione, inoltre, avrebbe dimostrato l’inefficacia del governo centrale nel controllare una forza oscura e predominante come la mafia e avrebbe smentito la propaganda fascista che dichiarava di agire efficacemente nel migliorare le condizioni economiche del Sud Italia. Questo punto di vista è presente nell’Enciclopedia Italiana nella voce Mezzogiorno, questione del, firmata da Ciasca, il quale si occupò per il volume XXIII (1934) proprio di storia del Mezzogiorno. Dopo aver esposto per sommi capi i punti salienti delle problematiche che portarono all’arretratezza del Sud, lo studioso individuò nelle leggi promosse dal governo fascista il miglioramento della qualità della vita e dell’economia: l’intervento del potere statale aveva determinato il «risollevamento del Mezzogiorno», e questo aveva assunto una «continuità, rapidità e ampiezza di proporzioni nuove». In questo modo, secondo Ciasca, si erano eliminati i «molti malintesi» che avevano diviso il Nord e il Sud Italia; anche se certamente non si poteva affermare che si erano sanate tutte le piaghe del Mezzogiorno, bisognava constatare che esse erano spesso dovute allo sfavore della natura e a tanti secoli di storia e di istituzioni così diverse dal resto della penisola. L’autore, quindi, si sentì di affermare che «di una “questione meridionale” non si può più, oggi, legittimamente parlare», in quanto non solo la «piena attuazione» dei provvedimenti del governo fascista aveva elevato «il tono dell’Italia agricola specialmente meridionale», ma ancora di più «perché ogni traccia di contrasto, di antagonismo, ogni senso di interessi diversi, sono scomparsi dagli animi per la fusione operata dalla guerra mondiale 142 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 143 Contadini e, quindi, italiani: l’Enciclopedia Italiana (1929-1938) e dal fascismo»26. Nella voce Napoli si ritrova il medesimo punto di vista: Fausto Nicolini constatò come la città che diede i natali al «generalissimo a cui l’Italia dové la vittoria» e che fu scenario del memorabile ritrovo delle camicie nere, ora fosse divenuta sede di un Alto commissario governativo che aveva intensificato al massimo grado la risoluzione dei problemi edilizio-demografici, cui i napoletani sarebbero stati riconoscenti27. L’autore in conclusione alla sua trattazione storica arrivò a dichiarare che grazie all’intervento del governo la cultura media si era alzata e la camorra era stata «debellata del tutto»: Quant’altro e del più rapido cammino a siffatto proposito si sia compiuto in questi anni, veggono gli stranieri, i quali trovano una Napoli non solo abbellita nella parte panoramica […], ma molto più incivilita nelle stesse classi popolari, le quali liberate dalla camorra, già ferita a morte in un processo clamoroso e ora debellata del tutto, sono anche discese a medie più basse negl’indici dell’analfabetismo e della delinquenza28. Anche secondo Ciasca, la «malattia sociale» costituita dalla mafia – la quale non era stata sconfitta in circa un sessantennio di unità nazionale29 – finalmente dopo circa un quinquennio di attività «vigorosa e talvolta spietata» del governo fascista si era riuscita a incrinare, in quanto si era rotta «la solidarietà della mafia del basso coll’alto; e una volta spezzata la catena del male fu più facile rompere i singoli anelli»30. Il «felice risultato»31, aveva cambiato la situazione della popolazione del Mezzogiorno sia da un punto di vista economico sia più profondamente «culturale» e «morale», trasformando la mentalità delle «classi agrarie» da cui la mafia traeva la maggioranza dei suoi adepti32. In questo quadro la scomparsa di una questione meridionale era tesa a saldare i legami nazionali cementati dalla tradizione storica comune fondata sulla terra e sul mito della ruralità. 3. Identità nazionale e ruralità. Per dimostrare che l’anima italiana era stata sempre, nettamente e prevalentemente, del tutto «contadina», la mitopoiesi del regime risalì R. Ciasca, Mezzogiorno, questione del, in Enciclopedia Italiana, XXIII (1934), p. 151. F. Nicolini, Napoli. Storia, ibid., XXIV (1934), pp. 241-2. 28 Ibid. 29 R. Ciasca, Mafia, ibid., XXI (1934), pp. 863-4. 30 Ibid., p. 864. 31 Rilevato da Ciasca anche nella voce Latifondo cit., p. 580. 32 Id., Mafia cit., p. 864. 26 27 143 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 144 Margherita Angelini ai Romani: lavoratori della terra ancora prima che soldati. I contadini italiani sarebbero stati destinati a ripopolare le campagne ricalcando le orme dei loro avi Romani ovvero di coloro i quali avevano ricevuto la terra come compenso delle fatiche della guerra e per creare avamposti di civilizzazione33. In diverse voci della sezione di antichistica si può trovare l’eco delle velleità di mediazione interclassisita dell’ideologia fascista e della sua mitizzazione dell’anima rurale: nel ripercorrere la storia romana si inventò così una tradizione per la legittimazione delle conquiste imperiali e della «bonifica integrale». Il governo fascista tramite la sua politica agraria fece una scelta di propaganda prima ancora che economica. Lo stesso Mussolini, come sottolinea Victoria De Grazia, «abbandonò l’abito cosmopolita dell’americanizzazione a favore del sobrio modo di vestire di “primo rurale d’Italia”», quasi a voler «infondere vigore simbolico alla pretesa secondo cui il regime stava proteggendo gli umili abitanti dell’Italia rurale dall’oppressione della società industriale». I teorici del fascismo si impegnarono a riprendere «il tema del nobile rurale, quasi come i primi imperialisti italiani avevano mitizzato l’indigeno abissino»34. Il «mito» del ruralismo nacque dall’alto, nel tentativo di intercettare il consenso, e durante il ventennio ebbe, come ha notato Silvio Lanaro, un ruolo importante nel cercare di formare un’identità nazionale. La politica agraria diventò, così, «da un certo momento in poi politica della razza – che esalta nel contadino robusto e frugale il “tipo” italiano storicamente più compiuto e mette in opera nel contempo i mezzi indispensabili per migliorare la qualità della stirpe»35. Agli agricoltori fu di conseguenza riconosciuta una netta specificità sociale e identitaria. Le opere di risanamento furono interpretate anche dagli autori del lemma Bonifica come la risoluzione dei problemi di «ripopolamento» e di «accrescimento della razza» grazie alla maggior produzione granaria36. Per Fileni la popolazione italiana era una «gens contadina», la quale, grazie alla «sua mirabile virtù operosa e parsimoniosa» e al suo «tenace amore della terra», fece «di gran parte del nostro paese […] un’accolta molteplice, se pur non ancora completata, di ridenti e produttivi giardini»37. Il fascismo, avendo intuito la natura del suo popolo, ebbe il merito, secondo Fileni, di aver governato il paese «con un’alta visione delle sue M. Cagnetta, Antichità classiche nell’Enciclopedia Italiana, Laterza, Roma-Bari 1990. V. De Grazia, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 1981, p. 113 e Stampacchia, «Ruralizzare l’Italia!» cit., pp. 207-62. 35 Lanaro, Retorica e politica cit., p. 140. 36 Buongiorno - Giannini, Bonifica cit., p. 418. 37 Fileni, Agricoltura cit., p. 961. 33 34 144 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 145 Contadini e, quindi, italiani: l’Enciclopedia Italiana (1929-1938) possibilità agricole e del suo carattere fondamentalmente rurale»38. In linea con questa interpretazione alcuni intellettuali, anche nelle voci enciclopediche, sfruttarono la mitografia legata alla Grande guerra attraverso l’uso di termini quali «terre redente» e «redenzione nazionale» per lodare l’opera del regime fascista che era venuto incontro alle esigenze primarie di un paese dissanguato dalla continua emigrazione. Fino al 1926 il regime sfruttò il fattore emigrazione per criticare i governi precedenti che non avevano saputo esaltare il sentimento nazionale all’estero e non avevano valorizzato l’apporto economico da esso derivante; questo punto di vista emerge con chiarezza anche nella voce Migratorie, correnti di Ratti39. Il governo fascista aveva avvertito, secondo l’autrice, il «pericolo» per la «comunità nazionale» e aveva indirizzato quindi gli sforzi in due direzioni diverse e complementari: da una parte cercando di far cessare questo movimento e dirottandolo verso l’interno del paese e dall’altra, seppure in misura minore, verso le colonie40. Fortunatamente, quindi, si attuò un «vasto programma di potenziamento, sia delle risorse naturali del paese (specie con la politica di agricoltura svolta nel regno e nelle colonie); sia del suo organismo produttivo (mediante soprattutto la sostituzione della collaborazione alla lotta di classe), sia ancora del suo patrimonio demografico, considerato come fattore principale della produzione e dello sviluppo della potenza nazionale»41. La politica tendente a comprimere l’emigrazione coincideva, in realtà, con la chiusura delle frontiere americane. Di conseguenza il governo fascista stabilì di limitare il concentramento di nuova manodopera industriale, che poteva essere fonte di disordini e proteste, e tentò di mantenere saldo il legame con la terra dei contadini. Con questi scopi nel 1926 fu istituito il Commissariato permanente per le migrazioni interne presso il ministero dei Lavori pubblici. L’ente aveva il compito di individuare le aree più densamente popolate e spostare gruppi di lavoratori, suscettibili di nuove attività, in particolare agricole, da una provincia all’altra. La valutazione dell’azione di questo Commissariato – che «si muove in armonia con la politica dei lavori pubblici» – è estremamente positiva nelle parole di Ratti sia da un punto di vista «economico e demografico, sia da quello morale: non va dimenticato infatti che oltre ad alimentare lo spirito d’iniziativa e a migliorare le capacità lavorative nelle popolazioni emigraIbid., p. 966. A. M. Ratti, Migratorie correnti, in Enciclopedia Italiana, XXIII (1934), p. 255. 40 Ibid. 41 Ibid. 38 39 145 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 146 Margherita Angelini te e in quelle locali, le migrazioni interne, con i frequenti contatti che suscitano tra regione e regione, contribuiscono efficacemente alla formazione di una coscienza nazionale»42. Grazie a queste migrazioni, come attestò Ciasca nel 1934: Ogni regione ha ora le sue bonifiche più o meno avviate. In molte località, dove dominava il latifondo impervio e a pascolo brado, dov’erano paludi e regno incontrastato della malaria, splendono ora al sole le glebe dissolte, i campi di grano, i vigneti, gli uliveti, i villaggi rurali e le opere feconde del lavoro umano. Ogni anno segna nuove tappe. Consorzi agrari sorgono ovunque nella Penisola. […] Villaggio Mussolini in Sardegna, l’Isola sacra non lungi dalla foce del Tevere, Littoria e Sabaudia nella zona delle Paludi Pontine, i lavori del Pisano segnano un trapasso di vita e insieme celebrano un avvenimento morale nella redenzione del suolo d’Italia43. I lettori dell’Enciclopedia Italiana poterono costantemente aggiornarsi sulle opere di bonifica partendo dalle prime voci enciclopediche e arrivando nel 1938 all’Appendice dove furono descritte da Virginio Gayda, direttore del «Giornale d’Italia», per il loro «alto valore economico e sociale» e per questo rappresentavano «uno dei vitali principi del regime fascista: la difesa e lo sviluppo della ruralità per l’equilibrio nazionale contro gli eccessi e le delusioni dell’urbanesimo industriale»44. Anche i lemmi Littoria e Sabaudia, entrambi redatti da Roberto Almagià, ebbero un andamento concorde: entrambe le città sorsero in «conseguenza ai lavori grandiosi per la bonifica integrale». Littoria, in particolare, fu costruita con una «rapidità meravigliosa» e il piano regolatore venne concepito con «ampiezza di linee e modernità di concezione»45. Anche Sabaudia era formata da «edifici modernissimi di sobria eleganza»46. Ambedue, infine, erano dotate di moderne infrastrutture e collegamenti stradali «magnifici». Nella voce Littoria, in particolare, le immagini della nuova architettura razionalista – dalla casa dei Ballila alle nuove poste – svelarono al pubblico sinteticamente queste realizzazioni. Alla descrizione della nuova città fu dedicato un ampio spazio anche nell’Appendice del 1938 che tratteggiò con precisione tutte le infrastrutture e i progressivi miglioramenti della provin42 Ibid., p. 258. Anche la disoccupazione presente nel paese fu considerata nel lemma a essa dedicato come temporanea difficoltà eliminata dall’azione dello Stato, il quale tramite l’autarchia aveva mantenuto «sana e crescente la razza». F. Spinedi, Disoccupazione, in Appendice (1938), p. 521. 43 Ciasca, Latifondo cit., pp. 580-1. 44 V. Gayda, Italia. Storia, in Appendice (1938), p. 751. 45 R. Almagià, Littoria, in Enciclopedia Italiana, XXI (1934), p. 287. 46 Id., Sabaudia, ibid., XXX (1936), p. 374. 146 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 147 Contadini e, quindi, italiani: l’Enciclopedia Italiana (1929-1938) cia. Le nuove città e le opere pubbliche grandiose rappresentavano, anche nelle parole di Arturo Marpicati vicesegretario del Pnf, «il segno più tangibile dell’immensa opera compiuta dal fascismo»47. Il governo aveva creato, come osservò Gayda, «sul territorio nazionale nuove terre redditizie ed abitabili, nuove basi di vita alla popolazione crescente» sviluppando la produzione48. La «sintesi più espressiva», sia per Fileni nel 1929 sia per Gayda nel 1938, era rappresentata dall’Agro Pontino49. L’area, per il presidente dell’Onc, grazie alla «volontà indomabile del Duce» e attraverso le legioni rurali di ex combattenti inquadrate dall’ente, aveva preso nuova vita: In una plaga, che fu di desolazione e di morte, è sorta oggi una nuova provincia con le sue città, con le due borgate rurali, con migliaia di poderi già in avanzata e crescente produzione, con decine di migliaia di lavoratori, trasformati da braccianti in coloni, e con un ricchissimo patrimonio zootecnico50. 4. Conclusioni: l’Enciclopedia Italiana tra modernità e tradizione. All’interno dell’Enciclopedia è possibile rilevare come fu indubbiamente manifesta una viva tensione tra modernità e tradizione nella costruzione di un’epopea nazionale promossa dall’ideologia fasci47 A. Marpicati, Fascismo, XIV (1932), p. 883. Sabaudia, in particolare, divenne «il caso più importante tra le realizzazioni del regime, tanto da essere ovunque menzionato come il modello di città nuova». Cfr. R. Mariani, Fascismo e città nuove, Feltrinelli, Milano 1976, p. 90. Questa tendenza in realtà sollevò non pochi dissensi alla Camera, tra gli strapaesani e in genere tra tutti i movimenti antinovecentisti. Tanto che lo stesso Mussolini dovette intervenire a difendere questa nuova concezione urbanistica, dichiarando che «in modo inequivocabile io sono per l’architettura moderna, per quella del nostro tempo» e che avendo ogni epoca la sua architettura funzionale «sarebbe assurdo pensare che noi oggi non possiamo avere il nostro pensiero architettonico […] il non volere la nostra architettura razionale e funzionale». Discorso di Mussolini citato in Stampacchia, «Ruralizzare l’Italia!» cit., p. 253. 48 Gayda, Italia. Storia cit., p. 751. 49 Cfr. Fileni, Agricoltura cit., p. 966 e Gayda, Italia. Storia cit., p. 751. Almagià affermò nel paragrafo «campagna romana» in Roma (XXIX, 1936, pp. 898-905) come a «tutti i provvedimenti il governo imprimeva un ritmo accelerato e vigoroso»: la lotta alla malaria era stata condotta con massima energia, vi era stato finalmente un ripopolamento delle campagne attraverso la trasformazione di molte aree di coltura, la costruzione di una rete stradale e di una ferroviaria. Furono descritte anche le opere di bonifica in Emilia (XIII, 1932, p. 901), nella Maremma (XXII, 1934, p. 279), nel Veneziano (XXXV, 1937, p. 77) e in Sardegna (XXX, 1936, p. 846). Nella voce Sardegna, in particolare, furono ampiamente messi in luce i lavori riguardanti la bonifica. Anche l’assetto idraulico dell’isola, sebbene fosse stato avviato da Angelo Omodeo nel primo dopoguerra, venne altresì presentato come la più importante realizzazione per «imponenza e mole» senza alcuna specificazione cronologica e ambiguamente venne inserito nel paragrafo Opere del regime fascista in Sardegna. 50 A. Di Crollanza, Combattenti, in Appendice (1938), p. 450. 147 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 148 Margherita Angelini sta. Ciò nondimeno è necessario inserire la traiettoria della cultura italiana all’interno di un quadro mondiale in cui questo duplice e ambiguo richiamo ebbe un peso rilevante nella costruzione di diverse identità nazionali, in particolar modo tra gli anni venti e trenta quando in molti paesi, anche non europei, l’intensificarsi degli scambi internazionali e la depressione agricola fecero maturare una diffusa preoccupazione. Numerose amministrazioni – dalla Francia alla Cina, dal Galles alla Svezia – costruirono così una rinnovata identità nazionale ponendo l’accento proprio sulla ruralità come elemento cardine della propria storia e della propria tradizione51. Al contempo la modernizzazione fu considerata la sola via per sanare le campagne ed evitare la disintegrazione sociale, economica e culturale. Per incrementare la produttività fu promosso quindi l’uso di nuove tecnologie e favorita l’educazione agricola. L’invenzione del mito di una società rurale come collante nazionale era stato elaborato in alcuni paesi, tra cui l’Italia, già a cavallo del Novecento52. Tuttavia, dopo la Grande guerra, in diversi Stati vi fu un’intensificazione di questi sforzi: in Gran Bretagna, ad esempio, il mercato editoriale produsse numerose guide popolari, saggi fotografici e romanzi regionali dedicati alla vita di campagna idealizzata, mentre in altri paesi la guerra segnò l’affermarsi di una «mitografia» contadina in un’altalena di appelli contradditori che si rivolgevano da un lato alla tradizione, dall’altro al progresso53. Analogamente, anche le radici della depressione agricola possono essere ricondotte allo sviluppo di un mercato globale dei prodotti alimentari fin dal 1870. Anche in questo caso, tuttavia, gli effetti furono più pronunciati tra anni venti e trenta e quasi ovunque i governi decisero di intervenire attivamente nel campo dell’agricoltura attraverso una legislazione protezionista e modernizzando il sistema di coltura nelle campagne, soprattutto in quei paesi lacerati dalle lotte per la riforma agraria o dove, come la penisola italiana, il conflitto tra contadini e proprietari terrieri fu più forte. Per questi motivi, quindi, lo studio dell’opera enciclopedica attraverso voci spesso con51 W. Roszkowski, Land Reforms in East Central Europe after World War One, Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 1995; E. J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality, Cambridge University Press, Cambridge 1990; M. Tracy, Government and Agriculture in Western Europe, Harvester Wheatsheaf, London 1989. 52 Sui caratteri di lunga durata cfr. Lanaro, Retorica e politica cit.; Id., L’Italia nuova. Identità e sviluppo (1861-1988), Einaudi, Torino 1988; Id., Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925, Marsilio, Venezia 1979. 53 Cfr. Burchardt (a cura di), Rurality, Modernity and National Identity cit., in particolare pp. 143-50. 148 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 149 Contadini e, quindi, italiani: l’Enciclopedia Italiana (1929-1938) siderate «minori» può fornire non solo un saggio della fortuna delle politiche governative fasciste, ma anche uno spunto inedito di riflessione sulla costruzione narrativa della nazione italiana in una prospettiva comparata di più lungo periodo, giacché la formazione degli autori avvenne proprio a cavallo tra Otto e Novecento. 149 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 150 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 151 PENSARE LA NAZIONE Internet e la globalizzazione contemporanea* di Tommaso Detti La parola globalizzazione aveva appena fatto il suo ingresso in alcuni dizionari e già qualcuno si affrettò a intonare un requiem allo Stato-nazione1. Fra coloro che criticarono quegli incauti epitaffi vi fu anche Silvio Lanaro: le patrie e le nazioni non sono certo eterne, scrisse nel 1996, «ma avranno esaurito il loro compito solo quando altre forme di organizzazione politica sapranno rispondere ai bisogni che attualmente sono esse a soddisfare». Il suo discorso era tanto più fondato, in quanto non ignorava il rilievo di fenomeni quali «l’addensamento dei flussi finanziari e delle economie virtuali», accennava a un «veloce rimescolamento di quelle che potremmo chiamare orbite gravitazionali della vita associata» e metteva nel conto il fatto che «lo sviluppo delle comunicazioni, l’informatica, la multimedialità tendono irresistibilmente a saltare le frontiere»2. A suo modo, questo contributo parte da lì: assume che lo Stato nazionale non ha esaurito la sua funzione e si interroga sul ruolo e sulle conseguenze di uno degli aspetti del processo di globalizzazione che ne hanno in varia misura limitato la sovranità. Quando Lanaro scriveva quelle parole, peraltro, i fenomeni ai quali più spesso ci si riferiva a tale riguardo erano l’attraversamento dei confini da parte dei flussi finanziari e migratori, nonché il ruolo delle corporations transnazionali e delle strutture di governance regionali e globali nel mondo contemporaneo. Le reti telematiche venivano citate (al plurale) essenzialmente in quanto veicoli della crescente mobilità dei capitali e a Internet non era in genere riservato che qualche sporadico accenno. * Ringrazio Giuseppe Lauricella, con il quale sto lavorando a un libro sulle origini di Internet, per avermi consentito di rifonderne qui alcuni passaggi. 1 Cfr. ad esempio K. Ohmae, La fine dello Stato-nazione e la crescita delle economie regionali, Baldini & Castoldi, Milano 1996 (1990). 2 S. Lanaro, Patria. Circumnavigazione di un’idea controversa, Marsilio, Venezia 1996, pp. 152, 146-7. 151 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 152 Tommaso Detti Benché proprio a partire dal 1996 venissero pubblicate alcune opere sulle origini e sugli sviluppi della rete3, ciò non è sorprendente. L’unificazione dei network sviluppatisi negli anni settanta e ottanta in una «rete delle reti», infatti, era ancora molto vicina e in quello stesso 1996 si contavano solo 36 milioni di «internauti»: meno dell’1% della popolazione del globo. Da allora, però, le cose sono bruscamente cambiate e internet ha acquisito un ruolo di spicco nel mondo attuale, portandovi alcune novità di grande rilievo. Ne farò una breve rassegna per verificare un’ipotesi interpretativa secondo la quale la rete ha differenziato l’odierna globalizzazione non solo da quella otto-novecentesca interrotta dall’epoca di crisi e di «deglobalizzazione» delle due guerre mondiali4, ma anche dalle prime fasi di quella dispiegatasi dopo il 1945. Dagli anni novanta a oggi gli utenti di Internet sono cresciuti a un ritmo impressionante, fino a oltrepassare nel 2011 i due miliardi: il 30% degli abitanti del pianeta5. La loro distribuzione è assai diseguale (si va dal 78,3% della popolazione nel Nord America all’11,4 in Africa), ma il cosiddetto digital divide si sta rapidamente riducendo, sia pure entro i limiti fissati dagli squilibri tra Nord e Sud che caratterizzano il mondo contemporaneo6: dal 2009 al 2011, ad esempio, gli utenti dei paesi africani hanno fatto registrare un incremento del 67,6%. Ancora più sostenuta è stata la crescita degli host, passati da 6,6 milioni nel 1995, a 126 milioni nel 2001 e a 769 nel 20107. Quanto al numero delle pagine web, per il 2000 le stime oscillano fra 350 e 500 milioni8, che nel 2010 sarebbero giunte a ben oltre 700, ma a esse va aggiunta un’enorme quantità di documenti contenuti in banche dati non 3 Se ne veda un’acuta rassegna in R. Rosenzweig, Wizards, Bureaucrats, Warriors, and Hackers. Writing the History of the Internet, in «The American Historical Review», 1998, pp. 1530-52. 4 Cfr. K. H. O’Rourke - J. G. Williamson, Globalizzazione e storia. L’evoluzione dell’economia atlantica nell’Ottocento, il Mulino, Bologna 2005 (1999). Sulle forme di globalizzazione succedutesi nel corso della storia si veda da ultimo P. N. Stearns, Globalization in World History, Routledge, London-New York 2010. 5 Cfr. Internet World Stats. Usage and Population Statistics e Internet Growth Statistics, http://www.internetworldstats.com/stats.htm e http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm (dati al 31 marzo 2011). 6 Cfr. G. Gozzini, Un’idea di giustizia. Globalizzazione e ineguaglianza dalla rivoluzione industriale a oggi, Bollati Boringhieri, Torino 2010. 7 R. Tehan, RL30435: Internet and E-Commerce Statistics. What They Mean and Where to Find Them on the Web, CRS Report for Congress, 24 ottobre 2000, http://ncseonline.org/nle/crsreports/science/st-36.cfm; Id., Internet Statistics. Explanation and Sources, CRS Report for Congress, 6 febbraio 2002, http://digital.library.unt.edu/govdocs/crs/permalink/meta-crs-3473:1; Internet Stats Today, http://internetstatstoday.com/. 8 Tehan, Internet Statistics cit., pp. 8-9. 152 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 153 Internet e la globalizzazione contemporanea reperibili con i motori di ricerca. Questo deep web ospiterebbe qualcosa come 7500 terabytes, a fronte dei 19 pubblicati sulla «superficie» della rete (un terabyte può contenere 300 milioni di pagine di testo o in alternativa 250 film o 100 000 lastre di raggi X)9. Dal 2006 al 2010, intanto, la larghezza della banda a disposizione di Internet è passata da 5 a quasi 40 terabytes al secondo, con un incremento annuo che, seppure calante dal 2008 per effetto della crisi finanziaria, è stato del 64%. Nello stesso periodo in grandi città come Londra, New York, Hong Kong e San Paolo i costi sostenuti dai provider per connettersi al backbone della rete sono diminuiti ogni anno del 25%10. Il ruolo di Internet non è peraltro misurabile sul semplice numero dei suoi utenti, degli host o delle pagine web: ogni giorno di più, infatti, la rete è usata per effettuare operazioni commerciali e finanziarie, ingloba le altre forme di comunicazione e gestione delle informazioni e – soprattutto – consente e favorisce lo sviluppo di relazioni sociali di tipo nuovo. Sia pure in estrema sintesi, di alcuni di questi fenomeni è perciò necessario render conto. L’e-commerce non è facile da misurare, e le stime presentano oscillazioni tali da rendere inaffidabili le cifre assolute11, ma la sua quota sul totale degli scambi è in fortissima ascesa12. Negli Stati Uniti tra il 2007 e il 2008 il commercio online al dettaglio è passato da 175 a 204 miliardi di dollari e le previsioni per il 2012 parlano di 335 miliardi13. In questo paese, che ospita una quota elevatissima di host, utenti e aziende attive online, l’e-commerce è particolarmente sviluppato14, ma secondo alcune stime di carattere generale nel 2008 l’85% degli internauti avrebbe acquistato qualcosa sulla rete, mentre le 10 maggiori 9 Brightplanet Corporation, The Deep Web. Surfacing Hidden Value, 2000-2009, http://www.brightplanet.com/images/uploads/12676518751-DeepWebWhitePaper_20091015.pdf. Un terabyte è pari a 1000 miliardi di bytes. 10 TeleGeography, Global Internet Geography Executive Summary, 2010, http:// www.telegeography.com/product-info/gig/download/telegeography-global-internet.pdf. 11 Per il 2000, ad esempio, B. M. Fraumeni, E-commerce. Measurement and Measurement Issues, in «The American Economic Review», 2001, 2, p. 319, riporta stime che variano da 52 a 406 miliardi di dollari per le transazioni business-to-business, da 7 a 200 per quelle business-to-consumer. 12 Cfr. D. L. Banks - Y. H. Said, Data Mining in Electronic Commerce, in «Statistical Science», 2006, 2, pp. 234-46. 13 United States Census Bureau, The 2009 Statistical Abstract. The National Data Book, http://www.census.gov/compendia/statab/2009/tables/09s1015.xls. 14 Secondo dati dell’Ocse (Business-to-Consumer E-commerce Statistics, 2001, http: //www.oecd.org/dataoecd/34/36/1864439.pdf), nel 2000 gli Stati Uniti coprivano il 65,4% del valore delle transazioni di 19 paesi aderenti (39,5 miliardi di dollari) e il 68,8% degli acquirenti (28,5 milioni). 153 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 154 Tommaso Detti compagnie globali effettuavano vendite online per 19 166 miliardi di dollari, con un aumento del 79% rispetto al 200615. Per apprezzare il rilievo di queste cifre è sufficiente porle in relazione con quelle che riguardano i processi di globalizzazione economica e finanziaria dell’ultimo quarantennio. Dal 1970 al 2007 gli investimenti esteri diretti sono passati da 10,5 a 2348 miliardi di dollari; nello stesso anno il valore degli scambi azionari risultava salito da 4783 miliardi di dollari nel 1992 a 98 816: dal 21 al 182% del prodotto lordo mondiale16. I flussi finanziari globali sono difficili da quantificare, ma è stato stimato che alla fine del XX secolo il volume quotidiano del mercato dei cambi valutari fosse 60 volte quello delle esportazioni di merci17. Negli Stati Uniti si sono registrati nel 2007 (senza considerare i «derivati») 2130 miliardi di dollari di entrate finanziarie e 1472 di uscite, a fronte di un saldo del bilancio di parte corrente di 730 miliardi. La Gran Bretagna, con un deficit di parte corrente di 80 miliardi, aveva uscite per almeno 2000; la Svizzera, con un surplus di 43 miliardi, aveva entrate per 32518. Secondo altre fonti, infine, nel 2005 i flussi finanziari netti di 99 paesi dell’Africa, dell’America Latina, dell’Europa orientale e dell’Asia (tra i quali la Cina e l’India) erano 8,4 volte la somma dei loro Pil19. Sebbene Internet non sia che una delle reti telematiche che hanno contribuito a rendere sempre più transnazionali la finanza e l’economia del pianeta, è già del tutto chiaro il suo ruolo nel mondo contemporaneo, e in particolare nei processi di globalizzazione che ne sono un aspetto cruciale. Come ha scritto Christopher T. Marsden, l’ubiquità, la rapida penetrazione e la comune necessità di flussi internazionali di dati sulle reti di comunicazione digitali (si pensi all’email di Internet), assieme agli effetti economici e sociali di tali flussi, fanno di Internet il paradigma della globalizzazione20. 15 Econsultancy Digital Marketers United, E-commerce Statistics Compendium, 2009, http://econsultancy.com/reports/e-commerce-statistics. 16 World Bank, World Development Indicators & Global Development Finance, http://data.worldbank.org/data-catalog/global-development-finance. La crisi, peraltro, ha fatto scendere gli investimenti a 1164 miliardi di dollari nel 2009 e gli scambi azionari a 63 975 miliardi (105% del Pil) nel 2010. 17 Cfr. R. Gilpin, Le insidie del capitalismo globale, Università Bocconi Editore, Milano 2001 (2000), p. 20. 18 K. H. Johnson, Gross of Net International Financial Flows. Understanding the Financial Crisis, working paper, July 2009, Council on Foreign Relations, Center for Geoeconomic Studies, http://www.cfr.org/publication/19726/gross_or_net_international_financial_flows.html. 19 NationMaster, International Development Association, Net financial flows, http://www.nationmaster.com/graph/eco_net_fin_flo_ida_cur_us_pergdp-ida-current-us-per-gdp. 20 C. T. Marsden, Hyperglobalized Individuals: the Internet, Globalization, Freedom and Terrorism, in «Foresight», 2004, 3, p. 130. 154 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 155 Internet e la globalizzazione contemporanea Si devono insomma alla rete le più significative peculiarità che distinguono l’odierna globalizzazione dalle precedenti. Le ha colte bene Moisés Naím quando – negando che «la macchina da stampa, il telegrafo e il telefono [siano] state tecnologie dall’impatto tanto dirompente in quei momenti storici quanto quello di Internet oggi» – ha scritto: L’accesso a Internet riesce a raggiungere gli angoli più remoti del globo, trasformando le vite di un maggior numero di persone in un maggior numero di paesi in un modo più economico di quanto si sia mai verificato prima, e il ritmo del cambiamento sta accelerando più velocemente di quanto possiamo sperare di poter raccontare. La globalizzazione attuale presenta inoltre tratti maggiormente individualistici rispetto a qualsiasi altra invenzione del passato. Il telegrafo fu utilizzato soprattutto dalle istituzioni mentre Internet rappresenta uno strumento autenticamente personale che consente alle donne spagnole di trovare potenziali mariti in Argentina e ai teenager del Sud Africa di condividere file musicali con coetanei che abitano in Scozia. L’odierna globalizzazione differisce anche per la velocità con cui è in grado d’integrare le attività umane in maniera spesso istantanea e quasi in assenza di costi. Inoltre, il cambiamento quantitativo di ciascuna componente della globalizzazione (economia, cultura, potere militare eccetera) è così enorme da determinare un cambiamento qualitativo21. Dei tre aspetti sottolineati da Naím – tratti individualistici, velocità e bassi costi –, quello discriminante è il primo. La trasmissione dei documenti in rete avviene infatti in tempo reale e l’accelerazione che ne è derivata ha prodotto un fondamentale cambiamento qualitativo; ma la velocità non è prerogativa solo di Internet (alcuni media analogici la possiedono in misura maggiore) e mutamenti comparabili, in termini relativi, si sono verificati anche nel passato. Una crescente rapidità caratterizza infatti da secoli la storia delle comunicazioni ed è stata un fattore decisivo delle precedenti forme di globalizzazione, definite da Christopher A. Bayly come progressivi incrementi «delle dimensioni di scala dei processi sociali da un livello locale o regionale a un livello mondiale»22. Applicando allo spazio una misura di tempo, Fernand Braudel disse che nell’età di Filippo II il Mediterraneo era lungo 60 giorni23. Nel Settecento i progressi della navigazione a vela «restrinsero» l’Atlanti21 M. Naím, Think Again. Globalization, in «Foreign Affairs», 16 febbraio 2009, http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/02/16/think_again_globalization (trad. it. Globalizzazione? Indietro non si torna, in «Il Sole 24 Ore», 16 aprile 2009). 22 C. A. Bayly, «Archaic» and «Modern» Globalization in the Eurasian and African Arena, ca. 1750-1850, in Globalization in World History, a cura di A. G. Hopkins, Norton, New York 2002, p. 47. 23 F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II (1949), Einaudi, Torino 1965, pp. 422-8. 155 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 156 Tommaso Detti co alle dimensioni del Mediterraneo di due secoli prima e negli anni quaranta dell’Ottocento le navi a vapore lo ridussero a due settimane24. Nel contempo il telegrafo elettrico fece sì che per la prima volta le informazioni non viaggiassero più al seguito degli uomini, separando i messaggi dai loro vettori25, e dopo il 1865 – quando un cavo sottomarino collegò il Vecchio e il Nuovo mondo – «miniaturizzò» l’Atlantico, abbattendo i tempi delle comunicazioni intercontinentali dalle settimane ai minuti. Non a caso Reinhart Koselleck, individuando nell’accelerazione il criterio generale e «infallibile» per distinguere la modernità, ne ha collocato gli inizi fra il XVI e il XVIII secolo26. Certo, assieme ai bassi costi dell’accesso a Internet da parte di ogni privato cittadino, la velocità contribuisce a farne un mezzo di comunicazione più personale che istituzionale, differenziandolo da quelli del passato. Tuttavia né gli uni né l’altra basterebbero a spiegare questa peculiarità se non si tenesse conto del fatto che la rete, grazie alle sue caratteristiche, ha creato nuove forme di comunicazione sociale. La televisione è gerarchica e unidirezionale perché l’informazione vi viene trasmessa dal centro alla periferia e non viceversa; il telefono stabilisce un collegamento paritario, ma fra due sole persone; la rete connette fra loro un gran numero di individui e al tempo stesso è interattiva perché ognuno dei suoi nodi trasmette e riceve: tutte le macchine e coloro che le usano hanno uguali possibilità. Perciò Internet conferisce all’odierna globalizzazione quei tratti individualistici che più di ogni altra cosa la distinguono dalle precedenti. Tali tratti si sono molto accentuati da quando il web è entrato in una fase che è stata definita 2.0. L’espressione viene in genere riferita ad alcuni mutamenti intervenuti nelle modalità con le quali coloro che scrivono programmi per il web e gli utenti finali si servono della rete. Uno di essi consiste nella possibilità di aggiungere commenti alle pagine pubblicate su Internet. Così una gran quantità di informazioni prima riservate alla comunicazione a due, o al massimo all’interno di gruppi più o meno chiusi come le mailing list (riflessioni estemporanee, sfoghi, reazioni immediate), è divenuta visibile a chiunque grazie ai motori di ricerca. Siti web quali eBay, Wikipedia, YouTube, Face24 A. Briggs - P. Burke, Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet, il Mulino, Bologna 2002 (2000), pp. 38, 158. 25 T. Rantanen, The Media and Globalization, Sage Pub., London 2005, p. 49. 26 Cfr. R. Koselleck, «Età moderna» (Neuzeit). Sulla semantica dei concetti moderni di movimento, in Id., Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Marietti, Genova 1986, pp. 258-99; Id., The Eighteenth Century as the Beginning of Modernity (1987), in Id., The Practice of Conceptual History. Timing History, Spacing Concepts, prefazione di H. White, Stanford University Press, Stanford 2002, p. 165. 156 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 157 Internet e la globalizzazione contemporanea book e i blog sono altrettante espressioni di tali modalità: consentono a ogni utente di condividere e scambiare con altri beni posseduti, conoscenze, filmati, immagini, dati personali, opinioni e pensieri. I dati che li riguardano sono dunque molto significativi. Fondato nel 1995, eBay è passato da 340 000 utenti nel 1997 a più di 94 milioni nel 2010, e il valore dei loro scambi è salito da 100 milioni a 92 miliardi di dollari27. Di eBay, fra l’altro, ha fatto parte nel 20052009 un mezzo di comunicazione come Skype, i cui utenti in quel periodo sono passati da 171 a 521 milioni28. A loro volta le voci pubblicate dalla versione inglese di Wikipedia sono passate da 19 700 nel 2002 a 3,7 milioni nel giugno 201129, quando le ore di video caricate ogni minuto su YouTube erano divenute 48: il doppio del 2010, otto volte quelle del 200730. E ancora, nel 2009 Facebook ha fatto registrare quasi 1 miliardo e 200 milioni di visite al mese, a cui vanno aggiunte le 810 000 di Myspace e le 425 000 degli altri 18 social network più diffusi31. Quanto ai blog, che rientrano sempre più fra le attività dei social network, dal 2003 al 2006 il loro numero è salito da meno di 2 a 34,5 milioni. Nel 2008 i messaggi «postati» in ventiquattr’ore nella «blogosfera» erano 900 000 e il 77% degli utenti attivi di Internet leggeva blog32. L’impatto di questi e altri fenomeni che sarebbe lungo elencare sulle relazioni sociali fra singoli e gruppi più o meno vasti è stato enorme e ha avuto ripercussioni molto rilevanti anche sulla cosiddetta sfera pubblica. Da quando notizie e opinioni sono liberamente accessibili in rete, la diffusione di quotidiani e riviste, in ascesa dagli anni quaranta, è entrata in una fase di declino, particolarmente rapido negli Stati Uniti: le copie dei giornali, che nel 1989 vi avevano superato i 62 milioni, dal 1994 hanno preso a diminuire e nel 2009 sono scese a 46,2 milioni, cioè ai livelli degli anni cinquanta33. Benché in misura meno accentuata, un trend analogo si riscontra anche in altri paesi dell’Ocse: dal 2007 27 Cfr. eBay Inc., Form 10-K For the Year Ended December 31, 1998 e eBay Annual Report 2010, http://investor.ebayinc.com/annuals.cfm. Dati su eBay dal 1996 al 2006, come altri che seguono nel testo, sono anche in J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, Einaudi, Torino 2011 (2010), pp. 141-2, 158, 171, 174-8. 28 Cfr. eBay Inc., Form 10-K For the Year Ended December 31, 2006, http://investor.ebayinc.com/annuals.cfm. 29 Size of Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_of_Wikipedia. 30 You Tube Gets 48 Hours of Video Every Minute!, 25 maggio 2011, http://www.youtube.com/watch?v=vQibgVXDG90. 31 Cfr. http://blog.compete.com/2009/02/09/facebook-myspace-twitter-social-network/ (dati al gennaio 2009). 32 Technorati, State of the Blogosphere 2006, 2008, 2010, http://technorati.com/state-ofthe-blogosphere/. 33 Newspaper Association of America, Total Paid Circulation, http://www.naa. org/TrendsandNumbers/Total-Paid-Circulation.aspx; Ryan, Storia di Internet cit., pp. 186-7. 157 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 158 Tommaso Detti al 2009 la Gran Bretagna ha fatto registrare un calo del 21%, seguita da Grecia, Italia, Canada, Spagna, Turchia e Giappone con flessioni del 20-15%34. Vero è che secondo altre stime in 65 paesi di vari continenti tra il 2000 e il 2004 le tirature dei quotidiani sono salite da 426,8 a 463,3 milioni, ma questo dato è la somma algebrica di 12,9 milioni di copie diminuite in 23 paesi e di 51,2 aumentate in altri 40. Se si tolgono dal conto la Cina e l’India, dove si è concentrato un incremento di 40,4 milioni di copie, il saldo totale è inoltre negativo35. Anche sulle forme della politica l’influenza di Internet è stata assai rilevante. Come ha scritto Johnny Ryan, la rete è divenuta sempre più il «sistema nervoso» delle campagne presidenziali americane, dando infine un importante contributo alla nomination di Barack Obama e alla sua vittoria nel 2008. Oltre a facilitare l’afflusso di un gran numero di piccoli contributi finanziari da parte del pubblico in luogo di poche cospicue donazioni, il ricorso a Internet da parte di alcuni candidati ha sostituito alla tradizionale comunicazione unidirezionale «uno a molti» una logica colloquiale, interattiva e decentrata, che ha favorito un’attiva partecipazione di massa e lo sviluppo di «politiche bidirezionali»36. È stata inoltre la rete a consentire la formazione e lo sviluppo di movimenti transnazionali come quelli cosiddetti no global o new global, fondati su «strutture organizzative e di appartenenza, ognuna delle quali costituisce un assemblaggio di varie reti e coalizioni, in assenza di organismi centralizzati o di gerarchie»37. Attivi anzitutto nei campi dei diritti umani e civili, dell’ambiente, della pace, della giustizia e dell’ineguaglianza globale, questi «movimenti di movimenti» riflettono la struttura della «rete delle reti» che li ha resi possibili38. Le 34 Ocse, Directorate for Science, Technology and Industry, The Evolutions of News and the Internet, 2010, http://www.oecd.org/dataoecd/30/24/45559596.pdf. 35 Unesco Institute for Statistics, Public Reports, Newspapers, http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=398. 36 Cfr. Ryan, Storia di Internet cit., pp. 191 sgg. Sottolineano invece alcuni limiti dell’uso politico della rete negli Stati Uniti S. Zavestoski, S. Shulman, D. Schlosberg, Democracy and the Environment on the Internet. Electronic Citizen Participation in Regulatory Rulemaking, in «Science, Technology, & Human Values», 2006, 4, pp. 383-408. 37 K. G. Ghimire, The Contemporary Global Social Movements. Emergent Proposals, Connectivity and Development Implications, United Nations Research Institute for Social Development, Programme on Civil Society and Social Movements, Paper n. 19, 2005, p. 9, http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/%28httpAuxPages%29/F0F8C2DF84C2FB2 DC1257088002BFBD9/$file/ghimire.pdf. 38 Cfr. tra gli altri J. Clark - N. Themundo, The Age of Protest. Internet-Based «Dot Causes» and the «Anti-Globalization» Movement, in Globalizing Civic Engagement. Global Society and Transnational Action, Earthscan, a cura di J. Clark, Earthscan, London 2003, pp. 109-26; S. Tarrow, The New Transnational Activism, Cambridge University Press, Cambridge 2005; S. Tarrow - D. Della Porta (a cura di), Transnational Protest and Global Activism. People, Passions, and Power, Rowman & Littlefield, Lanham 2005. 158 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 159 Internet e la globalizzazione contemporanea stesse caratteristiche si riscontrano nei movimenti delle «primavere arabe» del 2011. Più in generale, è nelle relazioni sociali tra singoli e gruppi che questo mutamento ha prodotto i suoi effetti più corposi. Connettendo fra loro una moltitudine di persone in uno spazio globale aperto e abbattendo le distanze che li separano in quello fisico, il web ha dato voce a soggetti che in passato l’avevano avuta per lo più in circostanze eccezionali e/o in ambiti geografici o sociali circoscritti. Nel loro insieme le diverse forme di relazione sociale che ne sono scaturite configurano un fenomeno di indubbia novità, alla cui comprensione può peraltro giovare la categoria di sociabilità applicata da Maurice Agulhon alla Francia tra XVIII e XIX secolo39. Questo concetto, che rimanda alla microsociologia dei gruppi di Georges Gurvitch, descrive infatti l’intensità della vita associata a partire dalle relazioni interindividuali e dalle modalità nelle quali si esplicano. Si tratta di uno strumento molto utile per analizzare le reti di relazione sviluppatesi su Internet perché rinvia alle loro forme e alle loro articolazioni prima e più che alle strutture sociali (di classe, professionali ecc.), sottolineando la permeabilità dei campi sociali e ponendo l’esigenza di definire i diversi gruppi in base alla loro funzione e agli spazi che occupano40. Tutte queste forme di attività e di sociabilità sono scaturite da quella che Marsden ha definito una «hyperglobalization of the individual», sostenuta anche dalla forte crescita del numero dei telefoni cellulari collegabili alla rete, dando luogo a un «hyperglobalized interdependent Internet planet»41 e aprendo una nuova fase della globalizzazione contemporanea. Questa sua peculiarità dipende essenzialmente dalla natura non gerarchica, acefala, aperta e individualistica di Internet. Perché la rete abbia assunto e conservato sino a oggi tali caratteristiche, è questione per rispondere alla quale occorrerebbe ripercorrer39 Cfr. M. Agulhon, Pénitents et Francs-Maçons de l’ancienne Provence. Essai sur la sociabilité meridionale, Fayard, Paris 1968; Id., Il salotto, il circolo e il caffè. I luoghi della sociabilità nella Francia borghese, 1810-1848 (1977), a cura di M. Malatesta, Donzelli, Roma 1993. 40 Cfr. G. Gemelli - M. Malatesta, Le avventure della sociabilità, in Forme di sociabilità nella storiografia francese contemporanea, a cura di G. Gemelli e M. Malatesta, Feltrinelli, Milano 1982, e i riferimenti bibliografici ivi citati. 41 Marsden, Hyperglobalized Individuals cit., pp. 130, 138. Nell’ottobre 2010 si stimava che entro l’anno i cellulari sarebbero ammontati a 5,3 miliardi, 940 milioni dei quali con accesso a servizi 3G: cfr. International Telecommunications Union, The World in 2010. Ict Facts and Figures, http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf. 159 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 160 Tommaso Detti ne la storia a partire dalle origini, che risalgono agli anni sessanta del Novecento42. In ogni caso le conseguenze che ne sono derivate hanno avuto un forte impatto non solo sugli Stati-nazione, ma anche su tutte le altre forme subnazionali e sovranazionali di organizzazione economica, sociale, politica e culturale del mondo contemporaneo, modificandone sia le dinamiche interne, sia i rapporti reciproci. È quasi superfluo sottolineare, del resto, che la rete favorisce sì la diffusione di una cultura globale standardizzata, ma al tempo stesso contribuisce al rafforzamento di culture e identità specifiche, tra le quali quelle nazionali. Mettere in agenda studi che permettano di comprendere meglio tali dinamiche sarebbe perciò quanto mai opportuno. Più modestamente, questo contributo intendeva soltanto richiamare l’attenzione su un problema ancora troppo trascurato. 42 Per una sintetica anticipazione cfr. T. Detti - G. Lauricella, Internet. Dalle origini al web 2.0, in «Mundus», 2009, 1, pp. 142-8. 160 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 161 PENSARE LA NAZIONE Over There di Gian Piero Brunetta Nel 1927 sull’«Eco del cinema», una delle riviste cinematografiche a carattere pubblicitario che fioriscono in un mercato in cui i prodotti italiani sono ormai quasi invisibili, appare la fotografia di un treno, con le ruote di gomma, accompagnata dalla didascalia: «Il treno della Metro Goldwyn Mayer, in partenza da Los Angeles per il giro del mondo, passa in Italia tra qualche giorno seguendo questo itinerario: Ventimiglia, Genova, Torino, Milano, Roma, Napoli». Confesso di non essermi ispirato all’Iliade nel cominciare il racconto dell’epopea della colonizzazione cinematografica hollywoodiana già a dieci anni circa dal suo vero inizio, ma forse è giusto fare un fermo immagine per tornare indietro e vedere come tutto ha inizio. Perché il cinema americano, dieci anni prima, durante la guerra mondiale, ha subito seguito le truppe americane sbarcate in Europa ed è andato alla conquista dei pubblici europei, avviando piani espansionistici inediti non solo sul piano commerciale. In effetti a pochi giorni dall’entrata in guerra degli Stati Uniti il 7 aprile 1917, come ci ha raccontato Vittorio Martinelli, una gigantesca flotta lascia i porti dell’Atlantico diretta verso l’Europa. A bordo della nave ammiraglia, assieme al comandante della spedizione generale Pershing, vi sono anche i civilians: tra questi i rappresentanti dell’Universal, della Famous Players Lasky, della Triangle e di un consorzio di case cinematografiche minori, denominato Transatlantic. Sbarcati nel vecchio continente questi inviati del Gotha del cinema americano, raggiungono Parigi ed è dalla Ville Lumière che comincerà la vera e propria conquista del mercato cinematografico europeo. Nei numeri di giugno-luglio cominciano ad apparire nelle riviste cinematografiche le prime inserzioni pubblicitarie per i film di Mary Pickford, Lillian Gish, Priscilla Dean, Douglas Fairbanks, Larry Semon, per il quale viene prescelto il soprannome di Ridolini1. 1 V. Martinelli, L’eterna invasione, La Cineteca del Friuli, Gemona 2002 , p. 7. 161 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 162 Gian Piero Brunetta Da un certo momento le vie della colonizzazione e le tecniche dell’evangelizzazione hollywoodiana si sono ramificate, costituendo un tessuto compatto di motivi, ripetuti e variati, finora mai del tutto studiati. E di cui tuttora sfuggono le novità all’interno dei processi di crescita di domanda e offerta nei confronti di prodotti che hanno conseguenze sull’economia mondiale. Ne consegue, comunque, che, oltre a una nuova esplorazione dei fenomeni dal punto di vista economico, il campo si potrà studiare per la rapidità con cui vengono fissati i canoni dell’entertainment e i nuovi principi comunicativi di valore universale; e poi andranno studiate le caratteristiche dei fenomeni di sedimentazione emotiva e cognitiva e gli effetti di media e lunga durata sui pubblici e sui differenti sistemi politici e culturali con cui entrano via via a contatto o in rotta di collisione. Alle denunce immediate, sul piano europeo, dei pericoli e dell’invasione barbarica di questa nuova forma di divertimento popolare non ha mai fatto seguito, né subito né dopo, alcuna ricerca che tentasse di fissare e ricomporre gli elementi che stanno all’origine della grande guerra mondiale mediatica che ha imposto, a partire dagli anni venti, il modello egemone di cultura popolare americana nel mondo. Solo di recente, nel 2010, è uscito un libro inchiesta del giornalista e ricercatore francese Fréderic Martel, frutto di cinque anni di lavoro in trenta paesi e di milleduecento interviste, dal titolo Mainstream, che, con il suo sottotitolo Come si costruisce un successo planetario e si vince la guerra mondiale dei media2, indaga, in modo originale e a tutto campo, i meccanismi di costruzione dei bestseller mediatici mondiali, definendo uno scenario assai dinamico e ricco di elementi nuovi, ma anche assai utile per uno sguardo retrospettivo. Oggi la campagna commerciale di un lungometraggio hollywoodiano – scrive Martel – è un vero e proprio piano di battaglia organizzato su diversi continenti. È la tappa fondamentale di ogni film mainstream. Negli ultimi trent’anni queste campagne sono diventate sempre più complesse e i loro costi sono raddoppiati (circa 2 milioni di dollari in media per un film di una Major nel 1975, 39 milioni in media nel 2003, ma si è arrivati anche a oltre 100 milioni per i grandi film commerciali come I pirati dei Caraibi)3. Nel giro di quattro pagine Martel riesce a mettere a fuoco, come meglio non si potrebbe, i meccanismi del marketing americano degli 2 F. Martel, Mainstream. Come si costruisce un successo planetario e si vince la guerra mondiale dei media, Feltrinelli, Milano 2011. 3 Ibid., p. 89. 162 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 163 Over There ultimi trent’anni, a mostrare le varie fasi di preparazione di una campagna a partire dall’individuazione di un potenziale pubblico. A un certo punto l’autore ci spiega che «queste campagne di marketing tradizionali e di massa erano ben rodate fino all’avvento di internet, che ha cambiato completamente lo scenario»4. Se oggi il lavoro di Martel ci fa capire la presenza necessaria della Coca-Cola e dei popcorn nel rito della visione cinematografica degli ultimi trent’anni, uno sguardo retrospettivo di più lunga gittata analitica sui denominatori comuni delle campagne pubblicitarie di alcune Majors ci fa capire come, fin dall’inizio dell’espansione, sia stata considerata l’importanza della creazione, per ogni film, di una rete di connessioni con le diverse realtà ambientali il più aperta e articolata possibile. Nella letteratura e negli studi sull’economia cinematografica americana ben pochi lavori però si sono addentrati in passato sulle vie del marketing. I sentieri più conosciuti sono piuttosto altri. Da una parte esiste, ed è la più esplorata e mappata, la grande via divistica, che si forma e discende direttamente dall’Olimpo di Hollywood e presenta le sue costellazioni ben visibili, con il suo firmamento di stelle di prima grandezza, più o meno fornite di tutti gli elementi caratterizzanti la deità e dotate di una propria luce autogena; dall’altra si possono osservare fenomeni complanari di diffusione e penetrazione del sistema, costituenti una specie di galassia che si muove su tempi e misure di scala differenti. Ma se cerchiamo di vedere come si organizza e articola il lavoro sottostante, di preparazione per il lancio e la messa in orbita che consente ai film e ai divi di raggiungere i grandi pubblici, e a determinati contenuti di farsi strada nell’immaginazione dei pubblici dei diversi continenti, adattandosi di volta in volta agli ambienti specifici, ci troviamo di fronte a percorsi che sembrano insieme vecchi e nuovi. Rotte che mettono a frutto, in nuovi grandiosi scenari commerciali, assieme a studi di mercato e di previsione dei comportamenti e delle psicologie di massa, di analisi e selezione accurata dei contenuti, anche saperi e modalità di vendita capillari – quasi con sistemi porta a porta – che giungono da molto lontano. Proprio il citato trenino con le ruote di gomma della Metro, che si ferma in una piazza italiana nel giorno del mercato, o sosta di fronte a una stazione, adotta un modo di promozione merceologica poco più aggiornato ed evoluto rispetto a quello dei colporteurs, che, fin dal me4 Ibid., p. 93. 163 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 164 Gian Piero Brunetta dioevo, hanno battuto le fiere, i mercati, le piazze, i luoghi pubblici e privati lungo tutte le strade europee, vendendo ogni genere di mercanzia e coprendo il territorio metro per metro5. In un processo di rapidissima globalizzazione e d’ideazione ininterrotta di strategie innovative di vendita di prodotti immateriali a persone appartenenti a tutte le classi sociali (e qui è la prima vera grande rivoluzione merceologica) anche le conoscenze che giungono da secolari commerci ambulanti vengono metabolizzate e riutilizzate con successo. E con gli adattamenti più opportuni agli ambienti diversi in cui si deve operare. Il cinema americano è stato anche questo: ha inventato sistemi di commercializzazione dei suoi prodotti del tutto all’avanguardia sul mercato internazionale in quanto fondati su contenuti forti e condivisibili ovunque nel mondo, su principi di inclusione di qualsiasi tipo di pubblico, di qualsiasi livello culturale e sociale e su algoritmi emozionali inediti, riuscendo, nello stesso tempo, a far tesoro di esperienze di lunga durata. Il suo raggio d’azione e i suoi obiettivi non si sono mai limitati ai pubblici delle grandi sale urbane. Hanno piuttosto contemplato e previsto una strategia di penetrazione capillare nelle aree periferiche e nelle campagne, un contatto diretto e la creazione di un rapporto, quasi di familiarità, se non di amicizia coi gestori delle piccole sale di provincia, per contendere alle diverse cinematografie nazionali ogni tipo di pubblico, fino all’ultimo spettatore. Come esempio, una sola lettera, inviata il 20 settembre del 1935 dal direttore della subagenzia di Padova della Metro Goldwyn Mayer a Gino Gottardi, proprietario e gestore del cinema Smeraldo di Valeggio sul Mincio: La presente solo per ringraziarla della cortese accoglienza che ha voluto riservarmi al mio passaggio a Valeggio ed esprimerle la fiducia che i nostri rapporti, nati da un così simpatico abboccamento, abbiano a continuare a lungo cordialissimi. Voglia gradire ed estendere a tutta la famiglia i miei più distinti saluti. Seguendo la programmazione di questa piccola sala negli anni trenta, fino alle leggi del 1938, ci si accorge che gli spettatori dello Smeraldo sono alimentati, quasi esclusivamente, dal cinema americano e che la programmazione di qualsiasi film italiano, nel corso di quegli anni, sembra quasi frutto di un atto di violenza e di invasione nei confronti 5 Rinvio al mio Il viaggio dell’icononauta. Dalla camera oscura di Leonardo alla luce dei Lumière, Marsilio, Venezia 1998. 164 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 165 Over There dei bisogni accertati del pubblico, che pare non desiderare altro cinema che quello di Hollywood. «Parlare delle persone e delle cose di Hollywood oggi è di moda». Così inizia Il mito di Hollywood di Umberto Colombini, secondo libro sulla capitale del cinema dello stesso autore (il primo si intitola Hollywood visione che incanta) nel giro di circa due anni6. Hollywood è un luogo di un culto che si è diffuso a livello mondiale in poco tempo, la più gigantesca macchina mitopoietica del Novecento, una realtà lontana in cui abitano, come in una versione moderna dell’Olimpo, esseri circonfusi dall’aura della divinità e circondati dai simboli significativi del loro successo, oggetto di culto di milioni di persone sparse in tutto il mondo. E, al tempo stesso, è un habitat familiare, osservato con strumenti di varia portata visiva, ora telescopica ora quasi microscopica, da cui si irradia uno spirito capace di dar vita a giganteschi flussi sentimentali e d’aiutare l’uomo comune, il proletario e il piccolo borghese, il vagabondo e l’operaio, la commessa e la casalinga, a immaginare il proprio futuro, a realizzare continui transfert del proprio desiderio con minima spesa, ma consistente investimento affettivo e reazioni neuroniche. I divi e gli eroi, ma anche solo gli uomini qualunque alla base della piramide sociale, i John Doe, i Longfellow Deed del cinema americano degli anni trenta, così come le goldiggers e le flappers, vengono, poco alla volta, a configurarsi come proiezioni inquietanti o processi d’identificazione di ciò che l’italiano medio, indifferente se non del tutto estraneo all’avventura imperialistica, desidera essere. La sala entro cui, con frequenza regolare e periodica, si celebrano i riti della visione collettiva di prodotti hollywoodiani, diventa così, tra le tante cose, un contenitore privilegiato di una potente carica di emozioni e speranze di un popolo che pare avvertire la trascrizione sullo schermo (quasi per un effetto di sdoppiamento e specularità) delle proprie pulsioni, o la rappresentazione del proprio inconscio: lo schermo diventa luogo di espansione privilegiato e dalle dimensioni indefinite dello spazio desiderante. Su un altro piano, un punto di confluenza e contaminazione di forme e modelli narrativi legati alla visione popolare, mescolati con nuove mitologie e rielaborati in base a una metrica e una ritmica inedite, mai riscontrate prima in altre forme dello spettacolo popolare. Hollywood diventa anche uno Stato sovrano in diversi Stati europei: ha il potere di trasformare in moneta corrente le immagini dei suoi 6 U. Colombini, Il mito di Hollywood. La sua aureola, la sua illusione, la sua realtà, La Prora, Milano 1931, preceduto da Hollywood visione che incanta, Lattes, Torino 1929. 165 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 166 Gian Piero Brunetta divi, è in grado di esercitare un potere psicologico, morale, ideologico superiore a quello esercitato dalle istituzioni tradizionali. Di fatto non esiste, né è mai esistito, alcun prodotto, o alcuna forma di pensiero, o alcun messaggio capace di avere una ricaduta globale così immediata e così capillare come quello del cinema. Per quanto la memoria di molti spettatori, più o meno illustri, tenda a non enfatizzare l’importanza dei film americani, è importante capire che non si tratta solo d’assimilazione e alimentazione costante; il cinema americano ha la funzione di irrorare molti gangli vitali legati alle funzioni emotive, morali, conative, deittiche, ideali, ideologiche, di attivare i neuroni specchio, di dilatare l’atlante delle emozioni, facendole andare alla scoperta di terre incognite e per molti inimmaginabili fino alla rivelazione nella sala cinematografica. La bulimia di milioni di spettatori italiani e di tutto il mondo, unita all’overdose di prodotti hollywoodiani, produce effetti non subito visibili o misurabili, importanti come fattori di crescita sentimentale e morale di mutamento della mentalità, di allargamento di diversi orizzonti… Come si può misurare, in termini quantitativi, la consistenza del patrimonio di immagini e mitologie che si sono depositate nella memoria dello spettatore popolare europeo e italiano in particolare nel periodo tra le due guerre, la sua durata e persistenza, il potere e l’influenza esterna e la produttività nel contesto di tutta l’azione pubblicitaria e comunicativa rispetto al rapporto privilegiato della pellicola con lo schermo e la sala? Di sicuro dagli anni trenta qualsiasi potenziale spettatore è sottoposto a un bombardamento ininterrotto d’immagini che lo accompagnano anche al di fuori della sala cinematografica, lungo tutti i suoi percorsi obbligati o le sue deambulazioni urbane nei luoghi più diversi. Le immagini divistiche gli appaiono nei giganteschi ingrandimenti degli addobbi esterni delle sale, nelle bacheche delle sale stesse, nei manifesti sparsi per la città, nelle vetrine dei negozi, nei bar, nelle hall degli alberghi, negli atri delle associazioni sportive, nelle pagine dei giornali e delle riviste illustrate… Dei divi si parla alla radio, sui giornali, sulle riviste illustrate nelle migliaia di lettere inviate ai rotocalchi e i commenti sulle loro performance cinematografiche, o le notizie e i pettegolezzi sulla loro vita privata sono spesso un denominatore comune di conversazione tra conoscenti o estranei. Anche senza volerlo gli italiani, nelle grandi città, ma ben presto anche nei piccoli paesi raggiunti dal cinema, respirano a pieni polmoni le polveri sottili che accompagnano ogni film americano e qualche effetto rispetto all’aria di casa verrà registrato. «Dice Federico Fellini – 166 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 167 Over There ricordava Biagi – che se non siamo cresciuti proprio stupidi, visti i canoni dell’educazione fascista in vigore a quei tempi, lo dobbiamo anche ai film americani»7. L’avvento del sonoro – hanno osservato Raffaele De Berti e Marina Rossi in uno studio pionieristico sul ruolo dei rotocalchi nella formazione della cultura di massa – porta il cinema insieme alla stampa periodica, soprattutto femminile e alla radio, ad essere il punto focale della cultura di massa. Sono i film di Hollywood che hanno un grande successo, anche in Italia, fino alle leggi autarchiche […] a soddisfare l’immaginario del grande pubblico. Un immaginario in cui dominano i temi della gioventù, del fascino misterioso, della bellezza e della seduzione. È proprio su questi temi che si realizza l’interazione reciproca fra stampa periodica a rotocalco e cinema, che sostenendosi e rimandandosi a vicenda, favoriscono la diffusione e il consumo di entrambi i prodotti di massa ad essi associati8. Pur avendo a disposizione il frutto delle ricerche storiche e filmografiche di Lorenzo Quaglietti9, Vittorio Martinelli10 e Mario Guidorizzi11, che hanno il merito di aver già esplorato non pochi aspetti e quantificato il numero di film americani giunti in Italia dagli anni venti alla fine degli anni trenta, non pochi problemi restano aperti, oltre a non essere finora riusciti a precisarne l’influenza sul piano dei comportamenti di massa o di gruppi sociali in termini linguistici, ideologici, di modificazione della mentalità, di costruzione di un immaginario collettivo e individuale. Non si è di fatto mai pensato, neppure per quanto mi risulti, da parte degli studiosi americani, di esaminare le tecniche di promozione e lancio dei prodotti cinematografici e delle mitologie divistiche, di smontarne i meccanismi, analizzare la morfogenesi e le caratteristiche dinamiche ed evolutive con cui si costruisce un brand, un marchio ben riconoscibile e dotato di un’identità diversa dagli altri, indicarne la continuità, le variazioni e le ragioni del successo, cercando di mettere a fuoco, in modo significativo, le differenti strategie da casa a casa, il ruolo dei vari soggetti e i modi del processo comunicativo. Le Majors scelgono di sviluppare una strategia di penetrazione del mercato italiano mettendo in azione più forze che interagiscono e opeE. Biagi, Hollywood santuario dei sogni, in «Panorama», 1° agosto 1973, p. 73. R. De Berti - M. Rossi, Cinema e cultura popolare. I rotocalchi illustrati, in F. Casetti R. De Berti, Il cinema a Milano tra le due guerre, in «Comunicazioni sociali», a. X, lugliodicembre 1988, 3-4, p. 228. 9 L. Quaglietti, Ecco i nostri. L’invasione del cinema americano in Italia, Eri, Torino 1991. 10 Martinelli, L’eterna invasione cit. 11 M. Guidorizzi, Il mito di Hollywood, I, Tutto sui film americani dal 1930 al 1949; II, Tutto sui film americani dal 1950 al 1960, Esi, Napoli 1999. 7 8 167 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 168 Gian Piero Brunetta rano a campo totale. I bollettini pubblicitari costituiscono una delle fonti meno studiate e, per quanto più sconosciute, più significative per capire analogie e differenze di strategia propagandistica e avere un immediato termometro del successo commerciale dei film americani. «La Voce del Leone», ad esempio, è un bollettino Metro Goldwyn Mayer, che nasce nel 1932 e interrompe le pubblicazioni nel 1938, per poi riprenderle nel dopoguerra. Ed era senz’ombra di dubbio la più rappresentativa delle tecniche pubblicitarie del cinema americano, colte in un arco di tempo che va dallo stato nascente al punto zenitale, almeno per la fase successiva alla nascita del sonoro. Ogni film, come è dichiarato dalle brochure, fruisce sempre di una campagna personalizzata ed «eccezionale». Prendiamo per tutti il piano di lancio di Amore in corsa, di W. S. Van Dyke: Anche Amore in corsa fruisce di una eccezionale propaganda di stampa, nella immediatezza della sua presentazione sugli schermi italiani. I 46 quotidiani, tra i più diffusi d’Italia, che fanno parte del congegno pubblicitario Metro, sono mobilitati per annunciare ed illustrare l’avvenimento cinematografico. Fin dagli anni precedenti l’esercente conosce la portata e l’effetto delle nostre campagne di stampa: quest’anno esse saranno ancora più curate nella veste e nella materia. Se si osservano i bollettini pubblicitari, l’onda del successo è esibita da tutti come crescente, anno dopo anno: «1937-38, una produzione che farà epoca!», annunciano i bollettini Metro, ma il tono trionfalistico raggiunge il suo apice l’anno successivo, quando si celebra il 15° anniversario della marcia dei film Metro in Italia e con questi slogan si dichiara di voler inaugurare una nuova fase di conquista del pubblico italiano: «La marcia trionfale dei primati Mgm è in atto! La produzione del XV anniversario è in marcia». Nessuno, tra i rappresentanti delle Majors, avverte i pericoli incombenti. Nessuno è in grado di immaginare che nei prossimi mesi verrà approvata una legge che intende condizionare, in modo significativo, la circolazione del cinema americano nel mercato italiano. L’idillio con il fascismo sta finendo, eppure produttori ed esercenti americani sembrano non volersene accorgere. Nessuna nuvola si profila mai nel loro orizzonte luminoso e numinoso. Mentre la marcia su Roma del fascismo di fatto è un episodio assai circoscritto, quella effettuata dal cinema americano si è svolta nel tempo e per gradi, dando quasi l’impressione ora di muoversi sulla scia della marcia del regime, ora di procedere in perfetta sintonia, ora in parallelo, ma sempre senza perdere il passo con un ritmo crescente. 168 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 169 Over There Col passare del tempo la marcia si è trasformata in apoteosi e il gruppo dei grandi dittatori dell’industria cinematografica hollywoodiana prende coscienza, poco alla volta, della potenza effettiva che l’esercito di divi, attori, comparse, registi e tecnici è in grado di esprimere. Nella realtà del mercato internazionale, percepita a lungo in maniera indistinta, Roma brilla ben presto, più ancora di Parigi, come la stella polare, la meta verso cui orientare, in prima istanza, tutte le rotte produttive. Lo spettatore italiano rivela da subito naturali doti di ospitalità e appare come il più immediatamente disponibile a familiarizzare con Greta Garbo, Marlene Dietrich, Norma Shearer, Claudette Colbert, Mae West, Jean Arthur, Joan Crawford, Jean Harlow, Robert Taylor, Clark Gable, William Powell, Mirna Loy, Constance Bennett, i fratelli Marx, Jeanette MacDonald… Sugli schermi delle grandi sale cittadine e sui teloni dei cinema ambulanti c’è posto per tutti. Accanto al dilagare della produzione fin dai primi anni venti, quando quella italiana collassa e affonda nel giro di poche stagioni come il Titanic, si diffonde una ricchissima pubblicistica di supporto che ha il compito, una volta attivate le diverse forme di culto divistico, di mantenerle vive, di creare un fitto sistema di comunicazioni con l’Olimpo hollywoodiano e di organizzarvi e predisporre, nel modo più spettacolare, vere e proprie forme di trasmigrazione ideale di massa. Tutto questo, paradossalmente, nel momento di massima espansione del culto mussoliniano. I due fenomeni, come mi è accaduto di dimostrare in varie occasioni, non interferiscono fra loro. Piuttosto procedono in parallelo e il fascismo non sembra avvertire un possibile concorrente ideologico nel cinema che giunge d’Oltre Oceano e negli ideali che trasmette. Anzi favorisce la circolazione dei film Usa ai danni della rinascita del cinema nazionale per buona parte degli anni venti senza prendere quei provvedimenti che pure la stampa di categoria sollecita a più riprese. Il processo di penetrazione del cinema americano in Italia durante il ventennio si sviluppa seguendo un andamento ascendente e godendo della spinta di più fattori favorevoli: poi si interrompe quasi senza preavviso, nel momento di massima accelerazione e di più rigorosa previsione commerciale: per fare infine ritorno, nelle vesti di liberatore e riprendere la sua marcia con le truppe che sbarcano in Sicilia nel 1943. In una prima fase, quella del muto, soprattutto i produttori di Hollywood confezionano le loro opere solo su misura del mercato interno, considerando gli eventuali profitti derivanti dalle esportazioni come incognite da non prendere in considerazione nei bilanci di previsione. 169 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 170 Gian Piero Brunetta Già verso la metà degli anni venti l’americanizzazione del pubblico europeo è pressoché un fatto compiuto: lo denunciano i rappresentanti della produzione, i critici, i giornalisti, gli intellettuali e tutti coloro che cominciano a prendere atto della crescita malthusiana dei film americani nei mercati dei diversi paesi12. Per la difesa del cinema francese monsieur Louis Aubert, decano dell’industria francese e vicepresidente della Chambre Syndicale rende pubbliche considerazioni e paure che possono adattarsi in maniera perfetta anche alla situazione italiana: Aubert osserva che, passato il periodo in cui il cinema francese aveva conquistato il pubblico mondiale dopo la guerra mondiale, la Francia (e dopo di lei tutta l’Europa) è stata letteralmente invasa dai film americani e la produzione nazionale rischia di soccombere per soffocamento. I pericoli non sono d’ordine solo economico e commerciale, anche se proprio da questo punto di vista la produzione francese stenta a risollevarsi. In effetti l’invasione americana va a toccare delle corde sensibili legate a paure di perdita dell’identità, delle tradizioni, dei valori, della storia, della cultura, a fattori connessi all’orgoglio nazionale in via di costruzione, ma anche in senso più banale a fattori economici, di semplice difesa dei prodotti italiani. Non credete voi che lo spettatore a forza di vivere in tale ambiente, di vedere usanze americane, abbigliamento americano, costumi americani, possa un giorno subirne la suggestione e ricercare nei più svariati acquisti più che per il passato il prodotto americano? Il cinema servirebbe allora come mezzo di colonizzazione economica e che ciò sia avvenuto abbiamo di già le prove di fatto. L’invasione straniera in Italia è anche più intensa di quella che subisce la Francia, perché colà americani, inglesi e tedeschi sono entrati come cooperatori nell’industria francese, soci alla pari. Gaumont lavora con capitali Metro… altre combinazioni vedono accordi con First National, Paramount… tutte sul piede di cooperazione in perfetta eguaglianza di diritti. Mentre in Italia è perfettamente l’opposto. Non una delle case invasore produce un solo metro di pellicola in Italia, ed anziché importare capitali per riattivare l’industria nazionale portano i loro film e con essi prelevano le nostre misere lirette che varcano gli oceani a alimentano la lotta per la depressione della lira13. Non era mai successo, fino agli inizi degli anni venti, che una qualsiasi forma di spettacolo popolare si muovesse in base a un piano com12 Gli esempi che si possono prendere a caso sono moltissimi. In Francia, ad esempio, nel 1933 Jean Cocteau così osserva con amarezza gli effetti della colonizzazione in atto sulla popolazione francese: «Le nostre strade, i nostri abiti, le nostre donne hanno ormai quell’odore eccessivo e quella falsa apparenza del cinema». 13 In «Eco del cinema», a. III, novembre 1925, 24, p. 372. 170 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 171 Over There merciale e pubblicitario perfettamente coordinato e capace di mobilitare, in simultanea, più mezzi di comunicazione e di pensare d’occupare tutti i possibili spazi di socializzazione, vecchi e nuovi, d’un mercato potenziale coincidente col mercato mondiale. I produttori americani hanno avuto la capacità di unire le proprie forze per creare, nel 1992, su iniziativa di Samuel Goldwyn, la Mpaa (Motion Picture Association of America), un’associazione, subito credibile, una lobby in grado di agire sul governo in maniera efficace, di sollecitarne, se necessario, l’intervento diplomatico e di operare con strategie capaci d’adattarsi alle esigenze territoriali nei più diversi paesi dei cinque continenti14. L’Europa, grazie anche alla partecipazione decisiva nel conflitto, non è più «Over There», una terra lontana, ma una fertile frontiera economica da seminare con vari tipi di prodotti. In particolare si presenta come una nuova Terra Promessa per la fiorente industria di venditori di sogni e di fabbricatori di nuovi mondi perfetti, virtualmente abitabili pacificamente da milioni di spettatori. Uno dei motivi conduttori della maggior parte delle campagne pubblicitarie delle Majors sarà proprio quello di contribuire alla messa in orbita e alla glorificazione da parte del pubblico di un’«Opera Mondo», di un prodotto unico e, sotto molti punti di vista, dotato di qualità insuperabili, certificato nella sua qualità totale dal marchio che gli ha consentito di vivere. Un prodotto in grado di far sognare milioni di persone. Un investimento sicuro destinato a moltiplicare gli utili del produttore, ma anche di tutti i partecipanti all’impresa, in proporzione geometrica. 14 J. Jarvie, Hollywood’s Overseas Campaign. The North Atlantic Movie Trade, Cambridge University Press, Cambridge 1992. 171 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 172 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp Parte seconda I libri 7-06-2012 13:21 Pagina 173 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 174 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 175 PENSARE LA NAZIONE Rileggendo Nazione e lavoro di Salvatore Lupo Edito nel 1979, Nazione e lavoro1 è a mio parere il più originale e affascinante dei libri di Lanaro; sottotitolo: Saggio sulla cultura borghese in Italia, 1870-1925; titolo dell’introduzione: Prima del fascismo. La triplice titolazione ci porta bene nell’argomento e nel ragionamento del nostro storico. A partire dal primo consolidamento dello Stato unitario, la cultura dell’Italia nuova (borghese) individua nel lavoro «moderno» (manuale, intellettuale, manageriale) lo strumento che consentirà alla nazione di uscire dalla cronica debolezza preunitaria: rendendola più ricca e produttiva, ma anche più sana, capace di riprodursi, competere ed eventualmente combattere, e più compatta politicamente perché moralmente più consapevole. In questa prospettiva di un’industrializzazione che non dissolve ma riaggrega, la cultura borghese abbandona la prospettiva liberista invocando uno Stato in grado di intervenire sia sul terreno economico (non solo doganale) sia su quello sociale. Finisce con l’abbandonare anche la prospettiva liberale, che pure sembra trionfare col giolittismo. Ma una cultura giolittiana come «progetto, planimetria di progetti, semplicemente non esiste», scrive Lanaro, e il giolittismo rappresenta la vera «parentesi» della storia italiana 1870-1925 (p. 16). Il progetto nazionale, quello egemone, rifugge invece dalle giolittiane pratiche di mediazione pluralista che sono tanto apprezzate dalla storiografia progressista, e implica progressive intolleranze nei confronti di quegli elementi, o parti di società, che si mostrano indifferenti verso le sue elevate finalità. In questa prospettiva autoritaria nuova, la cultura borghese riesce a promuovere un decisivo rimescolamento dei «vecchi» riferimenti ideali di destra e di sinistra comprendente larga parte del mondo radicale, e settori non marginali di quello socialisteggiante. 1 S. Lanaro, Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia, 1870-1925, Marsilio, Venezia 1979 (I edizione). Io trarrò le citazioni dall’edizione: Marsilio, Venezia 1988. 175 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 176 Salvatore Lupo Lanaro fornisce qui la sua risposta a una delle domande-base della contemporaneistica italiana: quale spinta interna portò l’Italia dello Statuto, del parlamentarismo e del progressivo allargamento del suffragio a precipitare in un regime liberticida e super-autoritario, tra il plauso o nel silenzio complice di quasi tutta la sua classe dirigente? Diciamo subito che questa risposta diverge da quelle dell’antifascismo radical-democratico o marxisteggiante degli anni venti, più o meno rielaborate dai tanti epigoni di età repubblicana, che largamente hanno innervato la cultura italiana. Il nostro autore non può accettare che del fascismo, e del prefascismo, vengano disconosciuti i caratteri dinamici, che ci si lasci ossessionare dal fantasma dell’immutabilità, da una sequenza addirittura plurisecolare di mancanze – della riforma protestante, della rivoluzione borghese, della riforma agraria, del capitalismo vero. Rifiuta le raffigurazioni del fascismo «come incarnazione del male storico, segno di caduta del tono di un’intera società, braccio secolare di un capitalismo spurio e miserabile, espressione di un’incapacità delle classi dirigenti di essere modernamente borghesia»; sottolinea che si tratta viceversa del «punto di approdo di una classe dirigente che con tutti i suoi difetti riesce a collocare in primo piano i bisogni e le aporie dell’industrializzazione» (p. 9). Che la vicenda dell’industrializzazione andasse messa al centro del dibattito storiografico, l’aveva affermato per la prima volta vent’anni prima Romeo in polemica con Sereni. Ne derivò un mutamento di rotta (bisognava ragionare dello sviluppo anziché dell’arretratezza) riguardante l’intera storia nazionale-unitaria, anche se l’attenzione degli storici economici si concentrò poi, com’era ovvio, sulle due fasi di (usiamo la terminologia enfatica allora in voga) take-off, l’età giolittiana e il «miracolo economico» degli anni cinquanta-sessanta. Come detto, sul versante politico il mainstream neo-liberale e neo-gramsciano della storiografia riconobbe al solo giolittismo un carattere progressista; mentre più tardo, e gravemente incompleto, fu l’analogo riconoscimento per il centrismo e per il centro-sinistra, e dunque per una ventennale stagione di sviluppo accelerato, crescenti consumi, nuovi costumi, mobilità sociale, nuove domande di partecipazione e cittadinanza, insomma di modernità. I più continuarono nella ricerca delle tare, e delle mancanze. Quanto al periodo fascista, era per definizione mancante di democrazia e libertà, e anche lo sviluppo, in termini di Pil, aveva subito gravi rallentamenti. Però il governo fascista dell’economia aveva creato l’Iri e riformato il sistema bancario, determinando una precondizione 176 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 177 Rileggendo Nazione e lavoro importante per la spinta che due decenni dopo avrebbe portato l’Italia «dalla periferia al centro» del sistema mondiale. Si era allora abbozzato un sistema di sicurezza sociale. Parte di un’Italia incline ormai a riflettere sulla propria modernità, Lanaro percepiva la banalità dell’idea di un fascismo cattivo perché tradizionalista e tradizionalista perché cattivo. Era d’altronde figlio di una cultura che non aveva temuto di formulare critiche anche aspre (foucaultiane, francofortesi, neo-marxiste) alla modernità: che, avendo riconosciuto il concetto generale per cui «autoritarismo e maturità capitalistica possono convivere benissimo», non aveva più bisogno di occultare il dato per cui il fascismo rappresentava la «cornice ultima di un flusso di modernizzazione» italiana (p. 9). Che questo fosse il problema storico, ovvero che ci fosse un problema storico di questa natura, non era peraltro così chiaro a tutti nel momento in cui Nazione e lavoro venne dato alle stampe. Non era chiaro innanzitutto ai molti critici impegnati nella polemica «da sinistra» contro le tesi espresse da De Felice nella Intervista sul fascismo pubblicata nel 1975, a cavallo dei due tomi della grande biografia di Mussolini editi nel 1974 e nel 19812. Lanaro segnalò nell’introduzione che, nel pieno di una stagione di studi straordinariamente ricca3, il problema storico e storiografico non poteva ridursi a una ripresa di un «ciellennismo storiografico» ispirato ai nomi pur nobilissimi di Gobetti e Dorso, Croce e Sturzo, Salvemini e Gramsci, la quale rischiava di risolversi nell’«ennesima operazione esorcistica» intesa a risospingere il nemico nell’oscurità rassicurante dell’arcaismo o peggio del male metafisico (p. 8). In un certo senso egli era più vicino al De Felice che, scrivendo una storia generale in forma di biografia, puntava sulla soggettività di Mussolini e dei suoi seguaci. Direi che era quello il rischio che si voleva, ma che non si poteva più a lungo esorcizzare. Si può capire che allora, a soli trent’anni dalla caduta del regime, ci fosse chi si scandalizzava nel ritrovarsela davanti; si deve però oggi convenire sul fatto che la scelta era matura: per studiare sul serio il fascismo era necessario prenderne sul serio l’ideologia, per contraddittoria, per repellente che fosse. L’autore di Nazio2 R. De Felice, Intervista sul fascismo, Laterza, Roma-Bari 1975; Id., Mussolini il duce, Einaudi, Torino 1974 e 1981 (i primi tre tomi dell’opera, intitolati a Il rivoluzionario e Il fascista, erano usciti sempre con Einaudi nel 1965, nel 1966 e nel 1968). 3 Segnaliamo, tra gli altri, A. Lyttelton, La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Laterza, Roma-Bari 1974 (I ed. inglese 1973); L. Mangoni, L’interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo, Laterza, Roma-Bari 1974; A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino 1975; M. Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, Einaudi, Torino 1979. 177 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 178 Salvatore Lupo ne e lavoro si sentiva per primo impegnato su quel fronte. Però Lanaro ambiva a scrivere una biografia collettiva anziché individuale, intendeva dar voce a strati profondi e anche periferici della cultura che limitandosi al set di fonti defeliciano, nell’ottica di uno storico tradizionalmente (angustamente?) politico, non potevano venire in superficie. La sua storiografia colta e sperimentalista si poneva domande generali cui De Felice non poteva o non voleva dare risposta. La cultura borghese di cui Lanaro si pone alla ricerca è quella del tempo nuovo, è la cultura dell’economista purché «storico», del sociologo, dello psicologo interessato alla sfera «collettiva», del medico con la passione dell’eugenetica; cultura tecnica sì, ma ben consapevole di dover giocare un ruolo sociale o politico, ovvero nella costruzione della modernità da essa pensata come equipollente alla nazione. Il testo si sofferma su personaggi come Leone Carpi, «ebreo ferrarese, proprietario fondiario, cospiratore mazziniano, economista, agronomo, statistico e sociologo dilettante di singolarissimo acume» (p. 22); come Corrado Gini, «padre delle scienze sociali italiane», artefice di un «sistema di correlazioni tra demografia, antropometria, eugenica e sociologia economica, istituite e rese affidabili ad una ad una – nessuna esclusa – dalle “certezze” epistemologiche racchiuse nel metodo statistico» (pp. 44-5); come Achille Loria, l’economista para-marxista maestro di generazioni di radicali. Vi compaiono Filippo Carli, Arturo Labriola, Napoleone Colajanni, intellettuali e nel contempo politici di primo piano. Riconosce un grande ruolo ai protezionisti, ma non dimentica che tra gli estremisti del nazionalismo prima, del fascismo poi, c’erano anche liberisti d’assalto come De Stefani o Pantaleoni (pp. 253 sgg., 227 sgg.). Dà voce a letterati anche minori, ma consapevoli del loro ruolo pratico di educatori. Lanaro riconosce la modernità del binomio nazione-lavoro ma non per questo prova a rinchiuderla in parametri razionalistici. Sa che, per coglierne il senso, bisogna dare la giusta importanza al registro emotivo, e scandagliare il terreno delle passioni. La nazione che vuole riunificarsi col lavoro lavora su visioni del futuro, mitologie, profezie. Se la sua idea di grandezza viene smentita, trova elementi antinazionali da incolpare. In certi casi, prende atto e rilancia con nuove mitologie: come quando, vedendo i suoi figli perdersi nel mondo con la grande emigrazione, formula improbabili auspici su un futuro in cui gloria e laboriosità della stirpe potranno ricongiungersi in una dimensione imperiale. 178 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 179 Rileggendo Nazione e lavoro Nazione e lavoro tratta di una retorica, di uno stile discorsivo, donde il suo linguaggio stesso: fascinoso, denso, felicemente disordinato, insomma mimetico. Mi viene alla mente il modo ammirato con cui Lanaro si accosta a Gioacchino Volpe, e particolarmente alla sua «prosa ellittica, accalorata, rotta, evocativa, paratattica, spesso e volentieri deverberata, che non ha avuto epigoni nella storiografia italiana del Novecento; una prosa tutta additivi sinominici, anafore concettuali, preziosismi arcaicizzanti, interrogativi retorici, costrutti nominali, effetti impressionistici»4. Qui cito da un testo del 2004, mentre in Nazione e lavoro Volpe viene citato una sola volta. Il lettore dovrebbe però essere molto disattento per non accorgersi della sintonia dei due storici innanzitutto nella definizione del loro oggetto, ma non solo. L’Italia in cammino di Volpe esce dalla sua fragilità postrisorgimentale, si rafforza, si avvia verso la soluzione nazionalfascista5; Lanaro parla di una «lunga marcia dell’Italia “liberale” verso il regime nazional-corporativo» (p. 7). Nel quadro dinamico disegnato da entrambi, diverse forze, sociali e ideali (liberali, radicali, socialisteggianti), si vanno ri-dislocando sotto l’egida della nazione. È facile d’altronde pensare che Volpe avrebbe potuto benissimo intitolare il suo libro Nazione e lavoro. È possibile anche che avrebbe apprezzato quel brano in cui Lanaro rivendica l’importanza della storia delle idee ma rifiuta una possibile sua versione in cui tutto si riduce ad «alberi genealogici dove si spiega tutto con libri che succhiano libri e con pensieri che masticano i pensieri»; consapevole che le idee vanno «fermate nel momento delicato del loro incontro o della loro collisione con la dura materia del sociale», sempre tenendo conto dello scarto «fra i programmi e le realizzazioni» (p. 10). Potrebbe dirsi che, mostrando entrambi gli autori un’Italia liberale che scivola omogeneamente nel fascismo, entrambi corrono il rischio del teleologismo. Lo corre molto più Volpe, però, il quale racconta una storia che sente contemporanea, che parla di lui – nazionalista autoritario convinto che il fascismo valga a riconquistare al suo paese il posto che merita nel mondo, che si tratti di un esito pacificato e pacificante. Non è questo ovviamente il punto di Lanaro, consapevole di raccontare una storia contraddittoria, per nulla scontata, e che soprattutto finisce male. Finisce male innanzitutto perché il corporativismo ovvero il corporatismo (per riusare la variante utilizzata in quegli stessi anni set4 S. Lanaro, Raccontare la storia. Generi, narrazioni, discorsi, Marsilio, Venezia 2004, p. 112. 5 G. Volpe, L’Italia in cammino. L’ultimo cinquantennio, Treves, Milano 1927 (segnalo qui la recente edizione Donzelli, Roma 2010, con mia introduzione). 179 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 180 Salvatore Lupo tanta da Charles Maier)6 è necessariamente frutto – lasciamo stare se fecondo o tossico – di una società pluralista, nascendo dal confronto tra organizzazioni rappresentative del lavoro, del management, del capitale. Già nel saggio su Ugo Spirito (1971)7, Lanaro aveva rilevato come nei fatti l’interventismo statale degli anni trenta passasse attraverso canali tecnocratici piuttosto che attraverso i moduli del corporativismo – nel senso di Maier e in qualsiasi altro significato possibile. In un testo molto bello scritto nel 1998, è tornato sulla logica tecnocratica dell’interventismo fascista, spiegando come in essa il riferimento alla modernità si faccia generico, e l’ideologia della nazione sostanzialmente tenue. Interessante qui la citazione di un brano (anch’esso molto bello) nel quale Paolo Ungari negava che il regime si fosse legittimato nel «nome di una rivoluzione sociale (che non fece) o dell’autogoverno dei produttori (che in definitiva rifiutò)», e tanto meno «della restaurazione dei diritti della Corona e dell’Altare (che nell’intimo disprezzò sempre)»; ma avesse piuttosto puntato sulla logica «delle grandi bonifiche, delle trasvolate atlantiche, dello sviluppo di zone industriali»8. Dal canto mio, rilevo che in tema di bonifiche come di riforma bancaria e industriale, tra Serpieri e Beneduce, la tecnocrazia messa o meglio lasciata al suo posto dal fascismo era di ispirazione radicalsocialista e nittiana, molto lontana dunque da eccessi nazionalistici e dal gran fiume del movimento fascista, ivi comprendendo la sua componente sindacale – che venne inserita, come ogni altra istituzione, in una macchina burocratica e centralista, chiusa a qualsiasi feedback dal basso e dalla periferia. Cito ancora dal Lanaro del 1998: «dalla parabola del fascismo emerge il carattere dissennato e temerario di tutti i tentativi compiuti […] per blindare in una sorta di armatura dittatoriale nazionalismo, imperialismo, statalismo e totalitarismo, vale a dire progetti di società componibili solo per via di relazioni ossimoriche»9. Le incongruenze non vennero certo risolte dalla dittatura personale del duce che ha sempre ragione, dalle scenografie e dalle prepotenze del 6 C. Maier, La rifondazione dell’Europa borghese, De Donato, Bari 1979 (l’ed. originale è del 1975). 7 S. Lanaro, Appunti sul fascismo «di sinistra». La dottrina corporativa di Ugo Spirito, in «Belfagor», 1971, pp. 377-99, poi in Il regime fascista, a cura di A. Aquarone e M. Vernassa, il Mulino, Bologna 1974. 8 S. Lanaro, Un secolo nazionalista senza linguaggio nazionale. Il caso del fascismo in Italia, in Aa.Vv., ’900, un secolo innominabile. Idee e riflessioni, Marsilio, Venezia 1989, ora in Id., Retorica e politica. Alle origini dell’Italia contemporanea, Donzelli, Roma 2011, pp. 31138; ibid., p. 329, la cit. del testo di P. Ungari, Ideologie giuridiche e strategie istituzionali del tardo fascismo, in Il regime fascista cit., p. 51. 9 Lanaro, Retorica e politica cit., p. 336. 180 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 181 Rileggendo Nazione e lavoro partito unico ridotto a strumento burocratico di comunicazione dal centro alla periferia, nella quale la politica si sviliva nella pratica del beghismo e delle lettere anonime, in una demagogia senza freni. Non vennero risolte neanche dalla tarda scelta razzista, che anzi squalificò il regime alla radice. Tanto meno furono risolte dalla guerra lungamente invocata per attestare la vittoriosa fascistizzazione delle masse, e che invece il fascismo si mostrò incapace non dico di vincere, ma di organizzare seriamente. In conclusione. Il magistrale studio del 1979 di Lanaro mostra quale «cultura borghese», e come, riesca nei cinquantacinque anni Prima del fascismo ad accendere grandi passioni collettive partendo dal binomio nazione-lavoro – donde la fuoriuscita da logiche oligarchiche, l’inclusione di soggetti nuovi, il governo di una grande trasformazione, e anche un progetto totalizzante dagli effetti perversi forse prevedibili. Altri studi di Lanaro sul regime fascista, e la storiografia cui fa riferimento, mostrano che il binomio risuonò dentro il ventennio più fragoroso ma più prepotente, meno convinto e convincente, alla fine molto meno efficace. Qui va collocato lo «scarto tra idee e realizzazioni», qui vanno valutate le continuità ma anche le discontinuità, e si ridimensiona il rischio del teleologismo. Lanaro è uno dei pochi storici italiani che abbia fornito contributi molto importanti sia sul periodo liberale, sia su quello fascista, sia su quello repubblicano. Mi sembra sia stato l’unico a porre il problema della nazione, che è un altro modo di dire della cittadinanza consapevole e della virtù repubblicana, al centro della riflessione per tutt’e tre le stagioni: tra le quali non c’è dubbio sia stata quella fascista, il regime che per eccellenza si diceva nazionale, a ottenere il risultato peggiore. 181 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 182 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 183 PENSARE LA NAZIONE Nazione e regione. La Storia delle regioni Einaudi e Il Veneto di Silvio Lanaro di Carmine Donzelli 1. Tra progetto editoriale e questione storiografica. Nella primavera del 1982 la casa editrice Einaudi decise di dar corso al progetto di una serie di volumi che avessero per oggetto Le regioni dall’Unità a oggi. La nuova serie nasceva in stretta connessione con la Storia d’Italia, la grande opera collettiva in sei volumi e dieci tomi che era stata pubblicata tra il 1972 e il 1978, a cura di Ruggiero Romano e Corrado Vivanti, e che nel frattempo conosceva una ulteriore prosecuzione nei volumi degli Annali. Come sempre, nel lavoro di progettazione di una casa editrice di cultura, si mescolavano nella decisione di aprire quel nuovo cantiere editoriale considerazioni di differente ambito e spessore. C’era – ed era ben avvertita, fin dall’inizio – la necessità di arricchire l’offerta della casa editrice sfruttando ulteriormente il fortunato filone della Storia d’Italia «madre», che aveva rappresentato nell’ultimo decennio un potente fattore di espansione dell’impresa einaudiana, contribuendo ad accrescerne in maniera assai significativa il conto economico, e generando contemporaneamente un circuito finanziario molto consistente, che aveva continuo bisogno di essere incrementato. E c’era – altrettanto netta e lucidamente percepita, almeno da chi fu chiamato a disegnare il progetto – l’opportunità di una rinnovata riflessione storiografica, attorno a un tema come quello delle regioni, fino a quel momento del tutto trascurato dalla nostra tradizione di studi storici: un tema che nel frattempo, per una serie di ragioni di cui si dirà, veniva in quel momento ad assumere una evidente urgenza civile. Fu Giulio Einaudi, una mattina di aprile del 1982, a chiamarmi nel suo studio per affidarmi il compito di redigere un primo appunto del 183 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 184 Carmine Donzelli nuovo progetto, il cui coordinamento fu poi affidato a Corrado Vivanti e a me. E fin dall’inizio io ne ebbi la diretta responsabilità operativa1. L’incarico mi si presentò immediatamente ricco di potenzialità ma anche – e forse ancor più – carico di insidie, in primo luogo di ordine scientifico e concettuale. Vi era, innanzitutto, un problema di definizione. Non tutte le regioni definite nel nostro ordinamento si presentavano con lo stesso grado di «evidenza», con la stessa dose di spessore storico. Il che poneva, naturalmente, una questione di dimensioni dello stesso progetto editoriale: bisognava farle tutte, le regioni? O non era meglio concentrarsi su quelle di più forte significato, nella ricostruzione della vicenda nazionale? E ancora, almeno in alcuni casi, non sarebbe stato più interessante scegliere ambiti e confini territoriali diversi da quelli definiti dall’ordinamento? Ma il problema di fondo si presentava ancora più spinoso: quale idea di regione si poteva adottare come punto di riferimento per la nostra storia? Che cos’era l’«identità regionale»? Quale criterio di riconoscimento si poteva adottare, specie nel caso di una serie di realtà dai confini amministrativi appena tracciati, e fino a pochissimi anni prima labili, incerti o addirittura indefiniti? E come tenersi egualmente distanti, nel maneggiare quel difficile concetto, dalle secche dell’«oggettivismo» e dai rischi del «soggettivismo»? La stessa duttilità, il carattere vischioso, la difficoltà di definizione dell’oggetto facevano delle regioni un campo di indagine di straordinario interesse. Scrivevo in un appunto per un seminario di lavoro tenutosi ad Arezzo nel 1984, in cui si provò a dare una valutazione in corso d’opera dei primi risultati ottenuti e dei problemi aperti: L’identità regionale è il frutto di stereotipi collettivi, profondamente radicati nel senso comune e nella percezione diffusa. Nel valutarli, bisogna partire dalla considerazione che vi è in essi qualcosa di «vero», nel senso che essi corrispondono all’azione effettiva di gruppi umani organizzati che hanno – consapevolmente o meno, positivamente o meno – agito su un territorio caratterizzandolo con la loro presenza e venendone in qualche misura condizionati. Ma vi è, in questi stereotipi, anche una parte di «falso», nel senso che essi sono anche il risultato di costruzioni a posteriori, che hanno esaltato o magnificato realtà solo parzialmente esistite, e spesso comunque definitesi per caratteri differenti da quelli poi adottati per celebrarle2. 1 Ero allora al mio decimo anno in Einaudi. Ero stato assunto come redattore nel 1972, proprio in vista della pubblicazione del primo volume della Storia d’Italia, immediatamente dopo essermi laureato con una tesi di cui Vivanti era stato il relatore. 2 L’appunto in questione fu poi parzialmente pubblicato in «Passato e Presente», 1985, 9, pp. 13-37 col titolo Il concetto storico spaziale di regione: una identificazione controversa. 184 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 185 La Storia delle regioni Einaudi e Il Veneto di Silvio Lanaro Alla (promettente) difficoltà di definizione concettuale dell’oggetto, si aggiungevano poi una serie di questioni connesse con la sua stessa applicabilità all’ambito della storia italiana. La prima questione riguardava l’uso che si era fatto del termine regioni, riferito a tutta la fase preunitaria. Per una secolare specificità della sua vicenda, l’Italia era stata, lungo il corso di tutta la storia moderna e fino alla piena metà dell’Ottocento, una realtà caratterizzata dalla presenza di molteplici Stati cosiddetti «regionali»: formazioni storicopolitiche a base territoriale ristretta, spesso propaggini di entità statuali esterne, e comunque soggette alla pressione di estrinseche egemonie. Solo con l’avvento del processo risorgimentale si era concretamente proposto il problema della confluenza di differenti tradizioni regionali in un ambito unitario. La dialettica tra nazione e regione, così come impostata e conosciuta in altri grandi spazi della storia europea, era arrivata in Italia molto tardi. La seconda questione – strettamente connessa con la prima – era data dal fatto che, nella storia italiana di lungo periodo, la dimensione territoriale «locale», vale a dire l’informale ma sostanzioso configurarsi di tradizioni, appartenenze, processi di identificazione e di amalgama sub-nazionali, si era espressa più nella forma dei municipalismi che non in quella dei regionalismi. Le città e i loro «contadi», molto più che non le regioni, erano stati – fino alla fase dell’unificazione – l’unità di riferimento di grandissima parte dei processi di costruzione storica delle identità locali. Nello stesso appunto che ho già citato, osservavo a questo proposito: La città, quella che Carlo Cattaneo definì «il principio ideale delle istorie italiane», ha aggregato e egemonizzato «contadi», non regioni. Troppo piccolo è stato il suo potere di attrazione, troppo simile e vicino a quello delle altre città concorrenti. Nella storia italiana preunitaria, con pochissime eccezioni, la gran parte delle città italiane sono state abbastanza forti da non soccombere, ma deboli quanto basta da non riuscire a polarizzare attorno a sé un territorio significativamente esteso. Solo dopo l’unificazione, con la modificazione e la specializzazione di alcune funzioni urbane legate ai processi di produzione e alle dimensioni dei mercati, si è sviluppata una selezione e differenziazione di alcune città, che hanno cominciato ad aggregare attorno a sé spazi compiutamente regionali3. La terza questione era legata al fatto che una simile dialettica territoriale, anche quando e laddove aveva cominciato a manifestarsi, non aveva trovato nel contesto dello Stato unitario un terreno favorevole 3 Ibid. 185 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 186 Carmine Donzelli per potersi affermare: era stata più negata che riconosciuta, dal momento che l’unificazione italiana si era risolta, per tutta una serie complessa di circostanze, in un modello statale di tipo centralistico. La sua concreta realizzazione si era presentata come una sconfitta dei «particolarismi», che presto, nella prima fase storica della nuova compagine, si sarebbero presentati, o sarebbero stati additati come forze antagonistiche e centrifughe, di natura sostanzialmente residuale. Una lotta tra «piccolo» e «grande» che era stata proposta più come una disputa tra vecchio e nuovo, tra arretrato e moderno, che non come una interazione tra differenti dimensioni territoriali disposte a confrontarsi e a integrarsi l’una nell’altra. Tutto questo insieme di ragioni contribuiva a spiegare per quale motivo la dimensione regionale avesse così fortemente stentato a trovare una sanzione istituzionale nell’ordinamento italiano. E quando, nel 1948, dopo la caduta del fascismo e la fondazione della Repubblica, sotto la pressione di agguerrite e convinte minoranze politico-intellettuali di ispirazione federalistica, la Costituente repubblicana ne aveva finalmente sancito l’esistenza in Costituzione, era stato necessario che passasse ancora un altro ventennio perché le Regioni venissero effettivamente insediate e assumessero via via i loro poteri di governo della sfera locale, secondo un processo comunque lento e contraddittorio. 2. Sfide e ambizioni. Due precisi ordini di conseguenze derivavano, per la nostra impresa editoriale, da questo insieme di considerazioni. In primo luogo – giacché la storiografia non può che essere figlia della storia che vuole raccontare – si trattava di fondare ex novo la storia delle regioni italiane. Vale a dire di impostarla su basi di metodo, criteri di ricerca, definizione stessa degli ambiti e delle fonti, che non potevano disporre, se non in maniera incompleta e parziale, di una base consolidata. Da questo punto di vista il campo degli studi si presentava quasi del tutto sguarnito, ben diversamente da quanto non lo fosse in altre tradizioni di studi storici, prima fra tutte quella francese. Si trattava – né più né meno – di dare origine a una storiografia regionale italiana, non di riprenderla o di rinverdirla. E anzi, da questo punto di vista, il riferimento alla pur copiosa storiografia degli «antichi Stati regionali» poteva solo complicare le cose, dando adito a possibili clamorosi equivoci. In secondo luogo, l’asse di tutto il ragionamento storiografico si concentrava necessariamente sulla storia dell’Italia contemporanea. L’ogget186 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 187 La Storia delle regioni Einaudi e Il Veneto di Silvio Lanaro to dell’attenzione dei nostri volumi dovevano essere non le regioni prima della nazione, ma le regioni dentro la nazione: le regioni come contrappunto informale ma decisivo della costruzione unitaria, come luogo d’origine delle pluralità, delle articolazioni, delle appartenenze costitutive di quella specifica e particolare nazione che si era costituita e che aveva poi costruito la sua storia. La Storia delle regioni si presentava da questo punto di vista – e così in effetti era vissuta anche nella discussione interna al gruppo intellettuale che dirigeva in quegli anni la casa editrice torinese – come un parziale sovvertimento di due pilastri portanti del «discorso storiografico» einaudiano del precedente decennio: la cosiddetta «storia lunga» (l’accentuazione dei processi di lungo periodo, l’attenzione alla braudeliana longue durée, che era stato uno dei punti forti della Storia d’Italia madre, e che si era consolidata nella formula del «blocco di quindici secoli»); e la recente esperienza della «microstoria», vale a dire di un insieme di pratiche storiografiche – in verità spesso assai diverse tra loro, e altrettanto spesso ispirate a differenti ascendenze storiografiche e metodologiche – tutte tendenti a esaltare il carattere ermeneutico della ricognizione a base «microanalitica»4. A ben vedere, la dimensione regionale si presentava, per quelli di noi che decisero di abbracciarne la prospettiva, come una provvida eresia, rispetto alla tradizione politica dell’histoire-nation, ma anche rispetto a quelle pratiche storiografiche alternative, come la storia sociale e la microstoria, che ne avevano conteso il campo nell’ultimo decennio. La storia regionale poteva rappresentare la concreta individuazione di una dimensione «intermedia» in grado di dare anima e sangue alla storia istituzionale, di conferire nuova linfa e sostanza all’indagine sui processi di formazione dei gruppi sociali e delle classi, dei movimenti e dei partiti, delle élites economiche e dei gruppi dirigenti politici. Se era vero, come molti di noi ormai apertamente sostenevano, che si trattava finalmente di intraprendere uno studio meno ideologico e più fortemente analitico del processo di nation-building e poi della formazione storica italiana, la dimensione regionale si presentava, con tutti i rischi e le ambiguità del caso, come un potente stimolo, come un motore di studi di grandissima intensità. Ma tutto questo portava («pericolosamente», agli occhi dei nostri interlocutori interni) in prima linea la riflessione sulla contemporaneità e al tempo stesso toglieva centralità al nuovo paradigma della 4 «Microstorie» era il nome di una collana della casa editrice, nata nel 1977, e diretta da due tra le personalità di maggiore prestigio del gruppo einaudiano: Carlo Ginzburg e Giovanni Levi. La collana era in quegli anni in piena attività e si presentava come uno dei punti più forti e innovativi dell’offerta editoriale di Einaudi. 187 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 188 Carmine Donzelli microstoria, che ostentava disinteresse per la storia nazionale, per i problemi di governo e costruzione della nazione. Il punto di vista regionale era dunque in quel momento un punto di vista scomodo: contrastato, per diversi motivi, sia dalla storiografia tradizionale che dalle nuove storiografie. Tutti, o quasi, tendevano a vederlo come un ibrido, a disconoscerlo, al massimo a derubricarlo al grado di un interessante esperimento minore. Ma i possibili antagonisti non si esaurivano lì. Vi era, nel nostro approccio regionale, un altro obiettivo polemico, che il progetto pose fin dall’inizio al centro del suo mirino, e i cui effetti si sarebbero fortemente dispiegati negli anni successivi. Il bersaglio forse più grosso era il «dualismo italiano». Per più di un secolo, dagli anni settanta dell’Ottocento, schiere di intellettuali, di storici, di politici di primissima grandezza avevano concorso alla costruzione del più solido e introiettato schema di rappresentazione territoriale del nostro paese. L’Italia solo in parte, e per molti versi solo apparentemente, si era fatta una: le Italie erano due. Spaccate, scisse, contrapposte, irrimediabilmente diverse tra loro, e sostanzialmente omogenee al loro interno. Uno schema talmente ripetuto e assimilato da apparire come il portato di una naturale constatazione. Una lente deformante, in grado di oscurare le differenze, le articolazioni, le ricchezze della formazione italiana. Una semplificazione troppo rigida e schematica, che la prospettiva regionale si doveva incaricare di disaggregare, al Nord, come al Sud. La storia delle regioni italiane poteva rappresentare, ai nostri occhi, il grimaldello attraverso il quale far saltare la persistente forza di quelle rappresentazioni troppo semplificatorie. Insomma, la Storia delle regioni dall’Unità a oggi (come si chiamò la serie dei volumi) non doveva, non poteva essere una storia dell’Italia contemporanea in tono minore. Senza troppi giri di parole, e con qualche dose di impudenza, l’ambizione era esplicitamente percepita: Sembrerà forse un paradosso: ma può darsi che la storia dell’Italia contemporanea, di un paese cioè «finalmente» divenuto nazione, si possa scrivere più compiutamente ponendo in primo piano le sue articolazioni piuttosto che la sua unità5. E qui l’idea di una storia per ambiti regionali della compagine postunitaria si connetteva a una esplicita motivazione civile. Si trattava di dare conto di una serie di percorsi storici che – soli – potevano spiegare le origini del complesso contesto politico e civile del presente, dell’Italia 5 Ibid. 188 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 189 La Storia delle regioni Einaudi e Il Veneto di Silvio Lanaro degli anni ottanta del Novecento: un paese avviato verso una turbolenta e ambigua trasformazione modernizzatrice, tra spinte e resistenze; un paese che si scopriva più complicato, più denso di articolazioni politiche, sociali e territoriali, meno disponibile alle semplificazioni e alle contrapposizioni frontali. Un paese in crisi di motivazione «nazionale», sempre più difficile da tenere insieme. Un paese in cui facevano la loro comparsa – confusi, sottovalutati, difficili da decifrare – i primi embrioni di separatismi. Poteva contribuire una Storia delle regioni a migliorare la percezione civile di un paese così criticamente proteso verso un cambiamento di cui era difficile individuare la direttrice? Forse, poteva. 3. Committenza. Queste dunque, appena celate tra false modestie e tattiche dissimulazioni, le non piccole ambizioni del progetto. Ma chi chiamare a raccolta, per realizzarlo? E prima ancora, per discuterne, per metterlo a punto? Si scelse di costruire dapprima due «cantieri-pilota»: il Veneto e la Calabria. Naturalmente vi erano molte e buone ragioni di merito storiografico, per decidere di partire proprio da queste due regioni. In primo luogo, il carattere particolare, estremamente polarizzato, delle realtà in questione. Profondo Nord, la prima, profondo Sud, la seconda. A forte intensità di sviluppo, il Veneto; ad altissimo tasso – almeno apparente – di stagnazione, la Calabria; entrambe caratterizzate da una forte dialettica di egemonie urbane; entrambe segnate – sia pure con modalità profondamente diverse – da potentissimi movimenti emigratori; entrambe in forte e complessa dialettica col potere politico centrale, con Roma. Ma il motivo primo di quelle due scelte pilota fu, a ben vedere, nel sodalizio che esse consentivano di realizzare con i curatori dei volumi e con i relativi gruppi di progetto. Chi, da Torino, doveva mandare avanti il cantiere, aveva bisogno di avere compagni di strada forti e consapevoli, coi quali discutere passo dopo passo prima l’impianto stesso del progetto, poi l’articolazione dei singoli volumi. Aveva bisogno di studiosi che condividessero l’ambizione di cui si è appena parlato; che ne fossero profondamente convinti; di più: che ne fossero complici. Fu questa la proposta che venne avanzata da un lato a Silvio Lanaro (cui presto si sarebbe affiancato, in punta di piedi, ma con apporti decisivi, Mario Isnenghi) e dall’altro lato a Piero Bevilacqua e Augusto Placanica. Della Calabria di Bevilacqua e Placanica non è qui il luogo per raccontare: basti dire che condivise del tutto equamente col Veneto il ruo189 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 190 Carmine Donzelli lo di capofila del progetto. È Il Veneto di Lanaro (e Isnenghi) quello su cui voglio concentrare l’attenzione. E non solo per la corposità e la forza degli esiti storiografici, che sono sotto gli occhi di tutti e che ne fanno, a quasi trent’anni dall’uscita, un volume ancora per moltissimi versi esemplare. Il punto di fondo è che quel volume rappresenta l’applicazione paradigmatica del modello di relazione tra nazione e regione che ho cercato fin qui di descrivere. Nel caso del Veneto, la scelta dell’interlocutore aveva un’origine ben precisa. Silvio Lanaro aveva scritto qualche anno prima un libro che aveva rappresentato una svolta nella storiografia dell’Italia contemporanea. Dentro Nazione e lavoro (altri, in questo volume, ne parlano)6 c’era, o si poteva trovare, per chi la sapesse cercare, l’essenza dei processi di costruzione della nostra compagine unitaria. Processi contemporaneamente veri e finti, inventati e al tempo stesso concretissimi, attraverso i quali, con tutte le aporie, le distorsioni e i difetti del caso, l’Italia unita si era fatta via via nazione – liberale, protezionista, industriale, solidarista, coloniale, interventista, fascista. Protagoniste di quel libro erano persone e idee – questo colpiva – che avevano le loro precise radici territoriali, che non stavano sospese nel vuoto, che avevano lavorato ad aggregare appartenenze, a predicare valori, a costruire identità, a partire da una radice territoriale sentita e vissuta come un punto di forza. In quel libro, in particolare, c’era un bel po’ di Veneto: del Veneto che a noi serviva, che ci sembrava particolarmente adatto per la nostra Storia delle regioni. Andammo a trovare Lanaro a Padova; e scattò immediatamente l’incanto. Fu disegnato un indice del volume; fu definito il gruppo dei collaboratori; si tenne una prima riunione del gruppo. Ci si mise al lavoro e in un tempo miracolosamente breve (che a me continuò a sembrare troppo lungo, e che Lanaro provvide a dilatare opportunamente, con i suoi estenuanti perfezionismi di scrittura, mendacemente camuffati attraverso finte spedizioni postali), nell’autunno del 1984 Il Veneto Einaudi fu gloriosamente pubblicato, primo volume della serie7. 6 S. Lanaro, Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia, 1870-1925, Marsilio, Venezia 1979. Si veda al proposito, in questo volume, il contributo di Salvatore Lupo. 7 Ad esso seguirono, nell’ordine, La Calabria, a cura di P. Bevilacqua e A. Placanica (1985); La Toscana, a cura di G. Mori (1986); La Sicilia, a cura di M. Aymard e G. Giarrizzo (1987), Le Marche, a cura di S. Anselmi (1988); La Puglia, a cura di L. Masella e B. Salvemini (1989); L’Umbria, a cura di R. Covino e G. Gallo (1989); La Campania, a cura di P. Macry e P. Villani (1990); Il Lazio, a cura di A. Caracciolo (1991). Una Storia del Piemonte dall’Unità a oggi, di Valerio Castronovo, era stata pubblicata da Einaudi nel 1977, ma non aveva rappresentato se non un lontano antecedente della serie, di impianto e approccio totalmente diverso. Dopo il 1991, altri volumi sono comparsi, nella stessa serie, ma con differenti responsabili del progetto. 190 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 191 La Storia delle regioni Einaudi e Il Veneto di Silvio Lanaro Nel frattempo – particolare non di poco conto – la casa editrice Einaudi era fallita, e l’azienda, commissariata, aveva cominciato un nuovo, difficilissimo ciclo della propria esistenza. Quel volume era stato messo insieme, letteralmente, tra le raffiche di vento e i lampi della tempesta. 1129 pagine, indice analitico compreso. 4. Il Veneto di Lanaro. Dopo quasi trent’anni, riapro il volume con una certa emozione. Lo maneggio con circospezione. Ho paura che mi deluda, tale è l’intensità dei ricordi. E invece no: mi piace più di quanto non immaginassi. Persino i difetti, che oggi vi si possono trovare, mi piacciono. Innanzitutto è un libro vero, organico, non una raccolta estemporanea di contributi. Corrisponde al disegno, a un progetto editoriale; pur nella sua corposità, risulta perciò essenziale: niente zavorre, niente paccottiglia. È davvero, come dichiara la Premessa, «una raccolta di saggi di storia contemporanea “in scala”, non una collezione di studi di storia locale» (p. XIX). In secondo luogo, Lanaro si ripropone programmaticamente di cercare non una contrapposizione ma una interazione tra la scala regionale e quella nazionale. È l’effetto combinato che lo interessa; attraverso quello si capirà meglio la storia del Veneto, mentre si capisce la storia d’Italia. Per questo, nel volume «il lettore non troverà né una storia d’Italia nel Veneto […] né una storia del Veneto in Italia». Vi troverà piuttosto una serie di contributi «di storia dell’industria, del “sentire” proprietario, dell’emigrazione, delle istituzioni culturali, della stratificazione sociale e della vita quotidiana» in grado di spiegare un pezzo di Italia, che è anche – e diventa – un modo d’essere italiani. Per far ciò, il libro parte dallo stereotipo regionale. Non lo aggira, lo affronta. Lo prende letteralmente di petto, per determinarne i gradi di verità e di falsità. «Che cosa rappresentava fino a ieri, in sintesi estrema, “il Veneto” per i non veneti?», è la domanda che apre il volume. La risposta è netta: «In un paesaggio ad elevato tenore alcolico vi si avvicendavano parroci e alpini, pazienza laboriosa e amabilità goldoniana, moderazione politica e familismo rurale. Venezia, per comune ammissione, faceva parte a sé…». È interessante l’implicita, fitta interazione che tutto il volume continuamente propone tra stereotipi, modelli e narrazione storica. Nel descrivere le formazioni storiche non si può che partire dai luoghi comuni; è utile verificarne la consistenza attraverso la costruzione di mo191 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 192 Carmine Donzelli delli interpretativi, in ciò non avendo alcuna ritrosia o soggezione a «contaminare» la pratica storica con quella di altri ambiti disciplinari; ed è infine l’indagine sul campo che dà conto della efficacia, vale a dire della capacità euristica dei modelli provvisoriamente elaborati, restituendo così lo spessore e la forza della narrazione. Un punto di estremo interesse, che ha valore specifico per il caso del Veneto, ma significato e portata più generali, è il modo con cui viene affrontato e risolto il rapporto tra la storia contemporanea e le fasi precedenti. Non v’è dubbio che la storia del Veneto conosca, a partire dal 1866, con l’immissione nella nuova compagine nazionale, un cambiamento radicale di scenario. Ma da dove viene il suo modo stesso di interagire con lo scenario nuovo? Quella modalità specificamente veneta di entrare nella nuova compagine viene da lontano, deriva da un modello «lungo», di cui è indispensabile ricostruire la genealogia8. Per questa via Lanaro affronta in modo efficacissimo, e su un terreno applicativo di estremo interesse, il problema delle radici di lungo periodo della storia contemporanea, istituendo un equilibrio di grande originalità e misura tra continuità e discontinuità. È il caso, per esempio, della particolarissima relazione tra Venezia e il Veneto, due realtà la cui difficile integrazione è destinata via via ad accentuarsi nel corso dell’Ottocento, quando «fra dominazione austriaca e crisi agraria matura […] il rovesciamento del rapporto tra grande e piccola Venetia». È da allora, e in modo progressivamente sempre più netto, che Venezia «entra in un’orbita eccentrica, se non appartata, con periodici scoppi di gelosia, di risentimento, di segregazionismo» nei confronti della regione alle sue spalle (pp. 20-1). Allo stesso modo, un altro punto decisivo della realtà e dell’autorappresentazione del Veneto contemporaneo – la presenza e l’influsso di un cattolicesimo in grado di costituire un profondo e radicato «potere diffuso» – nasce da una idea lunga di «compenetrazione perfetta tra depositum fidei e città terrena», cui corrisponde una pratica consolidata di radicamento del clero sul territorio, secondo un modello che considera l’organizzazione sociale come una «vigna del Signore». Il che garantisce agli «uomini di Chiesa» della regione di essere stabilmente e costantemente «attivi nei luoghi della pace e della guerra, del potere e della ribellione al potere, dell’integrazione sociale e dello scontro di classe». La forza ideologica del cattolicesimo veneto sta nella capacità di presentarsi sul lungo periodo come una «koiné che im8 Genealogia di un modello è il titolo del saggio di apertura del volume, firmato da Silvio Lanaro, quasi un piccolo libro a sé (pp. 5-96). 192 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 193 La Storia delle regioni Einaudi e Il Veneto di Silvio Lanaro pregna anche gli ambienti laici» e che «permane come alfabeto dell’anima, principio ordinatore dell’esperienza, grumo irrisolto di eredità intellettuale in coloro stessi che presto o tardi si emancipano». Nell’impatto con la modernizzazione e con la nascita di un Veneto a forte vocazione industriale, tutto ciò produce, nei decenni successivi all’annessione, quello che Lanaro definisce «il capolavoro della Chiesa veneta: la costruzione di un immaginario rurale, chiamato soprattutto a educare i lavoratori dell’industria». Si entra così in quello che è forse l’asse portante, il vero architrave dell’intero volume: il rapporto tra il Veneto rurale (che è, com’è evidente, qualcosa di ben più vasto e complesso di un insieme di pratiche produttive o di rapporti proprietari) e la sua progressiva trasformazione – la sua massiccia dislocazione – nell’esperienza di una modernizzazione industriale che si farà via via sempre più diffusa e capillare. Quello che farà del Veneto la patria di un disciplinamento operaio, in grado di alternare di volta in volta il solidarismo paternalistico e le durezze del controllo sociale, è esattamente il suo caratteristico modo rurale di entrare nella modernità. La pista, magistralmente dischiusa da Lanaro, è sviluppata con forza dai saggi di Carlo Fumian e di Giorgio Roverato, e completata da un inserto di fotografie, realizzate appositamente per il volume da Antonia Mulas, che conducono una lettura visiva di grande precisione attorno alle esperienze industriali della Schio di Alessandro Rossi e della Valdagno dei Marzotto9. Questo «modello» ha del resto – come mostra magistralmente Mario Isnenghi nella parte conclusiva del suo lungo saggio su I luoghi della cultura – il suo preciso corrispettivo letterario. Se «il Veneto è anche un sogno letterario, un’accumulazione narrativa opera dei suoi scrittori», non per caso «è Vicenza, la piccola città di Zanella e di Fogazzaro, il luogo di elezione della linea maggioritaria, un concentrato letterario dove, da cent’anni ed oltre, il romanzo nasce dal romanzo e la pagina dalla pagina» (p. 396). Quello letterario, per Isnenghi, è un universo regionale «magnetizzato dai preti: dalle loro canoniche assise al centro dei paesi rurali, dove passa e si decide tutta la vita del paese; dalle loro ansie teologiche ed erotiche, di carità e di potere; dalla loro diversità e centralità […]; dall’incombere dei seminari e dei vescovati». Il che non vuol dire che questo magnetismo comporti «l’assenza di fermenti critici, rimostranze e stanchezze avverso la centralità che si contribuisce, intanto, a ribadire e perpetuare» (p. 397). 9 C. Fumian, Proprietari, imprenditori, agronomi (pp. 99-162); G. Roverato, La terza regione industriale (pp. 165-230); le fotografie di A. Mulas sono raggruppate sotto il titolo Schio e Valdagno: l’imprenditoria veneta e i suoi «artisti» nell’inserto tra le pp. 96 e 97. 193 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 194 Carmine Donzelli Il contraltare – e per paradosso l’inveramento – di questa linea di lettura del Veneto contemporaneo (del suo essere a pieno titolo parte riconoscibile, modo d’essere specifico, e insieme luogo costitutivo di tratti essenziali dell’identità e della configurazione storica dell’Italia contemporanea) è rappresentato dalla forza, dal carattere e dalla complessità dei suoi flussi emigratori. Anche per questo aspetto Il Veneto Einaudi mostra una qualità storiografica particolare. I contributi di Emilio Franzina e di Piero Brunello10 registrano due punti di osservazione complementari; il primo disegna un potente quadro d’insieme del fenomeno dell’emigrazione veneta lungo tutto l’arco di un secolo, dagli anni settanta dell’Ottocento agli anni settanta del Novecento, quando si assisterà a una repentina inversione dei flussi, e rappresenta la prova sicura e autorevole di uno studioso che si accrediterà da lì in avanti come uno dei massimi storici del movimento migratorio italiano11; il secondo, in un piccolo saggio che rimane un gioiello dell’approccio «microstorico», racconta in chiave soggettiva la storia di Giacomo Rosso da Marcon, della sua improvvisa decisione di emigrare, dell’acquisto del biglietto, delle sue peripezie per arrivare all’imbarco, a Genova, della sua emigrazione… mancata. Una straordinaria «fenomenologia» dell’emigrante, descritta con potente qualità narrativa. E qui tocca fermarsi, per rispettare l’intento di queste pagine, che non è quello di passare in rassegna analiticamente Il Veneto di Lanaro (e di Isnenghi), quanto quello di ripercorrere le origini di un sodalizio che ne fece il primo esperimento, e dunque il capostipite, di una serie che ancora oggi mi pare caratterizzata da una ispirazione felice. Ma occorre, prima di chiudere, dar conto dell’ultimo capitolo del volume, dal titolo programmatico Un modello stanco, firmato insieme da Lanaro e Isnenghi (pp. 1069-85). Qui davvero il volume tocca la vetta da cui gettare uno sguardo che, a distanza di tre decenni, appare illuminante. Sono appena trascorsi pochi mesi da quando, nelle elezioni politiche del 26 giugno 1983, ha cominciato a manifestarsi l’affermazione della «Liga veneta», prodromo di uno tra i più complessi e controversi fenomeni della scena sociale e politica dei decenni succes10 E. Franzina, Dopo il ’76. Una regione all’estero, pp. 471-575; P. Brunello, Emigranti, pp. 579-634; tra i due, l’altro inserto illustrato del volume, una selezione di immagini dell’emigrazione veneta, raccolta sotto il titolo Il lungo addio e firmata da Emilio Franzina. 11 Non a caso, quindici anni dopo, e per iniziativa della casa editrice Donzelli, costituitasi nel frattempo (1993), Franzina avrebbe curato, insieme con Piero Bevilacqua e Andreina De Clementi, quella Storia dell’emigrazione italiana in due volumi che rimane l’indagine più completa e compiuta sull’argomento. 194 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 195 La Storia delle regioni Einaudi e Il Veneto di Silvio Lanaro sivi. È impressionante, oggi, guardare all’inizio di quella parabola, osservandola dal punto che forse comincia a segnarne l’esaurimento. E ancor più impressionante è osservare quell’inizio con le lenti lucide e lungimiranti di Lanaro e Isnenghi. Cosa c’è dietro le frasi xenofobe e le scritte anti-meridionali («A morte i teroni», «Fora i romani», «Forsa Etna») che campeggiano sui muri e sui ponti dell’autostrada Serenissima, e che «nessuno si sogna di cancellare»? Certo – rispondono Lanaro e Isnenghi – c’è «la lega dei senza-partito, dei contro-partito». Il non-partito che raccoglie «la stanchezza e il rancore» nei confronti di «tutti i partiti e del loro quarantennale potere». «Ma – sentite – che cosa interviene a differenziare il nuovo fenomeno da una risorgiva del vecchio qualunquismo nazionale […]? Dov’è propriamente il Veneto in tutto ciò?». Il fatto è che «il sentimento di non appartenenza al sistema dei partiti evapora e sfuma in una non-appartenenza al sistema-Italia […] questo chiamarsi fuori si esprime tanto con una desolidarizzazione del punto di vista statuale e grande-nazionale quanto con l’enfatizzazione del bozzolo di una “piccola patria”, e però nazione pur essa, il Veneto». Si tratta di esibire un «passato preunitario, un remoto e accertato statuto di popolo-nazione-stato», da contrapporre all’appartenenza unitaria che si intende negare. «E l’Italia? L’Italia è assente, come nazione e come stato. È il non-essere, la indebita forzatura istituzionale delle longevità storiche». Né si tratta di comportamenti legati alla sola parte più tradizionalmente rurale. «L’ecografia elettorale in proposito non inganna, perché i voti della Liga […] non toccano mai la soglia del 6% nella pianura bassa e nel suo abitato rurale [… mentre] il tetto del 6% viene addirittura sfondato proprio nei luoghi classici del modello agroindustrialista: […] 10% ed oltre nei comuni più ricchi intorno a Montebelluna e Valdobbiadene». Leghismo come fenomeno «moderno» e «post-industriale»? Agli intellettuali che si affannano a leggerlo così, e ai «sociologi di alta scuola» che vogliono cogliere in esso «un processo di enucleazione di tutte le minoranze che l’Europa reprime», Lanaro e Isnenghi danno una risposta brusca, con un giudizio che allora (confesso) mi sembrò troppo drastico: «La Liga veneta, così com’è, appare un mero epifenomeno, tutt’altro che all’altezza di un nobile domani». Troppo drastico? Potenza dei veri libri di storia. 195 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 196 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 197 PENSARE LA NAZIONE La storia della «prima Repubblica» riletta alla fine della «seconda» di Guido Crainz La Storia dell’Italia repubblicana di Silvio Lanaro esce nel 1992, cioè nell’anno e nei mesi in cui ufficialmente crolla la «prima Repubblica». In realtà il suo racconto si arrestava, in buona sostanza, al 1978: l’anno in cui, a mio avviso, la «prima Repubblica» era stata sepolta davvero, assieme ad Aldo Moro. Agli anni ottanta erano dedicate poche pagine, quasi si cogliesse bene che era iniziata ormai un’altra storia, destinata a portare altrove. Il libro si concludeva con un auspicio: che l’Italia, paese «che ha sempre pagato prezzi esagerati per diventare normale», potesse almeno per una volta «normalizzare la propria vita pubblica senza eccessi di sudore e di lacrime»1. Auspicio andato deluso, purtroppo: sudore e lacrime non sono mancati e abbiamo trovato anche risate sguaiate e dilapidazioni senza freno di civiltà, regole e culture. A mio avviso in quelle pagine del 1992 circola proprio l’idea che si fosse giunti davvero all’Epilogo, e non solo di un libro: quest’impressione ci colpisce oggi con enorme forza. Meglio ancora: questa è la prima cosa che quelle pagine ci aiutano oggi a capire in modo definitivo. Finisce con quell’Epilogo, finisce con l’assassinio di Moro assieme agli anni settanta anche la storia di cui si era narrato sin lì. E non per una sopravvalutazione del ruolo di Aldo Moro nella vita della Repubblica, cui sono dedicate nel libro pagine non proprio elogiative (che continuo a condividere). Moro è posto sì «una spanna sopra gli altri» per «l’indubbia statura intellettuale e l’innata abilità nel gioco della politica», ma questo giudizio è solo l’inciso della proposizione principale. E fa risaltare meglio quel che essa in realtà sottolinea, cioè 1 S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, Marsilio, Venezia 1992. 197 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 198 Guido Crainz la «alacre passività» del leader democristiano e la sua responsabilità nel far fallire il riformismo più ardito del primo centrosinistra2. L’idea della fine di una storia, di una Finis Italiae, viene proprio dall’«aura» di quell’Epilogo, dalle culture che ricostruisce ed esplora: quelle del Partito comunista di Enrico Berlinguer o quelle di una nebulosa terroristica di cui viene scritto il più feroce e fondato epitaffio. O le ombre piduiste e «gladiatorie» della Democrazia cristiana. Le ragioni per cui il paese è giunto a quell’epilogo sono ampiamente scandagliate nelle oltre quattrocento pagine precedenti. Necessariamente da rileggere, ove si voglia comprendere almeno in parte il dopo: ove si vogliano cogliere cioè le radici di quanto sarebbe accaduto all’indomani di quei funerali di Moro che molti – da Piero Craveri ad Andrea Riccardi – hanno letto come «funerali della Repubblica». Che fossero da leggere con grande attenzione lo diceva già allora – nel primo capitolo e nella prima nota di un libro secondo me molto «lanariano» e molto laico – Lorenzo Ornaghi, in quegli anni collega di Silvio a Teramo3: futuro rettore dell’Università Cattolica di Milano e poi ministro dei Beni culturali (è il secondo ministro che mi viene da citare in poche righe, e non come ministro ma come intellettuale: buon segno, forse). Lanaro, osservava Ornaghi, ha dimostrato «brillantemente e quasi sempre convincentemente» come l’Italia abbia faticato più di altri paesi «nel darsi una cultura egemone che fosse, soprattutto, “autonoma”». Nella Storia dell’Italia repubblicana, continuava, «la “cronaca di palazzo” è, giustamente, soltanto un tassello del cubo di Rubik rappresentato da una società italia2 Ibid., p. 335. Giustamente un’accurata e seria rassegna storiografica di Renato Moro su Aldo Moro nella storia d’Italia indica in Lanaro il più autorevole fra coloro che hanno espresso un giudizio molto critico su Moro (e sono molto orgoglioso di essere apparentato a lui in una nota): cfr. Aldo Moro nella storia dell’Italia repubblicana, a cura di «Mondo contemporaneo», Franco Angeli, Milano 2011, pp. 54-5. 3 Ho acuta nostalgia delle cene teramane in cui Filippo Mazzonis faceva da «padrone di casa», o da «teramano anziano», ai più recenti colleghi: da Lanaro a Ornaghi, appunto, da Gabriele Turi a Piero Moretti, ad altri ancora. Essendo appena giunto a Teramo come ricercatore di fresca nomina parlavo pochino e quindi mi godevo per intero e «imparzialmente» quelle discussioni. Evocando quel periodo dopo la morte di Mazzonis, Lorenzo Ornaghi ha scritto: «Le serate con Filippo Mazzonis, Piero Moretti e Silvio Lanaro sono tra i ricordi migliori e più gelosamente custoditi della mia esperienza teramana. Non saprei dire se quelle cene e quelle lunghe conversazioni fossero un “altro modo” di vivere l’Università, o non piuttosto rappresentassero ciò che ancora l’Università è e deve restare. Certamente imparai soprattutto lì ad affezionarmi alla Facoltà e ai suoi studenti». L. Ornaghi, Educare alla storia (ossia il mestiere dello storico come passione umana), in Filippo Mazzonis. Studi, testimonianze e ricordi, a cura di F. Bonini, M. R. Di Simone, U. Gentiloni Silveri, Edizioni Scientifiche Abruzzesi, Pescara 2008, p. 748. 198 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 199 La storia della «prima Repubblica» riletta alla fine della «seconda» na sempre in bilico tra scetticismo collettivo e ribellismo individuale, tra partecipazionismo vociante e qualunquismo da suk»4. Questa lettura illumina bene aspetti che troveranno dilatazione ed esasperazione in quella «seconda Repubblica» che a mio avviso ha la sua prima incubazione se non proprio nel 1978 forse nel 1980 (ma su questo tornerò): anno spartiacque, in cui è sempre più evidente un dilagare della corruzione e del degrado delle istituzioni che porterà al crollo del «sistema dei partiti», mentre inizia al tempo stesso ad affacciarsi l’irresponsabile ottimismo degli anni ottanta. In quell’anno, peraltro, consolida definitivamente la propria leadership nel Psi Bettino Craxi, che di entrambi questi aspetti sarà demiurgo e simbolo. Sono altrettanto illuminanti alcuni aspetti del libro che furono messi allora sotto accusa, in particolare quella che fu considerata una sottovalutazione e svalutazione della «stagione dei movimenti». Giovanni De Luna, ad esempio, ancora affezionato all’idea della «lunga durata del ’68 italiano, una specificità assoluta del nostro Paese» (parole sue), vedeva nel libro di Lanaro una lettura «totalmente marasmatica» e demonizzatrice del ’68, che ignorava le «vibranti passioni collettive e i grandi investimenti su progetti» di quel periodo5. A quelle passioni De Luna si è riferito anche di recente in Le ragioni di un decennio6: un libro che esplicitamente richiama Le passioni di un decennio. 1946-1956 di Paolo Spriano e che a mio avviso ne ripropone il «giustificazionismo soggettivo» (mutati naturalmente i decenni, i protagonisti e le organizzazioni d’appartenenza). E che poco ci fa capire del rapporto fra gli anni settanta e quel che sarebbe venuto poi. Condivisi allora quella critica di De Luna al libro di Lanaro; oggi mi sembra largamente sbagliato il giudizio «trionfalistico» sul ’68 che la reggeva. Certo, le parti della Storia dell’Italia repubblicana che De Luna criticava erano «estreme»: «una modernizzazione lasciata a se stessa – scriveva Lanaro – scialacqua il superfluo della propria ric4 L. Ornaghi - V. E. Parsi, La virtù dei migliori. Le élites, la democrazia, l’Italia, il Mulino, Bologna 1994, pp. 17 e 32. Il capitolo è di Ornaghi, il lavoro di Silvio è presente più volte anche nelle parti scritte da Parsi: cfr. ad esempio pp. 113 e 174. Ornaghi aveva già dedicato un’ampia e intelligente recensione al precedente libro di Lanaro su questi temi, L’Italia nuova: cfr. L. Ornaghi, Modernizzazione e giustificazione, in «il Mulino», luglio-agosto 1988, pp. 701-5. 5 G. De Luna, Teniamo famiglia, in «l’Unità», 20 luglio 1992. Lanaro rispondeva – non timidamente, come è facile immaginare – su quella stessa pagina: Caro De Luna, ma quali passioni?. Sono tornato su questi temi in un intervento «autobiografico» quanto il libro di De Luna, ma con giudizi molto diversi: cfr. G. Crainz, La difficile autobiografia di una generazione, in «Lo Straniero», luglio 2010. 6 G. De Luna, Le ragioni di un decennio. 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria, Feltrinelli, Milano 2009. 199 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 200 Guido Crainz chezza – e talora anche il necessario – in un’orgia di autoaffermazione dei soggetti che ne sono stati protagonisti» che ignora «sprezzantemente ogni mediazione politica e istituzionale»7. Giudizi estremi, certo, ma non ci appaiono oggi tragicamente fondati? Non vi è in quelle poche righe sul passato la lucida premonizione di quel che saremo diventati? Del tutto infondata ci appare semmai una lettura del «lungo ’68 italiano» e della «stagione dei movimenti» che include di fatto sotto il suo ampio manto l’esplodere dei corporativismi più sfrenati e le esplosioni localistiche (corporativismi e localismi di cui quel giudizio di Lanaro permette invece di cogliere alcune radici). Se negli «anni ’68» vi fosse stata solo la generosità collettiva evocata da De Luna (e anche da me), forse negli anni ottanta non avremmo visto riesplodere, senza più anticorpi, quella «cultura del successo», quell’individualismo sprezzante delle regole e del bene collettivo la cui incubazione risaliva agli anni del «miracolo». «Passata la bufera», cioè, non avremmo visto riemergere «intatta nei suoi quadri mentali, nei suoi tic comportamentali, nelle sue scelte politiche», come De Luna stesso scrive, un’Italia degli anni sessanta che pare «aver attraversato la stagione degli anni settanta senza lasciarsene sfiorare»8. È poi difficile eludere una domanda molto antipatica (soprattutto per me, figlio non pentito del ’68): ma come è avvenuto il passaggio da quell’ansia di partecipazione splendidamente cantata da Giorgio Gaber9 a quel «partecipazionismo degli italiani che nome non hanno» che Giorgio Bocca vedeva trionfare nelle trasmissioni di Raffaella Carrà degli anni ottanta?10 E …ce n’était qu’un début, verrebbe da dire: quel «partecipazionismo» è indubbiamente uno dei tratti distintivi più sciagurati della «seconda Repubblica». Non voglio negare che in queste parti del libro di Lanaro vi sia anche qualche ingenerosità: se gli «anni ’68» fossero stati solo quello che Lanaro diceva non capiremmo le incrinature reali che essi avrebbero indotto (ad esempio l’incubazione di «ceti medi riflessivi» reali, sia pur minoritari, per usare parole e idee di Paul Ginsborg). Voglio dire però che Silvio Lanaro poneva esattamente i problemi che ci aiutano a capire meglio anche le origini e gli incunaboli degli anni ottanta11. Cioè le origini di quel «deficit di cittadinanza» su cui Lanaro insisteva troppo Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana cit., p. 406. De Luna, Le ragioni di un decennio cit., p. 13. 9 «La libertà non è star sopra un albero/ non è neanche il volo di un moscone/ libertà non è uno spazio libero/ libertà è partecipazione»: G. Gaber, La libertà, 1972. 10 G. Bocca, Hip, hip, Carrà!, in «L’Espresso», 11 marzo 1983. 11 S. Viola, È già marcita la nuova Italia, in «la Repubblica», 6 dicembre 1994. 7 8 200 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 201 La storia della «prima Repubblica» riletta alla fine della «seconda» anche secondo un altro amico comune, Nicola Gallerano: al tempo stesso però Nicola era molto attento al «grande respiro intellettuale» e alla «grande sapienza narrativa» di un libro che «ha dato dignità storica al problema dell’identità nazionale dell’Italia repubblicana, per la prima volta affrontato con tanta ricchezza analitica e sicurezza interpretativa»12. E scusate se è poco. Già qualche anno prima, del resto, Lanaro aveva iniziato una impietosa riflessione sulle gravissime carenze, se non sull’inesistenza, dell’identità nazionale, sottoponendo al lettore dati aspramente contraddittori: L’Italia nuova. Identità e sviluppo. 1861-1988. Il libro iniziava ricordando che la Comunità europea prevedeva per l’Italia tassi di crescita molto più alti della media europea ma sottolineava anche lo stato disastroso del nostro bilancio, in particolare per l’entità abnorme del debito pubblico. E segnalava, sulla base degli studi del Censis, che almeno il 12,5% del Pil era frutto di attività criminose: e in quel perverso contenitore la somma da addebitare alla corruzione politica era di poco inferiore a quella lucrata con estorsioni e ricatti o al bottino complessivo di furti e rapine. Vi affiancava altri dati, che disegnavano l’immagine di un paese privo di regole e consapevole di esserlo: in altri termini, un paese privo di fondamenti condivisi e legittimi del vivere collettivo13. Una conferma, a me sembra, di quel che accennavo all’inizio: vi erano già lì i tratti di una «seconda Repubblica» iniziata negli anni ottanta. È eccessiva, questa mia lettura? È una pura provocazione, che ignora chiavi interpretative, questioni istituzionali, periodizzazioni consolidate? Certamente sì, ma forse ha più ragioni di quanto appaia a prima vista. E, sotto traccia, è meno isolata di quel che sembri. Nel maggio del 2011, ad esempio, mi hanno colpito i convergenti e quasi identici commenti che due osservatori acuti e ironici hanno dedicato alla sconfitta del centrodestra nella sua roccaforte milanese, indubbio annuncio che la stagione di Berlusconi era giunta al termine. «Ieri in Italia sono finiti gli anni Ottanta. Raramente nella storia umana un decennio era durato così a lungo», scriveva Massimo Gramellini su «La Stampa» del 31 maggio. In quello stesso giorno l’Amaca di Michele N. Gallerano, La repubblica degli apoti, in «L’Indice», novembre 1992. Un’indagine promossa dalla presidenza del Consiglio, ad esempio, aveva chiesto a un campione significativo di italiani cosa contasse di più per affermarsi nella vita, invitandoli a indicare tre opzioni. Per il 48% la cosa più importante era «conoscere le persone che contano» (indicazione ribadita da un’altra risposta, che raggiungeva il 31,3%: «disporre di un appoggio politico»); per il 42,5% era determinante «avere fortuna» e solo per il 35,4% «essere preparati culturalmente»: cfr. S. Lanaro, L’Italia nuova. Identità e sviluppo 1861-1988, Einaudi, Torino 1988, pp. 5-6 e 22-3. 12 13 201 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 202 Guido Crainz Serra su «la Repubblica» iniziava così: «Ieri, lunedì 30 maggio 2011, verso le quattro del pomeriggio, sono finiti per sempre gli anni ottanta italiani, il decennio più lungo della storia del mondo». Ritorniamo così al punto d’avvio e alla ragion d’essere di questo intervento, cioè a una lettura dell’Italia repubblicana che rivisiti quel libro di Lanaro proprio oggi: cioè nel momento in cui sembra giunta al termine anche la «seconda Repubblica» (sperando, naturalmente, che sia davvero così). Oggi, a me sembra, i rapporti fra i decenni sembrano complicarsi ma forse si semplificano, ci appaiono più trasparenti nella loro problematicità. Nello stesso anno dell’assassinio di Moro, ad esempio, si annuncia con forza un mutamento radicale degli scenari culturali, in primo luogo con lo stravolgimento dei confini fra «privato» e «pubblico». In molti e autorevolissimi commenti giornalistici quell’anno terribile andrà agli atti non come «l’anno di Moro» ma come l’«anno del riflusso»: Si chiude l’anno del riflusso e della riscoperta del privato, scriveva ad esempio il 31 dicembre 1978 Carlo Bo sul «Corriere della Sera», e convergenti bilanci venivano in quello stesso giorno da Eugenio Scalfari su «la Repubblica»: L’anno nuovo scacciapensieri ci porta un po’ di restaurazione. Ma era davvero inedito il prorompere negli anni ottanta di modelli individuali poco curanti dei vincoli collettivi? Davvero quei processi vennero alla luce all’improvviso, senza una lunga fase di incubazione? E ancora, volgendo lo sguardo all’economia e alla politica: i processi che portarono al tracollo del 1992 sono attribuibili per intero agli anni ottanta? In altri termini: è possibile riflettere sul nostro presente senza interrogarsi sull’insieme dei processi di modernizzazione che segnano la fine dell’Italia povera e contadina e hanno il loro primo culmine negli anni del «miracolo economico»? In questo allargamento drastico dell’orizzonte non scompaiono certo le specificità essenziali degli anni ottanta, o alcuni tratti di essi che dobbiamo ancora comprendere appieno (le radicali trasformazioni intervenute nell’universo della comunicazione, ad esempio). Sfumano però fortemente le contrapposizioni e le rigide separazioni di decenni e climi culturali. Se negli anni ottanta sembrano riemergere modi di essere che avevamo già visto prorompere negli anni del «miracolo», dovremmo considerare allora gli anni settanta come una «parentesi»? O dobbiamo piuttosto ammettere che il nostro modo di guardare a quel decennio è stato a lungo unilaterale, fortemente influenzato dai vissuti «conflittuali» di allora? Scomparvero davvero negli anni settanta quelle tendenze, quello sprezzo delle regole, quel202 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 203 La storia della «prima Repubblica» riletta alla fine della «seconda» la lontananza dallo Stato, quell’atteggiamento predatorio nei confronti del bene pubblico che erano già apparsi negli anni del «miracolo economico»? Mi ha molto colpito un libro di Howard Sounes che in riferimento all’Inghilterra parla di un «decennio piuttosto stupido e decisamente volgare […]: un periodo di mode adorabilmente demenziali, di musica cattiva in modo sconcertante (tanto cattiva da diventare buona) e di deliziosi film e programmi televisivi spazzatura, di cui siamo in qualche modo obbligati ad avere una nostalgia collettiva»14. Tutto bene, ma c’è un particolare: parla degli anni settanta, non degli anni ottanta. E ancora agli anni settanta europei si riferisce Tony Judt quando scrive che sull’onda della crisi economica e della «diffusa violenza politica […] il fascino per le aspirazioni collettive lasciò il posto a un’ossessione per i bisogni personali. In un mondo fattosi più minaccioso, badare al proprio interesse aveva la priorità sulla promozione della causa comune […] gli anni Settanta furono un’epoca di cinismi, illusioni perdute e speranze ridimensionate»15. La cultura degli anni settanta, prosegue Judt, «si rivolse non alle collettività ma all’individuo», e mise in discussione non solo le vecchie certezze ma la possibilità stessa delle certezze16. Ovviamente Sounes e Judt non sono il Vangelo, e naturalmente l’Italia ha una sua specificità: il prolungarsi dei conflitti sociali, i terrorismi, e così via. In realtà però proprio gli scontri asperrimi degli anni settanta, la curvatura ideologica che li segnò e il loro disastroso esito ridussero al minimo non le derive negative dei processi di modernizzazione ma – al contrario – proprio gli anticorpi che la società italiana aveva saputo esprimere sin lì nei loro confronti. Quelle derive poterono così occupare trionfalmente il proscenio e consolidarsi ulteriormente: ha radici qui il disastroso crollo dei primi anni novanta, che non chiamava in causa solo il Palazzo ma anche il paese. Non riguardava solo un ceto politico ma radicati modi di essere della «società civile», o di una parte rilevante di essa. Si collocano qui altre domande, che nel 1992 non erano ovviamente ipotizzabili e che rimandano al Palazzo. Se legami stretti e solide sintonie fra Craxi e Berlusconi vi sono indubbiamente stati, è sensata la lettura del leader socialista come «Giovanni Battista del Berlusconismo»? A me questa lettura pare vera e falsa al tempo stesso. Falsa, perché Craxi H. Sounes, Anni 70. La musica, le idee, i miti, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3 sgg. T. Judt, Dopoguerra. Come è cambiata l’Europa dal 1945 ad oggi, Mondadori, Milano 2007, p. 590. 16 Ibid., p. 593. 14 15 203 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 204 Guido Crainz è intriso degli umori della politica più classica, non di quelli dell’antipolitica. Nasce e cresce sulle ginocchia di Nenni, come si sa (però, come ci ha ricordato una fulminante gag di Antonio Albanese, Giuliano Ferrara è cresciuto su quelle di Togliatti e Furio Colombo su quelle di Agnelli. Poi prenderanno le loro strade). Quella definizione è però anche vera, in più sensi. Da un lato perché Craxi alimenta in modo decisivo quella crescita della corruzione e dell’occupazione partitica dello Stato che contribuisce a infangare e a distruggere l’immagine della politica nel vissuto di milioni di italiani. In quello scenario un intero ceto di amministratori e politici (e di cittadini beneficiari) cresce nell’idea che non esistano confini fra interessi privati e interessi pubblici. A quanti hanno discettato sulla differenza fra «rubare per il partito» e «rubare per sé» giova ricordare le parole di un figlio degli anni ottanta (e «figlio d’arte»: il padre era stato sindaco democristiano e presidente della Provincia), il neppur quarantenne sindaco, sempre democristiano, di Reggio Calabria arrestato per Tangentopoli. Il suo libro-confessione inizia così: Sono un ladro che non s’è mai messo una lira in tasca. Ho rubato per il mio partito. Per distribuire denaro ai big delle correnti che lo controllano […]. Io, per la verità, avrei dovuto incassare sotto forma di carriera: sindaco, consigliere regionale, deputato. Magari sottosegretario o presidente di uno di quegli enti che ti danno più potere di quando sei ministro17. È solo un esempio di quanto i nodi siano intricati, e di quanto alcune apparenze si rivelino poi meno rilevanti di quel che sembra. In un altro libro che a me pare molto «lanariano» – e molto bello sin dal titolo, Italia sperduta – Carlo Donolo ha contestato sul versante opposto l’idea che negli anni ottanta si rubasse «per il partito» e solo oggi, nell’era delle cricche, si rubi solo per sé. «Una menzogna ipocrita», ha scritto, e non solo perché anche allora «c’era un arricchimento privato cui il finanziamento di partito forniva l’alibi». Più ancora perché oggi, scomparsi di fatto i partiti come grandi collettori di idee e di denaro, il singolo politico guadagna per sé come individuo [come in passato, appunto] e come micro-organizzazione politica che deve affrontare campagne elettorali, finanziare un seguito di satelliti, tacitare, far parlare di sé, «comparire». Quindi si ruba per fare politica18. Per un’altra ragione, infine, l’idea di Craxi come «Giovanni Battista del Berlusconismo» ha un qualche fondamento. Con Craxi per la 17 A. Licandro - A. Varano, La città dolente. Confessione di un sindaco corrotto, Einaudi, Torino 1993. 18 C. Donolo, Italia sperduta. La sindrome del declino e le chiavi per uscirne, Donzelli, Roma 2011, p. 61. 204 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 205 La storia della «prima Repubblica» riletta alla fine della «seconda» prima volta il carisma del leader non è espressione di una solida aggregazione sociale, culturale e politica (come fu per Togliatti e De Gasperi, ad esempio) ma surrogato di essa. E si nutre di coreografie, media, dissoluzioni della politica (si rileggano le pagine che Norberto Bobbio dedicò a un momento chiave di quella esperienza, la conferma di Craxi a segretario per acclamazione e non per elezione nel 1984)19. Le questioni, come sempre accade, sono complesse. Proprio questa consapevolezza ci costringe a interrogare più da vicino anche la lunga egemonia dell’uomo di Arcore: era il frutto ineluttabile di un processo o vi hanno contribuito potentemente anche fattori che rinviano alla politica e a scelte politiche? Era tutto già scritto o ha giocato un ruolo decisivo l’inadeguatezza di chi avrebbe dovuto contrastare quella stagione? Nel dicembre del 1994, quando il primo governo guidato da Silvio Berlusconi stava per dissolversi, un lungimirante commentatore laico ammoniva: quando il governo Berlusconi prima o poi cadrà, sul paese non sorgerà un’alba radiosa. Vi stagneranno i fumi tossici, i miasmi del degrado politico di questi mesi. E non si riesce assolutamente a vedere chi sarà capace, a quel punto, di intraprendere l’opera di disinquinamento20. I mesi sono diventati anni e poi decenni ma quelle osservazioni non sono diventate per questo meno attuali. Anzi. 19 N. Bobbio, La democrazia dell’applauso, in «La Stampa», 16 maggio 1984 (ora in Id., Compromesso e alternanza nel sistema politico italiano, Donzelli, Roma 2006, pp. 219-21). 20 S. Viola, È già marcita la nuova Italia, in «la Repubblica», 6 dicembre 1994. 205 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 206 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 207 PENSARE LA NAZIONE Retorica e politica. I percorsi di uno storico di Carlotta Sorba Rileggere a distanza di parecchio tempo saggi che sono stati importanti per la propria formazione è operazione delicata che può avere esiti molto diversi1. Può capitare che ci si senta estranei, o comunque lontani dai temi affrontati o dagli approcci utilizzati; o che si riconoscano meglio, alla lontana, le ragioni dell’influenza che quei testi hanno avuto; o che invece ci si stupisca di non aver colto spunti ben presenti in quelle pagine. Per la mia generazione, quella che ha iniziato l’esperienza della ricerca storica nella prima metà degli anni ottanta, i saggi di Lanaro sono stati delle scoperte entusiasmanti. Il «Plutarco italiano»2, la «campagna che organizza la città»3, la «questione settentrionale»4 sono state immagini capaci di dare una luce nuova alla narrazione dell’Italia postunitaria che ci era arrivata dalla generazione storiografica precedente; ci hanno stupito, incuriosito, fatto pensare, e confermato in una passione per la storia fatta di costante sforzo interpretativo e non solo di ricostruzione documentaria. Non tutti ma molti di questi testi sono stati opportunamente raccolti da Donzelli in un volume uscito nel 2011 e riuniti intorno al titolo Retorica e politica. Alle origini dell’Italia contemporanea5. Sono una decina di saggi scritti tra il 1971 (così quello sul «protezionista precoce» Alessandro Rossi) e il 1998 (l’ultimo capitolo dedicato a «i fascisti»), comparsi a suo tempo su riviste («Quaderni Storici», «Meridiana», «Cheiron»), negli Annali Einaudi o in libri collettanei. Tutti riguardano la storia italiana, an1 Sulla pratica della rilettura si vedano le riflessioni di P. M. Spacks, On Rereading, Harvard University Press, Cambridge (Ma) 2011. 2 S. Lanaro, Il Plutarco italiano: l’istruzione del «popolo» dopo l’Unità, in Storia d’Italia, Annali, 4, Intellettuali e potere, a cura di C. Vivanti, Einaudi, Torino 1981, pp. 553-87. 3 S. Lanaro, La campagna organizza la città?, in «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», 1989, 5, pp. 49-60. 4 Id., Le élites settentrionali e la storia italiana, ivi, 1993, 16, pp. 19-39. 5 Id., Retorica e politica. Alle origini dell’Italia contemporanea, Donzelli, Roma 2011. 207 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 208 Carlotta Sorba che se sono costantemente attraversati da riferimenti alla storia europea, con un’attenzione specifica, inutile dirlo, alla Francia, alla quale Lanaro ha sempre attribuito un ruolo di speciale contraltare rispetto alla storia italiana. Del fatto che questa operazione di raccolta fosse utile e importante ero ampiamente persuasa già prima di prendere in mano il libro, e tuttavia rituffarsi dopo molto tempo in quelle pagine mi procurava qualche timore, forse in ragione dell’entusiasmo che ad esse era legato. Facevano comunque parte di una stagione storiografica lontana e diversa, sebbene fossero dotati di un’originalità molto particolare che li aveva resi subito ben difficili da classificare – una storia culturale ante litteram ma innestata sulla «dura materia del sociale»6 – oltre che quasi impossibili da tradurre. Quale esito avrebbe prodotto dunque la rilettura odierna? Di attuale c’era in prima battuta il filo scelto da Silvio Lanaro per tenerli insieme oggi e che era espresso innanzitutto nel titolo e nell’introduzione. Retorica e politica, spiega l’autore, sono un intreccio onnipresente nella storia dell’Italia unita, poiché la retorica accompagna e segna i percorsi della politica in modo più forte, pervasivo e continuativo di quanto non succeda in altri paesi europei. E per retorica sembra intendere il potere, creativo o manipolativo che sia, del linguaggio in tutte le sue forme, una sorta di gusto insistito per le parole e per i suoni che a suo dire percorre tutti i passaggi cruciali della vita collettiva del paese e ci consente di leggere tra le loro pieghe. E che descrive così: La retorica come apparato concettuale predisposto a tutela di un’opinione sinceramente professata, s’intende, ma anche come verbigerazione fonica (La Sagra dei Mille di Gabriele D’Annunzio), o come suggestione metaforica e metonimica («quota Novanta», «la quarta sponda» di Benito Mussolini), o come ossimoro ora provocatorio ora anticonformista (la «monarchia socialista» di Mario Missiroli, la «bellezza della lotta» di Luigi Einaudi), o come dotto espediente letterario (Quid agendum di Sidney Sonnino), o decisamente doppiezza e ridondanza esornativa […] intesa a mascherare nell’azione politica la mancanza di ogni rigore civile, serietà morale e impegno intellettuale7. In tali saggi, ci suggerisce allora in avvio del volume, sarà possibile individuare un’attenzione costante ai percorsi concettuali e comunicativi del linguaggio politico, e un interesse specifico per il potere delle parole. Si tratta di elementi che sono stati d’altronde sempre, an6 Cito da S. Lanaro, Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925, Marsilio, Venezia 1979, p. 10. 7 Id., Retorica e politica cit., p. VIII. 208 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 209 Retorica e politica. I percorsi di uno storico che prima della cosiddetta svolta linguistica, al centro della sua riflessione. È abbastanza chiaro inoltre, se si percorrono con attenzione queste pagine, che in quel gusto particolare della parola Lanaro in modo sottilmente autoironico include anche se stesso – lo storico che scrive – e finisce così per ritrovarsi immerso tra i numerosissimi personaggi che popolano il libro, in modo meno diretto ma altrettanto sofisticato di quanto ha fatto Natalie Zemon Davies dipingendosi tra le sue donne ai margini8. Questo ci ricorda, semmai ce ne fosse bisogno, che da questi stessi saggi, o da altri testi di Lanaro, sono emersi molti termini o locuzioni che hanno finito per accreditarsi stabilmente nella storiografia italiana, e in qualche caso (si pensi a «nazional-lavorismo», ovvero la spinta pedagogica che nelle classi dirigenti moderate aveva unito strettamente nazionalismo e produttivismo) per segnarne un’epoca e persino per entrare nel linguaggio della politica. Successe per il «paese normale», l’analisi-auspicio che conclude la Storia dell’Italia repubblicana e che Massimo D’Alema fece propria divenendo segretario nazionale del Pds nel 1994. Ma continuando sul filo dell’attualità si pensi anche all’immagine oggi politica più che mai di «questione settentrionale», un’espressione coniata da Lanaro per indicare come problema di lungo periodo della storia italiana il rapporto difficile tra élites settentrionali e unità dello Stato. Alla storiografia rimangono poi molte altre definizioni illuminanti – scelgo a caso all’interno del libro – come quella di «profeti dell’industriosità» usata per indicare quel filone di pensiero settentrionale, impersonato in primo luogo da Carlo Cattaneo o Melchiorre Gioia, che nel suo orientamento cosmopolita e autonomistico ma ben poco unitario in realtà Silvio Lanaro non sembra particolarmente amare; oppure ancora quella di «intellettuali nascosti», ad indicare tutti quei funzionari, piccoli intellettuali, bibliotecari, conservatori di musei, ispettori di scuola e di sovrintendenza che diffondono e costruiscono il sapere ufficiale della nuova Italia (il topos della nazione industrialista e protezionista), e che Lanaro insegue e descrive con una penna e un’abilità straordinarie in quanto «ingegneri di italianità». Sono alcuni esempi dei molti temi e dei molti personaggi che compaiono nel volume. Su alcuni di essi la storiografia ha lavorato parecchio negli anni ottanta e novanta (le diverse forme della pedagogia nazionale, ad esempio; o l’importanza dei saperi tecnici e speciali nel costituire uno sforzo normativo per il dominio sociale), sulla scia di una 8 N. Zemon Davis, Donne ai margini. Tre vite del XVII secolo, Laterza, Roma-Bari 1996. 209 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 210 Carlotta Sorba disseminazione molto ampia, ma anche assai frammentaria, delle suggestioni lanciate da Lanaro. Altri temi invece, e altri spunti rintracciabili in questi saggi, hanno trovato ben poco seguito negli studi successivi e rimangono tuttora isolati. Il più eclatante mi pare riguardi il capitolo dedicato ai contadini, un tema su cui la storiografia italiana ha in seguito lavorato pochissimo, tanto che la letteratura sull’Italia rurale postunitaria è ancora oggi sorprendentemente esigua. Messi uno affianco all’altro questi dieci saggi ci parlano di un itinerario di indagine che si snoda tra il periodo postunitario (con un’accentuazione sugli anni settanta e ottanta dell’Ottocento) e il fascismo, mostrando un asse interpretativo forte sviluppato lungo rivoli diversi. Difficile sintetizzarlo senza semplificarlo o banalizzarlo, per di più non avendo la maestria lessicale e sintattica dell’autore, che è una cifra forte di tutto il suo lavoro. E tuttavia il filo interpretativo che li attraversa è abbastanza chiaro e riguarda il rapporto stretto e molto italiano che tra gli anni ottanta dell’Ottocento e gli anni venti del secolo successivo unisce in un gioco di richiami sempre più stretti i tre elementi chiave dell’intera produzione di Lanaro sulla storia italiana, cioè il protezionismo, il nazionalismo e il fascismo. Pur nella solidità del filo interpretativo quello che l’autore ci propone si può però definire un percorso accidentato, che procede a frammenti, pieno di détours e di sfumature che lo rendono denso e complesso. Si parte dalla genealogia di quella che Lanaro definisce l’utopia protezionistico-conservatrice propria del moderatismo italiano e che ritiene essere stata, in declinazioni diverse, la base culturale fondamentale della sua egemonia. Da qui ci indica gli sviluppi di una via italiana alla modernizzazione che di passaggio in passaggio conferma di temere più di ogni altra cosa il conflitto, il pluralismo, il disordine, e che finirà per individuare nella soluzione fascista quasi una naturale continuità, o comunque uno sbocco coerente rispetto al percorso precedente. Si tratta dunque di domande alte, di interrogativi chiave per la comprensione della storia nazionale, che si sviluppano però in un itinerario molto personale che si lega piuttosto strettamente all’esperienza specifica del Veneto ed entra nella realtà del caso italiano attraverso singole esperienze individuali, incontri imprevisti o episodi apparentemente marginali. La struttura stessa del volume esplicita d’altronde un’attenzione privilegiata per gli «attori» della trasformazione. Ogni capitolo, a parte il primo di taglio più metodologico, è dedicato infatti a uno dei soggetti di questa via italiana alla modernizzazione e intorno ad esso, alle 210 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 211 Retorica e politica. I percorsi di uno storico sue strategie e ai suoi comportamenti, prova ad indagare. Sono ovviamente soggetti molto vari: istituzionali (la monarchia), sociali (i contadini, le élites, gli educatori), politici (gli antigiolittiani o i nazionalisti), o grandi singoli portavoce di quell’idea protezionista-conservatrice su cui particolarmente Lanaro insiste, come l’industriale Alessandro Rossi o il tecnocrate Filippo Carli. Ma sono in tutti i casi dei soggetti in carne e ossa, con le loro paure e le loro ossessioni, e non sono mai solo delle idee politiche o dei progetti intellettuali (come la storia politica o la storia delle idee avrebbero fatto in quegli anni) e nemmeno delle configurazioni discorsive (come avrebbe fatto più tardi la storia culturale più direttamente ispirata a Michel Foucault). Sono soggetti in carne e ossa (tutti, persino Vittorio Emanuele III e i suoi incubi), e per di più talmente complessi e talvolta contraddittori che si tratta di figure difficilmente incasellabili in quadri discorsivi compattamente definiti. Direi anzi che ad interessare particolarmente l’autore e ad attirare la sua attenzione sono per lo più proprio gli incroci, i pastiches e gli itinerari misti, più dei personaggi tutti d’un pezzo. E dal punto di vista delle situazioni quelle che definisce «le linee d’ombra, le terre di nessuno, le zone grigie, le marche di confine e le aree di interferenza dove si spengono le passate certezze»9, più dei quadri netti e ben definiti. È attraverso percorsi individuali e situazioni cangianti di questo tipo che Lanaro cerca di fornire una lettura della storia italiana che passi anche attraverso le sue pieghe più nascoste, non di primo piano, ma in realtà rivelatrici di snodi decisivi nella storia del paese. Due esempi, scelti con personalissimo arbitrio tra i mille che percorrono il volume, possono forse darne un’idea con i loro percorsi almeno in parte inattesi. Il primo riguarda una sorta di garibaldinismo africanista che si sviluppa tra il 1885 e il 1895 e rappresenta una torsione del ribellismo risorgimentale e delle sue eredità alle velleità civilizzatrici del colonialismo di fine secolo10. Un personaggio un poco sorprendente come il colonizzatore romagnolo Romolo Gessi si guadagna ad esempio l’appellativo di «Garibaldi d’Africa» eliminando la tratta degli schiavi praticata lungo il Fiume delle Gazzelle. Finisce così per rappresentare un tramite importante della diffusione a fine secolo di una leggenda garibaldina che trova anche in episodi di questo tipo i motivi di una propria rinnovata vitalità e che viene così sottratta alla custodia esclusiva di repubblicani e radicali per entrare pienamente nelle corde della cultura e della propaganda nazionalista. Sono an9 10 Lanaro, Retorica e politica cit., p. 158. Ibid., pp. 288 sgg. 211 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 212 Carlotta Sorba che fili di questo tipo che secondo Lanaro annodano l’esperienza risorgimentale a quella nazionalista di inizio secolo. Il secondo esempio, non lontano da qui, è impersonato dalla figura del giornalista Gualtiero Castellini, il cui profilo compare abbastanza diffusamente nel capitolo sui nazionalisti e la prima guerra mondiale, a indicare un itinerario biografico possibile nell’Italia del primo Novecento. Castellini è un giovane capitano di buona famiglia che muore sulla Marna a 28 anni. Prima di questa morte precoce ha avuto un’attività intellettuale intensa. Ha scritto sette libri, tra cui una biografia di Crispi e un’antologia di pagine garibaldine, un reportage sulla guerra di Libia e anche un opuscolo di riflessioni su Fasi e dottrine del nazionalismo italiano. Insomma è un giovane brillante, intriso delle contraddizioni e delle suggestioni contrastanti di quei tormentati anni dieci, che vediamo espresse nel bell’epistolario di guerra che viene pubblicato postumo. Chi è allora Castellini, si chiede Lanaro? È innanzitutto una figura che si ritrova a gestire un’eredità familiare che ci riporta direttamente a un altro periodo della storia nazionale: il nonno garibaldino è caduto nel 1866 indossando la camicia rossa; lo zio Scipio Sighele, l’autore della Folla delinquente e di studi pionieristici di psicologia collettiva, è stato rappresentante di un irredentismo moderato che non si riconosce nell’aggressività di Corradini. E lui, che porta in sé tutto questo bagaglio culturale e psicologico, si butta anima e corpo – fino alla morte appunto – in un nazionalismo imperialista che vede in Crispi il «vero e solo padre nostro», che cerca il gesto eroico, che anche nel fango e sotto la pioggia in trincea dà sfogo, in pagine estremamente letterarie, ad un immaginario romantico e melodrammatico dal sapore decisamente risorgimentale. È un «insaziabile consumatore di ideologia – scrive Lanaro – che vive di parole e per le parole»11. Attraverso figure di questo tipo – da un lato sommamente letterarie ma dall’altro costruite a partire da itinerari biografici reali e dalle loro tracce precise – Lanaro ci restituisce dei frammenti importanti della società italiana e della sua trasformazione tra Otto e Novecento. Castellini rappresenta infatti un’ufficialità borghese di cultura umanistica che si forma sul mito del Risorgimento, scopre il popolo, si innamora di lui e trova nel nazionalismo di inizio secolo («l’eccitante farmaco del nazionalismo»)12 una risposta e una soluzione ad un itinerario biogra11 12 Ibid., pp. 302 sgg. La definizione compare nel capitolo sugli educatori a p. 99. 212 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 213 Retorica e politica. I percorsi di uno storico fico e intellettuale di cui, conclude lapidariamente, «solo i nazionalisti sanno annodare i capi»13. Quale dunque l’esito di questa mia rilettura, delicata e timorosa come accennavo all’inizio? In modo abbastanza imprevisto queste pagine hanno finito per intrecciarsi e per dialogare con letture che andavo facendo sugli itinerari attuali della storia culturale14. E hanno rappresentato per me, insieme a quelle, l’occasione di alcune indicazioni importanti sulle direzioni di lavoro che si aprono oggi di fronte a quest’area di studi, dopo l’esaurimento della spinta travolgente della svolta linguistica, pur decisiva per una salutare messa in discussione delle categorie e dei metodi delle macronarrazioni precedenti. Mi riferisco in modo particolare all’idea di un ritorno forte alle soggettività, agli itinerari multipli e sfaccettati delle esperienze individuali, ora comprensivi della dimensione psicologica, emotiva e corporale su cui la nuova storia culturale ha lavorato in vari modi dall’ultimo decennio del secolo scorso15. È una sollecitazione che proviene oggi da direzioni diverse e di cui ritrovo esempi molto efficaci e anticipatori nei saggi di Lanaro. Jacques Revel, tra gli storici francesi uno di quelli che più precocemente ha riconosciuto l’importanza della lezione lasciata da Foucault alla storiografia, ha scritto ormai parecchio tempo fa che per lo più gli storici non avevano perdonato al filosofo di aver scritto la storia della follia senza i folli, quella della prigione senza i prigionieri, e infine quella della sessualità evitando i corpi16. La risposta di Foucault, in un saggio rimasto famoso, era stata lapidaria ed estremamente convincente. Bisognava riconoscere che la società stessa non era la sola «realtà» a cui la storia doveva guardare. Che anche un tipo di razionalità, un modo di pensare, un programma, una tecnica, un insieme di sforzi razionali e coordinati, degli obiettivi definiti e raggiunti, o degli strumenti per raggiungerli erano elementi del reale, senza per questo pretendere di essere «la realtà» nella sua interezza17. Tutto ciò è stato, mi pare, ampiamente assimilato dalla storiografia recente, probabilmente anche da quella meno sensibile all’analisi del discorso foucaultiano. È risultato però sempre più evidente col passare del tempo – lo Ibid., p. 304. Si veda la discussione critica sull’agenda attuale della storia culturale proposta da L. Hunt, La storia culturale nell’età globale, Ets, Pisa 2010. 15 Per uno sguardo sintetico a questi percorsi cfr. A. Green, Cultural History, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008. 16 J. Revel, Michel Foucault (1926-1984), in Dictionnaire des sciences historiques, a cura di A. Burguière, Puf, Paris 1986, pp. 290-2. 17 M. Foucault, La poussière et le nuage, in L’impossible prison. Recherches sur le système pénitentiare au XIX siècle réunies par M. Perrot, Seuil, Paris 1980, pp. 34-5. 13 14 213 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 214 Carlotta Sorba ha sottolineato opportunamente John Toews in un saggio di grande interesse – che il contributo più importante che gli storici possono fornire alla ricostruzione dei discorsi consiste nella particolare attenzione dedicata alla loro pluralità e conflittualità, nella capacità di seguirne le differenziazioni sociali, culturali, di genere, così come i livelli diversi di espressione (discorsi ufficiali, popolari, letterari, e così via)18. Tutto ciò ci riporta – mi pare evidente – agli autori dei discorsi, ai soggetti – individuali o collettivi che siano –, alle loro azioni e alle loro pratiche. Tra le molte cose che la raccolta di saggi di cui stiamo parlando implicitamente ci suggerisce c’è che dopo aver lavorato a lungo sul nazionalismo otto e novecentesco e sui suoi dispositivi discorsivi e comunicativi può essere utile e opportuno ritornare ai nazionalisti e alle loro diverse esperienze, recuperando quella densità di analisi, quell’attenzione per i percorsi dei singoli e i loro intrecci che i saggi di Silvio Lanaro indubbiamente ci restituiscono. 18 J. Toews, Linguistic Turn and Discourse Analysis in History, in International Encyclopedia of the Social and Behavioural Science, Elsevier Press, Amsterdam-Paris 2001, XIII, pp. 8916-42. 214 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp Parte terza Silvio 7-06-2012 13:21 Pagina 215 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 216 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 217 PENSARE LA NAZIONE Lanaro, l’«impolitico» di Umberto Curi La mia evidente extraterritorialità, rispetto al campo di ricerca occupato da Silvio Lanaro, sconsiglia di avventurarsi in un commento che pretenda di entrare nel merito della sua produzione scientifica. Altri, provvisti delle competenze necessarie, lo potranno fare con molta maggiore cognizione di causa, e dunque con la necessaria autorevolezza. Detto questo, vi è tuttavia un terreno nel quale i nostri percorsi si sono più volte incontrati, in maniera certo fugace, ma non per questo meno significativa. Alludo ad alcune vicende biografiche, che non hanno cambiato il corso della Storia (quella con la «esse» maiuscola, appunto), e che probabilmente non hanno modificato in maniera radicale neppure le nostre (minuscole) storie individuali, ma che tuttavia qualche influenza, in lui o in me (o in entrambi), hanno pure avuto. Vale dunque la pena di correre il rischio che sempre incombe su rievocazioni di questo genere, per cercare di cogliere aspetti non del tutto noti della personalità del nostro uomo. Incontro per la prima volta Silvio esattamente cinquant’anni fa, nell’atrio del Liviano, sede della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova. È matricola, iscritto al corso di laurea in Lettere moderne, mentre io, di un anno più vecchio, seguo i corsi per la laurea in Filosofia. Silvio arriva in facoltà preceduto da una fama imbarazzante, e anche un po’ fastidiosa: quella di essere una sorta di enfant prodige, un intellettuale indubbiamente ancora molto giovane, e tuttavia nient’affatto acerbo. Al primo contatto casuale fra noi (una riunione informale fra una decina di studenti, finalizzata alla costituzione di un circolo culturale) questa fama mi appare confermata – e così anche il fastidio per la sicurezza quasi sfrontata con la quale già nell’esordio sembra proporsi all’attenzione di tutti. Con alcune caratteristiche che lo accompagneranno, e lo distingueranno, anche negli anni successivi, fino appunto ai giorni nostri. Un eloquio fluente e forbito, infarcito di 217 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 218 Umberto Curi riferimenti colti, ma mai appiattito sulla mera erudizione. Una capacità di citare a memoria una sfilza interminabile di riferimenti storici e letterari. Un’ironia pungente, sottesa a una sorta di ghigno quasi satanico. Una rara capacità di andare al cuore dei problemi, magari senza la preoccupazione di risolverli pragmaticamente, ma certamente con l’abilità quasi giocolieristica di chi riesca a perlustrarli da tutti i punti di vista, illuminando aspetti per lo più sfuggiti all’analisi degli altri. Per parte mia, partecipavo a quella riunione per un puro caso, o piuttosto per la perspicacia e la lungimiranza di uno fra gli organizzatori di quell’incontro. Le cose andarono così. Una mattina, nell’atrio del Liviano (quante cose sono accadute nel corso di questi cinquant’anni sotto gli affreschi di Campigli!), mi imbatto in uno studente impegnato a vendere non ricordo più quale giornale. Doveva trattarsi di uno dei tanti periodici pressoché clandestini della sinistra «esterna» al Partito comunista italiano. Quasi per risarcire il mio interlocutore del mio rifiuto ad acquistare una copia (avevo già intaccato abbastanza la «paghetta» quotidiana con l’acquisto della «Gazzetta dello Sport»), scambio con lui qualche battuta. L’incontro si conclude con un invito. Giuliano Scabia (era infatti lui, il giovane dedito alla promozione della stampa rivoluzionaria) mi propone di partecipare a una riunione con altri studenti, nel corso della quale avremmo discusso alcune tesi di Gramsci. Confesso candidamente che, prima di allora, non avevo mai sentito nominare il personaggio evocato da Scabia. Ma per evitare di mortificarlo con un secondo rifiuto, accetto di recarmi a quell’incontro. Ci ritroviamo così in una decina di coetanei nei locali di una sezione del Partito socialista. Non per ragioni di contiguità ideologico-politica, ma perché si trattava di una sede riscaldata, a pochi passi dal Liviano e concessa gratuitamente. Non conoscevo nessuno. A presiedere e a introdurre la riunione era uno studente che appariva un po’ più vecchio degli altri (a quell’età, anche tre o quattro anni di differenza si notano), ma che soprattutto mi aveva impressionato per la solennità del suo modo di proporsi e per il rispetto da cui era circondato. Sedeva a capotavola, con la giacca non infilata, ma solo appoggiata sulle spalle, un maglioncino scollato a V, e sotto una camicia chiara e una cravatta annodata con cura. Accanto a lui (appresi quasi subito che il suo nome era Mario Isnenghi), altri con i quali a partire da quel momento avrei intrattenuto rapporti di collaborazione sul piano politicoculturale: Armando Balduino, Mario Quaranta, Lorenzo Renzi, Giuliano Scabia, Orio Caldiron e, appunto, seduto proprio vicino a me, 218 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 219 Lanaro, l’«impolitico» Silvio Lanaro. Non capii quasi nulla dei discorsi che ciascuno dei presenti, in successione meticolosamente ordinata, veniva pronunciando. Me ne rimasi anzi smarrito, un po’ in disparte, cercando di farmi perdonare il silenzio con una generosa distribuzione di ammiccamenti e sorrisi. Una cosa, tuttavia, mi fu subito chiara: che il «capo» del gruppo era Isnenghi, ma che l’elemento sul quale si puntava per una forte valorizzazione del lavoro politico che avremmo dovuto fare era Silvio. Poiché allora le categorie logiche con le quali avevo maggiore familiarità erano desunte dal calcio, si può dire che compresi subito che Isnenghi aveva il ruolo del regista, mentre il compito di segnare i goal era attribuito a Lanaro. Un centravanti di sfondamento, dunque. O, per restare nel paragone calcistico, un talento puro di attaccante, capace di sbloccare il risultato in qualunque momento. L’uomo di maggior classe (senza nulla togliere agli altri fior di «giocatori»), soprattutto per la capacità di abbinare ad una non comune abilità tribunizia, una stoffa indiscutibile di sostanza culturale. Il personaggio che meglio di tutti noi avrebbe potuto «rappresentarci» all’esterno, nel momento in cui fossimo usciti dalla dimensione semicarbonara dei «bravi» studenti del Liviano, e ci fossimo cimentati con platee nazionali. È quanto accadde poche settimane dopo quella riunione. Era stata convocata a Roma un’assemblea dei circoli culturali della sinistra giovanile indipendenti dai partiti storici del Movimento operaio. Ciascuna sede poteva inviare due o tre rappresentanti al massimo. Per il circolo padovano – nel frattempo intitolato a Giaime Pintor, giovane intellettuale sardo, caduto durante la Resistenza – fu immediatamente designato Silvio. Per ragioni che, a distanza di tanti anni ancora mi sfuggono, fui incaricato io di accompagnarlo. Nessuno mi aveva mai sentito pronunciare neppure un piccolo intervento. Avrei potuto essere muto o cerebroleso. Se non fosse stato per i sorrisi e gli ammiccamenti di cui sopra… Sia come sia, ebbi l’impressione di essere stato scelto quale scudiero del grande cavaliere, una sorta di Sancho Panza, tenuto a scortare e assistere la nostra star nella prima trasferta impegnativa di quella che si annunciava come una luminosa carriera politica. Feci diligentemente ciò che mi era stato richiesto, evitando con molta attenzione di prevaricare rispetto alla mera funzione di comprimario che mi era stata assegnata. Per Silvio, l’esperienza di Roma fu un vero trionfo. Pronunciò un discorso dei suoi, acuto, brillante, incisivo, perfino appassionato. Conquistò subito il consenso della stragrande maggioranza dei presenti. 219 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:21 Pagina 220 Umberto Curi Constatai anche, con un narciso sanguinante, che aveva fatto breccia non solo nell’intelligenza di alcune delegate particolarmente avvenenti. Quanto a me, mi ridussi a ricevere i complimenti come «amico» di così efficace protagonista. E compresi anche che, al mio ritorno, avrei dovuto in qualche modo «cantarne» le gesta. Senza peraltro poter neppure ambire alla fama imperitura di altri cantori di eroi del passato. D’altra parte, il duetto fra Sancho e il Quichotte sembrava funzionare a meraviglia, anche dopo la trasferta di Roma. Accadde così che entrambi fossimo eletti nell’Assemblea di Tribunato, il parlamentino degli studenti patavini, nel quale sedevano alcuni eletti più vecchi di noi, come Franco Freda e Toni Negri. Ed entrambi poi entrammo come «uditori» nelle prime sedute del Consiglio di facoltà aperte a rappresentanze selezionate di studenti. Per ritrovarci infine, di lì a pochi anni, ai primi passi della carriera universitaria, a guidare la mobilitazione dei docenti che allora si dicevano tristemente «subalterni», a sostegno del movimento studentesco del ’68-69. In tutte queste occasioni, Silvio ribadì costantemente quello che, a distanza di tanti anni, si può considerare il marchio distintivo della sua attività politica. Impareggiabile nel conquistare un’assemblea, sottile e acuminato nelle analisi teoriche come pochi altri, intellettualmente «libero» da condizionamenti di partito o di schieramento, davvero intensivamente «laico» nell’approccio ai problemi, Silvio era tuttavia drammaticamente incapace di riversare l’enorme prestigio che riusciva a guadagnarsi come uomo di cultura sul piano strettamente politico. Al contrario: talora suggeriva l’impressione di coltivare deliberatamente un tratto di «impolitico», per chiamarsi fuori dalle miserie della politica quotidiana, per accentuare il suo aristocratico disprezzo per i politicanti di professione, per sottolineare l’ulteriorità rispetto a qualunque tentativo di imprigionarlo in una sigla o in una organizzazione. Molto simile in questo al suo «gemello», sodale di vita e di ricerca, quale è stato Mario Isnenghi, si può dire che i due storici veneti abbiano attraversato mezzo secolo di vita politica locale e nazionale senza mai «sporcarsi le mani», senza mai accettare alcun compromesso, senza venire a patti con quella politique d’abord, tanto sbandierata da un personaggio ad entrambi particolarmente inviso, quale è stato Bettino Craxi. Forse anche a causa di questo aspetto – che sottolineo col dovuto rispetto, ma anche con sincero dissenso – verso la metà degli anni settanta la strada percorsa da Silvio si allontana abbastanza nettamente da quella intrapresa da me. Infatti, raccogliendo le costanti sollecitazioni di 220 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 221 Lanaro, l’«impolitico» Massimo Cacciari, nel 1975 mi iscrivo al Partito comunista italiano, rinnovando poi regolarmente la mia adesione fino al 1992, e anzi promuovendo, con lo stesso Cacciari e Luigi Nono, un movimento di intellettuali favorevoli al «nuovo corso» avviato da Achille Occhetto con la svolta della Bolognina. Silvio percorre un itinerario completamente diverso. A parte alcuni punti di contatto fra noi nella seconda metà degli anni settanta (sui quali ritornerò fra breve), egli si apparta sempre più dalla vita politica, verso la quale sembra anzi nutrire una sorta di sordo rancore. Quando, crollato il muro di Berlino, si assiste alla nascita della nuova «cosa» di sinistra, Lanaro e Isnenghi non nascondono la loro preoccupazione che tutto ciò preluda ad un appannamento dell’identità di «sinistra» del partito, e mostrano dunque, almeno inizialmente, maggiore simpatia per i tentativi di rifondazione di una sinistra che non rinunci a dirsi comunista. Ma entrambi non fanno mai mancare il loro sostegno, sia pure sul piano della sola opinione politica, quando si tratta di intraprendere o alimentare campagne contro il «cesarismo» craxiano, o più tardi contro il deterioramento del sistema politico avviato con la discesa in campo di Silvio Berlusconi, o quando si tratta di appoggiare iniziative in difesa della Costituzione repubblicana. Ma i fili del rapporto intellettuale e politico che mi hanno unito, sia pure in maniera «dialettica», per tanto tempo a Silvio, non si spezzano neppure dopo la metà degli anni settanta, e prendono anzi una nuova forma. Assumendo la direzione dell’Istituto Gramsci Veneto, la più innovativa e insieme la più eterodossa istituzione culturale della sinistra nel Veneto, all’inizio degli anni ottanta cerco ripetutamente di coinvolgere Lanaro nelle iniziative di punta della Fondazione, inserendo entrambi – Lanaro e Isnenghi – nel Comitato scientifico dell’Istituto e promuovendo con loro alcuni appuntamenti che lasciano un segno profondo e che appartengono ormai alla storia culturale di questa regione. Solo per citarne uno: il Convegno di studio sulla Democrazia cristiana nel Veneto, e i relativi Atti pubblicati presso l’editore Marsilio, costituiscono ancor oggi un documento imprescindibile per la lettura e la comprensione dei processi in corso, dal punto di vista economico, politico e culturale, nel territorio più «bianco» d’Italia. Un tesoro di analisi e di dati, ai quali un ceto politico meno sprovveduto e miope di quello del Partito comunista veneto avrebbe dovuto attingere a piene mani, per tentare di uscire da decenni di subalternità e di minoritarismo. La sintonia intellettuale con Silvio fu ribadita, all’incirca nella seconda metà degli anni settanta, anche nel contesto di quella esperienza 221 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 222 Umberto Curi per molti aspetti sconvolgente che è stata la lotta armata condotta dalle formazioni combattenti di sinistra, dalle Brigate Rosse a Prima Linea. In particolare, a Padova nell’ambito della sinistra si era creata una contrapposizione – in larga misura artificiosa, e alimentata da ragioni non sempre nobili – fra un fronte che si era autonominato della «fermezza», e un altro fronte, criticato perché giudicato incline alla «trattativa» o alla «mediazione» con i fautori dell’illegalità di massa. Pur essendo in posizioni politiche oggettivamente diverse (io iscritto al Pci, Silvio «libero battitore»), ci ritrovammo nella stessa, scomodissima, situazione: bersagliati, e non solo metaforicamente, da alcuni esponenti dell’autonomia operaia organizzata, da un lato, e accusati di essere «infiltrati» del terrorismo da organi di stampa ispirati dalla Federazione del Pci padovano, dall’altro. A distanza di più di trent’anni, credo che possiamo rivendicare di avere tenuto dritta la barra del timone, opponendoci fattivamente, e con forte rischio personale, al dilagare della violenza, senza rinunciare a cercare di capire, di analizzare, di scoprire cause prossime e remote. Senza mai vacillare, senza concessioni all’isteria politicistica, ma anche senza alcuna indulgenza verso il disegno di tradurre la politica in guerra. Nel corso degli ultimi anni, una serie di circostanze diverse ha gradualmente affievolito il coinvolgimento diretto di Silvio nelle vicende riguardanti la vita politica nazionale. Il suo contributo è diventato più indiretto, ma non per questo meno incisivo. Ricordo soltanto, fra i molti scritti rilevanti in questa prospettiva, quanto il suo bel volume, intitolato significativamente (e anche un po’ provocatoriamente) Patria abbia influito nel dimostrare in maniera inoppugnabile il carattere puramente retorico e storicamente infondato delle rivendicazioni leghiste relative alla «Padania». Più in generale, attraverso una molteplicità di interventi, prevalentemente di natura scientifica, ma anche di taglio giornalistico, Lanaro ha partecipato con vigore alla demolizione della mitologia di una presunta identità storico-culturale del Veneto, mostrando la complessità e l’interna articolazione dei processi storici che hanno condotto all’attuale configurazione regionale. Anche in questo frangente, come già accaduto in occasione delle analisi relative alla Democrazia cristiana, una maggiore sensibilità da parte delle forze politiche della sinistra avrebbe potuto consentire di riversare nella battaglia politica diretta le acquisizioni di un’indagine storica di alto livello. Né si può dire che Silvio abbia assistito passivamente alla diffusione e al consolidamento di quell’autentica neoplasia maligna costituita dal berlusconismo. Anche qui, infatti, pur senza scendere attivamente 222 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 223 Lanaro, l’«impolitico» in un agone politico caratterizzato da un tasso di conflittualità estremamente elevato, egli non ha fatto mancare il suo sostegno alle iniziative assunte in occasione delle campagne elettorali o nelle fasi di mobilitazione civile. Una nota esistenziale, forse anche un po’ malinconica, si impone a questo punto, in vista della conclusione di questa succinta rievocazione biografica. Negli ultimi anni, è accaduto qualcosa che, in un certo modo, ha finito per dare ragione a Silvio. Per quasi mezzo secolo – come ho cercato di illustrare molto schematicamente – Silvio ha interpretato in maniera del tutto personale il ruolo dell’intellettuale «impegnato», muovendosi in una direzione pressoché opposta, rispetto a quella descritta nelle pagine di Antonio Gramsci. Nessuna «organicità», nessun legame effettivo con questo o quel soggetto politico, nessun coinvolgimento personale nelle tante miserie della politica politicante. Un distacco che rasentava il disprezzo. Una scelta lucida e consapevole di giocare il ruolo di chi, attraverso il percorso di una ricerca rigorosa e puntuale, indichi la strada, sulla quale altri avrebbero dovuto procedere con decisione. A lungo questa linea di condotta, declinata talora con un atteggiamento che poteva apparire perfino aristocratico, aveva provocato in molti (e anche in me stesso) la disapprovazione di quanti avrebbero invece voluto trovarsi Silvio a fianco nelle talora estenuanti mediazioni della politica militante. Si può dire ora, dopo cinquant’anni, che in fondo la storia gli ha dato ragione. Gli intellettuali «organici» hanno fallito. Quelli che si sono direttamente impegnati nella politica, non sono riusciti a modificare le macchine infernali dei partiti, e spesso hanno finito per dover rinunciare all’integrità della ricerca culturale. Viceversa, in un paese che assume come modelli di riferimento le gesta dei penosi mentecatti asserragliati nella casa del Grande Fratello, la presenza di figure di maestri autentici, intransigenti e rigorosi, quale è stato ed è tuttora Silvio, può forse essere l’unico efficace antidoto all’ulteriore imbarbarimento della società italiana. Insomma, l’«impolitico» Silvio ha infine avuto ragione. L’augurio vivissimo è che continui ancora a lungo a indicare, con le sue parole e i suoi scritti, la strada che può condurre alla rinascita civile e culturale di questa nostra sfortunata «Patria». 223 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 224 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 225 PENSARE LA NAZIONE Anni sessanta di Cesare De Michelis Anni meravigliosi e terribili, i sessanta del Novecento coincisero con la fuoriuscita dall’adolescenza della mia generazione e al tempo stesso con l’acquisita coscienza che l’industrializzazione del paese avesse raggiunto una piena maturazione, che coincideva con un diffuso benessere, il quale consentiva l’uso e il possesso di mezzi tecnologici necessari, se non addirittura indispensabili, nella vita quotidiana: dall’automobile al frigorifero, alla televisione, per ricordare solo i più importanti. Certo l’adolescenza durante i secondi anni cinquanta era stata emozionante, mentre il mondo si agitava irrequieto inseguendo un continuo rinnovamento. Per me tutto ebbe inizio con la rivolta ungherese del ’56 e la sua insopportabile repressione, cui avevano provveduto i carri armati sovietici entrati a Budapest, ma, se questo era stato l’evento più clamoroso ed evidente, il XX Congresso del Pcus prima, la riscoperta delle avanguardie europee durante, la ricostruzione storica della guerra mondiale e partigiana, l’angoscia leggendo il Diario di Anna Frank, Si fa presto a dire fame di Piero Caleffi e Se questo è un uomo di Primo Levi, mentre sullo schermo si proiettava Notte e nebbia di Alain Resnais, imponevano un generale ripensamento della nostra lettura del mondo pacificata e rassicurante. Della guerra e della profonda cesura che aveva determinato nel corso della storia avevamo una visione e un’interpretazione tranquillizzante, secondo la quale noi – gli italiani – ne eravamo usciti vivi e redenti, tanto che del fascismo resisteva una memoria rudemente falsata che assolveva il popolo, succube e osannante, perché era stato costretto, ma poi si era in fretta ravveduto e riscattato. Ricordo bene sul finire di quel travolgente decennio adolescenziale l’ansia di accumulare letture radicalmente antiscolastiche, il deside225 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 226 Cesare De Michelis rio di sapere e capire, la curiosità di fronte ai testimoni che piano piano si aprivano fiduciosi e raccontavano quasi sempre il contrario della versione edificante dei fatti alla quale ci eravamo intanto rassegnati. Nel ’56 aspettavo il giornale radio con un’impazienza ogni giorno più grande e mi immedesimavo con il martirio dei ragazzi di Budapest, tanto che al mattino con una fascia tricolore sulla manica sinistra del cappotto, in alto a metà dell’omero, sfilavo fiero con i compagni più grandi, indignato con chi invece si rifiutava, ma anche sospettoso rispetto a quegli altri, che, andando oltre i fatti recenti, ne approfittavano per una propaganda nazionalista – Italia e Ungheria avevano lo stesso tricolore – che pretendeva di azzerare quel poco che avevo finalmente appreso sulla guerra e i suoi orrori. Contò molto allora il generoso sostegno che mi offrì, giovane ma al tempo stesso adulto, Matteo Matteotti, figlio della vittima esemplare della furia omicida fascista, ma anche rigorosamente estraneo a qualsiasi subalternità al comunismo, «saragattiano» e quindi «terzaforzista» come meglio non sarebbe stato possibile. Mi convinsi, dunque, di aver trovato un punto di vista ideologico che consentiva di abbracciare tutt’intero il secolo nostro e di interpretarlo con qualche lucida coerenza, distinguendo il bene dal male, e quindi di schierarsi senza incertezze, evitando il ribellismo violento, ma pure «politico», come aveva tempestivamente colto Guido Piovene (1959), dei teddy boys o dei blusons noir, ai quali riservavo una distaccata comprensione. Non condivisi mai fino in fondo l’azionismo terzista, ritenendolo eccessivamente elitario, anche se riconobbi il fascino disperato di Gobetti e dei fratelli Rosselli, troppo eroici per diventare esemplari; mentre il pragmatismo socialdemocratico con la sua tensione popolare e l’iniziativa riformista mi coinvolse senza esitazioni, avvicinandomi anche al marxismo e alla sua tradizione non leninista. Ero cresciuto in una famiglia evangelica, maturando un’istintiva insofferenza nei confronti di ogni dogmatismo dottrinario, cosicché la libertà era diventata un valore altrettanto forte della giustizia. Fu con questo piccolo bagaglio di esperienza e di letture che intrapresi nel 1959 la prima impresa giornalistica, raccogliendo attorno a una rivista – «Il Volto» – un gruppetto di amici che voleva mescolare politica e cultura, sviluppando un impegno intellettuale che accendeva straordinarie passioni per la scrittura e più ancora per il teatro e il cinema, dove il pubblico si allargava e addirittura si concretizzava nella sala piena di gente. 226 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 227 Anni sessanta Poco importava, allora, essere da una parte o dall’altra del palcoscenico o dello schermo, in ogni caso si trattava di prendere parte a un evento collettivo, che, uscendo dagli schemi scolastici, diventava esperienza di crescita, momento di dibattito, occasione di scontro o di confronto. Avevamo suppergiù sedici anni, ma tra il ’59 e il ’60 crescevamo in fretta in un paese che altrettanto in fretta si trasformava sotto i nostri occhi, e, quindi, della «storia», di quella piccola e antieroica che ci toccava, volevamo essere attori e, se possibile, protagonisti. Naturalmente non tutti avevamo lo stesso retroterra familiare e neppure uguali curiosità e passioni, e così anche tra noi, proprio mentre cominciavamo a fare concretamente delle cose – oltre al «Volto», il circolo del cinema Pasinetti, il teatro universitario di Ca’ Foscari, l’Adsm (Associazione democratica studenti medi), il circolo di cultura «Il Ponte» – si manifestarono le divisioni e le contrapposizioni alimentate da un dibattito ideologico aggressivo e feroce, ma anche si consolidò un’amicizia e una solidarietà inossidabile. Intanto, mentre si consumava definitivo il distacco tra socialisti e comunisti e si annunciava l’alleanza di centro-sinistra tra democristiani e socialisti, seppure tra mille distinguo e altrettante polemiche, Matteotti nel ’59 decise di lasciare i socialdemocratici per fondare il Muis (Movimento unitario di iniziativa socialista), che poco dopo confluirà nel Psi. L’anno dopo la carica dirompente dell’«apertura a sinistra» spostò a destra la coalizione di governo, che venne sostenuta dal Msi scatenando furibonde proteste di piazza e parallelamente un’accesa riscoperta del’antifascismo da parte delle generazioni più giovani. In fondo, alle nostre spalle, in quel momento non c’era un retroterra ideale unitario e neppure una tradizione di lotta che non fossero quelle sin allora settoriali del sindacato e, mentre scoprivamo la storia recente, invidiavamo chi aveva partecipato alla rigenerazione della nazione sentendo tradito il proprio sacrificio da un paese soddisfatto del benessere, piuttosto che preoccupato delle divisioni e delle sofferenze che intanto dilagavano. La dichiarazione che facemmo nostra in quell’estate infuocata recitava: «L’antifascismo delle giovani generazioni si sviluppa come volontà di costruzione di nuove strutture e rapporti sociali: esso ha cioè senso politico positivo e non di mera reazione difensiva: noi non abbiamo ragione di difendere le strutture sociali che storicamente hanno determinato e mantengono immanente alla società italiana il pericolo 227 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 228 Cesare De Michelis fascista, che non fa che esprimere la funzione sociale in forme esasperate, ma intendiamo contribuire alla eliminazione delle condizioni strutturali del fenomeno fascista. C’è una nuova forma costruttiva di Resistenza, perché permangono le condizioni storiche del fascismo. E ci deve essere una nuova forma di Resistenza, perché la prima, per obiettive ragioni storiche che la situazione odierna ci impone di studiare, non ha compiutamente realizzato i suoi obiettivi rivoluzionari». Era un manifesto che chiamava alla lotta e così, quando il congresso missino fu convocato a Genova, città medaglia d’oro della Resistenza, la ribellione fu spontanea e decisa, coinvolgendo nei giorni successivi numerose città dove avvennero violenti scontri con le forze dell’ordine che reagirono anche sparando, cosicché a Reggio Emilia, e non solo, ci furono giovani morti ammazzati. Durò pochi giorni, ma fu davvero il battesimo di fuoco per la mia generazione, che si entusiasmò quando, dopo le manifestazioni popolari, il governo Tambroni fu costretto a dimettersi, lasciando campo alle morotee «convergenze parallele» delle forze antifasciste e all’aprirsi di un nuovo ciclo politico. Per me fu la prima notte fuori di casa a organizzare il comizio in Riva dei Sette Martiri, ma anche l’occasione per misurare l’efficacia delle idee nel momento dell’azione e cercare in ogni modo di coniugare passato, presente e futuro in un disegno che fosse riconoscibile e servisse a capire quello che stava accadendo. La nostra formazione era approssimativa e confusa e ogni volta che partecipavamo a un dibattito faticavamo a non perdere il filo, ma i nostri valori erano saldi come forse mai più sarebbero stati. Costruivamo un’identità intellettuale e politica scartando con decisione la tirannia e la violenza, il colonialismo e l’oppressione, e intrecciando, al contrario, le passioni per la libertà e l’avanguardia, il progresso e la giustizia. Miracolosamente riuscivamo a non perderci in quel labirinto di confronti e discussioni, di libri e di film; in fondo era facile battersi contro la censura che si accaniva contro La dolce vita, L’avventura o Rocco e i suoi fratelli, certificando con la propria insofferenza quella qualità che ci entusiasmava, oppure indignarsi per l’aggressione ai romanzi di Pasolini, o ancora pretendere che la questione sessuale non si riducesse a un malinteso pudore, che invece veniva tranquillamente violato nei comportamenti quotidiani. Certo leggevamo e studiavamo ben oltre quello che proponeva la scuola, con una voracità e un’ansia indimenticabili: Gramsci e Brecht, 228 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 229 Anni sessanta Marx, Vittorini, Fortini, Lukács, Ionesco, Joyce, Beckett, Adorno, Benjamin e non so quanti altri, dipanando con fatica un filo rosso che ci sembrava impossibile non riconoscere. Di queste avventure i numeri del «Volto» offrono qualche testimonianza, ma ancor meglio ne danno conto le nostre biblioteche e ancor di più le amicizie con studiosi e letterati ben più grandi, o con compagni di scuola e d’università, alla quale arrivai giusto nel novembre 1961. Certo la partecipazione alla politica studentesca fu importantissima, ma altrettanto lo fu la militanza nel partito, al quale mi iscrissi presto, cercando gli strumenti per incidere nell’organizzazione culturale cittadina, ma poco dopo anche nazionale. All’Università diventai uno studente di Lettere e subito cominciai a lavorare nel cinema e nell’editoria; intanto studiavo, leggevo, scrivevo, sempre considerando ogni iniziativa, ogni intervento, come la parte di un progetto più grande, che aveva al centro la cultura e la società italiana, che volevo conoscere, interpretare, giudicare e trasformare. Il mondo culturale col quale mi confrontavo, aspirando a farne parte, più che quello radicale, che pure mi affascinava, era piuttosto quello del socialismo, per un verso con una scelta autonomista e anticomunista, che mi portava a diffidare dei cosiddetti «carristi», che avevano sostenuto l’intervento sovietico a Budapest, e per l’altro con un’attenzione speciale al marxismo «critico», che si allontanava da qualsiasi ortodossia leninista e si esercitava, non senza spregiudicatezza, nell’analisi sociale, allargando la propria curiosità alle scienze umane che intanto si sviluppavano rigogliose. Nella critica letteraria o cinematografica faticavo a ritrovarmi nella scolastica ortodossia di Guido Aristarco o Carlo Salinari, i quali rivendicavano l’attualità del «realismo» contro le sperimentazioni, preferendo la spregiudicatezza di chi non subordinava l’invenzione all’ideologia ed esitava di fronte a ogni ottimismo volontaristico, intravvedendovi il precipizio della propaganda. Tra questi, scoperto proprio in quei primissimi anni sessanta, anche sulle pagine di «Nuova Generazione» alla quale collaboravo anch’io, c’era l’Alberto Asor Rosa di «Mondo Nuovo», che scombinava tutte le classificazioni correnti proponendone di suggestivamente innovative. Asor Rosa, d’altronde, aveva già pubblicato una dissacrante monografia su Vasco Pratolini (1959) che ne svelava il populismo ideologico e che io avevo letto appassionandomi: era il disincanto a coin229 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 230 Cesare De Michelis volgermi, la severità di un giudizio che prescindeva da qualsiasi solidarietà ideologica, anzi che si faceva merito di conservare intatta una lucidità severa. In fondo – questo sì credo di averlo saputo già allora – mi premeva utilizzare tutti gli argomenti che la cultura moderna aveva offerto, e ogni giorno di più offriva, per andare oltre la scelta di un «fronte» sul quale assestarmi, e riconoscere, invece, le ragioni che frenavano, se non impedivano, lo sviluppo e la risoluzione delle contraddizioni in cui ci agitavamo. Riconoscere gli errori, i limiti, le chiusure della sinistra e della sua cultura sembrava l’unico modo per rinnovarla, e perlustrare i territori maledetti dell’altra cultura, quella infrequentabile della «destra», appariva come il segnale di un’indipendenza che si concretizzava nella lettura di Pound o Ionesco, delle avanguardie storiche fiorentine e futuriste, per non restare intrappolati nell’ortodossia imposta dal Partito, o, invece, le spregiudicate riflessioni di un marxismo eretico che legittimava qualsiasi avventura intellettuale partisse dal riconoscimento dello scontro «di classe», per diffidare di ogni delega a un gruppo dirigente che preferiva al confronto la scomunica e, quindi, la repressione violenta dell’avversario ideologico. Proprio a cavallo degli anni cinquanta e sessanta tra i socialisti più inquieti si poteva incontrare Raniero Panzieri, ormai prossimo a dare vita ai «Quaderni Rossi», o Gianni Bosio, che dirigeva le Edizioni Avanti! e intanto scopriva l’eterna effervescenza degli irregolari o l’inesauribile vitalità della cultura popolare, o Franco Fortini, che traduceva Brecht o Éluard e raccontava il nostro dopoguerra come i Dieci inverni, oppure, più direttamente impegnati nel sindacato e nel partito, Riccardo Lombardi, Vittorio Foa e Lelio Basso. Nella seconda metà degli anni cinquanta e nel decennio successivo fiorirono numerose e vitali le riviste di politica e cultura, per scelta minoritarie e anche settarie, ma certo mille miglia lontane da qualsiasi subordinazione ai poteri costituiti. Si affermavano in questo contesto, da un lato il primato politico della «base» o la centralità della classe operaia, rispetto al dirigismo partitico, e dell’altro l’autonomia dell’impegno culturale e della ricerca artistica che rispondevano a una missione di verità prima di qualsiasi loro funzionalità nella «battaglia delle idee». Per tutti Fortini aveva indicato nell’«astuzia delle colombe» il principio per evitare di trasformarsi in strumenti al servizio del mercato o dei rivoluzionari di professione. 230 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 231 Anni sessanta Fu proprio nei primi anni sessanta che maturò un modo di avvicinarsi alle attività culturali che sfidava l’ortodossia comunista, d’altronde fortemente indebolita dall’ubbidienza alle direttive sovietiche ormai costrette alla drammatica repressione di qualsiasi dissidenza ideologica o politica, e contemporaneamente la cultura del neocapitalismo occidentale sempre più consumista. Ci fu chi si sforzò di radicalizzare lo scontro sociale, nella convinzione che attraverso di esso si rivelasse l’insostenibilità del sistema e del mercato e l’urgenza della rivoluzione, anche ricorrendo a parole d’ordine brutali che collegavano l’odio alla conoscenza - «conosce veramente (solo) chi veramente odia» (Mario Tronti) – e invitavano all’azione e allo scontro, e chi, invece, puntò sul rinnovamento ideale attraverso l’esercizio della critica dell’ideologia, intesa marxianamente come «falsa coscienza», e quindi assimilava ad essa anche i gruppi dirigenti del movimento operaio che rinunciavano a confrontarsi con le reali dinamiche della società industriale e post-industriale. Quella che i rivoluzionari avevano messo in discussione era «la centralità dell’essere umano in un mondo di cui si stava perdendo il controllo», ovvero il primato della secolare tradizione umanistica, e per uscire dalla crisi, che aveva sempre all’orizzonte il «tramonto dell’Occidente», per un verso puntavano ad andare «oltre», incontro a un futuro liberatore, l’avvento del quale sarebbe stato accelerato dalla rivoluzione sociale, o, per l’altro, chi aveva fatto una scelta diversa credeva in un «revisionismo» che riallacciasse le fila di una continuità compromessa, ma non perduta, che aveva bisogno di una rilettura della storia e della società finalmente liberata dalle servitù ideologiche. D’altronde il mondo diviso in due blocchi dalla guerra fredda, che diventava calda in Corea prima e poi in Vietnam, sembrava non avere altra via d’uscita che uno scontro militare drammaticamente distruttivo grazie agli armamenti atomici, e quindi, nei fatti, era obbligato a riscoprire il dialogo e la costruzione degli accordi e dei compromessi, che non potevano essere raggiunti senza un disincantato confronto ideologico. Sul terreno della spregiudicata ricerca di strumenti d’analisi della realtà sociale, culturale ed economica lo scontro destra-sinistra si rivelava ogni giorno più paralizzante, al pari di quell’altro altrettanto ideologico fra moderno e antimoderno, tanto che crescevano tendenze rigorosamente critiche verso l’Occidente e la sua tecnologia invasiva, che mescolavano spregiudicatamente rinnovamento e antimodernismo, a cominciare da Adorno e dalla Scuola di Francoforte. 231 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 232 Cesare De Michelis Nacque in questo contesto, per iniziativa di Massimo Cacciari e mia, nel 1965, «Angelus Novus», trimestrale di estetica e critica, che fu l’ultimo momento – fino alla fine del ’67 – della collaborazione con Alberto Asor Rosa, collaborazione mai priva di tensione e di distinguo, ma sin allora anche complice e solidale, come peraltro, in quei primi anni sessanta, collaborai più marginalmente anche con Toni Negri, nel «Progresso veneto» o nel lavoro editoriale di Marsilio. Poi le posizioni diverse si rivelarono rapidamente alternative e sempre più inconciliabili: quella distinzione tra lavoro politico e impegno culturale che aveva reso possibile e anche fecondo l’incontro di tante strade diverse, ma anche di molti interrogativi comuni, venne rapidamente meno quando discriminante fu l’azione anche violenta e comunque decisa a far saltare qualsiasi confronto e mediazione. Se «Classe operaia» e «Angelus Novus» riuscirono a convivere per qualche anno, la scelta di dar vita a «Contropiano» nel ’68 significava chiudere la discussione per scegliere l’estremismo come «via per arrivare alla verità, passando per l’errore», per «sbarazzarsi del “modello positivo”, di qualsiasi “modello positivo”». Allora, come testimonia ora Asor Rosa ricostruendo la propria esperienza di quegli anni e alludendo a un suo saggio su Fortini, fu possibile «persino qualche vera e propria vigliaccata» nell’animosità «antiprogressista» che si immaginava autenticamente rivoluzionaria, ora – confessa –, dopo aver perduto la battaglia, non resta che «resistere» fino a quando, «forse, la storia riprenderà il suo corso». Chi resta comunque fuori dal loro disegno siamo noi, che allora, quando l’appello alla violenza divenne esplicito e inequivocabile, ci fermammo, scegliendo un percorso diverso e alternativo, e che di fronte alla loro apologia, nonostante lo scacco, proviamo a riaffermare di aver avuto più lucidità e lungimiranza. La storia non è finita e neppure il conflitto, ma il sogno moderno di superarlo una volta per tutte finalmente non c’è più e neppure la catastrofe «inevitabile» c’è stata; ci sono invece tanti problemi irrisolti, tante questioni aperte, che aspettano non la rivoluzione, ma un paziente esercizio del rimedio. 232 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 233 PENSARE LA NAZIONE Convergenze (e divergenze) parallele di Maurizio Reberschak L’ossimoro attribuibile ad Aldo Moro delle «convergenze parallele» si addice bene al percorso storico e culturale condotto da Silvio Lanaro e da chi scrive per oltre un decennio, finché l’ossimoro non cominciò a invertire il sostantivo per le strade diverse prese da ciascuno. Cominciamo dall’inizio. 1966. Dal 1962 sono iscritto alla Facoltà di Lettere e Filosofia a Padova dopo un anno più o meno incerto passato a Giurisprudenza, dove, peraltro, ho avuto la possibilità di accostarmi a materie sconosciute al liceo classico, come Diritto costituzionale, Diritto privato, Economia politica, Storia del diritto romano. Ma mi accorgo che non è quella la strada che fa per me. Passo a Lettere, dove le discipline mi sono più familiari e consone all’esperienza liceale. Cosa voglio fare da grande? Il giornalista. Una mattina a Padova incontro il mio amico Ciccio De Michelis, già compagno di liceo al classico Marco Polo di Venezia, gli racconto la decisione, e mi chiede se avessi pensato di cambiare anche mestiere in futuro. No, dico. Ma il giornalista non l’avrei mai fatto, anche se la possibilità mi sarebbe stata offerta. Frequento subito alcune materie storiche e sostengo i relativi esami: Storia romana, Storia medioevale, Storia moderna, Storia del Risorgimento. E Storia contemporanea? Non c’è. Esiste, come indicato, un insegnamento di Storia del Risorgimento, ma il professore ritaglia la materia soprattutto sulla storia diplomatica, e non mi interessa. La contemporanea arriva a Scienze politiche con Gabriele De Rosa nel 1962, dopo che solo l’anno prima Giovanni Spadolini aveva inaugurato a Firenze alla Facoltà di Scienze politiche Alfieri il primo insegnamento di questa cenerentola universitaria della storia. Devo trovare qualcuno che capisca che voglio proprio fare la tesi su un argomento di storia contemporanea, anche perché dopo il disastro del Vajont nell’ottobre 1963 comincio a pormi l’interrogativo di base del metodo storico alla ricerca non di risposte ma di comprensione: perché? e co233 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 234 Maurizio Reberschak me? Faccio l’esame di Storia moderna con Federico Seneca, che mi dà l’opportunità di portare alcune letture integrative della bibliografia classica nel settore modernistico. Comincio a leggere Arturo Carlo Jemolo, Federico Chabod, Rosario Romeo, nessuno contemporaneista in senso stretto, ma tutti cultori del lungo periodo nella storia e per questo attenti anche alla contemporanea. So che Seneca ha già accettato alcune rare tesi di argomenti contemporaneistici, soprattutto ottocenteschi. Un segno di attenzione, non solo per l’assenza allora della storia contemporanea a Padova, ma anche per una convinzione di metodologia della «scuola» storica padovana, cioè la considerazione della storia nel lungo periodo, che era un radicamento di vecchia data indipendente dall’onda di moda francese della «longue durée» delle «Annales». Dopo l’iterazione dell’esame di Storia moderna, in cui posso fare altre letture anche di metodologia storica (Marc Bloch, Edward G. Carr, Henry I. Marrou), decido di chiedere a Seneca una tesi su cattolici e socialisti a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento. Dopo vari approcci e colloqui Seneca accetta. Mi dice però di stare a contatto con chi ha competenza, De Rosa, Angelo Gambasin, Silvio Tramontin, ma di sentirmi anche con un laureando che gli ha chiesto la tesi sui temi di ruralismo e industrializzazione, tradizionalismo liberale e populismo cattolico, moderatismo e intransigentismo negli ultimi decenni dell’Ottocento, con particolare riferimento a un’area privilegiata di queste tematiche, il Vicentino: è Lanaro. Ma prima di mettermi in contatto, preferisco avere chiaro l’itinerario di ricerca che devo fare, l’ambito delle fonti da consultare, l’accessibilità agli archivi. Proprio all’inizio degli anni sessanta era stata aperta a Roma la nuova sede all’Eur dell’Archivio centrale dello Stato (Acs), al quale però potevano accedere solo alcuni illustri privilegiati, come, tra i primi, Renzo De Felice, Paolo Spriano, Fausto Fonzi; mi è sempre rimasta impressa una pagina di Spriano, in cui si racconta la passione e l’emozione capaci di suscitare un documento d’archivio: «Le buste talvolta emettevano un rumore meno discreto, meno di routine del solito. Mi davano allora la stessa ebbrezza che prova il cercatore d’oro dinanzi a una pepita lucente. La pepita stava sempre un po’ acquattata, in mezzo a fascicoli sbrindellati»1. Sarei venuto in contatto con l’Acs solo indirettamente nel 1967, quando Enrico Opocher, allora presidente dell’Istituto per la storia della Resistenza nelle tre Venezie (questa la sua denominazione allora), mi avrebbe contattato attraverso un suo stu1 P. Spriano, Le passioni di un decennio (1946-1956), Garzanti, Milano 1986, p. 132. 234 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 235 Convergenze (e divergenze) parallele dente, mio amico, dopo aver saputo che mi sarei laureato di lì a non molto con una tesi di argomento contemporaneistico: la proposta è di collaborare alla prima ricerca che sta avviando l’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (Insmli) – allora presieduto da Ferruccio Parri –, con la collaborazione degli istituti regionali associati, sull’«Italia dei quarantacinque giorni. 25 luglio-8 settembre 1943». Nelle riunioni che si tengono a Milano, dove ha sede l’Insmli, trovo tra i collaboratori della ricerca due archivisti dell’Acs, Nicola Gallerano e Elvira Gencarelli, che cominciano a fornire ai ricercatori regionali copie di documenti che erano stati prodotti nel periodo interessato dalla ricerca dal ministero dell’Interno e dai suoi organi periferici, le prefetture e le questure. Gallerano in seguito mi avrebbe accompagnato per mano nelle ricerche che successivamente avrei fatto nell’Acs su varie tematiche. Ma a Milano vengo in contatto anche con il coordinatore della ricerca, Gigi Ganapini, che collabora con il direttore dell’Insmli, Massimo Legnani, e che ha svolto una tesi di laurea sul «nazionalismo cattolico»; a Ganapini devo la riconoscenza di lunghe discussioni, a volte vivacissime, nonché suggerimenti sempre precisi per la ricerca. Lì quindi trovo un bel punto di riferimento. Nei seminari e nei convegni di Milano poi vengo a contatto anche con alcuni storici tra i migliori della ormai finalmente avviata storia contemporanea in Italia, Leo Valiani, Ernesto Ragionieri, Pietro Scoppola. E poi… e poi c’è Parri, per me mitica figura della Resistenza e del dopoguerra italiano, che vengo a conoscere personalmente: un mito che per me si incarna. Anzi, è Parri nella sua incredibile versione di umanità, che mi si avvicina la prima volta, chiede informazioni su di me, si interessa alle mie ricerche. È ormai settantasettenne. L’inverno è già alle soglie. Stiamo per uscire dalla sede originaria dell’Insmli nel Palazzo Reale in piazza Duomo. Gli porgono il soprabito per aiutarlo a infilarselo. Lui rifiuta cortesemente, prende il soprabito e se lo infila, ringraziando con voce riconoscente ma ferma: «Grazie, ma quando non sarò più in grado di mettermi il soprabito da solo, allora vorrà dire che sarò vecchio». E usciamo insieme con quella bella tempra di «giovanotto». Ma torniamo all’inizio dell’estate ’66. Una bella giornata di sole a Padova. Sono in compagnia di un amico anch’egli universitario, al quale avevo parlato della mia tesi. Lui conosce Lanaro. In Riviera dei Ponti romani incontriamo un tizio: «Questo è Lanaro – mi fa –, non volevi conoscerlo?». E ci presenta. Rapido scambio di informazioni. Di me gli ha parlato Seneca, il professore comune a entrambi. Comin235 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 236 Maurizio Reberschak cia così una frequentazione, che ha come sede principale l’Istituto di storia medioevale e moderna, che si è trasferito da non molto dalle quattro stanze dell’ultimo piano dell’ala del Bo costruita negli anni trenta – che fungevano da deposito librario e sala di lettura della piccola biblioteca, da aula di seminari, da studi dei professori –, al secondo piano del palazzo in cui ha sede Magistero in piazza Capitaniato, adiacente al Liviano, dove si trova la Facoltà di Lettere e Filosofia, costruito da Gio Ponti nella seconda metà degli anni trenta, il cui ingresso è arricchito dagli affreschi di Massimo Campigli e da una splendida scultura marmorea di Tito Livio pensante, opera di Arturo Martini. La nuova collocazione dell’Istituto è ben più ampia e offre spazi di incontri prefissati o occasionali anche nello sviluppo del corridoio. È lì che ci si comincia a incontrare con Lanaro e avere scambi sulle ricerche in corso. Certo Lanaro culturalmente è più scafato di me. Nel ’67 collabora già con una rivista di impegno culturale e politico, «Ideologie», per la quale è il responsabile della redazione padovana; la rivista, che porta il sottotitolo «Quaderni di storia contemporanea», ha la redazione centrale a Roma, dove di fatto è diretta da Ferruccio RossiLandi e Mario Sabbatini, e annovera tra i principali collaboratori Augusto Illuminati, Romano Luperini, Antonio Melis, Giuseppe Di Siena. Sabbatini è autore di una delle prime ricerche sul movimento cattolico nel Veneto, Profilo politico dei clericali veneti (1866-1913), che nel 1962 gli pubblica la nuova piccola casa editrice Marsilio, insediatasi l’anno prima a Padova per iniziativa di un gruppetto di intellettuali, tra cui Toni Negri, Giorgio Tinazzi, Giulio Felisari, Paolo Ceccarelli, e che di lì a qualche anno sarebbe stata presa in mano dai fratelli Gianni e Cesare De Michelis e trasferita a Venezia. Quando mi sposai in data coincidente con l’inizio del maggio francese, Ciccio mi regalò un libro innovativo pubblicato nel 1967 dalla Marsilio, I vinti di Caporetto di Mario Isnenghi, altro compagno di venture storiografiche. A proposito di «Ideologie», il termine «clericali», e non «cattolici», usato da Sabbatini qualifica nettamente l’interpretazione ideologica della storia del movimento cattolico italiano, in linea con l’affermazione teorica di ideologia che Rossi-Landi avrebbe espressamente dichiarata nel terzo numero della rivista, «ideologia come progettazione sociale», di netta impronta marxiana ma anche di evidente richiamo a Gramsci, di cui da qualche tempo io sto rileggendo le categorie storiche dei Quaderni del carcere pubblicati da Einaudi nelle sillogi tematiche e censurate imposte da Togliatti nel 1948 (per l’edizione critica dei Quaderni curata da Valentino Gerratana si sarebbe dovuto atten236 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 237 Convergenze (e divergenze) parallele dere più di cinque lustri). Lanaro pubblica il primo saggio storico proprio in «Ideologie»2 e mi fa dono dell’estratto. Lanaro insegna come supplente nelle scuole. Per qualche tempo trova come collega Ferdinando Camon, che gli fa leggere i dattiloscritti delle sue prime prove letterarie di narrativa. Sono anni in cui le scuole hanno fame di supplenti. Soprattutto dopo la nascita della scuola media unica dell’obbligo, i presidi sono sguarniti di personale insegnante e sono alla caccia di supplenti attinti da laureandi ma anche da semplici studenti universitari. Basta presentare domanda ai presidi e prima o poi si viene chiamati per una supplenza temporanea o annuale. Ci si può vivere e mantenersi negli studi. Ci laureiamo l’uno a distanza di poco tempo dall’altro, prima io – è giusto perché sono di qualche mese più vecchio –, poi lui, che fa dire a Seneca che avrebbe potuto finire prima; ma si sa, il perfezionismo è sempre stato una sua costante. Dunque io mi laureo nel febbraio ’68. Siamo in pieno clima di contestazione studentesca, anche se il mitico maggio francese deve aspettare ancora un paio di mesi prima di scoppiare. Ma ci sono già le occupazioni studentesche nelle università. A Roma in marzo ci saranno gli scontri studenti-polizia di Valle Giulia che faranno gridare a Pier Paolo Pasolini contro gli studenti «figli di papà»: «Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte/ coi poliziotti,/ io simpatizzavo coi poliziotti!/ Perché i poliziotti sono figli di poveri./ Vengono da periferie, contadine o urbane che siano». Nello stesso mese la scintilla sarebbe scoppiata anche a Padova proprio con l’occupazione della Facoltà di Magistero, facendo inviperire il custode Guerrino che ci vedeva solo l’obiettivo dei congiungimenti carnali notturni tra gli occupanti. E poi in Vietnam i vietcong hanno scatenato l’offensiva del Têt arrivando fino a Saigon, che segna il punto di svolta nella massacrante guerra. A Praga sarebbe fiorita la «primavera». In aprile sarebbe stato assassinato Martin Luther King lasciando il miraggio di «I have a dream». Ma ancor prima erano state accese faville in America, dove da Berkeley erano partiti da qualche tempo la lotta pacifista e il movimento per i diritti civili. La Cina era stata inondata dalla «rivoluzione culturale». Il Che aveva intrapreso la via della rivoluzione diffusa («crear dos, tres, muchos Vietnam»), era stato ammazzato in Bolivia, e il suo mito si era reso permanente. Il tutto col sottofondo musicale di Woodstock, e di Blowin’ in the wind, We shall overcome, All you need is love. 2 S. Lanaro, Nazionalismo e ideologia del blocco corporativo-protezionista in Italia, in «Ideologie», 1967, 2, pp. 36-92. 237 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 238 Maurizio Reberschak Dopo la laurea io entro subito nel sistema universitario. Scelta. Ci sono varie opportunità. Mirko Petternella mi chiede se mi interessasse entrare in Rai: sarebbe potuta essere la realizzazione del mio sogno giovanile di fare il giornalista. Bepi Mazzariol mi offre la possibilità di lavorare nella biblioteca della Fondazione Querini Stampalia a Venezia: ho imparato da tempo ad amare i libri e a custodirli con amore. Tutte ipotesi di lavoro buono e sicuro. Accetto la proposta temporanea di Seneca: c’è un incarico transitorio di assistente supplente. Sono gettato subito nella mischia con la responsabilità di un seminario di argomento contemporaneistico nell’ambito dell’insegnamento di Storia moderna: arrivano gli studenti della contestazione a mettere in crisi chi fino a qualche settimana prima aveva giocato in casa con loro e ora si trova in trasferta dall’altra parte. Lanaro attende un po’ di più, dopo la laurea, e deve pensarci perché già «tiene famiglia». Giovanna, donna sapiente dallo spirito critico, gli è misura di riflessione, è l’unica che riesca a farlo mettere in discussione. Io ci ho pensato e ripensato prima di accettare e di inserirmi nell’ambiente accademico, che non mi era certo simpatico. Soprattutto per i vincoli di subalternità che avevo visti imposti dai professori ai «sottoposti» (il fantozzismo, ancora da venire, avrebbe segnato una misura interpretativa anche per questi rapporti). Probabilmente ci avrà pensato su anche Lanaro, anche se sono sicuro che lui fin da piccolo voleva fare il professore universitario. Mi convince, anzi credo che convinca entrambi, la signorilità «umana» e il rispetto della persona di Seneca, che esercita il «culto» della libertà, appreso – dice – dal suo maestro, Roberto Cessi, grande conoscitore di storia della Repubblica di Venezia, che, pur nell’insofferenza spesso esercitata nei confronti di persone a lui indigeste, tuttavia rispettava la libertà di ciascuno. Entrambi, in tutte le nostre scelte, abbiamo potuto godere di un bene raro e privilegiato nel mondo accademico, la libertà. Sono convinto che diversamente nessuno dei due sarebbe rimasto in quel tipo di università allora dominante. E nessuno dei due si è pentito del mestiere che ha fatto. Dopo un po’ di tempo arriva per entrambi un posto di assistente incaricato, nella prospettiva e nell’attesa dei rispettivi bandi di concorso. Intanto cominciamo a fare esami insieme con gli altri assistenti e «esercitatori» – così vengono definiti quelli che, avendo un lavoro per lo più nelle scuole, nelle biblioteche, negli archivi, collaborano nelle commissioni d’esami della parte generale di storia moderna (= dalla scoperta dell’America ai nostri giorni; studio: un «buon» manuale di 238 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 239 Convergenze (e divergenze) parallele liceo) –. Prima con numeri ragionevoli, poi, dopo le liberalizzazioni degli accessi all’università e dei piani di studio, nonché con le frequenze degli appelli d’esame pressoché ogni mese, le iscrizioni degli studenti all’esame diventano mareggiate: dai 250 ai 350, e anche più, esami per appello. Ci sono gli studenti di Lettere e Filosofia, e di Magistero, facoltà questa in cui sorge anche il corso di laurea in Psicologia, un botto di quasi 10 000 iscritti. Si sta a fare esami almeno per un’intera settimana dal giorno in cui è fissato l’appello. Abbruttente. Non c’è coppia fissa di commissione per la parte generale dell’esame, le coppie sono variabili secondo le circostanze. Lanaro e io non siamo la coppia più temuta dagli studenti, che invece è quella formata da Achille Olivieri e me: gli studenti fanno le «scarampetole» per evitarci allarmati dall’«attenti a quei due», ma la lista è lista, e tocca a chi tocca. In seguito i numeri sarebbero andati progressivamente un po’ diminuendo, anche se non di molto, un po’ perché la liberalizzazione dei piani di studio diversifica anche le scelte degli esami e un po’ anche perché sarebbero aumentati gli insegnamenti su cui spartirli. Agli esaminatori della «vecchia guardia» che a vario titolo coprono il posto di commissari – nei primi tempi Angelo Ventura già avanti nella carriera, poi Paolo Preto e Achille Olivieri assistenti di ruolo, Sandra Secchi archivista di ruolo a Padova, Gabriella Stefani insegnante di ruolo nelle scuole superiori che aveva svolto a Padova la prima tesi di laurea sulla Resistenza – poco alla volta se ne affiancano altri – Franco Fasulo di ruolo nelle scuole superiori, Stefania Malavasi e Federica Ambrosini, entrambe borsiste –; infine da Milano, dove si era laureato con Berengo, attraverso Pedavena dove è tornato ad abitare, arriva Gigi Corazzol dall’aria frizzante di montanaro sornione. C’è anche un volto «umano» di fare esami, come quello sperimentato a Bressanone. Nella cittadina altoatesina si svolgono ogni anno a rotazione tra alcune facoltà universitarie corsi estivi «integrativi» – di fatto di «recupero» – per studenti iscritti all’Università di Padova, in base a un accordo con la Provincia autonoma di Bolzano che contribuisce mettendo a disposizione strutture e anche finanziamenti. In pratica si tratta di un appello d’esami supplementare per gli studenti, corredato da una breve serie di lezioni concentrate in due settimane. Si è nel 1972. Seneca chiede a Silvio e a me di svolgere lezioni di parte generale a Bressanone, dove lui avrebbe tenuto il corso breve di Storia moderna. A Lanaro vengono affidate le lezioni per gli studenti «ordinari», a me quelle per studenti lavoratori sudtirolesi iscritti nelle facoltà umanistiche. Il primo dei due svolge un compito «normale», il 239 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 240 Maurizio Reberschak secondo uno con qualche complicazione limitato anche dal condizionamento degli orari, perché le lezioni devono tenersi nel «tardo» pomeriggio, così indicato nel linguaggio delle abitudini sudtirolesi, che in realtà vuol dire di consuetudine semplicemente pomeriggio. Lanaro viene a Bressanone con la famiglia, alloggiando in una piccola pensione ai piedi del monte Plose, una località molto bella. Io ci vado da solo nell’albergo che molti anni dopo sarebbe diventato quello delle ferie di Joseph Ratzinger e del fratello Georg, il Grüner Baum (Albero Verde). Allora però è già un albergo di notevoli dimensioni ma di levatura contenuta e ancora modesta. Ci sono due sale da pranzo, una per i «signori», l’altra per i «locali», dove si mangia sul tavolo nudo al prezzo di lire 800 pasto completo dalle porzioni mastodontiche, che non ce la fai mai a finire. Naturalmente io frequento questa. Con Silvio e famiglia ci vediamo spesso, all’ombra di qualche bottiglia di Blauburgunder. La consuetudine dell’«ombra» ce la portiamo dietro da Padova, dove alla fine della giornata di lavoro a Magistero non manchiamo mai di passare all’osteria Ai Trani per farci il rosso o il bianco. Una consuetudine che a Brixen vedo molto condivisa dagli studenti lavoratori che frequentano le mie lezioni, che fin dal primo giorno mi invitano alla fine delle lezioni a passare con loro qualche momento in allegria allietati dal Sylvaner di Neustift, che allora producono solo i frati agostiniani di quell’abbazia da un vitigno originale disteso su un’unica collina adiacente: veramente di-vino. Uno degli studenti, piuttosto avanti nell’età, arriva sempre con una valigetta, nella quale si scopre che tiene non libri ma una batteria di fisarmoniche a bocca: è un musicista provetto, che si è esibito anche in trasmissioni televisive, e che alterna ogni sorso di buon vino con una suonata. Non per gli influssi del vino, ma perché l’esame risulta la conclusione di un lavoro didattico, Silvio e io riusciamo a concludere bene questa esperienza. Nessuno di noi due come tale a Padova viene contestato dagli studenti, ma a volte messo in discussione in quanto considerato «parte integrante del sistema». Tuttavia c’è un rapporto di dialogo sempre disponibile anche con i più duri di «Potere operaio» prima e di «Autonomia» poi. Capita solo un fatto increscioso, almeno per noi. In un appello nella lista degli studenti che devono sostenere l’esame compare il nome di Emilio Vesce. Quel giorno in una delle commissioni di parte generale facciamo coppia Silvio e io, e a Vesce nella lista tocca proprio venire da noi. La cosa non ci disturba né ci scompone. Tra l’altro conosciamo Vesce per discussioni diciamo «vivaci» e talvolta tese, così come conosciamo la maggior parte dei principali esponenti dell’«operaismo» 240 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 241 Convergenze (e divergenze) parallele padovano, da Toni Negri a Luciano Ferrari Bravo, da Guido Bianchini a Lisi Del Re, tutti docenti a vario titolo a Scienze politiche. Un collega ben più anziano di noi, che per questo ormai è esentato dal tirocinio degli esami della parte generale di storia moderna, ci fa presente di chiamarlo quando tocca a Vesce. Pensiamo che voglia essere presente, forse perché i compagni autonomi che accompagnano Vesce non vengano colti dal ghiribizzo di intimorirci o forse perché non si fida di noi; ma pensiamo che voglia stare di fianco come membro silente di commissione e lasci condurre a noi l’esame. Lo chiamiamo nel momento in cui deve venire Vesce. Eh, no. Si mette in una delle sedie degli esaminatori e fa lui l’esame, mentre il ruolo di marginali osservatori silenti è riservato di fatto a noi due imberbi. La cosa non ci garba affatto. Naturalmente l’esame di Vesce va male, a dire il vero non per l’atteggiamento del collega che svolge un esame normale, anche se decide da solo e non ci consulta sull’esito come sarebbe prassi normale, ma per l’impreparazione dell’esaminato. Ce ne saremmo accorti tranquillamente anche noi e avremmo optato di conseguenza. Ne nasce un tafferuglio prevedibile, prima sostenuto dal solo Vesce, poi rinforzato dai compagni di supporto. Potrebbe svilupparsi qualcosa di peggio. Silvio e io interveniamo, non per difendere alcuno (che non ha bisogno di difesa; e poi, chi?), ma solo per dire a Vesce, che indirettamente aveva insinuato una nostra complicità («non me la prendo con i suoi due colleghi, che non hanno potuto farmi l’esame», dice, «fanno il loro dovere»), che in realtà le domande d’esame erano quelle che normalmente si fanno, ma Vesce – rivolto al collega – con voce sopra tono punta allo scontro: «ce l’ho con lei che di proposito ha fatto in questo modo l’esame» (leggi: con l’intenzione di non farmelo passare); chiede retoricamente perché gli sia stato riservato un trattamento «privilegiato» con un esaminatore diverso dalla commissione con cui hanno sostenuto l’esame tutti gli altri studenti, concludendo: «lei si approfitta delle sue funzioni di pubblico ufficiale che si trova dall’altra parte del tavolo, se non fosse così solleverei il tavolo e glielo scaglierei addosso». Naturalmente è necessaria una ragionevole pausa per il ritorno della tranquillità, prima che Silvio e io possiamo riprendere gli esami proseguendo con la lista. Per alcuni anni a Padova, in università particolarmente, non è un bel vivere quotidiano tra occupazioni di sedi universitarie, manifestazioni quasi sempre violente, cariche di polizia nelle piazze – ovviamente senza distinzione di chi sta sotto i manganelli –, spari di fumogeni. La mattina sai come esci di casa, ma non puoi immaginare come 241 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 242 Maurizio Reberschak vi saresti tornato. Eppure… eppure, nonostante tutto, è fermo l’obiettivo di ricostruzione sociale: «eguaglianza, libertà e pace», Norberto Bobbio insegna parafrasando il trinomio della Rivoluzione francese «liberté, egualité, fraternité». E allora «occorre alzare la testa dalle schermaglie quotidiane e guardare più in alto e più lontano»3. Magistero e Lettere sarebbero divenute, dopo la formazione di Autonomia operaia, uno dei bersagli su cui scagliare pestaggi o anche scaricare pistole. L’Università diventa il target privilegiato. Solo per fare alcuni esempi: Oddone Longo (Lettere) e Guido Petter (Psicologia) sono sprangati (il primo tra l’altro colpito con particolare cattiveria in una delle due gambe già azzoppata, il secondo con violenta ferocia alla testa); Ezio Riondato (Filosofia) e Angelo Ventura (Lettere) vengono sparati (l’uno gambizzato, l’altro piedizzato). Comincia a costruirsi il cosiddetto «teorema Calogero» della continuità tra organizzazioni estremistiche e lotta armata – alias definito anche «terrorismo rosso» dallo stesso magistrato –, avviato silenziosamente fin dal 1977 ed elaborato nelle indagini dal sostituto procuratore Pietro Calogero appunto; il 7 aprile 1979 vengono emessi 22 mandati di cattura. Non va dimenticato poi che Padova nel 1974 è luogo della prima esecuzione politica da parte delle Brigate rosse di due militanti fascisti nella sede del Movimento sociale italiano. «Anni di piombo», sì. «Strategia della tensione», sì. «Terrorismo rosso», sì. Ma senza rimozione della memoria dello stragismo neofascista-nero, da piazza Fontana (12 dicembre 1969, 17 morti) alla stazione ferroviaria di Bologna (2 agosto 1980, 85 morti). A Lanaro e a me viene affidata da Seneca, oltre al coordinamento di seminari, anche l’opportunità di assegnare e seguire tesi di laurea nell’ambito delle nostre competenze contemporaneistiche, facendole poi figurare in commissione all’inizio come presentate dal solo professore ufficiale della materia, perché diversamente non si sarebbe potuto fare, e in seguito anche dall’assistente che le ha seguite. Il primo che laureo io è Piero Brunello, che per pagarsi gli studi ha fatto ogni tipo di lavoro precario e saltuario, benché onesto. Il primo di Silvio è Emilio Franzina. Franzina allora è come ora: una fiumana di parole che rimbombano nel corridoio dell’Istituto, una sventagliata di lunghi soliloqui con un interlocutore di fronte, che la maggior parte delle volte è Silvio al quale certo non manca la parola, ma in netta minoranza di fronte alla faconda e faceta logorrea del suo laureando; comunque ’milio fa os3 N. Bobbio, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli, Roma 1994, p. 90. 242 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 243 Convergenze (e divergenze) parallele servazioni che scremate dall’irruenza sono sempre intelligenti, come quando, nel fatidico corridoio dell’Istituto, non finisce più di parlare dei diari di Sidney Sonnino che si stanno pubblicando nel 1972. La storiografia sulla quale ci siamo esercitati, anche per le nostre prime ricerche di tesi, comincia a lasciarci insoddisfatti, ne avvertiamo sì i pregi, ma anche i limiti. Soprattutto non riusciamo ad accettare l’unidirezionalità dei principali storici contemporaneisti, dai quali abbiamo imparato e dei quali però individuiamo la demarcazione netta della linea d’orizzonte. La storia contemporanea in Italia tra gli anni cinquanta e sessanta aveva preso piede sulla germinazione della storia dei movimenti e dei partiti politici. La spinta era stata data da una precisa ragione storica metodologicamente fondata: conoscere la propria storia per comprendere le origini e lo sviluppo del presente. Un’impronta data da Marc Bloch («comprendre le présent par le passé», «comprendre le passé par le présent», erano gli aforismi perni centrali delle sue riflessioni). Quindi gli studi erano stati orientati per esempio da Gabriele De Rosa sulle origini ideologicamente anche lontane della Democrazia cristiana, guardando i precedenti del movimento cattolico e del Partito popolare, da Giorgio Candeloro sull’organizzazione del «partito» cattolico di fatto esistente tra Otto-Novecento pur se non nella forma-partito indicata da Max Weber, da Gaetano Arfè sulla nascita e lo sviluppo del movimento e Partito socialista (ma ancor prima e meglio lo aveva fatto Leo Valiani), da Paolo Spriano sulle origini e lo sviluppo del Partito comunista, da Renzo De Felice sul fascismo come «movimento» e come «istituzione». Le stesse storie del fascismo – a parte il taglio prevalentemente biografico dato da De Felice al «suo» Mussolini –, come quelle di Luigi Salvatorelli e Giovanni Mira o di Enzo Santarelli seguivano la china della storia politica interna: soltanto Alberto Aquarone con il suo L’organizzazione dello Stato totalitario nel 1965 aveva saputo cogliere il quadro delle istituzioni dello Stato fascista. Qualcuno di questi storici si era accostato per la prima volta a documenti inediti, talvolta, come nel caso di De Felice, monopolizzati per se stesso mediante un connubio istituzionale, certamente non per le sue «ascendenze» nel Partito comunista prima e nel Partito radicale poi, ma grazie alle interferenze prima del Partito socialista, quindi del Partito socialdemocratico, last but not least del Partito repubblicano, nei quali saltellò secondo i periodi in cui lui girava come banderuola, per finire alla fine solo «afascista», come lui piacque definire la «sua» storia: nessuno, al di fuori di lui, avrebbe potuto consultare i documenti dell’Acs finché il suo colossale «monumento al du243 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 244 Maurizio Reberschak ce» – come ebbe a definirlo Denis Mack Smith – non avesse preso una piega definitiva; la discrezionalità di concedere l’autorizzazione a consultare documenti «riservati» da parte del ministero dell’Interno secondo la legge archivistica del 1963 giocava a suo favore. In una delle mie tante successive frequentazioni di studio nell’Acs ho visto l’ossequio mellifluo nei suoi confronti di alcuni archivisti, che sussiegosi andavano a prendere loro direttamente e fuori orario nei depositi le buste da lui richieste: il «monumento» che lui stava costruendo al duce, altri lo avrebbero fatto a lui. Si tratta in ogni caso di storie tutte «interne» ai movimenti e partiti politici, che guardano soprattutto alle organizzazioni, alle dirigenze, ai congressi. Manca una visione più ampia di rapporto con la società, ciò che in qualche modo avevano cercato di avviare alcuni storici del socialismo, come Gastone Manacorda e Ernesto Ragionieri. Nessuno però ha mai raggiunto le vette della storia delle istituzioni e della società italiana, come aveva saputo fare Federico Chabod, nonostante alcuni apprezzabili tentativi di visioni di lungo periodo, come quelli di Denis Mack Smith, Giorgio Candeloro, Giampiero Carocci, Ernesto Ragionieri. Senza pretesa di colmare lacune, preme l’insoddisfazione per questi tagli di ricerca. Così a Milano (Gigi Ganapini), a Firenze (Mario G. Rossi), a Padova si cerca di aprire qualche spiraglio di nuova via da percorrere. Ganapini insiste sul «nazionalismo cattolico» come elemento intrinseco delle scelte di politica interna e internazionale dello Stato liberale; Rossi si avventura sulle relazioni tra le componenti del capitalismo finanziario, che negli ambienti cattolici, sia moderati che intransigenti, trovava un supporto fondamentale. I «padovani», che si muovono come gruppo di ricerca e di lavoro pur con tutte le caratteristiche originali di ciascuno, puntano all’individuazione delle relazioni fondamentali emergenti di fatto tra istituzioni statali e società: Stato liberale, ruralismo sociale, capitalismo imprenditoriale, movimento cattolico, partito cattolico (pardon, «di» cattolici dicevano i democristiani) sono i poli principali di riferimento. Nasce così l’idea del convegno Movimento cattolico e sviluppo capitalistico nel Veneto, che si svolge a Padova nel giugno 1973 nella prestigiosa sala della Loggia della Gran Guardia, una sede appositamente scelta oltre le mura universitarie, col proposito di portare la storia «fuori» della chiusa casta accademica. Uso pubblico della storia? No, un obiettivo di ragione civile e sociale, oltre che culturale, della storia: storia come cultura diffusa, come metodo di comprensione del presente, come 244 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 245 Convergenze (e divergenze) parallele retroterra indispensabile per ogni bagaglio di conoscenza. Relatori al convegno sono Silvio Lanaro, Mario Isnenghi, Maurizio Reberschak, Emilio Franzina, Livio Vanzetto4. A presiedere viene chiamato uno storico di razza, Marino Berengo, che da qualche anno insegna nell’Università di Milano, dopo che gli era stata negata la chiamata a Padova dalla maggioranza tradizionalista e cattolica della Facoltà di Lettere, perché «troppo fazioso», come avrebbe confessato molti anni più tardi uno dei suoi maggiori osteggiatori. Berengo ha già fatto studi magistrali sulla società veneta di fine Settecento e sull’agricoltura veneta nel primo Ottocento, quindi il suo taglio è congeniale. Ma… ma è molto amico di Angelo Ventura, che nei giorni del convegno lo ospita nella sua casa. Berengo e Ventura avevano allacciato un sodalizio molto stretto in Archivio di Stato a Venezia tra gli anni cinquanta e sessanta: Berengo svolgeva la professione di archivista, Ventura faceva ricerche. Ebbene, quale lo stupore di Berengo, quando viene a Padova per il convegno e non trova tra i promotori e i relatori il suo amico Ventura. Si cerca di spiegargli che l’iniziativa, come del resto già comunicatogli, è di un gruppo di giovani storici uniti da tematiche e linee di ricerca affini. Nessuno sgarro dunque. Allora presiede, inizialmente forse un po’ a malincuore, ma via via sempre più partecipe. A un certo punto della discussione interviene con una battuta che ad alcuni può sembrare astrusa, ma che in realtà nella espressione riduttiva racchiude anni di ricerche. «Che cos’è il Veneto?», si chiede dunque Berengo, e si risponde: «il Veneto è il Veneto», che non è un aforisma o una tautologia ma è la sintesi forse eccessiva, e per questo sfuggevole a molti, di anni di studi e ricerche, in cui ha individuato la complessità della società veneta nel passaggio tra età moderna e età contemporanea. «Il Veneto è il Veneto». Se ne è bene accorto Lanaro nel prosieguo delle ricerche iniziate con la tesi di laurea, che lo portano nel 1976 alla pubblicazione del suo primo libro Società e ideologie nel Veneto rurale (1866-1898)5. «È lecito parlare di “Veneto”, nel titolo di un lavoro che esamina fenomeni circoscritti all’area vicentina? O si promette al lettore un vino che la botte non contiene? […] Vicenza e il suo territorio amministrativo – nella seconda metà dell’Ottocento – possono essere assunti come esemplari di tutta la struttura del Veneto rurale». Lo sguardo spazia dall’arretratezza agricola allo sviluppo industriale, dal neoliberismo al tradizionalismo sociale, dal trasformismo moderato al po4 Movimento cattolico e sviluppo capitalistico. Atti del Convegno su «Movimento cattolico e sviluppo capitalistico nel Veneto», Marsilio, Padova 1974. 5 Edizioni di storia e letteratura, Roma 1976. 245 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 246 Maurizio Reberschak pulismo clericale. Sin da questo esordio in volume Lanaro, per accentuare indicazioni e interpretazioni, usa un linguaggio carico di ricercatezze, a volte quasi leziose, in ogni caso pavoneggianti. Si bea di alcune sue espressioni, lo sa, e se ne compiace. Una ricerca del lessico e della parola talora pure esasperata, ma anche della sintassi e della frase, a volte volutamente roboanti o forzate per caricarle di effetto, oppure forbite e vezzose per intingerle di gusto, siano pur esse barocche (accostabili al barocco bello, quello di Noto per intendersi) o rococò (delicate come le porcellane di Sèvres). Ma lo sa, tanto che ricorda nella prefazione la difficoltà a «contenere esuberanze di linguaggio». Il libro è dedicato in fronte alla moglie Giovanna. Me ne regala una copia con una dedica, che ho sempre riletto con piacere e tuttora tengo in grande considerazione di amicizia: «A Maurizio, con affetto ormai abbastanza antico». Gli anni settanta mettono in crisi i luoghi stantii e le melasse di ogni forma della cultura, compresa quella storica. Sono questi per esempio gli anni in cui si elabora il «modello veneto», alla ricerca di una interpretazione storica e di un progetto sociale. Sindacati, partiti, centri studi si arrovellano. Storici, economisti, intellettuali, politici, sindacalisti fanno i conti con la misura interpretativa del «modello». Non è un procedimento schematico e di solo taglio ideologico, come molti accusano, ma un obiettivo di interpretazione complessa, che sappia misurarsi con livelli interdisciplinari e una visione articolata della cultura sociale. L’accusa di «ideologismo» a questa impostazione è la più ricorrente, anche perché rivolta a intellettuali che si muovono prevalentemente nell’area marxista (o quanto meno di sinistra). Ma non sono stati gli storici economici americani ad avere usato l’elaborazione di un modello per l’interpretazione? L’americano Alexander Gerschenkron aveva insegnato, ponendo i modelli dell’«arretratezza» economica e della «continuità» come «teoria». Altri seguirono questa indicazione metodologica anche in Italia: Rosario Romeo – storico liberale – aveva tracciato dichiaratamente la strada dell’«uso di schemi concettuali» in contrapposizione al «modello storico» gramsciano; Luciano Cafagna aveva delineato gli assi portanti del «dualismo» arretratezza-sviluppo italiano. Il «modello veneto» diventa anche il titolo di un volumetto miscellaneo edito dalla Fiom-Cgil del Veneto, contenente contributi già pubblicati in varie sedi tra il 1974 e il 1979 da Silvio Lanaro, Massimo Cacciari, Enzo Rullani, Rino Serri, Renato Brunetta6. In qualche modo questa accezione sarebbe stata inserita da economisti e sociologi, come 6 Modello veneto. Realtà e prospettive, a cura di Fiom-Cgil-Veneto, Tipografia editrice trevigiana, Treviso s.d. [1981]. 246 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 247 Convergenze (e divergenze) parallele Bruno Anastasia, Enzo Rullani, Arnaldo Bagnasco, Carlo Trigilia, Marcello Messori, nel modello di «nuova periferia industriale» e delle «tre Italie», inerente le «problematiche dello sviluppo» italiano. Ma soprattutto il «modello veneto» sarebbe stato uno dei pilastri del volume Il Veneto, curato proprio da Lanaro e pubblicato da Einaudi nel 1984, il secondo dopo Il Piemonte di Valerio Castronovo della collana Storia d’Italia. «Le Regioni dall’Unità a oggi. Genealogia di un modello» si intitola il saggio introduttivo appunto di Lanaro, che esordisce con l’immagine stereotipata cinematografica e televisiva del Veneto: «in un paesaggio ad elevato tenore alcolico vi si avvicendavano parroci e alpini, pazienza laboriosa e amabilità goldoniana, moderazione politica e familismo rurale». Ampie sono le discussioni suscitate nel mondo della cultura da questo libro; tra queste va riferita solo per curiosità una stramba ed esilarante stroncatura di 41 pagine da parte di Aurelio Macchioro, simpatico e umoroso studioso di storia del pensiero economico che in quel periodo insegna a Scienze politiche a Padova. Macchioro spara a zero sul «volume-Lanaro», e «dovendo rivolgerci al volume Lanaro – dice – è opportuno rivolgersi, anzitutto, a Lanaro Silvio». «Tutti conosciamo Lanaro Silvio: letture amplissime, laicismo intransigente, nessuna predisposizione a compiacere quei di Palazzo, eloquio e scrittura ricche e scorrevoli; preciso: ricche, scorrevoli e apparentemente lucide». Il modello inoltre è il modello «Lanaro-Isnenghi», il quale ultimo è «assunto come espressione del collettivo Lanaro». Insomma, tutto il discorso secondo Macchioro è «notevolmente intricato e posticcio di cose». Conclusione: «noi ci facciamo dei modelli regionali una fisima di concettualizzazione storiografica – a valere anche dove la camicia sia tanto stretta da costringerci a traguardare per riduzionismi di costume»7. Ma siamo già troppo in là negli anni, per riproporre ulteriori «convergenze parallele». Io non collaboro al volume sul Veneto, certamente non per le ragioni che avrebbe addotto poi Macchioro, ma perché mi viene fatta un’offerta che «posso rifiutare». Lanaro cioè mi chiede un saggio sui vescovi veneti. Ma io non intendo più occuparmi negli studi di preti, vescovi, istituzioni di Chiesa: me ne ero interessato abbastanza fino allora e non voglio continuare ancora. Faccio alcune proposte alternative: il gruppo di potere veneziano (Giuseppe Volpi, Vittorio Cini, Achille Gaggia) – di cui avevo cominciato a considerare i legami con le istituzioni economiche, politiche, sociali. La risposta è 7 A. Macchioro, Discorrendo di «veneticità» e di storia regionale, in «Storia in Lombardia», V, 1986, 2, pp. 109-50. 247 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 248 Maurizio Reberschak che si tratta di un argomento troppo ristretto e troppo «veneziano». E non se ne fa nulla. Tra l’altro è noto che il saggio di Wladimiro Dorigo (Venezia e il Veneto) viene inserito dopo la costruzione dell’impianto iniziale del volume, che appare troppo sbilanciato sul Veneto senza la presenza di Venezia. Avevo già detto di no a un’altra proposta nel 1976, quando si tenne a Treviso un convegno su Movimento cattolico e Democrazia Cristiana nel Veneto. 1945-19488, patrocinato dalla Sezione veneta dell’Istituto Gramsci, perché volevo guardare i centri di potere e i luoghi di comando che andavano oltre i partiti e le istituzioni politiche, come per esempio il porto di Venezia come luogo di esercizio del potere. Anche allora avevo ricevuto più che un no secco, una serie di dubbi e incertezze. Un convegno quello che aveva posto al centro il problema del «collateralismo» tra Chiesa cattolica e Democrazia cristiana, ribaltando il luogo comune della prima funzionale alla seconda per affermare invece la direzione inversa: la Democrazia cristiana nel sistema politico e sociale italiano funzionale alla matrice dominante della Chiesa. Forse le «convergenze parallele» cominciano ad essere «divergenze», sempre «parallele» però, non opposte. Non è certamente causa di questo l’andare ognuno per le proprie strade. Né tanto meno alcune frequentazioni diverse. Io per esempio ho cominciato a frequentare piuttosto intensamente Paolo Sambin, medievalista, da cui avevo appreso sin dalle sue lezioni universitarie il culto del documento archivistico e imparato la lettura critica e filologica delle fonti – anche contemporanee –. Lanaro non avrebbe mai fatto una cosa quale quella propostami da Sambin e da me accolta anche se all’inizio con qualche ricalcitranza, un indice dei nomi di persona, di luogo e degli archivi per una miscellanea di studi raccolti in due volumi. «Sono lavori minuti, che procedono per schede, ma che insegnano la precisione e la disciplina dello studio», dice Sambin. E – ricordo per inciso per i più giovani – non esistevano ancora computer con annessi database: tutto era fatto a mano su schede, una per una, un lavoro da certosini. Comincia per Silvio un progressivo distacco dagli archivi, nella convinzione che «niente è più inedito dell’edito», come giustamente insegna l’ignoranza diffusa di chi non legge o non sa leggere. In questo senso ha ragione, ma solo parziale, perché la scoperta può avvenire dal documento edito ma sconosciuto o ignorato, oppure dall’«inedito» archivistico ignoto e zampillante come sorgente. Come si può desumere, io 8 La Democrazia Cristiana dal fascismo al 18 aprile. Movimento cattolico e Democrazia Cristiana nel Veneto. 1945-1948, Marsilio, Venezia 1978. 248 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 249 Convergenze (e divergenze) parallele imbocco decisamente la seconda strada, Lanaro invece si avvia sul tracciato della prima. E ne nasce il suo secondo libro, Nazione e lavoro, del 19799 – dedicato ai figli Nicola e Ugo –, nel quale viene proseguito il discorso del primo libro, puntando la focalizzazione dell’obiettivo sulla panoramica delle origini sociali e culturali del fascismo, o meglio sostanzialmente sulla continuità ed esasperazione fra «detriti» dell’ideologia liberale e nascita del fascismo. «Non ho la pretesa di cucire le brache al mondo», afferma Lanaro, quindi segue la linea «dedicata al censimento dei detriti del passato – dal ruralismo alla «concezione organica» del potere – che intervengono come elementi attivi in un processo di accumulazione ideologica volto a consolidare le basi materiali del capitalismo». Per questo «si darà conto […] del processo attraverso il quale una gamma di semilavorati – magari sfruttati anteriormente per fini diversi – diventa carne e sangue di una formazione sociale emergente». E allora via con Vilfredo Pareto e Fedele Lampertico, con Alessandro Rossi e Alfredo Rocco, con Luigi Einaudi e Filippo Carli, con Giorgio Mortara e Rodolfo Benni, e così dicendo. Ci si era trovati meglio in sintonia tra noi nell’affrontare convegni impegnativi, come quello dedicato a Luigi Sturzo, promosso nel 1971 da De Rosa e svoltosi tra Palermo e Caltagirone, dove Lanaro pone una domanda centrale, quale fosse in realtà il «progetto politico» o meglio l’«ideologia» di Sturzo, ricevendone da De Rosa la risposta – non registrata negli atti del convegno –: «Ma Lanaro sa benissimo che Sturzo non aveva nessuna teoria di progetto politico». Oppure nel discutere e progettare il rifiorire di una rivista storica, «Studi storici», che dopo un periodo di difficile gestione tenta un rilancio sotto la direzione di Ernesto Ragionieri e Renato Zangheri. Ragionieri viene a Padova accompagnato da Gabriele Turi e Mario G. Rossi pochi mesi dopo il convegno del giugno 1973, di cui si è parlato, per valutare insieme ai «padovani» le linee di ricerca storica che possano ridare vitalità alla rivista. Buone le prospettive che si individuano, ma non realizzate a causa della morte di Ragionieri nel giugno 1975, che provoca un nuovo rimescolamento di carte nella rivista. Ma già nel 1973 ci si avvia su sentieri diversi. In quell’anno nascono due insegnamenti nell’ambito della contemporaneistica, uno di Storia contemporanea – a titolo gratuito – a Magistero di Padova, l’altro di Storia del Risorgimento – remunerato per 1/3 – nella dépendance di Magistero che si insedia Verona. Seneca indica l’opportunità di puntare agli incarichi di insegnamento. Ma come fare? Chi sta a Padova (a 9 Marsilio, Venezia 1979. 249 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 250 Maurizio Reberschak gratis), chi va a Verona (a pagamento di 1/3, ma utile con i bassi stipendi di assistenti)? Seneca lascia a noi la scelta. Dopo i convenevoli del tira e molla che richiamano Enzo Jannacci (resto io, no, tu no; vado io, no, tu no), si decide di fare la cosa più ragionevole: tirare a sorte. E così si fa. Lanaro vince Verona. Io vinco Padova. Sì, tutti e due vinciamo, perché in realtà a me sarebbe seccato andare a Verona con un’ora di treno per l’andata e un’ora per il ritorno. Le mie origini veneziane si fanno sentire: non avevo lasciato con la famiglia Venezia per andare ad abitare a Padova, perché c’era da fare poco più di mezz’ora di andata da Venezia a Padova e altrettanto di ritorno? Si sa, per un veneziano di origine, tutto è difficile al di la del ponte translagunare. Oggi sarebbe diverso da allora, per l’invivibilità di Venezia nel carnevale permanente di una città (città?) diventata essa stessa carnevale permanente, inflazione di navi da crociera ciascuna dalla botta di più di 3500 calate di orde sbracate vomitate tutte insieme con ritmo mattutino e giornaliero alla conquista di quella che ancora chiamano «città» e che sta al di sotto dei 60 000 residenti (e abitanti, quanti? ancor meno) – una volta ho contato nove navi attraccate ai moli della Marittima e una decima era attraccata nel bacino San Marco, perché i moli erano tutti occupati: si faccia il conto –, cultura scenografica e di sola immagine che più falsa di così non si può (almeno nella pittura ci sono i falsi «d’autore»), dissolvimento di competenze e capacità amministrative e totale sparizione del tessuto sociale, e chi più vuole più ne metta. Tutti e due contenti e soddisfatti allora, anche se da vile non lo dico a Silvio. Comincia così il nostro itinerario di insegnamento in autonomia. Restiamo, sì, assistenti di ruolo a Padova, continuiamo a fare esami, ma non seguiamo più solo un seminario bensì svolgiamo un corso, diamotutoriamo-presentiamo le tesi di laurea nell’insegnamento di cui siamo responsabili. Per Silvio la permanenza a Verona sarebbe durata fino al ritorno nell’insegnamento a Padova nel 1978, mentre a Verona gli subentrerà il brioso Franzina. Per me si compie presto il passo verso Venezia, dove è nata da poco (1969) la Facoltà di Lettere e Filosofia, e nel 1975 vengono attivati alcuni incarichi «serali» di insegnamento per lavoratori studenti (e non per studenti lavoratori), attuazione universitaria delle 150 ore di formazione scolastica e culturale previste dai nuovi contratti di lavoro conseguenti allo Statuto dei lavoratori del 1970. Tra questi insegnamenti viene inserito anche quello di Storia contemporanea. Gaetano Cozzi, che è a Venezia fin dall’origine della nuova facoltà (prima insegnava Storia moderna a Scienze politiche a Padova) mi chiama e propone a me, chiedendo che io estenda l’invito anche a Silvio, di 250 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 251 Convergenze (e divergenze) parallele presentare domanda per l’incarico. Ne parlo con Silvio naturalmente, ma lui ritiene di non optare per un insegnamento «serale» (così mi dice), forse considerandolo una specie di diminutio capitis. Riporto a Cozzi il ringraziamento della proposta e il cortese respingimento dell’invito da parte di Silvio – senza riferimento, ovvio, al no per l’incarico «serale» –, e ne parlo con Marino Berengo, che l’anno prima (1974) su invito di Cozzi ha lasciato Milano per Venezia, dove insegna Storia delle istituzioni politiche e sociali. Naturalmente Berengo è al corrente di tutto, perché le mosse sono sempre state concordate da Cozzi con lui, e mi invita a sua volta a non lasciar cadere l’opportunità. Per inciso mi confida un particolare sui rapporti tra loro due: a suo conoscere è stata la prima volta in un’università italiana in cui un professore ordinario invita un altro ordinario di pari rango ma con maggiore anzianità di ruolo a trasferirsi nella stessa università, nello stesso istituto, in un insegnamento affine. Comincia per me una delle più felici esperienze didattiche, con lavoratori che vengono al mio corso: operai, sindacalisti, impiegati, insegnanti, tutti motivati allo studio, coi quali, accanto alle lezioni tradizionali, posso sviluppare seminari, «tesine», brevi ricerche personalizzate ai loro interessi professionali. E posso anche ritornare ad abitare a Venezia, allora ancora vivibile, a dimensione umana, col tessuto sociale ancora – ma per poco – popolare. A Venezia – dove nel 1979 avrebbe preso l’avvio il corso di laurea in Storia – sarei stato raggiunto negli anni seguenti da altri «padovani» di formazione o di adozione: Piero Brunello, che ormai ha lasciato perdere la Repubblica e i preti del 1848 e va dietro a «ribelli, questuanti e banditi»; Gigi Corazzol, che Giovanni Miccoli aveva invitato a Trieste per insegnare Storia dell’agricoltura; Mario Isnenghi, che da Scienze politiche di Padova era passato a Lettere a Torino, sempre più prolifico di libri, talora un po’ ombroso ma capace di attrarre studenti allo studio. Dagli anni ottanta i nostri due percorsi diventano decisamente «divergenze parallele», perché ciascuno imbocca la propria strada nell’insegnamento universitario, come si è detto, ma soprattutto nelle tematiche di ricerca. Io mi butto in tre filoni: industria idroelettrica e il Vajont, classi dirigenti e gruppi dominanti, intellettuali (veneziani) tra le due guerre. Lanaro invece spinge l’acceleratore su aspetti e problematiche di più ampia tela, puntando anzitutto sulla storia dell’Italia repubblicana10, argomento storico che, dopo il primo tentativo di Paul 10 Storia dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni novanta, Marsilio, Venezia 1992. Ora anche audiolibro in formato Mp3: http://www.ilnarratore.com/prodotti/idx/155/Silvio-Lanaro—-Storia-dellItalia-repubblicana—-download.html. 251 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 252 Maurizio Reberschak Ginsborg, diventa di interesse per molti storici (esempio: Pietro Scoppola, Aurelio Lepre, Enzo Santarelli) e attrazione di moda non insignificante, in un periodo in cui si diffonde il luogo comune becero e crasso del «novismo» dell’Italia che non avrebbe alle spalle storia recente, quindi aborre la comprensione del passato (che non esiste, secondo tale insulsaggine distrofica) e non intende capire il presente, perché il presente è creato solo dall’immagine – l’unica realtà esistente – e la cosiddetta cultura è la vuota affabulazione gridata; chi più mostra e più grida: ecco la «nuova» storia. In secondo luogo comincia a porsi interrogativi sulla storia, soprattutto di metodo e di epistemologia e semantica11. Le nostre originalità sono suggellate dalla dedica fattami nel 1988 nella prima pagina de L’Italia nuova12: «A Maurizio, con affetto nonostante tutto». Non so se Silvio abbia ricevuto dal nostro comune bizzarro amico Gigi il suo vaudeville di «come me la passo in pensione»; se non l’ha visto, glielo consiglio. In ogni caso faccio mio il saluto finale, mutando il drastico «addio» iniziale con un più fiducioso e speranzoso e proiettato al futuro «bondì» di quel dialetto del nostro montanaro, per concludere col saluto benaugurante di Ruzante: «Bondì ottimo amico, grazie per l’affettuoso interessamento. Vedi di starmi bene. Sanité». 11 Raccontare la storia, Marsilio, Venezia 2004; Retorica e politica. Alle origini dell’Italia contemporanea, Donzelli, Roma 2011. 12 L’Italia nuova. Identità e sviluppo 1861-1988, Einaudi, Torino 1988. 252 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 253 PENSARE LA NAZIONE Pensare in grande: storia, politica, amicizia Conversazione con Mario Isnenghi di Simon Levis Sullam e Gilda Zazzara* Ci racconti quando è avvenuto il tuo primo incontro con Silvio Lanaro? Dev’essere stato nell’anno accademico 1959-60. Io ero entrato a fine ’56, ero quasi laureando, mentre Silvio era matricola. Quattro anni di differenza all’università decidono di tutto e Silvio, avendo bruciato le tappe come studente al liceo, arrivava ancora più giovane di quanto avrebbe dovuto essere. Certo si era immediatamente evidenziato: tutto era fatto apposta per metterlo in luce, a partire dalla sua stessa giovinezza. Venivamo da due diversi punti del Veneto, convenendo, come tutti quelli che facevano Lettere a Padova, al Liviano, al Bo e poi al vicino Caffé Pedrocchi. Silvio veniva «a miracol mostrare» dalla provincia più profonda: quella provincia di Vicenza che batteva assolutamente tutti nella creazione di giovanissimi cervelli. La produzione vicentina di quella generazione, cioè Lanaro, Lorenzo Renzi, Anco Marzio Mutterle, Lorenzo Polato e, immediatamente prima, Enzo Mengaldo e Armando Balduino… beh, perbacco, nessun’altra città del Veneto poteva mettere in campo tutto questo. Dall’alto della mia altera venezianità dovevo ammetterlo. Quale era stato il suo percorso biografico, nella tua personale ricostruzione? Silvio è nato a Schio, si è spostato nell’infanzia a Malo, ha fatto le scuole a Vicenza. Così poteva giocare – e questo è molto importante nella sua biografia e nel suo senso di sé – sull’idea meneghelliana di una Malo da cui liberarsi, ma in cui affondare le proprie radici. Oppure, con Schio, poteva idealmente annettersi il centro industriale strategico di quello che anni più tardi lui stesso avrebbe chiamato «modello veneto»: la Fabbrica Alta del Lanificio Rossi campeggerà sulla copertina * Questa conversazione è stata registrata a Venezia il 2 dicembre 2011 e rivista dai tre autori. 253 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 254 Mario Isnenghi, Simon Levis Sullam, Gilda Zazzara del Veneto Einaudi nel 1984. Questa collocazione gli consentiva tra l’altro di ripensare diversamente dagli altri il Veneto, risalendo indietro fino al Seicento, agli antichi predecessori del «suo» Alessandro Rossi. Ho conosciuto i genitori di Silvio: il padre era impiegato, se non sbaglio bancario; la madre credo abbia sempre fatto la casalinga. Silvio ha un fratello minore: Paolo, stimato come poeta e che ha fatto il professore di Lettere nei licei vicentini. Ma all’inizio io sapevo solo che Silvio Lanaro veniva da Malo; e il fatto che tutti noi fossimo grandi lettori e innamorati di Meneghello faceva stupire che quel paesino, nel giro di non molti anni, avesse potuto «calare» due carte simili. Lanaro è un enfant du pays che a un certo punto se n’è andato altrove, continuando a studiare il pays; e presto non solo quello, essendosi messo a studiare il Paese. E poi il suo pays d’elezione: la Francia. Che tipo di orientamenti politici poteva avere, secondo te, la famiglia Lanaro? Non credo che la famiglia Lanaro fosse politicizzata, e neanche clericale. Credo fosse moderata, apolitica, «normale». Però non ho mai sentito Silvio ragionare di radici famigliari, casomai di riferimenti territoriali, di carattere misto tra ambientale e letterario. Insomma, per avventura Malo, nel caso di Silvio, esisteva non solo nei libri, ma nella vita vissuta; e così anche Schio. Fondamentalmente, l’una voleva dire Luigi Meneghello, l’altra Alessandro Rossi. Dovete capire, però, che Meneghello era presente tra noi come la misura di tutte le cose e significava radici e distacco ironico dalle radici. Se uno poi veniva da Malo, come nel caso di Silvio, nasceva naturalmente come il futuro Meneghello… D’altra parte la letteratura vicentina aveva già dato; il ripensamento di Vicenza e del Vicentino si era già prodotto alla grande in chiave letteraria, da Fogazzaro allo scrittore di Malo, appunto. Allora per chi pensava altamente di sé – con Silvio siamo di fronte a uno di questi casi – bisognava immaginare un’altra chiave di lettura, di accesso alla realtà. Ma con lo stesso fortissimo bisogno di leggere, inquadrare e contestualizzare se stessi dentro a una città amata e al tempo stesso soffocante quale era Vicenza, dove Silvio si era trovato dagli anni del liceo: la culla di Fedele Lampertico, ma anche di Mariano Rumor. Chi potevano essere, in questo piccolo ambiente, i suoi maestri? C’erano degli intellettuali «di paese», dopo che Meneghello se ne era andato? Toni Giuriolo è stato per Silvio un maestro indiretto, attraverso le autobiografie ideali e il «roverso mondo» del racconto pubblico dei vi254 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 255 Pensare in grande: storia, politica, amicizia centini, essendo morto durante la Resistenza. Credo che un altro «fratello maggiore» sia stato per lui, come per tutti i vicentini, Fernando Bandini. Poeta, maestro elementare, salito a docente universitario di Filologia in quanto allievo del grande Gianfranco Folena: come tutti noi, prima o poi, avremmo voluto essere o essere stati; ma bisognava occuparsi di grammatica e questo, almeno per me, era spoetizzante! Bandini era allora un militante del Partito socialista, i vicentini in sofferenza lo volevano sindaco, deputato: aveva dieci anni più di loro, una sorta di «nave scuola». Puoi ricordarci alcune delle vostre prime esperienze in comune, di Lanaro e tue? Avete presente la famosa frase su Enrico Berlinguer, «si iscrisse giovanissimo al Comitato centrale…»? Ecco, Silvio Lanaro «si iscrisse giovanissimo all’Unione goliardica italiana». Non aveva fatto gran vita di associazione goliardica provinciale a Padova, dove era arrivato per l’università. Uno dei primi ricordi che ho di lui è al Congresso dell’Ugi a Venezia: quello in cui noi veneti – cioè, oltre a noi due, anche Giannantonio (Nane) Paladini, Gianni De Michelis e qualche architetto – potevamo prendere la guida nazionale, perché eravamo già importanti. Silvio come studente era appena nato e nell’Ugi c’era solo un altro leader in incubazione così giovane: Adriano Sofri. Ho precisa memoria di una notte veneziana in piazza San Marco, nei giorni del congresso del ’60, con Silvio (diciottenne), Gianni e, appunto, la brillante mascotte pisana. Attraversavamo obliquamente la piazza dall’Ala napoleonica verso la Piazzetta dei Leoncini. Cinquanta metri davanti a noi c’era il nostro leader, un fascinoso siciliano, il socialista di sinistra Giacinto Militello. Stravedevamo per Militello, che poi si è alquanto burocratizzato, diventando precocemente presidente dell’Inps. Eravamo convinti che se le cose fossero andate per il loro verso potesse fare molto di più. Su De Michelis, invece, non abbiamo sbagliato di molto: lo vedevamo al governo. Insomma, tutto questo per dire che, sin dal principio, Silvio scommetteva sul grande e dialogava sempre ad alto livello. A questa sua caratteristica si legano molto i primi ricordi che ho di lui. Lanaro aveva condiviso con te l’esperienza della Fuci? Figuratevi, no! Questo è fondamentale. C’è la vulgata di una vita sempre condotta in simbiosi tra noi… In realtà è una vita in parallelo, 255 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 256 Mario Isnenghi, Simon Levis Sullam, Gilda Zazzara per molti versi: amici sempre, ma in diverse maniere nel corso di mezzo secolo di rapporti. In ogni caso Silvio non ha avuto poi il bisogno di essere anticlericale che ho io, che ho ancora dei rancori, delle rabbie da ex militante cattolico, quale lui non è mai stato. D’altra parte nel mondo cattolico lui ci era vissuto e ci viveva dentro. Le differenze di origine e formazione si riflettono per molti versi anche nei vostri primi interessi scientifici. Guardando alla tesi di laurea di Lanaro, o meglio al libro che ne nacque (Società e ideologie nel Veneto rurale, 1866-1898, uscito nel 1976), ci si potrebbe chiedere se questo interesse per il cattolicesimo non fosse proprio una sorta di mappatura del mondo in cui Silvio era cresciuto. I condizionamenti territoriali arrivano in effetti al punto che la stessa nascente critica rispetto alle visioni usuali del Veneto deve passare attraverso l’egemonia cattolica. Questo si esprime anche nel fatto che Gabriele De Rosa fosse venuto da Salerno proprio in Veneto – e precisamente a Vicenza – per studiare quello che appariva anche a lui e ai suoi amici (sacerdoti o meno) il laboratorio dell’Italia «bianca». Per cui si sono venute formando due scuole storiche che in realtà non si guardavano in cagnesco, al punto che l’ex tesi di laurea di Silvio può uscire appunto per De Rosa, cioè presso le Edizioni di Storia e Letteratura. Del resto la stima tra loro era reciproca. In ogni caso, del Veneto cominciavano a esserci due visioni e dentro una di queste, per gli studiosi che se ne facevano interpreti, c’era un elemento di antagonismo, con ricadute sul piano elettorale, dei comportamenti quotidiani e anche dell’immagine che avevamo di noi stessi. Ciò non comportava affatto una visione storica del Veneto spaccata in due perché anzi, quello che viene fuori dagli studi di Silvio e da una serie di studi da lui suscitati, era che i cattolici non significavano solo vetustà, archeologia, ritardo. A Vicenza, poi, c’era stato il modernismo. Sì, ma un modernismo genuflesso, come quello di Fogazzaro che – come poi abbiamo scoperto – per quella genuflessione perse il Nobel. «Sbagliare con la Chiesa» è stato il terribile motto che personalmente mi ha fatto decidere di abbandonare il mondo cattolico. Il modernismo può essere valorizzato, però alla fin fine ci sono i tre fratelli Scotton, che durano molto più a lungo; e c’è dell’altro, perché gli Scotton non riescono ancora a capire, nel 1915-16, che è finito il tempo del cle256 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 257 Pensare in grande: storia, politica, amicizia rico-intransigentismo e che c’è un nuovo connubio clerico-moderato che rappresenta la linea egemone della Chiesa. Ma qui il Veneto c’entra pienamente, è la linea moderata dell’industrializzazione «dolce» e della futura «fabbrica per campanile». Gli studi di Silvio ci hanno «armati» concettualmente rispetto a tutto questo. Mi pare importante partire dalla nostra assunzione del Veneto – che era, anche se diversamente, la regione di entrambi e del nostro gruppo – come il prototipo dell’Italia. Se l’Italia è il paese cattolico per eccellenza, il Veneto è la regione italiana per eccellenza: quindi noi storici veneti godevamo, godiamo, di un osservatorio privilegiato e siamo, per così dire, i «veri» storici dell’Italia. Il nostro venire da luoghi diversi favoriva, inoltre, la possibilità (e probabilmente anche l’intenzione) di cogliere Veneti differenti, anche per scomporre l’ipotetica compattezza monolitica di una regione sempre tutta ordinatamente «bianca». Allora la nostra «squadra» (via via, o per tratti di strada, Emilio Franzina, Piero Brunello, Giorgio Roverato, Maurizio Reberschak, Livio Vanzetto, Carlo Fumian) si è giovata del fatto che alcuni venissero da un luogo, alcuni da un altro. In questo caso che alcuni venissero dalla provincia vicentina: quindi dal «peggio del peggio» (detto in termini politici immediati, non storiografici!), cioè dalla «sacrestia d’Italia». Ma allo stesso tempo dal luogo che – di nuovo – aveva prodotto gli anticorpi di una narrativa laica. Nel capitolo sulla letteratura che feci per il Veneto Einaudi curato da Silvio, ho individuato questi due pilastri, Fogazzaro e Meneghello, a rappresentare una sorta di antagonismo interiore della regione. Lo spirito di contraddizione è, in definitiva, il modo per star di casa nel Veneto e questo non ha mai comportato atteggiamenti vittimistici, sensi di inferiorità: eravamo pronti semmai a rovesciare in protagonismo quello che continuava ad apparire come ritardo. Come si costituisce questa «squadra» – il vostro gruppo di storici – se a quel tempo non esisteva un insegnamento di Storia contemporanea all’Università di Padova? Ecco un’altra divaricazione: mentre io avevo scelto di laurearmi in Letteratura italiana contemporanea con Giorgio Pullini – anche se poi sarò esercitatore di Storia contemporanea come aiuto di Gaetano Cozzi a Scienze politiche –, Silvio, Emilio e altri si sarebbero laureati con Federico Seneca, docente di Storia moderna, studioso accanito di procuratori e di dogi secondo la tradizione filologico-erudita di Roberto Cessi – numen loci –, ma signorilmente disponibile a coprire le prime tesi di storia contemporanea. Occuparsi di Ottocento e Novecento, in 257 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 258 Mario Isnenghi, Simon Levis Sullam, Gilda Zazzara ogni caso, significava allora costruire le condizioni stesse dello studio del Veneto, in maniera autocosciente e critica rispetto ai luoghi dove eravamo nati. Io ci sarei arrivato un po’ dopo, pur essendo partito, ventenne, dal rapporto con Wladimiro Dorigo, grande studioso di Venezia che, con «Questitalia», cercava allora di dipanare il nodo dell’unità politica dei cattolici. Torniamo alla vostra amicizia, che continua dopo gli anni universitari. Silvio si trasferì presto a Padova con sua moglie Giovanna, una delle nostre compagne veronesi di università; ma di Legge, non di Lettere, indipendente e sempre un po’ sulle sue anche per questo. Hanno avuto un primo figlio, Nicola, seguito qualche anno dopo da Ugo. Silvio e Giovanna insegnavano qua e là nel Padovano: era un lavoro, non una missione. Io fino al ’66 mi muovo tra Feltre, Venezia e Chioggia. Infine mi trasferisco anch’io a Padova. Allora, come da studente, finalizzavo la mia vita alla scuola e alla riforma della scuola, badavo a interpretare il rapporto critico col territorio; Silvio invece ha sempre avuto come obiettivo la ricerca e quindi l’università. Tra le vostre esperienze comuni di quegli anni ci sono le Edizioni del Rinoceronte: come nascono? Nascono nel 1964 facendo rivivere quello stesso gruppo di amici studenti che a quel punto era costituito da lavoratori intellettuali, sostanzialmente insegnanti, qualcuno legato nettamente alla scuola, altri tra scuola e università. Allora non ci si trovava più al Liviano o al Pedrocchi; ci si trovava nelle case, ma i legami sopravvivevano, eccome. Comunque le Edizioni del Rinoceronte nascono anche perché voglio raccontare il mio licenziamento per motivi «politici» dall’Istituto tecnico di Feltre (ne nascerà il primo volumetto, a mia firma, L’impegno incivile) e perché alla Biblioteca Marucelliana di Firenze avevo trovato l’unico esemplare completo dell’«Astico» e del «Nuovo contadino» di Piero Jahier, di cui mi ero innamorato durante la mia tesi di laurea. L’antologia di Jahier fu uno dei titoli – solo tre! – che uscirono con il bel marchio del Rinoceronte di Dürer, ideato da due architetti e grafici veneziani, Diego Birelli e Franco Giacometti. Il terzo fu una raccolta di poesie di Gigetta Rizzo Pagnin, una maestra comunista, poi presidente della Provincia di Venezia, dal titolo granguignolesco – e però gramsciano – Il borghese agli agguati. Avevamo chiesto un’ipotesi di 258 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 259 Pensare in grande: storia, politica, amicizia libro al giovanissimo Massimo Cacciari, che allora ventilò non saggi, ma versi… Ci eravamo autofinanziati con cinquantamila lire a testa, cioè circa un terzo del nostro stipendio di allora: Silvio; Lorenzo Renzi (prole foleniana, poi ordinario di Linguistica alla facoltà di Lettere); Anco Marzio Mutterle e Lorenzo Polato (italianisti); Vania Chiurlotto (in seguito capo dell’Udi e di «Noi Donne»); l’allora brillantissimo Orio Caldiron (prossimo storico del cinema) e il sottoscritto. Dopo questi tre volumi il tipografo ha preteso di essere saldato e così… abbiamo chiuso in tutta fretta. In questo modo, tra l’altro, non siamo diventati noi la Marsilio. Un’altra esperienza comune degli anni sessanta, che probabilmente lascia un segno maggiore sul piano intellettuale e scientifico, è la vostra collaborazione alla rivista «Ideologie». Il passaggio di Silvio per «Ideologie» è stato molto più significativo del mio. Era un progetto molto colto, molto profondo, ricco di interrogativi metodologici e di contatti extrapadovani. Veniva incontro alle sue esigenze di pensare in grande: se lui aveva fatto la sua prima ricerca sulle ideologie rurali nel Veneto, la rivista pretendeva di allargare il tiro ragionando sul peso delle ideologie nel far politica, nel raccontarla e nel legittimarla. «Ideologie» aveva una specie di doppia direzione: Ferruccio Rossi-Landi e Mario Sabbatini. Il primo era un filosofo con moltissimi interessi, fece un breve passaggio accademico, molto controcorrente, nella Padova neo-scolastica. L’altro, Sabbatini, che prenderà poi la strada di Cuba, è rimasto un grande sconosciuto e andrebbe rimesso all’onor del mondo: ha stampato poco e scritto molto – lunghe lettere-saggio, soprattutto, a interlocutori anche occasionali –, ma va letto ancora il suo Profilo politico dei clericali veneti. Gli studi di Sabbatini che hanno avuto influenza su di noi sono appunto quelli sui cattolici nel Veneto, di cui si interessò anche Togliatti su «Rinascita». Questo Sabbatini, anche lui vicentino, è stato per Silvio un maestro esterno all’università. Spesso si piazzava in casa Lanaro e faceva diventare matta Giovanna, perché quella scintillante intelligenza nella vita di tutti i giorni era un grande imbranato. Su di lui, tra l’altro, fioriva allora la straordinaria vena di narratore orale di Silvio. Ecco un’altra grande componente biografica di Lanaro: la sua accattivante arte di affabulatore, sino a quelle che il Lelio goldoniano definiva «spiritose invenzioni». Le sue famose barzellette – un repertorio stranoto ma rivitalizzato ogni volta –, commiste di italiano aulico e di dialettalità, erano sempre richiestissime in compagnia. 259 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 260 Mario Isnenghi, Simon Levis Sullam, Gilda Zazzara Nell’intervista contenuta nel volume per il tuo settantesimo, Lanaro ha affermato di non essersi nemmeno «accorto» del Sessantotto. In realtà proprio su «Ideologie» scrisse nel ’69 un pezzo sulle origini ottocentesche del «proletariato accademico». Sempre in quella intervista, prendendone le distanze, ricorda tra l’altro la tua «infatuazione operaista». Il suo «non essersi accorto» discende, secondo me, dal fatto che Silvio ha insegnato o alle medie – proprio durante il Sessantotto – o all’università: le superiori, da docente, le ha saltate. Anche per questo lui non c’entra con la nascita – sessantottina e pan-sindacalista – della Cgil scuola (ricordo qualche intemerata dei vertici nazionali: «questa non è una lega anarchica, questa è la Cgil!»). Comunque abbiamo firmato un articolo assieme sulla rivista «Rendiconti» di Roberto Roversi, per difendere Francesco Tolin, un insegnante di un istituto tecnico-commerciale padovano arrestato perché, secondo la normativa sulla stampa, si trovava a essere il direttore responsabile di «Potere operaio», senza esserne affatto il direttore politico. Con molta correttezza e coraggio Cesco, in seguito dirigente del sindacato scuola Cgil a Padova, si era assunto una responsabilità che di fatto non aveva: questo gli sconvolse la vita, venne messo in galera, perse il posto… Questo piccolo ma significativo episodio è stato il nostro Sessantotto in comune. Allora già vi distinguevate, dal punto di vista politico come negli interessi scientifici e negli approcci metodologici: potremmo dire tu più «populista», lui più «elitista»? Lanaro è sempre stato attirato dai punti alti, dalla possibilità e dalla capacità di dialogare ai massimi livelli, scegliendosi certi interlocutori o personaggi «storici», tipo Alessandro Rossi. E anche certi interlocutori storiografici. Via via, nel corso dei decenni, il discorso storiografico di Silvio si è allargato, si è internazionalizzato: soprattutto in rapporto alla Francia. Il nostro «far squadra» si giova anche delle diverse propensioni, diciamo la sua «verso l’alto», la mia «verso il basso». Non sono fisiologicamente meno elitario di lui, però mi sforzo di più, avverto un dover essere che mi ha portato «verso il popolo»; Silvio, non se l’è mai sognato… Ha accettato dal principio l’idea di una società in cui conta sostanzialmente lo Stato e che si dirige dall’alto. Non avrebbe mai scritto canzoni (com’è avvenuto a me), frequentato gli anarchici, o cose di questo genere. 260 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 261 Pensare in grande: storia, politica, amicizia Parliamo, a questo punto, dei primi grandi libri di Lanaro. Società e ideologie nel Veneto rurale, che esce nel ’76, è un volume davvero importante per la ripresa degli studi sul Veneto: meditato, elaborato, documentatissimo. Forse solo penalizzato dalla sua collocazione editoriale riservata agli addetti ai lavori. Dentro, e poi negli studi che sfoceranno nelle grandi analisi del Veneto, ci sono le prime scoperte di Silvio, non solo contenutistiche ma anche metodologiche: scoperte che danno vita a una serie di espressioni, di formule diventate poi di uso comune come «modello veneto», «fabbrica diffusa», ma anche «transizione dolce» (perché a un certo punto, nel lasco di qualche anno, entra in funzione anche Emilio Franzina, che lavora sugli stessi temi utilizzando le stesse categorie; si dovrebbe poi verificare chi ha usato prima quale formula). Nessun isolamento editoriale o accademico, invece, per Nazione e lavoro, il secondo grande libro – probabilmente il capolavoro – di Silvio, che esce da Marsilio e fa subito discutere: nel 1979 mettere in prima pagina la nazione accanto al lavoro non era una scelta ovvia, manco per niente! È un libro colto, inventivo, molto pionieristico: nell’analisi del nesso tra capitalismo e cattolicesimo; nel recupero del concetto di nazione; nella riscoperta e valorizzazione di alcuni personaggi. Tra l’altro, Silvio inizia allora a parlare positivamente di nazione, prima e più di me. Mentre io sono ancora attirato dai sovversivi e dalla guerra, lui no… Questa è una netta differenza tra noi ed è una sua scoperta e una sua precocità: «dir bene» della nazione, dir bene dei capitalisti, pur non essendo stato operaista, che era la via per arrivarci da sinistra. Silvio Lanaro è un grande estimatore della borghesia e proprio di questo allora discutevamo molto, di lui che si appassionava alla borghesia professionista, alla classe dirigente che aveva costruito o voluto costruire lo Stato, mentre io e altri bazzicavamo più in basso, nella società, alla ricerca di alternative. Anche rispetto al fascismo, mentre io ho studiato la piccola borghesia e il sovversivismo piccolo borghese, a Silvio interessavano le arti di governo del grande borghese: teoricamente, quindi, più il nazionalismo che il fascismo; più Rocco che Mussolini. Risalendo alle origini ideologiche del fascismo e non studiando il regime, l’educazione dell’italiano, i funzionari, o quel maestro supplente venuto dalla Romagna… Nazione e lavoro inaugura tra l’altro una riflessione sulla mancata nazionalizzazione, sull’Italia che non è un paese «normale». È un discorso, questo, che va avanti fino agli ultimi suoi libri: la nazionalizzazione che non viene portata avanti più di quanto non lo sia 261 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 262 Mario Isnenghi, Simon Levis Sullam, Gilda Zazzara la democratizzazione. Una democratizzazione condotta nell’universo socialista e cattolico; mentre i liberali rinunciano alla nazionalizzazione democratica. E mi pare che in Silvio si insinui qui una deplorazione per il nostro liberalismo, più asfittico di altri. In un certo senso, però, investe sui cattolici che legittimano il capitalismo e sui capitalisti che non lo sono abbastanza. Questa è una strada sua: molto personale e originale. Attorno ad alcuni di questi temi e nessi, si arriva poi ai vostri studi degli anni settanta, condotti nell’ambito della sezione veneta dell’Istituto Gramsci, che portano ai volumi Movimento cattolico e sviluppo capitalistico, nel 1974, e Movimento cattolico e Democrazia cristiana nel Veneto (1945-1948), nel 1978. Movimento cattolico e sviluppo capitalistico nel Veneto sarà il «numero zero» della collana marsiliese «Veneto contemporaneo», che con Lanaro dirigiamo assieme tra il 1976 e il 1983. Naturalmente siamo approdati a Marsilio attraverso i fratelli De Michelis, Gianni e Cesare (Ciccio). Notate che il primo convegno, alla Gran Guardia di Padova, venne presieduto da Marino Berengo, che allora era nella sua fase tra Milano e Venezia e che accettò di farci da nume tutelare. Vedete che ritorna sempre questo gusto di pensare in grande e cercare grandi interlocutori… Questo è stato, si potrebbe dire, il «protolibro» rispetto al Veneto che inaugurerà alcuni anni dopo la serie sulle regioni della Storia d’Italia Einaudi. Allora c’erano già anche Emilio Franzina, Maurizio Reberschak e Livio Vanzetto. Silvio fece l’introduzione generale al convegno (io scrissi l’introduzione al volume, non firmata), come poi farà anche nel Salone dei Trecento a Treviso, nel ’76: un grande convegno rimasto d’improvviso «orfano» del suo principale patrocinatore, il Pci. Vi parliamo troppo chiaro della Dc, che intanto il committente dei lavori ha scelto come partner nel «compromesso storico»… La nostra collana Marsilio parte con una storia del «Gazzettino» di Maurizio De Marco, mio laureato a Scienze politiche: una forma di «posizionamento» rispetto alla costruzione e alla stratigrafia mentale del Veneto. Di «Veneto contemporaneo» voglio ricordare almeno altri due titoli destinati a durare: il libro di Emilio Franzina, La grande emigrazione, e quello di Piero Brunello, Ribelli, questuanti e banditi. In entrambi si ritrova il Veneto di chi lotta, perde, se ne va via, emigra. Il «modello veneto», insomma, ha le sue resistenze e le sue pene. Ed ecco infatti farsi largo il libro di Cesco Chinello su Porto Marghera, non precisamente in linea con la «transizione dolce». 262 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 263 Pensare in grande: storia, politica, amicizia Come nasce e come valuti, poi, superati gli anni ottanta, un altro importante libro di Lanaro, quello forse con maggior successo di pubblico e universitario, anche perché si tratta di una grande sintesi: la sua Storia dell’Italia repubblicana? La Storia – di spiriti, diremmo, «azionisti» – ha di interessante, preliminarmente, il coraggio di intraprendere una ricostruzione delle vicende dell’Italia repubblicana quando sono in pochissimi a volerlo e saperlo fare. Silvio l’ha fatto alla sua maniera, così diversa da quella che già aveva seguito Paul Ginsborg. La metterei al secondo posto tra i suoi libri più belli, dopo Nazione e lavoro. Una questione che serpeggia lungo tutta la Storia dell’Italia repubblicana, e poi si esprime nelle ultime pagine, è quella della «normalità» italiana. Ricordo quando Massimo D’Alema venne a Padova da ministro o presidente del Consiglio in pectore e volle incontrare alcuni di noi al Pedrocchi. Allora riconobbe a Silvio – ricordo chiaramente un nostro colloquio a tre in Sala Rossini – di aver preso dal suo libro la faccenda dell’Italia «normale», che io non condividevo. Normalità rispetto a chi? Rispetto a cosa? E il fascismo, che abbiamo inventato noi? È l’Italia! Abbiamo avuto il Partito comunista più grande d’Occidente: anche questo è Italia… Ma il gesto o la dichiarazione di D’Alema vanno registrati, ricordati come il riconoscimento di un leader politico alla storiografia di Silvio Lanaro. E gli altri lavori di Silvio: da quelli, che costellano due decenni, attorno all’idea di nazione, a quelli dedicati, in anni più recenti, alle «retoriche» degli storici e della politica? Gli altri suoi volumi, in particolare L’Italia nuova (1988) e Patria (1996), sono carichi di sapere, di idee e di grandi letture. Sono molto collegati tra di loro, perché Silvio continua a pensare alla nazione e a questo punto ha anche un coraggio che quasi nessuno di noi allora aveva: parla addirittura di patria, anche se sposta il discorso all’estero, in Francia, e lo fa per interposta nazione, con il «noi» degli altri. Io ancor oggi non ce la faccio e la parola «patria», per dirla proprio con il sottotitolo del libro di Silvio, la «circumnavigo». Lui già da anni usa questo termine, anche perché è passato proprio attraverso le sue letture francesi, Ernest Renan in primo luogo. Ho trovato ovviamente suggestive anche le sue pagine sul Raccontare la storia, che mostrano tutta la sua avvertenza metodologica – Silvio è più interessato di me a occuparsi esplicitamente di metodo – assieme alla sua sensibilità lettera263 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 264 Mario Isnenghi, Simon Levis Sullam, Gilda Zazzara ria, un tratto che invece ci accomuna. Il recente Retorica e politica offre invece un bello spaccato del suo laboratorio di storico attraverso i decenni, fino alle riflessioni, molto impegnate teoricamente, sull’«idea di contemporaneo». Un tratto che contraddistingue la storiografia di Lanaro è la ricchezza dello stile, della scrittura. La civetteria della parola difficile, talvolta sconosciuta, è un aspetto delle sue altezze di stile. Silvio scrive benissimo e ci tiene a scrivere benissimo. L’ha sempre fatto e l’ha sempre voluto fare. La difficoltà, certo, fa parte della complessità del ragionamento, e va bene. La parola difficile, invece, il termine lessicale, la singola parola che sai già che nessuno capirà: quella ce la vuol mettere lui, ed è un vezzo. Ma quando avete scritto assieme, allora, come procedevate? Una volta, in vista di un congresso dell’Ugi, abbiamo fatto tre giorni di preparazione – proprio gli esercizi spirituali… – salendo in Carso, a Prosecco. Eravamo Silvio, il mio amico Luciano Ferrari Bravo ed io. Così – a due, invece che a tre – sono nati gli articoli per «Belfagor» e, più tardi, l’epilogo del Veneto Einaudi: uno parla e l’altro scrive, a turno. Io avevo imparato a scrivere velocissimo andando in giro con Toni Negri, o da solo, per «Il Progresso Veneto». Questo tipo di lavoro di microgruppo nasce ovviamente da sintonie e non si può fare con tutti. Quindi i quattro o cinque pezzi firmati assieme – ad esempio Fascismo esorcizzato. Cinque schede sulla rivolta piccolo-borghese («Belfagor», 1970) – sono nati così: ci alternavamo, uno parlava e l’altro scriveva, e viceversa. Però le scritture non sono intercambiabili. D’altra parte c’era una fiducia reciproca in vista dell’altezza delle attese, della voglia che avevamo di scrivere bene. Naturalmente era una bella scommessa, perché è difficile scrivere ugualmente bene, si può creare un ibrido. Accettavamo l’ibrido stilistico pro tempore, in alcuni casi in nome del raddoppiamento delle conoscenze, delle esperienze, dei punti di vista. E l’oratoria di Silvio Lanaro, ce la vuoi descrivere? Molto simile alla sua scrittura: è la concinnitas, la grandiosità, l’ampiezza, la maestà… Tendendo al «barocco» come stile senz’altro compiuto. Silvio in certe stagioni è stato un grande oratore. Io in questo, allora, mi sentivo nettamente inferiore. 264 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 265 Pensare in grande: storia, politica, amicizia Sullo sfondo di questo nostro colloquio e delle tue parole ci pare scorra una grande amicizia. Quando eravamo piccoli, all’università, essere riconosciuto da lui come un punto di riferimento è stata una bella investitura. Proprio da lui, che era il migliore di tutti i giovani! Poi non dimentichiamo che oltre agli studi, ai libri e alla politica studentesca, andavamo assieme in campeggio e le nostre mogli si telefonavano tutti i giorni. È stata davvero un’amicizia di famiglia. Abbiamo fatto viaggi e cori tra amici su repertori di canzoni popolari. Silvio si prestava a intonare canzonacce populiste per amore del gruppo, ma declamava più volentieri romanze borghesi un po’ fané tipo Vipera, Come una coppa di champagne, Come pioveva. Tanto quanto si poteva prestare a imprese o giochi sportivi: a dire il vero con risultati non molto brillanti. Comunque era tacitamente ammesso che né io né lui sapessimo montare una tenda. Nonostante le molte diversità, scientifiche e caratteriali, per molti «passerete alla storia», per così dire, come «consoli» della storiografia veneta… È curioso, ogni volta che si esce dal Veneto questa associazione mentale che ci unisce è davvero frequente, perdura, anche se potrebbe dirsi interamente vera solo per alcune fasi. Tutto sommato c’è un «noi» fino all’84 e molto meno dopo. Una ragione è che quando Lanaro ha portato a termine la grande avventura scientifica ed editoriale del Veneto Einaudi, Emilio Franzina propone di fare assieme la rivista «Venetica», che dovrà coltivare analiticamente lo stesso campo. Silvio decide allora che ne sa abbastanza del Veneto: non gliene importa più prioritariamente, l’essenziale è stato detto, le sue vele si devono gonfiare di altri venti. E ci lascia a coltivare le sfumature, le «piccole russie» cittadine o della Bassa: Emilio con La classe, gli uomini e i partiti, io col mio indotto di «storici selvaggi», cioè di studiosi non accademici che incrocio via via. In ogni caso è stata una bella diarchia. A lungo abbiamo proceduto assieme, pur nella consapevolezza di essere diversi. Un simile «reciproco sapersi» avrebbe potuto rompersi in tante occasioni. Non è accaduto: la diversità alla fine ci ha uniti e questo forse è il segno di una vera amicizia. 265 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 266 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 267 PENSARE LA NAZIONE Indice dei nomi Accati, Luisa, 14n Adagio, Carmelo, 113n Adorno, Theodor W., 229, 231 Agnelli, Gianni, 204 Agostini, Tiziana, 13n, 26n Agrati, Carlo, 11n Agulhon, Maurice, 3n, 159 e n Aizpuru, Luis, 116 Alba Bonifaz, Santiago, 118 Albanese, Antonio, 204 Albanese, Giulia, 121n, 136n Albertini, Luigi, 127 Alfieri, Gabriella, 23n Alfonso XIII, re di Spagna, 113 e n, 114, 118n, 119 e n, 121 e n Allart, Hortense, 13 Almagià, Roberto, 146 e n, 147n Amadori-Virgilj, Giovanni, 29 e n-32 e n, 34 e n-36 e n, 37, 38 e n, 39, 41 e n, 42 e n, 44 e n, 45 e n, 46, 47 Amato, Giuliano, 131n Ambrosini, Federica, 239 Anastasia, Bruno, 247 Angioni, Napoleone, 24n Annoni, Carlo, 59n Anselmi, Sergio, 190n Antonetti, Nicola, 87n Aquarone, Alberto, 121n, 177n, 180n, 243 Arcomano, Arturo, 138n, 140n Ardigò, Roberto, 30 Arendt, Hannah, 129n Arfè, Gaetano, 243 Arisi Rota, Arianna, 56n Aristarco, Guido, 229 Arthur, Jean, 169 Asor Rosa, Alberto, 229, 232 Aubert, Louis, 170 Audisio, Guglielmo, 23n Augello, Massimo Mario, 80n, 90n Avesani, avvocato, 10 Aymard, Maurice, 190n Bachofen, Johann Jakob, 98 Bade, Klaus, 64n Badoglio, Pietro, 124, 127 Bagnasco, Arnaldo, 247 Baldi, Rita, 105n Balduino, Armando, 218, 253 Balleydier, Alfonso, 23n Ballini, Pier Luigi, 86n Bandini, Fernando, 255 Banks, David L., 153n Banti, Alberto Mario, 11n-13n, 17n Barbagallo, Francesco, 79n Barbaini, Piero, 25n Barbero, Maria Inés, 66n Barnabà, Marco, 66n Barolini, Antonio, 73n Barone, Giuseppe, 138n Barros, James, 114n Bassi, Ugo, 22-4 Basso, Lelio, 230 Battaglini, Mario, 19n Battini, Michele, 105n Bayly, Christopher Alan, 63n, 155 e n Beckett, Samuel, 229 Bell, David A., 17n Bell, Whintorp, 109n Belleme, René, 41 e n Ben-Ami, Shlomo, 117n-119n Benda, Julien, 108 e n, 109 Benedetto da Forano, 25 Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa), papa, 97 Beneduce, Alberto, 180 Benjamin, Walter, 229 Bennett, Constance, 169 Benni, Rodolfo, 249 Berchet, Giovanni, 11 e n Berengo, Marino, 71, 239, 245, 251, 262 Beretta Curi, Alcides, 66n Bergson, Henri, 95 Berlinguer, Enrico, 198, 255 Berlusconi, Silvio, 203, 205, 201, 221 Bernardello, Adolfo, 8n, 9n, 14n, 51n Bertelli, Sergio, 44n Berti, Giampietro, 53n Bertolotti, Maurizio, 59n Beseghi, Umberto, 22n-24n Bevilacqua, Felicita, 13, 14n Bevilacqua, Piero, 189, 190n, 194n Biagi, Enzo, 167 e n Biagini, Eugenio F., 63n 267 Bianchini, Guido, 241 Bianco, Gino, 130n Bin Laden, Osama, 35, 36 Biondi, Luigi, 66n Birelli, Diego, 258 Bistarelli, Agostino, 51n, 62n Blengino, Vanni, 51n Bloch, Marc, 234, 243 Blumenthal, Carlo, 4n Bo, Carlo, 202 Bobbio, Norberto, 102n, 205 e n, 242 e n Bocca, Giorgio, 200 e n Bodio, Luigi, 91n Boito, Camillo, 4 Bonini, Francesco, 198n Bortoluzzi, Fabio, 5n Bosa, Eugenio, 5n Bosio, Gianni, 230 Bourdieu, Pierre, 45, 46n Bracher, Karl D., 93n Braudel, Fernand, 155 e n Brecht, Bertolt, 228, 230 Bresciani, Marco, 130n Brice, Catherine, 80n Briggs, Asa, 156n Brissot, Jacques Pierre, 39 Brunello, Piero, 5n, 12n, 14n, 60n, 194 e n, 242, 251, 257, 262 Brunetta, Renato, 73, 246 Bruyère-Ostells, Walter, 63n Buber, Martin, 96 Buongiorno, Antonino, 138 e n, 144n Burchardt, Jeremy, 98, 136n, 148n Burguière, André, 213n Burke, Peter, 21n, 156n Bush, George W., 34 Busino, Giovanni, 102n Byron, George Gordon Noel, 61 Cacciari, Massimo, 221, 232, 246, 259 Cafagna, Luciano, 246 Caffi, Ippolito, 12, 132 Caffiero, Marina, 17n Cagnetta, Mariella, 144n Caldiron, Orio, 218, 259 Caldognetto, Maria Luisa, 66n Caleffi, Piero, 225 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 268 Pensare la nazione Calogero, Pietro, 242 Calvi, Pier Fortunato, 51 Camaiani, Pier Giorgio, 79n Cammarano, Fulvio, 80n, 82n, 84n, 88n Camon, Ferdinando, 237 e n Campigli, Massimo, 236 Camploy, Giuseppe, 4n Camurri, Renato, 13n, 55n, 80n, 81n Camus, Albert, 129n, 130 Candeloro, Giorgio, 243, 244 Candido, Salvatore, 62, 62n Cannistraro, Philip V., 66n Cantù, Cesare, 84 Cappelletti, Vincenzo, 138n Capponi, Gino, 84 Caracciolo, Alberto, 190n Carboni, Raffaello, 57 e n Cardini, Antonio, 86n Carli, Filippo, 178, 211, 249 Carmignano di Brenta, Arturo, 20n Carocci, Giampiero, 244 Carpi, Leone, 54, 178 Carr, Edward G., 234 Carrà, Raffaella, 200 Cartesio (René Descartes), 44 Caruso, Sergio, 98n Casellato, Alessandro, 5n Casetti, Francesco, 167n Cassola, Arnold, 23n Castellazzo, Luigi, 57, 58 Castellini, Gualtiero, 212 Castronovo, Valerio, 190n Cattaneo, Carlo, 185, 209 Cavallera, Hervé A., 96n Cavour, Camillo Benso, conte di, 51, 52, 87 Ceccarelli, Paolo, 236 Cecchinato, Eva, 12n, 51n Cerasi, Laura, XIn Ceschin, Daniele, 12n Cessi, Roberto, 238, 257 Chabod, Federico, 234, 244 Chartier, Roger, 90 e n Chase, Myrna, 105n Chateaubriand, François-René de, 61 Cheney, Dick, 36 Chiaramonte, José Carlos, 63 Chiaromonte, Nicola, 123n, 129 e n, 130 e n, 132, 133 Chinello, Ivone (Cesco), 262 Chiodi, Giovanni, 5n Chiurlotto, Vania, 259 Chomsky, Noam, 34 e n, 35 e n Christo Filho, Homem, 112 Ciampini, Raffaele, 13n Ciasca, Raffaele, 136, 139 e n, 140 e n, 142, 143 e n, 146 e n Cicconi, Michelangelo, 18 Cicogna, Giovanni, 52n Cimone, 43 Cini, Vittorio, 247 Cipolla, Costantino, 58n Clark, John, 158n Clerici, Naila, 61n Cocteau, Jean, 170n Codazzi, Agostino, 63n Cofrancesco, Dino, 105n Cohen, Arthur A., 96n Colajanni, Napoleone, 178 Colbert, Claudette, 169 Coletti, Ferdinando, 61 Colletta, Pietro, 19 e n Collotti, Enzo, 114n, 115n Colombini, Umberto, 165 e n Colombo, Furio, 204 Colombo, Paolo, 121n Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marchese di, 33 e n, 40, 132 Conte, Domenico, 97n-99n Cooper, James Fenimore, 61n Corazzol, Gigi, 239, 251 Corboli, Costanza, 26n Corradini, Enrico, 212 Correnti, Cesare, 53 Corti, Paola, 64n Covino, Renato, 190n Covino, Sandra, 26n Cozzi, Gaetano, 250, 251, 257 Crainz, Guido, XI, 199n Craveri, Piero, 106n, 198 Crawford, Joan, 169 Craxi, Bettino, 203-5, 220 Cremona, Agnese, 13n Crispi, Francesco, 212 Cristin, Renato, 94n Croce, Benedetto, 62, 94 e n, 100 e n, 131n, 177 Crotti, Ilaria, 81n Cuneo, Giovan Battista, 62, 63n Curi, Umberto, XI Curia, Beatriz, 67n D’Alema, Massimo, 209, 263 d’Alembert, Jean-Baptiste Le Rond, 135 D’Alessandro, Alessandro, 140n, 141n Dalluscheck, Giuseppe, 53n Dalmedico, Angelo, 6n Danelon, Fabio, 13n D’Annunzio, Gabriele, 95, 208 D’Antone, Leandra, 138n Dean, Priscilla, 161 De Berti, Raffaele, 167 e n De Clementi, Andreina, 194n De Felice, Renzo, 67n, 177 e n, 178, 234, 243 268 De Fort, Ester, 51n De Gasperi, Alcide, 205 De Giorgi, Alessandro, 53n De Grazia, Victoria, 121n, 144 e n DeLeon, Daniel, 132 Del Fabbro, René, 66n de’ Liguori, Alfonso Maria, 21 Della Peruta, Franco, 56n, 59n Della Porta, Donatella, 158 Del Re, Alisa, 241 De Luca, Iginio, 60n De Luna, Giovanni, 199 e n, 200 en De Marco, Maurizio, 262 De Marco, Michele, 63 De Marinis, Errico, 31 e n De Michelis, Cesare, 56 e n, 57, 59, 71, 233, 236, 262 De Michelis, Gianni, 236, 255, 262 De Nicola, Francesco, 73n De Rosa, Gabriele, 233, 234, 243, 249, 256 Derla, Luigi, 54n Derosas, Renzo, 9n Deschamps, Benedicte, 66n De Stefani, Alberto, 178 Detti, Tommaso, 160n Devoto, Fernando J., 66n Dicke, Ursula, 46n Di Crollanza, Araldo, 147n Diderot, Denis, 132, 135 Dietrich, Marlene, 169 Di Nolfo, Ennio, 114n, 115n Di Rienzo, Eugenio, 79n di Rudio, Carlo Camillo, 57 Di Siena, Giuseppe, 236 Di Simone, Maria Rosa, 198n Dogliani, Patrizia, 137n Donolo, Carlo, 204 e n Donzelli, Carmine, IX Dore, Grazia, 70 Dorigo, Wladimiro, 248, 258 d’Orsi, Angelo, 79n Dorso, Guido, 177 Durante, Francesco, 75n Durkheim, Émile, 30, 95 Duval, Jules, 53 Eden, Robert Anthony, 124 Einaudi, Giulio, 183 Einaudi, Luigi, 208, 249 Éluard, Paul, 230 Espadas Burgos, Manuel, 119n Fabre, Daniel, 9n Faccioli, Luigi, 58 Fairbanks, Douglas, 161 Fantoni, Gabriele, 14n Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 269 Indice dei nomi Farini, Luigi Carlo, 25n Fasulo, Franco, 239 Favero, Luigi, 67n Fedel, Giorgio, 19n Felisari, Giulio, 236 Fellini, Federico, 166 Ferrara, Giuliano, 204 Ferrari Bravo, Luciano, 241, 264 Ferrero, Guglielmo, 102, 103 e n, 104n, 105 e n Ferro, António, 112 Fileni, Enrico, 138 e n, 139n, 144 e n, 147 e n Filippini, Nadia Maria, 5n, 12n, 14n Filippo II, re di Spagna, 155 Finley, Moses I., 53n Florenzano, Giovanni, 54 Foa, Vittorio, 230 Fogazzaro, Antonio, 193, 254, 256, 257 Folena, Gianfranco, 75, 255 Fonseca Pimentel, Eleonora de, 19, 21 Fontana, Giovanni Luigi, XII, 55n, 80n Fonzi, Fausto, 234 Formigoni, Guido, 18n Fortini, Franco, 229, 230, 232 Foscarini, Iacopo Vincenzo, 6n Foucault, Michel, 45, 211, 213 e n Fourier, Charles, 132 Francia, Enrico, 15n, 17n Franzina, Emilio, XI, XII, 52n, 54n, 63n, 64n, 67n-69n, 75n, 80n, 81n, 84, 194 e n, 242, 245, 257, 261, 262, 265 Fraumeni, Barbara M., 153n Freda, Franco, 220 Freud, Sigmund, 95, 96 e n Fried, Alfred, 43 e n Fröbel, Friedrich, 42n Fruci, Gian Luca, 20 e n Fulcher, Jane F., 12n Fumian, Carlo, 137n, 193 e n, 257 Fusinato, Arnaldo, 52n, 54n, 61 e n Fusinato, Clemente, 61 Gabaccia, Donna, 64n, 66n Gaber, Giorgio, 200 e n Gable, Clark, 169 Gaggia, Achille, 247 Galante Garrone, Alessandro, 131n Gallerano, Nicola, 201 e n, 235 Gallo, Giampaolo, 190n Gallo, Stefano, 64n Gambasin, Angelo, 234 Ganapini, Luigi, 235, 244 Gangale, Giuseppe, 130 Garbo, Greta, 169 García Prieto, Manuel, 115, 117 Garibaldi, Giovanni, 57 Garibaldi, Giuseppe, 62 Garnier, Joseph, 53 Gasparri, Pietro, 113n, 114 Gattei, Teresa, 11n Gaumont, Léon, 170 Gavazzi, Alessandro, 19, 22-6 Gayda, Virginio, 146 e n, 147 e n Gazzetta, Liviana, 14n Gemelli, Giuliana, 159n Gemma, Antonio Maria, 60 Gencarelli, Elvira, 235 Gentile, Giovanni, 95, 96 e n, 135, 136n Gentiloni Silveri, Umberto, 198n George, Stefan, 95 Gerratana, Valentino, 236 Gerschenkron, Alexander, 246 Gerstlé, Jacques, 19n Gessi, Romolo, 211 Ghimire, Kléber Bertrand, 158n Ghiotto, Renato, 73n Ghiotto, Renzo, 73n Giacometti, Franco, 258 Giacopini, Vittorio, 130n Giannini, Achille Donato, 138 e n, 144n Giarrizzo, Giuseppe, 190n Gilpin, Robert, 154n Gini, Corrado, 178 Ginsborg, Paul, 9n, 12n, 17n, 200, 252, 263 Ginzburg, Carlo, 187n Gioia, Melchiorre, 53, 209 Gioia, Vitantonio, 80n Gioli, Gabriella, 90 e n Giolitti, Antonio, 131n Giolitti, Giovanni, 106 Giordano, Fedora, 61n Gish, Lillian, 161 Giuntella, Vittorio Emanuele, 18n Giuriati, Giovanni, 141 Giuriolo Antonio (Toni), 254 Gobetti, Piero, 131n, 177, 226 Godwin, William, 132 Goldwyn, Samuel, 171 Gómez Navarro, José Luis, 113n González Calbet, Maria Teresa, 115n-119n González Calleja, Eduardo, 119n Gorra, Marcella, 59n, 60n Gottardi, Gino, 164 Gottardi, Michele, 51n Gozzini, Giovanni, 53n, 152n Gramellini, Massimo, 201 Gramsci, Antonio, 112 e n, 122, 177, 218, 223, 228, 236 269 Grassi Orsini, Fabio, 106n Green, Anna, 213n Grimaldi, Gabriele, 59n Grossman, Zoltán, 34n Guerci, Luciano, 20n, 21n Guevara, Ernesto Che, 237 Guidi, Marco Enrico Luigi, 80n, 90n Guidorizzi, Mario, 167 e n Gurvitch, Georges, 159 Gutiérrez-Ravé, José, 113n, 121n Halévy, Daniel, 100 e n Halévy, Élie, 105 e n, 106 e n Hall, Morgan C., 118n Hampden Jackson, John, 132 Harlow, Jean, 169 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 99 Herder, Johann Gottfried, 40, 98 Herzen, Alexander, 132 Heywood, Paul, 118n Hitler, Adolf, 124 Hobsbawm, Eric J., 148n Hobson, John Atkinson, 37, 38 en Hopkins, Antony G., 155n Howells, William Dean, 4 e n, 13 en Hughes, Henry Stuart, 102n Huizinga, Johan, 107 e n Hunt, Lynn, 213n Hussein, Saddam, 36 Husserl, Edmund, 94n, 108, 109 e n, 110 e n Illuminati, Augusto, 236 Ionesco, Eugène, 229, 230 Isabella, Maurizio, 51n Isnenghi, Mario, IX, X, 5n, 12n, 51n, 71-4, 75n, 95n, 136n, 177n, 189, 190, 193-5, 218, 219-21, 236, 245, 251 Jackson, Robert, 34 Jahier, Piero, 258 James, William, 31 e n, 45 Jannacci, Enzo, 250 Jarvie, Ian, 171n Jemolo, Arturo Carlo, 234 Johnson, Karen H., 154n Jones, Ernest, 96n Joyce, James, 229 Judt, Tony, 203 e n Jünger, Ernst, 95 Kant, Immanuel, 44 e n King, Martin Luther, 237 Körner, Theodor Franz, 9n Koselleck, Reinhart, 156 e n Kropotkin, Pëtr Alexeevič, 132 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 270 Pensare la nazione Labriola, Arturo, 178 La Farina, Giuseppe, 51 La Fayette, Gilbert du Motier de, 39 La Marmora, Alfonso, 51 La Masa, Giuseppe, 13, 14 e n Lambruschini, Raffaello, 84 Lampertico, Fedele, 54, 55 e n, 77, 78, 80-2, 83 e n, 84 e n, 85 e n, 86-9, 90 e n, 91, 249, 254 Lanaro, Giovanna, 238, 246, 258, 259 Lanaro, Nicola, 249, 258 Lanaro, Paolo, 249, 254 Lanaro, Silvio, IX-XI, XIIn, 29 e n, 30, 31 e n, 32, 43 e n, 55n, 70 e n, 71, 72 e n, 74, 77 e n, 78 e n, 79n, 84 e n, 111 e n, 121n, 129, 133, 135n, 136n, 144 e n, 148n, 151 e n, 175 e n, 177, 179 e n, 180 e n, 181, 189, 190 e n, 191, 192n, 193-5, 197 e n-201 e n, 202, 207 e n, 208 e n, 209, 210, 211 e n, 212-4, 217, 219-23, 233-6, 237 e n, 238-42, 245-65 Lanaro, Ugo, 258 Lanciotti, Maria Elvira, 87n, 89n Lane, Richard D., 45n Larrington, Carolyne, 45n Lauricella, Giuseppe, 151n, 160n Le Bon, Gustave, 30 e n, 31 e n Lecomte, Jules François, 4n Legnani, Massimo, 235 Legoyt, Alfred, 53 Leoni, Carlo, 19n, 25 e n Leopoldo II, re del Belgio, 37 Lepore, Ettore, 53n Lepre, Aurelio, 252 Lepscky Mueller, Maria Laura, 10n Leso, Erasmo, 19n Levi, Giovanni, 9n, 187 Levi, Primo, 225 Levis Sullam, Simon, 51n Librandi, Rita, 18n Licandro, Agatino, 204n Lioy, Paolo, 81 Lombardi, Riccardo, 230 Longo, Oddone, 242 Lorenzon, Erika, 131n Loria, Achille, 178 Lorini, Giuseppe, 25, 26 Losurdo, Domenico, 96n, 110n Löwith, Karl, 40 e n Loy, Mirna, 169 Lucassen, Jan, 64n Lucassen, Leo, 64n Luconi, Stefano, 65n Lukács, György, 229 Luperini, Romano, 236 Lupo, Salvatore, IX, 190n Lutyens, Mary, 3n Luxemburg, Rosa, 132 Luzio, Alessandro, 58 Luzón, Javier Moreno, 113n, 119n Luzzatti, Luigi, 81, 85, 87 Luzzatto, Sergio, 121n Lyttelton, Adrian, 177n Macchioro, Aurelio, 247 e n Macdonald, Dwight, 123n, 129n, 132 MacDonald, Jeanette, 169 Machiavelli, Niccolò, 102 Mack Smith, Denis, 244 Macry, Paolo, 190n Maestri, Pietro, 53 Maeztu, Ramiro de, 112 Magalhaes Godinho, Vitorino, 37n Magri, Attilio, 60n Maier, Charles, 180 e n Malatesta, Maria, 3n, 159n Malavasi, Stefania, 239 Malraux, André, 130 Maltone, Carmela, 66n Manacorda, Gastone, 244 Mangoni, Luisa, 177n Manin, Daniele, 10, 51 Manin, Emilia, 10 Manin, Giorgio, 10 Mann, Thomas, 95, 96n Mantegazza, Paolo, 60 Manz, Peter, 66n Manzotti, Fernando, 70 Maometto II, 49 Marasti, Fabrizio, 137n Marazzi, Martino, 75n Marchionne, Sergio, 67 Marco, Costantino, 94n, 106n Marcus, George E., 45n Mariani, Riccardo, 147n Marinelli, Augusto, 137n Marinetti, Filippo Tommaso, 95 Marpicati, Arturo, 147 e n Marrou, Henry I., 234 Marsden, Christopher T., 154 e n, 158 e n Martel, Fréderic, 162 e n, 163 Martelli, Sebastiano, 75n Martinelli, Vittorio, 161 e n, 167 e n Martínez Garrido, Elisa, 23n Martini, Arturo, 236 Martini, Ferdinando, 25n Marx, fratelli, 169 Marx, Karl, 229 Marzari, Carlo, 5n Marzotto, famiglia, 193 Masella, Luigi, 190n 270 Massariello Merzagora, Giovanna, 69n Matteotti, Matteo, 226, 227 Mazzariol, Giuseppe (Bepi), 238 Mazzini, Giuseppe, 50, 62, 63n Mazzini, Maria, 23 Mazzoldi, Luigi, 59 Mazzoleni, Gianpietro, 19n Mazzonis, Filippo, 198n McAdams, Dan P., 46n McLuhan, Marshall, 18 Mead, George Herbert, 45 e n Meda, Ambra, 75n Meda, Juri, 57n Melis, Antonio, 236 Meneghello, Luigi, 72, 73 e n, 254, 257 Mengaldo, Pier Vincenzo, 253 Menolfi, Ernest, 66n Menozzi, Daniele, 18n, 27n Merivale, Herman, 53 Merli, Stefano, 70 Merzario, Raul, 64n Messedaglia, Angelo, 85 Messori, Marcello, 247 Miccoli, Giovanni, 251 Michelet, Jules, 39n, 40n Militello, Giacinto, 255 Milza, Pierre, 66n Minghetti, Marco, 53, 87 Mira, Giovanni, 243 Missiroli, Mario, 208 Moïsi, Dominque, 32 e n, 33 e n Molmenti, Pompeo Marino, 12 Molon, Francesco, 82 Monsagrati, Giuseppe, 55n Monti, Osvaldo, 61 Monticone, Alberto, 136n Morandi, Elia, 69 e n Morandi, Luigi, 10n Morelli, Anne, 66n Moreno Luzón, Javier, 113n Moretti, Piero, 198n Mori, Giorgio, 190n Moro, Aldo, 197, 198 e n, 202, 233 Moro, Renato, 198n Morris, Charles W., 45n Mortara, Giorgio, 249 Mosca, Gaetano, 81 e n Moscati, Ruggero, 114n Mosse, George L., 9n, 13n Mugnaini, Marco, 113n Mulas, Antonia, 193 e n Musatti, Cesare, 96n Mussolini, Benito, 112, 114, 119 e n-121 e n, 122, 124-7, 131, 144, 147n, 177, 208, 243, 261 Mutterle, Anco Marzio, 253, 259 Myers, Jorge, 63 e n Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 271 Indice dei nomi Nadel, Lynn, 45n Naím, Moisés, 155 e n Nani, Michele, XIn Nanni, Paolo, 137n Napoleone III, imperatore, 50 Nardi, Francesco, 53n Negri, Toni (Antonio), 220, 232, 236, 241, 264 Nenni, Pietro, 204 Nicolini, Fausto, 143 e n Nietzsche, Friedrich, 99 Nievo, Ippolito, 50 e n, 52 e n, 53n, 54 e n, 55, 56 e n, 57 e n, 58, 59 e n, 60 e n, 61 e n, 62, 67, 75 e n Nisbet, Robert, 97n Nitti, Francesco Saverio, 106 e n, 107 e n Nolte, Ernst, 94n Nono, Luigi, 221 Novalis (Friedrich von Hardenberg), 40 e n, 42, 47 Nützenadel, Alexander, 136n Obama, Barack, 33 e n, 34, 36n, 37 e n, 158 Occhetto, Achille, 221 O’Connel, Daniel, 26 Ohmae, Kenichi, 151n Olivieri, Achille, 62, 239 Olivieri, Silvino, 57 e n Olivieri, Ugo M., 59n Omodeo, Adolfo, 11n Omodeo, Angelo, 147n Onufrio, Salvatore, 100n Opocher, Enrico, 234 Ornaghi, Lorenzo, 198 e n, 199n O’Rourke, Kevin H., 152n Orsina, Giovanni, 72n Orsini, Felice, 50 Ortega y Gasset, José, 111 e n, 122 Ortes, Giammaria, 84 Paccagnini, Ermanno, 59n Paine, Thomas, 132 Paladini, Giannantonio, 255 Palidda, Salvatore, 53n Palomares Lerma, Gustavo, 113n, 119n Pannwitz, Rudolf, 94 e n Pantaleoni, Maffeo, 71, 178 Panzieri, Raniero, 230 Paoletti, Gianni, 73n Paolucci di Calboli, Giacomo, 119n-121n Papafava, Francesco, 71 Pareto, Vilfredo, 44 e n, 70, 71, 101, 102n, 249 Parise, Goffredo, 73n Parri, Ferruccio, 235 Parsi, Vittorio Emanuele, 199n Pasini, Valentino, 83 Quagliariello, Gaetano, 72n, 82n, 105n Quaglietti, Lorenzo, 167 e n Quaranta, Mario, 218 Quazza, Romolo, 26n Quiroga, Alejandro, 116n, 118n Reberschak, Maurizio, 245, 246, 257, 262 Recchia, Stefano, 63n Renan, Ernest, 263 Renzi, Lorenzo, 218, 253, 259 Resnais, Alain, 225 Revel, Jacques, 213 e n Rezzaghi, Albany, 58n Riall, Lucy, 13n Riccardi, Andrea, 198 Ridolfi, Maurizio, 79n Ridolini (Larry, Semon), 161 Rigoni Stern, Mario, 72, 73 e n Riondato, Ezio, 242 Rizzo Pagnin, Gigetta, 258 Robespierre, Maximilien, 39 e n, 40 Rocco, Alfredo, 249, 261 Rodríguez Fierro, Mercedes, 23n Romagnoli, Sergio, 52n Romano, Ruggiero, 79n, 183 Romeo, Rosario, 176, 234, 246 Romero Salvadó, Francisco J., 115n Roosevelt, Theodore, 35 e n Rosa, Mario, 21n, 27n Rosenzweig, Roy, 152n Rosoli, Gianfausto, 67n Rosselli, Carlo, 226 Rosselli, Nello, 226 Rossi, Alessandro, 70, 86, 193, 207, 211, 249, 254, 260 Rossi, Marina, 167 e n Rossi, Mario G., 244, 249 Rossi, Pietro, 98n, 99n Rossi-Landi, Ferruccio, 236, 259 Rosso, Giacomo, 194 Roszkowski, Wojciech, 148n Rota, Ettore, 21n Roth, Gerhard, 46n Rousseau, Jean-Jacques, 40, 98 Roverato, Giorgio, 193 e n, 257 Roversi, Roberto, 260 Rubattino, Raffaele, 52 Ruffilli, Roberto, 79n, 80n Rullani, Enzo, 246, 247 Rumor, Mariano, 254 Rumor, Sebastiano, 84n Rumsfeld, Donald, 36 Rusconi, Roberto, 18n, 21n Ruskin, Effie, 3n, 4 e n, 5 e n, 6n Ruskin, John, 4 Ryan, Johnny, 157n, 158 e n Ragionieri, Ernesto, 79n, 235, 244, 249 Rantanen, Terhi, 156n Ratti, Anna Maria, 141, 145 e n Ratzinger, Georg, 240 Ratzinger, Joseph, 240 Sabbatini, Mario, 72, 236, 259 Sacchi, Filippo, 119n, 122n Said, Yasmin H., 153n Saint-Simon, Claude Henri, conte di, 132 Saitta, Armando, 70 Pasolini, Pier Paolo, 228, 237 Passolunghi, Pier Angelo, 55n, 81n Patat, Alejandro, 60n, 61n, 62n Péguy, Charles, 95 Pelini, Fabio, 72n Pellegrinon, Bepi, 71 Pericle, 43 Perkins, Mary Anne, 17n Pestriniero, Renato, 4n Petri, Rolf, 42n-44n Petter, Guido, 242 Petternella, Mirko, 238 Pickford, Mary, 161 Pintor, Giaime, 131, 219 Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti), papa, 26 Pio XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti), papa, 113 Piovene, Guido, 226 Piretti, Maria Serena, 79n Pisacane, Carlo, 14, 15n, 50, 60 Pittaluga, Mary, 12n Pividor, Giovanni, 5n Pizzorusso, Giovanni, 64n Placanica, Augusto, 189, 190n Polato, Lorenzo, 253, 259 Pombeni, Paolo, 79n, 80n, 84 e n, 86n, 89n Ponti, Gio, 236 Ponziani, Luigi, 81n Pound, Ezra, 230 Povolo, Claudio, 5n Powell, William, 169 Pozza, Neri, 73n Pozzi, Giovanni, 26 Prat, Michel, 100n Pratolini, Vasco, 229 Pretelli, Matteo, 65n, 68n Preto, Paolo, 239 Priario, Luigi, 27 e n Primo de Rivera, Miguel, 112, 113n, 115, 116 e n-120 e n, 121, 122 Proudhon, Pierre-Joseph, 132 Pullé, Giulio, 6n Pullini, Giorgio, 257 271 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:54 Pagina 272 Pensare la nazione Sala, Roberto, 65 e n, 66 e n, 69 e n, 74 Salvati, Mariuccia, X Salinari, Carlo, 229 Salomoni, Filippo, 53n Salvatorelli, Luigi, 243 Salvemini, Biagio, 190n Salvemini, Gaetano, 177 Sambin, Paolo, 75, 248 Sanfilippo, Matteo, 57n, 63n, 64n, 74 Santarelli, Enzo, 112n, 243, 252 Santonastaso, Giuseppe, 103n Sari, Carmen, 81n Sarti, Maria Giovanna, 12n Savonarola, Girolamo, 25 Saz Campos, Ismael, 119n Sbordone, Giovanni, 12n Scabia, Giuliano, 218 Scafoglio, Domenico, 18n Scalfari, Eugenio, 202 Scavia, Giuseppe, 54 Schachermeyer, Fritz, 43 e n Scheidt, Eduardo, 63 e n Scheler, Max, 95, 96 e n Schiavoni, Natale, 11 Schlegel, Friedrich, 98 Schlosberg, David, 158n Schmitt, Jean-Claude, 9n Schopenhauer, Arthur, 98 Scialoja, Antonio, 90 Scolari, Saverio, 60 Scoppola, Pietro, 235, 252 Scotton, Andrea, 256 Scotton, Gottardo, 256 Scotton, Jacopo, 256 Scuderi, Gilberto, 61n Sebastiani, Chiara, 96n Secchi, Sandra, 239 Segneri, Paolo, 23 Seismit-Doda, Federico, 9 e n, 10, 11n Selassié, Hailé, 127 Seneca, Federico, 70, 71, 234, 235, 237-9, 242, 250, 257 Sensales, Alfredo, 55n, 80n, 89n Sereni, Emilio, 176 Serianni, Luca, 18n Sernagiotto, Luigi, 11n Serpieri, Arrigo, 136, 137, 142, 180 Serra, Michele, 202 Serri, Rino, 246 Settembrini, Domenico, 103n Shearer, Norma, 169 Shulman, Stuart, 158n Sighele, Scipio, 212 Silva, Nicola, 5n Simmel, Georg, 95, 96 e n Sinigaglia, Corrado, 109n Smith, Adam, 37 Sodini, Elena, 14n Sofri, Adriano, 255 Solitro, Giuseppe, 50n, 55n, 58n Sonnino, Giorgio Sidney, 208, 243 Sorba, Carlotta, 12n Sorel, Georges, 100 e n Sori, Ercole, 74 Souness, Howard, 203 e n Spacks, Patricia Meyer, 207n Spada, Giuseppe, 25n Spadolini, Giovanni, 233 Spengler, Oswald, 97, 98 e n, 99 e n Speri, Tito, 58 Spinedi, Franco, 146n Spini, Giorgio, 70 Spirito, Ugo, 138 e n, 180 Spriano, Paolo, 199, 234 e n, 243 Stampacchia, Mauro, 137n, 144n, 147n Stearns, Peter N., 152n Stefani, Gabriella, 239 Sturzo, Luigi, 177, 249 Sumner, Gregory D., 129n, 132n Tarquini, Alessandro, 136n Tarrow, Sidney, 158n Tassinari, Giuseppe, 140, 141n Taylor, Robert, 169 Tazzoli, Enrico, 58 Tedesco, João Carlos, 69n Tehan, Rita, 152n Tellini, Enrico, 114 Tenca, Carlo, 54 Termes, Josep, 115n Themundo, Nuno, 158n Thiesse, Anne-Marie, 42n Tilgher, Adriano, 100 e n, 101 Tinazzi, Giorgio, 236 Tirabassi, Maddalena, 68n Tocqueville, Alexis de, 132 Toews, John, 214 e n Toffanin, Giuseppe, 19n Togliatti, Palmiro, 204, 205, 236 Tolin, Francesco, 260 Tolomei, Gianpaolo, 53n Tolstoj, Lev Nicolaevič, 132 Tommaseo, Niccolò, 7 e n, 10 e n, 13 e n Torelli, Luigi, 52 Torre, Augusto, 114n Toscano, Mario A., 95n, 102n Tracy, Michael, 148n Tramontin, Silvio, 234 Traniello, Francesco, 18n Treccani, Giovanni, 135 Trifone, Pietro, 18n Trigilia, Carlo, 247 Tronti, Mario, 231 Tumiati, Gaetano, 131n Turi, Gabriele, 136n, 198n, 249 Tusell Gómez, Javier, 115n-117n, 119n 272 Ullrich, Hartmut, 82n Umberto II di Savoia, re d’Italia, 128 Ungari, Paolo, 180 Urbinati, Nadia, 63n Urquiza, Justo José de, 62 Urso, Simona, XIn Valenti, Ghino, 91n Valiani, Leo, 235, 243 Van Dyke, Woodbridge Strong, 168 Vangelista, Chiara, 52n, 67n Vanzetto, Livio, 245, 257, 262 Varano, Aldo, 204n Vecoli, Rudolph J., 66n Veneruso, Danilo, 105n Ventura, Angelo, 239, 242, 245 Ventura, Gioacchino, 26 Verdi, Giuseppe, 8 Vernassa, Maurizio, 180n Veronese, Domenica, 5n Vesce, Emilio, 240, 241 Viazzo, Pier Paolo, 64n Vico, Giambattista, 100, 102 Vieusseux, Giovan Pietro, 84 Villani, Pasquale, 190n Villari, Lucio, 107n Viola, Sandro, 200n, 205n Virgilio, Jacopo, 54 Vittoria Eugenia di Battenberg, regina di Spagna, 113 Vittorini, Elio, 229 Vittorio Emanuele III, re d’Italia, 113, 121, 211 Vivanti, Corrado, 183, 184 e n, 207n Vivarelli, Roberto, 106n Vollo, Giuseppe, 10 e n Volpe, Gioacchino, 64, 179 e n Volpi, Giuseppe, 247 Wakefield, Edward Gibbon, 53 Weber, Max, 84, 95, 96 e n, 243 Weil, Simone, 129n, 132 West, Mae, 169 White, Hayden, 156n Williamson, Jeffrey G., 152n Wilson, Thomas Woodrow, 100, 101 Wolowski, Louis, 53 Woolf, Stuart Joseph, 5n Zambelli, Barnaba, 53n Zanella, Giacomo, 54, 193 Zangheri, Renato, 249 Zavestoski, Stephen, 158n Zazzara, Gilda, 79n Zemon Davies, Natalie, 209 e n Zorzi, Elio, 5n Zweig, Stefan, 95 e n Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 273 PENSARE LA NAZIONE Gli autori Giulia Albanese è ricercatrice all’Università di Padova. Si è occupata di origini del fascismo, violenza politica e culture autoritarie. Attualmente lavora a un progetto sull’Europa mediterranea negli anni venti del Novecento. Tra le pubblicazioni: Alle origini del fascismo. La violenza politica a Venezia 1919-1922 (Il Poligrafo, 2001); La marcia su Roma (Laterza, 2006). Margherita Angelini svolge attività di ricerca presso il dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità dell’Università di Padova. È autrice del volume Fare storia. Culture e pratiche della ricerca in Italia da Gioacchino Volpe a Federico Chabod (Carocci, 2012) e di Transmitting Knowledge. The Professionalisation of Italian Historians (1920s-1950s) (Jaca Book, 2010). Giampietro Berti è professore di Storia contemporanea presso l’Università di Padova. Tra le principali pubblicazioni: Francesco Saverio Merlino. Dall’anarchismo socialista al socialismo liberale (1856-1930) (Franco Angeli, 1993); Storia di Bassano (Il Poligrafo, 1993); Il pensiero anarchico. Dal Settecento al Novecento (Lacaita, 1998); Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano e internazionale 1872-1932 (Franco Angeli, 2003); L’Università di Padova dal 1814 al 1850 (Antilia, 2011). Piero Brunello insegna Storia sociale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tra le sue pubblicazioni: Storie di anarchici e di spie. Polizia e politica nell’Italia liberale (Donzelli, 2009); Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-1866 (Cierre, 20112). Ha curato inoltre, di Anton Čechov, Senza trama e senza finale. 99 consigli di scrittura (minimum fax, 2002) e Scarpe buone e un quaderno di appunti. Come fare un reportage (minimum fax, 2004). Gian Piero Brunetta è professore emerito di Storia del cinema all’Università di Padova dove ha insegnato dal 1970. È stato visiting professor presso università americane e francesi. Tra le sue pubblicazioni: Storia del cinema italiano (Editori Riuniti, 1979-1982 e varie edizioni successive); Buio in sala (Marsilio, 1988); Cent’anni di cinema italiano (Laterza, 1991); Il viaggio dell’icononauta (Marsilio, 1998); Gli intellettuali italiani e il cinema (Marsilio, 2004). Ha curato la Storia del cinema mondiale (5 voll.) e il Dizionario dei registi del cinema mondiale (3 voll.) per Einaudi. Ha collaborato con «la Repubblica» e con riviste letterarie e cinematografiche italiane e straniere. Renato Camurri è professore associato di Storia contemporanea nella Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Verona. È stato visiting fellow presso varie istituzioni scientifiche e accademiche americane, tra cui Harvard University, ove ha a lungo soggiornato in varie occasioni. Tra i lavori più recenti si segnalano: il volume Franco Modigliani. L’Italia vista dall’America. Riflessioni e battaglie di un esule (Bollati Boringhieri, 2010) e il fascicolo del «Journal of Modern Italian Studies», 2010, 5, Mussolini’s Gifts. Exiles from Fascist Italy, di cui è stato curatore e autore. 273 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 274 Pensare la nazione Guido Crainz, nato a Udine, è docente di Storia contemporanea presso l’Università di Teramo. Fra le sue pubblicazioni: Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta (Donzelli, 1997); Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta (Donzelli, 2003); Il dolore e l’esilio. L’Istria e le memorie divise d’Europa (Donzelli, 2005); L’ombra della guerra. Il 1945, l’Italia (Donzelli, 2007); Autobiografia di una repubblica. Le radici dell’Italia attuale (Donzelli, 2009). Umberto Curi è professore emerito di Storia della Filosofia presso l’Università di Padova. Visiting professor presso le Università di Los Angeles (1977) e di Boston (1984), ha tenuto lezioni e conferenze presso numerose università europee e americane. Fra le sue pubblicazioni: Polemos. Filosofia come guerra e La forza dello sguardo (Bollati Boringhieri, 2000, 2004); Filosofia del Don Giovanni (Bruno Mondadori, 2002); Variazioni sul mito: Don Giovanni (Marsilio, 2005); Miti d’amore. Filosofia dell’eros (Bompiani, 2009); Via di qua. Imparare a morire (Bollati Boringhieri, 2012). Cesare De Michelis insegna Letteratura italiana moderna e contemporanea presso l’Università di Padova. È presidente della Marsilio Editori. Collabora con riviste e giornali e dirige «Studi Novecenteschi». È presidente dell’Edizione nazionale delle opere di Carlo Goldoni. Tra le numerose pubblicazioni ricordiamo: Goldoni nostro contemporaneo (Marsilio, 2008); Moderno Antimoderno. Studi novecenteschi (Aragno, 2010); Tra le carte di un editore (Marsilio, 2010). Tommaso Detti è professore di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Siena. Tra le sue pubblicazioni: Serrati e la fondazione del Pci (Editori Riuniti, 1972); Fabrizio Maffi. Vita di un medico socialista (Franco Angeli, 1987); Salute, società e Stato nell’Italia liberale (Franco Angeli, 1994). Insieme a Franco Andreucci ha curato Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico (5 voll., Editori Riuniti, 1975-79). È autore, con Giovanni Gozzini, di Storia contemporanea (2 voll., Bruno Mondadori, 2006-11). Carmine Donzelli è amministratore delegato e direttore editoriale della Donzelli editore. Enrico Francia è ricercatore di storia contemporanea presso l’Università di Padova. Si è occupato di stampa periodica nell’Ottocento, di milizie e corpi di polizia nel Risorgimento, e di clero e religione cattolica nel Risorgimento. Tra le sue recenti pubblicazioni, la curatela – insieme a Piero Del Negro – di Guerre e culture di guerra nella storia d’Italia (Unicopli, 2011), una raccolta antologica di testi dal titolo Il Risorgimento in armi. Guerra, eserciti e immaginari militari (Unicopli, 2012), ed è in corso di stampa presso il Mulino il volume 1848. La rivoluzione del Risorgimento. Emilio Franzina, studioso delle migrazioni internazionali e cultore a tempo pieno di public history, ha scritto molto su questi temi (La grande emigrazione Marsilio, 1976; Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti e friulani in America latina, 1876-1902, Feltrinelli, 1979; Gli italiani al nuovo mondo. L’emigrazione italiana in America, 1492-1942, Mondadori, 1995). Insegna Storia contemporanea e Storia e istituzioni delle Americhe nell’Università di Verona. Fra i suoi ultimi lavori: L’America gringa. Storie italiane d’immigrazione tra Argentina e Brasile (Diabasis, 2008); La parentesi. Società, popolazioni e Resistenza in Veneto, 1943-1945 (Cierre, 2009); Vicenza italiana (1848-1918). Intellettuali, notabili e popolo fra Risorgimento e prima guerra mondiale (Agorà & Factory, 2011). Mario Isnenghi è professore emerito di Storia contemporanea all’Università Ca’ Foscari di Venezia, presidente dell’Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e condirettore di «Belfagor». Ha pubblicato fra l’altro: Il mito della Grande guerra (Laterza, 1970), giunto alla sesta edizione (il Mulino, 2007); L’Italia in piazza (nuova ed. il Mulino, 2004); I luoghi 274 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Pagina 275 Gli autori della memoria (nuova ed. il Mulino, 2010); Garibaldi fu ferito. Il mito, le favole (Donzelli, 2008, 2010); Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento a oggi (Laterza, 2011); Dieci lezioni sull’Italia contemporanea (Donzelli, 2011); Breve storia d’Italia ad uso dei perplessi (e non) (Laterza, 2012). Simon Levis Sullam insegna Storia contemporanea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si occupa di storia italiana tra Ottocento e Novecento, storia degli ebrei e dell’antisemitismo. È autore, tra le ultime pubblicazioni, de L’apostolo a brandelli. L’eredità di Mazzini tra Risorgimento e fascismo (Laterza, 2010), e tra i curatori di Storia della Shoah (Utet, 2005-10). Salvatore Lupo è professore di Storia contemporanea presso l’Università di Palermo. È stato tra i fondatori della rivista «Meridiana», che attualmente dirige, ed è membro del comitato di redazione di «Storica». Tra le numerose pubblicazioni: Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri (Donzelli, 1993, 2004); Il fascismo. La politica in un regime totalitario (Donzelli, 2000, 2005); Che cos’è la mafia. Sciascia e Andreotti, l’antimafia e la politica (Donzelli, 2007); Quando la mafia trovò l’America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008 (Einaudi, 2008); Il passato del nostro presente. Il lungo Ottocento 1776-1913 (Laterza, 2010); L’unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile (Donzelli, 2011). Rolf Petri insegna Storia contemporanea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dopo aver conseguito il dottorato all’Istituto universitario europeo di Firenze e lavorato all’Istituto storico germanico di Roma nonché alle Università di Bielefeld e Halle. Dirige la Mediterranean Doctoral School in History e la Ca’ Foscari School of International Relations. Tra le sue pubblicazioni: Porti di frontiera. Industria e commercio a Trieste, Fiume e Pola tra le guerre mondiali (Viella, 2008); Storia economica d’Italia. Dal fascismo al miracolo economico (1918-1963) (il Mulino, 2002). Maurizio Reberschak è stato professore di Storia contemporanea presso le Università di Padova e di Venezia. Tra le principali pubblicazioni: Non-violenza e pacifismo (Franco Angeli, 1988); Il Grande Vajont (Longarone 1983; nuova ed. Cierre, 2008); Il Vajont dopo il Vajont (Marsilio, 2009); La Resistenza nel Veneziano (Istituto veneto per la storia della Resistenza, 1985); Venezia nel secondo dopoguerra (Il Poligrafo, 1993); La scoperta del cinema (Archivio storico Luce, 2002). Mariuccia Salvati è professore di Storia contemporanea presso il dipartimento di Discipline storiche, geografiche e antropologiche dell’Università di Bologna, condirettore del Comitato scientifico della Fondazione Basso e membro della direzione della rivista «Parolechiave». Tra le sue pubblicazioni: Il Regime e gli impiegati. La nazionalizzazione piccoloborghese nel ventennio fascista (Laterza, 1992); L’inutile salotto. L’abitazione piccolo-borghese nell’Italia fascista (Bollati Boringhieri, 1993); Cittadini e governanti. La leadership nella storia dell’Italia contemporanea (Laterza, 1997); Da Berlino a New York (Bruno Mondadori, 2000); Il Novecento. Interpretazioni e bilanci (Laterza, 2001). Carlotta Sorba è professore associato di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Padova. Tra le sue pubblicazioni: Il 1848 e la melodrammatizzazione della politica, in Storia d’Italia, Annali, 22, Il Risorgimento, a cura di A. M. Banti e P. Ginsborg (Einaudi, 2007); La legislazione comunale e provinciale (1861-2001), in Storia d’Italia nel secolo ventesimo. Strumenti e fonti, a cura di C. Pavone, I, Elementi strutturali (Guerini e associati, 2006). Gilda Zazzara svolge attività di ricerca presso il dipartimento di Studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove insegna a contratto Storia del lavoro e del movimento operaio. È autrice del volume La storia a sinistra. Ricerca e impegno politico dopo il fascismo (Laterza, 2011). 275 Lanaro_imp.qxp:Saggi_brossura_impos152X214.qxp 7-06-2012 13:22 Finito di stampare il 7 giugno 2012 per conto di Donzelli editore s.r.l. presso Str Press s.r.l. Via Carpi, 19 - 00040 Pomezia (Roma) Pagina 276
Scaricare