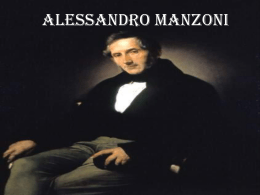EDIZIONE NAZIONALE ED EUROPEA DELLE OPERE DI ALESSANDRO MANZONI Estratto da: DISCORSO SOPRA ALCUNI PUNTI DELLA STORIA LONGOBARDICA IN ITALIA Premessa di Dario Mantovani A cura di Isabella Becherucci CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI MILANOΩ·Ω 2005 1. Il principe Adelchi. Dal Codex Legum Langobardorum. Capitularia Regum Francorum, sec. X-XI. Cava dei Tirreni (Salerno), Biblioteca del Monumento Nazionale. Le vocazioni del «Discorso» di Dario Mantovani S 1. celto Adelchi quale soggetto, Manzoni appoggiò la funzione poetica su una paziente e originale indagine storica della dominazione longobarda in Italia, di cui il Discorso è il documento, «notabile per finezza d’analisi e per grazia di esposizione», secondo il giudizio non invecchiato di De Sanctis. Il risultato cui giunse era opposto a quello allora più accreditato, che si leggeva negli Annali di Muratori ed era divulgato in Europa da Gibbon. Secondo Manzoni, lo stabilimento dei Longobardi in varie regioni d’Italia, dopo la calata di Alboino nel 568/569, non diede mai vita a un solo popolo, alla mistione di vincitori e vinti, di Longobardi e Romani (o Latini o Romanzi o Romanici o Italiani che dire si voglia) in una sola massa politica. La separazione su base etnica apriva, a sua volta, il varco a cupi interrogativi sulla condizione imposta agli indigeni. Per Manzoni, il silenzio improvvisamente calato sui vinti era il segnale della brutalità con cui era stato esercitato il diritto di conquista. Su questo sfondo, l’idea che i Romani fossero reclutati come arimanni nell’esercito longobardo gli appariva tanto lontana dal vero da poterla introdurre in poesia sotto forma di un generoso, ma improbabile piano escogitato da Adelchi per resistere ai Franchi, respinto da Desiderio appunto come «splendido sogno giovanil» (prima stesura, Atto i, sc. ii, v. 425, in Adelchi 1998, p. 34). Proprio in quanto parte «non ben legata all’azione, né storica» – come sentenzia una nota a margine dell’autografo – Manzoni si risolse poi ad espungere quest’utopica proposta persino dalla tragedia. Fu eliminata allo stesso modo la prima scena del quinto atto, in cui il disegno di aπrancare i Romani e trasformarli in «guerrier devoti» faceva un’altra comparsa, discusso quale estremo rimedio fra i Longobardi chiusi in Pavia assediata dall’esercito di Carlomagno, che ormai scorreva per la pianura padana, dopo la rotta delle Chiuse. Si delinea così, sotto specie di paradosso, un problema significativo. Stando alle risultanze dell’attuale storiografia sulla società ita- 6 dario mantovani liana in età longobarda, il disegno di Adelchi non era aπatto un sogno, anzi era da tempo realtà. Da un secolo almeno, fra i Romani e i Longobardi s’era compiuta – si aπerma oggi – una profonda acculturazione, e una fusione etnica, economica, giuridica. In particolare, quello che ad Adelchi stesso pareva un progetto fin troppo azzardato e a Manzoni, infine, un fuor d’opera, immaginare cioè di rivestire d’armature i petti inermi dei Romani, arruolarli come arimanni nell’esercito longobardo, avveniva – a quanto pare – almeno dall’età di Liutprando, se non di Cuniperto, alla fine del secolo VII. Il Discorso aveva fra i suoi scopi quello di «giustificare lo spirito storico del dramma», anche allora, come s’è detto, opposto a quello che usciva «dalle più riputate storie moderne». Da questo punto di vista, il nesso indissolubile che lo stringe all’invenzione poetica garantisce al Discorso la medesima fortuna dell’Adelchi, del quale aiuterà sempre a comprendere la materia e l’idea; non a caso, anche in queste pagine alcune riflessioni saranno svolte su questo piano, che si potrebbe chiamare piano di scorrimento della tragedia sul Discorso. Lo scopo primario che il Discorso si prefiggeva, tuttavia, era un altro, rinnovare gli studi sull’alto Medioevo. L’obiettivo fu pienamente raggiunto. Pubblicata nel 1822, l’indagine manzoniana sui Longobardi fece divampare una vigorosa discussione politica e storiografica, in felice concomitanza con il rinnovamento romantico della storia giuridica, specialmente tedesca. Carlo Troya riconobbe che «Alessandro Manzoni fu il primo, e ne ottenne gran lode, che osò dubitare, falsi parendogli [i fondamenti della Storia d’Italia] e vana la speranza di trovare la vera nostra Storia, se non si mettesse prima in buon lume la condizione civile de’ vinti Romani». Resta oggi al Discorso solo questo pur onorevole primato? È stato superato dalle ricerche ch’esso stesso ha promosso – destino che non sarebbe comunque nemmeno troppo amaro, proprio perché invocato – dovendosi alla fine proclamare la vittoria della visione cui si opponeva? Ci pare, al contrario, che il Discorso non abbia esaurito la sua vocazione. Per mostrarlo, non occorre procedere alla disamina del le vocazioni del «discorso» 7 problema storico sottostante, per distribuire meriti e torti – come fece Fausto Nicolini che processò il Seicento dei Promessi sposi –, se non per quel tanto che è indispensabile a chi si proponga onestamente di fare storia degli studi. A ricevere attenzione saranno invece l’impianto argomentativo e l’impostazione dei problemi; lungo il filo dell’intertestualità, verranno ripercorse anche le relazioni privilegiate del Discorso con alcune opere della storiografia illuminista, in primo luogo di Montesquieu e Sismondi, che furono particolarmente presenti al Manzoni. Accennare ad alcuni punti di metodo del Discorso e mostrare quale contributo abbia oπerto e possa ancora dare alla corretta impostazione della questione longobarda, suggerire insomma quale sia l’attualità storiografica del Discorso, è lo scopo di quest’invito alla lettura. 2. L’accesso al Discorso non è immediato. Per entrare nel vivo, bisogna trascorrere per un primo capitolo ingombro d’erudizione, che fa parte a sé poiché oπre chiarimenti su alcuni argomenti controversi toccati nelle compatte, ma disadorne Notizie storiche, dove i fatti e gli antefatti rilevanti per la tragedia si trovano asseriti, ma non dimostrati, avendovi il Manzoni «preso il metodo aπermativo, come il più breve». È insomma un’appendice d’approfondimento, che, posta a vestibolo del Discorso, sembra quasi sconsigliare l’ingresso a chi non sia pronto a farsi carico di «tanta zavorra». Il vero esordio è il secondo capitolo. È da qui che si sperimenta la verità del giudizio desanctisiano (che, formulato a proposito della seconda edizione del 1847, quasi raddoppiata in lunghezza, s’attaglia anche meglio alla versione del 1822, a cui è consigliabile quindi accostarsi per prima, come a quella in cui la maggiore concentrazione mette più nitidamente in risalto le linee compositive): il Discorso è veramente scritto «con un brio e una naturalezza, una precisione e un andamento analitico che nel più schietto stampo italiano ricordano i modelli più stimati della prosa francese». Nondimeno, soprattutto se si è assorbiti dal tentativo di comprendere un’argomentazione tutt’altro che elementare e filologicamente disimpegnata, si può avere la sensazione che i capitoli si susseguano 8 dario mantovani piuttosto accostati che collegati. È una sensazione che non resiste a una rilettura attenta. La potenza persuasiva del Discorso, prima ancora d’essere alimentata dalla lettura radente dei documenti e dalla sagacia del giudizio, si sprigiona proprio dal ‘congegno’, ossia dalla scelta e dalla disposizione degli argomenti. Un unico filo si dipana, infatti, dal secondo al quinto capitolo (il sesto, su Carlomagno, potendosi invece considerare a sé stante). Il punto di partenza, come si sa, è l’opinione, rintracciata in Machiavelli (nell’edizione del 1847 viene scovato un antecedente anche nella Cronaca di Giovanni Villani) e, nel XVIII secolo, in Giannone, Muratori e Denina, che i Longobardi e i Romani si fossero uniti in un solo popolo. La critica mossa a quest’opinione era prima di tutto concettuale, perché Manzoni deplorava che le formule usate per significare questa fusione non avessero a fondamento, nella loro pur suggestiva genericità, criteri rigorosi. «Unità – osservava, con l’esigenza di precisione che aveva ereditato dagli ideologues – comprende senza dubbio l’identità del nome e delle leggi» e, in particolare, partecipazione di tutti i consociati al governo, senza distinzione di etnia. Si tratta, come si vede, di un’impostazione giuridica per eccellenza: il metro preciso, l’unico valido per stabilire se vi sia o meno unione di due popoli in uno solo è, per Manzoni, il diritto, anzi il diritto pubblico. Solo l’eguaglianza dei diritti politici consente di individuare un popolo in un gruppo stanziato su un medesimo territorio. È una concezione formale molto antica, la stessa, a ben vedere, che presiede alla definizione di libertà politica in Aristotele (che consiste «nell’essere governati e nel governare a turno») o che regge il mito stoico della città cosmica, cui partecipano tutti gli uomini in quanto dotati appunto d’una legge comune, che è poi la ragione («di conseguenza – conclude Marco Aurelio – siamo tutti concittadini; perciò siamo tutti partecipi di una forma di governo»). Tale è il rigore della definizione, che vi si sottomette anche la composizione poetica. Nei versi in cui Adelchi «al confine del perir», cioè in Pavia assediata, ripropone il suo disegno d’unione fra Longobardi e Romani, la coalizione prevede – e non è l’unico punto in cui il risultato dell’indagine storica filtra in poesia senza sbiadire le vocazioni del «discorso» 9 – non solo l’arruolamento dei Latini nell’esercito, ma anche l’ingresso nell’assemblea deliberante; si configura dunque precisamente come concessione dei diritti politici: «Ogni RomanoΩ/Ωche in nostro ajuto sorgerà, divengaΩ/Ωcome un di noi: sia suo: libero seggaΩ/Ωnel suo terren, nudra un cavallo, assistaΩ/Ωai consigli del popolo» (prima stesura, Atto v, sc. i, vv. 96-100, in Adelchi 1998, p. 147). Analogamente, il duca Guntigi, che vendutosi a Carlomagno s’oppone al disegno d’unione, ribatte con altrettanto scrupolo (vv. 141-5, p. 151): «sappi che priaΩ/Ωche ad un Romano io di fratello il nomeΩ/Ωdia, ch’io gli segga in parlamento al fiancoΩ/Ωvoglio morir per la sua man e sappiΩ/Ωche Longobardo io nacqui», versi in cui la progettata fusione (a superamento della separazione presente) è di nuovo rappresentata in termini giuridici, come compartecipazione alla funzione deliberativa, senza riguardo all’etnia. Una simile nozione dev’essere stata ispirata al poeta dai resoconti sull’assemblea elettorale documentata da Paolo Diacono, quella che diede il regno a Clefi, descritta con parole che non potrebbero più nettamente esprimere l’esclusivismo su base etnica: «Langobardi vero aput Italiam omnes communi consilio Cleph, nobilissimum de suis virum, in urbe Ticinensium sibi regem statuerunt» (Hist. Lang. 2.31). Posto il criterio, la verifica dei fatti procede rapida e implacabile. Cade qui la fatidica domanda, che Manzoni traeva probabilmente da Scipione Maπei (e che non a caso tornò in seguito a turbare il massimo indagatore dell’età longobarda nel secolo passato, Gian Piero Bognetti): «Si è mai citato, non dico fra i re, ma fra i duchi, fra i giudici, fra i gastaldi, fra i gasindj reg j, fra gli u√ziali di qualunque sorta del regno longobardico, il nome d’un personaggio latino?». Inquadrata in questa verifica, si capisce anche l’insistenza (che potrebbe altrimenti apparire formale) sull’appellativo dei re legislatori, che si proclamavano rex gentis Langobardorum (e non anche degli indigeni), e sulla partecipazione dei soli Longobardi alle assemblee che ricevevano per gairethinx le leggi. Sono appunto i segni della discriminante etnica quale regola di attribuzione dei diritti politici, fondata a sua volta sul diritto di conquista. 10 dario mantovani L’avere adottato il metro del diritto è stato rimproverato a Manzoni, come se egli si fosse servito d’una misura artificiosa e troppo rigida rispetto alla storia (che richiederebbe probabilmente il flessibile regolo di Lesbo, che già Aristotele raccomandava ai giudici). Forse, come si vedrà più avanti, è con qualche svantaggio, fra tanti progressi, che la medievistica più recente ha rinunciato, o quasi, a farne uso. 3. Dimostrato che conquistati e conquistatori non erano un solo popolo, è eliminata una formula che gettava «una maledizione di sterilità su tutta la storia del medio evo» (cap. ii), ossia impediva anche il solo porsi di alcuni interrogativi cruciali. Il principale – che è toccato nel medesimo secondo capitolo – è ovviamente quello (giuridico anch’esso) della condizione personale dei Romani, dal momento che non coincideva con quella degli arimanni. Questo problema è distinto dal precedente – se le due popolazioni formassero un unico popolo –, la cui risposta negativa ne è l’antecedente logico (semplificando, il primo quesito attiene al diritto pubblico, il secondo al diritto privato). La precisazione occorre, perché la discussione che infuriò nell’Ottocento, e tuttora non è placata, verte essenzialmente sulla condizione personale dei Romani (se schiavi dei Longobardi oppure liberi e, in quest’ultimo caso, secondo quale diritto regolassero i loro rapporti privati e punissero i delitti). In realtà, Manzoni si astenne quasi dal pronunciarsi sulla questione privatistica: è precisamente a questo punto, infatti, che formulò la famosa esortazione alla storia (in cui Vladimiro Arangio Ruiz ha colto l’eco dell’esortazione a liberare l’Italia dalle mani dei barbari che chiude il Principe di Machiavelli), prefiggendo a «qualche acuto ed insistente ingegno l’impresa di trovare la storia patria di quei secoli», ossia «le istituzioni e i costumi, […] lo stato generale delle nazioni». In particolare, non appartiene alla prima edizione del Discorso, quella uscita congiunta all’Adelchi nel 1822, un esame dei due (ora) controversissimi luoghi di Paolo Diacono (Hist. Lang. 2.32 e 3.16) condotto al fine di trarne notizia sulla condizione giuridica degli indigeni (se ridotti a schiavi o lasciati liberi, e sottoposti a quale forma di tributo o confisca). le vocazioni del «discorso» 11 Un’ampia discussione in questa prospettiva si trova, invece, nell’Appendice al capitolo iv della ristampa nelle Opere Varie, uscita venticinque anni più tardi. È la disamina delle interpretazioni avanzate dalla storiografia italiana successivamente alla prima edizione del Discorso, e per suo sprone, principalmente da Carlo Baudi di Vesme e Spirito Fossati, da Carlo Troya e da Gino Capponi. Manzoni, che in un primo tempo s’era astenuto dal pronunciarsi in termini positivi sulla questione della condizione personale degli indigeni, raccolse egli stesso la propria esortazione, fu attirato nella controversia dopo averla suscitata. La sua idea – diversa da quella d’ogni altro interprete – era che, all’indomani stesso della conquista, i Longobardi avessero imposto il tributo d’un terzo dei prodotti agricoli ai latifondisti. Durante il decennio di anarchia ducale, ne avrebbero poi confiscato i beni e uccisi molti, riducendo gli altri a schiavi (tributari). Il destino della restante popolazione, priva di beni e per lo più allo sbando, sarebbe stato infine deciso sotto il regno di Autari (584-590), durante il quale i Romani furono ripartiti sotto i Longobardi, con il dovere del mantenimento di questi hospites (insomma servi della gleba) sulle terre confiscate. L’occasione di quest’esegesi, come s’è accennato, fu la riedizione del 1847 e, del resto, sarebbe stata impensabile senza il sostrato della discussione che ferveva in quegli anni, culminata nel Discorso di Carlo Troya del 1841, riedito proprio a Milano nel 1844, con le acute osservazioni del patrizio Francesco Rezzonico, futuro rappresentante di Como nel governo provvisorio dopo le Cinque Giornate. Sarebbe, tuttavia, inesatto ritenere (come ha fatto anche uno studioso attento come Umberto Pirotti) che Manzoni non avesse concepito un’idea netta della condizione personale dei Romani già negli anni Venti: ma è meglio cercarla, invece che nel Discorso, nella tragedia. Bastino due luoghi: il primo, già citato, è quello in cui Adelchi, nella scena i poi cancellata dell’Atto v, propone di restituire ai Romani, che prenderanno le armi con i Longobardi, la libertà e il diritto di proprietà, di cui erano stati evidentemente privati («sia suo: libero seggaΩ/Ωnel suo terren»), oltre ad oπrire loro la partecipazione all’esercito («nudra un cavallo») e la condivisione dei diritti politici («assistaΩ/Ωai consigli del popolo»). È segno che il 12 dario mantovani «servo sudor» che imperla le fronti dei Romani chini sui solchi nel primo Coro era inteso in senso letterale. Una seconda citazione è utile, perché mostra meglio di ogni altro punto la capacità di volgere in poesia l’interpretazione delle fonti, senza perdere in precisione storica. Nell’Atto iii, quando ancora si crede che i Franchi debbano rinunciare a scendere in Italia perché la munizione delle Chiuse pare insormontabile, Adelchi, tutt’altro che trionfante, paventa già la prossima impresa nella quale il padre intende guidare la sua gente, l’invasione del ducato di Roma e il regolamento di conti con il Papa Adriano: «l’anticaΩ/Ωnostr’arte è questa – lamenta AdelchiΩ–: ne’ palagi il focoΩ/Ωporremo e ne’ tuguri: uccisi i primi,Ω/Ωi signori del suolo, e quanti a casoΩ/Ωnell’asce nostre ad inciampar verranno,Ω/Ωfia servo il resto, e tra di noi diviso» (Atto iii, sc. 1, vv. 67-72). Si ha qui la trasposizione poetica dell’Historia Langobardorum (2.32): «Multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt, reliqui per hospites divisi […] tributari e√ciuntur». È anticipata in un verso l’interpretazione tributari = schiavi, che sarà meticolosamente difesa in molte pagine di dottrina nell’Appendice al cap. iii del 1847. 4. La schiavitù degli indigeni era un’interpretazione senz’altro distante da quella degli scrittori, da Machiavelli a Giannone a Muratori, che dipingevano gli Italiani e i Longobardi aπratellati e, di conseguenza, non avrebbero potuto nemmeno concepire l’asservimento dei primi ai secondi. Non che l’opinione ‘continuista’ tenesse il campo da sola, come la presentazione manzoniana potrebbe far credere. Che la dominazione longobarda avesse segnato una cesura violenta nella storia municipale tardoantica era stato infatti vigorosamente sostenuto, in tempi relativamente recenti, dal canonico Mario Lupo, nel Codex diplomaticus Civitatis et Ecclesiae Bergomatis (1784-1799). Ancora nel 1823, quando Antonio Pagnoncelli pubblicò le sue ricerche Sull’antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane, l’anno seguente l’uscita del Discorso (che l’avvocato bergamasco non dà vista di conoscere), la durezza della conquista longobarda era anzi definita un pregiudizio comune, contro il qua- le vocazioni del «discorso» 13 le era necessario trovare argomenti (per inciso, quelli che addusse Pagnoncelli riscossero il plauso di Savigny). Vero è, tuttavia, che all’inizio dell’Ottocento l’opinione favorevole ai Longobardi aveva acquisito un maggiore prestigio. Un esempio può servire a chiarire i rapporti tra le forze in campo. Nella compendiosa Storia del regno dei Goti e dei Longobardi in Italia, apparsa in tre tomi tra il 1825 e il 1826 a firma di Giovanni Tamassia (ascendente dell’omonimo storico del diritto che a cavallo di Otto e Novecento contribuì, da protagonista, al rinnovamento degli studi sull’età longobarda), i governi barbarici sono presentati in una luce molto favorevole (l’Adelchi, curiosamente, è citato con onore senza che l’opinione manzoniana, tuttavia, faccia breccia nel testo). Con l’opuscolo, Tamassia si propone, dichiaratamente, di divulgare le pagine di Gibbon dedicate a Goti e Longobardi, che, a loro volta, dipendono ampiamente da Muratori (e da Giannone). È la testimonianza di come le idee dell’erudito modenese avessero guadagnato, per la fama del suo autore e per il tramite di un’opera altrettanto influente come il Decline and Fall (ritradotto in francese, si noti, nel 1812 dal Guizot), un’udienza più vasta rispetto all’opinione secondo la quale si vedeva nell’invasione barbarica una crisi di civiltà, ch’era l’idea, invece, difesa da Lupo. Quando Manzoni si accingeva a sostenerla, l’opinione ‘catastrofista’ aveva, tuttavia, il solido appoggio di Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, che è il vero ispiratore latente del Discorso. Il silenzio sul nome dello scrittore, di famiglia pisana, esule per motivi religiosi (è menzionato solo nell’edizione del ’47 e per rivolgergli una critica su un punto marginale, l’identificazione degli scabini franchi con gli sculdasci longobardi, critica, per di più, già enunciata da Savigny: si veda l’Appendice al cap. iii), è compensato dalle numerose coincidenze, anche espressive, che pongono in stretto contatto non solo il Discorso, ma persino l’Adelchi con l’Histoire des Républiques italiennes du moyen âge. Basti ricordare, come ha segnalato acutamente Giuseppe Nava, che la frase assurta a emblema del Discorso, «una immensa moltitudine d’uomini, una serie di generazioni, che passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata, senza lasciarci traccia, è un tristo ma impor- 14 dario mantovani tante fenomeno», ricalca il ritratto che l’Histoire fa dei nobili romani sotto gli ultimi imperatori: «ils n’étoient pas fait pour laisser de traces après eux», «ils passaient inaperçus sur la terre» (cap. i, p. 18: ed. Zurigo, Gessner, 1807). L’opera, edita fra il 1807 e il 1818, prima a Zurigo quindi a Parigi (e tradotta in italiano a partire dal 1817, anno in cui finì anche all’Indice), fornì a Manzoni gli elementi per il carattere del personaggio di Carmagnola e influì sull’interpretazione del Seicento accolta nei Promessi sposi, oltre ad avere dato esplicito spunto, com’è noto, alle Osservazioni sulla morale cattolica, destinate a difendere la Chiesa dalle accuse del cap. cxxvii. Era dunque un libro centrale nella meditazione, e nell’invenzione artistica, di Manzoni negli anni del Discorso. Del resto, proprio nell’accingersi a confutarne le opinioni in merito all’influenza deleteria della religione cattolica sul carattere degli Italiani, Manzoni aveva voluto attestare la sua «stima per tant’altre parti d’un’opera» che si distingueva non solo per «le laboriose e esatte ricerche», ma per l’originalità dell’impostazione, che è poi la medesima impostazione che anima il Discorso, per «l’intento di rappresentare, per quanto si può, in una storia lo stato dell’intera società di cui porta il nome» (Osservazioni sulla morale cattolica, Al lettore). Dopo quest’attestato, non sorprende trovare già nell’Histoire pressoché tutti gli elementi che formano la visione manzoniana sulla condizione degli indigeni sotto i Longobardi. È del Sismondi, infatti, l’aπermazione ‘iconoclasta’ che i due popoli non si unirono mai (si mantennero anzi separati da quel reciproco odio che, nella tragedia, Desiderio dichiara invalicabile barriera fra oppressi e oppressori): «Les Lombards ne s’allièrent point aux Italiens, comme avoient fait les Goths, leurs prédécesseurs. A leur établissement dans le pays, ils avoient abusé de leur victoire d’une manière plus cruelle et une haine plus violente séparoit les deux nations. Elle se conserva longtems encore après la chute de la Monarchie de Pavie» (cap. i, p. 30). Anche il secondo caposaldo dell’interpretazione manzoniana si trova nell’Histoire des Républiques italiennes. La condizione dei Romani sotto i Longobardi era ricavata dal Sismondi, quasi le vocazioni del «discorso» 15 per deduzione, dal regime sociale dei popoli barbari (o meglio, semibarbari), la cui economia si basava sulla coltivazione autarchica della terra, senza sbocco di mercato. Per nazioni così organizzate, che facevano della proprietà immobiliare il vero attributo della libertà, la conquista d’un territorio portò sempre – questa è la tesi – alla confisca dei beni, e all’asservimento, degli antichi proprietari: «Un Peuple cultivateur peut aussi être conquis par un Peuple demi-barbare, et cultivateur comme lui. Si le premier est esclave, et excessivement corrompu; si le second est libre, le nombre des vainqueurs peut être infiniment moindre que celui des vaincus. Alors les premiers abuseront du droit de la victoire; ils s’attribueront la propriété des terres de la nation dépouillée, et ils réduiront les cultivateurs de la condition de propriétaires à celle de métayers» (cap. ii, p. 76; nell’ed. Bruxelles 1838, p. 53, la frase prosegue: «peut-être même à celle de serfs de la glèbe»). Questo paradigma, per Sismondi, spiegava la dinamica dell’assoggettamento dei Romani, già esausti, da parte dei Longobardi, sotto i quali «les laboureurs leurs vassaux, qu’ils avoient dépossédés, et qu’ils forçoient à travailler pour leur compte, et à leur livrer le tiers de leurs récoltes, étoient dans une condition approchante de l’esclavage» (p. 79). Proprio a questo punto, per sostanziare la propria interpretazione, Sismondi richiamava il passo dell’Historia Langobardorum (2.32), che abbiamo trovato incastonato nell’Adelchi (Atto iii, sc. i, vv. 67-72). Se fra le interpretazioni dei due autori corre una diπerenza, è nel rapporto fra confisca e schiavitù da una parte e tributo del terzo del raccolto dall’altra, sistemi che Sismondi accoglieva entrambi senza sospetto, mentre Manzoni evidentemente fin d’allora vi avvertiva una contraddizione (non a caso il verso dell’Adelchi tace del tributo). Quest’antitesi, giuridica ancora una volta, fra la condizione di schiavi e il definire ‘loro’ il raccolto («in qual maniera quel suarum frugum sarebbe potuto convenire ai Romani diventati lavoratori servili»?) diede luogo alla lunga Appendice aggiunta al capitolo iv nell’edizione del 1847, che risolve la contraddizione attribuendo l’imposizione del tributo e la riduzione in schiavitù a due successive, distinte fasi della conquista. 16 dario mantovani Nel 1822, la ritrosia di Manzoni a pronunciarsi positivamente sulla condizione dei Romani nel Discorso («Erano essi […] in vera servitù? Ma in qual grado?»), a confronto con la nettezza con la quale contemporaneamente li definisce schiavi nella poesia, è segno che l’idea enunciata da Sismondi, pur esatta, gli sembrasse da rifinire nei particolari e da passare al vaglio della documentazione (sul punto, come s’è visto, Sismondi procede piuttosto en philosophe che secondo il metodo dei Benedettini). È appunto il riesame che poté compiere venticinque anni dopo, sulla base delle fonti che nel frattempo altri, aderendo alla sua esortazione, erano venuti raccogliendo. Tuttavia, sui punti essenziali, ossia la distinzione dei due popoli e la riduzione in schiavitù dei Romani, l’Histoire e il Discorso già concordano senza residui. Altre coincidenze incontreremo nel séguito. 5. Le questioni a cui Manzoni è votato non sono, ovviamente, di natura giuridica: il diritto è soltanto il mezzo per impostarle correttamente. I problemi sensibili sono di ordine etico ovvero, per ricorrere a un’espressione crociana, gli sono dettati dalla sollecitudine morale. L’intreccio fra i due ordini di problemi (giuridici e morali) e la subordinazione dei primi ai secondi costituiscono il meccanismo che muove il Discorso. Quando Manzoni, dopo avere sgombrato il campo dalla falsa idea dell’unità di conquistatori e conquistati (sul piano del diritto pubblico), s’interroga sulla condizione personale (nel diritto privato) dei Romani soggetti ai Longobardi, in realtà è già entrato, anche se il lettore può non avvedersene, nel secondo e cruciale tema del Discorso, ossia quale giudizio si deve dare al ruolo svolto dai Papi nella caduta del regno, tema che compare come titolo del solo capitolo v. È questo, in realtà, sebbene quasi dissolto nella trama espositiva, il tema dominante del Discorso, cui tutti gli altri sono subordinati. Come aveva notato Giorgio Falco, la pagina delle Istorie Fiorentine da cui Manzoni prende l’abbrivio («Erano stati i Longobardi dugento trentadue anni in Italia, e di già non ritenevano di forestieri altro che il nome»: cap. xi), nel presentare la società romano-barbarica in una luce favorevole sottendeva un giudizio ne- le vocazioni del «discorso» 17 gativo sulla politica temporale della Santa Sede, che aveva impedito l’unificazione politica dell’Italia e fatto spesso ricorso, in propria difesa, allo straniero («il qual modo di procedere dura ancora in questi nostri tempi; il che ha tenuto e tiene la Italia disunita e inferma»: Istorie fiorentine, cap. ix). Sotto il governo dei Longobardi, l’Italia era stata prossima all’unità e la chiamata dei Franchi da parte di Adriano rappresentava perciò nel più alto grado la responsabilità della Chiesa nella disgregazione della patria. Il Discorso cerca di sciogliere il doppio nodo stretto da Machiavelli. Il biasimo della politica papale «è sempre fondat[o] – può osservare Manzoni dopo avere sciolto il primo nodo – sul supposto che i Longobardi vivessero in una comune concittadinanza con gli Italiani» (cap. v). La dimostrazione che i due popoli erano, al contrario, rimasti divisi rappresentava tuttavia solo la prima parte del ragionamento, quella che consentiva di sbloccarlo, ma non di arrivare alla soluzione. Ancora si trattava di stabilire in che condizione fossero tenuti i Romani, perché sarebbe stato arduo giustificare l’operato dei Papi qualora nel regno longobardo – a prescindere dalla mancata convergenza in un solo popolo – si fosse comunque stabilita «una certa quale equità […] una certa giustizia» (cap. i), ossia una condizione che potesse «diminuire i dolori» della moltitudine dei conquistati (cap. v). Precisamente a questo si volge allora Manzoni, a dimostrare le catastrofiche conseguenze della conquista e a indicare nel Papa il naturale catalizzatore delle speranze di «sollievo» della popolazione italica. Ancora una volta – e nel punto cruciale – l’interpretazione del Discorso s’incontra con quella dell’Histoire des Républiques italiennes du moyen âge di Sismondi. «La longue inimitié des Lombards avec les Romains et les Grecs, fut aussi la cause de la chute de leur Monarchie» (cap. i, pp. 32 ss). Per Manzoni, l’impero d’Oriente, che nominalmente manteneva la sovranità nelle regioni lasciate libere dai Longobardi, non era «forte né retto da ordini o da uomini migliori di quelli che avevano lasciato invadere l’altra parte d’Italia»; l’unica «speranza di sollievo, se non di risorgimento» per i Romani «era tutta riposta nei Pontefici». Così 18 dario mantovani per Sismondi: «Les Papes encourageoient les Romains à la défense de leur patrie […] Plus les Romains se voyoient négligés par les Empereurs, plus ils s’attachoient aux Papes, qui, pendant cette période, étoient eux-mêmes presque tous Romains de naissance, et ornés de vertus que les ont fait admettre pour la plupart dans le catalogue des Saints» (cap. iii, pp. 136 ss). L’accenno alla nascita romana dei pontefici risuona addirittura, ci pare, nella prima stesura dell’Adelchi: Adriano è «figlio di Roma, ei non comanda ai vinti,Ω/Ωai suoi fratelli antichi a quelli ond’ebbeΩ/Ωogni poter comanda» (Atto i, sc. 1, vv. 216-8, in Adelchi 1998, p. 21). Quando Sismondi scrive, pensando alla diaspora dei Romani in fuga dalle regioni invase dai Longobardi, che si rifugiano nell’esarcato, nella Pentapoli, nel ducato di Roma: «L’indépendance de ces Provinces que les Grecs abandonnoient presque à elles-memes, leur petitesse, et les dangers continuels auxquels elles étoient exposées, faisoient renaître ensuite l’amour de la patrie dans le coeur de tous leurs habitans» (cap. i, p. 31), prefigura, se non c’inganniamo, Adelchi: «Ei (il pontefice) sa che in tuttiΩ/Ωgl’itali cor pietà, rispetto accende, e desio di vendetta» (Atto i, sc. i, vv. 2313, in Adelchi 1998, p. 22). 6. Se la corrispondenza con l’Histoire attenua l’originalità del Discorso – ammesso che questa sia una categoria di giudizio pertinente – permette, tuttavia, di apprezzarne meglio l’assetto. L’intero Discorso, s’è visto, inclina verso la questione del giudizio (etico) sulla chiamata dei Franchi da parte dei Papi (è il quesito suscitato da Machiavelli, che da parte sua lo poneva ovviamente in chiave politica). Da Sismondi, Manzoni ricava alcuni elementi per la risposta: le due etnie rimangono divise, i Romani sono ridotti in schiavitù; il Papa diventa il punto di riferimento sia per quanti sono scampati alla furia barbara, e si sono rifugiati nelle regioni in mano bizantina (almeno nominalmente), sia per quanti la subiscono in occasione delle ripetute scorrerie in quelle stesse regioni. Pertanto, la chiamata dei Franchi è un rimedio giustificabile, anzi giusto (senza peraltro implicare, proprio per la sua natura morale, l’avallo del temporalismo: l’azione secolare della Chiesa, nell’Adelchi le vocazioni del «discorso» 19 e nel Discorso, è un male tollerato, se e in quanto può comportare provvidenzialmente un aiuto a chi non abbia altri difensori). Rispetto a Sismondi, Manzoni si preoccupa di dare al proprio assunto una dimostrazione più solida. A quest’approfondimento – oltre alla confidenza con le fonti, che lo tratteneva da conclusioni aπrettate – lo spingeva l’esigenza di rovesciare l’opinione che aveva preso piede nel Settecento italiano (ed europeo, tramite Gibbon, ma vi avevano contribuito già Grozio e poi Montesquieu, tessendo l’elogio della legislazione longobarda), e che reputava felice, o almeno non triste, lo stato dei Romani sotto i barbari. L’equanimità del regno longobardo s’opponeva a un giudizio favorevole sull’operato dei Papi che ne avevano promosso la caduta. Che poi, come s’è visto, già altre voci si fossero levate contro la riabilitazione dei Longobardi – non solo quella di Mario Lupo, ma anche voci nell’ambito della storiografia napoletana che si interrogava sulle radici medievali della società politica meridionale, come quella di Francesco Maria Galanti nella Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie, che biasimava il cattivo «spirito pubblico dominante, ch’è l’opera del governo de’ barbari» – Manzoni forse non lo sapeva, o comunque non le riteneva voci all’altezza del dibattito. Ecco finalmente chiarita la funzione argomentativa svolta nel Discorso dal tema della condizione personale dei Romani: accertare che tale condizione fosse la schiavitù avrebbe significato che la reazione dei pontefici fu encomiabile. Il tema è aπrontato dunque da Manzoni non come questione autonoma (come tenderà poi sempre più a divenire, specialmente nella storiografia giuridica), bensì come parte integrante della discussione sull’atteggiamento di Adriano I. Proprio l’inadeguatezza, tuttavia, a sostenere la funzione assegnata spiega l’esigenza di dare al Discorso un ulteriore sviluppo argomentativo. Manzoni, come s’è visto, si astiene (almeno in prosa) da conclusioni in positivo sulla condizione degli indigeni sottomessi (lasciando intendere che si trattasse di schiavitù, ma invocando nuovi studi sulla questione). Di conseguenza, l’indagine deve prendere altre vie, non senza avere fatto leva, come fenomeno eloquente, sull’«ignoranza stessa in cui siamo dello stato degli Italiani già 20 dario mantovani soggetti ai Longobardi» (cap. v). Il famoso «silenzio» della storia su un’immensa moltitudine d’uomini – che in genere, attraverso il facile collegamento con i Promessi sposi, assurge a simbolo della pietà verso gli umili – è quindi addotto nel Discorso come indizio del degrado della condizione in cui i Romani erano caduti sotto i Longobardi. Questa lettura, che emerge già dall’impianto del Discorso nella sua veste definitiva, è confermata da un brano della prima stesura, quella cui il Ghisalberti ha imposto il nome di Abbozzo. Considerato che il motivo del silenzio non sempre è stato bene inteso, vale la pena di riportarlo: «Forse una ragione del silenzio tenuto sugli italiani soggetti ai longobardi si è che nelle stragi che i longobardi ne fecero a varie riprese pare che avessero quasi cura di uccidere i nobili, i primi, i gran proprietarj, dimodochè quel che ne rimase era quasi la pura plebe, e le ricchezze, i possessi si trovavano forse presso i soli vincitori. L’industria non era che mancante e limitatissima, e le dottrine aπatto perdute». Un argomento e silentio – perché di questo, appunto, si tratta – non può tuttavia sorreggere da solo una teoria. Di positivi, però, non ne venivano in soccorso molti: forse il più impressionante parve a Manzoni – come già, a dire il vero, a Mario Lupo – quello dei massacri compiuti dai Longobardi sotto Clefi e sotto i duchi all’inizio del loro stanziamento, massacri che, trascorsi meno di due secoli, si ripeterono a Sinigaglia, Urbino e Blera, a dimostrare quasi la loro coessenzialità al «sistema longobardo di conquista» (cap. v; tema che ancora una volta presuppone le riflessioni sismondiane sulle «conséquences de la conquête»). Alla confirmatio, le regole retoriche chiedono di fare seguire la confutatio. Ecco dunque la critica degli argomenti addotti come testimoni della bontà dei Longobardi, specialmente quelli avanzati nell’Istoria civile di Giannone (che è il principale bersaglio nella polemica sul ruolo del papato), oltre che da Muratori (il quale, per il fatto di ricollegare la prosapia estense ai Longobardi e di sostenerne le pretese territoriali in lite con la Chiesa, dev’essere implicitamente sembrato al Manzoni un giudice non del tutto imparziale, come sarebbe parso più tardi a Carlo Troya). Le prove del- le vocazioni del «discorso» 21 la clemenza longobarda – clemenza che, al di là d’ogni pronostico sull’unificazione politica dell’Italia, avrebbe comunque tolto ogni giustificazione alla chiamata dei Franchi – erano principalmente due, la concessione ai vinti di vivere secondo il proprio diritto (ossia il diritto romano), e il quadro di prosperità dipinto da Paolo Diacono per l’età di Autari. Questi due temi diverranno i principali campi di battaglia per la successiva storiografia, ma sono introdotti da Manzoni in una prospettiva del tutto diversa, tangenziale o, per meglio dire, sono aπrontati dal punto di vista della confutazione e non della dimostrazione. In questa prospettiva, poterono essere almeno in parte disinnescati, trattati con maggiore souplesse. Così, Manzoni non è costretto a porsi una domanda fondamentale, quale fosse il rapporto fra lo stato di schiavitù nel quale i Romani a suo parere erano caduti e la concessione di vivere secondo il diritto (privato) romano, che presupponeva, viceversa, che fossero soggetti giuridici, e dotati di un patrimonio. Inoltre, data la medesima premessa, quale senso avesse il riconoscimento dei matrimoni misti e della filiazione legittima. È su√ciente, al suo scopo, smentire che il permesso di vivere secondo il diritto romano fosse un segno di clemenza da parte degli invasori. Agli indigeni fu concesso di continuare a vivere secondo il proprio diritto – conclude Manzoni – solo perché «posti in salvo i privilegi della conquista, le relazioni fra conquistato e conquistato diventavano indiπerenti ai padroni». È una spiegazione cui Manzoni stesso dava una qualche importanza, definendola addirittura «la sola conclusione» del suo discorso (e poco importa che fosse stato in realtà preceduto su questa strada da Donato Antonio d’Asti, nei due libri sull’uso e l’autorità della ragion Civile – cioè del diritto romano – nelle province dell’impero Occidentale, pubblicati a Napoli nel 1751). Questa considerazione – sia detto per inciso – è esatta, poiché è dettata dalla consapevolezza che il diritto antico è ordine quasi autarchico delle relazioni fra i consociati e non dev’essere confuso con le legislazioni dei tempi moderni – Manzoni viveva nell’età delle codificazioni – in cui «l’esercizio della sovranità si considera come un’amministrazione avente per fine la giustizia e l’utile pubblico» (la distinzione non a caso fu sùbito raccolta da 22 dario mantovani Luigi Blanch, nella Storia della legislazione nei suoi rapporti con la scienza e la società del 1835, che sviluppa interessanti relazioni fra il sistema di conquista e gli ordinamenti sociali dell’alto Medioevo). Analogamente, il famoso passo della Historia Langobardorum (3.16) che descrive il regno di Autari come età dell’oro, non viene esaminato nella sua parte più enigmatica, quella relativa al trattamento dei Romani, che è toccata solo in via di praeteritio, nel senso che quelle «parole di colore oscuro» vengono usate per gettare sul resto del passo un sospetto di inattendibilità o comunque una luce sinistra. Dopo la prova e la confutazione, la sequenza retorica attende la perorazione. Ne fa la funzione il quinto capitolo, intitolato Della parte che ebbero i papi nella caduta della dinastia longobarda (dove la parola dinastia anticipa già la risposta minimizzante), che chiude il Discorso con la richiesta di assoluzione (perché solamente dai Papi i Romani vessati potevano aspettarsi «una speranza di sollievo, se non di risorgimento»). L’accuratezza della disposizione può forse giustificare l’impressione di Falco: «Pure fra meravigliosi tesori di finezza e d’intelligenza, il Discorso ci dà più d’una volta il senso di un astratto giuoco intellettuale, di una sottilissima sofistica, che rimane assai lontana dalla ricchezza e dalla persuasiva vitalità della storia». Più semplicemente, il Discorso è uno straordinario esempio di scrittura retorica applicata alla storiografia. Bene avrebbe figurato nella analisi che Hayden White ha proposto delle principali forme di coscienza storica nel XIX secolo, a conferma che il contenuto profondo dell’opera storica è poetico o almeno linguistico (e non stupirebbe se il tropo dominante del Discorso fosse quello dell’«ironia che sta bene a tanta ragione»). 7. La negazione della bontà morale dei Longobardi è, come si è visto, un elemento essenziale alla logica del Discorso, e ne costituisce ‘retoricamente’ la confutatio. Questo ruolo portante rende a priori non verosimile l’ipotesi, avanzata in uno studio giustamente celebrato di Aurelia Accame le vocazioni del «discorso» 23 Bobbio, secondo cui, in una prima fase delle sue ricerche, Manzoni avrebbe, al contrario, creduto a «una mitigazione della dura oppressione originaria», a un «qualche riconoscimento di diritti ai vinti con relativa limitazione di quelli dei vincitori», a qualche indizio documentabile insomma di quella che poi avrebbe chiamato ironicamente la «bontà» dei Longobardi. In realtà, se questa fosse stata l’idea di partenza, tutta la traiettoria argomentativa, la tesi stessa del Discorso sarebbe stata interamente modificata. Se al tempo di Desiderio fosse già stata conseguita «una certa quale equità» fra vinti e vincitori, per usare parole manzoniane, quale giustificazione avrebbe avuto la chiamata dei Franchi da parte del Papa, che è il punto in cui si raccolgono tutti i fili del Discorso? Nei manoscritti del Discorso, di fatto, non v’è traccia di un simile ripensamento: la presunta clemenza dei Longobardi è una credenza invariabilmente contestata. Quest’accertamento, tuttavia, non fornisce ancora la prova risolutiva, poiché la prima stesura, quella battezzata Abbozzo dal Ghisalberti, fu preparata piuttosto tardi: stando a due testimonianze del carteggio, probabilmente fra il 21 settembre e il 3 novembre 1821. La prosa delle idee storiche è, quindi, posteriore ai versi della tragedia (prescindendo dalla revisione). Stante la sequenza cronologica Adelchi-Discorso, resterebbe perciò ancora lo spazio per ipotizzare, com’è stato ipotizzato, che il cambiamento di opinione sia occorso durante la composizione dell’Adelchi. Per fare cadere quest’ipotesi – che, come s’è detto, è resa già inverosimile dal ruolo cardinale che la negazione della «bontà» longobarda riveste rispetto alla tesi sostenuta nel Discorso – non è necessario appellarsi al carteggio, che pure invia segnali tutto sommato già eloquenti. L’insoddisfazione di Manzoni per «le caractère du protagoniste», aπetto da «une couleur romanesque», espressa a tragedia compiuta il 3 novembre 1821 in una lettera al Fauriel (Carteggio Manzoni-Fauriel, 67) e posta in relazione con l’infondatezza dei dati storici di partenza, è infatti più che bilanciata dalle lettere precedenti, da cui risulta che le idee di fondo del Discorso, persino alcuni argomenti, erano già definiti ancor pri- 24 dario mantovani ma di cominciare la tragedia, e la di√denza verso la vulgata storiografica – se così si può definire l’opinione di Muratori e di Gibbon – fu un precoce, anzi preliminare acquisto (il documento fondamentale è la lettera del 17 ottobre 1820 al Fauriel, Carteggio Manzoni-Fauriel, 63). I confronti eseguiti sopra hanno del resto mostrato che gli elementi necessari a comporre il sistema manzoniano erano già presenti nel Sismondi ed è quindi di√cile immaginare un’evoluzione interna. Il piano di verifica più sicuro è oπerto, tuttavia, dalla tragedia stessa. Che la crudeltà del regime longobardo fosse una convinzione acquisita fin dall’inizio dell’Adelchi, esce irrefutabilmente dai luoghi della prima stesura della tragedia, già ricordati, relativi alla condizione personale degli indigeni sotto i Longobardi. Lungi dal lasciar trapelare una visione edulcorata della conquista, fin dalla prima stesura la tragedia rappresenta i Romani in uno stato di vera servitù. Al contrario del movimento ipotizzato dalla Accame Bobbio, secondo cui Manzoni sarebbe passato da un’iniziale adesione all’idea d’una qualche clemenza della dominazione longobarda a un giudizio più cupo, il confronto fra la tragedia (composta per prima) e il Discorso ha mostrato, si ricorderà, che la tragedia esprime con ancor maggiore risolutezza (com’è consentito dalla diversità dei generi letterari) la nozione della brutalità dei vincitori e della permanente oppressione degli indigeni, lasciati nella condizione di «cultor soggetti», cioè di schiavi destinati ai lavori agricoli. In fondo, a chiarire quale fosse stata sempre l’idea di Manzoni, basterebbe la fulminante postilla da lui lasciata sulla Dissertazione 23 delle Antichità italiche, là dove Muratori aπerma che sotto il governo dei Longobardi «non mancavano le rugiade della contentezza». La postilla fa la sua strada fino al Discorso, dove diventa: «Le rugiade del medio evo! Dio ne scampi l’erbe dei nostri nemici». Più delicato è il secondo profilo su cui la Accame Bobbio ha con finezza costruito l’idea che la crisi dell’Adelchi, cioè il passaggio dalla prima alla seconda stesura, sia stata provocata da un approfondimento dell’analisi storica dell’età longobarda. L’altro dato storico sul quale Manzoni avrebbe poggiato la prima stesura le vocazioni del «discorso» 25 dell’Adelchi, per poi trovarlo fragile, sarebbe stato la convinzione che «la nascente coscienza nazionale italiana, orientata a riconoscere quale suo centro e capo ideale il pontefice romano, fosse l’origine prima della debolezza del regno longobardo». Non c’è dubbio, e l’analisi delle varianti condotta sistematicamente da Isabella Becherucci ne ha svelato anche la dinamica, che la revisione, per non dire il rifacimento dell’Adelchi, a partire dalla scena i dell’Atto v, sia consistita principalmente nella soppressione dello «splendido giovanil sogno» del protagonista di chiamare alle armi, accanto ai Longobardi, i Romani sottomessi, promettendo loro libertà, proprietà, parità di diritti. Di fatto, come nelle cronache contemporanee, nella stesura definitiva gli Italiani scompaiono quasi dalla scena, per ritirarsi nel primo Coro. Parallelamente, s’assiste al potenziamento del ruolo assegnato al tradimento dei duchi, tema peraltro già ben presente fin dall’esordio. Il problema resta, tuttavia, se queste variazioni debbano attribuirsi a un mutamento della ricostruzione storica, cioè se il Discorso, per dir così, abbia reagito sull’Adelchi, ovvero se dipendano da ragioni d’ordine diverso. Non è il caso di esporre qui le molte evidenze che s’oppongono alla prima ipotesi, ossia alla spiegazione oπerta dalla Accame Bobbio. Basti segnalare che il dato storico che si vorrebbe caduto, ossia l’ostilità nutrita dalla popolazione italica verso i Longobardi e il suo favore per Carlo, è ancora presente in quanto tale nella tragedia definitiva. Nell’allocuzione che Carlomagno rivolge a Conti e Vescovi prima di lanciarli a superare le Chiuse, la popolazione italica è infatti ancora rappresentata come partigiana dei Franchi e in loro attesa: «Là nella bella Italia, in mezzo ai campiΩ/Ωondeggianti di spighe, e ne’ fruttetiΩ/Ωcarchi di poma ai padri nostri ignote;Ω/Ωfra i tempii antichi e gli atrii, in quella terraΩ/Ωrallegrata dai canti, al sol diletta,Ω/Ωche i signori del mondo in sen racchiude,Ω/Ωe i martiri di Dio; dove il supremoΩ/ Pastore alza le palme, e benediceΩ/Ωle nostre insegne; ove nemica abbiamoΩ/Ωuna piccola gente, e questa ancoraΩ/Ωtra sè divisa, e mezza mia; la stessaΩ/Ωgente su cui due volte il mio gran padreΩ/Ωcorse; una gente che si scioglie. Il restoΩ/Ωtutto è per noi, tutto ci aspetta» 26 dario mantovani (Atto ii, sc. v, vv. 347-60). Il dato storico dell’ostilità italica verso i Longobardi non è dunque mai stato rifiutato da Manzoni: gli Italiani (il «resto») sono dalla parte dei Franchi, li aspettano. Quest’accenno, pur minimo, acquista tanto più significato se, come viene spontaneo, lo si collega ai famosi versi dell’Atto i: «DimenticastiΩ/Ωche ogni nostro travaglio è gioja a questaΩ/Ωitalica genia, che diradataΩ/Ωdagli avi nostri, che divisa in branchi,Ω/ noverata col brando, al suol ricurva,Ω/Ωche d’arme ignuda, che di capi scema,Ω/Ωancor, dopo due secoli, siccomeΩ/Ωil primo giorno, odia, sopporta e spera?» (vv. 58-65, Adelchi 1998, p. 9). Questa parte figurava ancora nella seconda stesura e fu soppressa solo in séguito alla censura (e sembra improbabile che Manzoni vi abbia provveduto spontaneamente). È la prova che il dato storico dell’ostilità italica non era caduto col progredire delle ricerche storiche. Di più. Il Discorso, scritto quando il processo di revisione dell’Adelchi era stato già avviato con la riscrittura dell’Atto v e aveva quindi preso ormai la sua direzione, contiene aπermazioni come queste: la «speranza, pei Romani, era tutta riposta nei pontefici»; «a quest’uomo adunque si dovevano rivolgere tutti i voti, e tutti gli sguardi de’ suoi concittadini, e così infatti avveniva». Sono proposizioni che fanno il pari con i versi che si trovavano nella prima redazione dell’Adelchi: «Le maniΩ/Ωei leva al cielo, e mille mani al cieloΩ/Ωson levate in un punto: il suo desioΩ/Ωdiviene il prego delle genti: ei parla,Ω/Ωe la terra risponde» (Atto i, sc. i, vv. 192-6, Adelchi 1998, pp. 19-20). Se questi versi sono stati poi soppressi, ma il Discorso, posteriore, contiene quelle proposizioni, significa che l’espunzione non è stata determinata da un mutamento della visione storica. La ragione – senza volere invadere il campo altrui – sembra da ricercare piuttosto in ragioni drammaturgiche, che in un révirement storiografico. Che la di√coltà sia stata poetica, e non storica, non significa, beninteso, che ad entrare in crisi sia stato il sistema tragico di Manzoni, le regole che presiedevano ai componimenti misti di storia e invenzione. La sua fedeltà non conosce tentennamenti durante i mesi in cui era dedito all’Adelchi, nemmeno nella lettera al Fauriel del 21 febbraio 1821, dove è parso a qualcuno di le vocazioni del «discorso» 27 intravederne i segnali (Carteggio Manzoni-Fauriel, 65): «le beau principe que tout ce qui est vague, incertain, fabuleux, confus est poetique de sa nature, et que lorsque on ne sait rien sur un sujet il faut en parler en vers», sono frasi pronunciate sotto il segno dell’ironia e, rovesciate come devono essere, riaπermano il solito principio che la poesia non deve mettersi in concorrenza con la storia. Non fu dunque la teoria a essere ripensata; le di√coltà sorsero nell’esecuzione. Il fatto stesso che la crisi sia intervenuta da un momento all’altro, nel corso della composizione della scena i dell’Atto v, lasciata incompiuta, ne è un sintomo. La nota con cui l’autore abbandonò la scena, «scartare tutto e rifar l’atto in modo più conforme alla storia», non significa certo che egli si fosse ricreduto sulla storicità degli eventi che era andato narrando. Il «sogno» di Adelchi di unire in un solo popolo Longobardi e Romani non apparteneva, infatti, a quei «fatti materiali ed esterni» che, secondo il canone manzoniano, il poeta è tenuto a rispettare. Atteneva, invece, a quelle «intenzioni e tendenze» dei personaggi operanti, che costituiscono il campo dell’invenzione poetica. L’estremo rimedio pensato da Adelchi per sconfiggere i Franchi, non avendo avuto sbocco sul piano degli eventi storici, era perciò fin dall’inizio condannato a rimanere intentato, sentimento interno, nobile espansione che definisce il carattere del protagonista, senza potere tuttavia incidere sul corso reale degli avvenimenti, pena lo stravolgimento del canone che regola i componimenti misti. L’esigenza di rifare l’atto in modo più conforme alla storia significa quindi che Manzoni, inoltratosi nella scena i dell’Atto v, dove il disegno era di nuovo riproposto da Adelchi e persino approvato da Desiderio, ritenne insostenibile, sul piano compositivo, assegnare tanto sviluppo a un motivo che doveva poi riuscire ininfluente sull’esito dell’azione (per inciso, la caratterizzazione psicologica di Adelchi e il contrasto con il padre trovano un sorprendente modello in una tragedia di Angelo Maria Ricci, l’Italiade, pubblicata giusto nel 1819, opera nella quale la Becherucci ha riconosciuto una fonte prossima dell’ispirazione manzoniana). L’atto doveva pertanto essere riscritto con maggiore aderenza ai fatti storici o, se si vuole, eliminando quelle espansioni del carattere dei pro- 28 dario mantovani tagonisti che (pur legittime in quanto luogo dell’invenzione poetica) più di√cilmente avrebbero potuto essere raccordate, com’era ineludibile, con la sequenza dei fatti storici, che costituiscono il binario lungo il quale scorre la tragedia. La nota che castiga l’analoga scena ii dell’Atto i, «ommettere tutta la parte cancellata non ben legata all’azione, né storica», esplicita precisamente questo pensiero: il difetto del proposito d’Adelchi non era la sua mancanza di fondamento storico, trattandosi appunto di moto d’animo lasciato alla creazione poetica, bensì la sua sterilità rispetto al crescere dei fatti, il non potersi legare all’azione, la quale doveva necessariamente procedere tenendo conto di ciò che era storico. Il rapporto fra esterno (fatti storici) e interno (intenzioni dei personaggi) è ben esemplificato dal monologo di Adelchi che, nell’Atto v definitivo (vv. 58-98), ci pare recuperi almeno in parte la funzione della porzione soppressa. Com’è noto, la tradizione storica più attendibile (della quale è testimone, per esempio, un’epistola di Adriano a Carlomagno) voleva che Adelchi fosse riuscito a fuggire da Verona prima della sua resa e avesse trovato rifugio a Bisanzio, da dove preparò una spedizione per combattere i Franchi, nella quale trovò infine la morte. Nella tragedia, il fatto storico viene rappresentato adottando il punto di vista interno del personaggio, assistendo al formarsi della sua deliberazione e passando in rassegna le possibili azioni alternative, lungo una linea che, sempre sul registro della nobiltà d’animo, conduce dall’orgoglio verso l’altruismo. Dapprima Adelchi prende in considerazione l’idea di una sortita che lo metta faccia a faccia con il nemico e con una onorevole morte: «Più d’un compagno troverò, s’io grido:Ω/Ωusciam costoro ad incontrar; mostriamoΩ/Ωche non è ver che a tutto i LongobardiΩ/Ωantepongon la vita; e… se non altro, morrem». Da questo impetuoso proposito lo storna un primo moto di altruismo, che s’esprime nello scrupolo di coinvolgere altri Longobardi nella morte: «Che pensi?Ω/ΩNella tua rovinaΩ/Ωperchè quei prodi strascinar? Se nullaΩ/Ωti resta a far quaggiù, non puoi tu soloΩ/ morir? Nol puoi?». Il pensiero della nobile morte solitaria sembra sedurlo: «Sento che l’alma in questoΩ/Ωpensier riposa alfine: ei mi le vocazioni del «discorso» 29 sorride,Ω/Ωcome l’amico che sul volto recaΩ/Ωuna lieta novella. Uscir di questaΩ/Ωignobil calca che mi preme; il risoΩ/Ωnon veder del nemico; e questo pesoΩ/Ωd’ira, di dubbio e di pietà, gittarlo!… / Tu, brando mio, che del destino altruiΩ/Ωtante volte hai deciso, e tu, securaΩ/Ωmano avvezza a trattarlo… e in un momentoΩ/Ωtutto è finito». Improvvisamente si riscuote anche dal pensiero di immolarsi da solo, avverte l’empietà del desiderio, in quanto ribellione ai disegni preparati da Dio per l’uomo: «Ah sciagurato!Ω/ΩPerchè menti a te stesso? Il mormorioΩ/Ωdi questi vermi ti stordisce; il soloΩ/Ωpensier di starti a un vincitor dinanziΩ/Ωvince ogni tua virtù; l’ansia di questaΩ/Ωora t’aπrange, e fa gridarti: è troppo!Ω/ΩE aπrontar Dio potresti? e dirgli: io vengoΩ/Ωsenza aspettar che tu mi chiami; il postoΩ/Ωche m’assegnasti, era di√cil troppo;Ω/Ωe l’ho deserto!». Andare incontro alla morte sicura, fuggendo al proprio destino, non è solo empio, significa anche togliere a chi rimane, al padre prigioniero di Carlomagno, ogni pur tenue speranza di libertà e rivincita: «per compagnia fino alla tomba, al padreΩ/Ωlasciar questa memoria; il tuo supremoΩ/Ωdisperato sospir legargli! Al vento,Ω/ empio pensier. – L’animo tuo ripiglia, Adelchi; uom sii». Solo a questo punto compare finalmente il fatto storico, la fuga verso Costantinopoli, che era il punto d’arrivo ineludibile, quello della realtà eπettuale, ma che compare finalmente illuminato nel suo significato morale dalla riflessione che lo ha preceduto: «T’oπre un asiloΩ/Ωil greco imperador. Sì; per sua boccaΩ/Ωte l’oπre Iddio: grato l’accetta: il soloΩ/Ωsaggio partito, il solo degno è questo.Ω/ΩConserva al padre la sua speme: ei possaΩ/Ωreduce almeno e vincitor sognarti,Ω/Ωinfrangitor de’ ceppi suoi, non tintoΩ/Ωdel sangue sparso disperando» (non è rilevante che poi, nell’eseguire il suo proposito, Adelchi cada prigioniero dei Franchi: quest’infrazione – necessaria per allestire l’incontro supremo fra i tre caratteri, Adelchi morente, Desiderio prigioniero e Carlomagno vincitore – è, infatti, esplicitamente dichiarata da Manzoni nelle Notizie Storiche). Questo raccordo fra storia e invenzione, qui riuscito nei termini ragionevoli d’un dilemma personale, dovette invece sembrare fallito a Manzoni mentre componeva la scena ben più complessa del piano d’Adelchi di unire Longobardi e Romani. Per il fatto di svol- 30 dario mantovani gersi non solo nel chiuso di un monologo, ma di coinvolgere e muovere molti personaggi, senza potere tuttavia sfociare sul piano della storia, questo disegno faticava a legarsi all’azione, che dalla storia, dai fatti eπettivamente accaduti, necessariamente dipendeva. È bene a questo punto rientrare nei limiti stretti che il regolamento di confini o, meglio, di competenza impone a chi scrive. A uscirne, per esprimere dubbi sulle ragioni della crisi dell’Adelchi, ha spinto la coerenza del Discorso, che non ammette facilmente modifiche di uno o dell’altro dei suoi elementi costitutivi. Inoltre, sia pure ridotte nella loro funzione, le tracce delle opinioni storiche sottostanti alla prima stesura ricompaiono identiche sia nel secondo Adelchi, sia nel Discorso. Se questi dubbi appaiono fondati, è bene lasciare ad altre competenze e sensibilità di approfondire le ragioni poetiche che (in dialettica forse con l’evolversi della situazione politica contemporanea, nel drammatico anno che vide sfiorire la speranza di insurrezione lombarda cui inneggia Marzo 1821) spinsero Manzoni a mettere la sordina sulla popolazione italica sottomessa. Sia consentito solo, quasi a proteggersi dall’audacia della sortita, porsi sotto lo scudo del Fauriel, che, nella Préface du traducteur all’edizione francese della tragedia, intendeva la «couleur romanesque», lamentata da Manzoni nella lettera del 3 novembre dalla quale siamo partiti, precisamente come difetto di legame con le azioni: «le caractère que M. Manzoni a donné à son héros […] n’est pas en rapport avec ses actions, ni par conséquent historiquement vrai». È la spiegazione che ci pare ancora la più convincente. 8. Il Discorso vero e proprio abbraccia dunque i capitoli dal secondo al quinto, che si svolgono in una sequenza argomentativa fitta e riconoscibile. I Longobardi e i Romani rimasero due popoli distinti (cap. ii) u si pone perciò la questione del trattamento (clemente oppure crudele) riservato ai RomaniΩu il silenzio delle fonti sulla condizione degli indigeni non consente di farsene un’idea precisa (anche se è di per sé stesso indizio di catastrofe)Ωu d’altra parte (cap. iii), la concessione della legge romana non è un atto di clemenza, e non è credibile la descrizione di Paolo Diacono d’un’età le vocazioni del «discorso» 31 dell’oro (cap. iv), è anzi verosimile che i Romani fossero angariatiΩu dunque i Papi che hanno causato la caduta della dinastia, e con questo oπerto ai Romani una speranza di sollievo, sono encomiabili (cap. v). In questa struttura, il sesto e ultimo capitolo rappresenta un’egressio, posta quasi a bilanciare simmetricamente il capitolo d’esordio, appendice delle Notizie Storiche e quindi anch’esso sganciato dalla struttura portante del Discorso. Lo conferma l’assenza dall’Abbozzo, in cui è annunciato, ma non svolto. Il capitolo conclusivo s’interroga sulla «cagione generale della facile conquista di Carlo», cioè sulla causa profonda, e√ciente, essendo le altre, quali il tradimento di alcuni duchi, solo un epifenomeno. La «libertà signorile» dei Longobardi ossia, vichianamente, la struttura federativa del regno, la divisione in duchee senza solida struttura centrale, rendeva il potere regio assai dipendente dalle qualità personali del re, dalle sue azioni e dal suo carattere. Fu dunque la personalità eccezionale di Carlomagno a fare la diπerenza: la sua volontà «nel manifestarsi annunziava una determinazione, una irremovibilità, una profondità di pensiero e una passione tale, che le altre s’accorgevano di non avere altrettanto da opporle». È la razionalizzazione dei diversi caratteri della tragedia: la monolitica volontà di Carlo – che è stata a volte rimproverata a Manzoni come un difetto artistico – era l’arma capace di vincere la sensibilità romantica di Adelchi e il cieco orgoglio di Desiderio. Anche in questo caso, la spiegazione era già nell’Histoire di Sismondi: «Charlemagne est un des plus grands caractères du moyen âge […] En eπet Charlemagne éteignit en quelque sorte son siècle; il parut seul sur la scène» (cap. i, pp. 34 e 38; nell’ed. Bruxelles 1838, il motivo, curiosamente, è amplificato: «il avait concentré tous les intérêts de l’Europe sur un seul théâtre; il les avait fait dépendre d’une seule volonté; il avait renfermé ses vaste projets dans une seule tête, il avait accoutumé ses contemporains à attendre l’impulsion qu’il leur donnerait, plutôt qu’à se combiner avec lui»). In questo punto, oltre che in Sismondi, l’opinione di Manzoni trovava corrispondenza in un altro dei libri che il Discorso sottende, l’Esprit des lois di Montesquieu, nel cui libro xxxi, al cap. xviii 32 dario mantovani che prende il nome da Carlomagno, si può leggere: «Charlemagne […] mit un tel tempérement dans les ordres de l’Etat, qu’ils furent contrebalancés, et qu’il resta le maître. Tout fut uni par la force de son génie» (ed. Parigi 1979, sull’ed. 1757). Anche in questo caso, il giudizio storico prende forma in versi, nelle orgogliose parole di Carlomagno: «al voler mioΩ/Ωogni voler piegò; Francia non ebbeΩ/Ωpiù che un aπar; tutta si mosse» (Atto ii, sc. 1, vv. 27-9) e in quelle meste di Adelchi: «ei che su un popol regnaΩ/Ωd’un sol voler, saldo, gittato in uno,Ω/Ωsiccome il ferro del suo brando; e in pugnoΩ/Ωcome il brando lo tiensi» (Atto iii, sc. 1, vv. 49-52). 9. Proprio l’Esprit des lois dà modo di aπrontare un problema importante per la comprensione del Discorso, poiché apre uno spiraglio sulle letture che possono avere indirizzato Manzoni a cercare nel Medioevo le origini della storia nazionale, senza voler sottovalutare gli spiriti amici che, nei mesi parigini che precedono l’inizio dell’Adelchi, lo confortarono nel suo orientamento, il Fauriel e l’allievo Augustin Thierry, sull’influenza del quale soprattutto si è appuntato lo sguardo, seguendo l’amplificazione che Sainte-Beuve fece della lettera di Manzoni al Fauriel del 17 ottobre 1820, nella quale il giovane giornalista è rievocato intento a consultare le cronache del Medioevo francese. Il tema della conquista e della relazione fra invasori e indigeni era, in eπetti, ben più antico dell’interesse che vi portavano i nuovi storici liberali dell’età della Restaurazione o del breve dibattito accesosi nel 1818 sul «Conciliatore». La discussione rimontava al secolo anteriore (per tacere delle premesse nella Francogallia di François Hotmann) ed è simboleggiata dall’Histoire de l’ancien gouvernement de la France (1727) del conte Henri de Boulainvilliers e dall’Histoire critique de l’établissement de la monarchie française dans les Gaules (1734) dell’abate JeanBaptiste Dubos. Per Boulainvilliers, i privilegi della nobiltà sul terzo stato si fondavano sulla vittoria dei Franchi e sulla sottomissione dei Gallo-Romani. Dubos replicava che i Franchi nel V secolo non avevano invaso la Gallia, ma v’erano entrati come al- le vocazioni del «discorso» 33 leati, non come nemici dei Romani: di conseguenza, la distinzione fra nobili e roturiers non trovava legittimazione nella conquista, ma era sorta quattro secoli più tardi, con il feudalesimo, lo smembramento della sovranità e la trasformazione degli u√ci in signorie. Il tema, e non solo per opera dei due eponimi, ebbe fortuna straordinaria nel Settecento: Claude Nicolet, cui si deve una recente reinterpretazione del ruolo di germanesimo e romanità nell’ideologia nazionale francese, ha censito ben settantacinque pubblicazioni sul tema anteriori al 1800. Se la Rivoluzione, l’abbattimento della monarchia e la scomparsa della nobiltà sembrarono mettere fine alla materia stessa del contendere, il contenzioso riprese già nel 1804, con l’opera commissionata da Napoleone al conte di Montlosier. Dopo il 1815, con la Restaurazione, la polemica tornò ad infiammarsi, a sostegno di passioni politiche diametralmente opposte, delle pretese ultraaristocratiche e delle rivendicazioni del terzo stato. È in questa cornice che si inquadra – e al tempo stesso si ridimensiona la pur certa influenza che essa esercitò su Manzoni – l’opera degli storici dottrinari, come Thierry e Guizot. Niente, insomma, era nuovo nel 1820. S’aggiunga che, a diπerenza del Thierry, nella cui interpretazione della storia nazionale l’elemento razziale riveste un ruolo ragguardevole, in Manzoni la contrapposizione fra Germani e Romani – per quanto possa sorprendere chi consideri la fortuna cui era destinata – non compare in quanto tale o è marginale, poiché la divisione sociale, seguìta all’invasione, è da lui ridotta a conseguenza della conquista in sé, quasi senza attribuirle coloritura di scontro di civiltà o di etnia. Per constatare la prossimità dell’ispirazione manzoniana con il tema della conquista così come era stato impostato nel Settecento francese, basti questo squarcio di una Dissertation di Boulainvilliers: «Il est certain que dans le droit commun tous les hommes sont nés égaux; la violence a établi les distinctions de la liberté et de l’esclavage, de la noblesse et de la roture. Mais quoique cette origine soit vicieuse, il y a si longtemps que l’usage en est établi dans le monde qu’il a acquis la force d’une loi naturelle». La loi naturelle di Boulainvilliers è al tempo stesso legge ‘fisica’ e diritto 34 dario mantovani naturale, e richiama alla mente il famoso lamento d’Adelchi: «non restaΩ/Ωche far torto, o patirlo. Una feroceΩ/Ωforza il mondo possiede, e fa nomarsiΩ/Ωdritto» (Atto v, sc. viii, vv. 352-4). Nella versione del 1847, il Discorso contiene del resto un riassunto piuttosto dettagliato del trattato di Dubos, che fa pensare a una conoscenza di prima mano. Nella prima versione, al posto di questo compendio, si trova solo un accenno, il che giustifica una diversa ipotesi. Come ha mostrato Nicolet, la schematizzazione del dibattito e il luogo comune storiografico di opporre i due systèmes di Boulainvilliers e Dubos dipendono quasi esclusivamente dalla lettura che ne diede Montesquieu, nella sesta e ultima parte dell’Esprit des lois (ed è significativo che uno dei primi scritti del Thierry sia una lunga rilettura dell’Esprit, ospitata dal «Censeur européen» del 1818). Il termine «sistema», che nella prima edizione del Discorso qualifica la teoria di Dubos, è la spia che anche la conoscenza che Manzoni aveva del dibattito settecentesco dipendeva da Montesquieu. Ma un’altra e curiosa criptocitazione è ancora più rivelatrice del debito, anche stilistico, verso l’opera di Montesquieu e anche dell’attenzione con cui Manzoni aveva letto le pagine aspre che il barone aveva dedicato proprio all’abate Dubos. Al cap. xxv del libro xxx, dedicato per l’appunto alla noblesse française (De l’Esprit des lois, ed. Parigi 1979, sull’ed. 1757), Montesquieu censura l’opinione di Dubos, secondo cui non vi sarebbe stato che un solo ordine di cittadini fra i Franchi (il che equivaleva a negare che i nobili potessero vantare la propria origine in quel popolo). Fra le prove male interpretate da Dubos, vi è una notizia tratta da una vita di Ludovico il Pio (il terzo figlio di Carlomagno e Ildegarda), in cui uno schiavo aπrancato, Ebone, si lamenta d’essere stato reso solo libero e non nobile. La notizia implica evidentemente che esistevano diπerenze di rango. Dubos non s’arrendeva all’evidenza, supponendo che forse Ebone non era stato schiavo fra i Franchi, ma presso un’altra gente che conosceva la distinzione fra ordini, sconosciuta ai primi. Per prepararci al confronto, leggiamo l’argomento di Dubos e il commento di Montesquieu: «“Peut-être aussi, ajoute-t-il [Dubos] encore, qu’Hébon le vocazioni del «discorso» 35 n’avait point été esclave dans la nation des Francs, mais dans la nation saxonne, ou dans une autre nation germanique, où les citoyens étaient divisés en plusieurs ordres”. Donc, à cause du peutêtre de M. l’abbé Dubos, il n’y aura point eu de noblesse dans la nation des Francs. Mais il n’a jamais plus mal appliqué de peutêtre» (di fatto – dimostra facilmente Montesquieu – dalla stessa cronaca da cui era tratta la notizia risultava che Ebone era stato schiavo dei Franchi). La medesima struttura espressiva ricorre nel cap. iii del Discorso. Manzoni si pone a contestare un’opinione della Storia della Letteratura di Tiraboschi: «“Dovevansi dunque essere, dic’egli [Tiraboschi], e tribunali e giudici italiani, che agli Italiani rendesser giustizia nelle cause che si oπerivano ad esaminare”. Non fu forse mai scritto un dunque tanto precipitato!». Nel passaggio da un ‘forse’ a un ‘dunque’, la pagina di Manzoni ricalca quella di Montesquieu, persino nell’uso del corsivo. Subito dopo, del resto, appone la firma, poiché il passo prosegue citando l’Esprit, questa volta esplicitamente: «e non si può leggerlo senza maraviglia; poiché dopo la pubblicazione dello Spirito delle Leggi, non pare che fosse lecito passare per dir così a canto, senza avvertirlo, a quel fatto capitale delle dominazioni barbariche, la riunione del poter militare e del giudiziario in un solo u√cio, e nelle stesse persone». Un legame intertestuale di tanta intensità conferma quanto fosse presente a Manzoni il dibattito settecentesco, prima ancora che contemporaneo, sulle conseguenze dello stabilimento barbarico in Francia. D’altra parte, questo rimando tenace, sotterraneo e poi dichiarato, all’Esprit des lois rivela la spiccata componente ‘filosofica’ del Discorso. Coincidenze ed eccentricità saranno da misurare tenendo conto d’un appunto autografo del Manzoni – che opportunamente Luca Badini Confalonieri ha riproposto di recente all’attenzione – che avverte: «Nel secolo scorso cominciò la moda della storia trattata filosoficamente […] Tutti gli scrittori più o meno considerano le diverse epoche storiche dal punto di vista del secolo decimottavo […] Montesquieu ha notato questo difetto (Liv. xxx) e quello che è più singolare è ch’egli stesso non ne è esente». 36 dario mantovani 10. La forte curvatura polemica della prosa manzoniana, che indirizza i suoi argomenti verso l’assoluzione (etica) del papato per l’intervento che provocò la caduta del regno longobardo, e la derivazione di alcuni di questi argomenti da opere della tradizione politica italiana e francese, di cui mantenevano il sapore, predisponevano il Discorso a suscitare un vigoroso dibattito in cui storiografia e ideologia sarebbero state più che mai interferenti. A maggior ragione era inevitabile che ciò accadesse nel venticinquennio che trascorse tra l’uscita della prima edizione e il 1847, periodo nel quale era operante la tendenza alla politicizzazione di ogni discussione culturale. Le linee di questo dibattito, in cui la difesa manzoniana della politica papale divenne bandiera del neoguelfismo, sono state più volte ripercorse, secondo l’interpretazione proposta da De Sanctis e fissata da Croce. Dopo gli studi definitivi di Falco e Tabacco sulla ‘questione longobarda’, si attende ora a riportarne alla luce le sfumature, per esempio il contributo dell’erudizione subalpina. Non ci soπermeremo perciò sui contenuti politici della rivisitazione manzoniana della vicenda longobarda e sulla sua ricezione ‘militante’. Basti, qui, accennare che Manzoni non sembra sostenere, nell’Adelchi e nel Discorso, disegni temporalistici, ma piuttosto consideri il ruolo secolare della Chiesa giustificabile solo dove non vi fossero state alternative praticabili. In questa sede interessa invece sottolineare che, raggiunto l’apice negli anni Quaranta con la pubblicazione dell’opera di Carlo Troya, Della condizione de’ Romani vinti da’ Longobardi (uscita a Napoli nel 1841 e ristampata a Milano nel 1844) e con la seconda edizione del Discorso manzoniano, la discussione, pur mantenendo molti dei suoi caratteri originari, abbandonò progressivamente il terreno della storiografia politica, anzi militante – i cui esponenti, da Manzoni a Balbo, da Capponi a Rezzonico, da Troya a Bianchi Giovini erano anche a vario titolo honoratiores implicati nelle vicende risorgimentali – per trasferirsi su quello più pacato della storiografia giuridica (non senza importanti prosecuzioni nel contiguo campo della storia politica d’indirizzo economicogiuridico di Carlo Cipolla e Gioacchino Volpe). Si può anzi dire le vocazioni del «discorso» 37 che la questione longobarda abbia rappresentato forse il tema principe intorno al quale, subito dopo l’Unità d’Italia, la storia del diritto italiano a√nò i propri metodi e stabilì i propri compiti. Il ponte di passaggio fra queste due fasi è senz’altro l’opera giovanile di Francesco Schupfer, Delle istituzioni politiche longobardiche, del 1863. L’opera riepiloga con cristallina chiarezza il dibattito svoltosi in Italia e in Germania nei quarant’anni trascorsi dalla pubblicazione del Discorso, depurandolo tuttavia dalle sue scorie ideologiche (non dalla contrapposizione fra romanità e germanesimo, assurta anzi a principio dominante). Schupfer conclude che i Romani, sotto i Longobardi, erano esclusi dal governo e dai diritti politici; conservavano tuttavia la libertà e la proprietà, e applicavano il diritto romano nella famiglia e nei rapporti patrimoniali fra loro; i municipi erano altresì estinti come comunità sovrane, ma mantenevano vestigia delle pristine istituzioni, ridotte alle funzioni amministrative. Da allora in poi, le istituzioni longobarde rimasero a lungo tema elettivo della storia del diritto italiano, ormai fattasi disciplina accademica. A raccomandarlo come tale era il fatto di costituire terreno comune fra la storia italiana e quella tedesca: era perciò l’interfaccia ideale per la ricezione in Italia dei metodi elaborati dalla scuola giuridica germanistica, cui la neonata scuola italiana cercava di adeguarsi, superando l’esperienza dei trattati di storia della legislazione, tributari del metodo sociologico di Vico e Giannone. La doppia appartenenza, italiana e tedesca, del tema longobardo era rispecchiata dalla vicenda personale di Schupfer, che era nato in Veneto nel 1833 come suddito dell’Impero e aveva compiuto i suoi studi a Innsbruck. Era stato dunque formato dai giuristi tedeschi che, nel solco tracciato da Eichorn, andavano cercando nel primo Medioevo le ragioni dell’originalità del diritto tedesco e le premesse per la sua vitalità anche dopo la ricezione in Germania del diritto romano come ius commune. La ricezione, ai loro occhi, si legittimava proprio perché in precedenza, nel Medioevo barbarico, il diritto germanico era stato a sua volta recepito in Italia e aveva quindi potuto influire più tardi sulla rielaborazione dotta del diritto romano che, a partire dall’XI secolo, le università ita- 38 dario mantovani liane avevano restituito all’Europa. Uno schema, come suggerisce Emanuele Conte, che, dopo il superamento del dualismo germanesimo vs romanità, a√ora ancora oggi nella polarità prassi vs teoria. Se Schupfer era dunque in posizione privilegiata per operare quest’avvicinamento, le condizioni perché si realizzasse erano state preparate dal Discorso. Come l’impulso dapprima fornito alla discussione ideologica in Italia scaturiva dalla struttura polemica del Discorso, così la sua vocazione a favorire dopo l’Unità la nascita della storia giuridica era iscritta nella forte componente giuridica, emersa più volte nel corso dell’analisi. Non a caso, nel presentare i risultati principali della discussione, Schupfer riproduce testualmente intere pagine del Discorso, di cui certifica così la piena validità sotto il profilo tecnico-giuridico. 11. Sarebbe, del resto, un errore assumere come indizio di isolamento dalle correnti più vive della cultura giuridica coeva la mancata conoscenza da parte di Manzoni, nel 1822, della Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter di Friedrich Carl von Savigny, il principale ispiratore del rinnovamento (neoclassico e) romantico della scienza giuridica tedesca. I primi due volumi (relativi all’alto Medioevo) erano usciti ad Heidelberg nel 1815 e nel 1816. L’opera intendeva porre come base della storia del diritto civile lo studio della condizione giuridica dei Romani negli Stati sorti dopo la caduta dell’impero Romano occidentale, ossia innanzitutto lo studio «delle sorti loro generali e della proprietà fondiaria; poi e principalmente quello del politico ordinamento sotto cui vivevano», quindi gli stessi argomenti del Discorso, di cui condivide persino l’ispirazione. «Nulla è più attraente – dichiarava Savigny – nella storia dell’uman genere di quei periodi in cui le forze e attitudini di nazioni diverse si fondono e creano per così dire nuove forme diΩ vita […] Ma se il modo e le ragioni di questa mescolanza sono ancor poco studiate, l’esito felice d’ogni simile indagine dee necessariamente essere fecondo di utili insegnamenti» (trad. it. di Emanuele Bollati). La lacuna, di cui Manzoni fece contrita ammenda nella riedizione del 1847, trova in realtà corrispondenza (e giustificazione) nella le vocazioni del «discorso» 39 cronologia della diπusione della Geschichte di Savigny fra il pubblico colto italiano (documentata specialmente da Laura Moscati). Benché non fossero mancati precoci contatti fra il Savigny e alcuni intellettuali italiani, cui s’era rivolto per documenti d’archivio e informazioni bibliografiche a servizio della redazione dell’opera, notizia e fama della Geschichte cominciarono seriamente a diπondersi solo alla fine degli anni Venti e nel decennio successivo. Principale incentivo alla lettura fu una serie di articoli pubblicata sull’«Antologia» di Vieusseux, fra il 1828 e il 1832, dal giovane giurista Pietro Capei, il più stretto referente toscano del Savigny (al quale, di rimando, faceva notare l’assenza del Giannone fra i suoi autori). È per questo tramite che della Geschichte ebbero notizia, per esempio, Mazzini e Troya. Sull’altro fronte, sempre nel 1828, si interessò a promuoverne una traduzione in italiano Antonio Salvotti, l’inquisitore dei processi del Ventuno, che di Savigny era stato allievo a Landshut. L’incarico, infine disatteso, fu dato proprio a Paride Zajotti, un’altra figura che variamente incrocia il cammino di Manzoni e nella quale si riconosce («oggi che l’interdizione risorgimentale è prescritta», celiò Dionisotti) uno dei maggiori critici letterari del suo tempo. Per tacere del suo ruolo di inquisitore, il suo intervento sui Promessi sposi, che esprime elogi per l’autore e riserve sul genere, costituisce il contributo forse più significativo al dibattito sul romanzo storico che attraversò il mondo letterario italiano intorno al 1830. Va detto, tuttavia, che il primo incontro documentato fra Manzoni e Savigny fu un incontro personale e precedette la divulgazione letteraria della Geschichte in Italia. Avvenne in casa Vieusseux, nel settembre 1827, proprio il mese in cui la «Biblioteca italiana» pubblicava la prima puntata della recensione di Zajotti al romanzo. A Firenze, Savigny era di sosta durante il suo secondo viaggio per le Università italiane, mentre Manzoni, preceduto dal successo strepitoso della Ventisettana, pubblicata in giugno, vi era arrivato a fine agosto, e di qui scriveva a Grossi dei «settantun lenzuolo da risciaquare, e un’acqua come Arno» (Lettere, 265). In quei giorni, anche Leopardi ebbe modo di incontrare il giurista tedesco e di giudicarlo «tanto buono quanto dotto e grande». 40 dario mantovani Il ritardo manifestato da Manzoni nel 1822 rispetto alla nuova scuola storica tedesca, di cui è simbolo la mancata citazione della Geschichte, era dunque il ritardo dell’intera cultura giuridica italiana, invischiata nella transizione dal diritto comune alle nuove codificazioni, in una fase di passaggio, che il continuo rivolgimento di sovranità e dominazioni e quindi di ordinamenti giuridici, rendeva sussultoria e ancora più estenuante. È la situazione d’arretratezza che lo stesso Savigny andava riscontrando nei suoi viaggi per le Università italiane. L’incontro del 1827 con Savigny, propiziato da Giovanni Piero Vieusseux, ci mostra semmai un Manzoni all’avanguardia nella cerchia di intellettuali che s’accingeva a rendere nota la Geschichte al pubblico italiano. Quando Manzoni si volse a rivedere il Discorso, intorno al 1845, l’influenza della Storia di Savigny sulla cultura italiana era un fatto acquisito. Fra il 1844 e il ’45, l’opera di Savigny usciva a Firenze in versione italiana, condotta sulla traduzione (parziale) francese. Nel 1849, la serie degli articoli di ragguaglio pubblicati da Capei erano riuniti in un Compendio. Dieci anni più tardi, fra il 1854 e il 1857, usciva la traduzione integrale di Emanuele Bollati, che tiene conto nelle note del dibattito suscitato da Manzoni e oπre in appendice un ampio saggio di Johannes Merkel sul diritto longobardo (che esamina specialmente la scuola lombardista pavese). L’influenza dell’opera è, per ammissione dello stesso Manzoni, tuttavia pressoché nulla anche sulla nuova edizione del Discorso: una nota al capitolo iii avverte che dopo la lettura della «dotta e insigne Storia del Diritto romano nel medio evo del Signor De Savigny» tutto ciò che gli parve di poter fare fu di riprodurre il capitolo «il meno corretto, come il più incorreggibile». La elegante fin de non recevoir non deve fare perdere di vista due cose. Innanzitutto, che con essa il Manzoni difendeva il merito di avere autonomamente approfondito, nella prima edizione, il senso della sopravvivenza del diritto romano sotto la dominazione longobarda, quando quel senso gli sembrava non fosse stato ancora «proposto, né cercato». Il capitolo, lasciato inalterato, rimaneva insomma a rivendicare il primato. le vocazioni del «discorso» 41 Inoltre, pur senza scendere in lizza con il nome di Savigny, la seconda edizione, a ben vedere, contiene ugualmente una lunga confutazione della teoria savigniana sulla continuazione dei municipi romani sotto il governo longobardo. Questa teoria, infatti, era stata sostenuta nel 1830 dal Romagnosi, che l’aveva ripresa proprio dalla Geschichte (nel 1823 era stata proposta anche dal Pagnoncelli, che vi era tuttavia giunto indipendentemente dalla Geschichte, di cui dichiara di conoscere solo un ristretto apparso su una rivista ginevrina: menzione, questa, dell’opera savignana che dovrebbe annoverarsi fra le più precoci nella nostra letteratura). La lunga Appendice aggiunta nel 1847 al terzo capitolo del Discorso, in cui Manzoni confuta le ragioni portate dal Romagnosi nel trattato Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento per dimostrare che, sotto i Longobardi, gli Italiani conservarono i loro municipi ed ebbero giudici della loro nazione – la cui importanza ha attratto per altri versi l’attenzione di Donato Valli – può dunque considerarsi anche una critica indiretta al libro di Savigny, a cui Romagnosi si rifaceva. Va aggiunto, per chiarire il rapporto fra le tesi del Discorso e quelle della Geschichte, che se divergono nel punto fondamentale (i Romani furono probabilmente schiavi per Manzoni, liberi per Savigny) e per quanto riguarda la continuità della costituzione municipale (interrotta dall’invasione secondo Manzoni, conservata secondo Savigny), esse sono molto vicine nell’aπermare la sopravvivenza del diritto romano, su cui verteva quel capitolo terzo del Discorso, che Manzoni lasciò inalterato. Entrambi gli scrittori traevano dalle leggi longobarde, in particolare da Liut. 91 e 127, la prova che gli indigeni continuarono a vivere secondo il diritto romano. Naturalmente, questa facoltà si addice meglio a individui lasciati liberi e titolari di un patrimonio, come Savigny riteneva fossero i Romani, piuttosto che a degli schiavi, come Manzoni sospettava fossero stati resi. S’è già avuto modo di osservare, tuttavia, che, grazie alla struttura argomentativa del Discorso, questa contraddizione non deflagra: infatti, la facoltà di vivere secondo il proprio diritto vi è esaminata in negativo, per smentire che la concessione fosse da ascrivere alla «bontà morale» dei 42 dario mantovani Longobardi, trattandosi invece, secondo Manzoni, di un riflesso dell’indiπerenza, mai mutata, degli invasori per la sorte dei vinti. Se in questo punto il Discorso si salva solo per virtù dialettica, altrove bisogna riconoscere che Manzoni si dimostra, invece, persino più sagace dell’illustre giurista in questo confronto a distanza. I dubbi che Manzoni esprimeva sulla pertinenza italiana della Lex Romana Utinensis, che Savigny adduceva come prova regina della continuazione della municipalità romana sotto i Longobardi, sono stati infatti confermati dalla scoperta di altri manoscritti, che accreditano l’ipotesi della provenienza del testo dalla Rezia, l’odierno cantone dei Grigioni, tant’è che oggi si preferisce chiamarla Lex Romana Curiensis. In definitiva, anche a paragone della Geschichte di Savigny, rispetto alla quale nasce indipendente, il Discorso mostra un dominio dei fenomeni giuridici più che adeguato se commisurato alle condizioni della coeva cultura italiana, che erano invece, in generale, piuttosto arretrate. Sono proprio tali condizioni culturali che resero più facile accogliere dapprima la vocazione ideologica del Discorso, la cui forte carica giuridica, tuttavia, dissodava al contempo anche il terreno per la rinascita, dopo l’Unità, degli studi di diritto, di cui l’opera di Schupfer fu l’araldo. 12. Lungo la linea di studio avviata da Schupfer, si succedettero alcune delle personalità che hanno illustrato la storia del diritto italiano: alla fine dell’Ottocento, Pasquale Del Giudice, Nino Tamassia, Francesco Brandileone, Augusto Gaudenzi; nel Novecento, Enrico Besta, Pier Silverio Leicht, Guido Astuti, Gian Piero Bognetti, Adriano Cavanna, per ricordarne solo alcune. Nel corso del XX secolo il baricentro dell’italianistica si è, tuttavia, spostato progressivamente verso la modernità e ora sotto la lente è semmai l’estremo opposto della storia giuridica nazionale, l’età dei Codici. In un certo senso, come a metà del XIX secolo la figura di Schupfer simboleggia la ricezione della questione longobarda come tema all’ordine del giorno per i giuristi, così a metà del XX quella di Gian Piero Bognetti incarna la riconsegna dell’età longobarda alla medievistica. le vocazioni del «discorso» 43 È una disciplina, quest’ultima, ovviamente ben lontana dall’erudizione risorgimentale screziata di ideologia. Dotatasi di nuove categorie antropologiche, capace di approfondire fonti e intenzioni della tradizione scritta sul regno longobardo, attenta alle componenti religiose e culturali dell’identità dei popoli in migrazione, e soprattutto disposta a includere nelle fonti l’evidenza archeologica e le testimonianze artistiche, la medievistica odierna ha superato lo schematismo unità/divisione sotto cui era impostata la questione longobarda nel XIX secolo. Il metodo etno-sociologico ha infranto la base scientifica del mito moderno del conflitto fra Romani e Germani quale origine delle nazioni occidentali e tolto fiato alle strumentalizzazioni, anche in chiave razzista, cui quel mito s’è talvolta prestato. In chiave di «etnogenesi», il concetto di civiltà longobarda (e a maggior ragione germanica) appare oggi da scomporre in uno spettro di componenti, alcune delle quali oltretutto di provenienza bizantina e assorbite dai Longobardi durante la stanza pannonica in qualità di federati dell’Impero. Portate in Italia dagli invasori, queste caratteristiche si sono legate a quelle del (di per sé variegato) sostrato indigeno romanico e agli influssi provenienti dal circuito mediterraneo. L’identità dell’Italia altomedievale ha origine dall’incontro, su un piede di pari dignità, di questi fattori. Che durante i due secoli del regno longobardo si siano verificati fenomeni di intensa acculturazione fra invasori e sostrato indigeno è evidente a livello linguistico, e della cultura giuridica e artistica. I fenomeni sono noti: i Longobardi assunsero il latino come lingua, almeno a partire dall’VIII secolo; la legislazione longobarda, pur essendo rielaborazione delle cawarfide tribali, lascia trapelare la conoscenza e il riuso di fonti giuridiche romane, oltre che di altre genti germaniche; l’architettura assorbì influenze anche orientali. Sul piano religioso, i Longobardi, come si sa, abbandonarono il paganesimo e, ripudiando prima l’arianesimo e poi l’eresia dei Tre Capitoli, si convertirono al cristianesimo della Chiesa di Roma: il sinodo pavese in cui fu respinta la dottrina tricapitolina è del 698, dunque poco più di un secolo dopo l’ingresso dei Longobardi in Italia, in tempo per spiegare molti eπetti. È no- 44 dario mantovani to che la maggior parte dei monasteri di origine anteriore al Mille è di fondazione longobarda. L’acculturazione non fu comunque a senso unico, del tipo Graecia capta ferum victorem cepit. L’onomastica segnala l’integrazione reciproca e dai documenti privati è impossibile distinguere l’etnia solo in base ai nomi. Nemmeno i materiali di corredo sembrano più oπrire un criterio sicuro di identificazione etnica degli inumati. In questo quadro interculturale, si ritiene oggi – per venire a un punto particolarmente sensibile – che i Romani fossero stati inclusi come arimanni nell’esercito longobardo almeno dall’età di Liutprando e forse già alla fine del VII secolo, durante il regno di Cuniperto. Non occorre sottolineare le implicazioni dirompenti di un simile fenomeno. Il regno dei Longobardi in Italia fu «una gerarchia militare capillarmente distribuita sul territorio» – per usare la formula proposta da Giovanni Tabacco nel saggio fondamentale sugli ‘esercitali’ – e questa caratteristica impronta di sé tutte le manifestazioni del regno. L’editto di Rotari, e le altre leggi, ad esempio, furono emesse in un’assemblea generale dell’esercito (il che non stupirà peraltro chi ricordi che la principale assemblea politica della Roma repubblicana, che votava leggi ed eleggeva magistrati, ossia il comizio centuriato, era precisamente l’exercitus). L’ingresso degli indigeni fra gli armati implicherebbe una trasformazione profonda dell’ordine sociale e il superamento della fase che vedeva i Longobardi come popolo armato e dominatore sul suolo italico. Lo «splendido sogno giovanil» di Adelchi, chiamare appunto i Romani alle armi per fare fronte comune con i Longobardi contro i Franchi, sarebbe dunque stato realizzato dalla storia, e quasi un secolo prima della fine del Regno. Eccoci così tornati al paradosso, da cui abbiamo preso l’avvio, della storia che supera la poesia. Ai nostri fini, non occorre discutere se l’assimilazione dei Romani agli arimanni sia realmente avvenuta (ipotesi che dipende in buona parte da una discutibile interpretazione in senso territoriale delle leggi di Astolfo del 750: Ai. 2-3). È su√ciente ammettere che l’impostazione manzoniana si precludeva a priori di riconoscere le metamorfosi subite dalla società romano-barbarica per eπet- le vocazioni del «discorso» 45 to del prolungato contatto fra invasori e vinti, specialmente all’interno delle città, come l’archeologia urbana tende oggi a dimostrare. Proprio per il fine dimostrativo che si prefiggeva, valutare l’operato dei Papi nel periodo dell’ultima dinastia longobarda, il Discorso tende infatti a rendere inerte il fattore tempo. Le condizioni della conquista non mutano nell’arco dei due secoli di stanziamento e non conoscono miglioramento. Questa sottrazione alla storia del suo movimento (che getta «quasi una maledizione di sterilità», se è consentito servirsi di queste parole contro il loro autore) è esplicitamente teorizzata da Manzoni fin dal primo momento in cui espose al Fauriel il proprio progetto, nell’ottobre del 1820 (Carteggio Manzoni-Fauriel, 63): «je trouve que depuis Machiavel jusqu’à Denina et après, tous s’accordent à régarder les Lombards comme des Italiens, et ce là par l’excellente raison que leur établissement en Italie a duré plus de deux siècle. Les Turcs à ce compte doivent être bien Grecs», argomento per assurdo ripreso alla lettera nel secondo capitolo del Discorso, con il quale viene accantonata la multiforme acculturazione prodotta invece in quei secoli (e almeno in parte già discernibile al tempo di Manzoni). 13. Di fronte alle nuove categorie interpretative, la qualificazione giuridica dei fenomeni sembra essere giudicata oggi poco proficua. Proprio per la sua natura prescrittiva, la legislazione tende a proiettare un’immagine schematica della società, che non garantisce di riflettere le nuance del sostrato sociale. Non stupisce, perciò, che la medievistica odierna di√di delle possibili schematizzazioni. In questo cambio di paradigma, si misura la distanza rispetto al Discorso di Manzoni, che invece inquadrava il rapporto fra Longobardi e Romani impiegando quasi esclusivamente le categorie del diritto. Il saggio manzoniano sembrerebbe dunque avere esaurito la propria vocazione ad alimentare il processo storiografico. In realtà, il ricorso alla qualificazione giuridica in funzione della comprensione del passato continua ad essere necessario. Il diritto (nel nostro caso il diritto longobardo), infatti, descrive i fenomeni secondo categorie proprie della società che esso ordina. Questa funzione di autorappresentazione è ben nota e non conviene insi- 46 dario mantovani stervi. Vale la pena però di ricordare che uno fra gli studiosi odierni dell’età longobarda più sensibili al problema giuridico ha supposto che la rimozione del passato longobardo, che si riscontra nella memoria municipale e nazionale, sia da ricollegare, in misura rilevante, al prevalere del diritto romano su quello longobardo nel corso del XII secolo. «Il diritto longobardo – scrive Stefano Gasparri nel saggio su oblio e memoria – aveva rappresentato il canale attraverso il quale la tradizione civile del regno e della sua popolazione libera si era perpetuata attraverso i secoli, in età carolingia e postcarolingia». Questa spiegazione presuppone l’importanza fondamentale del diritto nella costruzione e nella conservazione di un’identità, dal punto di vista stesso della società coeva. Posta questa premessa, sarebbe fuori luogo inoltrarsi in percorsi di revisione. È bene tuttavia accennare a qualche testo e problema, che possa se non altro suggerire l’attualità dell’impostazione manzoniana, che consiste proprio nell’additare l’importanza del diritto come strumento di analisi storica. Fra gli argomenti da sempre addotti a favore dell’integrazione fra Longobardi e Romani vi sono i matrimoni misti, quale fenomeno che può, nel tempo, aver prodotto una fusione etnica. Manzoni trovava quest’argomento in Muratori e lo confutava con un ragionamento giuridico incontrovertibile: «Quell’egregio scrittore non si rammentò che, in quelle stesse leggi longobardiche che furono ristampate e commentate da lui, sta scritto: “Se un Romano avrà sposato una Longobarda […], questa è diventata romana, e i figli che nasceranno da un tal matrimonio, siano romani, e seguano la legge del padre”. Sicchè questo fatto non serve ad altro che a somministrarci una testimonianza della separazione de’ due popoli» (cap. 2). La norma cui allude Manzoni è la legge 127, emessa da Liutprando nel diciannovesimo anno di regno, ossia nel 731. Poiché, oltre al precetto, è importante la sua lettera, conviene riprodurla: «Si quis romanus homo mulierem langobardam tolerit, et mundium ex ea fecerit, et post eius decessum ad alium ambolaverit maritum sine volontatem heredum prioris mariti, faida et anagrip non requiratur. quia posteûs romanum maritum se copolavit, et ipse ex ea mundio fecit, romana eπecta est, et filii, qui de eo matrimonio nascun- le vocazioni del «discorso» 47 tur, secundum legem patris romani fiunt et legem patris vivunt; ideo faida et anagrip menime conponere devit, qui eam postea tolit, sicut nec de alia romana» (ossia: se un Romano avrà sposato una Longobarda e ne avrà acquistato il mundio e dopo la morte di lui ella sarà passata ad un nuovo matrimonio senza l’assenso degli eredi del primo marito, non è dovuta [la composizione per] la faida e per l’unione illecita. Infatti, essendosi unita in coniugio con un marito romano, e avendo costui acquistato il mundio, è diventata romana e i figli che nascono da un tal matrimonio, secondo la legge del padre sono romani, e vivono secondo la legge del padre; perciò chi l’ha presa successivamente in moglie non deve assolutamente pagare per la faida e l’unione illecita, così come non dovrebbe se sposasse un’altra romana). Il senso è chiaro. La vedova, secondo l’editto di Rotari (188), poteva risposarsi solo con il consenso degli eredi del primo marito (in specie, i figli); altrimenti, l’unione era illecita e il secondo marito sarebbe stato esposto alla vendetta dei parenti, cui poteva sottrarsi con la composizione pecuniaria. Rispetto alla norma generale posta da Rotari, il caso aπrontato da Liutprando presentava una particolarità: in primo matrimonio, la donna s’era unita a un Romano. Il connubio e l’acquisto del mundio, chiarisce Liutprando, l’hanno resa Romana e pure i figli legittimi seguono la cittadinanza del padre e vivono secondo il diritto romano. Ecco perché non si applica la norma del diritto di famiglia longobardo. Questa disposizione, oltre che per il suo contenuto, è eloquente per la sua forma. A diπerenza di quanto spesso si ritiene, il suo carattere non è innovativo. Si tratta, come la semplice lettura dimostra meglio di qualunque parafrasi, di una norma emessa per eliminare un dubbio sorto su una questione molto specifica. Del resto, per loro natura, le integrazioni che i re successivi apportano all’editto di Rotari sono spesso suscitate dall’esigenza di chiarire dubbi applicativi (come i prologhi non mancano di protestare). Due sono le implicazioni fondamentali. Innanzitutto, che al tempo di Liutprando permaneva una precisa distinzione fra nazioni, su base giuridica. In secondo luogo, che la vigenza del diritto ro- 48 dario mantovani mano non è posta, bensì presupposta dalla norma di Liutprando. La coesistenza parallela dei due ordinamenti risaliva ai re suoi predecessori, e quindi a Rotari, e si era trasmessa formalmente immutata a lui, che, nel risolvere un caso singolo, la dà per scontata. Questo significa che, quand’anche vi fossero stati numerosi matrimoni misti – la dimensione del fenomeno, per inciso, è sconosciuta: un inconveniente non trascurabile per qualunque ricostruzione che aspiri ad essere realistica – essi avrebbero avuto certamente l’eπetto di mettere in comune il corredo genetico delle due popolazioni (che, in entrambi i casi, era già di per sé molto variegato). Questo sul piano della natura. Dal punto di vista dell’identità culturale, tuttavia, il diritto manteneva una precisa distinzione; i figli seguivano la condizione giuridica del padre. Dunque i figli erano qualificati o come Longobardi o come Romani, con una qualificazione alternativa, che ovviamente prescindeva dal crossing over biologico (o dai reciproci scambi culturali). Per converso, la distinzione formale operava come fattore di conservazione delle rispettive identità culturali. Basti ricordare – come trapela anche dalla norma di Liutprando – che il diritto determinava la struttura stessa della famiglia, oltre a regolare l’accesso al potere politico. Passando dalle dichiarazioni di principio alla realtà, una nota carta piacentina del 758 (CDL, ii 130) conserva il ricordo di una certa Gunderada, honesta femina, donna di rango, che dichiara esplicitamente d’essere Romana mulier. La carta – il cui contenuto non è immune da contaminazioni con la prassi longobarda – non attesta solo la persistente distinzione etnica, ma sembra confermare anche il principio espresso da Liut. 127. Se i nomi dei protagonisti – pur con tutte le cautele – raccontano qualcosa, è probabile che sia stato il matrimonio con Domninus a trasformare Gunderada in Romana. La discussione, naturalmente, porterebbe troppo lontano e dovrebbe del resto coinvolgere lo stesso versante giuridico, poiché anche fra gli storici del diritto non v’è identità di vedute su una questione fondamentale, se l’editto longobardo fosse divenuto (almeno a partire da Liutprando) territoriale (l’argomento a favore della territorialità dedotto a contrario dall’espressione «si quis Lango- le vocazioni del «discorso» 49 bardus», che ricorre solo in alcune norme di Liutprando, così che le altre sarebbero destinate a Longobardi e Romani, ci pare peraltro assolutamente reversibile). Le due posizioni sono entrambe vitali, tanto da essere ancora accolte in autorevoli ricostruzioni d’insieme, come quelle di Antonio Padoa Schioppa e di Ennio Cortese. Resta, tuttavia, che in linea di principio la distinzione è nitida, così come l’aveva vista Manzoni. Sia consentito, per concludere, menzionare una celebre charta donationis, da cui risulta che la distinzione su base giuridica non fosse solo un principio legislativo, ma trovasse rispondenza nella realtà. Il 6 dicembre 767, in Vico Bisbetuni, otto persone, un subdiacono e sette laici, donarono ad Anselperga – l’Ansberga manzoniana, figlia di Desiderio e sorella d’Ermengarda, moglie di Carlomagno poi ripudiata – abbadessa del monastero di S. Salvatore a Brescia («que domnus Desiderius rex a fundamenti edificauet») una porzione di terreno (altri interpretano i diritti di pesca) in Rio Torto, nel modenese (CDL, ii 212). Uno degli otto donanti, Benenato figlio di Stefano, nella sottoscrizione fa annotare: «iuxta lege sua Langobardorum recepit launechit manetia par uno», ossia dà atto di aver ricevuto il ‘corrispettivo’ simbolico che era necessario per la validità della donazione (non rileva qui che, secondo Liut. 73, le donazioni pro anima alla chiesa, ai luoghi santi e xenodochi fossero eccezionalmente ritenute irrevocabili anche senza launigild o thingatio). Se ne ricava, perciò, che gli altri sette donanti – che non menzionano il launigild né dichiarano di vivere secondo la legge longobarda – non fossero Longobardi e che vivessero secondo una diversa lex, ossia il diritto romano, il che è avvalorato dal fatto che la donazione contiene una clausola di irrevocabilità di tradizione romana (che il solo a dichiarare la propria appartenenza sia il Longobardo non è da interpretare come un riflesso di superiorità: corrisponde al fatto che, degli otto, egli fosse l’unico che, secondo il proprio diritto, era tenuto a un comportamento aggiuntivo – dare ricevuta del launigild – per conferire validità alla donazione). Ecco attestata, al tempo di Adelchi, la persistente distinzione, su base giuridica, degli invasori e dei vinti. 50 dario mantovani Che poi Romani e Longobardi, in Vico Bisbetuni, appaiano coinvolti in un atto di beneficenza e aπratellati da un’unica fede, è una di quelle constatazioni che raccomandano di congiungere lo studio (indispensabile) del diritto a quello (altrettanto necessario) della società, se si vuole raggiungere una comprensione integrale dell’età longobarda. 14. Il tentativo di scomporre le parti del Discorso, di indicarne alcune fonti d’ispirazione prossime o mediate, di ribadirne il valore per la comprensione della storia letteraria dell’Adelchi, di suggerirne la duplice, duratura vocazione ad alimentare la storiografia politico-ideologica e quella giuridica, aveva un solo intento: quello di invitare alla lettura di un testo che, proprio per il contenuto tecnico e per i suoi presupposti, può opporre qualche resistenza, che vale però la pena di vincere. Ogni lettore potrà sperimentare, infatti, che, prima d’ogni altro insegnamento, il Discorso oπre l’esempio di come una seria indagine storiografica si concilî con la grazia dell’espressione. nota bibliografica Sono qui elencate, in ordine alfabetico, le opere citate nella Premessa, ripartite per argomento. In relazione ai temi di interesse storiografico ancora attuale, sono aggiunti, in ordine cronologico, alcuni titoli per un primo orientamento bibliografico. edizioni Per la prima stesura dell’Adelchi, il testo di riferimento è: Adelchi, edizione critica a cura di I. Becherucci, Firenze, Accademia della Crusca, 1998 (Adelchi 1998). Per l’edizione definitiva, del 1847: Poesie e tragedie, a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, Milano, Mondadori, 1957, in Tutte le opere, vol. i. le vocazioni del «discorso» 51 Per le lettere di Manzoni: Tutte le lettere, a cura di C. Arieti. Con un’aggiunta di lettere inedite o disperse, a cura di D. Isella, Milano, Adelphi, 1986, voll. 3 (Lettere, seguìto dal numero della lettera). In particolare, per il carteggio con Fauriel: Carteggio Alessandro Manzoni - Claude Fauriel, a cura di I. Botta. Premessa di E. Raimondi, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2000. Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di Alessandro Manzoni, vol. 27 (Carteggio Manzoni-Fauriel). Le leggi longobarde sono citate secondo l’editio minor riveduta, Edictus ceteraeque Langobardorum leges cum constitutionibus et pactis principum Beneventanorum ex maiore editione monumentis Germaniae inserta correctiores recudi curavit Fridericus Bluhme, Hanoverae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1869 (Ai. = Astolfo; Liut. = Liutprando, seguìti dal numero della legge). Per una trad. it.: Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Milano, La Storia, 1992. Le chartae citate sono edite in L. Schiaparelli, Codice Diplomatico Longobardo, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, vol. ii, 1933 (CDL). Per Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, si veda l’edizione a cura di L. Capo, [Milano], Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore, 1992 (Hist. Lang.). storiografia preunitaria sui longobardi in italia C. Baudi di Vesme - S. Fossati, Vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell’imperio romano fino allo stabilimento dei feudi, «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», xxxix (1836). A. Bianchi Giovini, Storia dei Langobardi, Milano, Stabilimento di Civelli, 1846. P. Capei, Sulla dominazione dei Longobardi in Italia, discorso al marchese G. Capponi, Appendice all’«Archivio storico italiano», xii (1845), pp. 496-548. G. Capponi, Sulla dominazione dei Longobardi in Italia e altri saggi (1846), rist. Roma, Colombo, 1945. 52 dario mantovani G. Tamassia, Storia del regno dei Goti e dei Longobardi in Italia, Bergamo, Mazzoleni, 1825-1826, voll. 3. C. Troya, Della condizione de’ Romani vinti da’ Longobardi, Milano, Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1844. relazione fra longobardi e romani nella storiografia giuridica G. Astuti, Lezioni di storia del diritto italiano. Le Fonti. Età romanobarbarica, Padova, Cedam, 1953. E. Besta, Fonti del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano sino ai tempi nostri, Padova, Cedam, 1938. G. P. Bognetti, Longobardi e Romani, in L’età longobarda, Milano, Giuπré, vol. i, 1966, pp. 83-141. A. Cavanna, La civiltà giuridica longobarda, in I longobardi e la Lombardia. Saggi (Milano, Palazzo Reale, 12 ottobre 1978), San Donato Milanese, F.lli Azzimonti, s. d., pp. 1-34. E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, voll. 2. A. Padoa Schioppa, Il diritto nella storia d’Europa. 1. Il Medioevo, Padova, Cedam, 1995. F. Schupfer, Delle istituzioni politiche longobardiche. Libri due, Firenze, Le Monnier, 1863. F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici, con speciale riguardo all’Italia, vol. i. Le persone, la famiglia, Città di Castello, Lapi, 1907. N. Tamassia, Longobardi, Franchi e Chiesa Romana fino a’ tempi di re Liutprando, Bologna, Zanichelli, 1888. P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 20029. le vocazioni del «discorso» 53 relazione fra longobardi e romani sul versante della medievistica C. Cipolla, Della supposta fusione degli Italiani coi Germani nei primi secoli del Medioevo, «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, cl. mor.», s. v, ix (1900), pp. 329-60; 369-422; 517-603. G. Tabacco, Dai possessori dell’età carolingia agli esercitali dell’età longobarda, «Studi medievali», x (1969), pp. 221-68. G. Volpe, Origine e primo svolgimento dei Comuni nell’età Longobarda. Studi preparatori (1904), poi a cura di G. Rossetti, presentazione di C. Violante, Roma, Volpe, 1976. J. Jarnut, Storia dei longobardi, Torino, Einaudi, 1965, rist. 2002; W. Goffart, Barbarians and Romans. A. D. 418-584. The Techniques of Accomodation, Princeton, Princeton University Press, 1980; Chr. Wickham, L’Italia nel primo Medioevo. Potere centrale e società locale, 400-1000, Milano, Jaca book, 1983; A. Melucco Vaccaro, I Longobardi in Italia. Materiali e problemi, Milano, Longanesi, 1988; P. Delogu, Longobardi e romani: altre congetture, in Langobardia, a cura di S. Gasparri, P. Cammarosano, Udine, Casamassima, 1990, pp. 111-67; S. Gasparri, Il regno e la legge: Longobardi, Romani e Franchi nello sviluppo dell’ordinamento pubblico (secoli VI-X), «La Cultura», xxviii (1990), pp. 243-66; A. A. Settia, Longobardi in Italia: necropoli altomedievali e ricerca storica, «Rivista storica italiana», cv (1993), pp. 744-63; S. Gasparri, Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo, Roma, NIS, 1997; G. P. Brogiolo S. Gelichi, La città nell’alto Medioevo italiano. Archeologia e storia, Roma-Bari, Laterza, 1998; E. Migliario - Chr. Wickham, Continuità e fratture tra tardo antico e alto Medioevo, in Storia della società italiana. 4. Restaurazione e destrutturazione nella tarda antichità, Milano, Teti, 1998, pp. 647-83; B. Pohl-Resl, Legal practice and ethnic identity in Lombard Italy, in Strategies of distinction. The Construction of Ethnic Communities, 300-800, edited by W. Pohl with H. Reimitz, Leiden Boston Köln, Brill, 1998, pp. 205-20; W. Pohl, Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani fra antichità e medioevo, presentazione di A. A. Settia, Roma, Viella, 2000; G. Arnaldi, L’Italia e i suoi invasori, Roma-Bari, Laterza, 2002; Chr. Witschel, Rom und die Städte Italiens in Spätantike und Frühmittelalter, «Bonner Jahrbücher», cci (2001, ma pubblicato nel 2004), pp. 113-62. 54 dario mantovani il papato da gregorio magno a adriano iii O. Bertolini, Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi, Bologna, Cappelli, 1941; C. Azzara, L’ideologia del potere regio nel papato altomedievale (secoli VI-VIII), Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 1997; F. Marazzi, I patrimonia Sanctae Romanae Ecclesiae nel Lazio (secoli IV-X). Struttura amministrativa e prassi gestionali, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1998. premesse culturali del discorso G. Nava, Il Manzoni e l’«Histoire des républiques italiennes» del Sismondi, in «Studia ghisleriana. Studi letterari», s. ii, vol. iii (1967), pp. 143-72. U. Pirotti, Il Muratori e il Manzoni, «Convivium (Scritti sul Muratori)», iv-v (1950), pp. 533-75. C. De Lollis, Alessandro Manzoni e gli storici liberali francesi della Restaurazione (1926), ora in Scrittori d’Italia, a cura di G. Contini e V. Santoli, Milano-Napoli, Ricciardi, 1968; E. Gabbuti, Il Manzoni e gli ideologi francesi. Studi sul pensiero e sull’arte di Alessandro Manzoni, Firenze, Sansoni, 1936; T. S. Brown, Gibbon, Hodgkin and the invaders of Italy, in Edward Gibbon and Empire, ed. by R. McKitterick and R. Quinault, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 137-61; G. Gaspari, «Dove mai si va a ficcare il diritto»: legge e lettere tra Sette e Ottocento, in Con felice esattezza. Economia e diritto fra lingua e letteratura, a cura di I. Domenighetti, Bellinzona, Casagrande, 1998, pp. 199-231. la ‘questione longobarda’ nel secolo xix B. Croce, Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono. 2. ed. riv. con un’appendice sulla storiografia recente, Bari, Laterza, 1930. F. De Sanctis, Manzoni, a cura di C. Muscetta e D. Puccini, Torino, Einaudi, 1983. G. Falco, La questione longobarda e la moderna storiografia italiana, «Rivista storica italiana», lxiii (1951), pp. 265-78, poi CISAM. le vocazioni del «discorso» 55 Atti del primo Congresso internazionale di studi longobardi, Spoleto, 1952, pp. 153-66, infine in Pagine sparse di storia e di vita, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960, pp. 11-26. S. Gasparri, I Longobardi fra oblio e memoria, in Studi sul medioevo per Girolamo Arnaldi, a cura di G. Barone, L. Capo, S. Gasparri, Roma, Viella, 2000, pp. 237-77. G. Tabacco, La città italiana fra germanesimo e latinità nella medievistica ottocentesca, in Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell’Ottocento: il Medioevo, Bologna-Berlino, Il Mulino Duncker & Humblot, 1988 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi, 1), pp. 23-42. D. Valli, Romagnosi e Manzoni tra realtà e storia, Lecce, Milella, 1968. A. Visconti, Il pensiero storico-giuridico di Alessandro Manzoni nelle sue opere. Studio di storiografia giuridica del sec. XIX, «Archivio storico lombardo», xlvi (1919), pp. 382-440; P. Vaccari, La caduta della dinastia longobarda e la interpretazione storica di Manzoni, «Rendiconti Istituto lombardo Sc. Lett.», lvi (1923), pp. 54653; D. Moscarda, Sulla condizione dei Romani durante la dominazione longobarda nella storiografia dell’Ottocento, «Annali della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università di Roma», v (1965), pp. 97-113; L. De Courten, La civiltà longobarda in Italia nei più recenti studi, «Annali della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università di Roma», xiv (1974), pp. 4259; L. Moscati, Federico Sclopis storico dei Longobardi, «Rassegna storica del Risorgimento», lxvi (1979), pp. 259-76; P. Delogu, Il regno longobardo, in P. Delogu, A. Guillou, G. Ortalli, Longobardi e Bizantini, Torino, Utet, 1980, pp. 3-216 (Storia d’Italia, diretta da G. Galasso); G. P. Romagnani, La questione longobarda nella storiografia piemontese della Restaurazione, in Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1985, pp. 235-72; G. Panazza, Il concorso per il premio biennale dell’ateneo di Brescia sull’architettura longobarda del 1826-1829, Brescia, Ateneo di Brescia - Accademia di scienze, lettere ed arti, 1986; M. Dell’Omo, Dall’«Epistolario Tosti» dell'Archivio privato di Montecassino, i. Documenti della medievistica ottocentesca. Due lettere inedite di Carlo Troya a D. Luigi Tosti sulla ‘questione longobarda’, «Monastica», vii (1987), pp. 165-217; E. Gabba, L’età imperiale romana nella storiografia italiana dell’Ottocen- 56 dario mantovani to, in L’impero romano fra storia generale e storia locale, a cura di E. Gabba e K. Christ, Como, New Press, 1991, pp. 43-56; P. Cammarosano, Tradizione, storiografia e storia dei Longobardi: un cenno introduttivo, in Langobardia, pp. vi-xxi; Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno. Saggi, a cura di C. Bertelli, G. P. Brogiolo, Milano, Skira, 2000. savigny e l’italia L. Moscati, Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione, Roma, Viella, 2000. schupfer E. Conte, Eine Rezeption germanischen Rechts in Italien? Römisch-wissenschaftliches Recht und vulgarrechtliche Tradition in den italienischen Städten des 12. und 13. Jahrhunderts, in Die Rezeption des gelehrten Rechts im ‘Regnum teutonicum’. Kolloquium der Werner-Reimers-Stiftung im Februar 1998, hrsg. I. Baumgärtner, P. Johanek (in corso di pubblicazione). interpretazioni del discorso in relazione al pensiero storico di manzoni L. Badini Confalonieri, Per una rilettura del Manzoni storico, in La lotta con Proteo. Metamorfosi del testo e testualità della critica. Atti del xvi congresso A.I.S.L.L.I (Los Angeles, UCLA, 6-9 october 1997), a cura di L. Ballerini, G. Bardin e M. Ciavolella, Fiesole, Cadmo, 2000, vol. i, pp. 607-12. G. P. Bognetti, Manzoni giovane, a cura di M. Cataudella, Napoli, Guida, 1972. F. Ghisalberti, Il «Discorso sui Longobardi», in A. Manzoni, Saggi storici e politici, a cura di F. Ghisalberti, Milano, Mondadori, 1963, pp. 719-25, in Tutte le opere, vol. iv. B. Croce, Alessandro Manzoni. Saggi e discussioni, Bari, Laterza, 19524; B. Reizov, La teoria del processo storico nella tragedia «Adel- le vocazioni del «discorso» 57 chi» di A. Manzoni, «Aevum», xlii (1968), pp. 70-90; B. Fazio Allmayer, La formazione del pensiero etico-storico del Manzoni, Firenze, Sansoni, 19692; A. R. Pupino, «Il vero solo è bello». Manzoni tra Retorica e Logica, Bologna, il Mulino, 1982; De Sanctis, Manzoni; G. Barberi Squarotti, La storia impraticabile: le tragedie del Manzoni, «Forum italicum», xix (1985), pp. 205-36; P. Brezzi, Gli scritti storici di Alessandro Manzoni, «Cultura e scuola», xxiv (1985), pp. 56-72; A. Di Benedetto, Il «Discorso» sulla dominazione longobardica, in Manzoni e il suo impegno civile, Azzate, Otto/Novecento, 1986, pp. 109-28; A. Stella, Alessandro Manzoni, in Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, Roma, Salerno Editrice, 1998, vol. vii, pp. 605-725. rapporto fra il discorso e l’adelchi A. Accame Bobbio, Storia dell’«Adelchi», Firenze, Le Monnier, 1963. I. Becherucci, Alessandro Manzoni, «Adelchi»: per l’edizione critica delle prose storiche, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, cl. lett. e fil.», s. iv, Quaderni, i (1998), pp. 201-14. I. Becherucci, «Una storia così bella…»: suggestioni per l’«Adelchi», «Annali manzoniani», n. s., iii (1999), pp. 95-114. I. Becherucci, Sulla ‘crisi’ dell’«Adelchi», «Rivista di letteratura italiana», xii (1994), 2-3, pp. 383-400; I. Becherucci, Il dialogo con gli storici dei Longobardi. Postille manzoniane edite e inedite, «Per leggere», ii (2002), 3, pp. 101-27.
Scarica