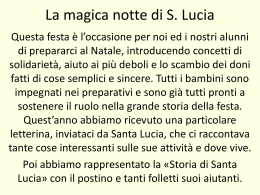Gianfranco Salvatore PARODIE REALISTICHE Africanismi, fraternità e sentimenti identitari nelle canzoni moresche del Cinquecento1 testo in progress di prossima pubblicazione su «Kronos» VIETATA OGNI CITAZIONE O PUBBLICAZIONE ANCHE PARZIALE DA PARTE DI TERZI © Gianfranco Salvatore 2011 1. La problematica moresca Uno stile parodistico non è mai frutto di mera invenzione letteraria: per definizione, ogni caricatura rispecchia e amplifica caratteri reali. È anche vero che qualsiasi parodia rischia di ridursi alle combinatorie di una convenzionale ed esigua serie di clichés, riducendo così il suo soggetto a una scheletrica deformazione della realtà. Il contenuto informativo di una parodia, relativo a qualsiasi realtà, va dunque considerato con prudenza, perché è il residuo di una selezione e deformazione dei dati reali. Ma qui ci occupiamo del repertorio cinquecentesco delle canzoni moresche, genere appunto parodistico, per evidenziare la sua peculiare ricchezza, che sembra esulare dagli stretti limiti imposti dai meccanismi della comicità. Tale repertorio non si limita a sviluppare pregiudizi ben noti e diffusi circa il carattere degli africani, come invece accadrà nell’Ottocento americano in generi paragonabili, quali i coon songs o il minstrel show. È invece dimostrabile che nelle canzoni moresche si fa ampio riferimento a numerosi dati obiettivi, della più varia natura, riguardanti precise nozioni e situazioni, tradizioni e stili di vita, degli africani presenti a Napoli durante il Rinascimento. Un argomento sul quale le fonti storiche, pur costantemente incrementate da ricerche archivistiche, non ci dicono abbastanza. Le moresche, anche se stilizzate attraverso convenzioni parodistiche, ritraggono con ricchezza di dettagli un contesto socioculturale reale, dei cui protagonisti africani (almeno quelli maschili) è leggibile in filigrana l’originaria provenienza geografica ed etnica. Si vedrà, ad esempio, fino a che punto l’incrocio di questi dati con quelli altrimenti disponibili possa arricchire le attuali conoscenze in materia. Mostrerò fra l’altro che, in quella sorta di pidgin napoletano2 ch’è parlato dai personaggi africani nelle moresche, si trovano inframmezzate parole e frasi provenienti da una specifica lingua nilo-sahariana, il kanuri; e che nei dialoghi di tali personaggi sono presenti riferimenti a dati storici verificabili, correlati a realtà, aspirazioni e speranze tipiche degli schiavi africani. L’insieme di questi dati potrà inoltre darci la misura di quanto potesse essere dettagliata, a Napoli, la conoscenza degli africani neri, delle loro etnie di provenienza, delle loro relazioni interpersonali, della loro vita in città; e al tempo stesso quali contorni potesse assumere la percezione di costumi, attitudini e idiosincrasie culturali di schiavi e liberti africani in una grande città rinascimentale dell’Italia meridionale. Auspichiamo che l’insieme di questi dati, magari incrementati da successive 1 Viene qui anticipata la versione italiana della relazione presentata dal professor Salvatore al convegno internazionale Di fronte all’Africa/Facing Africa - tenutosi a Lecce, presso l’Università del Salento, dal 15 al 17 giugno 2011 - in attesa della pubblicazione bilingue (in italiano e in inglese) dei relativi atti a cura della sede europea del CBMR (Center for Black Music Research), istituto di ricerca del Columbia College di Chicago. Il CBMR/Europe ha sede presso l’Università del Salento. 2 Sorta di idioma sincretistico, un pidgin rappresenta il risultato di una mescolanza di lingue di popolazioni differenti, entrate in contatto a causa di migrazioni o relazioni commerciali, o anche di processi di colonizzazione (in quest’ultimo caso il lessico dominante è quello dei colonizzatori). Si parla invece di “creolo” quando un pidgin viene trasmesso di generazione in generazione, come una lingua nativa, attraverso un processo di “creolizzazione” nel quale il pidgin si stabilizza nel tempo, acquisendo una precisa struttura morfosintattica. ricerche, possa contribuire a un arricchimento della nostra conoscenza degli effetti sociali e culturali della diaspora africana nel Rinascimento europeo. Introduciamo il nostro oggetto. “Moresche” sta per “canzoni dei mori” o “sui mori”. Di per sé abbastanza generico, il termine “mori” - con i suoi equivalenti nelle varie lingue europee - poteva indicare sia gli abitanti del Maghreb che quelli dell’Africa interna, e a volte era usato ancor più genericamente come sinonimo di “musulmano”3. Ma dai testi delle canzoni “moresche”, che qui esamineremo, è evidente che esse si riferiscono ad africani neri, residenti a Napoli come schiavi o come liberti. Sono solo dieci, i testi che abbiamo a disposizione, alcuni dei quali musicati più volte da compositori diversi: fra questi prevale, firmando la musica di ben otto brani, Orlando di Lasso, il musicista fiammingo più famoso della sua epoca, che non ancora ventenne trascorse un paio d’anni a Napoli, tra il 1549 e il 1551. Passiamo allo stato dell’arte. La moresca, per l’esiguità del repertorio ma anche per la sua prorompente originalità - a prima vista quasi indecifrabile -, costituisce ad oggi poco più che una nota a margine nella storia della musica rinascimentale. Tutto sommato è stata studiata pochissimo, e presenta ancora molte questioni irrisolte, perfino qualche enigma. Canzoni moresche furono pubblicate, nel corso della seconda metà del Cinquecento, un po’ a sprazzi, lungo un arco temporale di oltre venticinque anni, spesso in appendice a raccolte di villotte, villanelle o canzoni “alla napolitana”: altro genere minore del tempo, il cui repertorio poté godere però di dimensioni ben più ampie e di assai superiore fortuna. Tutto ciò ha contribuito a far considerare sbrigativamente le moresche rinascimentali come una sorta di curiosità marginale, affidata ad alcuni brani sciolti, dalle liriche ripetitive e in parte incomprensibili: brani accomunati soltanto dalla propria transeunte eccentricità. A mio modo di vedere, invece, le canzoni moresche si possono considerare come un vero e proprio ciclo, con una sua sequenza narrativa costruita attorno a una piccola drammaturgia, virtualmente adatta a una messa in scena, anche per la sua struttura dialogica4. La natura seriale e sequenziale del nostro repertorio si palesa già nel suo basarsi su due protagonisti principali, Lucia (la cui fortuna, come personaggio della “mora” a Napoli, proseguirà ancora nel Seicento) e Giorgio (il cui nome, come molte altre parole maschili, viene pronunciato con la “a” finale), più alcuni personaggi di contorno. Nei testi di molte moresche questo “Giorgia” - alias Giorgio - canta a Lucia sul liuto una serenata diurna, o “mattinata”, chiedendole di affacciarsi alla finestra; ma il corteggiamento cade a vuoto, spesso degenerando in un furioso battibecco. In una moresca, però, Giorgio si concederà un diversivo, corteggiando la fanciulla che dà il titolo al brano, Catalina (cioè Caterina, schiava mora anch’essa), con maggiore successo. In altre due (O Lucia miau miau e Canta Giorgia) il protagonista si dichiara geloso di un rivale che aspira alla mano di Lucia, appoggiato dalla padrona della schiava, e che potrebbe addirittura essere un bianco5. Ma inaspettatamente, quasi in un happy ending, alla fine di Canta Giorgia Lucia si affaccerà alla finestra per il musico africano, accettandone in extremis il lungo e travagliato corteggiamento. Nella sequenza intervengono più volte come comparse, e due volte - una a testa - da protagonisti, un paio di personaggi maschili secondari, anch’essi ritratti come musicanti africani a Napoli. Sono l’infido compare Martino, che in Chi chilichi divide proditoriamente il letto con Lucia (pur senza impegnarsi abbastanza e lasciandola insoddisfatta), e l’altro compagno Cristoforo, detto “Carcioffala”, che a sua volta in Tichi Toche corteggia una Maddalena il cui nome è storpiato in “Patalena”. Quando invece tengono un ruolo di contorno, l’uno o l’altro, oppure entrambi, accompagnano musicalmente le “mattinate” di Giorgio. 3 LOWE 2005: xvi; MINNICH 1995: 282. Altrettanto ambiguo poteva risultare perfino l’uso del termine “negro” in castigliano (CASARES 2005: 248). 4 Finora ci si è limitati a notare l’intrinseca “teatralità”, in senso lato, di questo repertorio (cfr. ad es. FERRARI-BARASSI 1991: 66; CARDAMONE 1999: 88). 5 A ciò potrebbe riferirsi Giorgio nei versi «Tutta negra sta storduta / Quando bede gente ianca» e «[…] gente lurma, / Che vo far gonell’a tia» in Canta Giorgia (la moresca che allude all’affrancamento di Lucia promesso dalla padrona in vista delle nozze), e forse anche nell’invettiva - in verità piuttosto oscura - pronunciata in Allalà, pia calia. Tre musici, dunque, e tre schiave. Ma traspare anche, sullo sfondo, un’intera comunità di loro pari, spesso definiti esplicitamente «gente negra»: schiavi o liberti appartenenti, come vedremo, a differenti etnie subsahariana. Nel loro insieme essi vengono più volte evocati con pregnanti allusioni, o anche ritratti in precise situazioni: essi sono ad esempio gli invitati ideali alla grande festa di nozze vagheggiata dal musico corteggiatore. Chi sia l’autore (o gli autori) di questi testi, nessuno lo sa. A lungo si è seguita una fortunata ipotesi di Adolf Sandberger, il quale riteneva che le moresche, in una forma iniziale, potessero essere state ideate a Napoli da commedianti di strada quali i bagattellisti, e poi rielaborate da autori e musicisti di livello per una committenza umanistica o aristocratica6. Più recentemente, la compianta Donna Cardamone ha invece ipotizzato un lavoro di gruppo degli artisti napoletani politicamente e culturalmente vicini al principe di Salerno, pratici di improvvisazione collettiva e dediti a forme di intrattenimento anche teatrali7. Il nostro piccolo repertorio, però, non è del tutto isolato: e un’attenta considerazione dei parallelismi rintracciabili in testi sia precedenti che conseguenti indebolisce i presupposti di entrambe le ipotesi. Il primo testo parallelo anticipa di nove anni la pubblicazione delle prime moresche8: nel 1546, infatti, il compositore fiammingo Anselmo De Reulx dava alle stampe una Bataglia moresca. Purtroppo di questo autore, attivo in Italia, sappiamo ben poco9. Per giunta, della musica della sua Bataglia sono andate perdute le tre voci principali, cosicché di essa ci restano solo la parte del basso (insufficiente a figurare lo stile melodico del brano), e il testo. Quest’ultimo però è prezioso per come anticipa vari aspetti delle moresche successive, a cominciare dal linguaggio, pur differenziandosene nel soggetto: qui non si tratta di una simpatica serenata fra africani a Napoli, ma della terrificante evocazione di una rivolta di schiavi neri che massacrano tutti i bianchi e li scacciano via. Il “tema moresco” nasce dunque col semisconosciuto De Reulx su toni insolitamente drammatici, perfino apocalittici: certo non adatti a semplici spettacoli di strada come quelli dei bagattellisti, né a patrizi e mecenati in cerca di lievi intrattenimenti umoristici. Dei personaggi delle successive canzoni moresche, nella Bataglia di De Reulx compare Martino, in veste di capitano dell’esercito africano, e lui solo. Invece, posteriormente alla pubblicazione delle moresche (le ultime di Orlando di Lasso furono date alle stampe nel 1581), ne ritroveremo tutti i personaggi nelle “Luciate”, cantate carnevalesche di cui si è conservata qualche versione seicentesca10. Dedicate fin dal nome al personaggio della mora Lucia, le Luciate ripropongono anche motti ed espressioni tipiche del nostro repertorio. Solidità e persistenza dei motivi e del cast forniscono un ulteriore indizio dell’esistenza di un ciclo narrativo, con possibili impieghi di tipo teatrale nel contesto del Carnevale (come suggeriscono le Luciate), o anche in altre possibili utilizzazioni, sceniche o di strada, di genere farsesco. La massima fortuna arriderà al personaggio di Lucia, destinato ad affermarsi anche in ulteriori narrazioni, sia di tipo letterario (come nel Pentamerone o Cunto de li cunti di Giambattista Basile), sia iconografiche (come nel ciclo dei Balli di Sfessania di Jacques Callot), sia più esplicitamente teatrali, come nella breve farsa carnevalesca (dove Lucia non è associata ai suoi “mori”, ma a una maschera napoletana della Commedia dell’arte, Coviello) messa in musica da vari autori e intitolata ora Luciata (nella versione di Francesco Manelli), ora Il carro di madama Lucia (in quella di Giovan Battista Fasolo). Tutte queste fonti letterarie, iconografiche, teatrali - furono prodotte fra gli anni Venti e Trenta del Seicento. 6 SANDBERGER 1921: 56 ss. CARDAMONE 1999: 88. Secondo libro delle Muse a tre voci, canzoni moresche di diversi aut. novamente raccolte e poste in luce, un’antologia pubblicata a Roma nel 1555 dall’editore Antonio Barrè. Sia Giovan Domenico del Giovane da Nola che Orlando di Lasso sono stati proposti come compositori delle moresche contenute nell’antologia di Barrè: Donna Cardamone ritiene possibile che essi si fossero incontrati a Roma, dove insieme avrebbero lanciato il genere (CARDAMONE 1999: 88). 9 Anselme de Reulx (anche Reux, Rieu) fu cantore alla corte di Carlo V. Il floruit della sua produzione viene posto fra il 1524 e il 1569. Si sa di suoi soggiorni in Italia, forse proprio a Napoli. 10 Ci riferiamo in particolare a La Luciata nuova. Posta in luce dal Rovinato Pover’Huomo, a compiacenza de’ Virtuosi (Terni, per il Guerrieri, 1628). Cfr. RAK 1994: 130 s. 7 8 Grazie al loro potenziale narrativo, dunque, ambientazioni e personaggi delle canzoni moresche sopravvivono a lungo, ben oltre i trentacinque anni che intercorrono fra la Bataglia moresca di De Reulx e la pubblicazione delle ultime moresche inedite firmate da Lasso11. 2. Decostruendo parodie La consistenza dei materiali utilizzati nelle moresche è notevole anche dal punto di vista musicale e melico, cioè nel loro impegno strettamente tecnico e artistico. Gioverà un confronto con altri “generi minori” presenti nel variegato panorama della light music rinascimentale, alternativi al sofisticato madrigale (il genere dominante) in quanto formalmente semplici, sia per la struttura strofica che nell’elementare trattamento della polifonia, e spesso di tono popolaresco o umoristico nei testi (a volte nelle melodie). La principale analogia fra le canzoni moresche e i repertori coevi sta nella presenza di stilizzazioni linguistiche di tipo parodistico. Come accade sovente negli altri generi minori, la moresca riproduce o rielabora il linguaggio e i costumi di una minoranza etnica alloglotta con intenzioni caricaturali. Dai canti carnascialeschi fiorentini alle successive “greghesche”, “ebraiche” e simili - e poi fino al plurilinguismo delle cosiddette “commedie madrigalesche” a cavallo fra Cinque e Seicento - la light music rinascimentale sviluppò stereotipie linguistiche dell’italiano distorto e storpiato dagli immigrati stranieri alle prese con la nostra lingua, basandosi in parte sulle idiosincrasie fonetiche della loro pronuncia, in parte su una buffa, goffa italianizzazione della loro lingua d’origine. Ad esempio i canti dei lanzi o lanzichenecchi (mercenari provenienti dai paesi germanici) giocavano su una ristretta cernita di parole tedesche, galleggianti in un italiano stentato fra gli scambi di consonanti dentali, gli assordimenti delle v in f, le alterazione vocaliche in finale di parola e l’abuso dell’infinito12. Anche nei testi delle moresche troviamo questa doppia contraffazione linguistica, che investe sia la fonetica sia il lessico. Qui, un misto di italiano e di dialetto napoletano viene intonato secondo distorsioni compatibili con la pronuncia idiosincratica delle lingue europee da parte degli africani, e già imitate nella stilizzazione del personaggio del “negro” africano nel teatro iberico di fine Quattrocento e poi del Cinquecento13. Le nostre deformazioni fonetiche “moresche” sono paragonabili infatti a quelle già usate nel cosiddetto guineo afrospagnolo. I frequenti scambi consonantici (r > l, d > t, c > g, g> b e viceversa) si devono a una generale confusione tra le consonanti dentali e le alveolari, ma anche fra queste e le palatali; spesso manca del tutto il suono c, sostituito da sh. Una generale difficoltà a distinguere il genere produce desinenze e finali incongrue in a, ma il comportamento anomalo rispetto alle vocali investe anche l’uso dei dittonghi. Ne risultano distorsioni come «sienta» per “senti”, «cliepare» per “crepare”, «basciata» per “baciata”, o «glidare» per “gridare” (riprendo quattro esempi a caso dal testo di Chi chilichi). Il retrogusto comico, nella messa in scena di queste pronunce bislacche, si accentua quando ne nascono equivoci. Alcuni, tipici, si basano su un’altra distorsione vocalica significativa, quella di o in u. Così un vocativo tipico della lirica petrarchista del Rinascimento, “core mio”, può diventare “core mia” o “cora mia” in alcune moresche (Catalina, A la lappia), con semplice colorito gergale afro-europeo; ma in altre sfocia in cula mia (Tiche toche, O Lucia, miau miau). Per assonanza con la parola “culo”, l’equivoco verbale abbassa il registro lirico su quello coprolalico: un artificio comico che dalla tradizione 11 Secondo libro di Madrigali De Anselmo Reulx a quatro voci con una bataglia moresca Nouamente da lui composto et posto in luce (Gardano, Venezia, 1546); Orlando di Lasso, Libro De Villanelle, Moresche, et altre Canzoni, A 4. 5. 6. & 8. voci (Parigi, 1581). 12 Cfr. CORTELAZZO 1976: 177. Per la fonetica delle contraffazioni carnevalesche e madrigalesche dei lanzi, si veda anche KIRKENDALE 1972: 188. Soluzioni analoghe per il linguaggio del personaggio del “todesco” in generale, e in particolare di “Mistre Righe” (cfr. VIANELLO 2005: 144). Per le altre minoranze prese di mira (gli “hebrei” con parodie del mestiere di usuraio e delle cantillazioni in sinagoga; greci, balcanici ed europei orientali nel genere specifico della greghesca e in vari sottogeneri “stradiotti” o “schiavoneschi”) v. infra. 13 Cfr., per le considerazioni che seguono e le relative ragioni fonetiche, soprattutto CHASCA 1946, SLOMAN 1949, LIPSKI 2005, passim. buffonesca e burlesca14 tracima efficacemente nelle parodie degli alloglotti. Anche la “cantata” che il cantore moresco offre all’amata viene due volte detta da lui “cantarata”15: la zeppa sillabica è forse giustificabile per la difficoltà degli africani a pronunciare consecutivamente la t in due sillabe contigue, ma un gioco di parole volgare sfrutta l’assonanza con “càntaro”, cioè il pitale16. Fin qui siamo nel campo della parodia anche greve, e nell’umorismo tipico dei malapropismi, sfruttato anche nel repertorio parodistico relativo ad altre minoranze17. Ma ci sono differenze quantitative e qualitative. In soli dieci testi, le canzoni moresche presentano un’alta densità di storpiature risibili ed umoristici giochi di parole sull’italiano o sul dialetto napoletano. Inoltre, al di là delle espressioni scherzose coniate in base al modo in cui effettivamente, per ragioni fonetiche, gli africani pronunciavano le nostre lingue, il gergo parodistico afro-napoletano si combina frequentemente, nei testi delle moresche, con una quantità di termini dall’apparenza esotica e dal significato oscuro. Tanto oscuro che - almeno per gli studi musicologici dell’ultimo secolo e più - il loro significato, sia denotativo che sociologico, è rimasto a lungo lettera morta. Si è infatti ritenuto erroneamente che i protagonisti dei testi delle moresche parlassero «un gergo incomprensibile, di pretesa origine africana», definito anche come una «parlata pseudo-africana»18. Così non era. E dovremo qui restituire agli schiavi africani ciò che gli apparteneva, innanzitutto in termini linguistici. Nelle nostre moresche compaiono (assieme ad alcune espressioni idiomatiche arabe) molti termini africani autentici. Essi appartenengono a un ceppo linguistico ben individuabile: quello delle lingue nilo-sahariane. I protagonisti della canzone moresca, oltre al loro napoletano stentato, parlano infatti il kanuri. Anche a questo riguardo le moresche si distinguono nettamente per densità dagli altri generi minori del Cinquecento. Il loro linguaggio, già denso di distorsioni dell’italiano e del napoletano, non si limita a giocare su pochi termini stranieri caratterizzanti, come è normale nelle parodie di altre minoranze alloglotte, ma contiene numerose parole ed espressioni originali africane, incluse intere frasi in kanuri, che esprimono - come vedremo - la condizione specifica degli africani a Napoli. Una differenza forte sta dunque nella competenza dimostrata dagli ignoti autori dei testi: competenza tanto più notevole in riferimento a una lingua extraeuropea, non destinata a relazioni culturali né commerciali ma, anzi, testimonianza del massimo grado di sradicamento e di subalternità. Una seconda peculiarità riguarda le porzioni in kanuri che, nei testi delle moresche, potevano forse far simpatia per il fatto di essere ritmicamente vivaci, ma mai si risolvono nei meccanismi della parodia, mostrandosi del tutto avulse da intenzioni comiche. Anche musicalmente, la moresca si mostra come una forma infinitamente più complessa rispetto a frottole, villanelle o altri generi strofici di light music rinascimentale. Benché la polifonia resti spesso rudimentale, limitandosi a sole tre voci, spesso trattate omoritmicamente e con abbondanza di quinte consecutive, il tasso di creatività è molto alto: le 14 Cfr. VIANELLO 2005: 37 ss., 78, 150, e passim. Cfr. «per voler far cantarata» (O Lucia, miau miau) e «senti bella cantarata» (Tichi toche). 16 Simili deformazioni, plasmate dalle intenzioni umoristiche degli autori come affettuose prese in giro del pidgin afro-napoletano, non erano estranee neppure alle parlate africane del coevo teatro spagnolo del Cinquecento, dove i besos diventavano quesos (Diego Sánchez de Badajoz, Farsa de la hechichera, 224, 16) mentre, sul registro coprolalico, açucena diventava caqucena nel gioco di parole su caca (Lope de Rueda, Los Engañados, 23) (CHASCA 1946: 338). 17 Il “basso” fisiologico e fisiognomico fa spesso da motore comico degli equivoci verbali, e le designazioni delle “parti basse” costituiscono un terreno favorito nel meccanismo a quiproquo delle interferenze linguistiche specie nell’ambiente veneziano del Cinquecento. Nel repertorio schiavonesco trovo interessanti, per l’ambiguità triviale, culami per il veneziano colo mi, “presso di me”, o per il croato ragusano kala mene; e, con epentesi di n, perinchuli per “pericoli” (tutti esempi riferiti, senza commento, da CORTELLAZZO 1971-72: 122, 125). Nel poema Libero del Rado stizuxo del buffone Zuan Polo, dove pure il quiproquo riguarda spesso voci veneziane deformate alla schiavonesca, troviamo mira in chulo per “miracolo” (e i nomi dei due figli di Rado, Licha e Miochulo, favoriscono amenità del tutto analoghe); e nell’Egloga di Andrea Calmo è frequente merdecina per “medicina”. In contesti analoghi ci si imbatte anche in chulo o culo per “collo” (cfr. ancora CORTELLAZZO 1971-72: 134 s.). Estremi echi cinquecenteschi nell’Amfiparnaso di Orazio Vecchi, dove troviamo “culintient” per “cuntent”. 18 FERRARI-BARASSI 1991: 55, 57; corsivi miei. A monte di questo diffuso pregiudizio è la vecchia opinione, imposta dall’autorità di Adolf Sanberger, che il «Kauderwelsch der mori» sia semplicemente «drollig» e «komisch» (SANDBERGER 1921: 52, 57). La prima versione di questo classico studio, più volte riproposto, risale alla fine dell’Ottocento (Orlando di Lassos Beziehungen zur italienischen Literatur, «Altbayeriscgen Monatsschrift, 1, 3, 1899). 15 ripetizioni interne sono limitatissime, assenti le scorciatoie formulari normalmente affidate alla forma strofica e ai refrain; le melodie non suonano né ariose né popolaresche, ma si srotolano con pregevole varietà; il metro muta incessantemente dal binario al ternario e viceversa, ogni pochi versi, spesso esprimendo concitazione pulsante e perfino frenesia; a sua volta il ritmo melodico è molto incisivo, talvolta martellante, con generoso uso di sincopi, emiole, inversioni di accenti. Formalmente, dunque, le differenze musicali con gli altri generi minori risultano molto più ampie e sostanziose delle analogie; e l’enfasi ritmica in particolare, pur non avendo nulla di autenticamente africano, pare appropriata a una varietà di canzone intitolata ai “mori”. Forse non si può pretendere che le moresche riproducessero stili musicali africani ascoltabili da estemporanee intonazioni o esecuzioni degli schiavi19, ma l’insistenza sull’incisività e la varietà ritmica possiede una sua efficacia simbolica. Soprattutto i testi sono rivelatori. Il modo in cui i personaggi comunicano, e quello che si dicono, suggerisce numerosi “punti di vista” sugli africani neri. Se a volte tali visuali possono corrispondere a quelle degli osservatori (cioè degli autori delle liriche), altre volte invece, correttamente considerate, si rivelano molto simili a punti di vista “emici”, riconducibili alla self-definition dei personaggi e dei loro reali modelli e referenti sociali, ivi incluso il modo di rapportarsi con la propria comunità. Qualcosa di completamente diverso dal modo in cui i generi rinascimentali raffigurano le altre minoranze linguistiche, cioè quasi sempre inseguendo luoghi comuni e pregiudizi correnti (con l’eccezione dei canti proposti da autori effettivamente stranieri, come in certi apporti gregheschi o schiavoneschi al repertorio veneziano)20. All’interno di ogni scenetta moresca, del suo linguaggio e dei suoi contenuti, si collocano informazioni attinte alla realtà della vita quotidiana di una minoranza africana costituita in parte da schiavi e in parte da liberti affrancati. Riconoscere tutte queste peculiarità restituisce una caratterizzazione straordinaria, per ricchezza di temi e dettagli, rispetto a qualsiasi altra parodia rinascimentale di una minoranza alloglotta. Ai canti dei lanzi erano sufficienti pochi luoghi comuni riferiti a vizi e intemperanze tipiche di quei mercenari (il vino, le donne, l’ozio)21; nelle parodie ebraiche (sia musicali che teatrali) di sinagoghe o banchi di pegni bastava insistere sulla presunta avidità, sulla litigiosità chiassosa e le colorite maledizioni, o sulla classica scena della circoncisione22. Stereotipi continuamente replicati da un testo all’altro, con limitate variazioni sul tema. Dietro un testo di moresca si cela invece un grado di conoscenza dei neri africani che, per quantità e qualità degli spunti, appare senza precedenti in un corpus letterario, di fiction, per giunta di carattere umoristico. 3. I precedenti iberici In alcune sue caratteristiche specifiche, la nostra fiction moresca non nasce dal nulla. Gerghi afro-europei erano già attestati nelle letterature minori, in particolare in quelle iberiche: falas de pretos in Portogallo e hablas de negros in Spagna. L’esempio più antico a noi noto è portoghese: una mourisca scritta in fala de preto che risale al 1455, con un secolo esatto di anticipo sulla pubblicazione delle prime canzoni moresche di ambiente napoletano23. Ma solo nel repertorio spagnolo del primo Cinquecento emergerà il prototipo di un battibecco fra due personaggi di colore, un pretendente e la sua amata. Il brano in questione, finora mai posto in 19 Solo Paul Nettl osò pensare a un effettivo, benché «debole riflesso della musica nera di Napoli, ora da tempo dimenticata», ma riconoscibile in tratti quali «i lunghi suoni prolungati che si suppone rappresentino le lunghe grida nei negri; i ritmi speziati dalla sincopazione, l’eloquio senza respiro, le numerose pause brevi, la ripetizione stereotipata di brevi motivi e l’imitazione di strumenti a plettro» (NETTL 1944: 112). 20 Cfr. STIPČEVIĆ 1993: 35 s. 21 Sul retroterra realistico di alcune di queste intemperanze si veda, per un episodio storico, BAUMANN 1996: 29. 22 Cfr. RE 1912: 388; BARICCI 2010: 149 s., 153, 158. Per il repertorio vocale delle “ebraiche”, che conta una dozzina di composizioni, cfr. HARRAN 1989: 118 n. 60; HARRAN 2009: 428 s., n. 9; NETTL 1931: 408 s. 23 Intitolata Por breve de huma mourisca rratorta que mandou fazer a senhora prinçeza quando esposou, la mourisca fu scritta da Fernam de Silveira in onore delle nozze di Joana del Portogallo ed Enrique IV di Castiglia, a Cordoba. Il personaggio a cui sono affidati i versi (si tratta di un monologo) è un re della Sierra Leone che invita il suo popolo a danzare per la principessa. Per i riferimenti relativi si rimanda a RUSSELL 1973: 228 e n. 4. relazione con il corpus italiano di cui ci stiamo occupando, è in grado di fornirci un precedente - se non un possibile modello - vuoi dello stile dialogico della moresca di ambiente napoletano, vuoi delle dinamiche che intercorrono fra i suoi personaggi maschili e femminili. L’autore è Rodrigo de Reinosa, poeta popolaresco e autore di ballate, serie o più spesso farsesche, per fogli volanti ed opuscoli di poco prezzo, la cui produzione viene datata fra il primo e il secondo decennio del Cinquecento. La scenetta che ci interessa porta come incipit Gelofe, Mandinga, e fu pubblicata a Burgos24. Il dialogo però è ambientato a Siviglia, e i versi tratteggiano un litigio con vivace scambio di insulti. Gli unici personaggi sono un liberto e una schiava. Già la scelta dei nomi propri suggerisce la presenza di elementi realistici nella costruzione della parodia: il personaggio del liberto – sicuramente battezzato - porta il nome spagnolo di Jorge, mentre quello della schiava, Comba, corrisponde a Kumba, nome proprio femminile molto diffuso nell’area del Senegambia25: il che è coerente col fatto che il personaggio dica di venire dalla “Guinea”, cioè - nell’accezione rinascimentale - dall’Africa occidentale subsahariana. Jorge è invece dichiaratamente un Wolof26. Ulteriori elementi realistici sono indicati dal fatto che il componimento, pur usando una habla de negros che rispecchia più o meno liberamente le tipiche deformazioni dello spagnolo parlato dagli africani, e che è convenzionale in questo tipo di letteratura, contiene anche un piccolo gruppo di africanismi morfologici e lessicali. Fra questi, Jeremy Lawrance segnala caranga (vv. 21 e 38), riferibile (come forse anche carpanga e garango) al termine mandinka karankoo (pidocchio, pulce), mentre l’espressione choque-choque (v. 27) sta per “rapporto sessuale”27. Più isolatamente fa la sua comparsa qualche termine arabo: in particolare, nel verso pronunciato da Comba «Guala nunca herrar le le» - ipometrico e non rimante, probabilmente un’espressione idiomatica - il termine “guala” è deformazione gutturale di wa-llâ, “per Allah!”28. Qui scopriamo un primo punto di contatto con le moresche italiane, dove tale esclamazione ricorre sia nella forma guallà che in composti del tipo bernaguallà o burnoguallà29. Nel corso del corteggiamento, Jorge si vanta della sua collocazione a servizio presso un vescovo e sottolinea che la sua condizione affrancata è testimoniata da una lettera di manomissione (aborría) che gli conferisce «classe» (porte). Anche nelle moresche i personaggi maschili, liberi di girovagare per Napoli coi loro strumenti musicali, vengono rappresentati come degli affrancati. Ma Jorge si dà delle arie. «Se fossi in Jolof – afferma a un certo punto, riferendosi al territorio dei Wolof – abiterei a corte» (v. 54), e ostentando una certa condiscendenza si offre di coabitare con Comba nonostante il naso camuso di lei (vv. 71 s.). Qui il repertorio iberico rivela una diretta conoscenza di un dato tradizionale africano, che sta nella piccata rivalità fra etnie e sottogruppi diversi, dove ciascuno afferma la propria presunta superiorità, anche in termini fisiognomici. Pure nelle moresche, come si vedrà, il 24 Comiençan unas coplas a los negros y negras, y de cómo se metejavan en Sevilla un negro de Gelofe mandinga contra una negra de Guinea; a el llamavan Jorge, y a ella Comba; y cómo él la requería de amores y ella dezía que tenía otro enamorado que llamavan Grisolmo. Cántanse al tono de ‘La niña quando bayléys’. Hechas por Rodrigo de Reinosa, Burgos, Juan de Junta, fols. 1-2; ed. critica in PUERTO MORO 2010: 168-177. 25 LAWRANCE 2005: 73. 26 Ma nei primi versi, contraddittoriamente, dichiara di essere “Mandinga Wolof” (e così lo definisce anche Comba nel ritornello): il che ci mostra, assieme alla consapevolezza dell’autore, anche gli ovvi limiti della sua competenza in materia di etnografia africana. Spiegazioni diverse addotte per giustificare questa contraddizione mi sembrano inutilmente complicate: in particolare quella di RUSSELL 1973: 241, che ipotizza un’intenzionale fusione di due razze nel personaggio da parte dell’autore. 27 L’espressione erotica è documentabile sia per la Sierra Leone (PUERTO MORO 2010: 173 n. 3) che per il Ghana (LAWRANCE 2005: 73 s.). Circa il termine Bucamande (v. 62), Russell accetta l’emendamento di José Maria de Cossío busca Mandé, che nel contesto della frase rimanda alla grande famiglia etno-linguistica dei Mandé dell’Africa occidentale (RUSSELL 1973: 237), di cui fa parte il popolo Mandingo (noto anche come Mandinka o Malinké). 28 LAWRANCE 2005: 85 n. 52. Ma voglio segnalare due precedenti occorrenze medievali in Spagna: l’espressione Wa-llah compare infatti già nella melica arabo-andalusa fra i testi lirici dello zadjal (per i riferimenti cfr. SHILOAH 1991: 19), e nel composto «Legualá» in un componimento in cinque stanze contenuto nella compilazione nota come Libro de buen amor (1330) di Juan Ruiz, arciprete di Hita nella diocesi di Toledo, tra le risposte di una mora a un tentativo di seduzione perpetrato tramite una mezzana (testo e commento in BARLETTA 2008). 29 V. infra. protagonista Giorgio ostenta fierezza tribale, col vantarsi della propria origine nell’impero del Bornu. Ma torniamo a Jorge, che perfino nel nome sembra una vaga anticipazione del “Giorgio” moresco30. Il suo corteggiamento presuntuoso e un po’ arrogante precipita presto in un battibecco a suon di reciproci insulti circa i rispettivi paesi d’origine: espressione ancor più esplicita di gelosie tribali. I due personaggi, definendosi l’un l’altro «nero/a come uno scarafaggio», si rinfacciano a vicenda disgustose abitudini alimentari ed escretive. Comba accusa quei morti di fame dei Wolof di mangiare lucertole, teste di cani, scarafaggi stercorari e mosche arrostite, e di cacare pulci; Jorge ribatte indignato che in realtà il suo popolo banchetta a cous-cous, mentre la Guinea di Comba è una terra di pidocchiosi marci, che si nutrono pesce avariato31. Questi scambi di contumelie sono già stati studiati a fondo da Jeremy Lawrance. Ai suoi commenti devo però aggiungere che simili battute non sono fantasiose, o inventate di sana pianta, ma si basano - pur proverbialmente - su fatti obiettivi. Già l’esploratore marocchino Ibn Battuta, che viaggiò nelle regioni sudanesi nella prima metà del Trecento, criticava l’uso, presso molti sudanesi, di nutrirsi di carogne putrefatte, nonché di animali immondi come gli asini32. Ma Reinosa non poteva conoscere le memorie di viaggio di Ibn Battuta, che non furono tradotte in nessuna lingua europea prima del XIX secolo. Il dato di natura dietetica (come altre vanterie o insulti tipici) dovette dunque penetrare nella fiction del bisticcio amoroso tramite la conoscenza reale di certi costumi, luoghi comuni o polemiche tradizionali, osservabili in Spagna tra gli schiavi e i liberti africani. Nello specifico, insomma, il contrasto fra Jorge e Comba si può interpretare come un polemico confronto tra un maschio wolof senegalese e una ragazza appartenente a un’altra etnia, sceneggiato sulla scorta di informazioni di carattere antropologico, certo attinte alla viva realtà interrazziale nel contesto spagnolo. La competenza di un autore come Reinosa - o dei suoi informatori - a ritrarre dinamiche interafricane in una credibile parodia si trova peraltro confermata dai riferimenti a determinate tradizioni musicali e coreutiche: ad esempio, Comba si dice orgogliosa di certi dolci canti di Guinea, undul e mangana33, nessuno dei quali è stato però identificato dagli studiosi34. In proposito voglio però sottolineare che il termine Mangana esiste anche come toponimo, molto diffuso in Senegal35, e che undul probabilmente corrisponde al termine wondole, riscontrabile presso le minoranze mandingo da tempo stanziate nel Senegal, non lontano dal confine con il Mali36. Col riferirsi nostalgicamente a sue tradizioni autentiche, Comba ci appare dunque credibilmente come un personaggio di razza mandinga, appartenente a una minoranza presente sul territorio dei Wolof: un battibecco di natura campanilistica, paragonabile ai contrasti medievali fra cittadini e villani, e costruito in base a competenze dirette o informazioni precise disponibili a Reinosa37. Ora, anche nelle moresche - mi riferisco in particolare a Lucia celu, Oh Lucia miau miau, Tichi toche - il battibecco tra Giorgio e Lucia chiama in causa reciproche abitudini alimentari ed escretive, oltre all’igiene e all’odore personale. La coincidenza apre la 30 In questa ulteriore connessione tra hablas de negros e moresche si può citare, fra altri possibili parallelismi, l’estribillo popolare «Canta, Jorgico…» e l’incipit «Canta Giorgia…» dell’omonima moresca. Tale estribillo, o refrain, si trova ad esempio un cantacillo viejo citato nel dizionario di Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (1611, cit. in PUERTO MORO 2010: 170 n. 5), e venne spesso riutilizzato nella letteratura popolare spagnola, sempre con riferimento a un africano nero: ad es. nelle anonime Coplas de como una dama ruega a un negro que cante en manera de requiebro, all’incirca contemporanee di Gelofe, Mandinga (testo integrale e commento in LAWRANCE 2005: 86-93). “Jorge” era comunque un nome comune, nella Spagna rinascimentale, per i negri battezzati (RUSSELL 1973: 241). 31 LAWRANCE 2005: 73. 32 BOVILL 1995: 95. 33 Mentre Jorge si vanta (v. 26) della sua abilità nel ballare il guineo, conosciuto da varie fonti come danza africana vivace e lasciva. 34 Cfr. RUSSELL 1973: 234; LAWRANCE 2005: 82 n. 39; PUERTO MORO 2010: 172 s., nn. 5 e 6. 35 Troviamo in Senegal città che portano i nomi di Kandion Mangana e Kandion Mankana (fra l’altro molto vicine fra loro), ma anche Manganem e Mankanondine. 36 A tale proposito, il griot senegalese Badara Seck, di nazione Wolof, parla di un’enclave mandinga, stabilita da persone venute “da fuori”, che in Senegal hanno creato una comunità (com. pers., primavera 2010). 37 Lawrance non coglie questa natura campanilistica del litigio. Si sofferma invece ad annotare che i personaggi di Reinosa «appaiono più umani di molti parlanti la habla de negros»; giustifica gli insulti affermando che «questi litigi in versi [flytings] richiedono un’enfasi carnevalesca sulla repellente natura terrigna del corpo»; e si lascia sfuggire totalmente la pertinenza antropologica e l’“africanità” della scena, pretendendo addirittura che «quel che è significativo, dal punto di vista della psicologia dell’autore, è che gli appetiti e le pretese di Jorge e Kumba sono indistinguibili da quelli dei bianchi» (LAWRANCE 2005: 73). possibilità che testi come quello di Reinosa abbiano fornito spunto alle moresche di ambientazione partenopea, e che anche le baruffe afro-napoletane possano essere interpretate nel senso della gelosia tribale. Una qualche influenza tematica del repertorio spagnolo cinquecentesco sulle canzoni moresche è plausibile. Nel contesto napoletano, soggetto al vicereame spagnolo, potevano sicuramente circolare, ed essere riadattati e riproposti, vari spunti offerti dalle farse iberiche, quali gli insulti, le polemiche dietetiche e igieniche, l’orgoglio etnico, le affermazioni di fierezza tribale38. Ma le tematiche comuni - a partire dalla baruffa fra un “lui” e una “lei” africani - trovano sviluppi assai più ampi nelle moresche, dove peraltro ci si riferisce, nei personaggi, a etnie diverse da quelle presenti e parodizzate in Spagna. Va rimarcato che la canzone moresca di ambientazione napoletana, qualunque sia stata la portata dei possibili influssi iberici, ne resta indipendente per esiti e dimensioni narrative. Ne consegue che (i) la riproposizione o riformulazione napoletana del modello spagnolo, se tale era, sussisteva sulla base di molti dati specifici e conoscenze autonome, localmente reperibili, e a disposizione degli ignoti autori dei testi delle canzoni moresche; (ii) che queste informazioni dovevano essere anche riconoscibili da parte del pubblico napoletano delle moresche, pena la vanificazione del meccanismo comico-parodistico; e (iii) che, qualunque fosse il contesto della loro ricezione (e la sua ampiezza), il successo di questo microgenere comico fu tale da generare un intero ciclo di canzoni. Uno studioso di letterature comparate potrebbe a questo punto stabilire che il tópos narrativo sfruttato da quasi tutte le moresche - un battibecco fra due africani innamorati, o meglio fra un pretendente e una ritrosa, rispettivamente un liberto e una schiava - si trova anticipato, con non pochi dettagli narrativi in comune, nel repertorio letterario delle hablas de negros spagnoli del primo Cinquecento. Per un antropologo o uno storico delle culture, però, la prospettiva è però più vasta, poiché tale tópos non rappresenta una mera invenzione letteraria. La dinamica delle interlocuzioni tra i due personaggi si fonda su modelli retorici molto peculiari e riconoscibili: gli insulti che riguardano abitudini personali, ad esempio di tipo igienico o sessuale, scaturiscono da reali rivalità etniche tra popoli africani confinanti, non da fantasie o pregiudizi degli osservatori bianchi, ovvero dei singoli autori dei testi e delle parodie in questione. Anche la provenienza etnica dei personaggi, nell’esempio spagnolo come in quelli italiani, è credibile e coerente con situazioni reali, poiché il commercio schiavistico iberico attingeva all’epoca, come è noto, proprio all’area senegalese e a quelle immediatamente circostanti. A questo punto dobbiamo considerare fino a che punto il ciclo delle moresche sviluppo seriale di un tópos condiviso col precedente iberico, ma narrativamente indipendente - poteva rappresentare realisticamente la situazione locale. Nei prossimi paragrafi vedremo che il nostro ciclo fissa, quanto meno per il protagonista maschile, una provenienza geografica e un linguaggio ben precisi: l’impero del Bornu, la lingua kanuri che vi era parlata. Vedremo inoltre che, autonomamente dagli spunti che poteva suggerire la farsetta spagnola, l’ampiezza dei riferimenti si estende fino ad alludere all’esistenza di una composita comunità degli africani residenti a Napoli, a certi aspetti del loro modo di vivere e delle loro tradizioni, al loro senso comunitario e identitario. 4. L’impero del Bornu e gli schiavi africani a Napoli 38 Una forte coincidenza narrativa, molto meno evidente, chiarisce anche un aspetto altrimenti poco illuminato nella fiction delle canzoni moresche. La vera ragione per cui Comba rifiuta Jorge è che la schiava africana è già promessa a un altro guardiano (v. 46), dal che si deduce che anche il nero Jorge è guardiano di schiavi neri. Il promesso sposo però è bianco: si tratta del cognato Grisolmo (già la sorella di Comba, evidentemente, aveva sposato uno spagnolo). Sentendosi coinvolto in una contesa interrazziale, Jorge definisce Grisolmo un «pidocchio bianco» e si vanta di sedere a messa accanto alla sua padrona, moglie del corregidor (36 s., 46-9, 65, 79). Nel corpus delle moresche, una situazione analoga si trova svolta in modo diverso: il povero Giorgio si limita a mettere in guardia Lucia da chi non le vuol bene, e ammette perfino il proprio disagio rispetto ai bianchi, pur estendendolo a tutta la “gente negra”: «tutta negra sta storduta / quando bede [vedono] gente jancha» (Canta Giorgia, con riferimenti anche in Oh Lucia, miau miau). Lo stato del Bornu si formò dal trasferimento del popolo del Kanem, che tra il IX e il XIII secolo era diventato sedentario, da nord-est del lago Ciad alle rive occidentali dello stesso lago, a seguito della pressione aggressiva di popolazioni confinanti, come i Bulala39. Nel 1472 fu edificata nel nord dell’attuale Niger, a Ngazargamu, una capitale fortificata in grado di resistere definitivamente ai Bulala. Nel frattempo ci si cominciava a scontrare con altre popolazioni locali, come gli Hausa a occidente, e con vari gruppi nomadi quali i Tuareg e Tubu a nord. Nel XVI secolo, l’epoca delle nostre moresche, si era ormai consolidato il potente impero integrato del Kanem-Bornu, che nella sua fase di massima espansione controllava territori oggi corrispondenti al Niger orientale, al nord est della Nigeria, a una porzione del Camerun, più vaste estensioni nel Ciad e nella Libia attuali. L’impero era forte di un’organizzazione militare senza pari nell’Africa sudanese, grazie alle armi in ferro (la cui tecnologia era conosciuta fin dal IV secolo) e all’uso di cavalli berberi: già sotto il re Dubama Dibalami, nella prima metà del XIII secolo, la cavalleria contava oltre quarantamila destrieri40. L’impero islamico del Kanem-Bornu monopolizzava il commercio di schiavi in un’area vastissima, grazie alle continue razzie nei territori “pagani” circostanti, alle frequenti attività belliche contro i numerosi nemici, e al controllo delle principali rotte transahariane che attraversavano la regione semidesertica del Fezzan. Costellato da un sistema organizzato di oasi, il Fezzan costituisce l’area centro-meridionale dell’odierna Libia: fin dall’antichità veniva percorso da rotte commerciali, nel XIII secolo era stato ormai conquistato dal Kanem, e durante il nostro Rinascimento fu parte integrante dell’impero del Bornu. I mercanti berberi che trattavano gli schiavi sui mercati di Tripoli e della regione Monti Barca, nella Cirenaica occidentale, si approvvigionavano direttamente dal Bornu. A differenza del Portogallo e della Spagna, che trafficavano in schiavi guineani (e diversamente anche dell’Italia settentrionale, rifornita di schiavi dai genovesi che li acquistavano nei mercati iberici), già dalla seconda metà del Quattrocento l’Italia meridionale importava, soprattutto dalle piazze libiche, gli schiavi africani razziati dai cavalieri del Bornu41. La tratta transahariana continuò ad alimentare a lungo, tramite i porti libici, i mercati maltesi e siciliani, e a soddisfare la domanda napoletana (probabilmente fino al Settecento incluso). Continuò a farlo anche quando portoghesi e spagnoli, tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, cominciarono a immettere su quei mercati i loro schiavi senegalesi e poi congolesi e angolani. Da allora, tuttavia, rotte commerciali e affari mercantili si mescolarono, e così le razze degli schiavi, pur senza smarrire la consapevolezza delle differenze geografiche ed etniche tra gli schiavi. Nel corso del Cinquecento divenne usuale, nell’Italia meridionale, distinguere nettamente quelli provenienti dall’Africa sudanica centrale da tutti gli altri africani neri. Nel censimento della popolazione di Palermo del 1565 venivano registrati 644 schiavi; di 456 si cita il colore: i «negri» erano 224, di cui 112 «negri di Burno»42: tale era infatti una delle pronunce convenzionali43, nel meridione d’Italia, del Bornu, con inversione vocalica. Per Napoli, grazie alle ricerche di Giuliana Boccadamo, abbiamo dati certi dal primo decennio del Seicento, quando solo il 4% degli schiavi proveniva dalla Barberia (l’odierno Maghreb, fino a Tripoli), contro un 10% di schiavi neri, di cui ben due terzi provenienti dall’area sudanese centrale, cioè l’area controllata dall’impero del Bornu44: vigeva insomma a Napoli una 39 Per la storia del Kanem e del Bornu sono stati consultati soprattutto PALMER 1936, URVOY 1949, COHEN 1967, LANGE 1977, AA.VV. 1991, AA.VV. 1997. I documenti originali, costituiti fino al Cinquecento esclusivamente da fonti arabe, sono raccolti in AA.VV. 1985: passim. 40 AA.VV. 1997: 325; AA.VV. 1991: 172. 41 Per la tratta schiavistica transahariana si veda soprattutto WRIGHT 2007. Per il commercio degli schiavi in Italia, il testo classico di riferimento è VERLINDEN 1955. 42 MINNICH 2005: 283 n. 10. 43 Nei documenti contabili si trova anche la lezione “barno”, come già in Leone l’Africano (che si trattenne nel Bornu circa un mese) (cit. in URVOY 1949: 68). Richmond Palmer ricorda che in realtà “Bornu” dovrebbe essere sempre scritto “Barnu”, variante delle forme Baran o Baram, cioè “uomini” (plurale di bar), e in certe lingue sahariane anche “guerrieri”: e “Barnu” gli arabi del Ciad chiamano ancora i Kanuri (PALMER 1936: 6). 44 BOCCADAMO 2010: 148. distinzione analoga a quella siciliana, tra africani neri in senso generale, e “neri del Bornu”, anzi “di Burno”. Statisticamente le schiave nere erano ancora più numerose, rispetto a quelle bianche, e oltre un terzo proveniva dal Bornu. Ma l’espressione “di Burno”, sui documenti commerciali o demografici, non va intesa in senso strettamente etnico. È anzi notevole che l’origine degli schiavi catturati e smistati dall’impero del Bornu, ma nativi dei territori circonvicini, veniva immediatamente cancellata: una volta immessi sul mercato essi erano considerati appartenenti al territorio da cui era iniziata la loro deportazione attraverso il deserto45. In sintesi, nella Napoli del Cinquecento si acquistavano anche schiavi africani smistati sui mercati maghrebini (nativi dell’odierno Senegal o di altre zone interne al golfo di Guinea), ma soprattutto, e già da molto tempo, schiavi provenienti dalla tratta transahariana gestita dall’impero del Bornu insieme ai commercianti berberi e ai mercati libici: i cosiddetti “negri di Burno”. Fra questi dovevano essere rappresentate soprattutto le piccole tribù più indifese che vivevano a sud del lago Ciad, come i Kotoko (abitanti in quelle che oggi sono le zone settentrionali di Camerun e Nigeria)46, ma anche i Bulala, acerrimi nemici fatti prigionieri in guerra, e il clan dei Sara che, rimasto pagano fino alla fine dell’Ottocento, rimase sempre vittima della legge del jihad47. È plausibile che attraverso la tratta transahariana siano arrivati in Italia anche degli Hausa, dall’omonimo impero che era stato a sua volta produttore di schiavi durante il basso Medioevo, ma che per la pressione del confinante Bornu continuava a fornire - oltre a pesanti tributi in denaro e beni materiali - numerosi prigionieri di guerra, subito immessi nella tratta schiavistica. Sia di questa congerie di etnie africane, sia del senso comunitario che essi poterono ricostruire in Italia riconoscendosi nel comune destino di schiavi, a dispetto delle rivalità tribali originarie, si troverà traccia nei testi delle moresche. Intanto, per quanto riguarda i repertori musicali e lirici inerenti al nostro discorso, dobbiamo prendere atto che il nome “Burno”, variante di “Bornu”, riceveva attenzione e creava suggestioni già nella singolare Bataglia moresca pubblicata da Anselmo De Reulx nel 1546, con nove anni di anticipo sulla prima pubblicazione a stampa di canzoni moresche. 5. Battaglie musicali e funzioni identitarie africane Come le successive canzoni moresche, anche la Bataglia moresca di De Reulx utilizza, nel testo, una cornice convenzionale. Le “battaglie musicali” costituivano infatti un vero e proprio genere rinascimentale, il cui brano prototipico A la bataglia di Heinrich Isaac, di fine Quattrocento (pervenutoci privo di testo e forse in forma frammentaria), già fissava le principali formule musicali caratterizzanti le battaglie musicali del Cinquecento: l’inizio a fanfara, lo svolgimento in moto ostinato, l’andamento spesso sincopato, gli episodi in tempo ternario fluidamente inseriti senza alcuna cesura48. L’autentico classico, destinato a servire da modello a tutte le principali “battaglie” rinascimentali, fu però la cosiddetta Battaglia francese di Clement Janequin (nota anche come Escoutez escoutez o La Guerre), del 1526, riferita alla vittoria di Francesco I e dei francesi nella battaglia di Marignano, svoltasi undici anni prima. Qui Janequin stabiliva canonicamente le caratteristiche testuali del genere, consistenti nella «descrizione realistica di una battaglia […] che segue e illustra minuziosamente tutte le singole fasi dello scontro, dall’iniziale schieramento all’ultima fuga degli avversari sconfitti», come ha sintetizzato Johann Herczog49. La Bataglia moresca osserva fedelmente tutte queste convenzioni, in particolare nella riproduzione fonetica, onomatopeica e musicale di una sorta di catalogo di “rumori” 45 WRIGHT 2007: 29. BOVILL 1995: 51. 47 WRIGHT 2007: 22. 48 HERCZOG 2005: 80, 87 ss. 49 HERCZOG 2005: 151. 46 tipizzanti: armi bianche e armi da sparo, ordini e incitamenti vocali, fanfare e segnali da campo eseguiti sugli strumenti musicali d’uso militare50 (principalmente da trombettieri e timpanisti associati alla cavalleria); nonché le varie fasi operative: dall’ordine di sellare i cavalli, agli ingressi in campo di cavalleria e fanteria, al serrare le fila, al parare i colpi, all’attaccare e contrattaccare, fino alla vittoria finale, con l’acclamazione del proprio signore o sovrano. Presumo che, nel comporre una “battaglia moresca”, De Reulx possa essere stato stimolato dalla recente ristampa veneziana della battaglia di Janequin, e forse congiuntamente dall’altrettanto recente pubblicazione di una prima parodia, per giunta in stile napoletano: La bataglia villanesca di Giovanni Tommaso Cimello. Ma una versione parodistica “nera”, avente per protagonisti gli schiavi africani in Italia, resta qualcosa di sorprendente, anche perché senza precedenti nelle letterature (prima ancora che nelle musiche) europee. Qui le convenzioni testuali delle battaglie musicali vengono rielaborate secondo la pronuncia afronapoletana che diventerà tipica delle successive moresche: tromberda per tromba, rumarda per bombarda, harchabrusia per archibugi, fiaschette per fischietti, tammorina per tamburo o tamburello, fantarina per fanteria. E tuttavia risulta impossibile cogliere in questa parodia una vena comica. È la visionaria, sconvolgente evocazione di una rivolta degli schiavi africani che massacrano i bianchi, grazie all’intervento, direttamente dall’Africa, del loro re. Qui compare inoltre per la prima volta, nella nostra documentazione, la parola “Burno”: prima ancora che nei registri commerciali o demografici. Si canta inizialmente «a re Burno, tutta gente negra cha vo fare ordinanza per commattere gente iancha»; reiterati “evviva” a questo re costellano la fine della prima parte, così come la sezione centrale e finale della seconda; e tale acclamazione viene preceduta, nel finale, dalla dichiarazione dell’esito incontrovertibile della battaglia: «nigra vinciuta / iancha faiuta» (“i negri hanno vinto, i bianchi sono fuiuti, fuggiti”). Da cosa scaturiva un testo così anomalo? Quella che dal punto di vista di uno schiavo esasperato avrebbe potuto essere la rappresentazione di un sogno, per un bianco era soltanto un incubo. Chi poteva scriverlo, da dove attingeva l’idea, quale era l’interesse a ritrarre un evento - pur del tutto improbabile - così terrificante, e per quale pubblico? Accontentiamoci di osservare che, tecnicamente parlando, poteva esserne autore soltanto qualcuno in possesso di conoscenze plurilinguistiche (del gergo afro-napoletano, e di alcune espressioni originali africane), nonché di alcune precise informazioni sulla civiltà del Bornu. Si noti che, pur imitando le convenzioni testuali usate nelle altre “battaglie”, qui la descrizione della potenza militare dell’impero africano, lungi dall’essere fantasiosa o paradossale, si rivela compatibile con la realtà storica. Agli storici dell’Africa è nota la sofisticata arte della guerra del Bornu, quale è documentata proprio nel secolo delle moresche: la famigerata potenza della cavalleria, l’ampia disponibilità di archibugi acquistati dai mercanti turchi, e l’uso di trombe, le lunghe e fragorose kakaki, il cui suono terrorizzava le popolazioni del Sudan centrale. Doveva saperlo anche il nostro ignoto autore, in grado anche di interpretare il sentimento di rivalsa di quegli schiavi che, a Napoli come altrove, vagheggiavano la liberazione dalla schiavitù o addirittura il ritorno in Africa; che progettavano fughe, e a volte le realizzavano. Nelle canzoni moresche, l’aspirazione alla libertà verrà più pacificamente declinata nella speranza che i padroni disponessero, magari per testamento, o per consentire le nozze, il loro affrancamento. Ma in almeno una moresca (A la lappia) l’annuncio - menzognero - di tale affrancamento verrà attribuito, ancora una volta, al “nostra [sic] re”, in continuità con il nesso anticipato da De Reulx. Si stabilisce così, dalla Bataglia moresca al successivo florilegio delle 50 «Una battaglia rinascimentale può […] in un certo qual modo essere considerata come un “catalogo di rumori”, da quelli acuti, penetranti o argentini delle armi bianche all’intera gamma di rimbombi, scoppi, spari, schiocchi, gracchi e colpi realizzati dalle molteplici bocche da fuoco, dalle più piccole alle più grandi, infine alle grida ed esclamazioni o interiezioni degli uomini, pronunciati nei diversi idiomi e formule rituali; per non parlare di effetti propriamente musicali, semplici e rudimentali come i precisi ed efficaci segnali da campo, o più compiuti come le vere e proprie musiche militari» (HERCZOG 2005: 36 s.). canzoni moresche, un repertorio testuale che esprime riferimenti vuoi all’autorità imperiale del Bornu, vuoi al senso dell’identità nazionale di chi dal Bornu proveniva. La Bataglia di De Reulx è la prima fonte nella quale l’esclamazione araba e islamica “wa-llah!”, “per Allah!”, si combini con un’affermazione identitaria. A dispetto della sua precocità, tale affermazione vi trova la sua espressione più articolata: il grido «gualla gualla bernagualla». Il termine “bernaguallà” comparirà più volte nelle moresche, anche nella forma foneticamente più esplicita di “burnoguallà” (in Lucia celù). Per poi affermarsi, con numerose distorsioni e varianti, come il motto più tipicamente applicato ai “mori” nella letteratura napoletana (ma anche toscana): certo sulla scorta di un impiego popolare anche scherzoso, riscontrabile tanto nei contesti carnevaleschi quanto nei giochi infantili51. Nel tempo, con tale termine si finì per designare gergalmente, e sempre più genericamente, caratteri e comportamenti degli africani nell’Italia meridionale52. Ma non c’è dubbio che esso costituisse in origine un’orgogliosa esclamazione identitaria: non per nulla, nella seconda parte della Bataglia moresca, il «bernaguallà!» si alterna all’affermazione «Berna siam!», cioè “noi siamo Burno, siamo del Bornu”. Da cosa nasce quest’esclamazione, che dobbiamo considerare fra i più interessanti “dati realistici” contenuti nelle moresche? Il fatto a noi noto che il paese d’origine degli schiavi catturati e commerciati dal Kanem-Bornu venisse dimenticato, per essere sostituito con una convenzionale dichiarazione di appartenenza al territorio di cattura, non risponde alla domanda. Non si vede come e perché un individuo ridotto in schiavitù dovesse rivendicare fieramente, quasi fosse propria, l’identità di chi lo aveva rapito e privato della propria libertà. La spiegazione è un’altra, e va a costituire una delle più sorprendenti nozioni storiche deducibili dai testi delle moresche. Sappiamo infatti dai resoconti di viaggio di Leone l’Africano che poco dopo l’inizio del Cinquecento, in una fase di debolezza dell’impero del Bornu, gli stessi kanuri suoi abitanti venivano spesso razziati dagli arabi e venduti come schiavi53. Di questa incresciosa situazione, rappresentanti ed emissari dell’imperatore ebbero a lamentarsi ufficialmente, nelle sedi opportune, non sappiamo con quanto successo. L’esclamazione di fierezza “bernaguallà!” va intesa perciò come un modo di rimarcare la propria identità autentica di cittadino dell’impero Bornu, rispetto agli altri schiavi neri presenti in città, e classificati come “negri Bornu” solo perché commerciati dalla tratta 51 Nel corpus delle canzoni moresche, il motto - da pronunciare sempre tronco, a prescindere dalla segnatura o meno dell’accento - si trova nelle lezioni «bernaguallà» (A la lappia), «bernaguala» (Allala, pia calia e Canta Giorgia) e «burnoguala» (Lucia celu), oltre che nella forma invertita «quala burno», ancora in Lucia celu (per il cui significato specifico v. infra), a dimostrazione che si tratta di una parola composta: guallà vuol dire «per Allah!». Nel poema di Felippo Sgruttendio da Scafato La tiorba a taccone (1646) il mottozzo verrà accostato a un gioco musicale infantile, forse un girotondo cantato, designato come “rota”: «Lo bedè de peccerille / chella rota, che se fa: / uno canta, e cchiù de mille / fanno un po’: Pernovallà» (Corda IX, A Scatozza, le grolie de Carnevale). La tarda variante “pernovallà” ricorre dunque a proposito di un gioco di bambini che “sfottono” i mori e il loro linguaggio: lo scherzo prende spunto da un tranche de vie. La parodia di per sé suggerisce che dovesse esistere un uso emico dell’espressione, interno alla comunità africana in Italia. Inoltre, la quantità di varianti della forma scritta del termine è per me un chiaro indizio che il suo uso appartiene a una tradizione strettamente orale, non letteraria. Infine, nei versi di Sgruttendio, la riproduzione infantile testimonia un preciso uso responsoriale del mottozzo, che evidentemente veniva esclamato in risposta a strofe di canto. Il gioco, o la sua moda, si diffonde anche in Toscana nella storpiatura di Bernaccalà (al femminile), a designare una canzone tipica, o addirittura un intero genere di canto, che veniva eseguito nei contesti carnevaleschi su uno strumento musicale inequivocabilmente napoletano come il colascione. Questo è almeno quanto ci suggerisce il poeta toscano Stefano Vai (1592-1650) il quale, secondo Elena Ferrari-Barassi, «mostra di aver assimilato elementi popolareschi napoletani» quando scrive: «E dove, dopo me, doce n’andrà / l’amato colascione, al suon del quale / talvolta il Carnevale / cantar solevo la bernaccalà?» (cit. in FERRARI-BARASSI 1991: 76 n. 42). Proprio questo canto (probabilmente pantomimico) del ritornello “bernaccalà” deve essere stato ipostatizzato nella maschera di un “Pernovalla” che appare nella celebre serie litografica Balli di sfessania di Jacques Callot (1621-22). 52 Il primo studioso a intuire il significato originale del motto è stata la citata Ferrari-Barassi, che a proposito della sua ricorrenza, con varianti, nelle moresche lo dice «forse connesso col “re Burno” del Reulx» (FERRARI-BARASSI 1991: 57). Ma è sbagliato affermare, come fa detta studiosa, che bernagualà, assieme alle sue numerose varianti, sia in assoluto «sinonimo […] di “schiava mora”» (FERRARIBARASSI 1991: 57). La stessa motivazione che il termine – il quale compare in quasi tutte le moresche rielaborate da Lasso, e anche in conclusione di A la lappia di Grammatio Metallo – venga usato per lo più dal personaggio di Lucia o dei suoi equivalenti femminili, tutte schiave more (FERRARI-BARASSI 1991: 57), risulta inesatta. Il bernagualà è invece la più frequente esclamazione dei personaggi maschili, pretendenti di Lucia, e quando viene usata dal personaggio femminile assume un significato diverso: v. infra al par. 6. Solo col passar del tempo il mottozzo comincerà a designare in generale quel che è moresco, africano e perfino turchesco: ad esempio, nella ’Ntroduzzione del Cunto de li cunti di Basile il principe indosserà «la varda a bernaguallà», cioè una bardatura alla moresca. 53 AA.VV. 1991: 171. Il problema si era già verificato fra il 1260 e il 1277, e poi nel 1391-92, come sappiamo da lettere di protesta inviate dal Bornu ai sultani d’Egitto (AA.VV. 1991: 171; CUOQ 1985: 25; AA.VV. 1985: 378 s.). Qualcosa di simile - una tratta abusiva che razziava schiavi tra gli stessi abitanti dei paesi schiavisti - si sarebbe più volte verificato anche nell’impero del Congo fin dall’inizio del Cinquecento, inducendo più volte l’imperatore a protestare ufficialmente, tramite l’invio di ambasciate e delegazioni sia al re del Portogallo che al papa (DAVIDSON 1968: 104 s.; LIPSKI 2005: 27 s.). imperiale. La formula esprime il fatto che un nativo del Bornu, rapito e trasferito con la forza in Italia, ritenesse di avere ottime ragioni per rivendicare la propria appartenenza etnica: forse non tanto per un senso di superiorità sugli altri schiavi, quanto una posizione da leader di una comunità eterogenea. Le moresche del Cinquecento registrano dunque non solo un fatto storico, ma - assieme ad esso - un punto di vista africano su tale fatto: esclamando “bernaguallà!”, lo schiavista finito schiavo rivendica orgogliosamente le proprie origini. È quel che Giorgio litigando con Lucia. Ma, a di là del bernaguallà, quel “punto di vista” africano era abbastanza articolato da poter esprimere sia un’identità etnica distinta dalle altre, sia un senso di collettività panafricana, come vedremo adesso. 6. La “gente negra” delle moresche Nelle canzoni moresche, il ritrovato motto bernagualà (già presente nella Bataglia) si presenta come la più frequente esclamazione di Giorgio54. Ciò non è privo di implicazioni: se teniamo presente che tutti questi schiavi africani erano stati battezzati, come attestano anche i nomi cristiani (Giorgio, Martino, Cristoforo) ad essi imposti, l’esclamazione «per Allah!», congiunta all’etnonimo burno/berna, si fa carico di un’orgogliosa e stentorea affermazione delle proprie radici. Il musico è del Bornu, fiero di esserlo, e quando chiama a testimone Allah si dimostra ancora legato alle tradizionali espressioni islamiche. Ma non è lo stesso per Lucia: l’unica volta che il motto verrà usato da lei, assumerà una forma e una retorica diverse. In Lucia celu lo troviamo infatti invertito, nella frase «Nigra [negro] quala burno!». Lucia rivolge tale espressione a Giorgio all’inizio di una sequela di insulti, al chiaro scopo di provocarlo o prenderlo in giro. Dobbiamo dunque intendere quell’esclamazione esplosa nel contrasto con Giorgio come una parafrasi sarcastica del “burnoguallà”: il che rafforza ulteriormente l’ipotesi che anche Lucia, come già Comba nel precedente spagnolo, appartenga a un’etnia diversa da quella del corteggiatore, a una minoranza tribale proveniente dallo stesso territorio: forse proprio a una di quelle popolazioni tributarie del Burno e vittime delle sue razzie schiavistiche55. Cosicché anche nelle moresche si troverebbero contrapposti, nel litigioso corteggiamento, due diversi modelli identitari. Non a caso, nel contesto del battibecco, dove Lucia apre la sua sequela di insulti con quel «Nigra quala burno!», Giorgio risponde a sua volta con «Scaba canaza!». La contrapposizione diventa ancora più chiara nel climax del sottofinale, dove Giorgio esclama stavolta «Burnoguala, scaba canaza!», combinando il motto (che reitera fieramente l’affermazione identitaria) con l’insulto a Lucia (schiava non affrancata e per giunta “cagnaccia”, cioè infedele in tutti i sensi). Indignato, Giorgio ripeterà ancora il motto identitario nel finale, aprendolo però a un plurale nobile - «siamo burnoguala» - quasi parlasse a nome di un’intera fazione offesa. Il contrasto di Giorgio con Lucia si intreccia così al senso di appartenenza e di comunità in complessi risvolti, la cui decifrazione richiede una distinzione analitica delle dinamiche interpersonali e collettive e delle loro espressioni formulari. Dal punto di vista narrativo, infatti, le canzoni moresche intrecciano due diversi tópoi. Consideriamo prima quello del contrasto fra il liberto e la schiava, già noto dai precedenti spagnoli, ma che nelle moresche si esprime all’interno di una tattica di corteggiamento più sofisticata, alternando strumentali promesse matrimoniali e annunci di riscatto sociale. Più volte Giorgio annuncia con grande enfasi a Lucia notizie e rivelazioni (in realtà pretestuose) addotte al solo scopo di favorire un contatto fra il corteggiatore e la ritrosa. In Hai, Lucia, dopo il richiamo incipitario, il protagonista entra subito in argomento annunciando: «bona cosa io dic’a tia: / che padrona fatta franca / et vò bella maritare / Giorgia tua vò pigliare». In 54 In Allala, pia calia, mancando il dialogo con Lucia, il nome del protagonista - probabilmente sempre Giorgio - non viene espresso. Certo è che Giorgio considera sia sé stesso che Lucia come sudditi dell’impero: ricordiamo che, quando in A la lappia le annuncia mendacemente l’imminente affrancamento, egli sostiene che la notizia arriva da «nostra re». 55 una diversa occasione, corteggiando l’altra schiava mora Caterina, annuncia la partenza per Valencia, dove sappiamo che esisteva una famosa e antica confraternita nera, fondata nel 1472, che si occupava tra l’altro di raccogliere fondi per negoziare la liberazione di schiavi africani56. Nella retorica del corteggiamento, le aspettative di riscatto personale vengono collegate a punti di riferimento collettivi: questi a garanzia di quelle. Nella dimensione narrativa, è la realtà (col richiamo all’istituto giuridico dell’affrancamento o manomissione, e alle forme organizzative delle minoranze africane in Europa) a far da garante alla fiction del corteggiamento, alle tattiche messe in atto dai protagonisti della narrazione. La massima articolazione narrativa del discorso si trova in A la lappia, dove Giorgio pretende addirittura di essere appena «benuta [giunto] de Granata, / che te porta bona nova». Anche qui la notizia richiede di essere annunciata con la pompa necessaria, e stavolta Giorgio la spara grossa: «Senta poca [senti un po’], ti vo’ dire, / l’ha mandata nostra re: / gente negra, longh’e corta, / siamo franchi, in bona fe». La quartina è straordinariamente densa e ricca di dettagli, nel suo disvelarci aspettative, contesti, referenti reali, sia pur all’interno di una fiction. A sentir Giorgio l’iniziativa proverrebbe addirittura dal loro sovrano, l’imperatore del Burno. Il provvedimento è generale, si estende a tutti gli schiavi neri, clamoroso successo politico e diplomatico. Si tratta, ovviamente, di una panzana: ma per noi è oltremodo significativa la pretesa di Giorgio che dall’affrancamento non sia esclusa nessuna razza o etnia africana. Quando il protagonista si contrasta con Lucia a livello personale, usa (nel motto) l’etnonimo Burno; quando invece promette l’affrancamento o una festa di nozze, si ricollega a una dimensione collettiva. «Gente negra longh’e corta» è la sua definizione più articolata: una varietà di complessioni che effettivamente rispecchia l’antropometria africana. Per noi è anche la conferma di quanto fosse ampia la varietà di etnie africane presenti a Napoli; di come il contesto sociale cui appartiene l’autore del testo ne fosse consapevole; e di quanto gli risultassero familiari quei referenti così vivaci e precisi, nella loro self-definition e nelle loro aspettative. Ma, anche nella sua formulazione più sintetica, l’espressione «gente negra» esprime magnificamente il senso di una collettività ideale, se non ancora fattuale, che già De Reulx contrapponeva a quella della «gente iancha». È questo il secondo tópos su cui si sviluppa la narrazione moresca. Ci troviamo in effetti in un’epoca nella quale, in Spagna e Portogallo ad esempio, ma anche in Sicilia, si costituivano confraternite africane di mutuo soccorso. Per Napoli, la ricerca archivistica non ha ancora trovato niente di simile nell’epoca delle nostre moresche (e le confraternite e congregazioni napoletane delegate ad occuparsi degli schiavi durante il Seicento non furono mai autogestite)57. Tuttavia, l’esistenza di qualche piccola comunità di “nigri” napoletani si potrebbe inferire, ad esempio, da una «cappella di nigri», documentata fin dal 1514, che era probabilmente una sorta di compromesso fra chiesa e moschea, e aveva a capo alcuni autorevoli «maestri». Si trovava nel Fondaco dei Mori al Porto, come appare da un documento del 1562, quando era ormai gestita da un «papasso» tout court, cioè un Imam, battezzato cristiano ma considerato «moro infidele»58. E non è l’unico esempio: gli storici sospettano anche l’esistenza di piccole organizzazioni private di africani neri di tipo clandestino o truffaldino, collegate con la Sicilia59. Dietro il tópos della «gente negra» più volte evocata nelle moresche è dunque legittimo cogliere un sentimento collettivo di fraternità che, ben confortato da situazioni storicamente documentabili, resiste solidamente a qualsiasi intenzione meramente umoristica. Che tale «gente negra» includesse fisionomie e complessioni diverse, gente «longh’e corta», è un ulteriore dato di fatto; e che tali differenze potessero essere elise da un senso di forte 56 BLUMENTHAL 2005: 227. BOCCADAMO 2010: 129 ss. 58 Cfr. i documenti citati in BOCCADAMO 2010: 13 ss. 59 BOCCADAMO 2010: 47; cfr. ivi: 23 s., 45. 57 solidarietà è, oltre che sociologicamente plausibile, perfettamente attestato dall’esistenza di alcune forme organizzative private. Anche il sempiterno cliché caricaturale dell’africano “che va matto per la musica” trova la sua ragione narrativa, nelle moresche, in attitudini e inclinazioni reali: non semplicemente caratteriali, ma di fondamento sociologico, rituale, tradizionale. Consideriamo ad esempio il verso «gente negra, vol cantare», che ricorre due volte in Hai Lucia, e si ripropone in una tipica distorsione fonetica e gergale - «gente nigra bo cantata» - in Tichi toche. Attorno a questa frase, forse proverbiale, la situazione evocata in Hai Lucia trova uno scenario contestuale talmente preciso da rendere improbabile l’ipotesi di un costrutto artificiale, di mera fiction. Qui la consueta proposta di matrimonio con cui Giorgio cerca di sedurre Lucia apre il sipario su una scena di festeggiamento nuziale, con la partecipazione della propria gente: «Tutta negra v’invitare / Notte giorno vonno sonare / Tambililili». Il suono del tamburello chiosa con icastica efficacia la descrizione della scena, dove il senso della festa è affidato in un verso («Tutta negra v’invitare») alla presenza dell’intera comunità, e nel successivo («Notte e giorno vonno sonare») a un intrattenimento musicale in grado di cementare quella stessa comunità tramite la cerimonia africana tradizionale della veglia festosa, che si protrae dal giorno alla notte, in un inesausto tambilililì. Comunicandoci, en passant, che anche nella Napoli del Cinquecento agli africani, schiavi affrancati e non, era lecito riunirsi per suonare le proprie musiche tradizionali in occasioni speciali quali una festa di nozze, come è attestato in altre realtà europee e mediterranee60. I nostri due tópoi rivelano dunque eloquentemente due facce distinte e differenti di una stessa medaglia. Dire “gente negra”, in un senso generale e collettivo, ma consapevole delle differenze interne simboleggiate dalle diverse antropometrie, è ben diverso che esclamare “burnogualla!” per dar voce in modo preciso e circoscritto ai Kanuri del Bornu, autenticandone l’identità e sigillando l’appartenenza etnica con un giuramento sacro: guallà!, “per Allah!”. Tra l’espressione «gente negra» e il motto «bernoguallà», che nelle moresche convivono, si intravede l’esistenza di una comunità nella comunità, un gruppo omogeneo (e forse dominante) proveniente dal Bornu e di etnia kanuri. Possiamo affermarlo sulla base della decifrazione di una serie di parole ed espressioni africane autentiche contenute nelle moresche, e finora considerate incomprensibili e misteriose. 7. Il messaggio kanuri delle moresche Una valutazione quantitativa prudenziale dei termini africani, in particolare kanuri, contenuti nella Bataglia moresca e poi nelle canzoni moresche, ne conterebbe complessivamente una ventina circa (ma, calcolando i casi ambigui o di difficile individuazione, potrebbero essere anche il doppio). Non pochi termini si trovano combinati in intere frasi di senso compiuto, anche se poi frasi o parole singole spesso si ripetono da un testo all’altro con grafie diverse: segno palese di una loro trasmissione esclusivamente orale, mai fissata in un unico testo di riferimento. Qui ne esaminerò solo alcune occorrenze, fornendo la traduzione61 e illustrando la loro collocazione all’interno di un eloquio misto di lingua italiana e dialetto napoletano, ma complessivamente definibile “afro-napoletano” nei suoi tratti lessicali e fonetici. Per semplificarne la trascrizione, trascurerò le quantità vocaliche e i segni diacritici normalmente usati nella traslitterazione del kanuri. 60 Ad esempio a Malta, luogo di smistamento della tratta verso la Sicilia e l’Italia meridionale, gli schiavi godevano di alcune precise libertà: potevano frequentare le taverne, mangiando e bevendo alcolici (e spesso progettandovi evasioni); nelle prigioni gli era concesso di parlare liberamente le loro lingue e praticare i propri culti religiosi; e in generale potevano frequentarsi, riunirsi in luoghi poco sorvegliati dalle autorità, creare associazioni di solidarietà (BROGINI 2002: 7). Brantôme, nel “Discorso secondo” della Vie des dames galantes (la più nota sezione dei suoi Mémoires), riferisce che a Malta, la domenica, cameriere e schiave nere potevano liberamente danzare in piazza la fiscaigne, da lui personalmente osservata durante alcuni mesi passati nell’isola poco dopo l’assedio turco del 1565 (BRANTOME 1982: 254). Per le feste e i passatempi degli schiavi neri in Portogallo si veda invece SAUNDERS 1982: 105-107. 61 Per questa prima ricognizione dei termini kanuri nelle canzoni moresche ho utilizzato il dizionario kanuri-inglese contenuto in KOELLE 1854. Diciamo innanzitutto che tutta una serie di espressioni viene introdotta da “a la” oppure “alla-”, corrispondente al kanuri álla, cioè “Allah”. Ricorre in particolare l’espressione idiomatica che si trova nelle partiture a stampa come “a la lappia” o “allalà pia”, corrispondente in kanuri ad álla seguito da lafia: il che equivale al nostro augurale “salute!, salve!” e viene usato anche nelle formule vocative convenzionali. Non a caso simili espressioni di saluto, quando ricorrono nelle moresche, si collocano all’inizio del testo, come incipit. In A la lappia, testo musicato da Grammatio Metallo, il distico iniziale recita: A la lappia camocan a la lappia gramini. In quel “camocan” - che in una forma leggermente diversa, “cam cana…”, compariva già nella Bataglia moresca - sembrano fondersi due parole più brevi. In kanuri, kâm vuol dire “un uomo, una persona”; kámu sta invece per “donna”. In alternativa, pensando a un’aspirata iniziale, avremmo hâm62 che è plurale di kâm e vuol dire “gente”. Non c’è dubbio che si tratti, nell’insieme, di un saluto collettivo, ovviamente rivolto a quanti comprendevano il kanuri nella Napoli del Cinquecento: dunque, un’espressione di fraternità e di identità collettiva fra africani. Quanto a “gramini”, il suono gr a inizio parola non esiste in kanuri. La parola che più si avvicina è karámini, che sta per “mio fratello [o sorella] minore”63. L’insieme del distico si può dunque considerare come una formula di saluto ben articolata nel rivolgersi alla propria gente: adulti e giovani, uomini e donne, l’intera comunità kanuri a Napoli. Nell’incipit di Allalà, pia calia, testo musicato da Lasso, troviamo una formula analoga, forse ancora più interessante perché kalia in kanuri vuol dire “schiavo maschio”64. Lo stesso termine ricorreva nel sintagma “Celùm calia”, con “calia” ripetuto quattro volte, all’inizio della Bataglia moresca di De Reulx. La prima delle due parole, pur diversamente vocalizzata nelle varie lingue nilo-sahariane del Ciad e dintorni, sta per “nero”: tzelam in kanuri, tsilim o cilim in mabire (altro linguaggio del Ciad)65. D’altronde, nel corpus delle moresche, lo stesso termine si trova anche nelle grafie “celù” e “cilùm”: nel primo caso nel vocativo Lucia, celu, ad incipit dell’omonima moresca di Lasso; nel secondo caso nell’espressione «Calia tauza cilum celumdini» presente in Tichi toche, dove addirittura due diverse lezioni, “cilum” e “celum”, si trovano collegate. Qui il saluto va dunque agli “schiavi neri”: la comunità allargata, formata da tutti gli africani di colore in cattività, non solo i “fratelli e sorelle” della nazione kanuri. Un saluto che ricongiunge nella stessa sorte i nativi del Bornu, “schiavisti” finiti fatalmente schiavi, con le etnie già vittime delle loro razzie. Un’ulteriore formula, paragonabile alle precedenti, si trova due volte nel corpus delle moresche, anche se con diverso spelling: la grafia è “a la gura gidde” nella Bataglia moresca di De Reulx, “a la cura chi de…” in Allala, pia calia di Lasso. Come sappiamo, “A la” sta per Allah, mentre kúra in kanuri vuol dire “grande”: titolo tradizionalmente riferito a Dio nel mondo arabo. Qui l’originale kanuri dev’essere álla guréntse, espressione stereotipa per “Dio ti protegga”, anche questa usata come formula di saluto. Più difficili da decifrare altri sintagmi basati sul termine kalia, presenti anch’essi in Allala, pia calia, come «pampana calia». In kanuri non esistono parole inizianti per pam- o pan-; tuttavia ampáma vuol dire “guardiano, custode”. Ne risulta l’espressione “schiavo guardiano” o “guardiano degli schiavi”, che non può non far pensare al personaggio di Concad’Oro, presente nella cantata carnevalesca del 1628 La Luciata nuova, assieme agli altri tre già noti alle moresche: Giorgio, Martino e Cristoforo. L’indizio è importante per supportare 62 Esiste anche l’alternativa âm. L’espressione normalmente richiede anche la parola per “fratello” o “sorella”. 64 Il termine per “schiava” è invece kir. 65 Cfr. JOHNSON/CAMERON 2002: 8. 63 l’ipotesi di un impianto teatrale implicito nel ciclo delle moresche, stabilendo una completa corrispondenza fra tale ciclo e lo spettacolo carnevalesco delle Luciate, anche se queste troveranno pubblicazione solo vari decenni più tardi. Un indizio così significativo contribuisce a valorizzare il testo di Allalà, pia calia, che è già il più emblematico fra quelli musicati da Lasso per il fatto di contenere il maggior numero di parole presumibilmente africane, ma anche il più atipico, in quanto non descrive una serenata. I primi tre versi contengono la formula di saluto e richiamo alla comunità degli schiavi, «Allalà, pia calia», seguita dall’affermazione identitaria «siamo bernagualà» e dal suono onomatopeico del tamburo o tamburello - Tanbilililili, Tanbilili -, a descrivere allusivamente una riunione di comunità o confraternita africana, convocata per ragioni cerimoniali o festose. Il quarto verso, “schinchina bacu”, può essere l’invito a Lucia - o ad altra schiava “mora” - ad unirsi alla festa: distorsione del napoletano “scinn’ abbasc’”, cioè “scendi giù” (stante l’impossibilità degli africani a pronunciare il suono sh66), un invito a uscire di casa e scendere in strada. Il quinto verso, “Gli, gli, pampàna calia”, può ben rappresentare a questo punto un riferimento al sorvegliante degli schiavi, vuoi per mettere in guardia i presenti, vuoi per invitare anche lui a unirsi alla festa. E il successivo, molto ritmato nell’esecuzione musicale - Cian, cian, nini gua gua… - si conclude con l’espressione «ania catuba», contenente la prima occorrenza del termine “catuba” (o “catubba”), associato a un ballo di strada che nella Tiorba a taccone (Corda IX, v. 109) di Sgruttendio viene riferito al personaggio di Lucia, e nella Luciata nuova alla comunità napoletana degli schiavi africani. Troviamo così evocata una festa danzante in pieno stile, una cerimonia africana a Napoli, aperta alla comunità nera in senso esteso, panafricano: indizio del riconoscimento di alcuni diritti, magari solo durante particolari celebrazioni private o festività pubbliche, ai membri della comunità. Nel ciclo delle moresche, questo invito alla danza corrisponde a quanto pare alla realizzazione della festa nuziale promessa da Giorgio in Hai Lucia, cioè alla conclusione della vicenda amorosa. Una combinazione più sintetica di questa straordinaria sequenza di sei versi, ma ad essa analoga per l’uso comune di alcuni termini, costituisce l’inizio di Lucia celù: Lucia, celù, hai, hai, biscanìa, Tambilililili guà guà, ciri, ciri cian. L’onomatopea del tambilililili ripropone il ritmo festoso del tamburo, il suono “cian” ritorna assieme ad altri fonemi ritmicamente reiterati. Ái in kanuri sta per “veramente, realmente”. Ma qui troviamo anche qualcosa che assomiglia alla radice besg- che, in kanuri, esprime relazione con la danza: ad esempio termini come bésge e besgéngin indicano una festa da ballo, bésgema un “bravo danzatore”. La stessa radice, peraltro, si trova presente anche nella frase “are buscani” presente in Allala, pia calia: laddove are, in lingua mabire, significa “venire”, e variamente accentato (“áre” o “aré”) corrisponde all’imperativo “vieni qui”67. L’espressione “are buscani” rappresenta dunque, nel contesto di Allala, pia calia, un ulteriore richiamo ai danzatori. Il lavoro di decifrazione non finisce qui: anzi, è appena iniziato. Mi limito a segnalare, per futuri approfondimenti, che del lessico africano delle canzoni moresche potrebbero far parte alcuni possibili toponimi ed etnonimi, e anche termini appartenenti ad altre lingue o dialetti, oltre quelli qui indicati. Ma per il momento ci fermiamo. Quel che emerge complessivamente - oltre all’esistenza di un ciclo di canzoni, in grado di celebrare, nel Carnevale napoletano o in contesti farseschi, la vivace e spesso festosa presenza a Napoli dei neri africani - è la 66 67 V. supra, par. 2. JOHNSON/CAMERON 2002: 8. vastissima portata del contributo che la decifrazione delle moresche può dare alla ricostruzione storica di questa presenza in termini culturali, identitari, comunitari. BIBLIOGRAFIA AA.VV. 1985: AA.VV (J.M. Cuoq, cur.), Recueil des sources arabes concernant l’Afrique Occidentale du VIII au XVI siècle (Bilâd al-Sûdân), Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1985. AA.VV. 1991: Histoire générale de l’Afrique. IV. L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, Présence Africaine/Edicef/UNESCO, Paris-Vanves, 1991. AA.VV. 1997: Histoire générale de l’Afrique. III. L’Afrique du VIIe au XIe siècle, Présence Africaine/Edicef/UNESCO, Paris-Vanves, 1997. BARICCI 2010: E. Baricci, La scena “all’ebraica” nel teatro del Rinascimento, «Acme», 63, 1, 2010. BARLETTA 2008: V. Barletta, Trotaconventos and the Mora: Grammar, Gender and Verbal Interaction in the Libro de buen amor, «La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures», 37, 1, 2008. BAUMANN 1996: R. Baumann, I lanzichenecchi, Einaudi, Torino, 1996 (ed. it. di Id., Landsknechte. Ihre Geschichte und Kultur vom späten Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg, Beck, München, 1994). BLUMENTHAL 2005: D. Blumenthal, ‘La Casa dels Negres’: black African solidarity in late medieval Valencia, in EARLE/LOWE 2005. BOCCADAMO 2010: G. Boccadamo, Napoli e l’Islam. Storie di musulmani, schiavi e rinnegati in età moderna, D’Auria, Napoli, 2010. BOVILL 1995: E.W. Bovill, The Golden Trade of the Moors, 2a ed., Markus Wiener, Princeton, 1995, rist. 1999 (1a ed. Oxford University Press, London-New York-Toronto, 1958). BRANTÔME 1982: Brantôme (P. de Bourdeille), Le dame galanti, Adelphi, Milano, 1982 (rist. 1994). BROGINI 2002: A. Brogini, L’esclavage au quotidien à Malte au XVIe siecle, in «Cahiers de la Méditerranée», 65, 2002. CARDAMONE 1999: D.G. Cardamone, The Salon as marketplace in the 1550s: patrons and collectors of Lasso’s secular music, in Peter Bergquist (cur.), Orlando Di Lasso Studies, Cambridge University Press, 1999. CASARES 2005: A.M. Casares, Free and freed black Africans in Granada in the time of the Spanish Renaissance, in EARLE/LOWE 2005. CHASCA 1946: E. de Chasca, The Phonology of the Speech of the Negroes in Early Spanish Drama, «Hispanic Review», 14, 4, ottobre 1946. COHEN 1967: R. Cohen, The Kanuri of Bornu, Holt, Rinehart and Winston, New YorkChicago-San Francisco-Toronto-London, 1967. CORTELAZZO 1976: M. Cortelazzo, La figura e la lingua del “todesco” nella letteratura veneziana rinascimentale, in Scritti in onore di Giuliano Bonfante, vol. 1, Paideia, Brescia, 1976. CUOQ 1985: J.M. Cuoq, Introduction a AA.VV. 1985. DAVIDSON 1968: B. Davidson, Civiltà africane, Mondadori, Milano, 1968 (ed. it. di Id., African Kingdoms, Time-Life Books, New York, 1966). DIEMLING/VELTRI 2009: M. Diemling, G. Veltri (curr.), The Jewish Body: Corporeality, Society, and Identity in the Renaissance and Early Modern Period, Studies in Jewish History and Culture 17, Brill, Leiden, 2009. EARLE/LOWE 2005: T.F. Earle, K.J. Lowe, Black Africans in Renaissance Spanish literature, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2005. FERRARI-BARASSI 1991: E. Ferrari-Barassi, La tradizione della moresca e uno sconosciuto ballo del Cinque-Seicento, in LORENZETTI 1991. HARRAN 1989: Don Harrán, Tradition and Innovation in Jewish Music of the Later Renaissance, «The Journal of Musicology», 7, 1, 1989. HARRAN 2009: Don Harrán, “Adonai con voi” (1569), a simple popular song with a complicated semantic about (what seems to be) circumcision, in DIEMLING/VELTRI 2009. HERCZOG 2005: J. Herczog, Marte armonioso. Trionfo della battaglia musicale nel Rinascimento, Congedo, Galatina, 2005. JOHNSON/CAMERON 2002: E. Johnson, C. Hamm, Mabire: A Dying Language of Chad, SIL International, 2002. JONES 1973: R.O. Jones (cur.), Studies in Spanish Literature of the Golden Age presented to Edward M. Wilson, Tamesis Books, London, 1973. KIRKENDALE 1972: W. Kirkendale, Franceschina, Girometta, and Their Companions in a Madrigal “a diversi linguaggi” by Luca Marenzio and Orazio Vecchi, «Acta Musicologica», 44, 2, 1972. KOELLE 1854: S.W. Koelle, African Native Literature, or Proverbs, Tales, Fables, & Historical Fragments in the Kanuri or Bornu Language. To which are added a translation of the above and a Kanuri-English Vocabulary, Church Missionary House, London 1854. LANGE 1977: D. Lange, Chronologie et histoire d’un royaume african (de la fin du Xe siècle jusqu’à 1808), Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 1977. LAWRANCE 2005: J. Lawrance, Black Africans in Renaissance Spanish literature, in EARLE/LOWE 2005. LIPSKI 2005: J. Lipski, A History of Afro-Hispanic Language. Five centuries, five continents, Cambridge University Press, Cambridge, 2005 (rist. 2009). LORENZETTI 1991: R. Lorenzetti (cur.), La moresca nell’area mediterranea, Forni, Sala Bolognese, 1991. LOWE 2005: K. Lowe, Notes on the text, in EARLE/LOWE 2005. MINNICH 2005: N.H. Minnich, The Catholic Church and the pastoral care of Black Africans in Renaissance Italy, in EARLE/LOWE 2005. NETTL 1931: P. Nettl, Some Early Jewish Musicians, «The Musical Quarterly», 17, 1, 1931. NETTL 1944: P. Nettl, Traces of the Negroid in the “Mauresque” of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, «Phylon», 5, 2, 1944. PALMER 1936: R. Palmer, The Bornu Sahara and Sudan, John Murray, Londra, 1936 (rist. Negro University Press, New York, 1970). PUERTO MORO 2010: L. Puerto Moro, Obra conocida de Rodrigo de Reinosa, Cilengua, San Millán de la Cogolla, 2010. RAK 1994: M. Rak, Napoli gentile. La letteratura in “lingua napoletana” nella cultura barocca (1569-1632), Il Mulino, Bologna, 1994. RE 1912: E. Re, Qualche nota sul tipo dell’ebreo nel teatro popolare italiano, «Giornale storico della letteratura italiana», 60, 1912. RUSSELL 1973: P.E. Russel, Towards an interpretation of Rodrigo de Reinosa’s “poesía negra”, in JONES 1973. SANDBERGER 1921: A. Sandberger, Orlando di Lassos Beziehungen zur italienischen Literatur, in Id., Ausgewählte Aufsätze zur Musikgeschichte, Drei Masken Verlag, Munich, 1921, vol. 1 (già in «Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft», 5, 3, 1904). SAUNDERS 1982: A.C. de C.M. Saunders, A Social History of Black Slaves and Freedmen in Portugal, 1441-1555, Cambridge University Press, Cambridge-New York (rist. 2010). SHILOAH 1991: A. Shiloah, The meeting of Christian, Jewish and Muslim musical cultures on the Iberian Peninsula (before 1492), «Acta musicologica», 64, 1, 1991. SLOMAN 1949: A.E. Sloman, The Phonology of Moorish Jargon in the Works of Early Spanish Dramatists and Lope de Vega, «The Modern Language Review», 44, 2, aprile 1949. STIPČEVIĆ 1993: E. Stipčević, La Serenissima, l’Istria e la Dalmazia. Contatti e interferenze musicali nel Cinque e Seicento, «IRASM», 24, 1993. URVOY 1949: Y. Urvoy, Histoire de l’empire du Bornou, Librairie Larose, Paris, 1949. VERLINDEN 1955: Ch. Verlinden, L’esclavage dans l’Europe medievale, vol. 2. Italie, Colonies italiennes du Levant, Levant latin, Empire byzantin, De Tempel, Brugge, 1955. VIANELLO 2005: D. Vianello, L’arte del buffone. Maschere e spettacolo tra Italia e Baviera nel XVI secolo, Bulzoni, Roma, 2005. WRIGHT 2007: J. Wright, The Trans-Saharan Slave Trade, Routledge, New York, 2007.
Scarica