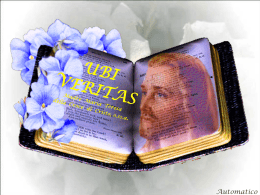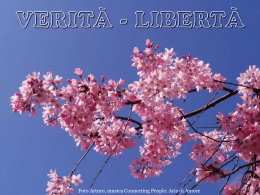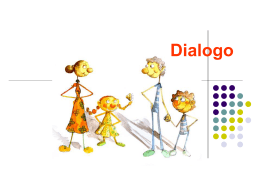Teorie
dell’argomentazione
cod. 10668
a.a. 2015-6
corso annuale
Richard Davies
Indicazioni di lettura
per frequentanti
e per non-frequentanti
1
Indice
Introduzione
Testi di riferimento
Modalità di verifica
Laboratorio ‘Linguaggi e stili della filosofia angolofona’
Programma delle lezioni I semestre
Programma delle lezioni II semestre
4
4
5
5
7
Testi “classici” in ordine cronologico
Platone,
Eutidemo (275c-7c, 283e-8d e 293a-303b)
Teeteto (169-72)
Aristotele,
Confutazioni sofistiche (capp. 1-5)
Protrettico (fr. 2)
Metafisica (IV, 3-4)
Crisippo di Soli Frammenti logici (270-87)
Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VII, 39-41;
Sant’Anselmo,
Proslogion 2-5;
Pietro Ispano,
Trattato di logica (VII, 150-63)
San Tommaso,
Somma Teologica, I, qu. 2;
J. Locke,
Saggio (IV, xvii, 1-4 e 19-24)
B. Bolzano,
Dottrina della scienza, (§§ 30-3)
A. Schopenhauer Dialettica
J. S. Mill,
Sistema di logica (V, 1-2)
F. Nietzsche,
“Su verità e bugie…”
C.S. Peirce,
“Deduzione, induzione e ipotesi”
10
26
29
34
37
39
43
46
49
52
57
65
70
87
95
103
Letture autonome
Strumenti di consultazione
Storie della logica
Possibili percorsi di approfondimento
111
112
113
Prontuario per la stesura di una tesina
115
3
Introduzione
Testi di riferimento
Modulo I
A Concetti base
Per i frequentanti: gli appunti delle lezioni, di cui verranno forniti estratti settimanalmente sul sito
del corso
Per i non-frequentanti: P.G. Odifreddi: Il diavolo in cattedra, Einaudi, Torino 2003, cap. I-VIII (pp.
9-83) e XI-XIII (pp. 114-51)
B La nozione di inferenza deduttiva
Almeno UNO tra:
A. Coliva e E. Lalumera, Pensare, Carocci, Roma 2007 capp. 1 e 2 (pp. 9-77: include anche una
breve esposizione delle tabelle della verità a pp. 47-67)
A. Iacona, L’argomentazione, Einaudi Torino 2010, capp. 1 e 2 (pp. 1-73)
G. Rigamonti, Corso di Logica, Bollati Boringhieri, Torino 2005, prima parte (pp. 15-60)
C Elementi di formalizzazione (si raccomanda di tentare gli esercizi, di cui i testi forniscono le
soulzioni)
Almeno UNO tra:
F. Berto: Logica da zero a Gödel, Laterza, Bari-Roma, 2007, capp. 1-3 (pp. 3-143)
E.J. Lemmon, Elementi di Logica, Laterza, Bari-Roma 2007, capp. 1-3.4 (pp. 3-141: con enfasi
sulla deduzione naturale anziché la verofunzionalità)
D. Palladino: Corso di logica, Carocci, Roma, 2004 capp. 2 (pp. 51-75) e 5 (pp. 119-57)
G. Rigamonti, Corso di Logica, Bollati Boringhieri, Torino 2005, capp. 5-7 (pp. 63-94) e 13-14 (pp.
147-67)
A. Varzi (et al.): Logica, McGraw-Hill, Milano, 2004 capp. 3 (pp. 45-80) e 6-7 (pp. 131-97)
Modulo II
D Rassegne di “fallacie”
Per i frequentanti: almeno UNO tra:
A. Coliva e E. Lalumera, Pensare, Carocci, Roma 2007 cap. 4 (pp. 101-33)
A. Iacona, L’argomentazione, Einaudi, Torino 2010, cap. 4 (pp. 107-41)
Per i non-frequentanti: almeno UNO tra:
F.F. Calemi e M. Paolini Paoletti, Cattive argomentazioni: come riconoscerle Carocci, Roma 2014
(pp. 128)
P. Cantù E qui casca l’asino, Bollati Boringhieri, Torino 2007 (pp. 177)
F. D’Agostini, Verità avvelenate, Bollati Boringhieri, Torino 2010 (pp. 257)
E Testi classici
Qui sotto alle pp. 10-110
Modalità di verifica
Fatto salvo che un voto per un esame universitario è valido solo se suffragato dalla firma dello
studente sui registri della stessa università alla presenza di almeno un membro della commissione
d’esame del corso per cui si procede alla valutazione, e tenendo fermo il diritto dello studente di
non accettare un voto, rifiutando di apporre la sua firma, si offre una varietà di modi di generare un
voto.
4
Quello più affermato è l’interrogazione orale. Tipicamente, questa è della durata di 10-15 minuti
per modulo e comincia con una domanda “a scelta” per ciascuna delle aree coperte nello
svolgimento delle lezioni. Il docente riserva il diritto di interrogare anche sugli argomenti meno
visitati dallo studente; in particolare, per quanto riguarda il primo modulo, potrà chiedere una breve
dimostrazione scritta di padronanza della tecnica delle tabelle della verità e delle regole base di
deduzione naturale. Nel caso in cui lo studente sia disposto ad accettare un voto generato per una
delle altre modalità, l’interrogazione può ridursi al minimo indispensabile.
Alla fine di entrambi i moduli, verranno proposti dei “pre-appelli” (paper) scritti riguardanti gli
argomenti trattati in aula nel corso delle lezioni. Per la valutazione del corso intero, i voti sono di
uguale peso, e quindi una media aritmetica (arrotondata in alto) dei due voti può essere registrata
come esito unico della frequenza. Lo studente che voglia integrare il voto è sempre libero di
sottoporsi a interrogazione orale sui temi già affrontati nello scritto. Entrambi gli esami sono di due
ore, e comprendono una scelta di tre domande tra le sei proposte. Ogni domanda vale 10/30. Nel
caso del primo modulo, ci saranno due domande sulla formalizzazione, indicate come tali e basate
sulle letture nella sezione C dei “Testi di riferimento”, e quattro sugli argomenti più latamente
concettuali. Lo studente deve rispondere ad almeno una delle domande nella prima sezione e,
quindi, non più di due nella seconda. Per il secondo modulo, la scelta delle tre domande sulle sei
proposte è libera. Risposte in sovrannumero non vengono prese in considerazione.
Studenti che presentano elaborazioni personali sia a lezione nel corso sia nel laboratorio possono far
valere il loro impegno fino ai 6 cfu riservati all’uno o l’altro dei moduli.
Un’ulteriore proposta è quella della tesina, ossia una relazione dattiloscritta di 5-10 pagine
riportando gli esiti di letture e riflessioni autonome riguardanti un argomento inerente ai temi del
corso. In appendice alla dispensa pp.113-4, si suggeriscono alcuni possibili percorsi con
bibliografia annessa e un prontuario per la stesura di una tesina. In ogni caso, e soprattutto per i
non-frequentanti, è vivamente consigliato di concordare l’argomento da trattare con il docente.
Gli studenti sono liberi di optare per una modalità o l’altra per un modulo a prescindere dalla scelta
operata per l’altra .
Laboratorio
Nel primo semestre, si propone un laboratorio di 30 ore (3 ore la settimana) dal titolo “Linguaggi e
stili della filosofia anglofona”, aperto a tutti gli studenti del Dipartimento nonché ai docenti, in cui
si prendono in esame testi in lingua inglese su temi inerenti al corso, tra cui alcuni a cui si fa
riferimento diretto a lezione. I testi per avviare il laboratorio verranno forniti e commentati dal
docente. L’ulteriore sviluppo del laboratorio dipenderà dagli interessi degli astanti.
Per gli studenti il cui Corso di Laurea non prevede il Tirocinio, questi incontri possono essere di
supporto alle lezioni del docente e contributi seminariali da parte degli studenti possono concorrere
alla valutazione del profitto del corso.
Per gli studenti il cui Corso di Laurea prevede il Tirocinio, la frequenza di almeno 80% degli
appuntamenti del laboratorio e l’offerta di almeno un intervento di analisi testuale verrà
riconosciuta come sostitutiva del Tirocinio stesso (e quindi valevole 5/6 cfu).
Programma delle lezioni
I semestre: Il guscio della filosofia (30 ore)
N°
Argomento trattato
lezione
1
Materiali e modalità del corso
“Il guscio della filosofia”: le parti prinicipali della disciplina (Diogene Laerzio, Vite.
nella dispensa)
2
Un ragionamento contro il non-ragionare (Aristotele, Protrettico nella dispensa)
5
– la non-generalizzabilità di ragionamenti che comunque funzionano
3
L’emergere di un’arte di persuadere: sofisti e politici in giro per Atene
– difendersi contro i sofismi (Platone Eutidemo: da riprendere nel secondo modulo)
4
La formazione dell’Organon aristotelico
5
La forma generale dell’inferenza e i suoi “sommi generi”
– deduzione, induzione e abduzione
6
La non-formalizzabilità della maggior parte delle inferenze
– che cosa s’intende per “forma logica”
– la nozione di “potere logico”
7
Una prima distinzione tra costanti logiche e “variabili”
– l’uso delle lettere da parte di Aristotele
8
La sillogistica (1): proprietà e la loro rappresentazione come insiemi
– alcune inferenze “immediate”
– premesse e conclusioni
9
La sillogistica (2): coppie di premesse
– coppie “sterili” e la riduzione di 256 combinazioni a 24
10
La sillogistica (3): modi e figure
– la “perfezione” di bArbArA
– la tradizone mnemonica al posto dell’assiomatizzazione
11
La definizione di “definizione” (1)
– condizioni necessarie e sufficienti
– definizione per genere e specie (l’albero di Porfirio)
12
La definizione di “definizione” (2)
– definizioni ostensive
– definizioni ricorsive
13
Ambiguità (1)
– omonimia (da riprendere nel secondo modulo), sinonimia, paronimia
– somiglianza di famiglia
– vaghezza
14
Ambiguità (2)
– significato focale
– significato primario
15
Ambiguità (3): elementi di suppositio
16
L’eliminazione di ambiguità: le formule ben formate
variabili proposizionali e costanti
– una “lingua” formale
17
La nozione di verofunzionalità: il caso di “non”
– l’iterabilità delle verofunzioni
6
18
Bivalenza e due variabili: 16 combinazioni
– l’interdefinibilità delle verofunzioni (doppia negazione)
– riduzione a “e” e “non”
19
La varietà dei segni grafici e la loro poca importanza
– che cosa sono le parentesi?
20
Simboli per alcune verofunzioni (e non altre)
– le ambiguità di “o”
– le connotazioni di “e”
21
La definizione verofunzionale di “se”
– un dibattito antichissimo (Filone/Diodoro/Crisippo)
– gli apparenti “paradossi” e i loro corrispettivi nel linguaggio ordinario
22
Semantica (“controfattuale”) e sintassi (“congiuntivo”) nell’analisi dei periodi ipotetici
– una terminologia “neutra”
– sottodescrizione di certe lingue: gli errori dei vari Lewis
23
Quantificare su “individui” in un “universo di discorso”
– variabili come pronomi
– quantificazione universale (“tutti”) e particolare (“qualche”)
24
Le regole di inferenza basilari: introduzione e eliminazione
25
Termini singolari e nomi
26
Descrizioni definite particolari
– il ruolo dell’identità nella definizione di “il”
27
Espressioni numeriche con i quantificatori e identità
28
Riflessività, simmetria e transitività
29
Necessità e possibilità
– la sottodeterminazione di “deve” e “può”
– la nozione di “accessibilità”: tra biblioteche prima che tra “mondi”
Sinossi delle tappe percorse
30
II semestre: Giochi di parole (30 ore)
N°
Argomento trattato
Testo di riferimento
lezione
1
Materiali e modalità del corso
(I testi della sezione D
– una certa moda più o meno recente per elencare “le della bibliografia)
fallacie” da 13 a 300
Platone, Eutidemo
2
Una conclusione nichilista e la sua autoconfutazione
– paradossi di autoriferimento (Russell e gli insiemi)
Nietzsche: “Su verità...”
Bolzano, Dottrina...
3
Una sfiducia logica e la sua autoconfutazione
– negazioni insensate (Cartesio e il “cogito”)
Aristotele, Metafisica, IV
4
Una proposta relativista e la sua autoconfutazione
Platone, Teeteto
7
5
“Il mio punto di vista” e “il punto di vista dell’universo”
– il significato di essere centrali, grandi e duraturi
– lo statuto dei “mitemi” nel testo nietzscheiano
Nietzsche: “Su verità...”
6
Mitema sulle essenze e la questione delle convenzioni
Nietzsche: “Su verità...”
7
Mitemi su lingua “naturale”, lingua “vera”, lingua “perfetta”, Nietzsche: “Su verità...”
lingua “convenzionale”, lingua “artificiale”, lingua
“formale”,
8
Mitema sulla superficie linguistica come guida alle essenze
– i termini generali, i nomi e i concetti
Nietzsche: “Su verità...”
9
Dio e la grammatica
Anselmo Proslogion e
Tommaso ST, I, 2
10
Solo ciò che è letterale è veramente vero
Nietzsche: “Su verità...”
11
Il compito negativo della logica: una teroria dei Mill, Sistema
ragionamenti cattivi
– perché i cattivi ragionamenti non hanno una “forma”
– un catalogo di confutazioni sofistiche, paralogismi,
paradossi, fallacie, idoli, Kunstgriffe, , trappole mentali,
kluges ...?
12
L’imprevedibilità dell’insorgere di errori, come i “falsi
amici” linguistici
13
C’è possibilità di “inchiodare” una fallacia?
– un ragionamento negativo
– un “folclore” delle forme deviate con etichette
14
Modelli collaborativi del dibattito
– la teoria pragma-dialettica di van Eemeren
15
Un modello feroce: il giudizio del maestro di scherma
16
Le distinzioni aristoteliche dei generi dibattimentali e i loro Aristotele, Confutazioni
scopi: il contesto dialettico e la logica formale
sofistiche, i, e Platone,
Eutidemo
– paralogismi verbali e non
– Causa apparentiæ e causa defectus
17
Varietà di homonymia ed i amphibolia
18
I giochi di parole più o meno intraducibili: “prosodia” e Aristotele, Confutazioni
forma dell’espressione
sofistiche, iv
19
Epomenon o affirmatio consequentis
– perché niente negatio antecedentis?
– la questione della “conversione”: il test di Wason
20
Gli esempi di epomenon forniti da Aristotele: ragionamenti Aristotele, Confutazioni
in buone condizioni?
sofistiche v
21
Un trattamento medievale della “fallacia”
Crisippo, Frammenti
Schopenhauer, Dialettica
Aristotele, Confutazioni
sofistiche iv, e
Schopenhauer, Dialettica
8
Aristotele, Confutazioni
sofistiche v
Pietro Ispano, Summule
22
Il “metodo scientifico” ipotetico-deduttivo come epomenon
conclamato
23
L’abduzione: l’unica operazione che introduce una nuova Peirce, “Deduzione,...”
idea
24
Le accuse di “circolarità” o di petitio principii
– Cartesio e Mill contro il sillogismo
25
Ignoratio elenchi: il paralogismo che è genere di cui è anche Aristotele, Confutazioni,
specie
v
26
Presunte fallacie di pertinenza/rilevanza
– appelli all’autorità (Einstein sul radersi)
27
Gli argumenta di Locke, che fallacie non sono
28
La tribù, la caverna, il mercato e il teatro: generi di trappola
mentale
29
Errare humanum est?
30
Sinossi delle tappe percorse
9
Locke Saggio, IV, xvii,
1-4
Locke, Saggio IV, xvii,
19-24
Platone di Atene (427-347 a.C.)
Eutidemo
lingua originale: greco
ed. standard (e paginazione): Stephanus (Henri Estienne), Ginevra, 1578
tr. it. basato su IntraText® Digital Library
suddivisioni in grassetto seguendo
M.L. Gatti in Platone: tutti gli scritti, Rusconi, Milano, 1999
indicazioni dell’alternarsi dei parlanti tra parentesi quadre R. Davies1
[Stephanus vol I. p. 271]
Dialogo preliminare tra Socrate e Critone sulla vita e la sapienza di Eutidemo e Dionosodoro
CRITONE: Chi era, Socrate, quello con cui discutevi ieri nel Liceo? Una grande folla vi stava
intorno, tanto che io, volendo ascoltarvi, pur essendomi avvicinato, non riuscii a sentire nulla di
chiaro; tuttavia, protendendo la testa, riuscii a vedere e mi parve che fosse uno straniero quello con
cui discutevi. Chi era?
SOCRATE: Di quale dei due chiedi, o Critone? Non c'era infatti una sola persona, ma ce n'erano
due.
CRITONE: Quello di cui parlo io sedeva alla tua destra, il terzo a partire da te; in mezzo a voi c'era
il ragazzo figlio di Assioco. E mi sembrò, Socrate, che fosse cresciuto moltissimo e che non avesse
molta differenza di età dal nostro Critobulo. Quello però è mingherlino, questo, invece, è prestante
ed eccellente d'aspetto.
SOCRATE: Quello di cui chiedi, o Critone, è Eutidemo, mentre quello seduto vicino a me a
sinistra è suo fratello Dionisodoro: anch'egli prende parte alle discussioni.
CRITONE: Non conosco nessuno dei due, Socrate. Come sembra sono nuovi sofisti. Di che paese
sono? E qual è la loro sapienza?
SOCRATE: Costoro, come credo, sono originari di Chio o lì vicino, ma emigrarono a Turi. Esiliati
di là vivono in questi luoghi già da molti anni. Quanto a ciò su cui mi interroghi, la loro sapienza, è
meravigliosa, o Critone: sono veramente sapientissimi. Prima io non sapevo che cosa fossero i
pancraziasti perché costoro sono perfettamente pronti ad ogni genere di combattimento, ma non
com'erano i due fratelli pancraziasti Acarnani. Quei due infatti erano capaci di combattere solo col
corpo, questi, invece, sono in primo luogo fortissimi fisicamente - essi sono molto abili a
combattere in armi [p. 272] e sono in grado di rendere tale un altro che paghi loro un onorario -; in
secondo luogo sono eccellenti nel combattere la battaglia nelle aule di giustizia e nell'insegnare ad
altri a pronunciare e a scrivere discorsi adatti ai tribunali.Prima, dunque, erano abili solo in questo,
ora invece hanno raggiunto la perfezione nell'arte del pancraziaste. Infatti ora hanno praticato un
genere di battaglia rimasto intentato da essi, sicché nessuno potrebbe assolutamente essere in grado
di opporsi loro: talmente abili sono diventati nel combattere nelle discussioni e nel confutare ciò che
di volta in volta viene detto, sia che sia falso sia che sia vero. Pertanto, Critone, ho in mente di
affidarmi a questi due uomini, perché dicono anche di poter rendere abile in questo stesso campo
chiunque altro in poco tempo.
CRITONE: Ma, Socrate, non temi l'età, di essere cioè ormai troppo vecchio?
SOCRATE: Niente affatto, o Critone: ho una prova sufficiente e un incoraggiamento per non
temere, perché questi stessi uomini, per così dire, iniziarono da vecchi a dedicarsi a questa sapienza
che io desidero, l'eristica; )l'anno scorso o due anni fa non erano ancora sapienti. Ma io temo una
1
A causa dei lunghi dialoghi indiretti con poca ‘segnalatica’ si sono aggiunte sigle per quella che, in un determinato
passo, sia la voce saliente: [S] per Socrate (anche come narratore), [E] per Eutidemo, [D] per Dionisodoro, [Cl] per
Clinia, e [Ct] per Ctesippo.
10
sola cosa, di coprire di discredito i due stranieri, come Conno, figlio di Metrobio, il citarista, che mi
insegna ancora oggi a suonare la cetra: quando mi vedono i ragazzi miei condiscepoli mi
scherniscono e chiamano Conno maestro di un vecchio. Temo quindi che qualcuno muova ai due
stranieri questo stesso rimprovero; e essi, temendo ciò, potrebbero non volermi accettare. Io, però, o
Critone, ho persuaso altri vecchi a frequentare la loro scuola come miei condiscepoli e ora cercherò
di persuadere altri. E tu perché non la frequenti con me? Come esca per loro porteremo i tuoi figli:
mirando ad essi so che istruiranno anche noi.
CRITONE: Nulla lo impedisce, Socrate, se così ti pare. Ma prima spiegami quale sia la sapienza
dei due uomini, affinché io sappia anche che cosa impareremo.
Ingresso di Eutidemo e Dionisodoro in Liceo
SOCRATE: Lo sentirai subito, poiché non potrei dire di non avere prestato loro attenzione, anzi ne
ho prestata molta e ricordo bene e cercherò di esporti tutto dall'inizio. Per divina disposizione stavo
seduto là dove tu mi vedesti, da solo, nello spogliatoio e avevo già in mente di alzarmi per
andarmene; ma, levatomi, si manifestò il solito segno, quello del demone. Allora mi sedetti di
nuovo e poco dopo entrarono questi due [p. 273] - Eutidemo e Dionisodoro - e insieme a loro altri
allievi, molti, mi parve. Entrati, si misero a passeggiare nel viale coperto. E questi due non avevano
ancora fatto due o tre giri, quand'ecco entrò Clinia che tu, dicendo la verità, affermi essere molto
cresciuto. Dietro di lui moltissimi suoi ammiratori e tra gli altri Ctesippo, un giovinetto del demo di
Peania, molto bello e buono per natura, per quanto arrogante a causa della giovinezza. Clinia,
dunque, quando mi vide dall'entrata seduto da solo, venendo subito verso di me, sì sedette alla mia
destra, come anche tu dici. Non appena Dionisodoro ed Eutidemo lo videro, dapprima, fermatisi, si
misero a discutere tra di loro, volgendo di tanto in tanto lo sguardo verso di noi - e io stavo molto
attento ad essi -, poi venuti da noi l'uno, Eutidemo, si sedette accanto al ragazzo, l'altro vicino a me
a sinistra, gli altri, invece, ciascuno come capitava. Li salutai, dunque, perché li vedevo dopo molto
tempo.
Dopo di ciò dissi a Clinia: ‘Clinia, certo questi due uomini, Eutidemo e Dionisodoro, sono sapienti
in questioni non di poca, ma di molta importanza. Infatti conoscono tutto ciò che riguarda la guerra,
quanto è necessario a chi vuole diventare un buon stratega, la disposizione delle schiere, il comando
degli eserciti e il combattimento in armi; ma sono in grado anche di rendere un altro capace di
difendersi nei tribunali, se qualcuno gli fa ingiustizia’.
Eutidemo e Dionisidoro si proclamano maestri di virtù
[S] Dopo avere pronunciato queste parole fui disprezzato da quei due: entrambi risero, guardandosi
tra loro, ed Eutidemo disse: ‘Non ci occupiamo più di questi argomenti, Socrate, ma li trattiamo
come questioni secondarie’. Ed io, meravigliato, dissi: ‘Il vostro lavoro, credo, dovrebbe essere
bello, se per voi faccende così importanti sono accessorie e, per gli dèi, ditemi qual è questa bella
occupazione’. ‘Noi, Socrate, crediamo di essere in grado di trasmettere la virtù meglio e più
rapidamente di tutti’, rispose.
‘O Zeus, che dite!’, esclamai. ‘Dove faceste questa felice scoperta? Pensavo, come dicevo poc'anzi,
che foste abili per lo più nel combattimento in armi e questo dicevo di voi due. Quando veniste qui
la volta precedente, ricordo infatti che facevate professione di questo. Ma se ora possedete davvero
questa scienza siatemi propizi: mi rivolgo a voi proprio come a dèi, pregandovi di perdonarmi per le
parole dette in precedenza. [p. 274] Ma badate, Eutidemo e Dionisodoro, se dite la verità: per la
grandezza della vostra professione non c'è affatto da stupirsi se non vi si crede’.
[E&D]‘Ma sappi bene, Socrate, che è proprio così’.
[S] ‘Allora io vi considero, per il vostro possesso, molto più felici del Gran Re per il suo potere. Ma
ditemi se avete in mente di mostrare questa sapienza o come avete deciso’.
[E&D] ‘Siamo qui proprio per questo, Socrate, per mostrarla e per insegnarla, se qualcuno vuole
impararla’.
[S] ‘Ma vi garantisco che tutti quelli che non la possiedono vorranno impararla, io per primo, poi
11
Clinia qui presente e oltre a noi Ctesippo e questi altri’, dissi, indicandoglì gli ammiratori di Clinia
che già stavano in cerchio intorno a noi. Ctesippo, infatti, si trovava seduto lontano da Clinia - mi
parve che Eutidemo, discutendo con me, si piegasse in avanti e impedisse a Ctesippo la vista di
Clinia che si trovava in mezzo a noi - e Ctesippo, desideroso di vedere il suo amato e nello stesso
tempo di sentire, balzato in piedi, per primo si mise di fronte a noi. Così anche gli altri, vedendolo,
si misero attorno a noi, sia gli innamorati dì Clinia, sia i compagni di Eutidemo e di Dionisodoro.
Indicando appunto questi, dicevo a Eutidemo che tutti erano pronti a imparare.
Invito a persuadere Clinia all’esercizio della filosofia
[S] Allora Ctesippo fu prontamente d'accordo e così gli altri e tutti insieme pregarono quei due di
mostrare il potere della loro sapienza. Pertanto dissi: ‘Eutidemo e Dionisodoro, assecondate in ogni
modo costoro e per amor mio mostratelo. è chiaro che non è un'impresa da poco mostrarne la
maggior parte, ma ditemi questo: se potete rendere buono solo un uomo che è già persuaso che
bisogna imparare da voi, o anche uno che non è ancora persuaso perché non crede affatto che la
virtù si possa imparare o che voi ne siate i maestri. Ma è compito della stessa arte o di un'altra
persuadere chi la pensa così che la virtù si possa insegnare e che voi siate coloro dai quali la si
potrebbe imparare nel modo migliore?’
‘Di questa stessa arte, Socrate’, rispose Dionisodoro.
‘Voi, dunque’, dissi io, ‘o Dionisodoro [p. 275], meglio di ogni altro contemporaneo potreste
esortare alla filosofia e alla cura della virtù?’
[D] ‘Lo crediamo proprio, Socrate’.
[S] ‘Bene, rinviate ad altra occasione la dimostrazione del resto’, dissi, ‘ma mostrateci questo:
persuadete questo ragazzo che bisogna filosofare e praticare la virtù e farete cosa gradita a me e a
tutti costoro. La sua situazione è all'incirca questa: io e tutti costoro desideriamo che diventi il
migliore possibile. è figlio di Assioco, figlio di Alcibiade il Vecchio, cugino per parte di padre
dell'Alcibiade oggi vivente: il suo nome è Clinia. È giovane, e temiamo quindi per lui, com'è
naturale per un giovane, che qualcuno ci prevenga, volgendo il suo pensiero a un'altra occupazione
e lo corrompa. Voi due, dunque, siete giunti a proposito. Se non vi spiace, mettete alla prova il
ragazzo e discutete davanti a noi’.
Dopo che ebbi detto press'a poco queste parole, Eutidemo con coraggio e audacia insieme disse:
[E] ‘Ma non ci spiace affatto, Socrate, purché il giovinetto voglia rispondere’.
[S] ‘Ma certo’, risposi, ‘è anche abituato a questo: spesso, infatti, costoro, avvicinandosi a lui, gli
fanno molte domande e discutono con lui, cosicché probabilmente non teme di rispondere’.
[S] Come potrei poi esporti bene quanto avvenne in seguito, o Critone? Non è impresa di poco
conto incaricarsi di ciò, esponendo una sapienza indicibile; sicché io, come i poeti, nell'iniziare la
narrazione, ho bisogno di invocare le Muse e Mnemosine. Eutidemo, dunque, credo, iniziò
pressappoco così:
[E] ‘Clinia, quali sono tra gli uomini quelli che imparano, i sapienti o gli ignoranti?’.
[S] E il ragazzo, poiché la domanda era difficile, arrossì e, imbarazzato, guardò verso di me. E io,
accortomi che era turbato, ‘Coraggio, Clinia’, dissi, ‘rispondi senza paura in quale dei due modi ti
sembra. Forse ciò ti reca un grandissimo vantaggio’.
Intanto Dionisodoro, piegatosi un po' verso il mio orecchio, con l'aspetto molto sorridente disse: ‘Ti
preannuncio, Socrate, che, in qualunque dei due modi il ragazzo risponda, sarà confutato’.
[S] E, mentre egli mi diceva queste parole, Clinia rispose, cosicché non mi fu neppure possibile
avvertire il giovinetto di stare attento [p. 276]: egli rispose che erano i sapienti quelli che
imparavano. Ed Eutidemo chiese: ‘Chiami alcuni maestri o no?’. Ammise di sì .
[E] ‘I maestri sono dunque maestri di coloro che imparano, come il maestro di cetra e il maestro di
scuola erano senza dubbio maestri tuoi e degli altri ragazzi, e voi, invece, eravate allievi?’.
[Cl] Assentì .
[E] ‘Non è dunque vero che quando apprendevate non sapevate ancora ciò che imparavate?’. Disse
di no.
12
[E] ‘Eravate forse sapienti quando non sapevate queste cose?’
[Cl] ‘Certamente no’, rispose egli.
[E] ‘Dunque se non eravate sapienti, eravate ignoranti?’
[Cl] ‘Senza dubbio’.
[E] ‘Voi allora, imparando ciò che non sapevate, imparavate essendo ignoranti’.
Il ragazzo annuì .
[E] ‘Perciò imparano gli ignoranti, o Clinia, e non i sapienti, come tu credi’.
[S] Dopo che egli ebbe detto queste parole, come un coro al segnale del maestro, quelli del seguito
di Dionisodoro ed Eutidemo si misero nello stesso tempo ad applaudire e a ridere. E prima che il
giovinetto si riavesse per bene e a dovere, Dionisodoro, subentrando, disse:
[D] ‘Ma, o Clinia, quando il maestro di grammatica vi dettava, quali bambini imparavano le lezioni
dettate, i sapienti o gli ignoranti?’
‘I sapienti’, rispose Clinia.
[D] ‘Perciò imparano i sapienti e non gli ignoranti e tu, poco fa, non hai risposto bene ad
Eutidemo’.
[S] Allora gli ammiratori dei due risero fragorosamente e applaudirono, ammirando la loro
sapienza; noi altri, sbalorditi, tacevamo. Eutidemo, accortosi che eravamo attoniti, perché ci
meravigliassimo ancora di più di lui, non lasciò in pace il ragazzo, ma continuò a interrogarlo e,
come i bravi maestri di danza, volteggiò due volte con le domande sullo stesso punto e chiese:
[E] ‘Coloro che imparano imparano ciò che sanno o ciò che non sanno?’.
[S] E Dionisodoro, bisbigliando di nuovo un po' con me, disse:
[D] ‘Anche questa domanda, Socrate, è tale quale la precedente’.
[S] ‘O Zeus’, esclamai, ‘veramente anche la prima domanda ci sembrò bella’.
[D] ‘Socrate, noi facciamo tutte domande insolubili simili a queste’.
[S] ‘Appunto per questo mi sembra che voi abbiate buona fama presso i vostri allievi’. Intanto
Clinia aveva risposto a Eutidemo che coloro che imparavano imparavano ciò che non sapevano. [p.
277] E quello lo interrogò con gli stessi procedimenti di cui si era servito prima:
[E] ‘Ma non conosci le lettere?’, chiese.
[Cl] ‘Sì’, rispose.
[E] ‘Tutte?’.
[Cl] Ammise di sì .
[E] ‘Allora, quando uno detta una cosa qualsiasi, non detta delle lettere?’.
[Cl] Riconobbe di sì .
[E] ‘Perciò’, disse, ‘detta cose delle quali sai qualcosa, se le conosci tutte?’.
[Cl] Ammise anche questo.
[E] ‘Ma allora’, continuò, ‘non impari ciò che uno detta, mentre impara chi non conosce le lettere?’
[Cl] ‘No’, rispose, ‘imparo io’.
[E] ‘Allora’, disse, ‘impari ciò che sai se conosci tutte le lettere’.
[Cl] Ne convenne.
[E] ‘Non hai, dunque, risposto correttamente’, concluse.
[S] Eutidemo non aveva ancora finito di pronunciare queste parole che Dionisodoro, prendendo la
parola come una palla, prese di nuovo di mira il ragazzo e disse:
[D] ‘Clinia, Eutidemo ti inganna. Dimmi, infatti, imparare non è acquistare scienza di ciò che uno
impara?’.
Clinia ammise di sì.
[D ‘E Sapere’, proseguì , ‘è forse altro che avere già scienza?’.
[Cl] Assentì .
[D] ‘Dunque non sapere è non avere ancora scienza?’.
[Cl] Fu d'accordo con lui.
[D] ‘Allora coloro che acquistano una cosa qualsiasi sono quelli che la possiedono già oppure quelli
che non la possiedono?’
13
[Cl] ‘Quelli che non la possiedono’.
[D] ‘Orbene, hai ammesso che tra questi, ossia tra coloro che non hanno, ci sono anche coloro che
non sanno’.
[Cl] Annuì .
[D] ‘Perciò quelli che imparano sono tra quelli che acquistano e non tra quelli che possiedono?’.
[Cl] Assentì.
[D] ‘Allora, Clinia’, concluse, ‘imparano quelli che non sanno e non quelli che sanno’.
Pagine 277d-283d ommesse
Aporie sul mentire, l’ingannare e il contraddire
[S] E Ctesippo, udendo ciò, si adirò per il suo amato e esclamò:
[Ct] ‘O straniero di Turi, se non fosse troppo villano dirlo, direi: ‘che possa ricadere sulla tua testa’,
perché ti è venuto in mente di fare calunniosamente contro di me e contro gli altri tale affermazione,
che io credo sia un'empietà fare, e cioè che io vorrei che costui fosse morto’.
[E] ‘Ma, Ctesippo’, disse Eutidemo, ‘ti sembra forse che sia possibile mentire?’
[Ct] ‘Sì , per Zeus’, rispose, ‘se non sono pazzo, almeno’.
[S ‘Dicendo la cosa di cui si parla, [p. 284] o non dicendola?’
[Ct] ‘Dicendola’, rispose.
[E] ‘Perciò se la si dice, tra le cose che sono non si dice altro che quella che si dice?’
[Ct] ‘E come si potrebbe?’, chiese Ctesippo.
[E] ‘E quella che si dice è una delle cose che sono separate dalle altre’.
[Ct] ‘Certamente’.
[E] ‘Dunque, colui che dice quella dice ciò che è?’, domandò.
[Ct] ‘Sì’.
[E] ‘Ma chi dice ciò che è e le cose che sono dice la verità, cosicché, se Dionisodoro dice le cose
che sono, dice la verità e non mente affatto contro dite’.
[Ct]‘Sì’, rispose Ctesippo, ‘ma chi dice queste cose, o Eutidemo non dice cose che sono’.
[E] Ed Eutidemo disse: ‘Non è vero che le cose che non sono non sono?’
[Ct] ‘Non sono’.
[E] ‘Non è dunque vero che le cose che non sono non sono in nessun modo cose che sono?’
[Ct] ‘In nessun modo’.
[E] ‘È possibile, dunque, che, riguardo a queste cose che non sono, si possa fare qualcosa, in modo
che anche una persona qualunque possa fare quelle cose che non sono per nulla?’
[Ct] ‘Non mi sembra’, rispose Ctesippo.
[E] ‘Ma i retori, quando parlano al popolo, non operano nulla?’
[Ct] ‘Operano, certo’, rispose.
[E] ‘Dunque, se operano, fanno anche?’
[Ct] ‘Sì’.
[E] ‘Il parlare, allora, è operare e fare?’.
[Ct] Ne convenne.
[E] ‘Nessuno, quindi’, concluse, ‘dice le cose che non sono, perché farebbe già qualcosa, ma tu hai
riconosciuto non è possibile che qualcuno faccia ciò che non è, cosicché, che secondo il tuo
ragionamento, nessuno dice falsità, ma se Dionisodoro parla, dice la verità e le cose che sono’.
[Ct] ‘Sì, per Zeus, o Eutidemo’, rispose Ctesippo: ‘dice in qualche modo le cose che sono, ma non
come stanno’.
[D] ‘Come dici, Ctesippo?’, chiese Dionisodoro. ‘Vi sono alcuni che dicono le cose come stanno?’
[Ct] ‘Ci sono certo’, rispose, ‘gli uomini eccellenti sotto ogni rispetto e che dicono la verità’.
[D] ‘Ma’, chiese, ‘le cose buone non stanno bene e quelle cattive male?’.
[Ct] Ne convenne.
[D] ‘E ammetti che gli uomini eccellenti sotto ogni rispetto dicono le cose come stanno?’
14
[Ct] ‘Lo ammetto’.
[D] ‘Allora, Ctesippo’, disse, ‘gli uomini buoni dicono male delle cose cattive se le dicono come
stanno’.
[Ct] ‘Sì, per Zeus’, rispose, ‘è proprio così, almeno degli uomini cattivi; e se mi dai retta ti
guarderai dall'essere di questi, affinché i buoni non dicano male di te; perché sappi bene che i buoni
parlano male dei cattivi’.
[E] ‘E parlano grandemente dei grandi’, continuò Eutidemo, ‘e caldamente dei caldi?’
[Ct] ‘Esatto’, rispose Ctesippo: ‘parlano freddamente dei freddi e dicono che discutano così’. [D]
‘Tu insulti, Ctesippo’, esclamò Dionisodoro, ‘tu insulti’.
[Ct] ‘No, per Zeus, no, Dionisodoro’, replicò, ‘perché ti voglio bene: ti ammonisco, come un
amico, e cerco di persuaderti a non dire mai in modo così rozzo di fronte a me che voglio la morte
di quelli che stimo di più’.
[S] [p. 285] Allora, poiché mi sembrava che essi si trattassero con troppa asprezza reciproca, mi
burlai di Ctesippo e dissi:
[S] ‘Ctesippo, mi pare che dobbiamo accettare dagli stranieri ciò che affermano, se vogliono
farcene dono, e non dissentire con un pretesto. Se, infatti, sanno annientare gli uomini così da
renderli buoni e saggi da malvagi e stolti che erano, sia che abbiano scoperto da sé sia che abbiano
imparato da un altro una rovina e distruzione tale da rendere di nuovo buono chi è malvagio, dopo
averlo ucciso; se sanno ciò - ed è chiaro che lo sanno perché hanno affermato che la loro arte da
poco scoperta consiste nel rendere gli uomini buoni da malvagi - concediamo, dunque, loro questo:
ci facciano perire il ragazzo e lo rendano saggio e anche tutti noi altri. Ma se voi giovani avete
paura, il rischio ricada su di me, come su di un Cario; perché io, dal momento che sono vecchio,
sono pronto ad espormi al pericolo e mi affido a Dionisodoro, come a Medea di Colchide Mi faccia
perire e, se vuole, mi faccia cuocere, altrimenti faccia ciò che vuole, purché mi renda buono’.
[Ct] E Ctesippo: ‘Anch'io, Socrate’, disse, ‘sono pronto a offrirmi agli stranieri, anche se vogliono
scorticarmi ancor più di quanto mi scorticano ora, purché la mia pelle non finisca in un otre, come
quella di Marsia, ma nella virtù. Eppure Dionisodoro qui presente pensa che sia in collera con lui; e
invece non sono in collera, ma contraddico ciò che mi sembra egli dica in modo non conveniente
dinanzi a me. Ma tu’, aggiunse, ‘nobile Dionisodoro, non chiamare ‘insultare’ il contraddire:
l'insultare è altra cosa’.
[D] E Dionisodoro chiese: ‘O Ctesippo, parli del contraddire come se esistesse?’
[Ct] ‘Certamente’, rispose, ‘proprio così ; oppure tu, o Dionisodoro, non credi che esista il
contraddire?’
[D] ‘Sicuramente tu’, ribatté, ‘non potresti mai dimostrare di avere udito qualcuno contraddire un
altro’.
[Ct] ‘Dici la verità?’, replicò. ‘Ma ora ti dimostro di stare ascoltando Ctesippo che contraddice
Dionisodoro’.
[D] ‘Potresti, forse, anche rendere ragione [logos] di questo?’
[Ct] ‘Certamente’, rispose.
[D] ‘Ma’, domandò, ‘esistono delle parole [logoi] per ciascuna delle cose che sono?’
[Ct] ‘Sicuramente’.
[D] ‘In quanto ciascuna cosa è o in quanto non è?’ [p. 286]
[Ct] ‘In quanto è’.
[D] ‘Infatti se ricordi’, continuò, ‘Ctesippo, anche poco fa abbiamo dimostrato che nessuno parla di
una cosa in quanto non è; perché è risultato che nessuno dice ciò che non è’.
[Ct] ‘E con questo?’, chiese Ctesippo. ‘Ci contraddiciamo meno io e tu?’
[D] ‘Ci contraddiremmo forse’, ribatté egli, ‘se entrambi parlassimo della stessa cosa, o così
diremmo certamente le stesse cose?’.
[Ct] Lo ammise.
[D] ‘Ma, quando nessuno di noi due’, domandò, ‘parlasse di una cosa, allora ci contraddiremmo? O
così nessuno di noi due si ricorderebbe affatto di essa?’.
15
[Ct] Anche in questo fu d'accordo.
[D] ‘Ma quando io parlo di una cosa, mentre tu parli di un'altra, allora ci contraddiciamo? Oppure
io parlo di una cosa, mentre tu non ne parli affatto? Chi non parla come potrebbe contraddire chi
parla?’
Aporie di chi sostiene che il dire il falso non esiste
[S] Ctesippo tacque, mentre io, meravigliato del discorso, chiesi: ‘Come dici, Dionisodoro? Pur
avendo udito questo discorso da molti e spesso, me ne meraviglio sempre - e infatti i seguaci di
Protagora se ne servivano molto e anche quelli ancora più antichi; eppure a me sembra sempre che
sia meraviglioso e abbatta gli altri e anche se stesso -; e credo che verrò a sapere da te nel modo
migliore la verità di esso. Non è vero che dire il falso non esiste? Questo, infatti, significa il
ragionamento: che chi parla dice il vero o non parla?’.
[D] Ne convenne.
[S] ‘Forse, dunque, non è possibile dire il falso, ma è possibile avere false opinioni?’ [D] ‘Neppure
avere false opinioni’, affermò.
[S] ‘Allora’, dissi, ‘non esiste neppure la falsa opinione’.
[D] ‘No’, rispose.
[S] ‘Allora nemmeno l'ignoranza né gli uomini ignoranti; o l'ignoranza, se esistesse, non sarebbe
l'ingannarsi sulle cose?’
[D] ‘Certamente’, disse.
[S] ‘Ma questo non è possibile’, continuai.
[D] ‘No’, rispose.
[S] ‘Dionisodoro, parli tanto per parlare, per dire un'assurdità, oppure perché ti pare veramente che
nessun uomo sia ignorante?’
[D] ‘Allora tu confutami’, ribatté.
[S] ‘È forse possibile, secondo il tuo ragionamento, confutare se nessuno si inganna?’
[E] ‘Non è possibile’, rispose Eutidemo.
[S] ‘Allora’, chiesi, ‘poco fa Dionisodoro non mi esortava a confutarlo?’
[E] ‘Come potrebbe uno esortare a ciò che non è. Ma tu inviti?’
[S] ‘Eutidemo’, dissi, ‘non comprendo bene queste vostre sapienti trovate, anche quelle ben
impostate, ma le capisco solo approssimativamente. Ti farò, dunque, una domanda forse troppo
grossolana, ma perdonami. Vedi: se non è possibile né ingannarsi, né avere false opinioni, né essere
ignorante, non è forse neppure impossibile sbagliare, quando si fa qualcosa? Infatti non è possibile
che chi fa sbagli in ciò che fa: non dite così ?’
[E] ‘Certamente’, rispose.
[S]‘Ora, questa è la domanda grossolana’, ripresi. ‘Se non sbagliamo né agendo, né parlando, né
pensando, voi, per Zeus, se le cose stanno così , che cosa siete venuti a insegnarci? O non
affermavate poco fa di potere trasmettere meglio di ogni altro la virtù a chi vuole apprenderla?’.
Valutazione dei ragionamenti eristici
[D] Dionisodoro prese la parola e disse: ‘Socrate, sei così rimbambito che ti ricordi adesso ciò che
abbiamo detto prima e, se ho detto qualcosa l'anno scorso, sei in grado di ricordartene ora, ma con i
discorsi fatti in questo momento non sei in grado di cavartela?’
[S] ‘Sono molto difficili’, replicai, ‘a buon diritto, perché sono fatti da uomini sapienti perciò è
difficilissimo cavarsela anche con quest'ultimo discorso che fai. Infatti che cosa mai vuoi dire,
Dionisodoro, affermando che non so come cavarmela? O evidentemente vuoi dire che non so
confutarlo? Perciò spiegami che cos'altro significa per te l'espressione ‘non so come cavarmela con
i tuoi discorsi’’.
[D] ‘Ma ciò che tu dici’, ribatté, ‘perciò rispondi’.
[S] ‘Prima che tu risponda, o Dionisodoro?’, domandai io.
[D] ‘Non rispondi?’, incalzò.
16
[S ]‘È forse giusto?’
[D‘Certamente giusto’, rispose.
[S] ‘Per quale ragione’, chiesi, ‘o evidentemente perché tu ora sei venuto da noi sapientissimo nei
discorsi e sai quando bisogna rispondere e quando no? E adesso non rispondi nulla, perché sai che
non bisogna rispondere?’
[D] ‘Tu ciarli’, disse, ‘senza pensare a rispondere. Ma, mio caro, dammi retta e rispondi, poiché
ammetti che io sono sapiente’.
[S] ‘Bisogna, dunque, obbedire’, continuai, ‘ed è necessario, a quanto pare, perché lo comandi tu.
Ma interroga’.
[D] ‘Gli esseri pensanti hanno forse senso perché hanno un'anima o hanno senso anche quelli
inanimati?’
[S] ‘Quelli che hanno un'anima’.
[D] ‘Conosci’, chiese, ‘qualche espressione che abbia un'anima’?
[S] ‘Per Zeus, io no’.
[D] ‘Perché allora poco fa mi hai domandato che cosa significasse per me l'espressione?’
[S] ‘Per quale altro motivo’, risposi, ‘se non perché ho sbagliato per la mia stupidità? O non ho
sbagliato, ma ho parlato correttamente, affermando che le espressioni hanno senso? Dici che io
abbia sbagliato o no? Perché se non ho sbagliato, neppure tu mi potrai confutare, anche se sei
sapiente, e non sai come cavartela con il discorso; se invece ho sbagliato neppure così parli
correttamente [p. 288], sostenendo che non è possibile sbagliare. E dico questo non in riferimento a
ciò che affermavi l'anno scorso. Ma, sembra’, continuai, ‘Dionisodoro ed Eutidemo, che questo
ragionamento rimanga fermo allo stesso punto e che ancora, come in passato, dopo avere abbattuto
il resto, cada e il modo perché non gli accadesse questo non è ancora stato trovato neppure dalla
vostra arte, sebbene essa sia così meravigliosa nel rigore dei ragionamenti’.
[Ct] E Ctesippo esclamò: ‘Dite cose meravigliose, o uomini di Turi o di Chio o di dove e come vi
piaccia essere chiamati, perché non vi importa affatto di delirare’.
[S] E io, temendo ne derivasse un insulto, calmai di nuovo Ctesippo e affermai ‘Ctesippo, dico
anche a te le stesse parole che dicevo poco fa a Clinia: non sai che la sapienza degli stranieri è
meravigliosa. Tuttavia essi non vogliono mostrarcela seriamente ma imitano Proteo, il sofista
egiziano, incantandoci. Noi allora imitiamo Menelao e non lasciamo andare questi due uomini
finché non ci abbiano mostrato ciò di cui si occupano seriamente. Credo, infatti, che ci mostreranno
qualcosa di bellissimo, quando cominceranno a parlare sul serio. Ma preghiamoli, esortiamoli e
supplichiamoli di mostrarcelo. Ho dunque deciso di mostrare di nuovo io come supplicarli di
rivelarlo. Cercherò di esporre loro il seguito, come posso, partendo dal punto in cui prima avevo
interrotto il discorso, per vedere se in qualche modo riesco a stimolarli e se, provando pietà e
compassione per me che mi sforzo e parlo seriamente, anch'essi facciano sul serio’.
Pagine 288d-292e ommesse
Aporie su scienza, sapienza e ignoranza
SOCRATE: Come no? E incominciò il discorso, o compagno, con molto orgoglio, così.
[E] ‘O Socrate’, chiese, ‘ti devo insegnare questa scienza, sulla quale da molto tempo siete in
difficoltà, o devo dimostrarti che la possiedi?’
[S] ‘O beato’, domandai, ‘questo è possibile, secondo te?’
[E] ‘Certamente’, rispose.
[S] ‘Dimostrami allora, per Zeus’, ripresi, ‘che la posseggo; infatti è molto più facile che impararla
per un uomo della mia età’.
[E] ‘Orsù, rispondimi’, disse: ‘c'è qualcosa che sai?’
[S] ‘Certo’, affermai, ‘e molte cose, ma di poca importanza’.
[E] ‘Basta’, asserì. ‘Credi forse che sia possibile che qualcuna delle cose che sono non sia proprio
ciò che è?’
17
[S] ‘Ma no, per Zeus’.
[E] ‘Tu dunque’, chiese, ‘sai qualcosa?’
[S] ‘Sì’.
[E] ‘Perciò se sai, sei sapiente?’
[S] ‘Certo, almeno in questo punto’.
[E] ‘Non importa; ma non è necessario che tu, se sei sapiente, sappia tutto?’
[S] ‘No, per Zeus’, risposi, ‘perché non so molte altre cose’.
[E] ‘Allora se non sai qualcosa non sei sapiente’.
[S] ‘Almeno in quello, amico’, ribattei.
[E] ‘Sei dunque un po’ meno ignorante?’, domandò. ‘Ma poco fa hai detto di essere sapiente. E così
ti trovi ad essere e poi di nuovo a non essere quello che sei riguardo alle stesse cose e nello stesso
tempo’.
[S] ‘Bene, Eutidemo’, risposi: ‘come si dice, fai risuonare belle parole. Come so, dunque, quella
scienza che cercavamo? Poiché è impossibile che la stessa cosa sia e non sia, se so una cosa le so
tutte - infatti non potrei essere sapiente e ignorante nello stesso tempo - ma, poiché so tutto, ho
anche quella scienza. Dici forse così ed è questa la tua gran sapienza?’
[E] ‘Tu stesso ti confuti, Socrate’, disse.
[S] ‘Ma, Eutidemo, a te non è accaduta la stessa cosa?’, ribattei. ‘Io, qualsiasi cosa mi succedesse
insieme a te e a Dionisodoro, mio caro amico, non mi irriterei affatto. Dimmi, non è vero che voi
due sapete alcune delle cose che sono, ma non ne sapete altre?’
[D] ‘Niente affatto, Socrate’, rispose Dionisodoro.
[S] ‘Come dite?’, chiesi io. ‘Ma allora non sapete nulla?’
[D] ‘Certamente sappiamo’, rispose egli. [p. 294]
[S] ‘Allora sapete tutto’, dissi, ‘poiché sapete anche una cosa qualsiasi?’ ‘
[D] Tutto’, ribatté, ‘e anche tu se sai anche una sola cosa, le sai tutte’.
[S] ‘O Zeus’, esclamai, ‘che cosa meravigliosa affermi e che grande bene è che sia stata rivelata!
Forse anche tutti gli altri uomini sanno tutto oppure nulla?’
[D] ‘Certo è impossibile’, rispose, ‘che sappiano alcune cose e non ne sappiano altre e siano nel
tempo stesso sapienti ed ignoranti’.
[S] ‘Ma perché?’ chiesi io.
[D] ‘Tutti’, disse, ‘sanno tutto se sanno anche una sola cosa’.
[S] ‘O per gli dèi, Dionisodoro!’, esclamai. ‘Mi è chiaro ormai che parlate sul serio, ma a fatica vi
ho indotti ad essere seri. Voi due sapete realmente tutto? Per esempio l’arte del falegname e quella
del calzolaio?’
[D] ‘Certamente’, rispose.
[S] ‘Siete, forse, anche capaci di rattoppare scarpe?’
[D] ‘Sì, per Zeus, anche di risuolarle’, affermò.
[S] ‘E sapete forse anche cose di questo tipo: quante sono le stelle e quanti sono i granelli di
sabbia?’
[D] ‘Certo’, rispose.
[S] ‘Poi, credi che non lo avremmo ammesso?’
Ctesippo intervenne ed esclamò: ‘Per Zeus, Dionisodoro, datemi una prova di questo, dalla quale
saprò che dite la verità’.
[D] ‘Quale prova ti darò?’, chiese.
[Ct] ‘Sai quanti denti ha Eutidemo e Eutidemo quanti ne hai tu?’
[D] ‘Non ti basta avere sentito che sappiamo tutto?’, domandò.
[Ct] ‘Assolutamente no’, rispose, ‘ma diteci ancora solo questo e dimostrateci che dite la verità. E
se dite quanti denti ha ciascuno di voi, e se risulta che lo sapete, dopo che noi li abbiamo contati, vi
crederemo subito anche nel resto’.
[S] Ritenendo di essere scherniti, non vollero rispondere, ma interrogati da Ctesippo su ogni singola
cosa, ammisero dì saperle tutte. Infatti non vi fu nulla su cui, infine, Ctesippo molto apertamente
18
non domandasse se lo sapessero, anche le cose più vergognose. Ed essi molto coraggiosamente
affrontavano le domande, ammettendo di sapere, come i cinghiali che si slanciano contro il colpo,
cosicché anch’io, o Critone, alla fine fui costretto dalla mia incredulità a chiedere se Dionisodoro
sapesse anche danzare. Ed egli:
[D] ‘Certamente’, rispose.
[S] ‘Senza dubbio’, dissi, ‘alla tua età non saprai anche fare il salto mortale sulle spade e girare
sulla ruota: non sei così progredito nella sapienza’.
[D] ‘Non c’è nulla che non sappia’, ribatté.
[S] ‘Forse’, chiesi, ‘sapete tutto solo ora o da sempre?’
[D] ‘Da sempre’, replicò.
[S] ‘Anche quando eravate bambini e appena nati sapevate tutto?’. Entrambi insieme assentirono.
[p. 295] E a noi la cosa sembrava incredibile. Ma Eutidemo domandò:
[E] ‘Non credi, Socrate?’
[S] ‘No, salvo che è probabile che siate sapienti’, risposi.
[E] ‘Ma’, disse, ‘se vuoi rispondermi, io ti dimostrerò che anche tu ammetti queste cose
meravigliose’.
[S] ‘Ma certo’, replicai. ‘Mi fa molto piacere essere confutato su questo. Se, infatti, mi è davvero
sfuggito dì essere sapiente, ma tu mi dimostrerai che so tutto e da sempre, quale scoperta più felice
di questa potrei fare in tutta la mia vita?’
[E] ‘Rispondi, dunque’, disse.
[S] ‘Domanda, convinto che io ti risponda’.
[E] ‘Dunque, Socrate, sei forse sapiente in qualcosa o no?’
[S] ‘Sì’.
[E] ‘E sai con ciò per cui sei sapiente o con qualcos’altro?’
[S] ‘Con ciò per cui sono sapiente. Credo, infatti, che tu parli dell’anima, o non parli di questo?’
[E] ‘Non ti vergogni, Socrate’, disse: ‘tu che sei interrogato, interroghi a tua volta?’
[S] ‘Bene’, replicai, ‘ma come faccio? Farò come tu ordini. Quando non so che cosa chiedi, tu mi
ordini tuttavia di rispondere, senza interrogare di nuovo?’
[E] ‘Infatti intendi in qualche modo ciò che dico?’, domandò.
[S] ‘Sì ‘, affermai.
[E] ‘Rispondi dunque a ciò che intendi’.
[S] ‘Ma’, ribattei, ‘se tu domandi intendendo in un modo, ma io comprendo in un altro e poi
rispondo a questo, ti basta se non rispondo nulla a proposito?’
[E] ‘A me sì, ma non a te, come credo’, disse egli.
[S] ‘No, per Zeus, non risponderò prima di avere capito’, replicai.
[E] ‘Non risponderai’, ribatté, ‘a ciò che man mano comprendi, perché continui a dire sciocchezze e
sei più antiquato del dovuto’.
[S] E io compresi che era in collera con me che distinguevo ciò che diceva, perché voleva darmi la
caccia, circondandomi con le parole. Mi ricordai allora di Conno, che si adira anch’egli con me,
ogni volta che non gli cedo e poi si prende meno cura di me, come se fossi ignorante. Ma poiché
avevo deciso di frequentare anche costui, credetti di dovere cedere, per evitare che, ritenendomi uno
scolaro inetto, non mi accettasse.Dissi dunque:
[S] ‘Ma se ti sembra bene fare così, Eutidemo, bisogna farlo, perché tu certamente sai discutere
meglio di me, che ho la tecnica di un incompetente. Domanda, dunque, di nuovo da principio’.
[E] ‘Rispondi nuovamente, allora’, riprese: ‘sai forse con qualcosa ciò che sai o no?’
[S] ‘Sì’, affermai, ‘con l’anima’. [p. 296]
[E] ‘Costui’, esclamò, ‘risponde di nuovo oltre il richiesto alle domande: non chiedo con che cosa
sai, ma se sai con qualcosa’.
[S] ‘Ho risposto più del dovuto’, dissi, ‘per ignoranza. Perdonami: ora ti risponderò semplicemente
che so con qualcosa ciò che so’.
[E] ‘Sempre con la stessa cosa’, chiese, ‘o talvolta con questa, talvolta con un’altra?’
19
[S] ‘Quando so, so sempre con questa’, dissi.
[E] ‘Non smetterai di fare di nuovo aggiunte?’, esclamo.
[S] ‘Ma badiamo che in qualche modo questo “sempre” non ci tragga in inganno’.
[E] ‘Certo non noi’, disse, ‘ma, se mai, te. Ma rispondi: sai sempre con questa cosa?’.
[S] ‘Sempre’, ribattei, ‘dal momento che bisogna togliere il “quando”’.
[E] ‘Dunque sai sempre con questa cosa. Ma, poiché sai sempre, sai forse alcune cose con questa
con cui sai e altre con un’altra o sai tutte con questa?’
[S] ‘So tutto con questa, almeno ciò che so’, risposi.
[E] ‘Ecco qui’, esclamò, ‘arriva la stessa aggiunta’.
[S] ‘Tolgo “almeno ciò che so”’, dissi io.
[E] ‘Non togliere neppure una parola’, replicò: ‘non ho affatto bisogno di te. Rispondimi: potresti
sapere tutte le cose se non sapessi tutto?’
[S] ‘Sarebbe un prodigio’, risposi.
[E] Ed egli disse: ‘Aggiungi ora ciò che vuoi; infatti ammetti di sapere tutto’.
[S] ‘Credo’, ribattei, ‘dal momento che le parole ‘ciò che so’ non hanno alcuna importanza, so
tutto’.
[E] ‘Dunque hai anche ammesso di sapere sempre con quella cosa con cui sai, sia quando sai, sia
come vuoi: infatti hai ammesso di sapere sempre e tutto nello stesso tempo. Perciò è chiaro che
anche quando eri bambino sapevi, quando nascesti, quando fosti generato, prima di nascere, prima
che fossero generati il cielo e la terra, sapevi tutto, se sai da sempre. Sì, per Zeus’, disse, ‘anche tu
saprai sempre e tutto, se io voglio’.
[S] ‘Ma lo volessi’, esclamai, ‘o molto stimato Eutidemo, se dici realmente la verità! Però non
credo affatto che tu sia capace, se non lo vuole insieme a te tuo fratello Dionisodoro qui presente.
Così forse saresti capace’. Continuai: ‘Ditemi - sul resto non so come obiettare a voi, uomini così
prodigiosi per sapienza, che io non so tutto, dal momento che voi lo affermate -: come posso dire di
sapere che gli uomini buoni, sono ingiusti, Eutidemo?
Orsù, dimmi, so questo o non lo so?’
[E] ‘Certamente lo sai’, rispose.
[S] ‘Che cosa?’, chiesi io.
[E] ‘Che i buoni non sono ingiusti’. [p. 297]
[S] ‘Certamente’, replicai, ‘da molto tempo. Ma non domando questo; bensì dove ho appreso che i
buoni sono ingiusti’.
[D] ‘In nessun luogo’, ribatté Dionisodoro.
[S] ‘Allora non so questo’, conclusi io.
[E] ‘Rovini il ragionamento’, disse Eutidemo a Dionisodoro, ‘e sembrerà che costui non sappia e
che sia sapiente e ignorante nello stesso tempo’. E Dionisodoro arrossì.
Aporie sui legami di parentela
[S] ‘Ma tu’, continuai, ‘come dici, Eutidemo? Non ti sembra che tuo fratello che sa tutto parli
correttamente?’
[D] ‘Sono fratello di Eutidemo?’, chiese Dionisodoro, prendendo subito la parola.
[S] E io risposi: ‘Lascia andare, caro mio, finché Eutidemo non mi abbia insegnato che so che gli
uomini buoni sono ingiusti e non rifiutarmi tale insegnamento’.
[D] ‘Tu sfuggi, Socrate’, disse Dionisodoro, ‘e non vuoi rispondere’.
[S] ‘Naturalmente’, ribattei. ‘Infatti sono inferiore anche a uno solo di voi, cosicché sono molto
lungi dal non sfuggire tutti e due. Sono molto più debole di Eracle, il quale non era in grado di
combattere contro l’idra che era una sofista e che, se qualcuno le tagliava un capo del
ragionamento, per la sua sapienza ne faceva rispuntare molti al posto di uno, e contro un granchio,
un altro sofista, giunto dal mare, approdato da poco, mi sembra. Egli, poiché il granchio da allora lo
tormentava così a sinistra, con parole e morsi, chiamò in aiuto il nipote Iolao che lo aiutò
adeguatamente. Ma il mio Iolao, se venisse, peggiorerebbe la situazione’. [D ‘Rispondi, dunque’,
20
riprese Dionisodoro, ‘poiché hai cantato questo inno. Forse Iolao era nipote di Eracle più che tuo?’
[S] ‘È meglio per me, o Dionisodoro, risponderti’, dissi io. ‘Infatti certamente non smetterai di
interrogarmi, sono quasi sicuro di questo, perché sei invidioso e per impedire che Eutidemo mi
insegni quella grande sapienza’.
[D] ‘Rispondi, dunque’, replicò.
[S] ‘Allora rispondo’, dissi, ‘che Iolao era nipote di Eracle, ma, come mi sembra, niente affatto mio.
Infatti suo padre non era Patrocle, mio fratello, ma uno dal nome simile, Ificle, fratello di Eracle’.
[D] ‘Ma Patrocle’, chiese, ‘è tuo fratello?’
[S] ‘Certo’, affermai, ‘nato dalla stessa madre almeno, ma non dallo stesso padre’.
[D] ‘Allora è e non è tuo fratello’.
[S] ‘Non nato dallo stesso padre, almeno, mio caro’, risposi, ‘perché suo padre era Cheredemo, il
mio, invece, Sofronisco’.
[D] ‘Ma padre era tanto Sofronisco quanto Cheredemo?’, domandò.
[S] ‘Certo’, ribattei, [p. 298] ‘l’uno mio, l’altro suo’.
[D] ‘Dunque’, disse, ‘Cheredemo era diverso dal padre’.
[S] ‘Dal mio, almeno’, replicai. ‘Era, dunque, padre, pur essendo diverso dal padre? O tu sei lo
stesso di questa pietra?’
[S] ‘Temo’, risposi, ‘di sembrare lo stesso per causa tua; tuttavia a me non sembra’.
[D] ‘Allora sei diverso da questa pietra?’, chiese.
[S] ‘Diverso, certamente’.
[D] ‘Non è, dunque, vero che essendo diverso dalla pietra non sei pietra? Ed essendo diverso
dall’oro non sei oro?’
[S] ‘È così ‘.
[D] ‘Anche Cheredemo, allora’, disse, ‘essendo diverso dal padre non è padre’.
[S] ‘Sembra’, risposi, ‘che non sia padre’.
[E] ‘Se, infatti, Cheredemo è padre’, disse Eutidemo prendendo la parola, ‘a sua volta Sofronisco,
essendo diverso dal padre, non è padre, cosicché tu, Socrate, sei senza padre’.
[Ct] E Ctesippo prendendo la parola chiese: ‘E a vostro padre non è accaduta questa stessa cosa? è
diverso da mio padre?’
[E] ‘Niente affatto’, rìbatté Eutidemo.
[Ct] ‘Ma’, domandò, ‘è lo stesso?’
[E] ‘Lo stesso, certamente’.
[Ct] ‘Non potrei acconsentire. Ma forse, Eutidemo, è solo padre mio o anche degli altri uomini?’
[E] ‘Anche degli altri’, rispose. ‘O credi che lo stesso uomo, essendo padre, non sia padre?’ [Ct]
‘Lo credevo, certamente’, replicò Ctesippo.
[E] ‘Ma credevi’, chiese, ‘che una cosa, essendo oro, non fosse oro o essendo uomo, non fosse
uomo?’
[Ct] ‘Bada che non si realizzi, Eutidemo, il proverbio “non cuci lino con lino”’, esclamò Ctesippo,
‘perché dici una cosa singolare, se tuo padre è padre di tutti’.
[E] ‘Ma è così ‘, affermò.
[Ct] ‘Degli uomini’, domandò Ctesippo, ‘o anche dei cavalli e di tutti gli altri animali?’
[E] ‘Di tutti’, rispose.
[Ct] ‘E anche la madre è madre di tutti?’
[E] ‘Anche la madre’.
[Ct] ‘Tua madre, dunque, è madre anche dei ricci di mare?’, proseguì.
[E] ‘Anche la tua’, ribatté.
[Ct] ‘E tu, allora, sei fratello dei ghiozzi, dei cagnolini e dei porcellini’.
[E] ‘Anche tu’, rispose.
[Ct] ‘Allora tuo padre è un cinghiale e un cane’.
[E] ‘Anche il tuo’, replicò.
[D] ‘Ma, se mi rispondi, Ctesippo, lo ammetterai subito’, affermò Dionisodoro. ‘Dimmi, hai un
21
cane?’
[Ct] ‘Sì, anche molto cattivo’, ribatté Ctesippo.
[D] ‘Ha dei cagnolini?’
[Ct] ‘Sì, certamente altri cani somiglianti a lui’, replicò.
[D] ‘Il cane è, dunque, loro padre?’
[Ct] ‘Io l’ho visto accoppiarsi con la cagna’, disse.
[D] ‘Ma non è tuo il cane?’
[Ct] ‘Certo’, rispose.
[D] ‘Allora, essendo tuo, è padre, cosicché il cane diventa tuo padre e tu diventi fratello dei
cagnolini’. E di nuovo, Dionisodoro, prendendo subito la parola, affinché Ctesippo non parlasse
prima disse: ‘E rispondi ancora a una piccola domanda: percuoti questo cane?’.
[Ct] E Ctesippo, ridendo, rispose: ‘Sì, per gli dèi, perché non posso picchiare te’.
[D] ‘Dunque tu picchi tuo padre’, concluse. [p. 299]
[Ct] ‘Picchierei, tuttavia, con molta più ragione vostro padre’, ribatté, perché gli è venuto in mente
di generare figli così sapienti. Ma certo, credo, Eutidemo, il padre vostro e dei cagnolini ha tratto
grande vantaggio da questa vostra sapienza’.
[E] ‘Ma non ha affatto bisogno di grandi vantaggi, Ctesippo, né quello né tu’.
Aporie sul bene e sulla felicità
[Ct] ‘Neppure tu, Eutidemo?’, chiese.
[E] ‘E neppure nessun altro degli uomini. Dimmi, infatti, Ctesippo, se ritieni che sia un bene per chi
è malato bere un farmaco, quando ne ha bisogno, o se ti sembra che non sia un bene. O quando va
in guerra, andarci con le armi piuttosto che senz’armi’.
[Ct] ‘Mi sembra’, rispose. ‘Tuttavia credo che dirai qualcosa di bello’.
[E] ‘Lo saprai benissimo’, continuò, ‘ma rispondi. Poiché hai ammesso che è un bene per un uomo
bere un farmaco, quando ne ha bisogno, non deve forse bere questo bene il più possibile, e non starà
bene allora se qualcuno, dopo averlo tritato, gli mescola un carro di elleboro?’.
[Ct] E Ctesippo replicò: ‘Certo, Eutidemo, se chi beve è grande come la statua di Delfi’.
[E] ‘Perciò, anche in guerra’, domandò, ‘poiché è bene avere armi, bisogna avere il maggior
numero possibile di lance e scudi, dal momento che è bene?’
[Ct] ‘Certo’, affermò Ctesippo; ‘ma non credi, o Eutidemo, che basti un solo scudo e una sola
lancia?’
[E] ‘Sì’.
[Ct] ‘Tu avresti armato così anche Gerione e Briareo?’, chiese.‘Credevo che tu fossi più abile, dal
momento che sei maestro d’armi e anche questo tuo compagno lo è’.
Ed Eutidemo tacque. Dionisodoro, invece, in riferimento alle risposte precedenti domandò a
Ctesippo:
[D] ‘Dunque, ti sembra sia un bene possedere anche dell’oro?’
[Ct] ‘Certo, e molto’, rispose Ctesippo.
[D] ‘Non credi sia necessario avere beni sempre e ovunque?’
[Ct] ‘Proprio così’, disse.
[D] ‘Dunque ammetti che anche l’oro sia un bene?’
[Ct] ‘L’ho ammesso’, ribatté.
[D] ‘Allora bisogna averne sempre, ovunque e quanto più possibile in se stessi? E uno sarebbe
felicissimo se avesse tre talenti d’oro nello stomaco, un talento nel cranio e uno statere d’oro in
ciascun occhio?’
[Ct] ‘Dicono, Eutidemo’, proseguì Ctesippo, ‘che i più felici e i migliori tra gli Sciti siano quelli
che hanno molto oro nei propri crani, secondo il discorso per cui poco fa dicevi padre il cane e ciò
che è ancora più singolare è che bevono anche dai loro crani indorati e li osservano all’interno,
tenendo fra le mani la loro sommità’.
22
Aporie sul vedere e parlare [p. 300]
[E] ‘Ma gli Sciti e gli altri uomini vedono le cose che si possono vedere o quelle che non si
possono?’, chiese Eutidemo.
[Ct] ‘Quelle che si possono vedere, certo’.
[E] ‘Perciò anche tu?’, domandò.
[Ct] ‘Anch’io’.
[E]‘Vedi i nostri vestiti?’
[Ct] ‘Sì’.
[E] ‘Questi, allora, possono vedere’.
[Ct] ‘Straordinariamente’, rispose Ctesippo.
[E] ‘E allora?’, disse.
[Ct] ‘Nulla. Ma tu forse non credi che essi vedano: sei così ingenuo! Mi sembra, Eutidemo, che tu
dorma ad occhi aperti e che, se si può non dire nulla parlando, tu faccia proprio questo’.
[D] ‘Non è forse possibile’, chiese Dionisodoro, ‘parlare tacendo?’
[Ct] ‘In nessun modo’, replicò Ctesippo.
[D] ‘E nemmeno tacere parlando?’
[Ct] ‘Ancora meno’, ribatté.
[D] ‘Perciò quando parli di pietre, di legni e di ferri, non parli di cose che tacciono?’
[Ct] ‘Certo no’, rispose, ‘se passo nelle officine dei fabbri, ma si dice che i ferri risuonino e
rimbombino molto fortemente, se qualcuno li tocca. Cosicché a causa della tua sapienza non ti sei
accorto di non avere detto nulla. Ma dimostratemi ancora il resto, cioè che è possibile tacere
parlando’.
[S] E a me Ctesippo sembrava preoccupato per il suo amato.
[E] ‘Quando taci’, chiese Eutidemo, ‘non taci tutto?’
[Ct] ‘Sì ‘, rispose.
[E] ‘Taci, dunque, anche le cose che parlano se fanno parte del tutto’.
[Ct] ‘Ma non tace tutto?’, domandò Ctesippo.
[E] ‘No certamente’, rispose Eutidemo.
[Ct] ‘Ma allora, mio caro, parla tutto?’
[E] ‘Le cose che parlano, certo’.
[Ct] ‘Ma non ti chiedo questo’, proseguì, ‘ma: tutte le cose tacciono o parlano?’
[D] ‘Nessuna delle due cose e entrambe’, ribatté Dionisodoro, afferrando la parola. ‘So bene, infatti,
che non saprai come cavartela con la risposta’.
[S] E Ctesippo, com’era solito, scoppiato in una risata fragorosa, disse:
[Ct] ‘O Eutidemo, tuo fratello ha posto l’argomento in modo da potere dare due risposte, è perduto
ed è stato vinto’.
[S] E Clinia si rallegrò molto e si mise a ridere, cosicché Ctesippo diventò più di dieci volte più
grande. Ctesippo, siccome è scaltro, aveva, mi sembra, carpito da loro queste sottigliezze, perché
una simile sapienza non esiste fra gli altri nostri contemporanei. Chiesi: ‘Perché ridi, Clinia, di
argomenti così seri e belli?’
Idee, dialettica e anima
[D] ‘Socrate, hai mai visto una cosa bella?’, domandò Dionisodoro.
[S] ‘Sì ‘, risposi, ‘e molte, o Dionisodoro’. [p. 301]
[D] ‘Erano cose diverse dal bello o identiche ad esso?’, domandò.
[S] E io rimasi perplesso per l’aporia e ritenni di avere subito la giusta punizione per avere fiatato,
tuttavia risposi: ‘Diverse dal bello in sé, tuttavia in ciascuna di esse è presente una certa bellezza’
[D] ‘Allora’, disse, ‘se vicino a te c’è un bue, tu sei un bue e, perché ora io mi trovo vicino a te, sei
Dionisodoro?’
[S] ‘Taci su questo’, replicai io.
[D] ‘Ma in che modo’, chiese, ‘una cosa diversa potrebbe essere diversa, quando una cosa diversa è
23
presente a una cosa diversa?’
[S] ‘Sei forse in difficoltà su questo?’, chiesi io. Ormai cercavo di imitare la sapienza dei due
uomini, perché la desideravo.
[D] ‘Come non essere in difficoltà’, domandò, ‘io e tutti gli altri uomini su ciò che non è?’
[S] ‘Che dici, Dionisodoro?’, chiesi. ‘Il bello non è bello e il brutto non è brutto?’
[D] ‘Se mi pare’, rispose.
[S] ‘E ti pare?’
[D] ‘Certo’, disse.
[S] ‘Allora anche l’identico è identico e il diverso è diverso? Certo il diverso non è identico, ma non
avrei creduto che neppure un bambino dubitasse che il diverso non fosse diverso. Dionisodoro, hai
deliberatamente trascurato questo punto, perché mi pare che anche voi per il resto, come gli
artigiani, cui compete produrre tutti i singoli oggetti, realizziate ottimamente la dialettica’.
[D] ‘Sai, dunque’, chiese, ‘che cosa compete a ciascun artigiano? In primo luogo sai a chi compete
lavorare dei metalli?’
[S] ‘Sì, al fabbro’.
[D] ‘E costruire oggetti in terracotta?’
[S] ‘Al vasaio’.
[D] ‘E sgozzare, scuoiare e, dopo avere fatto a pezzi le carni, bollirle ed arrostirle?’
[S] ‘Al macellaio’, risposi.
[D] ‘Perciò se uno fa ciò che gli compete, agirà correttamente?’, domandò.
[S] ‘Certo’.
[D] ‘Conviene davvero, come dici, fare a pezzi e scuoiare il macellaio? Hai ammesso questo o no?’
[S] ‘L’ho ammesso’, replicai, ‘ma compatiscimi’.
[D] ‘È chiaro, allora’, disse, ‘che se uno, dopo avere sgozzato il macellaio e averlo fatto a pezzi, lo
fa bollire e lo arrostisce, farà ciò che è conveniente; e se qualcuno foggia il fabbro e costruisce in
terracotta il vasaio, anche costui agirà in modo conveniente’.
[S] ‘O Poseidone’, esclamai, ‘ormai poni un coronamento alla tua sapienza. Questa non sarà mai
presente in me così da diventare mia?’
[D] ‘La riconosceresti, Socrate’, chiese, ‘se fosse divenuta tua?’
[S] ‘Se tu lo vuoi evidentemente’, risposi io.
[D] ‘Ma credi di conoscere le tue cose?’, domandò.
[S] ‘Se tu non dici altrimenti perché bisogna iniziare da te e finire in Eutidemo qui presente’. [D]
‘Credi, dunque, che siano tue’, chiese, ‘le cose che tu dirigi e puoi usare come vuoi? [p. 302] Ad
esempio un bue e una pecora: riterresti forse tuoi questi animali che potresti vendere, donare e
sacrificare a qualunque dio tu voglia? Mentre considereresti non tuoi quelli per i quali non è così ?’
[S] E io (sapevo infatti che da quelle domande sarebbe emerso qualcosa di bello e nello stesso
tempo desideravo ascoltare al più presto): ‘Certo’, dissi, ‘è così : solo tali animali sono miei’.
[D] ‘Ma non chiami animali quegli esseri che hanno un’anima?’
[S] ‘Sì ‘, risposi.
[D] ‘Ammetti, dunque, che fra gli animali sono tuoi solo quelli riguardo ai quali hai la possibilità di
fare tutto ciò che dicevo poco fa?’
[S]‘Lo ammetto’. Ed egli, dopo avere indugiato molto ironicamente, come se esaminasse qualcosa
di importante, chiese:
[D] ‘Dimmi, Socrate, hai uno Zeus patrio?’.
[S] E io, sospettando che il discorso sarebbe arrivato dove poi finì, cercavo di sfuggire al raggiro
insuperabile e mi rivoltavo già come fossi stato preso in una rete. ‘Non l’ho, Dionisodoro’, risposi.
[D] ‘Allora sei un uomo infelice e non sei neppure un ateniese, se non hai né dèi patrii, né riti sacri,
né nient’altro di bello e di buono’.
[S] ‘Lascia stare’, dissi, ‘Dionisodoro, taci e non insegnarmi con durezza. Anch’io ho altari, riti
sacri domestici e patrii e tutte le altre cose di questo tipo che hanno gli altri Ateniesi’.
[D] ‘Gli altri Ateniesi non hanno dunque Zeus patrio?’
24
[S] ‘Questa denominazione non è in uso presso nessuno degli Ioni’, risposi, ‘né presso quanti sono
emigrati da questa città e neppure presso di noi, invece Apollo è patrio a causa della generazione di
Ione. Zeus tra noi non è chiamato patrio, ma protettore della famiglia e protettore della fratria e
anche Atena è chiamata protettrice della fratria’.
[D] ‘Ma basta’, disse Dionisodoro; ‘tu hai, a quanto pare, Apollo, Zeus e Atena’.
[S] ‘Certo’, affermai.
[D] ‘Questi, dunque, sarebbero tuoi dèi?’, chiese.
[S] ‘Fondatori della stirpe e sovrani’.
[D] ‘Ma allora sono tuoi’, disse, ‘o non hai ammesso che essi sono tuoi?’
[S] ‘L’ho ammesso’, replicai: ‘che cosa mi può capitare?’
[D] ‘Allora questi dèi sono anche animali?’, chiese. ‘Già: hai ammesso che gli esseri che hanno
un’anima sono animali. O questi dèi non hanno un’anima?’
[S ‘L’hanno’, risposi.
[D] ‘Dunque sono anche animali?’
[S] ‘Animali’, ribattei.
[D] ‘Ma tra gli animali’, disse, ‘hai ammesso che sono tuoi quelli che puoi donare, vendere e
sacrificare a qualunque dio tu voglia’.
[S] ‘L’ho ammesso’, replicai: ‘non mi è possibile una ritrattazione, Eutidemo’.
[D] ‘Via dunque, dimmi subito’, riprese: ‘poiché ammetti che Zeus è tuo e gli altri dèi sono tuoi [p.
303], puoi forse venderli, donarli o servirti di essi come vuoi, come degli altri animali?’
[S] Allora, Critone, come colpito dal ragionamento, restai senza voce. Ma Ctesippo, venendomi in
aiuto: ‘Caspita, Eracle, un bel ragionamento!’, esclamò. E Dionisodoro: ‘Dunque, Eracle è caspita o
caspita è Eracle?’, chiese. E Ctesippo: ‘O Poseidone’, esclamò, ‘straordinari ragionamenti! Mi
ritiro. Sono invincibili questi due’.
“Elogio degli eristi” e conclusione ommessi
25
Platone di Atene (427-347 a.C.)
Teeteto
lingua originale: greco
edizione di riferimento: Stephanus (Henri Estienne), Ginevra, 1578
tr. it. G.Giardini, Bompiani, Milano, 2001
[Stephanus, vol. I, p. 169]
(Socrate sta discutendo la natura della scienza e prende in esame la dottrina di Protagora secondo
cui ‘l’uomo è misura di tutte le cose’)
La dottrina di Protagora
SOCRATE: Per prima cosa, dunque, riesaminiamo il problema allo stesso punto di prima e
consideriamo se eravamo malcontenti, a ragione o a torto, biasimando il ragionamento che
presupponeva che ciascuno è autosufficiente a se stesso rispetto alla conoscenza. Ma Protagora
non convenne con noi che quanto alla conoscenza del meglio e del peggio alcuni si distinguono
di gran lunga e questi proprio sono i sapienti. Non è così?
TEODORO: Sì.
SOCRATE: Se dunque egli, essendo presente, ce lo avesse concesso, e non avessimo invece dovuto
ammetterlo noi, prendendo la sua difesa, non ci sarebbe affatto bisogno di riprendere la
questione per renderla consolidata. Ora, forse, qualcuno potrebbe giudicarci senza diritto di fare
questa ammissione in vece sua. Per questo motivo è cosa migliore concordare in maniera più
chiara su questo stesso problema. Infatti non è che cambi poco se a cosa sta così o in maniera
diversa.
TEODORO: È vero.
SOCRATE: Dunque [pag. 170] non con il concorso di altri, ma del suo ragionamento, nel modo più
breve, cerchiamo di comprendere quello che è il suo assenso.
TEODORO: Come?
SOCRATE: Così: dice egli che quel che pare a ciascuno questo anche è per colui al quale pare?
TEODORO: Lo dice, sì.
L’apparente esclusione dell’opinione falsa
SOCRATE: E dunque, Protagora, anche noi manifestiamo il pensiero di un uomo, o meglio di tutti
gli uomini, quando affermiamo che per certe questioni non c’è nessuno che non consideri se
stesso più sapiente degli altri, per altre questioni invece non stimi gli altri migliori di sé, e che in
mezzo a grandissimi pericoli, come quando sono esposti a guerre e malattie, al mare in tempesta,
come a degli dèi si tengono vicini a quelli che in ciascuna di queste circostanze hanno il potere,
perché sembrano loro dei salvatori, mentre non sono diversi in altro da loro, se non per il sapere.
E ogni condizione umana è piena di persone alla ricerca dei maestri e comandanti o per sé o per
altri esseri viventi, o per iniziative che intendono compiere, ma lo è di individui che ritengono di
essere capaci di insegnare e di esserlo altrettanto a comandare. E in questi atteggiamenti cosa
diremo, se non che gli stessi uomini pensano che esista, in loro, sapienza e ignoranza?
TEODORO: Niente altro.
SOCRATE: Gli uomini dunque non considerano la sapienza vero pensiero e l’ignoranza opinione
falsa?
TEODORO: Ebbene?
Può Protagora contraddire qualcuno che lo contraddice?
SOCRATE: Dunque, Protagora, che ne faremo del tuo ragionamento? Diciamo dunque che gli
uomini nutrono talvolta opinioni vere e talvolta opinioni false? Da ambedue le ipotesi ne viene
che non sempre gli uomini nutrono opinioni vere, ma vere e false. Considera infatti tu stesso,
26
Teodoro, se qualcuno dei seguaci di Protagora, o tu stesso, volessi affermare con forza che
nessuno considera un altro ignorante e nutre pure false opinioni?
TEODORO: Ma è incredibile, Socrate.
SOCRATE: Ma giunge a tal punto di necessità chi sostiene che l’uomo è misura di tutte le cose.
TEODORO: E come?
SOCRATE: Ma quando tu dai un giudizio di per te stesso su una cosa, e poi manifesti a me su
quella stessa cosa il tuo parere, questo per te, secondo il ragionamento di Protagora, sarà vero,
ma per noi e tutti gli altri non è forse possibile divenire giudici, o dobbiamo sempre giudicare
che tu hai opinioni vere? Oppure sono una infinità gli uomini che ogni volta si contrastano
pensandola all’opposto, ritenendo che tu giudichi e pensi il falso.
TEODORO: Ma, per Zeus, Socrate, sono ‘migliaia di migliaia’ gli uomini, come dice Omero, che
mi cagionano ogni sorta di difficoltà.
SOCRATE: E dunque, vuoi che diciamo che allora tu per te stesso, hai opinioni vere, ma false per
tutte queste migliaia di uomini?
TEODORO: Pare sia necessario a seguito di questo ragionamento.
SOCRATE: E cosa ne è per Protagora in persona? Se neppure Protagora avesse mai creduto che
l’uomo è misura di tutte le cose, né la maggioranza degli uomini, come del resto non la pensano
neppure, non sarebbe forse necessario che quella “verità” [pag. 171] che egli delineò non
esistesse per nessuno? Se invece egli la credette realmente, ma la maggioranza degli uomini non
la crede, sai bene che quanto più numerosi sono quelli a cui pare rispetto a quelli cui non pare,
tanto più che essa non è rispetto a quelìa che è.
TEODORO: È giocoforza se essa sarà a seconda di ciascuna opinione o non sarà.
La verità per il relativista della tesi anti-relativista
SOCRATE: C’è poi questo secondo punto che è ancor più simpatico: egli, Protagora, rispetto alla
sua opinione siccome ammette come vere anche tutte quelle che pensano gli uomini, riconosce
che sia vera l’opinione di quelli che la pensano in modo opposto al suo e per il quale pensano
che egli abbia affermato il falso.
TEODORO: Proprio così.
SOCRATE: E non concederà dunque che sia falsa la propria opinione, dal momento che riconosce
come vera quella di coloro che pensano che egli abbia sostenuto il falso?
TEODORO: Necessariamente.
SOCRATE: Ma questi altri non ammettono certo con se stessi di nutrire false opinioni.
TEODORO: Certamente no.
SOCRATE: Egli invece Protagora dal canto suo riconosce che sia vera anche questa opinione in
conseguenza di ciò che ha scritto.
TEODORO: Pare.
SOCRATE: Cominciando da tutti questi, dunque, fin dallo stesso Protagora, ci sarà un dilemma:
ancora più quando egli ammette, che chi va predicando il contrario di lui, questo può nutrire una
opinione vera, allora lo stesso Protagora dovrà concedere che né un cane, né il primo uomo che
capita, sia misura neppure di una sola cosa che non abbia imparato. Non è così?
TEODORO: È così.
SOCRATE: Dunque, siccome ci si trova a dubitare da parte di tutti, per nessuno la verità di
Protagora può essere vera, né per alcun altro, né per lui stesso.
TEODORO: Socrate, noi incalziamo anche troppo l’amico mio.
Conseguenze etico-politiche della dottrina di Protagora
SOCRATE: Forse, mio caro, ma non è chiaro se lo incalziamo correttamente. è probabile però, che
lui, dato che è più vecchio, sia anche più saggio di noi. E se di qui, all’improvviso, balzasse fuori
fino al collo, è molto probabile che molte cose avrebbe da dire contro di me che vado
disseminando frottole e contro di te che le accetti, poi, calandosi giù di nuovo, se ne andrebbe via
27
a gambe levate. Ma per noi, è necessario, io penso, servirci di noi stessi, così come siamo e
ribattere il nostro modo di pensare, sempre alla stessa maniera. E, anche ora, cos’altro possiamo
dire che chiunque riconosce questo, cioè che uno è più sapiente di un altro, e un altro più
ignorante?
TEODORO: A me pare così.
SOCRATE: E possiamo affermare anche che il ragionamento poggia soprattutto su questo punto
che noi abbozzammo, correndo in aiuto a Protagora, che la maggior parte delle cose, le calde, le
aride, le dolci e tutte le altre di questa sorta, quali sembrano, tali sono anche per ciascuno. Ma se
poi si conviene che in certe cose vi è una certa qual differenza tra l’una e l’altra, come quello che
è salutare e nocivo al nostro corpo, Protagora dovrà pur concedere che non ogni donnetta, o
ragazzotto, o animale sono in grado di curare se stessi, conoscendo bene ciò che è giovevole alla
loro salute, ma proprio in queste faccende, se pure in altre mai, c’è differenza tra l’uno e l’altro.
TEODORO: A me pare così. [pag. 172]
SOCRATE: Parimenti nella sfera politica il bello e il brutto, il giusto e l’ingiusto, il santo e il non
santo, sono quali in ogni città, pensando che siano, pone nelle proprie leggi a suo beneficio; ed in
queste nessuno è più sapiente di un altro, né privato cittadino di cittadino, né città di città. Ma nel
porre una città provvedimenti di legge utili o non utili, in questo caso Protagora, se in altri mai,
concederà ancora una volta che esiste diversità tra consigliere e consigliere, tra una città e l’altra
nella loro valutazione del vero e non avrà certo il coraggio di sostenere che quei provvedimenti
che una città vara, ritenendoli utili a sé, questi lo dovranno essere a tutti i costi. Ma a proposito di
quello di cui parlavo, del giusto e dell’ingiusto, del santo e del non santo, chi segue Protagora si
ostina ad affermare che non c’è in natura nessuna di queste cose che abbia una sua essenza, ma
che la valutazione che si dà in comune diventa essa appunto vera, proprio allora mentre pare
valida e per tutto il tempo in cui lo pare. E quanti non abbiano in maniera assoluta il
ragionamento di Protagora, orientano la propria sapienza un presso a poco così. Ma da un
ragionamento, Teodoro, ci sopravviene un altro ragionamento e, da uno più piccolo, un altro più
grande.
28
Aristotele di Stagira (384-22 a.C)
Le confutazioni sofistiche
lingua originale: greco
edizione di riferimento: I. Bekker, Berlino, 1831 ecc.
tr. it. P.Fait, Laterza, Bari-Roma, 2004
[Bekker p. 164a]
CAPITOLO 1
Parliamo ora delle confutazioni sofistiche, cioè di quelle che sembrano confutazioni, mentre in
realtà sono paralogismi e non confutazioni, cominciando, secondo natura, da ciò che è primo.
Che veramente alcune argomentazioni siano sillogismi e altre lo sembrino senza esserlo è
manifesto, giacché, come questo avviene per le altre cose in virtù di una certa somiglianza, così
avviene anche per le argomentazioni. Infatti certuni sono in buona condizione fisica mentre altri
sembrano esserlo perché si agghindano e sono impettiti come offerte tribali; alcuni sono belli per la
bellezza, [164b] altri sembrano belli perché si truccano. E lo stesso vale per le cose inanimate,
giacché alcune di queste sono veramente d'argento e alcune d'oro, mentre altre non lo sono, ma lo
sembrano alla percezione: per esempio le cose di litargio e quelle di stagno sembrano d'argento,
quelle giallastre sembrano d'oro. Allo stesso modo anche le argomentazioni, qualcuna è veramente
sillogismo e confutazione, qualche altra non lo è ma sembra esserlo a causa dell'inesperienza,
giacché gli inesperti, come se ne fossero distanti, guardano le cose da lontano. [165] Il sillogismo,
infatti, è costituito da alcune cose poste in modo che sia necessario dire qualcosa di diverso dalle
cose poste, in virtù delle cose poste, mentre la confutazione è un sillogismo accompagnato dalla
contraddittoria della conclusione. Certe argomentazioni invece questo non lo fanno, ma sembrano
farlo per molte cause, fra le quali ce n'è una che è il luogo più fertile e diffuso: quello che dipende
dalle parole. Poiché infatti non è possibile discutere portando gli oggetti stessi, ma usiamo le parole
al posto degli oggetti come simboli, riteniamo che quel che risulta per le parole risulti anche per gli
oggetti – proprio come ritengono che avvenga per i sassolini quelli che fanno calcoli. Ma non è la
stessa cosa: infatti le parole sono finite, così come lo è la moltitudine delle locuzioni, mentre gli
oggetti sono infiniti di numero; è necessario dunque che la stessa locuzione e un'unica parola
significhino più cose. Pertanto, come in quel caso coloro che non sono abili a muovere i sassolini
vengono imbrogliati dai competenti, allo stesso modo, nelle argomentazioni, coloro che sono
inesperti della forza delle parole commettono paralogismi sia quando discutono in prima persona sia
quando ascoltano altri. Per questa causa, dunque, e per quelle che verranno dette, vi sono un
sillogismo e una confutazione apparenti ma non reali.
Poiché per alcuni è più vantaggioso sembrare di essere sapiente che esserlo e non sembrarlo – la
sofistica infatti è una sapienza apparente e non reale e il sofista uno che trae guadagno da una
sapienza apparente e non reale – è chiaro che per costoro è necessario sembrare svolgere il compito
del sapiente, piuttosto che svolgerlo e non sembrare. Per limitarsi al punto principale, compito di
chi conosce, rispetto ad ogni argomento, è non dire egli stesso il falso su ciò che sa e saper
smascherare chi dice il falso. Queste cose consistono l'una nel saper rendere ragione, l'altra nel
saper chiedere ragione. E necessario dunque che coloro che vogliono fare i sofisti ricerchino il
genere delle argomentazioni dette, perché recherà loro vantaggio. Una tale capacità, infatti, farà
sembrare sapiente, ed è appunto questa la loro intenzione.
Che dunque vi sia un tale genere di argomentazioni, e che a una tale capacità aspirino coloro che
chiamiamo sofisti, è chiaro. Diciamo ora invece quante siano le specie di argomentazioni sofistiche,
quante siano di numero le cose di cui si costituisce questa capacità, quante risultino essere le parti
della trattazione e tutte le altre cose che concorrono a quest'arte.
CAPITOLO 2
29
Vi sono quattro generi di argomentazioni che hanno luogo nel discutere: didattiche, dialettiche,
esaminatrici ed eristiche. [165b] Didattiche sono quelle che partono dai principi propri di ciascuna
disciplina e non sillogizzano a partire dalle opinioni di chi risponde (giacché chi impara deve
fidarsi), dialettiche sono quelle che sillogizzano la contraddittoria a partire dalle cose plausibili,
esaminatrici sono quelle che partono dalle cose che sembrano vere a chi risponde e che è necessario
sappia chi pretende di possedere la scienza (in quale maniera, è stato determinato altrove), eristiche
sono quelle sillogistiche o apparentemente sillogistiche che partono dalle cose apparentemente ma
non realmente plausibili. Ebbene, delle argomentazioni dimostrative si è detto negli Analitici, delle
dialettiche e delle esaminatrici altrove; parliamo ora di quelle competitive ed eristiche.
CAPITOLO 3
Prima di tutto bisogna apprendere quanti siano i fini che hanno di mira coloro che nelle
argomentazioni competono e desiderano la sopraffazione. Questi sono cinque di numero: la
confutazione, il falso, il paradosso, il solecismo e, quinto, l'indurre l'interlocutore a chiacchierare (e
questo è costringerlo a ripetere più volte la stessa cosa), o, se non la realtà, almeno l'apparenza di
ciascuno di essi. Costoro vogliono, infatti, in primo luogo confutare in modo palese, in secondo
luogo mostrare qualcosa di falso, in terzo luogo condurre ad un paradosso, in quarto luogo far
commettere solecismi (e questo è lo spingere chi risponde a esprimersi in modo barbaro in forza
dell'argomentazione) e in ultimo il far dire la stessa cosa più volte.
CAPITOLO 4
I modi di confutare sono due: delle confutazioni, infatti, le une dipendono dall'espressione, le altre
ne prescindono. Le cose che suscitano l'apparenza a causa dell'espressione sono sei di numero; esse
sono: omonimia, anfibolia, composizione, divisione, accento, forma dell'espressione. Prova di ciò è
quella per induzione e anche il sillogismo, qualora sia assunto un altro <numero> e <tale sillogismo
concluda> che tanti sono i modi in cui, con le stesse parole e locuzioni, possiamo indicare ciò che
non è lo stesso. Dipendono dall'omonimia le argomentazioni di questo tipo: ‘Apprendono
[manthanousin] coloro che conoscono; giacché sono quelli che conoscono le lettere che capiscono
[manthanousin] quel che viene loro recitato’. ‘Apprendere’ [manthanein] è infatti omonimo e
significa sia il comprendere usando la conoscenza sia l'acquisire la conoscenza. E ancora: ‘I mali
sono beni, giacché le cose che devono essere [ta deonta] sono beni e i mali devono essere [deonta]’.
‘Ciò che deve essere’ [to deon] è infatti ambiguo e significa sia ciò che è necessario, il che spesso
accade anche nei mali (giacché qualche male è necessario), sia ciò per cui diciamo che le cose
buone devono essere [deonta]. Inoltre si conclude che lo stesso uomo siede e sta in piedi ed è
malato e sano, giacché proprio colui che si alzava sta in piedi e proprio colui che guariva è sano,
[166a] ma si alzava il seduto e guariva il malato. ‘Il malato fa o patisce qualcosa’, infatti, non
significa una cosa sola, ma a volte significa che chi è ora malato fa o patisce qualcosa, a volte che
chi lo era prima fa o patisce qualcosa. D'altra parte guariva sia essendo malato sia il malato, mentre
sta bene non essendo malato, ma il malato: non essendolo ora, ma essendo chi lo era prima.
Dipendono dall'anfibolia le argomentazioni di questo tipo: ‘Desiderare che io catturi i nemici’ e
‘Quel che uno conosce, non è questo che conosce?’, giacché con questa locuzione può essere
indicato come conoscente sia colui che conosce sia la cosa conosciuta. E ancora: ‘Quel che uno
vede, non è questo che vede? Ma vede la colonna, sicché è la colonna a vedere’. E ancora: ‘Quando
dici che qualcosa è, dici essere quella cosa? Ma dici che una pietra è, dunque dici di essere una
pietra’. E ancora: ‘È possibile dire cose che tacciono?’. ‘Dire cose che tacciono’ [to sigonta legein]
è infatti ambiguo e può indicare non solo che chi sta dicendo tace, ma anche che tacciono le cose
dette.
Vi sono tre tipi di argomentazioni dipendenti dall'omonimia e dall'anfibolia. Uno quando la
locuzione o la parola significhino propriamente più cose, come ‘aquila’ e ‘cane’. Un altro è quando
siamo soliti dire in questo modo. Il terzo quando la parola composta con altre significhi più cose,
mentre quando è separata abbia un significato solo. Per esempio ‘conoscono le lettere’; infatti
30
ciascun membro, sia ‘conoscono’ sia ‘lettere’, ha forse un solo significato, mentre i due insieme
significano più cose: o che le lettere stesse hanno conoscenza o che un altro ha conoscenza delle
lettere.
L'anfibolia e l'omonimia dipendono dunque da questi modi. Dalla composizione dipendono invece
argomentazioni come ‘Potere sedendo camminare’ e ‘Potere non scrivendo scrivere’. Infatti,
quando uno asserisce come possibile ‘sedendo camminare’, non significa lo stesso se lo prende
dividendo o componendo. E similmente, nell'altro caso, se si compone ‘non scrivendo scrivere’,
giacché significa che qualcuno ha la possibilità di scrivere non scrivendo. Se invece non lo si
compone, significa che quando non scrive costui ha la possibilità di scrivere. E anche: ‘Impara ora
le lettere se è vero che ha imparatol ciò che sa’; e inoltre ‘Una sola cosa potendo portare molte cose
poter portare’.
Dipendono dalla divisione: ‘Cinque è due e tre ed è dispari e pari’. E anche ‘Il maggiore è uguale;
infatti è altrettanto e qualcosa di più’. La medesima locuzione, infatti, a seconda che sia divisa o
composta, non sarà ritenuta significare sempre lo stesso; per esempio: ‘Io ti feci schiavo essendo
libero’ e ancora ‘Di cento uomini il divo Achille ne lasciò cinquanta [o ‘di cinquanta uomini il divo
Achille ne lasciò cento’].
[166b] Non è facile costruire un’argomentazione dipendente dall’accento nelle discussioni
dialettiche non scritte, mentre lo è di più in quelle scritte e in poesia. Per esempio alcuni correggono
Omero contro coloro che lo accusano di aver detto assurdamente ‘ne [hou] marcisce alla pioggia’.
Risolvono questa difficoltà pronunciando ‘né’ [où] più acutamente. E risolvono la difficoltà relativa
al sogno di Agamennone dicendo che non fu Zeus stesso a dire ‘gli concediamo [dìdomen] di avere
gloria, ma ordinò al sogno di concedergliela. Tali sono dunque i casi che dipendono dall’accento.
Le argomentazioni che dipendono dalla forma dell’espressione hanno luogo quando ciò che non è
lo stesso viene espresso nello stesso modo; per esempio il maschile come femminile o il femminile
come maschile o il neutro come uno di questi, o ancora la qualità come quantità o la quantità come
la qualità o il fare come il patire o la condizione come un fare e così negli altri casi che sono stati
distinti prima. È possibile infatti significare per mezzo dell’espressione ciò che non è un fare come
se lo fosse; per esempio lo stare bene [hugiainein] viene detto, per la forma dell’espressione, in
modo simile al tagliare [temnein] o al costruire [oikodomein]. E però l’uno indica un tipo di qualità
o una determinata condizione e l’altro un fare. Allo stesso modo negli altri casi.
Le confutazioni che dipendono dall’espressione sono costituite da questi luoghi, mentre dei
paralogismi che prescindono dall’espressione vi sono sette specie. La prima dipende dall’accidente;
la seconda dall’essere detto in assoluto oppure non in assoluto, ma per un certo aspetto o in un certo
luogo o tempo o relazione; la terza è quella che dipende dall’ignoranza della confutazione; la quarta
quella che dipende dal conseguente; la quinta è quella che dipende dall’assumere ciò che era fissato
all’inizio; la sesta porre come causa ciò che non lo è; la settima il fare di più domande una domanda
sola.
CAPITOLO 5
I paralogismi che dipendono dall’accidente hanno luogo quando si ritiene che qualsiasi cosa
convenga nello stesso modo all’oggetto e all’accidente. Poiché infatti la stessa cosa ha molti
accidenti, non è necessario che tutte le stesse cose convengano a tutti i predicati e a ciò a cui si
predicano. Per esempio: ‘Se Corisco è diverso dall’uomo, egli è diverso da se stesso, giacché è un
uomo’. Oppure: se Corisco è diverso da Socrate e Socrate è un uomo, si dirà che è stato accordato
che Corisco è diverso dall’uomo per il fatto che ciò dal quale è stato detto essere diverso ha
l’accidente di essere un uomo.
I paralogismi che dipendono dal fatto che questo si dice in assoluto o per un certo aspetto e non
propriamente hanno luogo quando ciò che è detto parzialmente sia preso come se fosse detto in
assoluto; per esempio, se ciò che non è è oggetto di opinione, dire che ciò non è è. [167a] Non è lo
stesso infatti essere qualcosa e essere in assoluto. O ancora dire che ciò che è non è ciò che è, se,
per qualcuna delle cose che sono, esso non è quella cosa; per esempio se non è uomo. Non è lo
31
stesso infatti non essere qualcosa e non essere in assoluto, ma, per vicinanza dell’espressione,
sembra differire poco anche l’essere qualcosa dall’essere. Allo stesso modo anche il caso che
dipende dal dirsi per un certo aspetto o in assoluto. Per esempio, l’indiano, che è tutto nero, è
bianco rispetto ai denti; dunque è bianco e non bianco. Oppure, se entrambi i predicati si dicono per
un certo aspetto, dire che allo stesso tempo convengono predicati contrari. Questo tipo di
paralogismo è in certi casi facile da vedere per tutti; ad esempio, se l’interrogante, assumendo che
l’etiope è nero, chiedesse se è bianco rispetto ai denti, e se dunque è bianco in questo modo,
credesse di aver discusso perfezionando sillogisticamente l’interrogazione, che è nero e non nero. In
alcuni casi, invece, questo tipo di paralogismo sfugge spesso all’attenzione: in quelli in cui, qualora
un predicato si dica per un certo aspetto, sembrerebbe seguirne anche la predicazione in assoluto; e
in quelli in cui non è facile vedere quale dei due sia da rendere come attribuito propriamente; una
situazione del genere si verifica quando gli opposti convengono allo stesso grado: sembra infatti che
o entrambi o nessuno dei due siano da concedere in assoluto; per esempio: se una cosa è per metà
bianca e per metà nera, è bianca o nera?
I paralogismi che dipendono dal fatto che non si è determinato che cosa sia un sillogismo o che cosa
una confutazione si verificano a causa della mancanza della formula definitoria. La confutazione è
infatti la contraddizione di uno e lo stesso oggetto, non solo di una parola, t di una parola non
sinonima, ma della stessa; contraddizione derivante di necessità dalle cose concesse, senza
comprendere nel numero ciò che era stato fissato all'inizio, sotto lo stesso rispetto, in relazione alli
stessa cosa, nello stesso modo e nello stesso tempo. Nella stessa maniera si definisce anche il dire il
falso su qualcosa. Alcuni, tralasciando qualcuno dei punti detti, confutano in apparenza. Per
esempio dicendo che la stessa cosa è doppia e non doppia, giacché il due è doppio dell'uno, ma non
è doppio del tre. Oppure, se la stessa cosa è doppia e non è doppia della stessa cosa, ma non sotto lo
stesso rispetto giacché è doppia rispetto alla lunghezza e non è doppia rispetto alla larghezza.
Oppure se è doppia e non è doppia della stessa cosa, sotto lo stesso rispetto, nello stesso modo, ma
non al contempo, per la qua ragione è una confutazione apparente. Ma quest'<ultima> confutazione
potrebbe essere anche forzatamente inclusa in quelle che dipendono dall'espressione.
Le confutazioni che dipendono dall'assumere ciò che era stato fissato all'inizio si verificano in tali e
tanti modi quanti quelli in cui è possibile richiedere ciò che era stato fissato all'inizio e sembrano
confutare perché si è incapaci di cogliere ciò che è lo stesso e ciò che è diverso.
[167b] La confutazione che dipende dal conseguente deriva dal ritenere che la conseguenza si
converta, giacché quando, essendo questo, necessariamente è quest'altro, si ritiene pure che,
essendo quest'ultimo, necessariamente sia anche il primo. Da ciò nascono anche gli inganni nelle
opinioni fondate sulla percezione. Spesso infatti il fiele è prese per miele per il fatto che a
quest'ultimo consegue il colore giallo. E, poiché quando piove risulta che la terra si bagna,
riteniamo anche che quando è bagnata sia piovuto; ma ciò non è necessario. Nei discorsi retorici, le
dimostrazioni secondo il segno dipendono dai conseguenti, giacché, volendo mostrare che qualcuno
è adultero, si assume il conseguente, cioè che è azzimato o che lo si vede girovagare di notte; ma a
molti queste caratteristiche convengono pur non convenendo l'accusa. Allo stesso modo anche nelle
argomentazioni sillogistiche, come quella di Melisso volta a provare che il tutto è infinito, la quale
assume che il tutto è ingenerato (giacché nulla potrebbe essere generato da ciò che non è) e che
quanto è generato è generato da un principio <e conclude > che se dunque il tutto non è stato
generato, non ha un principio, cosicché è infinito. Ma ciò non risulta necessariamente, giacché se
tutto ciò che è generato ha un principio, non vale anche che se qualcosa ha un principio sia stato
generato, così come, se chi è febbricitante è caldo, non vale anche che chi è caldo necessariamente
sia febbricitante.
Il paralogismo che dipende dal considerare causa ciò che non è causa si verifica quando ciò che non
è causa sia assunto in aggiunta come se da esso dipendesse l'aver luogo della confutazione. Questo
tipo di paralogismo si verifica nei sillogismi che conducono all'impossibile. In questi, infatti, è
necessario demolire una delle premesse. Se dunque ciò che non è causa sia compreso nel numero
delle domande necessarie a far risultare l'impossibile, sembrerà spesso che la confutazione abbia
32
luogo in dipendenza da questo. Per esempio l'argomentazione che l'anima e la vita non sono la
stessa cosa. Se infatti la generazione è contraria alla corruzione, anche un tipo di generazione sarà
contrario ad un tipo di corruzione; la morte è un tipo di generazione ed è contraria alla vita,
cosicché la vita è una generazione e il vivere un generarsi; ma ciò è impossibile: dunque l'anima e la
vita non sono la stessa cosa. Questo però non è stato certo sillogizzato, perché l'impossibile risulta
anche quando non si dica che la vita è la stessa cosa dell'anima, ma soltanto che la vita è contraria
alla morte, essendo quest'ultima una corruzione ed essendo la corruzione contraria alla generazione.
Le argomentazioni di questo tipo non sono dunque in assoluto asillogistiche, ma lo sono in
relazione alla conclusione prefissata. Spesso tale paralogismo sfugge in uguale misura anche
all'attenzione degli stessi interroganti.
Le argomentazioni che dipendono dal conseguente e quelle che dipendono da ciò che non è causa
sono fatte in questo modo. Quelle che dipendono dal fare di due domande una domanda sola hanno
invece luogo quando sfugge che vi sono più domande e, come se ve ne fosse una, viene fornita
un'unica risposta. In certi casi è facile vedere che le domande sono più d'una e che non va data una
sola risposta; per esempio ‘È la terra che è mare o è il cielo?’ [168a] In certi casi è invece meno
facile, e, come se vi fosse una sola domanda, o si cede per il fatto di non rispondere a ciò che è stato
chiesto, oppure si sembra confutati. Per esempio: ‘Ma questo e quest'altro sono un uomo?’,
cosicché se si percuota questo e quest'altro si percuoterà un uomo e non degli uomini. O ancora,
dato un insieme di cose di cui alcune sono buone e altre non buone, tutte queste cose sono buone o
non sono buone? Qualunque cosa il rispondente dica, può essere ritenuto responsabile di una
confutazione apparente o di un'apparente falsità, giacché il dire, di una delle cose non buone, che è
buona o, di una delle cose buone, che non è buona, è falso. Talora poi, assunte alcune cose
aggiuntive, ne verrà una confutazione autentica. Per esemplo se qualcuno concede che è allo stesso
modo che una singola cosa e una pluralità di cose sono dette bianche, nude o cieche. Se infatti cieco
è ciò che non ha la vista ma è per natura atto ad averla, cieche saranno le cose che non hanno la
vista ma sono per natura atte ad averla. Dunque, quando dí due cose una abbia la vista e l'altra non
l'abbia, entrambe saranno o cieche o vedenti, il che è impossibile.
33
Aristotele di Stagira (384-22 a.C)
Protrettico
lingua originale: greco
edizione di riferimento: W.D. Ross Aristotelis fragmenta selecta, Oxford, 1955
tr. it. G. Giannantoni, in Opere (4 voll.) a cura di G. Giannantoni, Laterza, Bari-Roma, 1973
Frammento 2 [= 2 Walzer; 51 Rose]
1. ALEX. APHROD. In Aristot. top. [C.A.G. II 2] p. 149, 9-17.
Vi sono casi nei quali, qualunque interpretazione sia assunta, è possibile, sulla base di essa,
confutare l’asserzione di partenza. Ad esempio, se uno dicesse che non si deve filosofare. E poiché
per filosofare si intende sia il ricercare proprio questo, e cioè se si deve filosofare oppure no – come
disse Aristotele nel Protreptico –, sia il seguire una teoria filosofica, mostrando che l’una o l’altra
di queste cose è propria dell’uomo, in ogni caso avremo confutato l’asserzione di partenza. In
questo caso è possibile provare l’asserzione di partenza secondo l’una o l’altra delle due
considerazioni, ma negli esempi prima citati non è possibile né da tutte le considerazioni né o
dall’una o dall’altra, bensì soltanto da una o da più.
2. SCHOL. IN ARISTOT. An. pr. cod. Paris. 2064 f. 263 a.
Di tal genere è anche il ragionamento di Aristotele nel Protreptico: sia che si debba filosofare, sia
che non si debba filosofare, si deve filosofare; ma o si deve filosofare o non si deve filosofare:
dunque in ogni caso si deve filosofare.
3. OLYMPIOD. In Plat. Alcib. p. 144 Creuzer.
E Aristotele nel Protreptico disse che, sia che si debba filosofare, si deve filosofare; sia che non si
debba filosofare, si deve filosofare; ma allora in ogni caso si deve filosofare.
4. ELIAS In Porphyr. isag. [C.A.G. XVIII 1] p. 3, 17-23.
Oppure, come dice Aristotele nell’opera intitolata Protreptico, nella quale esorta i giovani alla
filosofia; dice dunque così: se si deve filosofare, si deve filosofare e se non si deve filosofare, si
deve filosofare: in ogni caso dunque si deve filosofare. Se infatti la filosofia esiste, siamo
certamente tenuti a filosofare, dal momento che essa esiste; se invece non esiste, anche in questo
caso siamo tenuti a cercare come mai la filosofia non esiste, e cercando facciamo filosofia, dal
momento che la ricerca è la causa e l’origine della filosofia.
5. DAVID Prol. philos. [C.A.G. XVIII 2] p. 9, 2-12.
E Aristotele in un suo scritto protreptico, in cui esorta i giovani alla filosofia, dice che sia nel caso
che non si debba filosofare, si deve filosofare, sia nel caso che si debba filosofare, si deve
filosofare, e che quindi in ogni caso si deve filosofare. Ciò vuol dire che sia nel caso in cui uno dica
che non vi è filosofia, fa uso di dimostrazioni con le quali nega la filosofia: e se fa uso di
dimostrazioni, è chiaro che filosofeggia (la filosofia è infatti madre delle dimostrazioni); sia nel
caso che uno dica che vi è filosofia, ancora una volta filosofeggia; si serve infatti di dimostrazioni,
con le quali fa vedere che essa esiste. In ogni caso dunque filosofeggia tanto colui che nega la
filosofia quanto colui che non la nega; l’uno e l’altro infatti fanno uso di dimostrazioni con le quali
rendere credibile quel che dicono; e se fanno uso di dimostrazioni è evidente che filosofeggiano: la
filosofia è infatti madre delle dimostrazioni.
6. LACTANT. Div. inst. III 16, 9.
L’Ortensio di Cicerone, disputando contro la filosofia, finisce per cadere in una conclusione del
tutto evidente, perché nel momento in cui asserisce che non si deve filosofare, non di meno,
35
all’apparenza, fa filosofia, perché è proprio del filosofo discutere cosa si deve e cosa non si deve
fare nella vita. Noi siamo immuni e liberi da questa accusa, noi che facciamo alta stima della
filosofia, perché è una scoperta della riflessione umana, difendiamo la sapienza, perché è tradizione
divina, e testimoniamo dell’opportunità che tutti ne diventino partecipi.
7. CLEM. ALEX. Strom. VI, XVIII 162, 5.
E a me sembra che sia ben fondato il ragionamento: se si deve filosofare, si deve filosofare. E
questo ne consegue: ma anche se non si deve filosofare; nessuno infatti potrebbe avere un’opinione
di qualcosa se non sa prima questo: dunque bisogna filosofare.
36
Aristotele di Stagira (384-22 a.C)
Metafisica
lingua originale: greco
edizione di riferimento: I. Bekker, Berlino, 1831 ecc.
tr. it. G. Reale, Vita e Pensiero, Milano, 1993
Libro IV (G), capitolo iii [Bekker pag. 1005a]
Dobbiamo dire, ora, se sia compito di un’unica scienza, oppure di scienze differenti, studiare quelli
che in matematica sono detti «assiomi» e anche la sostanza. Orbene, è evidente che l’indagine di
questi «assiomi» rientra nell’ambito di quell’unica scienza, cioè della scienza del filosofo. Infatti
essi valgono per tutti quanti gli esseri, e non sono proprietà peculiari di qualche genere particolare
di essere, ad esclusione degli altri. E tutti quanti si servono di questi assiomi, perché essi sono
propri dell’essere in quanto essere, e ogni genere di realtà è essere. Ciascuno, però, si serve di essi
nella misura in cui gli conviene, ossia nella misura in cui si estende il genere intorno al quale
vertono le sue dimostrazioni. Di conseguenza, poiché è evidente che gli assiomi appartengono a
tutte le cose in quanto tutte sono esseri (l’essere è, infatti, ciò che è comune a tutto), competerà a
colui che studia l’essere in quanto essere anche lo studio di questi assiomi.
Per questa ragione, nessuno di coloro che si limitano all’indagine di una parte dell’essere, si
preoccupa di dire qualcosa intorno agli assiomi, se siano veri o no: non il geometra e non il
matematico. Ne parlarono, invece, alcuni fisici, ma ne parlarono a ragione: infatti, essi ritenevano di
essere i soli a fare indagine di tutta quanta la realtà e dell’essere.
D’altra parte, poiché c’è qualcuno che è ancora al di sopra del fisico (infatti la natura è solamente
un genere dell’essere), ebbene, a costui che studia l’universale e la sostanza prima, competerà anche
lo studio degli assiomi. [pag. 1005b] La fisica è, sì, una sapienza, ma non è la prima sapienza.
Per quanto riguarda, poi, i tentativi, fatti da alcuni di coloro che trattano della verità, di
determinare a quale condizione si debba accogliere qualcosa come vero, bisogna dire che essi
nascono dall’ignoranza degli Analitici; perciò, occorre che i miei uditori abbiano una preliminare
conoscenza delle cose dette negli Analitici, e non che le ricerchino mentre ascoltano queste lezioni.
È evidente, dunque, che è compito del filosofo e di colui che specula intorno alla sostanza tutta e
alla natura di essa, far indagine anche intorno ai principi dei sillogismi. Colui che, in qualsiasi
genere di cose, possiede la conoscenza più elevata, deve essere in grado di dire quali sono i principi
più sicuri dell’oggetto di cui fa indagine; di conseguenza, anche colui che possiede la conoscenza
degli esseri io in quanto esseri, deve poter dire quali sono i principi più sicuri di tutti gli esseri.
Costui è il filosofo. E il principio più sicuro di tutti è quello intorno al quale è impossibile cadere in
errore: questo principio deve essere il principio più noto (infatti, tutti cadono in errore circa le cose
che non sono note) e deve essere un principio non ipotetico. Infatti, quel principio che di necessità
deve possedere colui che voglia conoscere qualsivoglia cosa non può essere una pura ipotesi, e ciò
che necessariamente deve conoscere chi voglia conoscere qualsivoglia cosa deve già essere
posseduto prima che si apprenda qualsiasi cosa. E evidente, dunque, che questo principio è il più
sicuro di tutti.
Dopo quanto si è detto, dobbiamo precisare quale esso sia. È impossibile che la stessa cosa, ad
un tempo, appartenga e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto (e si
aggiungano pure anche tutte le altre determinazioni che si possono aggiungere, al fine di evitare
difficoltà di indole dialettica ). E questo il più sicuro di tutti i princìpi: esso, infatti, possiede quei
caratteri sopra precisati. Infatti, è impossibile a chicchessia di credere che una stessa cosa sia e non
sia, come, secondo alcuni, avrebbe detto Eraclito. In effetti, non è necessario che uno ammetta
veramente tutto ciò che dice. E se non è possibile che i contrari sussistano insieme in un identico
37
soggetto (e si aggiungano a questa premessa le precisazioni solite), e se un’opinione che è in
contraddizione con un’altra è il contrario di questa, è evidente che è impossibile, ad un tempo, che
la stessa persona ammetta veramente che una stessa cosa esista e, anche, che non esista: infatti, chi
si ingannasse su questo punto, avrebbe ad un tempo opinioni contraddittorie. Pertanto, tutti coloro
che dimostrano qualcosa si rifanno a questa nozione ultima, perché essa, per sua natura, costituisce
il principio di tutti gli altri assiomi.
.
Capitolo iv
Ci sono alcuni, come abbiamo detto, i quali affermano che la stessa cosa può essere e non essere, e,
anche, che in questo modo si può pensare. [pag. 1006a] Ragionano in tale modo anche molti dei
filosofi naturalisti. Noi, invece, abbiamo stabilito che è impossibile che una cosa, nello stesso
tempo, sia e non sia; e, in base a questa impossibilità, abbiamo mostrato che questo è il più sicuro di
tutti i principi.
Ora, alcuni ritengono, per ignoranza, che anche questo principio debba essere dimostrato: infatti,
è ignoranza il non sapere di quali cose si debba ricercare una dimostrazione e di quali, invece, non
si debba ricercare. Infatti, in generale, è impossibile che ci sia dimostrazione di tutto: in tal caso si
procederebbe all’infinito, e in questo modo, per conseguenza, non ci sarebbe affatto dimostrazione.
Se, dunque, di alcune cose non si deve ricercare una dimostrazione, io essi non potrebbero, certo,
indicare altro principio che più di questo non abbia bisogno di dimostrazione.
Tuttavia, anche per questo principio, si può dimostrare l’impossibilità in parola, per via dí
confutazione: a patto, però, che l’avversario dica qualcosa. Se, invece, l’avversario non dice nulla,
allora è ridicolo cercare una argomentazione da opporre contro chi non dice nulla, in quanto,
appunto, non dice nulla: costui, in quanto tale, sarebbe simile ad un vegetale. E la differenza fra la
dimostrazione per via di confutazione e la dimostrazione vera e propria consiste in questo: che, se
uno volesse dimostrare, cadrebbe palesemente in una petizione di principio; invece, se causa di
questo fosse un altro, allora si tratterebbe di confutazione e non di dimostrazione.
Il punto di partenza, in tutti questi casi, non consiste nell’esigere che l’avversario dica che
qualcosa o è, oppure che non è (egli, infatti, potrebbe subito obiettare che questo è già un ammettere
ciò che si vuol provare) ma che dica qualcosa che abbia un significato e per lui e per gli altri; e
questo è pur necessario, se egli intende dire qualcosa. Se non facesse questo, costui non potrebbe in
alcun modo discorrere, né con sé medesimo né con altri; se, invece, l’avversario concede questo,
allora sarà possibile una dimostrazione. Infatti, in tal caso, ci sarà già qualcosa di determinato. E
responsabile della petizione di principio non sarà colui che dimostra, ma colui che provoca la
dimostrazione: e in effetti, proprio per distruggere il ragionamento, quegli si avvale di un
ragionamento.
Inoltre, chi ha concesso questo, ha concesso che c’è qualcosa di vero anche indipendentemente
dalla dimostrazione.
38
Crisippo da Soli (c.280-207 a.C)
Frammenti logici
lingue originali: greco e latino
ed. standard: Stoicorum Veterum Fragmenta (3 voll.) a cura di H. von Arnim, 1903-5
tr. it. R. Radice, Rusconi, Milano, 1998
La soluzione dei sofismi
Vol. II, fr. 270 [Plutarco, Le contraddizioni degli stoici, 1036c] — Sicché contraddice se stesso ...
quando consiglia gli altri di guardarsi dalle argomentazioni contrarie, in quanto fuorvianti rispetto
alla comprensione; eppure lui stesso si impegna in modo particolare a produrre argomenti contro la
comprensione (katalepsin) di ciò che è certo. Del resto è proprio questo il pericolo da temere, come
chiaramente dimostra nel quarto libro de Le vite, dove si legge: «Non bisogna neppure proporre gli
argomenti contrari, o che si applicano alle tesi contrarie rendendole credibili, così come capita,
perché, sviati da essi, non ci si allontani dalla salda comprensione; difatti la ricezione delle
soluzioni potrebbe non risultare adeguata, e cogliere il vero in modo precario. D'altra parte, coloro
che si attengono al sapere comune nella conoscenza sensibile e in quella che da essa deriva sono
pronti a lasciare tali cognizioni, disorientati dalle aporie dei Megarici e da altre ancor più numerose
e pericolose».
271 [Plutarco, Le contraddizioni degli stoici, 1036f] — E che, dobbiamo sentircelo dire da Crisippo
[che le aporie Megariche sono apprezzabili]? Guarda un po' che cosa scrive nel suo Uso del
ragionamento: «Qualcosa di simile è capitato alla dottrina di Stilpone e Menedemo: hanno
guadagnato una gran fama per la loro sapiente tecnica, ma ora il loro argomentare gli si è rivolto
contro e l'uno patisce l'accusa di rozzezza, l'altro di capziosità».
272 [Galeno, Sui peccati dell’anima, 3] — È fatale che chi si trovi d'improvviso chiamato a
giudicare un'argomentazione non riesca a riconoscere, e quindi a discriminare, il vero e il falso. La
prova di ciò la forniscono i cosiddetti sofismi, che sono ragionamenti falsi, ma così ben
confezionati da sembrare veri. La loro falsità vien fuori dalla conclusione, che non è vera. Non c'è
dubbio che in generale le argomentazioni false o hanno una delle premesse vere, o hanno un difetto
nell'inferenza della conclusione, tuttavia questo non salta all'occhio con facilità in tali sofismi, ed è
difficile da cogliersi per chi non ha dimestichezza con la logica.
273 [Scholiasta anonimo, in Rhetori græci, Walzer, VII, p. 383] — Dunque, gli Stoici hanno un
argomento che prende il nome di diallele, che è uno degli anapodittici, ad esempio: ‘Dove ha casa
Teone, l'ha anche Dione, e dove Dione anche Teone’. Un siffatto argomento — sto parlando del
diallele — è anapodittico, e nessun altro argomento lo delimita, in quanto i significati da esso
rappresentati si costituiscono a vicenda.
274 [Diogene Laerzio, Vite, VII, 82] — Vi sono alcuni ragionamenti aporetici: il Velato, il Celato,
îl Sorite, il Cornuto e il Nessuno. Ecco un esempio di Velato: «Non ‘due sono pochi’, non ‘tre sono
pochi’, e se si nega questi, allora anche non ‘quattro sono pochi’, e così via fino a dieci. Ma due
sono pochi, allora anche dieci sono pochi». Il Nessuno è un ragionamento composto che consiste di
una proposizione indefinita, di una definita, ed è provvisto di una premessa minore e di una
conclusione. Eccone un esempio: ‘Se uno si trova qui, questi non si trova a Rodi; ma qualcuno è
qui, dunque qualcuno non è a Rodi’.
275 [Sesto Empirico, Schizzi Pirroniani, II, 253] – Se i dogmatici che seguono Crisippo sostengono
che nella formulazione di un Sorite ci si deve arrestare e bisogna sospendere il giudizio anche se il
39
ragionamento fila, per evitare di cadere nell'assurdo, quanto più dovrà andar bene a noi che siamo
scettici, e sensibili alle assurdità, il non essere faciloni nel porre le premesse, ma sospendere il
giudizio su ciascuna fino a quando l'esposizione dell'argomento non sia completa?
276 [Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 416] – Poiché nel Sorite si aggiunge ad una
rappresentazione catalettica perfetta una rappresentazione acatalettica (= non comprensiva) allo
stato primitivo, e quindi scarsamente distinta, i seguaci di Crisippo sostengono che nel caso una
rappresentazione si distingua a malapena dall'altra il saggio deve fermarsi e prendere tempo; mentre
in presenza di rappresentazioni più definite, dovrà concedere il suo assenso a quella delle due che
gli sembra più vera.
277 [Cicerone, Accademici primi, II, 93]– Crisippo nelle interrogazioni graduali – ad esempio, alla
domanda ‘tre sono pochi o molti?’ – suggerisce di prendere tempo prima di arrivare a ‘molti’ (è
quell'atto che gli Stoici esprimono col verbo hesuchazein). «Per quanto mi riguarda – dice Carneade
– non solo puoi fermarti un attimo, ma anche russare».
278 [Simplicio, Commento alle Categorie di Aristotele, 26E] – Vale la pena di fare qualche
indagine per confutare quelli che sostanzializzano sia le specie che i generi, se di essi sí vorrà
affermare che sono ‘queste cose particolari’. E del resto, anche Crisippo dubita se dell'idea possa
dirsi che è un qualcosa di determinato. Nello stesso tempo, però, bisogna apprendere il trattamento
che abitualmente gli Stoici riservano alle qualità generiche, come trattano i casi, e in qual modo
definiscono gli universali ‘non-qualcosa’, e come – certo per ignoranza del fatto che non ogni
sostanza significa un qualcosa di definito – si generi il sofisma del ‘non qualcuno’ (= ‘Nessuno’), il
quale, peraltro, è un gioco di parole –: ‘Se uno è ad Atene, non è a Megara...’. Ma qui ‘uomo’ non è
un essere particolare, perché l'essere particolare non è universale, come invece abbiamo assunto
nell'argomentazione (del resto è proprio per tal motivo che esso ha preso il nome di ‘non
qualcuno’). Lo stesso dicasi per il seguente sofisma: ‘Quello che io sono, tu non sei; ma io sono
uomo, dunque tu non lo sei’. E anche in questo caso ‘io’ e ‘tu’ si dice di esseri individuali, mentre
‘uomo’ di nessuna realtà particolare. Il fraintendimento è nato quando Crisippo ha usato il termine
‘non qualcuno’ come fosse ‘un particolare qualcuno’.
279 [Diogene Laerzio, Vite, VII, 186] – Il nostro filosofo faceva ragionamenti di questo genere:
‘Chi svela i segreti misteri ai non iniziati è un empio; ma il sacerdote svela i misteri; dunque il
sacerdote è un empio’. Eccone un altro: ‘Ciò che non si trova nella città non si trova neppure in
casa; ma non c'è un pozzo nella città, dunque non c'è neppure in casa’. E un altro ancora: ‘C'è una
testa, e quella tu non l'hai; vi è quindi una testa che tu non hai; pertanto non hai testa’. Ancora uno:
‘Se uno è a Megara, non è ad Atene; ma c'è un uomo a Megara, dunque non c'è uomo ad Atene’.
Inoltre: ‘Se dici qualcosa, questo passa attraverso la tua bocca, ma tu dici carro; dunque un carro
passa attraverso la tua bocca’. E infine: ‘Ciò che non hai perso, questo l'hai; ma tu non hai perso le
corna, dunque hai le corna’. Qualcuno attribuisce quest'ultimo sofisma ad Eubulide.
280 [Epitteto, Dissertazione, II, 17,34] – Voglio proprio sapere che cosa dice Crisippo nelle sue
opere sul Mentitore.
281 [San Girolamo, Epistole a Oceano, 69] – ... gli venne subito in mente il sofisma crisippeo: ‘Se
menti, e dici di mentire secondo verità, menti’.
282 [Cicerone, Accademici primi, II, 96] – Come giudichi questo genere di conclusioni? ‘Se dici
che ora c'è luce, e dici la verità, allora c'è luce’; ma tu effettivamente dici che c'è luce, e dici il vero,
dunque c'è luce’. Certamente voi accettate questo genere di ragionamento e ne ritenete corretta la
conclusione, tanto è vero che nel vostro programma di educazione è la prima argomentazione che
40
insegnate. Però, sarete costretti ad approvare qualsiasi cosa concluda nel modo di questa
argomentazione, altrimenti questa vostra dottrina non vale nulla. Allora vedi un po' se ti riesce di
accettare questo ragionamento: ‘Se dici di mentire, e dici il vero, menti; ma tu dici di mentire, e dici
il vero; dunque menti’. Chi potrebbe non accettare una tale inferenza, una volta che hai accettato
quella di prima che è dello stesso tipo? Crisippo ha posto tali problemi, ma non ha saputo risolverli.
E come se la sarebbe cavata di fronte a quest'altro ragionamento: ‘Se c'è luce, c'è luce; ma c'è luce,
dunque c'è luce’. Senza dubbio si sarebbe arreso. È la stessa logica della coerenza che ti costringe a
concedere la seguente, una volta concessa la precedente. E allora che differenza c'è fra questa
conclusione e quella di prima?
283[1] [Epitteto, Dissertazione, II, 19,1] – Risulta che l'argomento Dominatore sia stato analizzato
a partire dai seguenti principi. C'è in generale un rapporto di contraddizione fra queste tre
proposizioni: ‘ciò che effettivamente si è realizzato nel passato è necessario’, ‘l'impossibile non
segue al possibile’, ‘ciò che è possibile o è vero o lo sarà’. Avendo scoperto una tale
contraddizione, si servì della credibilità delle prime due affermazioni per concludere: ‘Non esiste
alcun possibile che non sia o sarà vero’. Per altro, qualcuno potrebbe assumere queste fra le coppie
di proposizioni: ‘si dà qualcosa di possibile, che non è né sarà vero’; ‘l'impossibile non segue dal
possibile’; ‘non ogni cosa passata e vera è anche necessaria’. Così, a quanto risulta, hanno pensato i
discepoli di Cleante, seguiti da Antipatro. Crisippo invece scelse le altre due: ‘è possibile ciò che
non è e non sarà vero’; ‘tutto ciò che veramente è accaduto è necessario’; e inoltre: ‘L'impossibile
deriva dal possibile’. In ogni caso ammettere tutt'e tre le proposizioni insieme non è lecito, perché
fra loro c'è una contraddizione di carattere generale.
283[2] [Epitteto, Dissertazione, II, 19,9] – Ne ha scritto in modo eccellente Crisippo nel primo libro
de' I possibili, ma anche Cleante, in modo specifico, e Archedemo. Antipatro, poi, ne ha trattato non
solo ne' I possibili, ma anche in maniera particolare nei libri su L'argomento dominatore.
284 [Cicerone, Epistole alla famiglia, IX, 4] – Ti informo che sulla questione dei possibili io la
penso come Diodoro; per cui, se tu verrai, sappi bene che è fra gli eventi necessari il fatto che tu
venga, e se invece non verrai, sappi, che è fra gli impossibili. Ora dimmi quale posizione ti soddisfa
di più, se quella di Crisippo, o quest'altra che era così indigesta per il nostro Diodoro. Di ciò però
tratteremo quando avremo del tempo libero: del resto anche questo, stando a Crisippo, rientra nel
novero delle cose possibili.
285 [Cicerone, Accademici primi, II, 143] – Se pure i dialettici pongono questo punto a fondamento
del loro insegnamento, il disaccordo regna sovrano perfino sul modo in cui si deve giudicare, in
termini di vero o falso, questo nesso sillogistico: ‘Se è giorno c'è luce’. In un modo la pensa
Diodoro, in un altro Filone, in un altro ancora Crisippo. E che, non è forse vero che Crisippo
dissente da Cleante, il suo maestro, su innumerevoli questioni? E poi, due principi della dialettica,
Antipatro e Archedemo, insuperabili nel formulare ipotesi, non sono forse in disaccordo su
un'infinità di punti?
286 [Siriano, Scolio su Hermogene, II, 42] – Ecco l'argomento, aporetico quanto al predicato, che
gli Stoici chiamano ‘del coccodrillo’: Euatlo ha promesso un compenso al sofista Protagora, alla sua
prima vittoria in una causa. Quando ormai aveva imparato <la tecnica>, ma non aveva ancora osato
parlare <in tribunale>, Protagora chiese i soldi del suo compenso. Ma quello in risposta disse: «Se
avessi vinto non sarebbe giusto che io pagassi secondo quanto pattuito; se avessi perso, ugualmente,
non dovrei pagare, perché non sarei ancora esperto».
287 [Luciano di Samosata, I filosofi all’asta, 22]
Crisippo: Hai un bambino?
Acquirente: Che cosa?
41
Crisippo: Se un coccodrillo lo afferrasse cogliendolo mentre vaga nei pressi di un fiume, e poi
promettesse di restituertelo, a condizione che tu gli dica quali erano le sue vere intenzioni nel
restituire il fanciullo, quali pensieri gli attribuiresti? [...] Te ne racconterò di ancor più belli: [...] il
Mentitore, il Dominatore, e soprattuttto l'Elettra e il Velato... Elettra è quella che sapeva e insieme
non sapeva la stessa cosa. Quando Oreste le stava vicino e lei non l'aveva riconosciuto, sapeva certo
che Oreste era suo fratello, ma non sapeva che quello era proprio Oreste. E il Velato? Senti questo
argomento che è ancor più straordinario. Rispondimi: conosci tuo padre?
Acquirente: Sì
Crisippo: Ebbene, se io ti presentassi una figura velata e ti chiedessi: ‘Lo conosci?’, che cosa mi
risponderesti?
Acquirente: Naturalmente che non lo conosco
Crisippo: Ma questo era proprio tuo padre, sicché se tu non lo riconosci, vuol dire che non conosci
tuo padre.
42
Diogene Laerzio (prima metà III sec. d.C.)
Le vite dei filosofi
lingua originale: greco
edizione di riferimento: H. Frobenius, Basilea, 1533
tr. it. M. Gigante, TEA, Milano, 1991
Libro VII (Vita di Zenone di Cizio, fondatore dello stoicismo)
[36] Dei molti discepoli di Zenone uno dei più famosi fu Perseo figlio di Demetrio nato a Cizio,
che secondo alcuni fu alunno ed amico, secondo altri uno dei domestici mandatigli da Antigono per
il servizio bibliografico: egli era stato istruttore di Alcioneo, figlio di Antigono. Una volta Antigono
volle metterlo alla prova e gli fece annunziare la falsa notizia che i suoi campi erano stati
saccheggiati dai nemici. Perseo divenne scuro in volto e Antigono: «Vedi? La ricchezza non è cosa
indifferente».
Gli si attribuiscono le seguenti opere: Del regno, La costituzione degli Spartani, Delle nozze,
Dell’empietà, Tieste, Degli amori, Protrettici, Diatribe <in quattro libri>, Aneddoti, in quattro libri;
Commentari, Sulle « Leggi» di Platone, in sette libri.
[37] Altri discepoli illustri furono: Aristone figlio di Milziade, nato a Chio, che introdusse la
dottrina dell’indifferenza. Erillo di Calcedonia che definì fine la scienza. Dionisio detto l’Apostata
che si fece sostenitore della teoria edonistica, perché per la sua grave malattia agli occhi non ebbe
più la forza di affermare che il dolore è cosa indifferente. Dionisio era nato ad Eraclea. Sfro del
Bosforo. Cleante figlio di Fania nato ad Asso che fu successore nello scolarcato. Zenone era solito
paragonarlo a quelle tavolette spalmate di dura cera su cui è faticoso scrivere, ma che conservano a
lungo quel che v’è stato scritto. Sfero fu poi alunno di Cleante, dopo la morte di Zenone; e di lui
parleremo nella seguente Vita di Cleante.
[38] Ippoboto cataloga fra i suoi alunni anche Filonide di Tebe Callippo di Corinto, Posidonio di
Alessandria, Atenodoro di Soli, Zenone di Sidone.
In questa Vita di Zenone mi è parso opportuno dare un resoconto generale di tutta insieme la
dottrina stoica, per il fatto che Zenone fu il fondatore della scuola stoica. Abbiamo già dato la lista
dei suoi numerosi scritti, in cui parlò come nessun altro stoico. Le opinioni comuni a tutti gli Stoici
sono queste: esponiamole sommariamente, attuando il medesimo solito criterio che abbiamo
applicato agli altri filosofi. Gli Stoici dividono la filosofia in tre parti: Fisica, Etica, Logica.
[39] Questa distinzione fece per primo Zenone di Cizio nel libro Sulla Logica, poi Crisippo nel
primo libro Sulla Logica e nel primo libro Sulla Fisica e Apollodoro l’Efelo nel primo libro
dell’Introduzione alla dottrina ed Eudromo nell’Esposizione dei principi elementari di Etica e
Diogene di Babilonia e Posidonio.
Queste parti Apollodoro chiama luoghi, Crisippo ed Eudromo specie, altri chiamano generi.
[40] Gli Stoici paragonano la filosofia ad un essere vivente: alle ossa ed ai nervi corrisponde la
Logica, alle parti carnose l’Etica, all’anima la Fisica. Oppure la paragonano ad un uovo: la parte
esterna, il guscio (ektos), è la Logica, la parte seguente, l’albume, è l’Etica, la parte più interna
(esotatos), il tuorlo, è la Fisica. Oppure la paragonano ad un fertile campo: la siepe esterna è la
Logica, il frutto è l’Etica, la terra o gli alberi la Fisica. Oppure la paragonano ad una città ben
munita di mura e razionalmente amministrata. E nessuna parte è separata dall’altra, come pur
dicono alcuni Stoici, ma sono tutte piuttosto strettamente congiunte fra loro. Anche l’insegnamento
veniva trasmesso congiuntamente e non separatamente. Altri danno il primo posto alla Logica, il
secondo alla Fisica, il terzo all’Etica: tra costoro è Zenone nel libro Sulla Logica, oltre a Crisippo,
Archedemo ed Eudromo.
[41] Diogene di Tolemaide a sua volta comincia dall’Etica, Apollodoro pone al secondo posto
l’Etica, Panezio e Posidonio cominciano dalla Fisica, come afferma Fania, discepolo di Posidono,
nel primo libro delle Lezioni di Posidonio. Cleante poi distingue sei parti: Dialettica, Retorica,
43
Etica, Politica, Fisica, Teologia. Altri riferiscono questa partizione non alla Logica, ma alla stessa
filosofia. Così per esempio Zenone di Tarso. Alcuni distinguono la parte logica del sistema in due
scienze: Retorica e Dialettica; altri le attribuiscono l’ufficio di definire e di fornire canoni e criteri;
altri tuttavia le eliminano l’officio della definizione.
[42] Si servono dei canoni e criteri per trovare la verità perché in essa stabiliscono le regole per
la distinzione delle rappresentazioni, ed analogamente si servono delle definizioni per riconoscere la
verità, perché la realtà si apprende per mezzo di concetti. Definiscono la Retorica la scienza di dire
bene su argomenti pianamente ed unitariamente esposti, e la Dialettica la scienza di discutere
rettamente su argomenti per domanda e risposta. Perciò danno anche quest’altra definizione: la
scienza di ciò che è vero e di ciò che è falso, e di ciò che non è né vero né falso.
Dividono la Retorica in tre parti: deliberativa, forense, encomiastica
[43] La Retorica è costituita dai seguenti elementi: invenzione degli argomenti, loro espressione
in parole, loro disposizione e viva rappresentazione. Costituiscono il discorso retorico le seguenti
parti: il proemio, la narrazione dei fatti, la confutazione della parte avversa e l’epilogo.
La Dialettica abbraccia due campi: l’uno delle cose significate e l’altro dell’espressione o parola.
Il campo delle cose significate comprende da una parte la dottrina della loro viva
rappresentazione e dall’altra la dottrina degli elementi che la costituiscono, proposizioni enunciate
sia indipendenti sia semplici predicati, e termini simili attivi o passivi, generi e specie, e così pure
parole, tropi, sillogismi e sofismi determinati dal linguaggio o dall’argomento.
[44] Le varie specie di sofismi sono: il mentitore, il veritiero, il negante, il sorite e simili a
questo, il mancante, l’insolubile, il concludente, il velato, il cornuto, l’utide (il nessuno), il
mietitore.
Abbiamo or ora detto che l’altro particolare campo della Dialettica riguarda la dottrina della
lingua stessa. Questa dottrina si occupa della parola rappresentata in lettere, studia quali siano le
parti del discorso e tratta del solecismo, del barbarismo, della dizione poetica, delle anfibolie,
dell’eufonia e della musica e, secondo alcuni, anche delle definizioni, delle divisioni e degli stili.
[45] Gli Stoici affermano che è straordinariamente utile lo studio della teoria dei sillogismi.
Questa insegna il metodo dimostrativo, che molto contribuisce alla formulazione corretta dei
giudizi, alla loro disposizione e al loro ricordo, ed insegna altresì a possedere con salda sicurezza le
cognizioni scientifiche.
Il ragionamento stesso consiste di premesse e conclusione: il sillogismo è un ragionamento
conclusivo fondato su questi elementi. La dimostrazione è un ragionamento che per mezzo di
nozioni più chiare spiega nozioni meno chiare su ogni argomento.
La rappresentazione è un’impressione nell’anima: è qui adottato in senso traslato un termine
proprio in quanto propriamente l’impressione è l’effetto delle impronte che l’anello col sigillo
imprime nella cera.
[46] Di rappresentazioni ve ne sono due: l’una (comprensiva) che coglie immediatamente la
realtà, l’altra (non comprensiva) che coglie la realtà con scarsa o nessuna distinzione. La prima, che
essi definiscono criterio della realtà, è determinata dall’esistente , conforme all’esistente stesso ed è
impressa e stampata nell’anima. L’altra non è determinata dall’esistente oppure se procede
dall’esistente non è determinata conforme all’esistente stesso: non è quindi né chiara né distinta.
Essi dicono che la Dialettica stessa è necessaria ed è una virtù che abbraccia altre virtù speciali o
particolari: la tempestività ci insegna con scientifica sicurezza il momento in cui dobbiamo dare o
negare il nostro assenso; la cautela è la forza della ragione contro la semplice verisimiglianza, così
da non cedere ad essa; [47] l’inconfutabilità è il vigore nel ragionamento così da non lasciarci trarre
da esso al contrario; la serietà o assenza di leggerezza è la capacità di riportare le rappresentazioni
alla retta ragione.
La stessa scienza essi definiscono o una comprensione sicura (apprensione) oppure una facoltà di
ricevere le rappresentazioni, che non può essere scossa dalla ragione. Solo con lo studio della
Dialettica il sapiente potrà ragionare senza cadere in errore: infatti per mezzo della Dialettica si
44
distingue il vero dal falso e si discerne ciò che è persuasivo da ciò che è espresso ambiguamente.
Inoltre senza la Dialettica non è possibile interrogare e rispondere metodicamente.
[48] La precipitosa temerità nelle affermazioni estende il suo effetto anche su ciò che accade
nella realtà, sì che coloro che non hanno rappresentazioni bene disciplinate cadono nel disordine e
nell’irriflessione. Non altrimenti il sapiente apparirà acuto e perspicace e soprattutto abile nelle
argomentazioni. Ché è proprio del sapiente rettamente parlare e rettamente pensare, discutere le
questioni proposte e rispondere alle domande: tutti questi requisiti possiede chi è scaltrito nella
Dialettica.
Questi sommariamente esposti sono i princìpi fondamentali della logica stoica.
45
Sant’Anselmo (1033-1109)
Proslogion (1077-8)
lingua originale. latino
edizione di riferimento: F.S. Schmitt, Seckau, 1938
tr. it. I. Sciuto, Rusconi, Milano, 2001
Proemio
Dopo aver pubblicato, per le pressanti preghiere di alcuni confratelli, un opuscolo come esempio di
meditazione sulla razionalità della fede, mettendomi nella posizione di chi, ragionando
silenziosamente dentro di sé, ricerca ciò che non conosce, considerando che quell’opuscolo era
costruito con la concatenazione di molti argomenti, ho cominciato a chiedermi se per caso fosse
possibile trovare un argomento unico, tale che per essere dimostrato non avesse bisogno di altro, ma
solo di se stesse e che fosse da solo sufficiente a stabilire che Dio esiste veramente, che è il sommo
bene di nessun altro bisognoso e di cui tutte le cose hanno bisogno per essere e per ben-essere, e
tutto ciò che crediamo della divina sostanza.
Rivolgevo spesso e con impegno il mio pensiero su questo punto e talvolta mi sembrava di poter
già afferrare quanto cercavo, talvolta invece sfuggiva del tutto all’acume della mia mente; alla fine,
privo di speranza, volli cessare la ricerca di una cosa che sembrava impossibile trovare. Ma quando
volevo escludere completamente da me quel pensiero, affinché non impedisse alla mia mente,
occupandola inutilmente, di impegnarsi in altri pensieri nei quali potessi fare progressi, proprio
allora quel pensiero cominciò sempre più ad imporsi, con una certa importunità, a me che non lo
volevo e lo respingevo. Mentre dunque, un giorno, fortemente mi affaticavo nel resistere alla sua
insistenza, nel conflitto stesso dei pensieri mi si presentò ciò di cui avevo disperato, sì da farmi
applicare con passione a quel pensiero che mi ero preoccupato di respingere.
Ritenendo poi che quanto gioivo di avere trovato, se fosse stato scritto, sarebbe piaciuto a
qualche lettore, su questo e su altri argomenti ho scritto il seguente opuscolo, mettendomi nella
posizione di chi tenta di innalzare la sua mente a contemplare Dio e cerca di comprendere ciò che
crede. E poiché giudicavo che né questo opuscolo né quello che sopra ho ricordato fossero degni del
nome di libro o di portare il nome dell’autore, ma pensavo tuttavia che non si dovessero pubblicare
senza un titolo qualsiasi col quale invitassero alla lettura, in qualche modo, colui nelle cui mani
fossero pervenuti, diedi a ciascuno il suo titolo, chiamando il primo Esempio di meditazione sulla
ragione della fede e il successivo La fede che cerca l’intelletto.
Ma quando l’uno e l’altro erano già stati trascritti da molti con questi titoli, molti mi
sollecitarono (specialmente il reverendo arcivescovo di Lione, di nome Ugo, legato apostolico in
Gallia, che me l’ordinò con autorità apostolica») a scrivere il mio nome su di essi. Per fare ciò più
adeguatamente, ho dunque intitolato il primo opuscolo Monologion, cioè soliloquio, e questo invece
Proslogion, cioè colloquio.
Parte prima DIMOSTRAZIONE DELL’ESISTENZA DI DIO
-–ooOoo–2. Dio esiste veramente.
Dunque, o Signore, tu che dai l’intelligenza alla fede, concedimi di comprendere, per quanto sai che
mi possa giovare, che tu esisti come crediamo e che sei quello che noi crediamo.
E davvero noi crediamo che tu sia qualcosa di cui non si possa pensare nulla di più grande. O
forse non vi è una tale natura, perché «disse l’insipiente in cuor suo: Dio non esiste»? Ma
certamente quel medesimo insipiente, quando ascolta ciò che dico, cioè «qualcosa di cui non si può
pensare nulla di più grande», comprende ciò che ode; e ciò che comprende è nel suo intelletto,
anche se egli non intende che quella cosa esista. Altro, infatti, è che una cosa sia nell’intelletto, e
altro è intendere che quella cosa esista. Quando il pittore, infatti, prima pensa a ciò che sta per fare,
ha certamente nell’intelletto ciò che ancora non ha fatto, ma non intende ancora che questo esista.
47
Quando invece lo ha già dipinto, non solo ha nell’intelletto ciò che ha già fatto, ma intende anche
che esso esista. Anche l’insipiente, dunque, deve convenire che, almeno nell’intelletto, vi sia
qualcosa di cui non si può pensare nulla di più grande, perché quando sente questa espressione la
intende, e tutto ciò che si intende è nell’intelletto.
Ma, certamente, ciò di cui non si può pensare qualcosa di più grande non può essere nel solo
intelletto. Se infatti è almeno nel solo intelletto, si può pensare che esista anche nella realtà, il che è
maggiore. Se dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore è nel solo intelletto, quello stesso di
cui non si può pensare il maggiore è ciò di cui si può pensare il maggiore. Ma evidentemente questo
non può essere. Dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste, senza dubbio, sia
nell’intelletto sia nella realtà.
3. Non si può pensare che Dio non esista.
Tutto ciò è talmente vero, che non si può neppure pensare che Dio non esista. Infatti si può pensare
che vi sia qualcosa di cui non si possa pensare che non esiste; e questo è maggiore di ciò che si può
pensare non esistente. Quindi, se ciò di cui non si può pensare il maggiore può essere pensato non
esistente, quello stesso di cui non si può pensare il maggiore non è ciò di cui non si può pensare il
maggiore; ma questo è contraddittorion. Dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste
così veramente che non si può neppure pensare non esistente.
E questo sei tu, Signore Dio nostro. Dunque tu esisti così veramente, Signore Dio mio, che non
puoi neppure essere pensato non esistente. E giustamente. Se infatti una qualche mente potesse
pensare qualcosa migliore di te, la creatura si eleverebbe al di sopra del Creatore e sarebbe giudice
del Creatore; il che sarebbe grandemente assurdo. In verità, di tutto ciò che è, all’infuori di te solo,
si può pensare che non sia. Tu solo dunque hai l’essere nel modo più vero, e perciò massimo,
rispetto a tutte le cose, perché qualsiasi altra cosa non è in modo così vero e, quindi, ha un essere
minore. Perché dunque «l’insipiente ha detto in cuor suo: Dio non esiste», quando è così evidente
ad una mente razionale che tu sei più di tutte le cose? Per quale motivo, se non perché è stolto e
insipiente?
4. In che modo l’insipiente ha detto in cuor suo ciò che non si può pensare.
Ma in quale modo l’insipiente ha detto in cuor suo ciò che non ha potuto pensare, o in che modo
non ha potuto pensare ciò che ha detto in cuor suo, dato che è la stessa cosa dire nel cuore e
pensare? Se poi veramente, anzi poiché veramente sia lo pensò perché lo disse in cuor suo, sia non
lo disse in cuor suo perché non poteva pensarlo, non in un modo soltanto si dice nel cuore o si
pensa qualcosa. In un modo, infatti, una cosa è pensata quando si pensa la parola che la significa; in
un altro modo, quando si comprende ciò che la cosa è. Nel primo modo, pertanto, si può pensare
che Dio non sia, ma nel secondo assolutamente no. Perciò nessuno, il quale comprenda ciò che Dio
è, può pensare che Dio non esista, sebbene dica in cuor suo queste parole, non dando loro alcun
significato o dandogliene uno estraneo. Dio, infatti, è ciò di cui non si può pensare il maggiore. Chi
comprende bene questo, comprende certamente che egli esiste in modo tale che neppure nel
pensiero può non essere. Chi dunque comprende che Dio è così, non può pensare che egli non
esista.
Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio perché ciò che prima ho creduto per un tuo dono, ora per
la tua illuminazione lo comprendo in modo tale che, se non volessi credere che tu esisti, non potrei
non comprenderlo.
48
Pietro Ispano
(1205c-1277 (?))
Trattato di logica
lingua originale: latino
ed. crit., L.M. de Rijk, Van Gorcum, Assen, 1972
tr. it. A. Ponzio, Bompiani, Milano, 2004
Libro VII (Le fallacie)
Conseguenza
150. Le conseguenze sono semplici e composte. Semplice è la conseguenza come: ‘se c’è l’uomo,
c’è l’animale’, o ‘se è adultero, è elegante o è uno che va in giro la notte’; e così per altri casi.
Invece complessa è quella che concerne le contrapposizioni. E può sussistere nei contrari o nei
contraddittori, come è detto nel secondo libro dei Topici.
151. E tale conseguenza complessa, o relativa alle contrapposizioni, è di due specie, poiché una è
nello stesso modo, l’altra inversamente.
152. Ora, la conseguenza nello stesso modo si ha quando dall’opposto dell’antecedente consegue
l’opposto del conseguente. Come ‘se c’è la giustizia, c’è la virtù, dunque, se c’è l’ingiustizia, c’è il
vizio’: qui infatti dall’opposto dell’antecedente, cioè ‘ingiustizia’, consegue l’opposto del
conseguente, cioè ‘vizio’ . La conseguenza nello stesso modo, infatti, si effettua con quasi tutti i
contrari.
153. La conseguenza che avviene inversamente si ha quando dall’opposto del conseguente deriva
l’opposto dell’antecedente. Come ‘se c’è l’uomo, c’è l’animale’; dunque ‘se c’è il non-animale, c’è
il non-uomo’; qui infatti dall’opposto del conseguente, cioè ‘non-animale’ , deriva l’opposto
dell’antecedente, cioè ‘non-uomo’ . Ora, nei contraddittori, non può esserci conseguenza se non
inversamente.
154. Ancora. Due sono le specie della conseguenza semplice. Una è, infatti, in ragione del modo di
configurarsi dei luoghi. Come ‘se è uomo, è animale’; qui infatti vi è il configurarsi in base alla
specie. L’altra è, invece, in ragione delle circostanze; a quest’ultima si rivolge l’attenzione nella
retorica.
155. E così come si impiega ‘conseguenza’ in generale in riferimento a tutte queste conseguenze, si
impiega ‘conseguente’ in generale nel senso che un luogo è detto sofistico in considerazione del
conseguente. E questo luogo è detto in considerazione del conseguente e non dell’antecedente,
poiché il conseguente diventa qui principio dell’inferire in base a ciò che il conseguente pone
nell’antecedente, ma dall’inferente e non dall’inferito riceve il nome il luogo sofistico, come pure
quello dialettico.
Cause e modi di questa fallacia
156. Invece il principio motore della fallacia del conseguente è la compatibilità della conseguenza
diretta con quella che ne è la conversione. Invece, il principio del difetto è la falsità di ciò che
deriva per conversione. E a questa duplice causa accenna Aristotele quando dice "poiché si crede
che la conseguenza sia convertibile"2, mentre non lo è. Quando dice, infatti, ‘conseguenza’ sta
2
Aristotele,
Confutazioni
sofistiche,
v,
167b1‐2
(nella
dispensa)
49
accennando alla conseguenza diretta, che è il principio motore del credere a quella che ne è la
conversione; quando invece dice ‘sia convertibile’ si riferisce alla conseguenza che è la conversione
della conseguenza diretta. E questa è una falsa conseguenza, ed è il principio del difetto.
Inoltre Aristotele indica tre modi del conseguente.
Primo modo
157. Il primo modo consiste nel convertire la conseguenza stabilita in base alle configurazioni dei
luoghi. Come
‘se è uomo è animale
dunque se è animale è uomo’;
e avviene in base all’impiego del conseguente, quindi c’è qui la fallacia del conseguente. Alla stessa
maniera qui
‘se non è animale, non è uomo
dunque se non è uomo, non è animale’;
e alla stessa maniera avviene in base all’impiego del conseguente. Alla stessa maniera qui:
‘se è miele, è rossastro
dunque se è rossastro è miele
ma il fiele è rossastro
dunque il fiele è il miele’.
Alla stessa maniera qui:
‘se piove, la terra è bagnata
dunque se la terra è bagnata, piove’.
In tutti questi esempi, infatti, si ritiene che la conseguenza possa essere convertita, mentre non può
esserlo. E dunque essi difettano circa il conseguente.
Secondo modo
158. Invece il secondo modo si ha quando si crede di poter convertire la conseguenza dovuta ad
alcune circostanze inerenti alla persona, come accade nei retori. Come:
‘se è adultero, è un bellimbusto
o uno che si aggira nella notte’
e così per altre circostanze:
‘dunque se è un bellimbusto
o uno che si aggira nella notte, è adultero’;
qui vi è la fallacia circa il conseguente, poiché, se è adultero, presenta qualche circostanza
caratteristica ell’adultero, ma non viceversa, come ‘se è uomo, è colorato’, e non viceversa. Alla
stessa maniera qui
‘Se qualcosa è rubato, non è guadagnato né si è avuto in modo appropriato
dunque se non è guadagnato né si è avuto in modo appropriato, è rubato’.
Non è consequenziale; infatti, si ritiene di poter convertire la conseguenza che invece non è
convertibile.
Terzo modo
159. Invece il terzo modo della fallacia del conseguente si ha quando si ritiene di poter convertire la
conseguenza secondo l’opposizione stabilita. Come:
‘se è stato fatto, ha un principio
dunque, se non è stato fatto, non ha principio
ma il mondo non è stato fatto, cioè generato
dunque il mondo non ha un principio
dunque il mondo è infinito per durata
e quindi il mondo è da sempre’.
Melisso infatti cadeva nella fallacia del conseguente nella prima illazione; infatti, giusta è questa
50
conseguenza
‘se è stato fatto, ha principio’,
poiché qualsiasi cosa generata ha un principio, perché da niente non avviene niente, dunque se
avviene qualcosa avviene da qualcosa; dunque se è stato fatto ha un principio; ma non ne consegue:
‘se non è stato fatto, non ha un principio’.
Egli inferisce infatti a partire dalla negazione dell’accidente e pone la conseguenza nello stesso
modo negli opposti contraddittoriamente, mentre in essi la conseguenza deve essere posta sempre
inversamente. Come:
‘se è stato fatto, ha un principio dunque se non ha un principio, non è stato fatto’;
in tal caso il ragionamento è consequenziale. Alla stessa maniera c’è la fallacia del conseguente qui:
‘se è uomo, è animale dunque se non è uomo, non è animale’
in base alla negazione dell’antecedente. Sicché vi è qui una conseguenza nello stesso modo, mentre
doveva esserlo inversamente; nei contraddittori infatti non è lecito inferire nello stesso modo.
160. Da quanto si è detto risulta evidente che là dove vi sia la fallacia del conseguente vi è una
duplice conseguenza. Ciò risulta anche dal fatto che tutte le volte che Aristotele parla di fallacia del
‘conseguente’ sempre forma i discorsi che incorrono in tale fallacia secondo una duplice
conseguenza, come ‘se questo è, allora quello è’; ed essendovi quello, si ritiene sofisticamente che
si día anche questo.
161. Ancora. Il principio motore e il principio del difetto tanto nelle fallacie nell’espressione quanto
in quelle che non dipendono dall’espressione riguardano la sostanza di qualsiasi paralogismo.
Dunque se, nella fallacia del conseguente, la conseguenza giusta è il principio motore, e la
conseguenza falsa è il principio del difetto, è necessario che, tutte le volte che c’è íl paralogismo del
conseguente, vi sia una duplice conseguenza.
162. Ancora sullo stesso argomento. Non è possibile che una conseguenza si inverta, senza che si
diano in tal caso due conseguenze. Perché se si inverte la conseguenza, abbiamo la conseguenza che
si inverte e la conseguenza in cui si inverte. Dunque è necessario che vi sia una duplice
conseguenza, ogni volta che vi è fallacia del conseguente, se è corretta la causa stabilita da
Aristotele.
163. Ancora. Ciò è evidentemente provato dalla soluzione che dà Aristotele nel secondo libro delle
Confutazioni sofistiche riguardo ai paralogismi del conseguente. Aristotele dice qui, infatti, che la
conseguenza è duplice: una è quella in cui dal particolare consegue il generale, come ‘se è uomo, è
animale’, ed è quella che prima abbiamo chiamato semplice; l’altra, invece, è quella che, come egli
dice, riguarda le contrapposizioni, ed è quella che noi abbiamo chiamato complessa. Ed è appunto
la distinzione della conseguenza che stabilimmo all’inizio. Ma tanto per l’una quanto per l’altra
Aristotele trova la soluzione mostrando che una conseguenza può essere convertita nell’altra.
Dunque se la sua soluzione è generale, è necessario che tutte le volte che c’è fallacia del
conseguente, la conseguenza sia duplice, cioè quella che è invertita e quella in cui è invertita. E su
tutto ciò conveniamo. Sicché in argomenti come: ‘l’animale corre; dunque l’uomo corre’, o
‘l’uomo corre; dunque Socrate corre’ e in tutte quelli simili non c’è il sofisma del conseguente, ma
dell’accidente, come si è visto prima, quando ci siamo occupati della fallacia dell’accidente.
51
S. Tommaso d’Aquino (1225-74)
Somma teologica (1265-73)
lingua originale: latino
edizione di riferimento: ‘Leonina’ emendata dalle Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1988
tr. it., i padri domenicani italiani (34 voll.), ESD, Bologna, 1984
Parte I, Questione 2
Proemio
Lo scopo principale della sacra dottrina è quello di far conoscere Dio, e non soltanto in se stesso, ma
anche in quanto è principio e fine delle cose, e specialmente della creatura ragionevole, come appare
dal già detto; nell'intento di esporre questa dottrina, noi tratteremo: I - di Dio (I Parte); II - del
movimento della creatura razionale verso Dio (II Parte, divisa in I-II e II-II); III - del Cristo, il quale,
in quanto uomo, è per noi via per ascendere a Dio (III Parte). L'indagine intorno a Dio comprenderà
tre parti. Considereremo: primo, le questioni spettanti alla divina Essenza; secondo, quelle riguardanti
la distinzione delle Persone; terzo, quelle che riguardano la derivazione delle creature da Dio. Intorno
all'Essenza divina poi dobbiamo considerare: 1. Se Dio esista; 2. Come egli sia o meglio come non
sia; 3. Dobbiamo studiare le cose spettanti alla sua operazione, cioè la scienza, la volontà e la
potenza. Sul primo membro di questa divisione si pongono tre quesiti: 1. Se sia di per sé evidente che
Dio esiste; 2. Se sia dimostrabile; 3. Se Dio esista.
Articolo 1 Se sia di per sé evidente che Dio esiste
SEMBRA che sia di per sé evidente che Dio esiste. Infatti: 1. Noi diciamo evidenti di per sé quelle
cose, delle quali abbiamo naturalmente insita la cognizione, com'è dei primi principi. Ora, come
assicura il Damasceno "la conoscenza dell'esistenza di Dio è in tutti naturalmente insita". Quindi
l'esistenza di Dio è di per sé evidente.
2. Evidente di per sé è ciò che subito s'intende, appena ne abbiamo percepito i termini; e questo
Aristotele lo attribuisce ai primi principi della dimostrazione: conoscendo infatti che cosa è il tutto e
che cosa è la parte, subito s'intende che il tutto è maggiore della sua parte. Ora, inteso che cosa
significhi la parola Dio, all'istante si capisce che Dio esiste. Si indica infatti con questo nome un
essere di cui non si può indicare uno maggiore: ora è maggiore ciò che esiste al tempo stesso nella
mente e nella realtà che quanto esiste soltanto nella mente: onde, siccome appena si è inteso questo
nome Dio, subito viene alla nostra mente (di concepire) la sua esistenza, ne segue che esista anche
nella realtà. Dunque che Dio esista è di per sé evidente.
3. È di per sé evidente che esiste la verità; perché chi nega esistere la verità, ammette che esiste una
verità; infatti se la verità non esiste sarà vero che la verità non esiste. Ma se vi è qualche cosa di
vero, bisogna che esista la verità. Ora, Iddio è la Verità. "Io sono la via, la verità e la vita". Dunque
che Dio esista è di per sé evidente.
IN CONTRARIO: Nessuno può pensare l'opposto di ciò che è di per sé evidente, come spiega
Aristotele riguardo ai primi principi della dimostrazione. Ora, si può pensare l'opposto
dell'enunciato: Dio esiste, secondo il detto del Salmo: "Lo stolto dice in cuor suo "Iddio non c'è"".
Dunque che Dio esista non è di per sé evidente.
RISPONDO: Una cosa può essere di per sé evidente in due maniere: primo, in se stessa, ma non per
noi; secondo, in se stessa e anche per noi. E invero, una proposizione è di per sé evidente dal fatto
che il predicato è incluso nella nozione del soggetto, come questa: l'uomo é un animale; infatti
animale fa parte della nozione stessa di uomo. Se dunque è a tutti nota la natura del predicato e del
soggetto, la proposizione risultante sarà per tutti evidente, come avviene nei primi principi di
dimostrazione, i cui termini sono nozioni comuni che nessuno può ignorare, come ente e non ente, il
tutto e la parte, ecc. Ma se per qualcuno rimane sconosciuta la natura del predicato e del soggetto, la
proposizione sarà evidente in se stessa, non già per coloro che ignorano il predicato ed il soggetto
53
della proposizione. E così accade, come nota Boezio, che alcuni concetti sono comuni ed evidenti
solo per i dotti, questo, p. es.: "le cose immateriali non occupano uno spazio". Dico dunque che
questa proposizione Dio esiste in se stessa è di per sé evidente, perché il predicato s'identifica col
soggetto; Dio infatti, come vedremo in seguito, è il suo stesso essere: ma siccome noi ignoriamo
l'essenza di Dio, per noi non è evidente, ma necessita di essere dimostrata per mezzo di quelle cose
che sono a noi più note, ancorché di per sé siano meno evidenti, cioè mediante gli effetti.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. È vero che noi abbiamo da natura una conoscenza generale
e confusa dell'esistenza di Dio, in quanto cioè Dio è la felicità dell'uomo; perché l'uomo desidera
naturalmente la felicità, e quel che naturalmente desidera, anche naturalmente conosce. Ma questo
non è propriamente un conoscere che Dio esiste, come non è conoscere Pietro il vedere che qualcuno
viene, sebbene chi viene sia proprio Pietro: molti infatti pensano che il bene perfetto dell'uomo, la
felicità, consista nelle ricchezze, altri nei piaceri, altri in qualche altra cosa.
2. Può anche darsi che colui che sente questa parola Dio non capisca che si vuol significare con essa
un essere di cui non si può pensare il maggiore, dal momento che alcuni hanno creduto che Dio
fosse corpo. Ma dato pure che tutti col termine Dio intendano significare quello che si dice, cioè un
essere di cui non si può pensare il maggiore, da ciò non segue però la persuasione che l'essere
espresso da tale nome esista nella realtà delle cose; ma soltanto nella percezione dell'intelletto. Né si
può arguire che esista nella realtà se prima non si ammette che nella realtà vi è una cosa di cui non si
può pensare una maggiore: ciò che non si concede da coloro che dicono che Dio non esiste.
3. Che esista la verità in generale è di per sé evidente; ma che vi sia una prima Verità non è per noi
altrettanto evidente.
Articolo 2 Se [l’esistenza di Dio] sia dimostrabile
SEMBRA non sia dimostrabile che Dio esiste. Infatti: 1. Che Dio esista è un articolo di fede.
Ora, le cose di fede non si possono dimostrare, perché la dimostrazione ingenera la scienza,
mentre la fede è soltanto delle cose non evidenti, come assicura l'Apostolo. Dunque non si può
dimostrare che Dio esiste.
2. Il termine medio di una dimostrazione si desume dalla natura del soggetto. Ora, di Dio noi non
possiamo sapere quello che è, ma solo quello che non è, come nota il Damasceno. Dunque non
possiamo dimostrare che Dio esiste.
3. Se si potesse dimostrare che Dio esiste, ciò non sarebbe che mediante i suoi effetti. Ma questi
effetti non sono a lui proporzionati, essendo egli infinito, ed essi finiti; infatti tra il finito e
l'infinito non vi è proporzione. Non potendosi allora dimostrare una causa mediante un effetto
sproporzionato, ne segue che non si possa dimostrare l'esistenza di Dio.
IN CONTRARIO: Dice l'Apostolo: "le perfezioni invisibili di Dio comprendendosi dalle cose
fatte, si rendono visibili", Ora, questo non avverrebbe, se mediante le cose create non si potesse
dimostrare l'esistenza di Dio; poiché la prima cosa che bisogna conoscere intorno ad un dato
soggetto è se esso esista.
RISPONDO: Vi è una duplice dimostrazione: L'una, procede dalla (cognizione della) causa, ed è
chiamata propter quid, e questa muove da ciò che di suo ha una priorità ontologica. L'altra, parte
dagli effetti ed è chiamata dimostrazione quia, e muove da cose che hanno una priorità soltanto
rispetto a noi: ogni volta che un effetto ci è più noto della sua causa, ci serviamo di esso per
conoscere la causa. Da qualunque effetto poi si può dimostrare l'esistenza della sua causa (purché
gli effetti siano per noi più noti della causa); perché dipendendo ogni effetto dalla sua causa,
posto l'effetto è necessario che preesista la causa. Dunque l'esistenza di Dio, non essendo rispetto
a noi evidente, si può dimostrare per mezzo degli effetti da noi conosciuti.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'esistenza di Dio ed altre verità che riguardo a Dio si
possono conoscere con la ragione naturale, non sono, al dire di S. Paolo, articoli di fede, ma
preliminari agli articoli di fede: difatti la fede presuppone la cognizione naturale, come la grazia
presuppone la natura, come (in generale) la perfezione presuppone il perfettibile. Però nulla
impedisce che una cosa, la quale è di suo oggetto di dimostrazione e di scienza, sia accettata
54
come oggetto di fede da chi non arriva a capirne la dimostrazione.
2. Quando si vuol dimostrare una causa mediante l'effetto, è necessario servirsi dell'effetto in
luogo della definizione (o natura) della causa, per dimostrare che questa esiste; e ciò vale
specialmente nei riguardi di Dio. Per provare infatti che una cosa esiste, è necessario prendere
per termine medio la sua definizione nominale, non già la definizione reale, poiché la questione
riguardo all'essenza di una cosa viene dopo quella riguardante la sua esistenza. Ora, i nomi di
Dio provengono dai suoi effetti, come vedremo in seguito: perciò nel dimostrare l'esistenza di
Dio mediante gli effetti, possiamo prendere per termine medio quello che significa il nome Dio.
3. Da effetti non proporzionati alla causa non si può avere di questa una cognizione perfetta;
tuttavia da qualsiasi effetto noi possiamo avere manifestamente la dimostrazione che la causa
esiste, come si è detto. E così dagli effetti di Dio si può dimostrare che Dio esiste, sebbene non si
possa avere per mezzo di essi una conoscenza perfetta della di lui essenza
Articolo 3 Se Dio esista
SEMBRA che Dio non esista. Infatti: 1. Se di due contrari uno è infinito, l'altro resta
completamente distrutto. Ora, nel nome Dio s'intende affermato un bene infinito. Dunque, se
Dio esistesse, non dovrebbe esserci più il male. Viceversa nel mondo c'è il male. Dunque Dio
non esiste.
2. Ciò che può essere compiuto da un ristretto numero di cause, non si vede perché debba
compiersi da cause più numerose. Ora tutti i fenomeni che avvengono nel mondo, potrebbero
essere prodotti da altre cause, nella supposizione che Dio non esistesse: poiché quelli naturali si
riportano, come a loro principio, alla natura, quelli volontari, alla ragione o volontà umana.
Nessuna necessità, quindi, dell'esistenza di Dio.
IN CONTRARIO: Nell'Esodo si dice, in persona di Dio: "Io sono Colui che è".
RISPONDO: Che Dio esista si può provare per cinque vie. La prima e la più evidente è quella
che si desume dal moto. È certo infatti e consta dai sensi, che in questo mondo alcune cose si
muovono. Ora, tutto ciò che si muove è mosso da un altro. Infatti, niente si trasmuta che non sia
potenziale rispetto al termine del movimento; mentre chi muove, muove in quanto è in atto.
Perché muovere non altro significa che trarre qualche cosa dalla potenza all'atto; e niente può
essere ridotto dalla potenza all'atto se non mediante un essere che è già in atto. P. es., il fuoco
che è caldo attualmente rende caldo in atto il legno, che era caldo soltanto potenzialmente, e
così lo muove e lo altera. Ma non è possibile che una stessa cosa sia simultaneamente e sotto lo
stesso aspetto in atto ed in potenza: lo può essere soltanto sotto diversi rapporti: così ciò che è
caldo in atto non può essere insieme caldo in potenza, ma è insieme freddo in potenza. È
dunque impossibile che sotto il medesimo aspetto una cosa sia al tempo stesso movente e
mossa, cioè che muova se stessa. È dunque necessario che tutto ciò che si muove sia mosso da
un altro. Se dunque l'essere che muove è anch'esso soggetto a movimento, bisogna che sia
mosso da un altro, e questo da un terzo e così via. Ora, non si può in tal modo procedere
all'infinito, perché altrimenti non vi sarebbe un primo motore, e di conseguenza nessun altro
motore, perché i motori intermedi non muovono se non in quanto sono mossi dal primo motore,
come il bastone non muove se non in quanto è mosso dalla mano. Dunque è necessario arrivare
ad un primo motore che non sia mosso da altri; e tutti riconoscono che esso è Dio. La seconda
via parte dalla nozione di causa efficiente. Troviamo nel mondo sensibile che vi è un ordine tra
le cause efficienti, ma non si trova, ed è impossibile, che una cosa sia causa efficiente di se
medesima; ché altrimenti sarebbe prima di se stessa, cosa inconcepibile. Ora, un processo
all'infinito nelle cause efficienti è assurdo. Perché in tutte le cause efficienti concatenate la
prima è causa dell'intermedia, e l'intermedia è causa dell'ultima, siano molte le intermedie o una
sola; ora, eliminata la causa è tolto anche l'effetto: se dunque nell'ordine delle cause efficienti
non vi fosse una prima causa, non vi sarebbe neppure l'ultima, né l'intermedia. Ma procedere
all'infinito nelle cause efficienti equivale ad eliminare la prima causa efficiente; e così non
avremo neppure l'effetto ultimo, né le cause intermedie: ciò che evidentemente è falso. Dunque
55
bisogna ammettere una prima causa efficiente, che tutti chiamano Dio. La terza via è presa dal
possibile (o contingente) e dal necessario, ed è questa. Tra le cose noi ne troviamo di quelle che
possono essere e non essere; infatti alcune cose nascono e finiscono, il che vuol dire che
possono essere e non essere. Ora, è impossibile che tutte le cose di tal natura siano sempre
state, perché ciò che può non essere, un tempo non esisteva. Se dunque tutte le cose (esistenti in
natura sono tali che) possono non esistere, in un dato momento niente ci fu nella realtà. Ma se
questo è vero, anche ora non esisterebbe niente, perché ciò che non esiste, non comincia ad
esistere se non per qualche cosa che è. Dunque, se non c'era ente alcuno, è impossibile che
qualche cosa cominciasse ad esistere, e così anche ora non ci sarebbe niente, il che è
evidentemente falso. Dunque non tutti gli esseri sono contingenti, ma bisogna che nella realtà
vi sia qualche cosa di necessario. Ora, tutto ciò che è necessario, o ha la causa della sua
necessità in altro essere oppure no. D'altra parte, negli enti necessari che hanno altrove la causa
della loro necessità, non si può procedere all'infinito, come neppure nelle cause efficienti
secondo che si è dimostrato. Dunque bisogna concludere all'esistenza di un essere che sia di per
sé necessario, e non tragga da altri la propria necessità, ma sia causa di necessità agli altri. E
questo tutti dicono Dio. La quarta via si prende dai gradi che si riscontrano nelle cose. È un
fatto che nelle cose si trova il bene, il vero, il nobile e altre simili perfezioni in un grado
maggiore o minore. Ma il grado maggiore o minore si attribuisce alle diverse cose secondo che
esse si accostano di più o di meno ad alcunché di sommo e di assoluto; così più caldo è ciò che
maggiormente si accosta al sommamente caldo. Vi è dunque un qualche cosa che è vero al
sommo, ottimo e nobilissimo, e di conseguenza qualche cosa che è il supremo ente; perché,
come dice Aristotele, ciò che è massimo in quanto vero, è tale anche in quanto ente. Ora, ciò
che è massimo in un dato genere, è causa di tutti gli appartenenti a quel genere, come il fuoco,
caldo al massimo, è cagione di ogni calore, come dice il medesimo Aristotele. Dunque vi è
qualche cosa che per tutti gli enti è causa dell'essere, della bontà e di qualsiasi perfezione. E
questo chiamiamo Dio. La quinta via si desume dal governo delle cose. Noi vediamo che
alcune cose, le quali sono prive di conoscenza, cioè i corpi fisici, operano per un fine, come
appare dal fatto che esse operano sempre o quasi sempre allo stesso modo per conseguire la
perfezione: donde appare che non a caso, ma per una predisposizione raggiungono il loro fine.
Ora, ciò che è privo d'intelligenza non tende al fine se non perché è diretto da un essere
conoscitivo e intelligente, come la freccia dall'arciere. Vi è dunque un qualche essere
intelligente, dal quale tutte le cose naturali sono ordinate a un fine: e quest'essere chiamiamo
Dio.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Come dice S. Agostino: "Dio, essendo sommamente
buono, non permetterebbe in nessun modo che nelle sue opere ci fosse del male, se non fosse
tanto potente e tanto buono, da saper trarre il bene anche dal male". Sicché appartiene
all'infinita bontà di Dio il permettere che vi siano dei mali per trarne dei beni.
2. Certo, la natura ha le sue operazioni, ma siccome le compie per un fine determinato sotto la
direzione di un agente superiore, è necessario che siano attribuite anche a Dio, come a loro
prima causa. Similmente gli atti del libero arbitrio devono essere ricondotti ad una causa più
alta della ragione e della volontà umana, perché queste sono mutevoli e defettibili, e tutto ciò
che è mutevole e tutto ciò che può venir meno, deve essere ricondotto a una causa prima
immutabile e di per sé necessaria, come si è dimostrato.
56
John Locke
(1632-1704)
Saggio sull’intelletto umano (1690)
lingua originale: inglese
tr. it., M e N Abbagnano, UTET, Torino, 1971
Libro IV, capitolo xvii
DELLA RAGIONE
1. La parola ragione ha in inglese differenti significati : talvolta è presa per i principi veri e chiari;
talvolta per chiare ed esatte deduzioni da questi principi e talvolta per la causa e in particolare per la
causa finale. Ma io l’assumerò qui in un significato differente da tutti questi, cioè in quanto sta per
una facoltà umana, la facoltà per la quale l’uomo dev’essere distinto falle bestie e per la quale è
evidente che egli le sorpassa di volto.
2. Se la conoscenza generale, com’è stato mostrato, consiste nella percezione dell’accordo o
disaccordo delle nostre idee e la conoscenza dell’esistenza delle cose fuori di noi (eccettuata solo
quella di Dio, la cui esistenza ognuno può conoscere con certezza e dimostrare a se stesso a partire
dalla sua propria esistenza) può essere ottenuta solo dai sensi, quale posto rimane per l’esercizio di
ogni altra facoltà che non sia il senso esterno e la percezione interna? Che bisogno c’è della
ragione? Un gran bisogno: sia per estendere la nostra conoscenza sia per regolare il nostro assenso.
Essa infatti ha da fare sia nella conoscenza sia nelle opinioni ed è necessaria, e di aiuto, a tutte le
altre nostre facoltà intellettuali : ne contiene infatti due, cioè la sagacia e l’illazione. Con la prima,
essa scopre e con la seconda ordina le idee intermedie, per scoprire quale connessione c’è in ciascun
anello della catena dalla quale gli estremi sono tenuti insieme; e con ciò essa porta, per così dire,
alla vista la verità cercata, che è quella che chiamiamo illazione o inferenza e consiste
semplicemente nella percezione della connessione che c’è fra le idee a ciascun passo della
deduzione : per la quale lo spirito giunge a vedere o l’accordo o il disaccordo certo di due idee
qualsiasi, come accade nella dimostrazione in cui esso arriva alla conoscenza; o la loro connessione
probabile, sulla base della quale esso dà o nega il suo assenso, come accade nell’opinione. Il senso e
l’intuizione non fanno molta strada. La maggior parte della nostra conoscenza dipende dalla
deduzione e dalle idee intermedie; e nei casi in cui siamo inclini a sostituire l’assenso alla
conoscenza e a prendere per vere proposizioni che non siamo certi siano tali, abbiamo bisogno di
cercare, esaminare e paragonare i fondamenti della loro probabilità. In entrambi i casi, la facoltà la
quale trova i mezzi e li applica esattamente, per scoprire la certezza nell’uno e la probabilità
nell’altro, è ciò che chiamiamo ragione. Poiché, come la ragione percepisce la connessione
necessaria e indubitabile che tutte le idee o prove hanno l’una con l’altra a ciascun passo di una
dimostrazione che produce conoscenza, così pure percepisce la connessione probabile di tutte le
idee o prove l’una con l’altra a ciascun passo di un discorso al quale credo che sia dovuto l’assenso.
Questo è il grado più basso di ciò che può essere veramente chiamato ragione. Giacché dove lo
spirito non percepisce la connessione probabile, dove non discerne se tale connessione c’è o non
c’è, qui le opinioni umane non sono il prodotto del giudizio o la conseguenza della ragione, ma gli
effetti del caso e della fortuna, di uno spirito in balia di tutte le avventure, senza scelta né direzione.
3. Possiamo dunque considerare, nella ragione, quattro gradi: il primo e più alto è la scoperta e il
ritrovamento delle verità; il secondo è la disposizione regolare e metodica di esse, il situarle in un
ordine chiaro e opportuno per rendere semplicemente e facilmente percepibile la loro connessione e
la loro forza; il terzo è la percezione della loro connessione e il quarto è il dedurne una conclusione
esatta. Questi diversi gradi possono essere osservati in ogni dimostrazione matematica; giacché una
cosa è percepire la connessione fra le parti quando la dimostrazione è fatta da un altro, altra cosa è il
57
percepire la dipendenza della conclusione da tutte le parti; una terza cosa è fare da sé in modo
chiaro e netto una dimostrazione; e ancora diversa da tutte queste cose è l’avere prima trovato le
idee intermedie o prove di cui la dimostrazione consiste.
4. C’è ancora una cosa che desidero sia considerata circa la ragione: se il sillogismo, come
generalmente si pensa, sia lo strumento proprio di essa e il modo più utile di esercitare questa
facoltà. I motivi per dubitarne sono i seguenti :
Primo, il sillogismo serve alla ragione solo in una delle sue parti summenzionate, cioè per mostrare
la connessione delle prove in ogni singolo caso e non più; ma non è in questo di grande utilità
perché lo spirito può percepire questa connessione, dove c’è realmente, altrettanto facilmente, anzi
forse meglio, senza di esso.
Se osserveremo le operazioni del nostro spirito troveremo che ragioniamo meglio e più chiaramente
quando osserviamo solo la connessione delle prove senza ridurre i nostri pensieri alle regole del
sillogismo. Perciò si può osservare che molti uomini ragionano in modo estremamente chiaro ed
esatto, senza sapere come costruire un sillogismo. Chi guarderà in molte parti dell’Asia e
dell’America, troverà uomini che ragionano forse altrettanto acutamente di lui ma che non hanno
mai sentito parlare del sillogismo né sono in grado di ridurre un argomento a questa forma: e non
credo che uno faccia sillogismi ragionando fra sé. Infatti del sillogismo si fa uso, all’occasione, per
scoprire una fallacia nascosta in una figura retorica o astutamente avvolta in un armonioso periodo e
così, strappando all’assurdità la copertura di arguzia e di buona lingua, mostrarla nella sua nuda
deformità. Ma la debolezza o fallacia di un siffatto scucito discorso il sillogismo la mostra,
ponendolo in una forma artificiale, solo a quelli che ne hanno diligentemente studiato il modo e la
figura e hanno esaminato le molte combinazioni in cui le tre proposizioni possono essere poste
insieme per conoscere quale di esse conclude con certezza esattamente e quale no, e su quali
fondamenti ciò accade. Coloro che hanno considerato il sillogismo sino al punto di veder la ragione
per cui, se tre proposizioni sono poste insieme in una forma la conclusione sarà certamente esatta, e
se poste in un’altra, certamente non lo sarà, costoro sono certi, lo ammetto, della conclusione che
essi deducono dalle premesse secondo i modi e le figure ammesse. Ma chi non si è spinto così oltre
nella considerazione di queste forme non è sicuro, in virtù del sillogismo, che la conclusione segua
certamente dalle premesse ma lo ammette solo per una fede implicita nei suoi insegnanti e la fiducia
in queste forme di argomentazione; ma questo significa credere e non essere certo. Ora se in tutta
l’umanità quelli che sanno formulare sillogismi sono pochissimi in confronto a quelli che non sanno
e quei pochi, cui la logica è stata insegnata, solo un numero piccolissimo fa qualcosa più che
credere che il sillogismo nei modi e nelle figure ammesse, concluda esattamente, ma non conosce
con certezza che sia così: se il sillogismo dev’essere considerato come il solo strumento proprio
della ragione e il solo mezzo di conoscenza, ne seguirà che, prima di Aristotele, non ci fu nessuno
che connobbe o avrebbe potuto conoscere qualcosa mediante la ragione e che, dall’invenzione del
sillogismo, ci sarà stato solo uno su diecimila che abbia saputo farlo.
Ma Dio non è stato così avaro verso gli uomini da farne solo creature con due gambe e da lasciare
ad Aristotele il renderli razionali.
[Omessa una polemica anti-scolastica]
Di quale utilità sono allora i sillogismi? Rispondo che servono principalmente nelle Scuole dove è
consentito negare senza vergogna l’accordo di idee che manifestamente concordano; o, fuori delle
scuole, a coloro che in esse hanno imparato a negare senza vergogna la connessione e le idee che
anche a loro stessi è visibile. Ma per un sincero cercatore di verità che non ha altro scopo se non
trovarla, non c’è nessun bisogno della forma sillogistica per costringerlo ad ammettere l’inferenza:
la verità e la ragionevolezza di essa è veduta meglio combinando le idee in un ordine semplice e
chiaro; perciò, quando cercano la verità, gli uomini non usano mai il sillogismo per convincere se
stessi o per insegnare agli altri a istruire chi vuole imparare. Infatti prima di porla in forma
sillogistica, essi devono vedere la connessione che c’è fra l’idea intermedia e le due altre idee fra le
58
quali essa è posta e alle quali è applicata per mostrare il loro accordo; e, quando la vedono, vedono
pure se l’inferenza è buona o no e così il sillogismo arriva troppo tardi per stabilirla. Per usare
ancora l’esempio precedente, io chiedo se lo spirito, considerando l’idea di giustizia, situata come
idea intermedia fra la punizione e la colpa di chi è punito (e finché non l’ha così considerata, lo
spirito non può usarla come un medius terminus) non vede altrettanto chiaramente la forza e il
potere dell’inferenza di quando la formula in un sillogismo. Per mostrare la cosa con un esempio
semplice e facile, poniamo che animal sia l’idea intermedia o il medius terminus di cui lo spirito fa
uso per mostrare la connessione di homo e vivens; chiedo se lo spirito non veda più prontamente e
facilmente questa connessione nella posizione semplice e propria, cioè in mezzo, dell’idea
connettente, così:
Homo-Animal-Vivens
che non in questa più intricata
Animal-Vivens-Homo-Animal
che è la posizione di queste idee nel sillogismo per mostrare la connessione tra homo e vivens con
l’intervento di animal.
Si crede che l’uso del sillogismo è necessario anche per gli amanti della verità per mostrar loro le
fallacie che spesso si nascondono in discorsi fioriti, arguti o involuti. Ma che questa sia un’illusione
sarà manifesto se consideriamo che la ragione per la quale talvolta anche uomini che mirano
sinceramente alla verità sono coinvolti da questi discorsi scuciti o, come sono detti, retorici, è che la
loro fantasia rimane colpita da qualche vivace rappresentazione metaforica, e perciò essi trascurano
di osservare, o non percepiscono agevolmente, quali sono le vere idee dalle quali l’inferenza
dipende. Ora per mostrare a tali uomini la debolezza di una argomentazione siffatta, non occorre
altro che strappare le idee superflue, che mescolate e confuse con quelle dalle quali l’inferenza
dipende, sembra che mostrino una connessione che non c’è o almeno ostacolano la scoperta della
sua mancanza; e poi disporre nell’ordine dovuto le nude idee dalle quali la forza
dell’argomentazione dipende; nella quale posizione, lo spirito, considerando l’insieme, vede la
connessione che hanno ed è così in grado di giudicare l’inferenza senza bisogno del sillogismo.
Riconosco che in tali casi si fa uso comunemente del modo e della figura, come se la scoperta
dell’incoerenza dei discorsi slegati fosse completamente dovuta alla forma sillogistica; e così
credevo anch’io prima, finché, dopo un più attento esame, ho trovato che, il porre le nude idee nel
loro debito ordine mostra l’incoerenza dell’argomentazione meglio del sillogismo: non solo perché
sottopone alla immediata vista dello spirito ciascun anello della catena al suo proprio posto, in cui la
sua connessione è meglio osservata; ma anche perché il sillogismo rivela l’incoerenza solo a coloro
(che sono meno di uno su diecimila) che ca-piscono perfettamente modi e figure nonché la ragione
su cui queste forme sono fondate; mentre la disposizione regolare e ordinata delle idee, sulla quale
l’inferenza poggia, fa in modo che ognuno, abbia o no studiato la logica, capisca i termini e abbia la
facoltà di percepire l’accordo o il disaccordo delle idee (senza di che, con o senza il sillogismo, non
può percepire la forza o la debolezza, la coerenza o l’incoerenza del discorso), veda la mancanza di
connessione nell’argomentazione e l’assurdità dell’inferenza.
E così ho conosciuto un uomo inesperto del sillogismo che di primo acchito poteva percepire la
debolezza e l’inconcludenza di un lungo discorso artificiale e plausibile, mentre altri più esperti nei
sillogismi ne sarebbero stati ingannati; e credo che ci sono pochi fra i miei lettori che non
conoscono uno come lui. E infatti, se non fosse così, le discussioni della maggior parte dei
congressi di prìncipi e gli affari trattati dalle assemblee sarebbero in pericolo di esser condotti male,
dal momento che coloro a cui sono affidati e che abitualmente hanno in essi un gran potere, non
sempre hanno avuto la buona fortuna di imparare perfettamente le forme del sillogismo ed essere
esperti in modi e figure. E se il sillogismo fosse la sola, o almeno la più sicura via per scoprire le
fallacie dei discorsi artificiali, non credo che tutta l’umanità, e anche i principi, nelle faccende che
concernono la loro corona e le loro prerogative, siano tanto innamorati della falsità e dell’inganno
59
da aver trascurato dappertutto di portare il sillogismo nei dibattiti importanti o di aver creduto tanto
ridicolo di presentare sillogismi in affari di qualche importanza. Questa è per me una chiara prova
che uomini dotati di buon senso e acutezza, che non si trovavano a disputare oziosamente a loro
agio, ma dovevano agire conformemente al risultato delle loro discussioni e spesso pagare i loro
errori con la loro testa o la loro fortuna, trovavano la forma scolastica del sillogismo di scarsa utilità
per scoprire la verità o la fallacia mentre sia l’una che l’altra poteva essere messa in luce, e anche
meglio, senza quelle forme a coloro che non si rifiutassero di vedere quello che ad essi era mostrato
in modo visibile.
Secondo. Un’altra ragione che mi fa dubitare che il sillogismo sia l’unico strumento appropriato per
la scoperta della verità è che, qualunque sia l’utilità che modi e figure si pretende che abbiano nel
mettere allo scoperto una fallacia (il che è stato già considerato), le forme scolastiche del discorso
sono soggette alle fallacie non meno che i modi più semplici dell’argomentazione; e per questo mi
appello all’osservazione comune, la quale ha sempre trovato questi metodi artificiali di ragionare
più adatti a catturare e intrappolare lo spirito che ad istruire ed informare l’intelletto. Da ciò deriva
che gli uomini, anche quando sono battuti e ridotti al silenzio con questo procedimento scolastico,
raramente o mai sono convinti e conquistati alla parte vincitrice: riconoscono, forse, che il loro
avversario è più abile nella disputa ma restano tuttavia persuasi che la verità sia dalla loro parte e,
pur avendo avuto la peggio, si allontanano con la stessa opinione con cui erano venuti: il che non
potrebbero fare se questo modo di argomentare portasse luce e convinzione e facesse vedere dove
sta la verità. E perciò si è creduto che il sillogismo sia più adatto ad ottenere la vittoria nella disputa
che a scoprire o a confermare la verità in un’indagine ben condotta. E se è certo che nel sillogismo
possano nascondersi fallacie, come non si può negare, deve essere qualcos’altro e non il sillogismo
che deve scoprirle.
Ho avuto esperienza di come gli uomini sono pronti, quando non si ammette l’utilità che essi
attribuiscono solitamente a qualcosa, a gridare che uno vuol metterla completamente da parte. Per
prevenire quest’accusa ingiusta e infondata, dirò che non intendo mettere da parte niente che possa
aiutare l’intelletto ad acquisire la conoscenza. E se coloro che sono esperti a sillogizzare, e abituati
a farlo, trovano che ciò aiuta la loro ragione nella scoperta della verità, credo che debbano far uso
dei sillogismi. Tutto ciò che pretendo è che essi non attribuiscano a queste forme più di ciò che ad
esse appartiene e non pensino che gli uomini non possano, senza di esse, usare o usar pienamente le
loro facoltà razionali. Certi occhi hanno bisogno di lenti per vedere le cose chiaramente e
distintamente, ma coloro che le usano non dicono che nessuno può vedere chiaramente senza di
esse: se facessero così, si penserebbe che essi deprimano e screditino troppo la natura in favore di
un’arte, alla quale forse sono debitori. La ragione, con la sua penetrazione, quando è forte ed
esercitata, vede abitualmente più presto e più chiaramente senza sillogismi. Se l’uso di queste lenti
ha così offuscata la sua vista che non può senza di esse vedere le conseguenze o le inconseguenze
dell’argomentazione, non sono così irragionevole da oppormi al loro uso. Ognuno conosce quello
che meglio si adatta alla sua vista, ma non dovrebbe da ciò concludere che sono all’oscuro tutti
quelli che non usano proprio gli stessi aiuti di cui egli sente il bisogno.
[Omessa un’altra polemica anti-scolastica]
9. La ragione, sebbene penetri nelle profondità del mare e della terra, innalzi i nostri pensieri in alto
sino alle stelle e ci guidi attraverso i vasti spazi e i luoghi immensi di questa potente costruzione, è
tuttavia ben lontana dall’estensione reale anche del solo essere corporeo. E ci sono molti casi in cui
essa ci vien meno :
I. Ci vien meno quando ci vengono meno le idee. Non si estende né può estendersi al di là delle
idee. Perciò, ogni volta che non abbiamo idee, il nostro ragionamento si ferma e siamo alla chiusura
dei conti; e se talvolta ragioniamo su parole che non stanno per idee, ragioniamo su suoni e su
nient’altro.
60
10. II. La nostra ragione è spesso messa in imbarazzo o in svantaggio dall’oscurità, dalla confusione
o dalla imperfezione delle idee su cui è esercitata; e allora siamo implicati in difficoltà e
contraddizioni. Così, non avendo un’idea perfetta della estensione minima della materia né
dell’infinità, ci troviamo sperduti di fronte alla divisibilità della materia; invece, poiché abbiamo
idee perfette, chiare e distinte del numero, la nostra ragione non incontra, nei numeri, nessuna
difficoltà inestricabile e non si trova implicata in contraddizioni intorno ad essi. Così, avendo noi
solo idee imperfette delle operazioni del nostro spirito e dell’inizio del movimento o del pensiero e
di come lo spirito produce in noi movimento e pensiero; e idee ancora più imperfette delle
operazioni di Dio, ci imbattiamo in gravi difficoltà circa gli agenti liberi creati, difficoltà dalle quali
la ragione non si può districare.
11. III. La nostra ragione è spesso immobilizzata perché non percepisce le idee che possono servire
a mostrare l’accordo o disaccordo certo o probabile di altre due idee: e in questo, le facoltà di alcuni
uomini sono superiori a quelle di altri. Finché non fu scoperta l’algebra, questo grande strumento ed
esempio della sagacia umana, gli uomini guardavano con meraviglia molte delle dimostrazioni degli
antichi matematici e non potevano esimersi dal pensare che la scoperta di queste prove fosse
qualcosa di più che umano.
12. IV. Lo spirito, procedendo da principi falsi è spesso impegnato in assurdità e difficoltà e
precipitato in strettoie e contraddizioni senza saper come liberarsene; e in questo caso è vano
implorare l’aiuto della ragione, se non per scoprire la falsità e rigettare l’influenza dei principi
errati. La ragione non può chiarire le difficoltà nelle quali il costruire su fondamenti falsi porta un
uomo: perciò, se egli proseguirà a costruire, si imbroglierà sempre di più e sarà impigliato in
perplessità più profonde.
13. V. Come le idee oscure e imperfette ostacolano la nostra ragione, così, per la stessa causa,
parole dubbie e segni incerti nei discorsi e nella argomentazione, quando non vi si faccia molta
attenzione, mettono in imbarazzo la ragione degli uomini e li portano in un vicolo cieco. Ma in
questi casi la colpa è nostra e non della ragione. Le loro conseguenze tuttavia non sono meno ovvie;
e le perplessità e gli errori, di cui riempiono lo spirito degli uomini, sono osservabili ovunque.
14. Alcune idee che sono nello spirito, ci sono in modo da non poter essere immediatamente
confrontate l’una con l’altra; e per esse lo spirito è in grado di percepire che concordano o non
concordano con la stessa chiarezza con cui le percepisce. Così lo spirito percepisce che un arco di
cerchio è minore del cerchio intero, così chiaramente come percepisce l’idea del cerchio: questa,
come è stata detta, io la chiamo conoscenza intuitiva; essa è certa al di là di ogni dubbio, non ha
bisogno di prova né può averne, ed è la più alta di tutta la certezza umana. Di questa natura è
l’evidenza di quelle massime di cui nessuno dubita e che ogni uomo sa che sono vere (e non solo,
come suol dirsi dà ad esse il suo assenso) appena sono proposte al suo intelletto. Nella scoperta di, e
nell’assenso a, queste massime, la facoltà discorsiva è inutile, non c’è bisogno di ragionare, perché
esse sono conosciute con un grado superiore e più alto di evidenza. Tale, se posso tirare ad
indovinare su cose sconosciute, sono incline a pensare sia la conoscenza che gli angeli hanno ora e
che gli spiriti degli uomini giusti, resi perfetti, avranno in un futuro stato, di migliaia di cose che ora
o sfuggono completamente alla nostra attenzione o che la nostra miope ragione, avendone solo
qualche fioco barlume, va cercando a tentoni nell’oscurità.
15. Ma per quanto noi abbiamo, qua e là, un poco di questa luce chiara, qualche sprazzo di
conoscenza luminosa, la maggior parte delle idee è tale che non possiamo discernere il loro accordo
o disaccordo confrontandole immediatamente. Per esse tutte, abbiamo bisogno di ragionare e
dobbiamo fare le nostre scoperte mediante il discorso e l’inferenza. Ce ne sono di due specie, che
mi prenderò qui la libertà di menzionare nuovamente :
Prima, quelle il cui accordo o disaccordo, se anche non può essere visto ponendole immediatamente
insieme, può tuttavia essere esaminato mediante l’intervento di altre idee che possono essere
confrontate con esse. Questo caso, quando l’accordo o il disaccordo dell’idea intermedia, da
entrambi i lati, con quelle con le quali vogliamo confrontarle, è chiaramente scorto, equivale ad una
dimostrazione da cui è prodotta una conoscenza che, per quanto certa, non è così facile ed insieme
61
così chiara come la conoscenza intuitiva. In questa, infatti, c’è solo un’unica e semplice
intuizione, nella quale non c’è posto per il minimo errore o dubbio: la verità è vista perfettamente
tutta insieme. Nella dimostrazione c’è, è vero, l’intuizione, ma non tutta insieme; perché ci deve
esser il ricordo dell’intuizione del termine medio, o idea intermedia, con ciò con cui prima
l’abbiamo confrontato, quando lo confrontiamo con l’altro; e, dove ci sono molti termini medi, il
pericolo dell’errore è maggiore.. Ciascun accordo o disaccordo fra le idee deve essere infatti
osservato e visto a ciascun passo dell’intero procedimento e ritenuto nella memoria così come è; e
lo spirito deve essere sicuro che non sia omessa e trascurata nessuna parte di ciò che è necessario
per costruire la dimostrazione. Ciò rende alcune dimostrazioni lunghe e complicate e troppo difficili
per coloro che non hanno la forza di percepirne distintamente le parti e di conservare nelle loro teste
esattamente tanti particolari nel loro ordine. E anche quelli che sono in grado di dominare queste
speculazioni intricate, sono talvolta costretti a ritornarci sopra e c’è bisogno di più che un controllo
prima che possano arrivare alla certezza. Tuttavia, quando lo spirito ricorda chiaramente
l’intuizione che ha avuto dell’accordo di un’idea con un’altra, e di questa con una terza e di questa
con una quarta, ecc., l’accordo fra la prima e la quarta è una dimostrazione e produce conoscenza
certa; la quale può esser detta conoscenza razionale, come l’altra è detta intuitiva.
16. Secondo: ci sono altre idee il cui accordo o disaccordo - non può essere giudicato mediante
l’intervento di altre idee, che non hanno un accordo con gli estremi certo, ma solo abituale o
verosimile; e in questi casi il giudizio è propriamente esercitato, perché esso consiste nel persuadere
lo spirito che le idee concordano mediante il confronto con un termine medio probabile. Questo, se
non equivale alla conoscenza, non è neppure il grado più basso di essa; tuttavia, talvolta, le idee
intermedie legano gli estremi insieme così fermamente e la probabilità è così chiara e forte, che
l’assenso ne segue necessariamente, come la conoscenza segue dalla dimostrazione. La grande
eccellenza e l’utilità del giudizio consiste nell’osservare esattamente e valutare debitamente la forza
e il peso di ogni probabilità; poi avendole messe tutte esattamente insieme, scegliere quel lato verso
il quale la bilancia pende.
17. La conoscenza intuitiva è la percezione dell’accordo o del disaccordo certo di due idee
immediatamente confrontate l’una con l’altra.
La conoscenza razionale è la percezione dell’accordo o del disaccordo certo di due idee mediante
l’intervento di una o più altre idee.
Il giudizio è il pensare o l’assumere che due idee concordano o non concordano sulla base
dell’intervento di una o più idee, il cui accordo o disaccordo certo con esse non è percepito, ma è
stato osservato frequentemente e abitualmente.
18. Sebbene il dedurre una proposizione da un’altra ed effettuare inferenze in parole costituisca
gran parte della ragione e ciò su cui essa è abitualmente adoperata, l’atto principale del raziocinio
consiste nel trovare l’accordo o il disaccordo di due idee l’una con l’altra, mediante l’intervento di
una terza idea: come un uomo, con uno strumento di misura, trova che due case sono della stessa
lunghezza mentre non si potrebbe misurare la loro uguaglianza per giustapposizione, mettendole
l’una accanto all’altra. Le parole hanno le loro conseguenze in quanto segni delle idee; e le cose
concordano o no, nella loro realtà; ma noi le osserviamo solo mediante le nostre idee.
19. Prima di lasciare questo tema può valere la pena di riflettere un poco su quattro specie di
argomenti di cui gli uomini fanno uso ordinariamente, ragionando gli uni con gli altri per ottenere
l’assenso o almeno per ridurre al silenzio la loro opposizione.
I. Il primo argomento consiste nell’allegare l’opinione di persone alle quali l’ingegno, la dottrina,
l’eminenza, il potere o qualche altra causa han fatto guadagnare un nome, e la cui reputazione nella
stima comune è stabilita con qualche specie di autorità. Quando gli uomini hanno raggiunto una
certa dignità, si pensa che sia mancanza di modestia, per gli altri, derogare in qualche modo da essa
e mettere in dubbio l’autorità di coloro che ne sono in possesso. Si può censurare come cosa troppo
orgogliosa, che un uomo non ceda prontamente a ciò che è stato determinato da autori approvati e
che è abitualmente accettato con rispetto e sottomissione dagli altri; e si considera insolenza il
rimaner fermi nella propria opinione contro la corrente di pensiero dell’antichità e di porre la
62
propria opinione sulla bilancia contro quella di qualche sapiente dottore o di uno scrittore famoso
per una ragione qualsiasi. Chi appoggia le sue credenze su autorità siffatte pensa che avrà causa
vinta ed è pronto ad accusare di impudenza chiunque stia contro di esse. Penso che questo può
essere chiamato argumentum ad verecundiam.
20. II. In secondo luogo, un’altra via che gli uomini ordinariamente seguono per indirizzare gli altri
e forzarli a sottomettersi al loro giudizio e a ricevere la loro opinione nella discussione consiste
nell’esigere che l’avversario ammetta quella che essi allegano come prova o ne assegni una
migliore. E questo io chiamo argumentum ad ignorantiam.
21. III. In terzo luogo, una terza via è quella di far pressione su un uomo con le conseguenze tratte
dai suoi stessi principi o concessioni. Questo è già conosciuto sotto il nome di argumentum ad
hominem.
22. IV. La quarta consiste nell’usare prove tratte da uno dei fondamenti della conoscenza o della
probabilità. Io la chiamo argumentum ad judicium. Solo questo, di tutte e quattro, apporta
un’informazione vera e ci fa avanzare sulla via della conoscenza. Perché 1) Non arguisce che
l’opinione di un altro sia giusta perché io o per rispetto o per qualche altra considerazione — ma
non per convinzione — non la contraddico. 2) Non prova che un altro sia sulla giusta via né che io
devo prendere la stessa via perché non ne conosco una migliore. 3) Non segue da esso che un altro è
sulla buona via perché mi ha mostrato che io sono sulla via sbagliata. Io posso esser modesto,
perciò non oppormi alla persuasione di un altro; posso essere ignorante, e non essere in grado di
addurre una prova migliore; posso essere in errore, e un altro può mostrarmi che lo sono. Questo mi
può disporre forse a ricevere la verità, ma non mi aiuta a farlo. Il farlo deve venire da prove e
argomenti e dalla luce che sorge dalla natura delle cose stesse, non dalla mia timidezza, ignoranza o
errore.
23. Quello che è stato detto prima della ragione può metterci in grado di formulare qualche
congettura sulla distinzione delle cose in quelle che sono d’accordo, sopra e contro la ragione. 1.
D’accordo con la ragione sono le proposizioni la cui verità possiamo scoprire esaminando e
rintracciando le idee che riceviamo dalla sensazione e dalla riflessione o che possiamo trovare vere
o probabili con una deduzione naturale. 2. Sopra la ragione sono le proposizioni la cui verità o
probabilità non possiamo con la ragione derivare da questi princìpi. 3. Contro alla ragione sono le
proposizioni incompatibili o inconciliabili con le nostre idee chiare e distinte. L’esistenza di un Dio
è in accordo con la ragione; l’esistenza di più che un Dio è contraria alla ragione; la resurrezione dei
morti è al di sopra della ragione. Al di sopra della ragione può essere preso in due sensi: cioè o nel
significato di al di sopra della probabilità o in quello di al di sopra della certezza, e contrario alla
ragione è assunto talvolta, suppongo, in questo senso più esteso.
24. C’è un altro uso della parola ragione, per il quale essa è opposta a fede; e sebbene questo sia, in
sé, un modo improprio di parlare, l’uso comune lo ha tanto autorizzato che sarebbe follia opporglisi
o sperare di rimediarvi. Penso solo che non si può fare a meno di notare che la fede, per quanto sia
opposta alla ragione, non è che un fermo assenso dello spirito che, se è regolato come si deve, può
esser concesso solo per una buona ragione e perciò non può essere opposto alla ragione. Chi crede
di avere una ragione per credere può amare le sue proprie fantasie; ma non cerca la verità come
dovrebbe né presta l’obbedienza dovuta al suo Creatore che vorrebbe egli usasse la facoltà di
discernimento che gli ha dato per tenersi fuori da inganno ed errore. Chi non fa questo nel miglior
modo che può, anche se qualche volta s’imbatte nella verità, è nel giusto solo per caso e non so se
questa fortuna accidentale scuserà l’irregolarità del suo procedimento. È certo, almeno, che deve
rendere conto di tutti gli errori che commette; mentre chi fa uso della luce delle facoltà che Dio gli
ha dato e cerca di scoprire la verità con questi aiuti e con le abilità in suo possesso, può, facendo il
suo dovere di creatura razionale, avere la soddisfazione, anche se non raggiunge la verità, di non
perdere il premio che gli spetta. Giacché chi governa il suo assenso esattamente e lo concede come
deve, costui, in ogni caso o su ogni argomento, crede o non crede a seconda che la ragione lo dirige.
Chi fa altrimenti trasgredisce la sua luce e usa male le facoltà che gli sono state date soltanto per
63
cercare e seguire la più chiara prova e la maggiore probabilità. Ma poiché da alcuni la ragione e la
fede si considerano opposte, considereremo la cosa nel capitolo seguente.
64
Bernard Bolzano (1781-1848)
Dottrina della scienza (1837)
lingua originale: tedesco
edizione di riferimento a cura di E. Winter (et al) Stuttgart, 1969
tr. it. G. Rigamonti e L. Fossati, Bompiani, Milano 2014
§ 30.
Senso dell’affermazione che si danno verità in sé
L’espressione darsi di cui mi servo quando affermo che si danno verità in sé ha bisogno di una
spiegazione a parte per non essere fraintesa. Infatti nel suo significato proprio e usuale, quello che
ha per esempio nella proposizione «Si danno angeli», essa indica l’essere o esserci (l’esistenza) di
una cosa; qui però non possiamo prenderla in questo senso perché le verità in sé, come ho già
ricordato più volte, non hanno un esserci. Ma allora che cosa intendiamo quando diciamo che si
danno simili verità? Rispondo: nient’altro, se non che certe proposizioni hanno la proprietà di essere
verità in sé.
Tuttavia riguardo al numero di queste proposizioni, cioè se se ne dia più d’una oppure una
sola, inizialmente non ci pronunceremo, così che la nostra affermazione possa essere considerata
dimostrata anche se avessimo provato solo il darsi di un’unica verità, o – che poi è lo stesso – che la
tesi che non si danno verità è falsa.
Se mettiamo insieme questo punto con quello immediatamente precedente vediamo, infine,
che il senso della tesi che qui vogliamo illustrare può essere espresso nel modo più chiaro così: «La
proposizione che nessuna proposizione ha verità non ha a sua volta verità», o anche, più
brevemente, «Non è vero che nessuna proposizione sia vera».
§ 31.
Dimostrazione che si dà almeno una verità in sé
La chiarissima espressione alla quale abbiamo appena ricondotto (§ 30) questa asserzione è tale che
la sua dimostrazione non sfugge nemmeno ai più miopi. Infatti che nessuna proposizione abbia
verità è autocontraddittorio perché è a sua volta una proposizione e dunque se volessimo dichiararla
vera dovremmo contemporaneamente dichiararla falsa; infatti se ogni proposizione fosse falsa lo
sarebbe anche la stessa proposizione che ogni proposizione è falsa. Perciò non tutte le proposizioni
sono false ma si danno anche proposizioni vere; si danno anche delle verità – almeno una.
Osservazione. Gli antichi conoscevano già benissimo il ragionamento col quale dimostro
che si dà almeno una verità. Aristotele (Metafisica, IV, 8) sottolinea l’autocontraddittorietà della
proposizione che niente è vero. Sesto Empirico (Contro i logici, II, 55) espone molto accuratamente
il nostro stesso ragionamento: «Quanto a quelli che asseriscono tutte le cose essere false, abbiamo
precedentemente mostrato che essi vengono confutati» (cioè già nel Lib. I, 390 e 398, però non in
modo così serrato); «se, infatti, tutte le cose sono false, risulterà falsa anche l’espressione “tutte le
cose sono false” essendo essa una di tutte le cose. Ed essendo falsa l’espressione “tutte le cose sono
false”, risulterà vera l’espressione opposta ad essa, ossia quella “non tutte le cose sono false”».
(Avrebbe dovuto però invece di pavnta, «tutte le cose», dire, in modo più preciso, pa`sai
ajpofavntei", «tutte le proposizioni»). Nell’Organo di Lambert, Vol. I, §§ 258 e 262, troviamo
un’affermazione simile e similmente dimostrata; e anche Bouterweck (Idea di un’apodittica, Vol. I,
pp. 375 e 378) aveva concezioni analoghe. D’altronde questa dimostrazione si potrebbe condurre
pure in altri modi. Per esempio, per provare che qualcosa è vero non è indispensabile servirsi
proprio della proposizione che tutto è falso ma si può scegliere una qualsiasi proposizione «A è B»
e osservare che se essa è falsa l’affermazione che lo è è invece vera. E in ogni caso potremmo far
notare a chi ritiene che nulla sia vero che se questo è vero c’è almeno una proposizione vera; se poi
65
qualcuno continuasse a dubitare, basterebbe fargli capire che le parole «Non ci sono
proposizioni…» contengono già una proposizione, ecc. Io non credo però che simili dimostrazioni
sarebbero più evidenti.
§ 32.
Dimostrazione che si danno più verità, anzi infinite
1) Dal § precedente risulta che si dà almeno una verità oggettiva, perché l’affermazione opposta
contraddice se stessa. Ma si dà forse una sola verità oggettiva – solo questa, che si dà una verità?
Ora per eliminare questo dubbio mostrerò che si danno più verità, anzi infinite.
2) Supponiamo infatti che qualcuno affermi che si dà una sola verità, e mi sia consentito,
comunque essa suoni, di indicare questa verità con «A è B»; mostrerò ora che accanto a essa se ne
dà almeno una seconda. Chi ammette l’opposto, infatti, deve considerare vera l’affermazione «A
parte la verità “A è B” non si dà nessun’altra verità», ma tale affermazione è chiaramente altra cosa
da «A è B», essendo formata da parti completamente diverse. Perciò se fosse vera sarebbe già una
seconda verità; dunque non è vero che si dà una sola verità, ma se ne danno almeno due.
3) Ma procedendo in questo modo si può dimostrare che nemmeno due verità possono
essere le sole. Comunque suonino queste due, infatti, è chiaro che l’affermazione «Niente è vero se
non le due proposizioni “A è B” e “C è D”» è una proposizione ben distinta sia da «A è B» che da
«C è D»; perciò se fosse vera questa proposizione costituirebbe immediatamente una nuova – e
quindi una terza – verità, per cui sarebbe un errore supporre che si diano solo due verità.
4) Si vede subito che questo tipo di ragionamento può proseguire all’infinito; ne segue che si
danno infinite verità perché l’ipotesi che esse formino un insieme finito comunque grande racchiude
in sé una contraddizione. Così, se supponiamo che qualcuno voglia ammettere solo n verità, queste,
comunque suonino (anche se una di esse consistesse, ove possibile, nell’affermazione che si danno
solo n verità), si possono rappresentare con le n formule A è B, C è D … Y è Z. Ora, se l’avversario
pretende che al di fuori di queste n proposizioni non possiamo ammettere come vero assolutamente
niente, affermerà qualcosa cui possiamo dare la seguente forma, «Al di fuori delle proposizioni “A
è B”, “C è D” … “Y è Z”, nessun’altra proposizione è vera». Ma questa proposizione è fatta in
modo tale che le sue parti costitutive sono, chiaramente, del tutto diverse da quelle delle n
proposizioni «A è B», «C è D» … «Y è Z», e dunque è essa stessa una proposizione completamente
diversa; perciò, in quanto la considera vera il nostro avversario distrugge egli stesso l’affermazione
che si danno solo n proposizioni vere. Questa infatti sarebbe la (n+1)-esima.
Osservazione. Questa dimostrazione (così facile da esporre) che si danno più verità, anzi
infinite, per quanto ne so non era mai stata utilizzata finora. A quanto pare si pensava di avere già
fatto abbastanza strappando allo scettico l’ammissione che si dà almeno una verità. D’altronde
anche questo tipo di dimostrazione è suscettibile di diverse varianti; infatti si può procedere,
evitando la forma apagogica, pure così: se la proposizione «A è B» è vera anche l’affermazione «La
proposizione che A è B è vera» è a sua volta una proposizione vera, e date le sue parti costitutive è
già un’altra rispetto ad «A è B», dunque è una seconda verità, distinta dalla prima. Inoltre da
qualsiasi proposizione vera della forma «A è B» si può derivare la proposizione «Perciò alcuni B
sono A» ponendo con ciò una nuova verità, diversa da quella data; e così via.
§ 33.
Risposta a diverse obiezioni
Immagino che ognuno concederà senza difficoltà che si danno più verità, anzi infinite, non appena
gli saranno stati tolti tutti i dubbi sulla correttezza della dimostrazione che se ne dà almeno una.
Tuttavia, dopo lunga riflessione potrebbero nascere dubbi e perplessità in qualche lettore che in un
primo momento era rimasto soddisfatto. Perciò qui presenterò tutti quei dubbi che riesco a farmi
venire in mente e cercherò di risolverli ed eliminarli.
66
1) «Se», potrebbe dire un dubbioso, «mi lasciassi indurre dalla dimostrazione che ho appena
letto a rinunciare da oggi in poi ai dubbi che ho avuto finora sull’esistenza di una qualsiasi verità,
mi sembra che procederei troppo frettolosamente. Infatti (a) per lasciarmi convincere da questa
dimostrazione (o da qualsiasi altra, comunque costruita) dovrei attribuirmi preliminarmente la
facoltà di riconoscere delle verità, e perciò stesso presupporre il risultato che qui si dovrebbe
ottenere, cioè che si danno verità in sé. (b) Per farmi convincere da questa dimostrazione dovrei
presupporre innanzitutto che il tipo specifico di ragionamento che vi viene utilizzato sia corretto;
perciò dovrei dare preliminarmente per vero il dictum de omni, o comunque vogliamo chiamare
l’assioma che questo ragionamento utilizza. (c) Infine, poiché in questa dimostrazione compare la
premessa che la concatenazione di concetti espressa dalle parole tutte le proposizioni sono false è
effettivamente una proposizione, dovrei anche ammettere preliminarmente la validità di questa
premessa – e dunque già diverse verità. Ma posso farlo senza contraddirmi?».
2) Ora intendo eliminare queste perplessità con le seguenti controosservazioni, con le quali
mostrerò al lettore che può accettare come ben fondata e senza cadere in contraddizione la
dimostrazione che gli ho fornito sopra.
a) Non è assolutamente necessario che per lasciarci convincere di una qualsiasi conclusione
da una dimostrazione (come per esempio quella esposta sopra) dobbiamo preliminarmente attribuire
a noi stessi la facoltà di distinguere la verità dall’errore, presupponendo con ciò la proposizione che
si danno verità in sé – almeno se questo significa che dovremmo avere già proferito o accettato il
giudizio «Si danno verità, e noi possiamo riconoscerne alcune». Perché la dimostrazione data sopra
ci convinca abbiamo solo bisogno di considerare attentamente le proposizioni che vi occorrono,
cosa che possiamo fare anche in una condizione di dubbio universale. Per il solo fatto di dirigere
l’attenzione dell’anima nostra verso queste proposizioni, ce ne sentiamo pienamente convinti e
riconosciamo che si danno verità in sé; e in quanto eleviamo questa convinzione appena nata in noi
a chiara consapevolezza, cioè accettiamo il giudizio che abbiamo tale convinzione, diventiamo
anche consapevoli di essere creature pensanti e di avere la facoltà di riconoscere la verità. È
senz’altro vero, d’altronde, che per essere convinti dalla dimostrazione data sopra è indispensabile
una facoltà conoscitiva; ma avere una facoltà conoscitiva è una cosa e dover partire dal presupposto
di averla è un’altra, in nessun modo necessaria, per cui non procediamo affatto circolarmente nella
nostra dimostrazione; e meno ancora ci si può obiettare di contraddirci. Ci sarebbe contraddizione
solo se alla fine della dimostrazione affermassimo qualcosa che all’inizio avevamo negato, ma non
ce n’è nessuna se alla fine affermiamo qualcosa che all’inizio non volevamo ancora asserire e di cui
anzi dubitavamo. Dubitare non significa ancora negare, e chi si trova in uno stato di dubbio
universale dubiterà dell’esistenza di verità oggettive e della nostra capacità di conoscerle, ma non
negherà né una cosa né l’altra. È anche vero, d’altronde, che noi non possiamo nello stesso istante
dubitare che si diano verità, nonché di avere la facoltà di conoscerle, ed essere invece convinti di
entrambe le cose; a questo arriveremo solo dopo, quando, considerando le proposizioni che questa
dimostrazione ci presenta, l’attenzione del nostro spirito sarà distolta dalle ragioni del dubbio, che
quindi la nostra coscienza perderà, e riconosceremo la verità a esso opposta. Né ci dobbiamo
preoccupare che quel dubbio ricompaia ogni volta che torniamo retrospettivamente sulle ragioni che
l’avevano prodotto all’inizio, perché ora queste ragioni le vedremo da un punto di vista diverso e
capiremo che non dimostravano ciò che avrebbero dovuto dimostrare.
b) Come non è assolutamente necessario che noi, per restare convinti di una dimostrazione,
presupponiamo l’esistenza di verità in sé e la nostra capacità di riconoscerne alcune, così nemmeno
è indispensabile che conosciamo preventivamente la correttezza di certe forme d’inferenza. È sì
indispensabile che tali forme d’inferenza siano corrette e che noi non dubitiamo di questa
correttezza, cioè che non riteniamo che potrebbero anche essere sbagliate; ma non si richiede
assolutamente che abbiamo già accolto l’opinione opposta, cioè appunto che siano corrette. Che le
cose stiano effettivamente così deve risultare chiaro anche per il dubbioso quando considera come
egli stesso si regola nel costruire questa obiezione. Anche qui infatti egli fa delle inferenze, cosa che
gli sarebbe impossibile se ogni passo inferenziale dovesse essere preceduto da un giudizio sulla
67
correttezza del procedimento che sta alla sua base. Ciò sarebbe possibile in un unico caso, cioè se
un dubbioso tenesse presente la dimostrazione data sopra senza restarne convinto perché dubita
della correttezza dei suoi passaggi. Ma tali passaggi sono talmente semplici, talmente normali per
noi umani, che di fatto ciò non può accadere per nessuno che non sia totalmente ottuso o pazzo. È
vero che ognuno può fare l’ipotesi di dubitare; ma in realtà nessuno che abbia una facoltà di
giudizio ben sviluppata può dubitare anche un solo istante dell’ammissibilità di inferenze di questo
tipo, dato che il pensiero che potrebbe indurlo a un simile dubbio sarebbe a sua volta un giudizio
costruito in base a quello stesso genere di inferenze.
c) Per quanto riguarda infine l’affermazione che il nesso concettuale espresso dalle parole
«Ogni proposizione è falsa» è già una proposizione, è senz’altro vero che noi l’usiamo come
premessa, ma ciò non danneggia in alcun modo la forza di convinzione della nostra dimostrazione.
Infatti anche questa proposizione possiede una verità, e – per chiunque – talmente chiara da non
poterne dubitare. È bensì vero che chi concede anche questa sola verità, fondamentalmente non
dovrebbe più avere bisogno di farsi ancora dimostrare che si danno delle verità. Ma il fatto è che
non sempre noi umani ci rendiamo conto subito e da soli di quanto manchiamo di rigore quando
affermiamo che non si danno verità. Tutto il merito della dimostrazione data sopra dovrebbe stare
perciò proprio nel renderci evidente tale non rigorosità – cosa che essa fa mettendoci davanti una di
quelle verità delle quali non possiamo in nessun modo dubitare. Ho già detto che ci sono anche
molte altre verità delle quali ci si potrebbe servire a questo scopo, ma quella che ho utilizzato qui ci
si presenta nel modo più naturale. In questa dimostrazione le inferenze sono così ovvie, e vengono
percorse con tale velocità, anche dalla persona meno esercitata, che non appena gli si dà il «via»
uno nemmeno si rende conto di fare inferenze (per l’esattezza, due) o che per poterle mettere in
moto sarebbe necessario introdurre e dare per vera una terza proposizione, cioè che la stessa
affermazione che niente è vero è una proposizione.
Osservazione. All’obiezione del n. 1 (a), si potrebbe ribattere che contraddice se stessa.
Infatti in quanto pone la domanda se le proposizioni e inferenze presenti nella nostra dimostrazione
non sembrino soltanto vere e corrette senza esserlo realmente, già presuppone che ci sia un essere
pensante e che quelle proposizioni e inferenze compaiano nella sua coscienza, nonché la possibilità
che non concordino con la verità in sé – dunque la possibilità che ci siano verità in sé, ecc. – Questa
osservazione è già stata fata anche da altri. Nella Teoria del sapere di Stiedenroth, per esempio
(Gottinga 1819, pp. 75-76), leggiamo che «lo scetticismo ha il suo punto d’appoggio
nell’opposizione di oggettivo e soggettivo. Perciò per costruire se stesso deve presupporre il
soggetto come cosa certa. Ma dal punto di vista filosofico per lo scettico il soggettivo dovrebbe
essere altrettanto incerto dell’oggettivo; egli dovrebbe trattare l’esistenza del soggetto come
semplice ipotesi. Ma se gli crolla la certezza di se stesso come soggetto, crolla pure l’opposizione
fra oggettivo e soggettivo e con ciò l’intero scetticismo, che senza tale opposizione non può
sostenersi». – Ma per quanto corretto, secondo me tutto questo non basta da solo a guarire dallo
scetticismo. Infatti in quanto mostriamo al dubbioso che nelle sue inferenze egli si contraddice, gli
diamo solo una nuova dimostrazione di quanto sia confuso il sistema dei suoi pensieri, e ancor più
egli dubiterà della correttezza di qualsiasi successione di inferenze, per quanto stringente. Per
risanarlo dobbiamo guidarlo invece verso inferenze che dipendano solo da se stesse e risolvere le
contraddizioni che gli si presentano; è proprio questo che ho cercato di fare finora (con quale
fortuna, lo decidano i lettori). – Negli scritti degli scettici, e in particolare in Sesto Empirico,
s’incontrano tentativi di tutti i generi di confutare la proposizione che esistono verità o di far vedere
che la loro esistenza è indimostrabile. Qui presenterò due dei più notevoli di questi tentativi, che
tuttavia non mi sembrano tali da poter nuovamente distruggere le convinzioni acquisite di uno che
non li sapesse controbattere. (a) Negli Schizzi pirroniani (II, 9), Sesto afferma che è impossibile
dimostrare che una cosa è vera perché la dimostrazione dovrebbe presupporre appunto di essere
essa stessa vera. – Rispondo che noi non ammettiamo arbitrariamente che una dimostrazione sia
vera o falsa (o meglio corretta o scorretta) e la forza di convinzione di una dimostrazione corretta
non le viene da questa arbitraria ammissione iniziale. Perciò è falso che nel dare questa
68
dimostrazione noi presupponiamo già, secondo l’accusa di Sesto, che essa sia vera (o corretta).
Questo lo si vede solo alla fine, dopo che l’abbiamo ascoltata, quando ce ne sentiamo convinti.
Perciò chi volesse asserire che la nostra dimostrazione è scorretta dovrebbe mostrare che non ha
prodotto questo senso di convincimento. (b) In Contro i logici (II, 15 s.), Sesto cerca di mostrare
ancora più dettagliatamente come sia impossibile convincersi che qualcosa sia vero: «Quando
qualcuno afferma che si danno delle verità, presenta questa affermazione o senza dimostrazione o
con una dimostrazione. Se senza dimostrazione, deve essere consentito porre senza dimostrazione
anche la tesi opposta, cioè che non si danno verità. Se con una dimostrazione, chiedo: con una falsa
o una vera? Se con una falsa, l’intera affermazione non vale niente. Se con una vera, domando: con
che cosa ha potuto dimostrare che la sua dimostrazione è vera? Con un’altra dimostrazione? Ma
così ce ne vorrebbe sempre una nuova, per cui il nostro lavoro non potrebbe mai finire». – Qui
concedo tutto fino a quella che viene tacitamente considerata l’unica risposta possibile alla
domanda «Con che cosa ha potuto dimostrare che la sua dimostrazione è vera?», cioè «Con una
nuova dimostrazione». Invece di dare questa risposta, infatti, si deve controbattere «Che una
dimostrazione sia vera (o corretta) non va a sua volta dimostrato, ma nella misura in cui essa è tale
alla fine il lettore se ne sentirà convinto, e tanto più intimamente quanto più ci ripenserà. È per
questo effetto, e non per una nuova dimostrazione, che conclude che la dimostrazione è corretta».
69
Arthur Schopenhauer
(1788-1860)
Dialettica (ms. 1830-1)
lingua originale: tedesco
ed. di riferimento: A. Hübscher (1864)
tr. it. N. Curcio e F. Volpi, Adelphi, Milano, 2006
La dialettica eristica è l'arte di disputare, e precisamente l'arte di disputare in modo da ottenere
ragione, dunque per fas et nefas [con mezzi leciti e illeciti]. Si può infatti avere ragione objective,
nella cosa stessa, e tuttavia avere torto agli occhi dei presenti e talvolta perfino ai propri. Ciò accade
quando l'avversario confuta la mia prova, e questo vale come se avesse confutato anche
l'affermazione, della quale però si possono dare altre prove; nel qual caso, naturalmente, per
l'avversario la situazione si presenta rovesciata: egli ottiene ragione pur avendo oggettivamente
torto. Dunque, la verità oggettiva di una proposizione e la validità della medesima
nell'approvazione dei contendenti e degli uditori sono due cose diverse. (A quest'ultima è rivolta la
dialettica). Da che cosa deriva tutto questo? Dalla naturale cattiveria del genere umano. Se questa
non ci fosse, se nel nostro fondo fossimo leali, in ogni discussione cercheremmo solo di portare alla
luce la verità, senza affatto preoccuparci se questa risulta conforme all'opinione presentata in
precedenza da noi o a quella dell'altro: diventerebbe indifferente o, per lo meno, sarebbe una cosa
del tutto secondaria. Ma qui sta il punto principale. L'innata vanità, particolarmente suscettibile per
ciò che riguarda l'intelligenza, non vuole accettare che quanto da noi sostenuto in principio risulti
falso, e vero quanto sostiene l'avversario. Se così fosse, ciascuno non dovrebbe fare altro che
cercare di pronunciare soltanto giudizi giusti: quindi dovrebbe prima pensare e poi parlare. Ma, nei
più, all'innata vanità si accompagna una loquacità e una slealtà connaturata. Essi parlano prima di
avere pensato, e se anche poi si accorgono che la loro affermazione è falsa e hanno torto, deve
nondimeno apparire come se fosse il contrario. L'interesse per la verità, che nella maggioranza dei
casi è stato l'unico motivo per sostenere la tesi ritenuta vera, cede ora completamente il passo
all'interesse della vanità: il vero deve apparire falso e il falso vero. Tuttavia anche questa slealtà,
anche l'insistere su una tesi che già a noi stessi appare falsa, può trovare una scusante: molte volte,
all'inizio siamo fermamente convinti della verità della nostra affermazione; ma ora l'argomento
dell'avversario sembra rovesciarla: abbandonando però subito la nostra causa, spesso ci accorgiamo
poi che avevamo invece ragione; la nostra prova era falsa, ma per quella affermazione era possibile
darne una giusta: l'argomento risolutore non ci era venuto in mente subito. Perciò, si afferma ora in
noi la massima di continuare ugualmente a combattere contro l'argomento contrario, anche quando
esso appare giusto e decisivo, confidando sul fatto che la sua pertinenza sia anch'essa soltanto
apparente, e che durante la disputa ci verrà in mente un altro argomento per rovesciarlo, oppure per
confermare altrimenti la nostra verità: siamo così quasi costretti, o almeno facilmente indotti, alla
slealtà nel disputare. In questo modo, la debolezza del nostro intelletto e la stortura della nostra
volontà si sorreggono a vicenda. Ne deriva che, di regola, chi disputa non lotta per la verità, ma per
imporre la propria tesi, come pro ara et focis [per la casa e il focolare], e procede per fas et nefas,
perché, come si è mostrato, non può fare diversamente. Dunque, di regola ciascuno vorrà far
prevalere la propria affermazione, anche quando per il momento gli appare falsa o dubbia; e i mezzi
per riuscirvi sono, in certa misura, offerti a ciascuno dalla propria astuzia e cattiveria: a insegnarli è
l'esperienza quotidiana nel disputare. Ciascuno ha dunque la propria dialettica naturale, così come
ciascuno ha una propria logica naturale. Ma la prima non è una guida altrettanto certa della seconda.
Nessuno penserà o inferirà tanto facilmente contro le leggi della logica: falsi giudizi sono frequenti,
falsi sillogismi estremamente rari. Perciò, non capita tanto facilmente che qualcuno mostri una
deficienza di logica naturale; capita, invece, di riscontrare deficienze nella dialettica naturale:
71
quest'ultima è una dote naturale distribuita in modo diseguale (in ciò simile alla facoltà del giudizio,
spartita in maniera assai diseguale, e lo stesso capita in realtà anche per la ragione). Infatti, accade
spesso che ci si lasci confondere e confutare da argomentazioni solo apparenti, mentre in realtà si ha
ragione, oppure il contrario: e chi esce vincitore da una disputa molto spesso lo deve non tanto
all'esattezza del suo giudizio nell'esporre la propria tesi, quanto all'astuzia e alla destrezza con cui
l'ha sostenuta. Qui, come sempre, la cosa migliore è ciò che è innato: tuttavia l'esercizio e anche la
riflessione sulle frasi con cui demolire l'avversario, o quelle da lui più adoperate per demolire,
possono essere di grande aiuto per diventare maestri in questa arte. Dunque, anche se la logica non
può avere una vera e propria utilità pratica, può senz'altro averla la dialettica. Mi sembra che anche
Aristotele abbia posto la sua logica (analitica) principalmente come base e preparazione alla
dialettica, e che questa sia stata per lui la cosa capitale. La logica si occupa della mera forma delle
proposizioni, la dialettica del loro contenuto o materia: proprio per questo la considerazione della
forma, in quanto considerazione dell'universale, doveva precedere quella del contenuto in quanto
considerazione del particolare.
Aristotele non stabilisce lo scopo della dialettica così nettamente come ho fatto io: egli indica, è
vero, come scopo principale il disputare, ma al tempo stesso anche il reperimento della verità
(Topici, I, 2). In seguito dice ancora (Topici, I, 12): le tesi si considerino, filosoficamente, secondo
verità; dialetticamente, secondo l'apparenza o l'approvazione, l'opinione altrui. Egli è consapevole
della distinzione e della separazione fra la verità oggettiva di una proposizione e il far valere la
medesima o l'ottenerne l'approvazione: però non le tiene distinte abbastanza nettamente da
assegnare alla dialettica solo il secondo fine. Perciò alle sue regole per ottenere questo, se ne
mescolano spesso altre per ottenere il primo. Quindi mi sembra che egli non abbia assolto in modo
limpido il suo compito. Nei Topici, Aristotele ha affrontato la formulazione della dialettica, con lo
spirito scientifico che lo contraddistingue, in modo assai metodico e sistematico; ciò merita
ammirazione, sebbene lo scopo, che qui è evidentemente pratico, non si possa considerare
completamente raggiunto. Dopo avere considerato negli Analitici i concetti, i giudizi e i sillogismi
secondo la pura forma, egli passa al contenuto, dove si ha a che fare propriamene solo con i
concetti: perché è in questi che risiede il contenuto. Proposizioni e sillogismi, presi per sé, sono
mera forma: i concetti sono il loro contenuto. Procede nel modo seguente. Ogni disputa ha una tesi
o un problema (questi differiscono solo nella forma), e poi proposizioni che devono servire a
risolverli. Qui si tratta sempre del rapporto di concetti fra loro. Tali rapporti sono anzitutto quattro.
Di un concetto si cerca cioè 1) la sua definizione; oppure 2) il suo genere; oppure 3) il suo
connotato peculiare, la sua nota essenziale, il proprium; oppure 4) il suo accidens, cioè una qualche
proprietà, non importa se peculiare ed esclusiva o meno, in breve: un predicato. Il problema di ogni
disputa è riconducibile a uno di tali rapporti. Questa è la base dell'intera dialettica. Negli otto libri
dei Topici Aristotele presenta tutti i rapporti in cui i concetti possono reciprocamente stare in quei
quattro rispetti, e indica le regole per ciascun possibile rapporto; come cioè un concetto debba
rapportarsi a un altro per essere il suo proprium, il suo accidens, il suo genus, il suo definitum o
definizione: quali errori è facile commettere nell'esposizione, che cosa si debba quindi osservare
ogni volta che stabiliamo un tale rapporto, e che cosa invece si possa fare per demolirlo quando sia
stato l'altro a stabilirlo. Egli chiama topos, locus, la presentazione di ognuna di tali regole o di
ognuno di tali rapporti generali di quei concetticlasse fra loro, e indica topos: da cui il nome di
Topici. Aggiunge poi alcune regole generali sul disputare, le quali tuttavia non sono affatto
esaurienti. Il topos non è dunque puramente materiale, non si riferisce a un oggetto o a un concetto
determinato, ma riguarda sempre un rapporto di intere classi di concetti; tale rapporto può essere
comune a innumerevoli concetti, non appena questi, come accade in ogni disputa, vengano
considerati l'uno in rapporto all'altro sotto uno dei quattro rispetti menzionati. E questi quattro
rispetti hanno a loro volta classi subordinate. La trattazione è qui dunque ancora in una certa misura
formale, anche se non così puramente formale come nella logica, poiché si occupa del contenuto dei
concetti, ma in una maniera formale: essa indica cioè come il contenuto del concetto A si debba
rapportare a quello del concetto o affinché questo possa essere presentato come il suo genus, o
72
come il suo proprium (carattere distintivo), o il suo accidens, o la sua definizione, o secondo le
rubriche, ad essi subordinate, di opposto, causa ed effetto, proprietà e privazione e così via. Intorno
a un tale rapporto deve ruotare ogni disputa. La maggior parte delle regole da lui appunto indicate
come topos riguardanti questi rapporti, sono tali da essere insite nella natura dei rapporti concettuali
di cui ciascuno è consapevole da sé e tali che, proprio come accade nella logica, già da sé ciascuno
ne esige il rispetto da parte dell'avversario; è più facile osservare tali regole nel caso particolare o
accorgersi se esse vengono trascurate, che ricordarsi del topos astratto corrispondente: proprio per
questo l'utilità pratica di tale dialettica è modesta. Egli dice quasi sempre cose che si capiscono da
sé e che la sana ragione arriva a osservare da sé.
Esempi: “ Se di una cosa viene affermato il genus, allora ad essa deve convenire anche una qualche
species di questo genus: se questo non è, allora l'affermazione è falsa. Per esempio: si afferma che
l'anima è dotata di movimento; allora deve esserle propria una determinata specie di movimento,
volare, camminare, crescere, diminuire ecc.; se non è così, allora essa non è dotata di alcun
movimento. Dunque, a ciò a cui non conviene alcuna species, non conviene neanche il genus:
questo è il topos “ [Topici, II, 4]. Questo topos vale sia per stabilire, sia per demolire. E il nono
topos. E inversamente: se non conviene il genus, non conviene nemmeno alcuna species. Per
esempio: qualcuno avrebbe (così si afferma) parlato male di qualcun altro: se dimostriamo che egli
non ha parlato affatto, allora non ha nemmeno parlato male: infatti dove non c'è il genus non può
esserci nemmeno la species.
All'interno della rubrica sul proprium, il locus 215 dice così: “In primo luogo per demolire: quando
l'avversario indica come "proprio" qualcosa che si può percepire solo con i sensi, allora esso è
indicato male: infatti tutto ciò che è sensibile diventa incerto non appena esso esce dall'ambito dei
sensi: per esempio egli pone come "proprio" del sole la caratteristica di essere la stella più luminosa
che passa sopra la terra: questo non va bene, perché quando il sole è tramontato noi non sappiamo
se esso passi sopra la terra, in quanto è fuori dalla portata dei sensi. In secondo luogo per stabilire: il
"proprio" viene indicato correttamente quando si sostiene una cosa che non va conosciuta con i
sensi, oppure, se lo è, è però presente in modo necessario: ad esempio, come proprio della
superficie si indichi che essa è innanzitutto colorata; questa è sì una connotazione sensibile, ma tale
da essere evidentemente sempre presente, dunque giusta “ [Topici, V, 5, 131b19-36]. Questo per
offrirvi un'idea della dialettica di Aristotele. Non mi pare che essa raggiunga lo scopo: io ho dunque
tentato di raggiungerlo in un altro modo.
I Topici di Cicerone sono un'imitazione a memoria di quelli aristotelici: assai superficiale e povera:
Cicerone non ha proprio alcun concetto chiaro di che cosa sia e a che cosa miri un topos, e così
raccatta alla rinfusa ex ingenio ogni sorta di discorso e lo adorna riccamente con esempi giuridici.
Uno dei suoi scritti peggiori. Per formulare la dialettica in modo limpido bisogna considerarla,
senza badare alla verità oggettiva (che è oggetto della logica), semplicemente come l'arte di ottenere
ragione, la qual cosa sarà certo tanto più facile se si ha oggettivamente ragione. Ma la dialettica
come tale deve insegnare solo come difendersi da attacchi di ogni genere, in particolare da quelli
sleali, e parimenti come si possa noi stessi attaccare ciò che l'altro afferma, senza cadere in
contraddizione e, soprattutto, senza essere confutati. Bisogna separare in modo netto il reperimento
della verità oggettiva dall'arte di imporre come vere le proprie tesi: la prima è oggetto di una
trattazione affatto diversa, è opera della facoltà del giudizio, della riflessione, dell'esperienza, e per
questo non c'è alcuna arte specifica: la seconda invece è il fine della dialettica.
Quest'ultima è stata definita la logica della parvenza: è falso perché, se così fosse, servirebbe
unicamente a tesi false. Invece, anche quando si ha ragione si ha bisogno della dialettica per
sostenerla e si deve conoscere gli stratagemmi sleali per opporvisi: anzi, spesso bisogna anche farne
uso per battere l'avversario con le sue stesse armi. Per questo, dunque, nella dialettica la verità
oggettiva va messa da parte o considerata come accidentale, e bisogna badare solo a come difendere
le proprie affermazioni e rovesciare quelle dell'altro: nello stabilire le regole della dialettica non si
deve prendere in considerazione la verità oggettiva, perché per lo più si ignora dove essa si trovi:
noi stessi sovente non sappiamo se abbiamo ragione o no, spesso crediamo di averla e ci
73
inganniamo, spesso lo credono entrambe le parti: infatti veritas est in puteo (la verità sta nel
profondo, Democrito, secondo Diogene Laerzio, IX, 72): quando sorge la disputa, di regola
ciascuno crede di avere la verità dalla propria parte: in seguito entrambi diventano dubbiosi: solo
alla fine si vedrà e verrà sancita la verità. Dunque la dialettica non deve avventurarsi nella verità:
alla stessa stregua del maestro di scherma, che non considera chi abbia effettivamente ragione nella
contesa che ha dato origine al duello: colpire e parare, questo è quello che conta. Lo stesso vale
anche nella dialettica, che è una scherma spirituale; solo se intesa in modo così puro, può essere
costituita come una disciplina propria: infatti, se ci poniamo come fine la pura verità oggettiva,
ritorniamo alla mera logica: se invece poniamo come fine l'affermazione di tesi false, abbiamo la
mera sofistica. E in entrambi i casi il presupposto sarebbe che noi sapessimo già che cosa è
oggettivamente vero e falso: ma solo di rado questo è certo in anticipo.
Il vero concetto della dialettica è dunque quello formulato: scherma spirituale per ottenere ragione
nel disputare. Sebbene il nome di eristica sia più appropriato, il più esatto è dialettica eristica:
dialectica eristica. Ed è di grande utilità: a torto nei tempi più recenti la si è trascurata. In questo
senso, la dialettica deve semplicemente essere una ricapitolazione ed esposizione, ricondotta a un
sistema e a regole, di quelle tecniche, suggerite dalla natura, di cui la maggior parte della gente,
quando nella contesa si accorge che la verità non sta dalla sua, si serve per ottenere ugualmente
ragione. E anche per questo motivo che sarebbe del tutto inopportuno se nella dialettica scientifica
si volesse avere riguardo della verità oggettiva e del suo venire alla luce, dal momento che non è
questo ciò che accade in quella dialettica originaria e naturale il cui scopo è invece semplicemente
l'avere ragione. Il compito principale della dialettica scientifica, così come la intendiamo noi, è
perciò quello di presentare e analizzare gli stratagemmi della slealtà nel disputare, affinché nelle
dispute reali li si riconosca e li si annienti subito. Proprio per questo, nella sua esposizione, essa
deve dichiaratamente assumere come proprio fine ultimo solo l'avere ragione, non la verità
oggettiva. Per quanto abbia cercato in lungo e in largo, non mi risulta che sia mai stato fatto
qualcosa in questo senso: si tratta quindi di un terreno ancora vergine. Per raggiungere lo scopo, si
dovrebbe attingere all'esperienza, osservando il modo in cui, nelle dispute che si verificano spesso
intorno a noi, questo o quello stratagemma viene adoperato dall'una e dall'altra parte in causa,
quindi si dovrebbero ricondurre alla loro struttura generale gli stratagemmi che ritornano sotto altre
forme, ed esporre così certi stratagemata generali, utili poi sia per essere usati a proprio vantaggio,
sia per essere sventati quando ne fa uso l'avversario. Quanto segue va considerato come un primo
tentativo.
LA BASE DI OGNI DIALETTICA
Innanzitutto bisogna considerare ciò che è essenziale in ogni disputa, ciò che veramente accade
durante una disputa. L'avversario (o noi stessi, è uguale) ha presentato una tesi. Per confutarla ci
sono due modi e due vie.
1) I modi: a) ad rem, b) ad hominem o ex concessis: cioè noi mostriamo che la tesi non concorda
con la natura delle cose, con la verità oggettiva assoluta, oppure che non concorda con altre
affermazioni o ammissioni dell'avversario, cioè con la verità soggettiva relativa: quest'ultima è una
dimostrazione solo relativa e non stabilisce nulla in merito alla verità oggettiva.
2) Le vie: a) confutazione diretta, b) confutazione indiretta. La confutazione diretta attacca la tesi
nei suoi fondamenti, quella indiretta nelle sue conseguenze: quella diretta mostra che la tesi non è
vera, quella indiretta che essa non può essere vera. a) Nella confutazione diretta possiamo fare due
cose. O mostriamo che i fondamenti della sua affermazione sono falsi (nego majorem; minorem);
oppure ammettiamo i fondamenti, ma mostriamo che l'affermazione non ne consegue (nego
consequentiam), cioè attacchiamo la conseguenza, la forma dell'inferenza. b) Nella confutazione
indiretta adoperiamo o l'apagoge o la istanza.
a) Apagoge: noi assumiamo la tesi dell'avversario come vera: poi mostriamo che cosa ne consegue
se, unita a qualche altra proposizione riconosciuta come vera, la adoperiamo come premessa per un
sillogismo da cui discende una conclusione palesemente falsa in quanto contraddice la natura delle
74
cose o le altre affermazioni dell'avversario, ed è dunque falsa ad rem o ad hominem (Socrate in
Ippia maggiore e altrove) : di conseguenza anche la tesi era falsa. Infatti, da premesse vere possono
conseguire solo proposizioni vere, mentre da premesse false non sempre conseguono conclusioni
false. (Se essa contraddice addirittura una verità assolutamente indubitabile, allora abbiamo
condotto l'avversario ad absurdum).
b) L'istanza, exemplum in contrarium: confutazione della tesi generale mediante indicazione diretta
di casi compresi nella sua enunciazione, per i quali però essa non vale. La tesi generale deve perciò
essere falsa.
Questa è l'impalcatura di base, lo scheletro di ogni disputa: abbiamo dunque la sua osteologia.
Infatti a ciò si riconduce in fondo ogni disputare: ma tutto questo può avvenire effettivamente o solo
in apparenza, con ragioni autentiche o meno: e poiché su questo punto non è facile stabilire
qualcosa di sicuro, le dispute sono lunghe e ostinate. Neppure nel dare istruzioni possiamo separare
ciò che è vero da ciò che è apparente perché, per l'appunto, di questo i contendenti non sono mai
certi in anticipo. Perciò io offro degli stratagemmi senza badare al fatto se objective si abbia ragione
o torto: infatti non possiamo saperlo con certezza nemmeno noi stessi e deve essere stabilito proprio
mediante la contesa. Del resto, in ogni disputa, o in ogni argomentazione in genere, bisogna essere
d'accordo su qualche cosa che si prende come principio per giudicare la questione di cui si tratta:
contra negantem principia non est disputandum [non si disputi con uno che nega i princìpi di
partenza].
STRATAGEMMA N. 1
L'ampliamento. Portare l'affermazione dell'avversario al di fuori dei suoi limiti naturali,
interpretarla nella maniera più generale possibile, prenderla nel senso più ampio possibile ed
esagerarla; restringere invece la propria affermazione nel senso più circoscritto possibile e nei limiti
più ristretti: perché quanto più un'affermazione diventa generale, tanto più essa presta il fianco ad
attacchi. L'antidoto è la precisa formulazione del punctus o status controversiae.
Esempio 1. Io dissi: “Gli Inglesi sono la prima nazione nel genere drammatico “. L'avversario volle
tentare una instantia e ribatté: “E noto che nella musica, e di conseguenza anche nell'opera, essi non
hanno saputo combinare nulla”. Io gli replicai ricordandogli “che la musica non è compresa nel
genere drammatico; questo designa solo la tragedia e la commedia”: cosa che egli sapeva molto
bene, e quindi tentava solo di generalizzare la mia affermazione in modo che comprendesse tutte le
rappresentazioni teatrali, di conseguenza l'opera e la musica, per poi battermi con sicurezza. Se
invece l'espressione da noi usata lo favorisce, si salvi la propria affermazione restringendola oltre la
primitiva intenzione.
Esempio 2. A dice: “La pace del 1814 restituì persino a tutte le città anseatiche tedesche la loro
indipendenza “. B dà la instantia in contrarium, cioè che con quella pace Danzica perse
l'indipendenza conferitale da Bonaparte. A si salva così: Ho detto tutte le città anseatiche tedesche:
Danzica era una città anseatica polacca”. Questo stratagemma si trova già in Aristotele, Topici,
VIII, 12.
Esempio 3. Lamarck (Philosophie zoologique, [Paris, 1809], vol. I, p. 203) nega ai polipi ogni
sensazione poiché privi di nervi. Ora, però, è certo che essi percepiscono, infatti seguono la luce
mentre procedono con la loro tecnica di ramo in ramo; e afferrano la loro preda. Si è perciò
supposto che in essi la massa nervosa sia diffusa in ugual misura nella massa dell'intero corpo e, per
così dire, vi sia fusa assieme: infatti essi hanno evidentemente percezioni senza avere organi di
senso distinti. Poiché ciò ribalta l'ipotesi di Lamarck, egli argomenta dialetticamente così: “Allora
tutte le parti del corpo del polipo dovrebbero essere capaci di ogni specie di sensazione e anche di
movimento, di volontà, di pensiero: allora il polipo avrebbe in ogni punto del suo corpo tutti gli
organi dell'animale più completo: ogni punto potrebbe vedere, annusare, gustare, sentire e così via,
anzi, pensare, giudicare, inferire: ogni particella del suo corpo sarebbe un animale completo e il
polipo stesso starebbe al di sopra dell'uomo, poiché ogni sua cellula avrebbe tutte le facoltà che
l'uomo ha solo nel suo insieme. Non ci sarebbe inoltre alcun motivo per non estendere quanto si
75
afferma sui polipi anche alla monade, il più imperfetto di tutti gli esseri, e infine anche alle piante,
le quali pure vivono, e così via”. Con l'uso di tali stratagemmi dialettici uno scrittore tradisce
l'intima consapevolezza di avere torto. Poiché si è detto: Il suo intero corpo è sensibile alla luce, ed
è perciò di natura nervosa”, egli ne evince che l'intero corpo pensa.
STRATAGEMMA N. 2
Usare l'omonimia per estendere l'affermazione presentata anche a ciò che, al di là del nome uguale,
poco o nulla ha in comune con la cosa in questione; poi darne una confutazione lampante, e così
fingere di avere confutato l'affermazione. Nota: synonyma sono due parole indicanti il medesimo
concetto; homonyma due concetti indicati dalla medesima parola (vedi Aristotele, Topici, I, 13).
Profondo, tagliente, alto, usati ora per corpi ora per suoni, sono homonyma. Sincero e leale sono
synonyma. Questo stratagemma può essere considerato identico al sofisma ex homonymia: tuttavia
il sofisma palese dell'omonimia non trarrà seriamente in inganno.
Ogni lume può essere spento; / L'intelletto è un lume; / L'intelletto può essere spento.
Qui si nota subito che ci sono quattro termini: lumen in senso proprio e lumen inteso in senso
figurato. Ma nei casi sottili questo sofisma inganna certamente, soprattutto dove i concetti indicati
dalla medesima espressione sono affini e si sovrappongono l'uno all'altro.
Esempio 1. (I casi inventati appositamente non sono abbastanza sottili da essere ingannevoli;
bisogna dunque trarli dalla propria esperienza concreta. L'ottimo sarebbe poter distinguere ogni
stratagemma con un nome conciso e calzante, a cui si potrebbe ricorrere, al momento opportuno,
per respingere in un batter d'occhio l'uso di questo o quello stratagemma).
A: Lei non è ancora iniziato ai misteri della filosofia kantiana.
B: Ah, dove ci sono misteri, io non voglio saperne nulla.
Esempio 2. Io biasimavo il principio d'onore, giudicando incomprensibile che chi subisce una
offesa perda l'onore a meno che non la ricambi con una offesa maggiore o che non lavi l'onta con il
sangue, quello del nemico o il proprio; come ragione addussi che il vero onore non può essere ferito
da ciò che si subisce, ma soltanto da ciò che si fa; perché a chiunque di noi può succedere di tutto.
L'avversario attaccò direttamente la mia ragione: egli mi dimostrò in modo lampante che se si
calunniasse un commerciante dicendo che imbroglia o commette illegalità, o che è negligente nel
suo mestiere, questo sarebbe un attacco al suo onore che qui verrebbe ferito unicamente per ciò che
egli subisce, e che egli potrebbe ripristinare soltanto facendo punire tale calunniatore o
costringendolo a smentire l'accusa. Qui egli scambiò dunque, per l'omonimia, l'onore civile, che si
chiama altrimenti buon nome e che viene offeso col discredito, con il concetto di onore
cavalleresco, chiamato anche point d'honneur e che viene offeso con le ingiurie. E poiché un attacco
al primo non può essere trascurato, ma deve essere respinto con la pubblica confutazione, con lo
stesso diritto anche un attacco al secondo non dovrebbe rimanere ignorato, ma dovrebbe essere
respinto con un'ingiuria più forte e con il duello. Dunque: una confusione di due cose
essenzialmente diverse favorita dall'omonimia della parola onore: e così l'omonimia dà origine a
una mutatio controversiae.
STRATAGEMMA N. 3
Prendere l'affermazione presentata in modo relativo, come se fosse presentata universalmente,
simpliciter, absolute, o almeno intenderla sotto tutt'altro aspetto e confutarla poi in questo secondo
senso. L'esempio di Aristotele è: il moro è nero, ma quanto ai denti è bianco: dunque egli è allo
stesso tempo nero e non nero. E un esempio inventato, che non ingannerebbe sul serio nessuno:
prendiamone invece uno dall'esperienza concreta.
Esempio. In una conversazione di filosofia ammisi che il mio sistema difende e loda i quietisti.
Poco dopo il discorso cadde su Hegel, e io affermai che la maggior parte delle cose da lui scritte
sono insensate o, almeno, che molti passi dei suoi scritti sono tali che l'autore butta lì le parole e il
senso deve mettercelo il lettore. L'avversario non si avventurò a confutare ciò ad rem, ma si
76
contentò di proporre quest'argumentum ad hominem: io avevo appena lodato i quietisti, e anch'essi
avevano scritto molte cose insensate. Ammisi questo fatto, ma corressi l'avversario dicendo che non
lodo i quietisti come filosofi o scrittori, cioè non per le loro imprese teoretiche, ma soltanto come
uomini, per il loro agire, solo dal punto di vista pratico: nel caso di Hegel invece si parla di imprese
teoretiche. L'attacco venne così parato.
I primi tre stratagemmi sono affini: essi hanno in comune il fatto che l'avversario parla in realtà di
qualcosa d'altro rispetto a ciò che è stato affermato: si incorrerebbe dunque in una ignoratio elenchi
[ignoranza della confutazione] se ci si facesse liquidare da tali stratagemmi. Infatti, in tutti gli
esempi presentati, quello che dice l'avversario è vero: non è però in contraddizione effettiva ma solo
apparente con la tesi; chi è da lui attaccato quindi nega la consequenzialità della sua conclusione:
cioè che dalla verità della sua tesi discenda la falsità della nostra. Si tratta dunque di una
confutazione diretta della sua confutazione per negationem consequentiae.
Non ammettere premesse vere poiché se ne prevede la conseguenza. Come antidoto dunque i due
seguenti mezzi, le regole 4 e 5.
Quando si vuole trarre una certa conclusione non la si lasci prevedere, ma si faccia in modo che
l'avversario ammetta senza accorgersene le premesse una per volta e in ordine sparso, altrimenti
tenterà ogni sorta di cavilli; oppure, quando non si è certi che l'avversario le ammetta, si presentino
le premesse di queste premesse, si facciano presillogismi, ci si faccia ammettere le premesse di
molti di questi presillogismi senza ordine e confusamente, si occulti dunque il proprio gioco finché
non è stato ammesso tutto ciò di cui si ha bisogno. Si arrivi insomma al dunque partendo da
lontano. Queste regole le dà Aristotele in Topici, VIII, 1.
Non occorrono esempi.
STRATAGEMMA N. 5
Per dimostrare la propria tesi ci si può servire anche di premesse false, e ciò quando l'avversario
non ammetterebbe quelle vere, o perché non ne riconosce la verità oppure perché vede che la nostra
tesi ne conseguirebbe immediatamente: si prendano allora tesi in sé false ma vere ad hominem, e si
argomenti ex concessis a partire dal modo di pensare dell'avversario. Infatti il vero può conseguire
anche da premesse false, ma mai il falso da premesse vere. Allo stesso modo si possono confutare
tesi false dell'avversario per mezzo di altre tesi false, che egli però ritiene vere: infatti si ha a che
fare con lui e bisogna servirsi del suo modo di pensare. Per esempio: se egli è seguace di qualche
setta alla quale noi non aderiamo, possiamo adoperare contro di lui, come principia, le massime di
questa setta. Aristotele, Topici, VIII, 9. (Rientra nel precedente stratagemma).
STRATAGEMMA N. 6
Si fa una petitio principii occulta postulando ciò che si dovrebbe dimostrare: 1) usando un altro
nome, ad esempio buon nome al posto di onore, virtù al posto di verginità, e così via; o anche
concetti interscambiabili: animali dal sangue rosso al posto di vertebrati; 2) oppure facendo in modo
che ci venga concesso in generale ciò che nel caso particolare è controverso, ad esempio: si afferma
l'incertezza della medicina postulando l'incertezza di ogni sapere umano; 3) quando vice versa due
cose conseguono l'una dall'altra, e si deve dimostrare la prima, postulando la seconda; 4) quando si
deve dimostrare l'universale, facendosi ammette
re ogni singolare (il contrario del n. 2). (Aristotele, Topici, VIII, 11). Sull'esercizio della dialettica
contiene buone regole l'ultimo capitolo dei Topici di Aristotele.
Quando la disputa è condotta in modo piuttosto rigoroso e formale e ci si vuole far intendere molto
chiaramente, colui che ha presentato l'affermazione e deve dimostrarla procede contro l'avversario
ponendo domande, per concludere la verità dell'affermazione dalle stesse ammissioni
dell'avversario. Questo metodo erotematico era particolarmente in uso presso gli antichi (si chiama
anche metodo socratico): ad esso si rifà il presente stratagemma e alcuni che seguiranno più avanti.
(Completamente e Uberamente rielaborato dal capitolo 15 del Liber de elenchis sophisticis di
Aristotele). Domandare in una sola volta e in modo particolareggiato molte cose, così da occultare
77
ciò che in realtà si vuole che venga ammesso. Esporre invece rapidamente la propria
argomentazione a partire da ciò che è stato ammesso: così coloro che sono lenti di comprendonio
non riescono a seguire esattamente e non si accorgono di eventuali errori o lacune
nell'argomentazione.
STRATAGEMMA N. 8
Suscitare l'ira dell'avversario, perché nell'ira egli non è più in condizione di giudicare rettamente e
di percepire il proprio vantaggio. Si provoca la sua ira facendogli apertamente torto, tormentandolo
e, in generale, comportandosi in modo sfacciato.
STRATAGEMMA N. 10
Ci si accorge che l'avversario risponde di proposito negativamente alle domande, perché la risposta
affermativa potrebbe essere utilizzata per la nostra tesi. In tal caso bisogna chiedere il contrario
della tesi di cui ci si vuole servire come se si volesse la sua approvazione, o almeno sottoporgli
ambedue le tesi, in modo che egli non si accorga di quale si vuole che lui affermi.
STRATAGEMMA N. 11
Se noi facciamo un'induzione, e l'avversario ci concede i singoli casi attraverso i quali deve essere
attuata, non dobbiamo chiedergli se concede anche la verità generale che riporre le domande non
nell'ordine richiesto dalla conclusione che si deve trarre, ma con spostamenti di ogni genere:
l'avversario non capisce allora dove si voglia andare a parare e non è in grado di prevenire: ci si può
anche servire delle sue risposte per trarne conclusioni diverse, perfino contrarie, a seconda delle
risposte. Questo stratagemma è affine al quarto stratagemma in quanto bisogna mascherare il
proprio modo di procedere.
sulta da questi casi; dobbiamo invece introdurla in seguito come già stabilita e concessa, perché può
anche accadere che egli creda di averla concessa, e la stessa impressione avranno anche gli
ascoltatori, i quali si ricordano delle molte domande sui casi singoli, che devono pure avere
condotto allo scopo.
STRATAGEMMA N. 12
Qualora il discorso verta su un concetto generale che non ha alcun nome, ma che deve essere
designato tropicamente per mezzo di una similitudine, noi dobbiamo scegliere subito la similitudine
in maniera tale che essa sia favorevole alla nostra affermazione. Così, per esempio, i nomi con cui
sono designati i due partiti politici in Spagna, serviles e liberales, sono stati certamente scelti da
questi ultimi.
Il nome protestanti è scelto da questi, e così il nome evangelici; il nome eretici, invece, è scelto dai
cattolici.
Vale per i nomi di cose anche quando essi sono più appropriati: ad esempio, se l'avversario ha
proposto un cambiamento, lo si chiami innovazione, perché si tratta di una parola odiosa. Ci
dobbiamo comportare in modo contrario se siamo noi ad avanzare la proposta. Nel primo caso si
chiami l'opposto ordine costituito”, nel secondo una zavorra”. Ciò che una persona disinteressata e
imparziale chiamerebbe culto” o pubblica dottrina della fede”, uno che vuole parlarne a favore lo
chiama devozione”, pietà”, un avversario bigotteria”, superstizione”. In fondo si tratta di una sottile
petitio principii: si introduce già nella parola, nella denominazione, ciò che si vuole provare, così da
derivarlo poi con un semplice giudizio analitico. Ciò che l'uno chiama assicurarsi della sua
persona”, tenere in custodia”, il suo avversario lo chiama imprigionare”. Spesso un oratore tradisce
già la sua intenzione nei nomi che dà alle cose. L'uno dice i religiosi”, l'altro i preti”. Fra tutti gli
stratagemmi questo è quello che viene adoperato più spesso, istintivamente. Fervore religioso =
fanatismo; passo falso o galanteria = adulterio; espressioni equivoche = oscenità; squilibrio =
bancarotta; tramite influenze e conoscenze” = tramite corruzione e nepotismo” ; sincera
riconoscenza” = buon pagamento”.
78
STRATAGEMMA N. 13
Per fare in modo che l'avversario accetti una tesi, dobbiamo presentare la tesi opposta e lasciare a
lui la scelta, avendo l'accortezza di esprimere tale opposto in modo assai stridente, cosicché, se non
vuole essere paradossale, egli deve risolversi alla nostra tesi che invece appare molto probabile. Per
esempio: egli deve ammettere che uno ha il dovere di fare tutto ciò che gli dice suo padre: allora noi
chiediamo: “Bisogna essere in ogni cosa disobbedienti oppure obbedienti ai genitori?”. Oppure se
di qualche cosa si dice sovente, chiediamo se con “sovente” si intendono pochi casi oppure molti:
l'avversario dirà molti. E come il grigio che accostato al nero si può chiamare bianco, e accostato al
bianco si può chiamare nero.
STRATAGEMMA N. 14
Un tiro impertinente è quando, dopo che l'avversario ha risposto a molte domande senza favorire la
conclusione che abbiamo in mente, si enuncia e si esclama in modo trionfante, come dimostrata, la
conclusione che si voleva trarre, sebbene essa non consegua affatto dalle sue risposte. Se
l'avversario è timido o sciocco, e se noi abbiamo una buona dose di impertinenza e una buona voce,
il tiro può riuscire proprio bene. Questo stratagemma rientra nella fallacia non causae ut causae
[inganno tramite assunzione della noncausa come causa].
STRATAGEMMA N. 15
Se abbiamo presentato una tesi paradossale e ci troviamo in imbarazzo nel dimostrarla, proponiamo
all'accettazione o al rifiuto dell'avversario, come se volessimo trarne la dimostrazione, una tesi sì
giusta, ma non del tutto evidente: se egli, sospettando qualcosa, la respinge, allora lo conduciamo ad
absurdum e trionfiamo: se invece la accetta, intanto abbiamo detto qualcosa di ragionevole, e poi si
vedrà. Oppure introduciamo qui lo stratagemma precedente e affermiamo ora che questo dimostra il
nostro paradosso. Per farlo ci vuole la massima impertinenza: ma nella realtà succede: e c'è gente
che tutto ciò lo pratica per istinto.
STRATAGEMMA N. 16
Argumenta ad hominem o ex concessis. Di fronte a un'affermazione dell'avversario dobbiamo
cercare se per caso essa non sia in qualche modo, all'occorrenza anche solo apparentemente, in
contraddizione con qualcosa che egli ha detto o ammesso in precedenza; oppure con i canoni di una
scuola o di una setta che egli ha lodato e approvato; oppure con l'agire degli adepti di questa setta, o
anche solo degli adepti falsi e apparenti; oppure con il suo stesso comportamento. Se per esempio
egli difende il suicidio, allora gli si grida subito: Perché non ti impicchi?”. Oppure afferma che
Berlino è un luogo di soggiorno sgradevole, e gli si grida subito: “Perché non te ne parti
immediatamente con la prima diligenza?”.
In un modo o nell'altro, si riuscirà ben a cavar fuori un raggiro.
STRATAGEMMA N. 17
Se l'avversario ci incalza con una controprova, spesso ci potremo salvare con una sottile distinzione
a cui magari prima non abbiamo pensato, se la cosa in questione consente un doppio significato
oppure un doppio caso.
STRATAGEMMA N. 18
Se ci accorgiamo che l'avversario ha messo mano a un'argomentazione con cui ci batterà, non
dobbiamo consentire che arrivi a portarla a termine, ma dobbiamo interrompere, allontanare o
sviare per tempo l'andamento della disputa e portarla su altre questioni: in breve, avviare una
mutatio controversiae.
STRATAGEMMA N. 19
79
Se l'avversario ci sollecita esplicitamente a esibire qualcosa contro un determinato punto della sua
affermazione, ma noi non abbiamo nulla di adatto, allora dobbiamo svolgere la cosa in maniera
assai generale e poi parlare contro tali generalità. Ci viene chiesto di dire perché una determinata
ipotesi fisica non è credibile: allora parliamo della illusorietà del sapere umano e ne diamo ogni
sorta di esempi.
STRATAGEMMA N. 20
Quando abbiamo richiesto all'avversario le premesse ed egli le ha concesse, non dobbiamo chiedere
anche la conclusione che ne consegue, ma tirarla direttamente noi stessi: anzi, anche se manca
ancora l'una o l'altra delle premesse, noi la assumiamo come ugualmente concessa e tiriamo la
conclusione. La qual cosa poi è un impiego della fallacia non causae ut causae.
STRATAGEMMA N. 21
Se ci accorgiamo che l'avversario fa uso di un argomento solo apparente o sofistico, possiamo certo
annullarlo mettendone in luce la capziosità e illusorietà, ma è meglio liquidarlo ricorrendo a un
controargomento altrettanto sofistico e apparente. Infatti quello che importa non è la verità, ma la
vittoria. Se egli, per esempio, avanza un argumentum ad hominem, è sufficiente infirmarlo con un
controargomento ad hominem (ex concessis): e in generale, se se ne offre l'opportunità, è più breve
presentare un argumentum ad hominem, anziché fare una lunga discussione sulla vera natura della
cosa.
STRATAGEMMA N. 23
La contraddizione e la lite spingono a esagerare l'affermazione. Possiamo dunque stuzzicare
l'avversario contraddicendolo, e indurlo così a esagerare oltre il vero un'affermazione che in sé, e in
un certo ambito, potrebbe essere vera: e una volta confutata questa esagerazione, è come se
avessimo confutato anche la sua tesi di partenza. Al contrario, quando veniamo contraddetti,
dobbiamo fare attenzione a non esagerare o estendere la nostra tesi. Spesso inoltre sarà l'avversario
a fare direttamente il tentativo di estendere la nostra affermazione oltre i termini nei quali noi
l'abbiamo posta: dobbiamo allora fermarlo subito e ricondurlo ai limiti della nostra affermazione
con un tanto ho detto, e niente di più.
Se l'avversario ci chiede di ammettere una cosa da cui il problema in discussione conseguirebbe
immediatamente, rigettiamola spacciandola per una petitio principii; infatti non sarà difficile che sia
lui sia chi ascolta considerino identica al problema una tesi strettamente affine: e così gli sottraiamo
il suo argomento migliore.
La forzatura della consequenzialità. Dalla tesi dell'avversario si traggono a forza, attraverso false
deduzioni e deformando i concetti, altre tesi che non vi sono contenute e non corrispondono affatto
all'opinione dell'avversario, ma sono assurde o pericolose: poiché, ora, sembra che dalla sua tesi di
partenza discendano tali proposizioni, che sono in contraddizione o con se stesse o con verità
riconosciute, ciò vale come una confutazione indiretta, apagoge: è un nuovo impiego della fallacia
non causae ut causae.
STRATAGEMMA N. 25
Questo stratagemma para l'apagoge con una istanza, exemplum in contrarium. L’inductio,
abbisogna di una gran quantità di casi per porre il principio universale: apagoge basta che presenti
un unico caso per il quale il principio non è valido, e questo è demolito: un caso del genere si
chiama istanza, exemplum in contrarium, instantia. Per esempio, la proposizione Tutti i ruminanti
sono cornuti viene demolita tramite l'unica istanza dei cammelli. L' istanza è un caso di
applicazione della verità generale: sotto il concetto principale di quest'ultima deve essere sussunto
qualcosa per cui però quella verità generale non vale: perciò essa viene completamente demolita.
Sennonché qui possono verificarsi inganni: perciò quando l'avversario muove istanze dobbiamo
stare attenti a quanto segue: 1) se l'esempio sia effettivamente vero: ci sono problemi la cui unica
80
soluzione autentica è che il caso non è vero: per esempio molti miracoli, storie di spiriti, e così via;
2) se rientri effettivamente nel concetto della verità presentata: spesso è così solo in apparenza e per
chiarirlo è necessaria una precisa distinzione; 3) se sia effettivamente in contraddizione con la verità
presentata: spesso è così solo in apparenza.
STRATAGEMMA N. 26
Un tiro brillante è la retorsio argumenti: quando l'argomento che l'avversario vuole usare a proprio
vantaggio può essere usato meglio contro di lui. Per esempio egli dice: È un bambino, bisogna pur
concedergli qualcosa; retorsio: Proprio perché è un bambino bisogna castigarlo, affinché non
perseveri nelle sue cattive abitudini”.
STRATAGEMMA N. 27
Se, di fronte a un argomento, l'avversario inaspettatamente si adira, allora bisogna incalzare senza
tregua con quell'argomento: non soltanto perché va bene per farlo montare in collera, ma perché si
deve supporre di aver toccato il lato debole del suo ragionamento, e di potergli nuocere, a questo
punto, ancor più di quanto si possa credere in un primo tempo.
STRATAGEMMA N. 28
Questo stratagemma lo si può adoperare principalmente quando persone colte disputano davanti ad
ascoltatori incolti. Quando non si dispone di alcun argumentum ad rem e nemmeno di uno ad
hominem, allora se ne fa uno ad auditores, cioè si avanza una obiezione non valida, di cui però solo
un esperto vede l'inconsistenza: ma, mentre l'avversario è un esperto, tali non sono gli ascoltatori.
Ai loro occhi egli viene dunque battuto, tanto più se la nostra obiezione riesce a porre in una luce
ridicola la sua affermazione. A ridere la gente è subito pronta, e quelli che ridono li si ha dalla
propria parte. Per mostrare che l'obiezione è nulla, l'avversario dovrebbe inoltrarsi in una lunga
discussione e risalire ai princìpi della scienza, o cose del genere: ma se lo fa, non trova facilmente
ascolto.
Esempio. L'avversario dice: nella formazione della crosta rocciosa archeana, la massa dalla quale si
cristallizzò il granito e tutta la roccia restante era liquida a causa del calore, cioè fusa: il calore
doveva essere di circa 200° R: la massa si cristallizzò sotto la superficie del mare che la copriva.
Noi avanziamo l'argumentum ad auditores che a quella temperatura, anzi, assai prima, a 80° R, il
mare si sarebbe volatilizzato da un bel pezzo e aleggerebbe sotto forma di vapore. Gli ascoltatori
ridono. Per batterci egli dovrebbe mostrare che il punto di ebollizione non dipende solo dal grado di
calore, ma altresì dalla pressione atmosferica, e questa, non appena circa la metà dell'acqua del
mare è evaporata, è cresciuta al punto che neppure a 200° R ha luogo l'ebollizione. Ma egli non
riesce a dimostrarlo giacché per chi non sa nulla di fisica sarebbe necessario un intero trattato.
STRATAGEMMA N. 29
Se ci si accorge di venire battuti (vedi lo stratagemma n. 18), allora si fa una diversione, cioè si
comincia d'un tratto con qualcosa di totalmente diverso, come se fosse pertinente alla questione e
costituisse un argomento contro l'avversario. Questo avviene con un certo ritegno se la diversione
riguarda ancora in generale il thema questionis; sfacciatamente se riguarda solo l'avversario e non
parla affatto della cosa in questione. Per esempio: io lodavo il fatto che in Cina non esiste nobiltà
ereditaria e gli uffici vengono assegnati solo in seguito a examina. Il mio avversario affermò che il
sapere non prepara a esercitare uffici più dei privilegi di nascita (che egli teneva in qualche
considerazione). Ma gli andò storta. Subito fece una diversione, dicendo che in Cina tutti i ceti
vengono castigati con la punizione corporale, e mise questo in relazione con il molto bere tè,
rimproverando ai Cinesi l'una e l'altra cosa. Ora, chi s'impelagasse senz'altro in tutto questo, si
sarebbe lasciato sviare e quindi si sarebbe lasciato sfuggire di mano la vittoria già raggiunta. La
diversione è sfacciata quando abbandona completamente la cosa in questione e attacca circa così:
Sì, e del resto anche lei affermava di recente ecc.. Rientra infatti, in una certa misura, nel diventare
offensivi, di cui si parlerà nell'ultimo stratagemma. Considerata in senso stretto, la diversione è un
81
grado intermedio fra l'argumentum ad personam, di cui si discuterà appunto nell'ultimo
stratagemma, e l'argumentum ad hominem.
Quanto questo stratagemma sia per così dire innato, lo mostra ogni lite fra gente comune: infatti, se
uno avanza all'altro rimproveri personali, questi risponde non già confutandoli ma muovendo lui
rimproveri personali al primo, lasciando sussistere e quindi quasi ammettendo, quelli rivolti a lui
stesso. Si comporta come Scipione che affrontò i Cartaginesi non in Italia, ma in Africa. In guerra
tale diversione a volte può anche dimostrarsi utile. Nel contendere non va bene, perché non si fa
nulla contro i rimproveri ricevuti e chi ascolta viene a sapere le magagne di entrambe le parti. Nel
disputare è in genere usata solo faute de mieux.
STRATAGEMMA N. 30
L'argumentum ad verecundiam. Al posto delle motivazioni, ci si serva di autorità, secondo le
conoscenze dell'avversario. Dice Seneca: unusquisque mavult credere quam iudicare [ognuno
preferisce credere che giudicare. De vita beata, I, 4]. Si ha dunque buon gioco quando si ha dalla
propria parte un'autorità che l'avversario rispetta. Ma per lui ci saranno tante più autorità valide,
quanto più sono limitate le sue conoscenze e le sue capacità. Se queste sono di prim'ordine, per lui
ce ne saranno pochissime, pressoché nessuna. Egli accetterà, tutt'al più, l'autorità di persone
competenti in una scienza, arte o professione a lui poco nota o del tutto ignota, e anche questa con
diffidenza. Al contrario, la gente comune ha profondo rispetto per gli esperti di ogni genere. Essi
non sanno che chi fa professione di qualcosa non ama questa ma il suo guadagno: né sanno che chi
insegna una certa cosa rara
mente la conosce a fondo, perché a chi la studia a fondo di solito non rimane neppure il tempo per
insegnare. Solo per il vulgus ci sono molte autorità che trovano rispetto: se non se ne ha alcuna che
fa al caso, se ne prenda una apparentemente adatta, si citi ciò che uno ha detto in un altro senso o in
altre circostanze. Le autorità che l'avversario non capisce affatto per lo più producono l'effetto
migliore. Gli incolti hanno un rispetto tutto particolare per le espressioni retoriche greche o latine.
All'occorrenza, le autorità si possono non solo distorcere, ma addirittura falsificare o perfino
inventare: per lo più l'avversario non ha il libro a portata di mano e non sa nemmeno come
consultarlo. Il più bell'esempio a questo proposito è offerto dal francese Curè, il quale, per non
pavimentare la strada davanti alla sua casa, come erano obbligati a fare gli altri cittadini, citò un
detto biblico: paveant illi, ego non pavebo [tremino pur quelli, io non tremerò]. Ciò convinse gli
amministratori comunali. Anche pregiudizi generali possono essere usati come autorità. Infatti, con
Aristotele, credo nell'Etica Nicomachea, i più pensano: “le cose che sembrano giuste a molti, queste
diciamo che sono” (Etica Nicomachea, X, 2, 1172 b 36]; sì, non c'è alcuna opinione, per quanto
assurda, che gli uomini non abbiano esitato a far propria, non appena si è arrivati a convincerli che
tale opinione è universalmente accettata. L'esempio fa effetto sia sul loro pensiero, sia sul loro
agire. Essi sono pecore che vanno dietro al montone ovunque le conduca: è per loro più facile
morire che pensare. E assai curioso che l'universalità di una opinione abbia per loro tanto peso, dal
momento che essi possono pur vedere su di sé quanto si accettino opinioni senza giudizio e solo in
forza dell'esempio. Ma in realtà non lo vedono, perché manca loro ogni conoscenza di sé. Solo i
migliori dicono, con Platone, “i molti hanno molte opinioni” (Repubblica, IX, 576 c], cioè il vulgus
ha molte frottole in testa e, se si volesse tenerne conto, si avrebbe un gran da fare. L'universalità di
una opinione, parlando seriamente, non costituisce né una prova né un motivo che la rende
probabile. Coloro che lo affermano devono ammettere: 1) che la distanza nel tempo priva quella
universalità della sua forza probante: altrimenti dovrebbero riportare in vigore tutti gli antichi errori
che un tempo erano universalmente considerati verità: per esempio, dovrebbero ripristinare il
sistema tolemaico oppure, nei paesi protestanti, il cattolicesimo; 2) che la distanza nello spazio
produce lo stesso effetto: altrimenti l'universalità di opinione fra chi professa il buddhismo, il
cristianesimo e l'islamismo li metterà in imbarazzo. (Secondo Jeremy Bentham, Tactique des
assemblées législatives [Genève-Paris, 1816], vol. II, P. 76).
82
Ciò che così si chiama opinione generale è, a ben guardare, l'opinione di due • tre persone; e ce ne
convinceremmo se potessimo osservare come si forma una tale opinione universalmente valida.
Troveremmo allora che furono in un primo momento due o tre persone ad avere supposto o
presentato e affermato tali opinioni, e che si fu così benevoli verso di loro da credere che le
avessero davvero esaminate a fondo: il pregiudizio che costoro fossero sufficientemente capaci
indusse dapprima alcuni ad accettare anch'essi l'opinione: a questi credettero a loro volta molti altri,
ai quali la pigrizia suggerì di credere subito piuttosto che fare faticosi controlli. Così crebbe di
giorno in giorno il novero di tali accoliti pigri e creduloni: infatti, una volta che l'opinione ebbe
dalla sua un buon numero di voci, quelli che vennero dopo l'attribuirono al fatto che essa aveva
potuto guadagnare a sé quelle voci solo per la fondatezza delle sue ragioni. I rimanenti, per non
passare per teste irrequiete che si ribellano contro opinioni universalmente accettate e per saputelli
che vogliono essere più intelligenti del mondo intero, furono costretti ad ammettere ciò che era già
da tutti considerato giusto. A questo punto il consenso divenne un obbligo. D'ora in poi, i pochi che
sono capaci di giudizio sono costretti a tacere e a poter parlare è solo chi è del tutto incapace di
avere opinioni e giudizi propri, ed è la semplice eco di opinioni altrui: tuttavia, proprio costoro sono
difensori tanto più zelanti e intolleranti di quelle opinioni. Infatti, in colui che la pensa
diversamente, essi odiano non tanto l'opinione diversa che egli professa, quanto l'audacia di voler
giudicare da sé, cosa che essi stessi non provano mai a fare, e in cuor loro ne sono consapevoli.
Insomma: a esser capaci di pensare sono pochissimi, ma opinioni vogliono averne tutti: che
cos'altro rimane se non accoglierle belle e fatte da altri, anziché formarsele per conto proprio?
Poiché questo è ciò che accade, quanto può valere ancora la voce di cento milioni di persone? Tanto
quanto un fatto storico che si trova in cento storiografi, ma poi si verifica che tutti si sono trascritti
l'uno l'altro, per cui, alla fine, tutto si riconduce all'affermazione di uno solo (secondo Pierre Bayle,
Pensées sur les comètes [4a edizione, 1704], tomo I, p. 10).
Io lo dico, tu lo dici, ma alla fine lo dice anche quello: / Dopo che lo si è detto tante volte, altro non
vedi se non ciò che è stato detto”. Motto che si trova in esergo alla Parte polemica della Teoria dei
colori di Goethe
Nondimeno, quando si discute con gente comune si può fare uso dell'opinione generale come di
un'autorità. In genere si troverà che quando due teste ordinarie disputano fra loro, l'arma comune
che essi scelgono sono le autorità: con queste si battono l'un l'altro. Se una testa più fine ha a che
fare con un tipo del genere, la cosa migliore è che anch'egli si adatti a quest'arma, scegliendola
secondo i punti deboli dell'avversario. Infatti, contro l'arma delle ragioni questi è, ex hypothesi, un
Sigfrido cornuto immerso nella marea dell'incapacità di pensare e giudicare. In tribunale si disputa
esclusivamente ricorrendo ad autorità, all'autorità delle leggi che è certa: è compito della facoltà del
giudizio reperire la legge, cioè l'autorità, che trova applicazione nel caso dato. Ma la dialettica ha
spazio d'azione sufficiente quando, all'occorrenza, il caso concreto e una legge che in realtà non si
accordano vengono rigirati finché li si considera in accordo: anche viceversa.
STRATAGEMMA N. 31
Qualora non si sappia opporre nulla alle ragioni esposte dall'avversario ci si dichiari, con fine
ironia, incompetenti: Quello che lei dice supera la mia debole comprensione: sarà senz'altro
giustissimo, ma io non riesco a capirlo e rinuncio a ogni giudizio”. Con ciò, negli uditori presso i
quali si è tenuti in considerazione, si insinua che si tratta di una cosa insensata. Molti professori
della vecchia scuola eclettica all'apparire della Critica della ragione pura o, meglio, quando essa
iniziò a suscitare scalpore, dichiararono: Noi non la capiamo”, e con ciò pensarono di essersene
disfatti. Quando però alcuni adepti della nuova scuola mostrarono loro che avevano proprio ragione
e che davvero non la capivano, il loro umore ebbe un brusco cambiamento. Questo stratagemma si
può adoperare solo laddove si sia sicuri di essere decisamente più stimati dell'avversario presso
l'uditorio. Per esempio: un professore contro uno studente. In realtà rientra nello stratagemma
precedente ed è un modo particolarmente malizioso di far valere la propria autorità in luogo delle
ragioni. Il tiro contrario è: “Mi permetta, con il Suo acume dev'essere un'inezia capirlo, e può solo
83
esser colpa della mia cattiva esposizione”, poi sbattergli la cosa sul muso in modo che, nolens
volens, egli debba capirla, e risulti chiaro che prima, effettivamente, era lui a non averla capita. Così
l'argomento è ritorto: lui voleva insinuare nei nostri confronti un nonsenso: noi gli abbiamo
dimostrato che era lui a non avere capito. Entrambi con squisita gentilezza.
STRATAGEMMA N. 32
Un modo spiccio per accantonare, o almeno rendere sospetta, una affermazione a noi contraria
dell'avversario, è quello di ricondurla a una categoria odiata, anche se la relazione è solo di vaga
somiglianza o è tirata per i capelli; per esempio: Questo è manicheismo; questo è arianesimo;
questo è pelagianesimo; questo è idealismo; questo è spinozismo; questo è panteismo; questo è
brownianismo; questo è naturalismo; questo è ateismo; questo è razionalismo; questo è
spiritualismo; questo è misticismo; e così via. Con ciò supponiamo due cose: 1) che quella
affermazione è effettivamente identica a quella categoria, o che almeno è contenuta in essa, ed
esclamiamo dunque: Oh!, questa non è affatto nuova!; 2) che questa categoria è già stata del tutto
confutata e non può contenere una sola parola di vero.
STRATAGEMMA N. 33
Ciò sarà anche vero in teoria; in pratica però è falso. Con questo sofisma si ammettono le ragioni e
tuttavia si negano le conseguenze; in contraddizione con la regola a ratione ad rationatum valet
consequentia [da una ragione al suo effetto vige la consequenzialità]. L'affermazione pone una cosa
impossibile: ciò che è giusto in teoria deve valere anche in pratica: se ciò non si verifica, allora c'è
un errore nella teoria, qualche cosa è stato trascurato e non è stato calcolato e, di conseguenza, è
falso anche nella teoria.
Se a una domanda o a un argomento l'avversario non dà una risposta diretta o non prende una
posizione precisa, ma evade con una controdomanda, una risposta indiretta o addirittura con
qualcosa che non è pertinente all'oggetto in discussione, e vuole andare a parare da tutt'altra parte;
questo è un segno sicuro che abbiamo toccato (magari senza saperlo) un punto marcio: si tratta, da
parte sua, di un ammutolimento relativo. E' necessario dunque incalzare sul punto che abbiamo
toccato e non mollare, anche quando non vediamo ancora in che cosa consista la debolezza che
abbiamo colpito.
STRATAGEMMA N. 35
il quale, non appena sia praticabile, rende superflui tutti gli altri: anziché agire sull'intelletto con
ragionamenti, si agisca sulla volontà con motivazioni, e l'avversario, come pure gli uditori se hanno
gli stessi suoi interessi, sono subito conquistati alla nostra opinione, fosse anche presa a prestito dal
manicomio: per lo più, infatti, una briciola di volontà pesa più di un quintale di giudizio e di
persuasione. Naturalmente funziona solo in circostanze particolari. Se si riesce a far avvertire
all'avversario che la sua opinione, se fosse valida, arrecherebbe un notevole danno al suo stesso
interesse, egli la lascerà cadere con la stessa rapidità con cui si molla un ferro bollente incautamente
afferrato. Per esempio: un religioso difende un dogma filosofico: gli si faccia osservare che esso è
indirettamente in contraddizione con un dogma fondamentale della sua chiesa, ed egli lo lascerà
cadere.
Un possidente terriero afferma l'eccellenza della meccanica in Inghilterra, dove una macchina a
vapore compie il lavoro di molti uomini: gli si lasci intendere che presto anche i veicoli saranno
tirati da macchine a vapore, sicché i prezzi dei cavalli delle sue numerose scuderie dovranno subire
un crollo — e si vedrà. In questi casi il sentimento di ognuno è di regola: quam temere in nosmet
legem sancimus iniquam [con quanta leggerezza enunciamo una legge iniqua contro noi stessi.
Orazio, Satire, I, 3, 67]. Si agisca così quando gli uditori, ma non l'avversario, fanno parte della
nostra stessa setta, corporazione, sindacato, club, e così via. La sua tesi può anche essere giusta, ma
è sufficiente alludere al fatto che essa è in contrasto con l'interesse comune della suddetta
corporazione, ecc., che tutti gli uditori troveranno gli argomenti dell'avversario deboli e miserabili
84
anche se sono ottimi, e i nostri giusti e centrati anche se fossero campati per aria; il coro si
proclamerà a gran voce in nostro favore e l'avversario dovrà sgombrare il campo umiliato. Anzi, gli
uditori per lo più crederanno di avere dato la loro approvazione per puro convincimento. Infatti, ciò
che va a nostro danno, appare per lo più assurdo all'intelletto. Intellectus luminis sicci non est
recipit infusionem a voluntate et affectibus [l'intelletto non è una luce che arde senza olio, ma viene
alimentato dalla volontà e dalle passioni. Francis Bacon, Novum Organon, I, 49]. Di questo
stratagemma si potrebbe dire prendere l'albero per le radici” : di solito viene chiamato argumentum
ab utili.
STRATAGEMMA N. 36
Sconcertare, sbigottire l'avversario con sproloqui privi di senso. Ciò riposa sul fatto che: “L'uomo
crede abitualmente, anche se solo parole sente, / che vi si debba poter trovare pur qualcosa da
pensare” (Johann Wolfgang Goethe, Faust)
Se ora, in cuor suo, egli è consapevole della propria debolezza, se è abituato a sentire cose che non
capisce, e tuttavia a fare come se le capisse, si può impressionarlo propinandogli con aria seria una
scemenza che suona dotta o profonda, di fronte alla quale gli vengono meno udito, vista e pensiero,
e spacciarla come la prova più incontestabile della propria tesi. Come è noto, recentemente alcuni
filosofi hanno adoperato questo stratagemma, con esiti brillantissimi, addirittura di fronte all'intero
pubblico tedesco. Poiché però si tratta di exempla odiosa, ricorreremo a un esempio più antico tratto
da Oliver Goldsmith, The Vicar of Wakefield [cap. VII].
STRATAGEMMA N. 37
(che dovrebbe essere uno dei primi). Quando l'avversario, pur avendo nei fatti ragione, per fortuna
sceglie una cattiva prova; non abbiamo allora difficoltà a confutarla, e poi spacciamo questa per una
confutazione della cosa. In fondo, qui tutto si basa sul fatto che spacciamo un argumentum ad
hominem per uno ad rem. Se a lui, o agli astanti, non viene in mente alcuna prova migliore,
abbiamo vinto noi. Per esempio quando uno, per dimostrare l'esistenza di Dio, presenta la prova
ontologica, assai facile da confutare. Questo è il modo in cui cattivi avvocati perdono una buona
causa: vogliono difenderla con una legge che non vi si presta, e quella che si presta non viene loro
in mente.
ULTIMO STRATAGEMMA
Quando ci si accorge che l'avversario è superiore e si finirà per avere torto, si diventi offensivi,
oltraggiosi, grossolani, cioè si passi dall'oggetto della contesa (dato che lì si ha partita persa) al
contendente e si attacchi in qualche modo la sua persona. Lo si potrebbe chiamare argumentum ad
personam, e va distinto dall'argumentum ad hominem che si allontana dal puro oggetto in
discussione per attaccarsi a ciò che l'avversario ha detto o ha ammesso. Con quest'ultimo
stratagemma, invece, si abbandona del tutto l'oggetto e si dirige il proprio attacco contro la persona
dell'avversario: si diventa dunque insolenti, perfidi, oltraggiosi, grossolani. Si tratta di un appello
delle forze dello spirito a quelle del corpo o all'animalità. Questa regola è molto popolare poiché
chiunque è in grado di metterla in pratica, e viene quindi impiegata spesso. Ci si chiede ora quale
controregola valga in questo caso per l'altra parte. Perché, se questa farà uso della stessa regola, si
arriverà a una rissa, a un duello o a un processo per ingiuria. Ci si sbaglierebbe di grosso se si
pensasse che basti solo non diventare offensivi. Infatti, mostrando a uno, in tutta pacatezza, che ha
torto e che dunque giudica e pensa in maniera sbagliata, come accade in ogni vittoria dialettica, lo si
amareggia più che con qualsiasi espressione grossolana e oltraggiosa. Perché? Perché, come dice
Hobbes nel De cive, capitolo I [par. 5]: Omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est,
quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de seipso [Ogni piacere
dell'animo e ogni ardore risiedono nell'avere qualcuno, dal confronto con il quale si possa trarre un
alto sentimento di sé]. Nulla supera per l'uomo la soddisfazione della sua vanità, e nessuna ferita
duole più di quella in cui viene colpita la vanità. (Da ciò derivano modi di dire come “l'onore vale
85
più della vita” e così via). Questa soddisfazione della vanità nasce principalmente dal confronto di
se stessi con altri, sotto ogni aspetto, ma principalmente in relazione all'intelligenza. Questa
soddisfazione si verifica effective e molto intensamente nel disputare. Di qui l'amarezza dello
sconfitto senza che gli si commetta torto, e di qui il suo ricorso, come extrema ratio, a quest'ultimo
stratagemma: ad esso non si può sfuggire con la semplice gentilezza da parte nostra. Avere un gran
sangue freddo può tuttavia essere utile anche in questa occasione, se cioè, non appena l'avversario
diventa offensivo, si risponde con calma che ciò non pertiene alla cosa in questione e si ritorna
subito su questa, continuando a dimostrargli il suo torto senza badare alle offese — dunque più o
meno come dice Temistocle ad Euribiade: “bastonami ma ascoltami” (Plutarco, Temistocle, 11, 20].
Ma questo non è da tutti.
L'unica controregola sicura è perciò quella che già Aristotele indica nell'ultimo capitolo dei Topici:
non disputare con il primo arrivato, ma solo con coloro che si conosce e di cui si sa che hanno
intelletto sufficiente da non proporre cose tanto assurde da esporli all'umiliazione; e che hanno
abbastanza intelletto per disputare con ragioni, e non con decisioni perentorie, e per ascoltare
ragioni e acconsentirvi; e, infine, che apprezzano la verità, ascoltano volentieri buone ragioni, anche
quando provengono dalla bocca dell'avversario, e siano abbastanza equi da saper sopportare di
ottenere torto quando la verità sta dall'altra parte. Da ciò segue che, fra cento persone, ce n'è forse
una degna che si disputi con lei. Agli altri si lasci dire quello che vogliono, perché desipere est juris
gentium [essere irragionevoli è un diritto umano], e si rifletta su ciò che dice Voltaire: La paix vaut
encore mieux que la vérité [La pace è preferibile alla verità]; e un detto arabo recita: “Il frutto della
pace è appeso all'albero del silenzio”.
In ogni caso, la disputa, come attrito di teste, è spesso di reciproca utilità per rettificare i propri
pensieri e anche per produrre nuovi punti di vista. Ma i due contendenti devono essere pressoché
pari fra loro per erudizione e intelligenza. Se uno è privo della prima, allora non capisce tutto, non è
au niveau. Se gli manca la seconda, allora il rancore che ne sorge lo istigherà a cose sleali e ad
astuzie, o alla villania. Tra la disputa in colloquio privato sive familiari e la disputatio solemnis, pro
gradu non v'è alcuna differenza essenziale. La differenza è solo che in quest'ultima si richiede che il
re-spondens debba sempre ottenere ragione contro l'opponens e quindi che all'occorrenza chi
presiede, il praeses, lo soccorra; o anche che in essa si argomenta in modo più ufficiale e si
rivestono volentieri i propri argomenti di una forma sillogistica rigorosa.
86
John Stuart Mill
(1806-1873)
Sistema di logica (1843)
lingua originale: inglese
tr. it. M. Trinchero, UTET Torino, 1988
Libro V
Capitolo I: Le fallacie in generale
I. È una massima degli Scolastici che contrariorum eadem est scientia: non sappiamo mai
realmente che cosa sia una cosa a meno che non siamo anche capaci di rendere ragione a sufficienza
del suo opposto. In conformità con questa massima, una porzione non indifferente della maggior
parte dei trattati di logica è dedicata alla trattazione delle fallacie; e questa pratica è troppo
meritevole d'essere osservata, perché a noi sia consentito di allontanarcene. Per essere completa, la
filosofia del ragionamento deve comprendere tanto la teoria del cattivo ragionamento quanto la
teoria del ragionamento buono.
Ci siamo sforzati di accertare i princìpi in base ai quali è possibile controllare se una qualsiasi prova
sia sufficiente, e in base ai quali è possibile stabilire in anticipo la natura e la quantità delle prove
necessarie a provare una qualsiasi conclusione data. Se ci si conformasse a questi principi, sarebbe
pur sempre vero che il numero e il valore delle verità accertate risulterebbero limitati dalle
opportunità, o dall'industriosità, dall'ingegno e dalla pazienza del ricercatore singolo, ma almeno
non si abbraccerebbe l'errore in luogo della verità. Ma il consenso generale del genere umano,
consenso fondato sulla sua esperienza, attesta che nell'impiego delle sue facoltà raziocinative
l'umanità è ben lontana da questa, sia pur negativa, specie di perfezione.
Nella condotta della vita — nelle faccende pratiche dell'umanità — le inferenze sbagliate, le
interpretazioni scorrette dell'esperienza, sono assolutamente inevitabili se non a prezzo di un'intensa
coltivazione della facoltà del pensiero; e presso la maggior parte della gente queste inferenze
erronee, che dànno luogo ad errori corrispondenti nella condotta degli uomini, sono
deplorabilmente frequenti anche dopo che gli uomini abbiano raggiunto il loro grado di cultura più
alto. Perfino nelle speculazioni alle quali si sono dedicati sistematicamente intelletti eminenti, e
nelle quali lo spirito collettivo del mondo scientifico è sempre disponibile per prestare aiuto agli
sforzi degli individui e per correggere le loro aberrazioni, alla lunga le opinioni che non riposano
sopra induzioni corrette sono state espulse, generalmente parlando, soltanto dalle scienze più
perfette, vale a dire da quelle scienze il cui oggetto è il meno complicato. In quei settori della
ricerca scientifica che hanno da fare con fenomeni naturali più complessi, e specialmente in quei
settori che hanno per oggetto l'uomo, sia come essere morale e intellettuale sia come essere sociale
sia anche come essere fisico, la diversità di opinioni che ancora predomina tra le persone colte e
l'eguale confidenza con cui persone che pensano nei modi più opposti abbracciano i loro rispettivi
dogmi sono la prova, non soltanto che a proposito di questi argomenti non sono ancora stati adottati
i modi di filosofare giusti, ma che sono stati adottati i modi di filosofare sbagliati; non soltanto che
in generale i pensatori hanno perso di vista la verità, ma che spesso hanno abbracciato l'errore; che
anche la parte più colta della specie umana non ha ancora imparato ad astenersi dal trarre
conclusioni che non siano garantite dalle prove.
L'unica salvaguardia completa contro il ragionamento cattivo è l'abito del ragionar bene: la
familiarità con i principi del ragionamento corretto e la pratica nell'applicazione di questi principi.
Non sarà comunque superfluo prendere in considerazione quali siano i modi più comuni di ragionar
male, quali siano le false apparenze che hanno maggiori probabilità di distogliere dall'osservanza
dei veri principi dell'induzione; quali, in breve, siano le varietà più comuni e più pericolose di prove
apparenti che possono sviare le persone inducendole ad abbracciare opinioni per le quali non
esistono prove realmente concludenti.
87
Un catalogo delle varietà di prove che sembrano tali, ma che non sono prove reali, consiste in
un'enumerazione delle fallacie. Se non contenesse una tale enumerazione, la presente opera
soffrirebbe perciò di una manchevolezza essenziale. E mentre certi autori, che nella loro teoria del
ragionamento hanno fatto rientrare soltanto la deduzione, coerentemente con questa limitazione
hanno confinato le loro osservazioni alle fallacie che hanno la loro sede in quella parte del processo
della ricerca, noi, che professiamo di trattare del processo tutto intero, alle indicazioni per portare
correttamente a termine tale processo dovremo aggiungere avvertenze che ci impediscano di
compierlo scorrettamente in ogni e qualsiasi sua parte: sia che il difetto del ragionamento risieda
nella sua parte deduttiva sia che risieda in quella sperimentale, sia che risieda nel fatto che si
prescinde completamente dalla deduzione e dall'induzione.
2. Quando si prendono in considerazione le fonti dell'inferenza infondata, è inutile mettere nel conto
gli errori che hanno origine, non da un metodo sbagliato o magari dall'ignoranza del metodo giusto,
ma da una dimenticanza casuale dovuta alla fretta o alla disattenzione nell'applicazione dei veri
princìpi dell'induzione. Come gli sbagli che facciamo accidentalmente quando eseguiamo
un'addizione, questi errori non hanno bisogno di analisi filosofica o di classificazione; le
considerazioni di natura teoretica non gettano luce sui mezzi per evitarli. In questo trattato la nostra
attenzione deve concentrarsi, non già sulla pura e semplice incapacità a compiere l'operazione nel
modo giusto (i soli rimedi a tale incapacità sono infatti un'accresciuta attenzione e una pratica più
assidua) ma su quei modi secondo cui la si compie in maniera fondamentalmente sbagliata; sulle
condizioni nelle quali la mente umana si persuade d'avere ragioni sufficienti per trarre una
conclusione, cui peraltro è arrivata senza seguire nessuno dei metodi legittimi d'induzione, e che
non ha tentato di mettere alla prova, neppure in modo trascurato e affrettatamente, mediante quei
modi legittimi.
3. C'è un'altra branca di quella che possiamo chiamare la filosofia dell'errore, che dobbiamo
menzionare qui anche se la menzioniamo soltanto per escluderla dagli oggetti della nostra
considerazione. Le fonti delle opinioni erronee sono di due specie: morali e intellettuali. Di queste,
le fonti morali non rientrano nell'àmbito di questo lavoro. Possono essere classificate sotto due titoli
distinti: l'indifferenza nei confronti del conseguimento della verità e l'inclinazione. Il caso più
comune di inclinazione si ha quando ci lasciamo influenzare dai nostri desideri; però, se la
conclusione è tale da mettere in azione una qualsiasi delle passioni più forti, il rischio che adottiamo
indebitamente una conclusione per noi spiacevole è quasi tanto grande quanto quello che ne
adottiamo una che ,ci fa piacere. Quanto più una proposizione è stata calcolata per allarmarle, tanto
più le persone dotate di un carattere timoroso sono predisposte a crederci. In realtà, è una legge
psicologica deducibile dalle leggi più generali della costituzione mentale dell'uomo, che una forte
passione ci rende creduli circa l'esistenza degli oggetti adatti ad eccitarla.
Ma pur essendo per la maggior parte delle persone le più potenti di tutte, le cause morali delle
opinioni non sono che cause remote: non agiscono direttamente, ma per mezzo delle cause
intellettuali, con le quali hanno la medesima relazione che le circostanze, che nella teoria della
medicina vengono chiamate “cause predisponenti”, hanno con le cause cosiddette “eccitanti”. In sé
e per sé, l'indifferenza nei confronti della verità non può produrre una credenza erronea: piuttosto
essa agisce impedendo alla mente di raccogliere le prove appropriate o di applicare alle prove il
controllo di un'induzione legittima e rigorosa; per colpa di quest'omissione la mente è esposta,
senza alcuna protezione, a ogni sorta di prove apparenti che le si presentino spontaneamente o che
essa stessa porti alla luce quando abbia voglia di darsi la sia pur minima pena di cercarle. Così pure,
non si può dire che sia fonte di conclusioni sbagliate l'inclinazione. Non possiamo credere a una
proposizione soltanto perché desideriamo crederle o soltanto perché abbiamo paura di crederle. Le
inclinazioni più violente a trovar vere un insieme di proposizioni non costringeranno a crederle vere
neppure il più debole degli uomini, se il suo intelletto non ha almeno una pallida traccia di buone
ragioni per crederci; se cioè il suo intelletto non è neppure in possesso di prove apparenti.
88
L'inclinazione agisce indirettamente, mettendogli davanti agli occhi le ragioni intellettuali della
credenza in una forma distorta o incompleta. Lo induce, non appena abbia il presentimento che i
risultati di tale induzione possano riuscirgli spiacevoli, a rifuggire dalla tediosa fatica di
un'induzione rigorosa; e, nella ricerca che costui istituisce, lo induce ad esercitare in modo sleale la
propria attenzione (che in certa misura è volontaria) facendo in modo che ne presti di più a quelle
prove che sembrano essere favorevoli alla conclusione desiderata e di meno a quelle che sembrano
esserle sfavorevoli. Agisce anche inducendolo a cercare con sollecitudine buone ragioni, o ragioni
apparenti, per sostenere le opinioni che si conformano ai suoi interessi o ai suoi sentimenti e per
opporsi invece a quelle che a tali sentimenti e a tali interessi repugnano. E quando gli interessi o i
sentimenti sono comuni a grandi quantità di persone, vengono accettate e diventano moneta
corrente ragioni alle quali non si potrebbe dar retta neppure per un momento, come tali, se a proprio
favore la conclusione non avesse nulla di più potente delle proprie ragioni. Le parzialità naturali o
acquisite dell'umanità sfornano ad ogni piè sospinto teorie filosofiche il cui solo titolo di
raccomandazione consiste nel fatto che offrono premesse adatte a provare le dottrine predilette o a
giustificare i sentimenti favoriti; e quando una di queste dottrine sia stata screditata in modo così
completo da non servire più allo scopo per il quale fu creata, c'è sempre un'altra dottrina pronta a
prendere il suo posto. Quando sia esercitata in favore di una qualsiasi persuasione o di un qualsiasi
sentimento largamente diffuso, questa propensione viene spesso abbellita di epiteti elogiativi,
mentre l'abito contrario a questo, abito che consiste nel mantenere il giudizio completamente
subordinato alle prove, viene bollato con vari termini dispregiativi, quali: scetticismo, immoralità,
freddezza, durezza di cuore, ed espressioni simili, secondo la natura del caso. Ma benché, quando
non dipendano dalla pura e semplice abitudine e dal fatto che gli sono state inculcate, le opinioni
della generalità degli uomini abbiano la loro radice nelle inclinazioni assai più che nell'intelletto,
una delle condizioni necessarie al trionfo della prevenzione morale è che essa riesca prima a
corrompere l'intelligenza. Pur avendo la loro origine in cause morali, tutte le inferenze erronee
implicano l'operazione intellettuale che consiste nell'ammettere come sufficienti le prove
insufficienti; e chiunque stia in guardia contro tutte le specie di prove inconcludenti che possono
essere erroneamente scambiate per prove concludenti, non correrà il pericolo di essere indotto in
quest'errore neppure dalla prevenzione più forte. Ci sono spiriti il cui intelletto è così fortemente
agguerrito da non permettergli di rimaner ciechi di fronte alla luce della verità, anche quando sono
realmente desiderosi di farlo; con tutta l'inclinazione di questo mondo, questi spiriti non potrebbero
contrabbandare a se stessi come buone le argomentazioni cattive. Se fosse possibile far tacere
completamente le sofisticherie dell'intelletto, la sofisticheria dei sentimenti, privata dello strumento
con cui lavora, sarebbe impotente. Una classificazione esauriente di tutte quelle cose che, pur non
essendo prove, rischiano di apparire tali all'intelletto, dovrà perciò, di per se stessa, comprendere
tutti gli errori di giudizio che hanno la loro origine nelle cause morali, escludendo unicamente gli
errori di pratica che si commettono contro una conoscenza migliore.
Pertanto, l'oggetto di quella parte della nostra ricerca nella quale stiamo per addentrarci tra breve è
costituito dall'esame di quelle diverse specie di prove apparenti che non sono prove affatto, e di
tutte le prove apparentemente concludenti, che in realtà concludenti non sono.
L'argomento non è fuori della portata della classificazione e di una esposizione sistematica. In
realtà, le cose che non sono prove di nessuna conclusione data sono manifestamente infinite, e,
poiché non dipende da nessuna proprietà positiva, questa proprietà negativa non può essere messa a
fondamento di una classificazione reale. Ma le cose che pur non essendo prove possono tuttavia
essere scambiate erroneamente per prove, possono essere classificate relativamente alla proprietà
positiva, che invece posseggono, di avere l'apparenza di prove. Possiamo disporle, a nostra scelta,
in base all'uno o all'altro di due principi: in base alla causa che fa si che abbiano l'apparenza di
prove pur non essendo tali, o in base alla particolare specie di prove di cui hanno l'apparenza. La
classificazione delle fallacie che stiamo per tentare nel prossimo capitolo sarà fondata,
congiuntamente, su tutt'e due queste considerazioni.
89
Capitolo II: Classificazione delle fallacie
I. Nel tentar di stabilire certe distinzioni generali che differenzino l'una dall'altra le varie specie di
prove fallaci, ci proponiamo un compito completamente differente da quello che, si sono proposti
parecchi eminenti pensatori i quali, sotto il nome di fallacie politiche, o di altro genere, si sono
limitati a fornire una semplice enumerazione di un certo numero di opinioni erronee, di false
proposizioni generali che accade spesso di incontrare; di loci communes di cattivi ragionamenti a
proposito di qualche argomento particolare. La logica non si occupa delle opinioni false che si dà il
caso che la gente abbia, ma del modo in cui si arriva ad averle. La questione non è: quali fatti si è
creduto erroneamente, in una certa epoca, che fossero prova di certi altri fatti? ma: qual era quella
proprietà dei fatti che ha condotto certe persone a questa supposizione sbagliata?
Quando si suppone, sia pure erroneamente, che un fatto sia prova, o segno, di qualche altro fatto,
quest'errore deve pur avere una causa: il presunto fatto probante deve pur essere connesso in
qualche maniera particolare con il fatto di cui si ritiene costituisca una prova; deve pur stare con
quel fatto in qualche relazione particolare: in una relazione, senza la quale non sarebbe considerato
sotto quella certa luce. La relazione può essere una relazione che risulta dalla semplice osservazione
dei due fatti, l'uno accanto all'altro, o può essere una relazione che dipende da qualche processo
mentale in forza del quale è stata precedentemente stabilita un'associazione tra i due fatti. In ogni
caso, qualche peculiarità la relazione non può non averla: anche nel caso delle aberrazioni più folli,
il fatto, di cui si può supporre che provi un altro fatto, deve stare in qualche posizione speciale
rispetto a questo secondo fatto: e se potessimo accertare e definire questa posizione speciale
riusciremmo a scoprire l'origine dell'errore.
Se non crediamo che due fatti sono congiunti sempre o nella maggior parte dei casi, non possiamo
considerare uno dei due fatti come prova dell'altro fatto. La ragione per cui crediamo che A sia la
prova di B quando, vedendo A, siamo inclini ad inferirne B, consiste nel fatto che crediamo che,
dovunque c'è A, là anche B ci sia sempre, o nella maggior parte dei casi, sia come antecedente sia
come conseguente sia come concomitante. La ragione per cui quando vediamo A siamo inclini a
non aspettarci B — la ragione, cioè, per cui crediamo che A sia una prova dell'assenza di B — sta
nel fatto che crediamo che dove c'è A là B non si trovi mai, o si trovi solo raramente. In breve, le
conclusioni erronee, non meno delle conclusioni corrette, hanno una relazione invariabile con una
formula generale chiaramente espressa o assunta tacitamente. Quando inferiamo un qualche fatto da
qualche altro fatto che non Io prova davvero, allora, o abbiamo ammesso o, se non vogliamo
contraddirci, dobbiamo ammettere, qualche proposizione generale infondata relativa alla
connessione tra i due fenomeni.
Di conseguenza per ogni proprietà dei fatti o del nostro modo di considerare i fatti che ci conduca a
credere che i fatti sono abitualmente congiunti quando non lo sono, oppure che non sono congiunti
mentre in realtà lo sono, c'è una specie corrispondente di fallacia: e un'enumerazione delle fallacie
dovrebbe consistere in una specificazione di quelle proprietà dei fatti e di quelle peculiarità del
nostro modo di considerare i fatti che dànno origine a quest'opinione erronea.
2. Dunque, per cominciare: la presunta connessione o la presunta incompatibilità tra due fatti può
essere una conclusione tratta da certe prove (cioè da qualche altra proposizione, o da più d'una
proposizione) oppure può essere ammessa senza nessuna ragione di questo genere; può essere
ammessa, come si dice, in base alla sua propria evidenza: abbracciata come una verità evidente di
per sé, assiomatica. Questo dà origine alla prima grande distinzione: quella tra le fallacie d'inferenza
e le fallacie a prima vista. In quest'ultima divisione devono essere fatti rientrare non soltanto tutti i
casi in cui una proposizione viene creduta vera e come tale viene sostenuta senza che ci sia,
letteralmente, nessuna prova estrinseca tratta vuoi dall'esperienza specifica vuoi dal ragionamento
generale, ma anche quei casi più frequenti nei quali basta dare un'occhiata a una proposizione
perché si crei una presunzione in suo favore: questa presunzione non è sufficiente a giustificare la
credenza, ma è sufficiente a indurci a far a meno dei principi di un'induzione regolare e a creare una
predisposizione a credere alla proposizione in base a prove che, se tale presunzione non esistesse,
90
sarebbero insufficienti. Questa classe, che comprende la totalità di quelli che potremmo chiamare
“pregiudizi naturali” e che io chiamerò indifferentemente “fallacie a prima vista” o “fallacie a
priori”, sarà messa a capo della nostra lista.
Le fallacie d'inferenza, ossia le conclusioni erronee tratte da prove presunte, devono essere
suddivise in base alla natura delle prove apparenti da cui sono tratte le conclusioni; o (il che è la
stessa cosa) secondo la specie particolare di buon ragionamento che la fallacia in parola simula. Ma
prima occorre tracciare una distinzione, che non corrisponde a nessuna delle divisioni in cui sono
ripartiti i ragionamenti buoni ma che trae la propria origine dalla natura dei ragionamenti cattivi.
Può darsi che sappiamo perfettamente quali sono le nostre prove, e tuttavia ne tiriamo una
conclusione falsa; può darsi che concepiamo con precisione quali siano le nostre premesse, quali
presunti dati di fatto o quali principi generali stiano a fondamento della nostra inferenza, e ciò
nonostante può darsi che la nostra conclusione sia erronea, o perché le nostre premesse sono false o
perché abbiamo inferito da esse qualcosa che non sono in grado di sorreggere. Ma un caso forse
ancor più frequente è il caso in cui l'errore sorge dal fatto che non si concepiscono le nostre
premesse con la debita chiarezza, cioè con la dovuta fermezza; dal fatto che quando raccogliamo o
quando accettiamo la nostra prova ce ne facciamo una certa concezione, mentre quando ne
facciamo uso ce ne formiamo una concezione diversa; oppure dal fatto che, man mano che
procediamo, alle premesse dalle quali eravamo partiti sostituiamo sconsideratamente, e, in generale,
senza rendercene conto, premesse differenti, o sostituiamo una conclusione differente alla
conclusione che ci eravamo accinti a provare. Questo mette in esistenza una classe di fallacie che
(usando una frase presa a prestito da Bentham) possono a ragione essere chiamate “fallacie di
confusione”. Tra le altre, esse comprendono tutte quelle fallacie che hanno la loro origine nel
linguaggio, sia perché sorgono dall'imprecisione o dall'ambiguità dei nostri termini, sia perché
sorgono da associazioni casuali connesse con i nostri termini.
Quando la fallacia non è una fallacia di confusione, cioè quando la proposizione creduta e le prove
in base alle quali la si crede sono state apprese saldamente e sono state espresse ln modo non
ambiguo, rimangono ancora da fare due divisioni trasversali. Le prove apparenti possono essere o
fatti particolari o generalizzazioni precedenti: cioè, il processo può simulare o la semplice induzione
o la deduzione; e ancora: sia che consistano di fatti presunti, sia che consistano di proposizioni
generali, le prove possono essere false di per se stesse oppure, se sono vere, possono non essere in
grado di corroborare la conclusione che si tenta di fondare su di esse. Questo ci dà: primo, le
fallacie di deduzione e le fallacie d'induzione; secondo, una suddivisione di ciascuna di queste
fallacie, secondo che le presunte prove siano false, oppure siano vere ma inconcludenti.
Quando i fatti in base ai quali l'induzione procede sono erronei, le fallacie d'induzione possono
essere chiamate “fallacie d'osservazione”. Il termine non è rigorosamente accurato, o, per meglio
dire, non coincide esattamente con la classe di fallacie che mi propongo di designare con esso.
L'induzione non è sempre fondata sopra fatti immediatamente osservati, ma, qualche volta, sopra
fatti inferiti: e quando questi ultimi siano erronei, può darsi che l'errore non sia un. esempio di
cattiva osservazione nel senso letterale del termine, ma sia piuttosto un esempio di cattiva inferenza.
In ogni caso, sarà conveniente raccogliere in una classe tutte le induzioni il cui errore risiede in
questo: che i fatti sui quali è fondata la teoria non sono stati sufficientemente accertati; o che la
causa del fallimento sia la cattiva osservazione, o che sia una pura e semplice mancanza
d'osservazione, o che la cattiva osservazione sia diretta, o che sia avvenuta per mezzo di segni
intermedi che non provano quello che dovrebbero provare. E in assenza di un termine abbastanza
vasto da denotare l'accertamento dei fatti sui quali è fondata un'induzione — quali che siano i mezzi
con cui lo si compie —, per questa classe di fallacie mi arrischierò, in forza della spiegazione che
ne abbiamo dato or ora, a conservare il nome di “fallacie d'osservazione”.
L'altra classe di fallacie induttive, in cui i fatti sono corretti, ma la conclusione non è garantita dai
fatti, vengono denominate, in maniera appropriata, “fallacie di generalizzazione”; a loro volta,
queste fallacie ricadono nelle varie classi subordinate, o gruppi naturali, alcuni dei quali saranno
enumerati a tempo debito.
91
Se ora rivolgiamo la nostra attenzione alle fallacie di deduzione, vale a dire a quei modi
dell'argomentazione scorretta le cui premesse, o alcune tra le cui premesse, sono proposizioni
generali mentre l'intera argomentazione è un ragionamento deduttivo — vediamo che possiamo
suddividere anche queste due fallacie in due specie simili alle precedenti; vale a dire, in quelle
fallacie che procedono in base a premesse false e in quelle fallacie le cui premesse, pur essendo
vere, non riescono a sorreggere la conclusione. Ma di queste due specie, la prima non deve
necessariamente cadere sotto l'uno o sotto l'altro dei capitoli che abbiamo già enumerato. Infatti
l'errore deve per forza stare o in quelle premesse che sono proposizioni generali o in quelle
premesse che asseriscono fatti individuali. Nel primo caso si tratta di una fallacia d'osservazione a
meno che nell'uno e nell'altro caso le premesse non siano state assunte a prima vista: e in questo
caso la fallacia è a priori. Infine, può darsi che le premesse, di qualsivoglia specie siano, non siano
mai state concepite in maniera tanto distinta da produrre una chiara consapevolezza dei mezzi
grazie ai quali sono state ottenute, come nel caso di quello che si chiama ragionamento circolare:
allora la fallacia sarà una fallacia di confusione.
Rimangono pertanto, come l'unica classe di fallacie che abbiano la loro sede appropriata nella
deduzione, le fallacie in cui le premesse del ragionamento deduttivo non riescono a corroborarne la
conclusione; in breve, rimangono i vari casi di argomentazione viziosa, ad evitare i quali
provvedono le regole del sillogismo. Le chiameremo “fallacie del ragionamento deduttivo”.
Possiamo così distinguere cinque classi di fallacie, che possono essere espresse nella seguente
tavola sinottica:
Fallacie
a prima vista —
ê
ê
ç
ê
ê
ç
di
inferenza
í
ê
ï
ê
ï
î
î
—
—
da prove
concepite
distintamente ï
ê
î
da
prove
concepite
indistintamente
Fallacie
induttive
Fallacie
deduttive
1) Fallacie a
priori
2) Fallacie di
osservazione
í 3) Fallacie di
generalizzazione
4) Fallacie di
ragionamento
deduttivo
5) Fallacie di
confusione
3. Non dobbiamo comunque aspettarci di trovare che gli errori commessi effettivamente dagli
uomini cadano sempre, o anche soltanto per lo più, in una di queste due classi, tanto infallibilmente
che non sia possibile farli rientrare in nessun'altra classe. Le argomentazioni erronee non sono
suscettibili di una divisione così netta come la divisione di cui sono suscettibili le argomentazioni
valide. Se è erronea, un'argomentazione espressa in modo completo e con tutti i suoi passi scanditi
distintamente in un linguaggio che non presti il fianco a fraintendimenti, non può non rientrare
inequivocabilmente nell'uno o nell'altro dei cinque modi suddetti: o meglio, non può non rientrare
nell'uno o nell'altro dei primi quattro modi, dal momento che, in forza dell'ipotesi, il quinto modo
non ha ragione di esistere. Ma non è nella natura del cattivo ragionamento l'esprimersi in modo
tanto privo d'ambiguità. Quando si può costringere un sofista, che voglia ingannare se stesso o tenti
d'abbindolare qualcun, altro, a gettare il proprio sofisma in una forma così distinta, nella maggior
parte dei casi non sarà più necessario far ancora qualcosa per smascherarlo.
92
Dovunque, tranne che nelle scuole, da tutte le argomentazioni vengono soppressi alcuni passi:
questo accade, a fortiori, quando chi argomenta intende ingannare il suo interlocutore, oppure è un
pensatore zoppo e inesperto, poco abituato a sottoporre a controlli i propri processi di
ragionamento: e l'errore s'annida più spesso proprio in quei passi del ragionamento che vengono
compiuti in questa maniera tacita e semi-consapevole, o addirittura del tutto inconsapevolmente. Se
si vuole smascherare la fallacia si deve rendere esplicita la proposizione che, così facendo, viene
assunta tacitamente; ma è molto probabile che l’autore del ragionamento non si sia mai realmente
chiesto che cosa assumesse; chi intenda confutarlo (a meno che non gli sia concesso impiegare il
modo d’interrogazione socratico per estorcergli la premessa che ha soppresso) deve giudicare da sé
quale dovrebbe essere, perché possa sostenere la conclusione, la premessa che quell’altro ha
soppresso. E quindi, per usare le parole dell’Arcivescovo Whately, “spesso non può non essere
materia di dubbio, o, per meglio dire, di scelta arbitraria, non soltanto in quale genere si debba far
rientrare ciascuna specie di fallacia, ma anche a quale specie si debba attribuire ciascuna singola
fallacia; infatti, siccome di solito nel corso di qualsiasi argomentazione viene taciuta almeno una
premessa, nel caso di una fallacia accade frequentemente che agli uditori non sia lasciata altra
alternativa che non sia quella o di supplire alla mancanza con una premessa che non è vera o,
altrimenti, di aggiungere una premessa che non dimostra la conclusione. Per esempio, se un uomo,
dopo aver analizzato dettagliatamente le cattive condizioni in cui versa il Paese, arguisce che il
governo di quel Paese è un governo tirannico, dobbiamo ritenere che assuma, o che “ogni Paese che
versa in cattive condizioni si trova sotto il dominio di una tirannide” — e questo è manifestamente
falso — o, semplicemente, che “ogni Paese che si trovi sotto il dominio di una tirannide versa in
cattive condizioni”, e questo, per quanto possa essere vero, non prova nulla, dal momento che il
termine medio non è stato preso universalmente”. Nella nostra distribuzione, la prima di queste
fallacie verrebbe classificata tra le fallacie di generalizzazione, l’ultima tra le fallacie di deduzione.
“Che cosa dobbiamo supporre che il nostro interlocutore volesse darci ad intendere ? di sicuro”
(ammesso che lui stesso capisse quello che diceva) “esattamente quello che si dà il caso che
ciascuno dei suoi uditori preferisca intendere: alcuni possono assentire alla premessa falsa, altri
possono concedere il sillogismo fallace”.
A rigore, perciò, quasi tutte le fallacie potrebbero essere fatte rientrare nella nostra quinta classe:
quella delle fallacie di confusione. Raramente una fallacia può essere fatta rientrare in assoluto in
qualcuna delle altre classi: possiamo soltanto dire che se tra gli anelli che si dovrebbero poter
fornire in un’argomentazione valida non ci fosse nessun posto vuoto, le cose starebbero così (e
formerebbero una fallacia di una certa classe) oppure così (e allora formerebbero una fallacia di una
cert’altra classe); oppure possiamo dire, al massimo, che è estremamente probabile che la
conclusione abbia avuto origine in una fallacia di questa o di quell’altra classe. Così, è
estremamente probabile che nell’esempio che abbiamo appena citato l’errore che si è commesso
possa esser fatto risalire a una fallacia di generalizzazione: la fallacia, cioè, che consiste nello
scambiare erroneamente un segno incerto, o un pezzo di prova incerta, per un segno o per una prova
certi; nel concludere da un effetto a una delle sue possibili cause quando ci sono altre cause che
sarebbero egualmente state in grado di produrre quell’effetto.
Tuttavia, benché le cinque classi confluiscano l’una nell’altra e spesso sembri che sia del tutto
arbitrario il far rientrare un certo errore particolare in una di queste classi piuttosto che in una
qualsiasi altra, la distinzione che abbiamo tracciato è di considerevole utilità. Troveremo che è
conveniente separare dalle altre, come fallacie di confusione, quelle fallacie la cui caratteristica più
ovvia è appunto la confusione; quelle fallacie, cioè, in cui per l’errore che si è commesso non si può
trovare altra causa che non sia la trascuratezza nel formulare la questione, o l’incapacità di
formularla con proprietà e di apprendere le prove in modo ben definito e con esattezza. Nelle
quattro classi che rimangono metterò non soltanto i casi la cui prova si può vedere chiaramente per
quello che è, e tuttavia se ne ricava una conclusione sbagliata, ma anche quei casi in cui, pur
essendoci confusione, questa non è la sola causa dell’errore ma c’è una sia pur debole traccia di
ragioni d’errore nella natura delle prove medesime. E nel distribuire tra le quattro classi di fallacie
93
questi casi di confusione parziale, supporrò, quando possa sussistere qualche esitazione a proposito
della collocazione precisa della fallacia, che quest’ultima risieda in quella parte del processo in cui,
data la natura del caso e le tendenze della mente umana, è più probabile che si commetta un errore
in quelle circostanze particolari.
Fatte queste osservazioni procederemo senza ulteriori preamboli a prendere in considerazione le
cinque classi, nell’ordine che abbiamo stabilito.
94
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)
“Su verità e menzogna in senso extramorale” (ms. 1873)
lingua originale: tedesco
edizione di riferimento: G. Colli, M. Montinari, Sämtliche Werke,
Taschenbuch Verlag, Monaco di Baviera, 1988
tr. it. G. Colli, Adelphi, Milano, 1970
1
In un angolo remoto dell’universo scintillante e diffuso attraverso infiniti sistemi solari c’era una
volta un astro, su cui animali intelligenti scoprirono la conoscenza. Fu il minuto più tracotante e più
menzognero della «storia del mondo»: ma tutto ciò durò soltanto un minuto. Dopo pochi respiri
della natura, la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire. – Qualcuno potrebbe
inventare una favola di questo genere, ma non riuscirebbe tuttavia a illustrare sufficientemente
quanto misero, spettrale, fugace, privo di scopo e arbitrario sia il comportamento dell’intelletto
umano entro la natura. Vi furono eternità in cui esso non esisteva; quando per lui tutto sarà
nuovamente finito, non sarà avvenuto nulla di notevole. Per quell’intelletto, difatti, non esiste una
missione ulteriore che conduca al di là della vita umana. Esso piuttosto è umano, e soltanto chi lo
possiede e lo produce può considerarlo tanto pateticamente, come se i cardini del mondo ruotassero
su di lui. Se noi riuscissimo a intenderci con la zanzara, apprenderemmo che anch’essa nuota
attraverso l’aria con questo pathos e si sente il centro – che vola – di questo mondo. Non vi è nulla
di abbastanza spregevole e scadente nella natura, che con un piccolo e leggero alito di quella forza
del conoscere non si gonfi senz’altro come un otre. E come ogni facchino vuole avere i suoi
ammiratori, così il più orgoglioso fra gli uomini, il filosofo, crede che da tutti i lati gli occhi
dell’universo siano rivolti telescopicamente sul suo agire e sul suo pensare.
È degno di nota che tutto ciò sia prodotto dall’intelletto, il quale è concesso – unicamente come
aiuto –agli esseri più infelici, più delicati e più transitori, allo scopo di trattenerli per un minuto
nell’esistenza, onde essi altrimenti, senza quell’aggiunta, avrebbero ogni motivo di sfuggire tanto
rapidamente quanto il figlio di Lessing. Quell’alterigia connessa col conoscere e col sentire, sospesa
come nebbia abbagliante dinanzi agli occhi e ai sensi degli uomini, li inganna dunque sul valore
dell’esistenza, portando in sé la più lusinghevole valutazione riguardo al conoscere. Il suo effetto
più universale è l’inganno, ma anche gli effetti più particolari portano in sé qualcosa del medesimo
carattere.
L’intelletto, come mezzo per conservare l’individuo, spiega le sue forze principali nella finzione.
Questa infatti è il mezzo con cui gli individui più deboli e meno robusti si conservano, in quanto a
essi è preclusa una lotta per l’esistenza da condursi con le corna o con gli aspri morsi degli animali
feroci. Nell’uomo quest’arte della finzione raggiunge il suo culmine: qui l’illudere, l’adulare, il
mentire e l’ingannare, il parlar male di qualcuno in sua assenza, il rappresentare, il vivere in uno
splendore preso a prestito, il mascherarsi, le convenzioni che nascondono, il far la commedia
dinanzi agli altri e a se stessi, in breve il continuo svolazzare attorno alla fiamma della vanità
costituisce a tal punto la regola e la legge, che nulla, si può dire, è più incomprensibile del fatto che
fra gli uomini possa sorgere un impulso onesto e puro verso la verità. Essi sono profondamente
immersi nelle illusioni e nelle immagini del sogno, il loro occhio scivola sulla superficie delle cose,
vedendo «forme», il loro sentimento non conduce mai alla verità, ma si accontenta di ricevere
stimoli e, per così dire, di accarezzare con un giuoco tattile il dorso delle cose. Oltre a ciò, di notte
l’uomo si lascia ingannare nel sogno, per tutta la vita, senza che il suo sentimento morale cerchi mai
di impedire ciò; devono invece esistere uomini che con la forza di volontà hanno eliminato il
russare. In senso proprio, che cosa sa l’uomo su se stesso? Forse che, una volta tanto, egli sarebbe
capace di percepire compiutamente se stesso, quasi si trovasse posto in una vetrina illuminata?
95
Forse che la natura non gli nasconde quasi tutto, persino riguardo al suo corpo, per confinarlo e
racchiuderlo in un’orgogliosa e fantasmagorica coscienza, lontano dall’intreccio delle sue viscere,
dal rapido flusso del suo sangue, dai complicati fremiti delle sue fibre? La natura ha gettato via la
chiave, e guai alla fatale curiosità che una volta riesca a guardare attraverso una fessura dalla cella
della coscienza, in fuori e in basso, e che un giorno abbia il presentimento che l’uomo sta sospeso
nei suoi sogni su qualcosa di spietato, avido, insaziabile e, per così dire, sul dorso di una tigre. In
una tale costellazione, da quale parte del mondo sorgerà mai l’impulso verso la verità?
In quanto l’individuo, di fronte ad altri individui, vuole conservarsi, esso utilizza per lo più
l’intelletto, in uno stato naturale delle cose, soltanto per la finzione: ma poiché al tempo stesso
l’uomo, per bisogno o per noia, vuole esistere socialmente come in un gregge, egli è spinto a
concludere la pace, e tende a far scomparire dal suo mondo almeno il più rozzo bellum omnium
contra omnes. Questo trattato di pace porta in sé qualcosa che si presenta come il primo passo per
raggiungere quell’enigmatico impulso alla verità. A questo punto viene fissato ciò che in seguito
dovrà essere la «verità»; in altre parole, viene scoperta una designazione delle cose uniformemente
valida e vincolante, e la legislazione del linguaggio fornisce altresì le prime leggi della verità. Sorge
qui infatti, per la prima volta, il contrasto tra verità e menzogna. Il mentitore adopera le
designazioni valide, le parole, per fare apparire come reale ciò che non è reale. Egli dice per
esempio: «io sono ricco», mentre per il suo stato la designazione esatta sarebbe proprio «povero».
Egli fa cattivo uso delle salde convenzioni, scambiando arbitrariamente, o addirittura invertendo i
nomi. Quando egli fa questo in modo egoistico, che può d’altronde recare danno, la società non si
fiderà più di lui e così lo escluderà da sé. Nel far ciò gli uomini cercano di evitare, non tanto
l’essere ingannati, quanto l’essere danneggiati dall’inganno: anche su questo piano essi in fondo
non odiano l’inganno, bensì le conseguenze brutte e ostili di certe specie di inganni. In tale senso
limitato, l’uomo vuole soltanto la verità: egli desidera le conseguenze piacevoli – che preservano la
vita – della verità, è indifferente di fronte alla conoscenza pura, priva di conseguenze, mentre è
disposto addirittura ostilmente verso le verità forse dannose e distruttive. Oltre a ciò come stanno le
cose rispetto alle suddette convenzioni del linguaggio? Sono forse prodotti della conoscenza, del
senso della verità, forse che le designazioni e le cose si sovrappongono? Il linguaggio è dunque
l’espressione adeguata di tutte le realtà?
Solo attraverso l’oblio l’uomo può giungere a credere di possedere una «verità» nel grado sopra
designato. Quando egli non si accontenta della verità in forma di tautologia, ossia non si appaga di
gusci vuoti, baratterà sempre verità e illusioni. Che cos’è una parola? Il riflesso in suoni di uno
stimolo nervoso. Ma il concludere da uno stimolo nervoso a una causa fuori di noi è già il risultato
di una applicazione falsa e ingiustificata del principio di ragione. Se nella genesi del linguaggio la
verità fosse risultata decisiva, se nelle designazioni fosse stato decisivo unicamente il punto di vista
della certezza, come potremmo ancora dire: la pietra è dura, quasi che «duro» ci fosse noto anche
altrimenti, e non soltanto come uno stimolo del tutto soggettivo? Noi dividiamo le cose in generi,
designiamo l’albero come maschile e la pianta come femminile: quali trasposizioni arbitrarie! Che
distacco dal canone della certezza! Noi parliamo di un «serpente»: la designazione non riguarda
altro se non la tortuosità, e potrebbe quindi spettare altresì al verme. Quali delimitazioni arbitrarie,
quali preferenze unilaterali, accordate ora all’una ora all’altra proprietà di una cosa! Le diverse
lingue, poste l’una accanto all’altra, mostrano che nelle parole non ha mai importanza la verità, né
un’espressione adeguata. In caso contrario non esisterebbero infatti così tante lingue. La «cosa in
sé» (la verità pura e priva di conseguenze consisterebbe appunto in ciò) è d’altronde del tutto
inafferrabile per colui che costruisce il linguaggio, e non è affatto degna per lui di essere ricercata.
Egli designa soltanto le relazioni delle cose con gli uomini e ricorre all’aiuto delle più ardite
metafore per esprimere tali relazioni. Uno stimolo nervoso, trasferito anzitutto in un’immagine:
prima metafora. L’immagine è poi plasmata in un suono: seconda metafora. Ogni volta si ha un
cambiamento completo della sfera, un passaggio a una sfera del tutto differente e nuova. Si può
immaginare un uomo che sia completamente sordo e non abbia mai avuto una sensazione del suono
e della musica: allo stesso modo che costui, per esempio, si meraviglia di fronte alle figure
96
acustiche di Chladni, disegnate sulla sabbia, trova le loro cause nelle vibrazioni della corda ed è
disposto a giurare di sapere ormai che cosa sia ciò che gli uomini chiamano «suono», così avviene a
tutti noi riguardo al linguaggio. Noi crediamo di sapere qualcosa sulle cose stesse, quando parliamo
di alberi, di colori, di neve e di fiori, eppure non possediamo nulla se non metafore delle cose che
non corrispondono affatto alle essenze originarie. Come il suono si presenta in quanto figura nella
sabbia, così l’enigmatico x della cosa in sé ora si presenta come stimolo nervoso, ora come
immagine, ora infine come suono. In ogni caso il sorgere della lingua non segue un procedimento
logico, e l’intero materiale su cui e con cui più tardi lavorerà e costruirà l’uomo della verità,
l’indagatore, il filosofo, proviene, se non da una Nefelococcigia, certo però non dall’essenza delle
cose.
Soffermiamoci ancora particolarmente sulla formazione dei concetti. Ogni parola diventa
senz’altro un concetto, per il fatto che essa non è destinata a servire eventualmente per ricordare
l’esperienza primitiva, non ripetuta e perfettamente individualizzata, ma deve adattarsi al tempo
stesso a innumerevoli casi più o meno simili, cioè – a rigore – mai uguali, e quindi a casi
semplicemente disuguali. Ogni concetto sorge con l’equiparazione di ciò che non è uguale. Se è
certo che una foglia non è mai perfettamente uguale a un’altra, altrettanto certo è che il concetto di
foglia si forma mediante un arbitrario lasciar cadere queste differenze individuali, mediante un
dimenticare l’elemento discriminante, e suscita poi la rappresentazione che nella natura, all’infuori
delle foglie, esiste un qualcosa che è «foglia», quasi una forma primordiale, sul modello della quale
sarebbero tessute, disegnate, circoscritte, colorate, increspate, dipinte – ma da mani maldestre –
tutte le foglie, in modo tale che nessun esemplare risulterebbe corretto e attendibile in quanto copia
fedele della forma originale. Noi chiamiamo un uomo «onesto». Perché costui si è comportato oggi
così onestamente? – domandiamo. La nostra risposta è di solito: a causa della sua onestà. L’onestà!
Ciò significa nuovamente: la foglia è la causa delle foglie. Non sappiamo assolutamente nulla di
una qualità essenziale che si chiami l’onestà; e conosciamo invece numerose azioni individuali, e
quindi disuguali, che noi equipariamo tra loro, lasciando cadere ciò che vi è di disuguale, e che
allora designiamo come azioni oneste. Partendo da esse formuliamo infine una qualitas occulta, con
il nome: l’onestà.
Il trascurare ciò che vi è di individuale e di reale ci fornisce il concetto, allo stesso modo che ci
fornisce la forma, mentre la natura non conosce invece nessuna forma e nessun concetto, e quindi
neppure alcun genere, ma soltanto una x, per noi inattingibile e indefinibile. Altresì la nostra antitesi
tra individuo e genere è infatti antropomorfica e non sgorga dall’essenza delle cose, anche se non
osiamo dire che tale antitesi non corrisponde a tale essenza. Questa sarebbe infatti un’asserzione
dogmatica, e come tale altrettanto indimostrabile quanto la sua contraria.
Che cos’è dunque la verità? Un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi, in
breve una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeticamente e retoricamente, che
sono state trasferite e abbellite, e che dopo un lungo uso sembrano a un popolo solide, canoniche e
vincolanti: le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, sono metafore che si
sono logorate e hanno perduto ogni forza sensibile, sono monete la cui immagine si è consumata e
che vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non più come monete. Sinora noi non
sappiamo onde derivi l’impulso verso la verità; sinora infatti abbiamo inteso parlare soltanto
dell’obbligo imposto dalla società per la sua esistenza: essere veritieri, cioè servirsi delle metafore
usuali. L’espressione morale di ciò è dunque la seguente: sinora abbiamo inteso parlare soltanto
dell’obbligo di mentire secondo una salda convenzione, ossia di mentire come si conviene a una
moltitudine, in uno stile vincolante per tutti. Senza dubbio l’uomo si dimentica che le cose stanno a
questo modo; egli mente dunque nella maniera suddetta, incoscientemente e per una abitudine
secolare, giungendo al sentimento della verità proprio attraverso questa incoscienza, proprio
attraverso questo oblio. Con il sentimento di essere obbligati a designare una cosa come rossa,
un’altra come fredda, una terza come muta, si risveglia un sentimento morale riferentesi alla verità.
Fondandosi sul contrasto dell’uomo menzognero, di cui nessuno si fida e che tutti evitano, l’uomo
dimostra a se stesso che la verità è degna di rispetto e di fiducia, e altresì utile. Come essere
97
razionale, egli pone ora il suo agire sotto il controllo delle astrazioni; non ammette più di essere
trascinato dalle impressioni istantanee e dalle intuizioni, generalizza tutte queste impressioni,
traendone concetti scoloriti e tiepidi, per aggiogare a essi il carro della sua vita e della sua azione.
Tutto ciò che distingue l’uomo dall’animale dipende da questa capacità di sminuire le metafore
intuitive in schemi, cioè di risolvere un’immagine in un concetto. Nel campo di quegli schemi è
possibile cioè qualcosa che non potrebbe mai riuscire sotto il dominio delle prime impressioni
intuitive: costruire un ordine piramidale, suddiviso secondo caste e gradi, creare un nuovo mondo di
leggi, di privilegi, di subordinazioni, di delimitazioni, che si contrapponga ormai all’altro mondo
intuitivo delle prime impressioni come qualcosa di più solido, di più generale, di più noto, di più
umano, e quindi come l’elemento regolatore e imperativo. Mentre ogni metafora intuitiva è
individuale e risulta senza pari, sapendo perciò sempre sfuggire a ogni registrazione, la grande
costruzione dei concetti mostra invece la rigida regolarità di un colombario romano e manifesta
nella logica quel rigore e quella freddezza che sono propri della matematica. Chi è ispirato da
questa freddezza difficilmente crederà che il concetto – osseo come un dado, spostabile e munito di
otto vertici come questo – sussista unicamente come il residuo di una metafora, e che l’illusione del
trasferimento artistico di uno stimolo nervoso in immagini, se non è la madre, sia tuttavia l’antenata
di ogni concetto. In questo concettuale giuoco di dadi si chiama peraltro «verità» il servirsi di ogni
dado secondo la sua designazione, il contare con esattezza i punti segnati su ogni faccia, il costruire
rubriche giuste e il non turbare mai l’ordinamento di caste e la serie gerarchica delle classi. Come i
Romani e gli Etruschi dividevano il cielo con rigide linee matematiche e in ciascuna di queste
caselle, come in un templum, relegavano un dio, così ogni popolo trova sopra di sé un siffatto ciclo
concettuale suddiviso matematicamente, e per esigenze della verità intende il ricercare ogni dio
concettuale unicamente nella sua sfera. Senza dubbio si può a questo proposito ammirare l’uomo
come un potente genio costruttivo, che riesce – su mobili fondamenta, e per così dire, sull’acqua
corrente – a elevare una cupola concettuale infinitamente complicata; certo, per raggiungere una
stabilità su siffatte fondamenta, occorrerà una costruzione fatta di ragnatele, tanto tenue da non
essere trascinata via dalle onde e tanto solida da non essere spazzata via al soffiare di ogni vento.
Come genio costruttivo, l’uomo si innalza a questo modo al di sopra delle api: queste costruiscono
con la cera che raccolgono ricavandola dalla natura, mentre l’uomo costruisce con la materia assai
più tenue dei concetti che egli deve fabbricarsi da sé. In ciò egli è degno di grande ammirazione,
non già tuttavia a causa del suo impulso verso la verità e la conoscenza pura delle cose. Se qualcuno
nasconde qualcosa dietro un cespuglio, se lo ricerca nuovamente là e ve lo ritrova, in questa ricerca
e in questa scoperta non vi è molto da lodare: eppure le cose stanno a questo modo riguardo alla
ricerca e alla scoperta della «verità», entro il territorio della ragione. Se io formulo la definizione
del mammifero, e in seguito, vedendo un cammello, dichiaro: «ecco un mammifero», in tal caso
viene portata alla luce senza dubbio una verità, ma quest’ultima ha un valore limitato, a mio avviso;
è completamente antropomorfica e non contiene neppure un solo elemento che sia «vero in sé»,
reale e universalmente valido, a prescindere dall’uomo. L’indagatore di queste verità in fondo cerca
soltanto la metamorfosi del mondo nell’uomo, si sforza di comprendere il mondo come una cosa
umana e nel caso migliore riesce a raggiungere il sentimento di una assimilazione. Allo stesso modo
in cui l’astrologo considerava le stelle al servizio degli uomini e in collegamento con la loro felicità
e con i loro dolori, così un tale indagatore considera il mondo intero come connesso con l’uomo,
come l’eco infinitamente ripercossa di un suono originario, cioè dell’uomo, come il riflesso
moltiplicato di un’immagine primordiale, cioè dell’uomo. Il suo metodo considera l’uomo come
misura di tutte le cose: nel far ciò tuttavia egli parte da un errore iniziale, credere cioè che egli abbia
queste cose immediatamente dinanzi a sé, come oggetti puri. Egli dimentica così che le metafore
originarie dell’intuizione sono pur sempre metafore, e le prende per le cose stesse.
Solo quando l’uomo dimentica quel primitivo mondo di metafore, solo quando la massa
originaria di immagini – che sgorgano con ardente fluidità dalla primordiale facoltà della fantasia
umana – si indurisce e irrigidisce, solo quando si crede, con una fede invincibile, che questo sole,
questa finestra, questo tavolo siano verità in sé: in breve, solo quando l’uomo dimentica se stesso in
98
quanto soggetto, e precisamente in quanto soggetto artisticamente creativo, solo allora egli può
vivere con una certa calma, sicurezza e coerenza. Se egli potesse uscire soltanto per un attimo dalle
mura segregatrici di questa fede, la sua «autocoscienza» si dissolverebbe allora d’un tratto. Già gli
costa molta fatica l’ammettere che l’insetto o l’uccello percepiscono un mondo del tutto differente
da quello umano, e che la questione di determinare quale delle due percezioni del mondo sia la più
giusta è del tutto priva di senso, poiché una misura in proposito dovrebbe essere stabilita in base al
criterio della percezione esatta, cioè in base a un criterio che non esiste. In generale poi la
percezione esatta – il che significherebbe l’espressione adeguata di un oggetto nel soggetto – mi
sembra un’assurdità contraddittoria: in effetti tra due sfere assolutamente diverse, quali sono il
soggetto e l’oggetto, non esiste alcuna causalità, alcuna esattezza, alcuna espressione, ma tutt’al più
un rapporto estetico, intendo dire una trasposizione allusiva, una traduzione balbettata in una lingua
del tutto straniera, il che richiederebbe in ogni caso una sfera intermedia e una capacità intermedia
che fossero capaci di poetare e di inventare liberamente. La parola apparenza contiene molte
tentazioni, e perciò la evito per quanto è possibile: non è infatti vero che l’essenza delle cose appaia
nel mondo empirico. Un pittore, cui manchino le mani e che voglia esprimere con il canto
l’immagine che gli sta di fronte, lascerà indovinare, con questo scambio di sfere, più di quanto il
mondo empirico non lasci indovinare riguardo all’essenza delle cose. Persino il rapporto tra uno
stimolo nervoso e l’immagine prodotta non è in sé affatto necessario: ma quando la medesima
immagine viene prodotta milioni di volte e viene trasmessa ereditariamente attraverso molte
generazioni umane, apparendo infine a tutta quanta l’umanità ogni volta come conseguenza della
medesima occasione, essa in conclusione acquista per l’uomo il medesimo significato che le
spetterebbe se fosse l’unica immagine necessaria, e se quel rapporto fra l’originario stimolo nervoso
e l’immagine prodotta fosse un rigido rapporto di causalità. Allo stesso modo un sogno,
eternamente ripetuto, sarebbe sentito e giudicato interamente come realtà. Ma l’indurirsi e,
l’irrigidirsi di una metafora non offre assolutamente alcuna garanzia per la necessità e per l’autorità
esclusiva di questa metafora.
Ogni uomo cui tali considerazioni siano familiari ha senza dubbio sentito una profonda
diffidenza verso ogni idealismo cosiffatto, ogni volta che egli si sia convinto con grande chiarezza
dell’eterno rigore, dell’onnipresenza e dell’infallibilità delle leggi naturali. Egli è giunto alla
seguente conclusione: in questo campo – sin dove possiamo giungere, verso l’altezza del mondo
telescopico e verso la profondità del mondo microscopico – tutto è sicuro, costruito, infinito,
conforme a leggi e senza lacune; la scienza potrà eternamente scavare questi pozzi con successo, e
tutto ciò che sarà trovato risulterà concordante e non contraddittorio. Tutto ciò assomiglia davvero
poco a un prodotto della fantasia: se tale fosse il caso, difatti, da qualche parte dovrebbe trasparire
l’illusione e l’irrealtà. Invece occorre dire: se ciascuno di noi, per sé, avesse una differente
sensazione, se noi stessi potessimo percepire ora come uccelli, ora come vermi, ora come piante,
oppure se uno di noi vedesse il medesimo stimolo come rosso e un altro lo vedesse come azzurro, se
un terzo udisse addirittura tale stimolo come suono, nessuno potrebbe allora parlare di una tale
regolarità della natura, ma la intenderebbe unicamente come una creazione estremamente
soggettiva. Oltre a ciò, che cos’è per noi, in generale, una legge della natura? Essa ci è nota non già
in sé, bensì soltanto nei suoi effetti, cioè nelle sue relazioni con altre leggi naturali, che a loro volta
ci sono note soltanto come somme di relazioni. Tutte queste relazioni rimandano perciò sempre
l’una all’altra, e nella loro essenza risultano per noi perfettamente incomprensibili: in tutto ciò ci è
realmente noto soltanto quello che noi stessi aggiungiamo, il tempo, lo spazio, ossia rapporti di
successione e numeri. Peraltro l’intero elemento miracoloso –proprio quello che ammiriamo nelle
leggi naturali –che esige una nostra spiegazione e potrebbe indurci a diffidare dell’idealismo
consiste proprio unicamente nel rigore matematico e nell’inviolabilità delle rappresentazioni di
tempo e spazio. Queste, tuttavia, noi le produciamo in noi, traendole da noi stessi con quella
necessità con cui il ragno tesse la sua tela ; se siamo costretti a comprendere tutte le cose
unicamente in base a queste forme, non c’è allora più da meravigliarci che in tutte le cose noi
possiamo appunto comprendere, propriamente, soltanto queste forme: tutte quante debbono infatti
99
portare in sé le leggi del numero e il numero è appunto l’elemento più stupefacente che esista nelle
cose. Ogni conformità a leggi, la quale ci fa talmente impressione nel corso degli astri e nei processi
chimici, coincide in fondo con quelle proprietà che noi stessi introduciamo nelle cose, cosicché
siamo noi che facciamo impressione a noi stessi. Da ciò risulta senza dubbio che quella formazione
artistica di metafore, con cui comincia in noi ogni sensazione, presuppone già quelle forme, ossia
viene compiuta in esse; è soltanto la salda permanenza di- queste forme originarie, che può spiegare
la possibilità della susseguente costituzione, in base alle metafore stesse, dell’edificio dei concetti.
Tale edificio è infatti un’imitazione dei rapporti temporali, spaziali e numerici sul terreno delle
metafore.
2
Alla costruzione dei concetti lavora originariamente, come abbiamo visto, il linguaggio, e in epoche
posteriori la scienza. Come l’ape costruisce le sue celle e al tempo stesso le riempie di miele, così la
scienza lavora incessantemente a quel grande colombario dei concetti – cimitero delle intuizioni –
costruisce in quell’edificio piani nuovi e più alti, consolida, ripulisce, rinnova le antiche celle, e
soprattutto si sforza di riempire quella costruzione a scomparti, innalzata a un livello eccelso, e di
ordinarvi l’intero mondo empirico, ossia il mondo antropomorfico. Se già l’uomo di azione lega la
sua vita alla ragione e ai concetti razionali, per non essere trascinato via dalla corrente e per non
perdersi, all’indagatore poi spetta addirittura di costruire la sua capanna a ridosso della torre della
scienza, per poter contribuire alla sua edificazione e per poter trovare egli stesso un riparo ai piedi
del baluardo già costruito. E di protezione egli ha bisogno, poiché esistono forze terribili che
premono continuamente su di lui, contrapponendo alla «verità» scientifica altre «verità» di natura
del tutto diversa e munite dei più svariati stemmi.
Quell’impulso a formare metafore, quell’impulso fondamentale dell’uomo da cui non si può
prescindere neppure per un istante, poiché in tal mòdo si prescinderebbe dall’uomo stesso, risulta in
verità non già represso, ma a stento ammansito, dal fatto che con i suoi prodotti evanescenti, i
concetti, sia stato costruito per lui un nuovo mondo, regolare e rigido, come roccaforte. Tale
impulso si cerca allora un nuovo campo di azione, un altro alveo per la sua corrente, e trova tutto
ciò nel mito, e in generale nell’arte. Confonde continuamente le rubriche e gli scomparti dei
concetti, presentando nuove trasposizioni, metafore, metonimie; continuamente svela il desiderio di
dare al mondo sussistente dell’uomo desto una figura così variopinta, irregolare, priva di
conseguenze, incoerente, eccitante ed eternamente nuova, quale è data dal mondo del sogno. In sé,
anzi, l’uomo desto trae una chiara convinzione di essere sveglio unicamente dalla rigida e regolare
ragnatela dei concetti, e talvolta è portato a credere di sognare, appunto perché quella ragnatela
concettuale in certe occasioni viene strappata dall’arte. Pascal ha ragione quando sostiene che, se
ogni notte ci si presentasse il medesimo sogno, noi ci occuperemmo altrettanto di esso quanto delle
cose che vediamo ogni-giorno: «se un artigiano fosse sicuro di sognare ogni notte, per dodici ore
filate, di essere re, io credo allora» dice Pascal «che egli sarebbe altrettanto felice quanto un re che
sognasse tutte le notti, per dodici ore, di essere un artigiano». La veglia di un popolo — per esempio
degli antichi Greci — ispirato miticamente risulta, a causa dei miracoli continuamente operanti
quali sono accolti dal mito, realmente più simile al sogno che non alla veglia del pensatore
scientificamente disincantato. Quando ogni albero può avere l’occasione di parlare, nascondendo
una ninfa, quando sotto la figura di un toro un dio può trascinar via le vergini, quando la stessa dea
Atena viene vista improvvisamente, su un bel cocchio, attraversare le piazze di Atene in compagnia
di Pisistrato — e tutto ciò è creduto dai buoni Ateniesi – allora in ogni momento tutto è possibile,
come nel sogno, e tutta la natura si agita attorno all’uomo, quasi fosse unicamente una mascherata
degli dèi, contenti di fare uno scherzo all’uomo con ogni specie di metamorfosi ingannevoli.
L’uomo stesso peraltro ha un’invincibile tendenza a lasciarsi ingannare ed è come incantato di
felicità, quando il rapsodo gli racconta come vere delle favole epiche, o quando nel dramma l’attore
fa la parte del re in modo ancora più regale di quanto sia mostrato dalla realtà. L’intelletto, maestro
di finzione, è libero e sottratto al suo normale servizio da schiavo, sintanto che può ingannare senza
100
recare danno, e celebra allora i suoi Saturnali. In nessun’altra occasione esso è più esuberante, più
ricco, più orgoglioso, più abile e più audace: con gusto creativo mescola le metafore e sposta i
confini dell’astrazione, cosicché per esempio designa il fiume come la mobile strada che porta
l’uomo là dove di solito egli giunge camminando. Esso ha ormai gettato via da sé il segno della
soggezione: un tempo preoccupato, con triste operosità, di mostrare la via e gli strumenti a un
povero individuo che ha un ardente desiderio di vivere, un tempo pronto a rapinare e a predare
come lo è un servo per il suo padrone, ora invece è divenuto padrone e può cancellare dal suo volto
l’espressione della miseria. Tutto ciò che fa adesso, a confronto con le sue azioni precedenti, porta
in sé il segno della finzione, così come ciò che aveva fatto in precedenza portava in sé il segno della
caricatura.
Ora copia la vita umana, ma la prende come una cosa buona e sembra davvero contentarsi di
essa. Quella enorme impalcatura e travatura di concetti, aggrappandosi alla quale il misero uomo
riesce a salvarsi lungo la sua vita, costituisce, per l’intelletto divenuto libero, soltanto un’armatura e
un trastullo per i suoi audaci artifici. E se manda in frantumi tutto ciò, se lo mescola, lo ricompone
ironicamente, accoppiando le cose più estranee e separando le cose più affini, con ciò esso fa vedere
di non aver bisogno di quei ripieghi della miseria e di essere ormai guidato, non già da concetti,
bensì da intuizioni. Non esiste una strada regolare, che partendo da queste intuizioni conduca nella
terra degli schemi spettrali, delle astrazioni: la parola non è fatta per le intuizioni, e l’uomo
ammutolisce quando si trova dinanzi a esse, oppure parla unicamente con metafore proibite e con
inauditi accozzamenti di concetti, per adeguarsi creativamente – almeno con la distruzione e la
derisione delle vecchie barriere concettuali – all’impressione della possente intuizione attuale.
Vi sono epoche in cui l’uomo razionale e l’uomo intuitivo stanno l’uno accanto all’altro, il primo
con la paura dell’intuizione, il secondo con il disprezzo per l’astrazione. Quest’ultimo è altrettanto
non razionale, quanto il primo è non artistico. Entrambi desiderano di dominare sulla vita: l’uomo
razionale, in quanto sa affrontare i più importanti e i più impellenti bisogni con la previdenza, la
prudenza e la regolarità; l’uomo intuitivo, in quanto non vede – come «eroe supremamente
giocondo» – quei bisogni e considera come reale soltanto la vita trasformata dalla finzione in
parvenza e in bellezza. Se l’uomo intuitivo – come è avvenuto nell’antica Grecia – sa usare le sue
armi più vittoriosamente e più potentemente dell’avversario, può configurarsi, in caso favorevole,
una civiltà e può fondarsi il dominio dell’arte sulla vita: quella finzione, quel rinnegamento della
miseria, quello splendore delle intuizioni metaforiche, e in generale quell’immediatezza
dell’inganno accompagnano tutte le manifestazioni di una siffatta vita. Né l’abitazione, né
l’andatura, né l’abbigliamento, né l’orcio d’argilla lasciano scorgere di essere stati inventati da un
bisogno impellente. Sembra quasi che attraverso tutte queste cose debba esprimersi una sublime
felicità, una serenità olimpica, e per così dire un giocare con ciò che è serio. Mentre l’uomo guidato
dai concetti e dalle astrazioni non riesce per mezzo loro che a respingere l’infelicità, senza riuscire
egli stesso a procurarsi la felicità dalle sue astrazioni, mentre cioè egli si sforza per quanto è
possibile di liberarsi dal dolore, l’uomo intuitivo invece, ergendosi in mezzo a una civiltà, raccoglie
dalle sue intuizioni, oltre che una difesa dal male, un’illuminazione, un rasserenamento, una
redenzione, che affluiscono incessantemente. Senza dubbio egli soffre più violentemente, quando
soffre: egli soffre anzi più spesso, poiché non sa imparare dall’esperienza e cade sempre di nuovo
nel medesimo pozzo in cui era caduto una volta. Nel dolore poi è tanto irrazionale quanto nella
felicità: egli grida forte e non trova consolazione. Quanto diverso è il comportamento, di fronte a
un’eguale sventura, dell’uomo stoico, ammaestrato dall’esperienza, il quale si domina con l’aiuto
dei concetti! Lui, che altrimenti cerca soltanto la rettitudine, la verità, la libertà dagli inganni e la
difesa dalle sorprese seducenti, ora invece, nella sventura, mette in mostra il capolavoro della
dissimulazione, come quell’altro aveva fatto nella felicità: egli non rivela un volto umano mobile e
vibrante, ma per cosa dire una maschera, con un dignitoso equilibrio nei tratti; egli non grida e non
cambia nemmeno la sua voce. Se un nuvolone temporalesco si rovescia su di lui, egli si avvolge nel
suo mantello e se ne va a lento passo sotto il temporale.
101
Charles Sanders Peirce
(1839-1914)
‘Deduzione, induzione e ipotesi’ (1878)
lingua originale: inglese
prima pubblicazione in Popular Science Monthly (vol. 13)
ed. di riferimento (in via di essere superato): Collected Papers, a cura di Hartshorne
et al., Harvard UP, (8 voll.) 1931-58
tr. it. M.A. Bonfantini, Bompiani, Milano, 2003
Le tre combinazioni inferenziali di regola, caso, risultato
2.619. Il primo compito di un logico è la classificazione degli argomenti, perché tutte le
procedure di prova e dimostrazione dipendono dalla precedente classificazione. I logici hanno
introdotto certe classi di argomenti, definendole mediante certe forme tipiche, dette sillogismi.
Per esempio, il sillogismo detto “Barbara” ha la forma seguente:
S è M, M è P; Dunque, S è P.
Ovvero, mettendo le parole al posto delle lettere:
Enoch ed Elia erano uomini, tutti gli uomini muoiono;
Dunque, Enoch ed Elia devono essere morti.
L’espressione «è P» usata dai logici sta per qualsiasi verbo, non importa se transitivo o
intransitivo. Si può dimostrare rigorosamente (ancorché io non lo faccia, per non infastidire il
lettore) che tutti gli argomenti possono essere ridotti a questa forma – ma soltanto a
condizione di intendere l’è della formula come equivalente a «è per gli scopi
dell’argomentazione» ovvero a «è rappresentato da». Così, un’induzione, messa mediante
questo artificio in forma di sillogismo in Barbara, figurerà disposta in una guisa come questa:
Questi fagioli sono per due terzi bianchi,
Ma i fagioli di questo sacco sono (rappresentati da) questi fagioli;
Dunque, i fagioli di questo sacco sono per due terzi bianchi.
2.620. Ma, dal fatto che tutte le inferenze possano essere ridotte in qualche modo a Barbara,
non consegue che questa sia la forma più appropriata in cui rappresentare ogni genere di
inferenza. Al contrario, per mostrare i caratteri distintivi delle differenti specie di inferenza,
esse devono chiaramente essere esibite nelle differenti forme che sono peculiari a ciascuna
specie. Barbara raffigura specificamente il ragionamento deduttivo: se si prende il suo è nel
significato proprio e letterale, nessun ragionamento induttivo può essere ridotto alla sua forma.
Barbara in effetti non è nient’altro che l’applicazione di una regola. Questa regola sí esprime
nella cosiddetta premessa maggiore, a esempio così: Tutti gli uomini sono mortali. L’altra
premessa, o premessa minore, pone un caso sotto la regola, nel nostro esempio così: Enoch era
un uomo. La conclusione applica la regola al caso e così deriva il risultato: Enoch è mortale.
Tutte le deduzioni hanno sempre questo carattere: non sono altro che l’applicazione di regole
generali a casi particolari. Qualche volta ciò non è immediatamente evidente, come nel
seguente esempio:
103
Letture autonome
Tutti i quadrangoli sono figure geometriche,
Ma nessun triangolo è un quadrangolo;
Dunque, alcune figure geometriche non sono triangoli.
Ma qui il vero svolgimento del ragionamento è questo:
Regola: Tutti i quadrangoli non sono triangoli.
Caso: Alcune figure geometriche sono quadrangoli.
Risultato: Alcune figure geometriche non sono triangoli.
Il ragionamento induttivo o sintetico, essendo qualcosa dí più della mera applicazione di una
regola generale a un caso particolare, non può essere ridotto a questa forma.
2.621. Se, da un sacco di fagioli, di cui sappiamo che i due terzi sono bianchi, ne prendiamo
uno a caso, è inferenza deduttiva che questo fagiolo sia probabilmente bianco – la probabilità
essendo di due terzi. In effetti, abbiamo qui il sillogismo seguente:
Regola: I fagioli di questo sacco sono per due terzi bianchi.
Caso: Questo fagiolo è stato tratto in modo tale che a lungo andare il numero relativo
dei fagioli bianchi tratti in questo modo risulterebbe eguale al numero relativo dei fagioli
bianchi del sacco.
Risultato: Questo fagiolo è stato tratto in modo tale che a lungo andare risulterebbe per
due terzi delle volte bianco.
2.622. Se, invece di trarre un solo fagiolo, traiamo a caso una manciata, e concludiamo che
circa i due terzi dei fagioli della manciata sono probabilmente bianchi, il ragionamento è
ancora dello stesso tipo. Se, invece, senza sapere in che proporzione sono i fagioli bianchi del
sacco, traiamo a caso una manciata e, trovando che i fagioli della manciata sono per due terzi
bianchi, concludiamo che i fagioli del sacco sono per due terzi bianchi, allora rovesciamo il
corso della sequenza deduttiva, e concludiamo una regola dall’osservazione di un risultato in
un certo caso. Ciò è particolarmente chiaro quando tutta la manciata risulta del medesimo
colore.
L’induzione allora è:
Questi fagioli erano in questo sacco.
Questi fagioli sono bianchi.
Dunque, tutti i fagioli in questo sacco erano bianchi
Tale induzione non è che un’inversione del sillogismo
Regola: Tutti i fagioli in questo sacco erano bianchi.
Caso: Questi fagioli erano in questo sacco.
Risultato: Questi fagioli sono bianchi.
Sicché l’induzione è l’inferenza della regola dal caso e dal risultato.
2.623. Ma questa non è la sola guisa in cui si può invertire un sillogismo in modo da produrre
un’inferenza sintetica. Supponete che io entri in una stanza e qui trovi tanti sacchi pieni di
diversi tipi di fagioli. Sul tavolo c’è una manciata di fagioli bianchi. Dopo aver cercato un po’,
scopro che uno dei sacchi della stanza contiene soltanto fagioli bianchi. Ne inferisco subito
104
Letture autonome
che è assai probabile che la manciata di fagioli bianchi sia stata tratta proprio da quel sacco.
Percorrere questo tipo di inferenza si chiama fare un’ipotesi. L’ipotesi è l’inferenza di un caso
da una regola e da un risultato.
Abbiamo allora:
DEDUZIONE
Regola: Tutti i fagioli di questo sacco sono bianchi.
Caso: Questi fagioli sono di questo sacco.
Risultato: Questi fagioli sono bianchi.
INDUZIONE
Caso: Questi fagioli sono di questo sacco.
Risultato: Questi fagioli sono bianchi.
Regola: Tutti i fagioli di questo sacco sono bianchi.
IPOTESI
Regola: Tutti i fagioli di questo sacco sono bianchi.
Risultato: Questi fagioli sono bianchi.
Caso: Questi fagioli sono di questo sacco.
Di conseguenza, classifichiamo tutte le inferenze nel modo seguente:
Inferenza
Deduttiva
o
analitica
Sintetica
Induzione
Ipotesi
Le due inferenze sintetiche: induzione e ipotesi
2.624. Abbiamo un’induzione quando generalizziamo da un certo numero di casi per i quali
qualcosa è vero e inferiamo che quella medesima cosa è vera per un’intera classe. Oppure
quando troviamo che una certa cosa è vera in una certa proporzione di casi osservati e
inferiamo che quella medesima cosa è vera nella medesima proporzione per l’intera classe.
105
Letture autonome
Abbiamo un’ipotesi quando troviamo qualche circostanza curiosa, che sarebbe spiegata dalla
supposizione che fosse la conseguenza di un caso ascrivibile a una regola generale, e perciò
adottiamo quella supposizione. Oppure quando troviamo che due oggetti presentano una forte
somiglianza sotto certi rispetti e desumiamo che essi devono somigliare fra loro fortemente
anche sotto altri rispetti.
2.625. Una volta, sbarcato in un porto di Turchia, me ne andavo a piedi a fare una visita,
quando incontrai un uomo a cavallo, circondato da quattro cavalieri che tenevano sul suo capo
un baldacchino. Dato che il governatore della provincia era l’unico personaggio che potevo
pensare che fosse oggetto di così grandi onori, inferii che quell’uomo lo fosse. Questa era
un’ipotesi.
Troviamo dei fossili, resti come quelli dei pesci, ma ben dentro il continente. Per spiegare il
fenomeno, supponiamo che una volta il mare bagnasse il territorio. Questa è un’altra ipotesi.
Innumerevoli documenti e monumenti si riferiscono a un conquistatore chiamato Napoleone
Bonaparte. Sebbene non abbiamo mai visto quest’uomo, tuttavia ci risulta impossibile
spiegare quanto invece abbiamo ben visto, e cioè tutti questi documenti e monumenti, senza
supporre che sia realmente esistito. Un’altra ipotesi.
In generale, l’ipotesi va ritenuta una specie debole di argomento. Spesso inclina il nostro
giudizio così lievemente verso la sua conclusione che non si può dire neppure che crediamo
che questa conclusione sia vera: ci limitiamo a congetturare che potrebbe essere vera. Ma c’è
solo una differenza di grado fra queste inferenze deboli e dubitose e l’inferenza che ci fa
credere che noi rammentiamo davvero gli avvenimenti di ieri perché ne abbiamo il sentimento.
Da Baroco e Bocardo all’Ipotesi e all’Induzione
2.626. Oltre a quello testé illustrato c’è un altro modo di invertire un sillogismo deduttivo per
produrre un’induzione o un’ipotesi. Se dalla verità di una certa premessa segue
necessariamente la verità di una certa conclusione, allora dalla falsità della conclusione segue
la falsità della premessa. Prendiamo a esempio il seguente sillogismo in Barbara:
Regola: Tutti gli uomini sono mortali,
Caso: Enoch ed Elia erano uomini;
Risultato: Enoch ed Elia erano mortali.
Ora, chi nega il risultato può ammettere la regola, e allora deve negare il caso. Così:
Negazione del Risultato: Enoch ed Elia non erano mortali,
Regola: Tutti gli uomini sono mortali;
Negazione del Caso: Enoch ed Elia non erano uomini.
Questo genere di sillogismo, che è il modo tipico della seconda figura, è detto “Baroco”.
D’altronde, chi neghi il risultato, può ammettere il caso, e allora deve negare la regola. Così:
Negazione del Risultato: Enoch ed Elia non erano mortali,
Caso: Enoch ed Elia erano uomini;
Negazione della Regola: Alcuni uomini non sono mortali.
Questo genere di sillogismo, che è il modo tipico della terza figura, è detto “Bocardo”.
2.627. Baroco e Bocardo sono naturalmente sillogismi deduttivi; ma di un genere molto
particolare. I logici li chiamano modi indiretti, perché necessitano di alcune trasformazioni per
106
Letture autonome
essere messi nella forma di applicazione di una regola a un caso particolare. Ma se, invece di
partire come abbiamo fatto con una deduzione necessaria in Barbara, prendiamo una
deduzione probabile in Barbara, allora i modi indiretti che otterremo saranno:
un’ipotesi, corrispondente a Baroco;
e un’induzione, corrispondente a Bocardo.
Prendiamo infatti come base a esempio questa deduzione probabile in Barbara:
Regola: La maggior parte dei fagioli di questo sacco sono bianchi,
Caso: Questa manciata di fagioli è stata presa da questo sacco;
Risultato: Probabilmente, la maggior parte dei fagioli di questa manciata sono bianchi.
Neghiamo ora il risultato, accettando la regola:
Negazione del Risultato: Pochi dei fagioli di questa manciata sono bianchi,
Regola: La maggior parte dei fagioli di questo sacco sono bianchi;
Negazione del Caso: Probabilmente, questa manciata di fagioli è stata presa da un altro
sacco.
E questa è un’inferenza ipotetica. Neghiamo poi il risultato, ma accettando il caso:
Negazione del Risultato: Pochi dei fagioli di questa manciata sono bianchi,
Caso: Questa manciata di fagioli è stata presa da questo sacco;
Negazione della Regola: Probabilmente, pochi dei fagioli dí questo sacco sono bianchi.
E questa è un’induzione.
2.628. La relazione qui esibita fra il ragionamento sintetico e il ragionamento deduttivo non è
priva di importanza. Infatti, quando adottiamo una certa ipotesi, ciò avviene non solo perché
questa ipotesi spiega i fatti osservati, ma anche perché l’ipotesi contraria condurrebbe
probabilmente a risultati contrari a quelli osservati. Così, quando facciamo un’induzione,
traiamo quella conclusione, non solo perché quella regola spiega la distribuzione delle
caratteristiche nel campione osservato, ma anche perché probabilmente un’altra regola
avrebbe dato luogo a un altro campione diverso da quello osservato.
2.629. Ma non si deve sopravvalutare il vantaggio di questa prospettiva. Resta vero, infatti,
che l’induzione è l’inferenza di una regola, e che considerarla come la negazione di una regola
è concezione artificiosa, ammissibile solo perché, considerando regole le proposizioni
statistiche o proporzionali, la negazione di una regola è anch’essa una regola. Parimenti, resta
vero che l’ipotesi è la sussunzione di un caso sotto una classe e non propriamente la sua
negazione, tranne per il fatto che negare la sussunzione sotto una classe è ammettere la
possibilità di sussunzione sotto un’altra classe.
2.630. Bocardo può essere considerato quale un’induzione così timida da perdere totalmente la
caratteristica ampliativa propria dell’induzione genuina. Enoch ed Elia sono esemplari di un
certo genere di uomini. L’esempio di Enoch ed Elia mostra che tutti gli uomini di questo
genere sono immortali. Ma invece di concludere arditamente che tutti gli uomini molto pii, o
tutti gli uomini favoriti dall’Onnipotente, o così via, sono immortali, rifuggiamo dallo
specificare la classe di questi uomini, e ci arrestiamo all’inferenza puramente esplicativa che
alcuni uomini sono immortali. Analogamente, Baroco potrebbe essere considerato quale
un’ipotesi timidissima. Enoch ed Elia non sono mortali. Ora, potremmo arditamente supporre
107
Letture autonome
che siano dei o qualcosa del genere, ma invece ci limitiamo all’inferenza che essi siano di una
qualche natura differente da quella dell’uomo.
2.631. Ma, dopotutto, c’è una differenza immensa fra la relazione di Baroco e Bocardo con
Barbara e la relazione dell’Induzione e dell’Ipotesi con la Deduzione. Baroco e Bocardo si
basano sul fatto che, se la verità di una conclusione segue necessariamente dalla verità di una
premessa, allora la falsità della premessa segue dalla falsità della conclusione. E questo è
sempre vero. Diverso è il caso dell’inferenza probabile. Qui non è assolutamente necessario
che, se la verità di una certa premessa rende la verità di una conclusione probabile, allora la
falsità della conclusione debba rendere probabile la falsità della premessa. O meglio, ciò
avviene solo, come abbiamo visto in uno scritto precedente, quando la parola “probabile” è
usata in un senso nell’antecedente e in un altro nel conseguente.
Il caso del foglio strappato
2.632. Su un pezzo di carta strappato c’è uno scritto non firmato. Si sospetta che ne sia autore
una certa persona. Frugando lo scrittoio, cui solo quella persona aveva avuto accesso, si trova
un altro pezzo di carta, che combacia in tutte le sue irregolarità con il margine strappato del
primo misterioso pezzo di carta. È naturalmente inferenza ipotetica trionfante che il sospettato
sia effettivamente l’autore dello scritto. Il fondamento dell’inferenza sta evidentemente nel
fatto che è estremamente improbabile che due pezzi di carta strappati combacino per caso.
Perciò, solo una piccolissima parte di inferenze di questa sorta risulterà ingannevole.
L’analogia fra ipotesi e induzione è così forte che certi logici le hanno confuse. L’ipotesi è
stata chiamata induzione di caratteri. In un dato oggetto si rileva un insieme di caratteri
appartenente a una data classe; da ciò si desume che tutti i caratteri della classe appartengono
all’oggetto in questione. Questa procedura implica certamente il medesimo principio
dell’induzione, ma in una forma modificata: primo, perché i caratteri non sono suscettibili di
semplice enumerazione come gli oggetti; secondo, perché i caratteri confluiscono in categorie.
Quando facciamo un’ipotesi come quella sul pezzo di carta strappato, esaminiamo una sola
linea di caratteri, o al massimo due o tre, e non prendiamo affatto in considerazione esemplari
di altri caratteri. Se l’ipotesi fosse soltanto un’induzione, nel nostro esempio del foglio
strappato saremmo autorizzati a concludere nient’altro che questo: che i due pezzi di carta
accomunati dalle irregolarità riscontrate devono combaciare anche in altre, diciamo più
minute, irregolarità. Il passaggio inferenziale dalla forma del pezzo di carta all’identificazione
del suo remoto possessore è precisamente quello che distingue l’ipotesi dall’induzione, e rende
l’ipotesi un passo più audace e periglioso.
2.633. Le stesse obiezioni mosse contro la pretesa che l’induzione poggi sull’uniformità della
Natura si potrebbero ripetere riguardo all’ipotesi. Anche qui, tale teoria, non solo non riesce a
fondare la validità dell’inferenza, ma induce a pensare l’inferenza secondo percorsi
irriducibilmente viziosi. È certo vero che in Natura si danno determinate uniformità, la cui
conoscenza rafforza grandemente il valore di determinate ipotesi: a esempio, noi supponiamo
che nel sole esistano il ferro, il titanio e altri metalli, perché nello spettro solare riscontriamo
molte linee che per la posizione coincidono con quelle normalmente prodotte da quei metalli;
e questa ipotesi è grandemente rafforzata dalla nostra conoscenza della notevole specificità
distintiva della linea particolare dei caratteri osservati. Ma questo rafforzamento dell’ipotesi è
di genere deduttivo, e l’ipotesi può restare probabile anche senza tale rafforzamento.
Regole per l’ipotesi
2.634. Nell’uso pratico della logica non c’è errore più grave né più frequente del supporre che
cose fra loro assai somiglianti sotto certi rispetti debbano perciò più probabilmente
108
Letture autonome
rassomigliarsi anche in altri. Che ciò sia assolutamente falso, è passibile di dimostrazione
rigorosa – dimostrazione che io ometterò, perché temo riuscirebbe sgradevole al lettore,
seriosa e complicata e irta come tutte le dimostrazioni di A, B, C, ecc. Cercherò tuttavia di
illustrare la mia proposizione con un esempio. Gli studiosi di mitologia comparata si dànno da
fare per trovare punti di somiglianza fra il corso dei fenomeni solari e le carriere degli eroi di
tutte le storie tramandateci dalla tradizione; e sulla base di queste somiglianze concludono che
questi eroi sono personificazioni del sole. Se nelle loro argomentazioni c’è qualcosa dí più, mi
è sempre sfuggito. Per mostrare la futilità della loro impresa, un logico ingegnoso ha scritto un
opuscolo, in cui seguendo il medesimo modo di ragionare riusciva a dimostrare perfettamente
che anche Napoleone Bonaparte non è altro che una personificazione del sole. È davvero
sorprendente vedere quanti punti di contatto ha scovato fra Bonaparte e il sole. La verità è che,
una volta ammesse le somiglianze recondite, due cose qualsiasi saranno fra loro strettamente
somiglianti come qualsiasi altre due.
Invece, perché il processo di costituzione di un’ipotesi conduca a un risultato probabile, si
devono seguire le regole seguenti:
1. Prima di fare le osservazioni atte a comprovare la verità, l’ipotesi deve essere
chiaramente proposta come un interrogativo. Dobbiamo cioè cercare di vedere quali
sarebbero i risultati delle previsioni conseguenze dell’assunzione dell’ipotesi.
2. E per osservare somiglianze e dissomiglianze dobbiamo prendere le previsioni da
sottoporre al banco di prova della verifica a caso, senza privilegiare il genere di
previsioni per cui l’ipotesi va notoriamente bene.
3. Occorre prendere nota onestamente, non solo dei successi, ma anche dei fallimenti
delle previsioni. Tutto il procedimento deve essere leale e imparziale.
2.635. Certuni immaginano che lo scontro fra gli opposti pregiudizi giovi alla conquista della
verità: che, insomma, la via dell’investigazione sia quel dibattimento fra le parti e le passioni
che ha il suo modello teorico nella nostra atroce procedura legale. Ma la Logica annienta
questa pretesa, dimostrando irrefragabilmente che la conoscenza si guadagna solo con un reale
desiderio di sapere, e che tutti i metodi fondati sull’ostinazione, sull’autorità, su qualsiasi
volontà di conferma di una conclusione preconcetta sono assolutamente privi di valore. Queste
sono cose perfettamente provate. Il lettore può sì conservare al proposito libertà di opinione;
ma solo sino a quando non ne abbia esaminato la dimostrazione. Proprio allo stesso modo, il
lettore può conservare libertà di opinione riguardo alle proposizioni della geometria; ma solo
sino a quando non gli venga voglia di leggere Euclide. Allora, se legge attentamente e senza
salti quel libro poco divertente, la sua bella libertà di opinione riguardo alla geometria svanirà
per sempre. Ma sono poche le persone capaci di sottoporre alla loro coscienza la questione
seguente: “Io voglio o no sapere come stanno le cose?”.
Qui mi sono limitato a esporre le regole assolutamente essenziali per trarre le induzioni e le
ipotesi. Ci sono molte altre massime importanti che raccomandano certi dispositivi per trarre
buone inferenze sintetiche, fra cui ricordo, a esempio, i quattro metodi di Mill. Tuttavia, a
volte si danno induzioni e ipotesi che risultano del massimo valore anche se ottenute
trascurando tali raccomandazioni.
L’induzione classifica, l’ipotesi spiega
2.636. Classificazioni che funzionino perfettamente in tutti i casi non ne esistono. E così,
anche riguardo alla grande distinzione tra inferenze esplicative e inferenze ampliative, si
potrebbero trovare esempi che sembrano stare in mezzo, al confine fra le due classi,
partecipando sotto qualche rispetto dei caratteri di entrambe. Ciò vale anche per la distinzione
fra induzione e ipotesi. In linea di massima, la differenza è netta e decisa: con l’induzione,
109
Letture autonome
concludiamo che fatti simili ai fatti osservati sono veri in casi non esaminati; con l’ipotesi,
concludiamo l’esistenza di un fatto completamente differente da alcunché di osservato, fatto
ipotizzato da cui, in base a leggi note, qualche fatto osservato risulti necessariamente.
L’induzione è il ragionamento che va dai particolari alla legge generale, l’ipotesi è il
ragionamento che va dall’effetto alla causa. La prima classifica, la seconda spiega. È solo in
certi casi speciali che può essere motivo di dubbio più che momentaneo l’attribuzione di una
data inferenza all’una o all’altra categoria. Una di queste eccezioni si ha quando noi
assumiamo, non fatti simili in circostanze simili, ma fatti differenti in circostanze differenti –
dove però la differenza dei fatti ha relazione definita con la differenza delle circostanze. Le
inferenze di questo genere, sebbene siano in realtà induzioni, talora per certi caratteri
indubbiamente somigliano a ipotesi.
110
Letture autonome
Letture autonome
Come indicato nella sezione dell’Introduzione dedicata alle “modalità di verifica”, si
contempla la stesura di una tesina che può concorrere alla generazione di un voto. In questa
sezione, indichiamo delle letture pertinenti ad alcuni degli argomenti appropriati a tale scopo.
Studenti intenzionati a proporre un percorso personale devono comunque leggere il materiale
di obbligo comune e, in base ad esso, consultare con il docente del corso prima di procedere
all’elaborazione della loro alternativa.
Per il fatto che il primo modulo è più nozionistico e tecnico, sono pochi i temi che si prestano
a trattamento in forma di tesina. Per quanto riguarda i temi più storici del secondo modulo,
sono indicate delle letture dette ‘primarie’, che richiedono attento e dettagliato scrutinio, e su
cui quelle ‘secondarie’ offrono commento e inquadramento. I testi primari nella dispensa sono
presentati scevri del corredo di note, commenti, bibliografia che si trova di norma in una
versione pubblicata; si raccomanda pertanto almeno di consultare una fonte più elaborata dei
testi in questione.
Nella misura del possibile, il materiale indicato è a disposizione o nella biblioteca umanistica
in Sant’Agostino o presso la Biblioteca Civica «Angelo Maj» in Piazza Vecchia. In caso di
difficoltà, si contatti il docente.
Strumenti di consultazione
(A) Nozioni filosofiche generali
Gli studenti che hanno fatto filosofia alle superiori avranno studiato un manuale che può, nei
migliori dei casi (e quindi non tutti), offrire spunti bibliografici per approfondimento. Tra
questi possiamo segnalare:
N. Abbagnano, G. Fornero, Itinerari di filosofia: protagonisti, testi, temi e laboratori,
Paravia, Torino, 2002 (e poi rielaborato quasi annualmente per motivi grettamente
economici).
Anche dello stesso Abbagnano sono:
Storia della filosofia, (8 voll) iniziata nel 1946 e ripubblicata dalla TEA, Torino, in edizione
economica nel 1995;
e il suo dizionario dei concetti filosofici esposti nel loro sviluppo storico:
Dizionario di filosofia (1960), UTET, Torino, 1993.
Fornero, in collaborazione con Salvatore Tassinari ed altri, ha aggiornato gli ultimi volumi
della Storia fondata da Abbagnano e ha prodotto
Le filosofie del Novecento (2 voll.), Mondadori, Milano, 2002, in edizione economica dal
2004.
Altri dizionari, quali
Dizionario di filosofia (2° ed. 1993) a cura di G. Vattimo (et al.), Garzanti, Milano, 1999;
e
Dizionario di filosofia, (1960) a cura di D.G. Runes, Mondadori, Milano, 1972,
forniscono informazioni anche su individui, scuole e movimenti oltre a definizioni di termini
tecnici.
Forse l’opera più imponente per un ricognizione della cultura filosofica attuale è
Enciclopedia filosofica (12 voll.) (originariamente 1957-8, ma successivamente aggiornata,
ampliata, riveduta (e persino venduta a fascicoli con il Corriere)), a cura di V. Melchiorre,
Bompiani, Milano, 2006.
111
Letture autonome
In inglese, in consultazione nella Sala Furietti della Biblioteca Maj, si indica
Routledge Encyclopedia of Philosophy (10 voll.) a cura di E. Craig, Routledge, Londra.
1998
Per notizie su singole opere, con un breve riassunto e indicazioni sulla disponibilità di versioni
italiane, si consulti
Dizionario delle opere filosofiche, (1988) a cura e tr. it. di F. Volpi, Mondadori, Milano,
2000.
Va notato che l’uso esteso di materiale desunto/copiato da queste fonti è facilmente
riscontrabile, e conta come plagio (vedi sotto ‘Originalità’ nel ‘Prontuario’ qui sotto).
(B) Storie della logica
Nonostante estenuanti ricerche e consultazioni moleste presso i colleghi eruditi (e pazienti), si
è arrivati alla conclusione sbalorditiva che non esista una storia della logica elaborata in
italiano che copra l’arco cronologico preso in considerazione nel corso.
Si segnalano comunque le seguenti due opere:
J. Bochenski, La logica formale: I Dai presocratici a Leibniz; II La logica matematica (1956)
tr, it. A. Conte, Einaudi, Torino 1972
e
W. e M. Kneale Storia della logica (1960) tr. it. A.G.Conte, Einaudi, Torino 1972
Si presentano comunque due problemi: (i) entrambi questi lavori sono ormai datati, poiché non
hanno potuto assistere alle esplosioni di studi sulla logica in età ellenistica e nel medioevo; (ii)
in assenza di ristampe, le edizioni italiane sono difficili da reperire (non sembrano presenti
nelle biblioteche di Bergamo). Per gli interessati, il docente dispone di versioni inglesi.
In assenza di un manuale dedicato alla storia della logica, si suggeriscono i seguenti capitoli
della Storia del pensiero filosofico e scientifico a cura di Ludovico Geymonat (1975-1996) in
undici volumi in consultazione presso la biblioteca umanistica di Sant’Agostino (109 GEY
STO)
Vol I (Antichità e medioevo)
Sez. I: Antichità
Cap. sesto:
“I sofisti e Socrate” (parti i-viii: pp. 88-105)
Cap. decimo:
“Platone” (pp. 165-184)
Cap. dodicesimo:
“Progressi della matematica” (pp. 200-209)
Cap. tredicesimo:
“Aristotele” (pp. 210-237; esp. parte vi (pp. 219-227: Logica, anche se
si riconoscono solo 19 forme del sillogismo))
Cap. ventunesimo
“Educazione e scuola” (pp. 325-365)
Sez. II: Medioevo
Cap. quinto:
“I secoli XI e XII” (pp. 416-436)
Cap. settimo
“Il dissolversi della scolastica” (pp. 467-483)
Vol. II (Il Cinquecento e il Seicento)
Sez. III: Cinquecento
Cap. undicesimo:
“Galileo Galilei” (pp. 152-175)
Sez. IV: Seicento
Cap. secondo:
“Cartesio” (pp. 218-238)
Cap. nono:
“La logica nel Seicento” (pp. 344-365: Hobbes, Port Royal, Leibniz)
Vol. III (Sez. V: Il Settecento)
Cap. sesto:
“Logica e fondamenti della matematica” (pp. 126-167: postulato delle
parallele, teoria della probabilità)
112
Letture autonome
Vol. IV (Sez. VI: L’Ottocento (1))
Cap. settimo:
“Logica e fondamenti della matematica” (pp. 117-179)
Vol. V (Sez. VII: L’Ottocento (2))
Cap. nono:
“La svolta della logica” (pp. 192-259: De Morgan, Boole)
Vol. VI (Sez. VIII: Dall’Ottocento al Novecento)
Cap. dodicesimo:
“Logica e i problemi di fondamenti nella seconda metà dell’Ottocento”
pp. 353-426: Cantor, Frege, Hilbert)
Vol. VIII (Sez. IX: Il Novecento (1))
Cap. ottavo:
“Il pensiero di Wittgenstein” (pp. 184-209)
Cap. nono:
“Sviluppi dell’empirismo logico” (pp. 210-260)
Cap. quattordicesimo:“Il falsificazionismo di Popper” (pp. 456-518)
Vol. VIII (Sez. X: Il Novecento (2))
Cap. quinto:
“La logica nel ventesimo secolo (1)” (pp. 194-401: rassegna decennio
per decennio per la prima metà del secolo)
Vol. IX (Sez. XI: Il Novecento (3))
Cap. terzo:
“La logica nel ventesimo secolo (2)” (pp. 139-273: discussione di alcune
logiche non-classiche e sistemi intensionali, con una parte molto tecnica
sulla nozione di “categorie” a pp. 199-253)
Vol. X (Il Novecento (4))
Cap. secondo:
“Logica e calcolatore” (pp. 79-114)
Vol. XI (Il Novecento (5))
Cap. terzo:
“Sviluppi semantici nella filosofia del linguaggio” (pp. 112-139)
Molto del materiale presentato nei volumi IV-IX del Geymonat (ad opera di C. Mangione) si
trova anche in
C. Mangione e S. Bozzi, Storia della logica da Boole ai giorni nostri (2 voll.) Garzanti,
Milano 1993
Altri periodi specifici sono coperti da
V. Celluprica, La logica antica, Loescher, Torino 1978 (un’antologia minimamente ragionata
che dà comunque un po’ di spazio, oltre a Platone e Aristotele anche agli stoici e agli epicurei)
N. Kretzmann (et al.) La logica nel Medioevo, Jaca Books, Milano 1999
M. Mugnai, La logica da Leibniz a Frege, Loescher, Torino 1982
E. Casari, La logica nel Novecento, Loescher, Torino 1981.
Possibili percorsi di approfondimento
Si può fondare la nozione stessa di verità?
Testi primari nella dispensa tratti dal libro IV della Metafisica di Aristotele e dalla Dottrina di
Bolzano
Testi secondari:
J. Lukasiewicz, Del principio di contraddizione in Aristotele, (1910), Quodlibet, Macerata,
2003;
T.H. Irwin, I princìpi primi di Aristotele, (1988), Vita e pensiero, Milano, 1988, pp. 225-47;
F: Berto, Teorie dell’assurdo, Carocci, Roma, 2006, pp. 21-46.
L’attrattiva del relativismo: può tutto essere relativo?
Testi primari nella dispensa: il brano dal Teeteto di Platone; F. Nietzsche ‘Verità e bugia in
senso extramorale’
113
Letture autonome
Testi secondari:
G: Romeyer Dherbey, I sofisti, (1995), Xenia, Milano, 2000, pp. 5-23;
J.R. Searle, Occidente e multiculturalismo (1995), Sole24Ore, Milano, 2008, pp. 21-77.
Il ragionamento “ontologico”
Testi primari nella dispensa di SS Anselmo e Tommaso
Testi secondari:
D. Hume Dialoghi della religione naturale (1776, qualsiasi edizione o traduzione) Parte IX
G.E. Moore, “L’esistenza è un predicato?” (1936) in A. Varzi (a cura di) Metafisica, Laterza,
Bari-Roma 2008, pp. 9-23
Descrizioni definite e individuanti
B. Russell, Introduzione alla filosofia matematica (1919) Newton Compton, Roma 1970,
capitolo 16
(il volume di Bonomi citato qui sotto contiene anche il classico paper dello stesso Russell
“Sulla denotazione” del 1905, ma forse l’esposizione della sua teoria nel libro indicato è più
lineare)
P.F: Strawson “Sul riferimento” (1950) in A. Bonomi (a cura di) La struttura logica del
linguaggio, Bompiani, Milano 1973, pp. 197-224
K. Donnellan, “Referenza e descrizioni definite” (1966) in A. Bonomi (a cura di) La struttura
logica del linguaggio, Bompiani, Milano 1973, pp. 225-48.
S. Kripke, Nome e necessità, (1972) Boringhiero, Tornino 1982, prima lezione
I presupposti di dialogo
P. Cantù, I. Testa, Teorie dell’argomentazione: un’introduzione alle logiche del dialogo,
Mondadori, Milano, 2006
C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione: la nuova retorica, (1958)
Einaudi, Torino, 2001, parte seconda, pp. 69-121
F.H. van Eemeren, R. Grootendoorst, Una teoria sistematica dell’argomentazione, Mimesis,
Milano, 2008, capp. 7 e 8, pp. 133-61
Le fallacie
Testi primari nella dispensa: Eutidemo di Platone, Confutazioni sofistiche di Aristotele,
Dialettica di Schopenhauer e Sistema di Mill
C. Bruce, Sherlock Holmes e le trappole della logica, Cortina, Milano, 2001
M. Motterlini, Trappole mentali, Rizzoli, Milano, 2008
I periodi ipotetici
G.E.M Anscombe “Subjunctive Conditionals” (in inglese: .pdf contentuo nella dispensa del
laboratorio “Linguaggi e stili...)
D.K. Lewis Counterfactuals ch. 1 (inglese: .pdf contenuto nella dispensa del laboratorio
“Linguaggi e stili...)
R. Davies, Gli oggetti della logica, Mimesis, Milano 2009 cap. 11, pp. 365-405.
114
Letture autonome
Prontuario per la stesura di una tesina
Valore
Una tesina vale 6 crediti formativi universitari (CFU).
Presentazione
La tesina va redatta dallo studente stesso in lingua italiana in unica copia dattiloscritta e consegnata
con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell’appello in cui si vuole sostenere
l’esame relativo al corso.
La rilegatura della tesina è a scelta dello studente: qualsiasi metodo (dal graffetto alla rilegatura
come brossura) è accettato purché assicuri l’integrità del testo.
La pagina di copertina, che non conta come pagina del lavoro, deve contenere le seguenti
informazioni:
cognome e nome dello studente;
numero di matricola;
titolo del lavoro;
il titolo del modulo per cui viene presentato (con codice);
numero arrotondato delle parole; e
data prevista della sessione di esame.
Se la tesina è articolata in paragrafi o sezioni, un sommario o indice può apparire insieme al
materiale di titolo e non venir contato nel totale del lavoro.
Conteggio delle parole
L’indicazione di lunghezza di ‘5-10 pagine’ si traduce nella realtà come segue.
Una pagina è un foglio di carta A4. Il testo va stampato in spazio 1,5 o 2 in un font leggibile di
almeno 12 pt con margini di intorno ai 2,5 centimetri in alto e basso e su entrambi i lati (di più a
sinistra se richiesto dalla rilegatura).
Con queste dimensioni, il numero delle battute a pagine è approssimativamente 2,000, e il
numero delle parole intorno alle 400. Quindi, il totale dello scritto va dalle 10,000 battute (2,000
parole) alle 20,000 battute (4,000 parole).
Come già detto, la pagina di copertina è esclusa dal conteggio. In modo simile, la lista di letture
e altri rimandi, che si trova in fonda al testo, non va contato. Tuttavia, le note sono incluse.
Originalità
Come insieme, il testo esprime il pensiero del suo autore e non va copiato o parafrasato da qualsiasi
altra fonte senza le dovute indicazioni, pena il reato (non solo accademico e morale, ma anche
legale) di plagio.
La punizione accademica per plagio varia dall’insufficienza in caso di una tesina molto vicina a
un testo pubblicato alla riduzione del voto nonostante la sua apparente qualità. Lo studente è sempre
libero di contestare un’accusa di plagio, così come il docente è libero di sostenerla. Se lo studente
non è disposto ad accettare la valutazione del docente, può sostenere l’esame con un altro membro
della commissione d’esame.
Citazioni
La parafrasi è lecita quando chi scrive estrae il succo o la parte pertinente di un altro testo e dà
un’indicazione del punto da dove viene. La citazione è la prassi di prendere in prestito le parole
esatte di un altro testo e di riconoscerne la proprietà.
115
Letture autonome
Esempio di parafasi3:
Nel capitolo XXVIII del suo libro, Beccaria osserva come la pena di morte non sia efficace come
deterrente. Questo ragionamento dipende ...
Il rimando è sufficientemente preciso per gli scopi: la deterrenza è oggetto del intero capitolo in
questione e sappiamo che il libro è Dei delitti e delle pene. La parafrasi non riporta le parole esatte
del testo originale: la parola ‘efficace’ appare nel capitolo citato; la parola ‘deterrente’ non ci
appare, ma è utile come riassunto.
Esempio di citazione:
Beccaria osserva come, ‘[n]on è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno
scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di
servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i
delitti’15. Questo ragionamento dipende ...
Notiamo una serie di aspetti di questa operazione.
Primo, le parole citate vanno messe tra virgolette; queste possono essere singole (‘...’), doppie
(“...”) o a lisca di pesce («...»).
Secondo, sono le parole esatte così come appaiono nel libro da cui si cita. L’iniziale ‘n’ nella
citazione corrisponde all’inizio di una frase e quindi, nell’originale è in maiuscolo. Ma, nella
citazione, appare in mezzo a una frase; quindi l’ingerenza tipografica va segnalata con parentesi,
preferibilmente, per distinguerli da parentesi già presenti nel testo, quelle quadre ([ e ]) o increspate
({ e }); se una parte della frase beccariana, ad esempio da ‘divenuto’ a ‘che è il freno’, è da
tralasciare, inseriamo tre punti di sospensione tra parentesi quadre (o increspate) per indicare
l’omissione ([…] o {…}). Se vogliamo enfatizzare una parola o una frase, si usa corsivo
(sottolineatura per chi non dispone di una stampante a getto d’inchiostro o laser) e si aggiunge in
nota ‘corsivo nostro’; qualora il testo citato contenga un’enfasi, si aggiunge ‘corsivo originale’.
Terzo, questo è un brano relativamente lungo e, di solito, quelli di oltre 30 parole vanno messi
con un rientro al margine sinistro con una riga bianca prima e dopo e senza virgolette. Quindi, se si
tolgono le parole come sopra, il risultato sarebbe:
Beccaria osserva come, ‘[n]on è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno
scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che [...] è il freno più forte
contro i delitti’15. Questo ragionamento dipende...
Mentre, con testo intero, si ha:
Beccaria osserva come,
[n]on è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato
esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche
quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti15.
Questo ragionamento dipende...
3
Gli
esempi
vengono
presentati
attorniati
da
una
‘scatola’
allo
scopo
di
distinguerli
dai
commenti
che
se
ne
fanno.
Questa
prassi
NON
è
da
copiare
nella
stesura
della
tesina.
116
Letture autonome
Quarto, c’è un rimando ad una nota (‘15’). Tutti i programmi di word processing sono in grado
di generare automaticamente note a piè di pagina; chi non dispone di tali attrezzature può
raccogliere le note in fondo al testo, numerate in sequenza.
Note
Le note a piè di pagine raccolgono i dati bibliografici e di solito appaiono (automaticamente) in un
corpo due punti più piccolo di quello del testo. Si scoraggia l’uso delle note per commenti ulteriori:
o la controversia è rilevante e deve trovare il suo posto nello sviluppo del ragionamento all’interno
del testo, o non è rilevante e va soppressa.
I dati bibliografici si presentano, nei limiti del possibile, uniformamente. Per gli scopi del corso,
ci sono tre categorie di materiale a stampa da prendere in considerazione: (i) testi primari (ii) altri
libri; e (iii) articoli da riviste e miscellanee (volumi che raccolgono scritti di più autori). Siti internet
vengono citati riportando l’URL.
(i) Per la maggior parte dei testi classici esiste già un sistema di riferimento standardizzato. Ad
esempio, la paginazione, con quadrante o colonna pagine, più le righe, di Platone risale all’edizione
dello Stephanus (Henri Estienne) in tre volumi del 1578, e di Aristotele a quella di Bekker del
1831-6. Questi sistemi, consolidati e utilizzati da tutti commentatori, vengono riportati in quasi tutte
le edizioni e traduzioni moderne, e sono da privilegiare rispetto alla numerazione delle pagine del
testo che si ha in mano. Testi, come L’etica di Spinoza, che sono suddivisi in piccole sezioni, o,
come il Sulla natura delle cose di Lucrezio, che sono articolati in libri e hanno righe numerate,
possono essere citati con i numeri forniti nel testo. È comunque da segnalare quale edizione o
traduzione è stata adottata.
(ii) I rimandi a libri vanno organizzati nell’ordine:
autore;
titolo in corsivo;
nel caso, data di prima pubblicazione tra parentesi;
nel caso, nome/i del/i curatore/traduttore/i;
casa editrice;
città di pubblicazione;
anno di pubblicazione; e
pagina/e.
Per la nota alla citazione fatta sopra, questo risulta come segue:
15 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, (1764), a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino, 1965, pp. 634.
Se la successiva citazione è alla stessa opera, il rimando può prendere la forma o
16 Beccaria, op. cit., p. 64.
togliendo l’iniziale dell’autore già citato (‘op. cit.’ significa ‘opera citata’) o
16 Op. cit., p. 64.
Se due citazioni di seguito fanno riferimento alla stessa pagina, possono apparire così:
117
Letture autonome
8 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, (1764), a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino, 1965, p. 62.
9 Loc. cit..
oppure
9 Ibid..
(dove ‘loc. cit.’ significa ‘luogo citato’ e ‘ibid.’ [o l’italiano ‘ivi’] significa ‘lo stesso posto nel
testo’). Se, dopo aver citato un’altra fonte, si ritorna a un testo già citato, si può avere una sequenza
di questo genere:
15 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, (1764), a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino, 1965, pp. 634.
16 C. Cantù, Beccaria e il diritto penale, Sansoni, Firenze, 1862, p. 12.
17 Beccaria, op. cit., p. 65.
O, invece di ‘op. cit.’, un titolo abbreviato (‘Dei delitti’) può servire come indicazione utile a chi
legge.
(iii) I rimandi ad articoli vanno organizzati nell’ordine:
autore;
titolo del articolo tra virgolette;
nel caso, data di prima pubblicazione tra parentesi;
titolo della rivista o miscellanea in corsivo (o tra virgolette a lisca di pesce: questa forma è
normale solo in Italia);
nel caso di una miscellanea, nome del curatore;
nel caso di una miscellanea, casa editrice;
nel caso di una miscellanea, città di pubblicazione;
nel caso di una rivista, l’anno e il numero;
anno di pubblicazione (nel caso di una rivista, messo tra parentesi); e
pagina/e.
Esempio di un rimando in nota ad un articolo di rivista:
2 M. Isnardi Parente, ‘Simplicio, gli stoici e le categorie’, Rivista di Storia della Filosofia, XLI,
(1986), p. 14.
che era poi ripubblicato in una collezione degli interventi della stessa studiosa:
2 M. Isnardi Parente, ‘Simplicio, gli stoici e le categorie’, (1986), nel suo Filosofia e scienza nel
pensiero ellenistico, Bibliopolis, Napoli, 1991, p. 153.
Supponiamo anche (in questo caso, fantasiosamente) che, come un ‘pezzo da antologia’, lo stesso
saggio viene raccolto in una miscellanea; in quel caso il rimando avrebbe la seguente forma:
118
Letture autonome
2 M. Isnardi Parente, ‘Simplicio, gli stoici e le categorie’, (1986), in Logica ellenistica, a cura di
A.M. Ioppolo, Laterza, Bari-Roma, 2010, p. 97.
Per un articolo pubblicato per la prima volta in una miscellanea, in questo caso gli atti di un
convegno, si ha:
3 C. Natali, ‘Attività di Dio e attività dell’uomo nella Metafisica di Aristotele’, in Aristotele:
Perché la metafisicsa, a cura di A. Bausola e G. Reale, Vita e Pensiero, Milano, 1994, pp. 190-1.
Bibliografia
In fondo alla tesina, cominciando su una nuova pagina, va messa una lista dei testi citati e
effettivamente consultati. Oltre alle letture indicate (ai frequentanti) o obbligatorie (per i nonfrequentanti), tutto l’altro materiale utilizzato nella stesura della tesina va elencato: ricerche
bibliografiche intraprendenti sono viste di buon occhio. Come già detto, l’elenco bibliografico è
escluso dal conteggio delle parole.
L’ordine della lista è quello alfabetico per l’iniziale del cognome dell’autore. E il formato
corrisponde a quello delle note con poche varianti:
(i) nel caso di un testo che ha il proprio sistema di rimandi, come Platone e Aristotele, l’edizione o
traduzione usata va citata con indicazioni del tipo di pubblicazione; se si citano più di un testo,
tutti vanno elencati;
(ii) il cognome dell’autore viene prima del nome o iniziale per osservare l’ordine alfabetico;
(iii) non si ripete il nome dello stesso autore che viene citato più di una volta, ma per il secondo
testo si mette un trattino sulla nuova riga;
(iv) nel caso di un’opera in più volumi, si indica il numero di volumi tra parentesi prima della casa
editrice;
(v) nel caso di un articolo, le pagine di inizio e di fine;
(vi) per motivi puramente estetici, si mette un rientro (di mezzo centimetro = 18pt) sulle righe
successive se il rimando si estende su più di una riga.
Così, abbiamo, ad esempio,
Aristotele, Etica Nicomachea, trad. it. con testo greco a fronte, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano,
1992.
–– Etica Nicomachea, trad. it. A. Plebe in vol. III di Opere, a cura di G. Giannantoni, (4 volumi),
Laterza, Bari-Roma, 1973.
–– Metafisica, trad. it. con testo greco a fronte, a cura di G. Reale, (3 volumi), Vita e pensiero,
Milano, 1993.
Berti, E., Aristotele nel Novecento, Laterza, Bari-Roma, 1992.
Jaeger, W., ‘Genesi e ricorso dell’ideale filosofico della vita’, (1928), appendice al suo Aristotele,
(1923) trad. it. A. Calogero, Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 557-617.
Natali, C., ‘Attività di Dio e attività dell’uomo nella Metafisica di Aristotele’, in Aristotele: Perché
la metafisicsa, a cura di A. Bausola e G. Reale, Vita e Pensiero, Milano, 1994, pp. 187-214.
119
Scaricare