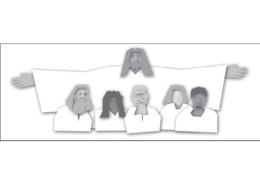SELEZIONE
di
Storie di Scuola
1
INDICE DEI BRANI E DEGLI AUTORI
BRANI ED AUTORI
PAGINE
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, CARROL LEWIS
5
6
9
11
12
14
15
16
20
21
23
26
27
28
29
32
34
37
38
39
40
43
44
46
47
51
52
55
59
61
62
63
65
66
69
71
72
73
75
76
79
80
ALLA SCUOLA, SERAO MATILDE
ALL'INIZIO DELL'ESTATE DEL 1970, YEHOSHUA ABRAHAM B.
ANNA KARENINA, TOLSTOJ LEV
ASCOLTA IL MIO CUORE, PITZORNO BIANCA
AUTOBIOGRAFIA, TWAIN MARK
CI SONO BAMBINI A ZIGZAG, GROSSMANN DAVID
CUORE, DE AMICIS EDMONDO
DAGO RED, FANTE JOHN
DAVID COPPIERFELD, DICKENS CHARLES
DI MESTIERE FACCIO IL MAESTRO, ROSSI DORIA MARCO
DUBROWSKI, PUSKIN ALEKSANDR SERGEEVIC
EMMA, AUSTEN JANE
FORTE COME LA MORTE, MAUPASSANT GUY (DE)
GLI ULTIMI DELLA CLASSE, TAVELLA PAOLA
GOCCE D'INCHIOSTRO, DOSSI CARLO
HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN, ROWLING J.K.
I BUDDENBROOK, MANN THOMAS
I FRATELLI KARAMAZOV, DOSTOJEWSKIJ FIODOR
I MISERABILI, HUGO VICTOR
I RAGAZZI DELLA VIA PAAL, MOLNAR FERENC
I VIAGGI DI GULLIVER, SWIFT JONATHAN
IL BUIO OLTRE LA SIEPE, LEE HARPER
IL CIRCOLO PICKWICK, DICKENS CHARLES
IL COMPITO DI LATINO, MONTAGUE RHODES JAMES
IL COMUNE AMICO, DICKENS CHARLES
DIARIO DI UNA MAESTRINA, GIACOBBE MARIA
IL DONO DI ASHER LEV, POTOK CHAIM
IL GRANDE MEAULNES, ALAIN FOURNIER
IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA, VAMBA - LUIGI BERTELLI
IL LADRO E IL SUO MAESTRO, GRIMM JAKOB E W ILHELM
IL LIBRO DELLE VERGINI, D'ANNUNZIO GABRIELE
IL MAESTRO DEI RAGAZZI, VERGA GIOVANNI
IL MAESTRO DI SCUOLA, ERODA
IL MAESTRO DI VIGEVANO, MASTRONARDI LUCIO
IL MAESTRO GIUSTO, RODARI GIANNI
IL MAESTRO GUERRAFONDAIO, BRECHT BERTOLT
IL MISTERO DELLA COLLINA, PONTREMOLI GIUSEPPE
IL RAGAZZO E IL MAESTRO DI SCUOLA, LA FONTAINE JEAN DE
IL ROMANZO DI UN MAESTRO, DE AMICIS EDMONDO
IL SEGRETO DI LUCA, SILONE IGNAZIO
IL TRIPLICE DESTINO, HAWTHORNE NATHANIEL
2
IL TULIPANO NERO, DUMAS ALEXANDRE PADRE
IL VECCHIO E IL BAMBINO, BERRI CLAUDE
JUDE LO SCURO, HARDY THOMAS
LA CACCIATORA, NEGRI ADA
LA CASA TRA GLI ALBERI, W ELSH RENATE
LA GRANDE GILLY HOPKINS, PATERSON CATHERINE
LA LENTE FOCALE, ROSENBERG OTTO
LA MAESTRINA BOCCARMÉ, PIRANDELLO LUIGI
LA MANO NEL CAPPELLO, CINQUETTI NICOLA
LA PENNA ROSSA, MORETTI MARINO
LA RIFORMA DELLA GRAMMATICA, RODARI GIANNI
LA SCUOLA O LA SCARPA, BEN JALLOUM TAHAR
LA SUPPLENTE, BERNARDINI ALBINO
LA TURBINOSA STORIA DI PICCO URAGANO, MAHY MARGARET
LA VITA È BELLA, CERAMI VINCENZO - BENIGNI ROBERTO
LA ZIZZANIA, DELEDDA GRAZIA
L'ANNO DELLA TIGRE, UNALI LINA
L'ARPA DI DAVITA, POTOK CHAIM
LE BACCHETTE DI LULA, BERNARDINI ALBINO
LE GUERRE DI ADA, PARIANI LAURA
LE MAESTRE PENSIEROSE (PARAFRASI), MALERBA LUIGI
LE VEGLIE DI NERI, FUCINI RENATO
L'ESCLUSA, PIRANDELLO LUIGI
LESSICO FAMILIARE, GINSBURG NATALIA
LETTERA A UNA PROFESSORESSA, MILANI DON LORENZO
LYDIA LA REGINA DELLA TERRA PROMESSA, ORLEV URI
L'OBBEDIENZA NON È PIÙ UNA VIRTÙ, MILANI DON LORENZO
L'UOMO NELL'ASTUCCIO, CECHOV ANTON PAVLOVIC
M AESTRA DI CAMPAGNA, PROSPERI CAROLA
M AESTRA E SCOLARO, O'DONNELL K. M.
M AESTRO M AGO, PREUSSLER OTFRIED
M ASTRANGELINA, ALVARO CORRADO
M ATILDE, DAHL ROALD
MOLL FLANDERS, DE FOE DANIEL
NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE, REMARQUE H.M.
PEL DI CAROTA, RENARD JULES
OCCHIO AL PROFESSSORE, NOSTLINGER CHRISTINE
PENNY WIRTON E SUA MADRE, D'ARZO SILVIO
PER RIFLESSO, DELEDDA GRAZIA
PICCOLE DONNE, ALCOTT MAY LOUISA
PIMPÌ OSELÌ, GIANINI BELOTTI ELENA
PINOCCHIO, COLLODI - LORENZINI CARLO
PIPPI CALZELUNGHE, LINDGREN ASTRID
QUARTO PIANO, INTERNO 4, DI GIACOMO SALVATORE
RAGAZZO NEGRO, W RIGHT RICHARD
REGISTRO DI CLASSE, ONOFRI SANDRO
3
81
83
85
86
87
89
92
93
94
96
99
100
104
107
109
113
115
116
118
121
122
126
127
129
130
131
133
134
135
137
139
141
142
144
145
146
147
149
151
152
154
156
157
159
161
163
RICORDI DI SCUOLA, MOSCA GIOVANNI
165
167
170
172
175
178
180
181
182
183
185
187
191
192
SI CHIAMAVA FRIEDRICH, RICHTER HANS PETER
STORIE ALLEGRE, COLLODI - LORENZINI CARLO
TOM SAWYER, TWAIN MARK
TRA INSEGNAMENTO E FILOSOFIA, SU W ITTGENSTEIN
UN ANNO A PIETRALATA, BERNARDINI ALBINO
UN CIELO DIPINTO DI BLU, URE JEAN
UN REGNO DI DONNE, CECHOV ANTON PAVLOVIC
UN RITRATTO, TOZZI FEDERICO
UNA LEZIONE IN LINGUA TEDESCA, NEERA
UNA STORIA COSÌ, D'ARZO SILVIO
UNA STRANA PRIMAVERA, PETROSINO ANGELO
VERITÀ SU UNA MAESTRINA, SCERBANENCO GIORGI
ZAZIE NEL METRO, QUENEAU RAYMOND
4
Alice nel paese delle meraviglie
Lewis Carroll
(...)
- Quando eravamo piccini, - riprese finalmente la Falsa testuggine, un po' più tranquilla, ma sempre
singhiozzando di quando in quando, - andavamo a scuola al mare. La maestra era una vecchia
testuggine... e noi la chiamavamo tartaruga...
- Perché la chiamavate tartaruga se non era tale?- domandò Alice.
- La chiamavamo tartaruga, perché c'insegnava,- disse la Falsa testuggine con dispetto. - Hai poco
sale in zucca!
- Ti dovresti vergognare di fare domande così semplici,- aggiunse il Grifone; e poi tacquero ed
entrambi fissarono gli occhi sulla povera Alice che avrebbe preferito sprofondare sottoterra.
Finalmente il Grifone disse alla Falsa testuggine: - Va innanzi, cara mia! E non ti dilungare tanto!
È così la Falsa testuggine continuò:
- Andavamo a scuola al mare, benché tu non lo creda...
- Non ho mai detto questo! interruppe Alice.
- Si che l'hai detto, - disse la Falsa testuggine.
- Zitta! - soggiunse il Grifone, prima che Alice potesse rispondere.
La Falsa testuggine continuò: - Noi fummo educati benissimo... infatti andavamo a scuola tutti i
giorni...
- Anch'io andavo a scuola ogni giorno, - disse Alice; -Non serve inorgoglirsi per così poco.
- E avevate dei corsi facoltativi? - domandò la Falsa testuggine con ansietà
- Sì - rispose Alice - imparavamo il francese e la musica.
- E il bucato? - disse la Falsa testuggine
- No, il bucato, no - disse Alice indignata.
- Ah! E allora che scuola era? - disse la Falsa testuggine, come se si sentisse sollevata. - Nella
nostra, c'era nella fine del programma: corsi facoltativi: francese, musica, e bucato.
- E vivendo in fondo al mare - chiese Alice, - a che vi serviva?
- Non ebbi mai il mezzo per impararlo - soggiunse sospirando la Falsa testuggine - così seguii
soltanto i corsi ordinari
- Ed erano?- domandò Alice.
- Annaspare e contorcersi, prima di tutto - rispose la Falsa testuggine. - E poi le diverse operazioni
della aritmetica... ambizione, distrazione, bruttificazione e derisione.
- Non ho mai sentito parlare della bruttificazione - disse Alice. - Che cosa è?
Il Grifone levò le sue zampe in segno di sorpresa ed esclamò: - Non hai mai sentito parlare di
bruttificazione! Ma sai che significhi bellificazione, spero.
- Sì, rispose Alice, ma un po' incerta: - significa... rendere... qualche cosa... più bella.
- Ebbene - continuò il Grifone - se non sai che significa bruttificazione, mi par che ti manchi il
comprendonio.
Alice non si sentiva incoraggiata a fare altre domande. Così volse alla Falsa testuggine e disse: Che dovevate imparare?
- C'era il mistero - rispose la Falsa testuggine contando i soggetti sullenatatoie... - il mistero antico e
moderno con la marografia:... poi il disdegno... il maestro di disdegno era un vecchio grongo,
veniva una volta alla settimana: ci insegnava il disdegno, il paesaggio e la frittura ad occhio.
- E che era?- disse Alice.
- Non te la potrei mostrare - rispose la Falsa testuggine - perché vedi son tutta d'un pezzo. E il
Grifone non l'ha mai imparata.
- Non ebbi tempo - rispose il Grifone: ma studiai le lingue classiche e bene. Ebbi per maestro un
vecchio granchio, sapete.
- Non andai mai da lui - disse la Falsa testuggine con un sospiro - dicevano che insegnasse Catino e
Greto.
5
- Proprio così - disse il Grifone, sospirando anche lui, ed entrambe le bestie si nascosero la faccia tra
le zampe.
- Quante ore di lezione al giorno avevate? - disse Alice per cambiare discorso.
- 10 ore il primo giorno, - rispose la falsa testuggine - 9 il secondo e così di seguito.
- Che strano metodo! - esclamò Alice.
- Ma è questa la ragione perché si chiamano lezioni - osservò il Grifone: - perché c'è una lezione
ogni giorno. (...)
6
Alla scuola
Matilde Serao
(...) Aspettavamo i giorni di tirocinio con una ansietà segreta. i giorni di lezione erano monotoni,
spesso tristi. Noi studiavamo senza voglia, malamente, con programmi incerti, con professori troppo
severi e assolutamente inetti. Eravamo già maestre e l'essere trattate da scolarette ci umiliava, ci
stizziva. A casa, qualcuna di noi aveva la povertà, quasi tutte una miseria decente - e chi un fratello
ebete, chi un padre paralizzato, chi una matrigna tormentatrice, qualche piaga celata con cura,
qualche vergogna nascosta con una nobile pietà, qualche infelicità, qualche ingiustizia del destino, a
cui la rassegnazione era completa. Non erano allegri i nostri diciotto anni e le aride lezioni di
aritmetica, di pedagogia, di geografia, finivano col ravvolgerci in un ambiente di malinconia.
Ma il tirocinio ci salvava dalla tetraggine, rompendo la monotonia, dandoci un giorno di pausa.
Eravamo trenta e ne scendevano tre al giorno al pianterreno, nelle scuole elementari: così il turno ci
capitava ogni dieci giorni. In questo benedetto decimo giorno, le tirocinanti indossavano l'abito
nuovo se lo avevano, e, se non lo avevano, mettevano un colletto pulito, un fiocco di nastro per
cravatta: si pettinavano, qualcuna si faceva i ricciolini. Entravano in otto, dicevano la preghiera,
segnavano la presenza sul registro, e stavano lì, distratte, con gli occhi trasognati, aspettando le
nove per andar giù, mentre le amiche mormoravano: - Beate voi che andate al tirocinio!
Risalivano alle due, molto riscaldate in volto, coi capelli un po' arruffati, con gli occhi lucenti,
stanche, ma felici, felici di quelle ore passate fra le bimbe, felici di quel primo contatto, di quelle
prime lezioni date timidamente, contente di quella nuova dignità conquistata. E narravano alle altre
quello che avevano spiegato alle piccine, l'addizione sul pallottoliere, i dittonghi e la maglia di
calza: dicevano che le piccine erano tanto carine, tanto intelligenti, alcune tranquille, alcune
insolenti, che la maestra titolare lasciava fare tutto alla tirocinante, che insegnare era un po' duro,
ma che infine diventava un piacere. Poi venivano i caratteri delle piccole descritti minutamente:
Orefice è buona, ma è stupida e si succhia il mignolo: bisogna tenerla sempre d'occhio. Abbamonte
è bellina, ma è zoppa, poveretta, non può fare ginnastica. Chiarizia è insolente, risponde male e
brontola, ma è figlia di un segretario municipale, non si può sgridarla molto. Tutte quelle che
avevano fatto il tirocinio prima di me, mi avevano detto: - Quando andrai giù, Aloe ti farà dannare.
- Aloe ha un diavolo per cappello.
- Se non ci fosse Aloe, la classe sarebbe tranquilla.
(...)
Mi fermai innanzi alla porta della classe, con una certa trepidazione. Sullo scalino una bimba era
accoccolata, col capo chinato: ma non piangeva. - Che fai qui? - le chiesi, dandomi un tono
d'autorità.
- Sono arrivata tardi - rispose a bassa voce, senza guardarmi in volto, - e la maestra non ha voluto
farmi entrare.
- Perché non te ne vai a casa?
- Perché mamma non ci sta, a casa, adesso.
- E dove sta mamma?
- Alla fabbrica del tabacco.
- Come si chiama mamma?
- Si chiama mamma - disse lei, semplicemente, un po' meravigliata.
- Entra con me in classe; ti farò perdonare dalla maestra il ritardo.
Appena entrai vi fu un movimento precipitoso: tutte quelle piccine - sessanta forse - si alzarono,
strillando su tutti i toni:
- Buon giorno, maestra! Buon giorno, maestra!
Credo di esser diventata rossa dall'orgoglio; mi tremava la voce, dicendo alla maestra titolare:
- Buon giorno, signorina. Fate sedere le piccole: vi prego, lasciate che questa qui rientri in classe.
La maestra fece una smorfietta:
- Questa qui è Aloe. Vi divertirete bene - disse.
E volte le spalle, se ne andò a far colazione. Aloe mostrò la lingua, tanto per cominciare.
7
Era una bambina di dieci anni, molto brutta, molto magra, coi pomelli sporgenti, una bocca larga e
avvizzita di donna, due occhi grigi e vivi, maliziosi, una criniera nera di ricciolini ruvidi, troppo
folti, che pareva le lasciassero il volto esangue. Portava un vestitino di lanetta stinto, le calze di
cotone azzurro tutte rattoppate col filo bianco e aveva le scarpe rotte.
- Andate al posto - le dissi - e state quieta.
Ella andò lentamente al banco e stette cinque minuti tranquilla. Ma mentre si diceva l'Ave Maria,
diede un pizzicotto nel braccio a Cavalieri, che si mise a piangere. Cavalieri era una grassottella,
bianca e pienotta, coi capelli castagni, la boccuccia rotonda e schiusa; le fossette nelle guance, al
mento, nelle manine; una piega nel grasso del collo, una piega nel grasso dei polsi.
- Aloe, perché avete dato un pizzicotto a Cavalieri? - Signora maestra, perché è troppo grassa - mi
rispose, levandomi in volto i suoi occhi di donnina malata e cattiva.
- Chiedetele scusa, subito.
- No - rispose duramente, battendo un piede sul tavolato.
- Andiamo, Aloe, siate buona: le avete fatto male a Cavalieri, Cavalieri piange, chiedetele scusa.
Allora, senza guardare né me, né la piccola vicina, mormorò a bassa voce: - Chiedo scusa.
Cavalieri, rabbonita le buttò al collo le braccia grassocce e la baciò sulla guancia.
E Aloe si diede a piangere, tremando tutta, singhiozzando, inconsolabile. Per quanto cercassi
d'essere imperiosa, non ci riuscivo. Quelle creature non ci credevano alla mia durezza,alle mie
occhiate burbere, alla voce secca e breve, alle minacce di castighi.
Mi sogguardavano, sorridendo; oppure, mi chiedevano perdono con certi sguardi supplici - io mi
voltavo verso la lavagna, per non perdere la gravità.
Non era possibile di farle stare tranquille: ogni momento nasceva un nuovo incidente.
(...) Lei Aloe non sapeva nulla, non aveva il sillabario, non aveva la penna, non aveva l'abbaco, non
aveva il quaderno per le aste.
Stava ritta innanzi al cartellone delle sillabe, guardandolo con le mani penzoloni, senza aprire
bocca. Una viva espressione di sofferenza le si traduceva sulla faccia smorta.
(...) Nelle vacanze, vicino alla bottega di uno stagnino, vidi Santelia seduta, che cuciva.
Mi riconobbe e si alzò, guardandomi con lo stesso sguardo timido:
- E papà vostro lo stagnino? - Sì, signora maestra.
- Voi siete passata all'altra classe?
- Sì, signora maestra: ho avuto la medaglia.
- E le altre?
- Ce ne sono restate venti, signora maestra.
- Anche Aloe, nevvero?
- No, signora maestra: Aloe è morta.
- Quando è morta?
- Nel mese di agosto.
- E di che male?
- Aveva la febbre e aveva pure la tosse e le faceva male il petto. Poi, è morta...
8
All'inizio dell'estate del 1970
Abraham B. Yehoshua
(da Tutti i racconti - Einaudi)
(...) Arrivo a scuola in ritardo, cerco inutilmente nell'aria tersa un'ultima eco della campanella.
Comincio ad avanzare nel cortile vuoto, tra i riquadri di luci e d'ombra proiettati dalle finestre
allineate; passo accanto alle porte bisbiglianti di classi che stanno studiando. E allora mi accorgo,
con sorpresa, che il direttore mi sta inseguendo, da lontano mi chiama. Ma ormai sono vicino alla
mia classe, dal fondo del corridoio ne giunge lo strepito soffocato. Hanno chiuso la porta per non
rivelare la mia assenza, ma li tradisce la loro agitazione.
Il direttore mi chiama di nuovo, dal fondo del corridoio, ma io mi sottraggo alla sua vista e apro la
porta della classe sui loro urli, risate, schiamazzi che si smorzano in un brusio di sottile delusione.
Erano sicuri che per oggi non sarei più arrivato. Rimango in piedi vicino alla porta e lì aspetto
finché non si sono separati, coi capelli in disordine, i visi arrossati, nelle loro divise azzurre, e non
ritornano ognuno al loro posto, spostano coi piedi le piccole sedie, rimettono a posto le loro Bibbie,
e un po' alla volta i banchi si coprono di fogli bianchi, pronti per il compito.
Qualcuno alla lavagna cancella delle parole oscene, una caricatura ispirata alla mia figura. Mi
guardano sfrontati, negli occhi, sorridono tra sé, ma rimangono zitti. La mia età è ancora sufficiente
per calmarli.
E in quel momento, quando comincio ad avanzare nella classe tenendo in mano i testi del compito,
arriva trafelato il direttore, pallido in volto.
(...)Sono ormai tre anni che non ci parliamo, che ci guardiamo come se fossimo sassi. E sono tre
anni che non metto piede nella sala professori, non mi siedo, non mi avvicino al bricco del tè. Sono
a scuola dal mattino presto, durante gli intervalli sono per i corridoi, o nel cortile. D'estate - con un
cappello grande, a larghe tese - e d'inverno - con un cappotto pesante, il bavero rialzato - mi unisco
al flusso degli studenti, avanti e indietro. In segreteria ci entro un bel po' dopo la fine delle lezioni,
lascio gli elenchi dei voti, mi rifornisco di gessi.
E' raro che parli con gli altri insegnanti.
Tre anni fa avevo raggiunto l'età per andare in pensione, e me ne ero fatta una ragione, avevo
persino pensato di scrivere un libretto sull'insegnamento della Bibbia, ma scoppiò all'improvviso la
guerra, e l'aria intorno a me si riempì del rombo dei cannoni e di urli lontani. Comunicai al direttore
che non mi sarei dimesso, che sarei rimasto nella scuola finché non fosse finita la guerra. In fondo,
adesso che gli insegnanti vengono richiamati sotto le armi uno dopo l'altro, avrebbe avuto molto
bisogno di me. Ma lui non vedeva nessun legame tra la guerra e me. - Presto la guerra sarà finita, mi rispose con uno strano sorriso, - e tu hai diritto di riposare.
Ma non venne il riposo, bensì un'estate di fuoco, e notizie infiammate. E due nostri ex studenti,
giovanissimi, furono uccisi in due giorni. E ritornai da lui, alterato, le mani che mi tremavano: gli
dico balbettando che non vedo proprio come potrei abbandonarli ora, cioè ora che li mandiamo a
morire. Ma lui non vedeva nessun legame tra la loro morte e me. E cominciarono le vacanze estive,
e io che non trovo pace, sono ogni giorno nella scuola deserta, giro per la segreteria, accanto alla
sala professori, aspetto le notizie, parlo con i genitori e chiedo dei loro figli, osservo gli studenti in
uniforme che vengono a informarsi sui voti ottenuti all'esame di maturità, o a restituire un libro in
biblioteca, e fiuto in lontananza odore di bruciato.
E venne un altro morto, inatteso, studente di uno dei primi corsi, così amato ai suoi tempi, saltato su
una mina in una strada polverosa, e io sono un'altra volta dal direttore; eccitato, prostrato, gli dico: Adesso vedi, - ma lui ormai si vuole staccare da me. Aveva dato istruzioni per preparare le pratiche
del mio pensionamento, voleva organizzare una piccola festa in mio onore, alla quale naturalmente
rinunciai. Una settimana prima dell'inizio delle lezioni gli proposi di lavorare gratis purché mi
lasciasse le mie classi, ma lui aveva già firmato un contratto con un nuovo insegnante, e io non
risultavo più inserito nell'organico. Riapre la scuola. E io arrivo al mattino con tutti gli altri, con una
borsa di libri e un pezzo di gesso, pronto per insegnare. Mi scoprì vicino alla sala professori e chiese
9
esterrefatto che cosa era successo, che cosa facevo qui, ma io non risposi, non lo guardai nemmeno,
come se avessi di fronte una pietra. Pensò che fossi ammattito, ma in quelle ore confuse dell'inizio
delle lezioni non aveva tempo per me. E io intanto seguivo con gli occhi il nuovo insegnante, un
giovane magro e pallido in volto, per poi andargli dietro. Lui entra in classe, io indugio un attimo e
poi entro dietro di lui. Scusa, gli dico accennando un sorriso, certo ti stai sbagliando, questa non è la
tua classe, e lui rimane confuso, mentre io sono già salito in cattedra e ho già tirato fuori la mia
vecchia Bibbia consunta. Lui balbetta delle scuse ed esce, e agli studenti stupefatti che non
credevano più di vedermi non lasciai nemmeno la possibilità di aprir bocca. Quando dopo qualche
minuto compare il direttore io sono ormai nel bel mezzo della lezione, gli studenti ascoltano avvinti.
Non era possibile spostarmi di lì. Durante l'intervallo non lasciai l'aula, rimasi sempre in mezzo ai
ragazzi. Il direttore mi aspettava fuori, ma non osò avvicinarsi. Se si fosse avvicinato avrei gridato,
lui sapeva bene che di fronte agli studenti avrei gridato, e temeva gli scandali più di ogni altra cosa.
Ritornai all'insegnamento con la forza. (...)
10
Anna Karenina
Lev Tolstoj
(...) In queste meditazioni il tempo passò e quando venne il maestro, la lezione sui complementi di
tempo, di luogo e di modo non era preparata, e il maestro non solo non fu contento, ma si
dispiacque. Il dolore del maestro commosse Serza. Si sentiva colpevole perché non aveva studiato
la lezione; per quanto si sforzasse non ci riusciva in nessun modo. Finché il maestro spiegava, ci
credeva e sembrava capire, ma non appena rimaneva solo, non poteva assolutamente capire e
ricordarsi come un'espressione così corta e facile a intendersi quale "a un tratto" fosse un
complemento di modo; gli dispiacque di avere addolorato il maestro, e voleva consolarlo. Scelse un
momento in cui il maestro taceva, guardando il libro. "Michail Ivanyc, quando è il vostro
onomastico?" chiese a un tratto.
"Sarebbe meglio che pensaste al vostro lavoro, ché l'onomastico non ha nessuna importanza per un
essere ragionevole. È un giorno come un altro, nel quale bisogna lavorare."
Serza guardò il maestro, la sua barbetta rada, gli occhiali che erano scesi più giù del taglio ch'era sul
naso, e si fece così pensieroso che non sentì più nulla di quello che gli spiegava il maestro.
Egli capiva che il maestro non pensava a quello che diceva; lo sentiva dal tono con cui le parole
erano dette.
"Ma perché si sono messi tutti d'accordo nel dire queste cose sempre alla stessa maniera, tutte le più
noiose e inutili cose?
Perché mi allontana da sé, perché non mi vuol bene?" si chiedeva con tristezza e non riusciva a
immaginare una risposta. (...)
11
Ascolta il mio cuore
Bianca Pitzorno
(...) Quando, mezz'ora dopo, la classe scattò in piedi per l'ispezione, Elisa gettò una occhiata
compiaciuta all'ultimo banco di sinistra. Le facce di Iolanda e di Adelaide erano belle lustre, un po'
arrossate per il gran fregare. Le orecchie erano pulite fuori e dentro e anche i colli, le mani, le
ginocchia.
La maestra poteva essere soddisfatta.
Ma la signora Sforza, arrivata a un metro di distanza dalle due bambine, anche questa volta si
arrestò storcendo il naso.
- Che olezzo di rose! Che profumo di viole! - esclamò. - Oggi vi siete lavate la faccia come il gatto.
Ma credete che basti una leccatina in superficie?
Elisa allora si rese conto che, se le facce erano pulite, i grembiuli, le calze, i capelli erano quelli di
sempre. - Cosa vi ho promesso ieri, carine? Ve lo siete già dimenticato?- chiese la maestra
minacciosa.
- Scusi, signora, ma non è colpa loro se la bambinaia... - saltò su Emilia Damiani, che odiava
l'acqua e tutte le sere veniva immersa a forza nella vasca dalla vecchia tata .
- Ma quanto sei scema, Emilia! Figuriamoci se quelle due hanno la bambinaia! - la rimbeccò
sprezzante Sveva Lopez.
- Appunto perché non ce l'hanno devono imparare a farsi più responsabili del loro aspetto - disse la
maestra.
Prisca strinse forte la mano di Elisa, conficcandole le unghie nel palmo.
Rosalba alzò la ribalta nel banco e la lasciò cadere con forza. BAM!
- Cosa succede?- chiese la maestra fulminandola con lo sguardo.
- Secondo me oggi sono abbastanza pulite - disse Rosalba in tono di sfida.
- Ah, sì? Davvero? Credi di intendertene più di me, Cardano? Allora vieni ad aiutarmi. Vieni qui,
ho detto!
Sconcertata, Rosalba uscì dal banco e si avvicinò.
- Per esempio, queste belle trecce bionde ti sembra che siano abbastanza pulite? - chiese la maestra,
sollevando col righello una treccia di Adelaide.
- Ti sembra che abbiano un buon profumo? Annusale, su! Annusale da vicino! Adelaide cominciò a
tremare.
Rosalba annusò e disse: - Un profumo squisito.
- Davvero? Allora senti, visto che non ti fa schifo toccarle, me le reggi sollevate, per favore?
Rosalba, perplessa, obbedì.
La maestra, velocissima, poggiò il righello, tirò fuori dalla tasca un paio di forbici e con due colpi
decisi ZAC! ZAC!, tagliò le due trecce alla radice.
- Grazie, Cardano. Se vuoi, portatele a casa per ricordo. Scommetto che la tua amica Guzzòn te le
regala. Puoi metter su un allevamento di pidocchi.
Poi guardò Adelaide, che era rimasta impietrita, con gli occhi che le si riempivano silenziosamente
di lacrime.
- E tu, Profumo di Viole, cos'hai da frignare? Non voglio mocciconi nella mia classe. Va' fuori a
lavarti la faccia. Anzi, visto che ci sei, va a casa a far ammirare a tua madre la tua nuova pettinatura
.
L'indomani Adelaide, arrivò in classe con i capelli rapati quasi a zero come un maschio, o come se
avesse la rogna, e con un livido sotto l'occhio destro.
- Cos'è stato?- si informò Rosalba allora di ricreazione.
- Sua madre l'ha picchiata - spiegò Iolanda.
E aggiunse aggressiva: - Potevi stare zitta, tu, ieri, con la maestra! Chi ti aveva chiesto
d'impicciarti?
- Ma come? - esclamò Prisca scandalizzata. - Invece di venire a protestare con la maestra, se la sono
presa con lei che non ha fatto niente? Non è giusto.
12
(...)Il 20 di aprile, con grande meraviglia di tutta la classe, appena entrata nell'aula Adelaide invece
di sgattaiolare furtiva verso il suo banco come faceva sempre, si fermò sulla soglia, aprì la vecchia
cartella e ne estrasse un voluminoso involto di carta di giornale. Svolse la carta e, mentre tutte la
stavano a guardare con curiosità, liberò un mazzo di tulipani rossi e gialli. Un mazzo non tanto
grande, senza cellofan né carta crespata, e senza neppure uno spago per tenere insieme i fiori.
Adelaide lo scrollò, gli dette una aggiustatina e andò a deporlo solennemente sulla cattedra,
pronunciando la formula di rito: - Questo è per lei, signora. Ma la maestra, che aveva seguito i suoi
gesti con lo sguardo vitreo e inespressivo di un serpente, invece di rispettare il copione dicendo a
sua volta: - Grazie. Che pensiero gentile! - guardò i fiori con aria disgustata e chiese in tono
d'accusa: - Dove li hai presi?
- In giardino - balbettò Adelaide, che non si aspettava una simile accoglienza.
- In quale giardino? Non mi verrai a raccontare che possiedi un giardino, Raperonzolo!
Adelaide non rispose.
Lo sapevano tutti che in via Mercato Vecchio giardini non ce n'erano.
- Allora, dove li hai presi? - incalzò la maestra.
Silenzio. - Li hai comprati dal fioraio, per caso?
- Sì! Dal fioraio! - disse Adelaide,
aggrappandosi a quel suggerimento come a un'ancora di salvezza.
- E con quali soldi? Ti scappano fuori dalle tasche, eh i quattrini? Ne hai tanti che non sai dove
metterli... ma chi credi di prendere in giro, brutta pezzente?
Adelaide si morsicò il labbro inferiore e chinò il capo.
- Non li hai comprati dal fioraio, brutta bugiarda! Altrimenti avrebbero la carta trasparente, il nastro
e l'etichetta...
Adelaide continuò a fissarsi le scarpe in silenzio. Era inutile negare l'evidenza.
- Te lo dico io da dove arrivano questi fiori, Raperonzolo - disse con aria sempre più feroce la
signora Sforza.
Fece una pausa per guardarsi in giro per controllare che tutta la classe la stesse a sentire con la
massima attenzione, poi tuonò, puntando l'indice contro Adelaide:- Li hai rubati!
Adelaide presa alla sprovvista, sussultò. - Non li ho rubati disse con una voce tremante.
- Sì, invece. E inutile che lo neghi, stracciona. Sei una ladra. E' chiaro come il sole. Sei una
bugiarda e una ladra. E io nella mia classe di ladre non ce ne voglio! La voce della maestra si faceva
sempre più alta e stridula, il tono sempre più minaccioso.
I Conigli, benché l'accusa non li riguardasse tremavano spaventati. Ma anche i Maschiacci e persino
le Leccapiedi, seguivano la scena col fiato sospeso, piene di apprensione. - Non li ho rubati. Non li
ho rubati. Non è vero - insistette testarda Adelaide.
- Ah. Non è vero! Dunque la bugiarda sarei io! Di bene in meglio, Raperonzolo. Mi offendi anche.
- Io non... - balbettò Adelaide. - Tu sei una ladra, e faresti meglio a confessare! Dove li hai rubati?
In quale giardino?
"Quante storie per quattro tulipani" pensava Rosalba e aveva una gran voglia di alzarsi e di gridare:
"Glieli ho regalati io!" ma temeva di metterla ancora più nei guai, perché sul viso della maestra si
poteva leggere un'espressione feroce e determinata, come quella che doveva avere il lupo quando
discuteva con l'agnello nella favola di Esopo.
Adelaide continuava a negare ostinatamente.
- Non li ho rubati.
- Benissimo - disse gelida la maestra. - Vuol dire che manderò a chiamare la polizia. Vedremo se,
quando sarai in prigione, ti deciderai a dire la verità.
La minaccia fece il suo effetto. Adelaide perse completamente il controllo. - No, no! In prigione no!
- si mise a strillare.
Stava lì in piedi, di fianco alla cattedra, scossa dai singhiozzi, col naso che le colava, le mani
tremanti.
- Neanche un cane... neanche un cane si tratta così! - sussurrò Prisca aggrappandosi alla mano di
Elisa e conficcandole le unghie nel palmo. (...)
13
Autobiografia
Mark Twain
(...) Cominciai ad andare a scuola quando avevo quattro anni e mezzo. A quei tempi nel Missouri
non vi erano scuole pubbliche, ma ve n'erano due private: tasse, venticinque centesimi alla
settimana per alunno, che si riscuotevano se si poteva. La signora Horr insegnava ai bambini in una
piccola casa di tronchi all'estremità sud della via principale. Il signor Sam Cross insegnava ai più
grandicelli in una casa di legno e mattoni sulla collina. Io fui mandato dalla signora Horr e
rammento distintamente il mio primo giorno in quella piccola scuola di tronchi d'albero, anche se
son passati sessantacinque anni e più: rammento, almeno, un episodio di quel primo giorno. Spezzai
una riga e fui avvertito di non farlo di nuovo, altrimenti la punizione per un'altra riga rotta sarebbe
stata una sferzata. Non tardai a romperla e la signora Horr m'ingiunse di uscire, trovare una verga e
portargliela. Ero contento che avesse scelto me, perché pensavo che avrei potuto prenderne una
adatta alla bisogna con miglior criterio di qualsiasi altro. Trovai nel fango un'assicella di quercia di
quelle usate una volta dai bottai, larga due pollici, spessa un quarto di pollice, terminante a
un'estremità con una leggera curva. Tutto intorno vi erano delle assicelle nuove dello stesso tipo,
ma io presi questa, benché fosse marcita. La portai alla signora Horr, gliela porsi e restai davanti a
lei in un atteggiamento sottomesso e rassegnato che mi sembrava adatto a vincere il favore e la
pietà; ma così non fu. Essa divise in parti eguali un lungo sguardo di grande disapprovazione fra me
e l'assicella; quindi mi chiamò col mio intero nome, Samuel Langhorne Clemens - e forse fu la
prima volta che lo udivo sfilare così come una processione - e disse che si vergognava di me. Più
tardi dovevo imparare che quando un maestro chiama un ragazzo con l'intero nome sono in vista
guai. Disse che avrebbe cercato di scegliere un ragazzo che avesse un criterio migliore del mio in
fatto di bacchette, e mi rattrista ancora ricordare quanti visi s'illuminarono per la speranza
dell'incarico. Lo ebbe Jim Dunlap, e quando tornò con la bacchetta che aveva scelto mi accorsi che
se ne intendeva. (....)
14
Ci sono bambini a zigzag
David Grossmann
(...) Più o meno una volta al mese, quando la mia insegnante, la signora Markus, mi espelleva una
volta per tutte dalla scuola, Gabi si fiondava in sala professori a chiedere pietà per me e allora, in
una specie di rituale, implorava di darmi un'ultima occasione, mi metteva le mani sulle spalle e, con
voce tonante, si domandava come potesse la scuola rinunciare a un bambino così meraviglioso. La
signora Markus sogghignava, dicendo che un'espulsione di una settimana era davvero una pena mite
per un elemento come me, così svogliato e inconcludente - all'epoca gli insegnanti calibravano per
bene i loro improperi, mica come oggi - e che a ogni modo bisognava rassegnarsi al fatto che avevo
bisogno di una struttura scolastica diversa, più consona ai miei limiti.
Potete star sicuri che Gabi non gliela faceva passare liscia: "Quelli che secondo lei sono limiti,
secondo me sono punti di forza!" e si piazzava davanti all'insegnante, gonfia come un cobra cui
abbiano insediato la prole. "Si possono anche definire, giusto per fare un esempio, un'anima da
artista! Si! Forse non tutti sono adatti all'inquadramento della scuola! Ci sono persone rotonde, mia
cara signora, ci sono bambini a forma, diciamo di triangolo, perché no, e ci sono......" Gabi
abbassava la voce, levava una mano per aria, come faceva la famosa attrice Lola Ciperola in CASA
DI BAMBOLA, e sussurrava con una voce da far rabbrividire: "Ci sono bambini a zigzag!" E come
si usa dire, mi struggevo per lei. (...)
15
Cuore
Edmondo De Amicis
(...) Il nostro maestro
18, martedì
Anche il mio nuovo maestro mi piace, dopo questa mattina. Durante l'entrata, mentre egli era già
seduto al suo posto, s'affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari
dell'anno scorso, per salutarlo; s'affacciavano, passando, e lo salutavano: - Buongiorno, signor
maestro. - Buon giorno, signor Perboni; - alcuni entravano, gli toccavan la mano e scappavano. Si
vedeva che gli volevan bene e che avrebbero voluto tornare con lui. Egli rispondeva: - Buon giorno,
- stringeva le mani che gli porgevano; ma non guardava nessuno, ad ogni saluto rimaneva serio, con
la sua ruga diritta sulla fronte, voltato verso la finestra, e guardava il tetto della casa di faccia, e
invece di rallegrarsi di quei saluti, pareva che ne soffrisse.
Poi guardava noi, l'uno dopo l'altro, attento. Dettando, discese a passeggiare in mezzo ai banchi, e
visto un ragazzo che aveva il viso tutto rosso di bollicine, smise di dettare, gli prese il viso fra le
mani e lo guardò; poi gli domandò che cos'aveva e gli posò una mano sulla fronte per sentir s'era
calda. In quel mentre, un ragazzo dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare la marionetta. Egli
si voltò tutt'a un tratto; il ragazzo risedette d'un colpo, e restò lì, col capo basso, ad aspettare il
castigo. Il maestro gli pose una mano sul capo e gli disse: - Non lo far più. - Nient'altro. Tornò al
tavolino e finì di dettare. Finito di dettare, ci guardò un momento in silenzio; poi disse adagio
adagio, con la sua voce grossa, ma buona: - Sentite. Abbiamo un anno da passare insieme. Vediamo
di passarlo bene. Studiate e siate buoni. Io non ho famiglia. La mia famiglia siete voi. Avevo ancora
mia madre l'anno scorso: mi è morta. Son rimasto solo. Non ho più che voi al mondo, non ho più
altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figliuoli. Io vi voglio bene, bisogna che
vogliate bene a me. Non voglio aver da punire nessuno. Mostratemi che siete ragazzi di cuore; la
nostra scuola sarà una famiglia e voi sarete la mia consolazione e la mia alterezza. Non vi domando
una promessa a parole; son certo che, nel vostro cuore, m'avete già detto di sì. E vi ringrazio.
In quel punto entrò il bidello a dare il finis. Uscimmo tutti dai banchi zitti zitti. Il ragazzo che s'era
rizzato sul banco s'accostò al maestro, e gli disse con voce tremante: - Signor maestro, mi perdoni.
- Il maestro lo baciò in fronte e gli disse: - Va', figliuol mio.
(...)
Un tratto generoso
26, mercoledì
(...) il maestro non c'era ancora, e tre o quattro ragazzi tormentavano il povero Crossi, quello coi
capelli rossi, che ha un braccio morto, e sua madre vende erbaggi. Lo stuzzicavano colle righe, gli
buttavano in faccia delle scorze di castagne, e gli davan dello storpio e del mostro,
contraffacendolo, col suo braccio al collo. Ed egli tutto solo in fondo al banco, smorto, stava a
sentire, guardando ora l'uno ora l'altro con gli occhi supplichevoli, perché lo lasciassero stare. Ma
gli altri sempre più lo sbeffavano, ed egli cominciò a tremare e a farsi rosso dalla rabbia. A un tratto
Franti, quella brutta faccia, salì su un banco, e facendo mostra di portar due cesti sulle braccia,
scimmiottò la mamma di Crossi, quando veniva a aspettare il figliuolo alla porta, perché ora è
malata. Molti si misero a ridere forte. Allora Crossi perse la testa e afferrato un calamaio glielo
scaraventò al capo di tutta forza, ma Franti fece civetta, e il calamaio andò a colpire nel petto il
maestro che entrava. Tutti scapparono al posto, e fecero silenzio, impauriti. Il maestro, pallido, salì
al tavolino, e con voce alterata domandò: - Chi è stato?
Nessuno rispose. Il maestro gridò un'altra volta, alzando ancora la voce: - Chi è stato?-. Allora
Garrone, mosso a pietà del povero Crossi, si alzò di scatto, e disse risolutamente: - Son io -. Il
maestro lo guardò, guardò gli scolari stupiti; poi disse con voce tranquilla: - Non sei tu -. E dopo un
momento: - Il colpevole non sarà punito. S'alzi!
Il Crossi s'alzò, e disse piangendo: - Mi picchiavano e m'insultavano, io ho perso la testa, ho tirato...
- Siedi, - disse il maestro. - S'alzino quelli che lo han provocato.
16
Quattro s'alzarono col capo chino. - Voi, - disse il maestro, - avete insultato un compagno che non
vi provocava, schernito un disgraziato, percosso un debole che non si può difendere. Avete
commesso una delle azioni più basse, più vergognose di cui si possa macchiare una creatura umana.
Vigliacchi!
Detto questo, scese tra i banchi, mise una mano sotto il mento a Garrone, che stava col viso basso, e
fattogli alzare il viso, lo fissò negli occhi, e gli disse: - Tu sei un'anima nobile -. Garrone, colto il
momento, mormorò non so che parole nell'orecchio al maestro, e questi, voltatosi verso i quattro
colpevoli, disse bruscamente: - Vi perdono.
(...) Il Direttore
18, venerdì
Coretti era contento questa mattina perché è venuto ad assistere al lavoro d'esame mensile il suo
maestro di seconda, Coatti, un omone con una grande capigliatura crespa, una gran barba nera, due
grandi occhi scuri, e una voce da bombarda; il quale minaccia sempre i ragazzi di farli a pezzi e di
portarli per il collo in Questura, e fa ogni specie di facce spaventevoli; ma non castiga mai nessuno,
anzi sorride sempre dentro la barba, senza farsi scorgere. Otto sono, con Coatti, i maestri, compreso
un supplente piccolo e senza barba, che pare un giovinetto. C'è un maestro di quarta, zoppo,
imbacuccato in una grande cravatta di lana, sempre tutto pieno di dolori, e si prese quei dolori
quando era maestro rurale, in una scuola umida dove i muri gocciolavano. Un altro maestro di
quarta è vecchio e tutto bianco ed è stato maestro dei ciechi. Ce n'è uno ben vestito, con gli occhiali,
e due baffetti biondi, che chiamavano l'avvocatino, perché facendo il maestro studiò da avvocato e
prese la laurea, e fece anche un libro per insegnare a scriver le lettere.
Invece quello che c'insegna la ginnastica è un tipo di soldato, è stato con Garibaldi, e ha sul collo la
cicatrice d'una ferita di sciabola toccata alla battaglia di Milazzo. Poi c'è il Direttore, alto, calvo con
gli occhiali d'oro, con la barba grigia che gli vien sul petto, tutto vestito di nero e sempre
abbottonato fin sotto il mento; così buono coi ragazzi, che quando entrano tutti tremanti in
Direzione, chiamati per un rimprovero, non li sgrida, ma li piglia per le mani, e dice tante ragioni,
che non dovevan far così, e che bisogna che si pentano, e che promettano d'esser buoni, e parla con
tanta buona maniera e con una voce così dolce che tutti escono con gli occhi rossi, più confusi che
se li avesse puniti. Povero Direttore, egli è sempre il primo al suo posto, la mattina, a aspettare gli
scolari e a dar retta ai parenti, e quando i maestri son già avviati verso casa, gira ancora intorno alla
scuola a vedere che i ragazzi non si caccino sotto le carrozze, o non si trattengan per le strade a far
querciola, o a empir gli zaini di sabbia o di sassi; e ogni volta che appare a una cantonata, così alto e
nero, stormi di ragazzi scappano da tutte le parti, piantando lì il giuoco dei pennini e delle biglie, ed
egli li minaccia con l'indice da lontano, con la sua aria amorevole e triste. Nessuno l'ha più visto
ridere, dice mia madre, dopo che gli è morto il figliuolo ch'era volontario nell'esercito; ed egli ha
sempre il suo ritratto davanti agli occhi, sul tavolino della Direzione. E se ne voleva andare dopo
quella disgrazia; aveva già fatto la sua domanda di riposo al Municipio, e la teneva sempre sul
tavolino, aspettando di giorno in giorno a mandarla, perché gli rincresceva di lasciare i fanciulli. Ma
l'altro giorno pareva deciso, e mio padre ch'era con lui nella Direzione, gli diceva: - Che peccato che
se ne vada, signor Direttore! - quando entrò un uomo a fare iscrivere un ragazzo, che passava da
un'altra sezione alla nostra perché aveva cambiato di casa. A veder quel ragazzo il Direttore fece un
atto di meraviglia, lo guardò un pezzo, guardò il ritratto che tien sul tavolino e tornò a guardare il
ragazzo, tirandoselo fra le ginocchia e facendogli alzare il viso.
Quel ragazzo somigliava tutto al suo figliuolo morto.
Il Direttore disse: - Va bene; - fece l'iscrizione, congedò padre e figlio, e restò pensieroso.
- Che peccato che se ne vada! - ripeté mio padre.
E allora il Direttore prese la sua domanda di riposo, la fece in due pezzi e disse: - Rimango.
(...) Le maestre
17, sabato
Garoffi stava tutto pauroso, quest'oggi, ad aspettare una grande risciacquata del maestro; ma il
maestro non è comparso, e poiché mancava anche il supplente,
17
è venuta a far scuola la signora Cromi, la più attempata delle maestre, che ha due figliuoli grandi e
ha insegnato a leggere e a scrivere a parecchie signore che ora vengono ad accompagnare i loro
ragazzi alla Sezione Baretti.
Era triste, oggi, perché ha un figliuolo malato. Appena che la videro, cominciarono a fare il chiasso.
Ma essa con voce lenta e tranquilla disse: - Rispettate i miei capelli bianchi: io non sono soltanto
una maestra, sono una madre; - e allora nessuno osò più di parlare, neanche quella faccia di bronzo
di Franti, che si contentò di farle le beffe di nascosto. Nella classe della Cromi fu mandata la
Delcati, maestra di mio fratello, e al posto della Delcati, quella che chiamano "la monachina",
perché è sempre vestita di scuro, con un grembiale nero, e ha un viso piccolo e bianco, i capelli
sempre lisci gli occhi chiari chiari, e una voce sottile, che par sempre che mormori preghiere. E non
si capisce, dice mia madre: è così mite e timida, con quel filo di voce sempre eguale, che appena si
sente, e non grida, non s'adira mai: eppure tiene i ragazzi quieti che non si sentono, i più monelli
chinano il capo solo che li ammonisca col dito, pare una chiesa la sua scuola, e per questo anche
chiamano lei la monachina. Ma ce n'è un'altra che mi piace pure: la maestrina della prima inferiore
numero 3, quella giovane col viso color di rosa, che ha due belle pozzette nelle guance, e porta una
gran penna rossa sul cappellino e una crocetta di vetro giallo appesa al collo. È sempre allegra, tien
la classe allegra, sorride sempre, grida sempre con la sua voce argentina che par che canti,
picchiando la bacchetta sul tavolino e battendo le mani per impor silenzio; poi quando escono, corre
come una bambina dietro all'uno e all'altro, per rimetterli in fila; e a questo tira su il bavero, a
quell'altro abbottona il cappotto perché non infreddino, li segue fin nella strada perché non
s'accapiglino, supplica i parenti che non li castighino a casa, porta delle pastiglie a quei che han la
tosse, impresta il suo manicotto a quelli che han freddo; ed è tormentata continuamente dai più
piccoli che le fanno carezze e le chiedon dei baci tirandola pel velo e per la mantiglia; ma essa li
lascia fare e li bacia tutti, ridendo, e ogni giorno ritorna a casa arruffata e sgolata, tutta ansante e
tutta contenta, con le sue belle pozzette e la sua penna rossa. È anche maestra di disegno delle
ragazze, e mantiene col proprio lavoro sua madre e suo fratello.
(...) Il maestro supplente
4, mercoledì
Aveva ragione mio padre: il maestro era di malumore perché non stava bene, e da tre giorni, infatti,
viene in sua vece il supplente, quello piccolo e senza barba, che pare un giovinetto. Una brutta cosa
accadde questa mattina. Già il primo e il secondo giorno avevan fatto chiasso nella scuola, perché il
supplente ha una gran pazienza, e non fa che dire: - State zitti, state zitti, vi prego.
Ma questa mattina si passò la misura. Si faceva un ronzìo che non si sentivan più le sue parole, ed
egli ammoniva, pregava: ma era fiato sprecato. Due volte il Direttore s'affacciò all'uscio e guardò.
Ma via lui, il sussurro cresceva, come in un mercato.
Avevano un bel voltarsi Garrone e Derossi a far dei cenni ai compagni che stessero buoni, che era
una vergogna.
Nessuno ci badava.
Non c'era che Stardi che stesse quieto, coi gomiti sul banco e i pugni alle tempie, pensando forse
alla sua famosa libreria, e Garoffi, quello del naso a uncino e dei francobolli, che era tutto occupato
a far l'elenco dei sottoscrittori a due centesimi per la lotteria d'un calamaio da tasca. Gli altri
cicalavano e ridevano, sonavano con punte di pennini piantate nei banchi e si tiravano dei
biascicotti di carta con gli elastici delle calze. Il supplente afferrava per un braccio ora l'uno ora
l'altro, e li scrollava, e ne mise uno contro il muro: tempo perso. Non sapeva più a che santo votarsi,
pregava: - Ma perché fate in codesto modo? volete farmi rimproverare per forza?
Poi batteva il pugno sul tavolino, e gridava con voce di rabbia e di pianto:
- Silenzio! Silenzio! Silenzio!
Faceva pena a sentirlo. Ma il rumore cresceva sempre.
Franti gli tirò una frecciuola di carta, alcuni facevan la voce del gatto, altri si scappellottavano; era
un sottosopra da non descriversi; quando improvvisamente entrò il bidello e disse: - Signor maestro,
il Direttore la chiama. Il maestro s'alzò e uscì in fretta, facendo un atto disperato. Allora il baccano ricominciò più forte.
18
Ma tutt'a un tratto Garrone saltò su col viso stravolto e coi pugni stretti, e gridò con la voce
strozzata dall'ira: - Finitela. Siete bestie. Abusate perché è buono. Se vi pestasse le ossa stareste
mogi come cani. Siete un branco di vigliacchi. Il primo che gli fa ancora uno scherno lo aspetto
fuori e gli rompo i denti, lo giuro, anche sotto gli occhi di suo padre! Tutti tacquero. Ah! Com'era bello a vedere, Garrone, con gli occhi che mandavan fiamme!
Un leoncello furioso, pareva. Guardò uno per uno i più arditi, e tutti chinaron la testa. Quando il
supplente rientrò, con gli occhi rossi, non si sentiva più un alito. Egli rimase stupito. Ma poi,
vedendo Garrone ancora tutto acceso e fremente, capì, e gli disse con l'accento d'un grande affetto,
come avrebbe detto a un fratello: - Ti ringrazio, Garrone.
(...) Addio
10, lunedì
(...) Entrò il maestro: si fece un grande silenzio. Aveva in mano l'elenco, e cominciò a leggere
subito. - Abatucci, promosso, sessanta settantesimi, Archini, promosso, cinquantacinque
settantesimi.
Il muratorino promosso, Crossi promosso. Poi lesse forte:
- Derossi Ernesto promosso,
settanta settantesimi, e il primo premio. Tutti i parenti ch'eran lì, che lo conoscevan tutti, dissero: - Bravo, bravo, Derossi! - ed egli diede
una scrollata ai suoi riccioli biondi, col suo sorriso disinvolto e bello, guardando sua madre, che gli
fece un saluto con la mano. Garoffi, Garrone, il calabrese, promossi. Poi tre o quattro di seguito
rimandati, e uno si mise a piangere perché suo padre ch'era sull'uscio, gli fece un gesto di minaccia.
Ma il maestro disse al padre: - No, signore, mi scusi; non è sempre colpa, è sfortuna molte volte. E
questo è il caso. Poi lesse: - Nelli, promosso, sessantadue settantesimi. Sua madre gli mandò un
bacio col ventaglio. (...) Letto l'ultimo, il maestro si alzò e disse: - Ragazzi, questa è l'ultima volta
che ci troviamo riuniti. Siamo stati insieme un anno, e ora ci lasciamo da buoni amici, non è vero?
Mi rincresce di separarmi da voi, cari figliuoli. S'interruppe; poi ripigliò: - Se qualche volta m'è
scappata la pazienza, se qualche volta, senza volerlo, sono stato ingiusto, troppo severo, scusatemi. No, no, - dissero i parenti e molti scolari, - no, signor maestro, mai. - Scusatemi, - ripeté il maestro,
- e vogliatemi bene. L'anno venturo non sarete più con me, ma vi rivedrò, e rimarrete sempre nel
mio cuore. A rivederci, ragazzi! - Detto questo, venne avanti in mezzo a noi, e tutti gli tesero le
mani, rizzandosi sui banchi, lo presero per le braccia e per le falde del vestito; molti lo baciarono,
cinquanta voci insieme dissero: - A rivederlo, maestro!
- Grazie, signor maestro!
- Stia bene!
- Si ricordi di noi!
Quando uscì, pareva oppresso dalla commozione... (...)
19
Dago Red
John Fante
(...) Fu proprio per via del catrame che, quando facevo la seconda, suor Agnes decise che non le
andavo proprio giù. D'altra parte, mica fu colpa mia se lei se la prese tanto. I banchi, in seconda,
erano talmente piccoli che quando si sedeva accanto a me prendeva tutto lo spazio, e io mica lo
sapevo che sulla seggiola c'era il catrame.
Per farla breve: dovevamo ripetere in coro la lezione e io, invece, masticavo catrame. Suor Agnes
mi vede e viene verso il mio banco. Quando io la vedo arrivare, e ho paura, mi tolgo il catrame di
bocca e lo butto via. Sul pavimento, credo. Però è caduto sulla seggiola e, cacchio, io non me ne
sono accorto. Non sapevo che lei si sarebbe seduta in banco con me. Ma l'ha fatto.
Scuote le dita e fa: "Quante volte debbo dirti di non ciancicare quella roba?" E infuriata. Io non
rispondo, e lei si alza, voglio dire: quasi. Insomma: cerca di alzarsi, perché c'è il catrame che la
tiene giù.
La tonaca si tende. Cerco di aiutarla. La tonaca comincia a strapparsi. Lei si infuria ancora di più.
Dice che debbo toglierle le mani di dosso. Mi tira un bel cazzottone. Poi dice a una ragazza di
prendere le forbici, e ritaglia un buchino nella tonaca.
"Sei uno sporcaccione. Mi sa che dovrò darti una scarica di botte" dice.
Insomma mi tocca rimanere dopo la fine delle lezioni e pulire tutto. Suor Agnes sta lì con me.
Mi tocca grattar via l'affare con un coltello. Ma non tutto il catrame viene via. Sono triste, molto
triste, ma non glielo dico. (...)
20
David Copperfield
Charles Dickens
(...) La scuola cominciò sul serio il giorno dopo. Ricordo l'impressione profonda che ebbi quando il
frastuono delle voci nell'aula si trasformò in un silenzio di tomba;
subito dopo la prima colazione il signor Creakle entrò e rimase sulla soglia a guardarsi intorno come
il gigante della favola che osserva i suoi prigionieri.
Al fianco del signor Creakle vi era Tungay, il quale non mi parve avesse motivo di urlare così
ferocemente: - Silenzio! - visto che tutti stavano perfettamente zitti e immobili.
Si vide parlare il signor Creakle e si udì la voce di Tungay.
- Adesso, ragazzi, comincia il nuovo semestre. State bene attenti a quello che farete in questo
semestre. Vi consiglio di prepararvi alle lezioni perché non vi prepari io il castigo. Io sono pronto.E
non vi servirà a nulla grattarvi perché non riuscirete a grattar via i segni che vi lascerò. E adesso al
lavoro, dal primo all'ultimo!
Al termine di questo pauroso esordio, e quando Tungay se ne fu andato fuori zoppicando, il signor
Creakle si avvicinò al mio posto e mi disse che se io ero famoso per mordere, lui pure era famoso
per mordere. Poi mi mostrò la bacchetta e mi chiese come mi sembrava per servire da dente. Era un
dente aguzzo, eh? Era un dente grosso, eh? Era un dente lungo, eh? Mordeva, eh? Mordeva? E a
ogni domanda mi sferrava un colpo tale da farmi sussultare per il dolore. E così (come disse
Steerforth) mi trovai a far parte di Salem House di pieno diritto e anche in lagrime.
Non voglio dire con questo che ricevessi io solo quei particolari segni di distinzione. Al contrario, la
grande maggioranza dei ragazzi (specialmente fra i più piccoli) ricevette lo stesso genere di
attenzioni mentre il signor Creakle faceva il giro dell'aula.
Prima ancora che incominciassero le lezioni, la metà degli studenti si contorceva e piangeva, e
quanti dovettero piangere e contorcersi prima della fine di quella giornata preferisco non cercare di
ricordare perché non mi si dica che esagero.
Direi che non può essere esistito un uomo che godesse della sua professione più del signor Creakle.
Tale era il piacere che provava nell'aggredire i ragazzi che lo direi non dissimile dalla soddisfazione
di uno smodato appetito. Ritengo per certo che non riusciva a resistere alla vista di un piccolo
scolaro paffuto, e che un soggetto del genere aveva per lui un tale fascino da non dargli pace fino
che non lo avesse scelto e segnato per la giornata. Io ero paffuto e posso parlarne con cognizione di
causa.
Certo è che se oggi ripenso a quell'individuo il sangue mi ribolle contro di lui con
l'indignazione spersonalizzata che dovrei provare anche se di lui fossi stato solo informato a fondo,
ma senza mai essergli stato soggetto, mentre l'indignazione è in me fortissima perché so quale bruto
ignorante egli fosse, indegno del grande posto di fiducia che occupava, così come sarebbe stato
indegno di essere grande ammiraglio comandante in capo, funzioni nelle quali avrebbe tuttavia
probabilmente commesso danni infinitamente minori.
(...) Mi rivedo di nuovo seduto al tavolino, intento ad osservare i suoi occhi, a spiarli umilmente,
mentre traccia righe nel quaderno di aritmetica di un'altra vittima le cui mani sono state appena
battute da quello stesso righello, e che cerca di cancellarne il bruciore con il fazzoletto. Ho il mio
bel daffare. Non osservo i suoi occhi per ozio, ma perché ne sono morbosamente attirato con
desiderio e timore di sapere che cosa egli passerà a fare, e se toccherà a me soffrire, o a qualcun
altro. Oltre a me tutta una schiera di scolaretti prova il medesimo interesse per i suoi occhi e li
osserva. Credo che egli lo sappia, sebbene finga di non accorgersene. Mentre traccia le righe del
quaderno di aritmetica fa le più spaventose smorfie e di colpo getta un'occhiata di traverso tra le
nostre file e tutti abbassiamo gli occhi sul libro e ci mettiamo a tremare. Un attimo dopo torniamo a
guardarlo. Un infelice viene scoperto colpevole di errori nel suo esercizio, e in seguito a un ordine
gli si avvicina. Il colpevole balbetta delle scuse, promette di fare meglio l'indomani. Prima di
staffilarlo il signor Creakle dice una facezia, e noi ne ridiamo, piccoli e vili come siamo, noi
ridiamo con le guance pallide come la cera e il cuore nelle calcagna.
Mi rivedo seduto al tavolino in un sonnolento pomeriggio d'estate. Mi sento circondato da un brusio
21
e ronzio come se i ragazzi fossero altrettanti mosconi. Mi pesa nello stomaco la sensazione del
grasso quasi freddo della carne (abbiamo pranzato da un'ora o due) e la testa mi pesa come il
piombo. Darei il mondo intero pur di dormire. Resto con gli occhi fissi sul signor Creakle, li batto
come un giovane gufo; quando per un momento il sonno mi vince, egli seguita a incombere sul mio
torpore mentre squadra i quaderni di aritmetica, fino a quando mi arriva in silenzio alle spalle e mi
riporta a una più chiara percezione della sua presenza imprimendomi una riga di fuoco sul dorso.
Mi rivedo sul campo da gioco con gli occhi sempre in cerca di lui anche se non lo vedo. La finestra
poco lontana, dietro la quale so che ora sta pranzando, fa le veci di lui, e fisso quella.
Se mostra là vicino il suo volto, il mio assume un'espressione di sottomessa implorazione. Se
guarda fuori attraverso il vetro, anche il ragazzo più ardito (con l'eccezione di Steerforth)
s'interrompe nel mezzo di un urlo e di una chiamata e diventa assorto.
Un giorno Traddles (il ragazzo più sfortunato della terra) infrange accidentalmente con una palla il
vetro di quella finestra.
Rabbrividisco anche adesso per la terribile impressione di aver visto quell'incidente, al pensiero che
la palla sia rimbalzata sulla sacra testa del signor Creakle.
Povero Traddles!
Strizzato in un abito color azzurro che gli riduceva braccia e gambe come salsicce tedesche o come
budini di pasta sfoglia con dentro la marmellata, era il più allegro e il più infelice di tutti i ragazzi.
Veniva continuamente preso a vergate, mi pare che in quel semestre sia stato picchiato ogni giorno
eccetto un lunedì festivo, in cui ebbe solo colpi di righello su entrambe le mani... (...)
22
Di mestiere faccio il maestro
Marco Rossi-Doria - (L'ancora del Mediterraneo)
(...) "Si ricordi", ha detto il direttore, "è una prima e l'italiano non è la loro lingua materna e devono
imparare a parlare la lingua santa d'Italia, a leggere e a scrivere e a fare di conto e poi viene tutto il
resto".
E io zitto non ho fiatato, non ho osato citargli le innovazioni... della scuola che viene avanti, ... che
dice che si può imparare bene anzi meglio il leggere, scrivere e fare di conto anche attraverso una
grande quantità di esperienze creative. (...)
L'aula è piena come un uovo, ventinove presenti su trentuno. Tutti i bimbi e le bimbe si sono
segnati con il loro contrassegno colorato sul cartellone, è stata data acqua alle dodici piantine che
stranamente crescono, tanto che debordano dai vasi, il vocìo ha un tono più dimesso, mi muovo
lento e tranquillo come poche altre volte e conservo un timbro di voce basso e suadente, non
richiamo nessuno, mi accovaccio, mi chino con dolcezza, mettendomi all'altezza dei bambini ad
ogni tavolo, che riunisce sei o sette bambini, così ho accorpato i banchi creando dei tavoli di lavoro
e tutti i tavoli stamattina si nutrono di parole di aiuto reciproco e quasi paiono lievitare nell'aria,
tanto sono senza strattoni, né calci, né rimbrotti ... né male parole e le matite sono appuntite, i
quaderni sui banchi, pronti, preparati come non mai.
(...) Ho fatto un bel disegno alla lavagna in seguito alla passeggiata fatta ieri alla stazione, me lo
hanno chiesto loro di farlo: è il treno che corre. Scrivo la frase intera in stampato maiuscolo, in
stampato minuscolo, in corsivo: il treno corre veloce.
Al secondo tavolo sulla destra c'è un sussulto improvviso, davvero inspiegabile, ma non ho neanche
il tempo di interrogarmi su cos'è: vedo i capelli neri di Patrizia che sbattono sul banco poi insieme
al viso e a tutto il capo si rivoltano con uno scatto all'indietro, spingono e urtano come scosse
successive sullo schienale della sediolina, la fanno cadere con una forza che mai avevo visto e
Patrizia rovina violentemente con la schiena a terra, battendo la testa, tutti si mettono a gridare, a
piangere, è la prima volta, è la prima volta e sarà la più difficile. Mi dico: ora calma Marco, ti sei
preparato con cura ad una crisi di questa bimba, per settimane ti sei preparato a questo evento, lo
sapevi, lo attendevi, sei rimasto in guardia e adesso è arrivato, ora tocca a te: tono fermo, rassicura
tutti gli altri bambini e occupati di Patrizia, ora è il momento, tocca a te.
"Bambini, ora ascoltate, Patrizia sta male, ma tra poco starà di nuovo bene, voi sedetevi, state
tranquilli, potete guardare, dopo il maestro insieme a Patrizia vi spiegherà tutto, non vi dovete
preoccupare, non dovete pensare che adesso capiterà anche a voi, perché a voi non succederà niente,
proprio niente, ve lo dice il maestro e anche Patrizia starà meglio tra poco; se non volete sedervi
potete stare in piedi, ma non correte fuori dall'aula, non aprite la porta perché qui non c'è pericolo e
il maestro si occuperà di tutto; vedrete, andrà tutto molto bene, non gridate , non piangete, non vi
succederà niente di male e vedrete che tra poco anche Patrizia starà meglio e dopo che Patrizia starà
meglio e vi avrò spiegato tutto, faremo tutti insieme pure il compito bello del treno che corre
veloce".
Mantengo il tono fermo, giusto, rassicurante e ripeto il messaggio mentre sto già inginocchiato per
terra a fianco di Patrizia ma ecco all'improvviso dentro di me viene fuori dal nulla e si attiva una
feroce voce interiore, inattesa, terribile, inesistente: è la voce del panico, mi dico, devo scacciarla,
devo subito mandarla via, ora, ma è una voce dannatamente forte, possiede un suo potere
inamovibile, non riesco a mandarla via, parla con parole con interrogativi crudi a scatti, nel volgere
di pochissime frazioni di secondo; quanto è rapido il pensiero, mi sorprendo a riflettere, sempre in
una frazione di secondo, quanto è rapido maledizione e la voce incalza dentro.
"Chi ti credi di essere, maledetto pazzo, vuoi rassicurare e tenere tranquilli ventotto bambini di sei
anni" così dice la voce da dentro "e vuoi pure lenire la crisi di epilessia che o si ferma da sola o non
si ferma, cretino, che hai letto, che hai chiesto a fare al tuo amico, pezzo di imbecille presuntuoso,
vuoi lenire l'attacco furioso di una bimba malata, che ti sei voluto accollare per forza nella tua
classe già così zeppa di bambini orfani, vilipesi dalla sorte con i padri e le madri ignoranti come
bestie, lo hai fatto pur sapendo che non avrai mai un'insegnante di sostegno; che ti credevi di stare a
23
Modena, a Pisa, a Bergamo; roba da Nord Italia che ti facevano avere subito subito il sostegno per
una bimba perfettamente normale salvo le crisi, invece te la sei accollata da solo, come l'eroe dei
due mondi, lo hai fatto non per dovere, come ami raccontarti ma per vanagloria, hai fatto tutto per
presunzione, vuoi bastare sempre a te stesso, sei pericoloso per te e per i i bambini; e adesso come
maledizione credi di potertela cavare, ma non lo vedi che adesso ti fa schifo, che stai per venire
meno, che forse vomiterai; sì, ti sei procurato da solo le informazioni rilevanti su Patrizia, ti assumi
compiti, responsabilità che spettano ad altri, che altri non assolvono, non rispetti la catena delle
responsabilità, così le cose, tra l'altro non cambieranno mai, ci vuole il danno, e non questa
assunzione di compiti impropri, parli tu con i medici, rassicuri la mamma, accetti Patrizia senza
sostegno ma perché non ti hanno almeno aggiornato su come fare su come agire, su cosa dire in
questi casi: anche in questo non vedi che ti hanno lasciato solo, e tu, povero imbecille tutto
contento, non te lo sei chiesto il perché, pezzo di imbecille presuntuoso, o non lo capisci che
semplicemente ti scaricano tutto addosso e tu te lo accolli perché sei presuntuoso, non ti leggi
neanche la normativa in materia, non ti tuteli neppure, vuoi bastare a te stesso e lo vedi che sbatte
forte con la testa a terra che gli altri bimbi urlano come dannati, sono terrorizzati e presi dal panico,
corrono, scappano, non puoi pensare di fare il maestro unico di classe, in questo Presepe che non è
per te, ci vuole gente con la pellaccia dura o almeno che stia al suo posto e agisca negli ambiti della
sua responsabilità; tu non hai neanche scritto nero su bianco che c'era questa minaccia incombente e
che spettava ad altri garantire servizi e personale senza cui è impossibile, impensabile, forse pure
illegale affrontarla e se crepa qui e ora, che ne sai tu chi la paga la mamma, o forse pensi che lei con
la figlia morta in classe tua, ti comprenda, ti ringrazi lo stesso, pezzo di imbecille presuntuoso, e poi
con tutti questi bimbi, ma sono ventotto ognuno con la sua testa, mica ne conosci le reazioni, le
debolezze, che tutti insieme si scatenano, ora si moltiplicano, ma lo vedi che stanno piangendo, che
dietro la tua schiena, urlano, corrono, ora salgono pure sui banchi, si mettono anche a ridere, a
rincorrersi per gioco addirittura, lo vedi che non si può dire quel che succede, che le reazioni sono
imprevedibili, altro che controllo; e c'è pure Gaetano che sta aprendo la porta e ora esce e sei solo tu
il responsabile, la senti la voce, è quella di Gaetano, e la vedi o no la testa di Patrizia, continua a
sbattere, le esce ora la saliva di bocca, ha gli occhi, che tu dici a lei e alla sua mamma che sono
tanto belli, che sono sbarrati, invece fanno impressione, guardali, se hai il coraggio presuntuoso,
sdolcinato della malora, ora come fai a fermarle il capo, ad assicurarle il respiro e a calmare tutti,
come fai?".
La voce non si ferma, passa forse un secondo, ho la fronte sudata, sento la tensione
sull'avambraccio che protende la mano fin dietro la nuca di Patrizia, sollevo il corpo di Patrizia e
con l'altra mano le scalzo la sediolina da sotto la schiena che le ripoggio con cura piano piano a
terra cercando di non oppormi ai sussulti, agli scatti che le hanno preso il corpo ora con più forza di
prima ed ecco decido ad un tratto di non ostinarmi a voler scacciare per forza questa voce terribile
da dentro che martella, che non dà tregua, ma invece di rispondere io alla voce in poche frazioni di
secondo si ridesta la determinazione, riesco a prendere forza, Iddio solo sa da dove, e rispondo
dentro di me. "Ora invece facciamo proprio come dico io" così scandisco la frase dentro di me e mi
dico in risposta alla voce "e innanzitutto io tra un istante mi giro e vedo la situazione dietro la mia
schiena, mentre tengo forte la mano sotto la nuca di Patrizia, poi prendo due maglioncini appesi, li
vado a prendere in fondo all'aula, dall'attaccapanni, torno di corsa, li metto sotto la testa di Patrizia e
non solo, mentre lo faccio lo annuncio a voce alta alla classe che così sentirà la mia voce e vedremo
chi avrà la meglio qui e poi, sempre dicendo alla classe quel che faccio come una telecronaca in
diretta, riacciufferò con calma e determinazione Gaetano che è uscito, rientrerò subito, inviterò tutti
ad aiutare e ripeterò con voce ferma il messaggio iniziale e ce la farò dannazione, ce la farò". Mi
giro e dico alla classe che i maglioni servono a Patrizia per non sbattere la testa, li agguanto, faccio
passi lunghi senza correre, riesco pure a sorridere a chi sta attonito, ma seduto ancora nella sediolina
e mi ascolta, prendo dalla tasca un fazzoletto che avevo sempre, preparato "nel caso che" e lo
allungo, lo avvolgo su se stesso come spiegatomi dal mio amico medico a cui avevo chiesto, mi
riaccovaccio su Patrizia, le infilo i maglioni sotto il capo, annuncio alla classe che il fazzoletto serve
a Patrizia così non si morde né si taglia la lingua e può pure respirare meglio e aggiungo "ora
bambini respiriamo tutti insieme piano piano e tutti insieme" e subito dopo riprendo a ripetere a
24
voce alta le informazioni, scandendole ora tra un respiro e l'altro che enfatizzo: "Bambini, ascoltate
il maestro Marco, Patrizia sta male, ma tra poco starà di nuovo bene, voi sedetevi, state tranquilli,
potete guardare, dopo il maestro, insieme a Patrizia vi spiegherà" (....)
E mentre lo dico, sento che i bambini respirano forte, esageratamente forte, mi asciugo la fronte,
infilo il fazzoletto con dolcezza tra i denti e poi sopra la lingua di Patrizia che ora sbatte sui
maglioncini, che attutiscono il suono del capo che sbatte, le metto una mano sulla fronte, sembra
sudata o forse è il sudore mio, preso dalla mia fronte, o la saliva di Patrizia, non importa, ma,
dannazione, mi sono dimenticato di andare ad acciuffare Gaetano che è scappato fuori, chiamo
Anna e le chiedo cortesemente ma con voce imperiosa di andare, insieme a Gaetano che sta fuori,
dal bidello per procurarsi un bicchiere d'acqua che è molto importante perché il maestro ha sete e
poi di tornare tutti e due insieme.
Mi giro di nuovo a guardare, i bambini non gridano più forte, parlano tra loro e guardano me, non si
rincorrono più tranne due, sono scesi tutti dai banchi, respirano quasi tutti con molta enfasi, e pure
io riprendo a farlo più forte, mentre ora tengo anche le due mani sulle tempie di Patrizia, non più
sulla nuca che è protetta dal morbido dei maglioncini e cerco di controllare i sussulti, quanto sarà
passato, pochi secondi, mezzo minuto, no, forse un minuto, e quanto può durare, dannazione, Dio
quante cose si fanno, succedono, si pensano, escono dall'anima in così poco tempo: a quanto può
durare, quanto! (....) Prendo le dita della mano a Patrizia, mi sembrano ora meno rigide, si sbatte
molto meno la testa, adesso tolgo il fazzoletto, gli occhi riprendono, è molto stanca, poi entrano
Anna e Gaetano che mi porta l'acqua, lo guardo, lui abbassa gli occhi, e gli dico che se il maestro
dice che non si esce, non si esce, ma che lo perdono solo per questa volta, dico a tutti di sedersi,
perché Patrizia sta meglio e tra poco starà bene.
Entra il bidello, il vampiro, mi guarda, ha una voce quasi affettuosa: "Ve lo avevo detto io che
questa nennella vi portava problemi, ora professore vi porto il caffè, subito ve lo porto".
Faccio disegnare a lungo il treno che corre sui grandi fogli, i toni di voce ritornano sommessi,
Patrizia non racconta niente e io neanche e si siede zitta zitta vicina a me.
25
Dubròvski
Puskin
(...) Il giovane attaccò discorso col viaggiatore in francese.
- Dove vi state recando?, gli domandò.
- Nella città più vicina - rispose il francese - e da lì mi dirigerò da un proprietario, che mi ha assunto
per corrispondenza come maestro. Pensavo di arrivare oggi stesso sul posto, ma il signor mastro di
posta pare abbia stabilito altrimenti. In questo paese è difficile procurarsi dei cavalli, signor
ufficiale.
- E da quale dei proprietari locali siete stato assunto? - chiese l'ufficiale.
- Dal signor Troekùrov - rispose il francese.
- Da Troekùrov? E chi è questo Troekùrov?
-Ma foi, mon officier... non ne ho sentito parlare un granché bene. Dicono che è un signore fiero e
bizzoso, crudele nel modo di trattare la gente di casa, che nessuno riesce ad andarci d'accordo, che
tutti tremano al suo nome, che con i maestri (avec les outchitels) non fa complimenti e ne ha già
frustati due a morte.
- Per carità! E voi avete deciso di farvi assumere da un simile mostro?.
- Che devo fare, signor ufficiale?
Mi offre un buon stipendio, tremila rubli all'anno, vitto e alloggio. Può essere che io sia più
fortunato degli altri. Ho una mamma vecchia, le manderò metà dello stipendio per il suo
mantenimento; col resto del denaro posso accumulare un piccolo capitale, sufficiente per la mia
futura indipendenza, e allora bonsoir, partirò per Parigi e mi darò alle imprese commerciali. (...)
- Vi conosce qualcuno a casa di Troekùrov? - domandò.
- Nessuno - rispose il maestro. - Mi ha fatto venire da Mosca attraverso un suo amico, al quale ero
stato raccomandato dal suo cuoco, mio connazionale. Dovete sapere che io non avevo l'intenzione
di fare il maestro, ma il pasticciere; mi dissero però che nel vostro paese la professione di maestro
era infinitamente più redditizia... (...)
26
Emma
Jane Austen
(...) Mrs. Goddard era maestra d'una scuola - non d'un educandato, o d'un istituto (...) - ma d'un vero
e proprio onesto convitto all'antica, in cui una ragionevole
quantità di cognizioni era venduta a un prezzo ragionevole, e dove si potevano mandare le ragazze
perché si levassero dai piedi e a forza di sgobbare si conquistassero un po' d'istruzione, senza
correre il pericolo di tornare a casa prodigi. La scuola di Mrs. Goddard godeva alta stima e molto
meritatamente poiché Highbury era considerata un sito particolarmente salubre: Mrs. Goddard
aveva una casa e un giardino assai vasti, dava alle bambine un vitto sano e abbondante, le faceva
scorrazzare attorno un bel po' durante l'estate, e nell'inverno medicava con le proprie mani i loro
geloni. Nessuna meraviglia, quindi, che una coda di venti coppie di giovinette le andasse ora dietro
in chiesa.
Era un tipo di donna materna, senza bellezza, che aveva lavorato indefessamente da giovane, e ora
riteneva di potersi concedere di tanto in tanto la vacanza d'una visita all'ora del tè... (...)
27
Forte come la morte
Guy De Maupassant
(...) La prozia di Wopsle teneva una scuola serale nel villaggio; vale a dire, era una vecchia ridicola,
di mezzi limitati e illimitati acciacchi, che si addormentava tutte le sere dalle sei alle sette alla
presenza di bambini che pagavano due pence a testa la settimana, per avere l'opportunità di
migliorarsi vedendola dormire. Era affittuaria di una casetta di cui Wopsle occupava il primo piano;
noi scolari lo sentivamo leggere nella sua stanza in modo austero e grandioso, e di tanto in tanto
picchiare sul soffitto. Era in uso la finzione di un esame cui Wopsle sottoponeva gli allievi ogni tre
mesi. Ciò che faceva in quelle occasioni, consisteva nell'arrotolarsi i polsini, scompigliarsi i capelli
e declamarci l'orazione di Marcantonio sul corpo di Cesare, seguita regolarmente dall'Ode
sullepassioni di Collins; lo veneravo soprattutto nella parte di Vendetta che getta a terra con fragore
la spada insanguinata e afferra con furia la tromba foriera di guerra. (...)
Nella stessa stanza, oltre all'Istituzione Pedagogica, vi era anche un piccolo emporio. La prozia di
Wopsle non aveva la minima idea di quale merce disponesse, né quale fosse il prezzo di ogni
singolo articolo; conservato in un cassetto, vi era però un taccuino bisunto che fungeva da listino
dei prezzi, e grazie a quell'oracolo Biddy regolava tutte le transazioni commerciali. Biddy era la
nipote della prozia di Wopsle
(...)
Il piano educativo o Corso della scuola si può riassumere come segue.
Gli scolari mangiavano mele e si ficcavano pagliuzze nella schiena, sinché la prozia di Wopsle
radunava l'energia necessaria per raggiungerli barcollando e colpirli indiscriminatamente con una
verga di betulla.
Accolta la carica con ogni possibile beffa, gli scolari si mettevano in fila, e in un continuo brusio si
passavano di mano in mano un libro sgangherato.
Conteneva un alfabeto, un po' di numeri, qualche tabella, un piccolo sillabario - o per meglio dire, li
aveva contenuti un tempo. Non appena il libro iniziava a circolare, la prozia di Wopsle cadeva in
uno stato di coma, dovuto al sonno o a un accesso reumatico. A quel punto gli scolari entravano in
competizione esaminandosi a vicenda in materia di scarpe, per accertare chi riuscisse a pestare quali
piedi con più forza.
Quest'esercitazione mentale durava sinché Biddy non si avventava su di loro distribuendo tre Bibbie
malconce (che dalla forma parevano maldestramente ritagliate dalla tozza estremità di qualcos'altro)
stampate, al loro meglio, nel modo più illeggibile che da allora mi sia mai capitato di vedere in una
qualsiasi curiosità letteraria, macchiettate di ruggine, cosparse di segni lasciati da svariati esemplari
del mondo degli insetti spiaccicati tra le pagine.
Questa parte del Corso veniva solitamente ravvivata da numerosi corpo a corpo tra Biddy e gli
scolari più caparbi. Finiti gli scontri, annunciava il numero di una pagina
e allora leggevamo ad alta voce ciò che potevamo - o non potevamo - in un coro spaventoso; era
Biddy a dirigere con voce acuta e monotona, mentre nessuno di noi aveva la minima idea di cosa
stesse leggendo, o dimostrava la minima riverenza. Quando l'orribile frastuono si era protratto per
un po', automaticamente svegliava la prozia di Wopsle, che barcollava verso un bambino a caso e
gli tirava le orecchie.
Era questo il segnale della fine del Corso per quella sera, e noi uscivamo all'aperto con urla di
vittoria intellettuale.
Va detto comunque che non veniva impedito l'uso, da parte degli scolari, di lavagne o persino
dinchiostro (quando ce n'era), anche se non era facile coltivare quel ramo del sapere d'inverno, a
causa dell'unica desolata candela di sego senza smoccolatoio, che illuminava fiocamente il piccolo
emporio dove si faceva lezione - e che fungeva anche da salotto e camera da letto della prozia di
Wopsle. (...)
28
Gli ultimi della classe
Paola Tavella
(...) Quando Davide stava per compiere quindici anni, a scuola hanno deciso di organizzargli una
festa. Nonostante sia uno di quelli che Nerone, per fare onore al suo nome, minaccia ogni tanto di
versarlo nel Vesuvio, e abbia una spiccata propensione al danneggiamento doloso, si fa amare da
tutti. È lungo e biondo con gli occhi che ridono. Occhi che sono stati una rivelazione, perché
quando è arrivato, a ottobre, guardava sempre in basso. La sua insegnante e tutore, Greta, è l'unica a
scuola a essere alta quanto lui. Ora che è quasi primavera si siedono insieme nel prato, attenti a non
finire nella spazzatura e sulle ortiche, con l'atlante aperto sulle ginocchia.
Ogni tanto ridono fino alle lacrime, chissà di che. Davide è incapace di concentrarsi per più di dieci
minuti anche quando le cose gli piacciono. Ma segue Greta ovunque lei lo voglia portare. In piscina
per imparare a nuotare, a Pompei a vedere gli scavi, al corso di canottaggio. Persino dal dentista.
La mattina della festa Greta arriva con la torta, un girello alla crema di mitica bontà che fa con le
sue mani. Lo decora con lenti di cioccolato, comincia ad andare avanti e indietro dalla cucina alla
porta e a chiedere se hanno visto Davide, come mai ancora non è a scuola.
Entra Antonia insieme a una folata di burro fritto, ha preparato i pop-corn e si lamenta che lei e la
sua automobile puzzano tremendamente. Entra Chiara, l'insegnante dei più piccoli, che doveva
comperare le bibite, e, infatti, eccole. Caterina sfoggia uno dei suoi rari, luminosi sorrisi, ha un
regalino per Davide, un braccialetto di cuoio con il nome. Intanto le dieci e il festeggiato non c'è.
A Gisella viene in mente che forse Davide non ha mai avuto un'autentica festa di compleanno in
vita sua, non sa bene cosa aspettarsi e quindi sarà in qualche punto imprecisato fra casa e scuola a
mangiarsi le unghie, senza andare ne avanti ne indietro.
Costernazione generale: come hanno potuto essere così sceme da non pensarci?
E poi c'è la faccenda del padre, dice Caterina. Dopo sette anni di carcere torna a casa. Da quando è
arrivata la notizia, Davide è agitato. Gli ho chiesto che cosa aveva, racconta Greta. Ha paura, dice,
che suo fratello Pino venga mandato in guerra contro la Serbia. Ma il fratello fa il poliziotto, in
guerra contro la Serbia i poliziotti non ci vanno. Una cosa del genere lo sanno perfino a casa di
Davide. Lo sapete che non è mai voluto andare a Poggioreale dal padre? Gli ha mandato delle
fotografie e gli ha scritto una lettera per Natale: <<Caro padre, spero che sarai libero quando
compirò quindici anni. Sarai molto orgoglioso perché sono molto cresciuto in muscoli e altezza.
Faccio canottaggio con Davide Tizzano, che si chiama come me ed è un grandissimo campione.
Sono stato in barca a vela con lui davanti a Nisida. Ora ti saluto perché devo andare.
Il tuo caro figlio Davide>>.
L'ha ricopiata sul quaderno di italiano. Forse non l'ha mai spedita. Dalla stanza Spassatiempo arriva
un gran chiasso. Segno che l'impazienza cresce. I ragazzi vogliono i pop-corn, e le coca-cole, il
girello, insomma la festa. E il festeggiato.
<<Se non arriva lo vado a cercare cò ò mezzo>> dice Peppe, dove ò mezzo è il motorino, che
peraltro Peppe non ha. Alle dieci e mezzo Davide viene avvistato, anche fuori del recinto della
scuola. Chiacchiera con il venditore di sigarette. Perde tempo. Greta parte per recuperarlo e, non si
sa come, lo attira dentro.
Entra e si sente un boato. Tutti urlano, saltano, gli tirano le orecchie e lo baciano. Lui resta in piedi
nell'atrio, immobile e come rassegnato, una specie di idolo assalito da ogni lato. La vista della torta
con le decorazioni e le candeline lo lascia di sasso <<E per il compleanno mio?>> chiede a destra e
a manca. Anche sua madre è stata avvertita e invitata e ha portato i fratelli - Silviuccio, il piccolo, e
Pino, che è a licenza a casa - e sua nonna, Ninetta. Il nonno sarebbe venuto, e ha anche provato a
muoversi, ma se mette giù le gambe urla dal dolore. I familiari di Davide vengono fatti accomodare
nella stanza Spassiatempo, vicino al ragazzo.
Sono seduti in semicerchio, serviti e riveriti come a una festa nuziale di paese. Quando le candeline
sono spente, e il dolce mangiato è complimentato, la madre e la nonna vengono gentilmente
sospinte verso l'automobile e spedite a casa. Così si può ballare.
Caterina accompagna Ninetta fino all'automobile e la aiuta a sedersi.
29
Le chiede come va. Ninetta si preme il fazzoletto sulla bocca e scuote la testa. <<Hai visto con i
tuoi occhi>> dice. Ieri il vecchio, che sta a letto con la finestra aperta sulla strada, ha adocchiato
Caterina passargli davanti e ha chiesto a Ninetta, sua moglie di uscire a chiamarla. Si conoscono
bene, abitano a pochi passi da vent'anni, le loro vite si sono intrecciate molte volte. Il vecchio sta
morendo, Ninetta lo sa e non lo vuole sapere. Lo rimbrotta, perché fuma, perché non vuole andare
all'ospedale, perché non prova nemmeno ad alzarsi. Faceva il ferroviere, uno di quelli che
sostituivano a giornata i malati o le vittime degli incidenti sul lavoro. Allora nei vagoni dei treni
c'era l'amianto e adesso quello lo uccide. È stata comunista sempre, negli anni trenta, negli anni
Cinquanta, quando i padroni assoldavano malamente perché venissero nel basso a sfasciargli tutto.
Caterina lo ha conosciuto nel 70 quando è arrivata qui dalla Valtellina, fresca sposa di Nerone.
Hanno fatto insieme le lotte nel quartiere. Era un uomo indomito, sempre in prima fila. Caterina
ricorda perfettamente com'era il basso a quei tempi. Due stanze e mezzo, e una era la cucina, ci
vivevano in dodici e facevano i turni per sedersi a mangiare. Il gabinetto era fuori, nel cortile, in
comune con un'altra famiglia. Adesso i figli hanno comprato anche i locali a fianco, allargato,
imbiancato, costruito un bagno enorme, con un intera parete di specchio. Mi hanno messo una
macchina del gas a sei fuochi, ha detto Ninetta, ma è troppo tardi. "Non cucino quasi più, siamo
rimasti soli. È nello specchio mi schifo a guardarmi, ormai sono una vecchia senza i denti."
Piuttosto le piace il cassettone con le cornici e le foto dei figli e dei loro bambini. Ha fatto con
Caterina il conto di quanti nipoti ha. Sono diciassette. O ne dimentica qualcuno?
Quelli che non dimentica sono i morti ammazzati. Al marito di Lina, la maggiore, hanno sparato per
la strada. Nanni invece, che era proprio figlio a lei, è scomparso nel nulla cinque anni fa. Ho
lasciato quattro piccirilli, uno ancora in grembo alla madre. Si era messo in mente di fare il
miliardo, dice il vecchio. E pensare che lui aveva voluto che i figli stesero lontani dall'amianto, ma
diventassero lo stesso operai specializzati.
"Lavoriamo il vetro." Poi è arrivata la droga - ma lui la chiama 'a fetenzia - e con quella i soldi
facili. Sembrava che tutto fosse a portata di mano, che lavorare non servisse più, che lui era stato
solo uno scemo.
"Speriamo che veda tornare Luciano, almeno," ha detto Ninetta a Caterina sulla porta. Luciano è la
luce degli occhi suoi, a quarant'anni è rimasto un guaglione e perfino la galera non l'ha cambiato,
non l'ha cresciuto. Veniva a casa e si sedeva con il padre, lo stava a sentire mentre raccontava dei
tedeschi e degli americani, dei fascisti e dei partigiani. Storie che nessuno vuole più sapere, ma a
Luciano piacciono. Luciano 'a fetenzia non l'ha mai toccata, è stato dentro per una vecchia storia di
sigarette, forse ha taciuto per coprire a qualcun altro. E pensare che era fabbro, abitava all'ultimo
piano, dalla finestra vedeva pure il mare, d'estate sentiva le voci dei bambini che giocavano sulla
spiaggia. Poi ha gettato tutto al vento.
Normale qui che da giovani si faccia un po' i mariuoli. Ma chi ha la testa sul collo nel frattempo
imparava un mestiere e quando si sposa o fa il guaio con una ragazza e arriva un bambino
inaspettato smette. Smette di fare il contrabbando, smette di arrangiarsi, di andare in giro con gli
amici. Piano piano cerca di togliersi dal giro e di farsi bastare quello che ha. Luciano invece non ha
mai capito come vanno le cose. Sempre a correre con le macchine, a montare e smontare, a
trafficare roba non sua.
Luciano è il padre di Davide. Quando Davide era alla scuola elementare nella classe di Nerone,
naturalmente, perché da lui finiscono tutti i bambini che nessun altro si tiene, Luciano era sempre
disponibile a dare una mano. Passava un pomeriggio a montare il palco per la recita di Natale o a
saldare le ruote a un carretto che serviva per giocare.
Caterina saluta ancora una volta Ninetta e chiude delicatamente la portiera. Fa un giro davanti alla
scuola. A casa sua coltiva un giardino e pure un orto e vedere questo pezzetto di verde invaso dalle
ortiche e dalla spazzatura le fa andare la giornata di traverso.
Si fa strada tra i rifiuti e raccoglie un po' d'erba di muro. Se la strofina sulle giunture dei polsi e
delle mani che fanno male. Al suo paese si dice che è miracolosa per i dolori. Dalle finestre aperte
della stanza Spassatiempo arriva una tarantella e comincia a canticchiare senza accorgersene.
Rosy, la maestra di danza delle ragazze, ha portato un mangianastri e dei dischi di canzoni
napoletane. Dalle copertine di cd artigianali occhieggiano cantanti impomatati e improbabili, ma i
30
ragazzi vanno in delirio soprattutto per Maria Nazionale, che a Napoli è una celebrità da Fan Club
ed è considerata pure una bellissima guagliona.
<< Putesse andà in galera pè Maria Nazionale>> fa Ciro, romantico, appena si sentono le prime
note di The best of Maria.
Dapprima ballano ognuno per conto suo. Poi un po' i maschi con i maschi e le femmine con le
femmine, tenendosi d'occhio senza parere. Alla fine è Ciro che tenta la sorte con Nunziata di cui è
innamorato pazzo. È opinione comune che anche lei abbia un debole per lui, ma lo consideri assai al
di sotto delle sue possibilità. Accetta, ma ritiene suo preciso dovere fumare distrattamente mentre
lui la abbraccia e si dondola da una gamba all'altra. Ciro è contento lo stesso, e grida <Professore, vi
amo> alle insegnanti che gli passano vicino nella confusione della festa. (...)
31
Goccie d'inchiostro
Carlo Dossi
La maestrina d'inglese
I
Tanto per cominciare
E' una pìccola stanza. Serve, con vece alterna, e da sala da pranzo e da vìsite, e, si potrebbe anche
dire, da càmera a letto, ché i due sofà mi han punto l'aria di restar sempre sofà. Tègoli troppi si
vèggono fuori, per crèderci bassi di piani; troppa poca mobilia dentro, per crèderci alti di fondi.
Squillo di campanello. Il campanello sussulta nella stanzetta; che la sia pure anticàmera?
E al suono, una ragazza gentile si presenta a una porta, e leggera leggera corre a dischiùderne
un'altra. Ed ecco un bel giòvane biondo, alto, entrare, e tosto pigliarle con trasporto le palme. "E il
pappà?" chied'egli di sottovoce. Aurora muove la graziosa testina tristissimamente.
"Ma il dottore, che dice?"
"Dice: vi è un sol rimedio... morire."
Aurora ha nel parlare la più adoràbile erre del mondo. Ma, oè, signore lettrici, non vi sforzate a
erreggiare; un rossetto e un bianchetto, come Natura dà, nel profumiere non troverete mai.
I due bei giòvani stanno zitti, mani con mani, sguardo con sguardo. "Aurora!" geme una voce dalla
stanza vicina. La fanciulla si scuote, scioglie le sue dalle mani di Enrico, che con passione le preme,
e accorre a chi chiama. Enrico ode la voce dell'ammalato, diventando agra e stizzosa, dire alla figlia
che lo si abbandona, che lo si lascia morire, anzi! che lo si desìdera morto... E Aurora, giù a
piàngere.
" Oh l'egoista!" fa il giovanotto fra i denti, e sospira.
II
Patria potèstas
(...) Aurora, vogliosa che nel bicchiere di babbo rosseggiàssene sempre del buono, saltò su a dire:
"Darò lezioni d'inglese"
Il signor Pietro fissolla con dubitoso stupore.
"E sai l'inglese... tu?" disse.
"Sì" ella fece timidamente "da un pezzo. Me l'ha insegnato la mia maestra Racheli... Pappà, scusa!"
e aggiunse, che la detta maestra, la quale amàvala molto, le offriva...
"No" interruppe il pappà, gentile come un chirurgo.
E tàquero entrambi. No, avvertite, era la sua risposta abituale; sentiva, nel proferirla, uno strano
piacere. Vero è, che dovèa poi scèndere al sì, ma pel momento era no.
Pur, questa volta, il diniego stette. Sospettoso come un topo frugato, il signor Pietro pensava che le
lezioni d'inglese d'Aurora, se non èrano già, potèvano convertirsi in tanti spedienti per istargli alla
larga. Aurora gli avrebbe dato ad intèndere ogni sorta di storie; ed egli, inchiodato su'na poltrona,
con la finestra che non vedeva che gatti, avrebbe dovuto, o bene o male, inghiottirle.. No, no; egli
s'amareggiava fin troppo quand'ella, per la poca provvista, era fuori.
Così passò un anno; muro a muro la vita. Tutto, men la pensione, aumentava; ed il Governo, giù
imposte! ché, quasi fosse una vigna il paese, credeva arricchirsi l'impoverendo.
Tornò il dare lezioni d'inglese a far capolino. Aurora disse che la sua vecchia maestra avèala cercata
per una brava signora e, acconsentendo pappà...
"No" rispose, secondo il suo vezzo, quella delizia di padre. Pure soggiunse: "La vuol proprio
imparare? ben, venga qui."
"Oh babbo!" esclamò la fanciulla con un ghignuzzo "chi può èssere quello che fa dieci scale per una
lezione d'inglese?"
Sul che, il signor Pietro si degnò di riflèttere. Stavolta, il suo falso-egoismo se ne trovava di fronte
altrettanto: lì si trattava di scègliere tra un po' più di minestra o un po' più di figliuola: e il signor
Pietro, forse in quella a digiuno, si attenne al "po' più di minestra.
Ma tuttavìa, volle e pretese un mucchio d'informazioni: dopo, impòsene uno di condizioni. Ed
32
eccolo, mentre Aurora è lontana, atteso con l'occhio alla lancetta del pèndolo, la quale ha trascorso
l'ora fissata... Inquieto, egli manda e rimanda la ragazzina che gli tien compagnìa, sul pianeròttolo...
E pàssano altri dieci minuti... Perché non torna? che fa? Aurora entra pressosa, anelante.
Il signor Pietro, senza lasciar ch'ella dica, comincia a bajare come un can da pagliajo. Ed essa, alla
prima in bilancia, risponde poi risentita. Egli, allora, fuori il secondo argomento! cioè il
moccichino... Dio mio! ingrata figliola! Bianchi capelli! padre ammalato... tanto che, spaurita la
tosa, con le perle negli occhi, e il singhiozzo, gli dimanda perdono.
Poi, un dì, il signor Pietro, veduto apparir la fanciulla con un mazzetto di fiori, si cacciò in testa che
gliel avèsser donato.
"È per tè" ella disse e lo porse "l'ho comperato per tè" aggiunse, avvertendo alla nuvolosa aria del
padre.
Ma, in segno di grazie, questi lo getta per terra. E fa "Tu hai arrossito"; quindi, una scena d'ira e di
pianto, il ricordo di cui, le làgrime molte di Aurora, èbbero pena, assài pena a lavare.
(...)
V
Progressi in inglese
Il dì seguente, incominciàrono le lezioni. Non mai fu uno scolare più assiduo di lui, né una maestra
più puntuale di lei. Uno sedèa ad un lato del tàvolo, l'altra all'opposto; tra loro, in sul terzo,
impoltronàvasi il babbo; gli occhiali, volti ad un libro; gli occhi, un po' a destra, un po' a manca.
E, dopo due chiàcchiere e sulla salute ed il tempo, aveva principio il dettato. Era curioso il notare
com'ella facesse fatica a dir bene, egli a scrivere male. A volte, Enrico sostava a porre una domanda
o un dubbio, o meglio, a consolarsi la vista; ed ella gli rispondeva turbata. Turbata? epperché?
perché forse vedèa che insegnava a un maestro? E, se sì, starsi zitta? a che? Appresso, si leggeva il
dettato; capital punto della lezione. Allora, le due sedie amorose s'avvicinàvano sul quarto lato del
tàvolo, cioè in facciatina all'egoista poltrona del babbo, e la bella ragazza, con l'imo di un
tagliacarte, apriva la strada ad Enrico, mentre costùi, spesso, si diperdeva a mirare, non la parola,
bensì le dita affilate che gliela indicàvano. E la ragazza: "su, coraggio, signore, dica".
Diàvolo d'un inglese! borbottava il pappà. Tanto che lo scolare, tirato fuori dall'èstasi, accentuava la
ritrosa parola in modo, che, se Aurora gentile fosse stata solo maestra, n'avrebbe fatto tesoro.
A volte poi, e' si sentiva solleticare da un capriccioso riccietto o titillare la guancia all'appressarsi
della rasata di lei; ancora un pochino, e si sarèbbero tocche. Serràvali in quella lo smarrimento
medèsimo; èrano come ubbriachi; leggèvano macchinalmente o almeno credèano lèggere, ché,
davvero, che forloccàssero mai, neppur Centofanti sarebbe riuscito a capire.
Fortuna, che tutto l'inglese del babbo consisteva in beef-steak e roast-beef con la giunta dell'yes!
Ma un dì, usando essi di fare anche un po' di diàlogo:
"Whom do you love?" chiese la bella volgèndosi ad Enrico e innamoratamente guardàndolo.
Enrico non tènnesi più.
"I love you!" fece con entusiasmo.
La fanciulla arrossò.
"Love? che significa love?" disse intorbidàndosi il babbo e strascicando la voce.
E, a botta risposta, Enrico: "Mangio."
Il Signor Pietro lampeggiò l'uno, poi l'altra, con un'occhiata tale, che, se le occhiate lasciàssero il
segno, quella li avrebbe uccisi di colpo. E, la lezione finita, ed il Giorgini partito, si die' a
carteggiare il "Baretti." (...)
33
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
J. k Rowling
(...)Una voce uscì all'improvviso dall'ombra, una voce dolce e misteriosa. "Benvenuti" disse. "E'
bello rivedervi in carne e ossa, finalmente".
La prima impressione che Harry ne ebbe fu quella di un grosso insetto luccicante. La professoressa
Cooman avanzò nel cerchio di luce nel fuoco, e videro che era molto magra; gli spessi occhiali le
rendevano gli occhi molto più grandi del normale ed era avvolta in uno scialle leggero, tutto
ricamato di perline. Innumerevoli catene e collane le pendevano dal collo esile, e le mani e le
braccia erano cariche di braccialetti e anelli. "Sedete, ragazzi miei, sedete" disse, e tutti presero
posto cautamente nelle poltrone o sprofondarono negli sgabelli. Harry, Ron e Hermione si sedettero
attorno allo stesso tavolino rotondo.
"Benvenuti a Divinazione" disse la Cooman, che aveva preso posto in un'ampia poltrona davanti al
fuoco. "Io sono la professoressa Cooman. Può darsi che non mi abbiate mai vista. Ritengo che
scendere troppo spesso nella confusione della scuola offuschi il mio Occhio Interiore." Nessuno
commentò questa straordinaria dichiarazione. La professoressa Cooman riaccomodò con grazia lo
scialle e riprese:
"Allora, avete deciso di studiare Divinazione, la più difficile di tutte le arti magiche. Devo però
dirvi subito che se non avete la Vista, potrò insegnarvi assai poco. I libri possono farvi progredire
solo fino a un certo punto in questo campo..."
Sia Harry che Ron sorrisero e lanciarono un'occhiata ad Hermione, allarmata alla notizia che i libri
non le sarebbero stati di grande aiuto in questa materia.
"Molte streghe e molto maghi, per quanto talento possano avere nel campo delle esplosioni e degli
odori e delle sparizioni improvvise, non sono tuttavia in grado di penetrare in misteri velati del
futuro" riprese la professoressa Cooman, con gli enormi occhi scintillanti che si spostavano da un
volto all'altro. E' un Dono concesso a pochi. Tu, ragazzo" disse improvvisamente rivolta a Neville,
che quasi cadde dallo sgabello, "sta bene tua nonna?"
"Credo di si" rispose Neville con voce tremante.
"Non ne sarei così sicuro se fossi in te, caro" disse la professoressa Cooman mentre il fuoco traeva
riflessi dai suoi lunghi orecchini di smeraldo. Neville deglutì. La professoressa riprese
tranquillamente.
"Quest'anno ci occuperemo dei metodi base della Divinazione. Il primo trimestre sarà dedicato alla
lettura delle foglie di Tè. Nel prossimo passeremo alla Lettura della Mano. Comunque mia cara"
disse, rivolgendosi d'un tratto a Calì Patil, "guardati da un uomo coi capelli rossi".
Calì scoccò uno sguardo stupito a Ron, che era dietro di lei, e allontanò la sedia.
"Nell'ultimo trimestre " proseguì la professoressa Cooman, "passeremo alla Sfera di Cristallo, se
avremo finito con i Presagi di Fuoco, naturalmente. Purtroppo, a febbraio avremo la classe decimata
da una brutta epidemia di influenza. Io stessa perderò la voce. E attorno a Pasqua, uno di noi ci
lascerà per sempre."
Un silenzio carico di tensione seguì questa dichiarazione, ma la professoressa Cooman parve non
notarlo. "Tu, cara" disse a Lavanda Brown, che era la più vicina e si ritrasse sulla sedia, "ti dispiace
passarmi la teiera d'argento, quella grande?"
Lavanda, sollevata, si alzò, prese un'enorme teiera dallo scaffale e la pose sul tavolo davanti alla
professoressa Cooman."Grazie, cara. Ah, fra l'altro, quella cosa che temi... succederà venerdì 16
ottobre". Lavanda prese a tremare. "Ora voglio che formiate delle coppie. Prendete una tazza dallo
scaffale, venite da me e io la riempirò, poi sedetevi e bevete; bevete finché non rimangono solo i
fondi. Fatteli roteare per tre volte con la mano sinistra, poi rovesciate la tazza sul piattino, aspettate
che il tè rimasto coli via e passate la vostra tazza al compagno per la lettura. Interpreterete i disegni
consultando le pagine 5 e 6 Svelare il Futuro. Io girerò fra di voi e vi darò una mano. Oh, caro"
esclamò afferrando il braccio di Neville che si stava alzando, "dopo che avrai rotto la prima tazza,
vorresti essere così gentile da prenderne una col disegno blu? Sono piuttosto affezionata a quelle
rosa".
34
Neville, in effetti, non aveva ancora raggiunto lo scaffale quando si udì un tintinnio di ceramica
infranta. La professoressa Cooman si avvicinò al ragazzo, gli tese paletta e scopino e disse : "Una di
quelle blu, caro, se non ti dispiace... grazie..."
Quando Harry e Ron ebbero riempito le loro tazze, tornarono al tavolo e cercarono di bere in fretta
il tè bollente. Fecero roteare i fondi come aveva detto la professoressa Cooman, poi voltarono le
tazze e se le scambiarono.
"Bene" disse Ron, mentre aprivano i libri alla pagina 5, "che cosa vedi nella mia?"
"Un mucchietto di roba marrone bagnata" rispose Harry.
L'aroma intenso del fumo lo aveva reso sonnolento e intontito."Aprite le vostre menti, cari, e
lasciate che i vostri occhi vedano al di là del concreto!" disse la professoressa Cooman nella
penombra.
Harry cercò di riscuotersi dal torpore.
"Bene, nella tua c'è una specie di croce tutta storta ..." disse consultando Svelare il Futuro. "Vuol
dire che dovrai affrontare prove e sofferenze, mi dispiace, ma c'è una cosa che potrebbe essere il
sole... aspetta... vuol dire grande gioia... quindi soffrirai ma poi sarai molto felice..."
"Il tuo Occhio Interiore ha bisogno di una bella visita, dammi retta " disse Ron, ed entrambi
soffocarono le risate mentre la professoressa Cooman guardava dalla loro parte.
"Ora tocca a me..." Ron scrutò l'interno della tazza di Harry, la fronte aggrottata per lo sforzo.
"C'è un grumo che assomiglia a una bombetta" disse ."Forse andrai a lavorare al Ministero della
Magia..." Rigirò la tazza dall'altra parte.
"Però visto da qui assomiglia più a una ghianda... Cosa vuol dire?" Studiò il libro. "Una fortuna
inaspettata, oro a sorpresa.
Ottimo, così puoi prestarmene un po' e qui c'è un'altra cosa" disse girando di nuovo la tazza "che
sembra un animale... si, se quella è la testa... sembra un ippopotamo... no, una pecora".
La professoressa Cooman si avvicinò mentre Harry scoppiava a ridere.
"Fammi vedere, caro" disse a Ron in tono di rimprovero, curvandosi per prendergli la tazza di
Harry. Tutti tacquero, in attesa.
La Professoressa Cooman guardò dentro la tazza, facendola ruotare in senso antiorario.
"Il falco... caro tu hai un nemico mortale."
"Ma questo lo sanno tutti" disse Hermione con un sussurro un po' troppo forte . La professoressa la
fissò. "Bè, e così" insistette Hermione." Tutti sanno che Harry... Lei-sai-Chi."
Harry e Ron la guardarono con un misto di stupore e ammirazione. Non avevano mai sentito
Hermione rivolgersi in quel tono a un professore.
La professoressa Cooman decise di non ribattere. Abbassò i grandi occhi sulla tazza di Harry e
riprese a farla ruotare.
"Il bastone... un agguato. Oh, caro questa non è una tazza benigna..."
"Credevo che fosse a bombetta" disse Ron imbarazzato.
"Il teschio... pericolo sul tuo cammino, caro..." tutti fissavano esterrefatti la professoressa Cooman,
che sprofondò in una poltrona vuota, colla mano scintillante posata sul cuore e gli occhi chiusi.
"Caro ragazzo... povero caro ragazzo... No... è meglio non dire niente... No... non chiedermi
niente..."
"Che cosa c'è, professoressa?" chiese Dean Thomas all'improvviso. Si erano alzati tutti e lentamente
avevano circondato il tavolo di Harry e Ron, avvicinandosi alla professoressa Cooman per guardare
nella tazza di Harry.
Gli occhi dell'insegnante si spalancarono in maniera teatrale. "Mio caro" disse, "è il Gramo".
"Il cosa?" chiese Harry. Non era l'unico a non aver capito.
Dean Thomas alzò le spalle e Lavanda Brown lo guardò perplessa, ma quasi tutti gli altri si
portarono le mani alla bocca, orripilati."Il Gramo, mio caro, il Gramo!" esclamò la professoressa
Cooman, stupita che Harry non avesse capito.
"Il cane fantasma gigante che infesta i cimiteri! Caro ragazzo, è un presagio... il peggior presagio di
morte!"
Harry sentì una stretta allo stomaco.
Quel cane sulla copertina di Presagi di Morte al Ghirogoro, il cane nella penombra in Magnolia
35
Crescent... anche Lavanda Brow si portò le mani alla bocca.
Tutti fissavano Harry: tutti tranne Hermione, che si era alzata alle spalle dell'insegnante. "Non mi
sembra che assomigli a un Gramo" disse con voce piatta.
La professoressa Cooman fissò Hermione con crescente antipatia. "Mi perdonerai se te lo dico, cara,
ma sento pochissima Aura attorno a te. Pochissima sensibilità agli echi del futuro".
Seamus Finnigan inclinò la testa da una parte all'altra.
"Sembra un Gramo se lo guardi così" disse strizzando gli occhi fin quasi a chiuderli, "ma visto da
qui sembra più un asino" disse piegandosi a sinistra.
"Avete finito di decidere se devo morire o no?" disse Harry cogliendo tutti, anche se stesso, di
sorpresa.
Ora nessuno sembrava aver voglia di guardarlo.
"Credo che per oggi ci fermeremo qui" disse la professoressa Cooman con la sua voce più velata
"Si... vi prego di portar via le vostre cose..." In silenzio, i ragazzi riportarono le tazze all'insegnante,
presero i libri e li riposero nelle borse. Perfino Ron evitava lo sguardo di Harry. (...)
36
I Buddenbrook
Thomas Mann
(...) Il signor Stengel - dalle tasche del suo panciotto spuntava sempre una mezza dozzina di matite
meravigliosamente appuntite - portava una parrucca rosso volpe e un mantello aperto, color bruno
chiaro, che gli arrivava fin quasi alle caviglie; aveva certi collettoni che salivano fino alle tempie, ed
era un sottile, che amava le distinzioni filosofiche, come per esempio:
- Tu devi fare una linea, figliolo, e che cosa fai? Fai un tratto! - Diceva lina invece di linea.
Oppure, a un fannullone: - Tu resti in quarta non degli anni, ma, vorrei dire, per anni! E diceva quaata invece di quarta, e non anni ma quasi onni...
Quel che gli piaceva di più era insegnare nell'ora di canto la bella canzone La verde foresta; in
quelle occasioni un paio di scolari dovevano andare nel corridoio e quando il coro intonava: Allegri
andiamo per campi e per prati... bisognava che ripetessero pianissimo l'ultima parola, come l'eco.
Ma quando questo compito toccava a Christian Buddenbrook, a suo cugino Jürgen Kröger o al suo
amico Andreas Gieseke, il figlio del comandante dei pompieri, quelli invece di far risuonare la
tenera eco buttavano giù per le scale la cassa del carbone, e alle quattro dovevano poi restare in
reclusione nell'appartamento del signor Stengel. Là però non si stava affatto male. Il signor Stengel
aveva dimenticato tutto e ordinava alla governante di servire agli scolari Buddenbrook, Kröger e
Gieseke una tazza di caffè, una per ciascuno, si badi; dopo di che li lasciava andare...
In realtà gli eccellenti dotti che, sotto la sovranità cordiale di un vecchio direttore umano e fiutator
di tabacco, adempivano al loro ufficio sotto le volte dell'antica scuola - era stata un convento - erano
persone innocue e bonarie, concordi nel ritenere che la scienza e l'allegria non si escludano a
vicenda, e desiderose di lavorare con piacere e benevolenza.
Nelle classi medie c'era un ex predicatore che insegnava il latino, un certo pastore Hirte, un uomo
lungo, con le basette castane e gli occhi vispi, per il quale era una gioia della vita la coincidenza fra
il suo nome e il suo titolo; e non si stancava mai di far tradurre la parola "pastor". La sua
espressione favorita era "sconfinatamente limitato," né divenne mai chiaro se si rendesse conto del
bisticcio. Ma quando aveva in mente di sbalordire gli scolari, ricorreva all'arte di far rientrare nella
bocca le labbra, in modo che poi scattassero fuori con il rumore di un tappo di champagne. Gli
piaceva andar su e giù per la classe a lunghi passi, rappresentando con straordinaria vivezza a
ciascuno scolaro la sua intera vita futura, all'esplicito scopo di stimolarne un pochino la fantasia. Poi
però passava al lavoro serio, cioè faceva ripetere i versi che egli stesso aveva composto con vera
abilità sulle regole dei complementi - lui diceva: "le regole dei complimenti" - e su tutte le
costruzioni difficili; versi che recitava, calcando il ritmo e la rima con ineffabile senso di trionfo...
(...) "Vai a scuola volentieri?"
"No," rispondeva tranquillamente, con quella franchezza che, di fronte a cose più serie, reputa
inutile mentire in simili questioni.
"No? Eppure si deve imparare: scrivere, leggere, far di conto..."
"E così via," diceva il piccolo Johann.
No, egli non ci andava volentieri in quella scuola, quell'antico convento con il chiostro e le aule
dalle volte gotiche.
Le assenze per malattia e la totale mancanza di attenzione quando i suoi pensieri si perdevano su
qualche accordo armonico o sui misteri ancora indecifrati di un brano musicale che aveva udito da
sua madre e dal signor Pfühl, non lo favorivano certo sulla via delle scienze (...) Il signor Tietge,
l'insegnante di aritmetica, un vecchietto in giacca nera e unta, che aveva lavorato al servizio
dell'istituto già ai tempi del defunto Marcellus Stengel, e che, incredibilmente guercio, cercava di
rimediare con lenti spesse e rotonde come oblò di navi, - il signor Tietge ricordava in ogni lezione
al piccolo Johann come suo padre fosse sempre stato diligente e svelto in aritmetica... Di continuo,
forti accessi di tosse costringevano il signor Tietge a coprire di sputi la pedana della cattedra. (...)
37
I fratelli Karamazov
Fiodor Dostojewskij
(...)All'ora convenuta Kolja si sdraiò fra i binari. Gli altri cinque che avevano accettato la
scommessa, con il fiato sospeso - ma verso la fine, ormai terrorizzati e pieni di rimorso aspettavano ai piedi della scarpata, fra i cespugli.
Finalmente si udì il fragore del treno in lontananza che si allontanava dalla stazione. Dall'oscurità
spuntarono scintillanti due fanali rossi, il mostro si avvicinava sferragliando. Corri, corri via dai
binari!, gridarono i ragazzacci dai cespugli, atterriti, ma era troppo tardi: il treno piombò lì in un
attimo e saettò via di gran carriera.
I ragazzacci si precipitarono da Kolja: questi giaceva immobile. Cominciarono a tirarlo, a
sollevarlo. Ad un tratto Kolja si alzò e scese dalla scarpata senza dire una parola. Giunto di sotto,
dichiarò di aver finto di essere svenuto, per farli spaventare, ma la verità era che aveva davvero
perduto i sensi, come confessò in seguito, molto tempo dopo, alla sua mamma. In questo modo, la
sua fama di "temerario" si consolidò una volta per tutte. Tornò a casa dalla stazione pallido come un
cencio. Il giorno seguente si ammalò di una leggera febbre nervosa, ma di umore era
incredibilmente allegro, contento e soddisfatto. Non si venne a sapere subito dell'incidente, ma
quando tornarono in città la notizia fece il giro della scuola e raggiunse l'orecchio dei superiori. Ma
a quel punto la mammina di Kolja si precipitò a supplicare l'indulgenza dei superiori per il suo
ragazzo e andò a finire che lo stimato e influente insegnante Dardanelov prese le sue parti,
intercedette per lui, e la faccenda fu ignorata come se non fosse mai accaduta.
Questo Dardanelov, uno scapolo ancora giovane, era appassionatamente innamorato della signora
Krasotkina, da molti anni ormai, e già una volta, circa un anno addietro, si era arrischiato, nella
maniera più rispettosa e tremando di paura e delicatezza, a chiederle la mano, ma lei aveva rifiutato
seccamente, ritenendo che accettare la sua proposta sarebbe equivalso a tradire il suo ragazzo, anche
se Dardanelov, in base a qualche misterioso sintomo, forse avrebbe avuto un certo diritto di sognare
di non essere completamente sgradito all'incantevole, ma troppo pudica e gracile vedovella. La folle
birichinata di Kolja sembrava aver rotto il ghiaccio e a Dardanelov, in cambio della sua
intercessione, fu concesso un barlume di speranza - in verità un barlume molto fioco - ma anche
Dardanelov era un campione di purezza e delicatezza e quindi quel barlume gli bastò a renderlo
perfettamente felice, per il momento.
Egli voleva bene al ragazzo, anche se trovava umiliante cercare di ingraziarselo, quindi con lui, a
lezione, era esigente e severo. Ma anche Kolja da parte sua lo teneva a rispettosa distanza: (...) tutti i
suoi compagni erano fermamente convinti che in storia universale Kolja fosse così preparato da
"battere" anche Dardanelov. Infatti, Kolja una volta gli aveva posto la domanda: "Chi fondò
Troia?", al che Dardanelov aveva risposto vagamente parlando di popoli, dei loro spostamenti, delle
trasmigrazioni, della remotezza dei tempi, della mitologia, ma non riuscì a rispondere esattamente
alla domanda su chi effettivamente avesse fondato Troia, cioè proprio quali persone, anzi, chissà
perché, considerava la domanda oziosa e inconsistente. Ma i ragazzi restarono nella convinzione
che Dardanelov non sapesse chi aveva fondato Troia. (...)
38
I miserabili
Victor Hugo
(...)
Nei villaggi dove non c'erano maestri di scuola citava ancora quelli di Queyras: - Sapete come
fanno? - diceva. - Poiché un paesotto di 12 o 15 famiglie non può sempre dar da vivere a un
maestro, hanno dei maestri stipendiati da tutta la valle, i quali percorrono i villaggi e insegnano
stando otto giorni qui, dieci giorni là. Questi maestri vanno alle fiere, dove io li ho visti. Si
riconoscono dalle penne che portano infilate nel nastro del cappello. Quelli che insegnano soltanto a
leggere hanno una penna, quelli che insegnano a leggere e a fare i conti ne hanno due, quelli che
insegnano a leggere a fare i conti e il latino hanno tre penne. Questi ultimi sono considerati dei
grandi scienziati. Ma che vergogna essere ignoranti!
Fate come la gente di Queyras. (...)
39
I ragazzi della via Paal
Ferenc Molnar
(...) Prima ancora che il professor Racz fosse uscito dall'aula, Boka mostrò ai ragazzi di via Paal due
dita, per indicare che l'assemblea avrebbe avuto luogo alle due. Quelli che non appartenevano alla
compagnia li invidiarono vedendoli tutti sull'attenti salutare militarmente. Erano già in procinto di
uscire quando accadde un fatto inaspettato.
Il professore Racz si fermò ai piedi della cattedra e disse: - Aspettate.
Un gran silenzio seguì questa parola. Il professore si tolse di tasca un foglietto, e dopo aver messo
gli occhiali cominciò a leggere i nomi che vi stavano scritti: - Weisz!
- Presente! - rispose l'interpellato.
Il professore continuò: - Richter! Csele! Kolnay; Barabas! Leszik! Nemecsek! Leszik! Nemecsek!
Il professore Racz rimise in tasca il foglietto e disse: - Voi non andrete a casa, ma verrete con me
nella sala dei professori. Devo parlarvi.
(...) Il professor Racz comincò a parlare:
- Si tratta di un'associazione che voi avete formato: l'associazione dello stucco. Chi m'ha dato questa
notizia m'ha anche consegnato l'elenco dei membri dell'associazione. I membri dell'associazione
siete voi, nevvero? Nessuna risposta. Tutti tenevano la testa china sul petto, il che provava che
l'accusa era vera. Il professore continuò: - Andiamo per ordine. Anzitutto voglio sapere chi ha avuto
il coraggio di fondare un'associazione dal momento che io l'ho proibito nel modo più assoluto.
Grave silenzio. Infine una debole voce disse: - Weisz.
Il professor Racz guardò severamente il ragazzo: - Weisz! Non sei capace di dirlo tu?
La risposta suonò tutta modesta: - Sì, sono capace.
- Allora, perché non l'hai detto subito?
A questa domanda il povero Weisz non rispose più.
Il professor Racz accese un sigaro e, dopo aver soffiato il fumo azzurrognolo nell'aria, cominciò a
far domande: - Andiamo per ordine - disse. - Prima di tutto voglio sapere che cosa è lo stucco.
Invece di rispondere, Weisz si tolse di tasca un grosso pezzo di stucco e lo posò sul tavolo. Lo
guardò in silenzio per qualche minuto e poi, con voce appena percettibile, dichiarò: - Ecco, questo è
lo stucco.
- E che cosé lo stucco?
- E una pasta con la quale il vetraio fissa il vetro nella cornice di legno. Il vetraio lo mette sulle
finestre; e noi lo si toglie con le unghie.
- E questo l'hai levato tu dalle finestre?
- No, questo è lo stucco dell'associazione.
Il professore spalancò gli occhi per la meraviglia.
- Ma che cosa significa?
Weisz, che si sentiva un po' più coraggioso, diede le spiegazioni richieste: - Questo stucco è stato
tolto dalle finestre dei membri dell'associazione, e poi la commissione l'ha affidato a me perché lo
conservassi. Prima lo custodiva Kolnay perché era lui il presidente, ma lo faceva sempre seccare
perché non lo masticava mai.
- Come? Bisogna anche masticarlo?
- Certo, altrimenti diventa duro e non si può più schiacciarlo bene. Io invece lo mastico tutti i giorni.
- Ma perché proprio tu?
- Perché nel regolamento dell'associazione sta scritto che il presidente è obbligato a masticare lo
stucco almeno una volta al giorno perché non diventi duro...
(...) Il professore si alzò, e camminando avanti e indietro per la sala, scosse il capo disapprovando.
- Una bella associazione, questo è sicuro! - disse. - Chi era il presidente?
A questa domanda Weisz dimenticò il suo gran dolore e, smettendo di piangere, rispose con
orgoglio: - Io.
40
- E il cassiere?
- Kolnay.
- Dammi i denari che ti sono rimasti.
- Eccoli.
Così dicendo Kolnay si mise le mani nelle tasche, che erano sullo stesso tipo di quelle di Csonakos.
Cominciò a frugarvi e rovesciò il contenuto sul tavolo. Anzitutto posò sul panno verde un fiorino e
quarantadue soldi, due marche da bollo, otto pennini nuovi e una pallina di vetro colorato. Il
professore guardò il denaro e domandò severamente:
- Dove l'avete preso?
- E' quello dei canoni. Ogni membro è obbligato al canone di un soldo per settimana.
- E a che cosa serviva questo denaro?
- Per pagare i canoni. Del resto Weisz non ha accettato neppure lo stipendio di presidente.
- Di quanto era lo stipendio?
- Di cinque soldi per settimana. I francobolli li ho portati io, la cartolina Barabas, le marche da bollo
Richter. Le ha...
I1 professore lo interruppe: - Rubate. Dì pure così, Richter. Rubate.
Dichter abbassò gli occhi. - Le hai rubate?
I1 ragazzo approvò col capo. - Che cosa fa tuo padre?
- L'avvocato. Ma poi l'associazione m'ha fatto rendere le marche da bollo.
- Come? Non capisco.
- Perché io ho rubato a papà le due marche da bollo, ma poi ho avuto paura. Allora l'associazione mi
ha dato una corona per comprare le due marche da bollo e rimetterle sulla scrivania di papà. Ma
papà, proprio nel momento in cui stavo per rimetterle a posto, m'ha sorpreso e m'ha dato due
scoppole...
Il professore Racz chiese:
- Ma perché avete comprato delle nuove marche da bollo? Avreste potuto rendere quelle che
avevate.
- Non era possibile - intervenne Kolnay - perché a tergo c'era già il timbro dell'associazione.
- C'é anche un timbro? Dov'è?
- La guardia del timbro è Barabas. (...)
- Signor professore - disse Barabas. - Ho giurato di custodire il timbro e di difenderlo anche con la
vita.
Il professore si mise in tasca l'oggetto.
- Silenzio! - disse.
Ma Barabas non seppe frenarsi:- Allora -disse con tono risentito - allora, signor professore, anche a
Csele prenda la bandiera.
- C'é anche una bandiera? Dammela! - disse il professore volgendosi a Csele. Il ragazzo si tolse di
tasca una minuscola bandiera che aveva per asta un sottile filo di ferro.
L'aveva fatta sua sorella, che era molto abile nei lavori femminili. La bandiera era bianca, rossa e
verde, e portava una scritta: "Associazione dello stucco. Budapest. Giuriamo di non esere più
schiavi".
- Humm! - disse il professore. - Chi è la persona coltissima che ha scritto "essere" con una esse
sola?
Nessuno rispose. Il professore chiese di nuovo:
- Chi ha scritto questo?
A Csele venne un'idea straordinaria. Pensò che per non far succedere altri guai, benché l'esere
l'avesse scritto Barabas, era bene che il professore non lo sapesse. Perciò rispose con umiltà: - Mia
sorella.
E ingoiò con uno sforzo. Non era una bella azione, ma almeno aveva salvato un compagno...
Il professore non rispose e i ragazzi ne approfittarono per cominciare a parlare senza essere
interrogati: - Signor professore, non è bene che Barabas abbia tradito la bandiera - disse Kolnay
tutto furioso.
Barabas cercò di difendersi. - Ha sempre da dire qualcosa contro di me. Se il timbro è stato preso,
41
vuol dire che l'associazione ha già finito di esistere.
- Silenzio! -intimò il professor Racz ai due litiganti. - L'associazione è sciolta e non voglio più
sentirne parlare. E vi auguro che io non m'accorga di cose del genere per l'avvenire. In condotta
avrete tutti otto. Anzi Weisz avrà sei perché era il presidente!
- Signor professore, - osò far notare Weisz - proprio oggi scadeva la mia nomina. Oggi doveva aver
luogo l'assemblea nella quale sarebbe stata decisa l'elezione di un nuovo presidente.
- E' il nuovo presidente sarebbe stato di nuovo Kolnay - disse Barabas tutto soddisfatto.
- Questo non m'interessa - disse i] professore. - Domani resterete qui fino alle due. Vi dirò io di che
cosa dovrete occuparvi. Potete andare.
- Buongiorno, signor professore - dissero in coro. In quel momento di confusione Weisz allungò la
mano per riprendere lo stucco.
Ma il professore lo redarguì. - E che non senta mai più parlare di associazioni! (...)
42
I viaggi di Gulliver
di Jonathan Swift
(...) Ci sono scuole di vario genere, adatte alle diverse condizioni dei due sessi, con insegnanti che
addestrano i ragazzi a quel tipo di vita che si confà ai loro genitori, sviluppando nel contempo le
loro capacità di inclinazioni. Darò prima qualche notizia degli asili per maschi e quindi di quelli per
femmine. Quelli per maschi di famiglie nobili o elevate sono dotati di maestri saggi e severi
affiancati da uno stuolo di assistenti. Cibo e vestiario sono semplici e privi di ricercatezza. Gli
allievi vengono allevati nel rispetto dei principi dell'onore, della giustizia, del coraggio, della
modestia, della clemenza, della religione e dell'amore per la propria terra; inoltre si affida loro
qualche cosa da fare in ogni ora del giorno, ad eccezione di quando mangiano e dormono. Fino
all'età di quattro anni ci sono degli uomini a vestirli, dopo di che, malgrado la loro elevata
condizione sociale, devono farlo da soli; le donne che svolgono il loro servizio nelle scuole, tutte sui
cinquant'anni, compiono soltanto i servizi più umili. Ai bambini non è concesso di conversare con
la servitù e si divertono in gruppi più o meno numerosi, sempre sotto gli occhi di un maestro o del
suo assistente. In questo modo si impedisce che ricevano le deleterie influenze del vizio e della
follia, alle quali sono sottoposti i nostri bambini. I genitori possono far visita ai figli solo due volte
all'anno e per non più di un'ora; è loro concesso di baciarli solo all'arrivo e alla partenza, mentre il
maestro, presenta questi incontri, impedirà loro di parlare sottovoce al bambino, di usare
vezzeggiativi nei suoi confronti, di portargli regali, giocattoli, dolciumi e roba simile. La retta per il
mantenimento dell'educazione dei figli è a carico dei genitori e, se non viene pagata, se ne delega la
riscossione agli esattori imperiali.
Gli asili per i figli della classe media, di mercanti, commercianti e artigiani sono organizzati, in
proporzione, secondo lo stesso schema; i ragazzi avviati a qualche mestiere, vanno a fare gli
apprendisti all'età di sette anni, mentre i figli dei notabili continuano a studiare fino ai quindici anni,
età che corrisponde a ventuno da noi, ma la vita di collegio si fa meno rigida durante gli ultimi tre
anni.
Negli asili femminili le bambine di nobile famiglia vengono educate come i maschi, con la sola
differenza che vengono vestite da inservienti del loro sesso, sempre al cospetto del maestro e del
suo assistente, finché non siano in grado di farlo da sole all'età di cinque anni. Se qualcuna di queste
inservienti cede alla tentazione di raccontare alle bambine storie paurose o fiabesche, oppure certi
pettegolezzi con le cameriere comunemente divulgano, vengono frustate in pubblico per tre volte,
imprigionate per un anno e confinate vita natural durante nelle più squallide contrade del paese. In
questo modo si insegna alle fanciulle, come ai maschi, a disprezzare la codardia e la frivolezza e a
non curarsi degli ornamenti della persona che non rientrino nella normale decenza e pulizia.
Non ho notato nessuna differenza nell'educazione dei due sessi, ad esclusione degli esercizi fisici
che, per le ragazze, sono meno pesanti di alcune nozioni di economia domestica impartite loro;
riducendo sensibilmente la cultura generale la loro massima è infatti che, fra la gente di rango, una
moglie deve essere sempre una saggia e piacevole compagna (...) Quando raggiungono i dodici
anni, che è l'età del matrimonio per loro, tornano a casa, mentre ai vivissimi ringraziamenti dei
genitori e dei tutori, nei confronti degli insegnanti, si unisce il pianto dirotto delle ragazze che
danno l'addio alle compagne. (...)
43
Il buio oltre la siepe
Harper Lee
(...) Non era ancora finita la prima mattina di scuola, che già miss Caroline Fisher, la maestra, mi
rimorchiava alla cattedra e, dopo avermi picchiato sul palmo della mano con una riga, mi metteva in
piedi, nell'angolo, fino a mezzogiorno.
Miss Caroline aveva appena ventun anni, i capelli di un bel castano chiaro, le guance rosee e lo
smalto delle unghie di un rosso acceso. Portava scarpette con i tacchi alti e un abito a strisce
bianche e rosse: pareva una caramella di menta peperita e ne aveva anche il profumo.
Stava a pensione da miss Maudie Atkinson, che abitava di fronte a noi, una casa più in giù; miss
Maudie le aveva dato la stanza davanti, al piano di sopra, e quando ci aveva presentati a lei, Jem era
rimasto con la testa nelle nuvole per parecchi giorni.
Miss Caroline scrisse in stampatello il proprio nome sulla lavagna e disse:
<<Questo, vedete, significa che io sono miss Caroline Fisher. Sono dell'Alabama del Nord, contea
di Winston.>>
Per tutta la classe si udì un brusio preoccupato: temevamo che miss Caroline fosse stramba come
quelli del suo paese. (Quando l'Alabama si separò dall'Unione, l'11 gennaio 1861, la contea di
Winston si separò dall'Alabama e nella contea di Maycomb lo sapevano anche i bambini).
Per gli abitanti dell'Alabama del Sud, l'Alabama del Nord era un paese che si poteva definire così:
alcool, acciaierie, filande, repubblicani, professori, altra gente venuta dal nulla.
Miss Caroline iniziò il primo giorno di scuola leggendoci una storia di gatti.
I gatti facevano conversazione tra loro, portavano abitini civettuoli e vivevano in una casa calda,
accanto alla stufa della cucina. Quando miss Caroline arrivò al punto in cui la signora Gatta
telefonava al negozio per ordinare dei topi al cioccolato, l'intera classe si dimenava sui banchi,
impaziente, come un cestino di vermi. Evidentemente miss Caroline non capiva che quei
bambinetti, mezzo stracciati, vestiti di cotonina rossa e di tela di juta, che per lo più avevano
trinciato cotone e dato da mangiare ai maiali fin dal giorno che erano stati capaci di camminare,
erano refrattari alla fantasia. Giunta alla fine della lettura, miss Caroline disse:
"Carina, questa storia, vero?"
Poi andò alla lavagna, scrisse in enormi lettere stampatelle e si girò verso la classe,
chiedendo: "C'è nessuno che sa cosa siano?"
Lo sapevano tutti: la maggior parte della classe era ripetente.
Forse scelse me perché sapeva il mio nome; mentre leggevo l'alfabeto le apparve tra le sopracciglia
una linea sottile, e dopo avermi fatta leggere ad alta voce quasi tutte le Prime Letture e le quotazioni
dei titoli sul Bollettino del Mobile, scoprì finalmente che non ero un'analfabeta e mi guardò con
vero disgusto. Mi disse che pregassi mio padre di non insegnarmi più nulla, perché il suo metodo
avrebbe potuto compromettere i miei progressi nella lettura.
"Devo pregare mio padre di non insegnarmi più nulla?" ripetei sorpresa. "Ma non mi ha insegnato
niente, miss Caroline. Atticus non ha tempo di insegnarmi" soggiunsi vedendo che miss Caroline
sorrideva scuotendo la testa, "è talmente stanco, la sera, che sta seduto nel soggiorno a leggere per
conto suo!"
"Se non ti ha insegnato niente, chi è che ti ha insegnato a leggere?" chiese bonaria, miss Caroline.
"Qualcuno deve pur avertelo insegnato: non sarai mica nata leggendo il Bollettino del Mobile!"
"Jem dice di sì. Ha letto un libro dove era scritto che io ero un fringuello marino invece di un
cardellino. Jem dice che il mio vero nome è Jean Louise Bullfinch, che sono stata sostituita in culla
e che in realtà sono una..."
Evidentemente miss Caroline pensò che mentissi.
"Non ci lasciamo trasportare dall'immaginazione, carina" disse. "Oggi pregherai tuo padre di non
insegnarti più niente. E' meglio che tu incominci daccapo, a mente fresca. Gli dirai che da ora in
avanti ci penserò io e che cercherò di rimediare al danno che ha fatto..."
"Al danno che ha fatto?..."
44
"Tuo padre non sa come si insegna ai bambini. E adesso siedi."
Mormorai una scusa e mi ritirai a meditare sui miei delitti. (...)
45
Il circolo Pickwick
Charles Dickens
Il maestro della scuola parrocchiale
C'era una volta in una cittadina di provincia, lontano lontano da Londra, un ometto di nome
Nathaniel Pipkin.
Era il maestro della scuola parrocchiale della cittadina e viveva in un casuccia nella viuzza di High
Street, a dieci minuti di cammino dalla chiesetta. Lo si poteva vedere ogni giorno, dalle nove alle
quattro, intento a insegnare qualcosina ai ragazzini. Nathaniel Pipkin era una creatura innocua, mite,
buona; aveva un naso girato all'insù e le gambe girate all'indentro; sguardo un po' strabico e
andatura un po' zoppicante. Divideva equamente il suo tempo fra la chiesa e la scuola, nella ferma
convinzione che il curato fosse la più brava persona al mondo, la sagrestia la stanza più bella e la
sua scuola la migliore di tutte.
Una volta, una volta soltanto in vita sua, Nathaniel Pipkin aveva visto un vescovo, un vescovo vero,
in carne e ossa, con le braccia infilate in ampie maniche di batista e la testa in un copricapo. Lo
aveva visto camminare e lo aveva sentito parlare a una cresima, e in quella occasione era stato
sopraffatto da tanta devozione e timore reverenziale che, quando il vescovo gli aveva posato la
mano sulla testa, Nathaniel Pipkin era caduto lungo disteso per terra, privo di sensi, ed era stato
trascinato fuori della chiesa, a braccia, dal sagrestano. Era stato un avvenimento di grandissima
importanza, un momento fondamentale nella vita di Nathaniel Pipkin, l'unico che fosse mai occorso
a increspare il tranquillo flusso della sua serena esistenza, finché, un bel pomeriggio, in un attimo di
distrazione non alzò gli occhi dalla lavagna sulla quale stava escogitando un terrificante problema di
somme composte per un monello insolente e non posò lo sguardo sul volto in fiore di Maria Lobbs,
l'unica figlia del vecchio Lobbs, il celebre sellaio che abitava dirimpetto alla scuola.
A dir la verità, gli occhi di Nathaniel Pipkin si erano posati già molte volte prima sul grazioso viso
di Maria Lobbs, in chiesa e altrove, ma mai, come in quel giorno, lo sguardo di Maria Lobbs era
stato così luminoso e le sue gote così colorite.
Nessuna meraviglia quindi che Nathaniel Pipkin non riuscisse a distogliere gli occhi da quel volto;
nessuna meraviglia quindi che madamigella Lobbs, vedendosi fissata da un giovanotto, si ritraesse
dalla finestra alla quale si era affacciata per curiosare, chiudesse i vetri e tirasse giù la tenda;
nessuna meraviglia che subito dopo Nathaniel Pipkin si lanciasse sullo scavezzacollo disobbediente,
gli appioppasse qualche ceffone e gliele desse di santa ragione.
Tutto perfettamente normale e non c'è di che meravigliarsi. (...)
46
Il compito di latino
Montague Rhodes James
(da "Il compito di latino" Nove racconti e una modesta proposta - Sellerio)
Due uomini conversavano in un salotto, rievocando il periodo trascorso in collegio. - Nel nostro diceva A. - avevamo l'impronta di un piede di fantasma sulle scale, assai poco convincente, però. Il
contorno di una scarpa col tacco quadrato, se ben ricordo. La scala era di pietra. Ma non ho mai
sentito raccontare storie al proposito. A pensarci bene, è strano, no? Chissa come mai nessuno ha
pensato a inventare qualcosa su quella impronta. Mah! E sì che i ragazzini hanno una fantasia
sbrigliatissima. A proposito, ecco un ottimo argomento per voi: " Il folclore nei collegi".
Già. Però il materiale è alquanto scarso. Credo che volendo esaminare, per esempio, il ciclo di storie
di fantasmi che si raccontano nei collegi, si scoprirebbe che sono tutte versioni abbreviate di storie
lette nei libri.
Oggi attingerebbero abbondantemente alle varie riviste, "Strand", "Pearson" e roba del genere.
Certo. Ma ai miei tempi non esistevano ancora. Vediamo un po'. Chissà se riesco a ricordare almeno
le storie classiche che ho sentito raccontare. Ah, si. C'era quella casa dove tutta una serie di persone
aveva voluto passare la notte in una certa stanza, e la mattina seguente ognuna, a turno, veniva
trovata inginocchiata in un angolo, appena in tempo per vederla morire dopo aver detto "L'ho
visto".
Non era la casa di Berkeley Square?
Mi pare di sì. Poi c'era la storia dell'uomo che sentiva un rumore nella notte, apriva la porta sul
corridoio, e vedeva qualcuno che si trascinava carponi verso di lui, con gli occhi penzolanti fuori
dalle orbite. E poi c'era ancora... lasciatemi pensare... Ecco! La stanza dove fu trovato un uomo
morto nel letto, con una impronta di ferro di cavallo sulla fronte, e anche sul pavimento sotto al letto
c'erano le stesse impronte. E c'era la signora che mentre chiudeva a chiave la porta della sua camera
in casa di amici dov'era ospite, udì una vocina che diceva: "Adesso siamo chiusi dentro per tutta la
notte". Nessuna di queste storie però aveva una spiegazione o un seguito. Chissà se le raccontano
ancora.
Oh, è probabile. E per di più infarcite di particolari tratti da storie lette nelle riviste, come dicevo.
Voi non avete mai sentito parlare, credo, di un vero fantasma in un collegio, vero? Me lo aspettavo,
e come voi, nessuno che io abbia conosciuto.
Dal modo come lo dite, pare che voi invece...
Per la verità, non ne sono certo. Ma è una cosa che mi è venuta in mente; un fatto accaduto nel mio
collegio, trent'anni fa o giù di lì, e del quale non ho mai avuto la spiegazione...
Il mio collegio era nei dintorni di Londra. Occupava un antico edificio bianco circondato da
bellissimi spazi verdi; c'erano enormi cedri come se ne trovano nei giardini più antichi della valle
del Tamigi, e vecchissimi olmi, nei tre o quattro prati che ci servivano come campi da gioco. Direi
che doveva essere un posto molto piacevole, per quanto sia quasi impossibile che i ragazzi trovino
qualcosa di piacevole in un collegio.
Io ci entrai di settembre, intorno al 1870, e tra i ragazzi che arrivarono con me, ce n'era uno che mi
fu subito simpatico. Era scozzese, e lo chiamerò Mc Leod. Inutile perdere tempo a descriverlo, ciò
che importa è che diventammo subito amici. Non era un ragazzo eccezionale, e non si distingueva
né nello studio né per gli sport, ma per me andava bene.
Il collegio era grande; di regola ospitava dai 120 ai 130 allievi, perciò richiedeva un notevole corpo
d'insegnanti, che venivano cambiati abbastanza spesso. Ero lì forse da sette od otto mesi, quando
arrivò un nuovo professore. Si chiamava Sampson: un tipo robusto, con la barba nera, un bell'uomo.
Devo dire che a noi ragazzi piaceva; aveva viaggiato molto e conosceva delle storie che ci
divertivano durante le passeggiate, tanto che facevamo a gara per stargli vicino ad ascoltare i suoi
racconti. Ricordo anche - santo cielo, credo di non averci mai più pensato da quei tempi - di avergli
visto un portafortuna appeso alla catena dell'orologio. Un ciondolo che un giorno attrasse la mia
attenzione, e che lui mi lasciò osservare da vicino. Ora, a ripensarci, doveva essere una moneta
bizantina. d'oro; su una faccia c'era l'effigie di un imperatore credo, l'altra invece era consunta, tanto
47
che lui viaveva fatto incidere, idea alquanto barbara, le sue iniziali, G.W.S. e una data, 24 luglio
1865. Sì, adesso ricordo; mi aveva detto di averla presa a Costantinopoli, ed era della grandezza di
un fiorino, forse un poco più piccola.
Ebbene, la prima cosa strana che accadde fu questa. Sampson ci insegnava latino. Uno dei suoi
metodi preferiti, e mi pare fosse buono, era quello di farci comporre delle frasi di nostra invenzione
per illustrare di volta in volta le regole che cercava di farci entrare in testa. Naturalmente, per un
ragazzo sciocco era una buona occasione per scrivere frasi impertinenti; ma Sampson sapeva
imporre la disciplina, e a nessuno di noi sarebbe venuto in mente di provarsi a fare dello spirito.
Dunque, quella volta ci stava spiegando come coniugare il verbo "ricordare" in latino e ordinò a
ognuno di noi di comporre una frase con la voce "memini". La maggior parte, si sa, buttò giù
qualche frase banale come "Ricordo mio padre" o "Egli ricorda il suo libro", o cose altrettanto
sciocche; e direi che parecchi combinarono un "memino librum meum", e così via; ma il mio amico
Mc Leod evidentemente stava pensando a qualcosa di più elaborato. Tutti noi avevamo già finito, e
volevamo presentare i nostri fogli per essere poi liberi, perciò qualcuno lo urtò col piede di sotto al
banco, e io, che gli sedevo accanto, gli diedi una gomitata dicendogli di sbrigarsi. Ma pareva che
non mi sentisse.
Diedi un'occhiata sul suo foglio e vidi che era ancora bianco. Allora lo urtai ancora più forte
rimproverandolo perché ci faceva aspettare tutti. La mia sgridata fece effetto; lo vidi sussultare e
parve svegliarsi; poi in gran fretta scarabocchiò un paio di righe e mise il suo foglio insieme agli
altri. Era stato l'ultimo o quasi, e poiché Sampson era occupato a dire il fatto loro ai ragazzi che
avevano scritto "meminiscimus patri meo" e così via, l'orologio batté le dodici e Mc Leod non era
ancora passato; dovette perciò rimanere in classe per far correggere la sua frase. Fuori non c'era
gran che da fare, perciò io rimasi in corridoio ad aspettarlo. Quando finalmente arrivò, camminava
adagio, e capii subito che c'era per aria qualche guaio.
"Allora" gli dissi "quanto ti ha dato?". "Oh, non lo so" mi rispose. "Non molto. Ma credo che
Sampson ce l'abbia con me". "Come mai, gli hai messo giù qualche strafalcione?". "No, no, la frase
era giustissima, da quanto ho capito. Era così: "memento", questo è facile da ricordare, e prende il
genitivo, "memento putei inter quatuor taxos". "Che pasticcio!" dissi io. "Ma che cosa ti è saltato in
mente? Che cosa vuol dire ?". "E proprio questa la cosa più buffa" disse Mc Leod. "Non sono
nemmeno sicuro di che cosa voglia dire. So soltanto che mi è venuta in mente così e l'ho buttata giù.
Mi pare di sapere che cosa significhi, perché prima di scrivere mi son visto come una immagine
davanti agli occhi. Credo che la frase sia: ricorda il pozzo fra i quattro..., che cosa sono quegli alberi
scuri, con le bacche rosse?". "Credo che tu voglia dire il sorbo selvatico". "Mai sentito nominare"
disse Mc Leod. "No, te lo dico io: è il tasso." "E che cosa ti ha detto Sampson ?". "Be', è stata una
cosa curiosa. Appena ha letto, si è alzato, è andato verso il camino ed è rimasto là un bel po',
voltandomi la schiena, senza dire niente. E poi, senza girarsi, mi ha chiesto molto tranquillo: "Che
cosa credi che voglia dire?" Io gli ho detto ciò che pensavo, solo non potevo ricordare il nome di
quello stupido albero; e poi lui ha voluto sapere perché avevo scritto così, e io lì a inventare una
cosa qualunque. Allora lui ha cambiato discorso e mi ha chiesto dove abitavano i miei, e cose del
genere, poi io sono venuto via, ma lui aveva l'aria di stare poco bene".
Non ricordo che altro dicemmo tra noi due in proposito. Il giorno dopo Mc Leod rimase a letto col
raffreddore o qualcosa del genere, e per una settimana non venne in classe. Poi, passò circa un mese
senza che accadesse niente di notevole. Se anche il signor Sampson era stato turbato, come pensava
Mc Leod, non lo dava a vedere. Certo oggi io sono persuaso che nel suo passato doveva esserci
stato qualcosa di molto strano, ma certo non si pretende che dei ragazzi siano tanto acuti da
indovinare problemi del genere.
E poi si verificò un altro incidente simile al primo. Ci era accaduto altre volte d'illustrare in classe
varie regole che avevamo imparato, ma non c'era mai stato niente di eccezionale da dire, se non
quando si facevano degli errori marchiani. Venne il giorno in cui ci toccò passare sotto le forche
caudine di quelle cose orrende che si chiamano frasi condizionali. Ognuno di noi doveva scrivere
una frase che esprimesse conseguenze future. Bene o male, tutti scrissero qualcosa e presentarono i
loro pezzi di carta a Sampson, il quale cominciò a esaminarli. Improvvisamente, si alzò in piedi
facendo uno strano rumore con la gola, e si precipitò fuori da una porta che era proprio accanto alla
48
predella della cattedra. Noi tutti restammo fermi per un paio di minuti, poi, credo che non sia stato
molto corretto, io e un paio d'altri ci avvicinammo alla cattedra per guardare i fogli. Immaginavo
che qualcuno avesse scritto delle impertinenze,
e che Sampson fosse uscito per andare a far rapporto al preside. Comunque, avevo notato che non
aveva preso nemmeno uno dei fogli andandosene via.
Bene, la prima pagina che copriva le altre, sulla cattedra, era scritta in inchiostro rosso, che nessuno
usava, e la calligrafia non era quella di nessuno di noi. Tutti vennero a guardare, Mc Leod e gli altri,
e tutti giurarono e spergiurarono che non era la loro scrittura. Poi, a me venne in mente di contare i
fogli: sulla cattedra c'erano diciassette fogli, e in classe eravamo sedici ragazzi. Mi presi il foglio
scritto in inchiostro rosso, e credo di averlo ancora. Adesso vorrete sapete qual era la frase.
Abbastanza semplice e innocua, mi pare, eccola: "Si tu non veneris ad me, ego veniam ad te", il che
significa, credo: "Se tu non verrai da me, verrò io da te"".
(...) ma c'è un'altra cosa strana. Quello stesso pomeriggio tirai fuori quel foglio dal mio armadietto,
ero certo che si trattava dello stesso foglio perché lo avevo segnato con un'impronta del dito, ma
sopra non c'era più la minima traccia di scrittura o d'inchiostro. L'ho conservato, come ho già detto,
e da allora ho fatto molte prove per vedere se era stato usato dell'inchiostro simpatico, ma senza il
minimo risultato.
E passiamo ad altro. Dopo circa mezz'ora, Sampson riapparve, ci disse che non si sentiva bene, e
che potevamo uscire. Si avvicinò alla cattedra, quasi guardingo, e diede un'occhiata al foglio che
copriva gli altri: io penso che credesse di aver sognato. In ogni caso, non fece domande. Il
pomeriggio era mezza festa, e il giorno dopo, Sampson era di nuovo in classe come al solito. Quella
notte si verificò il terzo e ultimo incidente della mia storia.
Noi due, Mc Leod ed io, dormivamo nell'ala che formava angolo retto con l'edificio centrale dove
era la camera di Sampson, al primo piano. Quella sera la luna era piena, e molto luminosa. Fui
svegliato a un'ora che non saprei precisare, ma doveva essere fra l'una e le due. Qualcuno mi
scrollava forte. Era Mc Leod, e mi parve sconvolto. "Vieni! Su, vieni!" mi disse. "C'è un ladro che
vuole entrare dalla finestra di Sampson". Appena mi fu possibile parlare, gli domandai: "Ma perché
non ci mettiamo a gridare e svegliamo tutti gli altri?". "No, no - disse lui - "non so bene chi sia.
Vieni a vedere e non far chiasso". Naturalmente andai a vedere e naturalmente non c'era nessuno.
Ero alquanto seccato, e avrei trattato volentieri Mc Leod come si meritava, soltanto, non saprei dire
perché, mi pareva che veramente nell'aria ci fosse qualcosa d'insolito, qualcosa che mi faceva
ringraziare il cielo di non essere solo in quel frangente. Eravamo ancora lì alla finestra e stavamo
guardando: io gli chiesi che cosa avesse visto o sentito. "Non ho sentito proprio niente" mi disse.
"Ma appena cinque minuti prima che ti svegliassi, ero qui alla finestra e vedevo un uomo, seduto o
inginocchiato, sul davanzale di Sampson. Guardava dentro e mi pareva che facesse dei cenni". "Che
tipo era ?". Mc Leod si strinse nelle spalle. "Non lo so. Ma posso dirti una cosa: era maledettamente
magro e pareva che fosse tutto bagnato, e poi..." si guardò intorno e abbassò la voce, come se non
gli piacesse sentire le proprie parole "non sono affatto sicuro che fosse vivo" concluse.
"Continuammo a bisbigliare ancora per un poco, poi finalmente ognuno s'infilò nel proprio letto.
Nessun altro si svegliò o si mosse, nel dormitorio. Dopo, forse, riuscimmo a dormire ancora un
poco, ma il mattino seguente eravamo alquanto malandati.
E il giorno dopo, il signor Sampson se n'era andato, nessuno seppe dove, e credo che da allora non
si sia più trovata traccia di lui. Ripensandoci, una delle cose più strane mi parve il fatto che né Mc
Leod né io aprimmo mai bocca con chicchessia su questo fatto. Si capisce, nessuno mai ci fece
domande in proposito, ma se anche avessimo dovuto rispondere, sono propenso a credere che non
avremmo potuto aprir bocca: pareva che non riuscissimo a parlarne.
(...) Il seguito della storia potrà essere giudicato molto banale; ma un seguito c'è bisogna pur farlo
conoscere. Il racconto aveva avuto più di un ascoltatore, e alla fine dello stesso anno, o dell'anno
seguente, uno di essi si trovava in una casa di campagna in Irlanda. Una sera, in salotto, il padrone
di casa vuotò un cassetto pieno di oggetti vari. "Dunque - disse all'ospite - voi che ve ne intendete di
antichità, ditemi un po' che cos'è questo". Il mio amico aprì l'astuccio e vi trovò una catenina d'oro
con appeso un ciondolo. Diede un'occhiata all'oggetto e poi si tolse gli occhiali per esaminarlo più
da vicino.
49
" Qual è la storia di questo ciondolo?" domandò. "Oh, alquanto curiosa. Avete visto il boschetto di
tassi, nel giardino? Bene, un paio d'anni fa, ho fatto pulire il pozzo che si trova nella radura, lì in
mezzo, e indovinate che cosa abbiamo trovato?" "Non mi direte che ci avete trovato un cadavere?"
disse l'ospite con una strana sensazione di nervosismo.
"Proprio così, invece. Anzi, vi dirò di più: ne abbiamo trovati due".
"Santo Iddio! Proprio due? E c'era qualche indizio di come hanno potuto finire là dentro? Avete
trovato questo ciondolo vicino ai corpi?"
"Certo. Fra gli indumenti ridotti a brandelli di uno dei due cadaveri. Vi assicuro che la scena era
agghiacciante: uno dei cadaveri teneva l'altro avvinghiato con le braccia. Dovevano essere là sotto
da trent'anni o più,
comunque da molto, molto tempo prima che noi venissimo ad abitare qui. Potete immaginare se non
ci siamo affrettati a riempire di nuovo il pozzo! Ma riuscite a capire che cosa c'è inciso su quella
moneta d'oro?"
"Credo di riuscirci" disse il mio amico, alzando la moneta verso la luce, ma già aveva letto senza
troppa difficoltà. "Mi pare che sia: G.W.S., 24 luglio 1865".
50
Il comune amico
Charles Dickens
(...)In realtà era un tipo di scuola-pasticcio insuperabile nel suo genere di maledetta confusione dove
alunni di ogni tipo e di ogni colore, neri, grigi, rossi e bianchi, facevano confusione tutte le sere. E
particolarmente ogni domenica sera. Perché allora, tutta una classe di infelici bambini, veniva
affidata al più noioso, al peggiore dei volonterosi insegnanti, a quello che nessuno degli adulti
avrebbe sopportato. Questi si piantava davanti a loro in qualità di giustiziere capo, e si giovava
dell'opera di un ragazzo (volontario, per modo di dire) in qualità di aiuto giustiziere. Come e
quando si fosse adottato per la prima volta il sistema per cui un ragazzo stanco e disattento doveva
essere richiamato all'ordine con l'intervento di una mano che lo colpiva più o meno amorosamente,
o come e quando il primo ragazzo, per così dire volontario, avesse visto per la prima volta quel
sistema in opera, infiammandosi di sacro zelo, qui non importa. Ma è certo che la funzione del
giustiziere capo era di tener duro, e quella dell'assistente era di piombare sui bambini che
dormivano, o sbadigliavano, o si muovevano, o piangevano, e richiamarli all'ordine con un colpo
più o meno amorevole sulla faccia del disgraziato: talvolta con una mano, come per applicargli
l'unguento per le basette; talvolta con ambo le mani, come se si trattasse di applicargli i paraocchi. E
così si tirava avanti in gran confusione, in questa classe, per tutta un'ora che non finiva mai, il
maestro biascicava per un'ora (Mieeei caaari bambiiini) diciamo, per esempio, sulla bellissima
visita al sepolcro; e ripeteva la parola sepolcro (molto in uso tra i bambini, si sa) cinquecento volte
senza mai dire una volta che cosa significasse; e il volontario, per modo di dire, richiamava
all'ordine a destra e a sinistra, a mo' di infallibile commento; e tutti quei bambini accaldati ed
esausti, in quell'ambiente particolarmente propizio, si scambiavano il morbillo, la scabbia, la tosse
convulsa, la febbre e i disturbi di stomaco, come se fossero stati riuniti proprio per quello scopo.
(...)
51
Diario di una maestrina
di Maria Giacobbe
(...)
Fonni: scolari all'aggiudu
(......) Sotto un velo di pioggia ecco Fonni! Le case sembrano schiacciate dalle grandi tegole
rugginose. Porte e finestre sprangate; di vivo c'è solo la pioggia. Mi sembra però che intorno mille
occhi sospettosi mi osservino, come se lì, dietro quei muri sghembi, si vivano intensamente ore di
attesa.
All'improvviso, nella piazzetta deserta, è accanto a me una bimba di nove o dieci anni.
- Siete la nuova maestra? Venite con me!
Mi accompagna a casa correndomi innanzi sotto la pioggia e il vento. E' scalza, i piedini violacei
affondano senza esitazione nei rigagnoli turgidi e impetuosi. La veste di cotone completamente
inzuppata, aderendole al corpicino magro, si rivela come il suo unico indumento. Ho un assurdo
senso di colpa e rabbrividisco sotto il mio caldo impermeabile. Mentre la padrona mi prepara una
scodella di caffelatte la bimba, asciugandosi alla fiamma del camino, mi dice, col tono grave ora
noncurante degli adulti, che non è parente della signora ma che va da lei tutti i giorni per "aggiudu"
e che, nonostante ciò, quest'anno potrà frequentare la scuola. Alla mia classe, una terza femminile,
mi presenta la più anziana delle maestre. Trenta visi mi guardano con curiosità e ascoltano con
indifferenza ciò che la collega mi va dicendo:
- Le tratti come si deve, sa! Sono cattive e maleducate. La povera maestra dell'anno scorso è dovuta
andare in pensione prima del previsto, per colpa loro. Le hanno talmente mancato di rispetto che è
dovuta scappare, proprio così, scappare le dico!
Io, confusissima, mi affanno a dire: - Spero che saranno buone, andremo d'accordo, saranno buone
certamente.....
Ma lei non mi ascolta: - La frusta ci vuole, dia retta a me, la frusta!
Agita la destra come se davvero fra le dita tenga uno staffile. E mi lascia. Salgo sulla cattedra. la
preghiera, l'appello. Passano così i primi momenti, quelli della maggiore confusione. Ma dopo, che
fare?
Piove e non si può iniziare con una passeggiata in campagna. Bisogna stare fra le quattro pareti. Ma
le bambine non hanno libri, non quaderni, non penne. Non so come intavolare una conversazione.
Tento qualche domanda, mi rispondono tutte in coro. Sto in silenzio un momento, dimenticano la
mia presenza e si mettono a chiacchierare e a ridere tra loro, un chiasso altissimo che ho paura arrivi
alle altre aule e faccia pensare male di me ai colleghi più esperti. Non voglio che le bambine si
accorgano del mio sgomento. Racconto una fiaba e la faccio durare il più a lungo possibile poi le
rimando a casa con la raccomandazione di portare, l'indomani, l'occorrente per scrivere. Il primo
esperimento di composizione è disastroso. Scritture orribili, ortografia e sintassi del tutto particolari
e poco somiglianti alle italiane. Ideuzze banali : "lasquola è bela" "lamama e brava".
Siamo a scuola già da quindici giorni ma ancora non sono riuscita a quadagnarmi la simpatia delle
alunne. Sono la maggior parte ripetenti, ripetenti recidive, veterane della scuola. Tra titolari e
supplenti devono aver cambiato decine di insegnanti e io, nuova del mestiere, devo sembrare loro
goffa e priva di imponenza. Le tratto con ostinata gentilezza, ma, forse proprio per questo, mi
disprezzano. Forse la mia cortesia fa sì che mi sentano diversa da loro e distante. Esse stesse, un
giorno, con una certa aria di protezione e superiorità mi consigliano di picchiarle se voglio ottenere
qualcosa:
- L'altra maestra aveva un bastone grosso così, - mi dicono con fervore, - e anche a casa,
"all'aggiudu", ci picchiano quando lo meritiamo!
Venendo meno ai propositi maturati durante gli anni di studio mi lascio convincere e, a freddo,
distribuisco qualche schiaffo. Dapprima è il silenzio, poi una risata serpeggia e esplode. non so dare
gli schiaffi e nel darli cerco di non fare male. Per tutte le quattro ore di lezione non doveva far altro
che raccontare quelle terribili fiabe nordiche in cui streghe crudeli, fanciulle bellissime e
perseguitate, principi azzurri cavalcanti magnifici cavalli dagli zoccoli doro, piccoli uomini bizzarri
52
e deformi, popolano boschi colmi d'ombra e di mistero. Allora finalmente tacciono, non tutte, ché
alcune non sanno ascoltare. La loro fantasia è assetata di cose forti e paurose, è la tragedia che le
interessa, il lieto fine di prammatica le delude. Ma il programma ? E' un incubo. Ad esso si
aggiungono le questue. Una circolare del direttore ci invita a parlare in classe della tragedia che ha
colpito intere regioni italiane e a raccogliere tra gli scolari offerte "pro alluvionati". Le bambine
sono povere e non riescono neppure ad avere quaderni a sufficienza, tuttavia penso sia utile, dal
punto di vista educativo, suscitare la solidarietà. Per rendere viva la lezione porto a scuola dei
giornali che, documentandosi con numerose fotografie, descrivono gli effetti dell'alluvione nelle
zone più devastate. Raccolgo le bambine attorno alla cattedra e commento le illustrazioni con le
parole che la drammaticità dell'argomento suggerisce .
Guardano, ascoltano, sembrano commosse. Certo che la loro fantasia è colpita soprattutto dagli
aspetti più appariscenti della tragedia: i gruppi isolati sui tetti, i viveri lanciati dagli aerei, i ponti
tesi dai balconi attraverso le strade.
E' arrivato il momento psicologico in cui credo di poter dire che sarebbe bello dimostrare ai più
disgraziati, con offerte "anche di una sola lira", la nostra solidarietà . Due o tre bambine mi
consegnano alcune lirette lungamente custodite entro le copertine dei libri. Ma una, guardandomi
fisso, quasi con sfida , dice: - Anche a noi la pioggia ha devastato l'orto e nessuno ci ha dato niente.
Lo stato d'animo che io avevo creato era distrutto, la commozione cade come una vela strappata. E
strano, non mi riesce di sentire diversamente da loro. Sono ormai giorni e giorni che tento
inutilmente di raccogliere le trenta lire della pagella. Ma oggi, a costo di non fare lezione, devo
poter consegnare al direttore la somma al completo. Pochissime mi hanno portato i denari il primo
giorno, alcune ieri dopo le mie insistenze, oggi quasi nessuna e non ho neppure la metà della
somma. Tutte mi rispondono: - Mamma dice che oggi non ha le trenta lire , quando le avrà me le
darà.
Non ci credo e le rimando a casa ma solo due, tornando, non mi ripetono la solita frase. Non riesco
a credere che in una casa, sia pure di poveri, di poverissimi, non ci siano trenta lire e vorrei
insistere. Mi dicono con fermezza che sarebbe inutile a meno che io non permetta che paghino la
pagella con un uovo. L'idea mi pare accettabile e presto la cattedre prende l'aspetto di un banco di
mercato. Finalmente tutte hanno pagato! No, manca ancora una quota. Anna. La cerco con lo
sguardo e mi accorgo che è più pallidina del solito e, rimpicciolendosi tutta, cerca di rendersi
invisibile. La chiamo e la rimando a casa. Vorrei poter umiliare la mamma che per estrema avarizia,
suppongo, non vuole pagare la pagella.
- Non abbiamo galline - mi dice a bassa voce - mamma non ha soldi e babbo è nel Belgio per
lavorare.
Ho pena della bambina ma sento di dover educare questa gente che non capisce l'importanza della
scuola e della pagella e rimando Anna dalla mamma. Per ben tre volte. Quando la piccola sta per
piangere io finalmente le credo e mi vergogno.
(...)
A un tratto mi sono accorta di aver conquistato le bambine. Son sicura, non so bene perché, che ora
mi vogliono bene; di certo si bisticcerebbero con chiunque per difendermi. Forse in questo
cambiamento c'entra in qualche modo il mio abito nuovo, o forse la mia malattia dei giorni scorsi o,
forse, i graziosi quadretti e i cartelloni che, per facilitare l'apprendimento delle scienze e della
storia, ho appeso alle pareti dell'aula. Cominciano a scrivere un po' meglio, più corrette e meno
banali. Davanti al foglio bianco non hanno più quella diffidenza che le costringeva a mentire con
<pensierini> estranei ai loro interessi e alla loro sensibilità. Scrivono della primavera che è
finalmente arrivata, dei fiori che a mazzi portano in classe dalla campagna, della neve che comincia
a sciogliersi dopo che per mesi e mesi ha coperto orti e pascoli, del battesimo del fratellino nuovo,
della gallinella che si è lasciata mangiare la zampa dal maiale, dei quadri che ornano l'aula, della
loro vita di servette. Cominciano anche a capire i problemi aritmetici e fanno a gara a chi ne risolve
di più e meglio. Per fortuna il Patronato scolastico ci ha messo a disposizione un numero sufficiente
di quaderni a quadretti e le bambine non devono preoccuparsi di chiederli a casa. Alcune hanno già
risolto tutti i problemi che io ho preparato per loro. Altre sono più lente ma ormai questo esercizio è
per tutte uno sport e devo addirittura frenare la loro passione aritmetica. Devo pensare che al
53
principio dell'anno molte non sapevano fare l'addizione e che la divisione ne ha fatto piangere
parecchie per vedere quanta strada abbiamo percorso.
ORGOSOLO
Oggi è il primo giorno di lezione. Ho due scolaresche di prima: devo supplire la collega con la
quale mi alternerò nell'aula. Cinque ore, sessanta bambini. Non riesco neppure a ricordare i nomi.
Alcuni piangono e vorrebbero tenere ancora la mano della mamma o della sorella che li ha
accompagnati. Finalmente riesco a sistemarli ai loro posti. Le gambe penzolano dai sedili troppo
alti.
C'è nell'aria un silenzio e una immobilità innaturali, so che non potrà durare perciò devo
approfittarne.
Attendono qualcosa da me, comincio a parlare ma ho appena aperto la bocca che un bambino
scoppia in un pianto convulso. Sembra che la mia voce lo spaventi, invoca la mamma e mi inonda
di lacrime.
Vorrei farlo accompagnare a casa ma, come un naufrago alla sua tavola, si attacca ostinatamente al
banco. E' disperato e io mi sento del tutto incapace di aiutarlo o di liberarmene. Ma ora, quasi
all'improvviso, tace, il piccolo incosciente, e ha il coraggio di sorridermi tra le lacrime.
Gli altri in tanto sono in rivoluzione. Abbiamo già detto la preghiera ma per calmarli non trovo di
meglio che rincominciare con il segno della croce e l'Avemaria.
Approfitto del relativo silenzio che segue alla preghiera per attaccare con Cappuccetto Rosso. In
principio mi ascoltano con molta attenzione, seguono affascinati il movimento delle mie labbra. Ma
poco dopo, e Cappuccetto non aveva ancora incontrato il lupo, si annoiano e cominciano ad agitarsi:
tanto vale che mi per dia per vinta: di ciò che dico in italiano non capiscono assolutamente nulla:
dovevi parlare il loro dialetto ma purtroppo non ne sono capace. Si ripete una situazione che avevo
conosciuto a Fonni, ma qui peggiorata perché non ho interpreti. Mi soccorre Giovanni, un monello
scalzo e magrissimo con grandi occhi adulti e un ciuffo biondo impastato di polvere. Si è fatto
notare dal suo primo ingresso; è arrivato solo ed entrando ha lanciato un <buongiorno> spavaldo
quasi provocatorio.
Poi ha preso posto sotto la lavagna e non l'ho potuto convincere a sedersi sul banco. A tutte le mie
esortazioni, a tutti i miei ragionamenti, a tutti i miei ordini rispondeva con una punta di disprezzo:
"Bae! Bae!" (Ma va! Ma va!). Adesso all'improvviso, quasi si sia accorto del mio smarrimento,
propone di raccontare lui una storia.
(...) Ho dei bellissimi gessi colorati e disegno alla lavagna. Dico i nomi degli oggetti rappresentati,
li faccio ripetere, ne dico i colori, invento piccole fiabe di poche parole e molti disegni. Cerco di
render viventi nella fantasia dei bambini le figure di cui la lavagna va popolandosi. Invito i bambini
a disegnare sui loro quaderni, nessuno mi ubbidisce, dicono che non sanno. Solo un ripetente si
azzarda a tracciare qualche linea. Devo insegnare fra quali dita si deve tenere la matita e in quale
mano. Ma hanno paura, non vogliono sporcare il quaderno nuovo di cui vanno fieri. Dopo molto
ottengo che segnino dei puntini sugli incroci delle righe. E già in primo passo per esercitare la mano
e l'occhio. Una settimana è passata. I progressi sono scarsi: io ho imparato i nomi degli alunni e loro
hanno imparato i nomi degli oggetti dell'aula e i verbi più comuni. In quanto al disegno e alla
scrittura siamo ancora lontani dal principio. Il <disegno spontaneo> non è spontaneo affatto, i
bambini sino ad ora non hanno dimostrato alcun desiderio di <<esprimersi per immagini>>. Hanno
orrore della matita e non vogliono usarla. Si divertono però a vedermi disegnare alla lavagna. Mi si
affollano intorno e mi ordinano: - L'automobile! Il carro! Il postale! L'aeroplano! -. Ho successo.
(...)
54
Il dono di Asher Lev
Chaim Potok
(...) Ci fermammo davanti a una porta in un corridoio silenzioso.
Dallo spioncino vidi di sfuggita una donna giovane e bruna, di una bellezza folgorante, seduta
dietro la cattedra, facce di bambine tutte in fila e un'alta parete di finestre bagnate di pioggia.
"E meglio che lei sappia", disse Rav Greenspan, "che l'insegnante non è ebrea. E' una delle migliori
docenti della scuola. Tutti i nostri insegnanti sono o ladover o non ebrei. Da noi non insegnano
ebrei non osservanti. Danno un cattivo esempio ai bambini. Venga, la stanno aspettando". Aprì la
porta e io lo seguii nell'aula. La porta si chiuse con il sibilo smorzato del freno idraulico.
Tutte le teste nella classe si girarono a guardarmi. L'insegnante si alzò in piedi dietro la cattedra.
Indossava una blusa avorio con le maniche lunghe e il collo alto e una gonna blu.
Come a un segnale, tutte le scolarette si alzarono in piedi.
"Signorina Sullivan", disse Rav Greenspan. "Questo è Asher Lev".
"E' per me un onore conoscerla", disse. Non mi porse la mano.
"Sedete pure", disse Rav Greenspan alla classe.
Con un leggerissimo scalpiccio, le bambine si affrettarono a sedersi. La signorina Sullivan si
allontanò dalla cattedra e, andando a mettersi davanti alla parete di finestre, proiettò la sua
silhouette contro la luce grigia del mattino piovoso. I suoi capelli neri, tirati indietro, erano raccolti
in uno chignon. Rav Greenspan rimase in piedi davanti alle scolarette. "Buongiorno, ragazze.
Voglio presentarvi il signor Asher Lev, che è un pittore molto famoso. Molti suoi quadri si trovano
in musei americani ed europei. E' cresciuto in questo quartiere e ha frequentato questa yeshivah. Ha
accettato di venire qui, questa mattina, a parlarci di arte e delle sue opere, e a rispondere alle
domande che vorrete porgli."
Il signor Lev Rav Greenspan si allontanò dalla cattedra e andò a mettersi verso il fondo dell'aula,
lungo la parete di fronte alle finestre. Si appoggiò alla parete e incrociò le braccia sul petto. Lì in
piedi, in fondo all'aula, parve all'improvviso un'oscura presenza di vigile guardiano.
Ero solo di fronte alla classe.
Una classe di venticinque, tutte ragazze; la sezione maschile della yeshivah era nell'edificio
adiacente. Sedevano in quattro file, ciascuna a un banco singolo. Nella quinta fila c'erano tre adulti,
due dei quali donne; il terzo era un uomo anziano dalla barba grigia in completo, cravatta e cappello
scuri. Ricordai di averlo visto in casa di mio zio Yitzchok durante la settimana di lutto, ma non
sapevo chi fosse. Rocheleh era seduta in seconda fila. Nel pesante silenzio dell'aula, udii
l'improvviso levarsi e smorzarsi di un clacson da un'auto che passava. Vidi che tutte mi guardavano,
e io non sapevo cosa dire.
Faceva caldo nell'aula e avevo cominciato a sudare sotto il berretto da pescatore. Fuori, la pioggia
continuava a cadere e gli angoli delle finestre erano appannati. Guardai le file di volti. Ragazzine
con la coda di cavallo, le trecce, i riccioli corti, la riga da un lato, la ciocca lunga trattenuta da una
molletta. Facce sottili, facce allungate, facce rettangolari, facce grassocce e occhialute, facce
rotonde, facce cilindriche, facce triangolari, facce pallide, facce arrossate. C'era Rocheleh, in attesa.
Una ragazzina aveva i capelli rossi e sedeva allungata sulla sedia, come se temesse di essere vista.
Mi stava osservando con gli occhi azzurri spalancati. Occhi, occhi in attesa. Comincia come faresti
con un disegno.
Comincia con un punto. Un altro punto. Una linea. Una verità chiara e immediata.
"Buongiorno", mi sentii dire, mi schiarii la gola e ripetei, "Buongiorno", e in qualche modo andai
avanti. "Tanto tempo fa ho studiato in questa yeshivah e ringrazio Dio per avermi mantenuto in vita
in modo da essere qui con voi oggi. Studiavo l'inglese, scrivevo dei temi e passavo molto tempo a
guardare dalla finestra. Ma un artista deve dire la verità e la verità è che, più di ogni altra cosa,
disegnavo sui quaderni e facevo arrabbiare i miei insegnanti". Un'onda di risate trattenute serpeggiò
per la classe. "I miei compagni mi consideravano strambo. Non facevo granché d'altro. Disegni,
55
disegni, disegni. Qualcuna di voi disegna, disegna, disegna tutto il tempo?". Tutte tacevano. "Ma
tutte disegnano qualche volta".
Tutte fecero segno di sì con il capo.
"Che cosa disegnate"?
Immediatamente le mani si alzarono. Le interpellai tutte, una dopo l'altra. "Il Seder di Pesach".
"La succah, il luvov e il lethrog".
"Le danze con la Torah".
"I giochi con gli archi e le frecce per Lag Bò Omer".
"Case".
"Giardini".
"Moshe Rabbenu sul Monte Sinai".
"La tavola del Sabato".
"Noè nell'arca".
"Molto bene", dissi. "Mi pare che disegnate tutte. Ora ditemi una cosa. Perché disegnate?".
Di nuovo le mani schizzarono su. Rocheleh sedeva in silenzio accanto alle finestre e osservava. "Mi
diverte" disse una ragazzina. "Mi piace", disse un'altra.
"Ce lo fa fare l'insegnante", disse una terza.
Risolini serpeggianti per l'aula, la signorina Sullivan sorrise.
Rav Greenspan rimase appoggiato alla parete sul fondo, con le braccia incrociate sul petto robusto.
Le due donne e l'uomo nell'ultima fila ascoltavano impassibili. Rocheleh non aveva ancora alzato la
mano. La pioggia scrosciava sul viale; pareva che fosse calata la notte. "Perché gli insegnanti ve lo
fanno fare?", domandai.
"Ci aiuta a ricordare meglio le cose", disse una bambina in prima fila.
"Sì. Che altro?". Silenzio. "Non succede nient'altro quando disegnate? Pensateci un momento.
Chiunque di voi". Esitante, dalla seconda fila, una ragazzina con le trecce: "Penso che a volte mi
aiuta a esprimere i miei sentimenti".
"In che modo?".
"Quando sono arrabbiata adopero un sacco di rosso".
"Nessun'altra di voi disegna i suoi sentimenti?".
"Qualche volta se non mi piace qualcuno gli faccio una faccia brutta", disse una ragazzina non
lontana da Rocheleh. Le due donne nell'ultima fila si scambiarono un'occhiata.
"E se disegni qualcuno che ti piace?", domandai.
"Cerco di farlo carino".
"A nessun'altra di voi capita di disegnare i suoi sentimenti?". Silenzio. Un rivolo di sudore mi scese
come un insetto lungo la spina dorsale. Avrei voluto appoggiarmi alla lavagna dietro di me e
grattarmi la schiena. Il silenzio si protrasse. Alcuni bambini si mossero a disagio sulla sedia. Che
altro? Pensa. Pensa. Due punti. Una linea. Forma. Spazio. Il piano bidimensionale. Colore. Un
quadro. I dipinti alle pareti dello zio Yitzchok. Cèzanne, Renoir, Matisse, Bonnard, Chagall, Utrillo,
Soutine.
"Tutti i disegni sono uguali?", domandai.
" No!", risuonò nell'aula. "In che cosa sono diversi?".
"Alcuni sono migliori degli altri", disse la ragazzina seduta di fronte a me. "Perché sono migliori?",
le domandai.
"Sono migliori. Sono più reali".
"Sono più veri", disse una seconda ragazza.
"Vuoi dire che sembrano delle fotografie?".
"Proprio così", disse la seconda. "Siete tutte d'accordo che un disegno che assomiglia a una
fotografia è migliore di uno che non gli assomiglia?" Tra tutte le teste che assentivano, vidi
Rocheleh; era l'unica dell'aula a scuotere il capo. Ma non disse nulla. "Volete dire che un disegno
così", estrassi un gessetto arancione dalla scatola che avevo comprato in cartoleria e, con gesti
rapidi, disegnai sulla lavagna una rappresentazione infantile di un ariete: zampe sottili e goffe,
corpo e testa sproporzionati, corna asimmetriche, "è meno vero e meno reale di un disegno così?".
In un'unica linea ininterrotta, disegnai i contorni realistici di un ariete, poi con il gessetto
56
ombreggiai il ventre dando l'illusione della tridimensionalità.
Le scolarette proruppero all'unisono in un "Sì".
"E che cosa ne dite di quest'altro ariete".
Disegnai un'astrazione lineare dell'ariete, senza ombreggiatura, sottolineando i contorni delle cosce
posteriori per enfatizzarne la forza e abbellendo la maestosa, alta spirale delle corna. "Quale ariete è
più vero!".
Silenzio. Vidi i loro giovani occhi spalancati passare da un disegno all'altro, quello infantile, quello
realistico, quello astratto e vidi anche il sorrisino sul volto di Rocheleh.
"Non sono tre modi diversi di vedere lo stesso oggetto?", dissi.
"Il primo è il modo di vedere di un bambino. Il secondo è un modo di vedere realistico, come lo
vedrebbe una macchina fotografica, per esempio. E il terzo", indicai il disegno astratto, " be', che
cos'è il terzo?". "E' più strano", disse una ragazzina.
"Perché è strano?", domandai.
"Sembra strano", disse. "Non ho mai visto un ariete come quello".
"Certo. Allo zoo".
"Quante di voi hanno visto un ariete come questo?".
Quasi tutte le mani si alzarono. "Avete visto tutte questo tipo di ariete?", dissi ."Così piccolo? Di
questo colore?".
Un mormorio di perplessità corse per la classe.
"Che cos'è questo?", domandai indicando il disegno. "Esattamente", dissi. "è un disegno. E
assomiglia moltissimo a quello che un ariete appare ai nostri occhi. Ora, che differenza c'è tra
questa visione esterna dell'ariete e il terzo disegno dell'ariete?".
Una ragazzina in quarta fila, lunghi capelli bruni, occhi scuri, labbra sottili alzò la mano. "Il terzo
disegno è una visione interna dell'ariete" "Che cosa vuol dire interna?". Non rispose. "Chi ha fatto il
disegno?" . "L'ha fatto lei", disse." È la sua visione interna".
"Sì. Come si chiama questo tipo di visione interna? C'è un termine importantissimo che conoscete
tutte". Un silenzio carico di tensione e l'ansiosa ricerca della chiave che schiude il mistero. Aspettai
un momento. "Qualcuno vuole provare?"
Scrutai tra le file di facce voltate in su. In fondo all'aula le due donne, l'uomo con la barba grigia e
Rav Greenspan parevano tutti ipnotizzati, gli occhi fissi su di me, in trepidante attesa. Contro i vetri
delle finestre si stagliava la silhouette della signorina Sullivan, occhi sgranati, un vago sorriso
stampato sulle labbra. Un ariete.
Avevo visto un ariete allo zoo. Mentre passeggiavo con Devorah e i bambini? Fra tutti gli animali
che avrei potuto disegnare, perché avevo scelto un ariete?
Rocheleh alzò la mano.
Poi la ragazzina coi capelli rossi e l'aria timorosa, seduta quasi sul fondo, alzò la mano esistente e
feci cenno a lei.
"E' un interpretazione", disse.
"Sì", dissi. "Esatto. E' un'interpretazione. Adesso ditemi una cosa. Quale grande interprete studiate?
Non di disegni ma di parole".
Ci fu un altro silenzio.
"Lo portate con voi", dissi. "lo studiate ogni giorno. È il migliore, il più chiaro di tutti gli interpreti".
"Rashi!", gridarono una decina di voci. Una di queste era la voce di Rocheleh.
"Ditemi un'altra parola per interprete?"
"Commentatore", gridarono alcune voci .
"Rashi è l'unico commentatore?".
"No!".
"Chi sono gli altri?
"Ibn Ezra ".
"Ramban".
"Rashbam".
"Sono tutti uguali?", domandai.
"No!".
57
"Hanno tutte le stesse idee?".
"No!"
"Che cosa interpretano?"
"La Torah"
"Tutti interpretano la stessa cosa . Ma vedono parti di essa in modo diverso, vero?".
"Sì!"
"Perché li stampiamo nello stesso Chummash? Perché? Perché non ne stampiamo uno solo? Perché
non stampiamo solo Rashi?
"Nel Chummash che usiamo in classe c'è solo Rashi", disse una ragazza, esitante. "Ma nel
Chummash di mio fratello ci sono tutti gli altri".
"Anche nel Chummash della sinagoga ci sono gli altri", disse la ragazza coi capelli rossi dal fondo
della classe.
"Perché stampiamo tutti i commentatori?", domandai di nuovo.
"E' più interessante", disse una ragazza.
"Come si fa a scegliere quale lasciar fuori?", domandò un'altra.
"Bisogna stampare tutti quelli buoni. Mio fratello dice che è entusiasmante averli tutti".
Sia ringraziato Iddio per tuo fratello, pensai. "Molto bene. Sì. L'arte nasce quando una persona che
sa disegnare passa da questo", indicai il secondo disegno "a questo". Indicai il terzo. "Quando si
interpreta, quando si guarda il mondo coi propri occhi. C'è arte quando l'oggetto che viene visto si
mescola all'interiorità della persona che lo vede. Se ne risulta un modo nuovo e entusiasmante di
vedere un vecchio oggetto, be', è interessante, non vi pare? Lì comincia l'arte seria. Ecco, adesso vi
mostro cosa intendo".
Cancellai gli arieti. Per un istante osservai attentamente la signorina Sullivan: zigomi alti, naso
diritto e sottile, viso ovale, occhi scuri, capelli scuri raccolti in uno chignon. "Questi sono i tre modi
diversi in cui tre grandi artisti moderni avrebbero visto e disegnato la stessa persona. Il primo si
chiama Matisse".
Scrissi il suo nome sulla lavagna. Sopra il nome, con una linea continua di gesso azzurro, disegnai il
volto della signorina Sullivan.
Sgorgò, immediatamente riconoscibile, dal gesso sulla lavagna. Tutta la classe si agitò,
mormorando di sorpresa nel riconoscerla.
"Il secondo artista si chiama Modigliani".
Scrissi il nome alla lavagna e con il gesso rosso disegnai il volto della signorina Sullivan, il collo
lungo, dei zigomi esageratamente alti e gli occhi a mandorla, sottolineando nella cilindricità del
collo il fascino e la raffinatezza che avvertivo nei suoi modi. "Il terzo artista è Picasso.
Quanti di voi hanno sentito parlare di Picasso?". Le mani si alzarono. "Bene. Quasi quanti hanno
sentito parlare di Asher Lev".
Rav Greenspan si unì alla risata generale.
Scrissi il nome dello Spagnolo alla lavagna e disegnai la signorina Sullivan con l'ocra, come un
tempo lui aveva dipinto Gertrude Stein: solida, scolpita, iberica, una creatura di pietra più che di
carne, ma con occhi che penetravano il futuro più lontano.
Da sopra la spalla vidi che la signorina Sullivan fissava il disegno a bocca aperta.
"E' stata lei a volermi qui, signorina Sullivan. Il potere dell'arte, signorina Sullivan. Sulle sue
giovani, belle carni..." (...)
58
Il grande Meaulnes
Alain Fournier
(...) Alle due del pomeriggio, l'indomani, l'aula del Corso Superiore è chiara, in mezzo al paesaggio
gelato, come una barca sull'oceano. Non c'è odore di salamoia o di unto come su un battello da
pesca, ma di aringhe arrostite sulla stufa e di stoffa strinata perché qualcuno, rientrando, s'è scaldato
troppo da vicino.
La fine dell'anno è ormai vicina e sono stati distribuiti i quaderni per i compiti. Mentre il signor
Seurel scrive i problemi alla lavagna, c'è un silenzio dubbio, incrinato da conversazioni a voce
bassa, da piccoli gridi soffocati, da frasi appena incominciate, tanto per spaventare il compagno di
banco: "Signor maestro! Lui mi..."
Il signor Seurel pensa ad altro, mentre copia i problemi. Di tanto in tanto si volta a lanciare
un'occhiata insieme severa e distratta. Allora per un secondo quel tramestio sornione smette del
tutto, per riprendere subito, da principio basso basso, come un ronfo sordo.
Solo io sto zitto, in mezzo a tutta questa agitazione. Sono seduto all'estremità di uno dei banchi del
quartiere dei più giovani, vicino alla vetrata, e mi basta alzarmi un poco per vedere il giardino,
laggiù il ruscello poi i campi.
Ogni tanto mi alzo in punta di piedi e guardo con ansia verso la fattoria della Buona Stella. Fin
dall'inizio della lezione mi sono accorto che Meaulnes non è rientrato dopo la ricreazione di
mezzogiorno. Anche il suo compagno di banco deve essersene accorto, però non ha detto ancora
nulla, troppo occupato dal compito. Ma non appena alzerà il capo, la notizia si spargerà per tutta
l'aula e qualcuno, come al solito, si metterà a gridare a voce alta le prime parole della frase:
"Signor maestro! Meaulnes...
So che Meaulnes se ne è andato. Diciamo meglio: sospetto che abbia tagliato la corda. Subito dopo
il pranzo, deve aver saltato il muretto per gettarsi attraverso i campi, passare il ruscello al vecchio
ponticello e arrivare alla Buona Stella. Avrà chiesto la cavalla per andare a prendere i Charpentier.
In questo momento è là che e fa attaccare.
La Buona Stella, laggiù, dall'altra parte del ruscello, sul versante della costa, è una grande fattoria
nascosta d'estate dagli olmi e dalle querce del cortile, dalle siepi verdi; dà su un sentiero che mette
capo da un lato alla strada per la stazione, dall'altro a un sobborgo del paese. Dentro gli alti muri
sorretti da contrafforti che sprofondano nel letame, la grande fabbrica feudale in giugno scompare
sotto il fogliame e dalla scuola si ode soltanto, al tramonto, il rotolare dei carri e le grida dei vaccari.
Ma oggi vedo dalla
finestra, attraverso gli alberi spogli, il muro grigio del cortile, la porta d'ingresso e quindi, fra
tronconi di siepe, una striscia del viottolo incanutito dal gelo che porta alla strada della stazione
seguendo il ruscello.
Nulla ancora si muove, in questo limpido paesaggio d'inverno; niente è ancora cambiato.
Qui il signor Seurel ha finito di copiare il secondo problema. Di solito ne assegna tre: se oggi, per
combinazione, ne desse due solamente, risalendo subito in cattedra si accorgerebbe dell'assenza di
Meaulnes. Allora manderebbe due ragazzi in paese a cercarlo, che lo scoverebbero certo prima che
la cavalla sia attaccata...
Il signor Seurel, dopo aver copiato il secondo problema, lascia cadere il braccio affaticato. Poi, con
mio gran sollievo va a capo e ricomincia a scrivere dicendo: "Questo, poi, è un giochetto da
ragazzi..."
... Due sbarrette nere, che spuntavano dal muro della Buona Stella, certo le due stanghe alzate di un
carretto, sono scomparse. Sono sicuro ora che laggiù si prepara la partenza di Meaulnes. Ecco la
cavalla che si affaccia con la testa e il pettorale fra i due pilastri dell'ingresso, poi si ferma, mentre,
senza dubbio, sistemano nella parte posteriore del carretto un altro sedile per i viaggiatori che
Meaulnes dovrebbe riportare. Finalmente cavalla e carretto escono adagio dal cortile, spariscono un
momento dietro la siepe, ripassano con andatura sempre lenta sul tratto di sentiero brinato che
59
appare tra due mozziconi della cinta. Riconosco nella figura nera che regge le briglie, un gomito
negligentemente appoggiato sulla banda del carro, come i contadini, il mio compagno Agostino
Meaulnes.
Un momento, e tutto sparisce dietro la siepe. Due uomini rimasti fermi sul portone della Buona
Stella per veder partire il carretto, ora si consultano con crescente eccitazione: l'uno, facendo
portavoce con le mani, si decide a chiamare Meaulnes e poi a staccare qualche passo di corsa sul
sentiero, alla sua volta... Ma la carretta ha raggiunto la strada della stazione, ormai dal sentiero non
debbono più vederla, e l'atteggiamento di Meaulnes cambia di colpo. Diritto come un auriga, un
piede puntato avanti, scuotendo le briglie a due mani lancia la bestia al gran galoppo e dilegua di là
dalla salita. Sul viottolo, l'uomo che chiamava ha ripreso a correre; l'altro galoppa attraverso i
campi, a quanto pare verso casa nostra. Di li a qualche minuto, proprio mentre il signor Seurel
lascia la lavagna strofinandosi le mani per pulirle dal gesso e tre voci all'unisono gridano dal fondo
dell'aula "Signor maestro! Il gran Meaulnes se ne è andato!" l'uomo dal camiciotto turchino è alla
porta, la spalanca e cavandosi il cappello domanda: "Scusi, signore, lei ha autorizzato quell'allievo a
chiedere la carretta per andare a Vierzon a ricevere i suoi genitori? C'è venuto il dubbio..."
"Assolutamente no," risponde il signor Seurel.
Di colpo, in aula, il pandemonio. I tre che stanno più vicini alla porta e che di solito hanno il
compito di scacciare a sassate le capre e i porci che entrano in cortile, a brucare l'erba storna, sono
schizzati via. Al picchio brutale dei loro zoccoli ferrati sul pavimento dell'aula tien dietro, fuori, un
rumore soffocato di passi che macinano la sabbia e slittano stridendo alla curva del cancelletto
aperto sulla strada. Tutti gli altri s'ammucchiano alle finestre: alcuni sono montati sui banchi per
vedere meglio.
Troppo tardi: il gran Meaulnes è scappato. "Andrai lo stesso alla stazione con Moucheboeuf," mi
dice il signor Seurel, "Meaulnes non conosce la strada per Vierzon, si smarrirà agli incroci... (...)
60
Il giornalino di Gian Burrasca
Vamba
(...) 5 Novembre.
In questi giorni non ho avuto un minuto di tempo per scrivere nel mio caro giornalino, e anche oggi
ne ho pochissimo perché ho da fare le lezioni. Proprio così. Si sono riaperte le scuole, e io ho messo
giudizio e voglio proprio studiare sul serio e "farmi onore", come dice la mamma. Con tutto questo
non posso esimermi di mettere qui, nel giornalino delle mie memorie, il ritratto del professore di
latino che è così buffo, specialmente quando vuol fare il terribile e grida:
- Tutti zitti! Tutti fermi! E guai se vedo muovere un muscolo del viso!...
Per questo noialtri, fin dai primi giorni gli s'è messo il soprannome di "Muscolo" e ora non glielo
leva più nessuno, campasse mill'anni!
(...) 6 Dicembre.
Oggi è tornato il babbo, la mamma e l'Ada, tutti di cattivissimo umore. (...) Io ieri avevo portato a
scuola una boccettina d'inchiostro rosso che avevo trovato sulla scrivania del babbo... e in questo mi
pare non ci sia nulla di male.
Io ho sempre detto che sono un gran disgraziato, e lo ripeto.
Infatti guardate: io porto a scuola una bottiglietta d'inchiostro rosso proprio nel giorno in cui alla
mamma del Nelli viene in mente di mettergli quella po' po' di golettona inamidata; e lei mette al suo
figliuolo quella golettona proprio nel giorno in cui a me è venuto il capriccio di portare a scuola una
bottiglietta d'inchiostro rosso. Basta. Non so come mi è venuta l'idea di utilizzare la goletta del
Nelli, la quale era così grande, così bianca, così luccicante... e intinta la penna dalla parte del
manico nell'inchiostro rosso piano piano
perché il Nelli non sentisse, gli ho scritto sulla goletta questi versi:
Tutti fermi! Tutti zitti
Che se vi vede Muscolo
Siete tutti fritti!
Poco dopo il professor Muscolo ha chiamato il Nelli alla lavagna, e tutti leggendo su quella bella
goletta bianca scritti questi tre versi in un bel color rosso hanno dato in una grande risata. Da
principio Muscolo non capiva, e non capiva nulla neppure il Nelli, proprio come l'altra volta quando
gli messi la pece sotto i calzoni che gli rimasero attaccati sulla panca. Ma poi il professore lesse i
versi e diventò una tigre. Andò subito dal Preside il quale, al solito, venne a fare un'inchiesta. Io nel
frattempo avevo fatto sparire la boccettina dell'inchiostro rosso nascondendola sotto la base di legno
del banco; ma il Preside volle far la rivista delle cartelle di tutti noi che stavamo di posto dietro al
Nelli (cosa insopportabile perché l'andare a frugare nella roba degli altri è proprio un modo di
procedere degno della Russia) e nella mia trovò la penna col cannello tinto di rosso.
- Lo sapevo che era stato lei! - mi disse il Preside - come fu lei a metter la pece sotto i calzoni dello
stesso Nelli... Va bene ! Tanto va la gatta al lardo...
E per questa cosa mi ha fatto rapporto. (...)
61
Il ladro e il suo maestro
Jacob e Wilhelm Grimm
C'era una volta un uomo che voleva far imparare un mestiere al figlio; va in chiesa a domandare a
Nostro Signore che cosa fosse meglio. Dietro l'altare c'era il sagrestano che dice: "Il mestiere del
ladro! Il mestiere del ladro"! Allora egli va a casa e dice al figlio che deve imparare a fare il ladro:
"Glielo ha suggerito Nostro Signore". E parte con lui per cercare qualcuno che conosca il mestiere.
Cammina un'intera giornata e arriva in un gran bosco, dove c'è una casina e dentro una vecchietta.
Dice il padre: "Non conoscete per caso qualcuno che sappia l'arte del ladro"?. "Potete imparare
benissimo qui, mio figlio ne è maestro". Allora egli parla con il figlio e gli chiede se davvero sa fare
il ladro. Il maestro dice: "Istruirò vostro figlio. Tornate fra un anno, e se lo riconoscerete non voglio
nessun compenso, ma se non lo riconoscerete, dovrete darmi duecento scudi".
Il padre torna a casa e il figlio impara bene l'arte degli stregoni e dei ladri. Trascorso l'anno, il padre
si incammina e piange, perché non sa come fare a riconoscere il figlio. Mentre va e piange, gli viene
incontro un omino che dice: "Perché piangete, siete così afflitto"?.
"Oh" risponde "un anno fa ho lasciato mio figlio da un ladro perché ne imparasse il mestiere; questi
mi ha detto di tornare dopo un anno, e se non avessi riconosciuto mio figlio, avrei dovuto dargli
duecento scudi, mentre se lo avessi riconosciuto non avrei dovuto dargli niente. Adesso ho tanta
paura di non riconoscerlo e non so dove trovare il denaro".
Allora l'omino gli dice di prendere un pezzetto di pane e di andare a mettersi sotto il camino: "Là,
sopra la spranga, c'è una gabbietta con dentro un uccellino che guarda fuori: è vostro figlio". Il
padre va e getta un pezzo di pane davanti alla gabbia, allora viene fuori l'uccellino e lo guarda. "Oh!
Sei qui, figlio mio"? dice il padre.
Il figlio è tutto contento di rivedere il padre, ma il maestro dice:
"Ve l'ha detto il diavolo, come riconoscere vostro figlio"!
"Andiamo, babbo"! dice il ragazzo. Il padre ritorna a casa con suo figlio; per strada passa una
carrozza e il figlio dice: "Mi tramuterò in levriero grigio e vi farò guadagnare molto denaro".
Il signore grida dalla carrozza: "Buon uomo, volete forse vendere il cane"?
"Sì" dice il padre.
"Quanto volete"?
"Trenta scudi".
"Ehi, buon uomo, è una bella somma, ma è un cane così bello che lo prenderò ugualmente". Il
signore fa salire il cane in carrozza ma, dopo aver fatto un tratto di strada, il cane salta fuori dal
finestrino: non era più un levriero ed era tornato da suo padre. Se ne vanno insieme a casa. Il giorno
dopo c'è mercato nel villaggio vicino e il giovane dice a suo padre: "Mi muterò in cavallo;
vendetemi, ma quando mi vendete toglietemi la cavezza, altrimenti non posso più riprendere
l'aspetto umano".
Il padre porta il cavallo al mercato, ed ecco arrivare il maestro del figlio che compra il cavallo per
cento scudi; ma il padre si scorda di togliergli la cavezza. L'uomo va a casa con il cavallo e lo mette
nella stalla. Arriva la serva e il cavallo dice: "Toglimi la cavezza, toglimi la cavezza"!.
La serva si ferma e borbotta: "Sai forse parlare"?.
Va e gli toglie la cavezza; allora il cavallo diventa un passero e vola fuori dalla porta, e il maestro
diventa anche lui un passero e gli vola dietro. S'incontrano e si sfidano, ma il maestro perde, si butta
in acqua e diventa un pesce. Anche il giovane si tramuta in pesce, si sfidano di nuovo e il maestro
perde.
Si trasforma in pollo mentre il giovane diventa una volpe e con un morso stacca la testa al maestro.
Così quello è morto e morto rimane. (...)
62
Il libro delle vergini
Gabriele D'Annunzio
Le vergini
(...) I discepoli tornarono: fu la prima volta una mattina del marzo nascente. Giuliana s'era levata dal
letto; stava seduta su la sponda, col calore del sole alla nuca ed alli omeri. Nella stanza si sentiva
l'odore agro dell'aceto che Camilla aveva versato nei calamai muffiti; e dalle finestre raramente il
vento recava li effluvi delle viole già fiorite su l'arco. Fu allora una irruzione d'infanzia nella stanza.
Fu prima sull'uscio un sospingersi tumultuoso di piccole teste che volevano sollevarsi le une su le
altre per vedere, poi una esitazione, una timidità, una specie di meraviglia ingenua dinanzi alla
maestra pallida pallida e scarna che i discepoli riconoscevano a pena. Ma Giuliana sorrideva, sotto
un turbamento improvviso di tutto il suo sangue; Giuliana li chiamava a sé, confondeva i loro nomi
che le si affollavano alle labbra e tendeva loro le mani. A uno, a due, a tre, i bimbi si avanzavano,
volevano prenderle le mani per metterci la bocca sopra, ridicevano le parole di augurio imparate a
casa, ingoiando per la furia le sillabe.
- No, no, non più! - esclamava Giuliana, sopraffatta, ma abbandonando le mani a quelle bocche
tiepide e molli. Si sentiva quasi mancare.
- Camilla, tienili, tienili.
Ogni bimbo recava un dono: erano fiori, erano frutta.
Le violette avevano subito sparso il profumo nell'aria, e in quel profumo, in quella luce tutte quelle
faccie infantili invermigliate dal buon sangue plebeo sorridevano.
Poi la scuola, nell'altra stanza, cominciò. La prima classe diceva a voce alta le vocali e i dittonghi,
la seconda sillabava; e su quel coro chiarissimo a tratti si levava l'ammonimento di Camilla.
- La, le, li, lo, lu...
Nelli intervalli di silenzio, si udiva Matteo Puriello picchiare su le suola o il telaio della Jece
sbattere.
- Va, ve, vi, vo, vu...
Allora il fastidio oppresse Giuliana.
La monotonia de' rumori e delle voci le dava al capo una pesantezza ingrata, le conciliava il sonno,
mentre ella voleva essere desta, mentre ella sentiva ancora intorno a sé la respirazione dei fanciulli,
il soffio giocondo di quelle vite.
- Bal, bel, bil, bol, bul...
Prese i fiori, li mise in un bicchiere pieno d'acqua per conservarli. Li fiutò poi lungamente. Stette
con le narici tra quel fresco, chiudendo li occhi, raccogliendosi tutta in quel peccato d'olfatto.
- Gra, gre, gri, gro, gru...
Una gran nuvola bianca velò il sole. Giuliana si accostò alla finestra, si sporse al davanzale per
guardar giù nella piazza. Di fronte, Donna Fermina Memma in una roba rosata stava su'l balcone tra
i vasi dei garofani; e un gruppo di uffiziali passava sotto a lei ridendo e facendo un tintinnìo di
sciabole su'l lastrico.
Più in là, nel giardino pubblico le piante di lilla erano su'l fiorire, la punta del gigantesco pino si
piegava al vento.
Dalla cantina di Lucitino usciva Verdura, l'eterno ubriaco, barcollando e vociferando. Giuliana si
ritrasse: era la prima volta, dopo tanto, che si affacciava su la piazza. Le parve di essere in alto in
alto, guardando in giù; la prese una leggera vertigine. - Nar, ner, nir, nor, nur...
Il coro dentro seguitava, ancora, ancora, ancora.
- Pla, ple, pli, plo, plu...
Giuliana si sentiva soffocare, venir meno, a quella tortura: i suoi poveri nervi indeboliti cedevano. Il
coro seguitava, al ritmo della bacchetta di Camilla battuta su'l tavolino, implacabile.
- Ram, rem, rim, rom, rum...
- Sat, set, sit, sot, sut...
Allora un impeto subitaneo di singhiozzi squassò Giuliana, l'abbatté su'l letto. Ella singhiozzava.
63
così, bocconi, a braccia aperte, premendo la faccia su i guanciali, senza potersi frenare.
- Tal, tel, til, tol, tul... (...)
64
Il maestro dei ragazzi
di Giovanni Verga
(...) La mattina, prima delle sette, si vedeva passare il maestro dei ragazzi, mentre andava
raccogliendo la scolaresca di casa in casa.(...) Donna Mena, la merciaia, gli faceva trovare il suo
Aloardo, già bell'e ripulito, a furia di scapaccioni, e il maestro amorevole e paziente, si trascinava
via il monello, che strillava e tirava calci. Più tardi, prima del desinare, tornava rimorchiando
Aloardino tutto inzaccherato, lo lasciava sull'uscio del negozio, e ripigliava per mano il bimbo con
cui era venuto la mattina. Così passava e ripassava quattro volte al giorno, prima e dopo il mezzodì,
sempre con un ragazzetto svogliato per mano, gli altri sbandati dietro, d'ogni ceto, d'ogni colore, col
vestitino attillato alla moda, oppure strascicando delle scarpacce sfondate; però tenendosi accosto,
invariabilmente le scolare che stavano più vicino di casa, sicché, ogni mamma poteva credere che il
suo figliuolo fosse il preferito. Le mamme lo conoscevano tutte; dacché erano al mondo l'avevano
visto passare mattina e sera, col cappelluccio stinto sull'orecchio, le scarpe sempre lucide, i baffi
come le scarpe, il sorriso paziente e inalterabile nel viso disfatto di libro vecchio; senza altro
distacco che il vestito mangiato dal sole e dalla spazzola, sulle spalle un po' curve.
(...)La scuola era un grande stanzone imbiancato a calce, chiuso in fondo da un tramezzo che
arrivava a metà dell'altezza, e al di sopra lasciava un gran vano semicircolare e misterioso, il quale
dava lume a un bugigattolo che vi era dietro. Accanto all'uscio vedevasi il tavolinetto del maestro,
coperto da un tappetino ricamato a mano, e sopra tanti altri lavori fatti di ritagli:
nettapenne, sottolume, e un mandarino di lana arancione, colle sue brave foglioline verdi, causa
d'infinite distrazioni agli scolari. L'altro ornamento della scuola, sulla larga parete nuda dietro il
tavolino, era una cornicetta di carta traforata, opera industre della stessa mano, che conteneva due
piccole fotografie ingiallite, i ritratti del maestro e sua sorella, somiglianti come due gocce d'acqua,
malgrado i baffetti incerati dell'uno, e la pettinatura grottesca dell'altra: gli stessi pomelli scarni che
sembravano sporgere fuori dalla cornice, la stessa linea sottile delle labbra smunte, gli stessi occhi
appannati, quasi stanchi di guardare perennemente, dal fondo dell'orbita incavata, lo sbaraglio delle
seggiole scompagnate per la scuola; e tutt'in giro la tristezza delle pareti bianche, macchiate in un
canto dalla luce scialba della finestra polverosa che dava nel cortiletto.
Di buon mattino, appena il falegname accanto principiava a martellare udivasi bisbigliare due voci
sonnolente nel bugigattolo oscuro, e poi si illuminava il vano al di sopra del tramezzo. Allora, dietro
la finestra appannata, vedevasi salire la fiamma del focolare annidato sotto quattro tegole sporgenti
dal muro, e il fumo denso che stagnava nel cortiletto cieco. In fondo allo stanzino la sorella del
maestro intanto cominciava a tossire, dall'alba.
Egli andava a prendere le scarpe appoggiate allo stipite dell'uscio,
l'una accanto all'altra, coi tacchi in alto, e si metteva a lustrarle amorosamente,
mentre faceva bollire il caffè, ritto innanzi al fuoco, col bavero del pastrano sino alle orecchie.
In seguito toglieva dal fuoco la caffettiera, sempre colla mano sinistra, per pigliare colla destra la
chicchera senza manico dell'asse inchiodata accanto al fornello, la risciacquava nel catino fesso
incastrato fra due sassi accanto al pozzo, e portava finalmente il lume nel bugigattolo, diviso in due
da una vecchia tenda da finestra appesa a una funicella. (...)
65
Il maestro di scuola
dai Mimiambi di Eroda
I Mimiambi di Eroda (od Eronda), vissuto a Coo nella seconda metà del terzo secolo a. C. , erano
noti solo attraverso pochi versi citati da altri autori, finché nel 1890 ne vennnero ritrovati sette in un
papiro egiziano.
PERSONAGGI
LAMPRISCO, maestro
METROTIMA, madre di Cottalo
COTTALO, scolaro
EUTIA, COCCALO, FILLO, scolari compagni di Cottalo
*******
METROTIMA
Che le dolci Muse ti dieno, o Lamprisco, di gustar un po' di bene nella vita! Ma a costui (indicando
il figliolo) gli hai a scorticare il groppone, fin che l'animaccia sua non gli venga proprio sulle labbra.
Tutta la casa m'ha messo sossopra giocando a pari e caffo; ché i dadi non gli bastano più, o
Lamprisco: e la faccenda ormai si va a far grossa. Dove stia di casa il maestro di scuola, che il trenta
d'ogni mese (e son dolori!) vuol la mesata, non gli caveresti di bocca, anche se versassi tutte le
lagrime di Nannaco.
Ma il ridotto dello sciopero, ove si dan convegno i facchini ed i monelli, quello, si, lo sa insegnare
anche agli altri. E quella povera tavoletta, ch'io m'arrabatto ad incerare tutti i mesi, se ne giace là
abbandonata davanti allo stramazzo, alla colonnina della parete. E se pure, sbirciandola di traverso
come se fosse l'Orco, la piglia in mano, non la piglia per scrivervi su qualche bella cosa, ma per
raschiarla tutta quanta. Le gazzelline intanto se ne stanno nei mantici e nelle reticole unte e bisunte
più dell'ampolla che ci serve a tutto. Una "a" dal "b" non la sa distinguere, se non gli voci cinque
volte la stessa cosa.
L'altro giorno, mentre suo babbo si sfiatava a farlo leggere, di un Marone fece un Simone questo bel
tomo: tanto che io mi dètti della citrulla, io che, invece di mandarlo a pascere i somari, lo tiro su
nell'abbicci con l'idea di farmene il bastone della vecchiaia!
Se io o suo padre (povero vecchio, mezzo sordo e mezzo cieco) gli diciamo di recitare qualche
pezzo, come si fa coi ragazzi, allora bisogna vederlo...: par che sgoccioli da un colino. O Apollo dei
campi! questo gli dico io, anche la nonna, poveretta, ti saprà recitare, essa che non sa di lettere, od
un Frigio qualunque. Se poi ci piace di borbottare anche un po' più forte, ecco per tre giorni non
rivede la soglia di casa, ma scappa da sua nonna, e tormenta quella vecchia e povera donna...;
oppure monta sul tetto, e se ne sta lassù, dinoccolato, con le gambe penzoloni, come uno
scimmiotto. Ci pensi tu, come si debbano rimescolare le viscere in corpo a me, disgraziata, quando
lo veggo? E non discorro tanto di questo: ma mi fracassa tutte le tegole, come se fossero stiacciate;
e come si avvicina l'inverno, tocca a me a disperarmi ed a pagare ogni rottura un obolo e mezzo.
Ad una voce tutto il casamento grida:
Queste sono le prodezze di Cottalo, il figliuolo di Metrotima; ed è la verità, che non fa una grinza.
Mira, in che modo sé fatta tutta lividi la groppa scorrazzando pel bosco: pare un di quei pescatori di
Delo, che sul mare trascinano la vita melensa! Però il sette ed il venti (Nota: giorni di vacanza) li sa
meglio degli strolaghi; e non piglia neppur sonno al pensiero di quando voi fate vacanza.
Ma se coteste dèe costì, o Lamprisco (accennando alle immagini delle Muse, che decoravano la
scuola), ti dien del bene e ti consentono una opera buona...
LAMPRISCO
Non stare, o Metrotima, a scongiurare per lui: ché non avrà meno di quel che deve avere.
(Chiamando ad alta voce) Dov'è Eutia? Dove Coccalo? Dove Fillo? Non vi spicciate a pigliare
66
costui in groppa, poltroni, che tirereste in lungo la cosa sino alle calende greche? Faccio onore ai
bei fatti, Cottalo, che tu fai. A te non basta più giocare alla buona con le tessere, come fanno questi
qui (accennando ai compagni); ma ti ci vuole il ridotto e il gioco del soldo tra i facchini. Ora io ti vo
rendere più ammodo d'una fanciulla: tale, che non moveresti una foglia, anche se te ne spirassi!
Qua il nerbo sodo, la coda di bue, con cui concio di santa ragione i riottosi ed i perversi... Presto,
qua: prima che io abbia vomitato la mia bile!
COTTALO
No, ti supplico, Lamprisco: per coteste Muse, e per la tua barba, e per l'anima di Cottide; non mi
conciare con quella soda, ma con l'altra...
LAMPRISCO
Ma tu se un briccone, o Cottalo: tanto, che non ti decanterebbe pur un rivendugliolo; neanche nel
paese ove i topi rosicchiano persino il ferro.
COTTALO
Quante, quante... Lamprisco... ti supplico... me ne fai dare?
LAMPRISCO
Non lo domandare a me, ma a costei (accennando la madre). Piff, paff!
(picchia).
COTTALO
Quante, dico, se t'ho a campare?
LAMPRISCO
Quante ne reggerà la tua pellaccia.
COTTALO
Smetti... bastano, Lamprisco!
LAMPRISCO
E tu smetti le tue birbanterie...
COTTALO
Non lo farò più, più... te lo giuro, o Lamprisco, per le care Muse!
LAMPRISCO
Ohè tu, che parlantina che tu hai... Ti appiccicherò subito il bavaglio, se più oltre borbotti...
COTTALO
Ecco, sto zitto... Ma ti prego, non mi ammazzare!
LAMPRISCO
Lasciàtelo, Coccalo.
METROTIMA
Non hai a smettere, Lamprisco. Ma rèbbialo ben bene, fin che il sole vada sotto...
LAMPRISCO
Peraltro la cotenna l'ha più screziata d'una tarantola...
67
METROTIMA
E deve buscarne, proprio mentre è chinato sul libro... il disutilaccio... altre venti, per lo meno: anche
se leggerà più spedito della stessa Clio.
COTTALO
(a quella fiera minaccia, riuscito a svignarsela, con la lingua fuori della bocca ghigna)
Issssch!
METROTIMA
(in atto ancor più minaccioso) Che senza accorgertene tu non abbia tuffato la lingua... nel miele!
(Dopo una breve pausa) Corro subito a casa a dirlo di proposito o Lamprisco, al mio vecchio; e
ritornerò con dei ceppi, perché lo mirino qui a saltellare con quelle collane ai piedi le dee
venerande, che egli ha in uggia.
68
Il maestro di Vigevano
di Lucio Mastronardi
(...) Bussarono alla porta. Era il direttore.
- Che state facendo?- domandò agli scolari.
- Numerando per decimi da uno a mille! - rispose il solito primo della classe.
- Ho il figlio malato, potrei andare a casa mezz'ora?- domandai.
Il direttore mi guardò scuotendo la testa.
- Le voglio raccontare un aneddoto, signor maestro Mombelli. Quando noi eravamo ancora maestro,
capitò che mio padre stava morendo. Noi andammo a scuola e ci dimenticammo che nostro padre
stava morendo. Questo perché? Perché, signor maestro, le preoccupazioni personali non si devono
portare nell'aula scolastica. Ma pensi, signor maestro Mombelli, ai missionari, pensi che la nostra è
una missione. Mi faccia vedere il registro, signor maestro!
Sfogliò il registro e si portò le mani ai capelli.
- Signor maestro, stia attento alle anellate! La elle deve toccare la riga superiore; la effe deve
toccare quella superiore e quella inferiore; la di invece è l'unica anellata che non deve toccare la riga
superiore ma deve fermarsi poco sotto, alla stessa altezza della ti... Ah! Non c'è un'anellata che sia
ben anellata, signor maestro! Vede qui: la bi è più alta della elle; la gi è più bassa della effe. Ma,
signor maestro, il registro è un documento ufficiale!
(....) - Ci duole, signor maestro, farle osservazioni. Oh! di che buon grado noi le diremmo: bravo!
bravo! ma... Vede, signor maestro Mombelli, non ci consideri quello che noi siamo. Lei in noi non
deve vedere il superiore, ma il collaboratore. Noi siamo i collaboratori dei maestri! Se ha qualche
dubbio pedagogico, se ha qualche scolaro difficile ce lo dica: ci chieda un consiglio, una
spiegazione. Pensi, signor maestro, che noi facemmo il concorso direttivo a venticinque anni. Allo
scritto eravamo in trentamila. Fummo ammessi agli orali in trecento. Vincemmo in tre. Noi fummo
terzi: ma dietro a due reduci di guerra con medaglia doro. Ed ella sa che una medaglia doro conta
cinquanta punti....
(......) - Che lezione ha preparato per stamattina, signor maestro Mombelli?
- Una lezione su... Cristoforo Colombo! - dissi.
Feci aprire il libro agli scolari e cominciai a spiegare.
- Ma questa è una lezione libresca. Via il libresco - gridò il direttore. - Scuola attiva! Scuola viva!
Drammatizziamo, signor maestro, drammatizziamo! Scolari, in piedi...Voi siete la ciurma! Tu sarai
Cristoforo Colombo - disse a un ragazzino: - il vostro signor maestro sarà il marinaio che guarda se
si vede la terra... Signor maestro, vada alla finestra... Non ha un cannocchiale?
- Veramente no! - Non importa! L'ontogenesi ripete la filogenesi. Il fanciullo ha tanta fantasia da
sostituire col pensiero l'idea degli occhiali con quella del cannocchiale.
- Cosicché il cannocchiale sarebbero i miei occhiali?
- Esattamente!
Dopo un momento tutta la scuola inveiva contro il ragazzino che faceva Cristoforo Colombo.
- Siamo stanchi di viaggiare - urlava uno.
- Vogliamo tornare a casa! - urlava un altro.
- Calma ciurma! Calma ciurma! - urlava Colombo.
- Ho lasciato mia moglie, i miei figli. Dove sono i miei figli?
- Calma ciurma calma!
- Non andiamo più in America da questa parte!
- Nelle Indie, - urlò il direttore.
- Calma, ciurma, calma!
- Abbiamo sete!
- Abbiamo fame!
- Alle catene alle catene alle catene alle catene Colombo alle catene!
- Calma ciurma calma!
69
- Da tre anni ci dici: calma ciurma!
- Quattro mesi - corresse il direttore.
- Da quattro mesi che ci dici, calma ciurma!
Il direttore si affaccendava dall'uno all'altro scolaro a dire di gridare i nomi delle navi.
- Noi della Pinta siamo stanchi!
- Noi della Santa Maria siamo esausti!
- Noi della Nina non ne possiamo più!
- Calma ciurma calma!
- A morte Colombo a morte Colombo a morte Colombo a morte a morte.
- Calma ciurma calma!
Il direttore si avvicinò a un ragazzino: - Parla a Colombo della tua città!
- Sono di Torino, città che si trova nel cuore del Piemonte e che conta seicentomila abitanti; dove ci
scorre il fiume Po' che nasce dal Monviso, ha affluenti a sinistra, e a destra, e si getta nel mar
Adriatico con un largo delta....
- Calma ciurma calma!
Il direttore mi fece segno di gridare.
- Terra! Terra! - gridai.
- Davvero? - gridò Colombo.
- Terra! Terra! - ripetei.
- Terra terra terra terra terra terra terra terra terra terra.
- Evviva Colombo! - urlò il direttore.
- Evviva Colombo! - urlò la ciurma.
- Ora, - disse il direttore - per riposarci da questo che in pedagogia si chiama collettivismo
individualizzato (apparentemente sono due termini che stridono come un do suonato a un si):
collettivismo individualizzato, dicevamo, ora un po' di divertimento. Bambini! Vero che a voi piace
la pasta Barilla?
I bambini si guardarono.
- Eh! Con pasta Barilla è sempre domenica e alla domenica la scuola è chiusa. (...)
70
Il maestro giusto
Gianni Rodari
C'era una volta un cane
che non sapeva abbaiare.
andò da un lupo a farselo spiegare,
ma il lupo gli rispose
con un tale ululato
che lo fece scappare spaventato.
Andò da un gatto,
andò da un cavallo,
e - mi vergogno a dirlo perfino da un pappagallo.
Imparò dalle rane
a gracidare,
dal bove a muggire,
dall'asino a ragliare,
dal topo a squittire,
dalla pecora a fare
" bè bè ", dalle galline a fare coccodè.
Imparò tante cose,
però non era affatto soddisfatto
e sempre si domandava
(magari con un " qua qua "...):
- Che cos'è che non va?
Qualcuno gli risponda,
se lo sa.
Forse era matto?
O forse non sapeva
scegliere
il maestro adatto? (...)
71
Il maestro guerrafondaio
Bertolt Brecht
C'era il maestro Huber.
lui voleva la guerra, la guerra.
Parlava del vecchio Frtiz
e subito negli occhi un guizzo;
non mai per Wilhelm Pieck.
La lavandaia Schmitt
era contro il lordume, il lordume.
Prese il maestro Huber
lo mise nel mastello
e fece sparire anche quello.
72
Il mistero della collina
Giuseppe Pontremoli
(...) Nel quale si parla di sveglie e d'un maestro di scuola un po' speciale
(...) Avete presente un'incudine? Si? Bene. E un martello, l'avete presente? Si? Benissimo!
Ecco; ora pensate ad un uomo, con in mano quel martello, vicino a quell'incudine. Pensato?
Benissimo. Un momento: bisogna dire che quell'uomo è molto, molto forte, e il martello che
impugna è molto, molto grosso. Pensato anche questo? Si? Perfetto. Ora guardatelo bene,
quell'uomo. Ben cosciente della propria forza, osserva attentamente l'incudine, la scuote con una
mano per controllare che sia posata saldamente; la raddrizza un poco; la riosserva scrupolosamente
e le dà un'altra raddrizzata. La guarda come se volesse ipnotizzarla e stringe la mano attorno al
manico del martello; alza lentamente l'avambraccio piegando un poco il gomito; alza tutto il braccio
portando il martello al di sopra della testa, poi fin dietro le spalle.
Un'ultima occhiata crudele all'incudine, e la colpisce con violenza tremenda. Il colpo provoca un
suono forte e limpido che risuona alle orecchie dell'uomo provocandogli una specie di estasi.
Questo fa sì che il secondo colpo non abbia bisogno di alcuna preparazione e avvenga di fatto per
effetto del rimbalzo. Chissà se il problema stia nell'estasi dell'uomo o nello stordimento del
martello?
Il fatto è che il secondo colpo, violento quanto il primo, si abbatte sulla mano dell'uomo
incautamente rimasta sull'incudine per l'ultima di quelle famose raddrizzate.
Questo secondo colpo provoca un suono forte ma sordo, completamente privo della limpidezza del
primo. Ma il suono più importante è il terzo, quello che a questo punto esce dalla gola dell'uomo. È
il più importante, ovviamente per il risveglio. Perché è questa la "sveglia in tre tempi" di cui
parlavano i Merli: martellata sull'incudine, marmellata della mano, urlululato finale. E quest'ultimo
è in grado di svegliare chiunque, anche chi avesse il sonno così profondo da non essersi già
svegliato alla prima martellata. E non è certo un risveglio che metta di buonumore.
Per non parlare poi dell'umore di quelli che i Merli svegliano con questi "tre tempi" ma solo dopo
averli mandati da sonnambuli vicino ad un'incudine con un martello in mano.
Svegliarsi così non mette davvero di buonumore, e mi auguro che a voi non sia mai successo.
Cosa? Non credete che sia possibile? Non credete che sia vero?
E come credete che si sveglino tutti quei generaloni che hanno le medaglie appuntate anche sulla
giacca del pigiama e dormono tenendo la fotografia del carrarmato sul comodino? E quegli
insegnanti che urlano sempre e non sorridono mai? Con la sveglia in tre tempi, si svegliano! I Merli
non se ne dimenticano mai, anche se certe volte sembrano un po' distratti. Invece non lo sono per
niente, ed hanno anche parecchi aiutanti. Chi sono questi aiutanti? Questo proprio non posso dirlo.
Dirò soltanto che io ne conosco qualcuno. Basta così. E poi, che importanza ha sapere chi siano gli
aiutanti dei Merli? Ciò che conta è non essere di quelli che vengono svegliati con la sveglia in tre
tempi. Certo, gli uccelli che dormono con una ninnananna sotto l'ala non corrono questo rischio. E
neanche il mio maestro lo correva. Eh sì, al tempo dei tempi, anch'io sono andato a scuola. Il mio
maestro arrivava sempre con le mani e le braccia tutte cariche di cose che barcollavano rischiando
di cadere da tutte le parti: libri, mele, panini, una gran borsa, la pipa, gli occhiali, pennelli e un
mucchio di altre cose ancora. Quando riusciva a portarle tutte dentro l'aula le rovesciava sul tavolo e
le metteva un po' in ordine. Un po', mica molto, e si vedeva bene che ci metteva poco impegno, e
poi sembrava proprio che non ci riuscisse. A dir la verità sembrava quasi che lo facesse apposta, a
non riuscire, perché a volte certi oggetti che erano lì ben ordinati venivano spostati, urtati, fatti
cadere, e lui li guardava con un sogghignetto malizioso. Poi, senza aver finito di mettere in ordine le
sue cose, andava alla finestra, guardava fuori, ci chiamava tutti accanto a sé e diceva:
"Oggi impareremo delle cose nuove, molto importanti. Ci vorrà molto impegno".
Allora ci mettevamo tutti a sedere. Lui infilava gli occhiali, prendeva in mano la pipa e cominciava:
"Tanti, tanti anni fa, il Re delle Nuvole era ancora un marmocchietto, e viveva in grande amicizia
73
con il Re del Sole." Oppure: "Al tempo dei tempi, quando desiderare era ancora possibile..." Altre
volte cominciava così: "Domenica mattina alle sei del pomeriggio navigavo tranquillo in cima ai
monti con la mia barchetta..." Oppure: "C'era una volta una donna piccolissima..." E ancora: "In un
paese lontano lontano, oltre l'ultimo sogno visibile...
"Oppure: "Si racconta che in un paese della Cina vivesse un povero sarto..." E così via, e raccontava
le storie di tutti i tempi e di tutti i paesi.
E noi, attentissimi, stavamo come aggrappati alla sua voce che ci portava sui mari all'inseguimento
della nave fantasma, nel bosco incantato, nel castello orroroso di Roccalanzona, nella Città degli
Specchi, nella locanda dello Spessart, alla ricerca del tesoro...
E così incontrammo streghe e maghi, gnomi e giganti, sirene e uccelli di fuoco, pentole magiche e
guardiani di porci; e Achab, il capitano dagli occhi infuocati e la gamba d'avorio che inseguiva la
balena bianca; e Long John Silver, il cuoco di bordo capo dei pirati; e poi Gavroche e Thenardier; e
il signor Wegg e Oliver Twist, Alfanhuì, Huckleberry Finn, Peter Pan, Pinocchio, Alice,il Piccolo
Principe, Mary Lennox, Schiaccianoci e il re dei topi, Don Chisciotte, Gulliver, Naftali, Harun,
Palmiro Mezzanella, Penny Wirton e il cieco... Animali parlanti, aquiloni, acque fatate, uccelli,
uomini e donne mai stanchi di darsi da fare per essere liberi, per essere finalmente felici. Questo è
tutto quel che ricordo di lui, e mi viene in mente soprattutto quando mi sembra di potere aiutare
qualcuno.
In quei momenti mi metto a fischiettare, mando in giro qualche giraffa ballerina e porto a casa
tassisti in difficoltà.
Sì, sono stato io, ma non posso certo dirvi come ho fatto. È un segreto professionale; e poi è finito il
capitolo. (...)
74
Il Ragazzo e il Maestro di Scuola
Jean de La Fontaine
Racconto questa favola per mostrar d'un tale la stupida burbanza magistrale.
Un ragazzo, giocando al fiume in riva, cadde nell'acqua e forse vi periva, se non avesse un salice
afferrato che, dopo Dio, lo tenne sollevato.
Mentre nell'acqua egli sta fino alla gola, viene a passare un maestro di scuola.
- Aiuto, aiuto! - grida quel che annega.
Il maestro si ferma, e a lui che prega, con una voce burbera e nasale, gli somministra questa
paternale: - Ah scimunito, ah sciocco, ah babbuasso! Guarda dove si caccia il satanasso. Andate
pure a prender dell'affanno per questi tristi, ho sì, che vi faranno morir tisici! Ah poveri parenti a cui
tocca di questi malviventi! Ah i tempi tristi, o i figli traditori ...
E quando ebbe finito, il tirò fuori.
Quanti non sono al mondo altri pedanti e brontoloni e critici ignoranti, razza dotta più in chiacchiere
che in scienze, che Dio conserva a nostra dannazione!
In ogni cosa, a torto od a ragione, bisogna ch'essi spuntino sentenze.
Prima di pena tirami, se puoi, il bel discorso lo udiremo poi.
75
Il romanzo di un maestro
Edmondo De Amicis
(...) Era una casa costrutta apposta, in una piazzetta fuor di mano, accanto a un vecchia cappella: un
gran dado bianco, che aveva le classi maschili da un lato e le femminili dall'altro, con due porte
d'entrata sulle due opposte facciate, davanti alle quali s'aprivano due cortiletti. Fu poi, più che
contento, maravigliato dalla bianchezza intatta delle pareti e dallo stato di conservazione dei banchi.
C'era poca cosa: quattro carte geografiche, che dovevano essere state levate da un atlante, una
lavagna troppo piccola e un solo cartellone di nomenclatura di piante, ma tutto pulitissimo, come
comprato allora. Il ritratto del re, in olografia, era fiancheggiato da due grandi quadri di soggetto
religioso, raccattati forse in qualche rigatteria, ma riverniciati di fresco. Fu anche stupito dalla
sufficiente pulizia dei suoi trentacinque scolari, e della lindura soldatesca del vecchio inserviente
comunale, che portava una giacchetta di velluto nero e un berretto gallonato d'argento, e aveva
sempre la barba fatta. E gli andarono a genio pure i suoi colleghi, coi quali si trovava ogni giorno
all'entrata e all'uscita nella piccola sala d'aspetto, bianca e fresca come tutto il resto.
(...) La maestra di 2a, che stava da dodici anni nel paese, era una signorina fra i trentacinque e i
quaranta, lunga e pallida, un viso da ragazza patita, coi capelli lisciati sulla fronte, con occhi dolci,
con una bocca affettuosa e triste; vestita più che modestamente e sempre ad un modo, come se
portasse un abito religioso. Il giovane sentì con piacere che la madre di lei, che viveva con la
figliuola, era stata molti anni nella città di****, e v'aveva conosciuto la madre sua. L'altra maestra
era una ragazza sulla trentina, vestita bene e formata meglio, di modi cortesi e dignitosi; della quale
lo colpirono sul primo momento gli occhi vivissimi, mobilissimi, che facevano grandi sopracciglia
raggiunte, e un singolare atteggiamento della bocca grande e sensuale, da cui pareva sempre che
dovesse scappare un frizzo, che'lla poi rattenesse, sorridendone discretamente. IL maestro era un
buon vecchio settuagenario, d'aspetto onesto e rassegnato, lentissimo nel muovere e nel parlare,
oberato d'una gran pancia, non prodotta da esuberanza d'alimentazione; il quale contava poco men
d'un mezzo secolo di servizio, prestato quasi tutto, in due riprese, a Piazzena; di modo che c'eran nel
Consiglio comunale parecchi dei suoi antichi alunni, e alcuni di questi si vendicavano con le piccole
sevizie, trent'anni dopo, dei rabbuffi ch'egli aveva fatti loro alla scuola. Mancavano al pover'uomo
due dita dalla mano sinistra, che aveva perdute in un villaggio di Val di Sesia, dov'era stato maestro
due anni. Un suo alunno, la cui famiglia teneva a dozzina due minatori, aveva portato a scuola una
capsula di dinamite, rubata nel guardaroba dei suoi dozzinanti, e stando solo nel banco della berlina,
l'andava rivoltando in tasca per gioco: non obbedendo egli al comando di buttar via il trastullo, il
maestro glielo aveva afferrato per levarglielo, e in quel tira tira la capsula era scoppiata,
sfracellando la mano a tutti e due. Piccoli incerti della professione.
(...) Incominciò nondimeno di buona voglia. Quella novità dell'istruzione obbligatoria gli dava quasi
un ardor nuovo, come se con essa dovesse principiare per gl'insegnanti un nuovo e miglior periodo
d'esistenza; un periodo nel quale i parenti, meglio persuasi dell'importanza dell'istruzione, imposta
così solennemente, come un sacro dovere sociale, avrebbero preso in maggior rispetto il maestro, e
agevolato in qualche modo il suo ufficio, adoperandosi, se non altro, con più impegno, a infonder
nei ragazzi l'amor della scuola, e a farceli andar tutti i giorni e tutto l'anno. Dal canto suo egli decise
di fare tutto il possibile perché fosse osservata la legge. Il giorno dell'apertura gli si presentò una
compagnia di ragazzi sani, tarchiatotti, d'un bel colorito di montanari, con certe forme di testoni che
rivelavan forza di volontà, e degli occhi azzurri chiari, che davano a sapere delle indoli quiete. Ma,
rispetto alla legge, non voleva dire: ventun mancanti eran molti. Passati alcuni giorni, il maestro ne
compilò l'elenco, e lo presentò al segretario, che lo trasmettesse al sindaco, e gli domandò insieme
notizie intorno ai parenti, per andarli a sollecitare. Quasi tutti stavan fuori del paese. Egli stabilì di
far due o tre visite al giorno, deviando qua e là dalla sua passeggiata solita. E cominciò il suo giro
con zelo veramente apostolico, dopo essersi predisposte in capo certe brevi esortazioni ragionate,
che gli parevano di efficacia sicura. Ma le sue illusioni duraron poco. Per quanto si presentasse in
modo cortese e amichevole, egli fu male accolto quasi da per tutto. Alcuni gli dichiararono
apertamente che non avrebbero mandato a scuola i figliuoli perché n'avevan bisogno per i lavori;
76
altri perché la scuola era troppo lontana; altri perché il ragazzo stava poco bene di salute; e mentre
parlavano, il malato era lì che macinava pane a quattro ganasce. Egli tentava prima di persuadere;
poi ammoniva in nome della legge.
- Ah, l'ammenda! - rispondevano; - son ciance. Vogliamo un po' vedere se il signor sindaco avrà il
coraggio di strapparci di bocca quel pezzo di pane! Alcuni se ne ridevano, dicendo che tutto si sarebbe ridotto a far pubblicare i nomi dei parenti a quel
luogo comodo dell'albo pretorio, dove nessuno li avrebbe neanche veduti. Un contadino fra gli altri,
lo investì.
- Ah sì ! Ah proprio ci mancava ancora questa delle angherie! Non bastava la leva, ci voleva per
giunta l'obbligatoria! Il signor sindaco me lo pagherà lui il servitore da mettere in cambio del
figliuolo che mi fa tute le commissioni! Dica un po': verrà il signor pretore a condurmi in pastura le
vacche? Lasciamola lì, signor maestro: ci vuole del fegato per portar di queste imbasciate!
Ma i più singolari eran quelli che ragionavan sulla cosa tranquillamente, come se il mandare a
scuola i ragazzi fosse rendere al Governo un servizio che desse loro il diritto a un compenso.
- Ebbene - gli disse un di questi, in un crocchio, - se il Governo vuole i ragazzi a scuola, ci dia un
sussidio. I soldati li mantengono e li pagano, mi pare. Ora il Governo vuole gli scolari, si paghi gli
scolari.
Con tutto questo, un po' per timore dell'ammenda, un poco per condiscendenza, sei o sette delle
venti famiglie renitenti mandarono i figliuoli. Per le altre vide il maestro che non c'era che aspettar
gli effetti del rigore del sindaco, e rinunziò alla sua propaganda.
(...) Gli fece cattivo senso, al principio della bella stagione, di vedersi abbandonare da un terzo circa
della scolaresca, che andava ai lavori della campagna; ma se ne consolò con la maggiore facilità
ch'egli trovava a instruire e a invigilare un numero ristretto d'alunni; fra i quali gli erano rimasti i
migliori. Senonché egli andava toccando con mano di giorno in giorno, con vero rammarico, che la
sua bontà e la sua buona maniera non recavano i frutti che si credeva in diritto d'ottenere.
Rimproverati e ragionati amorevolmente, quando s'aspettavano invece un castigo, pareva che i suoi
alunni si vergognassero, è vero, e mostravano un aspetto più soddisfacente di quel viso duro o
impaurito che fanno i ragazzi sotto una minaccia o una percossa; ma, passata quella momentanea
vergogna e quel principio di pentimento, scordavano affatto le buone parole e ricadevano nelle
mancanze, e c'era in queste una progressione lenta, ma sensibilissima, di frequenza e di gravità; egli
sentiva che la scolaresca gli sfuggiva di mano, e che fra non molto non l'avrebbe più potuta
dominare...
E se ne impensieriva seriamente. Ma persisteva nei suoi modi, nondimeno, ché gli ripugnava di
cambiar strada così presto, appena incominciato il cammino, confessandosi deluso in uno dei suoi
più cari desideri; e a persistere l'aiutava un'incerta e intermittente aspirazione religiosa, una
dolcezza rimastagli in cuore dalle credenze dell'infanzia.
(...) Ma un giorno, sul principio di maggio, gli seguì un caso che ebbe per effetto di scuotere
fortemente le sue idee intorno all'educazione. Stava in faccia all'uscio della scuola, con l'ombrello in
mano, sotto una pioggia fitta, a invigilare l'uscita degli ultimi alunni, quando sentì dietro a sé le
grida disperate d'un ragazzo, e, voltandosi, vide un contadino in maniche di camicia che con una
mano teneva afferrato per la nuca uno dei suoi alunni, e con l'altra lo picchiava furiosamente nel
viso. L'istinto imperioso che l'aveva sempre gettato con un coraggio cieco contro i percotitori dei
fanciulli, lo gettò contro quell'uomo. Si cacciò, gridando, fra lui e la vittima, fu percosso, afferrò la
mano che percoteva, si sforzò di separarli; ma non riusciva che a inferocir di più quel furioso. Era il
padre che aveva scoperta una birbonata del figliuolo mentre era a scuola, ed era venuto ad aspettarlo
all'uscita perché non pigliasse pei campi.
- Me ne infischio del maestro! - urlava continuando a menar le mani; - ho diritto di castigare i miei
figliuoli! Mi si levi d'attorno, giuraddio, o ne do anche a lei!
Gli alunni intanto avevan fatto cerchio, altra gente accorreva; il maestro riuscì a buttar via con uno
spintone il ragazzo, che andò a dar la schiena nel muro, atterrito, filando sangue dal naso.
E allora abbrancò il padre per le spalle, dicendogli in viso, trafelato, con accento di preghiera: Andiamo, via, si cheti, non faccia uno scandalo, vede che c'è gente, da bravo!
Il contadino, bestemmiando, smise di lottare, e riavute le braccia libere, raccolse il cappello e la
77
giacchetta che gli eran caduti; poi cercò il figliuolo con gli occhi, ancora tutto fremente. Il maestro,
angustiato dall'idea che potesse ricominciare a casa, seguitò a tentar di calmarlo, con la voce sempre
ansante: - Andiamo, facciamola finita. Non si batte un ragazzo così. E inutile batter. Si fa peggio.
Ora basta. Lei mi deve promettere che non ricomincerà più. Sono il suo maestro, in fin dei conti.
- M'ha fatto una birbonata! - esclamò il contadino, soffiando ancora, e minacciando il ragazzo col
pugno.
- E lei l'ha castigato, - ribattè il maestro; - ma che sia finita. Io non le lascio il figliuolo se non mi dà
la parola... Non posso lasciare ammazzar dalle busse uno dei miei migliori scolari. Che diavolo! Un
ragazzo d'un talento... Non lo dico per metter bene, ma per coscienza... Insomma, se lo vuol sapere,
- soggiunse a bassa voce, - conto su di lui per far buona figura agli esami, ecco.
Il contadino guardò il maestro in aria di dubbio; ma un poco d'effetto si vedeva che le blandizie
l'avevan fatto. Stette un momento muto; poi, rivolto al ragazzo, gridò: - A casa! L'accento era
brusco; ma il maestro capì che la causa era vinta. E l'accompagnò per un tratto di strada,
ragionando, per assicurar la vittoria. (...)
78
Il segreto di Luca
Ignazio Silone
(...) "Domani" disse don Serafino "è atteso qui Andrea Cipriani. Tu non puoi conoscerlo, ha meno
di quarant'anni. Non so esattamente quali e quanti misfatti abbia perpretato in questi ultimi anni; ma
so che si è formata attorno alla sua testa una aureola rossa di capo di bande rivoluzionarie. E' la
prima volta che torna a Cisterna e, siccome nel frattempo la causa rivoluzionaria ha prevalso, egli
non sarà arrestato ma portato in trionfo."
"Ho già sentito parlare di lui" disse Luca. "Non è il figlio di Carmine?"
"S', èil figlio del tuo amico Carmine" rispose il prete. "Te lo ricordi? Ma Carmine era un uomo
d'ordine, mentre il figlio ha scelto la vita dura e, dati i tempi, ha trovato pane a iosa per i suoi denti"
(...) "Non capisco" disse Luca. "Stando qui a Cisterna, come fece Luca a scoprire la politica?"
"La politica, mio caro Luca, è ora come il colera" spiegò don Serafino. "Le vie di diffusione sono
difficili a rintracciare. Andrea pareva un semplice maestro di scuola; a quel che si diceva, perfino un
buon maestro, benché di carattere scontroso e difficile. Ma, a dire la verità, fin da ragazzo era
apparso bizzarro. Sua madre venne da me varie volte a raccontarmi le stranezze di lui, a chiedermi
consiglio. Fosse stata una fanciulla, l'avrei giudicata un'sterica. Nessuno, allora, prevedeva tuttavia
quel seguito. Come accadde? In modo del tutto inaspettato. All'inizio di una delle guerricciole
mosse dal passato governo contro dei popoli inermi (adesso non ricordo più se fosse il turno degli
spagnoli o degli etiopi) Andrea dichiarò in piazza, in un crocchio di conoscenti: 'E' un'ignominia'.
Lo scandalo non era nel senso delle sue parole, ma nell'averle pronunziate in pubblico. Avrebbe
potuto smentirsi, riabilitarsi. Fece il contrario, come se avesse a lungo aspettato quell'occasione.
Convocato nella sede del partito, egli vi ripeté la sua affermazione, anzi, pare che rincarasse la dose.
Si capisce che fu più che sufficiente per il suo immediato imprigionamento e il resto..." (...)
79
Il triplice destino
Nathaniel Hawthorne
(...) Il più importante dei tre visitatori, il signor Hawkwood, era un anziano gentiluomo, molto
pomposo ma di ottimo carattere,capo e promotore di tutte le iniziative del villaggio, e generalmente
riconosciuto come uno dei più saggi. Portava sul capo un tricorno, secondo una moda già allora
antiquata, e impugnava un bastone col pomello d'argento, che sembrava usare più per brandirlo in
aria che per aiutare il cammino delle sue gambe. I suoi compagni erano due anziani e rispettabili
proprietari terrieri, che in ossequio a una prerivoluzionaria deferenza al rango e ai privilegi ereditari,
facevano da scorta al nobiluomo. Mentre si avvicinavano lungo il sentiero, Ralph Cranfield stava
seduto su un'alta sedia di quercia, scrutando distrattamente i tre visitatori (...)
- I miei colleghi e io, esordì il nobiluomo, siamo oberati di gravi compiti essendo noi i consiglieri
municipali di questo villaggio. Nell'arco dei tre giorni trascorsi, le nostre menti sono state
faticosamente impegnate nella scelta di una persona degna di occupare una carica molto importante,
e disposta ad assumersi un onere e un onore che, saggiamente considerati, possono essere giudicati
non inferiori a quelli dei sovrani e dei potenti. E considerato che tu, nostro concittadino d'origine,
sei dotato di buon intelletto naturale, coltivato nei tuoi viaggi all'estero, e che certe bizzarrie e
fantasie della tua giovinezza sono state sicuramente corrette dal tempo, considerato tutto ciò, e dopo
debita riflessione, siamo dell'opinione che la Provvidenza divina ti ha mandato qui, in questo
momento, proprio per questo nostro scopo.Durante questo lungo discorso, Cranfield aveva
continuato a guardare fissamente l'oratore, come scorgendo qualcosa di misterioso, quasi
ultraterreno, nella sua piccola figura pomposa, come se indossasse la tunica di un antico saggio,
anziché una giacca con le spalle squadrate, un panciotto coi risvolti, braghe di velluto e calze di
seta.
(...)
- E qual è questa carica? - domandò allora Ralph Cranfield con voce tremante, - che può rendermi
pari ai sovrani e ai potenti della terra?.
- Nientemeno che quella di maestro nella scuola del villaggio! - rispose il signor Hawkwood... (...)
80
Il tulipano nero
Alexandre Dumas padre
(...) - E a che servirebbero allora i piccioni viaggiatori? - diceva Cornelius alla ragazza. - Voi non
potreste leggere ciò che vi scriverei, né scrivermi ciò che vorreste.
- Ebbene, - rispondeva Rosa, che temeva la separazione quanto Cornelius - abbiamo a disposizione
un'ora ogni sera, facciamone buon uso.
- Mi sembra - osservò Cornelius - che noi ne facciamo già buon uso.
- Facciamone un uso ancora migliore - rispose Rosa sorridendo. -Insegnatemi a leggere e a scrivere.
Trarrò profitto dalle vostre lezioni, siatene certo, e in tal modo non potremo più essere separati,
tranne che dalla nostra volontà.
- Oh! allora, - gridò Cornelius - abbiamo l'eternità davanti a noi!
Rosa sorrise e alzò dolcemente le spalle.
- Forse che voi resterete sempre in prigione? - rispose. - Forse che dopo avervi concesso la vita, Sua
Altezza non vi concederà anche la libertà? Non riavrete allora i vostri beni? Non sarete nuovamente
ricco? E quando sarete libero e ricco, vi degnerete di guardare, passando in carrozza o a cavallo, la
piccola Rosa, la figlia di un carceriere, quasi di un boia?
Cornelius volle protestare, con tutto il cuore e con tutta la sincerità di un'anima colma d'amore.
Ma la fanciulla lo interruppe.
- Come sta il vostro tulipano? - domandò sorridendo.
Parlandogli del tulipano, Rosa riusciva a far dimenticare a Cornelius ogni cosa, anche se stessa.
- Abbastanza bene - disse il giovane; - la pellicola si annerisce, il processo di fermentazione è
incominciato, le vene del bulbo si riscaldano e s'ingrossano. Fra otto giorni, forse prima, si potranno
distinguere le prime protuberanze della germinazione. E il vostro, Rosa?
- Oh, io ho fatto le cose in grande, seguendo le vostre indicazioni.
- Vediamo, Rosa, che cosa avete fatto - domandò Cornelius, con gli occhi ardenti e con il respiro
ansimante come la sera in cui aveva conquistato Rosa.
- Ho fatto le cose in grande - rispose sorridendo la ragazza, che in fondo al suo cuore non poteva
impedirsi di studiare questo duplice amore del prigioniero per lei e per il tulipano nero: - in un
quadrato di terreno spoglio. lontano dagli alberi e dal muro, ho preparato un'aiuola di terra
leggermente sabbiosa, più umida che secca, senza una pietra, senza un sassolino, come voi mi avete
insegnato.
- Bene, bene, Rosa, e poi?
- Il terreno così preparato non attende che il vostro segnale.
- Nel primo giorno di bel tempo voi mi direte di piantare il mio bulbo e io lo pianterò; devo partire
in ritardo rispetto a voi, perché ho dalla mia tutte le condizioni favorevoli dell'aria buona, del sole e
dell'abbondanza dei succhi terrestri.
- E' vero, è vero! - esclamò Cornelius battendo gioiosamente le mani.
- Siete una brava allieva, Rosa, e guadagnerete certamente i centomila fiorini.
- Non dimenticate - rispose Rosa ridendo - che la vostra allieva, come vi piace chiamarmi, ha
qualcos'altro da imparare, oltre alla coltivazione dei tulipani.
- Sì, sì, interessa anche a me come a voi che sappiate leggere.- Quando incominceremo?
- Subito.
- No, domani.
- Perché domani?
- Perché oggi la nostra ora è terminata e debbo lasciarvi.
- Di già! Ma che cosa leggeremo?
- Oh! - disse Rosa - ho un libro, un libro che spero ci porterà fortuna.
- A domani dunque?
- A domani.
L'indomani Rosa ritornò con la Bibbia di Cornelio de Witt. (...)
Ebbe inizio allora fra maestro e scolara una di quelle deliziose scene che formano la gioia di un
81
romanziere.
Lo spioncino, unica apertura che servisse loro di comunicazione, era troppo alto per persone che
s'erano accontentate fino allora di leggere l'una sul viso dell'altra tutto ciò che si dovevano dire e
che non potevano leggere comodamente sul libro portato da Rosa. Perciò la fanciulla dovette
appoggiarsi allo spioncino, con la testa inclinata e col libro all'altezza del lume che reggeva con la
mano destra e che, per farla riposare un poco, Cornelius escogitò di fissare alla grata con un
fazzoletto. Così Rosa fu in grado di seguire con un dito le lettere e le sillabe che Cornelius le faceva
compitare, indicandogliele attraverso la grata con una festuca di paglia. La luce della lampada
illuminava il colorito di Rosa, il suo occhio azzurro e profondo, le sue trecce bionde sotto al casco
d'oro brunito che, come abbiamo detto, è l'acconciatura delle frisone; le sue dita alzate assumevano
una tinta pallida e rosata, mostrando la vita misteriosa che circolava sotto la carne.
L'intelligenza di Rosa si sviluppava rapidamente a contatto con lo spirito vivificante di Cornelius, e
quando la difficoltà appariva troppo ardua, quegli occhi che s'immergevano l'uno nell'altro, quelle
ciglia che si sfioravano, quei capelli che s'annodavano, provocavano delle scintille elettriche capaci
d'illuminare le tenebre dello stesso idiotismo.
E Rosa, scesa in camera sua, ripassava le lezioni di lettura e, in fondo all'anima, anche le
82
Il vecchio e il bambino
Claude Berri
(tratto dal sito internet della Fondazione Galiano; dalle ricerche bibliografiche effettuate risulta inedito in Italia)
(...) Pioveva ancora, la stessa pioggerella sottile ma costante di Nemours e di Caluires. Bastava già
questo a rendermi triste. E avevo paura di quello che sarebbe successo a scuola.
Mi domandavo se l'insegnante sarebbe stato un maestro o una maestra e se lui o lei sarebbero stati
simpatici. Mi domandavo se me ne avrebbero voluto per il fatto che ero ebreo. Mi domandavo
com'erano i ragazzi di campagna. Promisi a me stesso che avrei studiato, che sarei stato il primo in
tutto per far piacere ai miei genitori. Inoltre, se avessi studiato molto, non avrei avuto tempo di esser
triste. La scuola era situata in una piazzetta con un albero di sicomoro e una fontana. Mi sedetti su
un muro un po' lontano dai ragazzi e dalle ragazze, che mi guardavano parlottando a voce bassa.
Arrivò la maestra. Pensai che assomigliava a un'anguilla nera. I suoi occhi, i capelli, il vestito, tutto
era nero. Papà e io avevamo spesso giocato al gioco delle somiglianze tra persone e animali. Ne
avevo ancora l'abitudine. Le anguille non mi piacevano molto: ti guizzano tra le dita e sono viscide.
La maestra mi si avvicinò. Persino il suo sorriso m'innervosiva. Avevo l'impressione che mi
avrebbe fatto qualche scherzo crudele. Mi domandò come mi chiamavo.
- Longuet, signora.
Lo compitai con cura: - L-O-N-G-U-E-T.
Non avevo sbagliato, ed ero fiero di me. I ragazzi della scuola avevano preso coraggio ed erano là,
attorno a noi. La maestra fece una risatina cattiva: - Ma che nome buffo!
Attorno a me ci fu uno scoppio di risa.
Guardai per terra. Era vero che era un nome buffo. Ma che potevo farci? C'era una guerra
e io ero ebreo. Il mio vero nome era Langmann, un nome grande, bellissimo, caldo, il nome di mio
padre, il nome che lui aveva dato a mia madre il giorno in cui si erano sposati, il nome che aveva
dato a me il giorno in cui ero nato, il mio nome di prima della guerra. Avevo voglia di urlarlo.
(...) Finalmente la maestra uscì, seguita da Maxime. Battè‚ le mani e ci fece schierare in quadrato.
Era solenne. Ma non per questo aveva rinunziato al suo eterno, crudele sorriso. Maxime era al suo
fianco, e rigirava tra le dita il berretto. Guardai Dinou. Era calma e non sospettava nulla. La maestra
estrasse dalla tasca del suo grembiule la cartolina, la brandì in aria perché tutti potessero vederla e
domandò: - Chi ha scritto questa graziosa cartolina?
La sua voce era flautata, quasi dolce. Gli allievi si scambiarono delle occhiate. Guardai Dinou.
Dalla disperazione che mi vide dipinta in volto sospettò che fossi stato io. Maxime era pronto a
scagliarsi sul colpevole. La voce della maestra si fece ancor più mielata. - Chi ha fatto questi
deliziosi errori d'ortografia? Chi è l'anima coraggiosa che si firma con una padella?
Quale demonio mi spinse a farlo? Non lo saprò mai: invece di star zitto, firmai io stesso la mia
sentenza. disperazione che mi vide dipinta in volto sospettò che fossi stato io. Maxime era pronto a
scagliarsi sul colpevole. La voce della maestra si fece ancor più mielata. - Chi ha fatto questi
deliziosi errori d'ortografia? Chi è l'anima coraggiosa che si firma con una padella?
Quale demonio mi spinse a farlo? Non lo saprò mai: invece di star zitto, firmai io stesso la mia
sentenza.
- Non è una padella, è una ciliegia. Ero fiero di me, e sorrisi a Dinou che abbassò gli occhi. Avrei
voluto avvicinarmi a lei, prenderla per mano e dire a tutti che l'amavo. Tutta la classe scoppiò a
ridere. Soltanto Dinou non rise. La maestra mi venne vicino e mi sventolò la cartolina sotto il naso.
- Dunque, sei stato tu? -.
Guardai la maestra dritto negli occhi.
- Sono stato io! -. Non stavo confessando il mio delitto, stavo vantandomene.
Lentamente, la maestra estrasse dalla tasca la macchina tosatrice. Maxime si calzò il berretto sulle
orecchie e balzò verso di me. Io corsi via.
Da quel giorno so che cosa significa essere un animale braccato che sta per morire. Dinou era alle
mie calcagna, seguita da tutta quella marmaglia. Sento ancora i tonfi delle loro scarpe di legno, gli
urli delle ragazze. Correvo più in fretta che potevo. Andavo veloce, ma ero condannato.
83
Fu Maxime ad acchiapparmi. Mi riportò indietro nel cortile della scuola: io mi dibattevo e
scalciavo. Urlai. Piansi. Me ne infischiavo della mia dignità. Volevo i miei capelli! Ma la maestra
eseguì la sentenza fino alla fine. Rapato! Ero rapato, innocente, lontano da mia madre, lontano da
mio padre: rapato. Un animale, dopo che l'hanno marchiato, viene lasciato libero di andarsene in
pace. Fu lo stesso con me. Il padre di Dinou mi lasciò libero. Mi sentivo umiliato, disperato.
Avevano osato raparmi solo per una cartolina (...). E questa la chiamavano giustizia! Quando avevo
rubato dei giocattoli, quando mi ero strappato la camicia, mi ero meritato le botte che avevo preso.
Ma raparmi per una piccola dichiarazione d'amore! Mi toccai la testa: ero nudo. Piansi in silenzio.
Non ero più arrabbiato. Ero solo. La cerimonia era finita. Erano tutti attorno a me in circolo. Non
ridevano più. Smisi di piangere e li guardai a uno a uno. Non erano affatto fieri. Anche Maxime
abbassò gli occhi. E per una volta, la maestra aveva smesso d'inalberare il suo eterno sorriso. (...)
84
Jude lo scuro
Thomas Hardy
(...) Il maestro di scuola stava per lasciare il villaggio, e tutti sembravano dispiaciuti. Essendo più
che sufficiente per gli effetti che portava con sé, il mugnaio di Cresscombe gli aveva prestato il
carretto con il telone bianco di farina, e il cavallo, per trasportare le sue cose alla città cui era
diretto, distante una ventina di miglia da lì. Il suo alloggio presso la scuola, infatti, era stato arredato
in parte dagli Amministratori, e l'unico oggetto ingombrante di sua proprietà oltre alla cassa dei libri
era un piccolo pianoforte verticale, da lui acquistato a un'asta, l'anno in cui aveva pensato di
imparare a suonare uno strumento. Svanito l'entusiasmo iniziale, non ne aveva mai raggiunto alcuna
abilità con i tasti, e da allora l'acquisto era stato per lui fonte di continui fastidi durante i traslochi.
(...)
Un ragazzetto di undici anni, che aveva assistito pensieroso al trasloco, si avvicinò allora al gruppo
degli uomini, e mentre costoro, incerti sul da farsi, si fregavano il mento, arrossendo al suono della
propria voce disse: "Mia zia ha una grande cantina, e forse potreste metterlo là finche non avrete
trovato dove sistemarvi, signore."
"Un'ottima idea" disse il fabbro.
Fu deciso di inviare una deputazione dalla zia del ragazzo, una vecchia zitella del paese, per
chiederle se avrebbe tenuto in casa il pianoforte finché il signor Phillotson non avesse mandato a
ritirarlo. Il fabbro e il fattore si allontanarono per verificare la praticabilità di quella soluzione, e il
ragazzo e il maestro rimasero soli, in piedi nel soggiorno.
"Ti dispiace che parto, Jude?" domandò quest'ultimo con affetto. Gli occhi del ragazzo si
riempirono di lacrime, poiché egli non era uno degli scolari regolari della mattina, che vivendo ogni
giorno a contatto con il maestro erano alieni da qualsiasi romanticismo, ma aveva frequentato la
scuola serale solo durante il trimestre appena concluso. A dire il vero, in quel momento gli scolari
regolari, come certi discepoli del passato, evitano di farsi vedere nei paraggi, essendo poco propensi
a offrirsi con entusiasmo di aiutarlo. Il ragazzo aprì imbarazzato il libro che teneva in mano,
regalatogli dal signor Phillotson per ricordo, e ammise che gli dispiaceva.
"Anche a me", disse il signor Phillotson.
"Perché ve ne andate, signore?", chiese il ragazzo.
"Oh, sarebbe troppo lungo spiegarlo. Non capiresti le mie ragioni, Jude. Forse potrai capirlo quando
sarai più grande".
"Credo di poterle capire anche adesso, signore".
"E va bene ma non andarlo a raccontare in giro. Sai cosa è una università e una laurea? È il
lasciapassare necessario per chiunque voglia concludere qualcosa nell'insegnamento. Il mio
progetto, o il mio sogno, è di laurearmi, e poi prendere gli ordini. Andando a vivere a Christminster
o nei paraggi mi troverò per così dire al quartier generale (...)
Il fabbro e il suo compagno tornarono.
La cantina era asciutta e comoda, e la signorina Fawley pareva disposta a ospitare lo strumento. Si
decise di conseguenza di lasciarlo nella scuola fino a sera, quando avrebbero potuto contare su più
braccia per trasportarlo; e il maestro diede un'ultima occhiata intorno a sé.
Jude aiutò a caricare le poche cose rimaste, e alle nove in punto il signor Phillotson, salito sul
carretto e sedutosi vicino alla cassa dei suoi libri e agli altri impedimenta, si congedò dagli amici.
<<Non ti dimenticherò, Jude", disse sorridendo mentre il carretto iniziava a muoversi.
"Ti raccomando di fare il bravo; sii gentile con gli animali e gli uccelli, e leggi più che puoi. E se un
giorno verrai a Christminster, ricordati di cercarmi, in nome dell'antica amicizia".
Il carretto scricchiolò passando attraverso il prato, e scomparve dietro l'angolo, nei pressi della casa
del parroco. Il ragazzo tornò verso il pozzo, al limite del prato, dove aveva lasciato i secchi per
andare ad aiutare il suo protettore e maestro a caricare le sue cose. Le labbra ora gli tremavano, e
dopo aver sollevato il coperchio del pozzo per calarvi il secchio, si fermò e si appoggiò con la
fronte e le braccia contro il parapetto. (...)
85
La Cacciatora
Ada Negri
(...) Le fatiche della scuola non mi davano alcun pensiero. Insegnavo nella prima classe dei maschi.
Quegli ottanta o novanta diavoli scatenati, che m'irrompevano nell'aula, in gran parte sporchi,
puzzolenti di concio e di stalla, pieni di pidocchi e di monellerie, mi piacevano appunto perché, in
certo qual modo, fra essi mi sentivo un diavolo scatenato anch'io. Come ciò riuscisse a combinare
coi doveri dell'insegnamento e col progresso di quei ragazzi nell'alfabeto e nell'abbaco, lo ignoro.
Ma combinava. Pochissimi di loro portavano calze e scarpe, blusetta e calzoncini in ordine, e si
presentavano col viso e le mani lavate: i figli del sindaco, ch'era un fittabile, del segretario, del
droghiere: da contarsi sulle dita. Certe povere mamme col giallore della pellagra in faccia,
incontrandomi per via, mi gridavano a bruciapelo: - Giù botte, sa, scióra maàstra. Non abbia paura:
non c'è altro da fare con quel barabba del mio ragazzo: l'è a fin de ben.
Botte, no; Dio guardi. Ma urlare con loro e più di loro, sì: additando sui cartelloni figure d'animali e
d'ortaggi, scrivendo sulla lavagna sillabe e cifre, girando fra i banchi con l'illusione di mettere un
po' d'ordine nel passeraio, urlavo, urlavo sempre, da divenirne rauca. Riuscivo ad addolcire la voce
solo in fantastici racconti coi quali godevo calmare la loro irrequietezza: il tuffo nel meraviglioso li
rinfrescava, li rendeva miti come agnelli; ed io ne approfittavo per giungere attraverso la favola a
insegnar loro, di sorpresa, cose a cui non avrebbero, altrimenti, prestato attenzione. Mi amavano.
Sentivo che mi amavano. Non come una maestra: bensì come una compagna grande. Durante le
passeggiate del giovedì al Guado della Signora, e, di là, lungo il greto del fiume, non oso dire qual
fosse, fra loro e me, il più acceso a scoprir sassi e pietruzze variopinte.
A cogliere gigli d'acqua e malve selvatiche, a ingollar more, ferendosi gambe e mani nell'intrico dei
rovi. I più svelti mi portavano in classe fiori, lumache, spighe, semi speciali, bestioline bizzarre, con
cui s'improvvisavano lezioni e conversazioni gustose. Ma il baccano, vorrei dire, amorevole,
diveniva a volte così acuto nel tono, così impressionante, che il maestro Argentieri, dall'aula di
seconda e terza riunite, attigua alla mia, spalancava la porta, saliva sulla pedana della cattedra, e
standosene ritto in silenzio con le braccia conserte, rimetteva in dieci secondi le cose a posto.
Nemmeno una parola: la conosceva a fondo, lui, la potenza del silenzio. Alto, asciutto, lentigginoso,
con una vampa rossa di capelli a sommo della fronte e due occhi turchini quasi senza ciglia, tirava il
fiato.
(...) Era, lo confesso, un gran bel vedere, e un gran riposo, per qualche minuto: salvo poi a
ricominciare, quando il maestro aveva fatto dietro-front, ed era tornato ai fatti suoi. Alle spalle,
sottovoce, lo chiamavano el Rossin. Me li avrebbe bocciati tutti agli esami, e con soddisfazione, se
gli fosse riuscito.
Ma non poteva: facevan miracoli , e non parevano più loro; e io mi gonfiavo d'intima contentezza.
Candidi risvegli, il mattino. Mi destava, immancabilmente, la fragranza del pane caldo, appena
sfornato, che Chiarascura, fin dalle prime ore, vendeva, in silenzio, alle operaie della filanda e della
fabbrica di battúòro, alle massaie, alle contadine. Fragranza che mi faceva palpitar le narici e mi
dilatava il cuore e mi buttava giù dal letto con la gioia di cominciare una nuova giornata, d'amore e
d'accordo col sole e la pioggia, il freddo e il caldo, il previsto e l'imprevisto. Poteva essere il più
duro inverno, che l'odor del pane caldo richiamava in me l'immagine delle spighe di luglio,
fiammeggianti in attesa della falce, e delle pannocchie d'agosto, ben costipate ne' cartocci ruvidi,
con grani gemelli di cui non uno guasto, col bel pennacchio ricadente, d'un bruno rossiccio tal quale
come i miei capelli.
Allora mi lavavo con gran brividi e sbuffi, mi vestivo alla diavola, e dalla scaletta esterna mi
precipitavo nello stanzone del torchio: là sgranocchiavo non so quanti panetti.
Non li volevo intingere nella ciotola del latte ancora schiumante e tepido di mungitura; ma preferivo
gustarne il sapore di grano e farmeli crocchiare sotto i denti: il latte lo bevevo poi a sorsate. E via, a
scuola. (...)
86
La casa tra gli alberi
Renate Welsh
(...) Sulla strada che portava in paese le lucide scarpe nere si coprirono di polvere. Peter
trotterellava accanto a Eva. Si dava continui strattoni alla cravatta. Gerte gliel'aveva annodata
troppo stretta. Davanti alla scuola c'erano ragazzi grandi e piccoli, tutti con la loro lavagnetta. A
ognuna era appeso un cancellino, che ballonzolava a ogni movimento. In mezzo ai ragazzi ben
messi ce n'erano alcuni tutti sudici che correvano, si urtavano e si davano spintoni.
- Di nuovo quelli del Pian dell'Oca - disse una ragazza arricciando il naso.
Il maestro uscì dalla scuola: era vecchio, un uomo alto dai capelli grigi e vestito di grigio. A Eva
sembrò che avesse grigia anche la faccia. Batté le mani. - Mettetevi in fila per due! Entrate in aula
lentamente in silenzio!
Aveva una voce rauca, ma molto forte.Sotto il suo sguardo severo abbassarono la testa persino i
ragazzi più turbolenti. - Cos'è questo strascicare i piedi?- esclamò. - I ragazzi tedeschi camminano
ben diritti. E anche le ragazze.
Mentre entravano, squadrò ogni ragazzo da capo a piedi.
- Terzo banco dalla parte della finestra - disse a Eva, - e quarto banco dalla parte della porta - a
Peter.
Non osarono chiedere di potersi mettere l'uno vicino all'altra. Nelle prime due file di banchi il
maestro aveva sistemato quelli del Pian dell'Oca, a sinistra le ragazze, a destra i ragazzi, piccoli e
grandi alla rinfusa, poi venivano i più piccoli e in fondo c'erano quelli grandi di quattordici anni.
Il maestro restò fermo davanti alla porta dell'aula. I più grandi bisbigliarono: - In piedi!
Quando il maestro entrò nell'aula, alzarono il braccio e urlarono: - Heil Hitler!
In città la mamma aveva proibito a Eva di giocare con i bambini del secondo piano, perché i loro
genitori erano nazisti. Lì in paese a ogni domanda sui nazisti avevano ricevuto in risposta lo stesso
sguardo che riceveva a ogni domanda su papà.
C'era un mucchio di cose sulle quali non si poteva fare domande. Quasi tutte quelle che erano
interessanti .
- Sarebbe bella - disse il maestro - se non riuscissimo a fare di voi autentici ragazzi e ragazze
tedeschi, di cui il Führer possa essere orgoglioso.
Quelle parole suonarono come una minaccia. Improvvisamente Eva vide sul collo della ragazza
seduta davanti a lei un animaletto scuro che correva e che le sparì tra i capelli. La ragazza si grattò.
Dappertutto all'attaccatura dei capelli si notavano dei graffi. La compagna di banco di Eva alzò la
mano, non inclinata in avanti con le dita unite e il pollice in fuori, ma diritta verso l'alto. Il maestro
alzò il mento verso di lei.
- Signor maestro, quelli del Pian dell'Oca hanno i pidocchi. Ne ho visto uno adesso.
Lui annuì, come se non avesse aspettato altro. Fece venire quelli del Pian dell'Oca uno per uno
accanto alla cattedra, prese un bastoncino dal cassetto e lo passò tra i capelli dei ragazzi, come se
volesse far loro la scriminatura.
- Tutti pieni di lendini - disse disgustato.
- Ora riceverete una bottiglia di petrolio. Dite alle vostre mamme che stasera vi frizionino la testa
col petrolio e poi ve la avvolgano stretta con un panno. Di panni ne avete? Domani resterete a casa.
Dopodomani vi voglio vedere tutti con la testa lavata.
I ragazzi del Pian dell'Oca dissero : - Sì, signor maestro.
Non si vergognarono affatto. Uno di essi si volse e scrutò i compagni con aria di sfida. Il maestro
fece sgombrare i banchi della terza fila. - Dobbiamo scavare una trincea tra coloro che sono sani e
gli elementi infetti, un cordone sanitario, come dicono gli strateghi. - Rise. Era evidentemente una
battuta che Eva non aveva capito. Quella risata la turbava, si sentì sollevata quando il maestro smise
di ridere. Per il resto della mattinata dovette stringersi con gli altri ragazzi nei banchi in fondo
all'aula. - Sento che quell'uomo non mi piacerà - disse tornando a casa. Peter annuì.
- A me non piace già adesso.
87
(...)Lo sguardo di Eva cadde sull'orologio che era in cucina. Le due! Alle due e mezzo iniziavano le
lezioni pomeridiane, e per arrivare a scuola c'erano da percorrere quattro chilometri, tre quarti d'ora
buoni, andando svelti.
Eva e Peter partirono di corsa, ma dopo pochi passi si resero conto che la pancia troppo piena
impediva loro di correre.
Non potevano farcela, dovettero rassegnarsi all'idea di arrivare in ritardo.
- Mi sembra di avere uno zaino nella pancia - gemette Eva.
- Pensavo che fossero sei gnocchi, invece sono sei macigni - disse Peter .
Si trascinarono fino a scuola. Quando entrarono nell'aula, trenta paia di occhi si voltarono verso di
loro, senza contare lo sguardo irato del maestro.
Quest'ultimo esigette una spiegazione. Ma siccome ai due ragazzi non venne in mente alcuna scusa,
la spiegazione non fu data. Il maestro iniziò a parlare a bassa voce dello spirito di sacrificio delle
nostre truppe vittoriose, e continuò sempre più forte, asserendo che i due ragazzi con la loro
negligenza si dimostravano indegni di quel sacrificio. Infine afferrò la bacchetta e ordinò a Eva di
sdraiarsi sul banco. Le sollevò la gonna. I colpi le facevano male, la pancia piena le faceva male, ma
la cosa peggiore era che tutti potevano vederle le mutande. Proprio quel giorno indossava le
mutande azzurre, quelle tutte consumate a furia di essere lavate, che sembravano sporche. La
bacchetta sibilava nell'aria.
- Otto, nove, dieci - contò il maestro.
Poi fu la volta di Peter, i colpi schioccavano sui suoi calzoni di cuoio. Il maestro continuava a
picchiare, la fronte imperlata di sudore. Tredici, quattordici, quindici. Ai ragazzi toccavano più
colpi, o si era dimenticato di smettere?
- Gli faceva piacere - disse Eva mentre tornavano a casa. - Proprio un gran piacere.
Peter alzò le spalle.
- Per me fa proprio lo stesso.
- Per me no - disse Eva. Lui la guardò.
- Ma tu sei una ragazza. E poi con i calzoni di cuoio fa meno male. Fa solo un baccano.
Eva accelerò il passo, e quando Peter la chiamò si mise a correre.
88
La grande Gilly Hopkins
Katherine Paterson
(Edizioni Piemme)
(...) Il direttore stava esaminando dei documenti che dovevano essergli stati inviati dalla precedente
scuola di Gilly, la scuola elementare di Hollywood Gardens. Tossì ripetutamente. "Bene" disse
infine. "Credo che questa signorina abbia bisogno di essere inserita in una classe alla sua altezza".
"E' molto intelligente, se è questo che intende".
"Trotter, stupida che non sei altro, come fai a sapere quanto sono intelligente? Non mi hai mai visto
in vita tua prima di ieri."
"Ti inserirò nella classe della signorina Harris. Solitamente, in sesta abbiamo una parte di
departimentalizzazione, ma..."
"Avete cosa in sesta"?
"Oh, Trotter, chiudi quella boccaccia, per favore."
Ma il direttore non sembrò nemmeno accorgersi di quanto fosse imbecille Trotter.
Spiegò pazientemente che alcune delle classi seste si spostavano per le lezioni di matematica,
lettura e scienze, mentre la classe della signorina Harris rimaneva unita per l'intera giornata.
"Che noia mortale!"
Salirono le tre rampe di scale antiche fino alla classe della signorina Harris molto lentamente, in
modo che a Trotter non venisse un collasso. I corridoi puzzavano di cera per pavimenti e di
minestra della mensa. Gilly pensava di odiare tutte le scuole a un punto tale che niente potesse
ormai addolorarla o deluderla, eppure ogni gradino le sembrava più faticoso del precedente - come
un condannato a morte che percorresse un infinito ultimo miglio. Si fermarono davanti alla porta
con la scritta HARRIS-6. Il signor Evans bussò, e la porta fu aperta da un'alta donna con il volto
color del tè, coronato da un cespuglio di capelli neri. Sorrise guardando tutti e tre dall'alto in basso,
perché‚ era più alta anche del direttore.
Gilly si ritrasse, andando a sbattere contro l'enorme petto di Trotter, il che la fece rimbalzare subito
in avanti. Dio! Come se non bastasse, l'insegnante era di colore.
Nessuno sembrò accorgersi della sua reazione, anche se negli occhi scuri della signorina Harris
sembrò passare un lampo abbagliante.
Trotter fece una carezza sul braccio di Gilly, mormorò qualcosa che finiva in "tesoro" e poi lei e il
direttore si ritirarono, chiudendo Gilly nella classe HARRIS-6.
L'insegnante l'accompagnò fino a un banco vuoto al centro della classe, le chiese la giacca e la
passò a un'altra ragazza perché l'appendesse all'attaccapanni in fondo all'aula.
Disse a Gilly di sedersi, e poi andò ad accomodarsi alla grande cattedra per dare un'occhiata
all'incartamento lasciatole dal signor Evans. Un attimo dopo alzò lo sguardo, mentre un ampio
sorriso le illuminava il viso. "Galadriel Hopkins. Che nome stupendo! Da Tolkien, naturalmente."
"No" borbottò Gilly. "Da Hollywood Gardens."
La signorina Harris emise una risata argentina. "No, volevo dire il tuo nome, Galadriel. E' il nome
di una grande regina in un libro scritto da un uomo di nome Tolkien. Ma sicuramente lo sapevi già."
Diavolo. Nessuno le aveva mai detto che il suo nome era stato tratto da un libro. Era meglio fingere
di sapere già tutto o fare la finta tonta?
"Mi piacerebbe chiamarti Galadriel, se non ti dispiace. E un nome tanto bello!"
"NO!". Tutti si voltarono verso Gilly guardandola in uno strano modo. Doveva aver gridato più
forte di quanto non avesse intenzione di fare. "Preferirei" disse in tono secco "essere chiamata
Gilly."
"Va bene." La voce della signorina Harris assomigliava più all'acciaio, ora, che all'argento. "Allora
vuol dire che ti chiamerò Gilly". Poi si rivolse sorridente al resto della classe. "Dov'eravamo
arrivati?"
Il clamore delle risposte dei compagni le colpì il cervello. Gilly fece per abbassare la testa sul
banco, ma qualcuno le stava infilando un libro sotto il naso. Era un'ingiustizia, una vera ingiustizia.
Una volta, in un libro, aveva visto un'illustrazione che rappresentava una volpe rossa su un'alta
89
roccia circondata da cani ringhiosi. Ecco, era proprio così. Lei era più intelligente di tutti, ma loro
erano troppi. L'avevano circondata, ed erano pronti ad annientarla con i loro stupidi mezzi. La
signorina Harris si stava chinando su di lei. Gilly si ritrasse il più possibile.
"Hai fatto le divisioni con le frazioni, a Hollywood Gardens?"
Gilly scosse la testa. Dentro, ribolliva. Era già un oltraggio essere costretti a frequentare quella
vecchia scuola cadente, ma ritrovarsi addirittura indietro - sembrando più stupida del resto dei
ragazzi - dover apparire una sciocca davanti a...
Quasi metà della classe era composta da neri. E lei sarebbe apparsa stupida a "loro". Un mucchio
di...
"Perché‚ non accosti la tua sedia alla cattedra, così ci lavoriamo su?"
Gilly afferrò la sedia e arrivò alla cattedra prima della signorina Harris. Gliel'avrebbe fatta vedere
lei! (...)
La faceva infuriare rendersi conto di essere indietro in quasi tutte le materie, ma sapeva che la colpa
non era sua, bensì della scuola elementare di Hollywood Gardens. Avrebbe lavorato sodo finché‚
non solo li avesse raggiunti, ma anche sorpassati, e poi si sarebbe fermata completamente. Quella
strategia faceva impazzire gli insegnanti.
Il fatto che qualcuno che evidentemente batteva di gran lunga il resto della classe
si rifiutasse improvvisamente di stare alle regole del gioco costituiva per loro un affronto personale.
Proprio così. E nel caso della signorina Harris questa era esattamente la situazione che Gilly voleva
si creasse. (...)
Entro la terza settimana di ottobre Gilly aveva recuperato il divario tra lei e gli altri alunni della
classe e li aveva addirittura superati. Ormai aveva messo all'angolo la signorina Harris, costretta
com'era a darle sempre il voto più alto.
Certo doveva riuscirle penoso scrivere quei commenti entusiastici - "Eccellente", "Bene,
esposizione molto chiara", "Ottimo lavoro" - sui compiti di una persona che la odiava in modo così
evidente.
Ma la signorina Harris era un tipo calmo e controllato. Anche se aveva capito che Gilly la
disprezzava, non l'aveva mai lasciato trasparire. E così, Gilly non era ancora pronta a giocarle il suo
classico tiro, che consisteva appunto nello smettere di lavorare proprio quando l'insegnante si era
convinta di avere per le mani un genio.
La cosa aveva funzionato a meraviglia a Hollywood Gardens, l'intero corpo insegnante
era rimasto di sasso quando lei aveva iniziato a consegnare fogli in bianco. (...)
Certi giorni, a Gilly non importava quel che pensava o non pensava la signorina Harris.
Era piuttosto piacevole andare a scuola senza doversi aspettare strilli isterici o lusinghe e blandizie,
sapendo che il proprio lavoro sarebbe stato giudicato sulla base dei suoi pregi e non grazie
all'opinione personale dell'insegnante sulla persona che l'aveva svolto. Era un po' come giocare a
basket. Se si prendeva bene la mira, si riusciva a far entrare la palla nel canestro; era un gioco
imparziale e assolutamente impersonale. Altri giorni, invece, l'indifferenza della signorina Harris
dava sui nervi a Gilly. Non era abituata a essere trattata come tutti gli altri. Fin dalla prima
elementare, aveva costretto i suoi insegnanti a considerarla un caso a parte. Era lei la responsabile
della propria istruzione. Aveva imparato quanto e come le pareva. Gli insegnanti l'avevano
corteggiata e maledetta, ma nessuno, prima di allora, l'aveva semplicemente equiparata al resto
della classe.
(...) Prese in prestito un po' di soldi da Trotter per "materiale scolastico"
e comprò un pacchetto di pesante cartoncino bianco, e dei pennarelli. Dietro la porta chiusa della
sua camera iniziò a confezionare una cartolina d'auguri, cercando di farla assomigliare il più
possibile alle lunghe e sottili cartoline "scherzose" esposte sullo speciale piedistallo girevole
dell'emporio. Prima tentò di disegnare una figura sulla prima pagina, sprecando in questo modo
cinque o sei preziosi cartoncini.
Maledicendosi per la propria incompetenza, rubò una delle riviste di Trotter e ne ritagliò la figura
alta e sottile di una splendida donna nera che indossava un costume afro. La pelle era un po' più
scura di quella della signorina Harris, ma non troppo.
Sopra la figura della donna scrisse con cura queste parole (con lo stampatello se la cavava bene,
90
anche se il disegno non era il suo forte):
Sl DICE "NERO E BELLO!".
Poi, sotto la figura:
MA PER QUEL CHE PARE A ME
TUTTI QUELLI CHE LO DICONO
SEMBRANO PROPRIO...
E infine all'interno del biglietto, in caratteri minuscoli ...
Persone con un oscuro interesse ad affermare questo punto di vista.
(...) Quando suonò la campanella delle tre, sbatté‚ la sedia rovesciata sul banco e si diresse verso la
porta.
- Gilly.
Il cuore le diede un balzo, mentre si girava verso la signorina Harris.
- Puoi aspettare un minuto, per favore?
Rimasero entrambe in attesa, fissandosi in silenzio mentre l'aula si svuotava. Poi la signorina Harris
si alzò dalla cattedra e chiuse la porta. Prese una sedia da uno dei banchi della prima fila e la mise a
poca distanza dalla sua. - Siediti un attimo, va bene?
Gilly si sedette. Il libro di matematica sembrava intonso, con il bordo della cartolina che spuntava ai
due lati.
"Ti sembrerà incredibile, Gilly, ma io e te siamo molto simili."
L'attenzione di Gilly si risvegliò suo malgrado.
"Non mi riferisco all'intelligenza, sebbene sia vero anche questo. Siamo tutte e due intelligenti, e lo
sappiamo. Ma la cosa che ci avvicina, più che l'intelligenza, è la rabbia. Tu ed io siamo tra le
persone più arrabbiate che io conosca." Disse tutto ciò con una voce calma che tagliava ogni parola
dall'altra quasi fosse una fetta sottile, e poi attese, come per dare a Gilly la possibilità di
contraddirla. Ma Gilly era affascinata, come i protagonisti di un film che osservino un cobra che si
avvicini. Non voleva fare una mossa falsa.
"Naturalmente, usiamo la nostra rabbia in modo diverso. A me è sempre stato insegnato a negare la
mia, e io l'ho sempre fatto e lo faccio ancora. Ed è questo che mi porta a invidiarti. (...) Ma non ti ho
chiesto di fermarti dopo la scuola per dirti quanto sei intelligente e quanto ti invidio: l'ho fatto per
ringraziarti della tua cartolina." Doveva essere un sorriso ironico, ma HARRIS-6 stava sorridendo
quasi come un essere umano. Quando avrebbe colpito il cobra? "Me la sono portata nella sala
insegnanti a mezzogiorno, e ho imprecato creativamente per venti minuti. Sono anni che non mi
sentivo tanto bene."
Era impazzita, come il computer di 2001 Odissea nello spazio. Gilly si alzò e iniziò a indietreggiare
verso la porta. La signorina Harris continuò a sorridere, senza tentare di fermarla in alcun modo.
Non appena raggiunta la scalinata, Gilly si mise a correre e, imprecando creativamente, continuò a
correre fino a casa. (...)
91
La lente focale - Gli zingari nell'Olocausto
Otto Rosenberg
(Marsilio)
(...) Mi comprò dei pantaloni alla zuava con dei cinturini che si allacciavano all'altezza del
ginocchio, delle scarpe nuove e un berretto. In qualche modo volevano dimostrarsi gentili con noi.
Così conciato sembravo un altro. Non si può immaginare la gioia che provai nell'andare a scuola
vestito in quel modo. Schukalla non parlava, abbaiava.
Mio zio l'ha incontrato dopo la guerra. E sa che cosa gli ha detto?
"Be' dopotutto non ve la passavate così male a Marzahn. Va be', vi avremo dato un paio di schiaffi,
però in fondo vi trattavamo bene, no?"
Io e mia sorella diventammo rappresentanti di classe, io per i ragazzi e mia sorella per le ragazze.
Forse ci scelsero perché, oltre a far bene il nostro lavoro, eravamo sempre pronti ad aiutare gli altri,
non lo so. Comunque noi due eravamo molto legati, anche perché eravamo i più piccoli. Therese
aveva una malformazione alla valvola cardiaca e quando il cuore non batteva regolarmente
cominciava a scuotere velocemente la testa,
era terribile vederla in quello stato, purtroppo all'epoca non capimmo che in quelle condizioni
avremmo dovuto farla ricoverare d'urgenza.
È vero, prendeva delle gocce, ma non è che l'aiutassero molto. Nonostante fosse malata era molto
sveglia, sicuramente più intelligente di me e anche più brava a scuola. Fare i lavori di casa però le
pesava molto, non so, pulire, lavare i piatti, spazzare. Purtroppo essendo una ragazza le toccava farli
lo stesso.
Poiché ero sempre il primo ad arrivare a scuola mi divertivo a suonare la campana che pendeva
sulla porta dell'ingresso anteriore per avvertire gli altri che era ora di alzarsi:" din don, din don, din
don!" E dopo un po' si vedevano i primi bambini venir fuori dalle loro baracche o dai loro
carrozzoni. La donna addetta alle pulizie a quell'ora aveva già finito.
Più tardi arrivava anche il nostro insegnante, ci si piazzava davanti e faceva il saluto tedesco: " Heil
Hitler! Sedetevi!"
Prima di cominciare la lezione ci ordinava di mettere le mani sul tavolo. Chi ce le aveva sporche
doveva andarsele a lavare, poi poteva ritornare in classe.
Quando facevamo ricreazione invece, dovevamo toglierci le scarpe e far vedere i piedi, e anche in
questo caso chi ce li aveva sporchi doveva andare fuori a lavarseli.
Io ero contento quando capitava a me perché mi divertivo.
Fuori c'era la pompa. Uno pompava e gli altri si lavavano e correvano intorno alla pompa. Per noi
bambini era uno spasso.
Quando mancava qualcuno l'insegnante mi diceva: "Otto, valli a cercare e digli che devono venire a
scuola."
E io andavo e bussavo alle porte dei carrozzoni o delle baracche.
Qualche volta li trovavo che dormivano ancora, scompigliati e con qualche piuma nei capelli.
"Ehi, dai che devi venire a scuola, sbrigati che l'insegnante ti sta aspettando!"
"Accidenti, stamattina non ci siamo svegliati!" Si vestivano in fretta e correvano a scuola.
L'insegnante, il signor Barwich, li sgridava, ma non più di tanto. (...)
92
La maestrina Boccarmè
Luigi Pirandello
(...) Appena terminata la scuola del pomeriggio, la maestrina Boccarmè soleva recarsi alla
passeggiata del Molo, e là, seduta sulla spalletta della banchina, si distraeva guardando con gli altri
oziosi le navi ormeggiate: tre alberi e brigantini, tartane e golette, ciascuna col suo nome a Poppa:
L'Angiolina, Colomba, Fratelli Noghera, Annunziatella, e il nome del porto d'iscrizione: Napoli,
Castellammare di Stabia, Genova, Livorno, Amalfi: nomi, per lei che non conosceva nessuna di
queste città marinare; ma che, a vederli scritti lì sulla poppa di quelle navi, diventavano ai suoi
occhi cose vicine, presenti, d'un lontano ignoto che la faceva sospirare. E ora, ecco, arrivavano le
paranze, una dopo l'altra, con le vele che garrivano allegre, doppiando la punta del Molo; ciascuna
aveva già pronte e scelte in coperta le ceste della pesca, colme d'alga ancor viva. Tanti accorrevano
allo scalo per comperare il pesce fresco per la cena; lei restava a guardar le navi, a interessarsi alla
vita di bordo, per quel che ne poteva immaginare a guardarla così da fuori.
S'era abituata al cattivo odore che esalava dal grassume di quell'acqua chiusa, sulla cui ombra
vitrea, tra nave e nave, si moveva appena qualche tremulo riflesso. Godeva nel vedere i marinai di
quelle navi al sicuro, adesso, là nel porto, senza pensare che a loro forse non pareva l'ora di ritornare
a qualche altro porto. E sollevando con gli occhi tutta l'anima a guardare nell'ultima luce la punta
degli alti alberi, i pennoni, il sartiame, provava in sé, con una gioia ebbra di freschezza e uno
sgomento quasi di vertigine, l'ansia del tanto, tanto cielo, e tanto mare che quelle navi avevano
corso, partendo da chi sa quali terre lontane.
Così fantasticando, talvolta, illusa dall'ombra che si teneva come sospesa in una lieve bruma
illividita sul mare ancora chiaro, non s'accorgeva che a terra intanto, là sul Molo, s'era fatto buio e
che già tutti gli altri se n'erano andati, lasciandola sola a sentire più forte il cattivo odore dell'acqua
nera sulla spiaggia, che alla calata del sole s'incrudiva. La lanterna verde del Molo s'era già accesa
in cima alla tozza torretta bianca; ma faceva da vicino un lume così debole e vano, che pareva quasi
impossibile si dovesse poi veder tanto vivo da lontano.
Chi sa perché, guardandolo, la maestrina Boccarmè avvertiva una pena d'indefinito scoramento; e
ritornava triste a casa.
Spesso però, la mattina dopo, nell'alba silenziosa, mentre qualche nave con tutte le vele spiegate che
non riuscivano a pigliar vento salpava lentamente dal Molo rimorchiata da un vaporino, più d'un
marinaio uscito a respirare per l'ultima volta la pace del porto che lasciava, del paesello ancora
addormentato, s'era portata con sé un tratto l'immagine d'una povera donnina vestita di nero che, in
quell'ora insolita, dal Molo deserto aveva assistito alla triste e lenta partenza. Perché piaceva anche,
alla maestrina Boccarmè, intenerirsi così, amaramente, allo spettacolo di quelle navi che all'alba
lasciavano il porto. E s'indugiava più a sognare con gli occhi alle vele che a mano a mano si
gonfiavano al vento e si portavano via quei naviganti, lontano, sempre più lontano nella luminosa
vastità del cielo e del mare, in cui a tratti gli alberi scintillavano come d'argento; finché la campana
della scuola non la richiamava al dovere quotidiano.
Quando le scuole erano chiuse per le vacanze estive, la maestrina Boccarmè non sapeva che farsi
della sua libertà. Avrebbe potuto viaggiare, coi risparmi di tanti anni; le bastava sognare così,
guardando le navi ormeggiate nel Molo o in partenza. (...)
93
La mano nel cappello
Nicola Cinquetti
(Piemme)
(...) I miei insegnanti non erano quegli orchi e polifemi che avevo immaginato prima di iniziare la
scuola. Erano persone piuttosto bonarie, prive d'animosità. In particolare, le mie simpatie si
rivolgevano alla professoressa di italiano, la signora Eugenia Manzi. Se i primi giorni rimasi colpito
anzitutto dalla sua mandibola sporgente e dal leggero strabismo dei suoi occhi, a poco a poco
apprezzai sempre di più la chiarezza della sua personalità e la serenità che riusciva a diffondere in
classe durante le lezioni. A differenza degli altri professori, ci chiamava per nome e dimostrava un
interesse particolare per ciascuno di noi. Dopo le prime prove di italiano, cominciò a incoraggiarmi,
dicendo che nello scritto rivelavo di sapermi esprimere e di essere riflessivo: - Mi piacerebbe che tu
portassi il tuo contributo anche nelle discussioni che teniamo in classe.
Durante le ore di italiano, si affrontava spesso una tematica di attualità. A partire da una lettura
tratta dall'antologia, l'insegnante avviava la conversazione, cercando di coinvolgere tutti. Trattammo
così numerosi argomenti, dai problemi della scuola a quelli dell'adolescenza, dalla condizione della
donna alla questione religiosa.
Una mattina, era ormai autunno inoltrato, si lesse in classe un brano inerente alla problematica
dell'handicap, la lettera aperta di una madre, che raccontava la sua esperienza di vita con una figlia
disabile. La professoressa ci chiese se conoscevamo l'origine della parola handicap. Nessuno seppe
rispondere con precisione, e allora ci spiegò che si tratta di un termine di derivazione inglese:
- E' una parola usata nel mondo delle corse ippiche, dove vengono assegnati svantaggi iniziali ai
cavalli più forti, in modo da riequilibrare la gara. Handicap vuole dire dunque svantaggio, ma
letteralmente il suo significato è da scomporre nell'espressione hand in cap, in italiano mano nel
cappello: forse perché da un cappello venivano estratti a sorte i numeri che assegnavano le posizioni
di partenza ai cavalli in gara.
Io ascoltavo e pensavo alla sera in cui Geremia aveva tratto con la mano, dal suo cappello nero,
festosi coriandoli colorati. La professoressa Manzi ci domandò allora se avevamo mai conosciuto
persone con handicap. Io sussultai dentro di me, combattuto tra il desiderio di intervenire e il timore
di impaperarmi.
Parlò un mio compagno, Giovanni : - Quando vado in vacanza, d'estate, c'è un handicapato in
carrozzina, un ragazzo, che abita vicino a noi. Io lo saluto, ma non ho fatto amicizia. A volte mi
piacerebbe avvicinarmi a lui, ma poi non so cosa dire, non so cosa fare.
La professoressa annuì, senza commentare.
- Anch'io - intervenne Anna De Marchi - conosco degli handicappati. C'è un centro per loro nel mio
quartiere, e li vedo tutti i pomeriggi, poveretti, quando partono con il furgone.
- Perché hai detto poveretti? - domandò l'insegnante.
- Perché... perché sono così - rispose Anna, sorpresa per la domanda.
- Hai mai parlato con loro?
- Sinceramente... no.
- Perché?
- Perché. . . non so. Non li conosco.
- Io l'anno scorso a Natale - disse invece Marino - sono andato con il mio gruppo a cantare in un
istituto per handicappati. E stato bello, ci hanno fatto una grande festa, alla fine non volevano più
lasciarci andare via.
- Poi non sei più tornato? -, domandò la professoressa.
- No, ma forse a Natale ci andremo ancora.
Io seguivo i discorsi dei miei compagni con estrema attenzione. C'era qualcosa, nelle loro frasi, che
mi metteva un po' a disagio. Forse era quella lunga parola, che ripetevano in continuazione:
handicappati.
La pronunciavano in modo strano, un po' come se dicessero: extraterrestri. Ma chi sono, gli
94
handicappati? I miei amici della cascina? Oh, no quelli sono Carlo, Lorenzo, Francesca. . .
Cominciai a pensare che i miei compagni, anche i più bravi, avessero un'idea un po' falsata riguardo
a quelle persone.
Nel tono delle loro frasi percepivo un'ansia, un senso di paura. Già, doveva essere cosi: i miei
compagni avevano paura, la stessa che avevo avuto io quel giorno, prima di entrare alla cascina,
paura di trovarsi di fronte a uomini e donne carichi solo di dolore e di stranezze. Anch'io, quella
sera, prima di suonare il campanello, avevo temuto, come Giovanni, di non sapere cosa dire e cosa
fare. Erano passati alcuni mesi, e nel frattempo qualcosa era cambiato.
Alzai la mano. La professoressa mi guardò benevolmente e mi diede la parola: - Di fronte a casa
mia c'è una comunità dove vivono cinque di queste persone: si chiamano Carlo, Lorenzo, Geremia,
Costanza e Francesca. Non è tanto che abito lì, è da questa estate. Quando sono arrivati, io ero
molto incuriosito, ma avevo paura ad avvicinarli. Li guardavo da lontano, mi sembravano strani.
Poi, un giorno mi hanno invitato a una festa di compleanno. Io non sarei voluto andare, ma non
sono riuscito a dire di no. Prima di entrare, quella sera, davanti al cancello, mi sono domandato
anch'io:
<< Che cosa dovrò fare? Che cosa dovrò dire?>>. Sono entrato, e ho scoperto che non dovevo fare
niente di particolare, e non dovevo dire niente di particolare. E stato molto più semplice di quanto
credessi, perché sono persone. . . come posso spiegarmi?. . . Vere, sono persone vere. Da quel
giorno siamo diventati amici, eppure io non sono certo un ragazzo spigliato, tutt'altro: se è stato
possibile per me, può esserlo per tutti.
I miei compagni mi avevano ascoltato in silenzio. Qualcuno, alla fine, aveva sorriso, ma per
simpatia. Sorrise anche la professoressa, che mi disse: - Allora, se vuoi, William, sei capace di
parlare! E proprio cosi difficile?
- Beh. . . no. . . Un po'. . .
- E mi sembra - continuò - che tu sappia anche dire cose intelligenti!
- Insomma. . .
Durante la ricreazione, quella mattina, un gruppetto di compagni mi si avvicinò.
Non era mai accaduto. Vollero sapere qualcosa di più sui miei amici della cascina e poi mi rivolsero
molte domande su di me, volevano conoscermi. Uno mi offrì metà della sua merenda, un altro mi
propose di andare nel banco con lui, poiché il suo compagno si era ritirato. Io sorridevo a tutti,
frastornato da tutte quelle attenzioni. Al termine delle lezioni, Alberto, il mio nuovo compagno di
banco, decise di prendere il mio stesso autobus fino alla stazione:
- Allungo un po' la strada, ma lo è stesso.
Sull'automezzo parlammo senza soste dei più svariati argomenti, e scoprii che Alberto aveva una
bicicletta da corsa, come me, ed era un appassionato delle gare di ciclismo, e ogni anno saltava un
giorno di scuola per andare sulle Dolomiti a vedere la tappa del Giro d'Italia. Anche lui sapeva
suonare la chitarra, e aveva gli stessi miei gusti musicali. Parlammo dei nostri insegnanti... (...)
95
La penna rossa
Marino Moretti
("Maestrine" - Sellerio)
Nella valletta dei Tre Fiumi, allo sbocco di Ronta, e cioè nel cuore di quel Mugello che aveva dato a
Firenze alcuni dei suoi artisti migliori, a cominciare da Giotto, e i suoi grandi Medici, la scuoletta
della ben nota Lara Guidacci - altra maestrina della penna rossa - risuonava ancora dopo dieci anni,
come un alveare.
Erano dunque passati dieci anni scolastici e la penna rossa restava al suo posto come insegna d'un
modesto cappello, se non come l'inestinguibile fiamma d'una vocazione o disposizione d'animo di
cui aveva ormai avuto notizia l'intero Mugello press'a poco come dell'incontro di Giotto con
Cimabue, non lungi dalla Torre di Romagnano. E bisogna pur dire che da quelle parti nessuna
maestrina mai aveva portato cappello bastando, per gran parte dell'anno, recarsi alla scuola molto
alla buona, in capelli. Ma lei s'era modellata fin da principio su una delle maestrine del Cuore e
precisamente su quella dalla penna rossa, riuscendo nei primissimi tempi ad aver anche il viso color
di rosa, com'era detto nel libro, e le pozzette alle guance, le famose pozzette; più - si capisce - la
penna rossa e la crocetta di vetro giallo appesa al collo, com'era detto nel libro per il più felice di
quei ritrattini.
In verità, lei s'era dedicata alla scuola, oltre che al libro che dalla stessa era nato, perché la sorte la
voleva mamma di tanti bambini (tutti gli anni si rinnovavano) e non di uno solo.
Altre ragazze della sua condizione si facevano allora suore o anche solo maestrine per una
delusione amorosa. Lei si sarebbe vergognate d'ammettere codesto, tanto più che non aveva nulla da
rimproverare ai giovanotti di quelle parti, salvo forse uno, certo Stefano di Vicchio, che doveva
mancarle di rispetto in un modo così impreveduto che l'aveva insieme costernata e compiaciuta (due
sentimenti non ben mescolati se il secondo doveva in seguito prevalere); parendole che soltanto da
questi eccessi di confidenza molto simili alla sguaiataggine cavalleresca potesse nascere qualcosa di
durevole come la simpatia e la propensione amorosa.
Disgraziatamente il giorno dopo quel bel tipo le aveva chiesto scusa dando la colpa della sua
"imprudenza " a un bicchier di vino bevuto di troppo. Non s'era accorto insomma che una giovane
donna non voleva altro da lui, pur deplorando come educatrice la zotichezza dei bellimbusti di
campagna. Così quel tanghero con la sua sciocca idea di resipiscenza, aveva fatto l'infelicità della
maestrina dei Tre Fiumi.
S'era poi messa, la Guidacci, il cuore in pace continuando ad amare il suo libro per ragazzi con una
sorta di fedeltà che somigliava alla fedeltà del sentimento verso le persone care o verso l'ingenuo
passato: solo che se allora lo aveva preferito da scolaretta, ora lo amava come maestrina. E
continuava a pensarne l'autore come "il più cordiale e affabile dei nostri moderni scrittori" e magari
"il primo di tutti", allo stesso modo che, nel libro, il primo della classe era quel simpaticone di
Derossi: e quasi quasi più come Derossi che come De Amicis. Quando poi aveva saputo dai giornali
che a Torino s'era festeggiata la trecentomillesima copia del libro con un banchetto, lei avrebbe
voluto mandare un telegramma firmato "maestrina penna rossa".
E così avrebbe voluto confessare a qualcuno che codesto Cuore era addirittura il suo piccolo
vangelo; per tante e tante ragioni, ma anche e sopra tutto perché un giovane dei dintorni, uno di San
Piero a Sieve (non avrebbe mai detto di dove veramente proveniva, proprio di più vicino, da
Vicchio) dapprima le aveva mancato di rispetto, poi... poi, ecco, non era saputo andare più oltre
nell'irta strada della maschia soperchieria. (...)
Votarsi a De Amicis - il primo scrittore d'Italia era stato per lei come votarsi al pulzellaggio, e non
le pareva davvero d'essersi sacrificata, anche se l'idea del celibato di lui avesse insinuato di tratto in
tratto qualche asprigna dolcezza. Vero è che i suoi piccoli mugellesi della valletta dei Tre Fiumi la
consolavano presto di tutto. Quest'anno poi ne aveva giusti quarantaquattro e il numero, per quanto
esagerato, le piaceva straordinariamente perché erano proprio quarantaquattro - non uno di più non
uno di meno - i ragazzi che componevano la scolaresca di cui si faceva la storia nel Cuore. Perciò
forse la maestrina della penna rossa era sempre alla ricerca d'analogie.
96
C'era poi nella sua terza un solido torello dalle spalle larghe e dalla testa grossa come Garrone,
c'erano i capelli rossi di Crotti, non mancava il berretto di pelo di gatto del bravo Coretti e neppure
il muso di lepre del muratorino, né la giacca troppo lunga del figliolo del fabbro ferraio: non si
trovava tuttavia qualcuno da potersi paragonare al piccolo Nelli ch'era, purtroppo, un gobbino. Ma
si doveva sul serio e per la varietà desiderare proprio in classe un gobbino?
Lei intanto non aveva già più il bel viso color di rosa, color naturale, né le due pozzette alle guance:
cioè le guance sfiorite davano tutt'altra espressione a quel visetto ormai stanco, e per il resto
s'aiutava qualche volta lei stessa con uno scatolino di cipria rosa, sempre per rendere omaggio al
suo autore. Finché un giorno le dicono che il suo autore, il quale era, fra l'altro, anche membro del
Consiglio superiore dell'Istruzione, e si fermava volentieri a Firenze di ritorno da Roma, le dicono
dunque che da Firenze egli avrebbe fatto un'apparizione in Mugello rinnovando per suo conto il
pellegrinaggio del Carducci che in Mugello era stato ospite di Luigi Brilli e della sua illustre
compagna, la Poetessa Marianna.
(...) Egli entrò in aula con tre o quattro autorevoli signori del luogo - un modesto seguito in cui si
trovava il suo figliolo superstite, l'altro s'era ammazzato e la scolaresca, nella quale erano Garrone e
Garoffi, Crotti e Coretti, e il muratorino, scattò in piedi a un gesto risentito della maestrina. La
quale poi non fece in tempo a riconoscere l'illustre canizie, i mustacchi bonari, l'ampia fronte
luminosa del suo idolo perché, oh Dio, perché restava al fianco di lui Stefano di Vicchio, come se il
famoso Capitan Cortese le riportasse per cortesia il suo fidanzato, come se l'autore del Cuore le
restituisse il cuore dove era rimasto indelebile nei lunghi anni, l'immagine di lei, della maestrina di
ventitré anni.
Sempre lo stesso l'ormai maturo Stefano di Vicchio, nel viso pieno di ragazzone, sebbene
ingrassato, appesantito, solido, quel che si dice un "bell'uomo", espressione che tuttavia invecchia di
solito il sopraggiunto di cinque o sei anni, almeno. E non aveva costui nemmen dato la mano alla
maestrina, da molt'anni non riveduta, ma per la buona ragione che gli accompagnatori avevano
lasciato che il solo a stringere la mano fosse l'ospite insigne; mentre a un più attento esame l'ospite
insigne, come sbarazzatosi di colpo della sua aureola di santità letteraria per tornare quel che
realmente era, il poco felice viandante al termine del lungo cammino come dell'onesta fatica,
appariva in definitiva uomo deluso, oltre che stanco, forse tradito o sacrificato, e sopra tutto
d'occhio scrutatore. E questo diceva come un'intelligenza esperta d'ogni ripostiglio del cuore umano
- ma sottaciuta - facesse la bonomia di lui armata press'a poco come il malanimo.
Intanto egli confessava alla signorina la sua curiosità per questi piccoli virtuosi della pronunzia
accennando agli scolari dei primi banchi, e al tempo stesso ringraziava i signori che gli procuravano
l'emozione della scuoletta mugerese dando il maggior merito a chi gli era stato maggiormente alle
costole, Stefano di Vicchio, e che ora si ritraeva confuso, non si sa se per modestia o per fastidio
d'esser tirato in ballo.
- Come? non è stato lei a parlarmi per primo della signorina?
- Signore, per la verità...
- Che sia stato lei a dirmi che questa scuola è numerosa come la mia di Torino, che anzi ha lo stesso
numero di scolari, o che sia stato un altro, rimasto magari a Firenze, non ha alcuna importanza,
vero?
La maestrina aveva capito che l'uomo di Vicchio non s'impegnava e per darsi un contegno ricordò a
se stessa una cosa molto gradevole: la penna rossa. Non poteva logicamente tenere il cappello sulla
cattedra perché lo storico delle scolaresche ve la riconoscesse. E, d'altra parte, sapeva d'esser
toscana solo a metà, e cioè d'esser scesa in Mugello da quelle propaggini di Romagna che
appartenevano allora a Firenze, Romagna toscana, e la sua pronunzia non poteva quindi ritenersi
impeccabile.
Ma doveva deludere fino a tal punto il grande ospite che cercava la perfezione in via Tornabuoni
come ai Tre Fiumi?
Egli apriva intanto un libro di scuola e lo portava gentilmente a uno scolaretto di prima fila, che
invitava subito alla lettura, poi si preparava a bearsi e ascoltava a occhi socchiusi. Tutti leggevano
splendidamente. Faceva egli notare che codesto modo di leggere era assai più conforme ai modo di
parlare, specie nei dialoghi, e sopra tutto nelle interrogazioni, nelle esclamazioni, cui difficilmente
97
san dare il tono gli altri ragazzi. Il modo poi di pronunziare il c davanti all'i - quasi sci - nella parola
bacio gli pareva facesse quasi sentire il suono d'un bacio leggero, e la maestrina e Stefano di
Vicchio si guardarono per un istante, e quale non fu la sorpresa di lei nel riconoscere che per via del
bacio con l'sc lui l'aveva guardata in un altro modo, finalmente longanime, e sorridendo quasi di
gratitudine, tanto per lo sguardo istintivo della ragazza non più giovane quanto per la trovata
dell'ospite insigne che aveva saputo rompere il ghiaccio. Pareva che da questo punto i due si fossero
intesi, convinti ormai l'una e l'altro che il merito spettasse all'uomo del Cuore. Il quale, avendo l'aria
di non accorgersi di nulla, traeva dalla tasca che aveva molto capace diversi foglietti su cui aveva
scritto a grandi caratteri una serie di strani motti come: "Andò a tòrre la chiave della tórre",
"Cominciò a dar bòtte alla bótte", "Accètta in dono questa accétta", e si divertiva a distribuirli ai
ragazzi, e più ancora si divertiva quando ciascun lettore dava ad ogni vocale, in ciascun vocabolo, il
suo giusto suono senza pensarci sopra un momento. Bocchine fortunate, veramente! Ora provava a
far dire un verso di Dante: Con l'ali aperte e ferme al dolce nido, che "noi barbari sogliamo dire
dando lo stesso suono largo alla prima e di aperte e all'o di dolce e di nido" (così egli s'era già
confidato, sottovoce, all'insegnante che ora restava accanto a quel di Vicchio); e anche questa prova
riesce: lo scolaro (è l'apocrifo Crotti) pronunzia strettissime due delle vocali che esigono l'accento
acuto, sì che da una piccolissima differenza, secondo codesto orecchio nordico squisito, il verso
acquistava un'armonia sensibilmente più varia e molto più delicata.
- In tal modo - concludeva De Amicis con l'aria d'inchinarsi all'insegnante che non ci aveva alcun
merito in tal modo, - senza dubbio, pronunziò questo suo verso lo stesso autore Dante Alighieri.
Infine Stefano di Vicchio, come se non stesse in sé dalla gioia e si facesse avanti quasi per
sovrapporsi a un De Amicis, prese lui l'iniziativa e ingiunse a uno di quegli scolaretti di pronunziare
ad alta voce la frase: "Quando torno a casa, do subito un bàscio alla mamma", non si sapeva se per
far cosa grata allo scrittore a cui piaceva tanto sentir pronunziare il c davanti all'i - sci come sciolto o se per far piacere alla maestrina a cui la parola bacio doveva pur dire, dopo tanti anni, qualcosa.
Se non addirittura ch'egli sarebbe tornato a lei, e non c'era nulla di propiziatorio per loro due come
la visita deamicisiana alla scuola di codesta valletta dei Tre Fiumi.
E forse costui pensava davvero che il maggiore scrittore italiano favoriva, senza saperlo, la tardiva
resipiscenza d'un mugeflese, fedele tuttavia se non aveva pensato di sposarsi altrove; e si poteva
sperare d'averlo, il grand'uomo, testimone alle nozze, non si sa mai.
E poiché la maestrina, rimasta lungo gli anni "maestrina", capì come volle capire, fece anche una
specie di scarto sotto gli occhi dei visitatori autorevoli, voltò loro per un momento le spalle, aprì lo
sportello d'un armadietto accanto alla cattedra, vi pescò il suo cappellino, ne sfilò con uno strattone
la penna rossa,
tornò indietro e mostrò la penna, con un sorriso giovanile, all'ospite illustre: - Signor De Amicis, la
riconosce? la vuole?
De Amicis sorrise e assentì senza stupirsi che quella maestrina - quasi una sua "creazione" - avesse
proprio le lacrime agli occhi, e passò al figlio Ugo la penna rossa perché la serbasse fra i cimeli e le
cianfrusaglie che gli ricordavano le umane vicende del suo onesto capolavoro.
98
La riforma della grammatica
Gianni Rodari
(...) Il professor Grammaticus, un giorno, decise di riformare la grammatica. - Basta, - egli diceva, con tutte queste complicazioni. Per esempio, gli aggettivi, che bisogno c'è di distinguerli in tante
categorie? Facciamo due categorie sole: gli aggettivi simpatici e gli aggettivi antipatici. Aggettivi
simpatici: buono, allegro, generoso, sincero, coraggioso. Aggettivi antipatici: avaro, prepotente,
bugiardo, sleale, e via discorrendo. Non vi sembra più giusto?
La domestica che era stata ad ascoltarlo rispose: - Giustissimo.
- Prendiamo i verbi, - continuò il professor Grammaticus. - Secondo me essi non si dividono affatto
in tre coniugazioni, ma soltanto in due. Ci sono verbi da coniugare e quelli da lasciar stare, come
per esempio: mentire, rubare, ammazzare, arricchirsi alle spalle del prossimo. Ho ragione sì o no?
- Parole d'oro - disse la domestica. E se tutti fossero stati del parere di quella buona donna la
riforma si sarebbe potuta fare in dieci minuti. (...)
99
La scuola o la scarpa
Tahar Ben Jalloum
(Saggi di narrativa Bompiani)
(...) Ora sono il nuovo maestro. In realtà, devo essere il primo insegnante nominato dal ministero
per questo posto. Ho una lettera d'incarico, ma non so ancora quale sarà il mio stipendio. Forse sarò
pagato in sacchi di grano saraceno.
Come in ogni posto del mondo, il primo giorno di scuola è un giorno di festa. Qui, non è una festa
come le altre. I ragazzi fanno baccano, urlano, si tirano i gessi. Si divertono. Per loro la scuola è una
ricreazione, una curiosità. Accorrono per vedere se il maestro è in gamba. Io stesso mi chiedo se
sono in gamba. Cosa vuol dire, qui? Essere gentile e al tempo stesso severo. E io non sono né
troppo gentile né troppo severo. E' possibile essere in gamba nel villaggio del nulla, dove non è
stato sepolto un solo santo, dove non si è fermato nemmeno un profeta? Devo abituarmi all'idea
che, per questi bambini, la scuola è come il circo che passa una volta all'anno. Che cos'è la scuola
per un bambino che non ha da mangiare quando ha fame? Come spiegargli che è necessario passare
per la scuola per non patire più la fame, un giorno? Ho distribuito agli allievi dei quaderni e delle
matite arrivate dalla Francia, e delle cartelle, arrivate dal Belgio. Sono trenta ragazzi, tra maschi e
femmine. Vengono tutti dalla scuola coranica.
Certi sanno già leggere e scrivere. Hanno gli occhi vivi e i corpi magri. Come me. Anche io sono
alto e magro. Sono contento di portare i miei nuovi occhiali. Non solo vedo meglio, ma questi
occhiali rendono più chiare le mie idee. Sono contento di tornare in questa pianura persa fra le
colline e la sabbia. I ragazzi sono seduti per terra. Mi hanno detto che i tavoli e le sedie arriveranno
entro il mese. Saranno un regalo dei canadesi. Per il momento, ci dobbiamo arrangiare alla meglio.
E la lavagna?
Sarà il regalo del falegname più ricco della città.
La stiamo aspettando. Da sola non arriverà.
Bisogna andarla a prendere e trasportarla sul tetto del furgoncino del droghiere che viene ogni
quindici giorni al villaggio.
I miei ricordi d'infanzia non sono tristi. Come oggi, anche allora mancava tutto. La cosa faceva
soffrire molto i nostri genitori. Però noi bambini ci divertivamo; ci piaceva giocare con i gatti morti.
La nostra scuola era la moschea. Ci facevano imparare a memoria i versetti del Corano e li
recitavamo senza capirli.
ll maestro della scuola era un vecchio quasi cieco.
Era un saggio.
Diceva che l'Africa era la madre degli altri continenti, ma che si lasciava saccheggiare. Diceva
anche: "E' ricco chi non possiede nulla", "E' ricco chi è libero", e aggiungeva: "Ma noi non siamo
né ricchi né liberi, siamo schiavi del cielo e degli uomini che dettano legge." Quando faccio
l'appello, i bambini ridono.
A loro piace ridere. Sono incuranti o semplicemente felici?
Malgrado le difficoltà della vita, sono allegri. Il secondo giorno di scuola, mancano due allievi.
Sono ammalati o si sono persi per strada? Nessuno risponde. Due assenti su trenta non sono tanti.
Verranno domani. In realtà, l'indomani non arrivano. Mancano altri tre bambini. Mi preoccupo. Non
ho un direttore cui rivolgermi. Sono il maestro, il direttore, il bidello e il guardiano della scuola.
Gli altri bambini non dicono niente.
Faccio lezione nonostante la preoccupazione. Alla fine del mese, mi ritrovo con la metà degli
allievi. Dove sono finiti gli altri quindici?
A questa domanda, i ragazzi ridono e rispondono una cosa qualsiasi. Decido di parlarne al capo del
villaggio, Hadj Baba. Lo trovo sul tardo pomeriggio sotto l'albero, circondato da alcuni uomini,
sempre gli stessi. Mi dice, scacciando con la mano le mosche che gli ronzano intorno: "I bambini
sono sassi, rami di un albero che perde le foglie, parole azzurre, scoppi di risa... vanno, vengono,
passano e non lasciano tracce... tutto questo tu che vieni dalla città dovresti saperlo! Ricordati, non
hanno ancora l'abitudine di andare a scuola con regolarità. Forse, poi, non ti prendono sul serio, sei
100
troppo giovane, hai l'aspetto di un ragazzo. Per loro, il sapere deve essere insegnato da un uomo
maturo, un anziano con la barba bianca, un uomo che sappia parlare agli alberi e agli animali. Tu
vieni dalla città e hai dimenticato la realtà del tuo villaggio."
"No, è proprio perché amo il mio villaggio che sono tornato, per rendermi utile. Ma perché non
vengono a scuola?"
"Ah! La scuola! Tu chiami questo rudere una scuola? Non hai neanche una lavagna.
Quanto ai tavoli e alle sedie, aspetta, aspetta pure. Perché questo villaggio sperduto dovrebbe essere
preso in considerazione dalle autorità della città? Sei ingenuo, figlio mio. E poi, hai visto le
condizioni del bestiame? L'anno scorso tu non c'eri. Non ha fatto una sola goccia di pioggia. Intorno
a queste colline si aggira la morte. Tieni, siediti e guarda il cielo. Se hai pazienza, imparerai che il
cielo è vuoto; non ci riserva nulla di buono. Siamo maledetti. E in ogni caso, dopo la morte del
nostro maestro, il villaggio continua a morire. Quindi la scuola..."
"Ho una nomina ufficiale per insegnare in questa scuola."
"Benissimo, e quindi? Noi, qui, siamo vittime dell'aridità. L'aridità del cielo e degli uomini. Perché
le persone della capitale non hanno nominato qualcuno per aiutarci a lottare contro la fame?"
"Avete paura di un'epidemia?"
"Cos'è una epidemia?"
"Una malattia che colpisce tutti."
"No, non è una malattia; guardati intorno, cosa vedi? Sabbia, pietre, un albero, quello sotto cui
siamo seduti; vuoto, vento, polvere, un pazzo che parla da solo, e poi questa moschea trasformata in
scuola. Ecco tutto. Anche se arriva una malattia, se ne andrà. Non troverà niente e nessuno da
colpire. Questa è la nostra fortuna e la nostra sfortuna. Moriremo da soli. Non abbiamo bisogno di
malattie. Qui le persone muoiono dormendo. Non si svegliano. Tutto qui. Non te la prendere se i
bambini spariscono; torneranno."
"Devo andare a cercare i bambini e riportarli a scuola."
"Se li trovi. Forse sono stati inghiottiti da un pozzo, un pozzo secco, un buco in cui al momento si
svolge un congresso di scorpioni e serpenti a sonagli. I bambini ci sfuggono, come le parole,
prendono il volo e si allontanano con le rare nuvole che si fermano sopra le nostre teste."
"Parlerò ai loro genitori."
"Può essere un'idea, ma non ti porterà lontano; gira piuttosto, guardati intorno..."
Ho preso quindi la bicicletta, e sono andato alla ricerca dei bambini. Un pastore mi indica un
edificio, all'orizzonte. Non ci avevo mai fatto caso. Mi dice che gli piacerebbe andare in
quell'edificio bianco, ma non trova nessuno che gli controlli gli animali. "Cos'è quell'edificio?"
"Un posto dove si guadagnano dei soldi."
"E come?"
"Non lo so. Tutti quelli che ci vanno, escono con dei soldi. Io non ho mai avuto denaro. Anche le
capre sono attirate da quell'edificio bianco. Un giorno, anch'io partirò al mattino e tornerò la sera
con dei soldi. Credo che a quel punto non tornerò qui, andrò in città. Lì, col denaro si ottiene tutto.
Qui, abbiamo solo vento e polvere. Passo il mio tempo contando il bestiame. Do un nome a ogni
capra. La più grossa, la chiamo "Palazzo Bianco". Peccato che sia nera!"
La porta dell'edificio è chiusa. La forzo. Un guardiano mi minaccia con un bastone. Faccio un passo
indietro e aspetto. Gli offro delle sigarette e a questo punto mi apre. Entro in un corridoio e mi trovo
d fronte a una sala in cui un centinaio di ragazzi stanno cucendo pezzi di cuoio, bianco e nero. In
fondo, una dozzina di ragazze molto giovani lavora con le macchine da cucire. I miei allievi fanno
palloni da calcio o scarpe. Sulle pareti sono appesi dei manifesti pubblicitari in cui c'è un campione
sportivo negro che sta per iniziare una corsa. Il simbolo della marca assomiglia a un grande accento
grave bianco su un fondo nero. Cosa rappresenta questo accento grave? Un uccello senza testa, un
piede strappato, un'onda o una semplice freccia disegnata male? Non lo so. Leggo: "Le scarpe da
pallacanestro del terzo millennio", "Lo spirito della vittoria". Quale vittoria? Quella che fa lavorare i
bambini, quella che li allontana dalla scuola per poterli sfruttare visto che sono poveri e non
possono difendersi? Con la testa bassa, lavorano in silenzio e senza perdere tempo. Gli oggetti
confezionati vengono controllati da un capo bianco, occidentale, quindi messi dentro scatole di
cartone. Mi avvicino. Lui si stupisce, poi mi dice:
101
"Immagino che lei sia il maestro."
"Sì."
"I tuoi studenti preferiscono la mia fabbrica alla tua scuola. Almeno qui guadagnano."
"Ma sono dei bambini, dei minorenni, lei non ha diritto di farli lavorare".
"Non li obbligo io. Del resto, è qui tutta la tua classe. Potrai tenere le lezioni quando avrai dato loro
da mangiare. Perché io, qui, li faccio anche mangiare. In America, si lavora con le macchine. Qui, si
cucisce ancora a mano. E' roba buona, questa. Si fa notare."
"La denuncerò. Le ricordo l'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo. Nessuno
potrà essere tenuto in condizione schiavitù e di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite in qualsiasi forma. Ha capito? In qualsiasi forma. Il lavoro minorile è una forma di
schiavitù. È punito dalla legge."
"O la smetti o ti spacco la testa con questo bastone. Qui non abbiamo bisogno di persone che ci
diano lezioni di morale. Chiedigli di seguirti. Vedrai che nemmeno un ragazzino lascerà il suo
posto. Meglio che tu te ne vada."
Gli allievi non osano guardarmi in faccia. Forse per paura, forse per vergogna. Cerco di rivolgermi
a loro, ma il capo occidentale mi spinge verso la porta. Mi ritrovo fuori senza sapere cosa fare, solo
con la mia rabbia. Mi ripeto: "Far lavorare i bambini anziché lasciarli andare a scuola, che
cattiveria! È una forma di sfruttamento, di schiavitù."
Il guardiano mi osserva, un po' imbarazzato.
"Lì dentro, ho due bambini. Dopo la stagione sono sicuro che torneranno alla tua scuola. Per il
momento, portano a casa un po' di soldi." Tornando al villaggio, racconto tutto a Hadj Baba, che
scuote la testa e mi dice:
"Non sei più forte del vento, né più crudele del cielo. La terra ha sete e il bestiame è in pessimo
stato. Un dollaro al giorno, per ogni bambino: quasi nulla. La scuola è li, non si sposterà. Quando
andrà meglio, riprenderai le tue lezioni. Il sapere può attendere, la pancia degli uomini, no. Sai, i
poveri non li ama nessuno. E così, non c'è niente da fare. Vedi, potrai prendertela col cielo, con
Dio... Hai ragione, sarebbe meglio la scuola della fabbrica; ma non abbiamo scelta. Ah! Imparare la
storia, la geografia, la matematica e le scienze, la tecnica e la medicina... È importante, ma per noi,
in questo momento, è un lusso. Siamo abbandonati, crepiamo, viviamo di ciò che la gente di città
vuole donarci. La scuola sarà per un'altra volta, abbi pazienza, resta con noi; sono sicuro che
troverai una soluzione"
Alla fine della giornata, sono tornato a scuola; ho guardato le stuoie per terra, le pareti screpolate,
ho sentito le urla dei bambini e poi il silenzio. Cosa fare in una classe vuota? Non ho nessuno con
cui parlare. Ho pensato che avrei potuto aspettare il ritorno dei bambini. Una settimana. Un mese.
Forse più. Aspettare leggendo. Andare in città a cercare le sedie e i tavoli. Ma non ho denaro. Ho
raccolto le mie cose, il vocabolario, i libri.
Ho fatto un po' d'ordine nella stanza e sono uscito senza voltarmi indietro. Ho preso la bicicletta per
ritornare in città. Ho ripensato a quello che diceva il mio maestro, il saggio.
La miseria non è una fatalità, qualcosa di inevitabile. Non sta scritto da nessuna parte che questo
villaggio debba continuare ad essere maledetto, senza ricchezza, senz'acqua, senza scuola e senza
avvenire. Bisogna combattere, non bisogna incrociare le braccia. Ma io qui sono il solo a reagire.
Gli altri, soprattutto i vecchi, sono pigri e passano il tempo a parlare per non dirsi nulla. Si direbbe
che tutti siano stati punti dalla mosca tze-tze. No, la mosca tze-tze non esiste. Ma un insetto strano
deve girare intorno a questi uomini, che non si muovono e aspettano che la manna scenda dal cielo.
Per strada, ho incontrato alcuni studenti. Stranamente, erano calmi e disciplinati. Parlavano tra di
loro a voce bassa. Appena mi hanno visto, mi sono venuti incontro impedendomi di proseguire. Sul
loro viso, mi è sembrato di leggere una preghiera: "Resta!" Credo anche di aver sentito qualcosa
come: "Abbiamo bisogno di te, torneremo presto." Prima devo avere fatto un passo indietro, poi
due, spinto da tutti questi bambini stretti l'uno contro l'altro. Ho indietreggiato, commosso. Erano
cambiati. Forse la mia visita alla fabbrica li aveva fatti riflettere, il fatto che non vengano a scuola
non significa che non siano intelligenti. Qualche giorno dopo, il pastore bussa alla mia porta. Mi
dice: "Mio padre non è più malato; ha ripreso il suo gregge, quindi io torno a scuola."
"Non hai più voglia di andare alla fabbrica?"
102
"No, ci ho pensato. Ho voglia di imparare a leggere, a scrivere, a contare, a guidare il camion, a
conoscere il nome delle stelle, a fare molte cose."
"Ma non potrò aprire la scuola per un solo ragazzo."
"Non sarò solo. Ci saranno anche Dialo, quello che ha un braccio solo, la fabbrica non l'ha voluto;
Moh, quello che ha un occhio distrutto dalla polvere e che non si è nemmeno presentato all'incontro
per l'assunzione; e Souleymane, quello che il capo ha mandato via dalla fabbrica perché non era
abbastanza veloce; e ci sarà Felix, quello che non parla con nessuno e gioca con gli scorpioni, i suoi
genitori hanno un frutteto dall'altra parte della collina. Altri due bambini arriveranno dall'oasi,
perché hanno sentito parlare della nostra scuola e preferiscono venire qui; e poi ci sarà Modibo,
quel bambino piccolo e grasso a cui la scuola piace e la sorella gemella Aisha: non si lasciano mai".
Ecco, siamo abbastanza per fare una piccola classe... (...)
103
La supplente
Albino Bernardini
(La nuova Italia)
(...)Isabella e Marcello
L'inizio del nuovo anno scolastico, siamo ormai in quinta, è completamente diverso da quello
dell'anno passato.
Sin dal primo giorno tutti i genitori vengono in classe, e assieme decidiamo quello che dobbiamo
fare durante l'anno. Non solo, ma se ne sono presentati addirittura due di quelli che l'anno
precedente avevano fatto trasferire i loro figli; mi chiedono scusa, dicendo che si è trattato di un
errore, e vorrebbero riportarli nella mia classe. Li prenderei volentieri, ma mi trovo
nell'impossibilità di accontentarli: ci siamo tutti, non manca nessuno, e nell'aula non ce ne stanno
altri.
Dopo qualche giorno Alessandra ci lascia. La famiglia si è trasferita a Villanova, a 5 chilometri da
Bagni. Parlo con i suoi perché continuino a mandarla facendola viaggiare, ma hanno paura e
soprattutto costa l'abbonamento. Il suo posto viene subito preso da Marcello. Ci viene presentato da
Isabella, che ci dice che è figlio di una loro amica di famiglia. È appena arrivato dalla Puglia.
Viene accolto bene, anche perché, essendo un introverso, non parla quasi mai, e non ci crea nuovi
problemi.
Inserito subito nel gruppo di Antonio l'Abruzzese, diventerà il suo più caro amico. Nel gruppo c'è
naturalmente anche Isabella, a cui abbiamo dato l'incarico di aiutarlo, cioè di fargli capire come si
lavora e studia in classe nostra.
Così tutte le mattine Isabella e Marcello, abitano credo nello stesso palazzo, arrivano a scuola
assieme. Qualcuno comincia a mormorare e scherzare sulla loro amicizia, ma loro continuano,
anche se ogni tanto Isabella viene da me e mi dice preoccupata: <<Maestro, stanno dicendo che io e
Marcello facciamo l'amore, invece non è vero, glielo giuro! E sempre quel solito disgraziato di
Peppe che non sa fare altro che dire queste stupidaggini.>>
E rivolta a Peppe, che cerca di giustificarsi, gli fa le smorfie.
Io la tranquillizzo, dicendole che per adesso deve pensare a studiare, e che lasci cantare gli sciocchi.
Marcello, invece, timido come un coniglio, non dice nulla, ma ogni tanto arrossisce. Il lavoro ci
assorbe e non abbiamo più tempo di pensare a queste cose, anche perché Isabella non mi dice più
niente. I primi mesi passano velocissimi. Non so che cosa sia avvenuto tra loro in questo frattempo,
ma noto, ad un certo punto, che i due non vengono più a scuola assieme.
Inizialmente non me ne preoccupo, perché penso che si siano bisticciati così come capita a tutti i
bambini di questo mondo.
Un giorno, senza pensarci troppo, chiedo a Isabella:
<<Senti un po', perché non venite più assieme con Marcello? che vi è capitato?>>.
Isabella mi guarda, arrossisce ruotando i suoi occhi celesti come il cielo, e poi, senza voler dire
troppo, fa: <<Ma, non so, no, non è che ci siamo bisticciati...>> e cerca di squagliarsela. <<E allora
perché mai?>> insisto. <<Sei stata tu a dirci che Marcello era bravo; non credo che sia diventato
cattivo così di colpo?>>
<< No, non è questo, è un'altra cosa>>, risponde e scappa.
Noto nei giorni che seguono che a scuola sono amici come prima, chiacchierano, discutono, si
fanno i complimenti, ma appena escono fuori per rientrare a casa, ognuno prende la sua strada,
senza guardarsi, come se non si conoscessero. Mi faccio prendere dalla curiosità, ritorno all'assalto
e le chiedo: <<Ma allora si potrebbe sapere perché mai non andate più assieme come prima?>>
Niente da fare. Isabella non parla e Marcello fa scena muta, come se non dicessi a lui; lui arrossisce
e basta.
Chiedo in giro, ma non si sa molto. Solo Antonio l'abruzzese, grande amico di Marcello, sa dirmi
che c'è qualcosa che non dipende da loro, ma mi prega di non fare il suo nome, raccomandandomi
alla fine, con una mano alla bocca, per non farsi sentire: <<Maestro, per favore non dica che gliel'ho
104
detto io, che sennò Marcello non mi parla più>>, e sorride con ironia, facendo mille mosse con la
testa e la bocca.
Mi avvicino al loro gruppo, e dico <<Sentite, o voi due mi dite perché non andate più assieme, o
pongo la questione in discussione>>.
Isabella che si è tirata su i biondissimi capelli con una acconciatura ultimo grido, comincia a
toccarseli nervosamente finché non le vanno giù; è diventata pallida e mi guarda come dire: < Che
vai interessandoti delle cose che non ti riguardano!>>.
Marcello abbassa gli occhi e tace. Gli altri del gruppo che hanno drizzato le orecchie incuriositi,
sorridono malignamente e ammiccano un po' all'uno e un po' all'altro. Isabella si decide e fa,
avvicinandosi per non far sentire agli altri: <<Maestro, non metta la questione in discussione. Dopo
le dico come stanno le cose.>>
Prima di andare a ricreazione si avvicina, e come in confessione mi sussurra: <<La colpa non è, né
mia , né di Marcello, è mio padre che non vuole che mi accompagni>>.
<<Perché?>> chiede sorpreso.
<<Eh, perché dice che non è bello! Che i maschi devono andare con i maschi e le femmine con le
femmine>>.
Cerco di convincerla perché la cosa si discuta, ma mi implora dicendo: << No, maestro, per favore,
ché se lo sa mio padre mi picchia, e poi si bisticciano in casa col padre di Marcello, che quello è un
geloso che non le dico. Pensi maestro, che la moglie di lui non vuole che esca neppure al
balcone>>.
<<E tuo padre invece non è geloso, vero?>>
<< Chi? Mio padre? Uh, anche mio padre; anzi adesso no, ma prima... tutti sono così però dalle
nostre parti, in Puglia, perché loro la donna dicono che deve stare a casa e basta, a fare da mangiare
e...>> Tanto faccio e dico che, ad un certo punto, Isabella si fa convincere e si discute, ma a
condizione che non si faccia il suo nome e tanto meno quello del padre. Concordiamo tutti assieme
il tema: <<La donna e il lavoro>>.
Loredana, che interviene di rado, questa volta è la prima, fa decisa:
<<Io dico che la donna deve stare a casa per guardare ai figli, perché se lei va a lavorare chi glieli
tiene? Anche mio padre dice così. Mia madre prima lavorava, faceva la sarta, ma ora mio padre non
la fa più andare. Dice che in inverno specialmente le vede che muoiono dal freddo attendendo
l'autobus...>>
Virgilio la interrompe gridando: <<E se tuo padre si ammala, per esempio, sta un anno all'ospedale,
che mangiate? Invece se lavora tua madre...>>
Loredana si alza, comincia a fare le corna con le dita e dice: <<Toh, toh, ma tu sei scemo, oh, ma
che ragionamenti sono questi! Ma perché mio padre si deve ammalare?>>
Si fa una gran confusione e appena ritorna la calma, si riprende con Antonio: <<Mio padre ogni
giorno dice a mia madre: "Toh mille lire, schiavetta mia , vai a fare la spesa">>.
<<E tua madre che dice?>> gli chiedono. <<E mia madre lo manda a quel posto. Ma io dico che la
donna deve lavorare perché sennò l'uomo la tiene come schiava davvero, come dice mio padre>>.
<<Ma secondo me>>, precisa Antonio l'abruzzese, <<La donna deve lavorare, non solo per i soldi,
ma perché deve avvicinare e conoscere le altre persone, ché se sta sempre a casa poi non capisce più
niente>>.
<<Noi diciamo dell'Arabia, che le donne sono ancora schiave>>, interviene finalmente Delfina, che
da mezz'ora è con la mano alzata, <<Invece anche da noi le donne sono un po' schiave. Io lo vedo
da mia madre, poverina, che sta sempre a casa con quattro figli e non può mai uscire, invece mio
padre se ne esce. Perché ancora comandano gli uomini. Anche parlando si sente che comandano gli
uomini: io per esempio non ho mai sentito dire da una donna incinta "attendo una bambina", ma
sempre "Attendo un bambino". Anche nella lingua siamo diversi.>>
<<E vero sa, maestro>>, grida Massimo, <<Quando esce mio padre nessuno dice nulla, quando
esce mia madre invece, mio padre comincia: "Dove vai? Cosa fai?" e tante domande, e allora si
arrabbiano e si bisticciano.>> La discussione si prolunga ed ognuno dice la sua, con tutta la
passione che ci mettono sempre quando intervengono svelando i segreti di casa. Chiude Nadia:
<<Bene, voi dite tante cose degli uomini, invece in casa mia è tutto il contrario, perché dovete
105
sapere che chi comanda in casa è mia madre, e a mio padre lo fa filare, perché non è che mio padre,
sapete... Però maestro, queste cose che stiamo dicendo lei non le deve dire ai nostri genitori, quando
facciamo la riunione...>>
<<Vero! Si! Se me lo sa mio padre! E mia madre! Povera me! A me mi ammazza!>> intervengono
gridando. Io prometto il più assoluto riserbo; si sentono tranquilli ed altre volte così riprenderemo a
discutere sull'argomento. La più felice di tutti è Isabella, perché non si è fatto il suo nome. Ma non
sarà così per sempre, perché ad un certo punto si parlerà di lei e anche di suo padre. Se ne parlerà a
lungo fino a quando la stragrande maggioranza non sarà convinta che i bambini e le bambine
devono vivere sempre assieme, e non solo a scuola. (...)
106
La turbinosa storia di Picco Uragano
Margaret Mahy
(Salani)
(...)
La Scuola Inaspettata
La Scuola Inaspettata si trovava proprio sulla vetta di Picco Uragano, scavata nella montagna.
L'uragano la sferzava sei o sette volte al giorno (perché gli ci volevano tre ore e qualcosa per
soffiare su tutti i punti della circonferenza del picco e tornare a quello di partenza).
Quando Huxley e Zaza Hammond scesero per la scaletta di corda dell'elicottero della nettezza, il
vicedirettore era già li ad aspettarli. Era un giovanotto alto che indossava uno svolazzante mantello
nero coperto di parole magiche tipo abracadabra e anaxagorillaballirogaxana (parola che si può
leggere dall'inizio alla fine e dalla fine allinizio). Il giovanotto aveva un folto cespuglio di capelli
color rame, e questa era una buona cosa, perché, per quanto notevolmente, era dotato di orecchie
sporgenti come due manici di pignatta, e se i capelli non fossero stati così cespugliosi e di colore
così acceso, le orecchie sarebbero risaltate ancor di più.
"Sono Heathcliff Magik" disse. " Suppongo che abbiate indovinato alla prima occhiata che sono un
mago. Non vedo perché dovrei nasconderlo!"
Huxley e Zaza lo avevano già indovinato.
"In questa scuola tendiamo a specializzarci in magia" seguitò Heathcliff con voluta indifferenza,
mescolando un mazzo di carte mentre alle sue spalle l'elicottero della nettezza calava rapidamente
gli artigli per tirar su i sacchi d'immondizie della scuola. "Vostro padre desidera che vi
somministriamo forti razioni di scienze e matematica, e io gli ho promesso che avrei passato la
richiesta alla signorina Risoluti. Ma si dà il caso che la signorina Risoluti sia assente da molto
tempo, e io ho pensato che vostro padre sarebbe rimasto sconcertato se gliel'avessi detto.
Naturalmente, non appena la signorina Risoluti sarà di ritorno non mancherò di trasmetterle il
messaggio: per cui, in fin dei conti, a vostro padre ho detto la verità."
E confido fermamente che un giorno, magari non lontano, la signorina Risoluti possa fare davvero
ritorno. Ma ora entrate, svelti, perché l'uragano sta arrivando".
Infatti, mentre il signor Magik parlava, Huxley e Zaza avevano già sentito le prime sferzate
dell'uragano che ululava alle loro spalle. L'elicottero della nettezza frullò via in preda al panico.
"Ma lei" osservò Huxley mentre salivano di corsa le scale della scuola, "lei ha detto a nostro padre
che la signorina Risoluti si trovava a un congresso".
"Ai genitori dico sempre così" replicò Heathcliff Magik, scagliando le carte in aria, dove svanirono.
"Ho l'impressione che questo li tranquillizzi. E poi può anche darsi che sia vero. Io, almeno, spero
ardentemente che lo sia. Ciò non toglie che la storia dell'assenza della signorina Risoluti sia
sconcertante... e perfino un po' sconvolgente, mi rincresce dirlo. Sto chiedendomi se sia il caso di
raccontarvela... Ma sì, penso che sia il caso. Meglio essere sinceri... bè, insomma, il più sinceri
possibile". Sbattè il portone di pietra in faccia all'uragano (che ci restò con un palmo di naso) e
continuò a discorrere mentre faceva rotolare un masso sferico contro la porta. E pilotando Huxley e
Zaza fin dentro una stanza sulla cui porta stava scritto Ufficio del Vice, cominciò a raccontare.
"Dunque!... Molti anni fa assai prima che io venissi ad insegnare qui, la signorina Risoluti ebbe un
alunno molto indisciplinato, a nome Fondello Quinte. Senza entrare in particolari, posso dirvi che
questo alunno faceva il gradasso coi compagni più piccoli; tra l'altro li obbligava a investire i soldi
delle merendine in una banca fondata da lui stesso, e poi proibiva loro di prelevarli. Infatti li
prestava ai più grandi a un tasso di interesse molto salato. Ma alla fine la signorina Risoluti lo
scoprì, e naturalmente andò su tutte le furie. Quando se la vide piombare addosso, Fondello Quince
arraffò i suoi immorali profitti e filò fuori del portone come una palla di fucile, con la signorina
Risoluti alle calcagna. Per sfortuna, proprio in quel momento l'uragano era al culmine della
violenza, e i due furono spazzati via. Per farla corta, non si sono più rivisti da quarant'anni a questa
parte... A ogni modo, quarant'anni non sono niente per una donna come la signorina Risoluti, e io
107
confido che ormai la direttrice possa tornare in qualsiasi momento".
Huxley e Zaza intuirono subito di essere capitati nel tipo di scuola che faceva per loro. Non solo era
scavata in un picco di montagna, ma ai suoi frequentatori capitavano cose a tinte fortissime.
"Potrei scriverci una storia" esclamò entusiasta Huxley.
"E io potri illustrarla" propose Zaza.
"Oh, sì!" disse Heathcliff, estraendo un asso di cuori dal taschino di Huxley e fissandolo
affascinato. "Però prima dovreste compilare questi moduli rosa, ideati personalmente dalla
signorina Risoluti. Scriveteci il vostro nome e il nome dei vostri genitori e il loro numero di
telefono, e quanti soldi guadagnano eccetera, e mentre voi scrivete io guardo il panorama".
Mentre Huxley e Zaza compilavano i moduli, il vicedirettore si avviluppò nel mantello e andò a
mettersi in piedi accanto alla finestra, dove restò sospirando fra sé e sé e facendo apparire e sparire
l'asso di cuori fra le dita di una mano. Dal nulla vennero fuori altre carte, e di lì a pochi momenti
Heathcliff stava di nuovo mescolando l'intero mazzo. Fuori, l'uragano passò furibondo, trascinando
via con sé una quantità di foglie, fuscelli, topi, aquile, branchi di capre e via discorrendo; ma nella
pianura sottostante si poteva scorgere in lontananza la grande città di Farforca, magicamente
scintillante di luci. "Ah, Belladonna!" sospirò Heathcliff, e Zaza si chiese chi mai potesse essere
quella beltà. Ma siccome Huxley e Zaza impiegarono molto tempo a compilare i moduli,
tanto vale che io vi riporti in città per vedere che cosa faceva Belladonna, e che cosa significavano
quei colpi alla sua porta. (...)
108
La vita è bella
Roberto Benigni e Vincenzo Cerami
(Einaudi)
(...)
SCENA 19
Scuola elementare "Francesco Petrarca". Interno esterno giorno
Una grande aula piena di ragazzini azzimati e silenziosi, quasi impauriti, tutti nel loro grembiulino.
Sono seduti accanto ai banchi a formare una immensa M. Schierate intorno alla cattedra le autorità
della scuola. Ci sono l'anziana direttrice didattica, il segretario, alcuni insegnanti, tra cui Dora, e due
bidelli in camice e berretto.
Direttrice: "Fra poco arriverà l'ispettore da Roma.
Fatemi fare bella figura. Ascoltate tutto quello che dice attentamente e in silenzio. Dirà cose molto
importanti sulla nostra bellissima patria.
Al primo banco c'è un bambino magrissimo e sdentato, molto povero, di carnagione scura e con le
scarpe legate con lo spago: fa di sì con la testa. La direttrice lo vede e va su tutte le furie.
Direttrice: "Ma chi ha messo Fabio in prima fila? Fabio, vai in fondo...... all'ultima fila!"
Il piccolo si alza diventando rosso in viso.
Fabio: "Dove?"
Direttrice: "In fondo, laggiù! Dietro! Lorenzo, mettiti al posto suo".
Lorenzo è bellino, biondo, pettinato col sapone. Siede al posto di Fabio. Mentre questi va agli ultimi
banchi.
Entra un bidello nell'aula, tutto trafelato. Si avvicina alla direttrice.
Bidello: " Signora direttrice... è arrivato l'ispettore!"
E scappa via.
Direttrice: "Come? E' già arrivato? E in anticipo! Fabio... siediti!"
Il ragazzino, che era rimasto in piedi, si siede.
Il suono dei passi forti e sicuri dell'ispettore si avvicina.
In classe si fa il silenzio.
Guido, la fascia tricolore che gli passa fra le gambe, fa il suo ingresso in aula.
Direttrice: "In piedi!"
I bambini scattano in piedi all'unisono.
Guido si avvicina a grandi passi agli insegnanti.
Dora lo vede e si sbalordisce.
Poi fa qualche passo avanti, lentamente.
Guido: "Buongiorno principessa!"
La direttrice non capisce, forse ha sentito male. Si fa coraggio e gli da il benvenuto.
Direttrice: "Buongiorno ispettore, sono la direttrice".
109
E gli da la mano, che Guido stringe.
Guido: "Piacere"
Direttrice: "Questi sono alcuni insegnanti..."
Guido come un ufficiale dell'esercito li passa in rassegna: stringe la mano a ognuno di loro. La
prima è una maestrina dall'aria di zitella.
Guido: "Da quanti anni insegna in questo circondario didattico?"
Maestra zitella: "Sedici!"
E la volta del maestro. Gli dà la mano.
Guido: "E' in regola con il programma dell'anno scolastico in corso?"
Maestro: "Si."
Un'altra maestra.
Guido: "Ha letto la circolare ministeriale sull'igiene infantile?"
Maestra (mente): "Certo!"
L'ultima è Dora. Guido appoggia la mano al muro e incrocia le gambe.
Guido: "Che fa domenica?"
Dora: "Eh?"
Guido: "No, dico... domenica è Santa Maria, la festa della Madonna, che fa?"
Dora: "Ah, vado a teatro!"
Guido: "A vedere che?"
Dora: "Offenbach..."
Guido: "Ah, già è vero! Beh, allora arrivederci!"
E fa per andarsene. Ma la direttrice alza la voce e, prendendo un tono ufficiale, si rivolge ai
bambini.
Direttrice (forte): "Il signor ispettore, come sapete, è venuto da Roma per parlarci del manifesto
razzista della razza firmato dai più illuminati scienziati italiani."
Così dicendo mostra il manifesto attaccato alla parete, che Guido sbircia velocemente.
Direttrice: "Egli e noi ne siamo onorati ci dimostrerà che la nostra razza è una razza superiore, la
migliore di tutte! Seduti ragazzi..."
(A Guido) Prego ispettore!
E si fa di lato. Il silenzio è di piombo. Tutti guardano Guido, che non sa cosa fare. Dora è quasi
spaventata.
Guido (alla direttrice): "La ... nostra razza?"
Direttrice: "E' superiore!"
Di colpo Guido assume una posa scultorea, monumentale.
Guido: "Ecco... sono qua, come avete testè sentito...
per illustrarvi la superiore bellezza della nostra razza.
Sono stato scelto io dagli scienziati italiani per dimostrarvi acciocché voi sappiate quanto la nostra
razza è superiore a tutte."
110
In men che nulla balza in piedi sopra la cattedra e si mostra ai bambini in tutta la sua bellezza.
Guido: "Perché hanno scelto me? Ma c'è bisogno di spiegarlo bambini?
No, dico... partiamo magari da una cosa che uno dice 'che sarà?'... l'orecchio..."
E mostra l'orecchio sinistro ai bambini.
Guido: "Il ... padiglione auricolare sinistro con la campanula pendente finale... cartilagine mobile,
piegabile. Ora dico: trovatemene uno meglio e io me ne vado, per carità... però me lo dovete far
vedere questo orecchio! Ah, ah... mi fanno ridere gli orecchi spagnoli. Le cartilagini francesi mi
fanno spanciare. (Alza la voce, quasi grida) Il padiglione russo mi fa schifo! Non lo volevo dire, ma
quando ci vuole ci vuole. Bambini, le razze esistono eccome..."
Si tira su un pantalone e solleva il ginocchio.
Guido: "Bambini... no, dico..."
E indica il ginocchio col dito teso.
Guido: "... Un minuto di attenzione prego... questa si chiama 'piegatura di gamba ariana con
movimento circolare del piede italico... caviglia etrusca su stinco romano'... in Belgio se la sognano!
Ma andiamo avanti."
SCENA 20
Scuola. Corridoio. Interno giorno.
Il bidello, tutto spaventato, procede a passo svelto lungo il corridoio della scuola.
Bidello: "Venga signor ispettore..."
Alle sue spalle infatti si muove anche il vero ispettore, l'aria inferocita. Giunti alla porta dell'aula, il
bidello si scosta e lo fa entrare. Questi rimane paralizzato sulla porta dingresso
SCENA 21
Scuola elementare " Francesco Petrarca". Interno esterno giorno
Guido, in mutande e canottiera, la fascia tricolore tra le gambe, al massimo dell'enfasi, è in piedi sui
banchi disposti a M tra i bambini. Ha la canottiera sollevata sulla pancia, che mostra agli scolari.
Guido (forte): " L'ombelico! Non si snoda neanche coi denti... ci hanno provato gli scienziati
razzisti!"
Così dicendo sgambetta lungo tutta la M mostrando l'ombelico ai ragazzi. Poi si ferma e mette in
bella mostra i muscoli del braccio.
Guido: "La muscolatura: cipite, bicipite, tricipite!"
Prende a fare movimenti snodati con tutto il corpo.
Guido: "Disarticolazione degli arti... fanno ridere gli scozzesi!
Guardate che razza di razza!"
111
L'ispettore, fermo sulla porta, non crede ai suoi occhi. Guido lo vede e si precipita a raccogliere i
vestiti sul davanzale della finestra.
Guido: "Bambini... io vi saluto... esco da qua sennò faccio tardi. Arrivederci!"
Raccolti i panni, fa per scavalcare la finestra. Ma prima si gira per l'ultima volta verso Dora.
Guido: "Principessa... ci vediamo a Venezia!"
E se la da a gambe. (...)
112
La zizzania
Grazia Deledda
(...) Ma non c'era proprio nulla da fare. La neve, uno strato sopra l'altro, copriva con la sua lapide la
terra morta; non si poteva andar neppure a cogliere radicchio; e in casa, tutto, davvero, fino
all'ultima cotica del lardo,
era stato rosicchiato dalla malattia del padre e dai loro diamantini denti di giovani lupi.
Il solo a non preoccuparsi troppo era Giovannino, il più piccolo; anzitutto perché il suo maestro di
scuola, che la natura aveva tagliato sul modello disusato di qualche antico apostolo, insegnava che
la Provvidenza non manca mai: e poi perché questo riverito signor maestro, oltre al distribuire ai
suoi alunni poveri il pane della scienza, faceva loro servire, tutti i giorni d'inverno, una scodella di
minestra calda.
Giovannino, dunque, va a scuola, con gli occhi freschi come nocciuole nuove, il naso di garofano
rugiadoso di moccio.
La giornata è bella: sopra i cappucci di feltro bianco dei monti lontani brilla un grande sole i cui
raggi un po' mordono, un po' sorridono, allegri e felini come gli occhi del gatto del maestro. Questa
è l'impressione di Giovannino, forse perché egli ricorda le parole della nonna: il sole d'inverno ha i
denti: e si sente allegro e cattivo anche lui, pensando alle parole della mamma, al viso di morto del
padre, ai fratelli grandi buoni a niente. La scuola non è lontana, ma sorge isolata tutta rifulgente di
vetrate, come una chiesa, in mezzo a un prato coperto di neve. Gli alberi, intorno, sono neri e
bianchi, cornuti come fantasmi di cervi favolosi: e alcuni hanno anche gli occhi, vuoti eppure
luminosi, che di notte farebbero paura. Arrivano, di qua, di là, altri ragazzini, col naso sgocciolante,
le mani gonfie di geloni, le scarpe che pare abbiano battuto tutte le strade del mondo: ma quello che
sorprende Giovannino è l'accorgersi che anche i suoi fratelli spuntano in fondo alla grande spianata,
quasi vogliano ritornare a scuola. Giolì, uno spilungone col viso di mela rosa, s'è messo il tabarro e
il berretto del padre, il che gli dà un'aria distinta di galantuomo, mentre l'altro ha indosso un sacco, e
pare il servo del fratello maggiore. Dove vanno? Giovannino si ferma un momento ad aspettarli, poi
pensa che forse è meglio il contrario, e fingere anzi di non vederli. Infila quindi la porta della
scuola, entra in classe e trova il modo di spiare dalla vetrata: e vede i fratelli aggirarsi intorno
all'edificio scolastico, all'annessa abitazione del maestro, al muro dell'orto, come direttori didattici
in ispezione.
Il ritorno a casa fu ancora più felice dell'andata a scuola. Il sole aveva rammollito la terra e si
poteva, Dio volendo, far dispetto ai compagni, buttando loro a tradimento, sulla testa dura, palle di
neve che infine non producevano danno, anzi riscaldavano le orecchie ancora imbottite delle parole
del maestro. Vasto e magnifico era stato quel giorno il programma delle lezioni. Religione: ricòrdati
di santificare le feste (figuriamoci, domani è domenica); e i precetti della Santa Chiesa: non mangiar
carne di venerdì, e digiunare nei giorni prescritti (oh, questo lo sapevano, anche per i giorni non
prescritti). Disegno: sciatori che attraversano una vallata piena di neve (facile quadro da mettersi in
azione); e, infine, dopo la medicinale grammatica, la gagliarda e commovente recitazione: "L'han
giurato: li ho visti in Pontida... ". A casa, poi, lo aspettava una gradevole sorpresa.
(...) Disse Giolì:
- Siamo stati a caccia: sì, sì, accidenti a chi non ci crede: siamo stati con un cacciatore che ci ha
messo a guardia del varco delle lepri; e ne ha prese quattro. ("Per cominciare, non c'è male" pensò il
padre). Una l'ha data a noi, tenendosi lui la pelle, con la testa, e le zampe e la coda, che serve alle
signore per metterla al collo.
E Gino trasse dal sacco una lunga bestia insanguinata, già sventrata, pronta alla cottura. La madre
non la prese, fissandola con gli occhi vitrei: Giovannino si sentì la bocca piena di parole, ma se le
ringollò una per una. Allora Giolì, senza aspettare altro, infilò la bestia nello spiedo, da provetto
cacciatore. E quando ebbero mangiato, i due fratelli uscirono di nuovo col sacco ancora
insanguinato, senza badare alle rimostranze della madre che, con quelle sue parole fatali, li aveva
oramai liberati come puledri dalle pastoie. Giovannino avrebbe voluto seguirli, ma non poteva: e nel
vederli sparire, fra il chiarore della neve e della luna, adesso però silenziosi più che le loro ombre,
113
gli parve di vivere in una fiaba. Nessuno li sentì tornare, e solo sul tardi, la mattina dopo, la madre
si accorse che essi avevano seppellito qualche cosa sotto un mucchio di paglia e di neve, e che nel
pollaio, già desolatamente vuoto, c'era il miracolo di una gallina viva. Ben venga, la gallina, in
questo santo giorno di carestia; non aveva anche, una volta, preso forma di volatile lo stesso Spirito
Santo, mandato da Dio ad annunziare la sua grazia e la sua misericordia agli uomini angustiati?
Il lunedì mattina il maestro tardò alquanto ad entrare in classe. Giovannino, in cuor suo, come meno
ipocritamente i compagni, sperava che il signor maestro fosse malato. E il viso, infatti, era pallido,
più scarno e osseo del solito: gli occhi tuttavia vivissimi, con lucentezze di febbre. A Giovannino
parve stranamente che egli rassomigliasse, quel giorno, al suo babbo; e ne provò un vago terrore,
come appunto quando il padre si aggravava e l'odore della morte penetrava, col vento di scirocco e
il buio delle nuvole, nella casa disperata. Le lezioni, quel giorno, procedettero fiacche; e,
insolitamente, quella sulla religione fu lasciata alla fine. Fuori c'era un po' di nebbia; d'un tratto però
il sole vi si sollevò sopra, come un grande uccello d'oro, e le vetrate si riempirono di perle. Allora il
maestro si alzò solennemente, e lesse la parabola del grano e della zizzania: "In quel tempo propose
Gesù alle turbe questa parabola. Il Regno dei cieli è simile a un uomo, il quale seminò buon seme
nel suo campo. Ma nel tempo che gli uomini dormivano, il nemico suo andò, seminò zizzania in
mezzo al grano e se ne partì. Come poi il seminato germogliò e granì, allora apparve anche la
zizzania. E i servi del padrone di casa andarono a dirgli: - Signore, non hai seminato buon seme nel
tuo campo. Come mai c'è la zizzania? -. germogliò e granì, allora apparve anche la zizzania. E i
servi del padrone di casa andarono a dirgli: - Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo.
Come mai c'è la zizzania? Ed egli rispose loro: "Un uomo nemico ha fatto tal cosa". E i servi gli
dissero: "Vuoi che andiamo a coglierla?". Ed egli rispose: "No, ché cogliendo questa, non strappiate
con essa anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano sino alla mietitura: e al tempo della
raccolta dirò ai mietitori: sterpate prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla: il grano, poi,
riponete nel mio granaio".
Finita, con voce un po' monotona, la lettura, egli sollevò la testa (...)
"Vi ho detto questa parabola - disse il maestro, melanconico, - perché sabato scorso, di giorno, mi è
stato rubato il gatto, e di notte le galline. Vada pure per queste, ma il gatto lo si doveva rispettare.
Lo conoscevate tutti: era uno di famiglia. E noi sappiamo benissimo chi ha fatto la prode caccia: e si
potrebbero mandare i signori carabinieri per scovare, alla loro volta, i bravi cacciatori; ma nella loro
casa ci sono anche anime innocenti che possono crescere come il grano in mezzo alla zizzania e, a
suo tempo, dar buoni frutti"(...)
114
L'anno della Tigre
Lina Unali
Dai Racconti di Chin
(dal sito della Sun Moon Lake)
Sin dai tempi dell'antica Cina
il gatto e la tigre sono nemici.
Si è sempre saputo
il motivo di quell'inimicizia.
Si dice che ai tempi
in cui era maestro della tigre,
il gatto non le avesse insegnato ad
arrampicarsi sugli alberi.
Questo è il motivo per cui la tigre non riesce
ancora a arrampicarsi
sugli alberi.
Alla fine dell'insegnamento,
quando la tigre si era accorta
della sua minorazione,
spinta dall'odio
cercò di mangiare il gatto,
ma il gatto se la cavò
arrampicandosi
su un albero,
proprio quel che lei
non sapeva fare.
I maestri si comportano sempre così:
non insegnano mai tutto.
Sempre rimane qualcosa d'importante
non detto, non spiegato. (...)
115
L'arpa di Davita
Chaim Potok
(...) In classe, alzai la mano.
La maestra aveva parlato dei diversi gradi di parentela e domandò se qualcuno avesse una zia o uno
zio.
"Mia zia Sarah è in Etiopia", dissi. "L'Etiopia è un paese dell'Africa". Sedevo in terza fila, dalla
parte dell'aula vicina ai finestroni. Alcune teste si girarono verso di me.
La maestra, una donna ben piantata di mezza età che portava i capelli quasi grigi raccolti in
crocchia, sorrise pazientemente: "Cosa fa tua zia Sarah?".
"E' infermiera".
"Tua zia Sarah è infermiera in Etiopia? Lavora in un ospedale?".
"Certe volte lavora in ospedale. Ma soprattutto lavora nei villaggi. Aiuta gli etiopi feriti in guerra
dai fascisti italiani".
La classe era tranquilla.
"Gli italiani hanno invaso l'Etiopia l'anno scorso e bombardarono i villaggi. Uccidono donne e
bambini. E i fascisti stanno per scatenare una guerra in Spagna. Si rivoltano contro il governo e
cercano di prendere il potere nel paese".
La classe era calmissima.
"Bene", disse la maestra con un sorrisetto. "Sicuramente, ne sappiamo un bel po' di politica,
nevvero? Sappiamo anche chi è il signor Adolf Hitler?".
"Adolf Hitler è il capo fascista della Germania. E' una persona malvagia".
"E Benito Mussolini?".
"E il capo fascista dell'Italia".
"E Stalin sappiamo qualcosa di Stalin?".
"Stalin è il capo della Russia".
"E' fascista, Stalin?".
"Stalin è comunista. Non ha paura di usare il suo potere per grandi cause".
La maestra stava dietro la cattedra, e mi guardava. La sua faccia rotonda sembrava un pallido disco
fluttuante sull'oscurità del vestito, che cominciava subito sotto il mento e finiva molto al di sotto
delle ginocchia.
"Dove senti tutte queste cose, signorina ?".
"Da mio padre e mia madre e dai loro amici".
"Capisco. Be'. Va bene. Ma tralasciamo l'argomento politico. Si stava parlando di zii e di zie. C'è
qualcun altro che vorrebbe parlarci di sua zia o suo zio? Robert? Si. Continua tu".
Smisi di ascoltare. Sedevo annoiata, fissando dalla finestra la spianata di cemento del cortile della
scuola e pensando alla zia Sarah.
Durante l'intervallo, un ragazzo mi si avvicinò mentre giocavo da sola sulle sbarre in cortile. Era
basso e tozzo, con la pelle olivastra e gli occhi spenti. In aula sedeva due file dietro di me.
Disse: "Ehi, ragazzina, senti un po'. Fai attenzione a quello che dici degli italiani".
Ruotai fino a trovarmi seduta su una sbarra e lo guardai. Il ragazzo disse: "Mio padre dice che
Mussolini è un grand'uomo. Sta attenta alla tua bocca". Un altro ragazzo mi raggiunse, magro e
biondissimo, con freddi occhi e il mento aguzzo. Non l'avevo mai visto prima. Guardò in su verso
di me, seduto sulla sbarra. "Ehi tu, quattr'occhi". Mi guardai intorno. Il cortile era affollato e
rumoroso. Lontano dalla parte delle catenelle di recinzione, c'era un gruppo di maestri che
parlavano tra loro.
"Dico a te, puttanella", disse il ragazzo biondo. "Il mio fratellino mi ha riferito quello che hai detto
di Adolf Hitler. Stacci più attenta".
"E' quello che le ho detto anch'io", fece il primo.
"Mio padre dice che Adolf Hitler è la cosa migliore che sia mai capitata in Germania. Farà piazza
pulita di tutti i rossi e di tutti gli ebrei. Meglio che tieni la bocca chiusa o non la riporti a casa intera,
un giorno o l'altro."
116
Discesi dalla sbarra. Il biondo mi stava di fronte.
"Sei ebrea?", domandò, sovrastandomi, con gli occhi sfavillanti d'odio.
L'altro restava lì, e mi osservava. Le gambe mi tremavano. "Mio padre non è ebreo. Mia madre è
ebrea". Sembrava incerto sul da farsi.
"Sta attenta alla tua bocca", disse dopo un momento.
"Già", disse l'altro. "Attenta a ciò che dici."
Se ne andarono ciascuno per proprio conto e sparirono nella calca dei bambini che giocavano. Mi
appoggiai pesantemente alle sbarre, col cuore rimbombante. Non avevo pensato che le parole
potessero essere così pericolose. Occhi azzurri, freddi e assassini. Aveva voluto davvero farmi
male. Avrei dovuto stare attenta a ciò che dicevo in classe, d'ora in poi. Sibilò un fischietto. Passai
dal cortile al corridoio affollato e ritornai alla mia aula. Sedetti rigida al banco. Dietro di me il
ragazzo che mi aveva avvertito di stare attenta a ciò che dicevo di Mussolini e degli italiani.
Continuai a sedere immobile, fissando fuori dalla finestra, ascoltando distrattamente la maestra e
pensando a mia zia Sarah in qualche villaggio di un posto chiamato Etiopia. (...)
117
Le bacchette di Lula
Albino Bernardini
(La nuova Italia)
(...)
La paura.
Era inutile pensare a quella desolante realtà. Così cercai di intavolare una chiacchierata con i piccoli
che mi guardavano, immobili come una massa uniforme, stipati nei posti dei lunghi banchi. E questi
sarebbero i bambini da "domare"? fu la prima idea che mi venne in mente mentre li guardavo. E'
vero che i bambini di fronte ad una qualsiasi novità si pongono in posizione di attesa, ed io ero per
loro la "novità", ma l'esperienza mi diceva pure che mi trovavo di fronte non alla regola, bensì
all'eccezione. Altre volte, in paesi non diversi da Lula ero dovuto intervenire sin dai primi momenti
per avere un po' di calma ed organizzare una discussione. Qui invece mi guardavano, attendevano,
ma soprattutto diffidavano. Che significa? Eppure quando erano fuori e aiutavano il bidello erano
diversi: allegri, felici e contenti, chiassosi, come tutti i bambini normali di questo mondo. Perché
mai una volta tra i banchi le loro espressioni, i loro atteggiamenti erano completamente cambiati?
Forse non ispirava fiducia la mia presenza? Boh! Sul momento non riuscii a rendermi conto.
Passarono così alcuni minuti senza che il quadro mutasse. Io attendevo che qualcuno parlasse per
poter poi avviare la discussione su cose che a loro fossero più congeniali, ma niente. Mi decisi
dicendo: - Beh, ma qui nessuno vuol dire qualcosa?
Silenzio e sguardi smarriti.
- Allora vogliamo discutere? -continuai muovendomi dal tavolino verso i banchi per incoraggiarli.
Gli sguardi si ravvivarono, qualche sorrisetto, un po' di movimento ondulatorio che fece
scricchiolare i banchi e ancora silenzio assoluto.
- Ma avete la lingua? - chiesi con tono provocatorio.
- Sì. Sì. Altro che. Che l'abbiamo. Si, eccome! - risposero.
Qualcuno addirittura la fece vedere. Gli altri subito reagirono con voce soffocata: - Maleducato!
Non sai che la lingua non si fa mai vedere! Lo dico a tua madre! Vedrai! Uhi!
-Se avete la lingua vuol dire che sapete parlare e che quindi possiamo anche fare una chiacchierata,
no?
- Noi? -chiese uno stupito.
- Sì , tutti assieme precisai.
- Mah! -fece un altro.
- Cosa vuol dire questo? - chiesi ancora.
- Ma dobbiamo parlare noi? E che ne sappiamo delle cose? Il maestro deve parlare - dissero uno alla
volta come se fossero comandati.
- Perché, voi non sapete parlare?
- Noi dobbiamo ascoltare, signor maè! Noi dobbiamo imparare.
L'anno scorso il maestro non voleva!
- Che cosa non voleva? - chiesi.
- Di parlare. Non voleva di muoversi - disse un altro subito.
- E voi non parlavate?
- No.
- Ma cosa facevate?
- I compiti.
- E il maestro?
- Il maestro ci spiegava la lezione.
- E poi?
- Ci interrogava.
- E chi si muoveva e parlava?
- Bacchettate. Sì, bacchettate. E anche schiaffi. E anche ci mandava via... - si cominciò a dire a voce
più alta un po' da tutte le parti.
118
- Allora è per questo che non volevate parlare?
- Per forza!
- Come per forza? - chiesi sempre più incuriosito e interessato.
- Se lei faceva come quello dell'anno scorso!
- A me le bacchette non piacciono!
- E a chi piacciono?
- Io stavo buono e non mi picchiava.
- Signor maè, Antonio - disse uno bruno alzandosi di scatto, ora cominciavo a distinguerli - era
quello che ne prendeva di più.
(...) - Allora di che cosa vogliamo parlare? - proposi.
Silenzio di nuovo. Si era di fronte ad un fatto così nuovo per loro che non riuscivano ad immaginare
su cosa si potesse discutere.
- Ma di cosa dobbiamo parlare? Noi non sappiamo niente! - fece Antonio incoraggiato dalle mie
parole.
- Ma davvero credi di non sapere proprio niente?
- Sì.
- In casa, con gli amici, con le persone che conosci, parli sì o no?
- Sì, sì, altro che!
- Ma quelle non sono cose di scuola - interruppe uno.
- E quali sono le cose di scuola?
- Le lezioni che si studiano e si scrivono sui quaderni.
- Le cose di casa e che si dicono con gli amici non si possono dire - aggiunse un altro.
- Perché?
- Perché così non impariamo niente.
- Chi ve l'ha detto?
- Il maestro dell'anno scorso.
- Sì.
- Vero. Proprio lui! - gridarono.
(...) - Va bene, lasciamo da parte il maestro, ma siete convinti che parlando non s'impara niente?
- Eh. Altro che. Sì, si capisce! .
- Allora non vogliamo parlare delle cose del paese?
- No, no. No, no. No, no...
- Parlatemi di voi allora.
- E che diciamo? Boh, non sappiamo niente.
- Ecco, come giocate, come passate il tempo fuori dalla scuola, oppure fatemi delle domande.
- Signor maè - disse subito Giuseppe, un ragazzetto bruno dagli occhi vivi che sedeva negli ultimi
banchi - ora rimane sempre con noi?
- Vuoi dire per tutto l'anno scolastico?.
- No, se rimane sempre a Lula.
- Non lo so, ma credo di sì, - dissi per incoraggiarlo.
- Allora vi piace stare qui?
- Sì, mi piace. E' un bel paese e la gente è brava, -risposi un po' a denti stretti, tornando col pensiero
alla discussione che avevo avuto col Provveditore agli Studi di Nuoro, quando m'impose di andare a
Lula come condizione per il mio rientro a scuola.
- Non tutti sono bravi signor maè, ce ne sono anche cattivi - fece una voce dal fondo semibuio.
(...) L'incanto era ormai rotto. La paura e la diffidenza li avevano in parte abbandonati e si poteva
quindi discutere di tutte quelle cose che non erano di scuola.
Quasi tutti avevano parenti fuori. Mi accorsi però che ancora non avevano parlato le femminucce: Ma voi -dissi - perché non parlate? Non avete da dire niente? Non sapete nulla di tutte queste cose?
- Ne sanno, ne sanno signor maè, - gridarono in coro ancora i bambini, - hanno vergogna perché
sono femmine!
- Non è vergogna parlare. Perché, le "femmine" qui non parlano?.
- Si, si che parlano! - rispose ancora il coro dei maschi.
119
- Voglio sentire loro; voi avete parlato abbastanza precisai.
A forza d'insistere, di promettere e d'assicurare, Maria, una simpatica trecciona semibionda, con un
vestitino estivo di un indefinibile colore per le sfumature che aveva preso col tempo, si decise, e ci
raccontò con apparente disinvoltura le varie usanze del paese in occasione delle feste dei morti. - Il
giorno dei morti, la sera, prima di andare a letto, mettiamo la roba da mangiare sul tavolo:
pastasciutta, carne, frutta e dolci fatti in casa. Ma se i morti non vengono, allora il giorno dopo ce la
mangiamo noi.
- Buona! Bene!
- A me piace la pasta!
- A me la carne.
- Uh che buona! - gridarono.
- Una volta, signor maè, - intervenne Grazia alzandosi lentamente ma parlando con voce stridula,
mia madre aveva messo la roba per i morti, invece è tornato tardi mio padre con gli amici e se
l'hanno mangiata loro!
- Hanno fatto bene! Benissimo!
- Ma che, i morti mangiano - fece il solito coro che ormai cominciava a perdere confidenza ed
interveniva continuamente per ogni cosa.
- La mamma - riprese Grazia seria e composta - ha detto che i morti ci venivano e ha cominciato a
sgridarmi. Mio padre invece ha detto che i morti stanno bene dove sono e che la roba se la devono
mangiare i vivi.
Immediatamente si creò una divisione: quelli che credevano nei morti e quelli che invece non ci
credevano.
- I morti sono morti e non fanno niente; la roba si mette per la festa - disse convinto Francesco, uno
scarmigliato ricciolone.
- Invece i morti ci sono e vanno di notte. Mia zia ha detto che una volta li ha visti: cantavano le
preghiere.
Quando cantano così vuol dire che sono peccatori e lo fanno per penitenza. Quando hanno finito
allora se ne vanno al purgatorio; se invece non si liberano vanno all'inferno.
- Non mi hai detto il tuo nome - chiesi,
- Mi chiamo Antonietta -rispose arrossendo sotto la bruna pelle del volto affilato e magro.
- E tu ci credi a tutte queste cose?
- Si che ci credo! E ho anche paura! In casa non rimango mai sola perché ho paura che mi escano i
morti - concluse con sicurezza e con un fare ora civettuolo.
Si passò da un argomento all'altro fino al mestiere dei genitori: - Mio padre fa il pastore; ha le capre
nel monte -fece disinvolto Giovanni, che ancora non aveva preso la parola.
- Ne ha molte? -chiesi.
- Una cinquantina.
- Danno molto latte?
- Beh, molto non so... quando sono figliate che hanno i capretti babbo porta il formaggio in paese e
lo vendiamo
- Anche mio padre fa il pastore... - Anche mio padre. - Anche il mio. - Pure il mio...
Su ventisette, sedici erano figli di piccoli pastori di capre o pecore, sei avevano i genitori emigrati, e
gli altri erano figli di artigiani e piccoli proprietari di terre. (...)
120
Le guerre di Ada
Laura Pariani
Tratto dal volume Di corno o d'oro
(Sellerio)
Illustre signor Sindaco,
io, Marchini Ada, maestra elementare nella scuola del vostro paese, stanotte oso indirizzarvi una
lettera molto particolare. Sono qui seduta nella mia stanzetta, al mio tavolo, di fronte al letto. E tutto
in ordine, ma io... io non sono niente affatto in chiaro con me stessa e provo dolore, nostalgia,
qualcosa di simile a una nuova fatica di nascere.
(...) E' successo una sera della primavera scorsa, in questa stanza. A un certo punto ho alzato gli
occhi da un libro che stavo leggendo. Quelle severe frasi illuminanti che mi riempivano il cuore...
Mi levai e andai alla finestra, lo sguardo sulle pòbbie. Sotto casa mia i miei scolari giocavano. Il
figlio del Paulén Giulài aveva legato a un chiodo del muro un gattino rosso e, fra le grida di
incitamento di tutti gli altri bambini che gli stavano intorno, lo colpiva a testate. E l'animale, dopo
quattro o cinque colpi, non si è mosso più. Morto. Proprio appeso a quel muro sul quale la stessa
mattina avevo spiegato loro il sistema metrico decimale; che c'erano ancora i segni col gessetto
rosso.
Ero impietrita. lo con i miei opuscoli di pedagogia e la mia saggezza di gesso. Mi venne
all'improvviso un'immensa voglia di piangere, di morire. Tanto sottile è la corda su cui
camminiamo e tanto fondo l'abisso in cui possiamo cadere.
Che dovevo fare con quei bambini? io che avevo spiegato loro mille volte che non si devono
devastare i nidi degli uccelli, che non bisogna prendere a sassate i vecchi cani zoppi.
Ma non ne han colpa i bambini. E il mondo che non va.
E come si fa a spiegare loro quello che è giusto e quello che non lo è, in uno stanzone che non ha
neppure il pavimento e in cui d'inverno la stufa manda più fumo che calore? Già, voi non lo sapete,
signor Sindaco, perché non vi siete mai degnato di venire a vedere la mia classe... Se ci veniste nella
brutta stagione, quando i bambini mi arrivano fradici e intirizziti, con le maglie bagnate che son
costretti a tenersi addosso tutto il giorno... Perché? Dico io: non ha il diritto alla salute il popolo di
campagna?
Forse, poiché il contadino non ha mezzi per procurarsi quanto è di assoluta necessità per la salute
fisica, dovrà essere costretto a intorpidirsi in vestiti quasi ghiacciati anche quando si trova sotto un
tetto comunale?
Ah, signore, come fa compassione il loro continuo tossire profondo certi giorni, il loro pietoso
lamentarsi per il gelo da cui si sentono tormentati. E d'estate l'afa e il Puzzo della latrina. Una
cuccagna, insomma, che davvero una si domanda: a che pro la scuola? Sapete, illustre signor
Sindaco, qual è il numero dei miei alunni? Centoventicinque, sì signore, avete letto giusto:
centoventicinque. Ah! lo so che voi direte che a maggio diventano cinquanta, perché è la stagione
dei bigatti e i paesani ritirano i figli dalla scuola in massa per farli lavorare.
Ma anche ammettendo che a maggio questo numero diminuisca, è pur sempre superiore alle mie
capacità morali e fisiche...
Come posso insegnare loro qualcosa in tali condizioni? Come posso aiutare quei poverini? E sapete
qual è l'arredo della mia lussuosa classe? Diciassette banchi, due lavagne rotte e inservibili, un
tavolino, una sedia che perde la sua impagliatura, una stufa che non funziona; e un posapiede (quale
onore!)...
Nessuna carta geografica neanche un pallottoliere... Ah, dimenticavo: due quadri, del Re e della
Regina.
Quelli non mancano. (...)
121
Le Maestre Pensierose
(Parafrasando Le galline pensierose di Luigi Malerba)
A cura di Alberto Melis e Fabio Corona
Quando vennero a sapere che la terra è rotonda come una palla e gira velocissima nello spazio, i
maestri incominciarono a preoccuparsi e furono presi da forti capogiri. Andavano per i prati
barcollando come se fossero ubriachi e si tenevano in piedi reggendosi l'uno all'altro. Il più furbo
propose di andare a cercare un posto più tranquillo e possibilmente quadrato.
Un maestro di storia si trovò per caso in mezzo a un grande trambusto di uomini e di cavalli, rischiò
di venire calpestato, ma alla fine riuscì a scappare e andò a nascondersi dietro a una siepe. Quando
raccontò il fatto gli dissero che si era trovato in mezzo alla battaglia di Waterloo, dove era stato
sconfitto Napoleone. Il maestro fu molto orgoglioso di essere stato testimone di un grande
avvenimento storico.
Un maestro strabico vedeva tutto il mondo un po' storto e credeva che fosse storto veramente.
Vedeva storte anche le sue colleghe e anche il direttore.
Camminava sempre di sbieco e spesso andava a sbattere contro i muri. Un giorno di vento passò
con le sue colleghe davanti alla torre di Pisa.
- Guarda il vento che ha stortato quella torre, - dissero le colleghe.
Il maestro strabico guardò anche lui la torre e la vide perfettamente dritta. Non disse niente, ma
pensò che forse le sue colleghe erano strabiche.
Una maestra sventata che si era allontanata dalla scuola si trovò a tu per tu con un professore. Se ne
innamorò pazzamente, ma fu un amore infelice perché il professore era miope e aveva scambiato la
maestra per una docente universitaria. Sarebbe stato un amore infelice anche se il professore si fosse
accorto che era una maestra.
Un maestro sindacalista di base andava in giro con un fiammifero in bocca.
- Potrei bruciare tutto, - diceva, - e invece non brucio niente perché sono un maestro civile.
Messo alle strette dalle altre maestre confessò che non incendiava niente perché non era capace di
accendere il fiammifero.
Una maestra di storia era convinta di avere il profilo etrusco.
Teneva sempre la testa voltata da una parte perché tutti potessero ammirare il suo profilo. Finì per
prendersi un torcicollo così forte che la testa gli rimase voltata di traverso fino al giorno in cui
cadde in un tombino e si ruppe una gamba. Dopo la caduta le si raddrizzò la testa, ma restò zoppa.
Una maestra di filosofia un po' incerta andava in giro per la scuola brontolando: - Chi sono io? Chi
sono io?
Le compagne si preoccuparono perché pensavano che fosse diventata matta, finché un giorno una le
rispose: - Una cogliona -. La maestra un po' incerta da quel giorno smise di vaneggiare.
Una farfalla gialla infastidiva una maestra, le svolazzava intorno quando questa usciva dalla scuola,
le si andava a posare sulla testa. La maestra non ne poteva più e per la rabbia non dormiva di notte.
Una mattina prese la strada e disse che andava dai carabinieri per denunciare la farfalla gialla. Un
collega le disse allora che la farfalla le girava intorno perché l'aveva scambiata per un fiore.
La maestra ritornò indietro e da quel giorno non si lamentò più quando la farfalla gialla le
svolazzava intorno.
Una maestra che si era convertita al buddismo disse che cercava il vuoto, l'assenza delle cose.
Se fosse riuscita a realizzare che una volpe non è più una volpe o che un coniglio non è più un
122
coniglio, diceva, avrebbe raggiunto l'illuminazione.
Prima che potesse raggiungere l'illuminazione, un giorno, mentre stava meditando sul margine della
strada, un autoarticolato la investì.
Una maestra vide i suoi resti sparsi, li riconobbe e disse:
- Questa maestra non è più una maestra.
Una maestra pazza credeva di essere Giovanna d'Arco e le colleghe dicevano:
- Va bene va bene.
A un certo punto la maestra si stancò di essere Giovanna d'Arco e decise di essere Napoleone.
- Non è possibile, - dissero le colleghe, - perché Napoleone era un uomo.
La maestra pazza disse che lei poteva credere di essere chi voleva dal momento che era pazza.
- Se voglio, - disse, - posso credere di essere anche il monumento di bronzo di Napoleone.
Le altre maestre dovettero darle ragione e la maestra pazza passò intere giornate immobile in sala
mensa come se fosse il monumento di bronzo di Napoleone.
Un maestro analfabeta desiderava molto imparare a fare la sua firma. Quando finalmente trovò una
maestra che sapeva leggere e scrivere disposta a insegnargli, si batté una mano sulla fronte ed
esclamò:
- Non so come mi chiamo!
Un maestro ingegnoso aveva, in tempi molto lontani, inventato la ruota.
La mostrò ai suoi colleghi che si misero a ridere e dissero che non serviva a niente. Fu così che la
civiltà dei maestri rimase in arretrato rispetto a quella degli uomini, i quali presero il sopravvento e
ostacolarono il loro cammino sulla strada del progresso.
Un maestro di geografia che voleva andare in Cina aveva sentito dire che per arrivare in quel
lontano paese avrebbe dovuto trovare i punti cardinali e poi camminare verso Est.
Il maestro andò in giro per i prati e per i boschi a cercare Est, ma non riuscì a trovarlo. Lo cercò
sotto le siepi, nei fossi, ai bordi delle strade, nei dirupi, ma di Est non riuscì a trovare nemmeno
l'ombra e così dovette rinunciare al suo viaggio in Cina.
Un maestro scienziato faceva delle corse pazze perché voleva infrangere il muro del suono.
Un giorno andò a infrangersi contro il muro del cortile e così finirono i suoi tentativi.
Una maestra di matematica avrebbe voluto imparare a guidare il triciclo, ma vi rinunciò quando,
contandosi le gambe, si accorse di averne solo due.
Per guidare il triciclo pensava che ne servissero tre.
Una maestra del Minnesota aveva sentito dire che i grattacieli fanno venire le vertigini. Un giorno
fece un viaggio fino a New York, ma camminò per le strade tenendo sempre gli occhi bassi perché
temeva che le venissero le vertigini e così ritornò a casa senza a aver visto i grattacieli. Peggio per
loro, si disse durante il viaggio di ritorno.
Una maestra calabrese decise di diventare mafiosa. Andò da un ministro mafioso per avere una
raccomandazione, ma questo le disse che la mafia non esiste. Andò da un giudice mafioso, ma
anche questo le disse che la mafia non esiste. Andò infine da un sindaco mafioso e anche questo
disse che la mafia non esiste. La maestra ritornò a scuola e ai colleghi che le facevano delle
domande rispose che la mafia non esiste. Tutti i maestri pensarono così che era diventata mafiosa ed
ebbero timore di lei.
Un maestro sapiente voleva insegnare alle colleghe a contare e a fare le addizioni. Sulla lavagna
scrisse i numeri da 1 a 9 e spiegò che mettendoli insieme se ne potevano ricavare altri più grandi.
123
Per insegnare le addizioni scrisse su un'altra lavagna: 1 + 1 = 11; 2 + 2 = 22; 3 + 3 = 33 e così via
fino a 9 + 9 = 99. Le maestre impararono le addizioni e le trovarono molto convenienti.
Una maestra megalomane aveva deciso di scrivere un progetto.
- Su che cosa? - domandarono le colleghe. - Su tutto, - rispose la maestra megalomane. Le colleghe
si mostrarono molto scettiche e le fecero notare che tutto era un po' troppo. La maestra megalomane
corresse il suo progetto e disse che avrebbe scritto un progetto su quasi tutto.
Una maestra filosofa guardava un sasso e diceva: - Chi mi dice che questo è un sasso? - Poi
guardava un albero e diceva: - Chi mi dice che questo è un albero?
- Te lo dico io, - rispondeva una maestra qualsiasi. La maestra filosofa la guardava con
compatimento e domandava: - Chi sei tu che pretendi di dare una risposta alle mie domande? - La
maestra qualsiasi la guardava preoccupata e rispondeva:
- Io sono una maestra -.
E l'altra: - Chi mi dice che tu sei una maestra? - Dopo un po' la maestra filosofa si trovò molto sola.
Un maestro decadente una sera tardò a rientrare a casa per assistere al tramonto, poi lo raccontò alle
sue colleghe. Fu in quella occasione che il maestro decadente pronunciò una frase che divenne
celebre:
- Bello il tramonto!
Quando il direttore prese il raffreddore tutte le maestre fecero a gara per curarlo. Alcune trovarono
un tale piacere nelle cure che appena il direttore fu guarito, lo fecero cadere in acqua con uno
sgambetto perché prendesse un altro raffreddore. Invece prese una polmonite e morì.
Un maestro romano passò sotto l'arco di Costantino, ma non provò nessuna emozione particolare.
Ci passò una seconda volta e rimase ancora deluso. Si domandò perché mai Costantino avesse fatto
costruire quell'arco per poi passarci sotto.
Una maestra che aveva imparato a contare fino a quattro pretendeva che le colleghe la chiamassero
professoressa e voleva scacciare il direttore per prendere il suo posto.
Le altre maestre le strapparono tutti i capelli e poi dissero che l'avrebbero chiamata professoressa
solo se fosse stata capace di contare tutti i capelli che le avevano strappato.
Un maestro parigino volle salire sulla torre Eiffel. Si arrampicò a fatica gradino dopo gradino e
arrivò finalmente sulla terrazza più alta. Qui si affacciò e vide una distesa di palazzi, di monumenti,
di giardini. Che città sarà mai questa?, si domandò il maestro parigino che era rimasto con la bocca
aperta per la meraviglia. Incominciò a scendere le scale di corsa per domandare al guardiano il
nome della città che si vedeva dalla terrazza più alta della Torre Eiffel.
Una maestra di Vibo Valentia voleva studiare la filosofia di Wittgenstein, ma ogni volta le veniva
un gran male di testa. Provò con Whitehead, ma anche con lui le veniva il male di testa. Provò
ancora con Weisse con Wolff con Wahl con Wundt, ma andò anche peggio. Un giorno aprì per caso
un libro di Wodehouse e lesse molte pagine senza il minimo dolore. Da quel giorno decise che il
suo filosofo preferito era Wodehouse.
Una maestra un po' svagata diceva di sentire un gran vuoto dentro la testa, proprio nella parte dove
di solito si trova il cervello. - Ho paura di non avercelo il cervello, - diceva la povera maestra
piangendo, - se lo avessi me lo sentirei -. Ma le altre maestre la rassicurarono dicendo che non se lo
sentivano nemmeno loro.
124
- Per diventare filosofa diceva una vecchia maestra che credeva di essere molto saggia, - non
importa pensare a qualcosa, basta pensare anche a niente -. Lei si metteva in un angolo del cortile e
pensava a niente. Così, e non in altri modi, diceva di essere diventata una maestra filosofa.
Nel collegio dei docenti si accese una discussione se fosse più bella l'alba o il tramonto. Si formò il
partito delle maestre albiste e quello delle maestre tramontiste. Con il passare del tempo le une
dimenticarono l'alba e le altre dimenticarono il tramonto, rimase solo l'odio delle une contro le altre.
125
Le veglie di Neri
Renato Fucini
Scampagnata
(...) ...E quello con quel sciarpone di seta nera al collo, che è inginocchiato accanto al sor Cosimo,
continuò il Dottore, è lo Stelloni mugnaio, assessore della pubblica istruzione. Il sor Cosimo lo
prescelse alla carica, perché, vista l'antipatia che fin da bambino lo Stelloni aveva dimostrato per le
scuole, poté tranquillizzare il Consiglio che lui delle spese inutili non ne avrebbe fatto fare. E
l'assessore Stelloni, fedele al suo mandato, non ha mai messo piede in una scuola. Lui dice per non
compromettersi, perché le cose non vanno a modo suo; la canaglia dice che ha paura di dovere
interrogare i ragazzi.
È un buon diavolo, però, e non ha odio con altri fuori che col maestro comunale, quel giovanotto
pallido lì dalla piletta, perché sopra un componimento del suo figliolo corresse "appetito divoratore"
dove era scritto "appetito divoratrice". Lo Stelloni lo compatì benignamente finché la questione
rimase dubbia; ma quando fu accertato che il maestro aveva ragione, il benigno compatimento
dell'Assessore si convertì in odio implacabile, e ora cerca tutte le gretole per poterlo mettere nella
strada a morire di fame. (...)
126
L'esclusa
Luigi Pirandello
(...) Era chiaro! Marta Ajala avrebbe occupato il posto di maestra supplente nelle prime classi
preparatorie del Collegio, solo perché "protetta" del deputato Alvignani.
E vi fu, nei primi giorni, una processione di padri di famiglia al Collegio: volevano parlare col
Direttore. Ah, era uno scandalo! Le loro ragazze si sarebbero rifiutate d'andare a scuola. E nessun
padre, in coscienza, avrebbe saputo costringerle. Bisognava trovare, a ogni costo e subito, un
rimedio. Il vecchio Direttore rimandava i padri di famiglia all'Ispettore scolastico, dopo aver difeso
la futura supplente con la prova degli ottimi esami. Se qualche altra avesse fatto meglio, sarebbe
stata presa a supplire in quella classe aggiunta. Nessuna ingiustizia, nessuna particolarità...
- Ma sì! -. Il cavalier Claudio Torchiara, ispettore scolastico, era del paese e amico intimo di
Gregorio Alvignani. A lui i reclami si ritorcevano sotto altra forma e sotto altro aspetto. Voleva
l'Alvignani rendersi impopolare con quella protezione scandalosa? E invano il Torchiara s'affannava
a protestare che l'Alvignani non centrava né punto né poco, che quella della maestra Ajala non era
nomina governativa. Eh via, adesso! Che sostenesse ciò il Direttore del Collegio, TRANSEAT!, ma
lui, il Torchiara, ch'era del paese; eh via! Bisognava aver perduto la memoria degli scandali più
recenti... Era venuta dunque così dall'aria quella nomina dellAjala? E in coscienza se il Torchiara
avesse avuto una figliuola, sarebbe stato contento di mandarla a scuola da una donna che aveva
fatto parlare così male di sé? Che fior di maestra per le ragazze!
(...) Ricominciò la guerra fin dal primo giorno di scuola.
Già le altre maestre del Collegio, oneste e brutte zitellone, se la recarono subito a dispetto. Gesù,
Gesù! un breve saluto, la mattina, con le labbra strette, e via; un freddo, lieve cenno del capo, ed era
anche troppo! Un'onta per la classe delle insegnanti! Un'onta per l'Istituto! Il mondo, sì, intrigo: per
riuscire, mani e piedi! ma onestamente, oh! anzi, onoratamente. E, sotto sotto, commentavano con
acre malignità il modo con cui il Direttore e gli altri professori del Collegio fin dal primo giorno si
erano messi a trattare l'Ajala; e rimpiangevano quella cara maestra Flori che non avrebbero più
riveduta. La Flori: che pena! Riusciti vani i nuovi e più aspri reclami delle famiglie, le ragazze
(assentatesi per alcuni giorni dalla scuola all'annunzio della nomina di Marta) cominciarono man
mano a ripigliare le lezioni; ma cattive, astiose, messe su evidentemente dai genitori contro la nuova
maestra. A nulla giovò l'affabilità con cui Marta le accolse per disarmarle fin da principio; a nulla la
prudenza e la longanimità. Si sottraevano sgarbatamente alle carezze, si mostravano sorde ai
benevoli ammonimenti, scrollavano le spalle a qualche rara minaccia; e le più cattive, nell'ora della
ricreazione in giardino, sparlavano di lei in modo da farsi sentire o, per farle dispetto, accorrevano
ad attorniare le antiche maestre e a carezzarle, piene di moine e di premure, lasciando lei sola a
passeggiare in disparte.
Ritornando a casa, dopo sei ore di pena, Marta doveva fare uno sforzo violento su se stessa per
nascondere alla madre e alla sorella il suo animo esasperato. Ma un giorno, ritornando più presto dal
Collegio, accesa in volto, vibrante d'ira contenuta a stento, appena la madre e Anna Veronica le
domandarono che le fosse avvenuto, ella, ancora col cappellino in capo, scoppiò in un pianto
convulso.
Esaurita finalmente la pazienza, vedendo che con le buone maniere non riusciva a nulla, per
consiglio del Direttore s'era messa a malincuore a trattare con un po' di severità le alunne. Da una
settimana usava prudenza con una di esse, ch'era appunto la figlia del consigliere Breganze, una
magrolina bionda, stizzosa, tutta nervi, la quale, messa su dalle compagne, era giunta finanche a
dirle forte qualche impertinenza. - E io ho finto di non udire... Ma quest'oggi alla fine, poco prima
che terminasse la lezione, non ho saputo più tollerarla. La sgrido. Lei mi risponde, ridendo e
guardandomi con insolenza. Bisognava sentirla! "Esca fuori!" "Non voglio uscire!" "Ah! no!"
Scendo dalla cattedra per scacciarla dalla classe: ma lei s'aggrappa alla panca e mi grida: "Non mi
tocchi! Non voglio le sue mani addosso!". "Non le vuoi? Via, allora, via! esci fuori!" e fo per
strapparla dalla panca. Lei allora si mette a strillare, a pestare i piedi, a contorcersi. Tutte le ragazze
127
si levano dalle panche e le vengono intorno; lei, minacciandomi, esce dalla classe, seguita dalle
compagne. E' andata dal Direttore. Questi non mi dà torto in loro presenza; rimasti soli, mi dice che
io avevo un po' ecceduto; che non si debbono, dice, alzar le mani su le allieve... Io, le mani? Se non
l'ho toccata! Alla fine però accetta le mie ragioni... Ma Dio, Dio; come andare avanti così? Io non
ne posso più! Il giorno appresso, intanto, il padre della ragazza, il consigliere cavaliere ufficiale
Ippolito Onorio Breganze, andò a fare una scenata nel gabinetto del Direttore. Era furibondo.
L'obesità del corpo veramente non gli permetteva di gestire come avrebbe voluto. Corto di braccia,
corto di gambe, portava la pancetta globulenta in qua e in là per la stanza, faticosamente, facendo
strillare le suole delle scarpe a ogni passo. Alzare le mani in faccia alla sua figliuola? Neanco Dio,
neanco Dio doveva permetterselo!
Lui, ch'era il padre, non aveva mai osato far tanto! Si era forse tornati ai beati tempi dei gesuiti,
quando s'insegnava a colpi di ferula su la palma della mano o sul di dietro? Voleva pronta e ampia
soddisfazione! Ah sì, perrrdio! Se la signora Ajala aveva valide protezioni e preziose amicizie, lui,
il consiglierrr Breganze, avrebbe reclamato riparazione e giustizia più in alto, più in alto (e si
sforzava invano di sollevare il braccino) - sissignore, più in alto! a nome della Morale offesa non
solo dell'Istituto, ma dell'intero paese.
E DRI DRI DRI - strillavano le scarpe. (...)
128
Lessico famigliare
Natalia Ginsburg
(Einaudi)
(...) - Mia madre gli raccontò un fatto che era successo al bambino d'una sua amica, molti anni
prima, ancora prima della guerra e prima anche della campagna razziale. Questo bambino era ebreo,
e i suoi l'avevano messo alla scuola pubblica; avevano però chiesto alla maestra di esentarlo delle
lezioni di religione. Un giorno la sua maestra non c'era in classe e c'era invece una supplente, che
non era stata avvertita e quando venne l'ora di religione, si meravigliò a vedere quel bambino
prendere la cartella e prepararsia uscire.
- Tu perché te ne vai? - chiese.
- Me ne vado, - disse il bambino, - perché io vado sempre a casa quando c'è l'ora di religione.
- E perché? - domandò la supplente.
- Perché io - rispose quel bambino - non voglio bene alla Madonna.
- Non vuoi bene alla Madonna! - gridò scandalizzata la maestra. - Avete sentito bambini? Non vuol
bene alla Madonna!
- Non vuoi bene alla Madonna! non vuoi bene alla Madonna! - gridava ora tutta la classe. I genitori
s'erano trovati costretti a levare il bambino da quella scuola. A Mario questa storia piacque
immensamente. Non finiva più di estasiarsene, e chiedeva se era proprio vera. - Inaudito! - diceva
battendosi la mano sul ginocchio. - Una cosa inaudita!
Mia madre era contenta che la sua storia gli fosse tanto piaciuta; ma poi si stancò di sentirlo ripetere
che in Francia maestre cos¡ non esistevano e non si potevano nemmeno pensare. (...)
129
Lettera a una professoressa
Don Lorenzo Milani
(Libreria editrice fiorentina)
(...) A giugno del terzo anno di Barbiana mi presentai alla licenza media come privatista. Il tema fu:
"Parlano le carrozze ferroviarie". A Barbiana avevo imparato che le regole dello scrivere sono: aver
qualcosa di importante da dire che sia utile a tutti o a molti. Sapere a chi si scrive.
Raccogliere tutto quello ci serve. Trovare una logica su cui ordinarlo. Eliminare ogni parola che non
serve. Eliminare ogni parola che non usiamo parlando. Non porsi limiti di tempo...
...Ma davanti a quel tema che me ne facevo delle regole umili e sane dell'arte di tutti i tempi? Se
volevo essere onesto dovevo lasciare la pagina in bianco.
Oppure criticare il tema e chi me l'aveva dato. Ma avevo quattordici anni e venivo dai monti. Per
andar alle magistrali mi ci voleva la licenza. Quel fogliuccio era in mano a cinque o sei persone
estranee alla mia vita e a quasi tutto ciò che amavo e sapevo. Gente disattenta che teneva il coltello
dalla parte del manico.
Mi provai dunque a scrivere come volete voi. Posso ben credere che non ci riuscii. Certo scorrevano
meglio gli scritti dei vostri signorini esperti nel frigger aria e nel rifrigger luoghi comuni. Il compito
di francese era un concentrato di eccezioni. Gli esami vanno aboliti. Ma se li fate, siate almeno leali.
Le difficoltà vanno messe in percentuale di quelle della vita. Se le mettete più frequenti avete la
mania del trabocchetto.
Come se foste in guerra coi ragazzi. Chi ve lo fa fare? Il loro bene? Il loro bene no. Passò con nove
un ragazzo che in Francia non saprebbe chiedere nemmeno del gabinetto. Sapeva solo chiedere gufi,
ciottoli e ventagli sia al plurale che al singolare. Avrà saputo in tutto duecento vocaboli e scelti col
metro di essere eccezioni, non di essere frequenti.
Il risultato è che odiava anche il francese come si potrebbe odiare la matematica...
IL problema di geometria faceva pensare a una scultura della Biennale:
Un solido è formato
da una semisfera sovrapposta
a un cilindro
la cui superficie
è tre settimi di quella...Non esiste uno strumento che misuri le superfici. Dunque nella vita non può accadere mai di
conoscere le superfici e non le dimensioni. Un problema così può nascere solo nella mente di un
malato. Nella Nuova Media queste cose non si vedranno più.
I problemi partiranno "da considerazioni di carattere concreto"
Difatti la Carla quest'anno alla licenza ha avuto un problema moderno a base di Caldaie: "Una
caldaia ha la forma di una semisfera sovrapposta ..."
E di nuovo si parte dalle superfici. Meglio un professore all'antica, d'uno che crede di essere
moderno perché ha cambiato le etichette.
Il nostro era all'antica.
Fra l'altro gli successe che nessuno dei suoi ragazzi riuscì a risolvere il problema. Dei nostri se la
cavarono due su quattro. Risultato: ventisei bocciati su ventotto.
Lui raccontava in giro che gli era toccata una classe di cretini. (...)
130
Lidya la regina della terra promessa
Uri Orlev (Salani)
(...) Non avevo problemi con gli adulti, a parte Leah. Mi piaceva Dina, e anche David era un bravo
insegnante. Andavo d'accordo con l'insegnante di ginnastica, forse perché ero la migliore nel salto
in lungo. Ma la mia preferita era Hannah, la maestra d'inglese.
Grazie a Mister Lupo conoscevo l'inglese meglio degli altri bambini, tanto che all'inizio mi
annoiavo in classe e davo fastidio a tutti. Ogni volta che Hannah mi diceva qualcosa, io le
rispondevo facendo qualche battuta, finché un giorno mi chiese di fermarmi dopo la lezione.
"Vorrei fare due chiacchiere con te" mi disse in inglese.
Ero convinta che non sapesse una parola in ebraico, ma in seguito scoprii che lo parlava benissimo,
ma preferiva rivolgersi ai suoi alunni in inglese. Anche in quell'occasione mi parlò in inglese,
pronunciando parole e frasi molto semplici. Guardandola da vicino mi accorsi che aveva occhi
azzurri, molto luminosi, e il collo pieno di rughe.
Credeva che io fossi una ragazza di città che si trovava in pensione al kibbutz, e quando le spiegai
che mia madre era in Romania ma sarebbe arrivata al più presto, mi lanciò un'occhiata penetrante.
Non mi chiese nulla di mio padre. "La mamma deve andare in Turchia, e forse gli inglesi la
lasceranno passare". "Io sono inglese" sospirò Hannah.
"Come mai hai un nome ebraico?"
Mi spiegò che il suo vero nome era Ann, e che non era affatto ebrea.
"Ma allora perché... " Non finii la domanda. Mi venne in mente che poteva sembrare maleducato
chiederle per quale motivo gli inglesi non lasciavano entrare gli ebrei in Palestina, o cosa ci faceva
lei nel paese, visto e considerato che mi aveva chiamata per una ramanzina.
Hannah sembrò essersi dimenticata che doveva sgridarmi, e si mise invece a spiegarmi cosa l'aveva
portata in Palestina. Anche se mi sfuggì qualcosa, riuscii a capire che suo marito era un ufficiale
dell'esercito inglese, e lei non aveva voluto restare da sola a Londra. Gli Ebrei, la Terra Santa e la
vita nei kibbutz l'avevano sempre interessata, e quello era il motivo per cui si era offerta volontaria
per insegnarci l'inglese.
"Senza essere pagata?" le chiesi, per essere sicura del significato della parola volontaria.
"Senza essere pagata".
Avrei voluto chiederle se aveva figli, ma riuscii a controllarmi e le domandai invece cosa faceva
suo marito.
"E' un ufficiale dell'esercito inglese. Te l'ho già detto, ma forse non hai capito".
"No, ho capito. Voglio solo sapere cosa fa nell'esercito".
"Mio marito fa parte di un'unità così speciale che non so nemmeno di cosa si tratti. Viene a casa
raramente, e non abbiamo figli. Per questo mi piace tanto venire qui a insegnare. Amo il mio lavoro,
anche se a volte una certa bambina è un po' insolente"
aggiunse sorridendo.
Fece una pausa, e stavo per scusarmi quando lei riprese: "E tu dove lavori, qui al kibbutz?"
Le raccontai dell'angolo della natura, di quanto mi piaceva dar da mangiare agli animali e di come
non mi dava fastidio pulire gabbie e recinti.
"Senti la mancanza di tua madre? "
"Ogni tanto. A volte mi manca tantissimo, soprattutto dopo che ho litigato con qualcuno, altre volte
invece mi dimentico che sono qui da sola".
"Io sento terribilmente la mancanza dei miei genitori, e sono anche molto preoccupata per loro".
"I tuoi genitori vivono a Londra?"
"Sì. Sono molto anziani e molto cari".
Non avrei mai immaginato che una persona grande come Hannah potesse avere ancora i genitori.
"Perché sei preoccupata?"
"Per via delle incursioni aree tedesche. Forse non lo sai, ma i tedeschi continuano a bombardare
Londra".
131
Non lo sapevo. Da quel giorno in poi, non vedevo l'ora che arrivassero le lezioni di inglese. Hannah
mi nominò sua assistente, e alla fine della lezione l'accompagnavo nella sala riservata agli
insegnanti. Avevamo inglese la domenica e il mercoledì. La domenica era appena prima
dell'intervallo, e poiché la sala professori era vicina alla nostra aula, ci fermavamo a metà strada per
chiacchierare.
La lezione del mercoledì era invece l'ultima della giornata, e dopo accompagnavo Hannah alla
fermata dell'autobus, restando a farle compagnia. In quelle occasioni avevamo un sacco di tempo
per parlare, e io le raccontavo tutte le mie storie della Romania, le gite in montagna, le vacanze con
Mihai e Ion, le mie governanti, Marioara, Mister Lupo e il modo in cui mi ero liberata di lui, e
Adriana che correva sempre dalla mamma.
Le parlai anche delle bambole, dei matrimoni e dei funerali che organizzavo con loro, e delle
cerimonie che servivano a dichiarare qualcuno mio nemico ufficiale.
"Sai" mi spiegò Hannah, "In Africa e in altri posti lontani ci sono delle tribù che fanno la stessa
cosa quando vogliono uccidere un nemico, o vincere una guerra. Esiste persino una cerimonia
chiamata VOODOO nel corso della quale si prende una bambola che rappresenta il nemico e si
finge di ucciderla. Questo significa che anche il nemico morirà".
"E poi muore davvero"?
"Non lo so"! Hannah scoppiò a ridere. "Io non volevo uccidere sul serio Leah."
Un'altra volta mi chiese se mi piaceva la scuola. Prima d'allora non mi ero posta una domanda del
genere.
"Sì" le risposi, dopo averci pensato sopra.
"Io credo che qui i bambini siano abbastanza felici. Vorrei aver frequentato una scuola come
questa"! (...)
132
L'obbedienza non è più una virtù
Don Lorenzo Milani
(Libreria editrice fiorentina)
(...) La mia è una parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare.
Cinque classi in un'aula sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semianalfabeti e andavano a lavorare.
Timidi e disprezzati. Decisi allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile
e non solo religiosa.
Così da undici anni in qua, la più gran parte del mio ministero consiste in una scuola. Quelli che
stanno in città usano meravigliarsi del suo orario. Dodici ore al giorno, 365 giorni l'anno. Prima che
arrivassi io i ragazzi facevano lo stesso orario (e in più tanta fatica) per procurare lana e cacio a
quelli che stanno in città. Nessuno aveva da ridire. Ora che quell'orario glielo faccio fare a scuola
dicono che li sacrifico.
(...) Riceviamo le visite insieme.
Leggiamo insieme: i libri, il giornale, la posta.
Scriviamo insieme. (...)
133
L'uomo nell'astuccio
Cechov
(...)Bèlikov attese un poco, e riprese poi, piano, con voce triste: - E ho anche qualche altra cosa da
dirvi: sono professore da lungo tempo, mentre voi siete appena agli inizi, e in quanto più anziano di
voi credo dovervi dare un avvertimento. Andare in bicicletta è una distrazione del tutto
sconveniente, per un educatore dei giovani."
"E perché?" chiese Kovalènko, con la sua voce di basso.
"Forse che occorre una spiegazione? Non è facile capirlo"? Se il maestro va in bicicletta, che
rimane da fare agli scolari? Non resta loro altro che camminare sulla testa. E dal momento che ciò
non è autorizzato da una circolare, è chiaro che non è permesso. Ieri mi sono spaventato: quando
vidi vostra sorella non credevo ai miei occhi. Una donna, una signorina in velocipede! orribile!"
"Insomma, cosa volete?"
"Non desidero che una cosa: avvertirvi. Siete giovane, avete l'avvenire dinanzi a voi, dovete
comportarvi con molta, molta prudenza. Vi prendete troppa libertà! Oh, se ve ne prendete! Portate
delle camicie ricamate, circolate di continuo in città tenendo non si sa che libri; e adesso, in
velocipede! Il preside saprà che voi e vostra sorella andate in bicicletta e ciò arriverà sino agli
orecchi del provveditore... Non ne verrà nulla di buono!" (...)
134
Maestra di campagna
Carola Prosperi
Pioveva. Il villaggio, già sperduto in fondo alla valle, pareva diventato una pozzanghera sola, colle
aie melmose, le viottole e i campi deserti, le case chiuse, poiché le donne stavano nelle stalle a filare
e gli uomini al paese vicino, dove arrivava il vapore e dove c'erano due osterie. Non s'udiva che lo
scrosciar lieve lieve di una pioggia lenta, monotona, eterna.
Pochi minuti prima delle quattro, in una casetta più bassa delle altre, una vera bicocca all'estremità
del paese, coi vetri rotti accomodati con carta ingommata e una scaletta di legno esterna tutta tarlata,
la porta si aprì e ne uscirono cinque o sei ragazzi con gli scartafacci sotto il braccio.
Mentre se ne andavano di qua e di là, curvi sotto l'acqua, col loro passo lento e pesante di contadini,
la maestra stava a guardarli dritta e immobile sulla soglia. Era una ragazza anziana, vestita di nero,
magra e scialba, col volto avvizzito e lungo, fisso in un'espressione di fredda e abituale malinconia.
Davanti a tutto quel grigio plumbeo ella parve rabbrividire, nascose le mani sotto il grembiale,
allungò il capo per guardare intorno: non c'era nessuno. Chiuse la porta della scuola, salì la scaletta
di legno ed entrò nella sua abitazione, una vasta e squallida stanza che le serviva da camera e da
cucina.
Tutto tornò deserto per un pezzo. Solo una volta, poiché la pioggia cadeva con maggior violenza,
una tendina giallognola si alzò e il viso della maestra apparve, per un momento, dietro ai vetri. Più
tardi, verso le cinque, un essere umano spuntò finalmente in fondo alla strada, nella campagna
desolata: un giovinetto alto ed elegante col bavero del soprabito rialzato e le mani inguantate. Egli
evitava con cura le pozzanghere saltando da una parte all'altra della strada e si guardava inquieto le
scarpe, affondandole nella mota con disgusto. Giunto presso la scaletta di legno trasse un sospirone
di sollievo, chiuse l'ombrello, si scosse come un cane bagnato e salì, in due salti.
- Sono io, Paola. Stai al buio?...
- Sei tu, Ugo?
La maestra di scuola - forma oscura e immobile accanto alla tavola - si alzò ed accese una piccola
lampada a petrolio che illuminò fiocamente tutta la stanza, mentre Ugo brontolava contro il tempo e
le seccature del viaggio e cercava intorno cogli occhi il punto più adatto del pavimento per
appoggiarvi il bel pomo del suo ombrello aperto.
(...) - Che freddo!... Che umidità! - diceva di tanto in tanto e batteva i piedi. La sorella lo guardava.
Era un bel ragazzo di sedici anni, snello e ben fatto, con un viso gioviale e vermiglio, la fronte alta e
bianca, gli occhi chiari e limpidi, con un aspetto già virile ma pieno ancora di allegria fanciullesca.
(...) - E papà?... Come sta?... Ugo alzò le spalle .
- Sempre lo stesso. Il padre, infermiccio, apatico, rassegnato, non aveva da chiederle nulla, epperò
non le scriveva mai.
- Vi divertite?...
- Per conto mio, figurati!... Devo studiare... Le ragazze si divertono alla sera come possono. Viene il
fidanzato di Renata, quello spilungone, con qualche amico... Augusta suona, Clementina si
lamenta... La solita baraonda. Io mi rintano in camera mia. Ho poco da scherzare... Se non studio la
mamma non mi dà pace.
- Sei un uomo tu! - disse con asprezza la sorella. - Devi lavorare. Non puoi aspettare la fortuna
come quelle ragazze. E poi, lo sai... Siamo poveri!... Siamo poveri! ...
- Eh, lo so!... - rispose il ragazzo un po' stupito di quella violenza. E aggiunse con una graziosa aria
di impotenza: - Lavorerò.
Stettero un poco in silenzio.
Ella aveva preso in mano la calza e scalzettava rapidamente: di tanto in tanto un sorriso amaro le
increspava le labbra senza riuscire a schiudergliele. Ugo si guardava attorno con uno strano
stringimento di cuore. - Dove stai!... - e come se vedesse tutto ciò per la prima volta, mirò sbigottito
la stanza squallida e vasta, la mobilia miserabile, le pareti nude, il letto in un angolo, dietro un
paravento primitivo, il canapè colla fodera sdrucita, e un secchio pieno d'acqua, accanto al muro. E
pensò alla loro casa in città piena di chiasso e di gente, dove i creditori picchiavano ad ogni
135
momento e pure non riuscivano a rattristar loro la vita, perché ognuno pensava per sé e non faceva
nulla per gli altri.
Una baraonda sì, ma piena d'allegria. Egli sentì la sua fresca, ingenua anima offuscarsi.
- Non potrei ripartire adesso?
- Piove troppo... dormi nel mio letto. Io dormirò sul sofà.
- Ma...
- La strada è buia.
- Ma qui fa freddo...
- Oh appena... Sei tanto delicato? Che cosa faresti allora qui, d'inverno...
(...) Paola apparecchiava la tavola: stese una tovaglia grossolana, dispose due piatti rozzi, le posate,
il bricco del latte, una bottiglia piena di caffè chiaro e dolciastro e il pane.
Ugo mangiò con avidità, ella bevve appena del latte.
- Come mangi poco!... - stupì il ragazzo.
- Mi par d'aver lo stomaco chiuso da tanti anni!... - ella rispose, e s'alzò e andò al cassettone.
- Senti... Andiamo a dormire?... - sbadigliò Ugo di nuovo, infreddolito.
- Senti prima. Questa busta la darai alla mamma; quest'involto a Renata, quest'altro - ci son le calze
- ad Augusta. Per Clementina non posso darti nulla. Non scrivo, ma la cosa che devo dir loro, la
riferirai tu.
Ugo sbadigliava: - Che sonno, che freddo, Paola!...
- Dirai loro che non mi chiedano più niente. Non ho più niente ora. Puoi rovesciare la casa, non
troveresti un centesimo, non un filo di roba. E per l'avvenire, dirai che non sarò più padrona né del
mio tempo, né di ciò che guadagnerò.
- Ah, va bene... Perché?...
- Perché prendo marito.
Ugo si scosse, gridò un: "eh?", e il suo viso si rischiarò di un riso fuggevole di stupore e di
canzonatura.
- Tu prendi marito?
E pareva che volesse dirle: - Eh via! Che storiella è questa?...
Il cuore della povera zitella trasalì a quella ferita nuova e sentì ravvivato il bruciore di tutte le ferite
antiche.
Chi aveva stabilito, alla sua nascita, che il suo destino dovesse essere rinunzia, umiltà e sacrifizio?...
Aveva dovuto pagare il fio di essere nata virtuosa e savia, tra gente senza scrupoli, dispotica e
temeraria, che apprezzava soltanto l'ozio e i piaceri della vita; e quando la casa, peggio di una barca
che fa acqua da tutte le parti, era stata lì lì per sfasciarsi, ella sola si era rassegnata a partire. Che
supplizio durante i lunghi anni dell'avversa fortuna!...
Poi, un po' d'apparente agiatezza era tornata in casa, ma lei per consiglio di tutti era rimasta a
lavorare. Giacché aveva il beneficio di poter guadagnare, guadagnasse!... E tutti i suoi erano sempre
pronti a piombarle addosso come avvoltoi. Oh se avessero potuto spremerla di più, sfruttarla ancora,
toglierle il sonno, contarle i bocconi, far denaro d'ogni suo minuto!...Era un andirivieni continuo, un
richiedere concitato, delle esigenze senza fine, delle proteste senza tregua!... E le dicevano, senza
volerla schernire: - Beata te che sei indipendente e non hai bisogno di nessuno!...
Invece, ora, ella sentiva proprio bisogno di qualcuno che la difendesse dalla sua stessa debolezza,
che dicesse di no per lei; sentiva più acuta la sorda e latente ribellione di tanti anni, l'amarezza
dell'ingiustizia, il rancore della schiavitù, tutto ciò che voleva sfogarsi e le gonfiava il petto e la
agitava come un male insopportabile. (...)
Così Paola sposò un contadino e diventò matrigna di due contadinelle. Fu morta al mondo, come
una monaca, senza le dolcezze del convento; come una sepolta, senza la pace della tomba. Fu
rinnegata e dimenticata. Il fratello solo, nonostante le diverse vicende e fortune colle quali si era
conquistato il suo posto nel mondo, la ricordava; ma era il suo un ricordo vago, come di una
creatura sparita da tanti anni, di un fantasma dileguato, l'ombra di un'ombra...
136
Maestra e scolaro
K. M. O'Donnell
(da "Il compito di latino" Nove racconti e una modesta proposta - Sellerio)
Io sono un mostro che vuole uccidere gli altri morsicandoli sul collo con i denti affilati e bere il loro
sangue, ma finora sono riuscito a tenere tutto questo per me e nessuno conosce il mio segreto. Mi
chiamo Edward Alan Arthur e ho dieci anni. L'anno scorso ne avevo nove e non uccidevo gli altri.
L'anno prossimo ne avrò undici e avrò già ucciso della gente. Non manca molto, e poi non potrò più
reprimere le mie tendenze e impedire che esplodano e che abbiano la meglio. In questo momento
sto parlando con la mia insegnante, la signorina Green. La signorina Green è l'insegnante di lettura
per tutti quelli della quarta e da molto tempo è insoddisfatta del mio profitto. Adesso mi ha
chiamato nel suo piccolo ufficio, dopo la scuola, in modo, come dice lei, da mettere le cose in
chiaro una volta per tutte e scoprire perché non voglio leggere.
- Non hai problemi di vista - dice la signorina Green. - Non ci sono carenze nel tuo quoziente di
intelligenza e inoltre, quando hai voglia di leggere, sai farlo piuttosto bene. Allora perché non ti dai
da fare con il tuo lavoro e perché insisti a disturbare la classe durante le lezioni di lettura?
La signorina Green è giovane, e sarebbe carina se non fosse per quella voce stridula. Proprio
adesso, nella mia mente, le sono saltato addosso e i miei denti lucenti e forti stanno affondando
nelle morbide pieghe bianche del suo collo. Nella mia mente il sangue sta scorrendo e io bevo,
bevo. Ma nella stanza io tengo le mani unite in grembo e lo sguardo abbassato timidamente, in
modo che lei non possa vedere cosa sta succedendo ai miei occhi.
- Perché sono tutte bugie - dico io - tutte bugie scritte da bugiardi. I libri non insegnano niente ai
bambini sul mondo, ma sono scritti dagli adulti e così i bambini non vedono il mondo qual è. Gli
adulti hanno fatto diventare il mondo orribile, e adesso scrivono i loro libri e ci raccontano le loro
bugie così che noi non si possa vederlo com'è e non lo si distrugga.
La signorina Green si agita sulla sedia e per un attimo le sue mani si muovono, irrequiete. Io penso
a quanto sarebbe bello alzarmi e lanciarmi su di lei. Prima la colpirei nella parte molle del cranio
dietro l'orecchio, giusto per tramortirla, poi, mentre cade, l'afferrerei tra le pieghe del collo con i
miei lucidi denti micidiali e comincerei a morsicare. Il sangue zampillerebbe fuori come una cascata
di petardi e lei morirebbe prima di poter capire cosa le è successo. Ma nella stanza io cerco di
scacciare tutti questi pensieri o almeno di portarli a un livello che mi permetta di continuare a tenere
lo sguardo basso. Le mie mani si torcono, le dita si intrecciano, ma io non sono il tipo di mostro che
strangola. Quando avevo otto anni, una notte fui visitato da strane Potenze che mi offrirono la
possibilità di scegliere che tipo di mostro volevo essere, e io decisi di essere un vampiro. Così,
anche se mi piacerebbe molto strangolare la signorina Green, le mie dita non ne hanno la forza. I
denti sono una cosa diversa. Sono molto affilati e con le estremità appuntite, grazie alle Potenze che
mi hanno insegnato come spazzolarll e trattarli (...).
- Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito - dice la signorina Green. - Onestamente,
Edward, non so dove tu abbia preso un'idea del genere. I libri sono la porta che conduce alla verità,
e la lettura è la luce della coscienza. Anche se talvolta gli uomini usano la parola scritta per dire
menzogne, questo non significa che debba essere sempre così.
- Certo che è sempre così - ribatto io, immaginando piccole, frementi gocce del suo sangue. - Una
volta che gli uomini scoprono come mentire, non dicono più la verità. Perché dovrebbero? Non
rende.
La signorina Green scorre i fogli che tiene in grembo e poi si appoggia allo schienale. - Devo essere
onesta con te, Edward - dice. - Pensavo che potessimo risolvere i tuoi problemi discutendone noi
due soli, per aiutarti ad accettare la lettura, ma mi sembra che questo non ci porti a nessun risultato.
Perciò sarò costretta a farti vedere da un medico.
- Un medico? Volete dire un medico dei pazzi, non è vero?
- Qualcuno che parlerà con te, Edward, e cercherà di scoprire perché la pensi così.
- Pensate che sono matto, vero?
Di colpo sono in piedi, chino su di lei, e grido. Anche se sono piuttosto piccolo per la mia età, la
137
signorina Green è molto esile e, in piedi, io la domino. - Solo perché io ho il Potere - dico - solo
perché io so che le letture sono tutte storie e perché ho denti forti e micidiali che possono penetrare
nel vostro collo e farvi morire...
Di colpo mi fermo. Fino a questo momento non ho mai rivelato a nessuno il mio segreto. Devo
essere davvero molto agitato per aver rivelato il mio segreto alla signorina Green. Lei cerca di
alzarsi, ma le gambe non la reggono, e come una farfalla che cerchi di arrampicarsi su un filo d'erba
ricade indietro.
- Stai lontano da me, Edward - dice. I suoi occhi sono molto rotondi. - Vattene lontano da me,
subito.
- No - ribatto io, avvicinandomi. - Vi ho già svelato il mio segreto e adesso è troppo tardi. Non
avreste dovuto farmelo dire, ma l'ho detto, e adesso dovete pagare. E tutta colpa vostra. Non avrei
fatto niente, se non mi aveste costretto a dirlo.
- Per favore, Edward - dice alzando una mano - ci sono cose che non capisci, tu non capisci come
vanno le cose, cosa sta succedendo...
- No - dico (...). Mi avvicino sempre di più e scopro i denti.
- Adesso - dico.
- Edward, Edward, non capisci, non è come credi tu, mi hai costretta tu a farlo, Edward.
E poi c'è un grido e uno scarto, il grido, evidentemente, deve essere mio, lo scarto è della signorina
Green che si sposta di lato sulla sedia, e la sua faccia sta cambiando, cambiando. Si protende verso
di me e mi addenta il collo, io sento gli affilati e micidiali strumenti della sua bocca e poi ogni cosa
fluisce lontano da me. Avvolto da una specie di nebbia cado sul pavimento, guardando ottusamente
in su. La signorina Green è sopra di me. La sua testa si abbassa.
E sempre più vicina.
- Non avresti dovuto dire che i libri sono pieni di bugie - dice. - Alle Potenze non farà piacere. (...)
138
Maestro Mago
Preussler Otfries
(Piemme)
(...) La mattina del primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie, i bambini della terza classe
non sapevano ancora niente di niente. Fuori faceva freddissimo, e tutti sedevano nei banchi coi visi
arrossati, aspettando il signor Klingsor. Ai piedi delle scale il bidello Rapp scampanellò l'inizio
della prima ora di lezione. La porta dell'aula si aprì e, con gran meraviglia dei bambini, entrò la
signorina Wolf. La signora Wolf era una maestra anzianotta e rotondetta, coi capelli grigi tirati e
divisi nel mezzo da una scriminatura diritta. Sul naso portava un paio di occhialetti a molla, e sul
mento, a sinistra, aveva un grosso porro.
<<Buon giorno, bambini>> disse la signorina Wolf scrutando la classe con uno sguardo penetrante.
<<Perché mi fissate così?>>
<<Scusi, il signor Klingsor è malato? >> chiese la Steffi von Austerlitz.
<< No >> rispose la signorina Wolf. << E' stato trasferito in una piccola scuola sui monti
Metalliferi. D'ora in avanti sarò io la vostra maestra >>.
I bambini si sentirono morire. Perché la signorina Wolf era nota in tutta la scuola Rodolfo per esser
molto severa e incapace di stare allo scherzo. Proprio a lei dovevano dare la terza classe? La
signorina Wolf troneggiava dietro la cattedra come una regina. Una regina che avesse dimenticato
di mettersi la corona in testa.
<<Tenetelo bene a mente, bambini! >> disse con un 'occhiata severa. << Durante le mie lezioni
bisogna star seduti belli dritti. E non mi va che si chiacchieri. E neppure... >>
Quel che stava per dire, i bambini della terza classe non lo seppero mai. Perché in quel preciso
momento qualcuno bussò alla porta.
<< Avanti! >> Dalla voce della signorina Wolf si capiva benissimo che non amava essere interrota
durante una lezione. Entrò il bidello Rapp. << E' arrivato per lei con la posta>>.
<< Per me? >> domandò sorpresa la signorina Wolf.
<< Ci dev'essere uno sbaglio >>. Ma non c'era nessuno sbaglio: il pacchetto era veramente per lei. E
quando la signorina Wolf l'aprì, vide che conteneva tante lettere, tutte scritte a mano: una per la
signorina Wolf, ma anche una per ciascun bambino della classe. La signorina Wolf le fece
distribuire, così ciascun bambino ebbe la sua lettera, indirizzata personalmente a lui dal signor
Klingsor: una lettera diversa da tutte le altre. E quella del Franz Molnàr era addirittura in lingua
magiara! Ogni bambino lesse quel che il signor Klingsor gli aveva scritto, e tutti ne furono molto
contenti.
Ma a quel punto la signorina Wolf battè con le chiavi sulla cattedra. <<E ora, bambini, è il
momento di far qualcosa >>. La signorina Wolf aprì il primo cassetto a sinistra e fece distribuire i
fogli per il compito in classe, due fogli per ciascun bambino. Questo con il signor Klingsor non era
mai successo! Bisognava fare un dettato proprio alla prima ora dopo le vacanze natalizie?
<< Ecco fatto >> disse la signorina Wolf quando tutti ebbero avuto il loro foglio. << E ora
attenzione! >> Andò alla lavagna, prese un gessetto e scrisse, con molti svolazzi, una grande C
maiuscola.
<< E poi? Quale sarà il seguito?>> I bambini non indovinarono. In quel momento non avevano
voglia di indovinelli. E cosa scrisse la signorina Wolf sulla lavagna, nella sua perfetta scrittura in
corsivo?
"Caro signor Klingsor," aveva appena scritto la virgola, che i bambini capirono tutto al volo.
Ognuno di loro poteva scrivere una lettera al signor Klingsor! << E dopo >> disse la signorina
Wolf, << Andremo insieme alle poste a imbucare le nostre lettere. Però sappiate fin d'ora che con
me si va in fila per due. E senza chiacchierare, prego >>.
Dite voi se non era un buon inizio!
E i bambini non tardarono a convincersi che anche con la signorina Wolf sarebbero potuti andar
d'accordo. (...)
139
E a me, cosa resta da dirvi?
Che avete visto giusto.
La signorina Wolf era in effetti una brava maestra, e di conseguenza anche lei s'intendeva un po' di
magia.
Non bene, si capisce, come il signor Klingsor, però se la cavava.
Perché ogni maestro che sia davvero un bravo maestro deve sapere un po' di magia. Ognuno a suo
modo. (X)
140
Mastrangelina
Corrado Alvaro
(Bompiani)
(...) - Com'è il professore Feronti? - chiese Diacono.
- Fin troppo buono. E' un debole. E' guastato dai libri. Non si sa far valere.
- Dici che mi prenderà? - chiese Diacono trepidante.
- Ma certo, prende tutti. E' diventato rifugio della provincia.
- E come ci si sta?
- Dà un letto per dormire. Costa dieci lire al mese. Per il resto puoi provvedere da te. Anche se non
le hai, le dieci lire, gliele dai quando puoi. Se avesse denaro, ti terrebbe anche gratis Ma non ne ha.
(...)
Sarebbe bello che mai niente invecchiasse. Il professore non sarebbe vecchio, avrebbe una giacca
sempre nuova.
E' piccolo e con i capelli bianchi; ma potrebbe mettersi una giacca nuova, il direttore del convitto
Feronti. Delle volte lo prendono per il cameriere. Io ci andrei volentieri a spasso, è come un padre:
sarei più contenta se soltanto fosse un po' più alto, povero professore.
E' istruito, ma non lo fa vedere, scherza sempre e non dice mai niente di serio. È simpatico, e poi è
buono, se fossi in lui non terrei questi ragazzi senza soldi.
Nessuno lo paga, e lui dice che fa del bene a tanti ragazzi che non hanno soldi per studiare.
Dice che lo pagheranno poi. Ma questi ragazzi non hanno niente di bello, sono vestiti non si sa
come, non portano neppure il cappello, e i bastoni potrebbero lasciarli al loro paese. Che bisogno c'è
di portare i bastoni? Fanno curiosi giochi, si sfidano, lottano, si picchiano. Non saprebbero
sciogliere un nastro senza sciuparlo, scommetto. Da noi, nel convitto non vengono mai quei giovani
delicati, vestiti bene, ben pettinati.
Ce ne sono a Turio, ma stanno nelle pensioni, e qualche volta sposano la figlia della padrona. Da
noi vengono solo i poveri... (...)
141
Matilde
di Roald Dahl
(Salani)
(...)
Matilde sedette, mentre la Spezzindue si sedeva a sua volta dietro la cattedra. Era sempre rimasta in
piedi, nel corso della lezione. Tese la mano, afferrò la caraffa e, tenendola per il manico, disse:
"Non capisco perché i bambini siano così repellenti. Sono un vero flagello, come gli insetti.
Bisognerebbe sbarazzarsene una volta per tutte, come si uccidono le mosche con l'insetticida o con
la carta moschicida; perché non inventare uno spray che ci liberi dai bambini piccoli? Sarebbe
splendido entrare in questa classe con una bombola gigantesca e spruzzare dappertutto. Delle
enormi strisce di carta appiccicaticcia sarebbero ancora meglio. Le appenderei ovunque, voi ci
rimarreste attaccati, e addio. Non le sembra una buona idea Dolcemiele?".
"Se si tratta di uno scherzo, direttrice, non lo trovo molto divertente."
"Non mi stupisce. Comunque, non scherzavo. Secondo me la scuola perfetta è quella dove i
bambini non ci sono. Un giorno aprirò un istituto del genere. Penso che avrebbe un grande
successo".
"Questa donna è pazza", pensava la signorina Dolcemiele. "Completamente pazza. E di lei che
dovremo sbarazzarci."
La Spezzindue alzò la grande brocca di porcellana azzurra e riempì d'acqua il bicchiere. E insieme
all'acqua venne fuori un lungo, viscido tritone che cadde nel recipiente con un "plop" sonoro. La
Spezzindue cacciò un urlo e fece un salto come se le fosse scoppiato un petardo sotto i piedi. I
bambini videro la lunga, sottile, viscida creatura giallastra, simile a una lucertola dal ventre giallo
che si contorceva nel bicchiere, e presero a saltare a dimenarsi, gridando: "Che cos'è? E' disgustoso!
E' un alligatore!".
"Attenta, signorina Spezzindue!" gridò Violetta. " Credo che morda".
La Spezzindue, così grande e grossa, rimase impalata nei suoi pantaloni alla zuava, tremando come
una foglia. Era furiosa perché qualcuno l'aveva strillare e saltar su a quel modo, proprio lei che si
vantava d'essere coraggiosa. Fissò l'animale che si contorceva nel bicchiere. Non aveva mai visto un
tritone in vita sua; la storia naturale non era il forte, e non riusciva neanche a immaginare che tipo di
bestia fosse, comunque non aveva un aspetto piacevole. Si mise lentamente a sedere; era davvero
terrificante con quegli occhietti che sprizzavano odio e rabbia. (...)
Matilde e Violetta videro la gigantessa dai pantaloni alla zuava marciare in direzione di una
bambina di circa dieci anni, con le lunghe trecce bionde sulle spalle. Ogni treccia terminava con un
fiocco di raso azzurro. La bambina con le trecce, Amanda Trippi, rimase immobile, lo sguardo fisso
sulla gigantessa che avanzava verso di lei; aveva l'espressione di chi, intrappolato in un praticello,
sta per essere caricato da un toro inferocito. La ragazzina era paralizzata, terrorizzata, tremante e
con gli occhi sbarrati: sembrava certa che per lei fosse arrivato il giorno del giudizio.
La Spezzindue aveva ormai raggiunto la sua vittima e torreggiava su di lei.
"Voglio che quando tornerai a scuola, domattina, quelle trecce siano sparite!" abbaiò. "Tagliale e
buttale nella spazzatura! Hai capito?"
Amanda, sebbene paralizzata dalla paura riuscì a balbettare: " P -p- piacciono tanto alla m- m- m- ia
mamma. M- m- me le rifà ogni mattina".
" La tua mamma è un idiota!" tuonò la Spezzindue. Indicò con un dito grosso quanto un salame la
testa della bambina e latrò: "Sembri un topo con la coda che gli spunta dalla testa!"."
"La m- m- mia m- m- mamma mi trova molto carina così signorina Spezzindue".
"Non me ne importa un fico secco di quel che pensa tua madre!" ruggì la Spezzindue, e con una
mossa brusca afferrò le trecce di Amanda con la destra, sollevandola da terra. Poi cominciò a farla
roteare sempre più in fretta, mentre la bambina strillava più non posso. La Spezzindue muggiva : "
Te le do io le trecce, piccola delinquente!"
Proprio come alle olimpiadi la fece girare sempre più in fretta, come un martello. "Scommetto che
la lancerà" disse Ortensia. La Spezzindue si chinò all'indietro per bilanciare il peso della ragazzina
142
roteante, e prese a piroettare con abilità sulla punta dei piedi; in breve Amanda Trippi venne fatta
girare così rapidamente che non la si vedeva più e a un tratto, con un urlo bestiale, la Spezzindue
mollò le trecce e la bambina fu proiettata oltre la rete metallica del cortile.
"Bel tiro, signora!" gridò qualcuno, dall'altra parte del cortile, e Matilde, ipnotizzata da questo
pazzesco spettacolo, vide Amanda Trippi atterrare con una lunga e sgraziata parabola sul campo da
gioco.
Atterrò sull'erba e prima di fermarsi rimbalzò tre volte. Poi, sorprendentemente si mise a sedere.
Aveva l'aria stordita (ed era comprensibile), ma dopo un paio di minuti si alzò e trotterellò verso il
cortile. La Spezzindue si stropicciò le mani. "Niente male" grugnì, "se si pensa che sono fuori
allenamento. Proprio niente male". Poi se ne andò a grandi passi. (...)
143
Moll Flanders
Daniel De Foe
(...) Nella cura che mi assegnarono fu mia gran fortuna esser data, come si dice, a balia a una donna
che allora era povera ma aveva vissuto in condizioni migliori, e ricavava da vivere pigliando con sé
quelli che erano in situazioni come la mia e mantenendoli fìnché raggiungevano l'età in cui
potevano verosimilmente andare a servizio o guadagnarsi il pane. Quella donna aveva anche una
piccola scuola, che teneva per insegnare ai bambini a leggere e a lavorare; e poiché, come già ho
detto, era vissuta in altri tempi in un buon ambiente, tirava su i bambini a lei affidati non solo con
ogni cura ma anche con molta arte.
Ma la cosa più importante era che la donna cresceva i bambini in modo molto religioso, perché lei
era per bene, pia, donna di casa, amante della pulizia, piena di buone maniere, e sapeva vivere.
Vitto scadente, alloggio miserabile e vestiti brutti: ma per il resto eravamo tirati su con maniere e
garbo, come se quella fosse una scuola di ballo. (...)
144
Niente di nuovo sul fronte occidentale
Erich Maria Remarque
(...) Kantorek era il nostro professore: un ometto severo, vestito di grigio, con un muso da topo.
Aveva press'a poco la stessa statura del sottuficiale Himmelstoss, "il terrore di Klosterberg". Del
resto è strano che l'infelicità del mondo derivi tanto spesso dalle persone piccole, di solito assai più
energiche e intrattabili delle grandi. Mi sono sempre guardato dal capitare in reparti che avessero
dei comandanti piccoli: generalmente sono dei pignoli maledetti.
Nelle ore di ginnastica Kantorek ci tenne tanti e tanti discorsi, finché finimmo per recarci sotto la
sua guida, tutta la classe indrappellata, al Comando di presidio, ad arruolarci come volontari. Lo
vedo ancora davanti a me, quando ci fulminava attraverso i suoi occhiali e ci domandava con voce
commossa: "Venite anche voi, nevvero, camerati?"
Codesti educatori tengono spesso il loro sentimento nel taschino del panciotto, pronti a distribuirne
un po' ora per ora. Ma allora noi non ci si dava pensiero di certe cose. Ce n'era uno, però, che
esitava, non se la sentiva. Si chiamava Giuseppe Behm, un ragazzotto grasso e tranquillo. Si lasciò
finalmente persuadere anche lui, perché altrimenti si sarebbe reso impossibile. (...) Per uno strano
caso, fu proprio Behm uno dei primi a cadere. Durante un assalto fu colpito agli occhi, e lo
lasciammo per morto. Portarlo con noi non si poteva, perché dovemmo ritirarci di premura. Solo nel
pomeriggio lo udimmo a un tratto gridare, e lo vedemmo fuori, che si trascinava carponi; aveva
soltanto perduto coscienza. Perché non ci vedeva, ed era pazzo dal dolore, non cercava affatto di
coprirsi, sicché venne abbattuto a fucilate, prima che alcuno di noi potesse avvicinarsi a prenderlo.
Naturalmente non si può far carico di questo a Kantorek: che sarebbe del mondo, se già questo si
dovesse chiamare una colpa? Di Kantorek ve n'erano migliaia, convinti tutti di far meglio nel modo
ad essi più comodo.
Ma qui appunto sta il loro fallimento.
(...)Mittelstaedt ha pronta una novità che mi elettrizza subito. Mi racconta che Kantorek è stato
richiamato come soldato della territoriale (...). Scendiamo nel cortile. Mittelstaedt ordina il riposo e
passa l'ispezione. Ed ecco che mi appare il mio Kantorek, e mi mordo le labbra per non scoppiare a
ridere. Porta una specie di tunica color turchino slavato. Il dorso e le maniche mostrano enormi
rattoppi scuri; quella tunica deve aver servito a un gigante. In compenso i pantaloni neri, stinti
dall'uso, sono piuttosto corti, non gli arrivano che a mezzo polpaccio. Spaziosissimi sono invece gli
scarponi, assai antichi, duri come il ferro, con le punte voltate in su: di quegli scarponi vecchi
modello che si allacciano ancora sui lati. L'equilibrio è ristabilito dal berretto d'ordinanza,
minuscolo, unto e bisunto, miserabile. L'impressione d'insieme è pietosa.
Mittelstaedt si ferma davanti a lui: "Soldato Kantorek, questo si chiama pulire i bottoni? Non
imparerete dunque mai? Non andiamo bene, Kantorek, non andiamo bene!...".
Nel mio interno urlo di piacere. Esattamente così Kantorek biasimava Mittelstaedt, con la stessa
intionazione; "Non andiamo bene, Mittelstaedt, non andiamo bene!".
Mittelstaedt continua a disapprovare: "Guardate un po' Boettcher, quello sì è un modello, potete
imparare da lui".
Non oso credere ai miei occhi: c'è anche Boettcher, il nostro bidello! Ed è un modello! Kantorek mi
fulmina con lo sguardo, come se volesse incenerirmi. Ma io mi limito a sorridergli innocentemente
sul muso, come se non lo riconoscessi affatto.
Che faccia di stupido con quel pignattino in testa e quell'uniforme! E dire che davanti a un essere
simile si tremava di paura, quando troneggiava in cattedra e sembrava volerci infilzare con la punta
della matita, nel chiederci i verbi irregolari francesi, che poi in Francia non ci hanno reso un gran
servizio. Non sono passati due anni... ed ecco qua, rotto l'incanto, il milite territoriale Kantorek, con
le ginocchia storte e due braccia ad ansa, coi bottoni sporchi e un portamento ridicolo, un soldato
impossibile. Non riesco a metter d'accordo questo figuro col personaggio in cattedra, dallo sguardo
severo, e vorrei un po' sapere che cosa risponderei, se questo disgraziato tornasse un giorno a
interrogare me, un vecchio soldato..." (...)
145
Pel di Carota
Jules Renard
(Mondadori)
(...) Da Pel di Carota al signor Lepic:
Caro papà, pensa che ieri era l'onomastico del professore di latino e che i miei compagni unanimi
mi avevano designato per presentargli gli auguri di tutta la classe.
Lusingatissimo, mi metto a comporre con ogni cura il discorso nel quale inserisco alcune
appropriate citazioni latine. Modestia a parte, ero soddisfatto. Lo metto a pulito su un gran foglio di
carta protocollo e, giunto il giorno, spinto dai compagni che mi sussurravano: "Vai, su, fatti avanti"!
colgo il momento che il professore non ci guarda e mi avvicino alla cattedra. Ho appena spiegato il
foglio e pronunciato a voce alta: "VENERATO MAESTRO" che il professore s'alza infuriato e
grida:
- Fila al tuo posto, e spicciati!
Figurati se alzo i tacchi e scappo a sedermi; frattanto i miei amici si nascondono dietro i libri e il
professore mi ordina furibondo: -Traduci la versione!
Caro il mio papà, cosa te ne pare?
Risposta del signor Lepic: Caro Pel di Carota, quando sarai deputato ne vedrai ben altre. A ognuno
la sua parte. Se hanno messo il tuo professore in cattedra, probabilmente è perché‚ lui pronunci dei
discorsi, non perché stia ad ascoltare i tuoi.
Da Pel di Carota al signor Lepic:
Caro papà, son stato a portare la tua lepre al signor Legris, professore di storia e geografia. M'è
sembrato proprio che il regalo gli facesse piacere. Ti ringrazia molto. Siccome ero entrato con
l'ombrello bagnato, me lo prese di mano lui stesso e lo riportò nell'atrio. Poi chiacchierammo di
varie cose.
Mi disse che se voglio posso portar via il primo premio di storia e geografia a fin d'anno. Ma vuoi
credere che son stato in piedi tutto il tempo e che il signor Legris, il quale nel resto, ripeto, è stato
amabilissimo, non mi ha nemmeno indicato una sedia?
Si tratta di scortesia o di distrazione? Non lo so, e sarei curioso, caro papà, di sentire la tua
opinione.
Risposta del signor Lepic:
Caro Pel di Carota, protesti sempre. Protesti perché‚ il professor di latino ti manda a sedere, protesti
perché quello di storia e geografia ti lascia in piedi.
Forse sei ancora troppo giovane per pretendere dei riguardi: sarà che, ingannato dalla tua modesta
statura, ti credeva seduto. (...)
146
Occhio al professore
Christine Nostlinger
(Giunti Gruppo editoriale)
(...) Ora la finisco con questa introduzione e incomincio da dove diventa importante. A casa
abbiamo una situazione non comune. Perciò la mamma ha affittato una stanza al dottor Vranek. Il
dottor Vranek abita da noi fin da quando ho il ben dell'intelletto. Prima era professore di matematica
al liceo.
Sebbene il Vranek sia molto matematico, con l'insegnamento non gli è andata bene. E la cosa non
mi stupisce! Perché è piccolo, calvo e per niente divertente. E poi sa parlare solo a bassa voce, e
nello stesso tempo mentre parla fa dei sibili (Hansi Krenn dice che questo dipende dalla dentiera,
che ce l'ha anche suo nonno. Mia mamma dice che non dipende dalla dentiera, perché il Vranek
faceva questi sibili anche quando aveva i denti veri).
In ogni caso, a scuola i ragazzi lo prendevano continuamente in giro, e lui con la sua vocina
sibilante non poteva nemmeno farsi sentire. Una volta i ragazzi lo hanno fatto particolarmente
arrabbiare - qualcosa che aveva a che vedere con una sveglia che suonava, che si passavano da una
fila all'altra dei banchi, il Vranek allora si è messo a saltellargli dietro, ma la sveglia non gliel'hanno
data, e subito accanto c'era la presidenza, sicché il Vranek aveva paura non solo degli studenti, ma
anche del direttore, perché la soneria la sentiva sicuramente anche lui. Ma così bene non la so
neanch'io. Alla mamma non piace raccontarmi certe cose. Ha paura che poi io le rifaccia a scuola.
Insomma il Vranek si è beccato un esaurimento nervoso. Prima lo hanno portato all'ospedale e poi a
casa da noi.
E' rimasto sei mesi a letto a lamentarsi, poi è guarito, ma qualcosa gli è rimasto: ogni volta che vede
un bambino comincia a tremare come un martello pneumatico. Gocce e polverine non sono valse a
niente. E' dovuto andare in pensione prima del previsto perché a scuola per il tremito convulso non
riusciva a tenere il gesso in mano. E a casa io mi sono sempre dovuta nascondere dal Vranek, per
non fargli venire un attacco. Non che me ne importasse niente, sono una bambina che comunque a
casa ci sta poco.
La mamma, che ha una grande simpatia per il Vranek, ha provato spesso a farlo smettere di tremare,
ma il Vranek allora le diceva: "Signora Binder, verrà il giorno in cui non dovrò più tremare! Ma
finché i bambini sono così bisogna tremare per forza"!
Il finché e il così li rimarcava per di più in modo particolare. Abbastanza strano. E già allora mi
sono detta: - Occhi aperti e all'erta!
(...) Poi il mio sospetto si è ingigantito! Infatti il Vranek ha preso in prestito da mio papà la
macchina da scrivere. Ha detto che doveva scrivere una lettera al Ministero della Pubblica
Istruzione, perché aveva appena terminato un'invenzione, e che questa era un'invenzione che
avrebbe cambiato la vita di tutti noi! La mamma gli ha fatto le congratulazioni e gli ha chiesto se
aveva inventato una calcolatrice per ragazzi oppure una lavagna di tipo speciale.
Il Vranek ha detto: - No, no, cara signora Binder, è molto, ma molto più sensazionale! - Però, quel
che fosse, non l'ha detto, ma ha soltanto mormorato ancora: - E poi vedrà che anche lei, carissima
signora Binder, non avrà più preoccupazioni!
Questo mi ha confermato nell'opinione che volesse macchinare qualcosa contro i bambini. Perché
infatti mia mamma si lagna sempre che io sono la sua unica preoccupazione.
Ne so finalmente di più!
Era il 10 Ottobre. Il Vranek è andato a pranzare al ristorante della posta. La mamma puliva le
finestre nel soggiorno. Io avrei dovuto scrivere un tema. Si intitolava "Un fatto divertente". Siccome
non mi veniva in mente nessun fatto divertente che alla mia professoressa potesse sembrare
altrettanto divertente, sono andata a vedere nella stanza del Vranek. A parte i parecchi mucchi di
carta pieni di calcoli, questa volta ho scoperto un foglio di carta nella macchina da scrivere.
Sopra c'era scritto:
Friedemann Vranek
Dottore in matematica
147
Habergasse 14 (presso Binder)
1170 Vienna
E sotto c'era scritto:
AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Al signor Ministro della Pubblica Istruzione, personale e segreto!
Di più sul foglio non c'era. Però vicino alla macchina da scrivere erano appoggiati diversi fogli
scritti a mano. Su quello in cima, alla prima riga, cera scritto in lettere a stampatello:
PROGRAMMATORE AUTOMATICO
DELLO SCOLARO
ESATTA DESCRIZIONE PER IL PROFANO
Ci ho messo un quarto d'ora per capire il primo paragrafo. Non soltanto per via della scrittura-datappeto-persiano, ma anche per il contenuto.
Il contenuto diceva:
Il Programmatore Automatico dello Scolaro da me inventato (da qui in avanti menzionato solo
brevemente PAS), è un apparato completamente nuovo, mai esistito prima d'ora, che può
trasformarsi in un sussidio didattico ideale per tutti gli insegnanti.
Il PAS è in grado di trasformare completamente i tempi futuri. Tramite esso, la nostra gioventù
abbruttita, disumana, sprovvista di tutti i valori, può venire programmata nel modo desiderato anche
da insegnanti poco abili e non molto benvoluti.
Proprio in tempi di grande carenza d'insegnanti, il PAS mi pare un'istituzione incredibilmente
necessaria!
Sono rimasta di sasso. Ho riletto più volte il primo paragrafo da cima a fondo, e non mi sono
accorta di come il tempo passasse. La finestra era aperta per un largo spiraglio. All'improvviso
sento dallo spiraglio che mia mamma, che sta pulendo la finestra, grida giù in strada: - Allora, già di
ritorno dal pranzo, caro dottore?
Il Vranek sale le scale lentamente, ma purtroppo abitiamo soltanto al primo piano. Io mi sono
infilata sotto il golf i fogli scritti a mano, poi ho spalancato la finestra e sono uscita dalla stanza.
Avevo appena chiuso la porta del Vranek, che il Vranek ha aperto la porta di casa. Mi sono messa al
riparo dietro l'attaccapanni. Il Vranek ha attraversato l'atrio d'ingresso fino alla porta della sua
stanza e l'ha aperta. Avevo calcolato giusto! Per la corrente d'aria della finestra aperta del Vranek,
della porta aperta del Vranek e della finestra aperta del soggiorno, tutte le carte nella stanza del
Vranek hanno cominciato a svolazzare alla grande.
Era una tormenta di carte. Il Vranek ha cacciato uno strillo acuto, ha oltrepassato le carte fino alla
finestra e ha chiuso la finestra. Lo strillo acuto ha attirato la mamma. Anche la mamma è rimasta
molto impressionata dalla devastazione dei mucchi di carta, e voleva aiutare il dottor Vranek a
raccogliere e rimettere in ordine. Il Vranek non si è lasciato aiutare. Ha spiegato che questa non era
mancanza di fiducia verso la mamma, ma che la faccenda era ancora molto segreta, e lui non poteva
far avvicinare nessuno alla sua invenzione. Perché, diceva, l'invenzione più geniale nelle mani
sbagliate poteva trasformarsi in una cosa diabolica. (...)
148
Penny Wirton e sua madre
Silvio D'Arzo
(Einaudi)
(...) L'uscio si spalancò all'improvviso, e sbattè contro il muro, e due o tre vetri si infransero a terra.
E ne uscì un uomo tutto quanto vestito di nero, su per giù come un giovane prete, con in più due
fibbiole di latta alle scarpe e in mano una canna lunga il doppio di una lenza da trote.
Era magro come tre uomini magri, ed arrabbiato per sei: e quel che non era rabbia, era sdegno e
matto dispetto e desiderio d'usare la canna.
Con l'altra mano si trascinava dietro un ragazzo tutto vestito di giallo: e quando fu nel corridoio lo
lasciò andare di colpo come si lascia andare un canestro dal manico sporco di fango.
I tre ragazzi s'addossarono al muro con tutte le forze: sicché, a prima vista, parevano tre disegni e
nient'altro.
- E adesso apri bene le orecchie, - si mise a dire al ragazzo il Supplente che ormai non aveva più
voce.
- Adesso ascoltami bene. Io mi chiamo Isaia Balcop, sono Baccelliere d'arte e maestro di scuola: ho
ventisette anni e a momenti ventotto: e da dieci non faccio che andare da una scuola all'altra, come
un pitocco alle fiere. E ho conosciuti tutti i tipi di scolari del mondo: timidi, idioti, nervosi,
insopportabili, maniaci, smemorati, distratti, impudenti, malarnesi di strada, topi di banco e anche
peggio. Ho conosciuto, dico, ragazzi dalla lingua proibita, da dar dei punti anche a Gionata Swift...
Ma uno come te mai, in dieci anni. Sei l'impudenza incarnata. Questa, per prima cosa, ragazzo. E ce
n'è poi una seconda.....
Il Supplente s'interruppe per inghiottire saliva: e il ragazzo lo guardava tremando, e cercava di
balbettare qualcosa.
- E ce n'è poi una seconda. Se fai un giro per le quarantotto Contee, mare o monte è lo stesso, fa
questa domanda a tutti i ragazzi dai sette ai quattordici anni (quindici anni, in certi casi, perfino):
"Quante cose esigeva da voi il Supplente Balcop, Baccelliere darte e maestro di scuola?" E loro
subito: "Tre". "E quali?", dirai. "Prima cosa: rispetto. Seconda cosa: rispetto. Terza cosa: ancora e
sempre rispetto". E se tu un'altra volta t'azzarderai solo a pensare di... - E fece l'atto di alzare la
canna.
In quel momento s'aprì di colpo il cancelletto di legno e sulla ghiaia del viale si sentì un ben strano
rumore.
Una donna, sui cinquant'anni e un po' di più, tutta vestita di nero, attraversava in gran fretta il
giardino: e saliva i quattro gradini: e in un secondo e nemmeno era lì.
Il Supplente si volse accigliato.
- Mi dispiace per voi, la mia donna, ma questa qui non è ora da visite. Se non sbaglio, il cartello lo
dice ben chiaro e in chiarissimi caratteri inglesi.
- Non sbagliate, signore, - rispose ancora ansimando la donna.- E dispiace molto anche a me. Ma c'è
un fatto...
E gli disse qualcosa all'orecchio. Il Supplente guardò prima lei e poi il ragazzo, come chi non riesce
ancora a comprendere bene. E la donna gli si avvicinò nuovamente e gli parlò ancora ed a lungo
all'orecchio. E questa volta il Supplente dovette capire ogni cosa, perché alla fine si rivolse
sorridendo al ragazzo.
- Bene, Penny. Benissimo, - gli disse.
- Ecco una buona lezione per me: una lezione in piena regola, certo. Di questo puoi stare tranquillo.
Ma chi poteva saperlo, mi dici? Io sono un uccello forestiero, quaggiù: non conosco niente e
nessuno; e anche il Cieco potrebbe darmi dei punti... Così adesso, Penny, mi fai il favore di rientrare
al tuo posto. E se, prima, mi vorrai dare la mano, credo che la cosa sarà anche due volte migliore.
Il ragazzo vestito di giallo gli diede sorridendo la mano e mormorò qualcosa e rientrò.
Strisciando lungo il muro ed in punta di piedi, anche gli altri tre s'infilarono in classe.
- Perché c'è sotto tutta una storia, vedete, - disse un po' imbarazzata la madre al Supplente. - E se un
giorno non dovessi annoiarvi...
149
- E perché non adesso? - disse invece il Supplente. - Credete che a scuola se ne racconti qualcuna
migliore?
E, siccome in quel momento s'accorse d'aver ancora in mano la canna, per prima cosa arrossì e poi
fece l'atto di cacciare con quella le mosche. (...)
150
Per riflesso
Grazia Deledda
(...)Verso il meriggio, però, venne dai Verre poveri il maestro di scuola, il signor Giacinto Tedde,
un bel giovine di vent'anni, alto ed elegante, tutto roseo in volto.
Vedendolo salire i gradini della roccia, il piccolo studente arrossì e si sentì battere il cuore, anche
perché provava un vivo sentimento di ammirazione e di rispetto, tanto per il talento quanto per
l'eleganza del giovine maestro.
- Ebbene, buon giorno, che notizie da ieri ad oggi? - chiese il maestro.
- Favorisca, venga su - disse Andrea, tutto vergognoso per la miseria della sua casetta. Ma il giovine
volle stare in cucina, e non si guardò attorno: del che Andrea gli fu grato.
- Nessuna notizia - disse Andreana, sedendosi su uno sgabello, e curvandosi, con le mani giunte in
grembo. - Andrea però mi disse di aver veduto... "quell'uomo". L'ha veduto, lei? Non è vero,
Andrea?
- Sì - rispose con un soffio il fanciullo.
- Bene! - esclamò il maestro; poi sorrise come fra sé, e diede la gran notizia: - Sì, quell'uomo è stato
da me, e mi disse che acconsente...
- Ah!
- Ah! - fecero madre e figlio.
- Sì, acconsente. Ma ascoltatemi bene. - I due poveretti ascoltavano con l'anima sospesa.
- Pare ci sia stato consiglio di famiglia. La serva, mi pare si chiami zia Coanna...
- Sì, così.
- Ebbene, zia Coanna pare abbia fatto del chiasso. Egli era ben disposto fin dall'altro giorno, ma la
serva, appena usciti voi, cominciò a gridare, a dire che era il primo passo, e che Andrea finirebbe
col diventare padrone di tutto. "Il padrone sono io, - disse Larentu, - e appunto perché sono il
padrone voglio fare questa buona opera". E l'altra a gridare, a opporsi. E avrebbe finito col
dissuaderlo, senza l'intervento della moglie.
- Millèna! - disse Andreana.
- Giusto, Millèna o Maddalena, non so; deve essere una giovine molto buona e divota...
- Ah, sì, molto divota...
- Ebbene è intervenuta lei, come dicevo. Essa desidera grandemente un figliuolo, mi disse Larentu
Verre, ed è convinta che Dio non glielo abbia concesso perché... Insomma disse al marito: fa
studiare il figlio di Andreana Verre. Forse il Signore, dopo quest'opera buona ci concederà un
bambino. Così Larentu Verre si è deciso, ed è venuto per darmi la risposta, pregandomi di
comunicarvela. Però fa un patto. Senti bene, Andrea, e pensa bene se ti conviene. Egli vuole che tu
diventi medico.
Un'ombra passò sul viso intento del ragazzo. La madre lo guardò ansiosa: anche il maestro lo
guardò intensamente.
Qual pensiero occulto ferveva in fondo alla piccola mente? Quali progetti fantastici passavano già
nella piccola anima?
- Farò quello che egli vorrà - disse Andrea, senza sollevare gli occhi. (...)
151
Piccole donne
Louisa May Alcott
(...) E' necessario ora chiarire che il Professor Davis aveva impartito severissime disposizioni
perché i lecca lecca dichiarati generi di contrabbando fossero banditi dalle aule scolastiche, e aveva
anzi avvertito che le colpevoli di infrazione a quel bando sarebbero state, se scoperte, castigate
pubblicamente e condannate a ricevere una bella razione di bacchettate. Mediante una campagna di
guerra lunga e paziente era riuscito a far sparire i gommoni, aveva sequestrato in massa giornaletti e
figurine; aveva abolito un ufficio postale clandestino; aveva proibito sberleffi, soprannomi, smorfie,
caricature; aveva fatto tutto il possibile per tenere a freno cinquanta ragazze turbolente. I ragazzi, in
scuola, sono un'ira di Dio, ma le ragazze sono ancora peggio, sono una vera calamità per il povero
diavolo che abbia dei nervi sensibili e una carta tendenza, repressa, alla tirannia.
Il professor Davis era un cannone in fatto di latino, greco e filosofia, ed era quindi assai considerato
come insegnante; però era assai meno esperto in fatto di rispetto delle belle maniere, di delicatezza
di sentimento, di pazienza. Jenny Snow aveva capito, ad esempio, che quello era proprio il
momento adatto per vendicarsi dell'aborrita Ami March, perché quel mattino il signor Davis aveva
bevuto un caffè troppo ristretto; il vento che soffiava gagliardo da levante favoriva il manifestarsi di
una intermittente nevralgia dentaria; le sue scolare non gli avevano fatto fare di fronte all'ispettore
quella bella figura che i suoi sforzi d'insegnante avrebbero meritato, e perciò, per usare il linguaggio
pittoresco, se non molto accademico e rispettoso, delle sue allieve, era accigliato come un vecchio
gufo che non avesse digerito la colazione.
La parola lecca lecca fu come una miccia accesa gettata in un barile di polvere da sparo; la sua
faccia, di solito di una tinta così verde che lo faceva rassomigliare a un ramarro, diventò
subitamente scarlatta come la cresta di un gallo, e il suo pugno calò pesantemente sulla cattedra, con
un tonfo tale che Jenny Snow se la batté in ritirata e ritornò al suo banco rapida come un fulmine. Signorine, facciamo attenzione per un momento, prego!
A quell'ordine secco e deciso il cicaleccio cessò di colpo e gli occhi delle allieve, occhi castani,
azzurri, verdastri, grigi, si fissarono attenti sulla faccia dura e accigliata dell'insegnante.
- Signorina March, alla cattedra.
Amy si mosse prontamente, composta in apparenza, ma nell'intimo oppressa da una tremenda paura
per via della merce di contrabbando introdotta in classe che le pesava sulla coscienza. Ma non
aveva ancora superato la fila dei banchi che la voce dell'insegnante la fermò con un ordine inatteso:
- Mi porti i lecca lecca che ha sotto il banco.
Una compagna, cui non mancava certo la presenza di spirito, si sporse verso di lei. - Ehi, non glieli
porterai mica tutti, eh?
Lesta, Amy ne lasciò cadere una mezza dozzina dal cartoccio e andò a collocare il resto sulla
cattedra. Aveva l'impressione che qualunque essere umano, professor Davis compreso, avrebbe
dovuto senz'altro placarsi alla vista di tanto bendidio. Ma sfortunatamente l'insegnante detestava
quell'aroma dolciastro e alla sua collera si aggiunse il disgusto. - Sono tutti?
- Bè... proprio tutti no - rispose Amy che non sapeva dir bugie.
- Allora vada a prendere gli altri e li porti qui. Subito!
Con un'occhiata di impotente disperazione alle compagne, la ragazzina obbedì.
- Sicura di non averne altri? - inquisì l'insegnante. - Non è una bugia?
- Non dico mai bugie, professore.
- Va bene. Adesso prenda questi rivoltanti dolciumi a due a due e li butti dalla finestra.
Svanita ormai ogni speranza, cinquanta sospironi si levarono dalla scolaresca.
Rossa per la vergogna e la rabbia per ben dodici volte Amy percorse la via del supplizio dalla
cattedra alla finestra e ogni volta una coppia di splendidi lecca-lecca cadeva dalle sue mani nella
strada, salutato dal grido di esultanza dei monelli irlandesi, quei ragazzetti sguaiati e molesti con cui
le ragazze erano sempre sotto a litigare per via dei loro dispetti. Il che, naturalmente inaspriva il
tormento. Era davvero troppo! Le allieve fissavano il professore con occhi quali indignati, quali
supplichevoli, e una più sensibile delle altre al fascino dei lecca-lecca si mise addirittura a piangere.
152
Quando Amy, compiuto l'ultimo sacrificio, ritornò alla cattedra e rimase lì impalata a testa bassa,
l'insegnante ebbe una sorta di grugnito gravido di minacce e disse scandendo bene le parole: Immagino ricorderanno ciò che dissi una settimana fa. Sono spiacente di quanto è accaduto ma non
posso permettere che i miei ordini vengano presi sottogamba e procederò senz'altro a dare una
punizione esemplare a chi ha contravvenuto alle mie tassative disposizioni. Amy March, tenda la
mano.
La ragazzina fremette e istintivamente si portò le mani dietro la schiena rivolgendo all'insegnante
uno sguardo supplichevole, più commovente di qualsiasi parola. Era una delle predilette del
Vecchiaccio - come lo chiamavano le ragazze - che probabilmente, davanti a tanta contrizione,
avrebbe lasciato cadere la cosa, se proprio in quella una delle ragazze, non potendo più contenere
l'indignazione, non fosse uscita in un lieve fischio di protesta.
Per quanto appena percettibile, quel sibilo sommesso rinfocolò l'irritazione dell'insegnante e la sorte
della povera Amy fu irrevocabilmente segnata
- Tenda la mano, signorina March.
Troppo fiera per ricorrere alle lacrime e alle preghiere, la ragazzina strinse i denti, rialzò la fronte in
atto di sfida e protesse la destra a palmo in su, ricevendo senza batter ciglio una buona serie di
bacchettate. (...)
153
Pimpì Oselì
Elena Gianini Belotti
(Universale Economica Feltrinelli)
(.....) Gli scolari sono sessanta, come nelle altre classi. Il primo giorno di scuola, la maestra ha
assegnato i posti nei banchi, in ordine crescente di altezza: nella fila di sinistra le femmine, in quella
di destra i maschi: quelli avanzati, nella fila centrale, dove sta Cecilia, accanto alla Clotilde, la figlia
del segretario comunale. Le basterebbe allungare un braccio per toccare quello di Gianni, seduto di
fianco a lei, nella fila dei maschi. In un angolo sul fondo, contro il muro, c'è il banco degli asini,
nell'ultima fila i ripetenti.
La signorina maestra passeggia su e giù per la classe e lascia dietro di sé una scia profumata di
gelsomino. E' bella, la maestra, agile, snella, si muove di slancio, i polpacci frementi, come se fosse
sempre sul punto di spiccare una corsa, ha gesti impetuosi e scoppi allegri di voce, occhi brillanti
del colore delle castagne e capelli folti e ricci che scrolla come una puledra insofferente. Di tanto in
tanto bagna la punta dell'indice con la saliva e ridisegna le sopracciglia depilate e i tirabaci alle
orecchie, guarda assorta dalla finestra i rami nudi degli ippocastani e canticchia a mezza voce: "O
zingaro nero, ti sogno per me, tu fammi provare tu, l'amor cos'è."
Per giorni e giorni spiega come ci si comporta a scuola: si entra senza far chiasso e con la bocca
chiusa, si ripone la cartella sotto il ripiano del banco, ci si siede composti, le mani in prima ben
distese una accanto all'altra e si resta fermi e zitti. Lei sta ritta sulla cattedra, la mano sinistra lascia
dietro di sé una scia profumata di gelsomino. E sullo stomaco, la destra mezz'aria sulla fronte.
"Si deve sentir volare una mosca", dice in attesa di dare inizio, con il segno della croce, alla
preghiera del mattino. (....)
All'appello si risponde "presente" scattando in piedi e alzando il braccio destro. Tutti confondono la
destra con la sinistra, lei si ostina invano ogni giorno a farli esercitare perché arrivino a distinguere
un braccio dall'altro. Insegna anche la buona creanza: quando la maestra entra in classe, ci si alza in
piedi tutti insieme, si aspetta che ordini: seduti! e si risponde: grazie. Lo stesso si deve fare, per
rispetto, quando entra una persona adulta. Ci si toglie il berretto quando si parla con qualcuno e non
si tengono le mani in tasca. Non si risponde sì o no alla maestra, e neppure alle persone di riguardo,
ma sissignore o nossignore.
(...)
La signorina Margherita non ammette che gli scolari parlino bergamasco e insiste nel correggerli
quando storpiano l'italiano traducendolo dal dialetto. Non si dice il mio di me, il tuo di te, il suo di
lui, spiega, si dice il mio, il tuo, il suo... (...)
Copiare dal compagno di banco è proibito, anche nel caso fosse d'accordo: ma d'accordo non è mai.
I più bravi si difendono proteggendo con la mano a paravento la pagina del quaderno e allungando
al vicino calci negli stinchi.
Se si suggerisce e la maestra se ne accorge, si viene spediti in castigo dietro la lavagna. I craponi
che vengono a scuola solo per scaldare il banco, fanno scena muta all'interrogazione, si ostinano a
parlare dialetto,
prendono insufficiente nei compiti o si addormentano mentre la maestra spiega, vengono esiliati nel
banco degli asini.
Ogni tanto qualche mamma viene a parlare con la sciura maestra e le raccomanda di suonargliele di
santa ragione al figlio se non fa il bravo e non sa la lezione Quando si arrabbia con chi fa chiasso, fa
il burattino, parla col compagno di banco, allunga slèpe che spellano la faccia, le levate dalle mani,
voi, le sberle, grida.
Più spesso usa appendere sulle spalle del colpevole un cartello con scritto: "asino" e lo manda in
giro per la classe: i compagni sono autorizzati a ridere finché la maestra non dice basta. Capita che
uno scolaro di seconda, di terza e persino di quarta venga spedito in prima dalla sua insegnante
perché non ha studiato o ha fatto il matto: i bambini sono invitati a dileggiarlo e lo fanno
disciplinatamente, con una specie di doverosa compunzione, perché andare indietro come i gamberi
154
costituisce il massimo del disonore. Il reo entra accompagnato dal bidello, si sforza di affrontare
l'umiliazione ostentando indifferenza o spavalderia, sibila insulti ai vicini, i quali subito alzano la
mano e lo denunciano alla maestra. Nell'aula si respira un'aria torbida di voglia di linciaggio. C'è
paura quando non si sa una cosa che un altro bambino invece sa.
Quando il Batistì non ha saputo dire le vocali tutte in fila, la maestra le ha chieste alla Celestina che
aveva alzato la mano e le ha snocciolate con prontezza. "Brava"! ha esclamato, vai a bagnare il naso
al Batistì.
Cecilia, sgomenta, ha scorto un'abbietta luce di trionfo negli occhi della Celestina mentre s'infilava
l'indice in bocca, si dirigeva verso il compagno e gli inumidiva il naso. La scolaresca ha riso
sguaiata, finché la signorina ha picchiato il pugno sulla cattedra per farli smettere. Il Batistì aveva il
viso in fiamme, le orecchie infuocate e gli occhi pieni di lacrime. Si è asciugato furtivamente il
naso, ha chinato la faccia sul banco e non si è mosso più per tutta la mattina.
Ci han bagnato il naso, ci han bagnato il naso! Lo hanno deriso i compagni all'uscita, girandogli
intorno come avvoltoi sulla preda. (.....)
La maestra ha detto che ai bambini che non studiano e non fanno i compiti cresceranno le orecchie
d'asino, come a Pinocchio. Molti se le sono palpate, spaventati.
E come a Pinocchio, si allungherà il naso a quelli che dicono le bugie. Alcuni se lo sono toccato:
vuol dire, ha osservato, che non avevano la coscienza proprio pulita. Ai bambini bugiardi, prima
che il naso si allunghi, appare sulla fronte una macchiolina scura che solo le maestre possono
vedere. Le bugie hanno le gambe corte, ammonisce severa, la verità viene sempre a galla, perché il
diavolo fa le pentole ma non i coperchi. E chi è bugiardo è anche ladro. E infine: chi si scusa si
accusa e chi è in difetto è in sospetto.
I bambini, conclude, devono sforzarsi di essere buoni. Essere buoni significa fare il bene senza
speranza di ricompensa. (.....)
E' arrivato l'inchiostro. Il bidello è entrato in classe con un bottiglione, la Margherita ha illustrato
con solennità l'importanza dell'avvenimento,
ormai sapevano scrivere ed era giunto il momento di imparare a usare la penna. Il passaggio
iniziatico dall'universo della matita a quello superiore della penna, rappresentò per lungo tempo una
tortura per l'intera scolaresca. Intingere il pennino nel calamaio, liberarlo dall'eccesso di inchiostro
sfregandolo delicatamente contro il bordo, condurlo fino alla pagina del quaderno era un'arte
acrobatica dagli esiti incerti.
Nel breve, angosciante percorso dal calamaio al foglio bianco, stavano in agguato incognite
imponderabili. La perigliosa uscita del pennino col suo carico liquido dall'area protetta del calamaio
si materializzava in una goccia che piombava a tradimento stampandosi rotonda e densa sulla
pagina. Era la disfatta.
Sudati, congestionati, le dita avvinghiate alla cannuccia, i bambini volgevano intorno con occhi
imploranti a invocare soccorso. La carta asciugante premuta con circospezione sulla macchia,
lungi dal produrre la sperata magia di cancellarla, la sbiadiva appena. Restava lì in tutta la sua
terribilità, a testimoniare a gran voce la vergogna della sconfitta. Non c'era modo di liberarsene. La
Margherita aveva severamente vietato la gomma da inchiostro e ammonito di non portarla
nemmeno in classe perché l'avrebbe requisita senza pietà. Ma c'era chi sfidava il divieto e, facendosi
scudo della schiena del compagno, si accaniva con la pietrosa gomma contro la macchia nemica.
Abrasioni, spiegazzature, buchi nella pagina ampliavano il disastro invece di risolverlo.
Il pennino si rivelava uno strumento vendicativo: stridendo sulla carta, s'impuntava all'improvviso
nel bel mezzo di una parola e schizzava una grandinata di goccioline. Col tempo, nel calamaio si
depositava la polvere e sul fondo sedimentava uno strato di melma che il pennino dragava,
riemergendo con un invisibile filamento appiccicato alla punta. Una volta appoggiato sul foglio,
l'insidia nascosta si rivelava con uno sbaffo deturpante che doleva come una coltellata nel costato.
Il vento della catastrofe soffiava sulle teste chine dei bambini.
La maestra era un nemico crudele, senza misericordia.
155
Pinocchio
Collodi
(...) Il giorno dopo Pinocchio andò alla scuola comunale.
Figuratevi quelle birbe di ragazzi, quando videro entrare nella loro scuola un burattino!
Fu una risata, che non finiva più.
Chi gli faceva uno scherzo, chi un altro; chi gli levava il berretto di mano; chi gli tirava il
giubbettino di dietro; chi si provava a fargli coll'inchiostro due grandi baffi sotto il naso; e chi si
attentava perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare.
Per un poco Pinocchio usò disinvoltura e tirò via; ma finalmente, sentendosi scappar la pazienza, si
rivolse a quelli, che più lo tafanavano e si pigliavano gioco di lui, e disse loro a muso duro: Badate, ragazzi: io non son venuto qui per essere il vostro buffone. Io rispetto gli altri e voglio
essere rispettato.
- Bravo berlicche! Hai parlato come un libro stampato! - urlarono quei monelli, buttandosi via dalle
matte risate: e uno di loro, più impertinente degli altri allungò la mano coll'idea di prendere il
burattino per la punta del naso.
Ma non fece a tempo: perché Pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata
negli stinchi.
- Ohi! Che piedi duri! - urlò il ragazzo stropicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino. - E
che gomiti!... anche più duri dei piedi! - disse un altro che, per i suoi scherzi sguaiati, s'era beccata
una gomitata nello stomaco.
Fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di
tutti i ragazzi di scuola: e tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell'anima.
E anche il maestro se ne lodava, perché lo vedeva attento, studioso, intelligente, sempre il primo a
entrare nella scuola, sempre l'ultimo a rizzarsi in piedi, a scuola finita.
Il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppi compagni: e fra questi, c'erano molti monelli
conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore.
Il maestro lo avvertiva tutti i giorni, e anche la buona Fata non mancava di dirgli e di ripetergli più
volte:
- Bada, Pinocchio! Quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore
allo studio e, forse forse, col tirarti addosso qualche grossa disgrazia.
- Non c'è pericolo! - rispondeva il burattino, facendo una spallucciata e toccandosi coll'indice in
mezzo alla fronte, come per dire: "C'è tanto giudizio qui dentro!".
Ora avvenne che un bel giorno, mentre camminava verso scuola, incontrò un branco dei soliti
compagni, che andandogli incontro, gli dissero: - Sai la gran notizia?
- No.
- Qui nel mare vicino è arrivato un Pesce-cane, grosso come una montagna.
- Davvero?... Che sia quel medesimo Pesce-cane di quando affogò il mio povero babbo?
- Noi andiamo alla spiaggia per vederlo. Vieni anche tu?
- Io, no: voglio andare a scuola.
- Che t'importa della scuola? Alla scuola ci anderemo domani. Con una lezione di più o con una di
meno, si rimane sempre gli stessi somari.
- E il maestro che dirà?
- Il maestro si lascia dire. E' pagato apposta per brontolare tutto il giorno. (...)
156
Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren
(Salani)
(...) Pippi si buttò a sedere in un banco libero, senza che alcuno glielo avesse assegnato; ma la
maestra non sembrò notare la sua maniera sgangherata d'agire.
Disse soltanto in tono estremamente amichevole: - Benvenuta a scuola, piccola Pippi! Spero proprio
che tu ti ci troverai bene e imparerai tante belle cose.
- Tutto questo è giusto, ma io spero invece di avere la vacanze natalizie che mi spettano - disse
Pippi, - i diritti innanzi tutto!
- Se intanto vorrai essere così gentile da dirmi qual è il tuo vero nome, - disse la maestra - io lo
scriverò nel registro di classe.
- Mi chiamo Pippilotta Pesarella Tapparella Succiamenta, figlia del capitano Efraim Calzelunghe,
prima terrore dei mari, ora re dei negri. Pippi non è che il mio diminutivo, perché papà trovava
Pippilotta troppo lungo.
- Bene - disse la maestra - anche noi ti chiameremo semplicemente Pippi. Cominciamo intanto a
esaminarti per vedere che cosa sai: sei ormai una bimba grande, e certo hai già una quantità di
cognizioni. Iniziamo magari con l'aritmetica: dunque, Pippi, sai dirmi quanto fa 7 più 5?
Pippi la guardò, un po' stupita e un po' corrucciata.
Poi disse: - Beh, senti, se non lo sai da te, non aspettarti che te lo venga a raccontare io!
Gli altri bambini guardarono Pippi scandalizzati, e la maestra lo spiegò con pazienza che quello non
era il modo di rispondere, a scuola. Non si doveva dare del <<tu>> alla maestra, ma bisognava
chiamarla <<signorina>>.
- Oh, ne sono proprio spiacente! - disse Pippi, tutta contrita. - Non lo sapevo, e non farò mai più una
cosa simile.
- Lo spero - disse la maestra - e voglio anche dirti che 7 più 5 fa 12.
- Vedi dunque che lo sapevi! - esclamò Pippi - Ma allora perché me l'hai chiesto? Oh, che stupida: ti
ho dato di nuovo del <<tu>>! Scusa, eh! - disse - e si diede un vigorosa tirata d'orecchie. La maestra
fece finta di nulla, e proseguì:
- Allora, Pippi, quanto pensi che faccia 8 più 4?
- Così, ad occhio e croce, 67- rispose Pippi dopo matura riflessione.
- Ma no! - disse la maestra. - 8 più 4 fa 12.
- Ah, vecchia mia, ora stiamo proprio passando il segno! - s'indignò Pippi. Tu stessa hai detto poco
fa che è 7 più 5 che fa 12. Perfino a scuola ci vuole un po' d'ordine! D'altra parte, se ti perdi in simili
sciocchezze proprio come una bambina, perché non ti metti buona in un angolo a contare per conto
tuo, e ci lasci in pace, così noi intanto possiamo giocare a nasconderci? Dio mio, ti ho dato di nuovo
del <<tu>>! - gridò spaventata. Ti prego, perdonami, se ti riesce, ancora per questa volta, e ti
prometto di ricordarmene davvero, d'ora in poi!
La maestra disse che doveva cercare proprio di farlo; ma non ritenne fosse il caso di insistere ancora
sulla aritmetica, con Pippi. Preferì interrogare gli altri bambini.
- Tommy, guarda se ti riesce di risolvere questo problema - cominciò - <<Se Lisa ha 7 mele e Axel
ha 9 mele, quante ne hanno tra tutte e due?>>
- Si, si, rispondi, Tommy - intervenne Pippi. - E poi rispondi a questo mio problema: <<Se Lisa ha
mal di pancia e Axel ha ancora più mal di pancia, quale ne è la causa, e dove avevano rubato le
mele?>>
La maestra fece finta di non aver sentito, e si rivolse ad Annika:
- Ora, Annika, porrò a te un altro problema: <<Gustavo ha preso parte, con i suoi compagni, a una
gita scolastica. All'andata aveva una corona, e al ritorno 7 centesimi. Quanto aveva speso?>>
- Già - disse Pippi - e poi sono io che voglio sapere perché aveva le mani così bucate, e se i soldi li
aveva spesi per una gazzosa, e se si era lavato le orecchie per bene, prima di uscire.
La maestra stabilì di lasciar perdere l'aritmetica.
157
Forse Pippi avrebbe preferito imparare a leggere, pensò.
Così estrasse una figura che rappresentava un istrice, dinanzi al cui naso era tracciata la lettera
<<i>>.
- Ecco qualcosa di divertente da imparare Pippi - disse in fretta. - Qui vedi un iiiiiiistrice; e questa
lettera al principio dell'iiiiiiistrice si chiama <<i>>.
- Incredibile! - esclamò Pippi - A me sembra un'asta con una cacchina di mosca sopra: e sarei
curiosa di sapere che cosa centri un istrice con una cacchina di mosca.
La maestra estrasse la prima illustrazione, che rappresentava un serpente e spiegò a Pippi che la
lettera iniziale si chiamava <<s>>.
- A proposito di serpenti - sbottò Pippi - mai riuscirò a dimenticarmi quella volta che lottai con un
serpente gigante dell'India. Era un serpente così spaventoso, da non potersi immaginare, era lungo
14 metri e inferocito come un'ape, e ogni giorno mangiava cinque portate a base di Indiani e due
bambini piccoli come dolce, e una volta si mise in testa di avere me come dolce, e allora incominciò
a strisciarmi intorno sibilando crasc ma <<siamo o non siamo lupi di mare?>> mi dissi, e gli detti
un colpo in testa - bum - e - pfff - allora morì, ah ah, e questa sarebbe per voi la lettera <<s>>,
davvero mirabolante!
Qui Pippi fu costretta a riprender fiato, e la maestra, che incominciava a giudicarla una bambina
piuttosto rumorosa e noiosa, propose alla classe di dedicarsi un po' al disegno. Pensava che così
almeno Pippi si sarebbe messa a sedere tranquillamente e si sarebbe applicata in silenzio al disegno.
Tirò fuori carta e matite e li distribuì agli scolari. - Disegnate quel che volete - disse e si sedette in
cattedra per correggere in pace i compiti.
Quando dopo un po' levò lo sguardo per vedere se, coi disegni, le cose funzionassero meglio, si
accorse che tutti i bambini si erano seduti intorno a Pippi che, distesa sul pavimento, disegnava con
molta foga,
- Ma Pippi! - gridò la maestra spazientita. - Perché non disegni sulla carta?
- Quella l'ho già utilizzata da molto tempo - rispose Pippi - ma il mio cavallo tutto intero non ci sta
su quel misero foglietto di carta. Proprio ora sto facendogli le zampe anteriori, ma quando arriverò
alla coda credo che sarò costretta ad andare a disegnare in corridoio.
La maestra fece appello alle sue ultime risorse.
- E se invece ci mettessimo a cantare? - propose.
Immediatamente tutti i bambini si alzarono in piedi dietro ai loro banchi, tutti meno Pippi che
rimaneva sempre distesa sul pavimento.
- Cantate pure voi - disse - così posso riposarmi un po': l'eccessiva scienza può spezzare la fibra più
resistente.
Ma nella maestra ogni riserva di pazienza s'era esaurita. Invitò tutti gli altri bambini ad andarsene a
giocare in cortile, per poter parlare seriamente con Pippi a quattrocchi.
Quando questa e la maestra furono rimaste sole, Pippi si alzò e andò difilata alla cattedra. - Sai, ti
voglio dire una cosa, signorina - disse. - è stato davvero divertente vedere come ve la passate qui.
Ma direi che non mi interessa molto continuare ad andare a scuola. Sarà quello che sarà, per le
vacanze di Natale. Ma qui avete veramente troppe mele, istrici e serpenti: ho una grande confusione
in testa. Spero proprio, signorina, che questo non ti faccia troppo dispiacere. (...)
158
Quarto piano, interno 4
Salvatore Di Giacomo
(...) Di faccia alla finestra ove la servetta s'indugiava era quella della Marangi, la maestrina
comunale. A poca distanza dal parapetto, seduta a una tavola sulla quale era pur la piccola macchina
da cucire, la Marangi scriveva, piegata su un mucchio di carte. Di volta in volta, sostando, si
leccava il medio della mano destra che s'era insudiciato d'inchiostro, e lo fregava a una pezzuola.
- Signorina Marangi, - disse Milia - scusate tanto se vi disturbo. Io vado per una commissione e
lascio sola la mia signorina. Mi volete dare occhio alla porta?
La Marangi levò il capo. Rispose:
- Va bene.
E si rimise a scrivere. S'udì lo sbattere della porta e Milia scese le scale, canticchiando. Era così alto
il silenzio che la Marangi udì, chiaramente, la voce della servetta in cortile. Milia diceva al
portinaio:
- Don Angelo, non lasciate salire alcuno. La signorina è rimasta sola in casa. Io vado per un soldo
d'aghi e subito torno.
La maestrina, che aveva abbandonato il braccio sulla tavola e schiuse le dita dalle quali era sfuggita
la penna sospirò profondamente. I suoi grandi e dolci occhi azzurri si velarono, stanchi, fra le ciglia.
Appena tornata dalla scuola s'era posta a rivedere i compiti delle sue scolarette: un mucchio di
scritti infantili aspettava ancora i suoi segni di correzione a matita azzurra. E la notte precedente ella
aveva così poco dormito!
- Pazienza! - mormorò, passando e ripassando le dita sulle palpebre grevi.
Come un'eco, dalla finestra di rimpetto, una voce ripetette:
- Pazienza!
- Oh, Sofia! Sei tu? - disse la Marangi.
Immobile, ritta presso il davanzale della sua finestra, la signorina Sofia la guardava.
- E tu che fai, Laura?
La maestrina sorrise, malinconicamente. Con gli occhi indicò gli scritti sparsi sulla tavola. - Non
vedi? Correggo compiti.
Rimasero mute per un po' tutte e due, contemplandosi.
- Che fai? - disse la Marangi.
- Nulla.
- Nulla? Troppo poco... Tu soffri, Sofia, tu soffri, lo so. Lo vedo. Come sei pallida!
Si levò dalla tavola e venne a porsi davanti alla finestra. Mise le mani spiegate sul davanzale. E,
gravemente, soggiunse:
- Senti, Sofia, lascialo! Io te lo volevo dire da tanto tempo! Pensa a te, pensa a te! Quell'uomo lì non
è fatto pel tuo carattere nobile e fine. Lascialo. Egli ti lascerà, se non lo lasci. E' tristo, è
ingeneroso... Perdonami, sai, non ti dolere... è tristo, è tristo!...
Sofia Sponzilli tremava, bianca come un cencio. Tremavano le sue piccole mani nervose e
tormentavano i fascicoli del romanzo, il gomitolo, il ricamo che Milia aveva dimenticato sulla
finestra.
Rispose, piano:
- No... non posso.
- Ti lascerà! Lo vedrai.
- Ebbene... se fa questo... Vedrai, Laura!
La maestrina scosse la testa, pietosa. E si mise a riordinare, macchinalmente, i suoi compiti sulla
tavola.
- Tu non hai cuore per certe cose! - disse la Sponzilli, all'improvviso. - Tu non hai mai amato!
- Oh, figlia mia! - balbettò la maestrina, con tutta la commossa voce del suo cuore pieno di ricordi e
di rimprovero. E le carte le sfuggirono di mano, ed ella chinò la testa e si sentì piegare.
La Sponzilli era scomparsa. Laura Marangi scivolò temente lungo la tavola, tornò a sedere al suo
posto, riprese la penna e contemplò, muta, meditando, i suoi compiti. Gli occhi le si erano empiti di
159
lagrime. Bagnò due o tre volte la penna, cercò uno degli scritti nel mucchietto che se n'era posto
davanti. La mano e lo scritto rimasero lì, immoti. Ella si risovveniva, ora, di tutte le sue pene, di
tutto l'amor suo finito miseramente per una volgare questione d'interessi, di denaro. Povera, anche
lei: con una mamma vecchia, cieca, poveramente pensionata, con un fratello ferroviere che ora le
voleva abbandonare per ammogliarsi, e senz'altro, senz'altro, che uno stipendio meschino! E senza
più amore, e senza più speranza, davanti all'oscuro avvenire!
Reclinò la testa bionda sul braccio e ve la posò, e vi nascose la faccia. (...)
160
Ragazzo negro
Richard Wright
(Einaudi)
(...) La scuola religiosa si aperse, ed io v'introdussi la mia imbronciata presenza.
Venti scolari disposti per ordine d'età, dai cinque ai diciannove anni, e dalla scuola primaria fino
alla secondaria, erano ammassati in una sola stanza. L'unica insegnante era zia Addie, e fin dal
primo giorno, un acuto, aspro antagonismo sorse tra noi.
Era La prima volta ch'ella faceva scuola, e la innervosiva e imbarazzava il fatto che un suo parente,
un parente che non voleva condividere la sua fede e che non era un seguace della sua setta, si
trovasse nell'aula.
Aveva deciso di farmi conoscere a tutti gli scolari per un peccatore di cui ella non prendeva le parti
e al quale non si doveva accordare considerazione di sorta. Gli scolari erano ragazzi docili,
mancanti di quell'acuto senso di rivalità che fa dei ragazzi e delle ragazze della scuola pubblica
un'accolita di gente in cui un ragazzo è saggiato e pesato, ed in cui acquista una visione di ciò che è
il mondo.
Questi erano senza volontà, i loro discorsi erano piatti, i loro gesti vaghi, le loro personalità svuotate
di rabbia, di speranza, di allegria, di entusiasmo, di passione o di disperazione.
Io ero in grado di vederli con una obbiettività per loro inconcepibile.
Erano completamente dominati dal loro ambiente e non potevano immaginarne altri, mentre io
provenivo da un altro piano di vita, dalle porte volanti dei saloons,
dagli scali della ferrovia, dai capannoni, dalle bande di ragazzi di strada, dagli argini dei fiumi, e da
uno orfanotrofio; ero stato tramutato di città in città, di casa in casa, ed ero stato mescolato coi
grandi, forse più di quanto non avesse potuto giovarmi.
Dovetti reprimere la mia abitudine di dir parolacce, ma non prima d'aver scandalizzato più di metà
di loro e d'aver messo in imbarazzo zia Addie, facendola sentire impotente. Verso la fine della
prima settimana di scuola, il conflitto che covava tra zia Addie e me divampò apertamente. Un
pomeriggio ella si alzò dalla cattedra, venne tra i banchi e mi si fermò accanto.
"Sai bene che non devi farlo!" disse, battendomi con un righello sulle nocche. "Far che cosa?"
domandai, stupito, strofinandomi le mani.
"Guarda per terra!" disse lei. Guardai e vidi molti pezzettini di polpa di noce sparsi lì attorno, alcuni
avevano fatto delle macchie grasse sul lindo, chiaro tavolato di pino.
Ricordai d'un tratto che il ragazzo davanti a me ne aveva mangiato; le mie noci le avevo in tasca,
ancora da schiacciare.
"Io non ne so nulla," dissi.
"Lo sai bene che non si deve mangiarne in classe," disse lei.
"Io non ho mangiato," dissi.
"Non dire bugie! Questa non è una scuola come un'altra, è un luogo sacro del Signore!" disse lei
indignata.
"Zia Addie, le mie noci le ho qui in tasca..."
"Io sono Miss Wilson!" gridò lei.
La fissai, ammutolito, comprendendo finalmente ciò che la irritava.
Ella mi aveva avvertito di chiamarla Miss Wilson in classe, e per la maggior parte delle volte lo
avevo fatto. Temeva che se l'avessi chiamata zia ciò avrebbe scosso il morale degli scolari, benché
tutti lo sapessero che era mia zia, e molti la conoscessero da più tempo di me.
"Mi dispiace" dissi, e distolsi il capo da lei e apersi un libro.
"Richard, alzati in piedi!"
Non mi mossi. L'atmosfera era tesa. Le mie dita si stringevano al libro e sentivo che tutti gli scolari
ci stavano guardando. Non ero stato io a mangiare le noci; mi dispiaceva d'averla chiamata zia
Addie, ma non volevo essere scelto proprio io per una punizione gratuita.
E poi mi aspettavo che il ragazzo davanti a me inventasse qualche bugia per salvarmi, poiché era lui
in realtà il colpevole. "Ti ho detto di alzarti in piedi!" gridò.
161
Rimasi seduto, senza togliere gli occhi dal libro. D'un tratto ella mi afferrò per il colletto e mi
strappò dal sedile, e mi ritrovai barcollante in mezzo alla stanza. "Ho detto a te!" gridò
istericamente.
Mi drizzai e la guardai; c'era odio nel mio sguardo.
"Non guardarmi in quel modo"!
"Non sono stato io a buttar in terra le noci".
"E chi è stato, allora"?
Il mio codice dei ragazzi di strada mi metteva in imbarazzo. Non avevo mai fatto la spia a un
compagno, alla scuola pubblica, e aspettavo che il ragazzo davanti mi venisse in aiuto, dicendo una
bugia, facendo delle scuse, una cosa qualsiasi.
In passato mi ero preso delle punizioni che non mi spettavano per tener fede alla solidarietà della
banda, ed avevo visto altri ragazzi far lo stesso. Ma il ragazzo religioso, con l'aiuto di Dio, non
parlò.
"Non lo so chi è stato," dissi alla fine.
"Vai davanti alla cattedra," disse zia Addie. Adagio, andai alla cattedra, aspettandomi un
rimprovero; ma il cuore mi diede un balzo, la vidi andare all'angolo, scegliere una lunga, verde
sferza flessibile e venir verso di me. Persi il controllo dei miei nervi.
"Io non ho fatto niente!" urlai.
Mi colpì e feci un balzo da parte. "Non ti muovere"! esplose, la faccia livida di rabbia, il corpo
tremante.
Rimasi fermo, sentendomi sconfitto più dal santo ragazzo dietro di me che da zia Addie. "Para la
mano".
Parai la mano giurando a me stesso che mai mi sarebbe capitata un'altra volta una cosa simile, a
qualsiasi costo. Mi sferzò la mano fino a farmela diventar rossa, e poi le gambe nude fino a
rigarmele di rosa.
Strinsi i denti per evitare d'emettere un sol gemito e quando ella smise, continuai a tenere la mano
distesa, come a farle vedere che i suoi colpi non mi avrebbero mai veramente toccato, e fissandola
in viso senza batter ciglio.
"Abbassa la mano e va' al tuo posto," disse lei.
Lasciai cadere la mano e girai sui tacchi, la mano e le gambe in fiamme, il corpo rigido. Camminai
come in una nebbia di rabbia verso il mio banco.
"E ancora non l'ho finita, con te"! mi gridò dietro.
Aveva detto una frase di troppo; prima che potessi accorgermene mi ero voltato e la fissavo a bocca
aperta, gli occhi fiammeggianti.
"Non l'avete finita con me"? ripetei. "Ma che cosa vi ho fatto"?
"Siediti e sta zitto"! tuonò zia Addie.
Sedetti.
Di una cosa ero sicuro: che non mi sarei lasciato battere un'altra volta da lei. Ero stato spesso
battuto duramente, ma quasi sempre avevo sentito che le bastonature erano in certo qual modo
giuste e ragionevoli, che ero dalla parte del torto.
Adesso, per la prima volta, mi sentii alla pari d'un adulto, mi resi conto che ero stato battuto per una
ragione non giusta. (...)
162
Registro di classe
Sandro Onofri
(Einaudi)
(...) 26 aprile. La legge è proprio imperscrutabile, certe volte. Si pensi alle responsabilità che
toccano a un insegnante durante i quindici minuti di ricreazione, per esempio: se resta in classe, e i
propri alunni si scapicollano giù per le scale, lui è a posto; se invece si affaccia sul corridoio per
controllare che l'orda selvaggia non causi vittime né si accendano zuffe e risse, ma
malauguratamente l'unico alunno rimasto in classe subisce proprio in quel momento un infortunio,
allora per il docente sono guai seri, in quanto responsabile di avere "abbandonato il posto di lavoro"
e di "non avere ottemperato ai propri doveri di vigilanza". Io ho deciso di fare l'inglese e di
adeguarmi. Di questi tempi, quando si parla dei doveri dei professori, è meglio non stare a ricamarci
troppo sopra, stanno tutti coi nervi tesi, dai politici ai sindacalisti ai giornalisti. Per carità. Oltre tutto
è molto più comodo, almeno in questo caso, fare il proprio dovere. E cosi oggi - vengo al dunque mentre stavo seduto nella mia garitta a sistemare il registro, ignorando le cavalcate e le grida di
guerra che si succedevano per il corridoio, si è presentata Enza. Doveva parlarmi privatamente.
Della poesia che ha presentato al concorso letterario, ha aggiunto. L'ho invitata a sedersi su una
delle venti sedie vuote presenti nella mia postazione e lei, col viso arrossato per l'imbarazzo, ha
confessato di botto che quella poesia non era opera sua.
Sono rimasto di stucco. E vero che sono ormai preparato a tutto: in particolare per le iniziative che
esulano dalia stretta attività didattica le sorprese sono all'ordine del giorno. Ma cos'era adesso
questa novità? Pure tu, ho detto, Enza, adesso ti metti a fare la furba? Pure tu? Chi te l'ha scritta, la
poesia? Una cugina più grande? Tua sorella? E Enza, poverina, ha abbassato lo sguardo, e tutto d'un
fiato ha confessato che non c'era niente di tutto questo. La poesia era opera di Giovanni, un
compagno di classe. Ah, e cos'hai fatto? ho chiesto, sospettoso. Gliel'hai rubata? Macché, professo',
ha precisato lei, con un sorriso. Me l'ha chiesto lui. E come sarebbe, perché? Perché sennò i
compagni, se sanno che lui scrive poesie, cominciano a dirgli che è frocio, professo', e lui non
vuole. Ecco perché.
Be', io di fronte a questa motivazione, mi sono arreso. Queste sono cose serie, a quell'età. Li
conosco bene anch'io, certi condizionamenti, eccome. Adesso sarà un problema. Perché oltre tutto
la poesia è anche bella, e corre il rischio serio di vincere. Ma se vince, chi glielo dice a Giovanni? E
ai suoi amici? Pensateci bene, pensate da quale labirinto di pregiudizi emerge questo piccolo,
ridicolo problema.
10 maggio. Il ricevimento generale dei genitori lo considero un po' come la cartina al tornasole del
mio stato di salute. Se esco da quelle tre ore di colloqui senza avere mai provato nemmeno una
volta un istinto aggressivo, o uno stimolo regressivo che mi porterebbe a urlare e a rispolverare tutto
il mio sepolto archivio di spropositi e mal eloqui alla romana, be', se questo avviene, vuol dire che
posso sentirmi al riparo da ulcere e ansie per qualche mese.
L'ultima volta, proprio l'altro giorno, purtroppo non è andata così. E all'uscita non la prima sigaretta
dopo tre ore di astinenza ho messo in bocca ma una pastiglia di Zantac. Perché, vedete, ci sono
essenzialmente due categorie di genitori: quelli che vengono per parlare dell'andamento scolastico
dei propri figli, e quelli che ritengono di doverli proteggere contro le angherie dei professori. Tra
questi ultimi, poi, si devono distinguere due ulteriori tipi: coloro che si presentano in modo
aggressivo e pretendono ragione dell'affronto di un cinque o di un quattro affibbiato alle proprie
creature, e quelli che invece stanno li davanti, con aria afflitta, e scuotono la testa rassegnati, come
piegati da secoli e secoli di ingiustizie subite, di cui tu sei solo l'ultima incarnazione. Sono questi
ultimi a rappresentare un vero e proprio tesoro per i produttori di pastiglie Zantac.
L'altro giorno, dicevo, c'è stata una specie di spontanea manifestazione contro di me, durante i
colloqui. Erano sei signore, minigonne e calze a rete, che si sono sedute, e hanno subito assunto una
posa antica. "Quella" posa. Un po' pirandelliana, di colpa e di rimprovero, di un silenzio
ammonitore, gli sguardi bassi e ammaccati. Professore, ha cominciato la prima, ma come si fa? Noi
163
siamo lavoratori, non abbiamo mica i beni al sole. Campiamo di stipendio, noi!, ha aggiunto
un'altra. Non facciamo mica i professori! Le ho invitate a spiegarsi meglio. Insomma, professore, ha
ripreso la prima, ma come si fa? Un libro al mese! Un libro al mese lei fa comprare ai nostri figli! E
noi, poveracci, noi non ce la facciamo più! Allora mi sono difeso, ho detto che mi preoccupo di
scegliere solo edizioni tascabili, sono dieci, quindicimila lire al massimo...
Ma la sesta, l'ultima, che fremeva, la vedevo che fremeva da quando si era seduta, mi ha interrotto,
ha preso a dire sottovoce, scuotendo la testa, sguardo basso e percosso, che adesso si era aggiunta
pure la richiesta di comprare i giornali con le pagine sulla guerra. Ci mancava pure la guerra,
adesso, ha sospirato. Io, che mi sentivo ormai una carogna, ho tentato di dire che non c'era bisogno
di comprare dei giornali in più, bastava il quotidiano di tutti i giorni. E allora la prima ha alzato una
spalla e quale giornale?, ha detto, in casa nostra mica compriamo giornali, ha detto, ci mancherebbe
pure questo! Giusto mio marito, la domenica, il Corriere dello Sport. Ma per lei, professore, è
sempre domenica... (...)
164
Ricordi di scuola
Giovanni Mosca
(Rizzoli)
(...) La conquista della quinta C.
Avevo vent'anni quando, tenendo nella tasca del petto la lettera di nomina a maestro provvisorio, e
sopra la tasca la mano, forte forte, tanto era la paura di perdere quella lettera così sospirata, mi
presentai alla scuola indicata e chiesi del Direttore.
Il cuore mi faceva balzi enormi.
"Chi sei?", mi domandò la segretaria. "A quest'ora il signor Direttore riceve solo gli insegnanti".
"So... sono appunto il nuovo maestro..." dissi, e le feci vedere la lettera.
La segretaria, gemendo, entrò dal Direttore il quale subito dopo uscì, mi vide, si mise le mani sui
capelli.
"Ma che fanno", gridò, "al Provveditorato? Mi mandano un ragazzino quando ho bisogno di un
uomo con grinta baffi e barba da Mangiafuoco, capace di mettere finalmente a posto quei quaranta
diavoli scatenati! Un ragazzino invece... Ma questo, appena lo vedono, se lo mangiano!"
Poi, comprendendo che quello era tutt'altro che il modo migliore di incoraggiarmi, abbassò il tono
di voce, mi sorrise e, battendomi una mano sulla spalla: "Avete vent'anni?", disse. "Ci credo, perché
altrimenti non vi avrebbero nominato; ma ne dimostrate sedici. Più che un maestro sembrate un
alunno di quinta che abbia ripetuto parecchie volte. E questo, non ve lo nascondo, mi preoccupa
molto. Non sarà uno sbaglio del Provveditorato? C'è proprio scritto Scuola 'Dante Alighieri'?"
"Ecco qui", dissi mostrando la lettera di nomina. "'Scuola Dante Alighieri'".
"Che Iddio ce la mandi buona!", esclamò il Direttore. "Sono ragazzi che nessuno, finora, è riuscito a
domare. Quaranta diavoli, organizzati, armati, hanno un capo, si chiama Guerreschi; l'ultimo
maestro, anziano, e conosciuto per la sua autorità, se n'è andato via ieri, piangendo, e ha chiesto il
trasferimento...".
Mi guardò in faccia, con sfiducia: "Se aveste almeno i baffi...", mormorò.
Feci un gesto, come dire ch'era impossibile, non mi crescevano.
Alzò gli occhi al cielo: "Venite", disse.
Percorremo un lungo corridoio fiancheggiato da classi: quarta D, quinta A, quinta B... quinta C...
"E' qui che dovete entrare" disse il direttore fermandosi dinanzi alla porta della V C dalla quale
sarebbe poco dire che veniva chiasso: si udivano grida, crepitii di pallini di piombo sulla lavagna,
spari di pistole a cento colpi, canti, rumore di banchi smossi e trascinati.
"Credo che costruiscano barricate", disse il Direttore.
Mi strinse forte un braccio, se n'andò per non vedere, e mi lasciò solo davanti alla porta della V C.
Se non l'avessi sospirata per un anno, quella nomina, se non avessi avuto, per me e per la mia
famiglia, una enorme necessità di quello stipendio, forse me ne sarei andato, zitto zitto, e ancora
oggi, probabilmente la V C della scuola "Dante Alighieri" sarebbe in attesa del suo dominatore: ma
mio padre, mia madre, i miei fratelli attendevano impazienti, con forchetta e coltelli, ch'io riempissi
i loro piatti vuoti; perciò aprii quella porta ed entrai.
Improvvisamente silenzio.
Ne approfittai per richiudere la porta e salire sulla cattedra. Seduti sui banchi, forse sorpresi dal mio
aspetto giovanile, non sapendo ancora bene se fossi un ragazzo o un maestro, quaranta ragazzi mi
fissavano minacciosamente. Era il silenzio che precede le battaglie.
Di fuori era primavera; gli alberi del giardino avevano messo le prime foglioline verdi, e i rami,
mossi dal vento, carezzavano i vetri delle finestre.
Strinsi i pugni, feci forza a me stesso per non dire niente: una parola sola avrebbe rotto l'incanto, e
io dovevo aspettare, non precipitare gli avvenimenti.
I ragazzi mi fissavano, io li fissavo a mia volta come il domatore fissa i leoni, e immediatamente
compresi che il capo, quel Guerreschi, di cui mi aveva parlato il Direttore, era il ragazzo di prima
fila, - piccolissimo, testa rapata, due denti in meno, occhietti piccoli e feroci - che palleggiava da
165
una mano all'altra un'arancia e mi guardava la fronte.
Si capiva benissimo che nei riguardi del saporito frutto egli non aveva intenzioni mangerecce.
Il momento era venuto.
Guerreschi mandò un grido, strinse l'arancia nella destra, tirò indietro il braccio, lanciò il frutto, io
scansai appena il capo, l'arancia s'infranse alle mie spalle, contro la parete. Primo scacco: forse era
la prima volta che Guareschi sbagliava un tiro con le arance, e io non m'ero spaventato, non m'ero
chinato: avevo appena appena scansato il capo, di quel poco che era necessario. Ma non era finita.
Inferocito, Guerreschi si drizzò in piedi e mi puntò contro - caricata a palline di carta inzuppate con
saliva - la sua fionda di elastico rosso.
Era il segnale: quasi contemporaneamente gli altri trentanove si drizzarono in piedi, puntando a loro
volta le fionde, ma d'elastico comune, non rosso, perché quello era il colore del capo.
Mi sembrò di essere un fratello Bandiera.
Il silenzio si era fatto più forte, intenso.
I rami carezzavano sempre i vetri delle finestre, dolcemente. Si udì d'improvviso, ingigantito dal
silenzio, un ronzio: un moscone era entrato nella classe e quel moscone fu la mia salvezza.
Vidi Guerreschi con un occhio guardare sempre me, ma con l'altro cercare il moscone, e gli altri
fecero altrettanto, sino a che lo scoprirono, e io capii la lotta che si combatteva in quei cuori: il
maestro o l'insetto?
Tanto può la vista di un moscone sui ragazzi delle scuole elementari.
Lo conoscevo bene il fascino di questo insetto: ero fresco di studi e neanch'io riuscivo ancora a
rimanere completamente insensibile alla vista di un moscone.
Improvvisamente dissi: "Guerreschi" (il ragazzo sobbalzò, meravigliato che conoscessi il suo
cognome), "ti sentiresti capace, con un colpo di fionda, di abbattere quel moscone?"
"E' il mio mestiere", rispose Guerreschi, con un sorriso.
Un mormorio corse tra i compagni.
Le fionde puntate contro di me si abbassarono, e tuti gli occhi furono per Guerreschi che, uscito dal
banco, prese di mira il moscone, lo seguì, la pallina di carta fece; den! contro una lampadina, e il
moscone, tranquillo, continuò a ronzare come un aeroplano.
"A me la fionda!", dissi.
Masticai a lungo un pezzo di carta, ne feci una palla e, con la fionda di Guerreschi, presi, a mia
volta, di mira il moscone. La mia salvezza, il mio futuro prestigio erano completamente affidati a
quel colpo.
Indugiai a lungo, prima di tirare: "Ricordati", dissi a me stesso, "di quando eri scolaro e nessuno ti
superava nell'arte di colpire i mosconi".
Poi, con mano ferma, lasciai andare l'elastico: il ronzio cessò di colpo e il moscone cadde morto ai
miei piedi.
"La fionda di Guerreschi", dissi, tornando immediatamente sulla cattedra e mostrando l'elastico
rosso. "è qui, nelle mie mani. Ora aspetto le altre".
Si levò un mormorio, ma più d'ammirazione che di ostilità: e a uno a uno, a capo chino, senza il
coraggio di sostenere il mio sguardo, i ragazzi sfilarono davanti alla cattedra, sulla quale, in breve,
quaranta fionde si trovarono ammonticchiate. (...)
166
Si chiamava Friedrich
Hans Peter Richter
(Piemme)
(...) Il maestro
(...) La campanella della scuola suonò, e dopo l'ultimo squillo il maestro Neudorf chiuse il libro e si
alzò. Lentamente, con aria pensierosa, venne verso di noi, schiarì la voce e disse: - La lezione è
finita. Ma restate ancora un po'; vorrei raccontarvi qualcosa. Chi non ha voglia di ascoltare, però,
può andarsene a casa. Ci guardammo l'un l'altro con aria interrogativa, mentre il maestro andava
verso la finestra, dandoci le spalle. Tirò fuori la pipa dalla tasca della giacca e cominciò a riempirla,
guardando gli alberi nel cortile della scuola. Noi preparammo rumorosamente le cartelle e gli zaini,
ma nessuno lasciò la classe, e restammo in attesa. Il maestro accese meticolosamente la sua pipa e,
con evidente piacere, mandò ampie boccate di fumo a infrangersi contro i vetri. Poi si voltò, diede
un'occhiata ai banchi e si accorse che erano ancora occupati.
Così ci fece un cenno con la testa, sorridendo.
Noi restammo in silenzio, con gli occhi puntati su di lui, mentre dal pianerottolo veniva il rumore
delle altri classi che uscivano. In una delle ultime file qualcuno strisciava i piedi per terra. Il
maestro andò verso la prima fila e sedette su uno dei banchi
Aspirando dalla pipa, ci guardava uno per uno, soffiava il fumo sopra le nostre teste, verso la
finestra. Finalmente cominciò a parlare, con voce bassa e tranquilla: - Avete sentito parlare molto
degli ebrei, in questi ultimi tempi, non è vero? Oggi voglio parlarvene anch'io.
Noi annuimmo e ci chinammo in avanti per ascoltare meglio. Alcuni appoggiarono il mento sulle
cartelle: non si sentiva un fiato. Il maestro Neudorf soffiò una nuvola nera di fumo, verso il soffitto
e ricominciò. - Duemila anni fa gli ebrei vivevano nella terra che oggi si chiama Palestina e che loro
chiamano Israele. La regione era sotto il dominio dell'Impero Romano, ma gli ebrei non volevano
piegarsi agli stranieri e si ribellarono.I Romani domarono la rivolta e nel 70 D. C. distrussero il
tempio di Gerusalemme e mandarono i ribelli in esilio, in Spagna o sul Reno. Una generazione dopo
ci fu un'insurrezione, e questa volta i romani rasero al suolo Gerusalemme: gli ebrei dovettero
fuggire, oppure furono cacciati e si sparpagliarono in tutti i paesi, dove si guadagnarono stima e
rispetto. E poi ci furono le Crociate. I musulmani avevano conquistato la Terra Santa ed impedivano
l'accesso ai luoghi sacri dei cristiani. Schiere di predicatori chiesero la liberazione del Santo
Sepolcro, e migliaia di entusiasti si imbarcarono per la Palestina.
Ma ci fu chi disse: "Gli infedeli non vivono solo in Terra Santa, ce ne sono anche in mezzo a noi!"
Così cominciò la persecuzione degli Ebrei: chi si rifiutava di farsi battezzare, veniva torturato
oppure ucciso. Centinaia di ebrei si tolsero la vita per sfuggire alla conversione forzata o al
massacro. Chi poteva fuggire, fuggì. E quando terminò la persecuzione, re e principi impoveriti
gettarono in prigione i loro sudditi ebrei e li fecero giustiziare senza processo, per impadronirsi
delle loro proprietà. Gli ebrei dovettero fuggire di nuovo, stavolta verso est. Trovarono un nuovo
rifugio in Polonia e in Russia, ma nel secolo scorso cominciarono a torturarli e a perseguitarli anche
là. Chiunque fosse di religione ebraica doveva vivere in quartieri chiusi, chiamati ghetti, e non gli
era possibile recitare un mestiere "rispettabile" (per esempio quello dell'artigiano) o possedere casa
e terra. Le uniche attività erano il commercio e "il prestito di denaro".
Il maestro Neudorf mise la sua pipa ormai spenta nella scanalatura per le penne, e senza parlare
scese dal banco e si mise a passeggiare per la classe; prima di riprendere il racconto, si pulì gli
occhiali.
- Il vecchio testamento dei cristiani è anche la Sacra Scrittura degli Ebrei, che chiamano Thorà,
ossia "dottrina". In questo libro è scritto quel che Dio ha detto a Mosè, e in un'altra opera
importante, il Talmud (che vuol dire "insegnamento"), gli Ebrei hanno stabilito in che modo
bisogna interpretare la Thorà. Gli Ebrei molto osservanti seguono quelle regole ancora oggi, ma non
è facile! Esse vietano, per esempio, di accendere il fuoco il sabato, o di mangiare carni di animali
impuri, come il maiale. Nella Thorà è predetto il destino degli Ebrei: se infrangono i comandamenti
167
di Dio, vengono perseguitati e devono fuggire. Ma il popolo ebraico continua a sperare che il
Messia venga e lo riconduca alla Terra Promessa e lì fondi il suo Regno. Convinti che Gesù non
fosse il vero Messia, ma un impostore come tanti altri, gli Ebrei lo hanno crocifisso. E molti
cristiani che non sono riusciti a perdonare, sono pronti a credere le cose più insensate sul conto
degli Ebrei. Alcuni non vedono l'ora di perseguitarli come un tempo. Per costoro, gli Ebrei
rimangono stranieri, estranei di cui diffidare, ma è solo perché non li conoscono, che pensano tante
cose cattive sul loro conto. Noi eravamo attentissimi, e il silenzio era tale che si sentivano
scricchiolare le suole delle scarpe del maestro. Tutti lo guardavano; solo Friedrich si guardava le
mani. - Così gli Ebrei sono costretti a vivere nel continuo terrore di essere tormentati e perseguitati,
(...) e di dover fuggire dalle loro case abbandonando tutto ciò che possiedono, o comprandosi col
denaro la libertà e la vita... C'è una cosa che perfino i nemici degli ebrei devono riconoscere: sono
un popolo forte! Come avrebbero fatto, altrimenti, a sopravvivere a duemila anni di persecuzioni?
Se oggi o domani vi capiterà di veder disprezzare gli ebrei, ricordate: sono prima di tutto uomini,
uomini come noi!" Senza guardarci, il maestro Neudorf prese di nuovo la pipa, la vuotò dalla cenere
e la riempì di tabacco rimasto. Dopo qualche boccata, domandò: - Allora volete sapere perché vi ho
raccontato tutto questo? -. Sedette accanto a Friedrich e gli mise una mano sulla spalla. - Uno di voi
ci lascia. Friedrich Schneider non può più frequentare la nostra scuola; è ebreo, e d'ora in poi andrà
in una scuola ebraica. Questa non è una punizione, ma solo un cambiamento. Io spero che voi lo
comprendiate e restiate suoi amici, come me, anche se non sarà più nella mia classe. Può darsi che
presto Friedrich abbia bisogno di veri amici.
Il maestro prese Friedrich per le spalle e gli sollevò il viso, costringendo a guardarlo. - Ti auguro
ogni bene, Friedrich! - disse il maestro - e arrivederci! -. Friedrich chinò la testa e a bassa voce
rispose: - Arrivederci!
Il maestro si diresse verso la cattedra a passo svelto, poi, rivolto alla classe, alzò il braccio destro
con la mano aperta all'altezza degli occhi e salutò: - Heil Hitler! Noi ci alzammo e lo salutammo nello stesso modo. (...)
(...) Il professore di educazione fisica
Il nostro insegnante di educazione fisica si chiamava Schuster. Era anche capo delle SA e nella
guerra del 1914-18 era stato capitano.
Tutti quelli che lo conoscevano temevano la sua severità.
Quando qualcuno non gli ubbidiva o si cambiava troppo lentamente, gli faceva fare delle flessioni
finché non cadeva a terra stremato.
Noi scolari cercavamo di evitarlo in tutti i modi. L'educazione fisica secondo il signor Schuster,
consisteva soprattutto nella marcia: marcia veloce, marcia con equipaggiamento, e così via. Un
giorno arrivò in classe prima della lezione (aveva due ore di seguito) e annunciò: - Oggi l'intervallo
non si fa! Avrete modo di prendere abbastanza aria buona, visto che vi porto a fare una marcia
forzata.
I nostri visi si allungarono, ma nessuno osò fiatare; nemmeno Karl Meisen, che l'ultima volta,
durante l'ora di educazione fisica, si era slogato un piede.
- Vuotate gli zaini e le cartelle! - ordinò l'insegnante. - Libri e quaderni lasciateli sotto al banco!
Ubbidienti, mettemmo a posto le nostre cose, come ci era stato ordinato.
- In riga nel cortile della scuola, il capofila a tre passi dal castagno. Prendere cartelle e zaini!
Marsch, marsch!
Prendemmo cartelle e zaini e scendemmo le scale di corsa. Ma il signor Schuster ci aveva
preceduto.
- In fila, ho detto! - gridò. - Il che significa "Stare fermi!".
Respirò profondamente: - Tutti al muro, marsch, marsch!
Ci precipitammo verso il muro, ma ancora prima di raggiungerlo l'ordine "Attenti!!" ci paralizzò. Ci
toccò rimetterci in riga e correre ancora verso il muro, poi in fila, raggiungemmo l'entrata della
palestra. Là c'era un mucchio di pezzi di mattoni, abbandonati da qualche impresa edile, e il
professore Schuster li usò per riempire i nostri zaini.
- La mia cartella è più grande di quella degli altri - fece notare Franz Schulten. Poi, quando Schuster
168
ci mise dentro tre pezzi di mattone, si lamentò: - Gli altri ne hanno avuto solo due.
Per tutta risposta, il professore ne aggiunse un quarto.
Mentre i possessori di cartelle di solito guardavano con disprezzo quelli con lo zaino, ora, invece,
invidiavano chi poteva portarselo sulle spalle. In colonna, ci mettemmo in marcia.
Quando marciavamo nei dintorni della scuola, dove i genitori potevano vederci, il professor
Schuster ci faceva cantare una canzone scelta da lui: "Siehst du im Osten"
Il popolo è stato imbrogliato
per troppi, troppi anni.
Ebrei e traditori hanno imposto
i loro infami inganni.
Ma giunse infine un uomo
che cancellò l'infamia:
fede e speranza diede
a tutta la Germania
Popolo, in armi!
Popolo, in armi!
La canzone finì di toglierci quel po' di fiato che ci era rimasto, ma ci fu ordinato di marciare più in
fretta, e in questo modo attraversammo mezza città. Dopo un'ora e un quarto, ansimanti e sfiniti, ci
trascinammo verso la scuola. La maniglia della cartella di Franz Schulten si era rotta, e lui se l'era
caricata sulle spalle. La sua giacca era zuppa di sudore. Karl Meisen, con il suo piede slogato, era
rimasto per strada, in lacrime. Noi riuscivamo a malapena a camminare. Soltanto il professor
Schuster avanzava agile ed eretto, e sogghignava quando vedeva uno di noi zoppicare.
Ad un certo punto incrociammo un'altra classe.
Tra i ragazzi c'era Friedrich, e capimmo che dovevano essere alunni della scuola ebraica. Anche
Schuster aveva adocchiato Friedrich. - Ragazzi! - disse, risoluto. - Dobbiamo far vedere a quelli là
chi sono i Giovani Tedeschi, e che cosa sono capaci di fare. Non vorrete fare una figuraccia di
fronte a questi ebrei incapaci. Esigo un comportamento adeguato. Chiaro?
Passò accanto alla colonna e rimise in fila quelli che non ne potevano più. E mentre ci sforzavamo
di fare appello alle nostre ultime forze, Schuster ci ordinò di cantare una canzone. Con occhi fissi
davanti a noi, carichi di mattoni ma eretti, passammo davanti alla classe dei ragazzi ebrei, cantando
a squarciagola:
"L'ebreo va di qua e di là
il Mar Rosso attraverserà:
se le onde si chiuderanno,
il mondo è libero da ogni affanno." (...)
169
Storie allegre
Collodi
(...)
Fra babbo e figlio
Masino, pochi giorni dopo, andò in camera a cercare il suo babbo (il quale si era corretto del
bruttissimo vizio di brontolare) e gli disse: "Sai, babbo, che cosa mi ha fatto il maestro?".
"Che ti ha fatto?"
"Con la scusa che ho sbagliato a rispondere nell'Aritmetica, mi ha messo in penitenza........"
"Ma queste son cose orribili!...... Lo racconterò ai carabinieri!......."
"Senti, babbo; io non voglio più andare a scuola."
"Io farei come te. A che serve la scuola? La scuola non è altro che un supplizio inventato apposta
per tormentare voi altri poveri ragazzi."
"Capisci? Mettermi in penitenza perché l'Aritmetica non vuole entrarmi nella testa! Sta a vedere che
un libero cittadino non è padrone di non sapere l'abbaco? Perché anch'io sono un libero cittadino, ne
convieni, babbo?"
"Sicuro che ne convengo."
"Il mio maestro è un buon omo: ma è un omo piccoso. Figurati! Pretenderebbe che i suoi scolari
dovessero studiare!..."
"Pretensioni ridicole! Se viene a dirlo a me, non dubitare che lo servo io."
"Dovresti andare a trovarlo!"
"Vi anderò sicuro: e gli dirò che i maestri possono pretendere che i loro scolari sappiano la
lezione... ma obbligarli a studiare, no, no, mille volte no."
"La volontà è libera, ne convieni, babbo?"
"Sicuro che ne convengo, e quando un ragazzo dice: 'non voglio studiare' nessuno può
costringerlo."
"Figurati! Pretenderebbe che, durante la lezione, i suoi scolari stessero tutti zitti! Come è possibile
di stare zitti quando si sente la voglia di parlare?"
"Hai mille ragioni! Che forse la parola venne data all'uomo, perché a scuola stesse zitto? Lascia fare
a me: domani vado a trovarlo, e gli dirò il fatto mio".
A scuola
E il babbo andò davvero a trovare il maestro, e gli fece una bella lavata di capo, da ricordarsene per
un pezzo:tant'è vero che quando Masino tornò a scuola, il maestro gli si fece incontro tutto
mortificato, e tenendo il berretto in mano, gli disse:
"Scusa, sai, Masino, se l'altro giorno ti messi in penitenza. Fu uno sbaglio, perdonami:
tutti si può sbagliare in questo mondo. Che cosa avevi fatto povero figliuolo, da meritarti quel
castigo? Non avevi imparato la lezione... Ma è forse questa mancanza? Che forse gli scolari hanno
l'obbligo di saper la lezione? Non ci mancherebbe altro!
Animo, via, perdonami e non se ne parli più! Fammi intanto vedere i tuoi quinterni! Benissimo!
Sono tutti coperti di scarabocchi! Gli scarabocchi suoi quinterni provano che lo scolaro è un
ragazzino pulito e che studia bene. Ti darò sette meriti per gli scarabocchi. I ragazzi di buona
volontà, come te, vanno sempre incoraggiati. Vediamo ora i tuoi libri. Arcibenissimo! Questi libri
tutti strappati e sbrindellati, sono una bella prova che sai tenere di conto. La prima cosa che deve
fare uno scolaro perbene è veramente studioso, e quella di sciupare i libri di scuola. (...) E questa
macchia, che hai sul davanti della camicia, come mai te la sei fatta?".
"Me la son fatta stamani, nel leccare lo zucchero in fondo alla chicchera."
"E una macchia che ti torna benissimo (...). Io ho avuto sempre a noia gli scolari con la camicia
pulita. Gli scolari mi piacciono come te, tutti coperti di macchie e di frittelle. Ti darò sei meriti per
quella bella macchia di caffè e latte. Ne meriterebbe di più, ma per oggi tiriamo via. Dimmi,
Masino: hai studiato la lezione di Grammatica?". "Sissignore."
"Dimmi, dunque, quante lettere ci vogliono per formare una sillaba?"
"Così, all'improvviso, non saprei dirlo..."
170
"Benissimo. Me lo dirai un'altra volta. E l'abbaco l'hai studiato?"
"Sissignore.""Che cosa rappresenta una crocellina così, '+', posta fra due numeri?"
"Ecco... dirò... che rappresenta una croce..."
"Oggi non sei in vena a rispondere, mi risponderai un'altra volta. E la Geografia l'hai imparata?".
"Sissignore"
"Sentiamola. In quante parti si divide comunemente l'Italia?"
"In quattro parti: Italia di sopra, Italia di sotto, Italia nel mezzo, e l'Italia....."
"Italia come?..." .
"Italia... da una parte."
"Non è precisamente così, mi risponderai meglio un'altra volta. Eccoti intanto dieci meriti per la
franchezza, con la quale hai risposto a tutte le mie domande."
Agli esami della fin dell'anno, il bravo Masino si fece tantissimo onore, e il suo babbo e la sua
mamma gli regalarono venti pasticcini e un panforte di Siena. (...)
171
Tom Sawyer
Mark Twain
(...) Quando Tom raggiunse la baracca, piccola e isolata, che fungeva da scuola, vi entrò
speditamente, con l'aria di chi ci ha messo meno tempo che poteva. Attaccò il cappello a un piolo e
si gettò nel banco, alacre e solerte. Il maestro, troneggiante lassù nella sua poltrona sfondata, stava
sonnecchiando, cullato dal maleodorante brusio della scolaresca. L'interruzione lo svegliò: "Thomas
Sawyer!"
Tom sapeva che quando il suo nome veniva pronunciato per intero era segno di guai.
"Signore! Venga qui. Dunque, signore, perché lei è di nuovo in ritardo, come sempre?"
Tom stava per rifugiarsi in una bugia, quando vide due lunghe trecce di capelli biondi penzolanti su
una schiena che, mosso dall'elettrica simpatia dell'amore, riconobbe subito; e vicino a quel banco
c'era l'unico posto libero dalla parte delle bambine. Disse istantaneamente: "Mi sono fermato a
parlare con Huckleberry Finn"!
Il cuore del maestro si fermò, e il suo sguardo confuso si perse nel vuoto. Il brusio della scolaresca
s'interruppe; gli scolari si stavano chiedendo se quel temerario era uscito di senno.
Il maestro disse: "Lei... Lei ha fatto... Cosa"?
"Mi sono fermato a parlare con Huckleberry Finn".
Impossibile attribuire alle parole un diverso significato.
"Thomas Sawyer, questa è la confessione più sbalorditiva che mi sia mai capitato di sentire; non
basterà la ferula a lavare quest'offesa. Si tolga la giacca."
Il braccio del maestro lavorò fino a stancarsi, e lo stock di bacchette si ridusse notevolmente. Poi
seguì l'ordine: "E ora, signore, vada a sedersi tra le bambine! E questo le sia d'avvertimento".
(...)Il maestro, il signor Dobbins, aveva raggiunto la mezza età con un'ambizione insoddisfatta. Il
più vivo dei suoi desideri era sempre stato quello di fare il medico, ma la miseria aveva decretato
che non dovesse diventare nulla di più eminente maestro di scuola di campagna. Ogni giorno il
signor Dobbins prendeva dalla cattedra un libro misterioso e, quando non doveva interrogare, ogni
tanto si sprofondava nella lettura. Teneva questo libro chiuso a chiave.
Non c'era un solo bricconcello nella scuola che non morisse dalla voglia di dargli un'occhiata, ma
l'occasione non si presentava mai. Ogni bambino, maschio o femmina che fosse, aveva una sua
teoria sulla natura di questo libro; ma non ce n'erano due che coincidessero, e sembrava impossibile
arrivare ad accertare la verità dei fatti. Ora, passando davanti alla cattedra, che si trovava vicino alla
porta, Becky notò la chiave nella toppa!
Era un'occasione unica. Si guardò intorno, scoprì di essere sola, e dopo un attimo aveva il libro in
mano. Il frontespizio - l'Anatomia di un professor qualche cosa - non le disse nulla; allora Becky
cominciò a sfogliarlo. Arrivò subito a un'illustrazione, incisa e colorata con cura: una figura umana.
subito a un'illustrazione, incisa e colorata con cura: una figura umana. In quel momento un'ombra
cadde sulla pagina, e Tom Sawyer entrò dalla porta e vide di sfuggita la figura. Becky afferrò il
libro per chiuderlo, ed ebbe la sfortuna di strappare a metà, proprio in mezzo, la pagina con
l'illustrazione. Ficcò il volume nella cattedra, girò la chiave e scoppiò in lacrime di vergogna e di
collera: "Tom Sawyer, non potresti essere più cattivo di così, ad avvicinarti a una persona di
nascosto per vedere cosa sta guardando."
"Come potevo sapere che stavi guardando qualcosa?"
"Tom Sawyer, dovresti vergognarti; sai benissimo che farai la spia; e, oh, come farò, come farò? Mi
frusteranno, e non sono mai stata frustata a scuola."
Poi batté il piedino per terra e disse: "Sii pure cattivo quanto vuoi! Io so una cosa che succederà.
Aspetta e vedrai! Ti odio, ti odio, ti odio!" E uscì di corsa dall'aula con un nuovo scoppio di pianto.
Tom rimase immobile, piuttosto turbato da questo attacco furibondo. Finalmente si disse: "Che
strano! Come sono stupide le ragazze. A scuola non l'hanno mai picchiata? E con questo? Cos'è una
bastonatura? Tipico, tipico delle ragazze: pelle delicata e cuore di pulcino. Be', ma è naturale che
non farò la spia al vecchio Dobbins, su quel che ha fatto questa stupidella, perché ci sono altri modi,
172
meno meschini, di fare i conti con lei; ma che importa? Il vecchio Dobbins chiederà chi è stato a
stracciare il suo libro. Nessuno risponderà. Allora lui farà quello che fa sempre: chiederà prima
all'uno e poi all'altro, e quando arriverà alla ragazza giusta lo saprà, senza bisogno che qualcuno
faccia la spia.
Le ragazze hanno la faccia che fa la spia per loro. Sono senza spina dorsale. Le buscherà. Be', è un
brutto impiccio per Becky Thatcher, perché non c'è via di scampo." Tom studiò la cosa ancora per
qualche istante, e poi aggiunse: "Ma le sta bene; a lei piacerebbe vedermi in un guaio simile: si
arrangi!"
Si unì al gruppo di scolari che giocavano nel cortile. Di lì a poco arrivò il maestro e la scuola li
chiamò dentro. Tom non provava un grande interesse per i suoi studi. Ogni volta che guardava di
soppiatto dalla parte delle bambine, il viso di Becky lo turbava. Tutto considerato, non voleva
compatirla, eppure non poteva farne a meno. In quello che stava per succedere non trovava alcun
motivo di esultanza.
Finalmente venne fatta la scoperta dell'abbecedario, e da allora, per un po', la mente di Tom fu tutta
presa dai casi suoi. Becky uscì dal letargo della sua disperazione e mostrò un discreto interesse per
gli sviluppi della situazione. Non si aspettava che Tom potesse cavarsi d'impiccio negando di essere
stato lui a versare l'inchiostro sul libro; e aveva ragione. Il diniego parve solo peggiorare le cose per
Tom. Becky pensava che ne sarebbe stata lieta, e si sforzò di credere che era proprio così, ma scoprì
di non esserne certa. Quando le cose volsero al peggio, ebbe l'impulso di alzarsi per denunciare
Alfred Temple, ma fece uno sforzo e si costrinse a tacere perché, si disse, lui farà la spia sulla figura
che ho strappato, questo è certo.
"Non direi una parola nemmeno se si trattasse di salvargli la vita!" Tom si prese le frustate e tornò
al posto senza fare tragedie, perché pensava che poteva anche darsi che fosse stato lui a rovesciare
inavvertitamente l'inchiostro sull'abbecedario, mentre giocava con i compagni: aveva negato per
salvare la forma e rispettare la tradizione, e aveva insistito nel diniego per principio.
Lentamente passò un'ora intera; il maestro sedeva sul suo trono, col mento sul petto, l'atmosfera era
resa sonnolenta dal brusio dei ragazzi che studiavano. Dopo un po' il signor Dobbins raddrizzò le
spalle, sbadigliò, poi aprì il cassetto della cattedra e tese la mano verso il suo libro, ma sembrava
incerto se prenderlo o lasciarlo. Quasi tutti gli alunni alzarono distrattamente lo sguardo, ma tra loro
ce n'erano due che seguivano con occhio vigile i suoi movimenti.
Il signor Dobbins toccò per qualche tempo il suo libro con aria assente, poi lo tolse dal cassetto e
cercò sulla seggiola la posizione migliore per mettersi a leggere. Tom scoccò un'occhiata a Becky.
Aveva visto la sua stessa espressione sul muso di un coniglio raggiunto dai cacciatori, con un fucile
puntato alla testa. Di colpo dimenticò la lite che aveva avuto con lei. Presto, bisognava far qualcosa,
e farla subito, anche! Ma proprio l'imminenza del pericolo paralizzava la sua inventiva. Bene!
Aveva un'ispirazione!
Sarebbe corso a prendere il libro, si sarebbe gettato fuori dalla porta e sarebbe fuggito! Ma ebbe
appena un attimo di esitazione, e l'occasione andò perduta: il maestro aveva aperto il volume. Ah, se
Tom avesse potuto tornare indietro! Troppo tardi; ormai non c'era più nessuna possibilità di aiutare
Becky. Ancora un attimo, e il maestro squadrò la scolaresca. Tutti gli occhi si abbassarono sotto il
peso del suo sguardo; c'era qualcosa in quello sguardo, che faceva tremare di paura anche gli
innocenti.
Nell'aula cadde un silenzio durante il quale si sarebbe potuto contare fino a dieci; il maestro stava
gonfiandosi di rabbia. Poi parlò: "Chi ha strappato questo libro?"
Non un suono. Si sarebbe sentito cadere uno spillo. Il silenzio perdurò; il maestro scrutava un viso
dopo l'altro cercandovi i segni della colpa.
"Benjamin Rogers, hai strappato tu questo libro"?
Un diniego. Un'altra pausa. "Joseph Harper, sei stato tu"?
Altro diniego. L'inquietudine di Tom cresceva sempre più sotto la lenta tortura di questo modo
d'agire. Il maestro studiò le file dei maschi, rifletté un momento, poi si rivolse alle femmine: "Amy
Lawrence"? Una scossa del capo.
"Gracie Miller"? Lo stesso segno.
"Susan Harper, sei stata tu"?
173
Un altro no. La bambina successiva era Becky Thatcher. Tom tremava da capo a piedi per
l'emozione, e aveva ormai l'impressione che la situazione fosse disperata.
"Rebecca Thatcher..." (Tom guardò il suo viso: era sbiancata dal terrore) ... ... hai strappato tu... No,
guardami in faccia... (le sue mani si alzarono in un gesto supplichevole) ... hai strappato tu questo
libro?"
Un'idea passò come un fulmine nel cervello di Tom. Il ragazzo scattò in piedi e gridò: "Sono stato
io"!
L'intera scolaresca rimase a bocca aperta davanti a quest'incredibile follia. Tom attese qualche
istante per riprendere il controllo delle sue facoltà; e quando si fece avanti per ricevere il castigo, la
sorpresa, la gratitudine e l'adorazione per lui che brillavano negli occhi della povera Becky gli
parvero un compenso sufficiente per cento fustigazioni.
Ispirato dallo splendore del suo gesto, ricevette senza un grido la più spietata fustigazione che il
signor Dobbins avesse mai somministrato; e con pari indifferenza ricevette la crudeltà
supplementare rappresentata dall'ordine di restare a scuola per due ore dopo la fine delle lezioni:
perché sapeva chi lo avrebbe atteso fuori fino alla fine della sua cattività, senza considerare quel
monotono indugio una perdita di tempo. (...)
174
Tra insegnamento e filosofia: una testimonianza
Una singolare testimonianza su un grande filosofo che fu anche Maestro elementare
L'autore del Tractatus prende il diploma dl maestro elementare
Così scriveva Wittgenstein a Engelmann il 2 settembre del 1919. E il giorno 25 dello stesso mese,
sempre Paul Engelmann riceve un'altra lettera di Wittgenstein in cui, tra l'altro, si dice: "C. E.,
qualche giorno fa mi ha scritto Max Zweig, dicendo che mi aspetta presto a Olmùtz E...]. Io però
non posso veramente venire, perché ho iniziato un'attività. Frequento un corso per diventare
insegnante. E così sono di nuovo a scuola; e ciò suona più comico di quanto non sia. Vale a dire che
lo trovo enormemente difficile; non posso più comportarmi come un liceale e, per quanto ciò possa
sembrare buffo, l'umiliazione è per me così grande che spesso penso di non poterla sopportare!
Quindi, di un viaggio a Olmùtz neanche a parlarne. Ma quanto mi piacerebbe vederLa! Se appena è
possibile, venga a Vienna, La prego! Mi scriva subito E...] "
Wittgenstein, quindi, tornato dalla prigionia decide di diventare maestro. E, già trentenne, viene
iscritto nel 1919 a frequentare il quarto anno dellIstituto di formazione per insegnanti
(Lehrerbildungsanstalt) che era situato nel 3° distretto, sulla Kundmanngasse. Il 5 luglio del 1920
riceve il diploma di insegnante elementare.
Il periodo che va dal ritorno dalla prigionia all'assunzione come maestro è per Wittgenstein uno dei
più infelici della sua vita.
"Le mie condizioni esterne sono molto tristi e mi logorano nel morale. E non ho neanche niente a
cui appigliarmi. L'unica cosa buona che adesso ho è che spesso a scuola e leggo favole ai bambini.
A loro piace e per me costituisce un sollievo. Ma per il resto va proprio male al suo Ludwig
Wittgenstein"
"Adesso sono finalmente maestro di scuola elementare In un paese molto piccolo e carino che si
chiama Trattenbach".
"Il mondo dei felici è altro da quello degli infelici", leggiamo nel Tractatus. E Wittgenstein si sentì
rinascere allorché iniziò la sua attività di maestro.
(...)"Il lavoro a scuola mi fa felice, ed è per me necessario; altrimenti mi si scatena l'inferno dentro.
Come mi piacerebbe rivederLa e parlarLe di nuovo!!! Molte cose sono accadute; ho intrapreso
alcune operazioni che sono state molto dolorose, ma sono andate bene."
Wittgenstein inizia a fare il maestro a Trattenbach il 16 settembre del 1920. E questo lavoro, sulle
prime, fa rifiorire in lui un po'di speranza. Ma questo stato non dura a lungo. E se è vero che "Il
mondo dell'uomo felice è un mondo felice", è anche vero che il mondo dell'uomo infelice è un
mondo infelice.
(...) Con la data del 7 marzo 1953, quindi non molto tempo dopo la morte di Wittgenstein, giunge al
direttore della scuola elementare di Trattenbach una lettera dall'Università di Chicago. La lettera
portava la firma di F. A. Hayek, "un lontano parente di Wittgenstein ", il quale desiderava sapere
"se in quelle contrade fosse rimasto un qualche ricordo dell'attività di Wittgenstein maestro di
scuola". Hayek voleva più precisamente sapere "sulle circostanze della sua vita, del suo successo
come maestro e del suo rapporto con gli abitanti del luogo".
Ebbene, questa lettera, tra l'altro, suscitò la curiosità della Signora Luise Hausmann, insegnante di
inglese a Neunkirchen. E proprio all'impegno della signora Hausmann dobbiamo quello che è oggi
il miglior documento sull'attività di Wittgenstein come maestro. Questo documento è lo scritto della
Hausmann dal titolo: Wittgenstein als Volkssclzullehrer.
175
Durante una riunione di maestri, la Hausmann chiese a costoro se sapessero qualcosa di
Wittgenstein. E, in effetti, tra i sedici maestri presenti ce ne erano due che ne sapevano qualcosa. E
la risposta di un signore non si fece attendere: Wittgenstein era "un giovanotto totalmente pazzo,
che voleva introdurre l'alta matematica nelle nostre scuole elementari".
E un'altra insegnante, la signora Geler, disse: "Lo vidi unicamente nelle nostre riunioni di maestri,
durante le quali stava in perfetto silenzio. E noi sentivamo che egli era molto, ma molto superiore a
tutti noi"
Questo, tuttavia, era troppo poco. E la Hausmann, dopo una serie di tentativi, sulla strada della sua
ricerca, ebbe la fortuna di incontrare Oskar Fuchs, calzolaio in Trattenbach, che da bambino era
stato allievo di Wittgenstein. E proprio da Fuchs, Luise Hausmann riuscì a capire che "tipo di
insegnante fosse stato Wittgenstein"
."Wittgenstein era un asceta. Uomini come lui passano per pazzi, ma non si dovrebbe affatto
giudicarli con le misure normali".
Così, dice Luise Hausmann, cominciò la narrazione dei suoi ricordi sul grande e famoso filosofo, lo
sconosciuto e piccolo filosofo Oskar Fuchs, calzolaio di Trattenbach, allievo di Wittgenstein dal
1920 al 1922.
La fisionomia di Wittgenstein, scarno e una figura di media altezza, era nota a tutti, poiché egli era
solito passeggiare spesso, sempre con il bastone, con una giacca a vento con il collo aperto, lo
sguardo puntato lontano. Quando pioveva, portava un berretto da marinaio che gli scendeva fin
sulle spalle. Una volta che gli si offrì l'inattesa occasione di andare, con un contadino, dal dentista a
Kirchberg, Wittgenstein si avvolse un asciugamano intorno alla testa, a mo' di turbante.
Wittgenstein non mangiava in trattoria.
I bambini gli portavano da mangiare da una casa di contadini.
E per questo servizio ricevevano sempre dei piccoli doni. Ogni giorno gli portavano anche un litro
di latte.
La gente di Trattenbach ben si ricorda di quando Wittgenstein riparò il motore a vapore della
fabbrica tessile del paese. Il motore si era rotto. E gli ingegneri parvero trovarsi davanti ad un
mistero. La macchina doveva, quindi, venire smontata per essere portata a Vienna. Wittgenstein
venne a sapere della cosa e chiese se poteva dare uno sguardo al motore. Il direttore della fabbrica,
un cecoslovacco, disse bonariamente: "Diamogli la soddisfazione. Se gli ingegneri non ci sono
riusciti, egli ci riuscirà ancora di meno". Senonché, con la più grande meraviglia di tutti,
Wittgenstein trovò il difetto, riparò la macchina e la fece rifunzionare. Come ringraziamento il
direttore gli voleva dare alcuni metri di stoffa. Ma Wittgenstein rifiutò e chiese della stoffa per i
bambini. E l'ottenne.
Erano i ragazzi a portargli ogni giorno, come già si è detto, un litro di latte. E Wittgenstein aveva
nella sua stanza una scatola di lucido con dello spirito per far bollire il latte. Egli era generoso con i
suoi allievi. Comprava i libri ai ragazzi poveri. E portava loro in regalo le scarpe. E faceva tutto
questo, riferisce Luise Hausmann, in modo del tutto non appariscente. Un giorno, sua sorella, gli
mandò un cesto di arance, frutta che a quel tempo era ancora una rarità, specialmente in un paese
così piccolo e sperduto. Ebbene, ogni bambino ebbe un'arancia, e i più bravi due arance.
A Puchberg si legò di profonda amicizia con padre Alois Neururer, parroco del paese. E che tipo di
uomo fosse Neururer, è dimostrato da un significativo episodio. Un minatore stava morendo. Il
parroco andò da lui, ma l'uomo lo rispedì a casa, in quanto non attribuiva nessun valore ai conforti
della chiesa. Ebbene, di questo "ateo" Neururer disse: "Egli era un uomo onesto".
L'attività di Wittgenstein a Trattenbach, confermò Fuchs alla Hausmann, non fu capita. "Egli si
muoveva in un'atmosfera troppo alta e non gli riuscì di abbassarsi.
In uomini come lui, lo sviluppo spirituale procede così velocemente che essi dimenticano gli stadi
precedenti,
sui quali così tante persone si fermano.
Era troppo severo come maestro; si curava non troppo dei poco intelligenti e non risparmiò, quando
176
fu necessario, le percosse. Fu così che contro di lui si formò una congiura in piena regola. Ed egli
disse:
"Se voi siete contro di me, questo non fa niente per me, qualora voi siate d'accordo tra di voi. Con
voi è finita"
(...)
"Un giovanotto totalmente pazzo che voleva introdurre l'alta matematica nelle nostre scuole
elementari"; "sentivamo che era molto, molto superiore a tutti noi":
così ricordavano Wittgenstein due suoi ex colleghi appena alcuni anni fa.
E Luise Hausmann, nella sua bella ricerca su Wittgenstein maestro di scuola elementare, asserisce
che: "la gioia, l'entusiasmo di Wittgenstein nel donare il suo sapere ai suoi scolari non conosceva
limiti. Fuchs, che peraltro era tra i suoi migliori scolari, si ricorda in special modo degli stili
architettonici, di algebra, di scienze naturali.
Un giorno, Wittgenstein entrò in classe con uno scoiattolo morto,
e qui in classe questo venne sezionato a regola d'arte secondo tutte le sue parti interne. Una
ragazzina svenne. E dovette uscire.
Wittgenstein aveva portato con sé da Vienna un microscopio che veniva usato per osservare gli
stami dei fiori e il sangue.
Durante le serate più chiare, egli, insieme ai suoi piccoli assetati di sapere, usciva fuori, per indicare
loro le costellazioni.
In una certa occasione, Wittgenstein e i suoi scolari salirono
sino alla cappella che è su in montagna,
e là con l'aiuto del sole e del bastone stabilirono il grado di latutudine.
Non c'era tempo per la ricreazione. La lezione proseguiva initerrotta e i bambini dovevano ascoltare
mentre mangiavano.
Fuchs si ricorda molto bene del fatto che il suo maestro si dava ogni cura nel portare i bambini a
farli cercare da se stessi, quel che in qualche modo era possibile che cercassero. (...)
177
Un anno a Pietralata
Albino Bernardini
(La nuova Italia)
(...) Il cartaio in cattedra.
Non riuscendo ad uscire con la classe dal muro di cinta che limitava il nostro spazio, ad un certo
punto cominciai a far venire in classe qualcuno per trattare argomenti che potevano interessare i
ragazzi. Ne parlai prima con loro più volte, l'accoglienza fu piuttosto fredda, contrariamente alle
loro abitudini: si entusiasmavano, infatti, per qualsiasi cosa nuova. La discussione con persone
estranee alla scuola non li attirava. Quando poi, dopo tanta fatica, riuscii a trovare un operaio
disposto a venire a parlare di come si fabbrica la carta, sorse immediatamente un ostacolo: come
farlo entrare in classe?
La scuola che dovrebbe essere centro di vita, e quindi strettamente legata, almeno per certi aspetti,
alle attività della società che la circonda, veniva isolata come un penitenziario. Gli estranei, cioè
tutti coloro che non erano maestri, alunni o persone di servizio venivano sempre guardati con una
certa diffidenza, quasi portassero in seno a noi la zizzania più nefanda. Se le classi non fossero state
raggruppate in un unico caseggiato, sarebbe stato più facile risolvere il problema; per giungere alla
mia aula si doveva però passare in portineria, attraversare il corridoio e salire le scale: impossibile,
quindi, giungerci senza una regolare autorizzazione. D'altronde l'esperienza mi diceva che anche
questo mio tentativo sarebbe caduto nel vuoto, se avessi seguito la via della legalità.
Avrei corso il rischio di sentirmi ripetere lo stesso ritornello: "Ma lasci correre! Che importa a
questi bambini di certe cose? Interessante è che in quinta sappiano scrivere una letterina senza errori
e leggere senza balbettare. Crede forse che qualcuno dei suoi alunni possa seguire domani un corso
superiore di studi? Anche se avesse tutte le capacità e la volontà, non lo potrebbe per via
dell'organizzazione della scuola italiana. Tutte le sue iniziative, che per la verità sono
lodevolissime, non c'è che dire, che magari andrebbero benissimo in una scuola del centro, qui le
ritengo sprecate. Lasci perdere, non vada a caccia di guai!..."
Imboccai quindi la strada della clandestinità, l'unica che mi permettesse di realizzare il mio intento
di introdurre a scuola l'operaio, con una scusa qualsiasi, e quindi fargli fare la lezione. Quando il
cartaio entrò nell'aula, subito si fece un gran silenzio. Fu squadrato da capo a piedi e poi si cominciò
a chiacchierare sotto voce, finché pian piano i commenti non furono facilmente comprensibili. A
suo tempo, avevo messo in guardia l'operaio dicendogli che qualsiasi cosa fosse successa non se la
sarebbe dovuta prendere a male, giacché si trattava di una scuola del tutto particolare, e gliene
spiegai il motivo. Vedere in cattedra uno che non riconoscevano quale maestro, evidentemente non
convinceva i bambini e quindi li infastidiva. Così, prima ancora che l'operaio iniziasse a parlare di
come si produce la carta, si cominciò a protestare: <<Sor maè, ma che ce frega de sapè come sé
lavora>>, disse Beppe. <<A scola se deve da venì pè imparà a scrive, nun a fa a carta>>, fece
Roberto. <<Che, devo fa er cartaro! Quanno so grande farò er pittore, come mi padre!>>
Chi però passò la misura fù Sandro, che mi mise veramente in imbarazzo, perché avevo paura che la
cosa trapelasse fuori.
Sarebbe stato più facile in tal modo aggiungere alle critiche delle prove concrete. <<Sor maè>>,
disse, <<ma che ne sa lui? Se n'ha fatto le scole, vor di ché ignorante come na cucuzza! Mbè!
Allora!>>, e si sedette soddisfatto della sua uscita, guardandosi attorno per avere i consensi che non
gli mancarono. L'operaio mi guardò imbarazzato abbozzando un amaro sorriso, mentre gli alunni
sghignazzavano, come per rifiutare decisamente questa innovazione. Sapevo che non dovevo
perdere la calma e perciò anch'io sorrisi alla battuta di Sandro, pregandolo di non esagerare e allo
stesso tempo precisando ancora quale era il compito dell'operaio. Dopo avremmo scritto su quanto
ascoltato. (...) <<Posso parla, sor maè?>>, chiese Luciano.
<<Parla, avanti, ma non perdiamo tempo>>.
<<Mo' ce faccio venì mi padre e ce fa vede lui come se piallano 'e tavole>>.
Tutti risero, mentre io cominciavo a spazientirmi.
178
<<Se venisse non sarebbe mica male!>>, risposi.
<<Mo' anch'io>>, disse il nanetto, <<fo venì mi madre pe' face vede come s'allevano 'e galline e i
cuniji>>.
<<An vedi oh! A stronzoo! Iiih! Uh! Bum!>>.
<<Mo ce so' pure i cuniji!>>.
<<Beh, la smettiamo di fare dello spirito!>>,gridai seccato alzandomi. Si fece silenzio e il cartaio
cominciò a parlare un po' imbarazzato. (...)
179
Un cielo dipinto di blu
di Jean Ure
(E.Elle)
(...)All'epoca non avevamo la professoressa Rowe, e in quel caso fu una vera fortuna. (...) La volta
che Sara esordì scrivendo sul compito la data sbagliata,
la Rowe la gelò proprio con un commento del genere. Eh, sì, il sarcasmo è la sua miglior virtù.
Per esempio, ci chiama sempre, e sottolineo sempre, per nome: mai un soprannome o un
vezzeggiativo. La mia diagnosi e che, sotto sotto, voglia evitare un atteggiamento troppo
amichevole nei nostri confronti. Dice la prof: - Voi non abbreviate il mio nome. Perché io dovrei
abbreviare il vostro?
A proposito della Rowe la nonna direbbe che <<abbaia, ma non morde>>. Come se fosse facile,
abbreviare la parola Rowe! Qualche volta Sara la chiama Rosy, naturalmente a distanza di
sicurezza, quando non c'è pericolo che la prof possa sentire. Mi piace, la Rowe. E una tipa in
gamba, mi sta simpatica. E poi è corretta. Per lei gli alunni sono tutti uguali, non ha un occhio di
riguardo per qualcuno in particolare, odia i favoritismi, usa con tutti lo stesso metro di giudizio.
Vorrei tanto che anche lei fosse invitata allo show dedicato alla sottoscritta. C'è da dire che la mia
prof non è una che si tira indietro. L'anno scorso, per esempio, quando sono stata ammalata è venuta
a trovarmi. E stata una delle poche.
Quando l'ho raccontato a Sara, lei ha fatto la faccia disgustata e mi ha garantito che se mai dovesse
assentarsi da scuola per motivi di salute, per nulla al mondo vorrebbe ricevere la visita della Rowe.
- Brr, quella ti fa gelare il sangue nelle vene! - ha detto. Invece è stata molto carina con me, e per
una volta ha lasciato a casa il suo sarcasmo.
Mi ha regalato un bellissimo libro, una raccolta di foto che ritraggono ballerine e ballerini famosi,
più una foto cartolina di Darcey Bussel con scritto sul retro <<guarisci presto>>.
Chi glielo ha detto che Darcey Bussel è la mia ballerina preferita?
Forse ha curiosato nel mio armadietto, e ha scoperto le foto che ho appeso alle pareti.
Sarà, però rimane il fatto che ha comprato quella cartolina per me, e solo per me. Nessun altro lo
avrebbe fatto. E così mi sono resa conto che la sua freddezza e la sua severità sono soltanto
apparenti, come Sara, che ride sempre e sembra che tutto le scivoli addosso mentre invece non è
così. (...)
180
Un regno di donne
Cechov
(...) Vennero poi gli alunni della scuola di cui ella era curatrice. Avevano i capelli rasati e portavano
delle bluse grigie come uniforme. Il loro maestro, un giovanotto alto e ancora imberbe, col viso
chiazzato di rosso, visibilmente confuso, mise in fila gli alunni, i quali cantavano senza sbagliare
ma con voce sgradevole, stridula. Il direttore della fabbrica (...) non era mai in buoni rapporti coi
maestri, e senza una ragione disprezzava e detestava il maestro che stava lì, a segnare il tempo,
agitandosi. Lo trattava con alterigia e villania, ritardandogli gli onorari, inframmettendosi nel suo
lavoro di maestro; e perché se ne andasse, due settimane prima delle feste fu nominato custode della
scuola un lontano parente di sua moglie, un contadino ubriacone, che non dava retta al maestro e gli
diceva delle parolacce in presenza degli scolari.
Anna Akìmovna sapeva tutto ciò, ma non poteva farci nulla (...). Volle almeno incoraggiare il
maestro, dirgli che era molto soddisfatta di lui; ma quando, finito il canto, egli cominciò, tutto
confuso, a scusarsi di non so che cosa, e sua zia dandogli del tu lo condusse verso il tavolo, si sentì
annoiata e a disagio.
Dopo aver raccomandato di distribuire dolci ai bambini, sali nelle sue stanze.
"In queste usanze festive c'è in fondo molta crudeltà," si disse poco dopo, guardando dalla finestra i
fanciulli che, andandosene via intirizziti, si rimettevano camminando il soprabito. "Nei giorni di
festa ci si vuol riposare, e i poveri piccini, e il loro maestro, e gl'impiegati, sono invece costretti a
uscire col gelo, a fare dei complimenti, a mostrarsi rispettosi e a disagio." (...)
181
Un ritratto
Federico Tozzi
Era maestra elementare. Aveva un rocchio di capelli che sarebbe bastato almeno per due donne,
rossi e grossi; il viso giallo, sparso di lentiggini che pareva una pelle di sughero;
gli occhi strabici e con lo sguardo da bove; una bocca così larga che non riesciva mai a chiuderla
perché se tentava di farlo da un lato, allora dall'altro lato le pendeva anche di più, tutta sgualcita. Il
naso schiacciato con due buchi fatti come due forellini da aghi. Le spalle tirate in su, fin quasi alle
orecchie; benché non fosse gobba.
I piedi enormi; quando camminava teneva i tacchi accanto e le punte in fuora.
Aveva un sudore che si sentiva a parecchia distanza.
Era restata come istitutrice nell'educandato dove l'avevano accolta da bambina.
Ma voleva essere la più elegante di tutte; e quasi ogni giorno, perciò, aveva un vestito nuovo. Ella si
teneva da molto; e soltanto al direttore della scuola faceva gli occhi dolci. Allora posava la penna e
si metteva ad odorare i fiori che teneva lì preparati sul tavolino. Ma la dolcezza dei suoi occhi non
veniva fuori che a mezzo; ed ella alla fine non ci riesciva più, il suo viso s'irrigidiva a metà di una
parola. Anche i fiori sembravano irrigidirsi entro la sua mano. Allora ella si confondeva e si
smarriva; credeva di essersi compromessa tanto più che non riesciva a ricomporsi. Le veniva una
saliva ai denti cariati e sporchi. Poi impallidiva; e i fiori ricadevano sul tavolo. Ella allora piangeva.
Ma quando il direttore ripassava risorrideva tra le lacrime mandandosi indietro quei capelli grossi
come lo spago; sentendo con angoscia, che una ciocca gliene ricadeva sempre su un orecchio e che
ormai non era più in tempo a riaggiustarsi. In quei momenti credeva che avrebbe potuto essere
amata; mentre quel viso giallo sotto alle trecce rosse, certe trecce di canape greggia, faceva schifo.
182
Una lezione di lingua tedesca
Neera
Et je fis deux heureux à la fois!
(Béranger)
Raccontate - io dissi - ed egli incominciò:
Compivo a Bergamo l'ultimo anno di liceo quando, stimolato da un amico, mi posi in capo di
studiare il tedesco e lo stesso amico s'incaricò di scegliere il professore - un professorone coi fiocchi
certamente, un Anderbuchen o un Vlandisbachen colla barba, cogli occhiali e con tutto lo scibile
umano nel cervello. "Vieni" mi disse un giorno l'amico prendendomi sottobraccio, "voglio
presentarti alla fonte eccelsa dove noi beveremo a ondate, a fiotti, a torrenti la tedesca sapienza".
Prendemmo la salita di città - e su e su lungo i Torni che serpeggiano a guisa di spira sul cocuzzolo
della montagna.
"Dove diavolo mi conduci?".
"Il genio abita sempre in alto, le vette o il quinto piano. Il primo piano e le valli sono per la gente da
poco, per gli infelici banchieri carichi di reumatismi, per i milionari idioti, razza plebea che non
comprende la voluttà dell'aria libera, del cielo spazzato".
"E di quindici lire al mese per il fitto".
Eravamo giunti.
L'amico bussò a una casetta piccina e bianca che dominava da un letto di verdura tutta la valle del
Brembo; aveva davanti un giardinetto pieno di rose e a tergo i picchi di granito vestiti di muschio.
Vi si respirava l'idillio - ma io me lo guastai anticipatamente pensando alla barba del professore caso morale e pratico per dimostrare che a guastarsi le idee si è sempre a tempo!
Comparve una giovine signora bionda, grassottella, con un nastro ceruleo intorno alla vita.
"Guten Tag!" diss'ella inchinandosi con una mossa franca e leggiadra.
"Madamigella" rispose il mio amico, "noi siamo totalmente stranieri alla lingua di Goethe. Voglia
permetterci di salutarla in italiano".
Ella biascicò qualche parola italiana facendosi rossa, per mio conto capii più il rossore che le parole.
"Vittorio" dissi piano al mio amico, "costei è la figlia del professore?".
"Stupisci e impara. E' il Professore stesso".
Stupii sùbito - l'insegnamento venne dopo...
Un professore in gonnella! che larga prospettiva di istruzione volontaria e di scienza applicata per
due studenti! In quell'istante avrei pagato dieci lire un frammento di specchio e le avrei pagate tanto
più volentieri perché ciò implicava la supposizione che le dovessi avere. L'amabile maestrina ci
chiese se volevamo incominciare subito la lezione.
Vittorio mi consultò collo sguardo, a dir vero ci aspettava
il ripetitore di fisica con un tema preparato sull'attrazione dei corpi celesti - ma qual corpo potevasi
immaginare più celeste di quella ventenne giovinetta, fresca come il mattino e raggiante come un
sorriso ?
Attrazione per attrazione, Vittorio ed io non stemmo in forse.
Cinque minuti dopo si sedeva tutti e tre attorno a un tavolino lungo un metro e largo sessanta
centimetri.
Ella era la maggiore, noi toccavamo appena i diciotto anni - e vi domando cosa si fa, con
cinquantasei anni in tre, attorno a un tavolino!
Credo che per quel giorno non abbiamo veduto altro che il cartone della grammatica - ma in
compenso avevo osservato i bellissimi denti e la manina morbida di madamigella Wilhelmine.
Nei giorni che seguirono fu una gara tra Vittorio e me per arrivare i primi alla lezione; accadeva di
correre trafelati ambidue per strade opposte e di batterci il naso sulla porta della casetta solitaria.
Allora si prendeva un'aria seria: "Come hai anticipato!".
"Anzi tu!".
"Ti aspettavo".
183
"Ti cercai dovunque".
Sulle prime ella ci accoglieva gentilmente senza parzialità, ma mi parve notare che i suoi occhi
diventavano oltremodo teneri quando correggeva sul mio foglio il verbo Lieben.
Eravamo giunti alle piccole frasi e Wjlhelmin accentava con sentimentale languore: Mein Herz
seufzt unbekantes Wohl - il mio cuore sospira un bene ignoto.
Anche il mio cuore incominciava a sospirare un bene.. non troppo ignoto a dir vero - tuttavia
nemmeno notissimo; non vorrei mi pigliaste per uno scapestrato.
Io ero allora in quel periodo fortunoso della prima giovinezza che bene si può rassomigliare all'alba
- il sole non è sorto ancora ma non è più notte.
Sentivo una dolce commozione quando la bella Tedesca mi guardava, o quando, sotto al piccolo
tavolo, accadeva uno scontro più o meno involontario di ginocchi. il focherello prendeva a poco a
poco le proporzioni d'una fiamma.
Un giorno, fatto ardito dalla circostanza che Vittorio raccoglieva per terra alcune penne cadute e
quindi non Poteva vedermi, mi impadronii della mano di Wilhelmine e la strinsi con tutto l'ardore
d'una dichiarazione appassionata. Ella ritirò la mano, ma pochi momenti dopo scriveva sul mio
quaderno: Eure Augen gefallen mir: e siccome avevo il dizionario davanti, tradussi senza fatica: mi
piacciono i vostri occhi.
Che potevo desiderare di più? Gli occhi sono la via del cuore e se alla bella prima madamigella
Wilhelmine imbroccava la via giusta, io dovevo considerarmi senz'altro il più felice dei mortali frase consacrata per l'uso speciale degli innamorati in estrema cottura. (...)
184
Una storia così
Silvio D'Arzo
(Ed. Diabasis)
(...)
1. Nel quale si fa conoscenza di un uomo curioso, e poi di un altro uomo curioso, e poi di un'idea
più curiosa di tutti e due messi insieme.
Il signor Tobia Corcoran dirigeva da più di vent'anni il "Premiato Collegio Minerva". E fin qui
niente di strano, d'accordo. Centinaia di persone dirigono da più di vent'anni un premiato Collegio e
nessuno si prende la briga per questo di indicarli per strada col dito: a meno che proprio non si
decidano a uscire un bel giorno portando la giacca a rovescio.
(...)
Il suo lato strano era un altro: aveva in testa soltanto un'idea. (E non una alla volta, intendiamoci:
no, il signor Tobia Corcoran sotto il suo vecchio cappello aveva quella e poi quella soltanto. E non
sospettava nemmeno che qualche altro potesse pensarla in modo diverso dal suo, perché anche
questa sarebbe stata un'idea, e lui invece ne aveva una sola).E alla domenica, poi, com'è giusto e
come vuole perfino la legge,
le concedeva libera uscita: dimodoché, per ventiquattr'ore precise, in testa non aveva più neanche
quella. E così stava meglio del solito.
Ed ecco qui la sua idea:
"Uno studente dai sei anni in avanti non può compiere azione più immorale,
malvagia, spregevole, pericolosa, allarmante che leggere libri che non siano i tre libri di testo. E a
sua volta un maestro dai vent'anni in avanti non può compiere azione più infamante, allarmante,
pericolosa, spregevole, malvagia, immorale
che far leggere libri che non siano i tre libri di testo. Per non aver nessun dubbio in proposito, i tre
libri di testo sono tre:
1) Trattato di geometria e d'aritmetica, del signor Tobia Corcoran;
2) Trattato di grammatica, del signor Tobia Corcoran;
3) Trattato di analisi logica, del signor Tobia Corcoran.
Durante i cinque minuti di riposo agli alunni è concesso di ricrearsi guardando le figure
geometriche. Tenuto conto però dell'indole particolarmente esuberante dei giovani alunni e in via
del tutto eccezionale il signor Tobia Corcoran emerito quanto modesto direttore da più di ventanni
del "Premiato Collegio Minerva", si benignerà all'occorrenza di derogare dalle norme su esposte: e,
se i ragazzi lo avran meritato durante l'intero anno scolastico, l'ultimo giorno di Carnevale sarà in
grande allegria festeggiato con la lettura in classe di 'Una mia visita alla raffineria di zucchero nella
provincia di Portland' del signor Tobia Corcoran".
Questo, per dirvi che tipo.
Si capisce che con un tipo del genere un maestro riusciva a resistere un anno a dir molto (non
bisestile, però, attenti bene).
E così ad ogni anno il maestro cambiava.
(...)
Ma quell'anno al "Collegio Minerva" capitarono l'una sull'altra due memorabili cose: prima, si
presentò in qualità di maestro supplente al Collegio il signor Teddy Ted, uomo pieno di espedienti e
risorse: seconda, il direttore Tobia s'ammalò.
E in che modo lo avrete già immaginato da voi. Per due domeniche in fila si dimenticò di conceder
la libera uscita alla sua vecchia idea, e questo era molto di più di quel che potesse sopportare il
brav'uomo: e così gli venne l'esaurimento nervoso, e finì col mettersi a letto.
Prima di mettersi a letto, però, ebbe il tempo di afferrare dal comodino una ricetta prescritta dal
medico e sul rovescio scrisse queste parole: "Due volte al giorno analisi logica, almeno cinque
185
pagine per volta, sei per i ripetenti. Mezz'ora di geometria e d'aritmetica subito dopo mangiato.
Niente libri, niente libri e soprattutto niente libri."
E la fece consegnare al Maestro.
Il Maestro, però, com'è d'uso, lesse solo la parte davanti, quella scritta e firmata dal medico, che
diceva esattamente così:
ESAURIMENTO NERVOSO. SI PRESCRIVE UNA CURA DI FOSFORO.
Strano, però, pensò il signor Teddy Ted. E siccome in quel momento era solo e nessuno poteva
vederlo, si diede anche una grattatina di testa Non avrei mai e poi mai sospettato di aver
l'esaurimento nervoso. E poi il signor Corcoran non ha fatto in tempo a vedermi. Curioso! Ma io
sono solo un Maestro Supplente; mentre invece il signor Corcoran è nientemeno che Direttore di
Scuola e perfino proposto per la Croce di Merito. E' chiaro che ne sa più di me". Così, senza perdere
tempo, cominciò a fare la cura di fosforo; e se fin dalla nascita era pieno d'iniziative, risorse e
espedienti, figuriamoci allora. La sua prima prova fu questa. Il Maestro covava in cuore da anni
l'idea di scrivere un grosso romanzo, per comprarsi un vestito decente, di quelli che non fan voltare
la gente per strada, o, se non proprio, almeno la giacca: ma non ne aveva trovato mai il tempo. Ed
invece ecco pronto il rimedio.
Il giorno dopo fece scendere tutti quanti i ragazzi in giardino: li portò proprio dietro lo stagno, dove
alberi e siepi eran più fitti e più folti che mai, e distribuì un libro a testa.
- Ecco qua. Per un mese non farete altro che leggere questi: lo prescrive il nuovo programma. Ogni
sera, però, attenzione a riportarmeli indietro, e, badate, non ad altri che a me. E adesso, buon
appetito.
Nascosta in fondo al solaio aveva scovato per caso la biblioteca scolastica.
2 Dove si vengono a imparare piùcose che in cinque anni di scuola (sei per i ripetenti).
Si capisce che molte cose cambiarono. I ragazzi non facevano che leggere e leggere, e giocare a
quel che avevano letto: ed eran tutti più allegri che mai. Il signor Teddy Ted non faceva altro che
scrivere e scrivere ed era già arrivato comodamente alle tasche della sua giacca nuova, cioè a pagina
20-21. Dimodoché era anche più allegro di quelli.
Ma c'era anche dell'altro.
Tutte le sere, non appena i ragazzi riportavano i libri al Maestro, e lui usciva per andarsi a ispirare,
nella stanza di questi si ripeteva la medesima scena.
Il primo a sbucar fuori era Tarzan. Per prima cosa dava un'occhiata all'intorno, poi lanciava il suo
grido, e, appendendosi alle tendine spiccava di colpo un gran salto e si portava fin sopra la lampada.
A quel segnale uscivano dopo un po' tutti gli altri: Alice, col suo Coniglietto, Pinocchio, i tre
Porcellini, la Bella Addormentata nel Bosco, Mowgly, Davide Copperfield, il piccolo Lord
Fauntleroy, Topolino, i Nani di Gulliver, John Silver, Jimmy Hawkins, il dottor Jeckill e Robinson
Crusoe, e, insomma, un bel sacco di gente. (...)
186
Una strana primavera
Angelo Petrosino
Tratto da "Il giornale dei bambini che leggono e scrivono" nr. 2, Aprile 1992
Una mattina Giorgio si mise a guardare Florence in silenzio. Florence era la sua maestra. In quel
momento stava facendo l'appello e segnava i nomi degli assenti sul registro. Giorgio notò che gli
occhi di Florence erano più profondi e più luminosi del solito. Il sole entrava dalle veneziane
socchiuse e nuotava con allegria nelle sue pupille. Ma accarezzava anche i suoi capelli ricciuti e
metteva in evidenza la grana minuta della sua pelle. Florence era ancora giovane e la sua fronte era
priva di rughe. Le sue guance erano lisce e morbide e Giorgio ricordava di averle viste arrossate
solo nei giorni in cui il freddo era pungente. Altrimenti erano di un rosa tenero e puro. Florence,
d'altra parte, non si truccava mai. Non metteva nemmeno il rossetto sulle labbra. Le labbra di
Florence erano piene e increspate e somigliavano a due mezze fragoline selvatiche.
- Giorgio? - disse in tono interrogativo Florence.
Giorgio aprì la bocca e volle dire: "Presente". Ma ne venne fuori un suono smorzato che non sentì
nessuno.
- Giorgio? - ripeté Florence, che alzò la testa dal registro e lo fissò stupita. - Perché non rispondi?
- Presente, - bisbigliò Giorgio, con uno sforzo enorme. Florence gli sorrise, scosse la testa e andò
avanti con l'appello. Giorgio continuò a guardarla di sottecchi e si chiese perché Florence quella
mattina era diversa. Nel corso delle prime due ore si alzò spesso dal posto e andò a chiederle
infinite spiegazioni. - Sono davvero stupita, Giorgio, - gli disse ad un certo punto Florence. - Questi
problemi sono facilissimi e tu non hai mai avuto difficoltà a risolverli. Che ti succede?
Giorgio alzava le spalle, la fissava ostinato negli occhi e aspirava il profumo di rose che sembrava
emanare dal suo corpo.
- E' giusta questa trasformazione con la virgola? - chiedeva.
- Mi fai una domanda del genere alla fine della quarta? - gli chiedeva a sua volta Florence, prima di
rispondere.
Giorgio avrebbe voluto che in quel momento le dita di Florence si insinuassero tra i suoi capelli,
come facevano quando lei glieli arruffava per gioco. Ma quella mattina Florence non lo fece. Nel
suo sguardo c'erano stupore e sconcerto. Durante l'intervallo nel cortile della scuola, Florence gli
chiese: - Perché non vai a giocare a pallone con gli altri? Siamo in aprile e c'è un bel sole.
Approfittatene per togliervi dal viso il pallore che vi ha lasciato l'inverno.
- Vorrei stare un po' con te. Posso? - chiese Giorgio.
- Certo che puoi. Anzi, potresti dirmi se c'è qualcosa che non va. Stamattina in classe eri molto
strano.
Giorgio le si strinse al fianco e chiuse gli occhi.
- Cos'hai? Sei in cerca di coccole oggi? Non vuoi proprio dirmi cosa ti succede?
- Non mi succede niente, - mormorò Giorgio.
- E invece qualcosa ti succede. Ma non sei obbligato a dirmi niente, se non vuoi.
Il golfino di lana che Florence indossava era come un cuscino morbido sul quale Giorgio
abbandonò la testa. -Tu ci vieni volentieri a scuola? - le chiese Giorgio all'improvviso.
- Che domanda! Il mio mestiere mi piace. Non si vede, forse?
Giorgio si staccò da lei, la guardò negli occhi e disse: - Per me le ore che passo a scuola sono le più
belle della giornata. Io verrei a scuola anche con la polmonite.
- Rischieresti di morire, - disse ridendo Florence. - Non te lo consiglio, per il tuo bene.
A Giorgio non piacque la sua ironia, e s'incupì.
Quando Florence lo vide rabbuiarsi in viso lo attirò a se e gli disse: - Oggi non accetti nemmeno due
parole scherzose. L'ho detto io che c'è qualcosa che non va.
Giorgio non disse niente e abbandonò la testa sul seno di Florence. Le grida dei compagni gli
arrivavano fioche e il suo orecchio destro pulsava ai battiti tranquilli del cuore di lei. Da quel
giorno, Giorgio cercò tutte le occasioni per stare con Florence. Aspettava con ansia soprattutto i
minuti degli intervalli, quando trascurava i compagni e andava a passeggiare con lei sotto il
187
porticato della scuola. In quei momenti avrebbe voluto allontanarsi dalla vista degli altri bambini e
delle loro insegnanti.
Perciò, le prime volte, la prese per mano e la spinse lungo le ali della scuola meno frequentate.
Florence, però, si era rifiutata di seguirlo.
- Devo tenere sottocchio i tuoi compagni, gli aveva detto.
Giorgio si era rassegnato a malincuore e non aveva più avuto il coraggio di insistere. Avrebbe
voluto parlare a lungo con Florence, ma non poteva farlo davanti a tutti, in mezzo al chiasso che
riempiva il cortile. Inoltre, passeggiando sotto il porticato frequentato dalle altre insegnanti, Giorgio
aveva già dovuto sorbirsi le loro frecciatine ironiche e i loro stupidi commenti. Cos'ha questo
bambino da stare attaccato come una ventosa alle gonne della maestra? Dov'essere proprio senza
fondo la miniera di segreti che le racconti! Se te ne stessi con gli altri della tua età, non sarebbe più
normale? Su, ragazzina corri a divertirti.
A queste odiose espressioni, Giorgio aveva un giorno risposto per le rime. - Fatevi i fatti vostri e
lasciatemi in pace, - aveva detto.
- Perdiana! - aveva esclamato una vecchia maestra, rivolgendosi a Florence con una faccia grinzosa
e una voce scandalizzata.
- Spero che quando tornerai in classe punirai a dovere questo screanzato. Se lo avessi con me,
proporrei al direttore di lasciarlo a casa almeno un paio di giorni, per fargli calmare i bollenti spiriti
che sembrano agitarlo.
In quell'occasione, Florence aveva cercato di giustificarlo Giorgio è un bambino molto sensibile.
Forse è un po' cresciuto per la sua età. Per questo è assai curioso, fa un sacco di domande e vuole
discutere con i grandi.
- Già, però di grandi sembri esserci soltanto tu - aveva detto un'altra maestra.
- Mi sembra naturale, - aveva detto Florence. - Io sono la sua insegnante. Con chi volete che abbia
più confidenza?
- Secondo me gliene dai fin troppa - aveva continuato quella. - Questi bambini sono una lagna e ti si
attaccano addosso come zecche. Non so come fai a sopportarlo. Io me ne sarei sbarazzata con una
bella strigliata.
A quel punto Florence non aveva più replicato, però aveva riferito a Giorgio quella conversazione e
lo aveva esortato a giocare più spesso con i suoi compagni. Allora Giorgio le aveva scritto una
lettera. Perché non te ne infischi delle altre maestre?
Non vedi che stanno sempre a spettegolare? (...)
Perplessa, continuò la sua passeggiata sotto il porticato. Quando vide affacciarsi le altre maestre,
fece uno scarto e si nascose dietro un pilastro di cemento.
Ben presto, tuttavia, Giorgio dovette fare i conti non solo con le insegnanti, ma anche con i suoi
compagni di classe. Soprattutto con Franco, Roberto e Giuliano, che avevano preso male la sua
defezione dalla squadra e lo avevano invitato invano a riprendere il suo ruolo nelle partite che
disputavano con le altre classi durante gli intervalli in cortile. Mi fanno male le gambe, Mi gira la
testa, Mi viene da vomitare, erano state le scuse di Giorgio, per restare con Florence e sottrarsi agli
impegni di squadra. - Mi sembri una femminuccia, - gli aveva rinfacciato Roberto. - Ho male qui,
ho male lì, ho male là.
- La verità è che ti sei stufato di giocare con noi, - gli aveva detto Giuliano, che con la sua zazzera
rossa e il suo naso a becco aveva tormentato Giorgio sin dal primo giorno che si erano conosciuti a
scuola. Giorgio sospettava che Giuliano fosse semplicemente invidioso di lui. Giorgio, infatti, era
bravissimo in tutto. Giuliano, invece, non riusciva a mettere insieme nemmeno tre righe. Ad ogni
modo, per mettere fine a quelle proteste e a quelle punzecchiature insistenti, Giorgio aveva deciso
di inventarsi una grave malattia.
- La settimana scorsa, mia madre mi ha fatto visitare da uno specialista, - disse un giorno ai
compagni .-Purtroppo abbiamo scoperto che c'è qualcosa che non va nel mio cuore. In conclusione,
mi è stato proibito di correre e di affaticarmi. Dunque non posso nemmeno giocare a calcio. Sulle
prime, i tre erano rimasti a bocca aperta.
Sembravano decisamente impressionati dalla notizia e non sapevano cosa dire. Poi, però, Giuliano
aveva avuto un guizzo cattivo negli occhi, aveva dimenato la testa, si era fatto una gran risata e
188
aveva detto: - E voi gli credete? È un'altra scusa delle sue per non giocare con noi. Lui la testa non
ce l'ha più al pallone, perché preferisce metterla tra le poppe della maestra.
Boccheggiando di rabbia, Giorgio gli era andato addosso a testa bassa. Giuliano aveva perso
l'equilibrio, ma prima di rotolare a terra aveva reagito d'istinto e con un calcio aveva colpito Giorgio
nella pancia. Franco e Roberto erano scattati per solidarietà con il compagno e Giorgio era stato
sommerso da una gragnuola di pugni, di schiaffi e di calci che lo avevano lasciato intontito e
sanguinante.
Mentre lo medicava in infermeria, Florence gli ripeteva: - Allora, vuoi dirmi com'è successo?
Perché vi siete picchiati in modo così forsennato? Guarda qui, hai anche un labbro spaccato.
Giorgio faceva fatica a trattenere i singhiozzi che gli chiudevano la gola, e non rispondeva. - Perché
tre contro uno, poi? - insisteva Florence. - Sei stato tu a provocarli? Non posso crederci. Non vuoi
rispondere? - Eppure bisogna che io sappia, perché a tua madre dovrò pur dire qualcosa per
giustificare questi graffi e questi cerotti.
- A mia madre dirò che sono inciampato mentre correvo... Mi crederà, - si affrettò allora a
rispondere Giorgio, che voleva dimenticare presto l'occasione di quella batosta.
Florence, però, non lo aveva lasciato andare senza prima parlare con la madre, che era venuta a
prenderlo in auto. Anzi, aveva finito col salire in macchina anche lei e aveva accompagnato Giorgio
fino a casa.
- Venga signorina, - aveva detto la madre di Giorgio. - Era da un pezzo che volevo invitarla a
prendere una tazza di tè da noi. So che Giorgio la stima molto. Io purtroppo sono sempre impegnata
col mio lavoro di pubblicitaria e ho avuto finora scarse occasioni per parlare con lei. Approfittiamo
di questo infortunio per fare due chiacchiere. Vuole?
- Mi dispiace - aveva detto più tardi Florence, mentre sorbiva il suo tè, indicando con la testa
Giorgio che se ne stava acquattato silenzioso in poltrona.
- Oh, non si preoccupi - aveva detto la madre di Giorgio. - Sono bisticci di ragazzi. Sa, io non ci
faccio troppo caso, come è invece abitudine di molte madri. Secondo me i ragazzi devono imparare
a sbucciarsi le ginocchia e a rompersi la testa. L'importante è che ne vengano fuori senza troppi
danni.
- Il fatto è che è la prima volta che gli succede - aveva detto Florence.
- È vero - ammise la madre di Giorgio, lanciando un'occhiata al figlio. - Giorgio è in genere un
bambino tranquillo, anche se un po' sognatore. Finora non mi ha dato eccessive preoccupazioni. È
una fortuna per me. Suo padre, infatti, in casa si vede poco. Fa l'ingegnere aeronautico: un mestiere
che a lui piace molto, ma che lo tiene sul chi vive in varie parti del mondo.
- Allora Giorgio è spesso solo in casa - aveva osservato Florence.
- Sì, ma lui sa cavarsela benissimo. Vero, tesoro? - aveva chiesto la donna al figlio, con un sorriso
compiaciuto.
Giorgio aveva continuato a guardarsi la punta delle scarpe e non aveva risposto. Florence era
riuscita subito simpatica alla madre di Giorgio. Perciò di tè pomeridiani ce ne furono altri.
Una sera Florence fu addirittura invitata a cena.
- Mi fa piacere che abbia accettato - disse la madre di Giorgio accogliendo Florence sulla porta. Giorgio era fuori di sé dalla gioia quando gli ho parlato della mia intenzione di invitarla. Si è solo
raccomandato che non lo sappia nessuno dei suoi compagni di classe.
Giorgio si era affacciato nel corridoio e contemplava Florence ammutolito, come se la vedesse per
la prima volta.
- Vorrei farti vedere la mia camera - le disse.
- Volentieri - disse Florence, che gli diede la mano e lo seguì.
- Ecco, questa è la mia scrivania, questo è il mio letto, questi sono i miei libri e questo è un
Pinocchio di legno che mi ha regalato mio padre. E poi voglio farti vedere un'altra cosa.
Giorgio si avvicinò al cassetto del suo comodino da notte, lo aprì e ne tirò fuori un quaderno blu
bordato di rosso. Lo mostrò a Florence e le disse: - Questo è il mio diario personale. Non ho mai
detto a nessuno di averlo, perché mi vergogno.
- Come mai? - Perché i diari li tengono solo le bambine.
- Non è mica vero. Mio fratello ne ha tenuto uno per alcuni anni.
189
- Davvero?
- E' così. Vorresti leggerlo?
- No. Non mi piace mettere il naso nei segreti degli altri. A meno che non mi sia proposto dai diretti
interessati. Ma anche in quel caso, esito. Non vorrei proprio che poi si pentissero di avermeli
rivelati.
- Che cosa vuoi dire? Che non sai mantenere i segreti?
- Al contrario. So conservarli come in una cassaforte. Specialmente se si tratta dei segreti di un
bambino. Giorgio la fissò e non disse nulla. Indugiò qualche attimo con il suo quaderno tra le mani,
poi andò a riporlo nel cassetto. - Sono contento che sei venuta - disse stringendo Florence alla vita
con le braccia.
- Tua madre è stata gentile ad invitarmi e non c'erano motivi per rifiutare. Del resto, per
un'insegnante è molto utile vedere l'ambiente in cui abita un alunno. Dopo, si capiscono molte più
cose di lui.
- Ah, sì? E adesso che hai visto la mia camera, cos'hai capito in più di me, che prima non
conoscevi?
Florence fu sorpresa dalla domanda rivoltale in un tono tra il serio e lo scherzoso, e rimase a
guardare Giorgio in silenzio.
-Io... dicevo così in generale - rispose infine prendendogli il viso tra le mani. - Secondo me, ti
conoscevo bene anche prima di vedere la tua camera. Mi racconti tante cose di te.
- Tante, ma non tutte, - mormorò Giorgio.
- Hm, ritorniamo ai segreti. Se proprio vuoi raccontarmeli, sono disposta ad ascoltarti.
- Vieni, accomodati su questa poltrona vicino alla finestra - le disse Giorgio tirandola con una
mano. - Io mi ci siedo tutte le volte che leggo un libro. I miei libri più belli li ho letti acquattato su
questi cuscini imbottiti.
- Davvero molto comoda - disse Florence sprofondandoci.
- Ci si sta benissimo anche in due - osservò Giorgio con un tremito nella voce. E aggiunse: - Posso
sedermi vicino a te?
Florence si spostò di lato, allungò sulle ginocchia le falde del suo vestito a fiori e gli fece spazio
accanto a sé.
- Ecco, disse, siediti pure.
- Quanti anni hai? - le chiese Giorgio.
- In genere le donne non amano dire la loro età. Ma io non ho nessuna difficoltà a rivelarti questo
mio segreto. Ho ventotto anni.
- Davvero? Sembri molto più giovane.
- Non si può dire che non sai fare i complimenti a una donna - disse Florence sorridendo e
arruffandogli i capelli.
- Non l'ho detto per farti un complimento. È perché mi sembri davvero molto più piccola. Per me, tu
è come se fossi una ragazza.
- Be', anche ai complimenti c'è un limite. Non bisogna mai strafare. Una ragazza! Ricordati che,
dopotutto, io sono la tua insegnante e tu sei un mio alunno.
- Perché dici che sono un tuo alunno? -. - Perché, non è vero forse?- Io sono un tuo amico -. - Certo. Ma prima di tutto sei un mio alunno -.
- Non mi piace che mi chiami alunno. (...)
A tavola quella sera Giorgio parlò poco. Si limitò a guardare di sottecchi Florence e a seguire i
movimenti della sua forchetta. Florence mangiava a piccoli bocconi e masticava a lungo, al
contrario di lui, che divorava tutto in fretta.
Quella sera, tuttavia, Giorgio mangiò pochissimo. (... )
190
Verità su una maestrina
Giorgio Scerbanenco
da Maestrine (Sellerio 1981)
Fu solo verso la fine della lezione che una ragazzina del secondo banco, la più alta, si alzò in piedi,
e con voce incerta, timida, da ottenne, eppure come impositiva, domandò: - Perché la nostra
signorina maestra, la signorina Rossana, non è venuta? Perché è venuta lei?
La supplente, la signorina maestra Aureliana Bassi guardò negli occhi la bambina, e tutte le altre, e
sentiva che la stessa domanda gliela rivolgevano tutte le sedici bambine, forse.
Fu tentata di rispondere: "Perché ha l'influenza", ma la sua fantasia di maestrina ventenne e la sua
commozione, ebbero il sopravvento.
- Perché si è sposata - rispose.
La ragazzina alta, sensitiva ma energica, disse: - Se andava a sposarsi ce lo avrebbe detto.
- Non poteva dirlo - spiegò paziente, inventando,
la giovane supplente, e con quel fondo di pianto in gola, guardando tutti quei visi di bambine
all'alba della vita, - ha dovuto nasconderlo a tutti perché i suoi genitori non volevano.
Allora,
d'improvviso, è andata via col suo fidanzato e questa mattina si sono sposati -.
Lo raccontò come una favola,
cercando di rimandare indietro quel conato di pianto.
- Si sono sposati a Roma, e sono andati a vedere il Colosseo, questa mattina avete visto alla
televisione il Colosseo, ecco, sono andati lì.
Anche le bambine della seconda elementare sono sensibili alle storie di amore contrastato, e le
capiscono benissimo.
Nel frusciante, piacevole rumore di pioggia di primavera che veniva dal cortile della scuola, la
supplente arricchì di particolari adatti all'infantile immaginazione la storia della maestrina e del suo
sposo: le bambine amavano moltissimo - l'aveva subito capito - la loro maestra Rossana e lei voleva
che ne avessero l'immagine migliore.- E quando torna a scuola? - domandò l'altra ragazzina.
- Ci vuole un po' di tempo, bambine - disse la supplente, - adesso deve preparare tutta la casa,
perché gli
sposi si fanno una casa nuova, tutta per loro - spiegò,
finché la campanella della fine della lezione non la
salvò e la bidella entrò per aiutare le bambine a incolonnarsi e a uscire.
- Non è vero -.
In quarta fila, quella bambina brunetta e olivastra, senza alzarsi, con un pesante accento milanese,
aveva quasi gridato. - Ha raccontato tutte storie.
Non si sono sposati. Dovevano sposarsi, poi
invece lui se ne è andato con un'altra, e allora la signorina Rossana si è asfissiata col gas. Papà me
l'ha fatto vedere ieri sera sul giornale, mi ha detto: "Ma questa non è la tua signorina maestra?", e io
ho visto la fotografia e ho detto: "Sì, è la mia signorina maestra", e allora ho letto anch'io la storia
sul giornale...
- Stai zitta, Mirella - disse amara la supplente, stringendo i denti per non piangere.
Aveva tentato di coprire con un fantasioso velo rosa la verità, ma non vi era riuscita.
-Stai zitta, basta.
- Ha aperto il gas e si è ammazzata. C'era sul giornale - insisté la brunetta.
- Mettetevi in colonna, bambine - disse la bidella. La ragazzina alta, che aveva fatto la prima
domanda, si mise in colonna, le labbra, il mento, le tremavano. - - E vero? - ripeteva. - E vero?
- In colonna, bambine - disse la bidella.
191
Zazie nel metro
Raymond Queneau
(Einaudi)
(...) Gabriel si voltò verso Marceline, che sorrideva. Lo vedi come ragiona bene, a quell'età? C'è da
chiedersi se val la pena di mandarla a scuola.
Io, dichiarò Zazie, a scuola voglio andarci fino a sessantacinque anni.
Fino a sessantacinque anni? ripetè Gabriel, un pocolino sorpreso.
Si, disse Zazie, voglio far la maestra.
Un mestiere punto male, disse Marceline, con dolcezza. E poi, c'è la pensione. Queste ultime parole
le aggiunse automaticamente, perché conosceva bene la lingua francese.
Pensione un c..., disse Zazie. Farò la maestra, ma non è per la pensione.
No, certo, disse Gabriel. Si capisce. Perché allora? (...) Spiegacelo. Non ci arrivi da solo, eh? Ci va
un po' forte, eh, questa gioventù d'oggi, disse Gabriel a Marceline. E a Zazie: Allora? Perché vuoi
far la maestra?
Per romper le balle alle bambine, rispose Zazie. Quelle che avranno la mia età fra dieci anni, tra
vent'anni, tra cinquant'anni, fra cento anni, fra mille anni. Aver sempre da romper le balle a
qualcuno.
Bene, disse Gabriel.
Voglio esser carogna. Gli farò leccar l'impiantito. Mangiar la cimosa della lavagna. Gli metterò i
compassi nel didietro. Pedate nel sedere. Porterò gli stivali. D'inverno. Alti così (gesto). Con gran
speroni per scorticar la ciccia delle chiappe. Sai, disse Gabriel con calma, stando a quel che dicono i
giornali, non è proprio in codesta direzione che si sta orientando l'educazione moderna. Anzi, è
proprio il contrario. Si va verso la dolcezza, la comprensione, la gentilezza. E' vero, Marceline, che
dicono cosi sul giornali? S¡, rispose Marceline, con dolcezza. Ma te, Zazie, ti hanno trattato male a
scuola?
Ci mancava altro. E poi, disse Gabriel, fra vent'anni non ci saran più maestre: saranno sostituite dal
cinema, la tivù, l'elettronica, cose del genere. C'era scritto anche sul giornale, l'altro giorno. Vero,
Marceline?
S¡, rispose Marceline, con dolcezza. Zazie, per un attimo, prese in considerazione quell'avvenire.
Allora, dichiarò, farò l'astronauta. (...)
192
Scarica