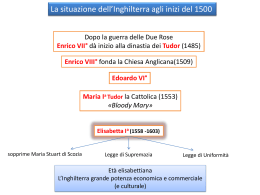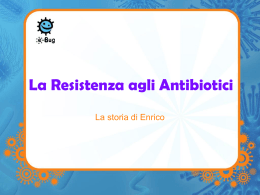a Giacomo, Tommaso e Michele Valeria Conti illustrazioni di Amalia Tucci © 2007 Edizioni Lapis Tutti i diritti riservati Edizioni Lapis Via Francesco Ferrara, 50 00191 Roma tel: +39.06.3295935 www.edizionilapis.it e-mail: [email protected] ISBN: 978-88-7874-053-2 Progetto grafico e impaginazione: Manuela Cordella Finito di stampare nel mese di febbraio 2007 presso Grafica Nappa (Aversa) Edizioni Lapis CHI SONO… Sigmund Freud Ha dieci anni, occhi scurissimi e capelli neri dai riflessi blu. Viene da una famiglia di religione ebraica. La sua materia preferita sono le scienze ed è appassionato di scacchi. È convinto che in ognuno di noi ci sia una parte di cui siamo coscienti e una, più profonda, che non conosciamo. Dopo qualche anno diventerà, come sappiamo, il padre della psicanalisi. Egitto, anno 1866 Enrico Pagani Bello, impetuoso e distratto. È nato a Triste, ma vive a Vienna con la sua famiglia. È compagno di scuola di Sigmund e il suo spirito d’avventura lo trascinerà in un’indagine spionistica. Emma Pagani Sorella di Enrico, si sottopone docilmente alle domande di Sigmund. Lui riuscirà a liberarla da un ricordo traumatico. Maria Cuoca triestina della famiglia Pagani, è grossa, robusta e dispotica. Tata Istitutrice triestina di Enrico e Emma, è dolce, giocherellona e si cuce degli abiti che riescono sempre un po’ storti. Avvocato Pagani Padre di Enrico e Emma, ha la passione per i reperti archeologici egizi e per il sigaro: passioni che da grande coltiverà anche Sigmund. Settembre 1866 L’ingegnere francese a capo dello scavo per il Canale di Suez stava rovistando disperatamente tra le sue carte. L’ufficio sembrava un campo di battaglia, c’erano documenti sparsi un po’ dappertutto, i grandi rotoli del progetto per la costruzione del canale erano aperti sul pavimento. «Disparue, disparue», mormorò il francese con la mani nei capelli, poi a voce più alta passò all’italiano, per farsi capire dal collega. «Scomparsa, la variante che l’ingegner Negrelli aveva aggiunto al progetto originale non si trova più!». «È quello che temevo. Da giorni tengo d’occhio uno degli operai. È stato lui a rubare la variante, ne sono sicuro, e sono sicuro che l’ha consegnata agli austriaci», rispose l’ingegnere italiano. «Gli austriaci? E adesso cosa c’entrano gli austriaci? Cosa gliene importa agli austriaci della costruzione del Canale?». «Del Canale gli importa poco, ma gli importa di Negrelli. L’ingegnere era trentino, e Trento è austriaca, adesso». 5 Il francese continuava a guardare l’italiano senza capire niente. «La situazione è complicata, da spiegare», tagliò corto l’italiano. «Accontentati di sapere che posso attivare una rete di uomini per recuperare quella variante del progetto. Il capo dei lavori sei tu, mi basta una tua parola». L’ingegnere francese continuava a non capire un’acca. Solo una cosa gli era chiara: l’italiano sapeva molto più di quanto diceva e aveva modo di riavere la variante. «Attiva quello che ti pare, basta che fermiamo la sabbia che sta rifluendo nel Canale, o tra un mese ce l’avremo fino al naso! Di questo passo la costruzione non sarà mai terminata». «Parlerò con i miei contatti. Sicuramente gli austriaci spediranno la variante in Austria, ma dovranno per forza fare tappa in un porto italiano. Lì interverremo noi, abbiamo uomini fidati in ogni angolo. Dobbiamo solo scoprire su quale nave sarà imbarcata la variante e in quale nascondiglio». L’ingegnere francese si afflosciò, distrutto, su una sedia. «Quanto tempo ci vorrà?». «Un mese o due. Non è un’operazione semplice». La nave, un bastimento commerciale decrepito, proveniva da Alessandria. La “Cleopatra” era arrugginita e sporca, a bordo, a parte l’equipaggio, nessun passeggero. Una donna castana, sui quarant’anni, osservava attentamente le manovre di attracco attraverso spesse lenti da miope; era immobile sul molo di Genova, nonostante il freddo e la nebbia. Tra poco i marinai, con gli abiti trasandati e la barba lunga, avrebbero cominciato a scarica- 6 re la stiva della nave. Poi tutta la merce sarebbe passata alla dogana. Dopo qualche ora di snervante attesa, la donna entrò negli uffici doganali. L’impiegato, un membro dell’organizzazione, aveva già portato a termine la sua missione: cambiare il nome del destinatario e il numero di registrazione sul pacco appena scaricato dalla “Cleopatra”. Era bastato trasformare un tre in un otto, un sette in un uno, e contraffare qualche lettera: il plico, imbarcato ad Alessandria, non risultava che fosse mai arrivato a Genova. Gli austriaci non lo avrebbero mai rintracciato. Gli uffici erano gelidi e semideserti, vi regnava un perenne odore di pesce marcio. «Buongiorno, devo ritirare un pacchetto», disse la donna con il suo accento dell’Italia del nord. Consegnò il suo documento, era falso: il nome che vi era scritto era la parola d’ordine. «Giovanna Archetti», lesse il doganiere guardandola fisso negli occhi. La donna annuì. L’uomo le consegnò il pacco del quale l’organizzazione aveva seguito le tracce con tanta fatica. Lei lo prese e uscì. Dei rivali austriaci neanche l’ombra, per una volta erano stati battuti sul tempo. Era un pacco di media grandezza, avvolto in carta marrone e legato con lo spago. Aveva l’aspetto di un plico qualunque, non era pesante. La donna camminava nervosa con l’oggetto sottobraccio e andò dritta a casa. Appena entrata, senza neanche togliersi il cappotto, strappò la carta, sotto c’era una scatola. La aprì. All’interno, avvolto in molti sottili fogli di carta velina, un oggetto di legno colorato. «Cos’è, un pollo?», mormorò tra sé. Poi si alzò sulla fronte gli occhiali da miope, avvicinò la statuetta al naso 7 e guardò con più attenzione. Era senza dubbio un volatile, ma aveva il becco di un falco. Se lo rigirò tra le mani. Poggiava su una base: una cassettina di legno nero. Eccolo il nascondiglio! L’aprì. Dentro c’era un foglio. Vedendolo, la donna tirò un sospiro di sollievo. Lo rimise al suo posto. «Lo porterò a destinazione», sussurrò decisa. 21 novembre 1866 Ore 12,40 Le strade di Vienna erano affollate, signore con eleganti e lunghi vestiti dal colletto di pizzo, giovani fattorini dei negozi che recapitavano la spesa a domicilio, tate in uniforme con i bambini per mano. Gli zoccoli dei cavalli sul lastricato della strada producevano un suono allegro, le carrozze coperte, quel novembre del 1866 era stato pieno di pioggia e il clima era già rigido, trasportavano i clienti ai loro appuntamenti. Due ragazzi di dieci anni tornavano da scuola, sulle spalle le pesanti cartelle di cuoio zeppe di libri. Sigmund e Enrico chiacchieravano allegramente e uno gesticolava frenetico. Non avrebbero potuto essere più diversi: il primo era pallido, con i capelli così scuri da avere riflessi blu, e due acutissimi occhi neri; Enrico, molto più alto e magro, aveva grandi occhi verdi, il viso regolare, era impetuoso e questo aspetto del carattere si rifletteva nei lungi riccioli castani, che nessun pettine riusciva a domare. «Il tuo errore è stato muovere l’alfiere», stava dicendo Sigmund, commentando la loro ultima partita a scacchi 8 9 giocata durante la lezione di geografia del decrepito e miopissimo Prof. Schwider. Erano appena usciti dal Communal-Realgymnasium, in parole povere il ginnasio, che frequentavano dall’anno precedente; Sigmund Freud era invitato a pranzo a casa di Enrico, di famiglia triestina. Lui andava spesso dall’amico a fare i compiti, il pomeriggio; la casa gli piaceva, era grande, Enrico aveva una camera tutta per sé, e dai Pagani la merenda arrivava dalla più famosa pasticceria di Vienna. Oggi, però, il ragazzo era un po’ preoccupato, non gli capitava spesso di essere invitato a pranzo senza i genitori e sua madre gli aveva imbottito la testa di raccomandazioni. Enrico stava difendendo con calore la strampalata strategia scacchistica che l’aveva portato alla rovinosa sconfitta, quando Sigmund vide arrivare una carrozza a tutta velocità. Trattenne l’amico impedendogli di finire sotto gli zoccoli del cavallo; Enrico, che non si accorse del pericolo corso, continuava a gesticolare. La carrozza passò schizzando fango, i ragazzi attraversarono la strada ed entrarono nel portone numero 10 della Herrenstrasse, a pochi passi dalla pasticceria Demel, di cui i Pagani erano fra i più affezionati clienti. Salirono di corsa l’ampio scalone che portava all’appartamento della famiglia. «Molla quel panino al sesamo». «Tu fatti gli affari tuoi». A tavola Enrico e suo fratello minore stavano litigando, fu necessaria un’occhiataccia del padre per metterli tranquilli. Emma, invece, la sorellina di nove anni, non aprì bocca per tutto il pranzo, in senso letterale perché non mangiò niente. A Sigi era sempre piaciuta quella ragazzi- 10 na dolce e allegra, ma oggi lei sembrava strana, lontana, assente. La madre le lanciava occhiate preoccupate, ma davanti all’ospite non disse niente. Enrico, dopo il battibecco con Claudio, si mise a chiacchierare con l’amico, senza degnare più di uno sguardo i fratelli. Il padre di Enrico era un famoso avvocato, pieno di impegni, in famiglia voleva tranquillità, soprattutto per poter chiacchierare a ruota libera con il suo tonante vocione. Aveva lasciato Trieste cinque anni prima, desideroso di fare carriera nella capitale dell’impero austro-ungarico. Trieste, come Trento, apparteneva all’Austria e all’avvocato Pagani, uomo intraprendente, non andava di restare confinato alla periferia dell’impero. Lui voleva vivere e lavorare nella città più importante ed effervescente di tutta Europa. Gli italiani, nel frattempo, erano riusciti a unificare quasi tutta l’Italia, e solo pochi mesi prima, con la Terza Guerra d’Indipendenza, avevano annesso anche il Veneto. Trieste e Trento erano rimaste escluse; erano italiane per lingua e storia, ma all’avvocato Pagani importava poco: a lui bastava vivere in una città frenetica e mondana, e questo era possibile a Vienna più che in ogni altra città europea. La madre di Enrico era una signora molto gentile, elegante e con le mani cariche di anelli, sempre assalita da dubbi ed incertezze. Questa volta non fece eccezione. Quando la cameriera Lottie portò in tavola un fumante arrosto di maiale con patate al forno, la signora Pagani impallidì. «Che sbadata! Sigi, devi perdonarmi, solo in questo momento mi sono ricordata che sei ebreo, non mangi maiale, ti faccio portare del formaggio? Ci è arrivata una forma di latteria da Trieste». 11 «Non si preoccupi», si affrettò a rispondere Sigmund, che aveva già l’acquolina in bocca, «nella mia famiglia non siamo osservanti, e non mangiamo kasher». «Non mangiate che?», domandò Claudio. «Gli ebrei devono seguire certe regole per la preparazione del cibo», spiegò Enrico al fratello, con aria di superiorità. «Non credevo che Freud fosse un cognome ebreo», intervenne Emma, rompendo finalmente il suo silenzio. Sigi la guardò preoccupato, e se anche lei avesse avuto antipatia per la razza ebraica? Ma la frase era stata pronunciata senza malevolenza. La signora Pagani, con un sospiro di sollievo, aveva passato il vassoio all’ospite perché si servisse. «A parte mangiare roba strana, la vostra religione è molto diversa dalla nostra?», chiese Claudio con curiosità. «Noi non crediamo che sia arrivato il Messia, lo stiamo ancora aspettando. Per il resto, le differenze non sono molte». Sigmund tralasciò di dire al bambino che gli ebrei non erano ben visti a Vienna, in quegli anni, e che anche al ginnasio lui veniva spesso preso in giro o, peggio, escluso, per il solo fatto di appartenere alla razza giudìa. «Avete molti compiti, oggi?», tuonò l’avvocato Pagani. «Non più del solito», rispose Sigi. «Matematica!», gemette Enrico, il quale nelle materie letterarie teneva quasi il passo con Sigmund, ma in quelle scientifiche era una vera schiappa. «Spero che Sigi che avrà la pazienza di aspettarti, allora». «Lui è sempre gentile e mi aspetta sempre», rispose il ragazzo, il quale aveva tutta l’intenzione di copiare di sana pianta dall’amico e poi mettersi a chiacchierare con lui 12 della partita di calcio organizzata dalla scuola per il sabato seguente. La camera di Enrico era una stanza d’angolo con due grandi finestre. Da un lato c’era il letto, sull’altra parete una grande libreria piena di romanzi di avventura che lui aveva, in gran parte, già letto; tra i suoi preferiti quelli di Salgari, pubblicati solo pochi anni prima. Fra le due finestre, la scrivania. «Il nuovo professore di scienze non mi sembra male», stava dicendo Sigi mentre, stravaccato sul letto dell’amico, digeriva il pranzo. «Spero solo che non ci porti troppo spesso in laboratorio. Gli esperimenti sugli animali mi danno sempre un po’ di voltastomaco», aggiunse Enrico che detestava le scienze almeno quanto la matematica. «Sei matto? Il laboratorio è la parte migliore! Mi piacciono da morire quei banconi pieni di provette di vetro, becchi Bunsen, pinze e tutto il resto dell’armamentario! Non dirmi che preferisci stare in classe!». «Preferisco starmene stravaccato a leggere un bel romanzo! Lo so che scienze è la tua materia preferita. Io la detesto, mai un esperimento che riesca, finisco sempre per bruciacchiare tutto, e la puzza poi è irrespirabile». Mentre i due amici chiacchieravano, si sentì lo sbattere violento di una porta. «È sparita, ti dico, sparita!», era la voce del padre di Enrico che stava urlando queste parole. «Non è possibile, ti sarai sbagliato, guarda meglio», cercava di consolarlo la moglie. «Dovrei essere miope come una talpa per non vedere una statuetta di legno colorato a forma di falco che stava 13 nel bel mezzo della mia scrivania!». «L’ultimo acquisto di mio padre» spiegò Enrico all’amico, «spende una fortuna in antiche statuette egizie, ne ha lo studio pieno. Vieni, cerchiamo di capire quanto è grave la situazione». A giudicare dal viso congestionato dell’avvocato, la faccenda era davvero molto grave. Nello studio si era riunita tutta la famiglia, con l’eccezione di Emma: la signora Pagani cercava disperatamente ovunque, Claudio stava tra i piedi della madre, intralciandola, Enrico chiedeva informazioni al padre: «Quando hai visto la statuetta l’ultima volta?». «Ieri dopocena, quando ho fumato l’ultimo sigaro qui nello studio», rispose l’avvocato Pagani, ansimando per l’agitazione. «La cameriera ha pulito la stanza, questa mattina?». «Gliel’ho chiesto poco fa, Lottie dice che ha pulito e spolverato, ma non ricorda se la statuetta c’era o no». Mentre padre e figlio parlavano, Sigmund ebbe modo di guardarsi intorno. La stanza era più piccola e meno luminosa di quella di Enrico, piena di librerie e vetrine ricolme di statuette. Là dentro si aveva la sensazione che mancasse l’aria, un po’ per i molti tappeti sparsi per la stanza, un po’ per il forte odore di sigaro che vi aleggiava. I ragazzi decisero di aiutare la signora Pagani nella ricerca del reperto archeologico. «È un falco con il dorso e le ali dipinte di rosso, il muso e il petto bianchi, con qualche striscia nera. Poggia su una base che sembra una cassettina, in effetti è la scatola in cui gli egizi mettevano le viscere del defunto, che venivano mummificate a parte». Sigmund era affascinato da un oggetto che racchiudeva in sé tanta storia e si mise a perlustrare la stanza pieno 14 15 di curiosità, mentre l’avvocato Pagani gemeva sconsolato per la perdita del suo ultimo, prezioso acquisto. Dopo una ricerca approfondita, Enrico si arrese: «Inutile continuare, abbiamo guardato in ogni angolo. Il falco non c’è». Un forte gemito dell’avvocato fece eco a queste parole. «Non mi resta che andare a denunciare il furto alla polizia», affermò con la sua voce profonda il padre di Enrico, sconsolato. «Furto?», saltò su la signora Pagani. «I ladri in casa nostra?». «La porta era chiusa, questa mattina?». La signora Pagani fu assalita dai soliti dubbi. «Mi sembra, forse, non saprei…». «E la finestra di questa stanza?», insistette Sigi. La madre di Enrico lo guardò angosciata. Non aveva la più pallida idea se le finestre fossero state aperte o chiuse, quella mattina. Il padre, sbuffando e gemendo, si preparava ad uscire per andare alla stazione di polizia, e Enrico tirò Sigi per la manica, segno che voleva parlare con lui in privato. Quando i ragazzi si trovarono soli in camera, Sigi disse: «Mi dispiace molto per tuo padre». «Ti dispiace?» ribatté Enrico. «Ma è una cosa esaltante, non lo capisci? Abbiamo un vero mistero per le mani. Un furto in casa nostra! Finalmente qualcosa di eccitante!». «Ma la statuetta dev’essere costata un sacco di soldi», rispose Sigi. «Niente paura, la troveremo!» affermò con sicurezza Enrico, che non aveva ereditato l’amore per il dubbio di sua madre. 16 «Noi chi, scusa?». «Noi, voglio dire tu ed io, che te ne pare? Condurremo un’indagine, beccheremo colpevoli e statuetta». L’entusiasmo di Enrico era contagioso e, per quanto a Sigi la ragione suggerisse di essere prudente, era curioso e l’idea lo solleticava. «Non sappiamo neanche da che parte cominciare!», ribatté. «Certo che lo sappiamo. Cominciamo da dove si sa sempre tutto, dal cuore della casa, dal suo punto nevralgico: la cucina! Vieni, ti presento Maria, la nostra cuoca triestina, e il resto della servitù. Loro sanno sempre quello che succede», e preso Sigi per una manica della giacchetta, Enrico lo trascinò verso la cucina. La cucina era un’enorme stanza con mobili bianchi e con tutti gli strumenti che una cuoca poteva desiderare. Più che la stanza di un appartamento sembrava un laboratorio, era qui che i domestici si riunivano per i pasti, ma non c’erano angoletti comodi, tutto era asettico e funzionale. Capo indiscusso del laboratorio-cucina era Maria, la cuoca triestina che comandava su Lottie, e spesso anche sulla signora Pagani, con pugno d’acciaio. La donna era imponente, alta e grossa, il suo viso sempre arrossato aveva un cipiglio che incuteva un certo timore. Anche Enrico la temeva, infatti, entrando nella stanza, la prese alla larga. Presentò la cuoca al suo amico: «Maria Cumani, personaggio importante in casa nostra». La donna si limitò ad un cenno con la testa. «Mi chiamo Sigmund Freud», disse Sigi compito. Enrico continuò ad evitare l’argomento che gli stava a 17 cuore: «Mi andrebbe un bicchiere di latte». «Latte, adesso? Ma se hai appena finito di pranzare!» ribatté il donnone, «dì piuttosto che sei venuto a spettegolare». Il tono della donna era acido, ma Enrico conosceva bene il suo punto debole. «Davvero buonissimo l’arrosto di maiale, vero Sigi?», chiese con aria noncurante all’amico. «Ottimo», non ebbe difficoltà a riconoscere l’ospite. «E le patate erano le più croccanti che abbia mai assaggiato», 18 aggiunse. Era chiara l’intenzione di Enrico di adulare la cuoca, ma Sigi era sincero. La donna adesso aveva un’espressione molto più bonaria di prima. «E le mie mele cotte, ti sono piaciute?», domandò all’ospite con un mezzo sorriso. Ormai era evidente la tattica giusta: «Soffici, dolci con un retrogusto aspretto, e un fondo di cannella. È un delitto chiamarle semplicemente mele cotte, quelle erano un capolavoro, un trionfo!». 19 Maria aveva il viso ancora più rosso dalla soddisfazione. Enrico, senza farsene accorgere, rivolse un sorriso complice all’amico. «Lei è una cuoca che meriterebbe di stare nella cucina di un grande ristorante. Ancora non ho capito per quale fortuna preferisca lavorare in casa nostra». «Mi piace conoscere le persone per le quali cucino, in un ristorante non hai la possibilità di guardare in faccia i clienti, mentre assaggiano i tuoi piatti», spiegò la cuoca, il cui cipiglio, adesso, era del tutto sparito. Enrico pensò di aver ammorbidito abbastanza la donna e affrontò l’argomento che gli stava a cuore: «Sai niente della statuetta scomparsa dallo studio di mio padre?». «Non ho la più pallida idea di dove sia né di chi l’abbia presa, ma una cosa la so. Quella statuetta ha già creato scompiglio in questa casa e altro ne provocherà, prima che la storia si chiuda. Tanto per cominciare, Lottie è stata interrogata da tuo padre ed è, come il suo solito, scoppiata a piangere. Questi austriaci sono troppo sentimentali, piangono per un nonnulla. Anch’io l’ho messa sotto torchio, ma lei dice che non sa niente, non ricorda neanche se la statuetta era sul tavolo, questa mattina. Lottie è una cara ragazza, ma quando si sente messa sotto accusa, il suo istinto è di puntare il dito su qualcun altro. In questo caso su Tata». «Ha incolpato Tata?», domandò meravigliato Enrico. Sigi sapeva che Tata era l’educatrice che aveva il compito di insegnare il francese ai ragazzi Pagani e di rinfrescare l’ortografia italiana. I ragazzi la adoravano perché, messa da parte la grammatica, Tata era capace di rotolarsi per terra con loro, e con le sue abilissime mani riusciva a co- 20 struire giocattoli divertenti e a realizzare buffi costumi. Si vantava di cucirsi gli abiti da sola, e nessuno in casa aveva il coraggio di dirle che il risultato era scarso, le cuciture non le riuscivano mai dritte e i vestiti le stavano sempre a sghimbescio. «Proprio lei! Sembra, a dar retta a Lottie, che questa mattina abbia sorpreso Tata a ficcanasare nello studio di tuo padre». «Lei che cosa ha detto?». «Si è chiusa in uno sdegnato silenzio. Sostiene di essere troppo offesa per ribattere alle accuse. Adesso, però, dovrà escogitare qualcosa di meglio perché ci penserà la polizia ad interrogarla. Purtroppo interrogherà anche me: tutto tempo sprecato! Se poi la cena di stasera si brucia, non è colpa mia!». E colta da fretta professionale, Maria voltò le spalle ai due ragazzi e cominciò a battere la carne con vigore, le braccia robuste vibravano colpi terribili sotto i quali il tavolo della cucina tremava in modo spaventoso e le povere braciole furono ammorbidite senza pietà. 21 22 novembre 1866 Ore 8,10 La mattina seguente Enrico e Sigi si incontrarono prima dell’inizio delle lezioni nel cortile della scuola. Un cortile grigio, chiuso ai lati dai due piani in cui trovavano posto le aule; non c’era una pianta né un filo di verde, insomma, era un posto desolante. Restava, però, il luogo di incontro degli alunni prima della campanella di inizio e durante la ricreazione. I ragazzi, pur di chiacchierare in pace con i compagni, erano capaci di andarci anche in giornate di pioggia, tornando in classe gocciolanti e spandendo nell’aula quel tipico odore di cane bagnato che esala dai vestiti umidi. «Novità?», domandò Sigi all’amico appena lo vide. Enrico aveva l’aria molto abbattuta. «Le peggiori che tu possa immaginare». «Raccontami tutto» incalzò Sigmund, che moriva dalla curiosità, «ma con ordine, ti prego», aggiunse ricordando la foga caotica di cui Enrico era capace. «Dopo la denuncia di mio padre, verso le sei di sera, è arrivato un agente di polizia. Aveva una pancia così enor- 22 23 me che i bottoni dell’uniforme temevo scoppiassero da un momento all’altro, colpendo come proiettili tutti noi. Ha detto subito che, secondo lui, si è trattato di un furto “dall’interno”. Voleva dire che è stato qualcuno dei domestici, ma, se vuoi il mio parere, è una fesseria: lo ha detto solo perché non aveva voglia di svolgere indagini serie. Si è limitato a fare qualche domanda per sapere se la porta di casa era aperta o chiusa, come se non lo avessimo già chiesto noi!». «Ci ha cavato qualcosa di nuovo?». «Non molto: nessuno si ricorda se le finestre erano aperte o chiuse, la mattina, ma la porta d’ingresso era senza dubbio chiusa con il paletto. E per questo l’agente ha concluso che è stato un furto “dall’interno”!». «Il ladro o i ladri potrebbero essere entrati da una delle finestre». «Quello che dico anch’io! Un passo avanti però è stato compiuto: Lottie si è finalmente ricordata che la mattina, spolverando lo studio di mio padre, la statuetta non c’era». «Perché non ha dato subito l’allarme?», chiese Sigmund, interessato alla novità. «Perché, sostiene, non ci ha fatto caso. Il falco era sulla scrivania solo da un giorno, e quindi lei non aveva ancora l’abitudine di spolverarlo». «Secondo te è verosimile?». «Lottie ha sempre la testa tra le nuvole, sì, conoscendola, è possibile». «Perciò il furto sarebbe avvenuto di notte». «Esatto. Tra le dieci di sera, ora in cui mio padre è uscito dallo studio, e le nove della mattina, ora in cui Lottie ha spolverato». 24 «Il poliziotto non si è chiesto perché è stata rubata proprio quella statuetta? Non è un oggetto qualunque, viene dall’Egitto, appartiene a un’altra epoca, a un’altra civiltà. Un falco che poggia su una cassetta per viscere imbalsamate non l’ha incuriosito?». «Era un tipo così ottuso che non ci ha pensato neanche. Per lui, potevano aver rubato un paio di forbici da cucina, era lo stesso!». L’aria cupa dell’amico spinse il ragazzo a chiedere: «Non è tutto, vero?». Enrico scosse tristemente la testa. «Lottie ha raccontato all’agente di aver sorpreso Tata a curiosare nello studio. Quando il poliziotto le ha chiesto spiegazioni, Tata si è impappinata, diventando tutta rossa. Lei con le mani è abilissima, ma per tutto il resto è goffa, sbaglia sempre tono. Conclusione: la polizia ha perquisito camera sua». «Senza trovare niente». «Ha trovato eccome! Tata aveva degli opuscoli nazionalisti italiani, dove si sostiene che non sono le spartizioni politiche a tavolino a fare le nazioni, ma la loro storia, lingua e cultura. Tata ha la testa imbottita di ideali, è convinta che la nostra città dovrebbe essere italiana, dice che l’Italia dovrebbe essere unita, da Trieste alla Sicilia, passando per Roma. Non ne ha mai fatto mistero con noi ragazzi. La polizia si è limitata a confiscare tutto il materiale e ad interrogare Tata per quattro ore. Tutto sommato, è andata molto peggio con i miei genitori. Mio padre ama l’Austria e mia madre è un’adoratrice dell’Imperatore Francesco Giuseppe. Mamma si è messa a strillare che tenevamo in casa una traditrice dell’impero austriaco, un’ingrata. 25 «Attentava alla vita dell’imperatore» strepitava. «Un uomo che ci da ordine e sicurezza! Vuole la guerra con la nostra cara Austria, si sono alleati con i prussiani per schiacciarci! Sputa nel piatto in cui mangia, odiare l’Austria che ci ha dato tanto, ci ha dato… la torta Sacher!». «Su questo punto posso trovarmi d’accordo con lei», ammise Sigi, il quale aveva assaggiato solo una volta la famosa torta di cioccolata con gelatina di albicocche, ma era stata un’esperienza indimenticabile. La sua famiglia non nuotava nell’oro, e la torta, la cui ricetta era segretissima, costava una fortuna. «Insomma, tanto ha gridato che Tata, offesa, ha preso la sua roba e se n’è andata!». «Mi dispiace, so che tu e i tuoi fratelli le volete molto bene». In quel momento il bidello cominciò a tempestare la campanella di colpi, e Sigi e Enrico furono costretti a correre in classe, dopo aver preso accordo per vedersi il pomeriggio sul luogo del furto. Ore 16,20 Nello studio dell’avvocato Pagani, i due amici cercavano di mettere ordine nelle idee. Il poliziotto grassone, convinto che il ladro fosse qualcuno dei domestici, non aveva svolto indagini. Enrico non la vedeva allo stesso modo. «Secondo me, aveva solo voglia di sbrigarsi per andare a scolarsi una birra», sentenziò. «Uno non dovrebbe mai avere idee preconcette, quando svolge un’indagine», affermò Sigi. 26 «Allora, se non diamo niente per scontato, dobbiamo controllare ogni possibile strada che ladri “esterni” potrebbero aver percorso. Tu come avresti fatto, considerando che la porta era sprangata?». «Scusa se te lo dico, ma abbiamo appena deciso di non avere idee preconcette. La porta, al ladro, avrebbe potuto aprirla Tata». Enrico rifletté su questo fatto e poi dichiarò: «D’accordo, ritiro quello che ho detto, ho diritto alle mie belle idee preconcette. Tata è innocente e non ha aperto la porta a nessuno. A questo punto, l’unica soluzione è che il ladro sia passato da una delle finestre». Sigi rise. «Va bene. E dato che questo è un appartamento al terzo piano, andiamo in strada a dare un’occhiata al tubo della grondaia. È quello che avrà fatto anche il ladro, no?». I ragazzi corsero fuori e osservarono tutte le finestre di casa, mentre il portiere, incuriosito, non li perdeva di vista chiedendosi cosa stessero combinando. «Guarda la finestra dello studio!» esclamò Enrico. «Non solo il tubo della grondaia corre proprio accanto, ma si vedono distintamente due orme di scarpe impresse sull’intonaco, come se qualcuno avesse fatto leva sui piedi per issarsi sul davanzale e da lì entrare». Sigi guardò l’amico con aria interrogativa. «Io i due pestoni non li vedo», affermò. «Due impronte nere, molto evidenti, com’è che non le vedi?». Sigi si sforzò, ma scosse la testa. «L’insegna del panettiere in fondo alla strada, la leggi?». «Niente da fare», fu la sconsolata risposta. 27 «Ti consiglio di metterti un bel paio di occhiali da miope». E con questo suggerimento, accompagnato da un’affettuosa manata sulla spalla, i ragazzi rientrarono in casa. Nello studio dell’avvocato aprirono la finestra e, a distanza ravvicinata, anche Sigi poté osservare le impronte di due scarpe diverse. Non c’erano dubbi, qualcuno si era arrampicato per il tubo. «Magari erano solo gli operai addetti alla manutenzione delle grondaie». «E magari la statuetta ce l’ha mio padre sotto il guanciale e non se n’è accorto!» rispose Enrico, esasperato dalla puntigliosità di Sigi. «Dobbiamo accettare un fatto, e da lì partire». «Bene, partiamo. I ladri, le orme sono di due scarpe, sono entrati dalla finestra. Hanno preso la statuetta e sono ridiscesi per la grondaia. E ora cosa facciamo?». «Ci poniamo la domanda seguente». «Che sarebbe?». «Il cervellone che ha sempre una risposta per tutto sei tu». Sigi si guardò intorno cercando di ragionare. Lo studio era invaso da statuette e piccole opere d’arte, per lo più egizie, che potevano essere comodamente rubate. «Perché i ladri hanno preso solo quella particolare statuetta? Valeva più di tutte le altre messe insieme?», fu la domanda che gli venne spontanea alle labbra. «Non so, mio padre l’aveva pagata più o meno come ognuno dei reperti che vedi in questa stanza. Hai ragione, il ladro poteva prenderne molte di più. Quella era solo l’ultima arrivata della collezione». 28 «Dobbiamo scoprire che cosa aveva di tanto speciale», concluse Sigi. «Possiamo chiedere all’antiquario da cui mio padre compra i pezzi della sua collezione. Lui forse saprà dirci le caratteristiche della statuetta». In quel momento entrò nello studio la madre di Enrico. «Cosa state combinando?» domandò sospettosa. «Lo sai che tuo padre non vuole che tu entri nel suo studio, quando lui non c’è». «Ce ne andiamo subito, signora Pagani», rispose Sigi con un sorriso. «Bravi. Per favore, non datemi grattacapi anche voi. Sono già abbastanza in ansia per Emma». «Che cos’ha?», si informò Sigi, non solo per educazione: Emma lo interessava sempre. Forse non ne era del tutto cosciente, ma lei gli piaceva, anche se non lo avrebbe mai confessato a Enrico, che lo avrebbe preso in giro senza pietà. La signora Pagani esitò: «Chissà se faccio bene a dirtelo, ma tanto te lo dico lo stesso. Emma è sempre stata una bambina sensibile e nervosa. Soffre d’insonnia. Da quando Tata se n’è andata non mangia, e, se sente odore di fumo, si mette a gridare e fugge via». «Capirai che con mio padre che fuma il sigaro come una ciminiera, quella scema strilla ogni due per tre», spiegò Enrico. «Cerca di avere più comprensione per tua sorella. È ammalata di nervi, poverina» lo rimprovererò la madre, chiudendo la porta dello studio dietro le spalle dei ragazzi. Sigi stava riflettendo e ascoltava appena l’amico che descriveva i tipi di sigaro preferiti dal padre. Ad un certo punto lo interruppe per chiedere: «Credi che tua sorella 29 non mangi perché Tata è andata via?». «Certo, è una forma di protesta, non lo capisci? Lei non è tipo da dire chiaro in faccia alla mamma che ha sbagliato ad offendere Tata. Lei se ne sta seduta a tavola con l’aria appesa senza toccare cibo per giorni e giorni. Che palla al piede!». «Allora credi che sia volontario? Pensi che lo faccia apposta e che, se volesse, potrebbe mangiare?». «Sicuro» esclamò Enrico con aria meravigliata, come se l’idea contraria fosse un’assurdità. «Io non tanto. Tua madre ha detto che è una bambina sensibile. Questo è certamente il suo modo di protestare, ma non è volontario, secondo me. Hai mai pensato che noi abbiamo dentro una parte razionale e una nascosta? Una parte di cui siamo consci e una di cui siamo inconsci? E quella inconscia, a volte, ha strani modi per bussare alla porta di quell’altra, che di solito la ignora. Il digiuno di tua sorella può essere un modo di protestare, è vero, ma non volontario». «Non so. Emma è sempre stata strana, pensa che la sua più grande passione sono gli animali feriti, e più le loro ferite sono schifose e purulente, più lei si ostina a curarli. Ha portato a casa di tutto, merli spennacchiati, mici con gli occhi cisposi, cani con piaghe puzzolenti. Per non parlare del suo sonnambulismo! Durante la notte la trovi che passeggia per casa con aria spettrale. Ti fa prendere certi spaventi! E lei, la mattina successiva, non ricorda cos’è successo, al massimo le sembra tutto un sogno». La mente di Sigi era al lavoro. «Se va in giro per la casa di notte, non potrebbe aver visto qualcosa che l’ha spaventata?». 30 Enrico guardò l’amico. Dove voleva arrivare? Ai ladri, ovvio. «La notte del furto, in effetti, Emma si è fatta una delle sue passeggiate notturne. Ho sentito mamma che lo diceva a papà, il giorno seguente». «E se fosse questo il motivo che le ha chiuso lo stomaco? Se avesse visto qualcosa che l’ha spaventata? A peggiorare la situazione, il giorno dopo, la tata a cui vuole bene viene incolpata di un furto e lei sa che è innocente. Poi Tata se ne va. È un colpo forte per lei, un trauma». «Non lo sapremo mai perché mia sorella non apre la bocca per mangiare e, in questi giorni, a stento la apre per parlare». «Le è già capitato altre volte di non mangiare per un periodo e poi ricominciare?». «Mai. A parte qualche disturbo di stomaco. Credo che mia madre stia facendo di tutto per rintracciare Tata. È l’unica con cui mia sorella si confidava. Dài, adesso lasciamo perdere Emma e andiamo a parlare con l’antiquario di mio padre». Sigi si lasciò trascinare fin sulla porta di casa, poi chiese all’amico: «Posso andare a trovare tua sorella nella sua camera? Questione di un momento». «E va bene, se ci tieni tanto. Ti accompagno». I due ragazzi bussarono alla porta. Emma venne subito ad aprire, in braccio teneva un gatto dall’aria astiosa, probabilmente una delle sue bestie piene di acciacchi. «Che cosa stai facendo?», domandò allegramente Enrico. Emma non rispose. Enrico fece un gesto all’amico che significava: «Visto?». Sigi guardò con attenzione la ragazzina, il suo sguardo era abbassato sulla pelliccia del gatto e non si fermava mai 31 sul viso di chi le parlava. Era come se Emma volesse sfuggire un contatto doloroso. «Cos’ha che non va questo micio?», chiese Sigi accarezzando la bestia sulla testa per attirare l’attenzione di lei, ma l’unico risultato che ottenne fu attirarsi lo sguardo d’odio del felino. «L’abbiamo trovato con la pancia sventrata» fu Enrico a fornire la spiegazione. «Tata ha dovuto costruire una barella di fortuna e così l’abbiamo portato dal veterinario che l’ha operato d’urgenza. Come vedi ora sta benone, peccato che sia antipaticissimo». Emma continuava ad avere lo sguardo sfuggente. Sigi ricordava una ragazzina timida, ma vivace e intelligente, con uno sguardo dritto e acuto. Perché adesso era cambiata? Era solo la tristezza per aver perso l’amata Tata? Enrico tirava l’amico per la manica, era impaziente di correre dall’antiquario. «Muoviamoci, Sigi. Ciao, Emma», disse, dando un distratto bacio sulla guancia alla sorella. Nonostante l’odiosità del gatto, Sigmund avrebbe voluto fermarsi ancora un po’ con la ragazzina, ma Enrico era impetuoso e impaziente per carattere, e lui non ebbe altra scelta che seguirlo. 32 33 22 novembre 1866 Ore 16,40 Per arrivare alla bottega dell’antiquario attraversarono il Ring, il grande viale costruito solo pochi anni prima per volere dell’Imperatore Francesco Giuseppe. Entrarono in un quartiere della città dove le strade erano meno strette e le zone verdi più ampie. Lì c’era un negozietto polveroso, che Sigi non avrebbe notato se Enrico non si fosse fermato: la vetrina esponeva pochi reperti scialbi, forse greci o romani. I ragazzi attraversarono la prima sala, vuota e dall’aspetto scuro e squallido, e passarono, dopo un educato “buongiorno” di Enrico, nella seconda. Questa era molto più grande e luminosa. Nel mezzo della stanza, un’enorme scrivania piena di carte. Il proprietario, un giovanotto dall’aspetto atletico e scattante, si alzò per salutare i due clienti. «Il figlio dell’avvocato Pagani!», esclamò non appena lo ebbe riconosciuto. «Che piacere vederti! Vieni, accomodati, saluto questo signore e sono subito da te». Enrico e Sigi furono squadrati attentamente dal cliente dell’antiquario, un uomo tanto grasso da sembrare una 35 sfera, anzi due sfere, la testa e poi il corpo piantato su due zampette tozze e corte. «L’aspetto la settimana prossima, signor Blitz» stava dicendo l’antiquario. «Le prometto che, per allora, avrò qualche reperto egiziano interessante, ne sono sicuro». Senza proferire parola, l’uomo sferico allungò due dita grasse che il commerciante strinse cordiale e uscì dal negozio, dopo aver lanciato un’ultima, penetrante occhiata ai ragazzi. «Vieni per conto di tuo padre? La statua egizia del falco è arrivata sana e salva a casa vostra? L’ha recapitata il mio fattorino di fiducia, ma non si sa mai», disse l’antiquario. I due ragazzi si scambiarono un’occhiata. Era evidente che l’uomo non sapeva niente del furto. La polizia, troppo occupata a reprimere tutte le spinte indipendentiste di ungheresi, cechi e italiani che convivevano sotto l’impero austro-ungarico, non si era neanche presa il disturbo di scambiare due chiacchiere con l’antiquario. «Per la verità credevo che fosse stato informato del furto. Il falco è sparito da casa nostra due notti fa». L’antiquario, che esprimeva il proprio turbamento alzandosi e tornando a sedersi subito dopo, volle essere messo al corrente dei fatti. Mentre Enrico raccontava, Sigi si guardò intorno. La vetrina della bottega poteva essere polverosa e poco allettante, ma quella stanza! Era completamente foderata di scaffali di legno, pieni zeppi di statuette e oggetti archeologici di ogni epoca e provenienza. Oltre alle statuette egizie simili a quelle nello studio dell’avvocato Pagani, c’erano busti classici greci e romani, vasi decorati, ciotole in terracotta, buccheri etruschi, animali scolpiti nella pietra o modellati nella creta… 36 37 «… il falco mi era stato venduto solo un giorno prima da una donna» stava dicendo l’antiquario, e Sigi fu costretto a distogliere l’attenzione dallo splendido spettacolo degli scaffali, per portarla sulla figura nervosa dell’antiquario in giacca e farfallino. «Aveva qualcosa di particolare? Era più prezioso degli altri reperti che sono nel suo negozio?». «No, assolutamente no. Era un’opera del periodo tardo, rappresenta la divinità funeraria Sokar, che controlla l’entrata nell’aldilà. Era ben conservato, ma non unico nel suo genere. Conoscendo l’interesse di tuo padre per questo genere di oggetti, mi sono affrettato ad informarlo. L’avvocato è venuto subito qui e ha acquistato il falco». «Perciò la statua è rimasta pochissimo nel suo negozio?», chiese Sigi. «Neanche ventiquattro ore. È stata subito portata a casa dell’avvocato. Per quanto riguarda il suo valore, vi assicuro che la maggior parte dei reperti che vedete qui sono molto più preziosi». Sigi e l’amico si guardarono sconsolati. Ne sapevano quanto prima. Stavano per andarsene, quando all’antiquario venne in mente qualcosa. «Adesso ricordo che il giorno seguente, la mattina, si sono presentati due individui. Hanno chiesto se avevo una statuetta che rappresentava proprio Sokar. Io ho detto che ne avevo una, ma che l’avevo venduta». «E ha detto chi era il compratore?», si affrettò a chiedere Enrico. L’antiquario assunse un’aria molto offesa. «Per chi mi prendi? Non fornisco mai, ripeto mai, informazioni sui miei clienti. È questione di discrezione professionale!». 38 «Ci scusi, era una domanda sciocca» si affrettò a dire Sigi, per calmare la dignità offesa dell’uomo. «I due uomini non possono essersi procurati il nome in qualche altro modo?». «Non vedo come. Annoto tutte le vendite nel registro che è sulla mia scrivania. E quel libro non si muove da questo negozio. La notte, poi, chiudo porta e finestre con parecchi lucchetti, serrature e chiavi. In questa stanza c’è un discreto patrimonio in opere d’arte», spiegò l’antiquario lasciando scorrere lo sguardo orgoglioso lungo le pareti cariche di reperti. «Potrebbe descriverci i due uomini?», lo pregò Enrico. «Uno era alto e magro, l’altro piuttosto tarchiato con un gran paio di baffi». Sigi pensò che i baffoni erano la moda del momento e quasi tutti gli uomini nel sfoggiavano un paio. L’informazione non li aiutava granché. «Fumava una sigaretta dopo l’altra e si è lasciato dietro una scia di fumo. Ho pensato di dirgli che fumare troppo fa male alla salute. Anzi, credo di averglielo detto, dal momento che si è sentito poco bene proprio nel mio negozio. È stato costretto a sedersi qualche minuto alla mia scrivania, perché si riprendesse». I due amici si scambiarono uno sguardo di vittoria! «Lei non si è allontanato un momento, mentre il signore tarchiato era seduto?». «No, perché avrei dovuto?» chiese stupito l’uomo con il farfallino. «A parte, ovviamente, andargli a prendere un bicchiere d’acqua nel bagno». I due ragazzi erano soddisfatti. Adesso sapevano che due uomini avevano mostrato interesse alla statuetta del falco 39 e avevano quasi sicuramente letto il registro che l’antiquario teneva sulla scrivania, mentre lui era a prendere il bicchier d’acqua. «I due signori in questione, avevano l’accento italiano, come il mio?», si informò Enrico. «No, al contrario, avevano uno spiccato accento viennese». «La ringraziamo molto, ci è stato utilissimo», disse Sigi. Stavano per andarsene, ma l’antiquario che, nonostante l’aria agile e scattante, aveva la caratteristica di reagire a scoppio ritardato, aggiunse: «L’accento italiano ce l’aveva la donna che mi ha venduto la statuetta. Ha detto di averla ereditata da un lontano zio vissuto in Egitto, ma di venderla perché aveva urgente bisogno di soldi. Non ha neanche contrattato sul prezzo. Certe donne sono davvero vanitose! Lei era così miope che, andandosene, ha urtato uno scaffale. Solo per miracolo i miei reperti non sono andati in mille pazzi! Perché non portare gli occhiali, dico io!». I due amici non ascoltavano più l’antiquario. Lo salutarono distrattamente e uscirono dal negozio trionfanti. Più che camminare, saltellavano, tanto erano eccitati, e parlavano tutti e due insieme. «È tutto chiaro! I due sanno chi ha comprato il falco e la notte si arrampicano per la grondaia e rubano la statuetta a mio padre», concluse Enrico. «La domanda a cui non abbiamo ancora risposta è: perché? Che cosa aveva di speciale quella statuetta?» Sigi rifletteva. «Potrebbe essere un simbolo» suggerì, «o un messaggio di morte. Dopo tutto, rappresenta il dio che sta a guardia dell’aldilà». 40 «Se tu volessi minacciare di morte un tuo nemico, non ti limiteresti a mandargli un biglietto con scritto: “Prima o poi ti faccio secco?”. Perché prendersi il disturbo di rubare una statuetta?». «Certo, può esserci un’altra spiegazione. E magari, questa spiegazione può fornircela tua sorella», concluse Sigi. «È una fissazione, la tua!», esclamò Enrico e Sigmund arrossì domandandosi se l’amico avesse indovinato il suo segreto interesse per Emma. I ragazzi si stavano avvicinando a casa Pagani. Enrico si fermò di botto: «Lascia in pace mia sorella, ha già abbastanza problemi!». «Io non voglio tormentarla, voglio risolverli, i suoi problemi. Non hai la sensazione, guardandola, che ci sia qualcosa di bloccato in lei? Come un pensiero o un’emozione che le si è congelata dentro, un «tappo» che impedisce a tutto il resto di uscire e magari anche di entrare, vedi il cibo?». Enrico guardò Sigi come fosse impazzito. «E quest’idea da dove ti è venuta?», si informò. «Non lo so, ma è quello che ho pensato guardando tua sorella, poco fa». Seguì mezzo minuto di silenzio. I due ragazzi meditavano sulle parole che Sigi aveva appena pronunciato. Alla fine quest’ultimo affermò: «Se riuscissimo a cavarle qualche parola, a capire dove e perché si è inceppata, forse si sbloccherebbe. Tolto il tappo, tutto verrebbe a galla. E di conseguenza riprenderebbe a mangiare». «Cioè il pensiero che la blocca passerebbe da livello inconscio a quello razionale, come hai detto prima a casa mia». «Sì, tanto per semplificare, direi di sì». «E perché sei convinto che tolto il tappo, tutto verreb- 41 be fuori? Non è mica una bottiglia». «È vero, probabilmente le cose sono molto più complicate. Ma è come quando hai un peso sullo stomaco, quando hai fatto qualcosa di male. Se confessi, ti senti sollevato». «La tua teoria è interessante. Non so come ti sia venuta in mente, non ho mai sentito niente del genere. Comunque devo rifletterci, potrebbero essere anche un mucchio di scemenze». «Non lo nego». «E continuo a pensare che, se Tata tornasse, Emma si rimetterebbe a mangiare come un bisonte». «Certo la presenza di Tata l’aiuterebbe». «E forse la pianterebbe anche di urlare tutte le volte che papà l’avvicina. È imbarazzante e molto penoso per lui. Ci resta malissimo, poveretto». «Sul serio ha una reazione così forte? Credevo fosse solo l’odore di fumo a darle fastidio». «Mamma, poco fa, ha minimizzato, davanti a te. È vero che Emma strilla anche quando entra semplicemente in una stanza piena di fumo, ma strilla sempre quando vede papà. E se, con la tua teoria bislacca, trovi il modo di spiegarmelo, sei un vero genio». I due ragazzi continuarono a camminare verso casa Pagani. Sigi rifletteva. Una volta davanti al portone, prima di salutare l’amico disse: «Se ci pensi bene, il rifiuto del cibo e la ripugnanza di Emma verso il fumo e verso tuo padre sono fenomeni apparsi insieme. La tua spiegazione del digiuno volontario di protesta spiega solo la prima parte dei sintomi di tua sorella. Se invece ipotizziamo che, durante la notte, mentre girellava per casa in preda ad un 42 attacco di sonnambulismo, lei abbia visto i ladri che rubavano la statuetta e si sia spaventata, anzi traumatizzata, al punto di non riuscire più a mangiare…». «Non capisco cosa c’entri il suo odio per la puzza di fumo e per mio padre». Era come incollare un vaso rotto per un archeologo, chissà se aveva tutti i pezzi e chissà in quale ordine sistemarli! Poi Sigi ebbe un’illuminazione: «L’antiquario ha detto che uno degli individui che si sono interessati al falco fumava una sigaretta dietro l’altra. Aveva i baffi, che si impregnano dell’odore di fumo, come del resto gli abiti. Forse la puzza di tabacco le fa tornare in mente il ladro». «E allora perché quella scema di Emma strilla tutte le volte che vede mio padre? Lui non ha neanche i baffi, non è possibile che le ricordi l’uomo che si è intrufolato in casa nostra nottetempo». «Questo non so spiegarlo, lo ammetto. Ci penserò sopra. Intanto me ne vado a casa. Credi che ci sia qualche possibilità che tua madre rintracci Tata e che lei accetti di tornare da voi?». «Non lo so, ma lo spero! La vita sarebbe molto più piacevole. E non solo perché, secondo me, nell’attimo in cui Tata ritorna, mia sorella la pianta di digiunare. Anche io e mio fratello tireremmo un sospiro di sollievo: mia mamma la finirebbe di aiutarci nei compiti di scuola. È un supplizio! A mia mamma voglio bene, ma è assalita da un dubbio al secondo, per ogni piccola cosa. Finisce che neanche io so più se due più due fa quattro!». «Tu non hai mai saputo che due più due fa quattro. Scrivi temi pieni di fantasia, ma la matematica meglio che la copi da me, e anche così non è detto che l’azzecchi!», ri- 43 se Sigi. Poi batté una mano sulla spalla dell’amico che aveva l’aria sconsolata e se ne tornò a casa meditando sui problemi dei ragazzi Pagani. 23 novembre 1866 Ore 9,50 Il giorno dopo, in classe, durante l’ora di latino, a Sigi arrivò un biglietto dal banco dell’ultima fila: quello occupato da Enrico. “È TORNATA!” c’era scritto a lettere cubitali. Anche l’espressione del ragazzo era esultante. Finalmente la campanella della ricreazione. Sbocconcellando il suo panino con lo speck, Enrico raccontò che Tata era stata rintracciata in casa di un’amica triestina a Vienna. «Mia madre ha dovuto scusarsi. Capirai, senza Tata rischiava l’esaurimento nervoso! La sera, però, l’ho sentita esprimere dei dubbi a papà. «Cosa ci faceva Tata nel tuo studio?», gli ha chiesto con aria sospettosa». «Non ha tutti i torti, cosa ci faceva Tata nello studio di tuo padre?», intervenne Sigi. «È la domanda che le ho rivolto non appena siamo rimasti a quattr’occhi». «E lei cosa ha risposto?». «È stata un po’ evasiva, lo ammetto. E, come al solito quando ha qualcosa da nascondere, si è impappinata. Ma 44 45 questo non vuol dire che non fosse in buona fede». «La tua obiettività quando di tratta di Tata scende a livello zero». «Può darsi». Il tono di Enrico era un po’ risentito. «Però mi ha apertamente detto che non poteva spiegarmi, ma che non faceva niente che potesse nuocere all’imperatore né all’Austria». «Patria della torta Sacher», aggiunse Sigi con un sorriso ironico. «Torta Sacher o no, noi amiamo l’Austria. Ci viviamo da cinque anni, ormai. Amiamo Vienna, amiamo gli austriaci e perché no? Amiamo anche la torta Sacher!». Sigi rise a questa dichiarazione categorica dell’amico. Conosceva bene Enrico, sapeva che era rimasto profondamente triestino, sotto certi aspetti, ma la sua lealtà e onestà erano a prova di bomba. I Freud, dal canto loro, erano arrivati qualche anno prima dalla Moravia, una regione a duecentocinquanta chilometri a est di Vienna, che faceva parte dell’impero, ma non si poteva definire austriaca in senso stretto. «Ha anche detto che è in ballo il buon nome degli italiani e la costruzione del fanale o del canale, non ho ben capito», aggiunse Enrico. «Il fanale? Quale fanale?». «Non ne ho la più pallida idea. Lei chiacchiera sempre troppo, le è sfuggito di bocca, ma poi non c’è stato verso di cavarle altro». I due amici si guardarono con aria interrogativa. Tutto questo non aveva senso. La ricreazione era agli sgoccioli, tra non molto sarebbero dovuti andare in laboratorio per la lezione di biologia, e l’idea non entusiasmava Enrico. Sigi rifletteva. Era- 46 no al punto di prima. Continuava ad essere convinto che il nodo potesse essere sciolto solo da Emma. «Tua sorella ha ripreso a mangiare?». Enrico scosse la testa con aria sconsolata. «Tata adesso sta con lei tutto il giorno. Forse chissà, stasera… Mia madre le fa ingurgitare qualche cucchiaiata di brodo, ma comincia a sembrare la sua ombra». L’espressione del viso di Enrico era molto abbattuta. «Mia sorella è una gran noia, lei, i suoi nervi scossi e i suoi animali straziati, però in casa siamo tutti molto in ansia». La campanella, impietosa, risuonò nel cortile. Gli studenti del ginnasio cominciarono a rientrare nelle classi. Mentre imboccavano lo scalone che portava al laboratorio di biologia sotterraneo, Sigi cercava di convincere l’amico a portare Emma a casa sua. «… accompagnata da Tata, è ovvio! Forse, lontana da casa, da tua madre e da tuo padre, sarà disposta a parlare, a sfogarsi, a sputare il rospo che le chiude la gola. In fondo, male non può farle, per lo meno si distrae!». Sigi aspettava con ansia una risposta. «Secondo te ci fanno sezionare quelle schifosissime rane, oggi?», fu l’incongrua domanda dell’amico. «Tu siediti vicino a me, ci penso io. Allora, la porti tua sorella a casa mia oggi pomeriggio?». «Pur di non sezionare rane, sono disposto a portartela anche imbavagliata e legata come un salame!». Ore 15,55 Sigi, preoccupato che gli amici fossero spaesati in un quartiere tanto diverso da quello in cui abitavano, decise di an- 47 dare loro incontro. La zona in cui vivevano i Pagani era austera ed elegante, il quartiere ebraico, invece, era più popolare e movimentato, pieno di botteghe artigiane, la maggior parte di sarti, ma c’erano anche ciabattini e venditori di cianfrusaglie usate, e pullulava di piccoli locali, anche il teatro ebraico aveva un’antica tradizione ed era molto vivace. Non era stato facile convincere la signora Pagani a dare il permesso ad Emma di accompagnare Enrico in una zo- 48 na poco elegante della città, ma la presenza di Tata e l’idea di procurare una distrazione alla figlia avevano compiuto il miracolo. Adesso Emma procedeva silenziosa a fianco dell’istitutrice, il suo sguardo però era tornato vivace e curioso, e guardava con attenzione quell’attività da formicaio che si svolgeva per le strade. Tata, dal canto suo, procedeva con il naso per aria e inciampava spesso nelle pietre irregolari del lastricato. Mentre i ragazzi Pagani camminavano guardandosi intorno, Sigi con la coda del- 49 l’occhio, individuò un tizio che sembrava seguire proprio loro. Nel quartiere ebraico tutti si conoscevano di vista, e lui avrebbe potuto giurare che l’uomo con il lungo soprabito nero non era giudeo, troppo pasciuto per appartenere a quel popolo in cui tutti facevano fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Certo poteva essere un amico ricco venuto in visita nel quartiere, ma Sigi provava una strana sensazione di inquietudine. Il ragazzo continuava a lanciare occhiate preoccupate dietro le spalle; ad un tratto vide che l’uomo aveva preso a camminare più in fretta, tra pochi secondi li avrebbe raggiunti, e l’espressione decisa del viso non prometteva niente di buono. Cosa voleva quell’uomo da loro? Li avrebbe aggrediti? Tramortiti? Rapiti? Come difendersi? Poteva mettersi a urlare, ma se l’uomo non aveva cattive intenzioni che figura ci faceva? Sigi stava per dare l’allarme agli amici, quando vide il macellaio kasher proprietario della bottega all’angolo intercettare l’uomo con il lungo soprabito, sbarrargli la strada e domandargli a muso duro cosa diavolo volesse. In pochi secondi si formò un capannello intorno all’intruso, il quale, se aveva pensato che il quartiere ebraico, dove la polizia non metteva quasi mai piede, fosse il luogo adatto per un rapimento, aveva fatto male i suoi conti: gli ebrei, che dovevano spesso fronteggiare aggressioni, erano sempre sul chi va là, e la sorveglianza, in quelle strade strette, era assicurata dagli stessi abitanti. Enrico avrebbe voluto fermarsi, domandare cos’era successo, ma Sigi, preoccupato che Emma si spaventasse, trascinò gli amici verso casa sua. Una volta entrati nel por- 50 tone, tirò un sospiro di sollievo. Promise a se stesso di non farne parola con Enrico, in fondo non poteva essere certo che l’uomo con il soprabito seguisse proprio loro; inutile creare allarmismi. Dopo aver presentato agli amici la sua famiglia, Sigi li guidò attraverso la camera in cui dormivano le sue cinque sorelle, e li fece accomodare nella minuscola stanza riservata solo a lui. Il ragazzo si vergognava un po’. Gli amici avrebbero certo notato la differenza tra la loro casa elegante e questo piccolo appartamento in cui vivevano ammucchiati i suoi genitori con sette figli. Suo padre era stato un commerciante di stoffe in Moravia, poi la sua attività era andata a rotoli, e lui aveva deciso di trasferirsi con tutta la famiglia nella capitale. Se il padre di Sigi era in cerca di fortuna, ne aveva trovata poca. Aveva cominciato varie attività, ma nessuna era sopravvissuta più di qualche mese. Saltava agli occhi la differenza tra lui, nei suoi abiti lisi, e l’avvocato Pagani, uomo ambizioso e di successo, vestito con eleganti completi di tweed confezionati da un sarto di Londra. La madre di Sigi, poi, donna alta, magra ed intelligente, non aveva la raffinata vivacità e spensieratezza della signora Pagani, sempre occupata com’era ad accudire i figli e ad occuparsi della casa. «Allora, come vuoi cominciare?», chiese Enrico con un sorrisetto ironico. Sigi cercò di ignorare l’amico e si rivolse a Tata. «Signorina, non voglio fare niente di male a Emma. Sono convinto che i suoi disturbi siano di origine nervosa…». «Di questo siamo convinti tutti», interruppe Tata con il suo caldo tono di voce e il suo spiccato accento italiano. 51 «Secondo me, Emma è bloccata da un ricordo sgradevole. Se parla di questo ricordo, se riesce a tirarlo fuori, a liberarsene, si libererà anche del sintomo che sostituisce questo ricordo sgradevole, cioè il rifiuto del cibo». «Scusa, ma perché dovrebbe volerne parlare con te? Perché non con me, per esempio? A me Emma ha sempre raccontato tutti i suoi segreti», ribatté Tata, e per Enrico il ragionamento non faceva una piega. «Non si tratta di volere, non è una scelta. Se Emma potesse liberarsi volontariamente di quello che la fa soffrire, lo farebbe. Ma io sono convinto che non possa, il ricordo è stato rimosso, non cancellato, ma è affondato nella parte più profonda di se stessa», spiegò Sigi, mettendo ordine per la prima volta in pensieri che non erano ben chiari neanche a lui. «E con questo siamo fermi al capolinea! Se lei non se lo ricorda, come fa a dirtelo e a liberarsene?», fece notare Enrico. «In effetti, qui sta la difficoltà», ammise Sigi che non aveva idea da che parte cominciare. «Il tè è pronto» esclamò in quel momento la signora Freud. «Purtroppo lo strudel che ho messo in forno non è ancora cotto. Se avete la pazienza di aspettare, lo assaggeremo appena pronto». Tutti si spostarono in salotto. L’atmosfera era allegra, le cinque ragazze Freud facevano a gara per servire gli ospiti e farli sentire a loro agio. L’ultimo nato, un maschietto, emetteva versi così buffi, che Emma si trovò a ridere spensierata. Una volta bevuto il tè, Anna, la sorella maggiore di Sigi, fece distendere Emma sul divano perché riposasse. La ragazzina, cullata dalle voci allegre e scherzose, si rilassò 52 completamente. Guardandola, il primo pensiero che si affacciò alla mente di Sigi fu che Emma era proprio carina, il secondo fu che quello era il momento giusto per provare se la sua teoria funzionava. «Ti va di fare un gioco?», le chiese avvicinandosi al divano. La ragazzina accennò ad alzarsi. «No, no, resta distesa. Anzi chiudi gli occhi. Hai presente il gioco che si fa tutti in cerchio, battendo le mani? Io dico “latte”, batto due volte le mani e l’amico che siede accanto a me dice “mucca”, il terzo “vitello” etc, etc?». «L’ho sempre trovato un gioco cretino», intervenne Enrico, ma Sigi lo ignorò. «Ti va di provare?», ripeté poi rivolto a Emma. L’espressione di Enrico la diceva lunga sul suo scetticismo. E quella di Tata non era da meno. A Sigi batteva il cuore. Stava rischiando una brutta figura davanti alla ragazzina che gli piaceva. In effetti, lui non aveva nessuna certezza che con una catena di ricordi sarebbero arrivati a scoprire qualcosa, ma era sicurissimo, sapeva che dentro Emma era intrappolato un ricordo rimosso che faceva soffrire la bambina. Tata prese in mano la situazione: «Per assurdo che sia, non mi sembra pericoloso. Ho portato Emma fin qui perché si distraesse, tanto vale farla divertire con questo stupido gioco delle associazioni libere». Detto questo, si sedette su una sedia e si limitò a sorvegliare che Emma non si stancasse troppo. Enrico fece spallucce, Emma chiuse gli occhi e si concentrò. 53 «Partiamo dal sintomo della tua fobia: l’odore di fumo, cosa ti fa venire in mente? Però non devi imbrogliare, devi dire tutto quello che ti passa per la testa». «Stiamo freschi», sibilò Enrico che non aveva troppa considerazione per l’intelligenza della sorella. Sigi gli lanciò un’occhiataccia. Sigi notò che la ragazzina era tanto concentrata da non sentire neanche l’affermazione del fratello. Anna Freud si era allontanata in silenzio portando con sé le sorelline più piccole. «L’odore di fumo mi fa ricordare la domenica dopo pranzo. Abbiamo appena finito di mangiare e mio padre si accende il sigaro». «Quella che stai vedendo nella tua mente, è una domenica particolare o una delle tante domeniche?». «Non so, potrebbe essere una domenica qualsiasi». «Mio padre si accende sempre un sigaro dopo pranzo, quando non deve correre allo studio», spiegò Enrico. «Pensaci, Emma», la incoraggiò Sigi. «Guarda la scena come fossi a teatro. Guarda chi c’è intorno alla tavola, come sono vestiti…». «Intorno alla tavola c’è la mia famiglia, mamma, papà… un momento, non c’è Claudio!». «Fino a tre anni fa lui non mangiava con noi, era troppo piccolo. Mangiava prima, in cucina», spiegò Enrico. «Bene, allora diciamo che è un ricordo che ha più di tre anni», Sigi era soddisfatto, il metodo sembrava funzionare. «E poi? Cosa vedi? Cosa ricordi?». «Niente», affermò con candore Emma, aprendo gli occhi. Sigi si sgonfiò come un pallone. Niente. Cosa doveva 54 fare, adesso? Forse l’idea era davvero cretina, tanto valeva darsi per vinti fin dall’inizio. Intervenne Enrico che invece, dopo lo scetticismo iniziale, si era fatto prendere dall’entusiasmo e dalla curiosità. «Se tu dici che Emma non può ricordare, non pretenderai che ti racconti un pensiero sgradevole affondato in profondità, senza un minimo di resistenza, ti pare? Dev’essere più difficile di così. Proviamo ad insistere, dài, Emma, chiudi gli occhi e concentrati. Cosa ti ricorda l’odore di fumo? È gradevole o sgradevole?». Sigi, un po’ seccato dell’invasione dell’amico gli sussurrò: «Sono io che devo farle le domande, sono io la figura estranea alla famiglia. Lascia fare a me». E dopo un secondo di silenzio non trovò di meglio che ripetere a pappagallo: «Cosa ti ricorda l’odore di fumo? È gradevole o sgradevole?». «Mi fa schifo», rispose la ragazzina senza esitazioni, «mi fa chiudere lo stomaco». Sigi saltò sulla sedia: «Perciò, anche se hai fame, te la fa passare?». «Sì», confessò Emma. Adesso anche Tata si era avvicinata con interesse al divano. «Sforzati ancora un po’. Ripensa al dopopranzo di quella domenica senza Claudio. Non è possibile che non ricordi altro», le sussurrò Sigi e la frase più che un incoraggiamento sembrava una supplica. «Ricordo che avevamo mangiato polenta pasticciata. Era molto buona e ne avevo mangiato troppa. Poi però avevo lo stomaco che tirava da quanto era pieno, e una vaga nausea». Nella stanza c’era un silenzio di tomba. Il ticchettio 55 dell’orologio a pendolo sembrava rimbombare. Il ricordo di Emma era importante, spiegava un sacco di cose. «E cos’altro hai pensato?», chiese timidamente Sigi, quasi avesse paura, parlando, di interrompere il filo dei pensieri di Emma. «Non so cosa ho pensato, a quel punto papà ha acceso il sigaro e a me si è chiuso lo stomaco restringendosi ancora di più». «E da quel giorno non hai più voluto mangiare la polenta pasticciata?», domandò Sigi. «A dire la verità, è uno dei miei piatti preferiti». Sigi guardò Enrico con aria avvilita. E allora? L’odore di fumo era legato alla polenta, ma Emma non aveva nessun problema a mangiarla. Dov’era il nodo della faccenda? O forse il fumo non era legato alla sgradevole sensazione di pancia piena, ma ad un sentimento più brutto, che si trovava più in profondità? «La polenta ci aiuta in qualche modo nel caso del falco rubato? Vedi qualche legame? », sussurrò Enrico. «Boh», ammise Sigi con un sospiro. «Forse la polenta ci porta fuori strada. Torniamo al punto principale: prova a chiederglielo», lo incoraggiò Enrico, sempre sottovoce. «Prova a chiederle se ha visto qualcosa la notte del furto». «Perché non glielo chiedi tu?», ribatté l’amico sempre sottovoce. «La figura estranea alla famiglia sei tu, sei tu quello che fa le domande. Arrangiati». Sigi incassò la risposta e continuò: «Ricordi qualcosa della notte in cui hanno rubato la statuetta egizia?». Silenzio. 56 «Tua mamma ha detto che quella notte hai avuto un attacco di sonnambulismo. Girellando per casa, hai visto qualcosa di strano?». Silenzio. Sigi si disse che forse doveva tentare un approccio più diretto. «Il falco della statuetta e la polenta dentro lo stomaco sono in qualche modo legati?». La bambina era pallida come uno spettro. Tata, che aveva seguito con vivo interesse tutta la seduta, stava per intervenire, quando Emma scoppiò in singhiozzi. «Due uomini, uno aveva i baffi. Ma forse li ho sognati», esclamò. «Quando hai le crisi di sonnambulismo sei come sdoppiata e la vita reale ti sembra un sogno?», azzardò Sigi che aveva letto qualcosa sul sonnambulismo su una rivista che gli era capitata tra le mani dal dentista. Emma accennò a un sì con la testa. Enrico si picchiò il dito sulla tempia. Sua sorella aveva sempre avuto una rotella fuori posto! Se uno sogna, sogna, sennò è sveglio! Sigi invece pendeva dalle labbra della ragazzina. «Raccontami questo sogno che forse non era un sogno». «Due uomini entrano nello studio di papà, non dalla porta, dalla finestra. Non fanno rumore, sembra che per loro entrare da una finestra al terzo piano sia la cosa più naturale del mondo. Girano per la stanza, guardano la sua collezione di statuette. Io penso che siano due collezionisti amici di papà». «In piena notte? Ma ti sei bevuta il cervello?», esclamò Enrico non reggendo più la situazione. Sigi lo zittì afferrandolo per un braccio. 57 Emma adesso non piangeva, si era calmata, e cercava di dare un senso a ciò che ricordava. «Commentavano, proprio come i collezionisti. Uno ha detto: “Questa sfinge piacerebbe molto al nostro capo”. L’altro ha riso e ha aggiunto: “Blitz è un vero intenditore!”. Non avevano l’aria di topi d’appartamento!». «Certo, tesoro, non dar retta a Enrico, continua a raccontare il tuo sogno», intervenne Tata, con voce dolce. Un ricordo si fece strada nella mente di Sigi, come un raggio di sole in una stanza buia. «Blitz! Non era questo il nome con cui l’antiquario si è rivolto all’uomo a forma di sfera che abbiamo incontrato nel negozio?». «È vero! Ed era interessato a reperti provenienti dall’Egitto, se non sbaglio», aggiunse Enrico. I due ragazzi avrebbero voluto ragionare ancora un po’ sull’informazione, ma Emma ricominciò a piangere disperatamente, sembrava inconsolabile, neanche Tata riusciva a calmarla. Ormai era chiaro per tutti che la bambina doveva parlare, doveva sputare il rospo che le serrava la gola e anche lo stomaco. Dopo qualche dolce pressione da parte di Tata e di Sigi, Emma non resistette più e, tra un singhiozzo e l’altro, raccontò: «Gli uomini, dopo aver guardato la collezione di papà, hanno messo un oggetto in una borsa. Io ho cercato di vedere che cos’era. A quel punto il parquet ha scricchiolato sotto i miei piedi e loro si sono accorti di me. È stato terribile! Nel sogno ho avuto paura che mi uccidessero! Quello con i baffi mi si è avvicinato e ha detto che avrebbe ucciso tutta la mia famiglia, se avessi raccontato quello che avevo visto! E io non riuscivo a pensare ad altro che al puzzo di fumo che emanava dai suoi baffi!». Emma si lanciò tra le braccia di 58 59 Tata, la quale, dopo un po’, riuscì a calmarla. «E poi mi sono svegliata in camera della mamma. Non so come sono arrivata lì». «Il giorno dopo, quando è stato scoperto il furto, non ti è venuto in mente che potesse essere la realtà?», chiese Enrico. «Non lo so, sì, forse ci ho pensato, ma poi ho cancellato il pensiero: così era anche peggio! Se non era un sogno, io non dovevo parlare o tutti voi sareste stati sterminati. Anzi, sarete sterminati, ormai non c’è più speranza!» e Emma riattaccò a piangere. Enrico emise un sospiro di impazienza! Possibile che sua sorella fosse così fifona? Stava per sbottare, quando incontrò gli occhi lucidi di Tata. «E adesso cosa c’è? Ti metti a piangere anche tu?». Davanti allo sguardo stupefatto dei ragazzi, Tata si era sciolta in grosse lacrime. «È colpa mia, tutta colpa mia», esclamò. «Ma ora basta. Vi dirò tutto». Enrico e Sigi non si erano ancora ripresi dalla rivelazione di Emma. Cosa diavolo poteva avere da confessare Tata? 60 23 novembre 1866 Pochi minuti più tardi «Avrei dovuto parlare prima» esordì Tata. «Vedere Emma così disperata mi fa sentire in colpa. Enrico, quando mi hai chiesto cosa combinavo nello studio di tuo padre, ho detto che non potevo rispondere. In realtà cercavo anch’io la statuetta. All’interno, nella base, era nascosta la variante del progetto indispensabile a terminare il Canale di Suez». Sigi ricordò di aver letto che l’enorme opera stava per essere ultimata dalla Compagnia Universale del Canale, una società internazionale. Il progetto per tagliare l’istmo tra l’Egitto e il Sinai (sempre egiziano) era di un ingegnere trentino. «È la variante che faceva parte del progetto originale dell’ingegner Negrelli. Con quella variante, il Canale non si sarebbe insabbiato durante la costruzione, come sta succedendo. Senza quel dettaglio, la sabbia continua a rifluire nelle zone già scavate e il Canale non sarà mai inaugurato», affermò Tata. «Scusa tanto, ma a te cosa te ne importa del Canale di Suez?», chiese Enrico sbalordito. 61 «Ma non capisci? L’ingegnere, che adesso è morto, era trentino! Se il Canale non verrà terminato, tutto il discredito ricadrà sui trentini, e sulle loro mire di indipendenza. Come dire: non sapete neanche costruire un canale, come potete pretendere di sapere se è meglio stare con l’Austria o con l’Italia? La variante all’interno della statua era destinata a me. Io avrei dovuto prenderla, lasciando poi il falco al suo posto, e passarla al mio contatto, del quale, per la verità, conosco solo il nome. Come al solito, so- 62 no riuscita a combinare un tremendo pasticcio!». «E poi?», incalzò Enrico. «E poi non lo so, io sono solo un corriere. La variante sarebbe arrivata a qualcuno dei capi del movimento d’indipendenza italiano, che l’avrebbe trasmessa in Egitto dove i lavori, adesso bloccati, sarebbero ripresi senza intoppi». I tre ragazzi si guardarono. Emma aveva ancora gli occhi rossi, ma si era dimenticata dei propri guai per partecipare a quelli di Tata. 63 «Emma ha detto che i due ladri hanno parlato del loro capo, un certo signor Blitz». Tata si asciugò le lacrime: «Trasmetterò l’informazione al mio contatto, forse è utile». «Come sarebbe trasmetterai l’informazione; e noi?», protestò Enrico, deluso di essere tagliato fuori dall’azione. «Voi ve ne starete alla larga! È una faccenda pericolosa!». «Non è giusto! Almeno tienici al corrente!». «Va bene, giuro che vi racconterò quello che scopro grazie alle rivelazioni di Emma ottenute da Sigi», così dicendo Tata rivolse un’occhiata piena di gratitudine al ragazzo. Sigi gongolava di gioia! Non solo adesso, forse, Emma avrebbe ripreso a mangiare, ma la sua teoria era giusta! In quel momento la signora Freud entrò nella stanza portando uno strudel ancora fumante che spandeva un profumo delizioso. «Ti andrebbe una merenda?»chiese Sigi pieno di speranze alla ragazzina. «No». «Come sarebbe no?». «Non ho fame. Ho lo stomaco chiuso, esattamente come quando sono arrivata qui». Sigi si sentì crollare il mondo addosso. Niente, non era arrivato a niente! «Non ti abbattere! In fondo abbiamo ottenuto quello che volevamo: sappiamo che i ladri erano due, che uno aveva i baffi, probabilmente erano i due individui che sono andati al negozio di antiquariato, la descrizione corrisponde. E abbiamo un nome: Blitz». Enrico diede un’affettuosa pacca sulla spalla di Sigi. 64 «E poi, ammettiamolo, la tua teoria era veramente bislacca, faceva acqua da tutte le parti! Io, in ogni caso, non ho blocchi allo stomaco, e la merenda la mangerei volentieri, grazie». Sigi era avvilito. Non degnò neanche di uno sguardo lo strudel che sua madre stava tagliando e servendo sui piatti migliori di casa Freud. Adesso era lui ad avere lo stomaco chiuso. Il resto del pomeriggio trascorse in chiacchiere allegre. Anna e Emma si trovarono molto simpatiche e decisero di incontrarsi al Prater, il grande parco della città, il pomeriggio seguente. Sigi quasi non si accorgeva di quello che succedeva intorno a lui. Aveva la testa da un’altra parte, si stava chiedendo dove avesse sbagliato, perché la sua teoria non aveva funzionato? Quando gli amici stavano per andarsene, il ragazzo esclamò: «Forse non abbiamo tentato fino in fondo! Dovevamo continuare, insistere. Ci siamo fermati alla notte del furto, ma non era lì il problema!». «Avanti, dài, ammettilo, era una teoria sballata. Non c’è niente di male a sbagliare, qualche volta, ti rende più umano!», replicò Enrico. «Non essere poco gentile!» lo rimproverò Tata. «Grazie a Sigi Emma si è liberata da un segreto pesante! Dobbiamo essergli riconoscenti. Se Emma se la sente, possiamo riprendere il gioco dei ricordi sfuggiti». La ragazzina acconsentì, avrebbe fatto il possibile per poter ingurgitare quello strudel dall’aria così croccante e gustosa. Una volta sul divano, chiuse gli occhi e si concentrò. «Allora, ricominciamo dove ti eri fermata. Se riuscia- 65 mo a superare questo blocco, forse scioglieremo il nodo», disse Sigi, animato da nuove speranze. «Hai la polenta che preme contro le pareti dello stomaco, e tuo padre accende un sigaro. Cosa hai pensato, in quel momento?». Emma rimase in silenzio per un po’, poi: «Niente». «Non è possibile non pensare niente», esclamò disperato Sigi. «Per lei è possibile eccome!», puntualizzò Enrico. Sigi fulminò Enrico con un’occhiataccia. Poi si rivolse gentilmente a Emma: «Fai un piccolo sforzo. Cerca di ricordare e sentiti libera di dire tutto quello che ti passa per la testa». «Ho pensato che a mio marito non permetterò mai di fumare un coso puzzolente come il sigaro!». «Ma chi ti sposerà mai, a te!», il commento era di Enrico, che venne zittito con vigore. «Continua», Sigi cercò di stimolare Emma. «E poi ho pensato che mi faceva schifo, il sigaro di papà, anzi che mi faceva schifo papà, con i suoi vestiti puzzolenti di fumo!», Emma scoppiò a piangere. Era diventata paonazza in viso, e il ricordo le provocava un forte dolore, era evidente. «Non è un pensiero tanto terribile», mormorò Sigi. «È spaventoso, invece! Non si pensano queste cose dei genitori! Mi sono sentita tanto in colpa! Io voglio bene a mio padre, non è una persona rivoltante come io ho pensato in quel momento!». Sigi guardò Enrico con aria interrogativa. Tutto qui? Possibile che Emma non mangiasse per un motivo così assurdo? Enrico fece spallucce. «La teoria è tua». Rifletté. Quello che lui considerava solo un pensiero 66 poco carino, per Emma era una cosa molto grave. Un’idea che si scontrava con le sue intenzioni coscienti, con quello che Emma considerava giusto. Da questo scontro derivava il senso di colpa. Ma perché lei non aveva smesso di mangiare subito dopo che era avvenuto il fatto? Perché aspettare almeno tre anni? Forse la visione traumatica, il “sogno” in cui il ladro puzzolente di fumo minacciava tutta la famiglia aveva funzionato da miccia, innescando il blocco allo stomaco. Si era sommato al ricordo della domenica dopo pranzo e, insieme, avevano creato la fobia del fumo. Emma era finita di nuovo tra le braccia di Tata. Dopo aver singhiozzato per un pezzo, alzò il viso ancora bagnato di lacrime e disse: «È rimasta una fettina di strudel?». La richiesta scatenò l’entusiasmo di tutti, soprattutto della signora Freud che attribuì alla bontà del suo dolce la fine del digiuno della bambina. «Non so come hai fatto, Sigi, ma Emma è già alla seconda fetta. Non ho capito un’acca della tua teoria, ma non importa, basta che funzioni!». «In effetti non è del tutto chiaro neanche a me. Credo che adesso Emma non strillerà più alla vista di vostro padre. Strillava perché vederlo le faceva tornare alla memoria una situazione dolorosa che non voleva ricordare. Almeno credo, ma non ci giurerei. L’importante è essere sulla buona strada. Ora sappiamo per certo che esiste una parte di noi conscia e una inconscia, e che, quando il flusso tra una parte e l’altra si interrompe, l’uomo soffre di strani e inspiegabili disturbi che non sono creati dal corpo, ma dalla mente. Chissà quante cose ci sono ancora da scoprire nella nostra testa, quanti meccanismi che ci sfuggono!». 67 I ragazzi Pagani salutarono e ringraziarono per il piacevole pomeriggio; Sigi, con la scusa che Emma era stanca, insistette perché prendessero una carrozza per tornare a casa. Si precipitò in strada, ne chiamò una, e disse al vetturino di fermarsi proprio sotto il suo portone. Poi scortò dentro gli amici, mentre gettava occhiate preoccupate ai passanti. Ma nessuno somigliava all’uomo con il lungo soprabito che li aveva seguiti all’andata. Quando la carrozza partì, Sigi si disse che forse aveva esagerato. «Dopotutto, l’uomo poteva essere venuto per tutt’altro scopo, e in ogni caso, a quest’ora gli sarà passata la voglia di far visita al quartiere ebraico». Considerando i bicipiti del macellaio, su questo non c’era alcun dubbio. 68 69 24 novembre 1866 Ore 16,05 La facciata ornata di guglie e pinnacoli della cattedrale di Santo Stefano quel giorno non attirò lo sguardo di Enrico: a lui quella chiesa era sempre piaciuta, ma era troppo impegnato a scrutare i passanti. La piazza era piena di vita, nel pomeriggio i signori passeggiavano sfoggiando i loro baffoni alla moda, i garzoni dei negozi correvano di qua e di là trasportando grosse scatole, i ragazzini, liberi dalla scuola, giocavano per le strette vie della parte più antica della città. Dopo aver osservato con impazienza la folla per cinque minuti, finalmente Enrico vide gli occhi neri e intensi di Sigi che si avvicinavano. Quel pomeriggio avevano appuntamento davanti alla cattedrale. Enrico non aveva voluto rivelare niente all’amico, lo avrebbe messo al corrente più tardi. Entrò subito in argomento, non ce la faceva più ad aspettare: «Ieri sera ho tormentato di domande Tata perché scucisse tutta la storia. Lei è una chiacchierona e non è in grado di tenere un segreto troppo a lungo; mi ha raccontato 71 come è stata contattata dal movimento per l’indipendenza. Questa era la prima volta che le affidavano un incarico importante. Sapendo che lavora per mio padre, e che mio padre è un collezionista di reperti egiziani, hanno fatto in modo che la statuetta del falco finisse in mano dell’antiquario da cui si serve sempre. Era ovvio che lui avrebbe chiamato il giorno stesso uno dei suoi migliori clienti. Tata, poi, avrebbe recuperato la variante del progetto con tutto comodo. Purtroppo lei non ha potuto agire la sera stessa, ha rimandato al mattino dopo, e nella notte le spie austriache si sono intrufolate in casa nostra. L’Austria non vuole assolutamente permettere a Trento e Trieste di tornare italiane. Chiacchierando, Tata si è lasciata sfuggire un’informazione importante: secondo il suo contatto, le spie austriache avrebbero il loro quartier generale all’Universität Hotel, davanti all’Università, appunto, a due passi da qui. Per questo ti ho dato appuntamento nel cuore di Vienna. Andiamo a dare un’occhiata». «Un momento, non essere il solito impulsivo. Dobbiamo ragionare, prima di agire», la voce calma e la saggezza di Sigi frenarono l’entusiasmo di Enrico. «Non dirmi che dobbiamo rivolgerci alla polizia perché nessuno ci crederebbe», ribatté con energia l’altro. «Tutto quello che abbiamo è un nome che mia sorella, una ragazzina dai nervi delicati, sostiene di aver sentito mentre girellava per la casa in camicia da notte convinta di vivere in un sogno!». «È vero. E poi Tata e il suo contatto, a cui doveva passare la variante del progetto, correrebbero il rischio di essere arrestati. La polizia austriaca non è tenera con i movimenti indipendentisti; ce ne sono troppi, gli italiani, gli 72 73 ungheresi, i cechi, e minano la saldezza dell’impero». D’un tratto Enrico divenne cosciente del fatto che Sigi non aveva niente contro l’Austria. Cosa gliene importava a lui dell’indipendenza di Trento e Trieste? Con aria imbarazzata il ragazzo disse: «Se non ti va di essere immischiato in questa storia, lo capisco. In fondo, non ti riguarda». «Certo che mi riguarda! A quanto ho capito, il progetto dell’ingegner Negrelli era perfetto. Che sia trentino, austriaco o di Vattelappesca, ha diritto che il suo lavoro venga riconosciuto. Perciò sono con te!». «Bravo, Sigi, bel discorso» rise Enrico. «E adesso come mettiamo in pratica questa bella teoria?». «Non lo so, dobbiamo escogitare un piano. Conosciamo il nome di uno dei capi delle spie austriache che vogliono impedire l’inaugurazione del Canale: Blitz. Sappiamo che il loro quartier generale in città è l’Universität Hotel. Cerchiamo di metterci in contatto con il signor Blitz per proporgli uno scambio: il falco egizio, vuoto, in cambio del silenzio». «Mio padre sarebbe felice di recuperare il suo reperto antico. Ma a noi, della statuetta, cosa ce ne importa, scusa?», domandò Enrico. «Non hai capito. È una trappola, un modo per farli uscire allo scoperto». «E quando gli austriaci sono usciti allo scoperto, come la mettiamo? Abbiamo già detto che rivolgerci alla polizia è escluso». «A questo punto interverrà il movimento per l’indipendenza. Dovranno rapire Blitz, o chi si presenta all’appuntamento, e ottenere la variante dal progetto in cambio dell’austriaco». 74 Enrico guardava Sigi perplesso, complimenti, aveva fegato! L’aveva sempre considerato molto simpatico, ma un po’ troppo sgobbone, e adesso ragionava come un’autentica spia, anzi contro-spia! «Dovremo parlare con gli indipendentisti italiani. Neanche Tata li conosce, ha visto solo il tizio che l’ha contattata». «Il suo contatto a sua volta ne conoscerà un altro, e via dicendo, fino ad arrivare ai capi. Manderemo un messaggio. D’altra parte, questo piano ha senso solo se è messo in atto da qualcuno della tua famiglia che ha un vero interesse a recuperare la statuetta». «E dato che è un piano che fa acqua da tutte le parti, e sembra concepito da un bambino, gli austriaci ci crederanno solo se a trattare con loro sarà un ragazzino», concluse Enrico, ridendo soddisfatto. Mentre chiacchieravano, i due amici si erano incamminati come per istinto verso l’Universität Hotel. Si fermarono davanti alla porta girevole dalle maniglie d’ottone dell’albergo. Scrutarono la sua facciata, non imponente: era discreto, non troppo di lusso, non troppo sordido, una via di mezzo che permetteva alle spie austriache di non dare nell’occhio. Era frequentato dai professori dell’Università e dalle loro famiglie, oltre che da qualche viaggiatore di commercio che voleva un albergo in pieno centro. Si trovava in una stradina stretta e facile da sorvegliare; girando intorno all’edificio Enrico e Sigi videro che le uscite secondarie dell’albergo erano più di una: il posto perfetto per uscire ed entrare senza controllo da parte del portiere dell’hotel. «Ci resta solo da informare gli indipendentisti che vogliamo parlare con uno dei loro capi. A quel punto ci of- 75 friremo come esca e dovremo convincerli che il nostro piano può funzionare». «Facile!», trillò allegro Enrico. Sigi lo guardò con aria dubbiosa, si era sempre chiesto come facesse Enrico ad avere quell’inesauribile riserva di ottimismo. Voltato l’angolo sbatterono contro un soprabito nero maschile. Mentre Enrico biascicava qualche scusa, Sigi alzò lo sguardo al viso dell’uomo e si sentì gelare il sangue. Non c’erano dubbi, quello era l’estraneo che stava seguendo i fratelli Pagani nel quartiere ebraico! Sigi strattonò la manica dell’amico e lo trascinò via. Corse a perdifiato, guardandosi alle spalle di tanto in tanto per controllare di aver seminato la spia austriaca. Questa era stata presa alla sprovvista dalla fuga dei due passanti, ma la sua mente aveva lavorato in fretta e una frazione di secondo dopo li aveva riconosciuti. L’uomo si era buttato all’inseguimento, ma due ragazzini in mezzo alle strade affollate e strette del centro della città riescono a svicolare in fretta. Ben presto li aveva persi di vista. Enrico seguiva Sigi recalcitrante, di tanto in tanto strillava: «Cosa ti è preso? Vuoi fermarti, accidenti?». Sigi non perse tempo in spiegazioni, se la spia li acchiappava li avrebbe costretti a confessare quello che sapevano, avevano i loro metodi. Oltre al pericolo, il loro piano sarebbe andato in fumo. Finalmente, sicuri di averlo seminato, si fermarono con il fiatone. «Mi devi una spiegazione», disse Enrico ansimando. Sigi gli raccontò dove aveva visto l’uomo con il pastrano nero. «È evidente che le spie austriache ci tengono d’occhio», 76 fu la deduzione del ragazzo triestino. «Non credo che oggi lui ci stesse tenendo d’occhio. È stato un caso, o non sarebbe mai venuto a sbattere contro di noi. Forse stava rientrando all’albergo. Io credo che l’altro giorno non seguisse te, ma tua sorella. Hanno paura che lei parli, che, nonostante le minacce di morte, racconti quello che ha visto quella notte». A queste parole, Enrico rimase di sasso. Non aveva paura per sé, ma Emma era un altro paio di maniche! Quando si riprese, le uniche parole che pronunciò furono: «Dobbiamo finirla con questa faccenda, e il più in fretta possibile». Enrico trascorse il resto del pomeriggio a convincere Tata ad inoltrare il messaggio. Si guardò bene dal rivelarle tutto il piano, altrimenti la ragazza si sarebbe rifiutata; disse solo che lui e Sigi avevano un’idea su come fermare le spie austriache e recuperare la variante del progetto, oltre al falco dell’avvocato Pagani. Alla fine la ragazza accettò e passò il messaggio al suo contatto, che promise di girarlo al suo. Trascorsero due giorni, in cui non successe nulla. Enrico non riusciva a prestare la minima attenzione alla scuola, ai compiti, alle sciocchezze che avevano riempito la sua vita fino a due giorni prima. Tutto, adesso, gli sembrava senza importanza, infantile e di una noia mortale. L’unico evento degno di nota fu che, un pomeriggio, convinse Sigi a fumare di nascosto uno dei sigari di suo padre. L’esperimento finì male, Sigi si limitò a tossire come un matto, sostenendo però che il sapore in fondo era buono, Enrico vomitò tutto il pranzo. 77 Dopo questo episodio, Sigi si immerse, come al solito, nello studio, ma sotto la calma apparente anche lui non vedeva l’ora di ricevere un segno dagli indipendentisti italiani. La risposta arrivò nel giorno sonnacchioso e tranquillo per eccellenza: la domenica mattina. Tata svegliò Enrico facendogli il solletico sul collo e chiedendogli se voleva accompagnarla alla Messa, nella chiesa di San Giovanni. Enrico, stupito e non del tutto sveglio, accettò. «Dovresti invitare anche il tuo amico Sigi», aggiunse Tata. «Sigi?», ribatté Enrico. «Ma se è ebreo! Cosa ci fa in una chiesa cattolica?». Tata sorrise degli occhi impastati di sonno di Enrico: «Tu digli che è interessante visitare i luoghi di culto di altre religioni. E digli anche che andremo noi tre soli. I tuoi fratelli resteranno con vostra madre». A quel punto Enrico era abbastanza sveglio da mangiare la foglia, si precipitò giù dal letto, si spruzzò qualche goccia d’acqua sulla faccia, si vestì e corse fuori ad avvertire Sigi. Appuntamento con Tata alle dieci davanti alla chiesetta cattolica di San Giovanni, non lontano da casa Pagani. Cadevano leggeri fiocchi di neve, che ovattavano i suoni della città. I due ragazzi arrivarono trafelati, i visi arrossati dal freddo e dalla corsa fatta per paura di essere in ritardo. Le campane della piccola chiesa suonavano per richiamare i fedeli alla funzione religiosa. Tata era in piedi davanti alla porta, i suoi vestiti con le cuciture un po’ storte la facevano sembrare asimmetrica. Aveva un’espressione tesa: «Prima assistiamo alla Messa, 78 poi andiamo in sacrestia. Lì qualcuno verrà a prenderci. Altro non so», furono le uniche parole che pronunciò. Durante la funzione, Sigi si guardava intorno con ansia. Ormai viveva nel terrore di vedere l’uomo con il cappotto nero spuntargli davanti. Nel gruppo di fedeli, però, il viso dell’uomo non c’era, e Sigi si accorse che tutti partecipavano alla funzione senza altri pensieri per la testa. Non gli era mai venuto in mente di assistere ad una cerimonia religiosa cattolica, ma adesso che era lì, lo trovava interessante. Enrico gli indicava di tanto in tanto le preghiere su un libricino e lui le recitava insieme agli altri. Quando il sacerdote ebbe impartito la benedizione, gli altri fedeli cominciarono a sciamare verso l’uscita. «Non restate lì impalati» bisbigliò Tata, «o attirerete l’attenzione. Muoviamoci lentamente verso la sacrestia». I tre varcarono la porta al lato dell’altare. Nella stanzetta si aspettavano di trovare il prete che aveva appena detto Messa, ma era già sparito. La sacrestia, che odorava di incenso e di muffa, era deserta. D’un tratto, una piccola porta laterale intagliata nello stesso legno che ornava il resto delle pareti, si aprì scricchiolando. Ne uscì un ragazzo di circa vent’anni, aveva la barba e indossava degli abiti un po’ sformati. Le mani erano grandi e callose, Sigi aveva notato tutti questi particolari in un secondo e concluse che si trattava di un operaio. «Seguitemi», si limitò a dire l’uomo. Attraversata la piccola porta di legno, si trovarono in un corridoio stretto e buio, illuminato, molto parzialmente, dalla lampada ad olio che l’indipendentista teneva in mano. Enrico e Sigi erano vigili, cercavano di capire dov’erano diretti, ma lo stretto corridoio curvava tanto spesso che 79 non era facile mantenere il senso dell’orientamento. Ad un certo punto inforcarono una scala e scesero. L’operaio sembrava essersi dimenticato della loro presenza. Tata rischiò di incespicare più volte negli scalini bui, e i ragazzi erano troppo occupati a non rimanere indietro per pronunciare parola. Dopo altri corridoi e giravolte, arrivarono in una stanza. Dovevano essere in un sotterraneo a giudicare dall’odore di muffa e dalla mancanza di finestre. La stanza era illuminata debolmente da alcune lampade. Nel mezzo troneggiava un tavolino, alle due estremità c’erano due ragazzi più o meno della stessa età del loro accompagnatore. Al centro una donna, la sua figura robusta e imponente occupava tutto il tavolo. Lei li guardò con aria severa e Sigi ebbe l’impressione di averla già vista. Si voltò verso Enrico e Tata e si accorse che erano letteralmente a bocca aperta dalla sorpresa. Allora Sigi si ricordò dove aveva visto la donna: la figura che avevano davanti, altri non era che Maria, la cuoca triestina di casa Pagani! 80 26 novembre 1866 Qualche secondo dopo «E tu cosa ci fai qui?», esordì Enrico; la domanda era idiota, ma non riuscì a trattenersi. «Volevate parlare con uno dei capi degli indipendentisti ed eccovi accontentati!», ribatté Maria con l’aria ancora più severa del solito. «Non potevamo parlare a casa? Era più comodo, ho il fiatone dopo tutti quei corridoi e quelle curve!». «Troppo pericoloso. E poi non è bene mescolare una vita con l’altra: quando sono una cuoca mi limito a cucinare, quando sono al comando dei miei ragazzi, è tutta un’altra storia». E in effetti, in quella cantina umida era chiaro che Maria non si limitava ad ammorbidire braciole, ma faceva morbido chiunque intralciasse la sua strada. Enrico era troppo preso dal digerire la sorpresa per poter aggiungere qualcosa. La cuoca, allora, con aria un po’ meno arcigna, si rivolse a Tata: «Ti devo delle scuse. Sono stata io a segnalarti perché ti arruolassero tra le nostre fila. Sei una brava ragazza. E poi mi serviva qualcuno per recuperare quel progetto nella statua egizia. Per me era troppo 81 rischioso, se qualcosa andava storto, come è successo, la polizia avrebbe preso di mira te, un semplice corriere, e avrebbe lasciato in pace l’organizzazione. Perdonami». Tata, ancora ammutolita dalla sorpresa, accennò ad un sì con la testa. In fondo ognuno doveva fare la propria parte secondo il proprio ruolo. «E adesso sentiamo questo vostro ingegnoso piano per recuperare la variante di Negrelli», concluse Maria incrociando le grosse braccia sul petto voluminoso e rivolgendo la sua attenzione ai ragazzi. Enrico e Sigi si scambiarono un’occhiata. Poi Sigi affibbiò una gomitata all’amico, il quale attaccò: «Grazie a mia sorella conosciamo un nome: Blitz e sappiamo dove gli austriaci hanno il loro quartier generale. L’idea è recapitare un messaggio all’Universität Hotel firmato da Sigi e da me nel quale scriveremo grossomodo così: «Sappiamo chi siete, abbiamo la descrizione dei due ladri, fornita dall’antiquario di mio padre, sappiamo cosa volete; o ci restituite il falco egizio o spifferiamo tutto alla polizia». «E, secondo te, gli austriaci sono così cretini da cascarci?», chiese Maria. Era la domanda che Enrico aspettava. Aveva la risposta pronta: «Sì, per il semplice fatto che siamo due ragazzini e gli adulti si aspettano sempre che i ragazzi facciano scemenze del genere». Maria sembrò convincersi di fronte all’inconfutabile risposta. «E poi? Ammettiamo che gli austriaci la bevano. Quando avrai recuperato la statuetta di tuo padre, cosa avrai dimostrato?». «La restituzione del falco è una trappola, il modo per attirare gli austriaci dove vogliamo noi. A quel punto, en- 82 trerete in azione voi. Dovrete rapire Blitz, o l’austriaco venuto all’appuntamento, e chiedere come riscatto la variante di Negrelli». Era stato Sigi a fornire la spiegazione dell’ultima parte del piano e l’aveva fatto con un tono di voce tanto deciso che l’operazione sembrava semplicissima. Il silenzio nella stanza buia era così intenso che si poteva tagliare a fette. Alla fine Maria parlò: «È rischioso». Enrico allargò le braccia come a dire «E con questo?». «Non è rischioso solo per i miei uomini, è rischioso anche per voi. Perché dovrei mettere in pericolo due ragazzini? Potrei tentare la trappola senza di voi». Fu Enrico a ribattere: «Funzionerà solo se sono due ragazzi a proporre lo scambio, l’abbiamo già detto, è un piano così stupido che ci crederanno solo se non ci sono in mezzo gli adulti. E l’unico ragazzo al mondo a cui può interessare quella statuetta sono io, dato che sono il figlio dell’uomo a cui l’hanno rubata». Il ragionamento filava, persino Maria doveva riconoscerlo. La cuoca scambiò un’occhiata con i due uomini seduti ai lati del tavolo. Quello che li aveva accompagnati, in piedi alle spalle del suo capo, parlò: «Si può fare. Attiriamo l’austriaco in un luogo non troppo affollato, ci appostiamo, gli diamo una legnata in testa e lo portiamo in un nascondiglio sicuro. Poi contattiamo gli altri all’Universität Hotel e proponiamo lo scambio che ci interessa sul serio». «Perché parli al singolare? Cosa ti fa pensare che gli austriaci non arriveranno all’appuntamento in più di uno?», chiese Maria, niente affatto convinta. «In tanti all’appuntamento con due ragazzini? Se abboccano, non si preoccuperanno troppo, al massimo saranno in due. E quei fetenti tratteranno per riavere il com- 83 pagno: le spie sono come le ciliegie, una tira l’altra, gli austriaci non possono rischiare che la polizia sgomini tutta l’organizzazione». «Ammettiamo che possa funzionare» continuò il capo degli indipendentisti, «come hai detto tu, il luogo dello scambio deve essere deserto. Ma io non ho il cuore di mandare due ragazzini in un luogo isolato, magari di sera. Troppo rischio!». «Ho già pensato al posto perfetto», queste ultime parole erano state pronunciate da Sigi. «Il Prater!». Maria e i combattenti per l’indipendenza si scambiarono un’occhiata. «Il parco della città? E perché sarebbe perfetto?», chiese la cuoca. «È allo stesso tempo affollato e deserto. All’interno ci sono molte piccole trattorie frequentate anche di sera, ma se ci allontaniamo dai viali principali, ecco che la folla sparisce quasi del tutto». Enrico guardò Sigi con ammirazione, questo dettaglio era nuovo anche per lui. Nessuno parlava. Tutti aspettavano con il fiato sospeso la decisione di Maria, la quale, alla fine, concluse: «Va bene. Ma voi due dovete considerarvi solo semplici corrieri. I corrieri obbediscono ciecamente agli ordini e nient’altro. Vi faremo sapere, tramite Tata, il giorno e l’ora dell’appuntamento». Enricò protestò: «Se non consegniamo noi il biglietto all’albergo, capiranno che è una trappola!». Maria sospirò. Era vero, tutto il piano si reggeva su quei due ragazzi e, francamente, presentava molti rischi, ma era l’unico appiglio che avevano per recuperare la variante di Negrelli. 84 «Va bene, vi diremo cosa scrivere sul biglietto. Poi, però, dovrete eseguire gli ordini alla lettera. Nella nostra organizzazione non c’è posto per chi agisce di testa propria. Mettereste in pericolo voi stessi e gli altri». Enrico e Sigi promisero di attenersi strettamente alle consegne. Poi i ragazzi e Tata salutarono e nessuno si preoccupò di riaccompagnarli fino alla sacrestia. Quando finalmente i tre riemersero nella stanza accanto alla chiesa, dopo un’interminabile mezz’ora trascorsa ad avanzare a tentoni per i corridoi bui, Tata aveva il fiatone e dopo tanto incespicare non solo il vestito, ma anche il suo cappellino era storto. Sigi sbottò: «Secondo voi, hanno voluto metterci alla prova?». «Non lo so», rispose Enrico. «Ma all’aria aperta del Prater sarà più facile. Senza contare che conosco il parco come le mie tasche, ci ho trascorso intere giornate quando ero piccolo, vero Tata?». La ragazza non aveva detto una parola, ma adesso affermò con aria decisa: «Enrico, io sono sempre dalla parte di voi ragazzi, ma questo non è un gioco. Tu non andrai all’appuntamento con gli austriaci. È troppo pericoloso. È mio dovere parlare con tua mamma e spiegarle tutto». I due ragazzi impallidirono. Era già stato abbastanza difficile farsi prendere sul serio dagli indipendentisti, e adesso arrivava Tata con il suo senso del dovere a rovinare tutto! «Ci rimetterai il posto di lavoro», ribatté Enrico. «Non m’importa. Tua mamma mi licenzierà, ma io avrò evitato che tu finisca nei guai». «E il movimento per l’indipendenza?», intervenne Sigi. «Il Canale di Suez che non sarà mai ultimato? Il buon 85 nome dell’ingegner Negrelli? Il buon nome di tutti i trentini e triestini?». Tata diventava più pallida ad ogni domanda. Sigi capì che quella era la strada giusta per convincere la ragazza. «Qui non si tratta solo dei rischi corsi da due ragazzi, c’è in ballo il buon nome dell’Italia, e anche il futuro degli scambi commerciali tra l’Europa e il resto del mondo. Una volta aperto il canale, sarà molto facile trasportare merce dall’Europa all’Africa e viceversa. Gli scambi commerciali non saranno più gli stessi, e chi siamo noi per impedire tutto questo?». Queste parole erano state pronunciate con tono solenne. In tono minore, Sigi aggiunse: « E poi gli indipendentisti saranno appostati nelle vicinanze, io ed Enrico dovremo solo riprendere la statuetta». Tata rispose che ci avrebbe riflettuto e poi avrebbe preso una decisione, ma i due amici capirono di averla quasi convinta. A quel punto si separarono: non c’era altro da fare che aspettare notizie. 86 27 novembre 1866 Ore 16,10 Il giorno seguente, Tata comunicò a Enrico il testo del biglietto per le spie austriache. La ragazza continuava a ripetere che era troppo rischioso, ma non ne fece parola con la signora Pagani. Il pericolo di essere fermati era scongiurato! Il pomeriggio i due ragazzi si ritrovarono a casa di Sigi, copiarono il messaggio e andarono a consegnarlo all’albergo: più sembravano sprovveduti e maggiori erano le possibilità che gli austriaci cadessero nella trappola. «Credi che prenderanno sul serio la minaccia di essere denunciati?», chiese Enrico che, sgonfiato l’entusiasmo iniziale, era pieno di dubbi. «Il messaggio contiene una descrizione precisa dei due ladri e del modo in cui sono entrati in casa tua. Sì, secondo me è abbastanza minaccioso: se andassimo alla polizia con queste informazioni, due dei loro agenti correrebbero il rischio di essere arrestati per furto e, come ha detto l’indipendentista, le spie sono come le ciliegie». Erano arrivati nei pressi dell’albergo. Il cuore batteva forte. I ragazzi si scambiarono un’occhiata, poi entrarono 87 nella porta girevole dell’albergo. La hall era tranquilla e silenziosa, e il portiere, un vecchio dall’aria bonaria a cui mancavano parecchi denti, domandò con gentilezza cosa desideravano. «Vorremmo lasciare questo biglietto per il signor Blitz», disse Enrico con decisione. Era il momento della verità. Se il portiere avesse risposto «qui non c’è nessun signor Blitz» il loro piano sarebbe andato in fumo. L’austriaco avrebbe potuto dichiarare un nome falso. Sigi, con il cuore in gola, si chiese perché non aveva pensato prima a questa eventualità. Era così ovvio! Una spia ha sempre documenti falsi, avrebbero dovuto prendere informazioni, cercare di scoprire il nome sotto il quale si nascondeva; così era tutto inutile, il loro piano falliva ancora prima di cominciare! «Certo, glielo consegnerò personalmente», rispose il portiere. Sigi non credeva alle proprie orecchie. I due amici imboccarono di nuovo la porta girevole che li sputò fuori. Si guardarono increduli. Ce l’avevano fatta! Ed era stato facilissimo. Adesso cominciava la parte difficile: aspettare pazientemente che trascorressero i due giorni stabiliti. «Non mi va di andare a casa adesso, sono troppo agitato», confessò Sigi. «Anch’io», ammise Enrico. «Allora cosa facciamo? Gironzoliamo per la città?». «Ho un’idea migliore. Facciamo quello che faccio sempre quando sono nervoso o depresso», Enrico tirò Sigi per una manica. Si incamminarono verso casa Pagani, ma nella Herrenstrasse si fermarono davanti a Demel, la famosa 88 pasticceria. Enrico spinse il battente della porta ed entrò, seguito dall’amico. L’alto bancone di vetro mostrava vassoi traboccanti di paste, dolci e leccornie di ogni tipo. «Rimpinziamoci!», propose Enrico. «Io non ho un soldo», confessò Sigi. «Non ne hai bisogno, mia madre ha il conto aperto in questo negozio. Prendi pure tutto quello che vuoi». «Ciao, Enrico, cosa posso servirti?», chiese in quel momento la commessa, a cui il ragazzo fece la sua lunga ordinazione. Poi fu la volta di Sigi. «Non fare il timido», lo incoraggiò Enrico con generosità. E lui mise da parte la buona educazione e la timidezza e ordinò una fetta di torta al cioccolato coperta di panna, una pasta alle mandorle, un bignè con una curiosa glassa verdolina, un budino tremolante e pasticcini assortiti, tanto per cominciare. Mentre affondava la forchetta in quel bendiddio, Enrico lo apostrofò: «Non credo che questi dolci siano kasher. Un ebreo non dovrebbe mangiarli». «Non distrarmi, immergere la forchetta in una fetta di dolce per afferrare il primo boccone è un’esperienza quasi mistica», fu la risposta. E cominciò a demolire la panna montata. 89 29 novembre 1866 Mercoledì, ore 18,00 davanti alla cucina del ristorante La Casseruola ungherese, al Prater. Questi erano la data e il luogo dell’appuntamento per la consegna del falco. Le parole sembravano non abbandonare mai la mente dei due ragazzi, che ebbero non poche difficoltà a concentrarsi sui problemi scolastici. Finalmente arrivò il fatidico mercoledì. Le ore al ginnasio scorsero confuse, né Enrico né Sigi avrebbero saputo dire cosa avevano studiato, cosa era successo, di cosa avevano parlato i professori. Suonò la campanella. Era finita! I due amici si diedero appuntamento per il pomeriggio a casa Pagani. Tata avrebbe fornito le istruzioni. Poi sarebbe cominciata l’avventura. Era una giornata fredda e umida d’autunno inoltrato. Durante la mattina il sole aveva riscaldato la città, ma mentre i ragazzi si dirigevano a piedi verso il parco, calò l’oscurità. Era quello che volevano, il buio, reso ancora più impenetrabile dalla nebbia di umidità che si stava già sollevando nei vialetti del parco, come fumo gelido. La neve era ammucchiata ai lati dei vialetti e dato che non nevi- 90 91 cava da qualche giorno, era sporca e annacquata. Enrico e Sigi continuavano a ripetersi, strada facendo, che sarebbe stato facile, uno scherzo, che ci voleva? Bastava ritirare la statuetta e promettere il silenzio. Al resto avrebbero pensato gli amici di Maria e Tata. Le due donne non avrebbero mai permesso che Enrico e il suo amico corressero rischi inutili. Fidati, è semplice, vedrai, tutto filerà liscio. A pochi passi dalla porta della cucina della Casseruola ungherese Sigi e Enrico aspettavano battendo i piedi, non si sa se per il freddo o per il nervosismo. Il ristorante era una piccola costruzione bassa, verniciata di giallo ocra, in mezzo al parco. Era una trattoria famosa, buon cibo ungherese e ambiente intimo ne facevano una delle mete preferite degli ufficiali dell’esercito e delle loro amiche. All’entrata principale, un via vai di gente elegante passava tra i tavolini e le sedie di ferro battuto, lasciate all’esterno perché i clienti si godessero il caffè dopopranzo, nelle giornate di sole. Il gazebo che serviva in estate per l’orchestrina aveva l’aspetto un po’ malinconico con una spolverata di neve sul tetto. I ragazzi perlustravano con lo sguardo i dintorni, cercando di individuare l’austriaco che doveva consegnare la statuetta. Sarebbe venuto Blitz in persona, o uno dei due che si era introdotto in casa Pagani e aveva rubato il falco? Erano già dieci minuti che Enrico e Sigi si indicavano a vicenda le possibili spie, uno era troppo grasso, l’altro aveva i tratti troppi slavi per essere austriaco, il terzo era in compagnia di una signora… D’un tratto, lo scricchiolio di un ramo spezzato alle spalle. I due amici si voltarono e si trovarono davanti uno sconosciuto né basso, né alto, né grasso, né magro, niente baffi, insignificante era l’u- 92 nico termine per descriverlo. Non era Blitz, evidentemente lui era troppo sferico per le missioni sul campo. Enrico e Sigi si erano preparati un discorso, credevano di essere pronti ad affrontare il nemico, ma al momento giusto non riuscirono a spiccicare parola e restarono impalati con un’espressione idiota sulla faccia. «Ho con me l’oggetto», sussurrò la spia austriaca, padrona della situazione, mostrando un pacchetto sotto il cappotto. Enrico fu il primo a recuperare il sangue freddo. «Non qui» esclamò con tutta la decisione che riuscì a racimolare. «Ci segua». I ragazzi si avviarono verso un vialetto laterale. In una piazzola troneggiava un grande faggio, per loro era un posto familiare: ai piedi dell’albero c’erano tre panchine, era il luogo d’incontro delle tate con le loro colleghe. Lì Enrico e Sigi avevano mosso i primi passi, si erano arrampicati sui rami più bassi approfittando di un attimo di distrazione della tata o della mamma, avevano giocato a nascondino con gli amici. L’austriaco li seguiva qualche passo più indietro. Arrivati vicino al faggio i ragazzi si fermarono. «Come faccio ad essere sicuro che non direte niente alla polizia?», chiese l’agente austriaco. «Ha la nostra parola d’onore», rispose Sigi con solennità. L’uomo lo guardò come fosse appena uscito da un manicomio. Enrico capì che dovevano trovare un argomento più convincente. «A noi interessa solo la statuetta. Quello che conteneva non è affar nostro». 93 L’uomo insignificante estrasse lentamente il pacco dal cappotto. Lo consegnò a Sigi, il quale cominciò a strappare la carta. Sotto apparve il legno dipinto. Aveva l’aria antica e rappresentava un uccello, su questo non c’era dubbio, ma lui non aveva mai visto l’originale, come essere certi che si trattava del vero falco? Stava per passare la statuetta all’amico, quando da un cespuglio spuntò una figura: con gesti fulminei gettò un cappuccio sulla testa di Enrico, lo stordì con un manganello, se lo caricò sulle spalle e se la diede a gambe. Tutto era avvenuto in una frazione di secondo. Mentre Sigi guardava il complice dell’austriaco rapire Enrico, gli italiani avevano tramortito l’uomo che aveva consegnato il falco, il quale avrebbe dovuto, con ogni probabilità, colpire e incappucciare Sigi. Il ragazzo era rimasto immobile, solo, nessuno si interessava a lui, il falco stretto in mano; d’un tratto si rese conto che stava a lui liberare Enrico, nessun altro sarebbe intervenuto. Da dietro il cespuglio, dove gli uomini di Maria avevano trascinato la spia austriaca, provenivano rumori di lotta. Non era facile immobilizzare un uomo addestrato e trascinarlo via. Gli italiani, soltanto due, avevano il loro daffare, non potevano occuparsi di Enrico. Sigi si gettò all’inseguimento del rapitore. La statuetta gli era scivolata di mano, ma non aveva importanza, il ragazzo riusciva a pensare solo all’amico. Corse a perdifiato sulle tracce dell’uomo, il quale non poteva muoversi veloce, impedito dal corpo sulle spalle. Sigi continuò a correre, si guardò intorno: nessuno, i vialetti laterali del Prater a quell’ora erano deserti. Nessuno a cui chiedere aiuto, nessuno che potesse fermare il rapitore. Sigi continuò 94 a correre, stava recuperando terreno, ma non era abbastanza veloce; si rese conto che la spia si dirigeva verso una delle uscite laterali del parco. Se ci arrivava, Enrico sarebbe stato caricato su una carrozza e tanti saluti. Lui doveva raggiungerli prima, ma di questo passo non ce l’avrebbe fatta, il fiato cominciava a mancargli, era stanco, sentiva il cuore rimbombargli nelle orecchie. Doveva pensare, usare il cervello. All’improvviso capì che il rapitore non avrebbe osato abbandonare il vialetto: non conosceva il Prater come lui, non ci aveva mai giocato ad acchiapparella, non aveva mai fatto navigare barchette di carta nei suoi rigagnoli. Sigi sapeva che, lasciato il vialetto e svoltato a sinistra, avrebbe tagliato e raggiunto di nuovo il viale più avanti. Era una scorciatoia. E se il rapitore abbandonava a sua volta il viale? Se non era diretto all’uscita laterale, ma un complice lo aspettava da un’altra parte? In quel caso lo avrebbe perso di vista per sempre, e con lui Enrico. Doveva rischiare? In certi momenti non è il cervello a decidere, ma l’istinto. Sigi si buttò a sinistra, e corse, corse. Raggiunse di nuovo il viale. Nessuno in vista. Raccolse da terra un lungo ramo di un albero e si appostò, il più vicino possibile alla strada, nascosto tra le piante. Seguirono secondi interminabili. Sigi non sentiva nessun rumore, nessuno stava percorrendo il vialetto. Finalmente dei passi si avvicinarono, alla fioca luce della luna, scorse una sagoma che trasportava un sacco in spalla. Era lui! Era il rapitore! Non correva più, forse pensava che Sigi si fosse perso, nel buio, nell’intricato reticolo di viali e vialetti del parco. Camminava spedito, e nell’istante in cui gli passò davanti, il ragazzo allungò il ramo e lo 95 piazzò proprio tra le gambe del rapitore. L’uomo inciampò, ostacolato anche dal carico, cadde a terra. Non c’era un minuto da perdere. Sigi aveva adocchiato un bastone più corto e più robusto di quello con cui aveva fatto lo sgambetto. Lo raccolse, si avvicinò all’uomo stordito a terra e glielo abbatté sul cranio. L’uomo sembrava svenuto. Sigi si precipitò a liberare Enrico dal cappuccio. Anche lui sembrava svenuto, se non peggio. Il ragazzo si sforzò di essere ottimista, ma Enrico doveva riprendere conoscenza, non ce l’avrebbe mai fatta a trascinarlo privo di sensi, era troppo pesante. Lo scosse, lo schiaffeggiò, cercò di rimetterlo in piedi. Finalmente lui sbattè le palpebre, era frastornato ma vigile. «Alzati, appoggiati a me e cammina», gli ordinò. «Cosa è successo?», domandò l’altro, confuso. «Te lo dirò dopo. Adesso muoviti». Enrico obbedì. Si rimise in piedi, camminò. E piano piano, mentre avanzavano nel buio, riacquistò lucidità e forze. «Cosa facciamo, adesso?», chiese quando la situazione gli apparve chiara. «Proviamo a tornare alla Casseruola ungherese. Forse gli amici di Maria ci verranno a prendere là, come d’accordo». «Ne dubito, ma è l’unica possibilità che abbiamo», ribatté il ragazzo triestino. Tagliarono per tutte le scorciatoie che conoscevano, era buio pesto, ma in quel parco potevano avanzare anche a occhi chiusi. Sbucarono sul viale principale, a pochi passi da dove era stato teso l’agguato. Enrico si diresse deciso verso sinistra. «Dove vai? Il ristorante ungherese è a destra», disse Sigi. 96 «Lo so, ma hai detto che il falco ti è caduto di mano mentre correvi per inseguirmi. Forse facciamo in tempo a ritrovarlo». Era pericoloso, e se un complice degli austriaci fosse stato ancora in circolazione? «Vabbe’», acconsentì Sigi. «Ma cerchiamo di sbrigarci». Il luogo dell’agguato era deserto. La luce arrivava fioca dai lampioni a gas del viale principale. Della statuetta neanche l’ombra. «Non ricordi se l’hai gettata da qualche parte, prima di metterti a correre?», chiese Enrico. «Non mi pare, ma in fondo cosa te ne importa del falco egizio?». «Non lo so, ma tutto è cominciato con quella statuetta, e con quella vorrei chiudere». «Anch’io vorrei chiudere e tornare a casa. Con mia madre non sono stato molto preciso sui miei programmi del pomeriggio. Se i miei scoprono quello che è successo, mi fanno nero». «I tuoi possono non scoprirlo mai, ma Tata ha già dichiarato che racconterà tutto per filo e per segno. Sarà divertente, non mi perderei la scena per niente al mondo!». Mentre parlavano continuarono a setacciare con il piede il suolo lì intorno. Ad un certo punto, la scarpa di Sigi urtò contro un oggetto di legno che emise un toc. «Il falco!», esclamò raccogliendo la statua. «E adesso muoviamoci». In pochi secondi raggiunsero la Casseruola ungherese, ma non c’era nessuno ad aspettarli. Enrico e Sigi si guardarono sconsolati, adesso sì che sarebbero arrivati tardi a casa! E cosa avrebbe fatto il rapi- 97 tore, una volta ripresi i sensi? Si sarebbe messo a cercare i ragazzi, era evidente! Stavano già per avviarsi verso l’uscita del parco, pregando di non fare brutti incontri, quando dalla cucina giunse la voce robusta di Maria. «Questa è la densità giusta per il gulash!». Possibile che la cuoca se ne stesse a chiacchierare spensierata con il suo collega ungherese? Enrico si affacciò in cucina. Non appena lo vide, Maria salutò tutti affabilmente e uscì. «Dove eravate finiti? Cosa è successo?», li aggredì, sfogando l’ansia che aveva nascosto davanti ai colleghi del ristorante. «Adesso ti raccontiamo tutto. Tu intanto dimmi cosa c’è in quella pentola», ribatté Enrico, indicando l’oggetto che la donna teneva energicamente in braccio. «Gulasch ungherese» spiegò Maria, «in altre parole, la vostra cena. Lo spaccerò per uno dei miei manicaretti: questa sera non avevo né il tempo né la fantasia di mettermi in cucina. Adesso sbrigatevi, c’è una carrozza che ci aspetta. E nel frattempo, vuotate il sacco». Parlando raggiunsero rapidamente l’uscita senza altri intoppi. La carrozza pubblica era lì per loro, vi salirono e a Sigi quei sedili di velluto un po’ consumati e sfilacciati non erano mai sembrati così morbidi e accoglienti. Sospirò di sollievo. A quanto raccontò Maria, l’agente austriaco era nelle mani degli indipendentisti. I suoi complici sarebbero scesi a patti. La cuoca era ottimista, forse tra pochi giorni la variante di Negrelli sarebbe ritornata in Egitto. Anche Enrico era raggiante. «Tieni» disse all’amico mettendogli il falco egizio sulle ginocchia, «te lo meriti. Sono sicuro che anche mio padre sarà contento che lo ab- 98 bia tu, quando gli avrò raccontato quello che hai fatto. In fondo hai salvato la vita a suo figlio e sua figlia mangia di nuovo con appetito». Sigi cercò di schernirsi, di restituire la statuetta all’amico, ma lui non sentì ragioni. Cullato dallo scalpiccio del cavallo della carrozza che li riportava a casa, Sigi guardò per la prima volta con attenzione il falco egizio. Era bellissimo, di legno colorato, parlava di una civiltà scomparsa, di faraoni mummificati, di grandi tombe cotte dal sole africano. Che sensazione aveva provato l’archeologo che l’aveva riportato alla luce? Scavare tra la polvere, senza nessuna certezza di trovarsi nel punto giusto, guidati solo da un’intuizione. E poi il rumore della pala che sbatte contro un oggetto, la piramide portata alla luce, con lentezza e fatica dissotterrata dalla sabbia. Sigi aveva l’impressione di conoscerla, quella sensazione di trionfo. E d’un tratto si rese conto che era quella che aveva provato quando aveva riportato in superficie il segreto di Emma, quando l’aveva liberata dal suo blocco allo stomaco, anche lui guidato solo da un’intuizione. E capì che Enrico aveva ragione, lui quel falco se lo era davvero guadagnato. «Grazie», si limitò a dire emozionato. Cos’altro poteva aggiungere? 99 LA STORIA Trento e Trieste furono annesse all’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. Il canale di Suez fu inaugurato nel 1869. (Freiberg, 6 maggio 1856 - Londra, 23 settembre 1939) diventò medico nel 1881 e si dedicò a curare la psiche umana. Attraverso l’ipnosi, prima, e il metodo catartico poi, cercò di far uscire allo scoperto i traumi che erano alla base dei sintomi nevrotici dei suoi pazienti. In questo modo ha rivoluzionato il nostro modo di pensare. La sua collezione di reperti antichi, soprattutto egizi, è diventata famosa quasi quanto lui. Sigmund non si staccava mai dalle sue statuette: erano esposte nel suo studio, molto simile a quello dell’avvocato Pagani, dove i pazienti si stendevano sul famoso divano. Tra le statuette spiccava un falco di legno egizio. Come l’avvocato, anche lui fumava il sigaro e si vestiva con eleganti completi di tweed inglese. 100 CHI SARANNO… Sigmund Freud INDICE Egitto, anno 1866 - Settembre 1866 5 21 novembre 1866 - Ore 12,40 9 22 novembre 1866 - Ore 8,10 23 22 novembre 1866 - Ore 16,40 35 23 novembre 1866 - Ore 9,50 45 23 novembre 1866 - Pochi minuti più tardi 61 24 novembre 1866 - Ore 16,05 71 26 novembre 1866 - Qualche secondo dopo 81 27 novembre 1866 - Ore 16,10 87 29 novembre 1866 - Mercoledì, ore 18,00 91
Scarica
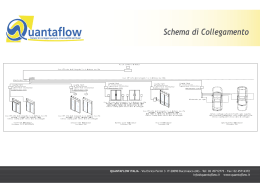


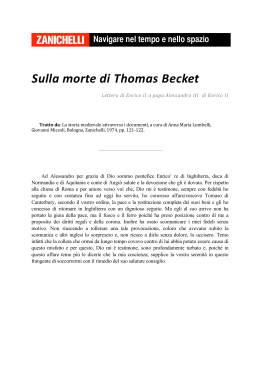
![Le monarchie nel `400 [a]](http://s2.diazilla.com/store/data/000083959_1-ca5d74ee92225e39e6e3647f024bfecf-260x520.png)