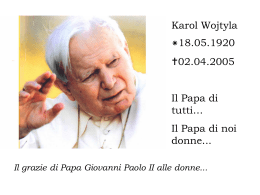Domenica La di DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 Repubblica l’inchiesta Orfanotrofi, addio alla favola triste FILIPPO CECCARELLI e MARIA NOVELLA DE LUCA il racconto Le feste e l’odio nella Gerusalemme inglese SANDRO VIOLA La sua malattia tiene in allarme il mondo. Ma chi è davvero Papa Wojtyla? Jerzy Kluger e Krzystof Zanussi lo conoscono bene e lo raccontano Il mio amico Karol FOTO CRISTIANO LARUFFA/AGF ANTONIO GNOLI PAOLO RUMIZ e fosse un racconto di Singer, Wadowice sarebbe un grande villaggio e i protagonisti della nostra storia due bambini leggeri come un quadro di Chagall. Se fosse un dramma di Bernanos, vedremmo le due stesse figure camminare con gli occhi pieni di domande in mezzo a quegli anni terribili che scossero le certezze e resero alla fine la fede più salda. Jurek e Lolek si conobbero all’età di cinque anni. Era il 1925. Jurek e Lolek erano i soprannomi di Jerzy Kluger e di Karol Wojtyla (sopra in una foto recente con la nipotina di Kluger). Non conoscevano nulla l’uno dell’altro. Non sapevano che erano destinati a fare un lungo tratto di strada assieme, poi a perdersi e infine ritrovarsi. Ma così è la vita: imprevedibile. Come trovarsi un papa per amico. Oggi Kluger ha 84 anni, la stessa età del pontefice. È un uomo che sembra avere sulla vita una presa particolare. (segue nella pagina successiva) on ne parleremo mica solo perché ha un raffreddore…», scherza il regista polacco Krzystof Zanussi, 63 anni, amico personale di Wojtyla e autore dell’unico film biografico su di lui. Lo scherzo è più di una scaramanzia. È l’esorcismo di chi ha fatto abitudine all’autunno infinito del grande vecchio, alla sua infermità vittoriosa esposta come una bandiera. È l’ansia di un popolo che in pochi mesi ha perduto due grandissimi — Czeslaw Milosz e Jacek Kuron — e ora non si rassegna al tramonto di chi gli ha dato luce dopo un secolo di piombo. Zanussi lo conosce come pochi. Ha riso con lui, ascoltato i suoi silenzi, misurato da regista i toni della sua voce e i riflessi del suo corpo. Ha mangiato zuppa di rape rosse alla sua tavola, assistito alle sue preghiere, imparato a memoria i tempi del suo humour “differito”. (segue nella pagina successiva) S «N le storie I bimbi schiavi dei cammelli da corsa GABRIELE ROMAGNOLI i luoghi Las Vegas, la città capovolta VITTORIO ZUCCONI le tendenze La vita è un giro di tavolo MICHELE SERRA 22 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 la copertina Il Papa malato Jerzy Kluger ha passato la giovinezza a Wadowice accanto al piccolo “Lolek”, poi lo ha reincontrato a Roma da papa. Ora racconta la scuola, lo sport, il teatro, le infatuazioni di due ragazzini polacchi alle soglie della guerra. E gli incontri di oggi tra un ebreo e il pontefice dei cattolici, uniti non dal “compromesso” ma dalla “comprensione” “Il mio amico Karol Wojtyla” H ANTONIO GNOLI (segue dalla copertina) a esplorato la sua biografia, costruito film su di lui e messo in scena le sue opere giovanili. Ancora lavora alla sua azienda, gioca a tennis. Rievoca un lontano torneo di Wimbledon cui partecipò nel 1947: «Nel singolo fui eliminato al primo turno», dice. Il ricordo lo distoglie per un attimo dall’apprensione per l’amico Karol. Pensa al peso delle responsabilità, alla malattia che lo ha infragilito fino al punto da metterne a repentaglio la vita. Apprende con sollievo che il bollettino medico è favorevole. Guarda una foto che lo ritrae con il pontefice, in una visita di tanti anni fa. Hanno l’aria distesa, quasi sorridente. Accanto a una bambina — la nipotina di Kluger — sembrano due vecchi ragazzi cresciuti in fretta, complici le strade di Wadowice, il campetto di calcio, il piccolo teatro, dove Karol amava recitare. Come vi siete conosciuti? «Vivevamo nella stessa città, andavamo nella stessa scuola, frequentavamo la stessa classe. Così ci siamo conosciuti: come due bambini curiosi l’uno dell’altro, felici di frequentarci. Karol viveva vicino a una grande piazza, in un appartamento di un palazzo che apparteneva a un ebreo. Il proprietario era uno strano personaggio che vendeva biciclette. E ricordo quante volte io e Lolek abbiamo desiderato averne una per potercene liberamente andare in giro». Abitavate nello stesso palazzo? «No, vivevo all’estremo opposto della piazza. Con i miei genitori occupavamo il primo piano di un edificio che apparteneva a mia nonna». La sua famiglia era ricca? «Mio padre era un avvocato, la famiglia di mia madre aveva un commercio di liquori». E com’era Karol a cinque anni? «Non deve pensare a un bambino speciale. Faceva le cose che l’infanzia dettava. C’era in lui, forse, una maggiore consapevolezza, una maturità precoce. Ma amava come tutti noi giocare e divertirsi». Che genere di giochi praticavate? «A me piaceva sciare e giocare a ten- nis. Lolek amava le escursioni in montagna e il calcio. Ricordo che durante il ginnasio avevamo allestito un squadretta che sfidava le altre classi». E Karol in che ruolo giocava? «In porta. Si arrabbiava quando nella concitazione del gioco, o magari davanti a qualche scorrettezza, qualcuno esplodeva con ingiurie, in particolare se quelle ingiurie avevano un tono antisemita». Nella Polonia dei primi anni Trenta c’erano forme di antisemitismo? «C’erano, ma a Wadowice non erano così forti. Lo diventeranno in modo tragico dopo il 1935, con la morte del Maresciallo Pilsudski». Com’era la famiglia Wojtyla? «Non era una famiglia ricca, se è questo che vuole chiedermi. Decorosa, sì, con un padre straordinario». Che cosa aveva di straordinario? «Era stato un ufficiale dell’esercito austriaco che dopo il crollo dell’impero era entrato nell’esercito polacco. La sua salute cagionevole lo obbligò ad andare in pensione molto presto. Credo che passasse molto del suo tempo a leggere. Era un autodidatta, ma ricordo le sue lezioni di storia. Io e Lolek stavamo ore a sentirlo raccontare le vicende della storia polacca. Nessun professore del ginnasio che frequentavamo avrebbe saputo creare un interesse altrettanto forte in noi ragazzi quanto il signor Wojtyla con i suoi racconti». Aveva anche un nome? «Ovviamente, ma per noi era il signor Capitano». Karol era figlio unico? «No, aveva un fratello più grande, che morì quando Lolek aveva undici anni. Diventato medico, fu chiamato in un istituto di ricerca a Bielsko, nella Slesia. Nel suo laboratorio sperimentavano vaccini contro la scarlattina. E fu il contagio di questa malattia a portarselo via. Per Karol fu un colpo terribile. Anni prima aveva già perso la madre e ora il fratello. Tornò a scuola dopo qualche giorno e mi colpì la sua grande maturità nel sopportare il dolore». Avete percorso assieme un lungo tratto scolastico. Com’era Karol a scuola? «Bravo, in particolare nelle materie umanistiche, nelle quali eccelleva. C’è un episodio che mi torna alla mente e che riguarda il nostro passaggio al ginnasio, per il quale occorreva un esame che sostenemmo. Seppi del risultato favorevole per entrambi e volli comunicarglielo. Quella mattina Lolek si trovava in chiesa a servire messa. Così entrai per la prima volta in una chiesa e lo vidi che svolgeva le sue funzioni». Che cosa accadde? «Mi fece cenno di aspettare la fine. E in quel momento una vecchia beghina mi scrutò chiedendomi se ero il figlio dell’avvocato Kluger, capo della comunità ebraica. Io dissi sì. E lei sbottò dicendo che non capiva per quale motivo un ebreo entrava in una chiesa. Non risposi e mi allontanai. Quando finì la messa Lolek si avvicinò e gli comunicai che entrambi eravamo stati ammessi al ginnasio. La notizia lo lasciò indifferente. Mi chiese, invece, che cosa mi avesse chiesto quella donna e quando glielo riferii, rimase turbato. Quella donna non ha capito, così disse, che siamo tutti figli di uno stesso Dio». Si è spesso ricordato l’amore del Papa per il teatro, al punto che se non avesse fatto il prete probabilmente FOTO WEBPHOTO Krzystof Zanussi è il regista dell’unico film biografico sul Pontefice: “Amico? Ho conosciuto altri papi, questo è il solo che conosce me. Il primo che mi invita a mangiare accanto a lui. Ed è sempre un’emozione” (segue dalla copertina) S orride e racconta dell’amico Karol, un Papa mediatico che in realtà è un grande sconosciuto. Uno che non «mette in vendita» la sua anima profonda, mistica e di raccoglimento. Da quanto conosce il Papa? «Da decenni. Da quando lui era vescovo di Cracovia e io studente universitario, nella stessa città. Ci siamo conosciuti in casa di un mio compagno di studi, che aveva il padre professore. Una famiglia di origine italiana, come la mia, ma molto più antica. Vetulani si chiamavano. Immigrati in Polonia nel Medioevo». Si considera suo amico? «Ci sono quaranta milioni di polacchi che si sentono amici del Papa, e io sono uno di loro. Certo, ho mangiato alla sua tavola. Ma non voglio vantarmi di un rapporto personale, che tale deve restare. In fondo ho conosciuto direttamente anche Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I. La differenza è un’altra». Mi dica, qual è la differenza? “Un mistico che sa ridere con i clown” PAOLO RUMIZ «Questo è il primo Papa che conosce me. Il primo che mi invita a mangiare accanto a lui. Una volta, anche quando invitava un re, il Papa sedeva a un tavolo separato». Di lui si sa tutto, anche cosa mangia. «Si è scritto anche questo. Mangia polacco e italiano. Una simbiosi naturale, perché l’Italia ha influenzato la nostra cucina da secoli. L’uso delle verdure l’abbiamo imparato da voi. Ancora oggi si chiamano “roba italiana”». Esisterà pure un Wojtyla segreto. «Un lato invisibile di lui è il suo essere profondamente uomo di preghiera. Il Papa mistico non è mai diventato figura mediatica. È un aspetto di lui che non appare e non si vende. Ed è il suo volto più vero, forse». Lo ha conosciuto quel volto? «Sì. Parecchie volte. In momenti di grande stanchezza, digrandepressione.Allorapreferivapregare,perchélapreghiera lo ritemprava, più del riposo. La preghiera è il suo rifugio. Quando prega, qualsiasi altra attività lo infastidisce». Uomo dai sentimenti forti. «Questa è la parte di lui che si vede. Tutti abbiamo visto la sua irritazione, nel primo viaggio in Polonia. E la sua grande allegria, in altri momenti. Un giorno rise fino alle lacrime, senza controllo, davanti agli artisti di circo e ai loro giochi di prestigio. C’era autoironia, in questo…». Cioè? «L’uomo che doveva vagliare i miracoli veri, quelli dei santi, rideva dei miracoli falsi, dei saltimbanchi…». Com’è il Papa nell’intimità della conversazione? «Ha un senso dell’humour molto particolare, che viaggia su una reazione sfasata. A volte certe mie frasi cadevano nel silenzio, ho quasi creduto che non mi avesse sentito. Poi, mezz’ora dopo, arrivava la risposta, il commento, sempre molto spiritoso, sorprendente. Con un’autorità come la sua, il ping-pong di un’intervista è impossibile. Sceglie sempre lui quando replicare». Un esempio… «Non mi sembra giusto rivelare conversazioni private. Il rischio di essere strumentalizzati è molto forte, la discrezione è indispensabile. Posso parlare solo della tecnica, del suo modo di porsi». Come lo giudica da regista? «Wojtyla ha fatto teatro, e si vede. È un grande comunicatore che sa fare anche l’attore. L’impostazione della voce, il dominio dello spazio, i ritmi: tutto questo lo aveva già in mano fin da sacerdote». Parli della sua voce. «Era magnifica, ricchissima di toni, e sapeva usarla. Oggi non è più così, e per lui è una grande limitazione. Colpa del Parkinson e delle medicine che prende. In compenso scrive, più di prima». E il suo modo di abitare il corpo? «Mi piace il modo che ha di esporre senza imbarazzo malattia e vecchiaia. È curioso, i vescovi devono andare in pensione a 75 anni, i cardinali smettono di votare il Papa a 80. Gli unici che restano a oltranza sono i parroci e il Papa. Il basso e l’alto della piramide. Oggi Wojtyla è l’unico grande vecchio al mondo che si assume un ruolo di guida». Anche per i non credenti? «Anche. Il bisogno di una guida va oltre le confessioni. Gli ortodossi l’hanno capito. Il culto della forza fisica è una malattia della modernità. L’Occidente non capisce che la vecchiaia non è un ostacolo nella fede. Può esser- DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 23 FOTO GENTILE CONCESSIONE DE “IL GIORNALE” COMPAGNI DI CLASSE Nella foto grande qui sotto, Wojtyla (cerchiato a sinistra) e Jerzy Kluger (cerchiato a destra) in quarta elementare. A sinistra, il giovane Karol (secondo da destra in prima fila) durante il servizio di leva nel 1939. A destra, Lech Walesa. Nella pagina accanto, Kluger e, sotto, Krzystof Zanussi e una scena del film “Da un paese lontano” Ma lei ebreo e lui cattolico. Dov’era il punto di compromesso? «Compromesso è una parola inadeguata. Preferirei parlare di comprensione. La comprensione nasce dall’amore, il compromesso dall’interesse. E due ragazzi come noi avevano dell’amicizia un’idea disinteressata». Vi separaste nel 1938, quando vi siete rivisti? «Fu durante il Concilio Vaticano II, appresi da un giornale che a Roma, dove nel frattempo io mi ero stabilito, era arrivato un certo Karol Wojtyla, arcivescovo di Cracovia». E lei che fece? «Telefonai e presi un appuntamento. Ricordo che alloggiava nel convento di suore di via Cavallini. Ci vedemmo in un pomeriggio di primavera. Non lo trovavo molto cambiato, salvo forse per la veste che indossava e che gli conferiva un’autorità particolare. Passeggiamo a lungo per le strade limitrofe al convento. A un certo punto fummo invasi dalla tristezza al pensiero di coloro che non ce l’avevano fatta a sopravvivere alle atrocità del nazismo e della guerra. Ricordo la commozione che ci avvolse quando parlammo del nostro amico di infanzia Tadek Czuprynski che saltò su una mina alla fine della guerra». E come apprese della sua elezione a Papa? «Ero dal dentista, sulla stessa poltrona dove nel 1960 sedeva Cassius Clay per curarsi un improvviso mal di denti». Perdoni la digressione che c’entra il pugile Clay? «Il fatto è che nel 1960 io ero uno degli interpreti ufficiali accreditati alle Olimpiadi e accompagnai il pugile dal dentista. E il dentista, più di vent’anni dopo, rievocando l’episodio di Clay, all’improvviso mi dice: “Senti? hanno appena eletto il Papa”. La radio stava trasmettendo questa bella voce che mandava un messaggio. Il dentista disse: “Ma che razza di pronuncia ha?” E io: è la lingua di Wadowice. E lui: “Ma come fai a dirlo?” Abbiamo fatto la stessa scuola, risposi». Con il Papa avete continuato a vedervi? «Sì, con regolarità e compatibilmente con i suoi numerosi impegni internazionali». “Ma ora deve darsi tregua” FOTO ANSA LECH WALESA Le grandi responsabilità lo hanno cambiato? «Cambiato non è la parola giusta. Angosciato sì, per tutto quello che è accaduto e che sta accadendo nel mondo». Le ha mai parlato dell’attentato che subì in piazza San Pietro? «Non ne ha mai voluto parlare, almeno con me». Che immagine può darci di Karol Wojtyla privato? «Di un uomo straordinariamente piacevole. Scherzoso, conviviale, con un senso raffinato dell’umorismo. E conoscendo questo lato, mi addolora profondamente vederlo oggi così fragile ed esposto alla malattia». Le ho chiesto prima qual è il modo per un ebreo e un cattolico di incontrarsi. E lei ha parlato di comprensione. C’è solo questa? «Non penso che mi debba soffermare sulle differenze fra le due religioni. Quando Karol è diventato papa ha fatto il possibile e l’impossibile per colmare il divario delle incomprensioni e mi piace pensare che a questo abbia contribuito la sua gioventù a Wadowice». lo per un manager. Ma il vescovo di Roma non è un manager, e può delegare la gestione del potere. La sua autorità morale, invece, resta intatta con l’età». Un Papa guerriero? «Sicuramente la sua figura non è pacifista, se essere pacifistisignificatollerarelaviolenzaapplicataaglialtri,quella che non tocca il nostro orticello. Noi polacchi abbiamo sofferto di questo, quando nel 1938 i pacifisti europei non bloccarono sul nascere l’espansionismo di Hitler. La guerra è un male assoluto, ovvio. Ma a volte è il male minore». IlPapacombatteancora?Oseguelacorrentedelfiume… «Essere cristiani significa essere all’opposizione, e lui resta controcorrente. Due anni fa disse no alla guerra in Iraq, e non credo che abbia cambiato idea. Anche la sua posizione contro il consumismo è immutata. Wojtyla è più vicino ai giovani scontenti che a qualsiasi potente cui il mondo va benissimo». Non vede un Papa prigioniero? «Di che cosa?» Del Vaticano, di Roma, del portone di bronzo di San Pietro. «La sua risposta a questo rischio è stata immediata: i viaggi. Nessun Papa ha viaggiato tanto. Le sue trasferte non erano solo il modo per evangelizzare. Erano anche il suo modo per evitare la dipendenza dall’apparato. Un modo per dire: non sono un amministratore sedentario. Sono uno che cerca la gente, senza mediazioni». Un nomade inquieto... «Noi polacchi per cinquant’anni non abbiamo potuto viaggiare, in noi il nomadismo è una reazione alla claustrofobia da regime. Ma il Papa ha viaggiato da sempre, fin da quando era vescovo di Cracovia. Credo che in lui sia un istinto speciale. Quello di cercare lontano per immedesimarsi nell’Altro. E per mettere in discussione se stesso». Il suo è stato un papato spettacolare, televisivo. Non vede dei rischi in questo? «Altri papi hanno scoperto la forza della radio, o della carta stampata… No, non parlerei solo di rischi. Ci sono anche i vantaggi. La parola scritta ha portato alla laicizzazione del mondo; l’audiovisivo invece consente un contatto più sensuale, meno intellettuale, con la gente, e va al cuore dei sentimenti. Questo Papa dice di più con i suoi passi, i suoi sorrisi, con le sue fermate, che con le sue encicliche e le parole». Di nuovo il tono della sua voce. «Ah, ricorda il suo urlo in Sicilia contro la mafia? Attraverso quell’urlo è passata una scarica di emozioni che nessuna carta stampata poteva convogliare. Lo dico da uomo dell’audiovisivo». Ma la Tv non intercetta le penombre, i misteri della fede. «Il rischio che spariscano sarebbe reale se la vita della gente si riducesse allo schermo televisivo. Ma così non è. Questa possibilità non esiste. La Chiesa stessa non è video-dipendente». Il Papa ha conosciuto l’amore fisico pieno? «Non posso dirlo. Certo la mascolinità di Wojtyla è evidente, completa, multiforme. Il suo libro sulla sessualità fa capire che il celibato è stato per lui una scelta sofferta. È uno dei pochi sacerdoti che hanno capito fino in fondo l’immenso potenziale del rapporto uomo-donna». Il primo che guarda alla teologia dell’amore attraverso il corpo. «Una cosa è sicura. La divisione manichea tra corpo e anima che ha segnato la Chiesa per secoli sicuramente in Wojtyla non si presenta». Cosa ha capito facendo film su di lui? «Ho imparato l’impossibilità di raccontare artisticamente un simile personaggio da vivo. Non lo si può esporre in modo interrogativo, investigare sulle sue decisioni. Così ho lavorato su tutto il resto. Sulla Polonia, prima che su di lui. Per questo il film si chiama Da un Paese lontano». La Polonia lo ama. Ma lo capisce? «In che senso?» Nel senso che non lo prendono troppo sul serio quando attacca il consumismo neo-liberale. «È più facile capire la condanna di un regime, come quello comunista, che vivere seguendo inflessibilmente i dieci comandamenti, così come vorrebbe lui. Ma a discolpa dei polacchi voglio dire che è facile cadere nella trappola del consumismo, se per cinquant’anni non hai consumato». Le cose cambiano? «Il primo decennio di libertà è stato di consumo sfrenato. Oggi le cose cambiano. La nuova generazione capisce che esistono altri valori. I giovani sono molto più profondi dei loro padri. E capiscono meglio il Papa». Questa Chiesa non è troppo Wojtyla-dipendente? «Tra il Concilio di Trento e il secolo ventesimo non ci sono stati papi importanti. Le grandi figure sono una cosa recente. Anche Giovanni XXIII è stato una figura forte… Anche alcuni grandi mistici del medioevo… Il rischio di uno smarrimento, dopo, effettivamente può esserci. Ma la Chiesa è millenaria… Si ancora a ben altro…». ono passati appena due mesi dal mio ultimo incontro con il Santo Padre. Due mesi fa in Vaticano, egli mi apparve in buone condizioni. E ora eccomi qui a pregare per lui ogni momento. Perché abbiamo ancora bisogno di lui che ci insegnò a non avere paura, di lui senza la cui forza noi non avremmo vinto. Lui senza il cui sorriso sereno e coraggioso l’Europa di oggi non sarebbe l’Europa senza muri. Ricordo ancora quell’ultima delle tante volte che c’incontrammo in questi ventisette anni. Era dicembre, laggiù da voi a Roma. Fui invitato per un’udienza privata, ed egli mi chiese di trattenermi a colazione. Parlammo a lungo, di Dio e degli uomini, della Polonia e del mondo. Uscii con una grande gioia da quell’incontro in Vaticano. Perché con mia sorpresa, una sorpresa gioiosa che porto ancora nel cuore, egli mi sembrò lucido, attento, e molto più sano, forte, vigoroso di quanto non mi fosse apparso un anno prima, alle celebrazioni per il suo venticinquesimo anno di pontificato. Mentre prego commosso per lui, mentre il mio cuore è al suo fianco sperando nella sua guarigione, riguardo alla sua vita straordinaria e specialmente ai suoi ultimi anni. Io credo che il Santo Padre chieda troppo a se stesso. Il mio augurio, la mia speranza è che adesso, quando si sarà ristabilito, sappia concedersi un po’ di riposo, una tregua. Non per egoismo, ma perché c’è ancora molto che egli può fare per noi. Per tutti noi: non solo per noi cattolici, per noi cristiani. Per tutti egli sa essere la massima autorità morale. Mentre prego, ripenso a questi anni straordinari per la mia Polonia e per il mondo, questi anni con lui alla guida della Chiesa. Ricordo le prime udienze che egli concesse a me e ai miei compagni nella lotta per la libertà. Eravamo incerti, spesso confusi. Fu lui a dirci di non avere paura, fu lui a insegnarci il coraggio e l’ottimismo, lui fece capire a tutti la forza della non violenza. Senza di lui non avremmo sconfitto il comunismo, senza di lui Berlino sarebbe ancora divisa dal Muro, senza di lui la nostra patria e tutte le nazioni dell’“altra Europa” oggi non sarebbero libere. Senza quest’uomo straordinario, lasciatemi insistere, in questa parte del mondo non sarebbe mai avvenuto nulla. Le conquiste e le vittorie di noi leader politici, di semplici uomini come me, non sarebbero state possibili. Nulla è a volte l’azione, se non ha dietro di sé il Verbo. Questa è l’immagine del Santo Padre forte e vincitore, che abbiamo nei cuori. Oggi il suo ruolo di massima autorità e guida morale non è certo meno importante, né facile di ieri. E oggi, chi ricorda il Papa forte e vincitore di allora ama questo grande uomo ancora di più. Un sentimento quasi di tenerezza, di affetto per l’uomo anziano e provato, rendono l’amore per lui e il suo messaggio ancora più grandi. L’altro giorno, a Danzica, alla festa della Candelora le chiese erano ancora più piene del solito. Anche da noi in Polonia la società si fa più laica, ma questa evoluzione non affievolisce i sentimenti verso di lui. Seppe insegnarci il coraggio, l’ottimismo, il valore della vita allora e sa farlo anche oggi mentre soffre. Proprio per questo, spero che egli sappia concedersi un po’ più di respiro anziché esigere ancora troppo da se stesso. (testo raccolto da Andrea Tarquini) S FOTO CRISTIANO LARUFFA/AGF avrebbe fatto l’attore. È vero? «Non credo che avrebbe mai potuto fare qualcosa di diverso da ciò che gli dettava la sua vocazione profondamente religiosa. Certo amava il teatro e recitava straordinariamente bene con una voce meravigliosa. Aveva avuto come maestra di recitazione Ginka Beer, un’affascinante ragazza di qualche anno più grande di noi, molto bella, della quale c’eravamo un po’ invaghiti. A un certo punto lei lasciò la Polonia. Era ebrea e sionista e per questo aveva deciso di andare a vivere in Palestina». Quando le vostre strade si sono separate? «Alla fine del ginnasio. Lui andò all’Università di Cracovia per studiare storia e io al Politecnico di Varsavia per fare ingegneria». Sentiva di aver perso un amico? «Non avevo l’impressione di averlo perso. Ma gli anni ai quali andavamo incontro erano terribili». E che tipo di amicizia era stata fra voi due fino a quel momento? «Era un’intesa molto bella fra due ragazzi cresciuti assieme». L’ex presidente polacco 24 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 l’inchiesta Fine di un’epoca Conto alla rovescia per gli “istituti per i minori”: alla fine del 2006 i 24mila ragazzini ospiti dovranno essere trasferiti in case famiglia o in famiglie affidatarie. Ma sono troppi e molti sindaci stanno già pensando agli “affidi professionali”, una forma moderna di baliatico Orfanotrofi S aranno chiusi per legge il 31 dicembre del 2006. L’Italia dovrebbe dire addio per sempre agli “istituti per i minori”, quelle “strutture protette” un tempo albergo degli orfani poi sempre di più residenze per bambini e ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà. La legge che sancisce lo storico cambiamento, già in parte avvenuto con la nascita di piccole comunità che hanno cercato di replicare contesti sempre più simili alle famiglie naturali, è stata approvata nel 2001. Ad oggi però, mentre la scadenza si avvicina, i conti non tornano. Gli ultimi dati Istat disponibili segnalano che tra istituti, comunità e case famiglia, ci sono ancora 23.825 minori in attesa di una sistemazione diversa, e a questi si aggiungono i piccoli immigrati che arrivano clandestinamente sulle nostre coste senza genitori, e che la legge classifica come “minori non accompagnati”. Dietro il (nobile) progetto di chiusura degli orfanotrofi c’è l’intento di potenziare l’istituto dell’affido familiare, ossia l’inserimento di un bambino che ha una famiglia d’origine e dunque non può essere dichiarato adottabile in una “famiglia affidataria”, che si impegni ad allevarlo, a farlo studiare, in attesa, se mai se ne verificassero le condizioni, di restituirlo al suo nucleo parentale. La realtà però è ben diversa. Le famiglie disponibili, seppure in crescita, sono ancora pochissime rispetto al numero di bambini in istituto, e infatti da alcuni mesi sono partite in tutta Italia campagne informative e pubblicitarie sull’affido familiare, mentre in molti comuni sono stati avviati corsi di formazione per gli “affidi professionali”. Si tratta, in concreto, di coppie a cui verrà offerto uno stipendio mensile per prendersi cura di bambini che altrimenti resterebbero in istituto. Trovatelli d’Italia una favola triste I MARTINITT Nelle foto, in alto Pietro Nenni all’orfanotrofio di Faenza nel 1903. Sotto, Leonardo Del Vecchio “martinitt” nel 1950. Qui in basso, Angelo Rizzoli senior, a 16 anni, aspirante tipografo FOTO GIOVANNI GIOVANNETTI /EFFIGIE l massimo della tristezza, il massimo della poesia. Lungo questi due estremi, attraverso fiabe di riscatto e letteratura da fogliettone, orrori di cronaca ed esorcismi cinematografici, si tenta, o ci si illude forse di misurare l’immaginario orfanotrofico italiano. Immaginario in via di esaurimento, si spera. Picchi e abissi della memoria, intanto. Dall’antica “ruota” dei conventi ai gradini delle chiese, fino ai cassonetti; dalle prime istituzioni della carità religiosa ai bigi casermoni dell’assistenzialismo statale; e poi le botte dei maestri, i libretti rossi dei «trovatelli», o «esposti», «gettatelli», «proietti», «bastardelli» : così vennero a lungo chiamati i piccoli ospiti. Le loro nere divise troppo larghe o strette, tozzi di pane induriti, i cori delle bambine co, di fronte a questa materia la pietà è un prezzo che nessun’anima, né alcun impegno civile riusciranno mai a sperperare. Perché l’orfanotrofio non sembra solo storia morta, ma anche ricordo vivente, e luminosa letteratura, e incrocio di vicende personali con i destini di un’intera società e dei suoi illustri protagonisti. Magro e minuto, all’indomani della morte del papà, per intercessione di una contessa, Pietro Nenni entrò a cinque anni nell’orfanotrofio di Faenza. Era l’inizio del secolo scorso: «Mi fu messa la corda al collo in un’età in cui niente è meno tonico di una disciplina servile». Giudizio senza speranze: «L’orfanotrofio fu per me una galera». E peggio, o meglio, forse: «A quella clausura devo un certo complesso di rivoltoso che non mi ha più abbandonato». E ancora oggi il riverbero di quell’acerba prigionia suona come una maledizione biblica: «Dei delitti della società — scrisse Nenni — nessuno è più atroce di quello di cui essa si macchia privando tanti fanciulli della voglia di vivere». Vero è che il giovane ribelle prese a scappare, di notte, d’accordo con il giardiniere, di fede repubblicana, che gli faceva trovare la scala appoggiata al muro dell’ospizio. Però un giorno scoprirono sotto il materasso di Nenni opuscoli di Mazzini e altre diavolerie propagandistiche. Fu dunque cacciato. Era il 1908, eppure mai la libertà riuscì a placare in lui quell’«alito di tempesta». Nenni è uno che ce l’ha fatta. Ne esistono altri, per cui il solo fatto di venire FOTO OMEGA FILIPPO CECCARELLI dall’orfanotrofio, e ciò nonostante di aver avuto successo nella vita, costituisce la prova di una forza morale enorme, sigillo e compimento di una autentica favola di redenzione sociale. Cesare Mori, «il Prefetto di ferro», uno dei pochissimi che per conto dello Stato diede un colpo terribile alla mafia, è venuto su in un orfanotrofio di Pavia, riconosciuto dai suoi genitori naturali soltanto a sette anni. Angelo Rizzoli, mecenate, produttore, capostipite di una dinastia editoriale, l’uomo che trasformava in oro tutto quello che toccava e chiedeva a Federico Fellini di mettere sempre «un raggio di luce» nei suoi film, uscì anche lui dall’orfanotrofio, a Milano. Era un “martinitt”, proprio come è stato “martinitt”, in tempi più recenti, un personaggio di straordinario ingegno e volontà come Leonardo Del Vecchio, classe 1935, fondatore e guida della “Luxottica”, uno dei 55 imprenditori più ricchi del mondo. Sono esempi che valgono nella loro più misteriosa eccezionalità. Mentre i bimbi infelici, destinati a divenire uomini ancora più infelici, purtroppo non si contano. Inevitabile destino. La miseria, la fame, l’ignoranza, la vergogna, la vita selvaggia: tutto questo è alla base del brefotrofio. La guerra, com’è ovvio, ci mette del suo, instancabile fabbrica di piccoli disgraziati, ma anche di santi che se ne fanno carico, li accolgono, li ricoverano, s’improvvisano portentosi organizzatori di cura, di amore. E qui senz’altro vale ricordare i don Gnocchi, i don Zeno Saltini, i don Minozzi. Quest’ultimo, prete amatriciano, nel dicembre del 1950 si carica una croce in spalla e porta 1.500 orfanelli a Roma, visita a San Pietro, poi al Quirinale, da Einaudi. Struggenti appaiono anche solo le descrizioni delle immagini del cortometraggio Incom, utilmente disponibile on line sull’archivio dell’Istituto Luce (www. archivioluce.com): «I bambini in fila entrano ordinatamente nel Palazzo. Sala da ballo del Quirinale. Guardano con stupore il soffitto, i lampadari di cristallo, le cornici dorate, si fermano a parlare con i corazzieri. Siedono attorno alle tavole imbandite. Una suora con cappello bianco si aggira tra i bimbi. Uno di loro mangia di gusto un piatto di lasagne. Il presidente Einaudi poggia la mano sulla spalla del bambino...». Era un’Italia a suo modo dignitosa e affamata, piena di necessità e di sogni. Di solito sono proprio le istituzioni chiuse, i luoghi di pena, a misurare il destino, le speranze, i peccati di un paese, di un popolo. Sull’orfanotrofio, in qualche modo, c’è un racconto agghiacciante di Pirandello, ambientato in un paese neanche troppo immaginario della Sicilia più estrema, sulle rive del «mare africano». S’intitola Il libretto rosso e crudamente rivela le modalità con cui, secondo una pratica che ormai s’era fatta abitudine, il locale ospizio dei trovatelli metteva in vendita i bambini. Chi li acquistava — il loro possesso era appunto certificato da un libretto rosso — riceveva 30 lire al mese. Ma poi, pur non avendo di che nutrire le creature, gli stessi acquirenti rivendevano bimbi e libretti di baliatico a mercanti di stoffe maltesi che ne facevano incetta, del tutto indifferenti alla sorte del trovatello comprato: «Il quale, se muore, a chi fa male? e chi se ne lagna, se patisce?». L’ombra dell’immondo e crudele mercato descritto da Pirandello si proietta a lungo nel tempo, fino a lambire un paese ormai ufficialmente progredito e comunque toccato dal boom. É l’amara scoperta degli orrori consumati da certi frati ai danni dei “celestini” di Prato (1969), come pure le sevizie di Suor Maria Diletta Pagliuca (1971). Storie cupe. Dietro ai nomi degli istituti religiosi, Santa Rita o Maria Vergine Assunta in Cielo, si nascondono in realtà terribili e avidi aguzzini. Ma partono in quegli anni anche le prime battaglie civili, le denunce dei radicali contro «l’ap- Per alcuni che ce l’hanno fatta, da Nenni a Rizzoli e a Del Vecchio, non si contano i bimbi infelici destinati a diventare uomini ancora più infelici DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 25 23.825 12 È il numero complessivo fornito dall’Istat sui minori presenti negli istituti, nelle case famiglia e nelle comunità. Le strutture ospitano bambini e adolescenti. L’assistenza finisce con la maggiore età 300 Secondo la nuova legge d’ora in poi le strutture per i minori non potranno ospitare più di dodici bambini, e dovranno essere sempre più simili a “famiglie allargate” Molti vecchi istituti si stanno riconvertendo L’Aibi, Associazione amici dei bambini, ha denunciato che oggi negli istituti ci sono ben trecento bambini al di sotto dei sei anni, e sempre più minori stranieri non accompagnati, arrivati clandestinamente in Italia Laura.Così ho unito il mio cuore diviso D FOTO OLYCOM/PUBLIFOTO TRIESTE palto del bambino povero», reso d’oro da convenzioni, assegnazioni e ricoveri che fondano il «racket clericale e democristiano». Casi sporadici, che però fanno effetto. Condizioni igieniche disastrose, vicende di maltrattamenti, abusi sessuali. Alcuni bimbi addirittura crepano, lì dentro: «Maurizio, Francesco, Mario... Quanti sono? Non basterebbero tutte le piazze d’Italia a ricordarli» scrive Marco Pannella nella prefazione di Un ragazzo all’inferno (Napoleone, 1975), l’autobiografia di Mario Appignani, il futuro “Cavallo Pazzo”, che ha già girato un’infinità di istituti e fatto in tempo ad assaggiare le cure della Pagliuca. A questo torbido mondo rende indimenticabile testimonianza l’Alberto Sordi de Il Giudizio Universale, il più cinico trafficante di bambini che sia dato di ricordare. Il cinema, in effetti, come d’altra parte il romanzo d’appendice con i suoi intrecci, i suoi scambi di neonati in culla, le sue “agnitiones”, da sempre gira intorno all’orfanotrofio, fantastica risorsa emotiva, perfino da umori- smo nero, luogo di dolore, certo, ma anche di tenerezza, terribile e al tempo stesso appassionato, irreale. Così, com’è nelle leggi inviolabili dello spettacolo, si ride e si piange. Ecco Totò ne I due orfanelli (l’altro è Carlo Campanini); ecco la Magnani, soubrette e rivale d’amore di un’orfanella in Teresa Venerdì. Ma ecco soprattutto il protagonista di Miracolo a Milano di De Sica, la più straordinaria e poetica figura cui abbia dato vita Cesare Zavattini, un trovatello angelico, anzi un vero angelo in divisa da orfanello, abbandonato sotto un cavolo, cresciuto in orfanotrofio, e tuttavia così buono da chiamarsi appunto “Totò il Buono”. Una specie di Charlot che saluta tutti togliendosi il cappello dell’uniforme che lo inchioderebbe al suo destino, e a tutti augura buon giorno, emissario più o meno occulto di «un regno dove buon giorno vuol dire veramente buon giorno», e per scaldarsi basta appena un raggio di luce, di tanto in tanto, solo quando il sole buca le nuvole e fa un cerchio di calore per terra. i sua madre parla con un amore protettivo e tenero, come si fa con le persone fragili, di quelle che nella vita hanno fatto errori e incontrato amori sbagliati. Si vedono al parco, in biblioteca, più spesso nei caffè, perché Laura in casa della madre e del suo convivente non può entrare, e in quei momenti rubati si dicono tutto, chiacchierano a lungo, a volte ridono, a volte scherzano, a volte sono tristi. Quando si salutano Laura torna al sogno di tutti i giorni: se prima o poi farà fortuna come cantante si comprerà un appartamento che guarda il mare e andrà ad abitarci con la madre, una casa solo per loro due, in una pace domestica che insieme non hanno mai provato. Laura ha 17 anni ed è una ragazza in affido. Ha una madre “naturale”, un padre che l’ha dimenticata molti anni fa, una sorella più piccola, ma da quando aveva sei anni vive con Luciana e Mario, da quando cioè il tribunale l’ha allontanata dalla famiglia per farla crescere in un ambiente diverso, e Luciana e Mario, due figli già grandi e oggi addirittura nonni, l’hanno accolta con loro. Una di quelle curve fortunate della vita senza la quale per Laura si sarebbero aperte le porte dell’istituto. Ed è qui, in questa casa ordinata e luminosa al quarto piano di un vecchio palazzo di Trieste che Laura torna ad avere 17 anni, quando discute con Luciana degli orari di “rientro” del sabato sera o ride di cuore agli scherzi di Mario, che ha una faccia strapazzata dalle rughe, il dono della battuta veloce e dell’ironia in allerta. «Fin da piccolissima ho capito di essere diversa dagli altri bambini. Non potevo vivere con i miei genitori, non potevo tornare a casa mia la sera. Avevo una famiglia, ma abitavo con un’altra... La notte mi svegliavo, tutta sudata, con una fortissima nostalgia di mia madre. A scuola ero tremenda. Non seguivo niente, con la testa ero lontana, assente, la mia angoscia la sfogavo attirando l’attenzione delle maestre, saltavo sui banchi, urlavo, ero una delle peggiori della classe. Poi per fortuna è arrivato lo psicologo, e piano piano mi sono abituata a questa doppia vita. Stavo qui, con Luciana e Mario dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica li passavo con mia madre». Usa parole asciutte, frasi brevi Laura, come se prosciugare un discorso l’aiutasse a mitigare un passato segnato da abbandono e solitudine. Anni di altalena, di cuore diviso a metà, tra il desiderio di restare accanto alla madre, in una casa dove ormai c’era la guerra e dove oggi lei non può più entrare nemmeno per vedere la sorellina, e la serenità dei giorni con Luciana e Mario, una vita “normale” fatta di scuola, compiti, amici, canto, musica, chitarra, volontariato, sport, regole e impegni, divertimento e rigore. «Ecco la mia stanza, la mia tana, qui studio, leggo, scrivo canzoni, e Luciana si arrabbia moltissimo perché sono troppo disordinata», dice Laura mostrando un “rifugio” a dire il vero quasi perfetto, tappezzato di ritratti di Bob Marley e pupazzi di peluche, con la collezione di cd di Withney Houston e Laura Pausini, un luogo dove convivono infanzia e adolescenza, le passioni di una teenager e l’orgoglio di pensare «appena trovo un lavoro vado a vivere da sola». «Quando sono troppo irrequieta mi chiudo qui dentro, quando i pensieri vanno all’indietro, al mio passato, a mia madre, a mia sorella, allora cerco di concentrarmi e di mettere in pratica il consiglio che mi ha dato l’anno scorso il prof d’italiano, di guardare ogni giorno davanti a me, al presente e al futuro, come fosse un esercizio per la felicità, oppure se sono davvero giù telefono allo psicologo. Mi conosce da sempre, ho iniziato a fare terapia che avevo sei anni e ho continuato per quattro anni, è stato un modo per reagire al dolore, per integrarmi nella società, ora ogni tanto passo a trovarlo». Laura è la testimonianza di un affido familiare riuscito. Una famiglia d’origi- ne con cui i rapporti sono stabili anche se difficili (la madre abita nello stesso isolato, a cinque minuti di distanza a piedi) e una famiglia affidataria che con l’aiuto dei servizi sociali ha di fatto allevato Laura. Una vera e reale alternativa all’istituto, così come prevede la legge che nel 2001 con un bel po’ di ottimismo ha decretato la chiusura degli orfanotrofi, in nome del progetto (o sogno) di dare ad ogni minore in difficoltà una famiglia, dei genitori “a tempo” che possano offrirgli un passaggio verso l’età adulta. Qualcosa di molto semplice e di molto grande però, un equilibrio delicatissimo che richiede dedizione totale, nessun desiderio di possesso e la tenacia di occuparsi di giovanissimi spesso difficili, diffidenti, chiusi. Semplici eroismi quotidiani insomma. Come stanno facendo da più di dieci anni Luciana e Mario, che dopo aver cresciuto due figli, sempre e soltanto con il solo stipendio di Mario, ex idraulico dell’azienda municipale, hanno deciso di occuparsi di Laura. «Mi fanno da genitori, e per me questo è un posto sicuro. Con gli amici non ho problemi, tutti conoscono la mia situazione, e so anche che non c’è nulla di cui vergognarsi. Mia madre dice spesso che vorrebbe riportarmi a casa, ma qui con Mario e Luciana posso costruire il ‘‘ Diversa Fin da piccolissima ho capito di essere diversa dagli altri coetanei. Non potevo vivere con mia madre Avevo una famiglia ma abitavo con un’altra FOTO MARINO STERLE MARIA NOVELLA DE LUCA Doppia vita Piano piano mi sono abituata a questa doppia vita. Mia mamma parla di riportarmi a casa, ma qui posso costruirmi il futuro. L’alternativa era l’istituto, per fortuna non è andata così mio futuro, mi mancano due anni per finire la scuola, frequento un istituto professionale per i servizi sociali, vorrei lavorare con i bambini ma anche continuare con la musica. La chitarra me l’hanno regalata Luciana e Mario, la tastiera mia madre, lei sogna di vedermi in televisione, la sera spesso già canto nei locali di karaoke, nei pub, ma so che è meglio rimanere con i piedi per terra», e Laura ha uno sguardo indulgente, adulto, quando parla di sua madre, mentre torna ad essere “figlia” con Luciana, in un rapporto che si evince affettuoso e dialettico nello stesso tempo. «Credo che lei ci veda un po’ come i suoi controllori — scherza Luciana — perché qui ci sono delle regole da rispettare, ma è consapevole del percorso fatto, a scuola ha sempre avuto l’insegnante di sostegno, poi l’aiuto dello psicologo, figura fondamentale anche per noi, anzi se in tutti questi anni abbiamo retto è stato grazie a lui, che si è occupato anche di andare a parlare con i professori, con i servizi sociali, con la nostra associazione, l’Anfaa. Abbiamo avuto degli aiuti economici, soprattutto all’inizio, non molto, ma sufficienti per la terapia e i corsi di musica. Adesso i contributi non ci sono quasi più, nelle scuole hanno tolto gli insegnanti di sostegno, così le ripetizioni di matematica e le lezioni di canto le paghiamo noi. L’anno prossimo, a 18 anni, i contributi finiranno del tutto, a meno che i servizi sociali non facciano un progetto ad hoc per Laura. Ma davanti a noi ci sono ancora due anni di scuola, e la vita tutta da costruire…». Dietro questo cammino dunque c’è stata una rete di servizi che ha funzionato, un “welfare” che oltre alla generosità di Luciana e Mario ha reso possibile il “progetto Laura”. Quegli stessi sostegni che oggi però iniziano a mancare, con i tagli fuori e dentro le scuole, nelle asl, nei comuni. Una contraddizione di intenti quindi, mentre si avvicina la data di chiusura degli istituti, e in ogni città partono campagne “pubblicitarie” per invitare le famiglie ad accogliere in casa minori in difficoltà. «A volte mi sono sentita Penelope — confessa Luciana — ricostruire ogni giorno quello che poteva perdersi in un’ora. Non saprei dire perché Mario ed io abbiamo iniziato questa avventura, forse perché avevamo avuto i figli tanto da giovani, ed è stata un’esperienza bella, faticosa, appassionante. Certo, ci ha uniti. Io poi ho sempre fatto la mamma e la casalinga a tempo pieno e abbiamo sentito che nella nostra vita c’era spazio per Laura, e in fondo anche per sua madre, che è un po’ il senso dell’affido familiare, non separare, ma laddove è possibile creare un ponte tra le famiglie». Ecco la sfida. Creare per 24mila bambini e ragazzi, tanti sono i minori ospitati in istituti e comunità, un percorso fatto di “famiglie in rete”. Un’impresa veramente difficile se si pensa che in molti comuni sono iniziati i corsi per gli “affidi professionali”, ossia coppie che verranno addirittura pagate per accogliere in famiglia dei ragazzi “dismessi” dagli istituti. Ma come si fa a prendersi cura di qualcuno senza, in cambio, desiderarne il possesso, soprattutto se si tratta di un figlio? Luciana alla domanda sorride e si emoziona. È qualcosa, quel sentimento, con cui si è confrontata. «Il senso di possesso non l’ho mai avuto, nemmeno per i miei figli. Mario ed io siamo cattolici, i figli sono un dono ricevuto da Dio e noi genitori li abbiamo in “gestione” con il compito di educarli e amarli al meglio. Ma c’è una cosa che ho detto in alcune riunioni dell’Anfaa e molti si sono scandalizzati: per Laura in certi momenti ho faticato così tanto, il mio investimento è stato così grande, che mi è sembrato, alla fin fine, di amarla di più». La risposta di Laura è una grande voglia di vivere e di incontrare il futuro. «La mia alternativa era l’istituto, per fortuna non è andata così. In comunità, lo so, ci si sente soli. Continuo a soffrire quando lascio mia madre, ma adesso ho imparato a convivere con tanti affetti diversi. Appena posso vado a vivere da sola. Ora — scherza Laura — non mi sento più diversa dagli altri bambini». 26 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 il racconto Terra promessa Il grand hotel è il simbolo del Mandato britannico in Palestina: lungo i suoi saloni si muovono Lawrence d’Arabia, belle donne, militari e avventurieri. Ma è dietro il sipario di questa scintillante vita coloniale, che esplode il lungo conflitto tra arabi ed ebrei SANDRO VIOLA I GERUSALEMME l King David fu inaugurato con un memorabile “garden party” a metà giugno del 1930. Nel giardino, la banda d’un reggimento scozzese suonò un po’ di Haendel, i motivi di qualche canzone allora di moda, e concluse col “God save the king”. L’albergo era con lo Shepheard del Cairo il più lussuoso del Medio Oriente. E se lo Shepheard aveva sul davanti una bellissima vista sul Nilo, il King David ne aveva sul retro, dove s’affacciavano la metà delle stanze, una anche più maestosa: le mura di Solimano attorno alla vecchia città araba, e più lontano, sulla destra, i fumi di Gerico e le biancheggianti colline della Giudea. Da qualche giorno sto cercando di ricostruire, con l’ausilio di qualche libro, d’una raccolta di fotografie dell’epoca e d’un paio di amici che mi guidano per la città, gli anni del Mandato britannico sulla Palestina. Non abito al King David (vi abitavo, ogni volta che ero a Gerusalemme, nei Settanta e Ottanta), ma se la giornata è bella e non fa freddo, ci vado ogni tanto a prendere un caffè sulla terrazza che guarda le mura. Non c’è infatti un altro edificio, in città, che ricordi e riassuma come quest’albergo il trentennio della presenza inglese in Palestina. Mi interesso al periodo del Mandato per vari motivi. Intanto perché Gerusalemme fu in quegli anni, riscossasi dal torpore levantino e dall’incuria in cui era stata immersa durante la dominazione ottomana, un va e vieni di personaggi straordinari se non romanzeschi. Una città più cosmopolita che mediorientale, in cui l’immigrazione ebraica (in specie quella austro-tedesca) trasferì tra i Venti e i Trenta un vasto patrimonio di cultura europea. Secondo, perché fu durante il Mandato che prima si posero le premesse, e poi bruciarono le micce, del conflitto tra arabi ed ebrei. Terzo, perché fu allora, col fallimento dei tentativi compiuti dai governi di Londra per arginare il conflitto, che cominciarono a cedere le fondamenta della potenza inglese. Ma torniamo al King David del 1930. Con l’apertura del nuovo albergo, la vita mondana di Gerusalemme si fece più intensa. Ai ricevimenti nelle residenze dell’Alto commissario e del governatore militare, ai pranzi in abito da sera al Circolo ufficiali o al Sodom and Gommorrah Golf club, s’aggiungevano adesso — nei saloni o sulla terrazza del King David — i balli annuali dei vari reggimenti e quello del Ramle Jackal Hounds — il club della caccia alla volpe e allo sciacallo — con gli uomini in giacca rossa e le signore in lungo. E quando nel ’31 il posto d’Alto commissario per la Palestina venne preso dal generale Arthur Wauchope, uno scozzese scapolo, molto ricco e con la passione delle feste (tanto che in un certo mese, fece sapere a Washington il console americano, Wauchope aveva avuto «non meno di seicento ospiti, e sempre con un fiume di champagne»), le sere di Gerusalemme divennero ancora più animate e brillanti. Einstein e gli altri “turisti” I protagonisti della vita sociale erano ovviamente gli inglesi, ufficiali e alti funzionari, i consoli stranieri e i turisti di maggior riguardo. Ma con essi c’erano poi i membri delle famiglie palestinesi più importanti, a formare una società per molti versi anglo-araba. Le personalità sioniste erano invece, sulla scena mondana, piuttosto rare. Richard Crossman, un noto giornalista e politico inglese, se ne accorse la sera che venne invitato a pranzo da Georges e Katy Antonius, una delle coppie palestinesi più eleganti. «È evidente scrisse - che gli inglesi preferiscono l’élite araba agli ebrei. Questi arabi sono di cultura francese, molto civili e divertenti… Al loro confronto gli ebrei appaiono invece tesi, e con i tratti tipici della piccola borghesia centro-europea». In quel passaggio tra i Venti e i Trenta, giungevano di continuo visitatori famosi: Albert Einstein, Rudyard Kipling, George Bernard Shaw, Arturo Toscanini, Thomas Mann. E tutti erano affascinati dalla città, dalle immagini che vi si coglievano, dalla bellezza dei dintorni. I tramonti sul deserto (il deserto che secondo Renan ha partorito il monoteismo), le IL BLITZ DI ALLENBY CONQUISTA LA CITTÀ Con la disgregazione dell’impero ottomano, nel dicembre 1917 Gerusalemme viene occupata dalle truppe del generale inglese Allenby e passa sotto il controllo britannico, poi trasformato in mandato dalla Società delle Nazioni nel 1922. Londra, impegnatasi contraddittoriamente a soddisfare sia le richieste arabe di uno stato indipendente, sia le aspirazioni sioniste di uno stato ebraico, favorisce tuttavia la continua immigrazione di ebrei nella regione. Ciò suscita un forte risentimento tra gli arabi e mette fine alla pacifica convivenza tra arabi ed ebrei: si moltiplicano invece gli scontri, sino alla grande sollevazione araba del ’36, finché, nel 1947, incapace di mediare tra le opposte richieste, la Gran Bretagna rimette il mandato all’Onu che decide per la spartizione della Palestina. Ma gli arabi respingono la decisione e attaccano Israele: inizia così la prima guerra arabo-israeliana KingLeDavid feste e l’odio nella LA VITA SOTTO IL PROTETTORATO Nella foto in alto, soldati britannici di pattuglia per le strade di Gerusalemme. Qui sopra, uno scorcio del quartiere ebraico. A destra, militari inglesi cercano di superare un blocco degli arabi all’ingresso della città. A sinistra, due preti ortodossi DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 27 LA CITTÀ VECCHIA Due donne camminano per le vie del quartiere ebraico della città vecchia. Sullo sfondo la sinagoga Nissan Bak ebrei vedevano infatti nella fine ormai Bianco che prevedeva come assetto defiprossima dell’impero ottomano la brecnitivo uno stato unico, dunque a maggiocia attraverso la quale si sarebbero realizranza araba. Fu allora che il terrorismo zati i propri progetti nazionali. I sionisti sionista prese di mira anche obbiettivi erano già bene impiantati tra Jaffa, Gerubritannici. Anni d’agguati e di bombe, sisalemme e Haifa, e pochi mesi prima delno all’attentato del ’46 al King David che l’arrivo di Allenby avevano avuto da Lonne fece crollare un’ala uccidendo novandra, per bocca del ministro degli Esteri ta persone: ed ecco perché dicevo che Lord Balfour, l’assicurazione che la Gran l’albergo è una specie d’epitome del Bretagna era favorevole alla nascita d’uMandato. na patria ebraica in Palestina. È vero che Bene amministrata dai vari governatola guerra non era ancora finita, e che non ri militari, nei Trenta Gerusalemme s’era si sapeva in che modo gli alleati si sarebingrandita di nuovi quartieri. Un archibero spartite le spoglie dell’impero turco. tetto immigrato dalla Germania, Richard Ma ora che l’esercito inglese occupava Kaufmann, aveva progettato il quartiere Gerusalemme, i leader sionisti erano cerdi Rehavia e allargato quello di Talbieh ti che dalle parole della cosiddetta Diinnestandovi gli elementi essenziali delchiarazione Balfour si sarebbe presto la lezione Bauhaus. Si trattava di zone depassato ai fatti. Vale a dire una Palestina stinate agli ebrei tedeschi in fuga dal naebraica. zismo, che erano riusciti a portare in PaNei lunghi anni dell’agonia ottomana, lestina una parte dei loro patrimoni. Le era però sorto un po’ ovunque nei paesi case erano infatti decorose, in genere di di popolazione araba — dalla Siria all’Idue piani, intervallate dalle ville orientaraq, dal Libano alla Palestina — un movileggianti delle grandi famiglie palestinemento nazionalista che aspirava all’indisi cristiane o mussulmane. Case e ville pendenza dei vari territori sottoposti alche sono andato a vedere strada per stral’impero. In Palestina il movimento aveda in questi giorni, e che costituiscono va avuto radici a Nablus, ma nel ’17 s’era ancora (nella via Markus, per esempio, ormai diffuso nelle altre città e cittadine, nella Alkalay, nella Hovevei Sion) il meGerusalemme compresa. Tanto che già glio dell’architettura in tutto il versante prima dell’occupazione inglese, i sospetoccidentale della città. ti, l’ostilità, i contrasti tra arabi ed ebrei Beninteso, il mondo di Rehavia e Tals’erano manifestati con un certo numero bieh costituiva l’élite dell’immigrazione. di fucilate e di morti. Mentre diverso era per coloro che sbarAd esasperare gli cavano senza mezarabi era il continuo zi, alloggiati dall’Aingrossarsi dell’imgenzia ebraica in migrazione sionimiseri appartasta. Dagli ultimi anmenti dei brutti ni Ottanta dell’Otquartieri che stavano sorgendo a Tel tocento sino alla Grande guerra, deAviv, a Gerusalemcine di migliaia d’eme, ad Haifa. Ma brei avevano infatti benché differenti raggiunto la Paleper cultura e origini stina: la «terra senza sociali, uno stato popolo» — come rid’animo accomupeteva la propanava gli ebrei ricchi ganda sionista — o poveri che arriva«per un popolo senvano — non per una za terra». Il governo chiara scelta sioniturco aveva prosta, ma spinti dal mulgato alcune legpresentimento delgi per limitare gli arla catastrofe — all’irivi e la vendita di nizio degli anni terre arabe ai nuovi Trenta. venuti: ma i funzioQuello stato d’anari locali, pronti a nimo pervade lunfarsi corrompere ghe parti dell’ultiDa I SETTE PILASTRI dalle organizzaziomo, struggente roDELLA SAGGEZZA ni sioniste, non le manzo di Amos Oz, avevano quasi mai Una storia di amore applicate. Sicché i e di tenebra. Cioè a nazionalisti arabi speravano che sarebdire il doloroso spaesamento di uomini e bero stati gli inglesi, adesso, a stagnare donne che venivano dai climi freddi, dai l’afflusso degli immigrati in provenienza grandi boschi, dalle città e cittadine della dall’Europa centrorientale. Mitteleuropa, e trovavano il caldo inferQuesto fu l’equivoco che ammorbò la nale, le sabbie del deserto, i reticolati che Palestina per tutti i trent’anni in cui vendividevano i quartieri arabi da quelli ne amministrata dalla Gran Bretagna: ebraici: e niente caffè di calco viennese, ambedue gli avversari, arabi ed ebrei, teatri o sale da concerto. Di quest’urto tra credettero di poter prevalere gli uni sugli realtà tanto diverse, della nostalgia per altri con l’aiuto inglese. E i governi di Lonl’Europa, si poteva morire, e infatti la madra fecero molto poco per rendere meno dre di Oz ne morì. ambigua la situazione. Da Allenby in poi, Né c’era, in Palestina, la sicurezza che militari e politici parvero infatti incapaci gli immigrati erano venuti a cercare. Perdi cogliere la peculiarità e gravità della ché per tutti gli anni Trenta, e in specie contesa, e di controllarne — quando ebcon l’insurrezione araba del ’36-’38 scabero inizio — le convulsioni. tenata dal Mufti di Gerusalemme, Hadj Certo, come potenza mandataria in Amin el-Husseini, il terrorismo e i massaPalestina (il Mandato le era stato confericri non conobbero pause. Poi, curiosamente, lo scoppio della Seconda guerra to nel ’22 dalla Società delle Nazioni), l’Inghilterra tentò a lungo e pazientemondiale portò una certa calma. I leader mente di smorzare i primi fuochi dell’inarabi (alcuni dei quali erano in contatto cendio. Ma se non vi riuscì, fu anche percon gli agenti dell’Asse) avevano scelto ché ondeggiò continuamente da uno aluna posizione attendista, e tra ’41 e ’45 sol’altro versante della contesa senza mai lo gli ebrei della banda Stern continuarodecidersi a una scelta definitiva tra le rino a piazzare le loro bombe contro arabi chieste degli uni e quelle degli altri. Non a e inglesi. caso l’Alto commissario Wauchope, l’inCome retrovia della guerra in Africa stancabile organizzatore di pranzi e settentrionale, Gerusalemme visse alloparty, raccontava di sentirsi come un ra il suo periodo più animato e cosmopoacrobata da circo costretto a cavalcare lita. Con Rommel che avanzava nel dedue cavalli allo stesso tempo. serto egiziano, l’estate del ’42 giunsero Il nodo più intricato restava quello delinfatti una quantità di personaggi sinall’immigrazione sionista. Secondo molti lora rifugiati al Cairo: re Giorgio di Grecia, degli alti funzionari del Mandato, la dire Pietro di Jugoslavia, Haile Selassie, michiarazione Balfour aveva messo l’Innistri di vari governi in esilio con mogli e ghilterra con le spalle al muro. A Londra e amanti, generali degli eserciti sconfitti a Gerusalemme ci si rendeva conto, cioè, dalla Wermarcht, ricchi levantini, avvendei pericoli rappresentati dal continuo turieri e spie. In Città alla deriva, un roaumento degli ebrei che giungevano in manzo di Stratis Tsirkas che Guanda Palestina (60.000 nel solo 1933), ma la Dipubblicò tre anni fa, c’è un bel ritratto di chiarazione del ’17 obbligava ad un atquel momento. I pranzi all’hotel Astoria teggiamento favorevole verso il progetto o al Queens, gli incontri al caffè Alaska o d’una patria ebraica. Allo stesso tempo, al Trocadero, le sere al bar Fink’s, l’unico gli imperativi politici e strategici emersi di quei posti che ancora sopravviva. Poi, finita la Guerra mondiale, riconegli anni Trenta — soprattutto dopo minciò la guerra tra arabi ed ebrei. Ormai l’avvento di Hitler al potere — spingevagli inglesi volevano solo andarsene, e il no a non alienarsi gli arabi. più presto possibile. Lasciarono la PaleGli inglesi finirono così col procedere a stina il venerdì 14 maggio 1948, mentre tentoni. Partiti dalla dichiarazione già crepitavano le mitragliatrici. Ci fu Balfour e dal progetto d’una patria ebraiuna frettolosa cerimonia dinanzi al paca, passarono invece nel ’37, con la Comlazzo dell’ultimo governatore, sir Alan missione Peel, all’idea di due stati indiCunnigham, quindi iniziò l’evacuazione pendenti, uno ebraico e l’altro arabo. Ma delle truppe. La Città santa era pronta nel ’39 l’idea della spartizione venne abper nuove carneficine. bandonata, e Londra pubblicò un Libro ‘‘ FOTO TRATTE DAL LIBRO JERUSALEM DI NACHUM TIM GIDAL Lawrence d’Arabia Io intendevo creare una Nazione nuova, ristabilire un’influenza decaduta, dare a venti milioni di Semiti la base sulla quale costruire un ispirato palazzo di sogni per il loro pensiero nazionale Gerusalemme inglese passeggiate sui bastioni, le visite ai kibbutz e al primo nucleo dell’università ebraica. I riti pittoreschi dei cristiani d’Oriente, lo spettacolo dei patriarchi e vescovi cattolici, ortodossi, armeni, siriaci, maroniti o copti, preceduti dai servitori in costumi azzurro e oro che battevano in terra le mazze con l’impugnatura d’argento. Ma interessanti erano anche le mésaillances che scaturivano dal particolarissimo intreccio etnico, religioso e sociale della città: come la relazione d’un ricco magistrato palestinese, Abcarius Bey, con una bellissima ebrea di trent’anni più giovane, Leah Tannenbaum, i quali ricevevano frequentemente in una lussuosa villa di Talbieh dove qualche tempo dopo sarebbe andato ad abitare il deposto imperatore d’Etiopia, Haile Selassie. Ma questa scintillante vita di colonia non era che un sipario: dietro il sipario, in quell’avvio dei Trenta, la Palestina era un vulcano prossimo all’eruzione. A Gerusalemme e a Hebron, nell’agosto ’29, l’ostilità tra arabi ed ebrei aveva prodotto le prime due delle tante carneficine che sa- rebbero seguite negli anni successivi. Sessantasette ebrei e una decina d’arabi erano rimasti sul terreno, i feriti erano stati dozzine: e s’era subito capito quanto sarebbe stato difficile, per gli inglesi, contenere lo scontro tra i sionisti e il movimento nazionalista arabo-palestinese. Perché di questo, ormai, si trattava: non più di attacchi sporadici e limitati, com’era stato sin allora, bensì d’uno scontro aperto. O per meglio dire, delle avvisaglie d’una guerra inevitabile. La guerra che sarebbe esplosa nel ’48 — dopo quasi due decenni d’ininterrotto, feroce terrorismo sionista e arabo —, al momento della partenza degli inglesi. E che seppure in forme diverse, dura tuttora. La rinascita della città Quando il King David aprì i battenti, gli inglesi erano in Palestina ormai da tredici anni. In una fredda e ventosa mattina del dicembre 1917, dopo che le truppe turche e tedesche si erano ritirate, il generale Allenby aveva fatto il suo ingresso a Gerusalemme dalla porta di Jaffa, fian- cheggiato da Lawrence d’Arabia e da un gruppo d’ufficiali francesi e italiani. La città aveva allora circa 55.000 abitanti (due terzi dei quali ebrei) e appariva piuttosto mal ridotta. Nell’ultimo scorcio di governo turco, e in particolare negli anni della guerra, le strade, l’illuminazione, il sistema fognario avevano infatti conosciuto un continuo degrado. Sir Edmund Allenby era un buon cristiano, un metodico lettore delle Scritture, e tali erano anche molti dei suoi ufficiali. Fu perciò con profonda e malcelata emozione che misero piede nella Città Santa. L’idea del “metter piede” non fu tuttavia del Toro, come Allenby veniva chiamato dalle sue truppe, ma del Colonial Office. Che la sera prima dell’ingresso a Gerusalemme spedì un telegramma con cui si consigliava d’entrarvi non a cavallo, come avevano fatto lungo i secoli i molti conquistatori della città, ma più rispettosamente a piedi. Il consiglio venne ovviamente accolto, e anche da esso derivò l’accoglienza calorosa che ebrei e arabi tributarono agli inglesi. Paradossalmente, sia gli arabi sia gli 28 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 le storie/1 IL PARADISO DELLO STRIP Il Crazy Horse apre i battenti il 19 maggio 1951, avenue George V, nel sottosuolo di un palazzo borghese: lo fonda Alain Bernardin, pittore senza fortuna, ammiratore dei saloon americani. All’inizio non ci sono coreografie, Miti d’altri tempi ma un violento nudo integrale. Negli anni ’60 lo show diventa collettivo. Il marchio che lo rende famoso nel mondo è scoprire il corpo delle ragazze per vestirle con raggi di luce colorata: una delle massime dive del Crazy Horse è Lova Moor (nella foto) Crazy Horse, nude senza peccato I PARIGI n fila sotto la pioggia. Avenue George V, marciapiede, lato desiderio. Tempio del nudo. Guardi le facce: normali, da provincia del mondo. Non vedi voglia, eccitazione, desiderio. Solo tiepida stanchezza. Tutti uguali: giapponesi, americani, francesi, italiani. Ieri su questo stesso marciapiede: Fellini e De Sica, curiosi e vitali; l’altro ieri: Dalì e Duchamp, pazzi e geniali. Stessa gioia di poter vedere, assistere, sognare. Oggi: gente comune, in giacconi, jeans, maglioni. Ti chiedi: ma questi sognano ancora il nudo? Il triangolo, sì. Del pube. Che oggi viene classificato come full frontal. Quello che una volta Alain Bernardin, creatore del Crazy Horse, misurava con precisione. Lui, da vero cultore, ne aveva canonizzato densità, colore, misure. Alle sue ballerine imponeva un triangolo equilatero di 12 centimetri, rigorosamente nero, anche in caso di capigliatura bionda o rossa. Leggi il cartello all’ingresso: «Gli italiani sono pregati di non portare le ballerine a casa». Sorridi, ingialliscono anche i peccati. Pensi a Brancati e ai suoi ingravidabalconi. Però quando Boris Vian scrisse «Sputerò sulle vostre tombe», (processo, condanna, libro vietato, multa di centomila franchi) il desiderio era rosso color sangue, impaziente, disperato come una nota di Sidney Bechet. Guardi Ken Achich, 18 anni, 15esimo arrondissement, maman l’ha portato qui per festeggiare la maggiore età. Ha offerto a lui e ai suoi amici un tour nell’archeologia della Belle Époque, nello scandalo che non è più. Hanno lo sguardo serio, i ragazzi, nessun guizzo scurrile. «Il mistero del mondo è nel visibile, non nell’invisibile», scriveva Wilde. Seni, natiche, let’s dance. Quante volte figlio mio? Tante, padre, basta cliccare su Internet e resti a bocca aperta. Non serve più il Crazy Horse, per capire com’è fatta la donna. E nemmeno leggere Henry Miller che andava in giro per le strade decadenti di Parigi fra puttane, alberi tristi e luci fioche, alla ricerca delle mille occasioni per notte. L’esistenzialismo sessuale non delira più sul destino dell’uomo. Il teatro è a semicerchio, piccole sedie di velluto, scomode. Taboo, si chiama lo spettacolo. Balletto d’apertura: God save our bareskin. Dio salvi il nostro nudo. Il modello sono le guardie reali della regina, ciuffo di crine di cavallo che copre e sobbalza sul pube. Non tutte vanno a tempo. Ventinove ragazze, 13 a spettacolo, tra l’1,66 e l’1,72, vietato l’1,74, età tra i 18 e i 26. Francesi, polacche, russe, rumene, ucraine, francesi, un’italiana con il nome d’arte di Lucrece Habanita. Segno zodiacale dominante: Vergine. Nessuna particolare perversione: Karlotta si sta trasferendo a Bruges per dare una mano al marito che apre un ristorante, Anja bionda e russa non parla una parola di francese. L’età dell’oro Devi chiudere gli occhi per capire cosa si provava ad aprirli allora. Anni Cinquanta e dintorni. Vadim girava con B. B. E Dio creò la donna, Alain Bernardin la denudava. Discuteva di piacere e desiderio con Yves Klein, César, Tinguely, Niki de Saint-Phalle, Arman, Hains, Rotella, Nel tempio dell’erotismo si potevano incontrare Fellini e De Sica. Oggi si vedono solo persone comuni, spinte dalla curiosità ma non dal desiderio: ecco come si è trasformato il teatro più trasgressivo di Parigi, dove una tiepida stanchezza ha preso il posto dell’eccitazione gazze». Il settore dopo anni di crisi si è ripreso e ora si lancia nell’esportazione. Il Moulin Rouge ha speso 6 milioni di euro per la rivista Feerie e ha chiuso il 2004 con un giro d’affari di circa 40 milioni di euro, il Lido ha investito 13 milioni di euro per il nuovo spettacolo Bonheur. Lova Moor non è più tornata al Crazy da quando Bernardin, che aveva sposato, è morto. Come tutti quelli pieni di vita Alain se l’è tolta, a 78 anni, nel ’94. Rosa Fumetto andò al funerale. «Ci guardavamo strani, ci chiedevamo: chi di noi sarà il prossimo a fare un gesto simile? Era la morte dello strip-tease». Ora ci sono i figli, Sophie, Pascal, Didier, a mandare avanti l’azienda che ha anche una succursale a Las Vegas e per la serie show a domicilio si parla anche di Tokyo e Shanghai. «Cerchiamo armonia e equilibrio, corpi sottili, ma con curve. Non vogliamo stimolare l’occhio, ma lo spirito. Il sesso è magnifico soprattutto quando sta in testa» spiega Sophie. Sembra di sentire Vargas Llosa: «L’erotismo è un atto di creatività a cui partecipano l’immaginazione e la cultura». Sarà, ma se non ti fa dormire di sabato sera è meglio. Fast food che non ingrassa il desiderio. E allora vai, con il balletto Vestal’s Desire ispirato all’Egitto e con Va-VaVoom, numero dove sulle ragazze vengono proiettate luci optical e i corpi perdono l’anatomia per diventare un’illusione di triangoli, pois, rombi. E vai anche con il mago pasticcione Otto Wessely che maltratta un coniglio e una colomba di pezza. È il numero più applaudito. Sissignori, quello del mago. Vestito, vestitissimo, ha anche il papillon. La gente ride, si rilassa, partecipa. Rosa Fumetto sostiene che se la gente impazzisce per il coniglio che esce dal cilindro c’è qualcosa che non va nell’equilibrio dello spettacolo: «Va bene che noi oggi chiediamo sempre di più, ma se uno spogliarello ti distende invece di eccitarti non è buon segno». FOTO CONTRASTO/CORBIS EMANUELA AUDISIO Rauschenberg e Jasper Johns. Di come svestirlo con Azzaro, Alaïa e Paco Rabanne che fece esordire i suoi primi modelli metallici proprio al Crazy Horse. Dolce bassa vita. Il locale apre il 19 maggio 1951 e fin dall’inizio spoglia in scena le più belle ragazze, a cominciare da Miss Fortunia (1952) che si esibisce nel numero della pulce creato da Max Revolt, per arrivare al duo Rita Renoir-Rita Cadillac (1953), a Victoria Nankin nel primo esperimento di grafica luminosa proiettata sulla pelle nuda (1960), a Prima Simphony, celebre per il suo spogliarello sulle note di Svestitemi della Gréco. Poi la contestazione, anche di quello che ci si metteva addosso. Il ’68: arrivò, spogliò, liberò. Le rivoluzioni si fanno con il corpo. Sulla barricate a Parigi c’era Rosa Fumetto. Nuda, al Crazy Horse. Sotto il selciato c’è la spiaggia. Lei ricorda: «Bernardin era un genio, nello spogliarello non cercava la volgarità, ma l’arte. Usava tutto: cinema, tv, pittura, musica. Aveva un vantaggio, era nato a Parigi, aveva vissuto la guerra, sapeva liberare la voglia. Era maniacale, controllava tutto, dai camerini alle toilette. Ma per noi c’erano i sarti, i disegnatori migliori, mai avuto scarpe così belle. Lo incontrai a Roma in un ristorante, mi offrì il biglietto aereo per un provino. Andai, lui osò con il resto. Inventò la storia di una donna che si perdeva dentro il Vesuvio. Ero strapagata, il teatro allora era piccolo, quando stavi in scena ti sentivi in mezzo al pubblico, e ti saliva l’adrenalina a mille. Volevo essere indispensabile: la gente era corretta, non allungava le mani, non ricordo le persone che ho stravolto, ma quelle che hanno eccitato me». Più ginnastica che seduzione Lo spettacolo di oggi va avanti, Lezioni di erotismo, ragazza a cavalcioni, su un divano rosso a forma di labbra. Più ginnastica, che seduzione. A muoversi con vera sinuosità sono i camerieri che scivolano nel buio per le ordinazioni. Pubblico L’ARTE DI SPOGLIARSI INVENTATA DA SALOMÈ Lo strip-tease ha origini antiche: dalla biblica danza dei sette veli di Salomè ai nudi di Frine o Lady Godiva. La definizione deriva da “to strip” (svestirsi) e “to tease” (stuzzicare). Alcuni storici indicano il 1889 come data del primo strip-tease, realizzato da Blanche Cavelli al café-chantant parigino Le Divan Japonais sull’aria della canzone Le Coucher d’Yvette: la ragazza si spogliava accanto al letto, di fronte alla fotografia dell’amato appena richiamato alle armi. Altri vedono la teatralizzazione della canzone napoletana settecentesca La cammesella come primo esempio di spogliarello. La fortuna dello strip si accresce negli Stati Uniti tra le due guerre: Gipsy Rose Lee è la massima diva dell’epoca. In Inghilterra c’è Phillis Dixey. In Francia nel 1957 si contano ben 24 locali in cui vengono presentati spettacoli di strip incerto: dov’è il velluto, la vena sottile di provocazione che si insinua pian piano, che prende forma in un particolare, che cresce con la lentezza, che sa farsi desiderare a lungo? Dov’è l’atmosfera, la tempesta che riaccende una voglia spenta? Tutto era diverso nel ’69 quando Lova Moor a 18 anni arrivò a Parigi da La Rochelle, città marinara affacciata sull’Oceano e roccaforte protestante nel XVI secolo. Di famiglia povera, Lova studia per diventare insegnante per bambini difficili, ma il suo sogno è fare la ballerina. Viene scoperta mentre balla in una discoteca dal coreografo del Crazy Horse che la invita a fare un provino. Bernardin le fa studiare danza, canto, recitazione. «Alain era geniale nel riunire donne bellissime, nell’esaltarne la bellezza con un gioco di luci particolare, rendendole simili a statue. Severo con noi ragazze, esigente con tutti, i suoi balletti nascevano spesso da coreografi americani. Un suo segreto: abbassare il soffitto del palco, in modo che la ragazza risaltasse al centro della scena, apparendo più grande». Già, il Moulin Rouge era can-can e nostalgia, il Lido piume e pailettes, il Crazy Horse nudo internazionale. «Il bel mondo non si vergognava di venire, né di farsi vedere. C’era spesso Fellini che diceva sempre che mi avrebbe fatto fare un film, c’era Alain Delon, con cui ho avuto un’intensa storia d’amore, ma quella che più mi ha impressionato è stata Liza Minnelli che una sera, imbottita di alcol, invaghita del direttore del locale, salì sul palcoscenico perché voleva insegnarmi a ballare. Oddio, anche Tony Curtis non scherzò, mi tenne ferma la testa sulla piattaforma mentre il mio corpo era in verticale e io continuavo a cantare e a muovermi. Adesso, gli spettatori non sanno più nulla dell'erotismo. Il sesso visto su Internet non ha niente a che vedere con il Crazy Horse e anche la televisione ha inflazionato la bellezza femminile. Bernardin accettava le telecamere una sola volta l'anno per lasciare la voglia e la curiosità di vedere le sue ra- La morte dell’eros Allora capisci: l’eros è caduto, vinto, battuto. L’hai appena visto trascinarsi stanco sul palco che è stata la sua culla per un’ora, girarti intorno con parrucche arancioni, verdi e viola, cercare di convincerti inutilmente con il fondoschiena. Uno spettacolo di luce, ma non qualcosa che ti scalda il sangue, che ti rianima voglia e desiderio. Chissà se James G. Ballard è passato di qua, in questo teatro sull’avenue George V, per capire che bisognava cercare sensi e sensualità altrove, quando scrisse Crash tutti si scandalizzarono perché il sesso passava per le auto, per l’identificazione totale corpo-macchina, scontroamplesso, mentre lui con la dovuta spigolosità stava solo cercando di provocare una reazione, di far rivivere l’eros, morto anche nel tempio del Crazy Horse, ucciso dall’abitudine al nudo, dal costume di far diventare tutto hard, dalla pubblicità dei tostapane a quella dello yogurt. Taboo, si chiude il sipario. Tutti a casa, anzi a nanna, per davvero. Senza sentirsi sporchi o peccatori, ma anche senza sogni. Se ne va con gli amici anche Ken, il ragazzo a cui la madre ha regalato la prima notte di trasgressione da grande. Contento? «Era meglio fare due tiri a pallone». Forse è vero: l’unico modo per tenersi una cosa è perderla. DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 le storie/2 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 29 Bambini nel deserto Hanno dai due ai sette anni, vengono comprati a duemila dollari nei paesi più poveri dell’Asia e dell’Africa, portati nel Golfo Persico e trasformati, con la violenza, in fantini. Un uomo arrivato dal Pakistan ha deciso però di dedicare la vita alla liberazione, con ogni mezzo, dei quarantamila bimbi che ogni anno rischiano di morire sulla sella GABRIELE ROMAGNOLI La via dei trafficanti Per prima cosa studiò come funzionava il traffico. I bambini arrivavano dal suo Pakistan, dallo Sri Lanka, dall’India, dall’Etiopia, dal Sudan. Destinazione: gli Stati del Golfo dove, per tradizione, si tenevano le corse: Qatar, Kuwait, Oman, ma soprattutto gli Emirati. Avevano la stessa nazionalità dei domestici a servizio nelle sontuose dimore, ma entravano illegalmente. Molti venivano rapiti, altri sottratti ai genitori con l’inganno, promettendo che sarebbero stati adottati da una famiglia ricca, di cui veniva prodotta la fotografia: eccoli nel giardino di una villa, con un cucciolo di cane e questa è l’altalena che vostro figlio userà. Non poté non ammettere che altrettanti venivano semplicemente venduti, per fame: duemila dollari, anche meno. All’aeroporto passavano i controlli drogati, in braccio a mamme fasulle. Oppure venivano stipati in un contai- Dubai, i piccoli schiavi dei cammelli da corsa ner, mentre una mancia entrava nelle tasche dei doganieri. Li attendevano campi di lavoro come quello davanti a cui adesso Burney sostava in auto, aspettando il momento per entrare in azione. Ne aveva già visti a decine, sempre uguali: baracche e recinti. Niente elettricità, niente acqua. I bambini dormivano su una stuoia, ammassati. Sveglia alle tre del mattino, ritirata alle nove della sera. Nelle altre diciotto ore accudivano i cammelli e si allenavano. Quando erano troppo piccoli venivano legati al cammello con strisce di velcro. Se urlavano, la velocità aumentava. Se andavano piano, venivano battuti. Loro, non i cammelli. All’ora del pasto: tre biscotti. Oppure: mezza pagnotta. Non bastava che fossero leggeri perché piccoli, li volevano ultraleggeri perciò denutriti. Un bambino salvato da Burney ha raccontato di aver assaggiato il cibo destinato agli animali. Lo stava gustando quando è stato scoperto: lo hanno frustato e poi collegato a un generatore provocandogli scosse a tutto il corpo. Gli allenamenti erano duri e rischiosi. A quell’età stare per ore in groppa a un cammello in corsa pregiudica un normale sviluppo degli organi sessuali. Le cadute erano frequenti, nessun medico accudiva i feriti, perché la loro presenza era clandestina. Qualcuno era morto. L’avevano trasportato qualche duna più in là e sepolto senza lasciare sulla sabbia altro che orme senza memoria. Ashraf e Akram, due fratelli di 5 e 7 anni riportati a Karachi dopo una lunga schiavitù, hanno raccontato: «Farsi male era una cosa comune. Abbiamo perso sangue dalla bocca, dal naso, dallo stomaco e l’abbiamo inghiottito in silenzio. I guardiani non volevano sentire lamentele. Di giorno urlavano, di sera tiravano a sorte con quale di noi divertirsi». Sessualmente, intendevano abbassando lo sguardo. Poi raccontarono anche che cosa successe a un bambino caduto in gara: «Lo riportarono al campo. Lo trascinarono in una baracca. Più tardi uno venne e, per punizione, gli bruciò una gamba. Dopo, non serviva più». Ansar Burney sapeva che la stessa cosa stava per succedere al bambino che aveva seguito. Un giorno Ansar Burney vide Shaid, tre anni, nella baracca in cui era prigioniero. Affrontò il guardiano, poi lo prese sulle spalle e cominciò a correre FOTO CORBIS/CONTRASTO L’uomo della liberazione Il suo nome era Ansar Burney. Nato in Pakistan, sposato, padre, attivista in difesa dei diritti umani. Sedici anni addietro aveva assistito per la prima volta a una corsa di cammelli. Come molti aveva pensato, andandoci, che potesse essere una buffa esperienza. «Ma non guardare gli animali — lo avevano avvertito — osserva i fantini. E capirai». Quando erano sbucati sulla dirittura aveva strizzato gli occhi: i fantini gli erano sembrati piccolissimi. Cresceranno avvicinandosi, aveva pensato. Invece no: erano bambini. Il vincitore, quando fu fatto scendere, faticava perfino a reggersi: avrà avuto due anni. Non ritirò alcun premio, sparì barcollando. Da quel giorno Ansar Burney decise di liberare i piccoli schiavi del cammello. Ci sono molti modi di fare l’attivista politico: «La maggior parte si siede a una scrivania e butta giù una dichiarazione. Io vado a cercare di tirare fuori dai guai chi ci è finito. Non m’importa se ci casco dentro anche io». La strategia gli parve semplice: riprendere i bambini a chi se li era presi. FOTO CORBIS/CONTRASTO Q DUBAI uando il cammello prese velocità il bambino in groppa commise l’errore più grosso: si mise a urlare. L’animale lo considerò un incitamento. Più il bambino piangeva e gridava, più il cammello accelerava. Uscì dalla curva in testa alla corsa. Gli uomini accalcati in tribuna lo incoraggiarono alzando le braccia infilate nelle bianche tuniche. Il proprietario della scuderia sorrise pensando alla vincita imminente. Poi ci fu uno scossone di troppo e il minuscolo fantino perse la presa. Volò sulla pista, nella sabbia. Gli altri cammelli gli passarono avanti, sfiorandolo e facendolo ruzzolare. Gli sguardi della folla proseguirono verso il traguardo. Il proprietario della scuderia spense il sorriso. I suoi sottoposti accorsero ad accertarsi che non ci fossero danni. Al cammello. Qualcuno raccolse il bambino e lo trascinò via, nessun medico lo visitò, sugli spalti soltanto un uomo restò a guardarlo mentre veniva allontanato, poi scese, andò al parcheggio, salì in auto e seguì il furgone dove era stato caricato. I grattacieli di Dubai scomparvero dal retrovisore, sul parabrezza apparve il deserto. Il furgone si fermò dopo qualche chilometro. L’accampamento era fatto di poche baracche con il tetto di lamiera, a rosolare sotto un sole da 50 gradi, senz’ombra. In un recinto si aggirava lenta una dozzina di cammelli. Tra di loro, occupati a sfamarli o lustrarli, una masnada di bambini di età apparente compresa tra i due e i sei anni. Qualcuno faceva fatica a camminare. Si fermarono un attimo quando il piccolo fantino caduto in pista fu scaricato e, per le ascelle, trascinato dentro alla baracca. Un grido secco gli fece riprendere il lavoro, a occhi bassi. Sapevano tutti cosa sarebbe successo al bambino che era caduto. Lo sapeva anche l’uomo seduto in auto: per questo doveva intervenire. L’ANNUNCIO SUL GIORNALE «Corsa con bimbi di 6 anni»: l’ultima gara è stata pubblicizzata il 15 gennaio sul libanese Daily Star Salvarne uno in più In sedici anni ne aveva portati via qualche migliaio, 387 nel solo 2004. Aveva fatto approvare negli Emirati una legge che puniva l’uso di fantini sotto i quindici anni o i quarantacinque chili. Ma non era riuscito a farla rispettare. Allora aveva nascosto una micro-telecamera in un accampamento. Da 24 ore di registrazioni aveva tratto un documentario trasmesso con scalpore dalla rete via cavo americana HBO. L’anno scorso lo sceicco Mohammed bin Zayed, che guardava la tv più di quel che succedeva nel suo emirato, decise di aiutarlo. Inasprì i controlli, creò, ad Abu Dhabi, un ostello per ospitare i bambini strappati ai predatori. Il Qatar annunciò che avrebbe provato l’impiego di mini-robot come fantini. Ma a Dubai le corse continuano. Gli annunci sui quotidiani arabi presentano come una speciale attrazione per il pubblico la possibilità di vedere i piccoli spaventati fantini. Per questo Burney era venuto, nuovamente, fin lì: per liberare almeno un bambino in più. Quando davanti alla baracca rimase un solo guardiano scese e lo affrontò. L’uomo fece resistenza. Burney mostrò una lettera personale dello sceicco, citò la legge. Il guardiano ribatté che il bambino aveva quindici anni. Mostrò un passaporto e un visto della federazione che erano stati falsificati o, peggio, rilasciati a pagamento da un funzionario corrotto. Burney non vide altra soluzione: lo spinse nella sabbia, si caricò il bambino in spalla e scappò portandolo con sé. Ora non gli restava che rimpatriarlo, cercare di riconsegnarlo alla famiglia, sperando che non l’avesse venduto. Il bambino tremava, disse di avere tre anni, di chiamarsi Shaid. Burney lo portò all’ambasciata del suo Paese. Sapeva già che non l’avrebbero aiutato volentieri. Il funzionario scosse la testa: «Perché si dà tanto da fare? È inutile. Serve solo a mettere nei guai lei e noi». Avevano cercato di incendiare la sua casa e il suo ufficio, preso a sassate la sua automobile. In telefonate notturne i trafficanti di schiavi avevano minacciato di ucciderlo. E un diplomatico pigro adesso gli diceva che, con la sua attività, «comprometteva le relazioni tra il suo Paese e quelli del Golfo. E le sarà chiaro quanto ne abbiamo bisogno». Burney sapeva che cosa dire in questi casi, l’aveva già fatto altre volte. Chiamò a sé il bambino che era caduto in corsa. Disse: «Ogni anno ci sono trentamila corse con i cammelli. Quarantamila bambini come questo li montano, rischiando la loro vita, rovinandosi le gambe e le palle per far divertire tutti quegli uomini ricchi, tutti quegli uomini tanto religiosi che stanno a guardarli. Trentamila gare e quarantamila bambini. Sa quanti bambini arabi, quanti dei loro figli hanno mai messo su un cammello da corsa? Neanche uno. Nessuno, mai». Il funzionario timbrò il documento. 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA i luoghi Vita d’azzardo VITTORIO ZUCCONI C LAS VEGAS hi pensa che l’inferno sia buio, non deve essere mai stato a Las Vegas. Qui è il cielo, a essere senza stelle. La terra è splendente. Ogni volta che ci atterro di notte — e ci sono atterrato troppe volte — ho la sensazione di precipitare verso l’alto, perché Las Vegas è un mondo alla rovescia, dove le stelle stanno sotto e il buio sta sopra. Forse l’inferno è un posto così, splendido, scintillante, succulento, topless, ma eternamente capovolto. E naturalmente senza vergini, tutte condannate al paradiso. Quest’anno, in maggio, l’infernetto nel deserto compirà 100 anni. Non sono proprio l’eternità, ma bastano per far male. Qui, dove quasi 40 milioni di anime entrano ogni anno gonfie di speranza ed escono disperate dopo avere lasciato 80 miliardi di dollari negli alberghicasinò (l’accento è del tutto optional), ogni cosa funziona benissimo, ma funziona alla rovescia. La forza di gravità spinge verso l’alto, nella rincorsa di mostruosità edilizie sempre più enfatiche, Torri Eifell e Statue della Libertà, Minareti e monoliti della Mgm, tendoni da circo e ville italiane da 80 piani che stroncherebbero il povero Palladio se le potesse vedere. Empietà architettoniche che si rincorrono come rilanci a un tavolo di poker. Il più nuovo, il “Wynn Hotel”, intitolato senza più tanti fronzoli al nome dell’uomo più ricco della città, Steve Wynn, sarà costato, quando sarà inaugurato questo aprile, circa un miliardo di dollari. Se appaltassero il ponte sullo Stretto di Messina a lui, l’avrebbe già costruito, Stretto compreso. Il peccato all’ingrosso Il peccato si vende all’ingrosso, al dettaglio, sciolto, a pacchi in confezione famiglia, con lo sconto e anche gratis, ma l’82 per cento dei residenti si definiscono nei sondaggi “religiosi” o “molto religiosi”. Le donne si vestono per andare a dormire, e si spogliano per andare a lavorare. La terra, con i suoi 23 mila chilometri di luci al neon, illumina il cielo, dove le stelle non possono competere e si nascondono. La notte è il giorno, e solo i profughi degli sconti per comitive si muovono sotto il sole che per nove mesi all’anno rosola i corpi. La gente vera vive di notte, dopo la una, quando gli alieni del buffet tutto compreso e i colombi dei 180 matrimoni al giorno nelle cappelle col finto Elvis intrippato in costumi troppo stretti, sono già a letto, per digerire il buffet o consumare il matrimonio, che all’alba saranno già passati. Una licenza matrimoniale instant e solubile nella luce del mattino, costa 35 dollari. Una petizione di divorzio al tribunale ne costa 450. L’uscita è più cara dell’ingresso, nel mondo capovolto. Le cose che si toccano sono tutte false, ma i miraggi sono veri. Uno dei mastodonti più redditizi di Wynn si chiama appunto Mirage. L’acqua non c’è e infatti zampilla da più fontane di quante ne abbia Roma, giurano le guide. Il centro della città è in periferia, nello Strip, nel rettilineo dei colossi, mentre la periferia sta in centro, decaduto e triste. I soldi non servono a nulla, perché sono troppi, sono semplici sogni, falsi come le moine delle lap dancer, delle ottomila professioniste delle contorsioni erotiche nel grembo dei clienti a un millimetro dal naso, che di notte fanno marchette e di giorno dicono tutte di frequentare la facoltà di medicina o di giurisprudenza presso l’ottima Nevada University pagando la retta con le mance degli arrapati. Una Harvard nel deserto, costruita con i quartini delle slot machine e dei dollari infilati nei microslip delle baiadere. La ricchezza si misura a miliardi, DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 Chi pensa che l’inferno sia buio, non è mai stato qui, dove è il cielo ad essere senza stelle. Questo è il mondo alla rovescia: le cose che si toccano con mano sono false, i miraggi sono veri e le donne si vestono per andare a letto. Un mondo che compie cent’anni ma non ha mai smesso di essere post-moderno Las Vegas la città capovolta due milioni di dollari non comprano niente. Sono bigliettini da Monopoli, Mickey Mouse Money, valuta immaginaria da Topolinia. Non bastarono neppure per pagare la stanzetta in un motel da tossici, naturalmente in centro, dove Stu Ungar, tre volte campione del mondo di poker e fresco vincitore di due milioni, morì da solo nel 1998. Un letto coperto di carte da gioco sparpagliate sulla coperta a fioroni sporchi, con le coronarie ingolfate dal cocktail di cocaina e di tranquillanti che usava ogni giorno per potere vivere la vita alla rovescia. Quando nacque, appunto nella primavera del 1905, la battezzarono Las Vegas che vuol dire “le verdi pasture”. Chi l’ha mai vista qui, una verde pastura, da quando l’ultimo ittiosauro morì, come Stu Ungar, anche lui solo come una belva estinta? Welcome to fabulous Las Vegas, ti accoglie lo stesso cartello stradale gusto “nostalgia” anni ’50 piantato da Frankie Old Blue Eyes Sinatra e dai suoi amici, Dino, Peter, Sammy, quando non erano troppo sbronzi per stare in piedi. Da allora, da quando il Rat Pack, i topi di Frankie si ubriacavano con Jfk e le dames, le ragazze dei mafiosi, al Sands, al Riviera, al Dunes, nei vecchi alberghi demoliti e scomparsi come i dinosauri e gli indiani Paiute che una Quasi quaranta milioni di persone arrivano ogni anno cariche di sogni e se ne vanno dopo aver lasciato negli hotel-casinò ottanta miliardi di dollari volta erano padroni di questa valle, tutto è cambiato e tutto è rimasto lo stesso. Non cambia mai la materia prima, il carburante, il motore che fa girare il pianeta capovolto e la voglia di degustare un sorso di deliziosa dannazione. «Certo che se questo è l’inferno» diceva “Dino”, Dean Martin, prima di stramazzare ubriaco addosso qualche corpo di donna senza nome, «il paradiso deve essere una noia terribile». Tra parentesi: quel cartello che augura il “benvenuto a Las Vegas” non sta neppure a Las Vegas, ma fuori, nella contea chiamata — non avranno molto buon gusto ma l’ironia non manca — “Contea del paradiso”. I primi umani ad arrivarci, nel senso dei primi non Indiani nativi, perché quando in America si dice i “primi”, degli Indiani ci si scorda sempre, furono due spagnoli, Antonio Armijo e Rafael Rivera, che inciamparono in un’oasi per caso. Avevano talmente sete da scambiarla, nel loro entusiasmo, per una verde pastura. Ma di loro è rimasto soltanto quel nome, che nel mese di maggio del 1905 venne appiccicato al grumo di baracche, di stalle, di bordelli, di bische, di cisterne per le locomotive a vapore della prima linea ferroviaria proveniente da Salt Lake City che osò attraversare il nulla verso la California, quando il signor Clark, barone delle ferrovie e della speculazione sui terreni, decise di nobilitare il villaggio e farne ufficialmente una incorporated town, una città. I primi “anglo”, i primi colonizzatori bianchi non spagnoli, alla fine dell’Ottocento erano stati, sempre per restare nel mondo del viceversa, quanto di più lontano si possa immaginare da ciò che Las Vegas sarebbe diventata. Furono i Mormoni ad arrivarci, setta tardo cristiana di insaziabili moralisti, astemi rigorosi, accaniti non fumatori, non giocatori, indossatori di cilicio, missionari implacabili, ma con un solo vizietto, che forse aiuta a spiegare quanto sarebbe accaduto dopo: la poligamia. La leggenda delle favolose “divorziate”, degli sciami di signore fresche di sentenza liberatoria che si gettano fameliche su Las Vegas per riguadagnare il tempo perduto, quella leggenda che crolla nell’umiliazione del «sono 500 dollari (minimo) tesoro», forse nasce dagli stuoli di ex mogli che i Mormoni si dovettero lasciar dietro, quando la poligamia divenne illegale e dovettero trovare da campare. La prostituzione naturalmente è proibita a Las Vegas, nella contea del Paradiso e nella contea di Clark, dunque è praticata con produttività cinese. Tutto alla rovescia. Per trovare gli ultimi bordelli autorizzati, gli scanna- DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 ‘‘ Dante non ha scritto all’epoca dei centri commerciali, ma avrebbe riconosciuto Las Vegas per quel che è: una religione, una malattia, un incubo, un paradiso per una razza bastarda FOTO CORBIS Da Holy City di NICK TOSCHES Croupier batte Reverendo dieci a uno. E i casini rendono quasi 10 miliardi di dollari in entrate fiscali alle casse di sindaco, ogni anno. Le chiese, che sono tutte non profit, ciccia. A chi andranno le simpatie del primo cittadino? 82% Sono i residenti che si definiscono religiosi o molto religiosi. A Las Vegas ci sono 160 chiese: altro che inferno. Molte di più però sono le case da gioco toi come quel “Mustang Ranch”, il ranch delle cavalline selvatiche (femministe astenersi) già quotato a Wall Street, ci si deve avventurare molto fuori, imboccare la strada del nord verso la sorellastra racchia di Las Vegas, Reno. Stanno dove zampettano gli scorpioni e scondizolano i rattlers, i serpenti a sonagli, e il deserto duro nasconde i cadaveri di molti bravi ragazzi che avevano pescato la carta sbagliata e fecero la fine di Bugsy Siegel, il capetto troppo ambizioso della “Jewish Mafia”, la famiglia mafiosa ebrea di Lansky, che costruì il primo hotel, casinò, resort, il “Flamingo”, sprecando troppi capitali e pestando troppi piedoni suscettibili. Il sindacato della mafia Oggi la mafia non controlla più Vegas (così la chiama il popolo della notte, Vegas, senza articolo). Non spadroneggiano più i fondi pensione del sindacato camionisti, i micidiali “Teamsters”, che negli anni ’50 e ’60 costruivano e demolivano a piacere, fino a quando il loro presidente Jimmy Hoffa scomparve e il suo cadavere non fu mai trovato. Forse sta qui, tra le tarantole e le mignotte, se non è embedded, incastonato nei piloni di cemento di un ponte. I vecchi pit boss, i capetti che controllano i croupier, i dealer, i giocatori e, guarda la coincidenza, si chiamano ancora in tanti Toni, Vinny, Carmelo, Salvatore e li riconosci subito dal capello cotonato, laccato e richiamato per coprire la piazza, lamentano, quando scoprono che sei «’taliano puro te» e hai perso abbastanza soldi per meritare due chiacchiere, che ormai è tutto un «bisenisse». È tutta un’industria senza cuore, pacchetti azionari e big corporation quotate in Borsa, consigli d’amministrazione e master in economia, controllate da quegli incorruttibili e occhiuti revisori dei conti che già certificarono con tanto rigore i bilanci della Enron, di Cirio e di Parmalat. La promessa di Micheal Corleone alla moglie, «tra cinque anni la famiglia sarà legittima» si è avverata. Il sindaco Oscar Goodman, il 19esimo da quando esiste Vegas, si mette a sibilare come un serpente se gli parli di Mafia. Poi leggi la sua biografia e ti accorgi che ha fatto i miliardi come avvocato difensore di tutti i principali “piezz’e Novanta” di Cosa Nostra, Mayer Lansky, lo sponsor del giustiziato Bugsy Siegel, compreso. «Difendere un assassino non fa dell’avvocato un assassino» sibila lui, giustamente. Ma i miliardi delle sue parcelle, avvocato, da dove venivano, da una colletta in chiesa? «Ci sono 160 chiese a Las Vegas, altro che inferno». Amen, amen, ma ci sono 1701 case da gioco autorizzate. 80miliardi Sono i dollari che, ogni anno, lasciano negli alberghi-casinò i quasi 40 milioni di turisti che entrano in città: 37 milioni i visitatori nel 2004. Sono 1701 le case da gioco autorizzate I MILLE VOLTI DI LAS VEGAS Dalla piramide di Luxor al casinò di Bellagio, da New York a Parigi al Canal Grande di Venezia: così Las Vegas ripropone il mondo in una città La torta più grande La Camera di Commercio, dove il mondo sembra per un momento raddrizzarsi e tornare alla normale banalità della propaganda ufficiale, vanta la gloria di questa città nel nulla che cresce più di ogni altra metropoli americana, sessantamila residenti legali in più all’anno, più i clandestini, totale un milione e mezzo di abitanti. Qui vive lo spirito della frontiera, diranno nel prossimo mese di maggio quando Wynn preparerà «la torta più grande del mondo» (vai poi a controllare) per il centenario, prosperano l’individualismo del cercatore d’oro, la tenacia dei 49ers, i disperati che attraversarono a piedi il deserto nel 1849 per arrivare, i superstiti, alla California. Ronald Reagan era adorato e proprio da Las Vegas, dal motel casinò “Thunderbird”, il dio indiano del tuono, lanciò (lo so, c’ero anche io, naturalmente non per giocare, per lavorare) la propria corsa alla Casa Bianca. Repubblicani di ferro, dunque, tutti Dio, patria, ballerine in topless, tavolini da gioco e bombe atomiche guardate dai tetti dei caffè mentre le esplodevano, crepino le radiazioni, dunque? E il mondo alla rovescia, lo abbiamo già scordato? Alle elezioni del novembre scorso, questa fu l’unica città del Nevada e di tutta la frontiera del West che votò per John Kerry. Forse perché, come mi disse una brava madre di famiglia di mezza età, divorziata con tre figli, che distribuiva le carte a un tavolo di black jack, «noi qui i bari li riconosciamo appena si siedono». O forse i bravi Vegans si ricordano che se il loro pianeta assurdo esiste e ramazza dollari, non lo deve allo spirito dell’iniziativa privata, ma a quella diga voluta da Hoover e costruita da quel “comunista” di Roosevelt che ferma il Colorado e alimenta con elettricità a buon mercato tutti i neon e tutti i condizionatori d’aria della città. Senza lo statalismo rooseveltiano, qui ancora correrebbero indisturbati gli Indiani Paiute. Un inferno privato alimentato dai soldi dei contribuenti. Una serie di gironi concentrici che si alzano verso il cielo, fino alle “balene”, alle whales, come nel gergo dei casinò si chiamano i giocatori, quasi sempre cinesi, giapponesi o arabi che perdono almeno un milione di dollari e le cui carcasse sono amorevolmente accudite con pasti, suite, ragazze di scorta (non armata), limousine, biglietti aerei a spese dell’albergo. Ci sono ormai voli di linea non stop di jumbo da Londra, Francoforte, Tokyo, Taipei. L’acqua della globalizzazione finisce in questo imbuto. Una sera del 2000 feci qualche mano di poker da Binion’s, la Betlemme dove nacque il mondiale, con Doyle Brunson, il vecchio maestro malato, dimenticando la Prima Legge del Poker («se non riesci a individuare il pollo seduto al tuo tavolo, vuol dire che il pollo sei tu»). Si degnò di rivolgermi anche la parola e di farmi notare ridendo qualcosa che io — il pollo — non avevo mai notato. Che c’è un solo Re, tra i quattro nel mazzo, senza i baffi, ed è il Re di Cuori. E che vuol dire? Vuol dire che lui aveva i tre coi baffi e io l’unico glabro. Prese il piatto e io uscii nella notte, a riveder le stelle sulla terra. 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 Il 12 febbraio settemilacinquecento drappi color arancio montati su settemilacinquecento “cancelli” saranno srotolati e vibreranno al vento tutti insieme, marcando un sentiero effimero, lungo 37 chilometri, nel cuore verde di New York. Il progetto chiamato The Gates è costato 20 milioni di dollari e durerà appena sedici giorni ma sta richiamando nella città americana centinaia di migliaia di nuovi turisti Un’onda d’oro su Central Park Christo PINO CORRIAS D LE OPERE NEW YORK ice Christo: «Sarà come un fiume dorato che appare e scompare, tra i rami. Sarà un percorso luminoso. Un’onda calda. Un nuovo cielo». Sarà unico, immenso, irripetibile. Immaginare l’evento da questo punto preciso, la Billy Johnson Playground, accanto a Fifth Avenue, all’altezza della 67th Street che taglia in due Central Park: 7.500 drappi color arancio che vibrano al vento. Il mondo che si ferma per guardare stupefatto. E loro due, Christo e JeanneClaude, gli autori, gli artisti, che si tengono per mano come adesso, appena finito l’ultimo sopralluogo. Nessun messaggio, nessuna simbologia, solo arte temporanea. L’arte di passeggiare sotto a un nuovo mondo di stoffa e di luce. Per l’esattezza 37 chilometri di nuovo mondo, lungo i sentieri spogli, e adesso innevati, di Central Park. Ai piedi del cielo atlantico di New York. Dentro alle ferite di New York. Lungo la memoria di New York. E ai bordi delle ombre precipitate l’11 settembre di tanto tempo fa, non solo qui, a New York. Christo e Jeanne-Claude, gli ideatori del primo grande evento artistico del 2005, lavorano al progetto da 26 anni. Il progetto si chiama The Gates, i cancelli. È costato migliaia di pagine scritte, migliaia di foto, centinaia di disegni, decine di sopralluoghi e 20 milioni di dollari tondi. Come tutti i progetti di Christo e JeanneClaude anche The Gates è completamente autofinanziato: nessun dollaro pubblico, nessuno sponsor, nessun finanziatore. Dice Christo: «A eccezione di noi, nessuno può comprare i nostri progetti, venderli, modificarli, scegliergli un destino». I cancelli hanno a che fare con i sogni, ma poggiano su solide basi di acciaio, e hanno la struttura indeformabile del vinile. Sono alti 4,8 metri. Sono 7.500. Ognuno è stato fissato lungo i sentieri del parco alla millimetrica distanza di 3,6 metri dall’altro. Ogni gate, ogni portale, regge un drappo di stoffa arancio. Tutti i drappi verranno srotolati nel medesimo istante il prossimo 12 febbraio, come una gigantesca trappola orizzontale per l’immaginazione e i nuovi sogni degli umani. La trappola durerà solo 16 giorni. Cioè una manciata di istanti, in proporzione agli anni di lavoro impiegati per idearla, disegnarla, e ai 20 milioni di dollari necessari per costruirla. La sproporzione fa parte dell’opera, quanto la stoffa e lo stupore. Perché tutto deve essere inimmaginabile prima e indimenticabile dopo. Dice Jeanne-Claude: «Tutto è temporaneo, irripetibile. Pensi all’arcobaleno. Pensi alla versione terrestre della Cometa di Halley». E come tutti i minuscoli segni del cielo, una volta precipitata sulla Terra, anche la loro cometa arancio produrrà nuovi pensieri, nuove equivalenze, una nuova prospettiva carica di spaesamento. Christo e Jeanne-Claude sono i formidabili maghi del perfettamente inutile. Sono geniali, scenografici, mediatici. Le loro magie producono eventi planetari. Gli eventi generano fama e polemiche. Dice Jeanne-Claude: «Lavoriamo sapendo che migliaia di persone cercheranno di aiutarci e che altrettante proveranno a fermarci». Un critico americano ha detto che Christo e Jeanne-Claude «recitano il ruolo degli artisti contemporanei, per WRAPPED TREES Sono 178 gli alberi coperti da 55mila metri quadri di polipropilene e 23 chilometri di funi: opera realizzata nel 1998 vicino a Basilea THE UMBRELLAS I 3100 ombrelli di forma ottagonale per collegare le due coste del Pacifico: 1340 blu a Ibaraki in Giappone e 1760 gialli in California THE PONT NEUF L’impacchettamento del Pont Neuf a Parigi dal 20 settembre al 4 ottobre 1985: usati 40mila metri quadri di tela e 1300 di corda. Il progetto è del 1974 WRAPPED REICHSTAG Uno dei maggiori successi, iniziato nel 1971 e completato nel ’95: realizzato con 100mila metri quadri di tessuto e 15mila metri di corda blu SURROUNDED ISLANDS Undici isole nella Biscayne Bay, vicino Miami, sono state ricoperte con 60 ettari di tessuto colorato per soli 15 giorni. L’opera risale al 1983 gente che non ama l’arte contemporanea». Spesso i giornali popolari li irridono. Polemizzano sui loro budget astronomici. E finiscono sempre per chiedersi, commentando le opere: a quale scopo? O addirittura: cosa significano? Per il pubblico, più semplicemente, sono «quelli che impacchettano le cose». Il che è quasi del tutto vero. In una quarantina di anni, perlustrando il mondo, assecondando il loro sguardo vorace, lui e lei hanno impacchettato oggetti e concetti di differenti dimensioni, cominciando da un telefono, una sedia, un albero. Per arrivare, nel 1983, a un gruppo di isole della Baia di Biscayne, in Florida, coperte di stoffa rosa. Poi al Pont Neuf a Parigi. Infine all’intero Reichstag a Berlino, anno 1995, trasformato dalla stoffa bianca in una gigantesca, indimenticabile, torta nuziale del dopo Muro. Non solo. Hanno steso sipari di cotone tra le montagne del Colorado, e installato 3.100 giganteschi ombrelli in California e Giappone. Hanno fatto sparire le Mura Aureliane a Roma, una torre medioevale a Spoleto, la statua di Vittorio Emanuele a Milano. E hanno fatto apparire un muro di 13mila barili di petrolio a Oberhausen, in Germania. In una quarantina di anni, lui e lei, hanno costruito giocattoli immensi per dire una cosa magari piccolissima, ma talvolta di vitale importanza: ogni oggetto conserva un mistero. Nasconderlo, lo svela finalmente allo sguardo. Lo sguardo diventa il nostro specchio. Lo specchio riflette una nuova traiettoria che corre verso il grande enigma della vita. La vita di Christo e Jeanne-Claude è un doppio enigma arrivato a coincidere perfettamente. Lui è di origine bulgara. Lei è nata a Casablanca da famiglia di militari francesi. Tutti e due sono venuti al mondo lo stesso giorno dello stesso anno, 13 giugno 1935. La coincidenza è sempre stata interpretata da Jeanne-Claude come un destino: «Ci siamo incontrati a Parigi nella primavera del 1958 e da quel giorno non ci siamo più lasciati. Col tempo, siamo diventati una cosa sola». Unica al punto che, una decina di anni fa, a un cronista curioso della loro età hanno risposto: «Abbiamo appena compiuto 120 anni». Abbandonati i cieli di Parigi, si sono trasferiti a New York nel 1964. I primi tempi lui firmava le opere, lei le cene. Nessuno sfuggiva ai loro inviti: Marcel Duchamp, Jasper Jones, Leo Castelli, Frank Stella. Inviti così assillanti che un giorno il critico David Bourdon ha scritto: «A quei tempi organizzavano le loro dannate cene. Metà della impopolarità che li circondava dipendeva dall’arte di Christo, l’altra metà dalle bistecche troppo cotte di Jeanne-Claude». Ambiziosi, arrivisti? Probabile. Però anche geniali. E perfettamente liberi. Il loro modo di finanziarsi, vendendo ai collezionisti i disegni preparatori, i collages, gli schizzi firmati, li ha resi autonomi, nomadi e infinitamente pazienti. Quando proposero la prima volta The Gates alle autorità di New York era il 1976. Gli risposero, più o meno, se erano matti. Loro viaggiaronoaltrove,Europa,Oriente,crearonoaltrove e aspettarono. Dieci anni dopo ripresentarono il progetto. E quando uno dell’amministrazione gli offrì zone meno cruciali di Central Park, magari un’alternativa tipo Coney Island, Jeanne-Claude saltò su È la prima volta che l’artista di origine bulgara e sua moglie Jeanne Claude, “quelli che impacchettano le cose” lavorano nella città in cui vivono. E lei dice: “Sono emozionata come per la nascita di un figlio” furiosa e disse: «Le farò una domanda stupida, signore. Lei ha sposato la donna che si è scelto o una donna alternativa?». Con l’arrivo di Michael Bloomberg sindaco, nonché loro collezionista, le cose hanno cominciato a raddrizzarsi. Il via libera è stato firmato nel gennaio del 2003. Da allora sono stati risolti una infinità di problemi. Nessun portale danneggerà gli alberi. Le basi saranno ancorate dal loro peso, e non più dalle 30mila viti che avrebbero bucherellato il parco. Tutti i materiali, e specialmente i 98mila metri quadrati di stoffa, saranno riciclati. Messa in moto la macchina, Christo si è occupato dei 20 milioni di dollari da rastrellare. È salito su al quarto piano della loro casa-studio che affaccia su Canal Street, quartiere di Soho, e ha cominciato a disegnare, ritagliare, incollare foto e pezzi di stoffa. I disegni hanno prezzi proporzionati alle dimensioni, vanno da 30mila a 600mila dollari. Christo disegna 17 ore al giorno. Scende un paio di volte al giorno per masticare una decina di spicchi di aglio, sorbire uno yogurt e qualche volta un bicchiere di latte di soja. Jeanne-Claude sta al piano terra. Caccia via i curiosi, sgrida i fotografi e mette in fila i collezionisti. I collezionisti arrivano da mezzo mondo e sono ammessi solo su appuntamento. Jeanne-Claude parla con apprensione del progetto, dice: «Sono emozionata come per la nascita di nostro figlio». Il figlio vero, l’unico, si chiama Cyril Christo, fa il poeta e vive molto distante da qui, a Santa Fe, New Mexico. In questi ultimi giorni di gestazione, lui e lei fanno brevi incursioni al Central Park. Navigano lenti con limousine e autista. Poi scendono, seguiti dagli assistenti. Dice Jeanne-Claude: «È la prima volta che lavoriamo senza jet lag. È la prima volta che lavoriamo a New York. Sono felice». New York li ripagherà. Dicono arriveranno fotografi e televisioni da tutto il mondo. Dicono che almeno 500mila turisti stiano modificando le rispettive traiettorie viaggianti per entrare sotto al loro cielo temporaneo,gentile,arancione.Cisaràiltempo di una passeggiata, un po’ di ricordi e poi un addio per sempre. Come la vita. LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 FOTO CONTRASTO/LAIF DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 FINANZIATO DAI DISEGNI Qui sotto, un fotomontaggio mostra la mano di Christo intenta a completare uno degli schizzi preparatori che, venduti ai collezionisti di tutto il mondo, hanno finanziato il progetto The Gates. A destra, un altro disegno Come una festa barocca Se l’arte è nomade ACHILLE BONITO OLIVA i può negoziare il bello? Si può. Si può negoziare il bello nella natura e nella città? Certo che si può. Negoziare significa comunicarlo esteticamente al corpo sociale, costi compresi. Nella società di massa mediante interventi in scala larga col paesaggio urbano e quello naturale, bucando la disattenzione collettiva e piegando l’attenzione individuale verso uno stato di concentrazione e sorpresa. Christo e Jeanne-Claude, due corpi e una sola mente ormai, riescono a tanto con il bello della diretta. Sviluppano una strategia di occupazione ed oscuramento di spazi pubblici e privati con una tecnica semplice e lampante, il packaging. Oggetti comuni, edifici storici, alberi e vallate vengono sottratti allo sguardo della collettività e messi in sonno sotto larghi strati di tela ruvida ed industriale che ne impedisce per lunghi periodi il riconoscimento. Prima di arrivare a questo eclatante e produttivo ossimoro (svelar celando), Christo, artista del Nouveau Réalisme, realizza da solo opere nelle quali già modifica il concetto stesso di arte e del processo creativo per arrivarvi. All’inizio adopera la realtà per quello che è, senza alcuna alterazione, semmai dando misura all’oggetto quotidiano: le cataste di fusti vuoti di benzina, definite secondo la forma geometrica del triangolo. Inizia così la sua occupazione di suolo pubblico, stabilendo un’apertura verso l’architettura e scardinando il concetto di riconoscibilità dell’oggetto artistico. Se la tradizione e il mito dell’avanguardia poggiano sulla sfacciata e esibita frontalità del quotidiano, seppure riconvertito ad altro uso, Christo ne intuisce già la caduta a merce, a oggetto tranquillizzante. L’artista decide così di operare attraverso il rilevamento dell’oggetto e la sua esclusione mediante l’impacchettamento che interdice ogni significato ed occlude il conseguente alone. L’involucro accompagna e ricalca la forma, estrovertendo l’ossatura dell’oggetto sottostante e sospendendone ogni funzionale presenza. Il velo progressivamente steso su ogni realtà da Christo e la moglie Jeanne-Claude, produttori ormai di un’arte a responsabilità familiare, non è certamente un velo pietoso. Piuttosto un intervento macroscopico sempre più aperto verso l’architettura che vuole intercettare, secondo i canoni di una moderna comunicazione, l’attenzione di massa nella società moderna. La monumentalità dell’intervento è direttamente proporzionale al bisogno di globalizzare una visibilità culturale, sociale economica e mediatica. L’impacchettamento non produce nessun’aura per l’oggetto messo al riparo ed assunto nella sua pura grammatica di ingombro. Qui il problema non è certamente quello di dare significato al mondo, riqualificando l’oggetto attraverso la citazione, ma di circoscrivere l’area di occupazione del proprio intervento. Si dà così voluta e spettacolare visibilità a tutte le procedure che preparano il progetto e l’esecuzione dell’opera. Ormai è avvenuto il salto. Ormai non ci si collega più a microstrutture organizzative (gallerie e musei), ma alle macrostrutture (città, grandi parchi e istituzioni pubbliche) che possono disporre di grandi mezzi adatti agli interventi per progetti sul paesaggio artificiale e naturale. Il lavoro (dall’ideazione all’esecuzione) implica rapporti con l’immaginazione e l’economia, architetti ed operai tutti al servizio di un movimento creativo in cui i partecipanti sono produttori diretti di esperienze, ognuno con un proprio ruolo autonomo. Lo sforzo comunitario sembra riprendere le cadenze della bottega rinascimentale o della festa barocca romana, dove la divisione del lavoro fa di tutti i partecipanti autori e spettatori insieme. Le 7500 porte volanti e svolazzanti, modulari e capricciose, in sinuosa e provvisoria fila indiana nel Central Park di New York, indicano un’idea nomade dell’arte, una leggerezza di appropriazione del suolo pubblico forse più consona alla Grande Mela dopo l’11 settembre, sicuramente più della stabile superbia verticale dei nuovi grattacieli. S Parlano Christo e Jeanne Claude: The Gates nasce dall’amore per New York e per i suoi abitanti “Quarant’anni per battere la burocrazia” ALBERTO FLORES D’ARCAIS P NEW YORK erché Central Park? «Quando siamo arrivati a New York nel 1964 con nostro figlio Cyril, che aveva quattro anni, restammo molto colpiti dalla skyline, dai grattacieli di Manhattan. Ci sarebbe piaciuto “impacchettarne” uno e così andammo dal proprietario di un grande edificio downtown per chiedere il permesso». Che grattacielo era? «Si trova al numero 20 di Exchange Place e al numero 2 di Broadway, molto, molto downtown. Lui ci rispose che eravamo pazzi; andammo da un altro e ci rispose allo stesso modo. Contattammo il proprietario del grattacielo sulla 42esima, Times Square, niente da fare. Chiedemmo il permesso di impacchettare il Museum of Modern Art (MoMA) e il Whitney Museum, niente, nessun permesso». E allora cosa avete fatto? «Impacchettammo il primo palazzo a Berna, in Svizzera, nel 1968». Cosa rappresenta New York per la vostra arte? «Visto che nei primi anni Settanta lavoravamo molto lontano da New York, in Australia, in Colorado o in Northern California, quando pensavamo a New York, quando tornavamo a New York da posti così lontani capivamo che il nostro interesse artistico non era più per i palazzi di New York ma per la gente di New York. New York è la città al mondo dove si cammina di più. E l’unico posto dove i newyorchesi camminano per piacere e non di fretta è nel parco. Per questo nel 1979 nacque il progetto dei “gates” per Central Park». Perché “gates”? «Central Park è completamente circondato da palazzi, è tagliato fuori da ogni forza naturale. Quando 150 anni fa la città di New York comprò un grande pezzo di terra per costruire il parco, lo circondarono con un muro. Ovviamente costruirono degli ingressi e li chiamarono “gates” perché uno degli architetti ci voleva mettere dei cancelli di acciaio che chiudessero il parco durante la notte». Cancelli che non esistono più? «I cancelli non vennero mai messi, ma il nome “gates” rimase, tanto che ancora oggi si chiamano così. Ogni “gate” ha un nome perché nel diciannovesimo secolo la città di New York creò una commissione per il parco e un commissario voleva dare a ogni ingresso il nome di un santo. Gli altri dissero no, perché New York non è una città religiosa. Così li chiamarono il “gate” degli emigranti, degli artisti, dei soldati, dei ragazzi, delle ragazze. Solo uno — per fare contento quel commissario — venne chiamato il “gate di tutti i santi”». Come avete sconfitto la burocrazia di New York? «Nel 1981 ricevemmo dalla commissione del parco un rifiuto che ci venne spiegato con un volume di 140 pagine:140 pagine solo per dire no. Da allora non abbiamo più cercato il permesso». E cosa è successo? «Che l’ufficio del sindaco di New York Michael Bloomberg ci contattò nel marzo 2002. Poi ci incontrammo con il sindaco, che fece venire con sé il nuovo commissario del parco. Fu lui a dirci che il progetto “si poteva fare”». Qual è il vostro rapporto con New York? «È la città dove abbiamo scelto di vivere. Noi abbiamo da 41 anni un unico e solo indirizzo, che è qui a Manhattan, per la precisione downtown Manhattan. Abbiamo scelto New York perché Parigi non è più da tempo il centro del mondo dell’arte, questo centro è diventato New York». Eravate qui l’11 settembre? «No, eravamo a Berlino per una nostra grande esibizione. Tornammo solo il 17 settembre perché non fu possibile trovare un aereo prima. Fummo fortunati, la nostra casa non ebbe danni, non puzzava di fumo, né era coperta di polvere». Avete mai pensato di fare qualcosa sulle Twin Towers, ovviamente prima dell’11 settembre? «No, mai, assolutamente mai». Dopo Central Park lavorerete ancora a New York? «No, in estate faremo un altro “work in progress” che si chiama “Over the River”, un progetto sul fiume Arkansas in Colorado». 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 Feste leggendarie e interminabili, statuette appoggiate distrattamente sul tavolo o dimenticate nella toilette, come accadde a Meryl Streep. Gioie, eccessi e retroscena del super gala di Hollywood raccontati da Graydon Carter in un libro fotografico che ne celebra il mito. Le immagini dei vincitori esprimono gioia, eccitazione e potere, ma anche malinconia e un profondo senso di vuoto Oscar Uno sguardo dietro le quinte della premiazione più gloriosa del cinema Usa, spiando decennio dopo decennio i re di celluloide nel momento del trionfo ANTONIO MONDA NEW YORK STELLE DI OGGI Nella foto qui sotto, un giovanissimo Leonardo DiCaprio con Sharon Stone e Ellen Barkin, fotografati durante una festa a Los Angeles in occasione degli Oscar del 1994 FOTO CORTESIA VANITY FAIR ella mitologia e nella quotidianità hollywoodiana non esiste nulla di lontanamente paragonabile all’importanza degli Oscar, e nulla che serva in eguale misura a consacrare un mondo luminoso ed insulare, che promette di essere alla portata di tutti ma che sta ben attento a dimostrarsi irraggiungibile. Dalla lunghissima parata sul “red carpet” sino alle feste successive alla premiazione, che competono per glamour e presenze di star, la notte degli oscar vive nella celebrazione continua del suo stesso mito, ed omologa le personalità di ogni partecipante: anche le rarissime ribellioni e gli atteggiamenti anticonformisti fanno parte del gioco, e si trasformano, nel bagliore dei flash e nella rincorsa delle diverse telecamere, in una forma di spettacolo squisitamente hollywoodiano. Un libro monumentale e divertente, intitolato Oscar Night, testimonia attraverso fotografie ed aneddoti il fascino della notte delle stelle, con lo sguardo dell’insider che vuole condividere alcuni retroscena ma è ben felice di ribadire come nella realtà sia uno dei protagonisti (il testo è curato da Graydon Carter, direttore di Vanity Fair). Se l’arrivo delle “stretch limo” di fronte al Kodak Theatre e la sfilata sul tappeto rosso sono vissute ad uso e consumo delle telecamere e la cerimonia immortala in mondovisione l’eterna ripetizione di spasmi, giubilo e commozione, la notte è soltanto per coloro che dalla fine della premiazione sino alle prime luci dell’alba sentiranno l’ebbrezza di essere al centro dell’universo e vivranno il rituale delle feste impareggiabili, degli Oscar appoggiati distrattamente sul tavolo o addirittura dimenticati nella toilette, come accadde a Meryl Streep dopo la vittoria per Kramer contro Kramer. La storia delle premiazioni enumera una lunghissima serie di esclusioni clamorose, scelte causate da motivazioni prettamente industriali ed episodi di sconcertante miopia culturale, ma il testo preferisce celebrare gli altrettanto numerosi momenti di gloria, ed il sapore di festa per pochi eletti. In una vecchia foto in bianco e nero che immortala il ballo al Biltmore vediamo un’attrice di nome Margarita Carmen Cansino abbracciata all’agente e marito Edward Judson, che le suggerì di cambiare il nome in Rita Hayworth. Sembra una coppia che si amerà in eterno, e la futura diva sorride con un’innocenza che non potrebbe mai far prevedere l’esplosione di Gilda né i matrimoni con Orson Welles ed Ali Kahn. Nella festa leggendaria offerta dall’Academy nel 1941, James Stewart sorride di fronte all’unico Oscar vinto in carriera (per Scandalo a Filadelfia) mentre esita di fronte a un caffè che in realtà non ha nulla di particolarmente invitante. Maurice Chevalier canta con sguardo languido un brano in francese di cui nessuno capisce le parole, mentre Paul Newman, che esibisce un ele- FOTO CORBIS/CONTRASTO L’album segreto della notte più lunga N STELLE DI IERI gantissimo frac, danza abbracciato alla moglie Joanne Woodward. Sono gli anni della Hollywood leggendaria, dove anche le battaglie più sanguinose erano combattute con classe. Dopo un rapporto sul set segnato dal reciproco disprezzo, Bette Davis ottenne una candidatura come protagonista per Che fine ha fatto Baby Jane?, lasciando a bocca asciutta Joan Crawford, la quale si complimentò calorosamente in pubblico con la rivale ed iniziò in privato una capillare cam- pagna pubblicitaria nella quale elogiava la magnifica interpretazione di Ann Bancroft in Anna dei miracoli, la quale finì per vincere a sorpresa l’Oscar. La Davis, che vinse due volte su undici nomination, fu la prima a complimentarsi per l’inaspettata vittoria e citò perennemente l’interpretazione della Bancroft come la migliore del decennio. Scorrendo le immagini che immortalano la notte dei premi è quasi impossibile distinguere cosa ci sia di sincero e quanto sia fatto ad uso e consu- Nella foto qui sopra, Warren Beatty con la sorella Shirley MacLaine durante un ricevimento per gli Oscar del 1966. A sinistra, Audrey Hepburn stringe in mano la statuetta: la diva fu premiata come migliore attrice nel 1953 per “Vacanze romane”. Nelle altre immagini di queste pagine, inviti alle feste e memorabilia dei party entrati nella storia del cinema DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 mo dell’obiettivo: l’esplosione di gioia di Sophia Loren in compagnia di Carlo Ponti è accompagnata da una didascalia che ricorda che Clark Gable disse di lei «ti fa venire in mente i pensieri più proibiti», mentre Warren Beatty e Shirley MacLaine si abbracciano come se non fossero fratello e sorella. C’è qualcosa di autenticamente principesco nel gesto che fa Grace Kelly di fronte ad uno dei premi più sorprendenti della storia degli Oscar: i pronostici erano tutti per l’interpretazione di Judy Garland in È nata una stella, ed era stata organizzata persino una diretta con l’ospedale Mount Sinai dove quest’ultima aveva dato alla luce il giorno prima il figlio Joey. Ma i membri dell’Academy preferirono la futura principessa alla diva con problemi di alcolismo, e nella sera della vittoria per La ragazza di campagna Dominick Dunne profetizzò che Grace Kelly era «una ragazza ricca destinata a diventare una stella». Una leggenda hollywodiana racconta che la vittoria di Marisa Tomei per Mio cugino Vincenzo sia dovuta al fatto che uno sbronzo Jack Palance, incaricato di consegnare il premio, abbia letto il suo nome al posto di quello di Judy Davis, e nessuno ebbe il coraggio di rettificare. L’imbarazzo del momento si tramutò in gioia quando fu chiaro a tutti che la giovane età della Tomei rappresentava un investimento molto più proficuo di quello legato alla vittoria della straordinaria attrice australiana, data per trionfatrice certa della serata. Molto diverso il caso di Julie Andrews, caratterizzato per una volta da una solidarietà corporativa da parte dei votanti dell’Academy di fronte ad un evidente sopruso. Nonostante il trionfale successo a Broadway, Jack Warner impose che l’attrice inglese venisse rimpiazzata con Audrey Hepburn nella versione cinematografica di My Fair Lady. Il film di George Cukor fu il trionfatore di quella edizione, ma nel ruolo di protagonista la Hepburn venne battuta proprio dalla Andrews per Mary Poppins, e lei ringraziò perfidamente Jack Warner. LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 Il rito della grande notte ha un ruolo talmente importante nella mitologia hollywoodiana che ogni parola assume una importanza strategica ed economica. Dopo la delusione della mancata vittoria per Mask, Cher salì sul podio per Stregata dalla luna ma dimenticò di ringraziare gli agenti, i produttori ed il manager. Il giorno seguente fu costretta ad acquistare tre pagine di pubblicità su Variety nelle quali si scusò SEX SYMBOL Sopra, Kim Basinger, premio Oscar nel 1998 come miglior attrice per il film “L.A. Confidential” pubblicamente con coloro che non erano stati citati in mondovisione. Non mancano episodi di distacco (Woody Allen rimase a suonare il clarinetto a New York la sera del trionfo di Io & Annie) e protesta (Marlon Brando mandò una pellerossa a ritirare il premio per Il Padrino), ma nel grande nulla di Hollywood, il momento del premio può rappresentare ciò che dà il senso ad un’intera esistenza, e sono IL GIORNO DOPO Sopra, Faye Dunaway, miglior attrice nel 1977 per il film “Network”. La foto è stata scattata dal fotografo Terry O’Neill che sarebbe diventato suo marito passate alla storia la commozione di Sally Field che ringraziò i votanti perché aveva finalmente compreso di essere apprezzata, e l’emozione paralizzante di Kim Basinger che arrivò a «ringraziare tutte le persone mai incontrate nella mia vita». Le fotografie esprimono tutte gioia, eccitazione e potere, e tralasciano momenti imbarazzanti come i due Oscar vinti da Ian McLellan e Robert Rich, prestanomi per Dalton Trumbo, il grande sceneggiatore messo sulla lista nera all’epoca del maccartismo. Il dolore sembra inconcepibile o addirittura inesistente, ed anche i personaggi colpiti dalla tragedia appaiono splendenti di una luce innaturale: fa una certa impressione vedere Francis Ford Coppola che fa stringere l’Oscar vinto per Il Padrino parte II al figlio Gian Carlo, ed il sorriso di un giovanissimo Sal Mineo pretende un futuro radioso che gli è stato negato dalla vita. I potenti di sempre danzano serenamente con i re per una notte, e la dirompente felicità di qualche ora mette sullo stesso piano Ted Turner, David Geffen e Barry Diller con tutti coloro che dal giorno dopo dovranno sperare in una loro approvazione per i propri progetti. Ci sono delle tavolate spettacolari definite con gergo hollywoodiano «A list» (Steven Spielberg, Bruce Springsteen, Tom Hanks, Elton John) ed atti sublimi di snobismo (un Oscar dimenticato accanto al dessert), ma c’è soprattutto la bellezza, esibita con orgoglio dopo settimane di preparazione, trucco, massaggi e scelta del vestito perfetto. È straordinariamente bella Demi Moore alla cerimonia del 1992, lascia senza fiato la Halle Berry di dieci anni dopo ed è sintomatico notare come nel tempo sia aumentata drasticamente la presenza di interpreti di colore. In questo tripudio di felicità procurano un certo disincanto le effusioni d’amore in stile Hollywood tra Brad Pitt e Jennifer Aniston, Tom Cruise e Nicole Kidman, ed è un segno di coraggiosa sottigliezza l’immagine scelta come conclusione del libro, che immortala Faye Dunaway la mattina successiva alla vittoria mentre contempla a bordo piscina il suo Oscar con uno sguardo che esprime, stanchezza, malinconia ed un profondissimo senso di vuoto. 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 l’anniversario Tempi moderni Quasi per caso, settant’anni fa, la DuPont scopre una nuova fibra “resistente come l’acciaio e delicata come una ragnatela” che consente di rimpiazzare la seta. È il boom della sensualità e della seduzione a prezzi popolari. Ma passano gli anni e le mode: il collant accompagna la stagione dell’emancipazione femminile i nuovi tessuti hi-tech esaltano la praticità e sterilizzano l’erotismo Nylon E la calza inventò la donna donna, giorno dopo giorno, passa attraverso l’indumento più diffuso e anche il più banale: le calze. Non importa che i sondaggi sull’immaginario erotico maschile tornino ogni volta a confermare che sono le gambe, meglio se velate da calze con la giarrettiera, la principale calamita dell’erotismo: più del seno, più del fondoschiena, più dello sguardo, più del sorriso. È il reggicalze ora a diventare indumento di nicchia, esibito una tantum come arma letale di un supremo arsenale feticista, e non certo per affrontare la vita quotidiana. Il resto è cronaca dei nostri giorni. Ed è stata certamente una meteora passeggera la moda, attorno all’anno 2000, di andare in giro a gambe nude anche con temperature siberiane, decretata da tutti gli stilisti e adottata dalle attrici di Hollywood più che dalle donne normali. Un lusso che possono permettersi in poche, giovanissime e dalle gambe perfette. La riscossa non si è fatta aspettare: tramontata la livida moda del piedino nudo anche quando nevica, le aziende hanno immesso sul mercato un’impressionante quantità di collant in modelli e anche in materiali d’avanguardia. I nuovi collant, ma anche le nuove calze autoreggenti e no, diventano un prolungamento dell’abito, molto più di un semplice accessorio. Pudichi o sfacciati, sono sofisticatissimi, ricamati, stampati, tempestati di paillettes o spruzzati di lurex, hanno il logos tatuato o l’intarsio geometrico, il labirinto optical o il graffito, copiano il tweed, la spina di pesce, lo scozzese, il gessato; sono a righe, a scacchi, a maglie di rete giganti; hanno tagli e strappi fatti ad arte, e poi borchie, ornamenti etnici, disegni in rilievo. Possono essere a vita bassa, come piacciono alle giovanissime, e possono lasciare il piede nudo per i sandali infradito, come invisibili ghette. Le nuove microfibre consentono calze make up altamente tecnologiche, dotate di effetti speciali: possono essere antibatteriche, antistatiche, antifatica, antizanzare, anticellulite, traspirantimassaggianti-abbronzanti. Possono essere antivarici alla centella asiatica, idratanti-profumate all’olio di albicocca o sapere per esempio di limone al mattino e di lavanda al pomeriggio. Possono avere l’effetto push up che fa lievitare anche i glutei più stanchi. Possono lenire il jet-lag e presto anche depilare. In Giappone, dove non sta bene andare in giro a gambe nude neanche d’estate, hanno inventato il collant spray: una doppia pelle a portata di bomboletta. Noi continuiamo ad essere i maggiori produttori di calze da donna del mondo ma ne consumiamo un po’ meno che in passato. Per una volta non è colpa dell’effetto euro: è semplicemente che le calze di oggi, grazie alle nuove fibre tecniche, sono più resistenti. Quanto al loro carico di seduzione, al loro antico essere emblema o baluardo di femminilità, più si allontanano dal concetto di nudo e più appaiono, ormai, sterilizzate. FOTO CORBIS/CONTRASTO S Per le ragazze passare dai mortificanti calzettoni a quelle che comunemente venivano chiamate «calze fini», agognatissime, segnava l’ingresso nell’età adulta. Negli anni del boom le «calze fini» erano un privilegio del mondo occidentale tecnologicamente avanzato, facilmente accessibili, in vendita in qualunque grande magazzino. Non così oltrecortina: è con le valigie piene di calze, graditissimo dono, che i giovani italiani partivano d’estate per i paesi dell’Europa dell’Est, scopo rimorchio. La seconda rivoluzione data dalla metà degli anni Sessanta, in concomitanza con l’invenzione, audace e liberatoria, della minigonna. Arrivano — con la lycra — i primi collant. Tentativi goffi, più parenti della calzamaglia da paggio o da sci che delle calze hi-tech di oggi. Comunque un indumento simbolo, apprezzatissimo dalle donne (all’inizio solo dalle ragazze) per la sua dirompente praticità. E invece osteggiato e antipatizzato dall’universo maschile, che lo ha sempre vissuto con ostilità, lo ha subìto come un sopruso defraudante e come negazione dell’erotismo, ingiusta censura delle prime perlustrazioni se non tattili, per lo meno visive di ogni uomo nell’approccio verso l’altro sesso. Ma quella del collant è una strada senza ritorno, a cambiare costumi, gusti, abitudini. Considerato con diffidenza nei primissimi tempi, indumento di nicchia, dilagherà presto in ogni classe sociale e anagrafica. La liberazione della IL CINEMA Quattro indimenticabili immagini di seduzione sul grande schermo: immancabile la calza di nylon Lo spogliarello di Sophia Loren in “Ieri, oggi e domani” (1963); a destra, Marilyn Monroe e Jane Russel in “Gli uomini preferiscono le bionde” (1953); in alto, la celebre scena da “Il laureato” (1967) con Dustin Hoffman e Anne Bancroft. Nella foto grande, Silvana Mangano nel film “Mambo” (1954) FOTO WEBPHOTO ettant’anni in un soffio: è il fruscio delle calze di nylon. Pochi oggetti sono così prosaici e così evocativi ad un tempo. Simbolo assoluto di femminilità, sembra che esistano da sempre, come la donna. Niente appare più intimo di una calza. Le vedi una accanto all’altra, le bellissime: icone di seduzione e di meraviglia. Marlène Dietrich, calze scure e giarrettiere, angelo della perdizione. Silvana Mangano mondina piegata sulla risaia. Sophia Loren, era il ’63, che si cimenta in uno spogliarello diventato cult non solo per la sensualità ma anche per l’ironia, e si sfila lenta una calza nera facendola oscillare ipnoticamente. Sante e peccatrici, dive e sex symbol, personaggi dei cartoon come Betty Boop e super oggetti del desiderio come Marilyn Monroe o il suo peccaminoso contraltare europeo, Brigitte Bardot. Sciantose e casalinghe, signore e cameriere. Ecco Laura Antonelli, colf in Malizia, arrampicarsi su una scala regalando l’estatica visione di quella proibita porzione di cosce che le calze lasciavano nuda. Ecco Kim Basinger in Nove settimane e mezzo: che cosa resterebbe del suo leggendario strip-tease senza la veneziana dello sfondo e la calza di nylon fatta franare quasi al rallentatore? Sarebbe un peccato estetico, tuttavia, relegare la fibra artificiale che ha cambiato la vita delle donne a questa galleria di fotogrammi. Certo: nell’immaginario collettivo, non solo maschile, le calze evocano un fremito di sensualità. Molto più complessa, nella realtà quotidiana della cronaca, è la marcia verso la libertà, la comodità, l’emancipazione che le calze di nylon hanno compiuto in settant’anni di storia. Una rivoluzione già dal loro primo impatto sul mercato, nei tardi anni Trenta, a decretare la democratizzazione di un indumento fino allora riservato a pochissime. Prima che nel ’35 la DuPont scoprisse per caso il nuovo polimero chiamato nylon, le calze erano esclusivamente di seta. Dunque costosissime, riservate a chi poteva permettersele. Pregiate ma anche scomode, dure, facevano le grinze sulle caviglie, si sfilavano con una facilità vertiginosa e, costando una fortuna, venivano ciclicamente riparate da valenti rammendatrici. Ci volle qualche anno perché fossero prodotte in serie. Si creò una curiosità enorme attorno a quella nuovissima fibra che i produttori definirono «resistente come l’acciaio e delicata come una ragnatela». Distribuite nel 1939 in tutti gli Stati Uniti, furono accompagnate da un imponente battage pubblicitario: solo a New York se ne vendettero quattro milioni di paia in poche ore. Ma già l’anno successivo cominciarono i tempi magri: la produzione di calze in nylon venne bruscamente interrotta. Si preferì concentrare l’utilizzo della nuova fibra sintetica su impieghi militari, per esempio per confezionare paracadute. L’attrice Betty Grable, fidanzata d’America in giarrettiere, si sfilerà le calze mettendole pubblicamente all’asta per 40mila dollari da destinare all’esercito. Durante la guerra, soprattutto in Europa, né di seta né di nylon: le calze non c’erano proprio, o comunque erano rarissime, soprattutto nell’Italia autarchica. Così le donne supplirono con la fantasia e con l’ingegno, disegnandosi sul polpaccio nudo la cucitura, en trompe-l’oeil. Il primo dopoguerra ma soprattutto gli anni Cinquanta videro l’esplosione della calza di nylon come bene di massa, usa e getta. Comparvero i primi modelli senza la riga dietro, grazie ai nuovi sistemi di produzione. Davvero il massimo della praticità, nonché il primo segnale di emancipazione: per lo meno dalla schiavitù di dover sempre tenere riga e talloni sotto controllo, perfettamente allineati. Dalle giarrettiere di Marlène Dietrich alla mondina Silvana Mangano, dallo spogliarello di Sophia Loren alla cameriera Laura Antonelli: una galleria di icone indimenticabili FOTO WEBPHOTO LAURA LAURENZI DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 L’EVOLUZIONE LA MAGLIA Già nelle antiche tombe dei faraoni egizi sono stati trovati frammenti di calze lavorate a maglia, mentre i romani avvolgevano le gambe con fasce di tela o lana LA SETA Le prime calze in seta compaiono nel Medioevo: a indossarle sono esclusivamente gli uomini. Solo in seguito diventano simbolo del lusso anche per le donne IL SINTETICO Nel 1939 vengono messe in vendita le prime calze in nylon alla portata di tutte le tasche. È subito un delirio: davanti ai negozi si formano lunghe code di donne IL COLLANT È la seconda rivoluzione, nella prima metà del 1965: con la minigonna arrivano le calze alte fino alla vita. Gli anni Sessanta verranno ricordati per calze e collant in pizzo 1 grammo È il peso di un solo filo prodotto in microfibra di nylon lungo ben 9 mila metri 3,8 milioni Sono le tonnellate di nylon prodotte nel 2003 in tutto il mondo 400 milioni II fatturato 2004 di Nylstar la società mista italofrancese leader europea della produzione di nylon FOTO CORBIS/CONTRASTO LA RETE La robustezza del nylon e la resistenza alla salsedine ne fa il materiale ideale per le reti da pesca. La fibra chimica ha quasi sostituito le reti in corda di canapa AIR BAG Tra le applicazioni più recenti della fibra sintetica c’è l’air-bag usato per le automobili Il “plus” del nylon è costituito dal mix fra la resistenza del materiale e la sua elasticità Vita e ascesa del superfilo di Carothers GIORGIO LONARDI degno di Hollywood il dramma di Wallace Hume Carothers, il chimico americano fragile e geniale che inventò il nylon. Chiamato nel 1928 a soli 31 anni dal colosso industriale DuPont de Nemours a riorganizzare i laboratori di Wilmington nel Delaware, Carothers, sofferente di depressione, espresse i suoi timori in una lettera indirizzata ad un alto dirigente della corporation: «I miei periodi di nevrosi e di semi-infermità potrebbero costituire un ostacolo molto più serio in un ambiente industriale che ad Harvard». La DuPont, però, non mollò la presa e Carothers, alternando periodi di iperattività e di profonda prostrazione, non tradì le aspettative. Già nel 1932 il giovane chimico inventava il neoprene, una gomma sintetica utilizzata ancora oggi per le mute da sub. Poi Wallace Hume si concentrò sulla preparazione per via di sintesi di polimeri (macromolecole) con una struttura simile a quella della seta e della cellulosa. Il 28 febbraio del 1935 il gruppo di Carothers produsse la prima fibra completamente sintetica con caratteristiche simili a quelle delle fibre naturali. Era nato il nylon che DuPont avrebbe brevettato nell’aprile del 1937. Tre settimane dopo Carothers, atterrito dal peso della notorietà e convinto di essere un fallito, si suicidò con la fiala di cianuro che portava sempre in tasca. La marcia trionfale di questa fibra robusta ed elastica, che poteva essere facilmente tinta, definita «resistente come l’acciaio e delicata come una ragnatela» fu rapida ed inarrestabile. Nel ’38 DuPont annunciò lo stanziamento di 8 milioni di dollari per la costruzione a Stanford nel Delaware del primo stabilimento. Due anni dopo, nel 1940, furono vendute nel territorio degli Stati Uniti 64 milioni di paia di calze di nylon e le americane fecero la coda per acquistarle. Intrisa di cultura yankee, creata a ridosso della seconda guerra mondiale, già nella genesi del nome la creatura di Carothers avrebbe eccitato nazionalismi e leggende metropolitane. «È nata una nuova parola e una nuova fibra: il nylon» recitava la pubblicità di DuPont. Ma per molti cittadini nylon era l’acronimo di «Now you lousy old nipponese». Una frase il cui significato cambia a seconda di dove si mette la virgola ma che suona più o meno così: «Ora sei un pidocchioso, vecchio giapponese». Secondo altri, invece, il nome nylon nasce dalla contrazione delle due prime città dove le calze furono messe in vendita: New York e Londra. Molto più probabilmente, invece, la scelta finale fu fatta dalla DuPont all’interno di 400 nomi di fantasia già preselezionati. Il monopolio americano del nylon durò poco. Nel dopoguerra la nuova fibra fu introdotta in Italia. La produzione in un primo momento fu affidata solo alla società Rhodiatoce mentre dal 1956 entrarono sul mercato anche Snia e Bemberg. A tirare la volata furono (e sono) indubbiamente le calze da donna tanto è vero che nella zona di Castelgoffredo si sviluppò un vero e proprio distretto industriale che avrebbe conquistato l’egemonia del comparto a livello mondiale. Dopo la crisi del settore delle fibre chimiche degli anni Settanta e Ottanta anche il comparto del nylon ha subito una serie di concentrazioni e di razionalizzazioni. Oggi il maggior fabbricante europeo è la Nylstar (400 milioni di euro di fatturato), una joint-venture franco-italiana costituita dai gruppi Rhodia e Snia che controlla il 40 per cento del mercato del vecchio continente. Eppure il nylon non è soltanto il materiale con cui si producono calze e collant. La leggerezza, la resistenza a muffe e batteri combinata alla facilità di manutenzione ne hanno ampliato il campo di utilizzazione. Basti citare i costumi da bagno, fabbricati in abbinamento agli elastomeri, un’altra fibra chimica. Sempre più diffusi anche gli impieghi tecnici per borse, zaini, corde, pneumatici, cinture di sicurezza. Ma non solo. Fra le applicazioni meno conosciute ci sono anche gli air bag delle automobili. È DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 le tendenze Di legno pregiato, in alluminio, acciaio o cristallo, il “mobile” intorno a cui si riuniscono amici e famiglie non è solo un elemento di arredo ma è da sempre simbolo della socialità domestica. Oggi più che mai il mercato lo riscopre e propone modelli di nuova generazione Case da abitare FOTO ZEFA La vita è un giro di tavolo MICHELE SERRA crisse Natalia Ginzburg che nell’aldilà avrebbe voluto portarsi una sedia, nel timore che tutta quella immensità la stancasse. Ci aggiungerei (se non mi allargo troppo) un tavolo, perché se penso al vuoto penso a una casa senza un tavolo, un giardino senza un tavolo, un bar senza un tavolo, una vita senza un tavolo. Pensandoci meglio, un posto senza il tavolo è un posto che non prevede gli altri: e dell’assenza degli altri ho paura più della morte (o forse vedo nella morte soprattutto l’irrimediabile assenza degli altri). Dunque un tavolo, almeno uno, per disporre attorno ai suoi quattro lati, o alla sua circonferenza, le persone che condividono il mio tempo, il cibo e il bere, il gioco e la conversazione. “Mettere le gambe sotto un tavolo” non indica mai un gesto individuale, ma sempre un’intenzione comune, la spartizione di un momento o di un atto anche minimo, purché comune. Il tavolo è sempre il testimone di un “noi”, guai se è addossato al muro come la solitaria scrivania, richiede intorno a sé lo spazio del convivio, e non per caso non amo i tavoli poggiati alla parete, quel lato monco stona e respinge, decurta le occasioni, attorno ai tavoli si deve poter passare, correre quando si è bambini piccoli (terribile lo spigolo quando è giusto all’altezza della capoccia), e non per caso la giusta collocazione del tavolo, quando si sistema una casa, è una delle questioni più delicate. Perché il tavolo è come il biliardo (a suo modo il Tavolo dei Tavoli), prevede intorno a sé l’agio dell’accessibilità e della circolazione, è un punto al quale si deve poter arrivare da ogni punto cardinale, l’approdo ideale dalle diverse stanze, dalle diverse solitudini. Se fate il conto (e non sono conti facili) vi accorgerete che il tavolo, non il letto, è forse il luogo dove avete speso la maggiore percentuale di amore e di dolore, di fatica intellettuale e di felice intesa, lungo le infinite conversazioni delle vostre stanze di vita. Perché a tavola ci si guarda negli occhi, ci si dicono le cose che altrimenti possono scivolare via per la casa, al tavolo non si scantona. Èattorno al tavolo (dei ristoranti, in genere) che si costruisce ogni amore. Di tanti tavoli, quello patriarcale (interminabile, di noce) della casa di mia bisnonna, tutt’ora in auge (non la bisnonna, ma la casa e il tavolo) è per me il più caro, e significativo. Il capo- S LASCIA O RADDOPPIA Il tavolo Morris di Bontempi Casa si raddoppia. Per tutti i single che amano ospitare tanti amici ALLUMINIO MON AMOUR Flat è un tavolo tutto in alluminio e completamente smontabile Di Giuseppe Bavuso per Rimadesio JOLLY E I SUOI FRATELLI Ha la sobrietà del grande protagonista; Jolly è in policarbonato colorato e trasparente. Palesemente di Kartell tavola è sempre stato il più anziano, poi via via, a scalare lungo il vecchio legno familiare, i più giovani, fino ai bambini, a far casino in fondo, all’altro capo del tavolo e del tempo. Ho risalito quel tavolo, lungo gli anni, fino a ritrovarmi quasi a capotavola, e ormai è poco il margine che mi separa da quell’approdo, perché le generazioni, attorno ai tavoli, trascorrono veloci. Ma se attorno a quel tavolo aleggia l’ombra degli scomparsi, quando le luci della sera sono tutte accese e il legno è imbandito (e il tavolo diventa tavola, femmina nutrice) è la vita che trionfa, è il vino che brilla, la conversazione che rimbalza, allietata dagli equivoci che la sordità degli anziani — presto la mia… — genera, dai racconti mai veramente desolati che si fanno sul passato e sui morti. Se penso a quanta vita e quante parole, quanti sentimenti e liti, discussioni politiche, parole d’amore quel tavolo ha assorbito (in italiano, in francese, in inglese) dico che è un altare. Ci hanno mangiato e scherzato, ai primi del secolo, ragazzi poi morti ventenni nelle Ardenne, in quella carneficina idiota e orrenda che fu la Grande Guerra. Ci hanno litigato severi professori antifascisti e psicologie più disponibili al compromesso, signore con le sottovesti e le gonne lunghe e teen-agers in minigonna (ora madri di altre teen-agers col piercing). Quando le sedie rinserrano le persone attorno a quella tavola da pranzo, è come se si ricomponesse una storia collettiva che il tempo vorrebbe destrutturare, ma la parentela (perfino quel dubbio vincolo non sempre sincero che è la parentela) ricompone ogni estate. Infine, apparecchiare la tavola per gli amici e le persone care è da sempre, per me, uno dei gesti più allegri e sacri. Allegro e sacro non sempre vanno a braccetto, pensate dunque che privilegio ha la tavola quando li riassume entrambi, la tavola che è abbondanza e ringraziamento, memoria dei commensali scomparsi e omaggio al vigoroso appetito dei vivi. La sola preghiera che mi manca davvero, che vorrei tanto saper pronunciare, è quella che si fa a tavola e che precede il pasto, la gratitudine per il pane e soprattutto per il companatico. Sì, ogni tavolo è un altare, e se non lo diventa è solo per la nostra colpevole distrazione. GEOMETRIE IN CODICE Geometrie essenziali e praticità è la scelta di Feg per il tavolo allungabile Code, realizzato in legno di teak AGGIUNGI UN POSTO Per chi della convivialità non può fare a meno Il tavolo Hollywood offre un’ampia scelta di forme e misure. Di Tacchini LAMIERA SAGOMATA Il tavolo Less Molteni, in lamiera sagomata sottilissima, è nato dal progetto di Jean Nouvel per la fondazione Cartier QUESTIONE DI STATURA Piano è il più piccolo e Altipiano il più alto: i nomi dei tavolini Rexite giocano sulle differenti altezze. Entrambi in versione quadrata e rotonda RIUNIONE AL TOP Il designer Luca Scacchetti ha firmato Corinthia, tavolo da riunione caratterizzato dalla sezione centrale in cristallo e dalla struttura di sostegno in tubolare d’acciaio. Di Poltrona Frau L’OGGETTO MISTERIOSO Katava, il tavolo-consolle d’alluminio disegnato da Satyendra Pakhalé per Duepuntosette, è prodotto in edizione limitata a soli trenta pezzi Difficile relegarlo in un angolo 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 i sapori Tavolette, torte, sfoglie di cacao purissimo: i maestri cioccolatieri italiani continuano a sperimentare con successo nuove delizie per i più golosi. Fondente e gianduiotti vengono contaminati con spezie esotiche ed aromi rubati alla cucina e seducono il palato e i sensi dei più esigenti. Ecco una carrellata delle ultime tendenze Dolci passioni itinerari Silvia Imparato, ex fotografa di origine napoletana, produce uno dei migliori rossi italiani, il Montevetrano, un vero e proprio “SuperCampan” da uve Aglianico, Cabernet Sauvignon e Merlot, prodotto in provincia di Salerno. È innamorata della sua terra e del cioccolato fondente Positano TORTA CAPRESE Il suo segreto - ingredienti nordici (a partire dal burro), niente farina,croccante all’esterno e morbida al cuore - fu trafugato al bar Vuotto di Capri direttamente dalla residenza di Maxim Gorki. Esiste anche in una versione, meno affascinante e più leggera, con i limoni della costiera amalfitana DOVE DORMIRE CASA ALBERTINA, via Tavolozza 3 telefono 089-875143. Positano (Salerno). Camera doppia da 130 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE AL PALAZZO, via dei Mulini 23 telefono 089-875177. Aperto tutti i giorni, solo a cena, da marzo a novembre: 45 euro, vini esclusi Positano (Salerno) DOVE COMPRARE PASTICCERIA LA ZAGARA via dei Mulini 8 telefono 089-875964 Positano (Salerno) www.lazagara.com Prato TORTA PISTOCCHI La ricetta della sottrazione. Niente farina, uova, zucchero, burro. E nemmeno grassi vegetali, conservanti, ogm. Solo cioccolato fondente (buonissimo), cacao amaro in polvere e pochissima crema di latte fresca. Eppure, la creazione del fiorentino Claudio Pistocchi è straordinaria. Esistono due varianti: peperoncino e amarene DOVE DORMIRE B&B RESIDENZA JOHANNA via Cinque Giornate 12, telefono 055- 473377. Firenze Camera doppia a 85 euro, colazione inclusa Vignola TORTA BAROZZI Uno strepitoso assemblaggio di mandorle, cioccolato e polvere di caffè, elaborato dalla famiglia Gollini, giunta alla quarta generazione di arte pasticciera. Il dolce, dalla ricetta segretissima e senza punti vendita se non il laboratorio originale, è dedicato al celebre architetto vignolese Jacopo Barozzi DOVE DORMIRE ALLA ROCCA, via Matteotti 76 telefono 051-831217, Bazzano (Bologna). Camera doppia a 130 euro, colazione inclusa DOVE MANGIARE FUSION BAR (Gallery Hotel Art) vicolo dell'Oro 5, telefono 055- 27263. Chiuso il lunedì, menù da 35 euro, vini esclusi DOVE MANGIARE HOSTERIA GIUSTI vicolo Squallore 46, telefono 059-222533. Modena. Chiuso domenica e lunedì. Cena su prenotazione. Menù da 40 euro, vini esclusi DOVE COMPRARE L'ANTICA GASTRONOMIA via degli Artisti 58r telefono 055- 578460. Firenze www.tortapistocchi.it DOVE COMPRARE PASTICCERIA GOLLINI via Garibaldi 1N, telefono 059-771079 Vignola (Modena) www.tortabarozzi.it 4 kg Il consumo di cioccolato procapite ogni anno in Italia Cioccolata Piaceri dell’altro mondo LICIA GRANELLO appuntamento è vecchiotto, usurato ma ineludibile. Lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, riuscirà difficile far finta di nulla. Archiviato il brillante e rinnegata la pelliccia, esaurita la scelta di cravatte e dopobarba, a far la differenza più che il costo sarà l’idea. Con il cioccolato, per esempio, non si sbaglia mai. Ma si rischia la banalità. A meno che, messi da parte i cioccolatini da agiografia pubblicitaria, ci si addentri nel territorio golosissimo (e ancora poco conosciuto) delle nuove praline, delle torte-culto, delle supertavolette seducenti come una scollatura velata. Questione di palato e di allenamento. Abbiamo importato il cioccolato dal Messico quattro secoli fa attraverso i conquistadores spagnoli. Lo abbiamo riscattato dalle ruvidezze originali (coperte dall’uso massiccio di spezie) grazie ai sofisticati cioccolatieri torinesi, allievi dei grandi “maitres patissieres” francesi (a metà Ottocento, fare il cioccolatiere era considerata un’arte tanto L’ Sacher Torte La madre di tutte le torte al cioccolato è stata inventata nel 1832 dal pasticcere austriaco Sacher, in servizio alla corte del principe austriaco von Metternich Winnesburg L’elaborazione, a base di materie prime da pasticceria classiche – farina, burro, zucchero, uova, cioccolato – si contraddistingue per la farcia di marmellata d’albicocche e la lucida glassatura a base di cioccolato remunerativa che le carrozze dei più bravi rivaleggiavano in lusso con quelle reali). E negli anni abbiamo imparato che la tipologia al latte è un po’ come per l’astemio bere un bicchiere di Moscato d’Asti: una tappa di avvicinamento facile e goduriosa al paradiso dei Grandi Golosi. Dove si mangia quasi solo fondente, purché di alta qualità. Siamo diventati così bravi, in Italia, da aver bagnato il naso ai francesi, strappando loro l’esclusiva di Chuao e Porcelana, due nomi-mito del pianetacioccolato. Merito dei fratelli Tessieri, proprietari di una fabbrica-bomboniera alle porte di Pontedera, cuore di quella Chocolate Valley, meta di pellegrinaggi devoti da tutto il mondo. Dalla “Amedei”, infatti, il percorso si snoda irresistibile tra i laboratori-culto di Catinari (Agliana), Slitti (Monsummano Terme), De Bondt (Pisa), Molina (Quarrata), Mannori (Prato). Come una ciliegina sulla torta (è il caso di dirlo, dopo aver assaggiato la torta al cioccolato e amarene) la new entry del fiorentino Claudio Pistocchi. Sono loro, insieme a una manciata di “esterni” – Guido Gobino, Corrado Assenza, Franco Rizzati, Domori, Franco Ruta – a fare del cioccolato un gioiello da gustare senz’altri sensi di colpa che quelli legati alla quantità. Perché in accordo perfetto con nutrizionisti e scienziati, basta limitare i dosaggi per trasformare l’oscuro oggetto del desiderio gourmand in una medicina miracolosa: euforizzante, digestiva, tonificante, afrodisiaca, a secondo delle esigenze (e delle convinzioni). I cioccolatieri si sono adeguati rapidamente: le tavolette sono sottili e lievi, le minisfoglie non superano i sei grammi di peso, le praline poco di più. Meno facile trattenersi davanti a una delle torte elette a oggetto di culto dal passaparola dei buongustai. È il caso della torta Barozzi, inventata da un pasticcere emiliano oltre un secolo fa: ricetta segreta, distribuzione negata, durata limitata. Chi l’ha assaggiata, non la dimentica più. Ma il cioccolato, si può conoscere anche da molto, molto vicino. Se vi sentite ispirati e vogliosi di fai-da-te, la ChocoTravels organizza veri e propri week end didattici per imparare i segreti dei cioccolatieri direttamente nei loro laboratori. Dopo lo stage dal piemontese Giacomo Giraudi (creatore di una meravigliosa crema al cioccolato: la “Giacometta”), il prossimo corso si terrà a casa De Bondt il 19 e 20 febbraio. Potete immaginare un modo più goloso di festeggiare San Valentino? ZUCCA Il ferrarese Franco Rizzati ha sfruttato l’ortaggio principe della sua terra candito ad arte per ammorbidire il gusto deciso del fondente. Nella sua offelleria, si realizzano anche i cioccolatini con lo zenzero candito in proprio. Ultime sue creazione: due nuove tipologie di cioccolato affumicato DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 FOTO ZEFA 1528 ‘‘ CARLO GOLDONI Che bevanda delicata Che diletto mi dà! Viva pur la cioccolata Che dà gusto e sanità Viva pur la cioccolata E colui che l’ha inventata da LA CONVERSAZIONE ‘‘ GABRIEL GARCIA MARQUEZ Un momento (...) ora assisteremo ad una prova irrefutabile dell’esistenza di Dio. Il ragazzo che aveva servito messa gli portò una tazza di cioccolato spesso e fumante che egli bevve d’un fiato da CENT’ANNI DI SOLITUDINE È l’anno in cui arriva il cioccolato in Europa 25 mila Sono i laboratori artigianali di cioccolato in Italia 5 mln Le tonnellate di cioccolato prodotte nel 2004 nel mondo Dopo il mix europeo con lo zucchero Tornano le ricette dei sacerdoti Maya MASSIMO MONTANARI 40 mila “C Sono i cioccolatieri che lavorano in Italia ROSMARINO A pochi chilometri da Pistoia, i fratelli Lunardi hanno messo a punto un’inedita fusione di gusti tra gli odori dell’orto rosmarino e salvia e il cioccolato. I “cretti” sono profumati, suadenti. Dall’orto al laboratorio, sempre in regime di alimentazione naturale, sono state create anche le gustose praline alla frutta ASSENZIO La storica azienda torinese Leone, famosa per le mitiche pastiglie realizzate con ingredienti naturali, estratti e oli essenziali, ha recuperato il liquore maledetto (ingentilito) per sposarlo al cioccolato al 70%, inventando un gusto complesso e suadente I Leone producono anche un interessante cioccolato privo di zucchero PEPERONCINO Il più antico degli “additivi” del cioccolato, secondo ricetta azteca, è riproposto dalla Dolceria Bonajuto di Modica, impreziosito dallo zucchero in cristalli. Fedeli alla ricetta originaria pure gli assemblaggi con vaniglia e cannella, che caratterizzano le tavolette, senza snaturare i gusti primari del cacao SALE Una coppia toscoolandese, Cecilia e Paul De Bondt, ha eletto a prelibatezza l’associazione tra cioccolato in due sfoglie (al latte e fondente) e cristalli di sale (fleur de sal), che temperano l’acidità del cacao, esaltandone la morbidezza e gli aromi Oltre a spezie come il pepe nero, esistono varianti con rosa, anice stellato, gelsomino acahuaquchtl”. Così gli antichi maya chiamarono una pianta dell’America centrale i cui noccioli, una volta abbrustoliti, sbucciati, frantumati e ridotti in polvere, venivano bolliti in acqua caldissima con l’aggiunta di pepe, peperoncino, zenzero, miele, farina di mais. La bevanda che ne risultava, dal sapore aspro e pungente, era consumata dai sacerdoti durante i riti religiosi ed era offerta agli déi, che, si diceva, la preferivano a ogni altra bevanda. Quando gli europei invasero l’America, la bevanda al cacao suscitò subito la loro curiosità, ma non incontrò il loro gusto. Essi infatti, in quei secoli, erano tutti presi dalla moda dello zucchero e dei sapori dolci. La loro cucina ridondava di zucchero, un prodotto allora sconosciuto in America, che gli arabi avevano portato in Europa durante il Medioevo e che era rapidamente diventato un segno di prestigio sociale. I menù delle corti rinascimentali si aprivano con zuccherini e questo sapore accompagnava poi l’intera successione dei piatti: carni intrise di zucchero, pasta spolverizzata di zucchero, torte dolcisalate, e così via, fino alla confetteria finale. Cuochi, gastronomi, dietologi, scienziati erano tutti d’accordo che “il zuccaro fa compagnia ad ogni altra cosa” e che “nessuna vivanda lo rifiuta”. Nessuna sorpresa, dunque, se anche la cioccolata fu accolta in Europa solo a patto di essere ammorbidita e addolcita. Le spezie forti della tradizione americana (pepe, peperoncino, zenzero) furono sostituite da aromi più delicati: vaniglia, muschio, ambra. Ma, soprattutto, fu il massiccio impiego di zucchero a trasformare il sapore della bevanda, che tuttavia conservò l’antico nome maya di “chacahoua”, da cui derivarono lo spagnolo e l’inglese “chocolate”, il francese “chocolat”, l’italiano “cioccolata”. In Europa, come già in America, la cioccolata rimase per lungo tempo una bevanda per pochi. Soprattutto i ceti aristocratici la adottarono, e poiché gli alimenti non sono solo alimenti ma anche immagini sociali, essa diventò, nel XVII-XVIII secolo, quasi un simbolo dell’ozio nobiliare, a cui la cultura borghese contrapponeva l’operosità dei mercanti, la produttività degli industriali e l’acume degli intellettuali illuminati, che si celebravano piuttosto nella “bottega del caffé”. I due prodotti, la cioccolata e il caffé, finirono per rappresentare stili di vita opposti. La cioccolata incontrò un notevole successo anche tra i religiosi, dato che, in quanto bevanda (ma con una capacità nutritiva decisamente insolita), ne fu consentito il consumo nei giorni di digiuno. In certi paesi, come la Spagna, si continuò a prepararla con l’acqua, secondo l’uso americano. Altrove, come in Italia o in Inghilterra, si preferì sostituire l’acqua con il latte. Nel XIX secolo apparve la cioccolata solida, destinata a enorme fortuna. Attorno alla cioccolata le sperimentazioni non si sono mai fermate. Nel Settecento vi fu chi propose di mescolare il cacao con il vino o con la birra, con il caffé o con il tè, con l’acquavite, col brodo di carne. Le “novità” che abbiamo oggi sotto gli occhi (cioccolate con altissime percentuali di cacao e poco zucchero, cioccolate con aromi piccanti e spezie forti) paiono in qualche modo riportarci là dove questa storia era cominciata, nelle foreste dell’America centrale dove maya e aztechi celebravano i loro riti con bevande al cacao mescolato con zenzero e peperoncino. ZAFFERANO Il cioccolatiere torinese Guido Gobino, celebre per avere reintegrato la ricetta del gianduiotto senza latte, ha creato una pralina dal carattere speziato e persistente, con fondente al 60% , zafferano di Navelli e Vaniglia Bourbon. Da gustare anche il ginger&lemon e il Pinguino, minigianduiotto “foderato” di fondente 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 l’incontro Testimoni della storia Alla soglia dei suoi novant’anni il rabbino capo emerito di Roma racconta il Novecento che ha attraversato prima come studente universitario perseguitato perché ebreo, poi come partigiano e infine come guida religiosa: il secolo breve dei totalitarismi, delle leggi razziali e della Shoah. Ma anche il secolo, ci dice, che ha aperto una strada di pace e tolleranza da cui non è più possibile tornare indietro Elio Toaff «H ROMA o visto le più grandi tragedie del secolo passato. I drammi e le violenze delle guerre, delle sopraffazioni e della povertà. Ho visto le tragedie della Shoah, i morti innocenti di Auschwitz, di Dachau e degli altri campi di concentramento. Ho visto bambini ammazzati, gente impiccata, feti strappati dal ventre della madre e uccisi a colpi di pistola. Ho visto tante, troppe persone umiliate dalle leggi razziali, dall’antisemitismo, dall’odio apparentemente inspiegabile verso l’ebreo. Ma la speranza non l’ho persa mai. E oggi, alle soglie dei miei novant’anni, malgrado tutto, guardo al futuro con fiducia, rincuorato anche dalla ritrovata vitalità del dialogo ebraico-cristiano che, grazie in particolare a un papa come Giovanni Paolo II, ha imboccato una strada fatta di reciproca comprensione e di fraterna intesa. Un dialogo fruttuoso che nessuno più riuscirà a spezzare». Elio Toaff, rabbino capo emerito della comunità ebraica di Roma, la più antica d’Europa, lo racconta così il Novecento, il secolo “breve”, il secolo delle grandi tragedie dell’umanità. L’occasione è doppia: i novant’anni che compirà alla fine del prossimo aprile ma anche il sessantesimo anniversario, appena passato, dell’apertura dei cancelli di Auschwitz. Novant’anni, una meta che — assicura — «attraverserò guardando sempre avanti». Ma che offre l’opportunità, per una volta, di girare lo sguardo sul secolo passato, attraversato di corsa, sempre in prima linea, prima come studente universitario perseguitato dalle leggi razziali, poi come padre di famiglia, docente, rabbino e, anche, partigiano. «Ma la cosa di cui sono più sono fiero — confessa — è l’essere stato testimone dello sviluppo di questo paese, nel quale la comunità ebraica ha svolto un ruolo sempre più rilevante e condiviso, malgrado un passato fatto anche di leggi razziali, di campi di concentramento, di persecuzioni». Toaff parla con un inconfondibile accento toscano — o, meglio, livornese — e accompagna le parole con un sorriso vivace, a tratti nervoso, ma sempre spontaneo. Anche quando evoca eventi tristi. Negli occhi brilla sempre una luce, come se le antiche tragedie fossero ormai dimenticate. Ma è solo apparenza. «Sono nato a Livorno — racconta — il 30 aprile del 1915 e la mia famiglia, come quelle di tutti gli ebrei italiani, ben presto fu costretta a fare i conti con le leggi razziali». Figlio del rabbino della città toscana Alfredo Sabato Toaff e di Alice Yarch, il giovane Elio studia al collegio rabbinico di Livorno e si laurea all’università di Pisa. Ha una sorella, Pia, e due fratelli, Cesare e Renzo che si rifugiano in Israele. «Renzo — ricorda oggi —, un bravo chirurgo, fu letteralmente cacciato dall’ospedale mentre era alle prese con un intervento. “Me ne andrò solo dopo aver terminato l’operazione”, disse. E così fece». La laurea in giurisprudenza è una scommessa vinta quasi per caso. «A causa delle leggi razziali nessun docente era disposto a farmi da relatore. Alla fine solo un professore accettò. Si chiamava Lorenzo Mossa e mi affidò una tesi sul conflitto di leggi in Palestina, frutto dell’incontro della tradizione ottomana, inglese ed ebrea. Ma al momento della discussione della tesi, il presidente Cesarini Sforza se ne andò, buttando la toga sul tavolo, arrabbiato perché ero ebreo. Mossa, senza farsi intimorire, decise di continuare e mi laureai con un 105. Era il 1939». Ma la vera vocazione del giovane Toaff non è la magistratura. Mentre studia all’università continua l’impegno religioso all’interno della comunità ebraica livornese. E nel 1940 viene nominato rabbino. «Mio padre non voleva», ricorda con un sorriso. «In famiglia, mi diceva, di rabbino ce n’è già uno, che basta e avanza. In realtà, aveva timore per me, avendo annusato la brutta aria che in Italia si respirava già da anni. Non lo ascoltai. Ed eccomi qua». Il primo incarico arriva nel ’41 con la nomina a rabbino capo della comunità ebraica di Ancona. «Fu una esperienza interessante, molto formativa, a tratti anche dura. All’inizio, i momenti più difficili. Appena arrivato — dice — seppi che una famiglia di ebrei stava per convertirsi al cristianesimo. Senza esitazioni, li andai subito a trovare poche ore prima della celebrazione. Dissi al padre che stavano per fare un passo vigliacco, inutile e poco dignitoso. In un primo momento non fui capito, ma sarà stato per la mia foga, per la mia sincerità o forse la passione con cui parlai, alla fine nessuno si convertì. Anzi, il padre diventò presidente della consulta umanitaria della comunità». Sono anni difficili per il giovane rabbino. Un giorno Toaff va in ospedale per portare il conforto religioso a un pa- ziente ebreo. «Appena mi presentai fui cacciato via da due infermieri. Senza scoraggiarmi andai dal maresciallo dei carabinieri che, con grande determinazione, mi fece scortare da quattro carabinieri, assicurandomi che avrei potuto sempre rivolgermi a lui per qualsiasi problema. Un galantuomo». Ad Ancona, anche la comunità ebraica vive il dramma della guerra: «La gente partecipava alle preghiere del tempio, ma senza fare molta vita comunitaria. Quando arrivarono i tedeschi, chiusi la Sinagoga, anche in occasione della grande festa del Kippur, e insieme a tutta la popolazione mettemmo in salvo la comunità nelle case e nelle parrocchie. I ragazzi e i bambini li imbarcammo su una nave in direzione del Sud, dove erano arrivati gli alleati». Nel ’43, il matrimonio con Lia Luperini, insegnante di lettere, dalla quale avrà quattro figli: Ariel, Miriam, Daniel e Godiel. L’arrivo dei nazisti costringe i Toaff a cercare rifugio in Versilia, a Val di Castello. Si salvano grazie a un par- A Sant’Anna di Stazzema ho visto un feto strappato dal ventre della madre e finito con un colpo di pistola. Ecco perché dalla Germania non sono mai passato neppure in aereo roco, don Francalanci: «Ci nascose per molto tempo nella sua parrocchia. Dormivamo in chiesa, mio padre sui gradini dell’altare maggiore, noialtri sulle panche». Con l’arrivo degli alleati, la famiglia Toaff può tirare un sospiro di sollievo. Ma durante un nuovo rastrellamento delle Ss, il rabbino — insieme ad altre persone — viene catturato. «Mi salvai per sbaglio mentre mi stavo scavando la fossa. Gli altri furono fucilati: io, per ordine di un comandante austriaco con cui avevo scambiato un po’ di parole in francese, fui salvato. Prima di andarmene pregai sui corpi dei compagni che non avevano avuto la mia stessa fortuna». La scelta partigiana è un passo obbligato, che Toaff compie unendosi alle brigate versiliane e che, tra l’altro, lo porterà, armi in pugno, ad essere uno dei testimoni oculari della strage di Sant’Anna di Stazzema. «Entrammo in città quando i tedeschi se ne erano già andati. Trovammo un deserto spettrale — ricorda — poi davanti ai nostri occhi apparvero i corpi privi di vita di 505 persone fucilate». Ma all’orrore non c’è fine, negli anni più bui del ventesimo secolo. È un’altra la scena che segna Elio Toaff per tutta la vita: «Con altri partigiani entrai in un casolare e vidi una donna appoggiata al tavolo come se dormisse. Non era così. Era morta. Aveva la pancia squarciata dall’alto in basso. Accanto a lei trovammo il feto che le era stato strappato dal ventre, morto, con la testa traforata da un colpo di arma da fuoco. Quell’immagine mi ha cambiato l’esistenza. E da allora — confessa — non ho avuto più la forza di toccare il suolo della Germania, né di sorvolarlo con l’aereo. Non l’ho più fatto, anche se qui a Roma ho accettato l’invito dell’ambasciata tedesca. Devo aggiungere che da partigiano non ho mai sparato e, tantomeno, ucciso». Finita la guerra, nel 1945 arriva la nomina a rabbino capo della comunità ebraica di Venezia, che guiderà per sei anni. «Anche quella fu una esperienza bellissima. Trovai una comunità vivace, vogliosa di crescere, specialmente dal punto di vista culturale e scolastico, ben inserita nel tessuto cittadino. Tra gli episodi più curiosi di quel periodo, l’invio nel ’48 di un carro armato abbandonato dai tedeschi al nascente Stato di Israele. Un dono simbolico, ma fu il primo carro armato dell’esercito israeliano». Nel ’51, «inaspettatamente», la nomina a rabbino capo di Roma, incarico che coprirà per cinquant’anni. «Ricordo che all’inizio qualche rabbino si lamentò per il mio arrivo, perché non ero romano. Poi ci conoscemmo bene e non ci furono più problemi». Nella capitale il primo problema in quegli anni era la povertà: «Con le ferite della guerra e delle deportazioni ancora aperte, la comunità era in grande difficoltà. Ma piano piano, lavorando sodo, senza mai scoraggiarci, cominciammo a crescere e a camminare». Non senza difficoltà. «Il momento più terribile che ho vissuto da rabbino capo di Roma è stato l’attentato alla Sinagoga del 1982, quando i terroristi palestinesi del gruppo di Abu Nidal provocarno la morte del piccolo Stefano Tasché e il ferimento di quaranta persone. Un episodio triste e drammatico frutto di un clima politico antiebraico, come denunciai al presidente Pertini. Un clima che spero non torni mai più». Ma il Novecento di Toaff è anche quello del dialogo. Nel suo mezzo secolo romano, il rabbino è stato dirimpettaio di cinque papi. Ma solo uno è diventato suo amico personale, quasi un fratello: papa Wojtyla. «Con Pio XII non ci furono mai contatti, nemmeno istituzionali — racconta Toaff — purtroppo era il clima del tempo. Con Giovanni XXIII incominciò la svolta: con il Concilio che cancellò l’accusa di deicidio al popolo ebraico e con lo stesso Roncalli che abolì quell’espressione di “perfidi giudei” in uso per secoli tra i cristiani. Giovanni XXIII fu poi autore di un gesto che emozionò tutta la comunità: un giorno fece fermare la sua auto davanti alla Sinagoga per benedire gli ebrei che uscivano dal tempio. Fu un momento bellissimo, commovente: dopo duemila anni, per la prima volta, un papa aveva benedetto un gruppo di ebrei». «Con Paolo VI — ricorda Toaff — non ci furono incontri, ma iniziò il dialogo ebraico-cristiano grazie a figure come il vescovo Clemente Riva, uno dei silenziosi artefici della storica visita di Giovanni Paolo II alla Sinagoga, l’indimenticabile visita contrassegnata da quella felicissima espressione di “fratelli maggiori” con cui il Papa definì il popolo ebreo. Questo papa — al quale auguro una pronta guarigione e che spero di incontrare presto — ha veramente fatto tanto per la reciproca conoscenza tra ebrei e cristiani. Ha chiesto sinceramente scusa per le colpe storiche dei cristiani nelle persecuzioni ebraiche, ha allacciato le relazioni diplomatiche tra Vaticano e Israele, ha visitato la Sinagoga. Per questo, dico, i rapporti tra ebrei e cristiani si sono ormai avviati verso una felice strada senza ritorno». ‘‘ ORAZIO LA ROCCA
Scarica