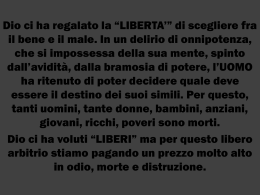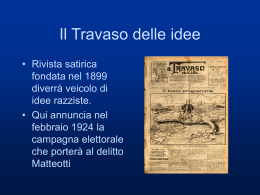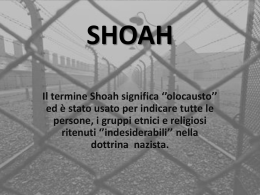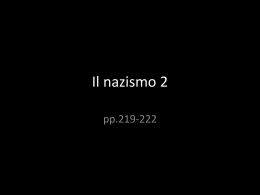Istituto Tecnico per Geometri
GUARINO GUARINI
Torino
A.S. 2000-2001
DEPORTAZIONE
La storia della deportazione è anche la storia di coloro che non furono inviati nei
Lager nazisti perché riuscirono a nascondersi o a fuggire. In gran parte di queste
vicende ritroviamo il complesso intreccio che caratterizzò il comportamento degli
italiani e delle istituzioni: solidarietà, silenzio colpevole, ostilità, fino ad arrivare, in
diversi casi, alla delazione. In tutti coloro che si salvarono troviamo comunque la
difficile eredità morale e psicologica dei sopravvissuti. Esaminate il contesto storico
in cui queste vicende si inseriscono mettendo in luce esperienze di singoli o di gruppi,
ricostruibili attraverso fonti orali, oppure attraverso la letteratura sull'argomento (in
particolare diari o memorie dei protagonisti).
CLASSE 5ª A sp.
Christian Di Potenza
Luigi Gentile
Andrea Pozzi
Andrea Ragno
L'insegnante:
Antonella Filippi
Dedichiamo il nostro lavoro alle Sorelle Giordana,
ringraziandole per il loro grande esempio di umanità.
2
INTRODUZIONE
Questo non è un lavoro sulla deportazione nei campi di sterminio tedeschi ma uno studio su coloro
che riuscirono per vari e diversi motivi a salvarsi dal viaggio verso la Germania, e sulle
circostanze umane o fortuite che li aiutarono a rimanere in Italia e a sopravvivere alla furia
nazista.
La nostra ricerca si concentra storicamente sul periodo che segue l'8 settembre 1943 e la
successiva invasione nazista dell'Italia, quando cioè iniziarono in massa le deportazioni anche dal
nostro paese, come già era successo dagli altri paesi occupati dai tedeschi.
Le prime vittime delle persecuzioni, che avevano come fine la morte o la cattura, furono gli ebrei: e
infatti i primi a capire l'imminente tragedia furono gli ebrei stranieri, rifugiati, nascosti o internati
in Italia, i quali già conoscevano la furia e la brutalità nazista.
Ma la complessa situazione di quei giorni che seguirono l'annuncio dell'armistizio, portò anche
altri gruppi a cercare la fuga o il nascondiglio: erano soldati, come si dice, sbandati, che non
accettavano più di continuare la guerra o di entrare nelle file dei repubblichini. Moltissimi sono
infatti i casi di gente comune che ha nascosto qualche soldato e ha fornito loro vestiti civili;
numerose sono anche le fughe in Svizzera di interi reparti o alla spicciolata, di soldati in fuga.
Un'altra situazione di fuga in extremis fu quella tentata, e raramente riuscita, dai treni che
andavano in Germania o dai campi di transito italiani.
Le testimonianze che abbiamo raccolto riguardano in special modo casi e situazioni di ebrei salvati
e nascosti, anche perché questa è stata la situazione più drammatica e rischiosa, sia per chi
cercava di fuggire sia per chi dava aiuti di qualunque tipo, dal fornire documenti falsi al
nascondere nelle proprie case intere famiglie.
Alla nostra ricerca di fonti di memoria scritte e orali, si è affiancato, per la posizione degli ebrei, lo
studio della specifica situazione dell'Italia, che fin dal 1938 aveva una propria legislazione
razziale; abbiamo però cercato di passare dalla analisi nazionale a quella che ci concerne più da
vicino, e quindi alla risposta di Torino alle leggi razziali e al crescendo di paure e violenze che
caratterizzarono la nostra città dopo l'occupazione tedesca.
Le testimonianze raccolte riguardano solo casi di coloro che si sono salvati o di coloro che hanno,
con grande coraggio, dato ogni sorta di aiuto. I casi di delazione sono più difficili da testimoniare,
perché chi ne è stato vittima forse non può più raccontare; o forse perché la nostra memoria tende
a non cercare esempi dolorosi e vergognosi del nostro essere uomo.
E infatti, nel corso della preparazione del nostro lavoro, abbiamo incontrato alcune persone che
per la loro testimonianza di umanità e coraggio, difficilmente dimenticheremo.
3
Un intero capitolo della ricerca è dedicato agli ebrei di Saint Martin Vésubie, che fuggirono dalla
Francia nelle valli di Cuneo, scappando dai tedeschi e finendo in un' Italia anch'essa invasa dai
nazisti. Per capire meglio la dinamica dei fatti, ci siamo recati sul posto, a Boves, a Borgo San
Dalmazzo e a Valdieri; e abbiamo avuto la possibilità di incontrare e intervistare Don Francesco
Brondello (all'epoca vicecurato di Valdieri) e le Sorelle Giordana, che abitano ad Andonno, un
paesino poco prima di Valdieri. Le loro storie e le loro testimonianze sono state per noi
importantissime e di grande insegnamento.
In un altro capitolo abbiamo analizzato l'altra grande possibilità di fuga, che era la Svizzera; in
questo caso abbiamo lavorato sugli ultimi testi di ricerca storica, ma siamo riusciti ad isolare una
storia importante e poco conosciuta, quella dei "Ragazzi di Villa Emma", che furono salvati prima
dalla solidarietà della popolazione civile del luogo (siamo in provincia di Modena), e poi dalla
fuga in Svizzera.
Gli altri capitoli riguardano casi singoli di salvezza alla cattura nazista: la storia della Signora
Carmela Mayo Levi (che abbiamo incontrato e intervistato nella sua casa di Torino), le
drammatiche vicende raccontate nel suo diario da Renzo Segre, e la fuga della famiglia Benedict
che trova, fuggendo da Fiume ,la salvezza a Boves.
Abbiamo lasciato per ultimo, ma non per importanza, il capitolo dedicato alle fughe dai trasporti
per la Germania: l'argomento, infatti per la sua specificità, non si inserisce nell'ambito della
persecuzione razziale. Infatti i casi di fughe dai trasporti riguardano un altro aspetto della
deportazione, quello dei prigionieri politici, poiché i pochi che hanno tentato di scappare dai carri
bestiame blindati erano, per ovvi motivi, soli, giovani, e con un'esperienza di lotta partigiana alle
spalle.
Alcuni capitoli sono il frutto del lavoro di un solo studente, altri, soprattutto quelli delle
testimonianze da noi trascritte, sono il frutto della cooperazione di tutti.
Torino, marzo 2001
L'insegnante
4
INDICE
1. Dal 25 luglio del '43 all'occupazione nazista....................................................... p.
5
La persecuzione razziale a Torino nei Diari di Emanuele Artom e di Carlo Chevallard.
2. Gli ebrei di Saint Martin Vésubie: storie di deportazione. .............................. p.
(di Luigi Gentile)
21
I personaggi:
A. Donati ............................................................................................................... p.
Don Raimondo Viale............................................................................................. p.
Il Campo di Borgo San Dalmazzo. ...................................................................... p.
Don Francesco Brondello ..................................................................................... p.
Le Sorelle Giordana. ............................................................................................. p.
36
38
41
44
58
3. La fuga in Svizzera................................................................................................ p.
( di Andrea Ragno)
66
4. Carmela Mayo Levi. ............................................................................................. p.
86
5. Renzo Segre. .......................................................................................................... p.
( di Christian Di Potenza)
96
6. La Famiglia Benedict. ........................................................................................... p.
( di Andrea Pozzi)
113
7. Le fughe dai trasporti. .......................................................................................... p.
(di Chistian Di Potenza).
120
5
Dal 25 luglio '43 all'occupazione nazista.
La persecuzione razziale a Torino nei diari
di Emanuele Artom e di Carlo Chevallard
6
Carlo Chevallard 1 nel suo diario di guerra 1942-45, annota il 5 agosto del 1943 una riflessione
importante: «Sto rileggendo i colloqui di Ludwig, mai come oggi interessanti. Leggo la pagina sul
problema semita: “il problema semita non è mai esistito in Italia” queste sono parole pronunciate
nel 1932 da Mussolini, lo stesso che 6 anni dopo doveva, sull’esempio tedesco, introdurre in Italia
le leggi razziali! Raramente credo la storia ricorderà simili esempi di voltafaccia» 2
In quell’estate del 1943, dopo il 25 luglio, gli ebrei in Italia avevano incominciato a sperare: le leggi
razziali non erano state abolite 3 , ma il clima era cambiato.
Nei quarantacinque giorni che precedono l’armistizio, sembra che il fascismo sia finito, si vive in
una sorta di momento felice, di speranza e di contraddizioni; la stampa riprende a scrivere senza
bavaglio, la gente ricomincia a parlare liberamente, i simboli del regime vengono distrutti, i fascisti
cercano di levarsi la camicia nera, e di non incorrere nella rabbia della gente.
«Oggi passo davanti alla sinagoga: vi sventola una enorme bandiera tricolore. Son giorni di festa
per gli ebrei, questi!» 4 , scriveva Chevallard il 28 luglio 1943.
L’incubo della discriminazione razziale iniziata nell’estate del 1938, la paura delle violenze, la
segregazione, le umiliazioni, sembravano dunque avviarsi alla fine, così come si credeva che di lì a
poco sarebbe finita la guerra e con essa Hitler e Mussolini.
Erano passati cinque anni da quell’estate del 1938, quando (in seguito ad una campagna di stampa
scatenata fin dall’aprile del 1937) con il Manifesto della razza degli scienziati fascisti nel luglio e
con il censimento degli ebrei, nell’agosto, si misero le basi dell’antisemitismo italiano, che andrà
poi meglio definendosi nei mesi e negli anni successivi. Fu una sorpresa per gli italiani e per gli
ebrei? Le testimonianze ebraiche, all’epoca del censimento, non fanno presagire (se non in parte) le
persecuzioni e le umilianti discriminazioni dell’autunno del 1938.
In Italia non era arrivata la forte corrente antisemita della fine dell’800 e dell’inizio del ‘900,
sviluppatasi in Europa dalla Francia (Dreyfus) alla Russia (I Protocolli dei Savi di Sion) con forti
punte nella Germania della Repubblica di Weimer.
1
Carlo Chevallard, nato a Torino nel 1913, figlio di un'agiata famiglia borghese, è negli anni della guerra dirigente
industriale. Chevallard che si definisce "dissenziente" al regime, pur senza avere un impegno politico attivo, è un uomo
di sentimenti democratici, di idee liberali e sicuramente un antifascista.. Il suo diario, scritto negli anni di guerra 1942'45, è la maggiore fonte di memoria di cui si disponga su Torino in guerra.
Nel 1974 il Diario di Chevallard è pubblicato in un'edizione parziale, da Le Bouquiniste, Torino.
L'edizione completa del Diario (quella a cui si fa riferimento) è pubblicata dalla Città di Torino - Archivio storico, nel
1995, nel volume Torino in guerra tra cronaca e memoria.
2
Op. cit., p.83.
I "colloqui di Ludwig" a cui Chevallard fa riferimento, sono il testo pubblicato nel 1932 dallo scrittore tedesco Emil
Ludwig, Colloqui con Mussolini. Nel capitolo "Socialismo e nazionalismo", Mussolini afferma:<…l'orgoglio nazionale
non ha bisogno dei deliri di razza.> e, all'osservazione del Ludwig che questa era la migliore dimostrazione contro
l'antisemitismo, egli infatti ribatte: <L'antisemitismo non esiste in Italia.> E prosegue con un elogio agli ebrei italiani.
3
4
Soltanto nel gennaio 1944 la legislazione razziale è abrogata nell’Italia liberata
Chevallard, opera citata pag. 76
7
Dal momento dell’entrata in vigore delle leggi razziali, scattarono anche in Italia tutti quei
meccanismi che nascono quando si definiscono superiorità ed inferiorità presunte, e in questo caso
“certificate” dal Manifesto, che si inventava una razza italiana pura e incontaminata da cui
bisognava espellere l’elemento inquinatore degli ebrei.
Nell’attuare la capillare operazione del censimento del 22 agosto del 1938, utilissima fu ad esempio
l’opera dei vigili, (che si affiancò a quella dell’anagrafe e della questura) che erano inviati «a
interpellare tutte le portinaie della città al fine di individuare il numero più ampio possibile di
nominativi» 5 E quando il clima di sospetto e di intimidazione andò crescendo per le pesanti
conseguenze su chi veniva individuato israelita («innumerevoli licenziamenti subiti dagli ebrei già
nell’ autunno del ’38 e alle altre limitazioni imposte per legge o per via amministrativa, nonché alle
umiliazioni patite dai colleghi, dai vicini o da emeriti sconosciuti»6 ) ci fu anche la “corsa”di coloro
che volevano un certificato di “razza ariana”o per se' o per eventuali soci di lavoro. «Le richieste
individuali non erano ancora numerose, ma già davano un’ idea piuttosto chiara di come anche nei
rapporti fra le persone singole si stesse ormai diffondendo il sottile veleno instillato dalla montante
campagna di opinione e accuratamente canalizzato da meccanismi istituzionali appositamente
predisposti» 7 .
Eppure, solo qualche anno prima lo stesso Mussolini dichiarava che “L'antisemitismo non esiste in
Italia”!
Erano bastati dunque alcuni mesi di campagna battente sui quotidiani e quelle deliranti affermazioni
di razza italiana = razza ariana (ariani gli italiani? Razza incontaminata quella italiana!) per
sconvolgere una convivenza pacifica e non razzista tra cristiani ed ebrei, perché gli ebrei erano
italiani da sempre.
Finiti con le lotte Risorgimentali e con lo Statuto del 1848 le limitazioni e le ghettizzazioni di ebrei
e valdesi, in Piemonte, come altrove in Italia, l’ebreo era italiano.
Il fascismo dunque immette in Italia un antisemitismo moderno, costruito sugli stereotipi
dell’antisemitismo nazista, e senza collegamenti alla tradizione italiana che aveva al più convissuto
con l’antigiudaesimo medioevale tipico della lunga e antica storia cristiana.
«Nessuna attenuante dal punto di vista etico o politico può essere invocata a favore del fascismo
italiano. (…) Dopo le leggi di Norimberga del 1935 la legislazione italiana fu l’apparato normativo
più esteso e analitico che fosse introdotto nel mondo. Non se ne può valutare la sostanza
valutandolo in senso più blando al confronto con la legislazione e la prassi nazista; lo si deve
5
Fabio Levi,”Il censimento antiebraico a Torino”, in L’applicazione delle leggi antiebriche a Torino 1938-43, Consiglio Regionale del Piemonte
(opuscolo introduttivo) pag. 8
6
F. Levi, opera citata pag. 18
7
F. Levi opera citata pag. 18
8
valutare in base alla lesione che recò ai diritti civili e umani e al tentativo di imbarbarimento del
popolo italiano che con esso fu compiuto». 8
Perché l’Italia si mette, nel 1938, sulla strada dell’antisemitismo?
L’antisemitismo italiano è “prodotto autoctono” «ma anche effetto diretto o indiretto del montare
della persecuzione in Germania». 9 Mussolini ha, nel 1938, cambiato da tempo le linee della sua
politica estera: l’avvicinamento alla Germania fin dalla scelta della guerra d’Etiopia e soprattutto
con l’appoggio comune a Franco nella guerra di Spagna è, nel 1938, una decisa scelta di campo.
E il fatto che con la campagna antisemita del 1938 il fascismo identificasse l’antifascismo con il
giudaismo, ci fa ricordare molto da vicino l’assioma di Hitler per cui gli ebrei erano bolscevichi.
Le leggi razziali ebbero effetto immediato sulla scuola: l’allontanamento degli studenti e professori
ebrei dalle aule ebbe, con l’inizio dell’anno scolastico nell’ottobre del 1938, una ripercussione
significativa, sia per gli ebrei sia per i compagni che non avevano più i loro vicini di banco e i loro
insegnanti.
Ma anche qui la campagna antisemita aveva avuto effetti sull’opinione pubblica; dice Giuliana
Bozzi Punteruoli: «frequentavo l’istituto delle Martelline perché mi avevano mandato via già da
altre scuole, dal Manzoni… Sul grembiule bianco, dietro, mi scrivevano: “porca ebrea, vattene”. Mi
scrivevano così….. e questo anche da una mia compagna di banco che mi aveva sempre adorato». 10
Le discriminazioni, con i “Provvedimenti per la difesa della razza italiana” del 17 novembre 1938,
(firmati da Vittorio Emanuele III, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lamtini), raggiungono un
livello capillare per la vita degli ebrei: con l'art. 10 è negata la vita civile; con l’art. 13 è negata la
possibilità di lavoro nell’amministrazione pubblica.
Il 16 maggio 1940 si decreta la chiusura della frontiera agli ebrei stranieri provenienti dai territori
del Reich. A ciò seguiranno misure restrittive; elenchi di persone da internare, disposizioni per
l’arresto di stranieri e altro. Ma il continuo afflusso di stranieri costringe le autorità ad aprire campi
di internamento 11 in località isolate dell’Italia centro-meridionale. Gli internati erano costretti a
vivere in condizioni spaventose, ma non peggiori di quelle della popolazione contadina del luogo:
vi sono comunque opere di solidarietà da parte di queste persone, rimaste indifferenti di fronte alle
leggi razziali. Occorre fare una maggior pressione sulla popolazione, per convincerla che la
discriminazione degli ebrei è una giusta causa, e Mussolini sa cosa fare.
8
E.Collotti, La soluzione finale, Tascabili economici Newton, 1995, pag. 17
E.Collotti, Opera citata, pag. 15
10
R.Broggini, La frontiera della speranza, Mondadori, 1998, pag. 123
11
Il più importante campo di internamento nell’Italia meridionale fu quello di Ferramonti di Tarsia, in Calabria, dove si arrivò a concentrare 2016
ebrei (Broggini, op.cit., p.128). Nel complesso nell’Italia meridionale saranno raccolti circa 3800 ebrei.
Per questi ebrei, dopo l’8 settembre 1943 , con l’avanzata degli alleati, l'internamento nel Sud, significò la salvezza.
9
9
Il 16 ottobre 1941 la campagna stampa, che lo stesso Mussolini aveva intrapreso nell’aprile1937, si
appesantisce con i manifesti che vengono incollati nelle vie centrali delle città. Ne riportiamo i testi:
Giudei sono: Da Verona, Pitigrilli, Moravia, Loria, Segre, Somigliano, Terracini,
Franco, Levi Montalcini, Einstein, Blum, La Passionaria, Alvarez del Vajo, Carlo
Marx, Litvinof, Lenin, Mordavisi, Voronof, Modigliani, Maestro, Roosvelt, Jachia,
Bombacci, Artom, il Negus, De Benedetti, Dario Disegni.
Giudei sono tutti i capi della Massoneria e tutti i manutengoli della Borsa. Giudei sono
i vigliacchi più spregevoli, i propalatori delle notizie allarmanti, gli accaparratori e gli
affamatori del popolo, i denigratori più impenitenti, i disfattisti più perversi, gli
sfruttatori di donne e di uomini. Giudei sono gli omosessuali, quelli che non hanno mai
sudato, mai lavorato, quelli che han sempre tradito la patria,quelli che han voluto le
sanzioni.
Dunque vogliamo finirla una buona volta? Non hai campi di concentramento, ma al
muro con i lanciafiamme.
Viva il Duce! Viva Hitler!
P.S. Faremo i conti anche con i complici degli Ebrei, i cosiddetti giudei onorari.
Italiani,
Mentre in Russia i nostri fratelli combattono, muoiono e vincono, mentre in Africa
Settentrionale i nostri figli preparano la più fulgida delle vittorie, mentre a Gondar il
sangue del nostro sangue insegna al mondo intero come l’Italia può combattere,
resistere e vincere con poche munizioni e tirando la cinghia anche oltre l’ultimo buco,
qui in patria l’Ebreo la cui unica passione è l’oro, il cui unico sentimento è la pancia,
il cui unico credo è l’egoismo, vive tranquillo e indisturbato incettando i nostri viveri,
seminando falsità e calunnie, insidiando le nostre donne.
Italiani il nostro nemico N. 1 è l’ebreo; il nostro nemico N. 2 è l’Ariano che
protegge l’Ebreo. Non diamo quartiere a questi due nemici, più pericolosi degli altri
perché vivono tra noi, tradiscono tra noi.
Italiani, al moto Vincere uniamo il motto Morte all’Ebreo. Solo così accelereremo
la vittoria, solo così ci renderemo degni di chi al fronte combatte, soffre e muore.
Vincere! A morte il Giudeo! 12
12
E. Artom, Diari, Centro di Documentazione Ebraica, 1966, pag. 31-32
10
Ma già tra la notte del 14 e il 15 ottobre '41 avviene un attentato incendiario al Tempio di Torino; è
segno che i modi di pensare della gente sono cambiati, la dispendiosa campagna stampa
incomincia a fare effetto. Con l’attentato al Tempio e i manifesti, gli ebrei sono veramente
diventati i capri espiatori di una situazione cui sono totalmente estranei; ma la gente ormai
comincia a convincersi, ne sono testimonianza le scritte ironiche e intimidatorie che compaiono sui
muri della città la sera dopo l’affissione dei manifesti. Il 17 esce il terzo manifesto contro gli ebrei,
e la popolazione prima indifferente ora li legge con sempre più attenzione.
Emanuele Artom 13 scrive: «Un gruppo di studenti che nella scorsa notte strappava dei manifesti è
stato insultato e malmenato da un ufficiale di complemento» 14 . Questo ingiustificato
comportamento incomincia a suscitare, tra la comunità ebraica, in particolare tra i giovani, qual è
anche Artom, delle reazioni: «leggere dei cartelli, … nei quali ci si minaccia di morte, accusandoci
per esempio di tradimento e di omosessualità, è un’esperienza che non a tutti è dato di vivere» 15 .
Il 6 maggio1942 viene disposta la precettazione per il lavoro manuale obbligatorio sancito dal
Ministro dell’Interno; le cartoline furono recapitate
settembre. La legge recitava: «Con
agli interessati sul finire del mese di
disposizione in data odierna, gli appartenenti alla razza
ebraica, anche se discriminati, di età dal 18 al 55 anno compresi, sono sottoposti a precettazione
civile a scopo di lavoro» 16 . In realtà non venivano precettati tutti gli ebrei, ma soltanto coloro che
erano disoccupati e gli studenti che avevano ultimato le scuole medie.
E. Artom che ricevette la cartolina il 1 ottobre e sarà costretto a presentarsi il 3 ottobre, scrive:
«abbiamo tirato fuori la tuta. Me la sono misurata e se l’è misurata anche papà. Infatti mi hanno
destinato a scaricare la legna a partire da lunedì mattina alle 8.» 17
Il lavoro manuale obbligatorio, anche detto coatto, veniva svolto dagli ebrei precettati. Erano
lavori umili e spesso inutili come ci racconta Aldo Zargani «… i fascisti decisero di umiliare i
giovani ebrei con una sorta, idiota, di lavoro coatto, che consisteva nello spostare traversine
13
Emanuele Artom nasce ad Aosta nel 1915 e cresce, a Torino, in un ambiente intellettuale, fedele alla tradizione
ebraica e di forte avversione al fascismo. Laureato in lettere, si dedica alla ricerca storica e collabora con il Museo del
Risorgimento di Torino. Le leggi razziali lo costringono ad uscire dall'ambiente universitario, ma non gli impediscono
di continuare i suoi studi sull'emancipazione ebraica nel Risorgimento.
Nelle leggi razziali E. Artom trova una ragione in più per approfondire la conoscenza dell'ebraismo: la sua prima spinta
ad una "resistenza" attiva, nasce proprio dal suo essere ebreo.
Dopo l'8 settembre 1943 E.Artom si iscrive volontario nelle forze di Giustizia e Libertà (Partito d'azione). Il 7
novembre entra a far parte delle Bande partigiane di Barge; nel gennaio '44 è nominato commissario politico del Partito
d'Azione ed è attivo in Val Pellice. Catturato il 25 marzo in Val Germanasca, fu brutalmente torturato nelle Carceri di
Luserna San Giovanni e terminò il suo "martiro" alle Nuove di Torino, dove morì per le torture e le sevizie subite.
Il suo diario, iniziato il 1 gennaio 1940 e interrotto il 23 febbraio 1944, è un'altissima testimonianza di onestà morale ed
intellettuale ed esempio di pacata e lucida riflessione su persone ed avvenimenti di quei tragici anni.
14
E. Artom, op. cit. , pag.34
E. Artom, opera citata, pag. 35
16
E. Artom, opera citata, pag.44 (nota)
17
E. Artom, opera citata, pag.44
15
11
ferroviarie da un mucchio all’altro per poi rimetterle al posto di prima. Lo spettacolo si svolgeva,
tra le risate dell’intera città, ebrei compresi, in un’area brulla di via Cernaia vicino alla stazione
ferroviaria di Porta Susa.» 18
Nonostante da questa testimonianza riaffiori il carattere umiliante e persecutorio del lavoro coatto,
Guido Weiller afferma che essi non furono trattati male né sul posto di lavoro dai padroni né tanto
meno dagli stessi compagni. Erano quindi una minoranza costretta a lavorare in mezzo alla strada
18
A.Zargani, Per violino solo, Il Mulino, 1995, pag. 61
12
13
dove tutti potevano assistere a ciò che veniva ordinato loro di fare; così facendo venivano alla luce
segni che permettevano il riconoscimento anche per strada degli ebrei. Il fatto di indossare la tuta
da lavoro, avendo un aspetto signorile, mani poco rovinate, segno di chi, fino a quel momento non
aveva mai fatto lavori pesanti.
A Torino infatti le famiglie ebree appartenevano in modo preponderante al ceto medio-borghese
(45-51%), seguivano i commercianti e gli artigiani (29-36%), imprenditori e liberi professionisti
(7-15%), mentre in consistenza numerica molto bassa (3-6%) erano i figli di lavoratori manuali e
di agricoltori.
Ma una svolta che gli ebrei credevano mettesse fine alla loro condizione di emarginati, si ebbe
nella notte tra il 24-25/7/1943 con la caduta del governo di Mussolini.
Gli ebrei venuti a conoscenza del fatto in piena notte, festeggiarano con spumante l’accaduto, ma
ciò che avevano subito fino a quel momento era niente di fronte alle terribili prove che spettavano
loro. E.Artom nel suo diario il 28 luglio del 1943 scrive: «C’è lo stato d’assedio, ma si parla di
libertà. La situazione è incerta e confusa, ma è lecito sperare. Il governo di Badoglio è stato
salutato da tutti con entusiasmo, perché si credeva che il maresciallo avesse mandato via Mussolini
e fatto la pace. » 19
In effetti gli eventi non sono più favorevoli all’Asse; arrivano notizie dal fronte Russo che i
tedeschi stanno cedendo e questo fa affiorare nella popolazione una nuova luce, anche la stampa
incomincia a scrivere in termini di uguaglianza e di libertà sulla questione ebraica. Il 19 agosto a
Torino avvengono dopo molto tempo i primi scioperi, in modo totalmente spontaneo. La morsa
fascista sugli ebrei non si fa quasi più sentire; alcuni uomini israeliti importanti, ricevevano
informazioni confortanti e le diffondevano tra la gente, tant’è vero che viene di nuovo concesso di
pubblicare gli annunci funebri, tenere donne di servizio, frequentare tutte le stazioni di
villeggiatura, avere la radio. E. Artom il 3 settembre riporta: «Oggi sulla Gazzetta del Popolo era
pubblicato un articolo sugli antifascisti torinesi, fra cui molti ebrei»20 .
Era uscito sempre sulla Gazzetta del Popolo, il 10 agosto, un articolo del nuovo Direttore del
giornale, Tullio Giordani, in cui si ricominciava a parlare di libertà: «…. Nel concetto di libertà è
insita la libertà di coscienza e di culto. Per contro, di recente il fascismo, con le leggi così dette
razziali, a messo gli israeliti in condizione di inferiorità rispetto agli altri cittadini violando uno dei
concetti fondamentali della libertà, importante come la conquista dei diritti dell’uomo:
l’eguaglianza di tutti di fronte alla legge». 21
19
E.Artom: opera citata, pag. 55
E. Artom: opera citata, pag.63
21
E. Artom: opera citata, pag.67, nota 48
20
14
Anche i giornali dunque, con il cambio di redazione, dopo il 25 luglio, ricominciano a parlare
liberamente e il tono dell’articolo citato non dà certo a presagire quello che sarebbe successo da lì
a un mese.
Annota Chevallard il 4 agosto: «in treno (…) si commentano gli avvenimenti (…) La situazione
internazionale dell’Italia, gravida com’è di incognite, offre un campo infinito di discussioni: e tutti
in queste discussioni – in definitiva inconcludenti – ci si butta a corpo morto, ci si immerge
voluttuosamente. Questa di poter parlare liberamente senza tema di arresto od altro dopo vent’anni
di silenzio fa lo stesso effetto a tutti, come un bicchier di vino forte a chi è astemio: dà alla
testa». 22
Ma queste attese saranno ben presto e ben tragicamente deluse. I Tedeschi infatti sono già dietro le
frontiere e in alcuni casi, nella confusione delle parti, incominciano ad entrare in Italia, l’alleato da
difendere. «Intanto i tedeschi affluiscono in Italia: a Torino se ne cominciano a veder non pochi, e
tra essi molte truppe. (…) Secondo le voci che circolano, specialmente il Veneto, sarebbe pieno, a
tal punto che molti civili abbandonano quelle zone». 23
Carlo Chevallard, attento osservatore, vede e annota il cambiamento già il 16 agosto. Eppure
E.Artom il 3 settembre scrive: «Pare che la situazione ebraica continui a migliorare. (…) La polizia
si occuperà direttamente di ospitare profughi ebrei che verranno dalla Francia». 24
L’annotazione è del 3 settembre e precede dunque di 5 giorni l’inizio dell’esodo forzato degli ebrei
dalla Francia, ma l’Italia sembra essere ancora ignara di quel che succederà, dal momento che la
“polizia” si predispone ad “ospitare” gli ebrei. Sappiamo
bene che molti di questi ebrei
ripartiranno invece il 21 novembre 1943 per la Francia, prigionieri dei nazisti e di “competenza”
delle SS francesi, e saranno deportati prima a Drancy e poi ad Auschwitz.
Ma il clima, a distanza di una settimana dall’8 settembre, è ancora molto fiducioso. «Pian piano
gli ebrei ricompaiono: le mostruose e medioevali leggi razziali stanno cadendo nel dimenticatoio.
(…) “Calandrino” su “Tempo” scrive che gli ebrei in Inghilterra sono anzitutto inglesi come è
sempre stato in Italia. Se Dio vuole un po’ di buon senso torna a trionfare». 25
L’8 settembre, con l’annuncio dell’armistizio, dopo l’entusiasmo immediato, iniziano i timori. E’
ancora Chevallard, a spiegarci il clima di quelle ore: «mercoledì 8 verso le 19.30, rientrando da
Milano, arrivo a Santhià: clamori di folla, gente che si abbraccia, che urla, che ride. Il capostazione
percorre la banchina del treno gridando «Armistizio! Armistizio! Badoglio ha letto alla radio il
22
Chevallard, op. citata, pag.83
Chevallard, op. citata, pag.87
24
E.Artom, op.citata, pag. 70
25
Chevallard, op. citata, pag. 95 – (31/8/1943)
23
15
proclama: la guerra è finita! ». Nello scompartimento di prima siamo in quattro (……), ci
guardiamo: ma la gioia che la guerra sia finita è subito interrotta da un ansioso interrogativo: e la
Germania? ». 26
L’armistizio era stato firmato il 3 settembre e reso pubblico solo l’8: in quei giorni, per gli Italiani
del tutto ignari si stava preparando la tragedia degli ultimi due anni di guerra. Chi era al potere
aveva avuto il tempo di prepararsi la fuga e mettere in salvo la pelle (il Re, la famiglia, Badoglio, i
gerarchi avevano le automobili pronte per la partenza nel cortile del Quirinale) e per scrivere
quella ignominiosa pagina di storia per cui gli italiani (civili, soldati, ebrei) saranno abbandonati a
loro stessi, e per ovvia conseguenza, ai tedeschi, che già si erano infiltrati in Italia e che
arriveranno, ben organizzati e in forza per occupare il paese.
La tempistica dell’occupazione tedesca delle città del nord, ci dice che la Germania si preparava
fin da luglio ad invadere l’Italia. La rapidità con cui i tedeschi prendono possesso di città e paesi è
impressionante: tra il 9 e il 10 settembre l’esercito tedesco è nella pianura padana. Scrive E, Artom
il 10 settembre :«Una terribile giornata. I tedeschi sono entrati ieri sera a Torino e circolavano le
voci più folli». 27
E.Chevallard : «Venerdì 10 settembre: a Torino tutte le voci più disparate (…) i tedeschi hanno
occupato Genova, Savona, Ovada, Acqui, Alessandria. (…) Intanto tutti parlano dei tedeschi:
hanno occupato Milano, sono ad Asti, scendono dal Moncenisio, 600 automezzi sono attestati a
Chivasso. (…) Nel pomeriggio si intensifica il movimento di truppe: dal nostro ufficio, sito vicino
agli Alti Comandi, si ha un’impressione abbastanza esatta di quanto avviene. Alle 16 (…..) un
forte concentramento di carri armati e di autoblindo è in prossimità del comando: alle 17 (…..)
tutte le truppe sono partite. Alle 17,30 una piccola colonna tedesca – poche autoblinde e poche
automobili – arriva in corso G. Ferraris e prende possesso del palazzo del comando. (…) Così
avviene l’occupazione di Torino, come e perché abbiamo ceduto senza colpo ferire ad uno sparuto
gruppo di tedeschi questo è un mistero». 28
Era “l’Operazione Alarico" che gli alti comandi tedeschi avevano incominciato a predisporre fin
dal 27 luglio ’43, e che prevedeva la liberazione di Mussolini, la restaurazione del fascismo, la
neutralizzazione dell’esercito italiano e il controllo germanico dell’Italia.
Mentre il Re, Badoglio e gli alti comandi nulla avevano predisposto per una difesa organizzata, i
tedeschi avevano tenuto sotto controllo la situazione, tanto che entrare in Italia e prendere il
comando fu azione facilissima. L’esercito era “sbandato”, non esistevano più comandi, i soldati
26
Chevallard, op. citata, pag. 98
E.Artom, op.citata, pag.76
28
Chevallard, op. citata, pag. 99,100
27
16
venivano disarmati e presto internati in Germania, tutti fuggivano, chi poteva, con tutti i mezzi,
tornava a casa.
Mussolini fu liberato il 2 settembre 1943 e portato in Germania da dove annunciava, via radio, la
nascita di un governo fascista repubblicano nei territori italiani rimasti sotto il controllo tedesco.
Tale governo viene effettivamente formato il 27 settembre 1943, con il nome di Repubblica
Sociale Italiana.
Gli italiani si dividono. Tra le tante, difficili, scelte di quei mesi, ci sono coloro che scelgono la
strada dei tedeschi e ci saranno anche coloro che diventano SS.
L’autorità militare occupante è imperante e le scelte dipendono sovente direttamente da Hitler.
La germanizzazione dell’Italia (senza togliere nulla alle responsabilità degli Italiani che aderirono
alla Repubblica di Salò) fece precipitare in modo tragico la situazione degli ebrei.
Le leggi razziali in Italia avevano perseguitato vergognosamente gli ebrei, ma fino ad allora la
“soluzione finale” era rimasta estranea ai territori italiani.
Da quando l’Italia è occupata dai Tedeschi, gli stessi metodi fino ad allora applicati su tutti i
territori occupati, a partire dalla Polonia, all’Olanda, alla Francia, alla Cecoslovacchia,
all’Ungheria, all’Austria, vennero immediatamente applicati in Italia.
E allora iniziò la terribile caccia all’ebreo.
Le tappe di questa tragedia si consumano nel giro di pochi mesi.
La strage di Meina avviene tra il 22 e il 27 settembre 1943, ad opera di elementi della I Divisione
corazzata A. Hitler, alla quale apparteneva il battaglione che occupò Cuneo ed effettuò la strage di
Boves.
Scrive il 6 ottobre del ’43 Chevallard nel suo diario: «Sul Lago Maggiore, in special modo a
Meina, è cominciato il massacro sistematico degli ebrei (…) Famiglie intere sono state sterminate,
in gran parte con il sistema delle noyades . Portati in mezzo al lago su una barca e poi scaraventati
dentro. E dire che siamo in Italia e in pieno secolo XX: povera umanità, che deve assistere muta a
simili orrori» 29 . In tutta l’Italia occupata dai tedeschi si assiste a rastrellamenti di ebrei svolti in
comune dalle SS e dalle polizie speciali repubblichine.
La prima “azione speciale” decisa da Berlino è la razzia del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943:
1022 ebrei sono deportati ad Auschwitz e per la maggior parte uccisi nelle camere a gas al loro
arrivo.
Il numero più alto di razzie si conta tra ottobre e dicembre: a migliaia, stipati nei convogli
bestiame, dalle città italiane, partono per la Germania. Si parla già di campi di concentramento, ma
29
Chevallard, op. citata, pag. 130
17
nessuno in Italia sa che cosa vuol dire in effetti questa parola, si pensa al lavoro forzato, alla
prigionia.
18
19
Carlo Chevallard, 10 ottobre 1943: «La Gazzetta del Popolo di oggi riproduce un commento di un
giornale danese, in cui si dice che tutti i provvedimenti che colpiscono gli ebrei danesi (sembra che
vengano deportati in massa in Germania) sono opera delle autorità tedesche.
(…) la cosa è abbastanza credibile dato che anche in Italia la persecuzione continua: ad
Alessandria ed a Carrù (parlo solo di notizie certe) sono successi fatti analoghi a quelli del lago
Maggiore». 30
E ancora, il 22 ottobre 1943: «Un amico di mio suocero, ebreo, è stato internato nel campo di
concentramento di San Dalmazzo di Tenda: sono colà circa 450 ebrei. Sono già tra i fortunati se si
pensa a tutti i disgraziati che sono stati uccisi. ». 31
Esiste già nel linguaggio comune il termine “campo di concentramento”, ma come ben si capisce
dalle parole di Chevallard, ad esso non si attribuisce che il blando significato di prigionia. Il campo
di San Dalmazzo, era quello in cui erano rinchiusi i 320 ebrei di S.Martin, che, come abbiamo già
detto, saranno deportati con gli altri prigionieri il 21 novembre.
Il 14 novembre del 1943, con il Manifesto di Verona, la R.S.I. introduce le “sue” disposizioni sugli
ebrei: questi sono dichiarati stranieri e quindi appartenenti “a nazionalità nemica” e viene decretato
il loro concentramento in un “campo nazionale”. Questo campo sarà Fossoli, aperto il 5 dicembre,
su un campo per ex prigionieri di guerra alleati, in una zona strategica per avviare al Brennero i
prigionieri. 32
Il 1 dicembre 1943 vengono decretati nuovi provvedimenti contro gli ebrei. A tutti i capi delle
province, sotto forma di ordinanza politica, al fine della immediata esecuzione, viene trasmesso
l’ordine di internamento di tutti gli ebrei e la confisca di tutti i loro beni.
E’ decisamente la fine. Non rimane che la fuga, o il tentativo di nascondersi, con i gravissimi rischi
che corre chi aiuta gli ebrei. C’è chi, allo stremo delle forze, senza più mezzi di sostentamento,
braccato, si consegna alle autorità.
«Alcuni pochi si erano consegnati spontaneamente o perché ridotti alla disperazione dalla vita
randagia, o perché privi di mezzi o per non separarsi da un congiunto catturato, o anche,
assurdamente, per "mettersi in ordine con la legge"». 33
Scrive Emanuele Artom, ormai partigiano a Barge, il 1 dicembre del 1943 «vengo dalla signora
Segre: mi dice che il giornale radio dell’una aveva annunziato i provvedimenti antisemiti: tutti gli
30
Chevallard, op. citata, pag. 133
Chevallard, op. citata, pag. 141
32
Fossoli resta in funzione fino al 31 luglio 1944, quando per l’avanzata del fronte è smantellato e sostituito con quello di Bolzano (Gries), attuato
il 21 luglio sotto diretto controllo tedesco.(Da Fossoli passarono complessivamente 2445 ebrei)
33
Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, 1996, pag. 12
31
20
ebrei in campo di concentramento, i beni confiscati a favore dei sinistrati. Che cosa ne sarà della
mia famiglia? Forse non vedrò più né mio padre né mia madre. In questo caso chiederò al
comandante di essere mandato in una missione tale da essere ucciso». 34
Anche nelle pagine del diario di Chevallard, troviamo in data 3 dicembre 1943: «Ieri i giornali
hanno pubblicato un’ordinanza governativa che condanna tutti gli ebrei al campo di
concentramento e alla confisca immediata dei loro beni mobiliari e immobiliari. Anche questa
vergogna, quella di una medievale persecuzione contro una razza, non sarà risparmiata alla
tedeschizzata Italia repubblicana. Gli ebrei, poveretti sono tutti scomparsi: rintanati, nascosti,
vivono quasi alla macchia». 35
Si fa strada con sempre maggior chiarezza e drammaticità che il destino degli ebrei sono i campi di
concentramento in Germania, ed a questa parola incomincia a corrispondere un destino di morte.
Anche un osservatore esterno, perché non ebreo, come Chevallard, nella sua attenta percezione dei
fatti che succedono in quei mesi lega alla partenza per la Germania l’ipotesi ormai certa che gli
ebrei vengano “liquidati”: «Prosegue evidentissima la campagna anti-ebraica: in seguito ad un
decreto pubblicato qualche giorno fa tutti gli ebrei vengono arrestati e tradotti in campo di
concentramento (salvo essere “liquidati” in seguito) ed i loro beni confiscati.Di conseguenza è la
caccia all’ebreo che si sta organizzando, la caccia a queste disgraziate creature, creature di Dio
come noi che hanno il solo torto di vivere nel 1943 in terra tedesca (9 dicembre 1943) ». 36
Agli inizi del 1944 funzionari delle SS arrivano in Italia per trasferire tutti gli ebrei in Germania. Il
governo di Mussolini compie l’opera “transitoria” di rastrellare gli ebrei nel campo di Fossoli, che
è ancora sotto il controllo italiano, da cui, fino all’estate del 1944, gli ebrei sono trasportati in
Germania sotto il controllo nazista.
«Alle questure italiane fu assegnato il compito di rintracciare, arrestare e consegnare le loro vittime
al campo: questi sono i termini inequivocabili della collaborazione fornita dall’amministrazione
italiana alla messa in atto della soluzione finale, nei venti mesi della RSI: aver svolto quella parte
del lavoro che i tedeschi, per loro stessa ammissione, non erano in grado di eseguire». 37
Nel marzo del ’44, viene istituito un Ispettorato generale per la razza, al fine di coordinare la
persecuzione: nel giugno Giovanni Preziosi, capo di questo infame Ispettorato, otterrà dal duce gli
elenchi del censimento del 1938. A questo punto il cerchio si chiude: non sfuggirà più nessuno,
nemmeno gli ebrei di “origine mista” e la caccia all’ebreo potrà essere compiuta casa per casa, con
la certezza dei dati del censimento di sette anni prima.
34
E.Artom, op. citata, pag. 97
35
Chevallard, op. citata, pag.159
36
Chevallard, op. citata, pag.161
37
Liliana Picciatto Fargion, Per ignota destinazione. Gli ebrei sotto il nazismo, Mondadori, 1994, pag.172
21
Per tutti non restano che poche vie di scampo: nascondersi, tentare la strada della Svizzera o dal
fronte del sud. Ma soprattutto bisogna nascondere la propria identità con documenti falsi, che
certifichino l’appartenenza alla razza ariana. L’ebreo non deve più esistere.
27.000 ebrei costretti alla clandestinità si salvano per altrettanti grandi o semplici gesti di
solidarietà.
Circa 500 passano il fronte di guerra verso il sud liberato.
Circa 6.000 riescono a salvarsi attraverso l'unica frontiera praticabile, quella svizzera. 38
Ma rimane il numero, terribile, di coloro che invece non ce l'hanno fatta:
6.746 ebrei italiani deportati. 6.200 uccisi nei campi di sterminio nazisti. 39
38
39
Le cifre sono date da Renata Broggini, La frontiera della speranza, Mondadori, 1998, p.132,133.
C.D.Rom, Destinazione Auschwitz, Editore Proedi
22
Gli ebrei di Saint Martin Vésubie:
storia di deportazione e di solidarietà
23
St.Martin Vésubie è un villaggio delle Alpi Occidentali, situato sul versante francese, a circa 1000
metri di altitudine, quasi al confine con l'Italia, in prossimità del Colle delle Finestre.
In questo luogo alpino di villeggiatura, a partire dal novembre del 1942, arrivarono numerosi gruppi
familiari di ebrei che si sistemarono negli alberghi e nelle case in affitto, con un crescendo tra luglio
e settembre 1943, quando si calcola che gli ebrei potessero essere circa 700.
Questi ebrei non erano, per lo più, di nazionalità francese, ma erano arrivati in occidente fin dal
’38,’39 dall’Europa orientale, da quelle aree che venivano progressivamente annesse o occupate
dalla Germania nazista, ed erano stati i primi a capire il pericolo delle leggi antisemite naziste; si
erano rifugiati in Belgio, in Olanda, in Francia per cercare la salvezza (lo stesso fenomeno di
emigrazione si ebbe dalla Germania all’Italia, in seguito alle Leggi di Norimberga)
Ma gli avvenimenti tragici
40
degli anni seguenti resero ben presto queste terre, che gli ebrei
avevano pensato sicure, delle trappole senza salvezza: in Italia già fin dal ’38 con le leggi razziali e
in Olanda, Belgio e Francia nel ’40 con l’invasione tedesca.
La fuga, per questa gente braccata, proseguì nel sud della Francia, dove il governo collaborazionista
di Vichy sembrava dare qualche sicurezza in più dei territori occupati dai nazisti, anche se così non
fu e anzi, nel sud della Francia la caccia all’ebreo si fece serrata, anche da parte della popolazione
civile.
Si calcola che nel 1940, dopo l’armistizio della Francia con la Germania e l’Italia, un numero
elevato di ebrei si fosse riversato nel sud, fuggendo le zone occupate dai nazisti: si trasferirono
complessivamente 20.000 persone di cui 10.000 a Nizza.
Dal 1940 al 1942 l’occupazione italiana si limitò a una piccola striscia di territorio, profonda solo
da uno a cinque chilometri, situata al confine tra la Francia e l’Italia, ma l’armistizio prevedeva
40
Il 10 maggio 1940 si scatenò l’offensiva tedesca verso la Francia: l’attacco prevedeva di evitare la linea Maginot e
sorprenderla alle spalle; fu così che i Tedeschi riuscirono ad arrivare a Parigi il 14 giugno. Nel frattempo Mussolini,
credendo in una fine imminente della guerra, decise di attaccare la Francia per poter poi avere “un pugno di morti da
usare al tavolo delle trattative”, ma lungo il confine occidentale francese le nostre truppe subivano sensibili perdite
senza ottenere alcun successo data l’impervietà del sistema alpino e le sfavorevoli condizioni meteorologiche. Il tracollo
francese era, però, già in atto e il maresciallo francese Petain dovette sottoscrivere l’armistizio con la Germania (22
giugno) e con l’Italia (24 giugno); la Francia si trovava così divisa in 2 regioni: la parte settentrionale e l’intera costa
atlantica rimasero in mano ai Tedeschi, mentre la parte meridionale , con capitale Vichy, fu assegnata al governo
collaborazionista francese, guidato da Petain.
24
anche il ritiro delle truppe francesi da una zona di circa cinquanta chilometri (la cosiddetta “zona
libera”); in tal modo si posero le basi per la conquista dei territori di Vichy,che avvenne solo nel
novembre del 1942.
In questo periodo di tempo il governo collaborazionista francese adottò numerosi provvedimenti
riguardanti gli ebrei riversatisi in massa in queste zone alla ricerca di condizioni di vita migliori.
Queste speranze si avverarono in minima parte in quanto i francesi si dimostrarono pronti a seguire
una linea filonazista: “Le autorità francesi avevano istituito a Nizza, già nel 1941, un Commisariat
General aux Questions Juives con servizi annessi quali una Police des Questions Juives, una Section
d’Enquete et de Controle, incaricate rispettivamente di provvedere alla sorveglianza degli ebrei, al
censimento periodico ed al frequente sequestro dei loro beni”. 41 Queste disposizioni si andavano
41
Alberto Cavaglion, Nella notte straniera, L’arciere, 1991, p. 26
25
inasprendo sempre più e raggiunsero il loro culmine nell’estate del 1942, quando si applicarono
misure spietate contro gli ebrei di nazionalità straniera: si creò così un clima di terrore acuito anche
dall’atteggiamento della popolazione che, animata da un forte sentimento antisemita, appoggiava in
pieno la politica razziale del governo Petain aiutando le autorità a scovare quei pochi ebrei sfuggiti
alla morsa della legislazione francese.
Esistevano, però, anche organismi di soccorso che si occupavano del benessere degli ebrei e delle
loro condizioni di vita in questi territori: il più importante di questi era il Centre d’Accueil di
boulevard Dubouchage a Nizza, centro creato dai profughi stessi e diretto da Ignace Fink. Questo
centro d’accoglienza era di grande importanza per la vita degli ebrei nei territori di Vichy e si
adoperava a tal punto che “ben presto il Centre fu in grado di distribuire documenti di identità con
fotografia; copia di queste carte veniva mandata alla gendarmeria italiana che prendeva i titolari
sotto la tua protezione. Ciò bastava a render nulla ogni misura repressiva della polizia francese”. 42
Questa situazione terminò il 28 novembre del 1942 quando, attraverso il “piano Attila” in cui gli
italiani erano associati ai tedeschi, in un documento dello Stato Maggiore italiano si sanciva
l’occupazione di una consistente zona dei territori di Vichy: l’avanzata, iniziata l’11 novembre, fu
abbastanza rapida anche per l’inconsistenza dell’opposizione francese.
La linea di demarcazione dei territori occupati dai due paesi alleati fu denominata linea del Rodano;
questa linea arrivava fino a Vienne e si staccava dal fiume per raggiungere il confine svizzero a
quattro chilometri da Ginevra. “I tedeschi avevano concesso all’alleato italiano l’occupazione totale
di sette dipartimenti. Alpes Maritimes, Var, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Drome, Savie e HauteSavoie; il dipartimento dell’Isere e quello di Vaucluse erano quasi interamente tedeschi, mentre
quello di Ain lo fu solo in piccola parte”. 43
42
43
op. cit., p. 26
op. cit., p. 23
26
Ma perché intraprendere una campagna che solo due anni prima aveva prodotto una grande perdita
di uomini e di capitali in cambio di una misera striscia di territorio? I motivi di questa occupazione
sono legati allo sbarco delle truppe anglo-americane sulle coste dell’Africa del nord. “La
convinzione che ormai la guerra d’Africa fosse perduta e si preparassero attacchi diretti all’Europa
meridionale, e, più esplicitamente, che si preparassero sbarchi sulla Costa Azzurra medesima,
spinse Hitler ad attuare questo piano di occupazione”. 44 Inoltre era forte il desiderio, da parte dei
fascisti, di attuare quelle rivendicazioni territoriali rimaste soffocate dopo la limitatissima
occupazione del 1940.
A seguito dell’occupazione italiana le condizioni di vita degli ebrei cambiarono radicalmente, anche
se per un breve periodo di tempo (circa nove mesi). Gli italiani, infatti, adottarono una politica
tollerante e protettiva verso un popolo che subiva una violenta persecuzione praticamente in tutta
Europa (ad esclusione della Jugoslavia e della Grecia, anch’esse occupate dall’esercito italiano).
44
op. cit., p. 22
27
Nella pratica le autorità italiane autorizzavano il rilascio di carte d’identità e di permessi di
trasferimento da parte del Centre d’Accueil di Nizza. Ma sicuramente il provvedimento più
importante era quello dell’istituzione delle “residences forcées” (residenze forzate): i rifugiati
venivano dislocati nei vari dipartimenti occupati dalla IV armata dopo il novembre del 1942, e tra
queste residenze vi era anche St. Martin Vésubie. “‘Le autorità italiane’ ha scritto Poliakov
‘requisirono un certo numero di alberghi in quei luoghi e le organizzazioni ebraiche provvidero per
il loro mantenimento. Fu organizzata una vita sociale. Furono aperte scuole per i bambini’.” 45
L’interesse del Ministero degli Esteri italiano fu abbastanza elevato tanto che era richiesto un
continuo aggiornamento della situazione: proprio per questo fu ferma la risposta alla richiesta dei
francesi di trasferire gli ebrei di nazionalità straniera in zone di occupazione tedesca in vista di una
sicura deportazione. Un tale comportamento creò numerose e gravi questioni riguardanti gli ebrei,
per gli attriti nati con le autorità tedesche: esse non smisero mai di protestare per la politica razziale
adottata dagli italiani: essi, anche in territorio francese, spingevano per nuovi provvedimenti che
permettessero di identificare il maggior numero di ebrei e cercarono di modificare la situazione
della zona italiana senza alcun esito, per loro positivo.
“Lo stesso Ribbentrop, in una conversazione col Duce del febbraio del 1943, parlò di questi
argomenti senza ottenere alcun risultato. Anzi, circa tre mesi dopo quel colloquio il Ministero degli
Interni italiano mandò a Nizza un suo alto funzionario, Guido Lospinoso, a dirigere un ufficio
creato apposta per lui, il Bureau Royal de Police Raciale. In un primo momento i tedeschi cedettero
che Lospinoso si recasse sulla Costa Azzurra con l’incarico di impostare il problema secondo i
criteri tedeschi e della polizia di Vichy.In realtà la presenza del nuovo funzionario non portò nessun
sostanziale mutamento.” 46
Il comportamento degli italiani nei confronti degli ebrei è sicuramente condivisibile ma di difficile
comprensione in quanto l’Italia era alleata con i più grandi persecutori della popolazione ebraica e,
sin dal 1938, in tutto il paese erano in vigore le leggi razziali, simbolo di restrizione e di privazione
dei principali diritti dell’uomo. Forse i motivi di una linea di condotta così controversa non sono
chiari ancora tutt’oggi ma “tre sono i fattori che abitualmente si ricordano per dare una spiegazione
a questo comportamento:
1) la preoccupazione costante di dimostrare una certa indipendenza, una certa autonomia di
giudizio nei confronti della Germania;
2) la volontà di affermare la sovranità italiana nella regione occupata, in qualsiasi campo e in
qualsiasi circostanza;
45
46
op. cit., p. 26
op. cit., p. 28
28
3) l’attività svolta dal banchiere Angelo Donati presso le autorità civili e militari italiane” 47 ,
(attività di cui si parlerà più dettagliatamente in seguito).
A queste cause va aggiunta quella che è stata chiamata “latente germanofobia”, cioè una tendenza
“a mettere le mani avanti” in un possibile rovesciamento delle alleanze. Comunque queste sono
ipotesi, se pur attendibili, che non chiariscono completamente la un tale comportamento.
Un importante punto di svolta della vicenda si verifica il 25 luglio 1943, data della caduta del
fascismo: la notizia fu accolta positivamente dai soldati della IV armata, anche se al quartier
generale dell’esercito, situato a Mentone, vi era una grande incertezza per quel che riguardava il
futuro. Il più grande interrogativo riguardava la reazione tedesca alla caduta del Duce e ci si
preoccupava soprattutto per un eventuale spedizione di nuovi contingenti tedeschi di fronte ai quali
le truppe italiane avrebbero potuto ben poco.Per questo motivo tra la popolazione ebraica si diffuse
un più che giustificato panico per l’incerto avvenire.
“Il timore di un imminente passaggio sotto il controllo tedesco provoca il panico generale: a partire
da questo periodo i tentativi di passare clandestinamente in Italia si fanno più frequenti. Poco dopo
l’arresto di Mussolini il maresciallo Von Runstaedt chiede di effettuare una ispezione di controllo
nel Nizzardo. I tedeschi rivelano aperta diffidenza verso gli italiani e la crisi tra gli alleati non tarda
a esplodere. Le aspirazioni antisemite dei nazisti, a lungo frustrate durante i mesi dell’occupazione
trovarono, con la fine del governo mussoliniano, ampio spazio per la loro realizzazione”. 48 Si
aggravò così una realtà che era destinata a diventare ancora più pesante in vista dell’otto settembre e
della firma dell’armistizio tra l’Italia e gli alleati.
Il 9 settembre la Gestapo si stabilì a Nizza, che per i nazisti era diventata la sede del complotto
ebraico per rovesciare Mussolini. Nella città vi erano “16 mila ebrei; a questi andrebbero aggiunti
altri duemila che non furono mai schedati dalla Polizia francese. Altre centinaia e centinaia poi
confluirono verso Nizza, non appena furono informati. Provenienti dalle varie residenze coatte
finirono in quello che tra breve, sarebbe diventato il ‘lieu du crime’.” 49
Ovvia fu la brutalità dei tedeschi, il cui unico scopo era quello di catturare tutti nel minor tempo
possibile, e altrettanto ovvia fu la reazione della IV armata e di tutti gli ebrei occupanti le residenze
forzate, alla pronta invasione della zona di occupazione italiana da parte dei tedeschi: il panico
sopraggiunse e l’unica soluzione fu quella del tentativo di fuga, anche se qualcuno preferì il suicidio
per scampare alla deportazione. La fuga riuscì soprattutto a coloro che non si trovavano nei grandi
centri ma nelle residenze più defilate (St. Martin ne è un esempio); la stragrande maggioranza della
47
op. cit., p. 25
op. cit., p. 29
49
op. cit., p. 30
48
29
colonia ebraica di Nizza fu, infatti, deportata, prima a Drancy, località della periferia di Parigi, e poi
ad Auschwitz. Si concluse così quel periodo di relativa tranquillità vissuto in quelle che erano
diventate delle vere proprie oasi di pace per un popolo perseguitato e afflitto.
St. Martin Vésubie
St. Martin Vésubie era, “di tutte le località prescelte dagli italiani, la più ambita. Ben collegata a
Nizza si trovava al tempo stesso in una posizione defilata, ideale per chi voleva osservare da
lontano l’evolversi di una situazione politica e militare delicata”.50 Si pensa, infatti, che il numero
degli ebrei residente a St. Martin ammontasse a circa 700 persone, che, una volta assegnata la
residenza dovevano pensare a loro stessi e a stabilire un contatto con organizzazioni ebraiche di
soccorso. Visto l’alto numero di residenti si rese necessario nominare un responsabile che si
occupasse della gestione della residenza: tale funzionario era Jacques Weintraub, un belga che
coordinava la situazione da Nizza avvalendosi di collaboratori, formanti un Comitato, inviati sul
posto. Per quanto riguarda la vita nel domicilio coatto, sono molto significative le testimonianze di
due “abitanti” di St. Martin.
La prima testimonianza è dell’allora studentessa polacca Bronka Halpern, che descrisse così lo stile
di vita nella “residence forcée”:
A quell’epoca a St. Martin c’erano circa trecento famiglie di ebrei, che si erano bene
organizzate: avevano eletto un comitato che le rappresentava e ne era responsabile di
fronte alle autorità italiane; c’erano delle scuole per i bambini, e un movimento sionistico
diretto dai giovani. La vita scorreva piena, nonostante i tempi incerti, e, soprattutto grazie
ai giovani, la vita culturale era molto intensa. Naturalmente la gente della residenza non
aveva il diritto di lavorare, i ricchi vivevano con il denaro che erano riusciti a salvare
dalle mani dei tedeschi, mentre i poveri ricevevano aiuti dal Joint tramite il comitato. Si
poteva perfino ricevere visite di amici e parenti. Tutto sommato la gente non era infelice, e
sarebbe stato bello se quello stato di cose fosse durato fino alla fine della guerra; ma era
troppo bello per durare. 51
La seconda testimonianza appartiene ad Alan Feldmann, che ricorda l’atmosfera di quei momenti di
vita “normale”, in cui l’unico obbligo era quello di doversi presentare due volte al giorno alla
polizia italiana; egli dice:
Arrivai a St. Martin verso sera e vidi qualcosa che non ero più abituato a vedere da
tempo: degli ebrei che passeggiavano tranquillamente per le strade, sedevano nei caffè,
parlavano in francese, tedesco, alcuni persino in jiddish. Vidi anche alcuni carabinieri
50
op. cit., p. 38
Testimonianza di Bronka Halpern, 1967, op. cit., p. 41
51
30
che passeggiavano per le strette vie della cittadina con il loro caratteristico cappello
napoleonico, ed anche un gruppo di bersaglieri con le loro nere piume. Ogni cosa
sembrava svolgersi liberamente; non vi erano ordini particolari circa i rapporti tra i
rifugiati. La discussione fioriva nella più ampia libertà. Mia nonna che allora aveva 83
anni stava a poca distanza da noi. Un ospizio ebraico era stato preparato in un locale del
paese e mio padre l’aveva sistemata là. Era forte e in piena salute, ma addoloratissima.
Aveva avuto sette figli, tutti ormai sposati con famiglia (…).
Dalla nostra abitazione si poteva osservare una vista meravigliosa sulla Valle Vesubie.
Un mio cugino, Majne Rosembaum, con moglie e tre figli, stava vicino a noi. Con altra
gente viveva in una villa elegantissima, un po’ fuori dal paese. In questa villa c’era un
pianoforte: questa è una delle cose che mi sono rimaste più impresse, forse perché era da
tanto tempo che non sentivo più il suono di uno strumento musicale. 52
Sarebbe stato perfetto se questo stato di cose fosse durato fino alla fine della guerra, ma “era troppo
bello per durare”, come la Halpern aveva previsto. Quando, l’8 settembre, giunse la notizia
dell’armistizio, l’idea della fuga fu il primo e unico tentativo di salvezza a cui tutti pensarono anche
se scappare in Italia non era certo più sicuro che rimanere in Francia; un tale tentativo sembrava,
però, dal punto di vista morale, una difesa, una risposta al sopraggiungere dei tedeschi. Ma da dove
fuggire? Quale via intraprendere? “Tra le due vie di fuga, quella attraverso il mare ipotizzata da
Angelo Donati e quella attraverso i monti prospettata dal Comitato, si scelse la seconda che a tutti
sembrò più realistica. Degli italiani, sia pure con le dovute cautele, ci si poteva fidare perchè il loro
comportamento in quegli mesi era stato corretto, generoso, schietto.” 53 Inoltre si pensava che i
tedeschi avrebbero occupato solo la Francia, mentre il territorio italiano sarebbe andata in mano agli
americani cosicché le Alpi sarebbero diventate un fronte di guerra. Si creò, quindi, un esodo che
vedeva coinvolti soldati allo sbando, senza più ordini, ed ebrei nuovamente in cerca di salvezza e
pace.
La traversata
La traversata delle Alpi marittime fu un evento di grande importanza, tanto che i profughi stessi
definirono il gran numero di persone in fuga un vero e proprio “convoglio biblico”.
L’esodo si svolse principalmente attraverso due colli, quello delle Finestre e il Ciriegia: tramite essi,
dalla valle Vesubia, si poteva raggiungere la valle Gesso, anche se il tragitto era tutt’altro che
agevole. La prima tappa del viaggio consisteva nel raggiungere il santuario dedicato alla Madonna
52
53
Testimonianza Alfred Feldmann, 6 settembre 1976, op. cit., p. 42
op. cit., p. 51
31
delle Finestre, costruito nell’ 887 da un gruppo di benedettini; da qui vi era una mulattiera che
giungeva fino al valico, che si apriva tra due cime del colle. Dal valico la strada incominciava a
scendere ma rimaneva impervia e difficile da percorrere: attraverso il piano del Praiet si poteva
giungere a quello che per molti fu il punto d’arrivo, cioè S. Giacomo d’Entraque.
Non tutti i profughi seguirono questo percorso, ma optarono per una seconda strada: da St. Martin
essi si diressero a Le Boreon, piccolo paese quasi abbandonato, e poi, seguendo un ripido pendio
franoso, arrivarono al valico del colle Ciriegia. Anche loro camminarono in discesa lungo una
mulattiera, più ampia e delineata della precedente, che li condusse a Valdieri senza passare per
Entraque.
Come detto, la traversata presentò molte difficoltà, non tanto per i soldati della IV armata e per i più
giovani, ma per i bambini e per gli anziani. A dimostrazione di questo, è significativa la
testimonianza di Alan Feldmann, che racconta il viaggio suo e della sua famiglia. Egli racconta:
Inizialmente la strada era larga e saliva poco.Continuammo a marciare anche col buio.
Camminavano con noi anche dei soldati italiani. Alcuni sembravano essere da soli, senza
ufficiali e senza uniformi. Altri caricarono alcuni nostri bagagli sulle spalle o prendevano
in braccio i bambini.
‘Passi lunghi e piani ’ incominciavano a dirci.
Il giorno dopo alle otto iniziò la vera e propria salita. Lasciammo alle nostre spalle la
boscaglia, la strada divenne uno stretto sentiero sopra le rocce. Si poteva vedere, in alto e
in basso, altra gente che saliva. Nessuno sapeva fino a quando sarebbe durata questa
salita, né aveva importanza. Gli italiani avevano preso quella via e noi dovevamo stare
dietro a loro (…). Verso mezzogiorno mio padre ed io finalmente raggiungemmo il passo.
La via in discesa era naturalmente più veloce. Nel tardo pomeriggio raggiungemmo una
strada al fondo della valle che conduceva verso un centro abitato. Si trattava dell’ hotel di
villeggiatura delle Terme di Valdieri. Qui registrarono i nostri nomi sebbene chiaramente
non avessimo da pagare. Dormimmo in una elegante stanza (…). Eravamo preoccupati:
gli Americani che noi credevamo ormai padroni di tutta la penisola italiana, tardavano ad
apparire, anzi cominciavano a diffondersi delle voci riguardanti una possibile invasione
tedesca. Ripartimmo quasi subito chiedendoci cosa avrebbero fatto i Tedeschi vedendo in
uno stesso posto così tanti Ebrei. 54
Dopo aver descritto il tragitto percorso dagli ebrei e le difficoltà da loro incontrate, rimangono due i
punti, inerenti la fuga, da chiarire:
1) la cronologia della traversata, cioè quando iniziò e quando terminò il viaggio;
54
Testimonianza A. Feldmann, op. cit., p. 57
32
2) la definizione del numero esatto delle persone protagoniste dell’esodo.
Per quanto riguarda la cronologia, vi sono testimonianze di soldati italiani che affermano che il 9
settembre alcuni erano già giunti al di quà del confine italiano anche se altri affermano che già
l’otto i più giovani erano giunti ad Entraque o Valdieri. “Come si può vedere una cronologia
assoluta è del tutto impensabile. Si può tentare invece una cronologia ‘relativa’. I due estremi
potrebbero essere da un lato la notte fra l’8 e il 9 settembre e dall’altro il mezzogiorno del 13
settembre” 55 , giorno in cui arrivarono coloro che trovarono più difficoltà nella traversata e furono
costretti a passare due notti al freddo.
Per quanto concerne il numero dei fuggitivi si può fare un ragionamento analogo al precedente: non
si può stabilire un numero certo, ma se ai 700 ebrei residenti in St. Martin si aggiungono anche i
soldati della IV armata, si può pensare a circa 1200-1300 persone in fuga.
Entraque e Valdieri
Dopo il mezzogiorno del 13 settembre tutte queste persone si ritrovarono ad Entraque e Valdieri;
“per alcuni giorni si ricrearono condizioni di vita analoghe a quelle che si erano verificate nella
residenza francese. La popolazione locale, il clero ed anche le autorità locali si diedero da fare,
nonostante la caotica situazione di quei giorni”. 56 Per i fuggiaschi l’arrivo in queste zone fu una
nuova fonte di speranza, vista la bontà degli italiani, che fornirono del cibo agli ebrei e trovarono
loro una sistemazione per trascorrere le notti seguenti. Alcuni si sentivano fin troppo sicuri,
nonostante la situazione fosse inevitabilmente più confusa e incerta, come si nota nelle parole della
Halpern:
Io guardavo le mie compagne: si truccavano, si toglievano i vestiti per mettersi il pigiama,
come se fossero a casa loro, in casa loro in tempo di pace; e mi stupivo della loro fiducia
nel domani. Era ingenuità o incoscienza? 57
La maggior parte degli Ebrei, stanca per l’estenuante viaggio, si riposò in queste due località,
mentre solo una minoranza comprese la pericolosità del momento e si affrettò a ripartire per
raggiungere località a valle probabilmente più sicure.
E questo allontanamento fu provvidenziale: infatti il 18 settembre il capitano delle SS Muller dettò,
ad un segretario comunale di Borgo San Dalmazzo, il testo di un bando che doveva essere affisso il
più velocemente possibile su tutte le piazze della zona. Il testo è il seguente:
55
op. cit., p. 57
op. cit., p. 62
57
Testimonianza di Bronka Halpern, 1967, op. cit., p. 63
56
33
COMANDO GERMANICO di BORGO S. DALMAZZO
Entro le ore 18 di oggi tutti gli stranieri che si trovavano nel territorio
di Borgo S. Dalmazzo e dei comuni vicini devono presentarsi al
Comando Germanico in Borgo S. Dalmazzo, CASERMA DEGLI
ALPINI.
Trascorso tale termine gli stranieri che non si saranno presentati
verranno immediatamente fucilati.
La stessa pena toccherà a coloro nella cui abitazione detti stranieri
verranno trovati.
Borgo S. Dalmazzo, 18 settembre 1943
IL COMANDANTE GERMANICO DELLE SS
Capitano Muller 58
I Tedeschi con questo bando raggiunsero il loro scopo: la maggioranza dei profughi si arrese senza
opporre resistenza. Così commenta la Halpern :
I Tedeschi non si aspettavano che gli Ebrei si presentassero spontaneamente, e
mandarono due soldati a cercarli: uno a Valdieri e uno a Entraque. Si misero, revolver
alla mano, in mezzo alla piazza, e fermavano gli Ebrei. E gli Ebrei si lasciavano prendere,
senza che nessuno cercasse di salvarsi. Che cos’altro avrebbero potuto fare? Non
avevano alternativa: si avvicinava l’inverno, l’inverno delle montagne, con la neve e il
gelo. Dove sarebbero andati, con i vecchi e i bambini? Non conoscevano il paese e
dappertutto c’erano tedeschi. Questo logico ragionamento fu alla base del crollo del loro
coraggio, e di ogni volontà di lotta. 59
Borgo S. Dalmazzo e la deportazione
Scaduto l’ultimatum gli arrestati furono concentrati a Borgo S. Dalmazzo in una ex caserma di
alpini, sistemata al centro della cittadina a pochi metri dalla stazione ferroviaria, punto cruciale per
la deportazione di circa due mesi dopo.
Di Borgo era parroco un uomo che risultò essere uno dei principali aiutanti degli ebrei: quest’uomo
è Don Raimondo Viale (sulla cui vita si parlerà in seguito). Dopo il bando del Capitano Muller, Don
58
59
ABSD, Dossier ebrei, docc. 1 e 2
B. Halpern, op. cit., p. 68
34
Viale si attivò e “da quel momento l’impegno evangelico fece tutt’uno con la prassi quotidiana
verso chi cercava un rifugio nelle baite e soprattutto verso chi giaceva nei bui stanzoni del
Quartiere”. 60 Grazie all’aiuto di collaboratori da lui conosciuti e non, l’attività di assistenza si fece
molto intensa e fu possibile recare un relativo sollievo agli internati, prossimi ad affrontare un
viaggio verso la morte.
Nella caserma furono rinchiuse 350 persone, come risulta da un elenco stilato all’interno del campo
stesso, di varie nazionalità. La stragrande maggioranza delle persone erano “profughi di nazionalità
polacca (119 persone), francese (56 persone) e tedesca (42 persone). Numerosi anche gli ungheresi
(34 persone), gli austriaci (25 persone), i belgi (22 persone) e infine i rumeni (20 persone). Infine
non mancavano i russi (7 persone), i greci (6 persone), gli slovacchi (4 persone), i croati (ancora 4
persone), i lituani (3 persone), i turchi (2 persone). Completano l’elenco due persone identificate
come ‘palestinesi’, un olandese, un algerino, un bulgaro, uno svizzero.” 61 Questo numero subì
numerose variazioni in quanto si verificarono delle evasioni, parecchi furono i ricoveri in ospedale e
ci furono nuovi internamenti dovuti ai continui rastrellamenti effettuati nella zona.
Vi è una precisazione da fare: questo campo era un campo di concentramento o di transito e non di
sterminio (quello di Risiera di San Sabba ne era un esempio). Non vi fu nessun eliminato, non vi
erano camere a gas e all’interno dell’ex caserma non venne eseguita nessuna fucilazione.
“Gli ebrei di Borgo - come si è detto – furono deportati il 21 novembre 1943 prima a Nizza, poi a
Drancy e di qui ad Auschwitz. Non è difficile rintracciare nel dossier di Klarsferd il convoglio che
potrebbe averli deportati in Germania. Si tratta del n° 64, partito da Drancy il 7 dicembre 1943,
pochi giorni dopo che gli ebrei di Borgo erano giunti nel famigerato campo di raccolta francese. Il
convoglio numero 62, quello che direttamente precede il convoglio del 7 dicembre, partì il 20
novembre, un giorno prima della partenza dalla stazione di Borgo S. Dalmazzo. Il convoglio n° 63,
per una banale inversione, spiegato dallo stesso Klarsferd, parte da Drancy il 17 dicembre e
comprende ancora un piccolo numero di ebrei di Borgo, comunque di gran lunga inferiore al
precedente. Ancora qualche nominativo, infine è rintracciabile nell’elenco n° 66 partito da Drancy il
20 gennaio 1944”. 62
La deportazione dall’ex caserma alpina alla vicina stazione ferroviaria fu un episodio talmente
sconvolgente che, per chi ne fu testimone, è impossibile dimenticarlo. Sono molti coloro che
potrebbero raccontare i fatti di quel tragico giorno. “‘Il carico’ ricorda Enrico Boeris, allora
capostazione ‘fu effettuato dai Tedeschi. Il treno era trainato da una locomotiva elettrica del
60
op. cit., p. 73
op. cit., p. 73
62
op. cit., p. 83
61
35
deposito di Cuneo. I carri erano quattro o cinque al massimo’ 63 . I preparativi furono lunghi e il
treno, stando alla testimonianza di molti, poté partire soltanto verso le due del pomeriggio. Lo
stesso Boeris esclude che i tedeschi abbiano presentato alcun documento e, per quanto riguarda il
personale della stazione, precisa che gli ordini erano limitati all’accertamento della via libera”. 64
Gli aiuti e la solidarietà
Il problema più grande era quello di nascondere e prestare soccorso a tutti gli ebrei che sfuggirono
alla macchina di distruzione tedesca. I più attivi in questo senso furono degli uomini di chiesa, e in
particolar modo Don Viale e Don Francesco Repetto, segretario dell’allora Arcivescovo di Genova,
cardinale Pietro Boetto.
“Don Viale divenne il punto di riferimento attorno al quale ruotarono tutte le attività di soccorso. Il
parroco di Borgo cominciò a preparare elenchi di rifugiati, annotando con quella sua caratteristica
minuscola grafia ogni utile dato. Si tratta di fogli sparsi, gelosamente conservati da Don Viale:
carte, registri che divennero, con il passare del tempo, ora quaderni di contabilità, ora elenchi
riguardanti la dislocazione delle diverse famiglie. Spesso Don Viale utilizzava il retro dei volantini
delle ‘Giornate Religioso-Sociali per Uomini e Gioventù di Borgo S. Dalmazzo’ o di altre
organizzazioni religiose. Si tratta di una schedatura utilissima dal punto di vista operativo (Don
Viale riassumeva i dati che, volta a volta, gli fornivano i vari parroci di Bestiona, Demonte,
Valdieri, Vernante e di altre località)”. 65 Sulla base di questi elenchi, successivamente, il parroco
riuscì a preparare dei documenti falsi con le generalità del rifugiato e una foto formato tessera.
Durante questo periodo furono numerosi i contatti, sia diretti che per corrispondenza, di Don Viale
con Don Repetto: nelle loro corrispondenze si parlava con linguaggio cifrato, con cui il parroco di
Borgo chiedeva denaro per continuare ad assistere gli ebrei.
Don Repetto, in qualità di segretario dell’Arcivescovo di Genova, era spesso in contatto con
l’organizzazione ebraica della Delasem 66 , associazione che salvò migliaia di ebrei. Quando, con l’8
settembre 1943, la Delasem dovette chiudere l’attività e continuarla solo in forma clandestina, Don
Repetto continuò l’opera di soccorso permettendo a molti rifugiati di raggiungere la Svizzera: egli
stilò un elenco di coloro che richiesero aiuto alla curia e che furono, poi salvati. Gli ebrei venivano
smistati in case o Istituti e poi partivano per una di quelle che erano le possibili vie di salvezza:
raggiungere Roma, raggiungere il confine svizzero, rimanere “tumulati vivi” a Genova aspettando
la fine della guerra.
63
Testimonianza Enrico Boeris, 12 febbraio 1966, op. cit., p.85
op. cit., p.85
65
op. cit., p. 89
66
DELASEM: Delegazione Assistenza Emigranti Ebrei. La Delasem era un ente ebraico di assistenza ai profughi ebrei
stranieri che, dopo l'inizio della campagna persecutoria in Germania, erano affluiti in Italia.
64
36
Collaborarono all’opera di assistenza anche altre persone, come Guido De Angeli membro della
DELASEM che fece parecchi viaggi nel cuneese per portare i soccorsi dell’organizzazione. Inoltre
molte furono le iniziative della gente del posto, che organizzava espatri prima del novembre del
1943.
“Vittime della guerra erano sia gli ebrei sia la popolazione contadina che li ospitava, non vi è
dubbio. La solidarietà di cui stiamo discorrendo è di quelle, indimenticabili, che sorgono nelle
condizioni estreme di chi è costretto a subire gli avvenimenti. L’attesa, la speranza, l’improvvisa
delusione, un’imprevista e dolorosa separazione sono soltanto alcuni fra gli elementi da tenere in
considerazione (…). Non tutti s’adattarono a quello stato di cose. Non tutti erano disposti ad
attendere rimanendo inerti. Vi fu una piccola, sparuta rappresentanza di ebrei di St. Martin Vesubie
che militarono nelle fila del partigianato cuneese (…). La tragedia di quelle ultime settimane aveva
insegnato a non esitare più, a non rinviare oltre una decisione da tempo coltivata”. 67
Sono così intervenuti nella resistenza alcuni ebrei nascosti nelle valli, che si sono attivati per cercare
di abbreviare i tempi di una tortura che terminò definitivamente il 25 aprile 1945. Il 25 aprile,
giorno della Liberazione, “un momento unico anche per gli ebrei riusciti a sopravvivere a quei
lunghi mesi di attesa: la fine di un incubo”. 68
67
68
op. cit., p. 103
op. cit., p. 106
37
I PERSONAGGI
38
Angelo Donati
Nei quarantacinque giorni intercorsi tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943, si distinse la figura di un
uomo, ormai da alcuni anni dedito alla causa degli ebrei: Angelo Donati.
Egli è ricordato per quello d’importante che ha compiuto nel periodo 1942-43: l’aiuto “a favore dei
miseri, degli infelici, dei perseguitati, spesso anche di quanti si erano resi colpevoli di qualche
mancanza perché, privati della libertà, erano più in balia del bisogno, afferrati da leggi inesorabili
anche quando ingiuste; ed Egli li assisteva, li faceva difendere e, appena possibile, liberare;
procurava loro nuovo lavoro e nuova dignità, con una spontaneità, con un’immediatezza, con una
larghezza non comune di concezioni(…). Perché sentiva che più largo era l’abisso da colmare
affinché un infelice, un diseredato, un ammalato, uno sfortunato potessero riacquistare la loro
dignità umana”. 69
Angelo era nato a Modena il 3 febbraio del 1885 da una famiglia ebrea conosciuta nel luogo da oltre
quattro secoli. Suo padre era Salvadore Donati, uomo di grande fede e di grande cultura ebraica,
morto nel 1928 a 91 anni. Con il suo nome veniva indicato uno dei due Templi di Modena, perché
era frequentato giornalmente da lui e dai suoi figli e mantenuto a loro spese. Salvadore Donati era
conosciuto come una persona onesta e buona, e il figlio ereditò tutte le sue buone qualità. Angelo,
ottenuti il diploma di ragioniere e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Modena, si
iscrisse come avvocato al Foro milanese senza però esercitare la professione (nel 1939 si rese
dimissionario dall’Albo per non subire cancellazioni per motivi razziali). Fece pratica bancaria a
Milano per poi divenire agente di cambio alla Borsa di Torino.
Rispose alla chiamata di leva nel maggio del 1915, combatté valorosamente in prima linea e in
trincea come capitano di fanteria. Nel 1916 passò in aviazione e partecipò a missioni di guerra. Nel
1917 venne inviato in Francia come ufficiale di collegamento tra l’esercito italiano e l’esercito
francese e, dopo l’armistizio, fece parte della missione italiana per la conclusione del trattato di
pace. Nel 1919 prese stabile dimora a Parigi, dove si dedicò ad attività finanziarie e bancarie, ed era
talmente stimato dalle autorità francesi che gli fu conferita la Legion d’Onore. Angelo Donati
conservò, però, la cittadinanza italiana e mantenne ottimi rapporti con l’Italia, dove ritornava spesso
per trovare i suoi parenti e i suoi amici.
Fu sempre attivissimo nell’aiutare la comunità ebraica, essendo lui anche un sionista convinto: nel
1919 si occupò della Delegazione ebraica alla conferenza di Versailles, mentre un paio di anni dopo
aiutò i diplomatici israeliani in Francia ad inserirsi nella diplomazia francese, in genere restia ad
69
RAOUL ELI
39
accettare nuovi personaggi. Inoltre la sua casa di Parigi era frequentata da tutti coloro che avevano
problemi e richiedevano il suo aiuto per consigli, ricerca di lavoro, appoggio negli studi, soccorso
urgente. “Per tutti Angelo Donati trovava il tempo, la parola adatta, il consiglio appropriato, il
soccorso necessario e perfino – per sé e per gli amici – la giustificazione di una grossa o piccola
mancanza”. 70
La situazione cambiò radicalmente con l’avvento del nazismo e quindi l’aumento della
persecuzione ebraica. “Non più giovani senza carichi, ma famiglie intere cominciarono ad affluire
in Francia, non più gente in avanscoperta per cercare un posticino e poi chiamare i propri cari dalla
Polonia o dalla Romania, ma torme smarrite e disordinate, coloro che nella Germania nazista
avevano visto crollare non solo invidiabili posizioni di primato e di agiatezza, ma tutto un mondo
nel quale avevano creduto”.
71
Donati si distinse in questa situazione dimostrando un altruismo
immenso in un mondo sempre più alla ricerca del solo benessere personale, data la grande crisi del
1929 e la chiusura delle frontiere. Nell’inverno 1940-41 egli si trovava a Nizza dove ottenne dalla
Commissione italiana d’Armistizio di poter sottrarre alle misure della polizia di Vichy gli ebrei
rifugiati nel sud-est della Francia non occupata dai tedeschi, in cambio di un documento che
metteva gli ebrei stessi a disposizione della Commissione.
L’attività del Donati si intensificò ancor di più nel novembre del 1942, quando fu agevolato
dall’occupazione italiana del sud-est francese così che il numero di persone aiutate aumentò
notevolmente: particolare importante fu che Angelo Donati non volle nessuna pubblica attestazione
di gratitudine, dimostrando un carattere umile e modesto.
Ma la sua più grande azione fu quella compiuta tra il 25 luglio e l’8 settembre del 1943: durante la
snervante incertezza vissuta dagli ebrei, egli elaborò un piano per il trasferimento di tutti i rifugiati
nelle zone liberate dell’Africa settentrionale. Si trattava, però, di “un progetto utopistico, alla cui
realizzazione comunque si lavorò alacremente. Secondo il disegno di Donati il governo italiano
avrebbe dovuto fornire 85 autocarri, Donati stesso affittò quattro fondi del Joint Committée e fece
preparare cinquemila esemplari di uno speciale passaporto. Infine, il 23 agosto a Roma preparò
l’elenco delle località in cui dovevano essere trasferiti i profughi”. 72 L’attuazione fu fermata dalla
firma dell’armistizio dell’otto settembre e dall’arrivo dei tedeschi nella zona di occupazione italiana
in Francia.
Mentre i tedeschi continuavano la loro avanzata in Costa Azzurra per catturare il maggior numero
possibile di ebrei, egli fu costretto a riparare in Svizzera perché la polizia tedesca considerava il suo
arresto della massima importanza, “in quanto egli era la mente direttiva degli ebrei nella zona di
70
RAOUL ELI
RAOUL ELI
72
op. cit., p. 30
71
40
influenza italiana e manteneva apertamente i migliori rapporti con gli organi dell’ex Governo
italiano di Roma”. 73
Dal suo rifugio di Montreux, in Svizzera si prodigò per portare in salvo la sua famiglia, molto
numerosa, e per tenersi aggiornato sulla sorte degli ebrei da lui aiutati: i risultati, nonostante i suoi
numerosi viaggi a Berna, a Ginevra, a Zurigo e a Lugano per incontrare i rappresentanti dei governi
italiano, inglese e nord-americano, furono però scarsi non certo per colpe a lui attribuibili.
Sebbene cittadino italiano, poté rientrare a Parigi prima che finisse la guerra. Conclusa la parentesi
della guerra ritornò alla vita di ogni giorno aggiungendo alle altre attività quelle di Delegato per la
Francia della Croce Rossa italiana e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di San Marino
presso la Repubblica Francese.
Morì a Parigi il 30 dicembre 1960 in seguito a una lunga e penosa malattia, stoicamente sopportata,
curato da un medico che era un ebreo da lui aiutato e che grazie al suo soccorso aveva potuto
intraprendere la via della scienza.
Don Raimondo Viale
Don Raimondo Viale è uno dei personaggi più importanti nella vicenda di St. Martin Vésubie e, più
in generale, il più prodigo nell’aiutare tutti gli ebrei perseguitati. Don Viale era nato a Limone
Piemonte nel 1907 e portava il nome, Raimondo, del suo nonno paterno e del suo fratellino morto
nel 1901. Lui stesso descrive la sua famiglia: “Mio padre, Battista, del 1876; mia madre Marianna
del 1882. e tre figli: Margherita, la maestra, del 1902; io del 1907, e Anna del 1910. Margherita ha
conseguito il diploma di maestra, mamma l’ha fatta studiare, lavorando e facendoci lavorare.
Mamma era una donna meravigliosa, eccezionale come intelligenza e come carattere. Era anche
molto bella.” 74
Un primo periodo difficile della sua vita (ne seguiranno infatti altri) è quello del triennio 1915-18,
quando suo padre era in guerra e il cibo scarseggiava: era costretto a rubare il pane a sua madre
oppure ad elemosinarlo davanti alla caserma. Nel 1917 Raimondo, a 10 anni, entra nel seminario di
Cuneo, grazie all’aiuto di Don Riberi e appoggiato nella scelta dalla madre ma non dal padre, pur
essendo entrambi molto devoti. Di questi anni Don Viale ha sottolineato l’aiuto della madre nel
73
74
RAOUL ELI
Nuto Revelli, Il prete giusto, Einaudi, 1998, p. 3
41
continuare gli studi e, soprattutto, gli scontri con i professori che erano protagonisti di soprusi nei
suoi confronti (era disciplinato Don Viale, ma non sopportava le ingiustizie) che crearono problemi
per la sua vestizione, che alla fine ci fu grazie all’intervento di Don Riberi. Nel 1930 Raimondo
prese l’ordinazione e fu assegnato come vicecurato alla parrocchia di Borgo San Dalmazzo. Erano
gli anni del Concordato, dell’accordo fra Chiesa e Fascismo, che sembrava un grande avvenimento,
ma che poi si sarebbe rivelata un’arma a doppio taglio.
Durante gli anni da vicecurato, Don Viale si dedicò ai giovani e a tutte le attività culturali, ma i
fascisti non gradivano questa situazione e sequestravano documentazioni e bandiere della
parrocchia. Questo fece accrescere l’odio di Don Raimondo verso il regime; uno scontro che si fece
molto più duro dopo la promozione a parroco di Borgo S. Dalmazzo, di Don Viale, nel 1936.
Egli, uomo che non sopportava i soprusi, cercava di opporsi in tutti i modi alla propaganda fascista
e all’indottrinamento che i suoi giovani subivano. Lui manifestava il suo dissenso sul bollettino
parrocchiale: i fascisti imposero alla tipografia di Borgo di non stampare il bollettino e,
successivamente, furono ritirati gli altri tre numeri pubblicati grazie a un tipografo milanese. Ma il
fascismo non poteva tollerare un personaggio che era chiaramente “contro”.
Il 3 marzo 1939 tre fascisti cercarono il parroco nella casa canonica, ma non trovandolo infierirono
con i suoi due viceparroci. Non tardò il secondo tentativo.
Racconta Don Viale: “31 marzo. Nel tardo pomeriggio, verso le diciassette, stavo tornando da
Robilante, in bicicletta, sotto la pioggia. Con una mano reggevo il paracqua, e con l’altra tenevo il
manubrio. Ero già in Borgo, lungo la salita che dalla vecchia caserma porta al piazzale della
parrocchia quando vedo spuntare un macchina che mi muove contro. Mi sposto il più possibile sulla
destra. Mi dico: ‘quello lì non sa guidare o è matto’. Mi butto sulla sinistra, ma l’auto sterza e mi
investe. La bici finisce sotto le ruote della macchina fuori uso. Io mi scanso, cado lungo e disteso.
Mi piombano addosso in due, uno agita un bastone. Mi picchiano, tanto da ammazzarmi”. 75
Le ferite furono gravi, ma anziché demordere, il parroco continuò i suoi attacchi al regime fascista:
il culmine vi fu la domenica del 2 giugno del 1940, con l’ Italia ormai quasi in guerra. Don Viale
disse dal pulpito: “Se disgraziatamente dovesse scoppiare una guerra, non ripetete poi quelle
cretinaggini che addebitavano al Papa, ai vescovi, e al clero di allora la responsabilità della guerra
1915-18. Noi, se svolgiamo la nostra missione, dobbiamo condannare le guerre, tutte le guerre.
Eccetto che sia per difenderci da un nemico che ci aggredisce”. 76 Naturalmente le sue parole non
passarono inosservate: due fascisti avvertirono il questore e per Don Viale ci fu l’arresto immediato,
e la prigione, fino alla sentenza del 19 giugno 1940. “Il parroco venne condannato a anni quattro di
75
76
op. cit., p. 21
op. cit., p. 29
42
confino (poi la pena sarà ridotta a un anno e mezzo, per intervento personale del vescovo di
Cuneo)”. 77
Il 29 giugno ci fu la partenza per Agnone nel Molise, accompagnato da un graduato in borghese che
fu molto gentile e comprensivo con Don Viale. Il primo mese in Molise lo trascorse nella casa di un
prete, poi si trasferì nella stanza di un condominio. Durante questo periodo aveva instaurato buoni
rapporti con un gruppo di giovani, mentre diffidava di tutti i preti del paese. Per alcuni mesi visse
con lui anche sua sorella che gli fu di grande compagnia ed esercitò un controllo sul suo carattere
impulsivo. Alla fine di settembre del 1941 tornò a Borgo San Dalmazzo, dove ritrovò l’affetto dei
suoi familiari ma era guardato con sospetto dalle autorità locali.
Quando arrivò, prima il 25 luglio e poi l’8 settembre del ’43, l’impegno di Don Viale nell’aiutare
chi era ricercato e perseguitato fu veramente encomiabile. Egli si impegnò per portare sollievo a
tutti gli ebrei che arrivavano dalla valle Vésubie: riuscì a dare solo un sostegno morale ai circa
quattrocento rinchiusi dai tedeschi nella ex-caserma di Borgo, mentre diede un aiuto anche
materiale a “tutti gli altri, forse circa trecento, che avevano invece scelto di non arrendersi ai
tedeschi, ma di darsi alla macchia, e si erano dispersi qua e là, nelle valli che confluiscono su
Borgo”. 78
Don Viale preparò elenchi di rifugiati e ne sistemò molti presso famiglie amiche. Nella zona di
Roccavione non erano numerosi gli ebrei alla macchia, mentre erano molti di più nella bassa e
media Valle Stura. E sempre nell’ottica della solidarietà fu convocato a Torino, nell’ottobre, dal
Cardinal Fossati. Questa è la loro conversazione. “Mi dice: ‘Cerchiamo un prete che sia coraggioso,
che aiuti sti poveri ebrei’. E io a lui: ‘Ma di quale aiuto parla? Un aiuto morale? Siamo di religione
diversa, l’aiuto morale non basta. Occorre un aiuto materiale, concreto se vogliamo che
sopravvivano’. ‘Per il momento disponiamo di pochi mezzi, comunque le diamo già qualcosa. Poi
vedrà che l’aiuteremo. Lei però non li abbandoni sti poveri ebrei. E non solo quelli che sono lì,
vicino alla sua parrocchia, ma anche gli altri che sono dispersi nelle vallate dei dintorni. Sappiamo
che lei è stato al confino, e perseguitato anche dopo. Perciò lei non teme i pericoli’.” 79
Dopo l'incontro Don Viale si dedicò solo agli ebrei liberi, mentre per quanto riguarda quelli
catturati, aveva contatti e conversazioni solo con chi era ricoverato in ospedale, perché entrare nel
campo di Borgo era per lui alquanto pericoloso.
Ricordava Don Viale: “Era un grande impegno il mio, un lavoraccio da esaurire un elefante. Mi
spostavo quasi sempre con il buio, in bicicletta. Trascorrevo in parrocchia brevi periodi, qualche
ora, poi trovavo ospitalità presso le famiglie di Sant’Antonio d’Aradolo. Quante volte ho dormito a
77
Alberto Cavaglion, Nella notte straniera, L’arciere, 1991, p. 72
Nuto Revelli, Il prete giusto, Einaudi, 1998, p. 47
79
op. cit., p. 49
78
43
Tetto Peros, nella casa di una brave donna anziana che mi assisteva come un figlio. Mantenevo i
rapporti sia con i partigiani che con gli ebrei. Ero imprudente come uno scemo. Ogni tanto, di notte
con il coprifuoco, scendevo a Borgo, a trovare i miei due vicecurati. Rischiavo molto (…)”. 80
Con l’inizio del 1944 si intensificarono i rapporti con il Vescovado di Torino e con quello di
Genova: erano infatti urgenti altri aiuti finanziari per poter trasferire gli ebrei “alla macchia” in
Liguria e poi in Svizzera o al sud; gli aiuti non tardarono, divennero regolari e consistenti, e infatti
in una lettera Don Viale ringrazia Don Repetto, se pur con un linguaggio cifrato: “Ringrazio per
aver ricevuto per mano del reverendo Don Petroni i quattromila fogli di propaganda religiosa
richiesti”. 81
L’attività di Don Viale continuò imperterrita fino al dicembre del 1944, quando il prete fu costretto
ad andare a nascondersi a Torino: non stava bene di salute ed era pericoloso rimanere in quelle valli
dove era molto conosciuto ed era un personaggio scomodo per le autorità italiane e tedesche. A
Torino non trovò nessuno che lo accogliesse ma, grazie all’aiuto del Cardinal Fossati si sistemò a
Villarbasse.
Passare in rassegna la vita di Don Viale è stato un esperienza interessante e al contempo istruttiva.
Oltre ad aver conosciuto la vita di questo parroco prodigo di aiuti, c’è da prendere esempio dal
coraggio da lui mostrato in un contesto a lui estremamente ostile e difficile. E il riconoscimento a
questo suo tipo di vita egli lo ha avuto nel 1980 quando, quattro anni prima della sua morte, il 25
settembre del 1984, è diventato uno dei “Giusti” di Israele.
80
81
op. cit., p. 54
Alberto Cavaglion, Nella notte straniera, L’arciere, 1991, p. 95
44
45
Borgo S. Dalmazzo
Borgo S. Dalmazzo era una ex caserma di alpini, sistemata al centro della cittadina a pochi metri
dalla stazione ferroviaria, punto cruciale per la deportazione.
Nella caserma furono rinchiuse 350 persone, come risulta da un elenco stilato all’interno del campo
stesso, di varie nazionalità. La stragrande maggioranza delle persone erano profughi di nazionalità
polacca (119 persone), francese (56 persone) e tedesca (42 persone). Numerosi anche gli ungheresi
(34 persone), gli austriaci ( 25 persone), i belgi (22 persone) e infine i rumeni (20 persone). Infine
non mancavano i russi (7 persone), i greci (6 persone), gli slovacchi (4 persone), i croati (ancora 4
persone), i lituani (3 persone), i turchi (2 persone). Completano l’elenco due persone identificate
come palestinesi, un olandese, un algerino, un bulgaro, uno svizzero.Gli ebrei stranieri di Borgo
come si è detto furono deportati il 21 novembre 1943 prima a Nizza, poi a Drancy e qui ad
Auschwitz.
.
Stele a ricordo delle vittime del nazismo
Quello che rimane oggi di originale
della caserma di Borgo San Dalmazzo
46
Oggi la caserma di Borgo S. Dalmazzo è ben lontana dall’essere quello che è stata per gli ebrei di
transito, con destinazione i campi di sterminio. E’ un edificio che passa totalmente inosservato pur
mostrando una discreta mole; circonda una piazzetta adibita a parcheggio intitolata al prete giusto,
Don Viale, e a ricordare la sofferenza di quegli ebrei c’è un cippo con il quale si ricorda il sacrificio
degli ebrei, vittime del nazifascismo.
Oggi è un edificio da poco ristrutturato e adibito a ASL, completamente rivestito di vetri; ma prima
di questo intervento negli anni ’50 aveva funzione di scuola. Da questi nuovi lavori non traspare
nulla che possa ricondurre a quel periodo, se non un muro laterale che ha mantenuto una certa
originalità, grazie ai mattoni faccia vista e le spalle larghe che affondano nel terreno per aumentarne
la stabilità e che fornisce a chi guarda una sensazione di possanza.
Come aspiranti geometri non possiamo rimanere indifferenti alla conservazione di questo
manufatto; questo tipo di ristrutturazione sembra un’opera effettuata per modernizzare l’edificio
nascondendo l’aspetto storico e cancellarne la memoria, che invece va preservata.
Questo fenomeno è già molto forte in Austria, dove a Gusen hanno costruito le villette sul campo
delle vergogne, e la popolazione che ora ci abita, intervistata dalla TV italiana, non sa niente o fa
finta di non ricordare, compresi i più anziani, che hanno vissuto realmente quei fatti; molti dicono
che c’è un monumento che li ricorda, proprio come a Borgo. Le somiglianze sono preoccupanti; la
voglia di dimenticare è forte ma la memoria storica è necessaria, soprattutto per le generazioni
future.
La nostra tappa a Borgo S. Dalmazzo era dovuta alla speranza di trovare un museo dedicato a quelle
anime che hanno trovato pace nelle camere a gas di Auschwitz o al “prete giusto” Don Viale che
tanto aveva fatto per gli ebrei del luogo, ma le nostre speranze sono andate deluse.
47
DON FRANCESCO BRONDELLO
Don Francesco Brondello vive a Fontanelle, vicino a Boves, in una casetta con un piccolo giardino,
messagli a disposizione dalla Curia. A mezzogiorno e alle sette di sera, attraversa la strada per
andare a mangiare alla Casa di riposo del Clero, vicino al Santuario.
È andato in pensione, Don Francesco, dopo una vita dedicata alla sua missione. Ma anche da
"pensionato" continua ad aiutare i sacerdoti, nelle messe, nelle confessioni, al Santuario di
Fontanelle.
E la sua grande vitalità non lo fa certo stare fermo: "Io sono vecchi d'età, ma con la mente sono più
giovane di voi!".
Francesco Brondello è nato a Borgo San Dalmazzo nel 1920.
Nel 1943 è vice parroco a Valdieri, e le tragiche vicende di quegli anni lo vedono impegnato in
prima linea, come tanti altri sacerdoti delle valli, ad aiutare chi soffre.
È un impegno attivo, da "combattente", fatto di atti continui di resistenza all'oppressore nazifascista.
Il giovane di 23 anni ha messo la sua scelta cristiana di sacerdote al servizio di chi soffre, di tutti
quelli che hanno la "tessera della sofferenza". Dei partigiani,(con cui peraltro collabora
attivamente), dei soldati sbandati, degli ebrei.
Giovane, coraggioso, convinto delle sue scelte, aiutato da una dote naturale di "scalatore di
montagne" e di grande agilità, questo piccolo prete dai capelli rossi, riesce a scappare ai tedeschi in
mezzo alla Promenade des Anglais, a Nizza, e a tornare da solo, in una fuga rocambolesca
attraverso le sue montagne, a Valdieri.
Non sfugge però all'arresto dei fascisti, nel '44; imprigionato e interrogato a Cuneo, è riempito di
botte per gli aiuti agli ebrei e ai partigiani.
Il sui racconto scorre vivace e le sue vicende personali non sono mai ne' vittimistiche ne' eroiche:"E
allora picchiavano, sanguinavo dappertutto", è tutto quello che dice delle sevizie subite.
Non c'è mai, d'altro canto, il benché minimo senso di compiacimento per gli aiuti, a rischio della
vita, offerti a chi aveva bisogno. Anche nei ricordi lontani, i gesti di solidarietà rientrano nella
normalità della sua missione di uomo di Chiesa. E anche il pericolo continuo della morte è una
normalità: "Quest'anno tocca a me!", dopo che l'anno prima era stato ucciso dai Tedeschi il suo
amico e compagno, Don Mauro Ghibaudo.
48
Solo un momento di commozione. Nel ricordare i due ebrei salvati che nel giorno della liberazione
lo riconoscono e gli vengono incontro per ringraziarlo, Don Francesco ha pianto.
L'emozione è salita nel ricordo della vita e della salvezza.
Don Francesco Brondello, dopo la guerra, ha detto basta al mondo e si è rifugiato sulle montagne,
dove ha vissuto in alcune baite con una chiesetta, sopra Limone, per 35 anni. Ha vissuto nella
natura, dove ha trovato il contatto più vero con Dio: "Senza acqua corrente, senza luce, senza
servizi, neh! E senza telefono".
Abbiamo intervistato Don Francesco Brondello il 4 febbraio2001, nella sua casa di Fontanelle.
Per l'importanza degli avvenimenti ricordati e per la scorrevolezza della narrazione di Don
Francesco, abbiamo scelto di trascrivere integralmente l'intervista, da cui abbiamo omesso solo
brevi parentesi fuori dalla storia o accenni ad episodi insignificanti per il senso del discorso globale.
D.: Don Francesco, che cosa è successo a Valdieri, dopo l'8 settembre?
Era il 12, io dico il 12 settembre, però non bisogna prendere il 12 limitato a 24 ore, può essere l'11
come può essere il 13, perché erano avvenimenti… però si focalizza col 12, perché all’8 settembre
c’era stato lo sfascio della IV armata, la famosa IV armata, che era la più attrezzata e ben armata di
tutta l’Italia ed era quella che governava il sud-est della Francia, Nizza, Montecarlo, da quelle parte
lì, e avevano anche la zona di San Martin.
Noi l'abbiam saputo prima, noi, quei pochi che eravamo lì, perché i Reali avevano le ville a
sant’Anna di Valdieri, quindi venivano sempre in villeggiatura; quindi noi li conoscevamo, perché
la Regina andava sempre a pescare; poi c’era la questione della caccia dei camosci. E abbiam
capito, alla fine di agosto, qualcosa qui funsiuna nen, perché i Reali che erano lì con le principesse
ecc…le avevano pregate di andar via ed erano andate in Svizzera. C’erano i guardiacaccia, che
erano del posto: qui c’è qualcosa…
E di fatti poi è arrivato l’armistizio, l’8 settembre: ecco perché noi abbiamo capito prima che c’era
qualcosa che non funzionava.
E lì c’è stato proprio lo sfascio perché… son cose anche dolorose per noi, come dire, queste cose
qui; perché gli ufficiali, sono i primi che l’han saputo e se ne sono andati; e han detto niente ai
soldati.
La caserma aveva tutti i viveri, per sei mesi, per seicento militari per sei mesi, perché eravamo
d’autunno, preparazione all’inverno. Io parlo di Valdieri, perché in quei momenti lì noi non
sapevamo quello che capitava nelle altre parti […] c’era la caserma, c’era la guardia frontiera, poi
c’erano tutti gli avamposti Ser Bagarin, Marcantour, il Passo Ciriegia ecc… ecc… che davano sulla
49
Francia. E questi amici miei che erano tenenti , non han più saputo niente: ma come mai non ci
telefonano più, il telefono non funziona…
E allora, tipo Beppe Sannino, che era comandante dell’avamposto del Bagarin, è venuto giù (era il
giorno… forse l'11, credo); un altro amico che era tenente, il tenente Rosato, che era su con
Ballestrieri al Marcantour o colle Ciliegia, da quelle parti lì, non sentendo più niente, son venuti giù,
han trovato che gli ufficiali non c’erano più, la caserma svaligiata. Perché mica la lasciamo andare
in mano agli altri, allora tutta la gente è andata a prendere, e chi prendeva formaggi, e chi prendeva
le scatole.. carne in scatola e chi prendeva ecc… ecc… Allora sono arrivati giù e han trovato questo
sfascio.
È stato già un primo sfascio, perché quelli che erano italiani, piemontesi, lombardi, potevano andare
a casa; ma c’era per esempio il tenente Rosato che era abruzzese, non poteva andare a casa, vestito
da militare. Allora noi sacerdoti ad aiutare, a dare abiti borghesi: va dalla mamma, va da un altro:
allora è la popolazione che ha aiutato molto sia gli ebrei sia questo sfascio, questi giovanotti; perché
avevano magari figlioli in Russia, l’altra aveva il marito in Libia e allora per, come dire, come un
saluto al militare, davano a me i vestiti in borghese da portare a questi qui che potessero andare a
casa.
Era tutto uno sfascio. In quel momento lì è anche arrivato la questione degli ebrei […]
È difficile capire chi non l’ha vissuto, perché era proprio la Babele come c’è nella Bibbia, non si
capiva più, perché, partigiani non esistevano (e proprio lì si è incominciata a formare la formazione
partigiana). Per esempio il 12, dico sempre il 12 settembre, la prima formazione partigiana,(…) con
Livio Bianco, sono venuti a Valdieri, perché Livio Bianco aveva una villa vicino alla Canonica, io
avevo 23 anni, mi han chiamato anche loro, quindi con la prima formazione partigiana: cosa fare?
dove andare? Madonna del Colletto, dagli la chiave che loro si rifugino a Madonna del Colletto.(…)
Poi contemporaneamente, per esempio, ad Entraque, si formava un’altra banda partigiana, che erano
quelli di Entraque, che sono andati all’Osteirà, la banda dell’Osteirà, che non ha niente da vedere in
quel momento lì con la banda Giustizia e libertà di di Galimberti. Al Sabèn una montagna che è
prima, per Andonno e Valdieri, c’era un gruppo la cosiddetta banda del Sabèn che erano miei
compaesani di Borgo (io sono di Borgo San Dalmazzo).
Lì sono arrivati gli ebrei: capito che pasticcio che c’era? Non è che era sia cosa semplice!
E sono arrivati sti ebrei: erano circa novecento, da San Martin Vésubie. Loro lì, era una cosa bella,
perché gli ebrei che erano a San Martin Vésubie… e arrivavano chi dalla Polonia e chi è sempre
fuggito… si trovano bene a San Martin Vésubie, che è un paese di montagna, di villeggiatura, per i
francesi, come Limone per noi; loro stavano volentieri perché c’erano gli italiani che erano umani,
dei tedeschi avevano una paura matta, loro sapevano tutto quello che succedeva e quindi loro si
50
sono trovati li a San Martin Vésubie come, non diciamo in paradiso, ma in confronto a quello che
hanno visto in queste varie fughe, un posto tranquillo, un’isola di pace e tranquillità.
Quando c’è stato lo sfascio, che i nostri anche dalla Francia son venuti via, sono scappati, son
tornati, loro si son trovati nel pericolo di cadere sotto i tedeschi. È lì che han valicato le Alpi e…
scapuma mac, proprio scappare, valicare, andare con gli italiani non stare con i tedeschi, perché noi
eravamo più umani. Allora capite che con le Alpi, eravamo al12 di settembre, loro han dovuto
valicare…e non avevano mica l’attrezzatura, non erano mica preparati, scarponi quelle cose lì…,
poi d' autunno comincia a far freddo, poi erano giornate piovigginose; valicare il colle Ciriegia,
2500 metri, oppure il Marcantour, oppure il passo dei Ladri che era ancora più alto, oppure…,e
scappavano per venire da noi. Ma son piccoli sentieri di montagna, senza attrezzatura, con il freddo
e non sapevano neanche…, han girovagato,diciamo così, circa quattro giorni, dall’8 settembre al 12,
per arrivare qua ad Entraque o a Valdieri.
Io ricordo, è stata una scena. Avevamo già la preoccupazione di aiutare questi soldati nostri ad
andar via. Mi son ricordato anche di un altro episodio: c’eran quattro militari che avevano un mulo
e nient’altro. Non potevano andare a casa, perché erano del Trentino, e io li andavo ad aiutare: loro
non ne volevano sentire di partigiani, perché avevano già fatto tre, quattro anni di guerra: basta
guerra, basta guerra, non vogliamo parlare di guerra!… avevano un mulo, hanno ammazzato il mulo
e poi ogni tanto mangiavano un pezzettino di carne di mulo abbrustolita e io gli portavo su le
gallette, poi dopo son poi arrivati a casa ….
Quindi era una situazione dolorosissima e vedere ancora il paese invasato… proprio invasato da
questi ebrei, che cercavano rifugio, non avevano niente, ne' coperte, niente! anche da mangiare.
Una mamma per esempio, ricordo, cercava il bambino e non trovava più il bambino; perché sui
sentieri di montagna, chi cammina un po’ più in fretta, chi un po’ più tardi, il bambino arrivato lì
nel cuore della sera, era d’autunno, quindi anche già alle otto nove di sera era buio, coprifuoco. E io
ricordo che cercava sto bambino, poi dopo l’ha trovato.
Allora, noi in Canonica ne abbiamo messi dodici,(…) dalle suore che avevano ricovero, altri gruppi,
poi nelle varie case. I giovanotti che, fiutavano il pericolo, si son riposati un poco, han mangiato,
poi sono andati via per conto loro.
Ebrei, qui son rimasti dei vecchietti … e allora lì, piano piano, si facevano questi piccoli gruppi,
quattro o cinque, e io li portavo a Borgo, dove c’è Don Viale, voi ne avrete sentito parlare… Don
Viale poi li aiutava, perché una parte andavano verso la Svizzera: allora,Torino, Milano e poi
Svizzera, altri invece a Genova, per andare nel centro Italia: lì c’era anche il clero genovese che
collaborava.
E allora abbiam cercato di fare il nostro possibile […]
51
D.:Che cosa avete fatto per aiutarli?
.Abbiamo cercato di aiutarli, di dar da mangiare… quello che potevamo perché era tutto
razionato….era un problema, sottrarlo a noi per darlo a loro…ma lo facevamo volentieri…
C’erano anche gli ebrei che erano organizzati tra di loro. Per esempio, adesso racconto un
particolare: era mi pare, il 7 di ottobre, un signore da Firenze è venuto su e aveva delle buste con del
danaro e sapeva che io aiutavo, facevo quel che potevo là; mi aveva dato delle buste con del danaro
da consegnare. E (pensare) che io ho studiato la Bibbia; poi in quel momento lì non mi è più venuto
in mente che cos’era, e lui mi diceva: <mi raccomando dica a tutti che domani è il gion chippur ,
dica a tutti che domani è il gion chippur,< ma che cos’è?>,< niente, non si preoccupi!> .
C’era questo spirito di diffidenza, perché erano momenti pericolosi: lui veniva da me, però non mi
ha mai visto, gli han detto -si fidi- però, fidati,… fino a un certo punto! Allora io dico, va bene; ma
non mi ha detto ne' chi era: sapevo che era venuto da Firenze a portare del danaro per gli ebrei, poi
lui se n’è andato.
E io poi, di notte, a girare fra le baite dove c’erano questi gruppi di ebrei. E allora: <domani è il
gion chippur >. Cosa voleva dire? È il giorno della espiazione, il giorno della purificazione. E loro
contenti! Un prete cattolico che andava dagli ebrei a dire che domani è il giorno della purificazione,
il giorno del perdono, è il giorno…, e baciavano la mano e io poi davo la busta e davo anche delle
scatolette di carne e qualche galletta che avevo preso in caserma, si distribuivano.
E allora dico, guarda un po’, adesso a pensarci, un prete cattolico che va di baita in baita, nel cuore
della notte, perché bisognava stare attenti a portare queste cose, ed era bello!
E lì era venuto fuori un bando militare dei tedeschi: Muller ha fatto affiggere a tutte gli angoli dei
paesi, sia a Valdieri sia a Entraque, proprio questo: "Guai a chi non si presenta". Avevano già fatto
una puntatina e avevano trovato qualche ebreo e l’avevano caricato su questo camioncino, ma poca
roba, poi dopo li hanno obbligati, mi pare che fosse stato il giorno 17 o 18 settembre, perché il 19
c’è stato l’eccidio di Boves.
Il giorno prima è comparso quest’affare. Quindi bisogna mettere insieme: se non vi presentate, non
solo questi qui verranno uccisi ma anche quelli che li hanno ospitati.
Quindi immaginate che panico!
Ma il giorno prima è ancora arrivato l’eccidio di Boves, han bruciato Boves.
Quindi, questi qui fanno sul serio! Gli ebrei avevano paura, aveva paura la popolazione, sti ebrei
hanno detto, ma sì, son anni che fuggiamo, fuggiamo; mica possiamo stare qui in inverno, i bambini
ecc.. e allora si son consegnati anche loro liberamente, sono andati in caserma a Borgo .
D.: Quindi quasi tutti quelli che erano nel campo di Borgo, si sono consegnati?
52
Si sono consegnati perché c'era questo bando, e lì bisogna capire, avevano attraversato la montagna,
erano sfiniti di salute e avevano tanta paura, c'era questo bando che diceva "Guai se non vi
presentate", c'era stato l'eccidio di Boves il giorno prima, qui ci ammazzano tutti…e allora andiamo,
presentiamoci. E su 900, 300 e tanti si sono presentati.
D.: E gli altri che sono rimasti?
Noi gli andavamo a portare dei viveri, gli avevamo trovate noi le baite.
Erano baite di montagna, per esempio, non so, in certi posti erano, come dire, casolari dove i
montanari tenevano i strumenti di lavoro, badili, zappe, quelle cose lì, raccoglievano per esempio le
foglie secche. Poi c’era vicino magari qualche stanzino, qualche cosa, si rifugiavano lì; assistiti da
quelli che vivevano per esempio ad Esartetto e noi collaboravamo, aiutavamo, quello che potevamo
dare.
Per esempio una ragazza. Quando ci trovavamo, questa qui era penata, penata! Avrà avuto 17, 18
anni. E sempre incominciava il suo discorso così: "I nostri vecchi avevano ragione a dirci …i nostri
antenati là sul calvario hanno implorato che la maledizione di Dio scendesse su di loro e il sangue di
questo innocente…", come c’è nel Vangelo, e lei era presa da questa frase; e io
le facevo
coraggio:" Ma signorina, sono passati duemila anni, adesso non la prenda così.", cercavo di farle
coraggio e lei aveva sempre quel pensiero fisso.
" Hanno chiesto che il sangue di questo innocente scenda su di noi ed ecco che si realizza e noi è da
anni che fuggiamo ". Non so se era polacca o da dove veniva: fuggivano sempre. Era arrivata lì e
io a consolarla .(…) Dopo la guerra ho saputo che questa qui era andata in Palestina, però si è fatta
battezzare, poi è entrata in clausura è diventata suora di clausura […].
D.: Quante famiglie erano nascoste?
A Esartetto c'erano due o tre famiglie, ce n'erano anche a Borgo, poi noi ne avevamo verso
Madonna del Colletto.
A Boves hanno ucciso il vice curato, che era il mio compagno di scuola, Don Ghibaudo Mauro…, 82
compaesani, coetanei, compagni di scuola, di sacerdozio, poi di montagna, andavamo sempre in
montagna insieme.
Lui è venuto il 14, (l’hanno ucciso il 19) a trovarmi: dico sì, ma qui c’è un disastro, hai ragione,
cosa facciamo? Noi stiamo con questa gente qui: il nostro dovere è come il buon samaritano che
mica chiede la tessera. Difatti in prigione quando mi picchiavano sulla testa ecc... loro ce l’avevano
perché io avevo aiutato gli ebrei e i partigiani. Dico, ma scusate, tanto noi siamo super partes, se io
vedo uno che è ferito in terra non vado a chiedergli: sei ebreo, allora ti do un calcio. A me non
interessa che lui sai ebreo che sia ateo, che sia cattolico non mi ... mi interessa che in quel momento
82
Don Viale ricorda la tragica morte di Don Ghibaudo e Don Bernardi nel suo dialogo con Nuto Revelli. Vedi: Nuto
Revelli, Il prete giusto, Einaudi,1998, pp.46,47.
53
soffre, in quel momento io mi devo fermare lo devo aiutare. E quelli picchiavano: ma quello era un
ebreo, ma quello era...!
E allora con Don Ghibaudo c’eravamo messi d’accordo: dico, noi stiamo con questi, io avevo molte
cartine militari delle nostre montagne, con i sentieri, io gliele ho date, anche a lui. Dico, teniamo
queste cartine, perché lì non possiamo poi più camminare lungo le strade perché qui....hoilà!, e
allora teniamo i sentieri, così se abbiamo da incontrarci e aiutare questi giovani che scappano,
sappiamo dove...
Avevamo combinato: se ci scriviamo dei biglietti li scriviamo in piemontese, però con caratteri
greci, così quelli non capiscono niente.
Voi capite, avevamo 23 anni, dovevamo fare questi lavori qui perché era tutta gente che soffriva e
noi sacerdoti eravamo usciti dal seminario, bisognava stare con chi soffre, certo è Gesù che lo dice,
stiamo con chi soffre: però bisognava essere allerta perché, hói, eravamo ricercati, perché lì poi
sono venuti fuori i Tedeschi, le SS, ma c’erano poi le brigate nere che sono venute fuori, ma poi
c’era la Monte Rosa, ma poi c’era la Decima mas, non si capiva più niente; noi potevamo essere
presi un po’ dappertutto. E allora ci scriviamo in piemontese, però con i caratteri greci, gli altri se
prendono non capiranno niente almeno noi ci… poi dopo lo hanno ammazzato…
D.: C'è stato qualcuno che ha fatto la spia?
Noi lì no. Parlo degli ebrei, neh, perché è stata una cosa veloce, eccettuate quelle poche famiglie
che sono rimaste con noi, fino alla fine.
Mi pare che il libro di Cavaglion parli che qualcuno è scappato dalla caserma dei tedeschi. Non so
se lui lo sappia, ma sono io che li ho liberati. Io ero andato al cimitero, perché non si poteva, come
dire, sotterrare, dar funerale, niente sia ebrei sia altri, quand’uno era, come dire, morto bisognava
portarlo al cimitero, ma guai a toccarlo! Di fatti Don Ghibaudo, che era a Boves, l’han trafugato e
l’han portato a Borgo nella casa …allora io sono sceso da Valdieri, lì c’era suo cognato che allora
aveva una balilla, l’abbiam preso tutto insanguinato, con la veste insanguinata, avvolto in un telo
militare che nessuno se ne accorgesse, poi lui si è messo alla guida della balilla e io ce l’avevo così
questo cadavere; portarlo al cimitero di nascosto!
Poi io son stato lì e ho cercato di lavarlo un po', e lui è andato a prendere una cassa da morto, poi lo
abbiamo seppellito in una tomba che nessuno sapesse niente!
Gli abbiam poi fatto il funerale a settembre 2 anni dopo, il 19 settembre del ‘45. Quindi erano
momenti…
A Valdieri […], per esempio, in una casetta, una povera donna, mi ricordo sempre, una donnina,
aveva il marito in guerra, in Russia, chissà dove, e lì c’erano due militari che non potevano andare a
casa. Però loro non volevano entrare nelle bande; bisogna anche capire, dopo tante guerre, in
54
Grecia, di qui e di là ...noi non vogliamo entrare più con le bande… e facevano i servizi di
campagna a questa donna, tagliare la legna, fare il fieno..., e lei li ospitava volentieri perchè pensava
a suo marito e ai suoi figli che erano chissà dove.
Come sono arrivati i tedeschi, che io ho dovuto fare il giro del paese, con l’ufficiale che mi teneva il
fucile nella schiena,…guai se qualcuno avesse sparato, io ero il primo a essere liquidato…, come è
entrato in questa casa, ha visto sul tavolo tre piatti di polenta fumante, e questa donna sola; da lì ha
capito al volo: qui c’è qualcuno che è scappato. Ha guardato la casa, che non sono palazzi, ha
trovato niente, però ci son tre piatti con la polenta fumante qui c’era qualcuno che è scappato,
partigiano ecc...,allora cosa ha fatto? ha rispettato la donna, però ha dato fuoco alla casa.
Come io sono arrivato poi giù da Desartetto, ho detto, guardate che lassù c’è pericolo ci sono i
tedeschi a Valdieri.
Il tedesco, l’ufficiale, fa: "Pastore, là sul ponte ci sono due morti, ma mica li abbiamo uccisi noi,
voi, tra di voi, vi siete uccisi", e io sono andato sul ponte e ho chiesto la collaborazione di un certo
Giordano Vincenzo, con un carretto a mano li abbiamo messi uno sopra l’altro, portati al cimitero,
seppelliti così per modo di dire, ma non si poteva, erano cose che... ci facevano fuori noi!
E allora lì a Borgo, venivo dal cimitero, c’era il coprifuoco, c’era il temporale, ma io conoscevo
bene perchè sono di Borgo, e dovevo andare a Valdieri a piedi, son dieci chilometri, ma tutto per
vie traverse. E allora sono passato nei campi, ho attraversato la ferrovia, poi son passato vicino al
muro della caserma per venire in Borgo. E facevo questo tratto, come dire, con il fulmine: il fulmine
illuminava, guai se mi avessero visto, mi avrebbero sparato. Io aspettavo che il fulmine, come
scompare vien notte, buio, non si vede più niente, di sera tardi, saranno state le 8 o le 9, erano i
primi di novembre, forse la fine di ottobre…mi pare il 26 di ottobre… e mi nascondevo, come il
fulmine scompariva, c’era il tuono e il tuono impediva di sentire i miei passi e impediva di vedere la
persona…poi mi nascondevo dietro un muro, dietro un albero, aspettavo un altro lampo, quando
scompariva di nuovo...
Quando sono arrivato lì vicino alla caserma, mi son sentito prendere da dietro…, per fortuna che mi
han detto juif, siamo ebrei, perchè sentirsi prendere così, in quei momenti lì...se eran tedeschi!
Invece gli ho spiegato, 'Voi venite dietro di me', e loro capivano abbastanza bene l’italiano… allora
come io partivo loro di corsa dietro di me, poi mi nascondevo e loro nascosti lì e poi di nuovo…
Abbiamo attraversato Borgo, sono andato su verso Madonna di Monserrato… erano tre o quattro
uomini. E allora quando sono stato fuori di Borgo, ho detto voi andate sempre su, perchè io dovevo
andare a Valdieri, avevo ancora dieci chilometri da farmi attraverso i prati, attraverso i campi; voi
andate su, voi su troverete dei partigiani, son tutti miei amici, o Veglia o Bastiano ecc... qualsiasi
55
che trovate, presentatevi: "Noi siamo stati salvati da Don Francesco, siamo ebrei" e vedrete che loro
vi aiutano.
E allora loro sono andati su, lì ormai erano tranquilli perché erano fuori Borgo, non c’erano più ne'
brigate nere ne' tedeschi.
Quando è arrivato il 25 aprile (anche lì il 25 non è poi 24 ore, son parecchie ore, son parecchi
giorni, perchè in un posto il 25, in un altro posto il 26), il 28 c’era la festa della liberazione a Borgo.
I partigiani sfilavano, ormai Borgo (era stata) liberata il 28. Io ero a Castelletto in captivitatem e
sono andato a Borgo a vedere mia mamma, come stava. Perché finita la guerra io avevo la mia
bicicletta a Valdieri su un solaio, mia mamma a Borgo e io giù in captivitatem perchè mi cercavano,
per uccidermi.
E allora alla liberazione sono andato a Borgo, a vedere mia mamma. Ero lì in piazza; sfilano tutti
questi qui che io conoscevo, che erano scesi dal Saben ecc... e ho visto due signori distinti, che mi
guardavano e sorridevano, e io non capivo che erano quegli ebrei, perché era di notte, sì che io
ricordo la faccia! Loro mi son venuti incontro, mi hanno abbracciato, baciato, la gioia di questi qui,
voi non avete l'idea, erano gli ebrei che avevo salvato. Abbracciati, a piangere, insieme: "Non si
ricorda più di noi?", ma io cosa ricordo, sì, c’è tanti avvenimenti… "Noi siamo due di quelli che lei
ha liberato ecc...". Allora baci e abbracci e poi mi hanno accompagnato al tram che andava da
Borgo a Cuneo, poi andavo a piedi a Castelletto, e loro mi hanno accompagnato al tram poi con un
fazzoletto.... poi ci siam persi di vista e loro son tornati a casa.
D.: Ci racconta come è stato arrestato?
Allora…prima di tutto sono scappato dai Tedeschi.
D.: C'erano Tedeschi su a Valdieri?
Loro venivano da Borgo, venivano ogni tanto a fare delle puntate. Hanno bruciato la casa a quella
donna il 20 agosto del '44.
D.: Ma non sapevano che c'erano gli ebrei nascosti in montagna?
Lo sapevano, però… difatti uno l'hanno ammazzato davanti ad una cappellina, perché s'era trovato
lì a Valdieri in una loro…l'han trovato, ebreo, l'han fatto fuori subito davanti alla chiesa, con il
mitra, hanno sparato. Lui aveva i documenti in tasca, l'hanno ammazzato subito, subito.
D.: Torniamo al suo arresto.
Quando son venuti giù gli ebrei, scappando da San Martin Vésubie, avevano lasciato là le famiglie
che li avevano ospitati, poi avevano anche delle conoscenze ecc... e allora avevano, mi pare, che
fossero settantotto lettere scritte da ebrei, che io sono andato a portare a San Martin, ho fatto il
portalettere degli ebrei, per modo di dire.
56
Era novembre, c’era già tutta neve, valicare le Alpi in pieno inverno con quella neve lì non è che sia
facile. Comunque avevo queste lettere di ebrei.
Poi c’era una signora, allora signorina, che aveva lavorato in Francia, perché in montagna non c’era
lavoro, allora andavano in Francia a fare le cameriere, baby sitter e lei aveva in Francia, come dire, i
suoi interessi, perché con la guerra poi era scappata era venuta in qua, però là stavano cambiando le
monete e lei perdeva tutto quei pochi soldi che aveva guadagnato lavorando. Io le dico, guardi io
devo andare in là a portare tutte queste lettere.
C'era (anche) uno slavo che erano anni che non vedeva più la mamma; saputo che la mamma era
andata a fare la cameriera ad una nobildonna inglese e questa qui era venuta a San Martin Vésubie,
lui voleva rivedere la mamma.
Allora io gli dico, guarda ti porto a San Martin Vésubie, devo portare queste lettere, c’è questa
donna, poi devo parlare con il tenente Rosato che non potendo andare a casa...dovevo trovarlo…
Dico, combiniamo e siam partiti.
Era metà novembre, valicare le Alpi a metà novembre, con la neve [...] Lì ero in borghese,perché
avevo messo la veste nello zaino, per poter camminare nella neve…
Andiamo giù, trovo Rosato che sale(…) ci dice: " I tedeschi mi inseguono, perché han saputo che io
ero lì nella casa della mia fidanzata, e son venuti a prendermi; allora io ho dovuto scappare stanotte"
e risaliva. Allora se è così, mica possiamo andare coi tedeschi che inseguono lui e noi gli andiamo
in bocca.
Allora ci siamo nascosti nel bosco aspettando che arrivasse notte [...] e il giorno dopo lo slavo e il
tenente Rosato sono rientrati in Italia perché c’era pericolo, e io con la signora sono andato giù a
distribuire le lettere. E li è andata bene la mattinata, ho celebrato la messa dal parroco poi …ho
trovato una donna di Borgo, ho dato notizie.
D.: A S. Martin Vésubie c'erano i Tedeschi?
Caspita! Adesso vi racconto. Quando siam venuti giù,abbiamo attraversato una zona che si chiama
Les Trois.Monts: uno scoppio, un'eco! Proprio di una bomba sparata e un'eco… Ma cosa succede,
ma perché? E andiamo giù e c'erano già due Tedeschi, tutti ben armati, che salivano sul sentiero per
andare a vedere che cosa era capitato. Questa donna mi fa:" Curà, i Tedesch!", le dico, faccia finta
di niente.
Io ero vestito in borghese, 23 anni, appena valicato il confine, in alta montagna, dopo uno scoppio!
Io dico sempre che il buon Dio c'è e assiste e aiuta! Quelli, così, sul sentiero, si son fermati; io dico
"Bonjours!" e loro:"Bonjours!", m'han guardato e non m'han detto niente. Io sono andato giù.
Quando sono arrivato giù, che c'erano dei cespugli, ho subito fatto la metamorfosi: ho preso dallo
57
zaino la talare, mi son vestito con la talare, ho messo le scarpe basse, e poi ho messo lo zaino nella
borsa 'diplomatica' e sono arrivato a S. Martin vestito da prete…
E poi (nel pomeriggio) ho preso la corriera per andare a Nizza a trovare gli altri.
E anche lì, è stato il buon Dio, che poi aiuta!
Monto in corriera, si vede che quel colpo lassù ecc... ecc...e poi quello non era uno slavo(lo sono
poi venuto a sapere dopo la guerra), era sì uno slavo, ma era una spia, e segnalava che arrivava
qualcuno di pericoloso; e io che sono andato da sua mamma a portare sue notizie e lì c’era questa
signora inglese...
E allora, quando sono salito in corriera, sono arrivati due in borghese, Gestapo, e subito a me:
"Carte" e io non avevo mica il passaporto, perché ero valicato lì. Allora mi han preso, in fondo alla
corriera, che non c’erano uscite (...)
La corriera è partita, alle tre, e a San Martin Duvar, è salito un ufficiale tedesco, ben armato, loro mi
han consegnato a sto ufficiale tedesco.
È arrivato a Nizza alle sei di sera, c’era il coprifuoco, era notte e io ho detto, qui devo scappare,
perché erano momenti che... e allora, come fare? Ho guardato indietro e ho visto che c'erano dei
cespugli, (io non ero mai stato a Nizza, non conoscevo Nizza!). Ringrazio il buon Dio perché io
avevo molta elasticità, anche a camminare in montagna, alle volte alle sei del mattino ero già sulla
punta del Monviso!(…)
E ho detto, qui questo tedesco ha gli stivali, è armato, io scappo, salto i cespugli e faccio perdere le
mie tracce. Questo qui ha capito allora s'è messo un metro dietro di me, a guardarmi. E allora io
vedevo- ero nella strada centrale di Nizza- i tram; io dico, siccome rallentano, salto lì di corsa,
mentre viaggia, e quando arriva un po' più in là, scendo dall'altra parte e vado in un'altra direzione.
Ma in quel momento arrivano quei due che mi avevano incontrato a S. Martin Vésubie, mi han
detto di seguirli, mi han fatto fare sotto i portici…
E allora io dico, qui bisogna scappare!
Quando lui mi dice: "montez!", per me è finito, perché come dice "montez", io vado a finire in
caserma: Come ha detto "montez", io sono scappato, sparavano di qua e di la ma io son scappato.
Le signore di Nizza, che erano lì a far la passeggiata, erano le sei di sera, le sei e mezza, a vedere un
prete in sottana, sotto i portici, un po' sotto un po' fuori,perché io avevo calcolato, se sparano!
Poi ho trovato una chiesa, l'ho poi saputo dopo, St.François dePaul; sono entrato in chiesa (…) e
chiedo collaborazione al parroco. E difatti lì c'erano i frati; e c'era un frate campanaro e io
dico:"Guardi, sono inseguito dai Tedeschi! Mi apra il solaio" Lui, subito, mi ha fatto andar su, sono
andato su di corsa sul solaio.
58
Lì ho avuto paura; prima non ho mai avuto paura, perché se uno avesse paura in quei momenti, ne'
fugge e non ha forza di correre!
E allora son rimasto lì, mi son nascosto bene: quando è arrivato il frate,(…) avevo paura, ma
quando ho visto che aveva un abito borghese, allora mi son fatto vivo.(…)
Poi ho parlato con uno e gli ho detto:"Senti, fammi una cortesia, cercami una bicicletta e io ritorno
in bicicletta a prendermi gli scarponi … a S. Martin Vésubie . "E lui mi ha detto: "Io ti
accompagno.";" Mi fa piacere, tu parli francese!" E allora siam partiti in bicicletta, la Promenade
des Anglais, la prima volta che l'ho fatta (ero) in bicicletta, e c'era tutta la colonna di Tedeschi…
Arriviamo su al Belvedere (…) e io sono andato in casa canonica da un prete. E lui mi ha detto:
"Stai attento perché l'altro giorno i contrabbandieri hanno sparato ai Tedeschi, e i Tedeschi si sono
presi anche dei cani poliziotto particolari."
E io al mattino son partito di lì, era metà novembre, terreno ghiacciato; c'era la luna, da un lato mi
faceva piacere perché io non avevo mai fatta la Gordolasca di lì per andare a Valdieri, però c'era la
luna e mi permetteva, sul terreno ghiacciato di vedere un po'. Ma d'altra parte dico, qui segnalo la
mia presenza; ma poi è andato bene, sono arrivato su al rifugio. Credevo di rifugiarmi lì, prendere
un po' di fiato, era tutto sfasciato, freddo, tutti i rigagnoli ghiacciati, la neve… e allora per non
lasciarmi prendere dalla morsa del gelo, io mangiavo un po' di colazione… e intanto 'ballavo' su e
giù, su e giù, per non (gelare).
E poi dopo ho fatto il colle del Clapier, 2800 metri, tutto ghiacciato, però.. si vedeva bene Nizza, era
una giornata stupenda! Però la parte opposta, siccome prende il sole del levante, era ghiaccio vivo;
senza ramponi, senza piccozza; però ho visto che anche giù in fondo anche il nevaio era ricoperto
da neve fresca, non c'erano pietre…ho fatto tre passi e poi ho fatto un volo di 200, 300 metri, nel
canalino, fino in fondo.
Ero così felice che mi venivano le lacrime dalla commozione.(…)
E sono arrivato a Valdieri… e quando dicevo :"Sono scappato ai Tedeschi", mi dicevano "Ca ne
cunta nen tante!"
D.:E quand'è che l'hanno arrestata?
Io avevo sposato uno delle Brigate nere con una ragazza della Cantoria, e quindi mi conoscevano,
quindi questa ragazza sapeva tutto. Parlando con suo marito, han parlato di tutto e sapevano che io
avevo aiutato gli ebrei, aiutavo i partigiani, ero scappato ai Tedeschi, e allora un bel giorno…
19 settembre del '44, l'anno dopo che hanno ucciso Don Ghibaudo, io ho detto, quest'anno tocca a
me.
Quando ho sentito: ci sono i Tedeschi in Valdieri, io ho detto, adesso tocca a me!
59
Allora sono andato in chiesa, ho pregato, poi c'era un prete lì e gli ho detto:" Può darsi che stasera io
sia già fuori dal mondo: facciamo una bella confessione".(…)
È arrivato questo Ferraris, che io avevo sposato, mi conosceva bene, delle brigate nere e mi dice:
"Lei è Don Francesco?" e io dico sì, allora usciamo e lui mi fa: "Vada a prendere il cappello perché
deve venire con noi". Allora io sono andato in canonica, avrei potuto scappare liberamente(…) però
ho detto no, stavolta non scappo, stavolta voglio vedere come va a finire.
Allora poi siamo andati giù alla trattoria Cacciatori, a Valdieri, perché c’era la camionetta. Poi mi
han portato al comando, dal comandante Bellinetti, comandante delle Brigate nere, che mi ha fatto il
primo interrogatorio. Poi c'erano i due fratelli Ferraris.
Allora lui mi faceva delle domande! Per esempio: "Perché voi obbedite a Papa Pio XII?" Io dico:
"In fin dei conti è il mio superiore"; allora gli ho detto: "É Gesù che lo dice: <tu sei Pietro e su
questa pietra io edificherò…>" e lui mi ha interrotto e mi ha detto: "Voialtri preti avreste il diritto di
vivere soltanto se invece di insegnare a servir la messa ai ragazzini metteste nelle loro mani dei
fucili e insegnaste a sparare, sparare, sparare".(…)
Poi è arrivata la camionetta (…) e arrivati a Cuneo, altro interrogatorio.
Uno ha preso una piccola bomba a mano, la 'balilla', e me l'ha messa in bocca… e l’altro alla
scrivania mi diceva: "Come ti chiami?" e io non potevo rispondere; e allora l’altro con lo staffile
picchiava nella schiena: "Rispondi!". Come facevo, con la bomba a mano? Allora l’altro con la
pistola puntata: "Rispondi altrimenti ti sparo!"(...)
Il giorno dopo, altro interrogatorio: lì allora picchiavano sul serio! Sanguinavo…per fortuna che in
Seminario mi dicevano che avevo la testa dura!! Se non avessi la testa dura, saria bele mort!
Nel mentre loro picchiavano, sanguinavo dappertutto: due ore!
E proprio per quel motivo lì,(…) volevano sapere degli ebrei e partigiani e io rispondevo: "A me
non interessa, che uno sia ebreo o partigiano, quando uno ha la tessera della sofferenza, io
sacerdote, mi devo fermare, costi quel che costi, io mi devo fermare. Poi che sia ebreo, che sia
partigiano, che sia di un banda che sia di un'altra banda, a me non interessa, io devo aiutarlo perché
è mio fratello".
E allora lì picchiavano ancor di più .
E allora…come sono uscito di lì? Devo dire grazie ad una signorina …Il Vescovo ha fatto di
tutto,niente da fare; il Prefetto di allora ha fatto di tutto, niente da fare; il Prefetto ha anche scritto al
General D'Agosti, niente da fare;(…) e allora, c'era un mio compagno di scuola, che è andato da
questa signorina. Perché sua sorella era stata prelevata dai partigiani; e allora lui è andato e ha detto:
"Ma senta, io ho liberato sua sorella, ho un amico carissimo in prigione, non può dire …". E tutte le
60
sere lei andava trovare il comandante generale Ronza, delle Brigate nere, tutte le sere, a tenergli un
po' di compagnia, diciamo così.
Lei va giù e dice: "Senti, lassù c'è un prete, così, così…; bisognerebbe liberarlo". E Ronza, subito ha
preso il telefono, e ha telefonato su:"C'è un prete che si chiama Brondello Francesco? Fuori!! Ho
detto fuori!!".
E loro, terrorizzati, Bellinetti, i Ferraris , mi han messo fuori, però mi hanno obbligato a stare in
seminario, e tutte le mattine andavo a presentarmi, tutte le sere andavo a presentarmi…E ad un certo
momento, il Vescovo mi dice, abbiam bisogno anche di te.
E allora lì c'era il comandante dell'ufficio politico: io sono andato, ma guardi che il Vescovo…come
mai io non posso più ritornare a Valdieri? E lui,: "A Valdieri c'è Madonna del Colletto, là ci sono i
partigiani e per non indurti in tentazione, tu a Valdieri non ci vai più, ti mandino dove vogliono."
E allora mi hanno mandato a Castelletto Stura. E i Bellinetti, i Ferraris, vai pure, ma non finisce qui,
il conto lo salderemo, ti ritroveremo.
E infatti, mica li ho visti a Castelletto Stura ad ammazzare due padri di famiglia, intenti a pescare?
Io ero nascosto, ma li ho riconosciuti.
Quando, finito la guerra c'è stato il processo, io sono andato, son voluto andare, ma non per loro,
per difendere queste due mamme, il papà ucciso, una aveva mio pare tre figli; l'altra aveva una
bambina. E io dico, vado a difendere queste due mamme, perché se gli riconoscono che sono
vedove per motivi di guerra ricevono un compenso, e i bambini vengono riconosciuti orfani di
guerra.
E poi sono andato a Roma (al processo) e io ho detto tutto (…) a me non interessa quello che han
fatto a me in carcere, io li ho perdonati, li perdono (…), prego solo non fate più quello che avete
fatto…non ammazzate più, che sia finita.
Comunque queste due donne le hanno poi riconosciute vedove di guerra e i bambini hanno avuto
(tutto)
D.: Ha conosciuto Don Viale?
Oh! Lo portavo sempre in montagna, perché lui non era alpinista per conto suo (…), poi io son di
Borgo, lui è venuto a Borgo vice-curato …lo conoscevo molto bene.
…Le campane suonano mezzogiorno, e Don Francesco ci deve lasciare perché lo aspettano per il
pranzo.
61
Lo abbiamo ascoltato per un'ora e mezza, seguendolo sulle sue montagne e nella sua fresca capacità
di ricostruire le vicende tragiche della sua giovinezza, con solo qualche attimo di commozione e
sempre nella certezza della sua fede.
62
Chiesa di
Valdieri
Le sorelle Giordana
Don Francesco Brondello
63
LE SORELLE GIORDANA
Le sorelle Anna e Marianna Giordana abitano ad Andonno, nella vecchia casa che fu dei genitori e
dei nonni.
Andonno è un piccolo e grazioso paesino, in cui il tempo sembra essersi fermato, appoggiato sul
fianco della montagna, sulla strada tra Borgo San Dalmazzo e Valdieri. Circondato da montagne, in
una bella e ampia valle, Andonno, a 756 mt. di altezza, vive ancora oggi di economia semplice, fatta
di raccolta dei prodotti che offre la natura e della sapiente conservazione per l'inverno dei frutti
della propria terra.
Questo luogo fu travolto, come tanti altri piccoli paesi vicini, dalla storia tragica degli anni tra il
'43e il '45. Dopo l'armistizio, con l'arrivo dei Tedeschi a Cuneo e con la formazione delle bande
partigiane, molto attive e numerose in queste zone, violentissime furono le rappresaglie dei Nazisti,
con paesi bruciati, fucilazioni e nefandezze di ogni sorta.
Ma, come abbiamo visto, con l'arrivo degli ebrei di S. Martin Vésubie e dei soldati "sbandati" della
IV armata in fuga dalla Francia, la situazione si complicò e il pericolo crebbe.
Le sorelle Giordana erano, nel settembre del '43, poco più che bambine, due ragazzine di 10 e 12
anni.
Queste due donne portano nel cuore, ancora oggi, le vicende di quei mesi, vicende che hanno reso
tutta la famiglia Giordana protagonista, forse inconsapevole, di uno straordinario atto di "resistenza"
contro l'"ordine" nazista.
La paura di quegli anni, il terrore dei nazisti così vicini e così feroci, "sono cose che non si
dimenticano".
In mezzo a quel delirio di violenze si concretizza uno degli esempi più alti di bontà e di solidarietà
umana, una di quelle pagine che ci fanno dire che l'umanità non era morta.
La famiglia Giordana salvò un'intera famiglia di ebrei (7 persone), senza chiedere nulla, senza
sapere chi fosse questa gente che non parlava la loro lingua, senza nemmeno osare chiedere da dove
arrivassero. Erano uomini e donne senza niente, braccati, spaventati, affamati: e i Giordana non
ebbero nemmeno un attimo di esitazione. Si tolsero il pane di bocca, corsero grossissimi rischi
(c'era la pena di morte per chi nascondeva gli ebrei), con il solo pensiero di salvare vite umane.
"Se morivano loro, allora morivamo anche noi insieme a loro"
La famiglia Giordana, con cui vivevano anche gli anziani nonni, partecipò tutta unita a questo
salvataggio, che fu vissuto come un dovere, forse come una missione.
64
Il padre di Anna e Marianna è la figura forte di questa famiglia: montanaro,con un piccolo
commercio ambulante a Cuneo, uomo semplice, "aveva fatto solo la terza", ma di grandissimi valori
e di alta umanità.Uomo intelligente e con grande autonomia di giudizio, aveva capito l'iniquità delle
leggi razziali del '38 e insegnava alle figlie che gli ebrei erano come gli altri e che era
profondamente ingiusto e sbagliato discriminarli.
Tutta la storia delle sorelle Giordana ruota intorno alla figura di questo padre,nato nel 1893, che
aveva trasmesso valori morali altissimi ai figli, di grande bontà e integrità
Tutta la famiglia , senza un attimo di esitazione, si impegna con tutte le proprie energie e povere
risorse ad aiutare a sopravvivere e infine a salvarsi, quei sette ebrei simbolo di un'umanità braccata
e vittime di un'ingiustizia insopportabile per chi era cresciuto in un'educazione semplice ma
fortissima di valori umani.
E' il padre che nella metà di marzo del '44, con i nazisti alle porte del paese, riesce convincere un
ferroviere a fermare il treno a Roccavione e alle due di notte parte con il carretto coperto di paglia,
sotto cui si nasconde la famiglia ebrea e riesce, con un atto di grandissimo coraggio, a far
raggiungere il treno a questi sette ebrei braccati che partiranno per il sud, saltando i controlli
tedeschi di Borgo, e mettendo in salvo le proprie vite con destinazione Roma.
Mentre tutti i Giordana a casa pregano, si compie l'ultimo altissimo atto di eroismo silenzioso, fatto
di gesti semplici ma che ancora oggi Anna e Marianna raccontano come se fosse l'unica e
naturalissima cosa che tutti insieme potevano fare.
Dopo 40 anni, nel 1984, il Sig. Albert Sharon, dalla Palestina, viene ad Andonno a trovare le sorelle
Giordana.
Anna e Marianna sono rimaste sole: è morto il padre, la madre si è spenta dopo 14 anni di malattia.
La loro vita è continuata in questi 40 anni, tra le "tribolazioni"della gente di montagna, senza sapere
più nulla di quella famiglia a cui loro avevano dato tutto.
Immaginiamo l'emozione di quell'incontro: ne rimane una fotografia che loro mostrano, insieme ai
loro ricordi, come una reliquia. Quei signore dai capelli bianchi era lui, il giovane figlio della
famiglia ebrea, a cui loro non avevano mai chiesto nemmeno da quale paese provenivano.
E nemmeno oggi lo sanno.
Non era bello chiedere: bisognava solo aiutare quella povera gente.
L'incontro con le sorelle Giordana è stato per noi molto emozionante.
Non è facile trovarle, perché ancora oggi non hanno il telefono e continuano a vivere con gli stessi
ritmi che hanno insegnato loro, i nonni e i genitori. I ritmi della montagna, della pulizia del bosco,
della raccolta delle castagne e dei funghi, della legna da tagliare per la "cucina economica" che è
l'unica risorsa di riscaldamento della casa
65
Le abbiamo fatte avvertire del nostro arrivo dal Sindaco di Valdieri e loro ci aspettavano.
La loro accoglienza è stata calorosa come i loro cuori. E hanno incominciato a parlare, parlare..
Subito sono arrivati sul tavolo della cucina i "ricordi", portati dalla sorella maggiore.Una scatolina
con il libro su cui è trascritta l'intervista fatta negli anni '80 da Caracciolo per la T.V. La lettera del
Sig Sharon da Gerusalemme, che ringrazia e manda le foto del loro incontro.
La lettera del Console di Toronto che invia al Sindaco di Valdieri la copia dell'articolo di giornale in
cui i Signori Sharon raccontano la loro storia e ringraziano la famiglia Giordano. Le fotografie di un
giornalista che è venuto dalla Danimarca per intervistarle .Un piccolo pacchettino contiene un
ricordo importante: una medaglia di Israele incorniciata in legno d'ulivo.
Sono piccole grandi cose mostrate come fossero sacri ricordi. Queste sono le ricchezze delle signore
Giordana, che altrimenti non hanno mai voluto niente per quello che hanno fatto.
Raccontano che quando sono venuti quelli della televisione ad intervistarle, hanno voluto
consegnare una busta con il denaro. Loro non volevano, ma quelli insistevano che era nel contratto.
E allora, senza nemmeno aprirla, hanno portato tutto al parroco: non si paga con il denaro un
grandissimo atto di generosità, che loro hanno nel sangue, e che chiaramente non ha prezzo
materiale ma solo morale.
Abbiamo intervistato le signore Giordana il 4 febbraio 2001 nella loro casa di Andonno: abbiamo
chiesto loro semplicemente di raccontarci la loro storia, e il racconto di quei mesi tra il settembre
del '43 e il marzo del '44, è venuto fuori in un fiume di parole e di emozione.
Trascriviamo la parte saliente della loro testimonianza, differenziando gli interventi di Marianna (la
sorella maggiore, nata nel 1931) da quelli di Anna (nata nel 1933), anche se sovente le loro voci si
confondono in un incalzare di ricordi.
Le sorelle Giordana hanno preferito parlare in piemontese e quindi la nostra trascrizione è una
traduzione , il più fedele possibile nell'espressione del linguaggio parlato, in italiano.
A.: Io dico la verità, quello che hanno tribolato quella gente lì, io preferisco che mi ammazzino, ma
non vedere più quelle cose lì. Io dico la verità, noialtri abbiamo risicato tutti la vita, neh, ma non ha
fatto niente, ma non vedere quella gente lì… piuttosto morivamo tutti insieme, non ce ne faceva
niente.
M.: A noialtri, papà, ci ha sempre insegnato, anche agli ebrei, di volergli bene, perché è anche gente
che ci è passata prima di noi quella gente lì. Papà leggeva, leggeva tanto, quando andava in chiesa
capiva il latino, capiva tutto e diceva sempre così… quella gente lì, bisogna volergli bene più che a
noialtri.
66
Noi non sapevamo chi erano, quando li abbiamo visti e gli abbiamo portato la prima volta da
mangiare, noialtri non sapevamo chi era quella gente lì, non sapevamo chi era; abbiamo visto quella
bambina …
Quell'anno là pioveva sempre: guardi, noialtri quando li abbiamo trovati erano in una baita, c'era
tutta terra marcia là dentro, perché il padrone che aveva quella baita lì era morto nel '40, non c'era
più, e la baita andava giù in malora.
Quando siamo venute a casa lo abbiamo detto a mio papà; mio papà è andato a chiedere al vicino
qui, gli ha detto, fammi il piacere dammi le chiavi del ciabot , ma non andare lassù, lascia stare, tu
fai conto che non ci sia nessuno lassù, io ti pago,io ti do qualcosa, basta solo che tu lasci chi c'è
lassù.
Ma io non so come faceva quella gente, avesse visto com'erano, erano stravolti, sa quando uno è più
morto che vivo, erano così, ma avevano ancora coraggio.
Allora papà è andato, lui gli ha dato la chiave, gli abbiamo portato la paglia lassù al ciabot vicino,
un po' più in qua, gli abbiamo fatto un po' di pagliericcio, hanno dormito un po'. Erano in sette. Il
papà era il capo dei Rabbini.(…)
Erano in sette: c'erano papà e mamma , dopo c'era Albert, questo della foto, poi c'era Jean che era
sposato, e dopo c'erano due sorelle.(…)
D.: Ma da dove arrivavano?
A.:Non gli abbiamo chiesto, credo che anche papà non abbia mai chiesto,perché noi lo abbiamo
fatto proprio così…
M.: Andare a chiedere sembrava poi troppo…
A.: Io anche quando è venuto a trovarci non gli ho chiesto né l'indirizzo né niente, lui lo sa il nostro
indirizzo, ma io non gli ho chiesto per non mettermi lì a… capisce com'è?
M.: Papà diceva, proviamo ad aiutarli, portiamogli da mangiare. Mia mamma ci diceva così: oggi
mangiate due patate in più, così avanziamo il pane e lo portate lassù.
A.: Quando sono partiti… papà è andato dal capostazione a Roccavione, gli ha detto, fa la carità,
trova una scusa che il treno si è rotto, che c'è qualche guasto; io ti porto giù questa gente qui,
caricali sul treno e che sia finita.
M.: Perché c'era il posto di blocco…lì più in giù…li ammazzavano tutti.
A.: Allora papà è partito alle due di notte, con queste sette persone, ha preso il biroch, l'ha coperto
di fieno, ed è andato giù…
M.:Sotto il coprifuoco,neh!
A.: A Roccavione il treno è arrivato e s'è fermato, e loro sono saliti sopra, il treno è partito e loro
sono venuti a casa.
67
D.: Dove sono andati?
A.: A Roma, e si sono salvati tutti e sette. Perché Susanna 83 , l'interprete, aveva 18 anni e parlava
sette lingue,neh! E mio papà e mia mamma facevano gli ambulanti e conoscevano gente a Cuneo
per bene e allora hanno preso questa Susanna e l'hanno portata a Cuneo e gli hanno fatto i
documenti falsi per andare a Roma. Gli hanno scritto sopra che era gente di qui.
E lei che era interprete, parlava sette lingue, ha potuto parlare con i Tedeschi, con tutti, è andata a
finire a Roma. A Roma gli hanno fatto gli altri documenti falsi.
Mia mamma con un ago gli ha cucito i soldi, tutto, e poi con i documenti sono partiti di qui.
D.: Ma come è incominciata la storia?
M: Era il mese di settembre, e noi siamo andate ai funghi su da lì, ne trovavamo sempre tanti… e
abbiamo visto questa bambina là al sole così, avesse visto, bianca come una cosa… proprio gli
mancava tutto, capisce? Allora io ho detto a mia sorella, perché io avevo due anni in più, guarda,
passiamo di qui, questa bambina qui ha bisogno di noialtri, non vedi in che stato è? E allora siamo
passati da lì, ma la prima volta non le abbiamo parlato, abbiamo solo guardato. Era una bambina
così… aveva un anno meno di mia sorella, ma a forza di fame, era piccola, a forza di non mangiare,
era piccola.
Allora io ho detto a mia sorella, questa gente qui ha bisogno di qualcosa, non andiamo più ai funghi.
E quel giorno lì non siamo più andate ai funghi, siamo venute giù. Abbiamo parlato a mia nonna,
perché la casa non era nostra, era dei miei nonni. E allora noi gli abbiamo parlato insieme per
rispetto…e loro hanno detto sì, sì.
Mio papà è andato a mungere le mucche perché tanto d'altro non avevamo, ma un coso di latte
andava bene. Era come fosse adesso, le due e mezza o le tre (del pomeriggio), e allora siamo andati
a mungere, abbiamo preso il latte e glielo abbiamo portato su.
Mia mamma ci ha dato il pane, quel po' di töma che avevamo, ci ha dato quello che aveva.
E allora siamo partite e siamo andati a portaglielo lassù. Quando ci hanno viste, sono stati lì, si sono
quasi nascosti: e allora noi abbiamo detto: "Non ci avete viste prima?". Noi avevamo paura che non
ci fosse nessuno che ci capisse, e allora Susanna, l'interprete, dice:"Sì, vi abbiamo viste".
"Noi siamo andate a prendervi il latte, siamo andate a prendervi un po' di pane."
Questa gente qui, non so i giorni che non mangiavano più; perché sa, prima di venire da noi son
passati in un posto fuori del paese, e bene, gli hanno preso tutti i soldi e non avevano più niente.
E allora questa gente qui si son guardati, come dire non abbiamo niente da contraccambiare, e allora
noi abbiamo detto:"Noi vi abbiamo visti prima, siamo andati giù, vi abbiamo portato un po' di latte,
83
Susanna era la moglie di Jean; si erano sposati a S.Martin Vésubie.
68
il pane, tutto quello che avevamo a casa." Ma papà e mamma ci avevano detto, bevetene un
goccio,(…) per fagli vedere che noi non volevamo mica portargli roba per avvelenarli, neh!
E allora loro sono stati contenti, hanno bevuto…guardi… ci hanno baciato le mani, non so le volte
che ci hanno baciato le mani…
E noi abbiamo detto, adesso andiamo giù, lo diciamo a mio padre che ci cerchi un'altra baita, questa
baita qui non va, e poi torniamo.
Noialtre siamo andate ancora su una volta, neh, quella sera lì, papà è andato su con noi. Li abbiamo
messi dentro un'altra baita, gli abbiamo portato il fieno da mettere sotto, e poi…
A.:Mia mamma aveva delle trapunte, tutto quello che potevamo avere, calze, tutto, mia nonna e mia
mamma facevano calze di lana d'inverno, gli abbiamo dato tutto. Perché quella gente era gelata,
erano abituati a stare al caldo…
Papà ha detto, prendiamo tre paia di calze, quattro, quello che avevamo,abbiamo portato su, e
maglie, perché stessero un po' al caldo… perché morivano…morivano.
M.:E allora papà più tardi è andato a chiedere al priore 84 ,"Hai quella stanza lì vicino che è calda".
E lui ha detto,sì,sì -era bravo neh- che vengano pure.
A.: Ma la responsabilità era sempre nostra.(…)
M.: E così li abbiamo avuti un po' più vicino;e quando nevicava?
Sono stati due o tre mesi nella baita, fino a che non ha nevicato (…) erano i primi di dicembre e poi
sono venuti in quella stanzetta, e lì era meglio portargli da mangiare, e così!
E dopo, il priore, la sera di Natale, l'ha detto, lui l'ha detto in chiesa che avevamo quella gente lì, e
dopo è stato male di averlo detto.
Il 7 di gennaio c'è stata la rappresaglia,(…) sono arrivati i Tedeschi, hanno bruciato, hanno fatto di
tutto; hanno picchiato papà…perché una zia aveva ucciso il maiale e volevano portarle via la roba, e
allora l'hanno picchiato perché volevano per forza portargli via sta' roba Gli hanno preso anche il
portafoglio.
A.: E allora, alla mattina, li abbiamo avvisati e sono andati in un ciabot che aveva mio nonno, da
questa parte.(…) E anche noi siamo scappati e siamo andati via di casa.
D.: Ma i Tedeschi non lo sapevano che avevate questi ebrei?
A. M.: No, no, se lo avessero saputo ci ammazzavano tutti!
M.: Mia mamma gli ha fatto cuocere delle uova ai tedeschi, gli ha fatto tutto in quei giorni; hanno
anche stappato delle bottiglie i tedeschi.(…)
D.: Non avevate paura?
A.: Ma intanto, noi eravamo già belle che rassegnati…
84
Don Bassotto, parroco di Andonno.
69
Noi eravamo su di lì, sparavano; noi ci siamo stati fino alle dieci, loro sono stati fino all'una di notte
M.: Due di notte, quando papà è andato chiamarli.
A.: Ma sa, papà ha detto a mia mamma, fagli da mangiare a quella gente, muore di freddo. Mia
mamma gli ha fatto da mangiare, dopo faceva caldo andare su, papà non voleva più portarli, allora
(…) e allora sono venuti qua.
Quando faceva freddo, così venivano nella stalla, stavano lì. Gli abbiamo voluto bene, loro
pregheranno per noi tutti i giorni.
Però io dico questo, non posso più un'altra volta vedere una cosa così!
E poi sono partiti a metà marzo.(…)
M.: Ci siamo affezionati, abbiamo tutti pianto quando sono andati via. Papà è partito alle due di
notte con il biroch Eppure mia mamma aveva ancora più coraggio: guardi loro sono partiti e noi
abbiamo detto il rosario, abbiamo sempre pregato, finchè papà è arrivato, tutti nella stalla a pregare.
Il Signore ci ha aiutati, sennò.
E poi non hanno più detto niente, nessuno.(…)
A.: Quella gente lì quello che hanno visto, guardi, e anche noialtri, guardi, preferisco la morte, io
dico sempre così.
M.: Io non so gli altri cosa pensano, ma io vedere un disastro così, preferisco morire.
A.: Però poi fa anche piacere, vedere che si son salvati. Dopo 40 anni.
M.: Io quando l'ho visto 85 io sono stata tanto male, mi è preso un affanno! Sa noi avevamo avuto
sempre tanto affanno quando c'era quella gente lì. Lui stava a Gerusalemme, gli altri stavano a New
York.
A.: Però le dico una cosa: gli ebrei di Cuneo,con mio papà, li abbiamo sempre rispettati.
M.: E li rispetteremo sempre; perché papà diceva sempre così, quella gente lì fa ancora bene a
noialtri, perché se hanno qualcosa, pagano le imposte più grosse, e perché dobbiamo maltrattare la
gente?.
A.: Che mio papà aveva poi fatto solo la terza!
M.: Ah, va là, che papà sapeva,va, sta tranquilla. Quando è partito soldato, è stato sei anni soldato,
quello che non sapeva lo ha imparato.(…) E' stato sei anni soldato, senza mai venire a casa un
giorno, non è poi mai venuto in licenza. E' partito nel settembre del '13, è arrivato nel '19, l'8
settembre. Mio papà era del '93.(…)
A.: Ah, li ammazzavano tutti. Una volta hanno preso mio nonno, con 80 e passa anni, l'hanno
portato in piazza, lo volevano ammazzare. Noi ci siamo messi a piangere, siamo andati a
inginocchiarci in piazza, davanti a loro. C'eravamo noi, i nostri cugini; e mia mamma si è
85
Albert Sharon è venuto a cercare le sorelle Giordano ad Andonno nel 1984; rimane di questo incontro una fotografia e
una lettera. Il Sig. Sharon è morto nel 1990.
70
inginocchiata in terra e baciava la terra. Poi abbiamo preso mio nonno sotto il braccio e lo abbiamo
portato a casa. La compassione ha preso anche loro!
M.:Perché mia mamma gli ha portato la carta di identità, tutto, gli ha parlato, lui aveva l'aria ancora
giovane, ma era anziano!
A.: Ah, mi ricordo sempre di quello, mi è stato proprio nel cuore, era il 20 di agosto, il giorno di S.
Bernardino. Il 20 agosto del'44.
71
La fuga in Svizzera
72
Per poter raccontare il grande esodo che avvenne nel 1943, dopo l’invasione dei tedeschi in Italia, di
ebrei italiani e non, verso la Svizzera, bisogna innanzitutto descrivere la legislazione svizzera
riguardante i permessi di soggiorno, gli asili etc.
La Costituzione del 1848 permetteva che un perseguitato politico di un altro paese potesse essere
ospitato: il Cantone concedeva il soggiorno, la Confederazione lo revocava. Nel 1874 la revisione
costituzionale permise alle autorità di espellere lo straniero che minasse la sicurezza esterna ed
interna della Svizzera.
Avendo quindi questo tipo di legislazione fu inevitabile che già allo scoppio della 1° guerra
mondiale, la Svizzera fosse invasa da disertori, prigionieri evasi e renitenti, obbligando di
conseguenza le autorità svizzere ad assumere misure sempre più restrittive. Nel 1915 infatti i
Cantoni ricevono disposizioni per il controllo dei documenti, e nel 1917 un articolo regola il
soggiorno dei rifugiati politici, mentre i Cantoni rilasciano speciali “permessi di tolleranza”. Nel
1918 si decide di internare disertori e i renitenti di leva. Dal ‘21 al ‘25, ribadendo i concetti base
dell’asilo politico, si decide che i permessi siano rilasciati caso per caso (durante l’esodo dall’Italia
alla Svizzera si vedrà appunto che saranno i soldati di guardia al confine, a decidere chi era idoneo
o meno a passare il confine).
Nel 1929 quando ci fu il periodo della crisi economica, la Svizzera fu costretta a regolamentare
ancor più severamente l’ingresso degli stranieri perché diventavano i “nemici” degli svizzeri sul
mercato del lavoro. Fino al ‘33 la Svizzera regolò minuziosamente la residenza ed il lavoro dello
straniero; poi con la presa del potere da parte di Hitler ci fu una gran massa di ebrei che tentò di
passare il confine, ma che la Svizzera fu costretta a respingere o quantomeno chi riusciva ad entrare
non poteva stabilirsi definitivamente ma doveva dirigersi in breve tempo verso un altro paese,
altrimenti sarebbe stato rispedito al paese di provenienza. Tutto ciò accadde anche quando l’Austria
fu annessa al Reich (1938) e la gestapo costrinse gli ebrei ad emigrare.
Bisogna però dire che la Svizzera usò queste contromisure severe per evitare un attacco ed una
conseguente occupazione da parte delle armate naziste; le autorità svizzere volevano mantenere la
propria autonomia verso i paesi belligeranti. Non lo fecero per odio verso la razza ebrea.
Nel 1940, con l’aggravarsi della minaccia tedesca, i profughi salirono da 7000 a 10000, e dato il
numero consistente si decise di instaurare nei diversi cantoni i “campi di lavoro”, verso i quali si
spedirono i profughi ritenuti “fisicamente idonei” al lavoro.
Dopo il ‘40, con l’occupazione nazista della Francia, venne la terza emergenza razziale, infatti
migliaia di ebrei provenienti prima dal nord e poi dal sud della Francia si affollarono sul confine
cercando di sfuggire alla persecuzione nazista ma il Consiglio federale svizzero decise di
respingerli, condannandoli ad una morte certa.
73
Questo comportamento fu, ed è tuttora, molto contestato anche dalla stampa, e le cose si
aggravarono maggiormente quando i tedeschi incominciarono le deportazioni anche in Francia.
Infatti le autorità svizzere negarono sempre più i permessi ai semplici ebrei, favorendo i perseguitati
politici, i quali a loro volta si presentavano alla frontiera con più insistenza. Questa situazione
costrinse gli svizzeri a proteggere il confine con la Francia col filo spinato (29 Novembre 1942)
aggravando quindi la vita di ogni singolo ebreo.
Le cause di questo comportamento da parte delle autorità svizzere si riscontrano nella paura, che li
accompagnerà per tutta la guerra, di un’invasione della Germania, nella paura di essere sottoposti
anche loro alla dittatura hitleriana.
La quarta emergenza arrivò dall’Italia, nel Settembre 1943, in cui il confine controllato dal filo
spinato fu allungato anche sul fronte italiano, dove il permesso di soggiorno veniva assegnato
direttamente dai soldati del posto, e nel periodo in cui gli alleati stavano sbarcando ormai in tutta
Europa (6 Giugno 1944: sbarco in Normandia). Per quanto riguarda i profughi militari italiani che
cercarono di espatriare in Svizzera “il Governo federale decise così, il 17 settembre, di considerarli
come rifugiati civili, anche se giunti sul suolo elvetico con le loro uniformi.”(1)
Con l’invasione dei tedeschi in Italia, infatti, si dà inizio ad un breve periodo di storia della guerra
in cui gli ebrei residenti allora nel nord Italia (per coloro che capirono il reale pericolo di tale
avvenimento) furono costretti a tentare la fuga verso un paese che sembrava in quel momento il più
neutrale alla guerra, ed anche il più vicino. Purtroppo parleremo di “tentativi” di fuga, perché molte
di queste furono respinte o stroncate sul nascere.
Dal 9 Settembre 1943, dunque i primi a rendersi conto di ciò che gli sarebbe accaduto furono gli
ebrei stranieri, proprio perché avevano già sperimentato la ferocia nazista. “Costretti a tentare un
confine dopo l’altro in un Europa che li ha messi al bando e vuole sterminarli. Nascosti in
montagna, in casolari, nel timore di essere denunciati sono i primi a cercare una via di salvezza”( 86 ).
Con l’andar del tempo le notizie di ebrei messisi in salvo, e le notizie delle prime retate naziste nei
vari paesi italiani (a Merano (16 Settembre) ove gli ebrei furono prelevati e deportati al campo di
sterminio di Reichenau; nelle valli di Cuneo da dove i profughi arrestati furono deportati ad
Auschwitz, e da Meina dove furono uccisi 54 ebrei profughi da Salonicco), convinsero sempre più
altri ebrei, soprattutto Italiani, a tentare di mettersi in salvo in Svizzera. Solo che, con l’andar del
tempo, come ho già detto, gli Svizzeri presero le loro contromisure, cercando di controllare un
1 M. Cerutti, I rifugiati italiani nella confederazione elvetica durante la seconda guerra mondiale, Angeli, 1989, p. 208. A p. 215 l’autore decifra con certezza l’ammontare dei militari
che entrarono sul suolo elvetico. Si stima che fossero circa 30.000, di cui 21.000 entrati solo nel 1943.
86 R.Broggini, La frontiera della speranza. Gli ebrei dall’Italia verso la Svizzera, Mondadori, 1998, p. 18.
74
esodo di massa molto pericoloso vista la vicinanza della Germania, mettendo per esempio delle
recinzioni di filo spinato lungo tutto il confine italiano, interrotte da vari posti di blocco. Chi volesse
passare al di là del confine doveva presentare i propri documenti (generalmente falsi) e sperare che i
soldati di guardia non trovassero dei motivi futili per non permetter loro di passare.
“Nel settembre 1943 papà venne a prendere noi ragazzi all’istituto Don Guanella. Fuggimmo
attraverso le montagne e, camminando una notte intera, arrivammo in Svizzera alle 6 del mattino.
La guardia ci respinse perché eravamo apolidi. Ricordo la scena delle guardie con i fucili puntati: Dovete andare.. Dovete andare...fuori!-. Alle 9 eravamo già fuori. Avevo 14 anni”( 87 ).
Le vie di fuga erano molte, ma sostanzialmente avvenivano tutte nella zona circoscritta dai laghi
Maggiore e di Como. Anche il piano di fuga era molto simile da una famiglia all’altra, variava solo
per i mezzi di cui si disponeva (e non era poco), però il progetto di base era raggiungere il confine
eludendo i nazisti col favore della notte e grazie all’uso di documenti falsi procurati grazie alle
giuste conoscenze che ogni famiglia ebrea possedeva. “Qualcuno accenna alla possibilità di fuggire
in Svizzera,... .Un avvocato di Milano ci procura carte d’identità false, preziosissime,... un capitano
dei carabinieri, amico nostro carissimo, ci avverte dell’ordine di arresto immediato per americani,
inglesi ed ebrei...”(4) ; “...un giorno salì in casa un funzionario della Questura che veniva da Milano
e che conoscevamo, ci disse: -I rifugiati ebrei di Gandino stanno fuggendo in Svizzera...., vi dico di
provvedere in merito...-. Un dipendente del comune venne di corsa una mattina a dirci che i tedeschi
erano arrivati in paese”(5).
Una volta raggiunto il confine, specificatamente nei paesi tipo: Monte Lema; Madonna del Piano;
Ponte Tresa; Stabio; Novazzano; Laghetto; Chiasso; Pizamiglio;etc, o il lago di Lugano a Morcote e
Torrazza, ci si rimetteva nelle mani dei contrabbandieri che aiutavano ad oltrepassare la recinzione,
o il lago, per somme di denaro molto consistenti per l’epoca(6), che variavano da contrabbandiere a
contrabbandiere: “Dori Shonheit Bontifogli -Era gente che lo faceva per tanto guadagno, costava
5.000 lire a testa-; Lilla Hassan Coen -abbiamo pagato ai contrabbandieri 12.000 lire per 4 persone-;
Bruna Cases -Ci hanno chiesto i soldi per il contrabbandiere, il camioncino chiuso da un telone,
l’atte sa in casa di contadini, prezzo: 10.000 lire a persona-; Marialuisa Cases -Ci indicarono una
signora di Lanzo d’Intelvi... le lasciammo 40.000 lire, per allora era una somma enorme-”(7).
Senza contare il fatto che i contrabbandieri il più delle volte derubavano i fuggiaschi portando via le
loro valigie: “Ci accorgiamo dell’ignobile trucco: il sacchetto più grosso contenente i gioielli di
87
Broggini, Testimonianza di Tommaso Berger, p. 9.
4
Broggini, Testimonianza di Lucia Forneron Roditi, p.30
5
Broggini, Testimonianza di Giuseppina Bachi Guastalla, p.30.
.
6 Da molte testimonianze, si deduce che la cifra media fosse di £ 5.000. In base ai coefficienti Istat, è stato calcolato che 1 lira del 1943, corrisponde (valore 1994) a £ 417.94 odierne. Il
che significa che £ 5.000 del ‘43 corrispondono a £ 2.090.000 circa di oggi.
7 Broggini, op. cit., pp. 44/45.
75
Lida è scomparso, come qualche oggetto d’oro di mia appartenenza. Per me è nulla, trattandosi di
poco valore mentre per Lida è uno schianto: tutto il suo patrimonio è sfumato e, con questo, la
76
77
possibilità di via libera o, per lo meno, con qualche agiatezza. Scene di disperazione, ma ormai è
troppo tardi.”(8) I Valobra -le guide si sono accorte che avevamo dei gioielli, li hanno presi-; Bechi
Ottolenghi Behar -Siamo i superstiti dell’eccidio di Meina. Siamo entrati clandestinamente sotto la
rete; ognuno di noi con un sacco a pelo. I contrabbandieri cui avevamo pagato una somma enorme ,
un milione a testa, ci hanno rubato tutto quello che avevamo-.(9)
Oltrepassare il confine quindi non era affatto una cosa semplice, tanto più che già sotto il regime
fascista per poter espatriare bisognava eseguire una lunga trafila di procedure burocratiche che
richiedevano la collaborazione sia del paese di provenienza, col rilascito del passaporto, sia del
paese di destinazione, col rilascito del visto. Dopo l’8 settembre 1943 tutto si complica, perché le
frontiere controllate dai nazisti, costringevano l’espatrio solo verso vie ben definite: via
Ventimiglia, via Chiasso e via Brennero. Tutto ciò se si era delle persone non sospette, tipo
funzionari, giornalisti e persone facoltose; se si era invece dei disertori o degli ebrei, l’unico modo
per espatriare era la clandestinità. Per gli ebrei, più che per gli altri, ogni tappa del percorso era
rischiosa, soprattutto dopo il 14 novembre ‘43 quando la Repubblica sociale italiana li definisce di
“nazionalità nemica”. “Braccati di continuo, con il terrore di soffiate, per gli ebrei spostarsi vuol
dire esporsi a una cattura quasi certa”(10).
Circolare, quindi, per le città era diventato pericoloso, visto che l’ebreo era considerato
“fuorilegge”, l’unico modo era usare documenti falsi per lo più provenienti dal sud, liberato dagli
alleati, perciò risultava difficile controllare il timbro sul documento. Comunque sia, per l’ebreo in
fuga una volta alla frontiera, doveva dimostrare agli Svizzeri che era ebreo, cioè perseguitato, e per
fare ciò ci si portava lungo tutto il viaggio anche dei documenti che testimoniassero l’appartenenza
ebraica.
“Fu una medaglietta da collo cucita nell’imbottitura della giacca, alla spalla, a persuadere il
comandante che probabilmente noi eravamo davvero ebrei- -In una tasca di mio marito avevo cucito
un documento che dichiarava che noi eravamo ebrei, tale foglio sarebbe stato utile per essere accolti
in Svizzera, ma nel corso del viaggio era fonte di ansie e paure”(11).Una volta raggiunto il confine,
dopo aver corso innumerevoli rischi, ci si affidava ai contrabbandieri o come venivano chiamati
allora i “passatori”. Il mestiere del passatore era sorto nel ‘43 quando iniziarono gli “anni del
riso”, cioè quando gli Svizzeri ebbero bisogno del contrabbando dei generi alimentari, ma tramutò
8 Broggini, testimonianza di Edoardo Pavia, pp. 44/45.
9 Broggini, op. cit., pp. 46.
10 Broggini, op. cit., pp. 39.
11 Broggini, Testimonianze di Luciano Tas e di Clara Calò Servi, p. 41.
78
velocemente in un vero e proprio trasporto di uomini dall’Italia alla Svizzera, e tramutò anche nel
personale nel senso che durante questo periodo i contrabbandieri furono soprattutto dei giovani
disertori, i quali conoscevano perfettamente ogni singolo passo o vallata del luogo.
“Alle prime ore del 23 dicembre con il contrabbandiere, uomo non molto alto ma robusto, di cui
non conosco il nome, abbiamo intrapreso il cammino, io con le nostre due valigie, mia mamma
sulla schiena del trasportatore, e finalmente abbiamo raggiunto la sospirata rete. Nascosti nel bosco,
atteso che si allontanasse la ronda, il contrabbandiere ci ha condotti ad un affossamento sotto la rete,
pericolosissima da toccare perché i campanelli d’allarme avrebbero potuto suonare. Dopo avergli
consegnato l’importo pattuito, strisciammo sotto la rete e passammo dall’altra parte.- ...Ci troviamo
così soli con i due contrabbandieri che ispirano poca fiducia. Uno, Pietro Invernizzi, piccolo, magro
e dall’aspetto energico; l’altro, Andrea Taroni, alto, grosso e tarchiato. Babbo è sgomento e vuole
lasciar perdere, ma io insisto perché si affronti il nostro destino a due mani...- Dopo il primo
passatore infatti di lì a poco giungono alla spicciolata altre sei guide, quasi tutte ex militari e
conoscitori di queste montagne passo per passo” (12).
Altra incognita per i fuggiaschi era l’onestà dei contrabbandieri, infatti come testimoniano tanti
superstiti, molte volte si era vittime di passatori che magari dopo essersi fatti pagare il trasporto ti
consegnavano ai tedeschi o fascisti, incassando anche la taglia che c’era su ogni ebreo: “Goti Bauer
-Noi lì non vi possiamo accompagnare perché ci sono le guardie svizzere... Detto fatto si voltarono,
fecero un fischio e sparirono. Nel medesimo istante si udirono degli spari, si accesero delle luci,
fummo circondati dalle guardie di finanza, arrestati, portati in casermetta” (13).
Il dilettantismo è un altro rischio non da poco, perché il miraggio di denaro spinge molti ad
improvvisarsi guide senza averne l’esperienza: un dramma per chi è costretto a fidarsi.
Bruno Acht scrive: -Le guide l’abbandonarono, e dovette passare parecchie volte la rete, una volta
coi figli, un’altra con pacchi e valigie: una cosa tremenda-.
In ogni modo, nonostante i vari pericoli, le fughe non cessarono un solo giorno, tanto che se da
principio si organizzavano per persone singole o piccoli gruppi di max tre persone (vigeva il divieto
di riunione per più di tre soggetti), con l’andar del tempo si era costretti ad azzardare la fuga con
altre 10/15 persone formando gruppi chiamati dai contrabbandieri i “pacchetti”. “...il “pacchetto”
come dicevano questi signori, doveva essere composto da noi quattro, più il fratello di mio padre
con la moglie (Eugenio e Valeria Vita) e mio cugino Enrico Mondovì...-” (14). Questi “pacchetti”
aumentavano i rischi, perché una famiglia in movimento con bagagli, bambini e anziani non certo
12
Broggini, Testimonianze di: Ettore Nacamuli, Arnoldo Tedeschi, Angelo Dello Strologo, pp. 43/44.
13
Broggini, Goti Bauer, p. 45.
14
Broggini, Testimonianza di Alberto Vita, p. 53.
79
disinvolti, sollevava sospetti. Tanto più in località di frontiera, dove si è estranei e non è difficile
intuire perché si è lì.
Per ovviare ai maggiori rischi derivanti dai “pacchetti”, la rete di aiuti si allarga, alcune famiglie
ariane, partigiani, parroci e particolari associazioni tra cui “i famosi protestanti Valdesi del Partito
d’Azione (rifiutavano il sevizio militare e la pena di morte)” aiutano le famigli ebree nella ricerca
dei contatti giusti, nei documenti, nei passatori fidati. Per esempio la signora e il signor Nogara, tra
Bellano e Colico, organizzarono una fitta rete per nascondere prigionieri di guerra evasi ed ebrei,
prima di farli espatriare “Fidati alpini, di notte, li porteranno poi con la lancia di casa Nogara, sulla
sponda opposta del lago, ad Acquaseria; ove guide esperte dei luoghi li condurranno in
Svizzera”(15); in questo modo i Nogara misero in salvo duecentocinquanta ebrei.
Molto attivi erano anche i centri ebraici della “Delasem⇒Delegazione Assistenza Emigrati Ebrei”
che erano dei veri e propri enti ebraici di assistenza ai profughi stranieri che si costituirono su base
nazionale nel 1939. Particolarmente attivo fu il centro di Genova, diretto da Massimo Teglio, che
provvedeva personalmente a porre sui documenti il timbro “appartiene alla razza ebraica” per “far sì
che gli svizzeri li accettassero”. Secondo la testimonianza di Graziella Baggiani Pavia, il Teglio
aiutò le famiglie Pavia e Pontecorboli nella fuga.
Come ho già detto anche le diocesi ebbero un ruolo importante, secondo alcune testimonianze erano
la rete di soccorso più valida formata da basi sicure e solide tipo parrocchie e conventi, e gestita da
parroci e vescovi che conoscevano le autorità del luogo, quindi di chi fidarsi, chi poter corrompere e
quando far viaggiare gli sfollati.
“Ci siamo nascosti da amici carissimi, i Piva. Loro con l’aiuto del parroco del posto ci hanno
organizzato il trasferimento in Svizzera. Il parroco aveva trovato due boscaioli- contrabbandieri coi
quali una mattina di novembre ci incamminammo verso il confine. Ad un tratto, a metà percorso, i
due si accorsero che qualcosa non andava, ci dissero di nasconderci sotto le foglie e di aspettare il
loro ritorno, loro sarebbero andati a controllare più in alto. Dopo un po' li vedemmo scendere
scortati da altre persone che sembravano fascisti, a quel punto ci accorgemmo di essere soli e da soli
dovevamo attraversare il confine.”(16) In alte parole le diocesi offrono un ricovero che non si può
avere altrove; non chiede soldi, ma contributi per chi aiuta; non tradisce né abbandona.
Alla base di tutti questi rischi c’era sempre la speranza, la speranza di passare il confine, arrivare
alla terra libera da liberi (per quello che si poteva essere liberi) e poter essere con orgoglio ciò che si
era: ebrei, disertori, partigiani, etc.
15 Broggini, Antonietta Nogara Osio (1904-1987), p. 50.
16
Broggini, Testimonianza scritta di Mario Latis, p. 51.
80
“Là, quella è la rete...”, l’ultimo ostacolo verso la libertà. Un ostacolo però circondato da molta
insidie; campanelli pronti a suonare ad ogni minimo passaggio, pattuglie di guardia 24 ore su 24,
intemperie del luogo, etc. Questo era ciò che si prospettava al fuggiasco poco prima di raggiungere
la tanto sospirata libertà.
“Quando c’è stato un po’ di silenzio ci siamo precipitati verso il confine fino a quando non abbiamo
trovato un guardaboschi che armeggiava vicino ad un cancelletto, lo convincemmo bruscamente a
far finta di non averci visto e passammo subito dall’altra parte.”(17)
Il passaggio legale é autorizzato ai valichi doganali, chi tenta l’espatrio abusivo va incontro a
sanzioni severe, a norma del “Testo unico di pubblica sicurezza italiano”.
Le storie dei passaggi in Svizzera si possono distinguere in tre diversi periodi: il primo che va fino
all’ 8 settembre 1943 in cui la frontiera è controllata dai tre reparti italiani (la Guardia di finanza,
l’Arma dei carabinieri, la Milizia volontaria). Il secondo dopo l’armistizio che va dal 9 al 16
settembre in cui si passa una settimana di confine sguarnito, e dove chi è furbo coglie l’occasione al
volo. “Ebbi la prontezza di spirito, dissi alla guardia -Vieni con me che i tedeschi stanno portando
via i tuoi commilitoni.- Lui mi fisso un attimo, abbasso la canna del fucile, superammo assieme il
confine.”(18)
Il terzo periodo va dall’ 18 settembre in poi, quando i tedeschi prendono il controllo della
sorveglianza tramite l’utilizzo della Grenzwache, polizia speciale di frontiera che dipende dal
comandante delle SS in Italia, l’Obergruppenführer Karl Wolff, capo delle forze di polizia del
Reich.
A fianco della Grenzwache, il governo italiano, per garantire l’impermeabilità dei confini, impiega
la milizia del Partito fascista, e la Guardia nazionale repubblicana alla frontiera.
Il “nuovo orientamento” dei servizi di polizia confinaria è esposto in un rapporto del dicembre
1943: “Individuare i favoreggiatori degli espatri, poi seguirli sino in prossimità della linea
confinaria, ed arrestare chi tenta di guadagnare il suolo elvetico a comitive giudaiche con i loro
preziosi e valori sottratti alla ricchezza nazionale.” (…) “E’ così che la corsa verso il confine degli
ebrei, che con la fuga nell’ospitale terra elvetica - rifugio di rabbini - tentano di sottrarsi alle
provvidenziali e lapidarie leggi fasciste, è ostacolata dalle vigili pattuglie della Guardia nazionale
repubblicana che, indefessamente, su tutti i percorsi, anche i più rischiosi, con qualsiasi tempo e in
qualsiasi ora, con turni di servizio volontariamente prolungati, vigilano per sfatare ogni attività
17
Broggini, Testimonianza scritta di Mario Latis, p. 56.
18 Broggini, Alberto Vigevani, p. 57.
81
oscura e minacciosa di questi maledetti figli di Giuda. Gli ebrei fermati nel territorio di questa
provincia ammontano, dai primi di ottobre a oggi, a cinquantotto.”(19)
Da metà settembre, in buona sostanza, chi si avventura verso la frontiera sa che può finire nelle
mani delle SS. Per militari e politici, se catturati, c’è il tribunale speciale e il carcere; per gli ebrei la
deportazione e il campo di sterminio, o anche l’uccisione sul posto.
“C’è un solo incubo ricorrente, per cui ancora oggi mi sveglio terrorizzato. E’ l’incubo della nostra
fuga in Svizzera: il buio di un armadio in cui ero stato chiuso con mio fratello, la corsa a perdifiato
oltre la rete di confine, la sventagliata di mitra che ha ucciso due miei cugini...A un certo punto, mio
padre mi tira fuori dall’armadio, mi dice che, appena usciamo dalla porta, devo correre e star
chinato. Così, di corsa, mi trascina verso una rete e, praticamente, mi butta dall’altra parte attraverso
un buco nelle maglie. Io non capivo più niente, non sapevo cosa stava succedendo. Accanto a me
c’erano mio fratello e mia madre, mio padre ci seguiva di corsa e la donna , al di là della rete,
gridava: “Vai, vai, presto!”. salto un fosso e, quando rialzo gli occhi, su un terrapieno che mi sta di
fronte vedo un soldato con il fucile spianato. Resto come paralizzato, finché mio padre mi grida:
“Vai, corri, è svizzero!”. Passa qualche secondo e, alle mie spalle, sento il crepitio di una
sventagliata di mitra. Mi volto e, più in basso, vicino alla rete di confine, vedo i cugini stesi a terra,
tutti insanguinati, e gli zii che vengono ammanettati da una pattuglia tedesca.”(20)
Arrivando al confine, comunque, qualcuno fa in modo di non vedere chi passa, qualcuno addirittura
aiuta: soldati austriaci, guardie di finanza, carabinieri, militi fascisti.
Forse li commuove veder fuggire bambini, donne, vecchi: il sapere cosa li aspetta se venissero
catturati; forse non accettano il peso di obbedire ai “camerati” tedeschi.
“Da Venegono siamo andati a Varese, siamo passati con dei contrabbandieri e, devo dire la verità,
c’erano dei militi fascisti che mi hanno aiutato tanto.”(21)
“Presso la rete una guardia di finanza ci ha avvistati, ma lasciati proseguire: “Via, passate!”; ricordo
il terrore dei nonni e la nostra eccitazione nel vedere le luci di Lugano.”(22)
“Con la complicità di due finanzieri italiani, che ci alzarono un punto quasi inaccessibile della rete,
complicità largamente ricompensata con tutto il ciò che avevamo, la nostra compagnia si avviò, col
cuore in gola, verso le due del pomeriggio.”(23)
“Un finanziere ci ha visto arrivare: -Voi dove state andando?- e ricordo mia madre arrossire fino
alla cima dei capelli... -Si sta facendo una passeggiata. - E quello: -No! Una passeggiata alle sette
19
Archivio di Stato, Como, Prefettura-Gabinetto u.v. 1943-1944 (Franco Scassellati-Prefetto), b.126, cat. - XII (pratiche di frontiera), “Fermo di
ebrei”, Como, 12 dicembre 1943, firmato “il Comandante della Legione Console Marcello Mereu
”.
20
Broggini, Carlo De Benedetti, pp. 59/60.
21 Broggini, Paolo Marcus, p. 60.
22 Broggini, Luca Gentili, p. 61.
23 Broggini,
Testimonianza di Rina De Benedetti Milano, p. 61.
82
meno dieci di sera, con una bambina di tre anni sulle spalle, lo zaino e una valigia, no! Non me la
raccontate-. Mia madre, balbettando, perché mio padre non era capace di dire una parola in quella
situazione, disse: -Effettivamente si stava andando in là- indicando con gli occhi, carichi di
significato, la frontiera. allora, il finanziere, con nostra grandissima fortuna, ci disse molto
esplicitamente: -Se siete ebrei e state cercando di scappare vi conviene dirmelo. La finanza, in
questo momento, essendo fedele al governo Badoglio, protegge gli ebrei, per quanto può; quindi, vi
conviene dirmelo-. Mi ricordo, come se fosse adesso, la sguardo di terrore che si sono scambiati i
miei, per consultarsi silenziosamente: se fosse il caso di credergli e quindi di fidarsi, oppure potesse
essere un tranello. Poi, mia madre, perso per perso: -Sì, siamo ebrei e stimo cercando di scappare-.
Allora, il finanziere: -Vi consiglio di affrettarvi, si sono fatte le sette meno cinque, c’è di guardia la
finanza alla frontiera, ma alle sette cambia il turno: scende la finanza e arriva la milizia, e la milizia
vi cattura e vi consegna ai tedeschi. Quindi, avete cinque minuti di tempo per varcare la frontiera.”(24)
Bisogna comunque segnalare il fatto che quasi la totalità delle guardie aiutavano dietro lauti
compensi, proprio come testimonia Ignazio Bassi: -La pattuglia della finanza, per un po' di soldi, ci
ha aiutato a passare: “Svelti, svelti, i cani tedeschi abbaiano”-. Oppure come ricorda Elena Kahn
Aschieri: “A Gabriella Bergmann hanno imposto l’alt, c’era uno iugoslavo che le ha detto: -Ha
soldi?
Mi dia le 15.000 del passaggio-. Metà le ha date alle guardie italiane, metà ai tedeschi e uno di
questi ha detto: -Siamo austriaci, non abbiamo niente a che fare con i tedeschi-; così hanno preso i
soldi e noi siamo passate”.
Bisogna anche dire, purtroppo, che in alcuni casi l’ebreo rimane vittima delle denunce al nemico, le
così dette “delazioni”. “Da informatore attendibile, ero venuto a conoscenza che i coniugi Levi
Guido fu Cesare e fu Ascoli Elvira nato in Ancona il 9 settembre 1882 residente a Milano - via
Castel Morone 12 - e Ascoli Luigia in Levi fu Adolfo e fu Bernardi Emilia nata il 7 novembre 1877
a Livorno e residente a Milano, notoriamente antifascisti, avevano progettato di espatriare
clandestinamente per riparare in Svizzera e tale Progetto stavano per mettere in esecuzione. Fatti
cautamente vigilare e dati ordini al Comando della Milizia Confinaria di procedere all’arresto ove i
due avessero cercato di superare la linea di confine, in data 23 ottobre infatti in località Maslianico
(Como) situata nei pressi della linea di confine con la Svizzera, i due coniugi vennero tratti in
arresto. Secondo le disposizioni del comando delle SS Grenzbefehlstelle West di Cernobbio (Como)
trattandosi di ebrei, la Milizia Confinaria ha provveduto alla loro consegna a quel comando.
Durante la perquisizione dei due fermati vennero rinvenuti valori e oggetti che il Comando della
24 Broggini, Lucia Roditi, pp. 61/62.
83
Milizia provvide a rimettere a questa Prefettura e che il Ragioniere Capo Cav. Giuseppe Laudiano
ha preso in consegna. Tali valori sono custoditi presso la cassaforte di questa Prefettura in attesa
delle determinazioni di codesto Ministero”(25) .
Un ulteriore fattore, che aumentava la paura, era affrontare delle vie di fuga impervie e quasi
sempre sconosciute. C’era la possibilità di attraversare il confine passando per le montagne, tipo
quelle della Val d’Osta, Valsesia, Valtellina, Val d’Ossola dove è praticamente impossibile
sopravvivere senza una guida e l’equipaggiamento adatto. Dai monti della Val Chiavenna entrano
sette Levy: -Ci hanno consigliato di scappare; i nonni anziani non potevano attraversare lo Spluga,
noi l’abbiamo fatto con molti pericoli, ci siamo persi nella nebbia... mai avremmo potuto
attraversarlo senza una guida-; Noè Foà e il padre Augusto, partiti dalla Valtellina, varcano il
confine da Campocologno a circa 2000 metri, anche loro con l’aiuto di guide.
Un altro percorso forse più facile era passare per i laghi: dal Verbano al Cersio, al Lario nel
novarese, Varese e Como; una zona in apparenza facile, ma anch’essa piena di insidie, per i
fuggiaschi sono infatti ore ed ore di percorsi accidentati, sentieri a strapiombo, torrenti, rocce e
neve. Era soprattutto una pena per le persone anziane che camminavano tra un affanno e l’altro.
“Ho vissuto la notte più lunga della mia vita, perché, a otto anni, trasportato sulle spalle di un
contrabbandiere, con mia sorella, vedevo mio padre e mia madre cadere in continuazione nella
neve, perché non erano attrezzati a un passaggio di questo genere. Ricordo quando mio padre cadde
e scivolò e rimase aggrappato a un arbusto, mi sembra su un burrone: io quella notte ho pregato per
tutto il resto della mia vita”.(26)
Un’ultima strada era quella di attraversare i boschi dove la frontiera taglia in modo irregolare questi
ultimi, c’è poi l’enclave italiana di Campione, di fronte a Lugano, circondata da territorio svizzero,
a ridosso del Generoso. Non a caso la maggior parte dei profughi si avventuravano in questi luoghi,
spesso rischiando di perdere l’orientamento e le guide stesse.
“Siamo finiti, poi, in un roveto dal quale zio Guido non era capace di risollevarsi. Giungemmo
stanchi morti su di un prato bagnato. Ci siamo riposati un po’, mentre l’ufficiale era andato ad
avvertire le guardie svizzere, che sono venute in nostro aiuto perché, non trovando la strada,
eravamo decisi a passare la notte all’aperto.”(27)
Una volta oltrepassata la rete, questo non significava essere in salvo, anzi per ogni storia di
fuggiasco che arrivava in Svizzera il momento, la situazione, si faceva sempre più difficile, proprio
25 Broggini, testimonianza di Franco Scasellati, p. 375.
26
Broggini, Testimonianza di Piero Dello Strologo, p.66.
27 Broggini,
Testimonianza di Ada Schreiber Fano, p.67.
84
perché in questa situazione si decide chi vive e chi muore, chi è accettato e chi è costretto a tornane
indietro per essere consegnato nelle mani dei fascisti.
In ogni caso però ci si doveva innanzi tutto imbattere in una guardia svizzera e per molti non era
una bella sensazione, visto che gli svizzeri e tedeschi indossavano uniformi pressoché identiche.
“Un lunghissimo attimo di paura per il casco di foggia simile a quello germanico e la divise grigio
verde; ma la vista dei bottoni, l’emblema della Svizzera, spezza la tensione.”(28)
Una volta catturati si veniva trasportati nelle casermette del paese più vicino e qui decidevano se si
era accettati o meno. Durante la guerra infatti la Svizzera intensificò le ronde sul confine,
incorporando la polizia federale con le pattuglie; poi ogni decisione veniva presa telefonando al
comando principale. Infatti gli ordini del governo erano quelli di respingere i clandestini oltre la
frontiera, tranne che per i casi eccezionali, tipo i rifugiati politici; giovani sotto i sedici anni; i
soldati
disertori ecc. Per tutti gli altri l’ordine era tassativo, se non ché i soldati, che ormai erano a
conoscenza di cosa andava in contro un ebreo catturato e deportato, non avevano il coraggio di
eseguire gli ordini, non volevano prendersi la responsabilità di decidere chi viveva o chi moriva.
Quindi si trasportavano i detenuti alla casermetta e lì il comandante, telefonando al comando
principale di Berna, dopo aver esposto per telefono la storia, la vicenda del rifugiato catturato,
sapeva a sua volta della decisione finale di “ vita o morte”.
“Sabatino Lopez e la moglie Sisa si sentono dire: -Vous êtes des réfugiés?- Guarda i documenti.
Dice che sarà difficile che ci accettino, ma che va a chiamare l’ufficiale.... Aspettiamo la telefonata
del comando. -Siamo accettati-.”(29)
In casermetta oltre alla telefonata decisiva si chiedevano prima di tutto i documenti riportando su di
un registro le generalità e la provenienza. Poi in base alle norme in vigore la guardia di confine
valuta se è necessario o no fare la telefonata a Berna (cosa che avveniva nella quasi totalità dei
casi).
Su questa pratica comunque le istruzioni ai militari sono diverse: -E’ proibita alla truppa
d’interrogare dei rifugiati civili o di trattenerli a questo scopo e alla truppa è proibito accattare dai
rifugiati qualsiasi oggetto o danaro-.
Dopo questa procedura si arriva al momento fatidico dove si decide chi resta o chi torna in dietro,
prendendo a volte delle responsabilità molto pesanti perfino per il più bieco degli assassini.
“Camminavamo già da pochi minuti, quando dei soldati svizzeri ci fermarono. Io credetti che erano
tedeschi e, impaurito, mi rannicchiai nel paltò della mamma singhiozzando. Quei soldati aprirono
28 Broggini, op. cit. p.71.
29
Broggini, op. cit., p.74.
85
bocca soltanto per dirci. -Sarete rimandati-.... Appena arrivati, un doganiere ci venne in contro
gridando. -non potete nemmeno passare le valigie, ritornate subito indietro-. La mamma si
inginocchiò, pregò e pianse, ma il doganiere rimase duro e disse: -Andate a letto e domani vi
accompagnerò al confine-. La mamma domandò di suo padre di ottant’anni e di sua madre, che
erano entrati la sera prima, ma il doganiere disse con voce cattiva: -Sono stati respinti-. La mamma
a quelle parole cadde a terra, si strappò i capelli e quasi svenne. Pio andammo a dormire affranti da
tutti i dolori e ci addormentammo. La mattina dopo il doganiere ci disse. -Siete accolti dalla
Svizzera e oggi partirete- e di fatti dopo poco partimmo con una lunga carovana e giungemmo
finalmente in un palazzo dove ci diedero da mangiare due cucchiaiate di minestra.”(30)
“17 Novembre, primo mattino. Ci riceve un doganiere. Ha l’aria seccata per questo inizio di
mattino. Diciamo qualche parola. Mio padre conferma che siamo ebrei. gli mostra un certificato
notarile (!) che lo attesta. niente da fare: - Di queste carte in Italia con mille lire ne compro quante
ne voglio -. Duro e ottuso. Non conta dirgli di Tullio, che è a Losanna da anni; che telefoni a Berna
dove conosciamo un diplomatico italiano eccetera. Il doganiere ci invita a tornare fuori nello
spiazzo: - Anche perché ho appena pulito il pavimento -. Ci sediamo sugli scalini, sulla neve. La
mamma, io, Donata e Romano. Il papà è rimasto a parlare con lo svizzero. Al di là del confine
compaiono alcuni soldati fascisti che sghignazzavano, indicandoci. Il papà ci raggiunge scuro in
volto con il doganiere che sbrigativamente indica il confine: -Fra un’ora tornerete di là, non è
possibili ospitarvi in SvizzeraE’ finita. Il lavoro e le ansie di un mese si concludono. Un ritorno che significa la consegna ai
fascisti o ai tedeschi che sono a pochi metri. Trascorrono minuti infiniti. Mia madre, solitamente
mite e schiva, ha un soprassalto; si rivolge al doganiere: -Non possiamo tornare; mio marito sarà
catturato perché è stato “podestà”-. Questa parola colpisce il doganiere. -Cosa significa podestà?
Forse Badogliano?-. al che mia madre di istinto -Certo sì badogliano-. E di nuovo il doganiere Allora cambia tutto, vado a telefonare a Berna-. Su queste battute, casuali e sconnesse si gioca il
destino di cinque persone. c’è la telefonata a Berna, la risposta è di non rispedirci in Italia, almeno
per il momento.... Di colpo, il doganiere si trasforma. Ci invita a rientrare, ci offre un brodo caldo,
ci consente di rilassarci: dopo ventiquattro ore stremanti e un mese di fuga. Inizia così il soggiorno
svizzero.”(31)
“Un capitolo a parte è poi quello che riguarda gli autentici privilegiati (industriali, membri
dell’aristocrazia, gente che aveva fatto fortuna grazie al regime fascista, o anche ex gerarchi o ex
funzionari fascisti), i quali disponevano dei mezzi necessari per vivere in alberghi di
30 Broggini, Testimonianza di Guido Levi, p.81.
31
Broggini, Testimonianza di Paolo Ravenna, p.83
86
lusso,…membri della famiglia reale, come ad esempio la principessa Maria José, alla quale le
autorità svizzere permisero di effettuare numerose visite nei campi di rifugiati militari,…”(32) lo
stesso discorso vale anche per la gente di fama internazionale (musicisti, scrittori, studiosi, medici
ecc..). Entrare nel paese è più facile anche per chi ha parenti di nazionalità svizzera, soci in affari o
amici importanti, questo perché si interviene di persona presso le gendarmerie e i comandi di polizia
riescono il più delle volte a fare accettare rapidamente lo straniero.
“Biscaglia lanterne, elmetti: “Vous êtes en Suisse!”;”Dieu vous bénisse”; ma al posto di guardia:
“Domani Via !”. Le scene di disperazione, di pazzia di mia madre e la decisione delle guardie di
rinviare solo il padre. Poi la telefonata ai Koch, finanzieri di Berna, e siamo stati accettati.”(33)
Dopo essere stati accettati, dopo le ore di sosta passate al posto di dogana (limitato “allo stretto
necessario” il contratto con la truppa, impedito invece quello con la popolazione) guardie o soldati
accompagnano i profughi nei centri di raccolta più vicini, aperti in genere in aule scolastiche di
località di confine. Lì inizia la trafila.
Per qualcuno invece l’accoglienza resta un miraggio o una conquista faticosa.
Molti infatti, una volta rifocillati, vengono rimandati indietro, o di propria volontà o accompagnati
il che voleva dire essere consegnati nelle mani dei fascisti o delle SS.
“.... -Tornate per conto vostro altrimenti vi mettiamo in mano ai tedeschi-...”(34)
Le disposizioni, in territorio svizzero, di respingere o ricondurre al confine senza indulgi qualsiasi
straniero che non abbia legami di parentela, al di qua della rete, furono emanate il 27 luglio del ‘43,
con la caduta di Mussolini, in controllo di una prevista ondata di fascisti al momentaneo sbando.
Furono successivamente rielaborate per profughi civili o militari il 14 agosto. Queste disposizioni,
aggiornate quasi di settimana in settimana, regolamentavano i modi di accoglienza e soprattutto chi
accogliere e chi no.
“Madri, bambini, anziani sono accolti; gli adulti devono cercare di rendere verosimile la loro
situazione di grave pericolo, come i politici, gli antifascisti. Gli adulti ebrei, invece, non
trovano
giustificazioni perché non sono considerati politici né ancora in pericolo: si vuole che per loro
valgano le leggi razziali italiane discriminatorie del ‘38 e in genere vengono rimandati tutti
indietro.”(35)
32 Cerutti, op. cit. , p. 220.
33 Broggini, op. cit., p.85.
34
Broggini, Testimonianza di Marcella Contini Myer, p. 90.
35 Broggini, op. cit., p. 91.
87
Il problema consisteva nel riconoscere subitamente chi era in pericolo o meno, la qual cosa era
complicatissima dato che ogni profugo aveva le sue buone ragioni di sentirsi minacciato dal regime
italiano e quindi di scappare. Comunque la legge Svizzera imponeva un tale comportamento e i
soldati al confine cercavano di eseguire gli ordini per quel che potevano. Alcune dichiarazioni o
scritti riguardanti questo tipo di politica adottata in Svizzera citano in questo modo: “-Ai posti di
frontiera le persone (non militari), Che hanno strette relazioni con la Svizzera possono essere
lasciate passare senza il visto, in particolare: 1. Le donne che già erano cittadine svizzere, e hanno
perduto la loro cittadinanza per matrimonio, con i loro figli; 2. Altri stranieri che hanno strette
relazioni con la Svizzera, in particolare quelli che hanno i genitori, il coniuge o i figli nella
Svizzera. Semplici relazioni d’ affari o lontani rapporti di parentela non bastano. 3. Gli stranieri che
possono rendere verosimile di correre un grave pericolo per la loro vita, devono essere notificati
telefonicamente dai posti di frontiera all’ ufficiale di polizia del Comando territoriale. Questo
dispone se possono essere lasciati entrare o se devono essere respinti.- AFB, n.2001 (d) 3, Bd. 319,
-Istruzioni relative ai profughi dall’ Italia-, Berna, 14 settembre 1943: -A richiesta, per evitare
malintesi, si comunica quanto segue: 1. Le persone (non militari) ammesse all’ entrata, giusta il
comma II devono naturalmente essere trattate come tutti gli altri profughi e consegnate alla polizia,
la quale le notifica, nel modo solito, all’ Uff.le di polizia del Comando territoriale per l’ invio a un
campo di quarantena-. Ivi, n.4001 (c) 1, 1941-51, Bd. 281, “Aggiunta”, Berna, 15 settembre 1943,
firmate “Rothmund”, comunicate al Comando dell’ esercito, servizio di sicurezza sezione di polizia,
comandi delle gendarmerie dei cantoni, direzione generale delle dogane e direzioni circondariali,
per conoscenza anche al capo di Stato maggiore dell’ esercito, direzioni di polizia di tutti i cantoni,
uffici cantonali di polizia degli stranieri, Divisione affari esteri del Dipartimento politico federale e
al Ministero pubblico federale.”(36)
“1) Tutti i profughi di sesso maschile, di età superiore ai 16 anni, devono essere respinti; 2) Per le
donne e i fanciulli continuano a valere le nostre istruzioni del 14-15/9/43; 3) Il rinvio oltre la
frontiera deve essere fatto sul luogo stesso del tentato varco; se ciò non è possibile i profughi vanno
condotti al posto d’ entrata più vicino e quivi respinti oltre il confine; 4) Le presenti istruzioni
saranno revocate non appena la situazione lo permetterà.- AFB, n. 4001 (c) 1, 1941-51, Bd. 231, Istruzioni relative ai profughi dall’ Italia-. Berna, 17/9/43.”(37)
Nonostante la legge contraria molti profughi tentano lo stesso di varcare il confine visto che per
molti rimaneva l’ unica via di salvezza. In queste tragiche settimane, appunto, molti furono i
respinti che un a volta tornati in dietro furono catturati e portati ad Auschwitz, molti però, e per
36 Broggini, op. cit., p. 382.
37 Broggini, op. cit., p. 382.
88
fortuna, dopo vari tentativi riescono a farsi accettare, così come accadde ai 95 scolari iugoslavi che
dopo vari tentativi giunsero in salvo passando il confine a piccoli gruppi. Con loro c’ erano anche
gli insegnanti e il bidello-segretario che fece la spola al confine ma che non fu accettato.(38)
“Della famiglia Polacco di Venezia hanno tenuto il nonno e il nipote marco Jarach, respinti invece i
genitori e il figlio Renzo di diciassette anni perché la legge diceva: -Può difendersi da solo-. E’ stata
una tragedia, congelati i piedi alla madre, sono tornati a Milano e sono rimasti chiusi in un
appartamento, vicino alla stazione centrale, nell’ intercapedine di un muro. Noi che eravamo su,
tramite Canevascini dopo tre mesi siamo riusciti a farli entrare.”(39)
Visto che la situazione si faceva sempre più pesante col passare dei mesi il governo svizzero, più
precisamente con Rothmund, il 13/12/43 comunica ai vari comandi di frontiera di non respingere
più gli ebrei. Interpretato in modo diverso da cantone a cantone questo messaggio finisce per
assumere il significato che il profugo resta a seconda della sua determinazione. In pratica rimane
solo chi si impunta e si oppone alla respinzione svizzera.
“Avvistammo un folto gruppo di persone che camminavano nella direzione opposta alla nostra;
dopo un primo istintivo moto di paura non fu difficile intuire che si trattava di profughi come noi,
ma che facevano il cammino inverso. Ci fermarono e in preda alla disperazione tentarono di
dissuaderci dal tentare la loro avventura, perché in Svizzera ormai non accettavano più nessuno ed
essi erano stati inesorabilmente respinti poche ore prima. Mio padre, ostinatamente, volle comunque
proseguire, nonostante che l’ impresa sembrasse ormai disperata e solo carica di pericoli. I miei
genitori conoscevano di vista alcune delle persone che componevano quel gruppo. Ci salutammo
tristemente, proseguendo ognuno per la nostra strada. Al ritorno in Italia, dopo la guerra, venimmo
a sapere che pochi minuti dopo il nostro incontro furono tutti arrestati dai tedeschi che stavano
rastrellando la zona e deportati. Nessuno di essi ritornò... Tra i nostri parenti respinti: Jolanda
Debenedetti (deceduta in Germania), Leonardo Debenedetti (sopravvissuto dalla deportazione ad
Auschwitz), Giorgio Tedeschi, padre di mia moglie (deceduto ad Auschwitz), Marcello Fiorentino e
Roberto Tedeschi (salvatisi in Italia).”(40)
“Pochi passi in un bosco, bagnati e intirizziti (era il 7 dicembre 1943), poi ci imbattemmo in una
sentinella che ci accompagnò al comando di Arzo... Là un ufficiale svizzero-tedesco, subito odioso,
non volle sentire né ragioni né suppliche, né pianti (miei), anzi mi allontanava con un piede quando,
38 Un episodio particolarmente significativo delle riuscite fughe in Svizzera, fu quello dei ragazzi ebrei di Villa Emma, in provincia di Modena. Dedichiamo a questa storia un breve
capitolo di approfondimento .
39 Broggini, Testimonianza di Tina Sonnino Polacco, p. 103.
40
Broggini, Testimonianza di Enrico Fubini, p.105.
89
inginocchiata per terra, lo supplicavo di tenerci in Svizzera e, dicendoci sgarbatamente che eravamo
degli impostori, ci rimandò in dietro scortati da sentinelle armate e sogghignanti.”(41)
In conformità alle varie disposizioni che per altro nel dicembre del ‘43 riconoscono che è
notevolmente aumentata la sorveglianza dei militi fascisti e tedeschi, e che respingere i fuggiaschi
diventa sempre più impossibile, le statistiche dal ‘43 al ‘44 danno 3349 ebrei ammessi, respinti
3344 nel ‘43 e 3986 nel ‘44, 1365 nel gennaio-maggio del ‘45. Tutti provenienti da nazionalità
differenti.
41 Broggini, Testimonianza di Liliana Segre, p.105.
90
I ragazzi di Villa Emma e la loro fuga in Svizzera
I “ragazzi di Villa Emma” erano un gruppo di centinaio di ragazzi, bambini e alcuni adulti, giunti in
modo fortuito nel modenese, tra il ’42 e il ’43.
Arrivarono in questa villa, divisi in due gruppi, il primo composto da 42 giovani tra i 9 e i 21 anni
ed una decina di adulti. Tutti di provenienza est-europea, come polacca, rumena e jugoslava. I
ragazzi erano tutti orfani perché i loro genitori erano stati portati nei campi di sterminio.
L’ultimo posto in cui si erano rifugiati era la Slovenia ed era proprio da lì che provenivano in questo
loro ultimo viaggio verso la salvezza. Sotto la pesante avanzata delle truppe tedesche, si cercò di
ottenere con urgenza il permesso di trattenere il gruppo sul suolo italiano. Furono dapprima tenuti a
Lubiana, per qualche mese, poi la DELASEM riuscì a portarli a Villa Emma. Questi permessi e
soprattutto questo cambiamento di rotta fu ottenuto dal Generale dei Carabinieri Giuseppe Picche,
che grazie anche a “numerosissimi altri salvataggi è stato recentemente insignito della medaglia
d’oro che l’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane ha riservato a coloro che si adoperarono per
aiutare ebrei durante l’ultima guerra mondiale”(1)
Per tornare al racconto di questi ebrei dirò che Villa Emma è un edificio di costruzione civile situato
a 10 km da Modena nei pressi di Nonantola in, una posiziona facilmente raggiungibile da diverse
città, all’incrocio di due vie nazionali; la strada del Brennero con la via Emilia.
Il secondo gruppo, circa cinquanta, arrivò nella primavera del ’43, erano ebrei profughi e orfani
prevalentemente croati, di età compresa tra i 4 e i 22 anni. La vita a Villa Emma non era quella che
gli altri ufficiali tedeschi credevano, tipo campo di internamento, ma anzi “la competenza di coloro
che furono chiamati a dirigerla, il dott. Umberto Jacchia di Milano e la dott.ssa Laura Cavaglione di
Genova, riuscirono a far si che nulla, né nella vita associata; né nell’ordine che si dovette dare aal
convenienza, ricordasse ai giovani, nemmeno lontanamente, un campo di concentramento”(2)
Assumendo così le caratteristiche di un collegio, di una comunità organizzata con la massima
perfezione possibile.
Durante i 14 mesi in cui si rifugiarono a Villa Emma oltre l’istruzione scolastica che si diede loro, si
cercò di impartirgli anche delle vere e proprie lezioni di pratica agraria tenute da una famiglia di
mezzadri, condotte sui campi adiacenti la villa. Queste lezioni per molti di loro saranno utili una
1 I. Vaccari,Villa Emma. Un episodio agli albori della resistenza modenese nel quadro delle persecuzioni razziali.,Istituto storico della resistenza,
1960, p. 20.
2 Vaccari, op. cit., p.22.
91
volta emigrati in Israele, dopo l’internamento in Svizzera, a stabilire rapporti di comune attività coi
locali.
Ma Villa Emma non era solo questo. La DELASEM, infatti, la fece diventare un centro raccolta di
medicinali e viveri raramente rintracciabili tra il ì42 e il ’43.
A questo proposito, secondo il dott. Jacchia, “la DELASEM aveva demandato ai giovanie ai
dirigenti della villa l’assistenza, cioè, agli ebrei stranieri internati nei campi di concentramento
dell’Italia centro-meridionale, con spedizione di medicinali, effetti di vestiario, viveri,
corrispondenza ecc. Per cui la vita del gruppo era radicalmente cambiata, e tutte le energie dei cento
ragazze degli adulti che li assistevano erano investite dell’umanissimo compito di assistenza e
solidarietà nei confronti dei fratelli confinati nei campi di concentramento.”(3)
Uno di questi campi di concentramento era il campo di Fossoli, in provincia di Modena, vicino a
Nonantola.
In questa atmosfera spirituale e materiale di attività, piombò, sul gruppo di Villa Emma, la tragedia
dell’8 settembre, e l’opera paziente ed appassionata dei dirigenti e la serenità relativa riacquistata
attraverso il lavoro e l’attività, furono distrutte d’un colpo. I primi che capirono cosa stesse per
succedere furono proprio i ragazzi, che essendo profughi stranieri, conoscevano già gli effetti del
potere nazista.
Tuttavia, per fortuna loro, i ragazzi di Villa Emma furono subitamente aiutati dai paesani, che
rischiavano la pena di morte.
“Riferisce il presidente della DELASEM : -IL gran cuore della popolazione emiliana, che nei 14
mesi precedenti aveva imparato la conoscere la tragedia di ognuno dei componenti di Villa Emma,
che si era prodigato con slancio e disinteressato amore per aiutare in ogni senso il gruppo e per
facilitarne la vita e l’attività, dette ancora una prova di bontà e solidarietà: in 24 ore tutti i
componenti di Villa Emma si trovarono ospitati e raccolti dai nonantolani entro un raggio di 10 km
dintorno alla villa-.”(4)
Moti, in pratica, furono coloro che diedero spontanea protezione ai giovani: dai mezzadri, che
avevano una certa libertà, ai braccianti; dagli artigiani alla gente agiata, persino i sacerdoti che
ospitarono gran parte dei giovani fra le loro mura (in un primo tempo insospettate).
“Ormai la resistenza alla sopraffazione e la ribellione all’ingiustizia e alla prepotenza era come un
dovere civile ed umano.”(5)
3 Vaccari, op. cit., p.24
4 Vaccari, op. cit., p.28
5 Vaccari, op. cit., p.28
92
Le ricerche da parte dei tedeschi, che per un pelo non trovarono i giovani a Villa Emma, si estesero
anche verso il seminario dove però un pacatissimo Mons. Pelati riuscì, con un abile giro di parole, a
non far entrare i tedeschi in chiesa e a garantire per l’innocenza di quelle mura.
Le ricerche dei giovani furono in futuro rese impossibili grazie ad una fitta rete di spie che avvertiva
non appena si avvicinavano le guardie ad un posto pericoloso, facendo così spostare i giovani da un
casolare all’altro.
Questa situazione andò avanti per qualche settimana fino a quando non si riuscì a far evadere, a
piccoli gruppi, tutti i giovani in Svizzera.
Per raggiungerla due furono le vie seguite: per la Valtellina, da Milano a Sondrio a Tirano; e per la
Brianza, da Milano a Erba.
“Prima di partire (alcuni vestiti da preti cattolici, con tonache e cappellini forniti da Don Beccari),
Ricevettero una falsa carta d’identità, indispensabile per gli innumerevoli controlli che venivano
effettuati durante il lungo cammino.”(6)
Alla fine della guerra si seppe che non uno dei cento e più ragazzi e degli adulti di Villa Emma
conobbe la cattura e la deportazione:
“Questo miracolo- dice il presidente della DELASEM- va indubbiamente attribuito per la massima
parte alla popolazione di Nonantola e dei paesi vicini.”(7)
Ora gli ebrei di Villa Emma sono stabiliti in America, in Inghilterra, in Israele. Qualcuno è tornato
con moglie e figli a rivedere i suoi salvatori di un tempo.
6 Vaccari, op. cit., p.31.
7 Vaccari, op. cit., p.40.
93
Carmela Mayo Levi
94
Carmela Mayo è nata Gradisca d'Isonzo (Gorizia), nella Venezia Giulia, nel 1914, da una famiglia
ebrea di estrazione borghese. Il padre era il discendente di ebrei sefarditi arrivati nell'Europa
orientale, nel XV secolo, dalla Spagna, in seguito alla Reconquista e alle persecuzioni
dell'inquisizione spagnola. La Signora Levi ricorda che nella famiglia del padre si parlava ancora
correntemente lo spagnolo.
Nel corso della 1° guerra mondiale, a causa dello spostamento del fronte di guerra sull'Isonzo, la
famiglia Mayo è costretta ad abbandonare la propria casa e la propria città; si trasferiscono a Torino
nel 1915, dove tra molte difficoltà di inserimento e difficoltà economiche, riescono a ricuperare un
livello di vita dignitoso.
Da bambina frequenta le scuole israelitiche, vive una vita serena, inserita pienamente nella sua città
d'adozione.
L'avvento del fascismo non ha ripercussioni sulla famiglia: "A casa mia non si parlava di politica,
mia madre era sempre affaccendata per allevare i tre figli(…)". 88 La ragazza cresce come tutte le
giovani del suo tempo, seguendo le regole dell'educazione fascista; è iscritta alle Giovani Fasciste,
partecipa alle adunate del regime: "Nel 1938 ero diventata una comune ragazza piccolo-borghese di
24 anni, impiegata, ligia ed ossequiente alle leggi dello Stato che pensavo facesse l'interesse di tutti
i cittadini". 89
Le leggi razziali e la campagna antisemita offendono profondamente Carmela Mayo: "Dunque io
ero una piovra, facevo parte della plutocrazia giudaica che viveva alle spalle del popolo italiano; io
che lavoravo dall'età di 14 anni e che mi ero fatta un minimo di cultura studiando alla scuola serale
e domenicale." 90
L'indignazione per la campagna diffamatoria contro gli ebrei la porta a restituire la tessera fascista:
"Le mie camerate coetanee mi guardarono stupite e una mi chiese:< Ma perché rendi la tessera?>
<Io sono ebrea- risposi- mi considerate straniera e nemica perciò mi tolgo dal partito > E me ne
andai." 91
88
Carmela Mayo Levi, "Anni difficili", in La Beidana,cultura e storia nelle valli Valdesi, Società di studi Valdesi, n16,
febbraio 1992, p.31.
89
Op. cit., p.32.
90
Op. cit., p.32.
91
Op. cit., p.33.
95
Mentre le difficoltà per la famiglia Mayo crescono con il montare della campagna diffamatoria
contro gli ebrei e con il susseguirsi dei provvedimenti razziali(il padre vende il negozio ed emigra in
Spagna per cercare di ricominciare; uno zio che lavorava all'aeronautica di Milano è licenziato da
un giorno all'altro), l'Italia entra in guerra e la Signora Levi ricorda con tristezza tutta quella gente
che, in Piazza Castello, applaudiva al discorso del Duce trasmesso con gli altoparlanti.
Carmela Mayo continua il suo lavoro nel negozio di articoli per disegno, in Via Mazzini ("I miei
principali mi stimavano e non pensavano di licenziarmi" 92 ), dove casualmente fa conoscenza con
Mario Levi, più grande di lei di 16 anni, con cui inizia una corrispondenza e un' amicizia, che
sfocerà nel fidanzamento. Mario Levi (vedi nota 6 p.2) fu sicuramente una guida per la giovane
Carmela, una guida politica che la portò a maturare quella coscienza antifascista che già si era
espressa con il suo rifiuto di appartenenza al partito.
Dopo l'8 settembre la loro vita prende una svolta: il matrimonio e la fuga sulle montagne per seguire
l'unica scelta che il marito, comunista e antifascista da sempre, poteva fare, quella di combattere il
nazifascismo.
A Rorà, nella Val Pellice, i coniugi Levi sono entrambi attivi nella Resistenza. Carmela con grande
coraggio, accetta senza esitazione di fare la staffetta e portare a Torino, quasi settimanalmente, i
comunicati dei partigiani, per tenere i contatti con il C.L.N. torinese. I rischi che corre sono
altissimi: lei, ebrea, partigiana, riesce a passare ogni volta i posti di blocco con la sua preziosa
borsetta sotto il braccio e a portare a termine così un incarico delicato e importantissimo per la
resistenza.
Oggi la Signora Levi racconta di quelle sue "imprese" con tranquillità, e a noi che, spaventati per i
rischi che correva, le chiediamo:" Ma non aveva paura?", lei risponde: "Ma bisognava fare
qualcosa!" e poi quasi per farci contenti nei nostri timori, lei conclude:"Sono stata sempre molto
fortunata!"
Abbiamo intervistato la Signora Levi nella sua casa di Torino, il 22 febbraio 2001.
D.: Sig.ra Levi, quanti anni aveva nel '38?
Io sono nata nel '14, dunque nel '38 avevo 24 anni. Io lavoravo, ero impiegata. Ho visto i giornali
che insultavano gli ebrei, la piovra giudaica, i manifesti per le strade, hanno licenziato tanti dai
posti di lavoro…Io lavoravo in una ditta, ma era una ditta privata, che mi conosceva da tanti anni, e
mi diceva:"Signorina, non dica niente!", loro non mi hanno licenziata.
92
Op. cit., p.34.
96
Quando è scoppiata la guerra, io mi ricordo che c'è stato il discorso di Mussolini a Roma, che è
stato trasmesso in tutta Italia con gli altoparlanti, e in Piazza Castello han detto "Noi dichiariamo la
guerra alla Francia e all'Inghilterra, noi vinceremo"…e mi ricordo che hanno applaudito. Perché
Mussolini era riuscito a conquistare la gente, i giovani specialmente. Anch'io, con la scuola ero una
giovane fascista, perché nella scuola c'era quello, c'era la palestra, le sfilate, e uno seguiva la
corrente. Poi quando mi son sentita fare i discorsi la piovra giudaica, noi vi schiacceremo, io mi
sono sentita stupita, offesa; siamo cittadini come gli altri, avevamo lavorato come gli altri, avevamo
fatto ognuno il proprio dovere.(…)
[Dopo l'8 settembre] hanno incominciato ad arrivare le truppe tedesche. Ho visto quel giorno(…)
quando è arrivata la truppa tedesca, perché io abitavo vicino a Porta Nuova, ed ero combinazione
con mia sorella, attraversavamo Corso Vittorio all'altezza di via Nizza, ed è arrivata la colonna
tedesca, con i carri armati, che sparava sulla gente: dovevano tutti attraversare il Corso con le mani
alzate.(…)
I generali se ne sono scappati, e i soldati, poverini, si sono trovati senza guida; i Tedeschi sono
arrivati e prendevano la gente, perché avevano bisogno di uomini (…) e io mi ricordo che lavoravo
in un negozio di articoli per disegno, in Via Mazzini,… è arrivato di corsa un giovane :" Presto, ci
sono i Tedeschi che rastrellano", e allora è entrato dentro da noi; era un soldato e allora lo abbiamo
fatto passare dal retro, si è tolto la giacca da militare, gli abbiamo dato un camice da lavoro e lui è
passato da dietro ed è scappato.
È incominciato da allora a formarsi le prime formazioni partigiane: perché questi giovani, per non
essere presi, andavano verso le colline.(…)
Io allora conoscevo mio marito[ Mario Levi] 93 . Lui era un vecchio antifascista: era stato studente di
ingegneria, al politecnico di Torino. Lui era stato arruolato nella 1° Guerra Mondiale, a 19 anni, e
dopo gli orrori della guerra, che lui raccontava,(…) è tornato proprio disgustato dalla guerra. Si era
iscritto allora al Partito Comunista e ha fatto sempre propaganda contro la guerra.(…)
93
Mario Levi, nato a Torino nel 1898 da una tradizionale famiglia ebraica borghese, è studente del Politecnico quando
viene chiamato a combattere sul fronte della 1° guerra mondiale. Il contatto con i soldati, la tragica realtà della guerra,
gli fanno capire le ingiustizie sociali, e dopo la tragica ritirata di Caporetto, diviene antimilitarista.
Al ritorno dalla guerra aderisce al Partito Socialista e collabora con i compagni di Ordine Nuovo (Gramsci, Terracini)
nell'intento di preparare il movimento di occupazione delle fabbriche. Arrestato e condannato nel 1920 per incitamento
alla rivolta, scontati due anni e mezzo di carcere, finisce gli studi in Belgio.
Rientrato in Italia nel '27, è sempre sorvegliato perché sospettato di antifascismo. Nel '40 viene mandato al confino in
Abruzzo come ebreo politico antifascista, da cui torna nel '43. Sposatosi con Carmela Mayo, dopo l'8 settembre fugge
sulle montagne sopra Lucerna, a Rorà, dove inizia un'attiva opera di resistenza. Fu rappresentante del Partito Comunista
nella formazione partigiana e nel locale C.L.N.
Attivamente impegnato nella politica anche dopo la guerra, fu segretario del primo Sindaco Comunista di Torino,e
lavorò alla ricostruzione della città distrutta dalla guerra. Continuò la sua attività politica nella sezione comunista
centro; il suo impegno fu sempre rivolto ai problemi della pace e del disarmo e alla coesistenza pacifica.
97
Io l'ho conosciuto per caso. Lui era confinato in Abruzzo (..) ed era venuto in licenza a Torino,
perché aveva il padre che era vecchio ed era malato; e allora è venuto nel negozio dove lavoravo io,
per comperare un decametro. Abbiamo chiacchierato, lui mi ha detto che era confinato, e poi
quando è poi tornato là, ci siamo scritti: facevo la madrina di guerra! C'era mio fratello che mi
diceva: "Ma cosa scrivi ad un confinato politico?". Io continuavo a scrivere, e quando c'è stato il 25
luglio, la caduta del fascismo, lui è stato liberato e allora è venuto a Torino e abbiamo continuato la
conoscenza.
È poi diventato pericoloso perché c'è stato l'8 settembre e lui mi dice,"Scappiamo insieme", ma
allora c'era un'altra mentalità.… e io volevo sposarmi.
Il Tempio a Torino era già stato bombardato: perché qui a Torino c'erano i bombardamenti,
suonavano le sirene, bisognava correre, andare in cantina. E il Tempio è stato tutto incendiato: e io
che abitavo in Via Pio V, mi ricordo quella sera siamo andati in un rifugio, e attraversando la strada
ho visto le fiamme di fuoco che uscivano dalle finestre: sembrava una cosa apocalittica!
E allora abbiamo deciso di sposarci: c'era un Rabbino giovane che ci ha fatto un matrimonio così,
alla svelta.(…) Io mi sono sposata il 28 novembre del '43: per le nozze avevo invitato mia sorella,
che era venuta giù da Coazze, mio fratello, lui era ricoverato all'ospedale di Cuorgné, poi c'era una
cugina di mio marito, eravamo in quattro o cinque. Poi abbiamo
chiuso casa, e mi hanno
accompagnato tutti alla stazione di Porta Nuova. Quando mia mamma è tornata a casa, la portinaia
la chiama, e le dice:"Sono venuti i carabinieri per prenderli!"; e allora ha fatto che non fermarsi più
a casa, e con mia sorella sono andati a Coazze.(…)
E poi siamo andati in montagna, siamo andati nelle Valli Valdesi, perché quelle valli sono molto
aperte, perché loro sono stati perseguitati; tant'è vero che nessuno ha fatto la spia, c'erano tante
famiglie ebree in quel posto.
Noi siamo andati a Rorà. Rorà è un paesino a 1000 metri, in montagna; è un paese che confina tra
Luserna e la Val Pellice.(…)
D.: Chi vi ha accolto, che collegamenti avevate?
Noi siamo andati con le carte false. Qui a Torino c'era un tipografo, mi ricordo sempre, Castagnole,
che dopo aver lavorato, chiudeva, e di notte faceva le carte false per i compagni, per altri.
D.: Le faceva a pagamento, oppure come un favore?
No, no, questo qui era un compagno, che faceva le cose con passione, per aiutare quelli che non
andassero in carcere e non fossero presi.(…)
Allora noi ci siamo sposati e siamo andati all'albergo Malan, di Torre Pellice; in viaggio di nozze,
Torino, Torre Pellice!… in piedi, su quei carri bestiame.
98
Questo qui della pensione Malan, conosceva mio marito e sapeva che si chiamava Levi; lui gli
presenta le carte false e allora lui ha detto:"Guardi, io non lo registro, potete stare questa notte, poi
se ne vadano."
Il giorno dopo abbiamo fatto i bagagli, mi son messa gli scarponi, lo zaino e abbiamo detto,
andiamo su, cercheremo delle cascine.
Abbiamo trovato un uomo con un carretto per la strada, e abbiamo chiesto, senta, sa che ci sia un
appartamento, qualcosa, un alloggio?. E lui ha detto :"Io ho una casa lassù, se lei vuole gliela
affitto". E allora abbiamo fatto tutta la strada da Lucerna su a Rorà, ci sono 14 chilometri, tutti in
salita, a piedi.
D.: Lui non ha chiesto: siete ebrei, da dove arrivate…?
Abbiamo fatto vedere le carte false e non abbiamo detto niente!(…)
Lì mi sono sentita una signora, proprio, perché a Torino non si trovava più niente: con la guerra ci
davano un etto e mezzo di pane al giorno, ma era un pane… dicevano pane di segatura; e poi la roba
non si trovava.(…)
Quando mi sono sposata, avevamo fatto un piatto unico, tagliatelle, ed era una festa; perché
mancava tutto!
Quando sono arrivata lassù c'erano le patate, le castagne, le mele; abbiamo comprato delle galline,
io ho fatto la massaia rurale, avevo i conigli, avevo un piccolo orto…Sono stata lì dal '43 al '45.
Però noi lì non pensavamo di non far niente: perché mio marito era un compagno, e man mano che
passava la guerra venivano su questi giovani, perché a Torino c'erano i rastrellamenti.
A Torino ormai i Tedeschi avevano occupato tutta la città, le caserme, e ogni tanto chiudevano un
isolato e prendevano i giovani, per portarli in Germania a lavorare.(…)
E allora lassù a Rorà un po' per volta si è formata la 105° Brigata Garibaldi.(…) A Torre Pellice
c'era Giustizia e Libertà, quella di Emanuele Artom, e poi c'erano degli altri autonomi.(…)
E lì mi hanno dato l'incarico di tenere il collegamento.
Le donne non combattevano, almeno lì non c'erano donne combattenti, ma le donne sono servite
molto, perché a parte per portare i viveri,(…) e poi, mi ricordo, anche le donne del posto andavano
su, lavoravano, facevano delle padelle così di patate fritte…e patate, castagne, mele, quello ce
n'era!
E poi facevano dei piccoli gruppi, cercavano di organizzarli, in modo che non fossero banditi;
facevano l'ora politica, facevano le istruzioni, perché c'erano degli ufficiali. Perché tanti ufficiali
sono scappati perché non volevano stare con l'esercito tedesco, non c'erano soltanto dei ragazzi
sbandati.
99
E poi, nella trattoria, avevano dietro una radio, e allora c'era chi teneva il collegamento con radio
Londra, per sapere anche il movimento delle truppe. Mi ricordo, venivano anche a casa nostra alla
sera, questi partigiani, e mio marito apriva la carta geografica dell'Europa, e si sentiva il giornale
radio, e si guardava il movimento delle truppe. Perché c'è stato un momento che la Germania aveva
occupato tutta l'Europa!
Chi aveva un pochino di coscienza, diceva, bisogna fare qualche cosa!
E mio fratello mi diceva, ma sei matta!
Mi davano dei comunicati: a Torino c'era il Comando che si era formato, il Comitato di Liberazione
Nazionale, e cercavano di potere collegare tutti per poter fare qualche cosa di importante. E
bisognava tenersi in collegamento.
Allora mi davano dei documenti, e io avevo una borsa che avevo fatto doppio fondo, cioè avevo
aperto la fodera, mettevo la roba dentro alla fodera che andava a finire sotto. Perché si passava il
posto di blocco…
D.:Allora lei veniva a Torino?
Io venivo a Torino per far questo, da Rorà scendevo a Luserna e poi prendevo il treno; e certe
volte(…)prendevo il camion della Tessitura 94 che portava le pezze di stoffa a Torino. Si vede che
sapevano, che collaboravano…
Però dovevo passare il posto di blocco, dove c'era il Dazio. E c'erano i Tedeschi.
Facevano scendere tutti e guardavano se c'era qualcosa…; avevo la borsa, e mi dicevano, c'è
qualcosa? E io aprivo la borsa, avevo i documenti falsi…vedevano una ragazza, bisognava essere
un po' disinvolti, fare magari un sorriso.
D.: Quante volte ha fatto questo percorso?
Venivo giù una volta alla settimana. E mi è sempre andata bene.(…)
Io avevo gli appuntamenti; mi dicevano, quando partivo, guarda, devi trovarti, per esempio alla
fermata del tram…ci sarà Vittoria. Ci si chiamava solo per nome, io ero Carmela e basta.
Un'altra volta ho avuto l'appuntamento con Ludovico Geymonat, che anche lui faceva parte della
nostra brigata, lui era Commissario politico. Mi avevano detto, al caffè Platti, vicino alla porta di
ingresso dove c'è il corso Re Umberto; e allora lì, al tavolino, cerchi di fare, insomma,…come un
appuntamento. E allora è arrivato lui e ci siamo scambiati i documenti…ma si stava un momento.
Andavo via, mettevo la roba di nuovo nella mia borsa, e poi tornavo su.(…)
Il 21 marzo del '44 c'è stata una grande battaglia.
I tedeschi avevano preso stanza a Lucerna dove c'è la caserma. La caserma dove hanno torturato
Emanuele Artom. Perché Emanuele Artom io l'ho visto lì, perché lui faceva parte dei G.L., solo che
94
La Ditta Mazzonis
100
noi eravamo nel versante di Lucerna, loro erano nel versante di Torre Pellice; e una volta era venuto
anche a casa nostra (perché io Emanuele Artom lo conoscevo già da prima), e quella volta che è
venuto ha detto:"Oh, la tovaglia e la tavola apparecchiata!", perché loro come partigiani vivevano
nelle baite e nei fienili. I contadini avevano paura di ospitarli, perché dicevano, se vengono, che non
mi brucino la casa…e ne han bruciate tante! A secondo, magari c'era qualcuno che poteva pagare e
allora aveva magari una casa migliore…
Il 21 marzo del '44 è incominciata la battaglia95 : il posto di blocco era al Ponte Vecchio. Il ponte era
sulla strada che porta su a Rorà, e i partigiani hanno fatto saltare il ponte. I Tedeschi con le Brigate
nere, le brigate nere che erano al servizio dei Tedeschi, i Tedeschi ordinavano: lì hanno fatto segare
degli alberi, gli alberi li hanno messi sopra la strada che avevano fatto saltare e loro son passati
sopra con il carro armato. Sono arrivati fino a Rorà, sono entrati in tutte le case, son arrivati fin sulla
piazza, cercavano gli uomini. C'era Don Ettore, un bravo prete, giovane, che è andato incontro a
questi Tedeschi e gli ha detto:"Ma qui, non ci sono partigiani", ma i Tedeschi non gli han dato retta,
e sono andati in tutte le case lo stesso. I partigiani si erano nascosti, e loro sono andati da tutte le
parti.
Sono venuti anche a casa mia, a mio marito ho messo un fazzoletto legato [in testa], ho detto che
era malato, e si vede che han visto che non era un ragazzo tanto giovane, aveva già più di
quarant'anni, aveva la barba lunga, come fosse malato, e allora l'han lasciato stare. Però han
cominciato a girare in tutte le stanze, han fatto razzia di tutte le cose, io avevo una collana sopra al
comò, l'han presa, han preso la macchina fotografica. Sono andati in tutte le case, han portato via i
formaggi, i salami, le galline, i conigli. E poi sono andati in trattoria a farseli cuocere e a mangiare.
E poi, le case dove pensavano che c'erano dei partigiani, hanno dato fuoco alle case.(…)
Poi hanno chiamato gli uomini che c'erano lì e hanno detto che dovevano portarli dove c'erano i
partigiani; li han fatti mettere in fila, con il fucile dietro puntato; ma nessuno li ha portati alle sedi,
perché non c'è stato nessuno che abbia fatto la spia.(…)
95
Rorà era zona libera e si era formata un'amministrazione democratica. Il 21 marzo 1944 un pesante rastrellamento
dell'esercito tedesco guidato dai repubblichini mette a fuoco la cittadina, i partigiani la difendono strenuamente poi si
ritirano in alta montagna subendo delle perdite. " Tutta la popolazione venne poi allineata lungo il muro del cimitero e
ad ognuno venne chiesto dov'erano i banditi, poi chiusero tutti nelle due aule della scuola (…).
Al mattino mandarono le donne a casa a preparare da mangiare e gli uomini vennero radunati in piazza. (…)
Formarono un gruppo di uomini con i quali andarono a prelevare le mucche nella stalla e le caricarono sui camion; un
altro gruppo di uomini doveva portare i Tedeschi alle basi dei partigiani. Caricarono le armi e le munizioni sulle spalle
di alcuni e mettendo i montanari davanti intimarono di andare.(…) I tedeschi bruciarono una sessantina di case della
zona e fecero alcuni prigionieri (tra i quali Emanuele Artom e Geo Levi).
Nessuno aveva fatto la spia! Nessuno aveva portato i Tedeschi alle basi, nessuno aveva tradito i partigiani." (da "Anni
difficili" di Carmela Mayo Levi, in La Beidana, cultura e storia nelle valli Valdesi, Società di Studi Valdesi, n.16,
febbraio 1992.)
101
Poi i 25 aprile abbiamo sentito suonare le campane da tutta la vallata, tutte le chiese suonavano le
campane, finalmente è finita! E allora tutti sono scesi giù, tutti che ballavano(…) perché finalmente
era finita, certo che è durata tanto!
102
Comunicati partigiani che fanno riferimento alle azioni nella val Pellice (da: La Battaglia di
Pontevecchio edito da: Comune Luserna S. Giovanni 1984)
103
La firma “Luca” è il nome di combattimento di Ludovico Geymonat.
104
Renzo Segre
105
Il diario di Renzo Segre 96 va inserito, a gran titolo, negli scritti di memoria di ebrei perseguitati in
Italia: ma non solo perché è la storia di un uomo,che insieme alla moglie, ha subito le nefandezze
della persecuzione razziale.
La sua storia vale la pena di essere raccontata e ricordata per esteso, perché insieme ad essa si
seguono i tragici eventi degli ultimi due anni di guerra, e quelli di un'umanità allo sbando, da cui
però, in mezzo alle tante brutte immagini di uomini e donne che tradivano, si ergono alcune figure
umane altissime, di coloro che hanno aiutato.
È il caso, in questa storia, dell'anziano "professore" che da direttore della clinica psichiatrica, è
riuscito a nascondere coloro che, come i coniugi Segre, avevano bisogno di tutto.
Ma alla fine del diario, scopriamo l'alta, grande umanità di quest'uomo, che aveva rischiato la sua
vita difendendo con i denti, in via Asti a Torino, la falsa identità dei coniugi Segre, senza mai
svelare loro il pericolo mortale che essi avevano corso, se non a liberazione avvenuta.
La delicatezza del suo silenzio, verso chi ormai aveva perso qualunque identità ed equilibrio
mentale, è ancora più grande, se questo fosse possibile, del suo gesto di estremo coraggio ed
altruismo.
È per questo che la storia di Renzo Segre è un po’ la storia di tutti, ma soprattutto di chi ha aiutato
gli altri a salvarsi, senza chiedere nulla, anche a rischio concreto della propria vita.
Il Diario di Renzo Segre é la storia di un uomo che per sfuggire alla deportazione, si rifugiò in una
clinica psichiatrica con la moglie, dove rimase per quasi due anni, venti mesi appunto, fingendo di
essere un malato mentale e vivendo nella costante paura di essere scoperto e deportato.
Questa devastante esperienza lo segnerà per tutta la vita e, come dice la figlia Anna, la sua vita
successiva fu caratterizzata da un “perenne stato di depressione e di ansia per il futuro”97 . Per capire
cosa ha cambiato la psiche di quest’uomo, basta ripercorrere la sua vita dagli ultimi anni della
dittatura fascista passando per l’occupazione tedesca, la Repubblica Sociale Italiana e il lento
evolversi dell’avanzata alleata dall’Italia meridionale che dava la falsa speranza di una liberazione
imminente a chi viveva nell’angoscia e nel dolore.
Renzo Segre nasce a Casale Monferrato nel 1909. Di famiglia ebrea, si laurea a Torino e nel 1935,
si trasferisce a Roma per lavorare nell’ufficio economico della Confederazione dei lavoratori
dell’Industria. Tre anni dopo, la sua vita, fino a quel momento normale, viene investita dalle leggi
razziali, e dopo essere stato licenziato in quanto ebreo va a vivere a Biella dove, per cinque anni,
96
97
Renzo Segre, Venti mesi, Sellerio, 1995.
Op. Cit., p.
106
lavora in una ditta privata di commercio all’ingrosso di tessuti, che era tenuta dai fratelli della
moglie.
Il colpo di stato del 25 luglio 1943 con l’arresto del capo del governo e lo scioglimento del partito
fascista fu salutato con le lacrime, ma l’annuncio dell'armistizio dell’8 settembre, del maresciallo
Badoglio, ebbe invece una gioia piuttosto contenuta in quanto vi era la consapevolezza che i
tedeschi avrebbero occupato il paese, cosa assai probabile, e si sarebbero comportati da padroni
assoluti e sarebbero cominciati “arresti, deportazioni, torture, campi di annientamento, pazzia,
morte lenta per inedia o per assassini: ecco quanto spettava a noi, ai nostri genitori, fratelli, figli, se i
tedeschi avessero prevalso” 98 .
Il 10 settembre cominciarono a circolare le voci circa una colonna tedesca che si stava avvicinando
alla città, con l’intenzione di occuparla. Lo sbandamento del nostro esercito, che non lasciava
speranze di resistenza armata all’occupazione tedesca, fecero presagire il loro imminente arrivo e,
come avevano fatto in altre città straniere, la persecuzione e la deportazione degli ebrei. Allarmati
da queste notizie, i coniugi Segre decisero di spostarsi in un paesino in provincia di Biella, dagli
anziani genitori di lei; ma arrivarci fu un problema visto che non si trovava nessuno disposto ad
accompagnarli in auto “già si sentiva per aria, forse, la preoccupazione di poter essere accusati di
aiuto ai predestinati al sacrificio” 99 . Seguiranno due giorni di continui spostamenti tra Biella ed il
paese dove vivevano i genitori di Nella, così si chiamava la moglie di Renzo, fino a quando il 13
dello stesso mese, dopo una notte ospiti di un parroco, i coniugi Segre arrivarono al santuario di
Graglia dove furono ben accolti dal rettore e dove capirono subito di non essere i soli ospiti; infatti
la sera, a cena, scoprirono che vi erano sei o sette giovani, che si rivelarono poi essere ufficiali che
avevano abbandonato l’esercito regio e che stravano formando una delle prime formazioni
partigiane.
La vita nel santuario scorreva lenta e piena di paure, viste le sempre più insistenti voci di arrivo di
reparti tedeschi che si rivelarono infondate ed andarono ad alimentare la crescente paura ed
insicurezza nel futuro. La notte del 24, dopo la notizia del transito di un folto gruppo di tedeschi da
Biella, diretti verso le montagne vicino al santuario, Renzo Segre e la moglie decisero di andare a
passare la notte dai genitori di lei. Il viaggio fu tormentato anche se “era breve il tragitto, ma quanta
ansia! Ad ogni svolta si temeva di incontrare il nemico” 100 . Il giorno dopo, 25 settembre, i fratelli
della moglie, Aldo e Italo Morelli, comunicarono alla famiglia la loro decisione di tentare l’espatrio,
ritenendo che il momento fosse propizio, come forse non lo sarebbe più stato. I loro genitori
98
Op. cit., p. 28
Op. cit., p. 29
100
Op. cit., p. 34
99
107
accolsero l’annuncio con sufficiente forza d’animo, forse anche perché illusi che il distacco sarebbe
stato di breve durata, e anche perché le persone anziane, meno al corrente dei giovani di ciò che gli
ebrei avevano passato negli altri paesi precedentemente occupati, non avevano il senso del pericolo
imminente nelle sua spaventosa completezza. Questo episodio fece ricordare a Renzo il suo ben più
tragico distacco dal fratello Giuseppe, che dopo le leggi razziali nel lontano 1938, era emigrato con
la sua famiglia in Marocco.
Tornati nel monastero di Granaglia il 28 settembre, la loro prima preoccupazione fu quella di
studiare un piano di fuga, nella possibilità di un rastrellamento nel monastero, cosa che sembrò
alquanto semplice vista la conformazione del monastero; ma la realtà era ben diversa, e se ne
accorgeranno presto, perché non conoscevano la metodicità e l’efficienza tedesca nei rastrellamenti.
La vita al monastero trascorse tranquilla e monotona fino alla fine del 31 settembre quando, alle 8
del mattino, Renzo e la moglie furono svegliati da un gran vociare nel corridoio e dal tentativo di
aprire la porta della loro camera chiusa dall’interno. Non ci volle molto per capire che era un
rastrellamento tedesco. Dal di fuori, nel corridoio, si sente un continuo rumorare di chiavi, per
tentare di aprire la loro stanza, che si mischia a urla in tedesco. La fine sembrava ormai imminente
fino a quando non si sente la voce del rettore che, che spiegando ai tedeschi che nessuna chiave
andava bene per quella porta, ordina ad un suo uomo di andare a cercare quella giusta: un’abile e
pericolosa mossa fatta dal rettore per cercare di distogliere l’attenzione tedesca da quella porta che
lui sapeva bene essere stata chiusa da loro dall’interno. Le sei ore successive, che parvero giorni se
non mesi, trascorsero nella consapevolezza di essere rimasti soli e completamente nelle mani di
Dio. Quando li vennero ad avvertire che finalmente potevano aprire la porta, videro tutte le porte
delle altre stanze del lungo corridoio lasciate spalancate a prova dell’avvenuta perquisizione e che
solo la loro era rimasta chiusa. Chissà per quale arcano motivo i tedeschi, così metodici e precisi,
non erano tornati per aprire quell’ultima porta.
Il rastrellamento all’interno del santuario durò fino alle 14, quando finalmente gli automezzi presero
la via opposta da quella da cui erano arrivati. Ora il loro compito era quello di incendiare le baite
indicate da due delatori, come deposito di armi destinate ai nascenti gruppi partigiani. Il terrore dato
dal rastrellamento è tale che la perpetua del santuario minaccia dimissioni immediate.
“Anch’io darei volentieri le dimissioni, ma più radicali, dimissioni da uomo, dimissioni da
appartenente a questa abbietta razza umana, a cui appartengono anche i due giovani traditori, partiti
naturalmente con i tedeschi, dopo l’orribile misfatto compiuto contro la Patria, contro i compagni
fiduciosi, contro il gruppo di casolari che generosamente li ospitava; dimissioni da questa belluina
108
razza umana, cui appartengono anche i tedeschi, che, su ordine dei loro capi, uccidono, incendiano,
distruggono, con automatismo di fantocci, con ferocia di tigri” 101 .
Trascorsero altri due mesi ed i coniugi Segre decisero di lasciare quel loro rifugio: ormai
l’amministrazione non li vedeva più di buon occhio e la paura di nuovi rastrellamenti era sempre
più forte. Questi due mesi però non furono segnati da una clausura completa, ma da sempre più
frequenti uscite, seppur furtive, con lo scopo di andare a trovare gli anziani genitori di Nella, di
recuperare qualche indumento pesante o oggetto d’uso quotidiano dalla loro casa, in cui per timore
d’essere presi, bisognava entrare come ladri. Bisognava anche cercare una nuova sistemazione da
sostituire al loro ormai precario rifugio. Molte idee furono scartate, perché comportavano la
vicinanza a persone conoscenti che avrebbero potuto tradirli.
La scelta cadde su un ospedale psichiatrico di San Maurizio Canavese, in provincia di Ivrea, il cui
direttore, definito buon patriota, era amico di un medico che fino ad allora li aveva aiutati. Sistemati
gli anziani genitori di Nella in una clinica del posto, la mattina del 1° dicembre, i coniugi Segre
lasciarono il santuario dopo aver salutato tutti quelli che fino ad allora li avevano aiutati, ma senza
rivelare loro, per prudenza, il loro nuovo rifugio.
Il viaggio fu un problema: oltre a dover lasciare tutti i loro averi nel santuario, la macchina presa a
noleggio (dal medico loro amico che gli aveva trovato quella nuova sistemazione) li poté
accompagnare solo fino al limite della provincia di Biella, visto che il permesso di circolazione si
limitava a tale provincia. Il viaggio proseguì in autobus fino a Torino e da qui in treno fino a San
Maurizio Canavese. Il medico loro amico che li aveva accompagnati fin lì, dopo aver parlato con il
direttore, si congedò e così Renzo e Nella, dopo essere stati registrati con i nomi dei documenti falsi
che si erano procurati agli inizi del loro soggiorno nel santuario di Granaglia, vengono
accompagnati alla camera che era stata assegnata loro.
Ormai Renzo era un malato di mente con crisi nervose, che gli avvenimenti fin lì sopportati non gli
rendevano difficile simulare: “il tetto della clinica ci proteggeva come una capanna di frasche può
riparare da un ciclone, come ad un animale inseguito un arbusto fa da schermo ai cani inseguitori: la
capanna poteva essere involata nel turbine, i ci potevano azzannare mortalmente in qualunque
momento, mentre dormivamo, mentre mangiavamo, mentre parlavamo, nell’istante stesso in cui
potevamo crederci più riparati” 102 .
Nel secondo giorno di "degenza" sorgono già i primi problemi: in assenza del direttore, Renzo e
Nella vengono chiamati nell’ufficio della clinica per la consegna delle carte annonarie 103 (di cui
101
Op. cit., p. 44
Op. cit., p. 57-58
103
Documento personale che da' diritto a particolari generi razionati, per cause di guerra
102
109
naturalmente erano sprovvisti); ma la loro falsa residenza, Potenza (secondo i documenti falsi) li
aiuta a dilazionare la consegna e a salvarsi, almeno per il momento.
Altro problema presentatosi nei primi giorni è il vedere che due loro correligionari, che già erano
presenti in clinica prima del loro arrivo, sono consigliati dall’amministrazione di andarsene, in
quanto l’autorità repubblichina ha invitato la clinica a presentare un elenco degli ebrei degenti.
Il 28 dicembre sembra il giorno della fine del sogno, quando due ufficiali tedeschi, accompagnati da
un italiano, presentano un ordine di requisizione della clinica con tutta la sua attrezzatura a favore di
un reparto di paracadutisti: i degenti devono essere sgomberati entro 48 ore. Il giorno 30, dopo due
giorni di peregrinazioni tra uffici torinesi, torna alla clinica il direttore con la sospensione
dell’ordine di requisizione che poi si trasformerà in revoca.
L’anno nuovo inizia con un lume di speranza: da Radio Londra Churchill ha parlato più volte delle
idi di marzo come data per la fine della guerra, gli animi si rinfrancano e si è sempre più determinati
ad andare avanti resistendo a tutte le difficoltà.
I giorni passano e la vita dentro la clinica, come d'altronde fuori, è sempre più difficile; oltre alla
paura di essere scoperti, ora si aggiunge anche quella di essere catturati ed uccisi in rappresaglie
fasciste, in seguito alle sempre più pesanti operazioni dei partigiani che si nascondono in montagna.
La paura delle rappresaglie si aggiunge all’attesa snervante piena di ansie che ne deriva e che logora
i nervi. La paura inoltre va aggiunta all’angoscia, l’angoscia di non avere più notizie dei propri cari,
l’angoscia di non essere loro vicini nei momenti difficili, insomma il senso di impotenza verso gli
eventi.
Ad alleviare questo peso ci pensa il professore direttore della clinica che, vista la loro spasmodica
ansia causata dalla mancanza di notizie e dalla rottura di ogni collegamento, decide di partire alla
ricerca di notizie dei loro cari. Dopo due giorni il professore torna con buone notizie: i loro genitori
stavano bene ed erano “collocati” ed inoltre il professore aveva predisposto un collegamento con il
nipote di Renzo ed il fratello di Nella che a giorni si sarebbero recati, essendo muniti di buoni
documenti falsi, nella sua casa di Torino dove ci sarebbe stato lo scambio di notizie tenendo però
sempre segreta la collocazione delle parti. Oltre alle buone notizie il professore ha portato anche
alcune valigie piene di indumenti e vettovaglie che i coniugi Segre avevano dovuto abbandonare al
santuario di Graglia nella loro frettolosa partenza: “è come se ci fosse giunto un pezzo di casa
nostra, perduta, forse per sempre. Ogni indumento, ogni oggettino, anche se insignificante come
valore, ci rallegra e rende meno sconsolata la nostra clausura” 104 .
Nella, al suo ritorno da Torino, dove si era incontrata a casa del professore con il nipote di Renzo,
informa Renzo che i suoi genitori sono ospitati da qualche parente a San Damiano, nei pressi del
104
Op. cit., p. 62
110
luogo dove abitavano, mentre i genitori di lei, che erano stati sistemati inizialmente in un ospedale
di Biella, dalla cui amministrazione erano stati invitati a lasciare in poche ore, si trovavano da
qualche conoscente in Lombardia.
Il giorno stesso del ritorno di Nella da Torino, i Segre assistono alla rappresaglia dovuta al
ferimento del segretario del fascio locale e per l’uccisione della sua segretaria: mentre alcuni
repubblichini portavano coattivamente la gente al funerale della segretaria del fascio, altri operano
in paese e catturano una dozzina di persone e li conducono nel municipio, dove hanno il loro
quartier generale.
Gli arresti sono operati anche all’interno della clinica dove, su delazione di un abitante del
quartiere, arrestano un infermiere reo di aver partecipato ad una manifestazione di giubilo, il 25
luglio, in seguito alla caduta di Mussolini.
Dalla clinica manca un altro ospite, ma non perché è stato anch’egli arrestato, ma perché sta
collaborando, in quanto fascista repubblichino, all’azione.
In paese, fino al 20 febbraio, non vi era un presidio della Guardia Nazionale, cosa che garantiva
una relativa sicurezza; ma a questa data la scuola fu requisita e adibita a caserma per il nuovo
presidio. I fascisti, praticamente ogni notte, lanciavano bombe e sparavano nel vuoto a scopo
intimidatorio e preventivo per mantenere una costante paura negli abitanti del paese. “I repubblicani
in paese ne fanno d’ogni colore; arrestano, rubano, prelevano merce dai negozi senza pagare,
essendo il presidio a carico del paese, come se appartenesse ad esercito nemico occupante; e di
notte sparano” 105 . Il presidio opera in modo talmente barbaro e incontrollato che già la mattina del
7 marzo il presidio è scomparso, successivamente si saprà che erano stati prelevati da carabinieri
venuti apposta per loro da Torino.
In clinica il pericolo principale è costituito dai delatori: non sono pochi quelli che fanno professione
di delazione, primi fra tutti vi sono due coniugi, lui federale e lei tedesca; poi ci sono i morfinomani
che, pur non essendo di fede o simpatie fasciste, venderebbero anche i propri genitori per una dose
di droga; infine, ma non meno pericolosi, ci sono tutti quelli, compreso il personale medico, che
uscendo spesso dalla clinica hanno modo di parlare sovente con altra gente e con i militi, tra questa
categoria vanno anche inseriti coloro che per leggerezza nel parlare rischiano di mettere nei guai chi
ha qualcosa da temere.
Alle idi di marzo, che secondo Churchill avrebbero dovuto segnare la vittoria alleata e quindi la fine
della guerra, arrivano in clinica una coppia di coniugi, che, da alcuni indizi, possono essere ebrei;
ma i nuovi arrivati non si “comportano bene”: lui, che dovrebbe essere il malato, non fa alcuna cura
e simula la propria malattia in modo insufficiente, non come Renzo: “al contrario, io faccio cure
105
Op. cit., p. 68
111
continue, mi sottopongo ad ogni esperienza, perché ritengo questo indispensabile, anche per
giustificare, con la gravità del caso, la presenza di mia moglie” 106 . Sempre in questo periodo Nella
riesce a rivedere il fratello, sempre tramite il professore nella sua casa di Torino, che non vedeva da
cinque mesi e ad avere nuove notizie sui propri genitori che, come le vecchie notizie, stavano bene
ed erano sempre ben collocati. Questo li tranquillizza molto anche perché accende in loro la
speranza che la disposizione, che si diceva esistente, secondo cui le persone anziane o molto malate
venivano dispensate dall’arresto, esistesse veramente.
In aprile le sempre più frequenti azioni dei partigiani sono seguite da sempre più feroci rappresaglie
ed è in questo periodo che i mali simulati da Renzo, (che già da tempo cominciava ad accusare
veramente), diventano veri e frequenti; dopo che i due coniugi collaborazionisti, ospiti della stessa
clinica, erano stati prelevati dai partigiani, per la paura della futura rappresaglia che certamente
avrebbe colpito la clinica o, nella migliore delle ipotesi, avrebbe comportato un controllo sui propri
ospiti, “mi dispero, travagliato da un attacco di nervi, questa volta non simulato, ma non trovo la
soluzione: abbandonare la clinica in questo momento, a parte il fatto che non sapremmo dove
andare, è certo che è ancora più pericoloso che restare. Oltre a tutto, non c’è il professore con cui
consigliarci, perché lui stesso è degente a Torino per un’operazione chirurgica”107 . Ormai molta
gente ha abbandonato il paese per paura, ma le rappresaglie non ci sono e la coppia prelevata, dopo
sette giorni, può tornare in clinica, dopo uno scambio di prigionieri con i partigiani.
E’ maggio, ed il professore ancora non torna, è molto malato, si tratta di una polmonite
postoperatoria che fa presagire una lunga assenza.
La vita intanto scorre “monotona” tra paura, rappresaglie, false speranze e l’arrivo di sempre nuovi
ospiti , sempre più pericolosi: un morfinomane, notoriamente in rapporto con ufficiali tedeschi; un
signore molto equivoco che ha un figlio che lavora per i tedeschi al Palazzo degli Alti Comandi ed
un fascista sfegatato.
Verso la fine di maggio i coniugi Segre vengono chiamati in ufficio per un controllo dei documenti
visto che, essendo scaduto da poco il termine concesso ai renitenti alla leva repubblichina, la clinica
era stata invitata ad esaminare attentamente la situazione di tutti i degenti. Questo fu un motivo di
grande paura perché i documenti falsi nelle mani dei coniugi Segre erano mal fatti, ma per fortuna o
perché chi doveva notare la loro falsità non l’aveva fatto, il controllò passo senza problemi.
Lo sbarco alleato sul continente e l’entrata degli alleati a Roma, fecero aprire uno spiraglio di luce
nel buio cielo che era il loro futuro, “forse potremmo un giorno, forse prossimo, uscire di qui,
106
107
Op. cit., p. 70
Op. cit., p. 72
112
rivedere i nostri genitori, camminare sicuri su qualunque strada, senza pericolo di essere presi,
torturati, deportati, uccisi?” 108 .
A metà giugno un duro colpo al già basso morale, fu dato dalla partenza della coppia di coniugi
arrivata in marzo; inizialmente fu detto che partivano per andare ad accudire un loro parente molto
malato, ma presto la signora tedesca, accertata confidente dei tedeschi, informò tutti che erano stati
mandati via perché era risultato che il loro nome era falso e che erano ebrei.
Il professore ormai era malato da due mesi e pur essendo degente nella stessa clinica dei coniugi
Segre non era permesso loro di vederlo e ciò fa sì che rimangano completamente isolati, essendo lui
l’unico loro collegamento con l’esterno. Altra complicazione della sua malattia, è il fatto che non
può più effettuare le giornaliere visite mediche ai degenti, così Renzo, dovendo essere visitato da un
altro medico di noti sentimenti filofascisti, è costretto a raddoppiare la simulazione, ma soprattutto
le cure; “mi fanno iniezioni ogni giorno d’ogni sorta di pasticci e applicazioni elettriche alla testa:
se uscirò vivo dalle mani dei tedeschi, è difficile che possa uscirne da quelle… dei dottori” 109 .
Renzo non si spiegava perché dopo aver consegnato poche tessere annonarie al suo arrivo la
direzione non fosse più tornata sull’argomento; la spiegazione la ebbe a fine giugno quando i
degenti furono invitati a consegnare le proprie tessere in quanto dal 1° luglio le razioni destinate
alla clinica non sarebbero più state considerate come razioni per una convivenza che aveva diritto a
razioni complessive, ma il cibo sarebbe stato consegnato e distribuito in base alle tessere annonarie
personali. Probabilmente questa era una manovra che faceva seguito alla revisione dei documenti
che vi era stata poco tempo prima, per stanare gli ultimi rifugiati, visto che chi era in regola poteva
procurarsele senza problemi presso il comune, cosa che non poteva fare chi non era in regola o
viveva sotto falsa spoglia.
Renzo riesce a vedere il professore, ma quando è al suo capezzale, non riesce a parlargli di questo
problema, viste le sue precarie condizioni di salute, ma è lo stesso professore che propone il
discorso e lo consiglia di rivolgersi ad un’infermiera che è una sua cugina che lavora all’ufficio
annonario del comune, informandolo che entrambe collaborano come possono con la resistenza.
Renzo seguendo le indicazioni del professore, si rivolge a quest’infermiera invitandola anche a fare
in modo che non risulti il loro nome in nessun registro del comune, visti i sempre più frequenti
controlli di polizia. Seguono due giorni di forte apprensione per le tessere, ormai “non ho più
bisogno di fingere di star male, perché le ansie, le preoccupazioni, le angustie portate dalle sempre
nuove difficoltà, le notizie dei giornalieri fatti di sangue che avvengono attorno a noi, mi hanno
prostrato in modo indicibile” 110 . Le tessere sono consegnate, sono regolarmente rilasciate dal
108
Op. cit., p. 77-78
Op. cit., p. 79
110
Op. cit., p. 80
109
113
comune e in più con i nomi con cui sono registrati in clinica; il fatto di essere vere per l’autorità
emittente, ma false nel nome, fa sì che servano anche di supporto alle loro misere carte di identità
che invece sono false sotto ogni punto di vista.
Le rappresaglie si fanno sempre più dure e crudeli, il paese arriva persino ad essere bombardato
provocando molti danni materiali e facendo sei vittime tra la popolazione civile, tra cui una anziana
donna e una bambina di soli sei anni, di cui le bombe non hanno avuto nessuna pietà; “Io non so in
che direzione marceranno la morale e i sentimenti degli uomini negli anni avvenire: noi siamo ora
abituati a queste stragi pazzesche e prive di ogni senso comune, tanto che forse non ne valutiamo a
pieno l’enormità. L’unica speranza è che l’avvenire non le sanzioni, ma che possa portare alla
punizione degli infami assassini, a petto dei quali il delinquente che ti ferma all’angolo della strada
è una persona per bene, perché se non altro affronta anche lui un minimo di rischio: cosa che non ha
l’aviatore –sedicente italiano– che dall’alto tira giù bombe su un inerme ed ignaro paese
agricolo” 111 .
In agosto si riaccende la speranza che la guerra possa concludersi entro l’inverno, ma già altre volte
ci si è illusi che il movimento possa continuare rapido e vincente; l’esperienza ha insegnato che
ogni volta che si creava quest’illusione ci volessero dei mesi prima che ricominciasse il movimento.
Il professore è sempre malato e per questo non può andare a Torino, e questo taglia Renzo e Nella
fuori dal mondo.
Nel paese continua a non esserci un presidio stabile, per questo le incursioni di questi banditi si
limitano ad arresti o requisizioni in case dove i delatori hanno segnalato la presenza di uomini da
rastrellare o qualcosa da portar via. Ormai per sopravvivere, l’importante è evitare, rispetto a
chiunque, anche il più lontano sospetto di essere rifugiati, in quanto “senza esagerare, il 90% delle
persone che ci circondano sono informatori; dei novanta, dieci sono spie patentate che si
ripromettono dalle delazioni guadagni e privilegi, e gli altri ottanta sono occasionali, per leggerezza,
e sono forse i più pericolosi, in quanto non c’è maniera di neutralizzarli”112 .
Durante la lunga degenza a Renzo tornò utile la simulazione di una malattia che aveva simulato più
volte prima dell’8 settembre, per sottrarsi al servizio obbligatorio del lavoro coatto per gli ebrei; il
loro caro amico, il dottor Mussone (quello che gli aveva trovato il ricovero presso la clinica che li
ospitava e che li aveva accompagnati), gli aveva insegnato a simulare l’enterocolite113 , una malattia
con sintomi esterni poco identificabili e quindi più difficile da smascherare. L’aggiunta di questo
nuovo malanno fu particolarmente necessaria in questo periodo visto che vi era la necessità di
giustificare rispetto alle duecento persone che erano presenti in quella clinica, di cui la maggior
111
Op. cit., p. 82
Op. cit., p. 84
113
Infiammazione dell'intestino.
112
114
parte infidi, la prolungata permanenza in clinica e in più il bisogno di essere assistito dalla moglie;
per migliorare la simulazione, Renzo studiò attentamente i sintomi ed il decorso su un libro
capitatogli tra le mani. Ma la simulazione non durò molto visto che dopo venti giorni gli si presentò
veramente l’enterocolite con tutti i suoi sintomi palpabili.
Ormai Renzo esce pochissimo dalla sua camera e l’unico che vi può entrare, oltre a sua moglie, è il
medico che lo visita e lo “cura” ogni mattina. Per questa sua particolare condizione gli è stata
concessa una presa di corrente in camera, con la scusa di improvvisi bisogni di acqua calda, con la
quale può cucinarsi qualcosa in più della misera razione che passano in clinica. La razione che
veniva fornita giornalmente agli ospiti della clinica era composta da riso… a sorpresa, in cui ci si
poteva trovare, giornalmente, fino a quattro tipi diversi di insetti! Il pasto serale invece consisteva in
un uovo fradicio o in una cosa chiamata frittata, ma che aveva la particolarità di essere fatta senza
uova. Il pane poi era un intruglio acido e amaro, fatto di acqua, patate ed altri generi escluso il
grano. Ogni pasto in clinica, oltre ad essere privo di qualunque condimento, è privo anche del sale;
per questo lo si doveva comprare al di fuori della clinica a trecento volte il prezzo di solo un anno
prima. Il sale, essendo grosso, inizialmente veniva pestato con una bottiglia per farlo diventare fino,
ma Renzo trovò un altro stratagemma molto più efficace che aveva anche il pregio di impegnargli
tutto il pomeriggio: ne faceva una soluzione satura in acqua calda che veniva fatta bollire fino alla
totale evaporazione, così quando tutta l’acqua era evaporata nel fondo si trovava il sale fino.
Agli inizi di settembre torna al lavoro, dopo oltre cinque mesi di malattia, il tanto caro professore
che era stato in punto di morte, ma che dall’alto dei suoi settanta anni si era rimesso perfettamente.
Sempre in questo periodo, la prospettiva del possibile arrivo di un presidio di Brigate Nere, fa
pensare che le carte false in loro possesso dovevano essere sostituite in vista di un futuro controllo,
così ci si rivolge nuovamente all’infermiera che aveva procurato le carte annonarie; il primo impatto
è poco incoraggiante visto che servono tre foto di cui una deve essere spedita, con tutti i dati
anagrafici, alla polizia di Torino. Dopo dieci giorni di maneggi e ricerca di soluzioni alternative,
colloqui segreti e “mance” palesi, si arriva alla soluzione: non si doveva più richiedere due nuove
carte d’identità “vere”, ma si doveva richiedere delle dichiarazioni di identità; così facendo
l’ostacolo dell’invio dei dati e delle foto a Torino era superato dal fatto che facevano fede i bolli
sulle loro vecchie carte d’identità false. A questo punto bisogna studiarsi un curriculum vitae più
corposo di quello già imparato in modo da preparasi ad ogni evenienza; la cosa è facilitata da una
guida del Touring trovata in clinica e dal fatto che nessuno poteva controllare i fatti della loro
"falsa" vita, svoltasi tra Potenza e Roma, città sotto il controllo alleato.
Dopo sei mesi, sempre tramite il professore, i Segre ricevono delle notizie rassicuranti riguardo la
sorte dei loro cari, che servono ad alzare il morale.
115
Il gioco alterno delle speranze e delle illusioni è tremendo per logorare i già fragili nervi. La
distruzione del vicino campo di aviazione da parte degli stessi tedeschi, il più importante del nord
Italia, un mese prima, aveva fatto sperare qualcosa di nuovo, così come la notizia di analoghe
distruzioni a Torino, che preludevano un’imminente evacuazione da parte dei tedeschi. Si era poi
sperato che le grandi battaglie estive e lo sbarco in Normandia, potessero dare al ’44 il titolo di
ultimo anno di guerra, ma invece non era così e ci si preparava ad un altro inverno in cattività.
Siamo alla metà di ottobre e sta per arrivare il tanto temuto presidio e, anche potendo, sarebbe
difficile scegliere il male minore. La popolazione preferirebbe addirittura i tedeschi della
Wehrmacht, essendo le Brigate Nere e la Guardia Nazionale Repubblicana composte di feccia,
senza alcuna disciplina militare e ai cui soprusi non è possibile opporsi: qualunque armato può
uccidere il primo che incontra senza dover rendere conto a nessuno. Dai tedeschi dell’esercito
regolare si può anche essere fucilati, ma non senza ordini del comando, il che è già un vantaggio.
Il 20 ottobre arriva, nella notte, un presidio di circa duecento uomini della famigerata "Nembo",
cosiddetti paracadutisti, ma che non avevano mai fatto un lancio con il paracadute. Subito dopo il
loro insediamento, vi è uno strano attacco partigiano così, per “precauzione” futura, vengono
rastrellati decine di giovani che vengono portati in caserma come ostaggi; poco dopo anche un
gruppetto di giovanissimi, poco più che ragazzi, vengono portati in caserma. Vicino alla caserma vi
è un bel caseggiato, sede di una colonia estiva di bambini venuti da Torino in quanto senza tetto: il
comando locale, prendendo a pretesto l’attacco subito pochi giorni prima, ha dato ordine che i
ragazzi vengano sfollati e che il caseggiato venga subito occupato. Tutto questo fa pensare che lo
strano l’attacco di pochi giorni prima sia stato simulato per terrorizzare il paese, per prendere degli
ostaggi e per avere un pretesto per occupare il bel caseggiato.
Ormai non si può più dire di stare sempre male, così, anche per sospendere le balorde e costose
cure, Renzo dice di stare meglio e ricomincia a farsi vedere in giro e nella tanto odiata sala comune,
luogo di ritrovo di spie e loschi personaggi. Ma come si poteva dire di stare meglio se la “maggior
tortura è quella di essere tenuti, per mesi, come polli nella stia in attese di essere scannati? E’
inaudito, ma ormai, nella impossibilità di colpire coloro che si rendono colpevoli verso gli occupati,
perché son troppi e perché non lasciano perdere, l’unico sistema di cosiddetta giustizia funzionante
è l’uccisione di ostaggi, di persone, cioè che certamente non hanno commesso il fatto, del quale,
anzi il più delle volte, non hanno neppur sentito parlare, per la semplice ragione che sono in
prigione da mesi. Povera umanità!” 114 .
Ormai non ne possono più, l’unica persona su cui possono contare è il tanto caro professore che gli
fa da padre, madre, fratello e con le sue parole da' tanto sollievo. Ormai sempre più spesso
114
Op. cit., p. 99
116
l’angoscia si impadronisce di loro e li fa piangere per il loro destino e per quello dei loro cari.
Piangono lacrime amare, senza neppur tentare reciprocamente vane parole di consolazione.
Renzo prima fingeva una fobia del cibo, ora, sovente, non ha più bisogno di fingere: non si tratta di
semplice inappetenza, ma di una vera e propria repulsione al cibo. Secondo Freud la diagnosi è
semplice: è il subcosciente che ordina all’organismo di non compiere più atti necessari per
prolungare una vita ormai diventata insopportabile. Ogni mattina gli vengono fatte delle punture di
insulina che generano un’artificiosa fame rabbiosa che gli fa strappare il piatto di mano a chi glielo
porge; è una sensazione dolorosa, ma allo stesso tempo piacevole che contribuisce a distruggerlo
nel corpo e nella mente.
Il 6 dicembre arriva loro la prima visita: è Rosanna 115 ! Abbracci, lacrime, gioia. E’ difficile dopo
tanti mesi rendersi conto di cosa voglia dire riabbracciare e parlare con una persona cara, poter
parlare con una persona che li chiama con i loro veri nomi, che ormai erano stati quasi dimenticati.
Mangiano, o meglio fanno finta di mangiare tante sono la gioia e le cose da dirsi; bisogna fare in
fretta perché può restare solo un’ora. Le notizie che porta sono buone: tutti i loro cari sono ancora
vivi e sempre ben collocati. E’ arrivata lì da loro grazie alla collaborazione del dottor Mussone, per
il quale Renzo scrive una lettera da portare ai suoi genitori. L’ora a loro disposizione passa presto
ed è già ora di andare; Nella decide di accompagnarla alla stazione per stare un po’ più di tempo
con lei. Prima di andare le affidano delle foto con la raccomandazione di usarle per avere dei nuovi
documenti di riserva nel caso le loro attuali generalità debbano essere abbandonate per un motivo o
per l’altro.
Passano così dicembre e gennaio con i soliti scontri, rastrellamenti e rappresaglie; il più importante
rastrellamento è stato fatto grazie all’aiuto di una donna il cui nome di battaglia è Mirella che,
grazie alla conoscenza dei luoghi e delle persone, è al servizio dei fascisti.
In questi mesi la situazione si fa sempre più pesante: i partigiani intensificano la loro azione ed i
fascisti rispondono sempre con una violenza sempre maggiore: man mano che si vede avvicinare la
fine, i nazifascisti, aumentano in ferocia, ritenendo il terrore l’unico mezzo per tenere il paese.
Povero professore, lui non racconta mai nulla, non racconta mai il peso che gli da' quella sua
situazione, non fa trasparire mai niente, sembra sempre felice e disinvolto, chissà forse è così, ma
può anche essere che sappia simulare molto bene, consapevole del fatto che qualche suo cedimento
possa essere determinante per il morale di chi gli sta attorno. Lui non abbassa mai la testa e pur
sapendo di essere un "osservato" da parte delle autorità, continua la sua opera senza mai piegarsi a
nessuno e prendendo sempre le giuste decisioni in modo da non compromettere i “suoi protetti”.
115
Rosanna Morelli. Moglie di Dario, quindi cognata di Renzo e Nella
117
La sera del 2 febbraio 1945, si ferma davanti alla porta della clinica un automezzo con a bordo due
partigiani che vogliono lasciare in clinica, per quella notte, una donna accusata di spionaggio che
dovrebbe essere portata al comando partigiano poco distante per il processo, ma che per la presenza
di repubblicani, sulla strada ora non può essere trasportata. Il professore, pur essendo un patriota
molto attivo, si rifiuta di “ospitarla” anche solo per una notte visto l’eccessivo pericolo che veniva
fatto correre ai suoi “malati” e neppure quando gli puntano le rivoltelle addosso si piega; dopo
un’ora di accese discussioni e di minacce i due partigiani ripartono per la loro strada.
Il reparto della clinica destinato ai malati lievi, dove è anche ospitato Renzo, è scenario di sempre
nuovi arrivi; il loro reparto è ormai tutto destinato ai malati “politici”. La figura che desta più
curiosità, ma anche paura, è un tedesco che vive ormai da molto anni in Italia, dove ha lavorato da
interprete presso reparti tedeschi, e vanta grandi benemerenze a favore della popolazione dei paesi
in cui è stato e dove è sempre riuscito ad evitare grane ai civili. Il professore rassicura Renzo
dicendogli che non è una spia, infatti prima di “ricoverarlo” ha fatto fare su di lui accuratissime
indagini, ma Renzo lo guarda sempre con sospetto visto che appena arrivato era informato sul suo
curriculum vitae ad uso clinico.
Secondo gli accordi presi a dicembre con Rossana, Renzo e Nella ricevono della corrispondenza dei
loro cari tramite il professor Mussone; in una di queste lettere trova i due documenti d’identità
richiesti, rilasciate dal comune di Pescara, timbrati, firmati, con le loro foto, ma con le generalità
lasciate in bianco, in modo da poterle compilare ad hoc per un’eventuale emergenza.
Ormai anche marzo è quasi passato e con il bel tempo Renzo ricomincia ad uscire, anche per la
necessità di cercare qualche genere alimentare, essendo quelli disponibili in clinica immangiabili.
Il primo di aprile il presidio repubblicano lascia finalmente il paese. I tedeschi sorvegliano le
operazioni di trasferimento e su ogni camion vi erano anche i tedeschi: forse non erano sicuri delle
loro pecorelle! Purtroppo con loro sono partiti anche gli ultimi ostaggi.
In sostituzione dei repubblichini partiti, giunge un piccolo presidio di circa venti uomini formato
di ausiliari tedeschi, di origine cecoslovacca, dotati di alcune autoblindo. Fin dal loro arrivo la gente
aveva cominciato a lavorarseli parlando, prima con vaghe allusioni e poi apertamente, dei partigiani
e della loro causa; l’effetto di questa paziente opera si vede dopo soli otto giorni quando una
colonna partigiana arriva in paese e riparte poi verso la montagne seguita dagli ausiliari che
avevano deciso di unirsi alla causa partigiana.
Il 18 aprile in Torino e provincia comincia lo sciopero generale che desta tanta paura nelle autorità
tedesche, perché pensano che fosse l’inizio del sollevamento di massa; invece non lo è, è solo una
prova generale per dare ai capi partigiani l’esatta misura della compattezza delle forze antifasciste.
Quando lo sciopero termina si contano molte vittime di scontri e rappresaglie, specie a Chieri, che
118
è stata dichiarate in stato d’assedio. Le autorità sono compiaciute, credono di aver domato il
movimento con la forza: non sanno che la cessazione era prestabilita e chi si trattava solo di un
ultimo collaudo prima della prova finale. Le vittime di questi ultimi giorni di guerra fanno ancora
più pena di tutte le altre visto che, pur essendo arrivati così vicini alla libertà, non la potranno mai
assaporare.
Il 25 aprile, come al solito, i coniugi Segre sono, con il solito gruppetto di antifascisti, vicini
all’apparecchio radiofonico, oggi in particolare si aspettavano nuove notizie viste le sempre più
insistenti voci che davano ormai per raggiunti gli accordi di pace; le 13 sono passate da qualche
minuto quando Radio Milano Libera annuncia la liberazione della città ed il progredire della rivolta
in tutta l’alta Italia. Prima che qualcuno abbia il tempo di fare commenti, il gruppo si riversa in
piazza dove vi è già quasi tutto il paese in festa, ci sono anche i partigiani che dopo tanto possono
finalmente riabbracciare i loro cari, quelli che non sono del posto abbracciano il primo che capita o
meglio, la prima che capita.
Il commissario prefettizio repubblicano ormai ha già abbandonato il suo posto da alcuni giorni e
così il CLN locale assume i poteri ed il professore è nominato sindaco.
Da Torino ancora non giungono notizie, ma questa volta ci si può anche abbandonare alle illusioni
vista la situazione degli scenari di battaglia europei tra cui era presente anche Berlino.
Ormai Renzo non riesce a passare più di cinque minuti in quella clinica che per tanti mesi era stata
il suo rifugio, sente il bisogno di partecipare alla frenesia generale e si mette a disposizione del
professore nell’ambito dell’amministrazione del comune. Il paese è ormai tutto imbandierato ed il
tricolore sventola su ogni finestra, i nomi delle vie dedicati a personaggi della dittatura fascista sono
cambiati con nomi più degni. Le notizie da Torino arrivato il 26, grazie a delle staffette che portano
la notizia che pure lì la rivolta e scoppiata che servono rinforzi. Di lì non se ne potevano inviare
perché i pochi partigiani presenti servono a fronteggiare i gruppi fascisti che girano sbandati per la
campagna. Ma non si può trattenere nessuno contro la propria volontà e così molti corrono verso
Torino.
Verso mezzogiorno del 28 aprile la radio annuncia che Himmler ha chiesto la resa incondizionata,
a questa notizia i nervi di Renzo non reggono più “i miei nervi, da troppo tempo tesi sino allo
spasimo, cedono e mi abbatto piangente sul letto” 116 .
In paese l’entusiasmo è al colmo. Il giorno dopo un’altra notizia va ad accrescere l’entusiasmo
generale: l’ex duce, che pochi giorni prima era stato preso mentre travestito da tedesco cercava di
attraversare il confine svizzero, era stato fucilato: “questa fine, ucciso a schioppettate a ridosso di
un muro, è quanto di meglio si potesse desiderare, perché lo ha privato anche di quello che il suo
116
Op. cit., p. 117
119
animo teatrale, di regista di terz’ordine, più avrebbe desiderato: un bel processo in cui far sfoggio
della sua oratoria” 117 .
Poche ore dopo si sente anche la voce di Torino liberata, con un discorso del prefetto annunciante la
liberazione della città; vi sono ancora cecchini isolati che sparano dalle finestre delle case, ma il
loro rastrellamento procede inesorabile.
Ma le notizie non sono tutte buone: nel triangolo Chivasso-Ivrea-Cigliano c’è un punto di
raggruppamento tedesco dove continuano ad affluire gli sparsi presidi esistenti. A due chilometri da
San Maurizio Canavese vi è un comando di tappa tedesco che instrada tutti i rottami della
Wehrmacht in quella direzione, ma per raggiungere il punto di raccolta dal comando di tappa
bisognava passare dal paese. La notizia fa paura, soprattutto perché aggregati vi possono essere dei
nuclei repubblichini che, dove giungono, in un ultimo sfogo di rabbia imponente, portano lo
sterminio.
La manifestazione del primo maggio di libertà viene confermata; ma le ore di angoscia non sono
ancora finite e la sorte ha voluto elargire altre sofferenze ed apprensioni:una colonna tedesca armata
di tutto punto e con artiglieria pesante si sta dirigendo in quella direzione. Il paese è ancora pieno di
bandiere e di manifesti inneggianti alla liberazione, i nomi dei componenti del CLN sono ormai di
dominio pubblico, compreso il professore.
Cosa vorranno fare? Transitare? Accamparsi? Sfogare la loro rabbia? Gli interrogativi rimangono
senza risposta fino a sera tarda quando la colonna giunge in paese; i partigiani coraggiosamente non
hanno abbandonato il posto di blocco ed alla richiesta da parte tedesca di accamparsi in paese per la
notte, hanno risposto, dopo essersi presi del tempo per decidere, che sarebbe stato possibile, ma
prima dovevano ritirare “l’artiglieria” e poi li avrebbero fatti passare. Una volta entrati in paese
vogliono usare la clinica come riparo per la notte, ma dopo che il professore ha fatto fare,
all’ufficiale d’ordinanza tedesco, un giro nel reparto "agitati", decidono di accamparsi nelle vicine
scuole informandolo che per qualunque “incidente” sarà ritenuto responsabile ed informandolo che
la mattina seguente alle otto doveva presentarsi a rapporto. La notte passò tranquilla ed il professore
alle otto, puntuale come un orologio, dritto come un fuso, pacato, serio, calmissimo, si presentò al
comando. Gli vengono ripetuti gli ammonimenti della sera prima ed in più lo si informa che presto
la colonna lascerà il paese. Oltre alla paura dei tedeschi, che sono più di duemila, vi è anche quella
dei bombardieri alleati che colpiscono le formazioni tedesche nei dintorni ormai da giorni.
Verso le diciassette dello stesso giorno la colonna riparte; nei camion che sfilano per il paese si
vedono anche dei repubblichini che sperano nella salvezza seguendo i tedeschi.
117
Op. cit., p. 117
120
Il giorno dopo, nessuno esce di casa per la paura delle bande fasciste che imperversano nella zona e
che, dalle poche notizie che si hanno, stanno sfogando la loro rabbia uccidendo ed incendiando
interi paesi.
Ma alle diciassette l’atmosfera cambia si diffonde la notizia che carri armati alleati sono a pochi
chilometri dal paese; in un batter d’occhio le bandiere che erano state tolte il giorno prima
ricompaiono, il professore in municipio organizza il discorso in inglese e si preparano i fiori da
offrire ai tanto attesi soldati alleati. Giunti alle porte del paese cominciano a distribuire biscotti e
cioccolata, ma non vogliono entrare in paese perché stanno inseguendo la colonna che era transitata
il giorno prima di lì. Per non deludere la popolazione, dopo qualche insistenza, si riesce a
convincere gli americani che almeno uno di loro, simbolicamente, compia il giro del paese per
accontentare la popolazione in festa. Un ufficiale scende da un carro armato e salito su una
motocicletta di un partigiano si lascia condurre in paese dove quando scende scompare in mezzo
alla folla festante, tutti lo vogliono abbracciare, toccare, quasi ad accertarsi che non sia un sogno.
Quando riesce a riemergere, assume informazione sui tedeschi e riparte carico di mazzi di fiori
visibilmente commosso.
La sera si assiste ad una scena che ormai non si era più abituati a vedere: non c’era più
l’oscuramento totale e quindi era stata riaccesa l’illuminazione pubblica, che spettacolo!
Altra notizia che riempie tutti di gioia viene data dalla radio: alle ore 2 di quel 2 maggio 1945 le
forze tedesche in Italia si erano arrese. In quella sera di libertà tutti passeggiano e cercano il
professore per abbracciarlo e ringraziarlo; quando Renzo lo trova per rinnovargli la sua gratitudine,
il professore lo invita a seguirlo nel suo studio dove gli porge un plico di carte; quando lo apre legge
e capisce che si tratta di un’istruttoria del settembre scorso dell’ufficio politico investigativo di via
Asti a Torino, tristemente noto per la ferocia dei suoi componenti, fatto a nome di Renzo Segre.
Ora che il pericolo è scampato gli può dire quello che aveva omesso di dirgli mesi prima per non
compromettere il suo già fragile equilibrio psicologico, il suo rifugio era stato scoperto ed il suo
arresto era stato scongiurato grazie all’intervento del professore che, recandosi di persona (dopo
aver raccomandato alla moglie i giovani figli nella probabile possibilità che non fosse più tornato)
nella tana dei boia a giurare e spergiurare che quella persona che loro credevano Renzo Segre non
era affatto la persona che cercavano, ma la persona che dichiarava di essere e a riprova del fatto si
era offerto garante in quanto lo conosceva da anni.
Questa era una carta disperata giocata dal professore nello stesso luogo degli orrori fascisti. La
tempestività del suo intervento aveva avuto gli effetti sperati, forse per il fatto che chi aveva
ascoltato il suo intervento, era stato convinto dalla nobiltà di un animo che non credevano si potesse
sacrificare fino a quel punto per un uomo e così avevano archiviato il caso.
121
Renzo commosso abbraccia ancora il professore senza trovare nessuna parola che possa esprimere
la sua riconoscenza e la sua ammirazione.
Renzo e Nella essendo ancora impossibilitati a partire per il mancato funzionamento della ferrovia
locale, che era stata danneggiata da un attacco partigiano durante l’occupazione nazifascista,
affidano una lettera per i loro genitori ad un giovane, che andava in bicicletta ad Asti, per non
prolungare la loro angoscia.
In questi giorni si assiste al ritorno di quelli che avevano mantenuto “l’ordine” in paese per subire
un processo che desse la giusta punizione ai loro misfatti. Ogni volta che ne arriva uno la
popolazione lo circonda per farlo oggetto del loro scherno e delle loro parole di odio ricordando le
loro barbarie. Dopo il primo processo Renzo e Nella vanno ad assistere all’esecuzione di un
graduato della Nembo: assistono impassibili alla scena, ormai “anche noi siamo morti dentro. Le
tremende angosce sopportate e che ancora ci travagliano nel pensiero dei molti cari che certo non
troveremo più, ci hanno trasformati, fisicamente e psichicamente, sino a renderci altri individui.
Siamo sopravvissuti, ma dal nostro mondo di prima, una tremenda frattura ci separa, che forse non
potrà mai più essere colmata” 118 . Il 6 maggio fanno le celebrazioni organizzate per il primo maggio.
Il giorno dopo arriva anche l’ultima notizia: la Germania ha capitolato sopraffatta dalle forze alleate
e sommersa dall’odio di tutto il mondo.
E’ l’8 maggio o Victory Day, da oggi la guerra è finita ufficialmente.
Il professore chiama nel suo studio Renzo e Nella per consegnargli le loro nuove carte d’identità,
da lui firmate, e questa volta con i loro veri nomi. La guerra era finita, ora cominciava un’altra fase
della loro vita, forse altrettanto difficile: ricominciare a vivere normalmente senza farsi
condizionare troppo dagli avvenimenti passati.
Un ultimo pranzo nella sala comune della clinica addobbata con bandiere e tavoli infiorati, un
brindisi alla fine della guerra, un breve discorso del tanto caro professore e poi il treno verso casa ed
il difficile futuro.
118
Op. cit., p. 128-129
122
La famiglia Benedict
123
La storia di questa famiglia ebrea costretta a scappare e lasciare la casa, la sicurezza, gli amici per
colpa dell’arrivo dei nazisti a fiume, se non fosse per la tragicità delle vicende, potrei definirla
appassionante.
Se potessi dare un titolo a questa avventura la intitolerei “la beffa”. Sì, perché i tedeschi dopo la
morte della loro interprete, scelsero proprio la nostra protagonista per sostituirla, e lei giovane
ebrea, si trovò a fare da interprete a quegli stessi uomini che dicevano che la puzza degli ebrei la
sentivano a distanza.
La fuga li portò a boves, paese medaglia d’oro per la resistenza.
Loro erano perfettamente a conoscenza di tutto ciò che era capitato a quella cittadina e proprio lì
sentivano che la popolazione non li avrebbe traditi, anzi li avrebbe protetti in caso ve ne fosse stata
necessità.
Proprio per questa ragione, quella zona rimaneva particolarmente calda, a sole sei chilometri da
Boves infatti, in Borgo San Dalmazzo, dal settembre al novembre 1943 era rimasta in funzione una
vecchia caserma dove rinchiudevano gli ebrei fuggiti attraversando le Alpi da Saint Martin Vésubie.
Tutti quegli ebrei rinchiusi furono poi trasportati ad Auschwitz. Ma altri ebrei trovarono rifugio
nelle cascine del cuneese, anche a Boves, come ha raccontato don Viale a Nuto Revelli in “Il prete
giusto”.
I nostri protagonisti erano riusciti ad avere i passaporti falsi da “ariani”, e questo li aiutò
sopravvivere. Le loro giornate da profughi erano pressoché vuote, l’unica che lavorava era
Rosemarie, che dava lezioni soprattutto di matematica; mangiavano molta pasta e fagioli e
Rosmarie racconta: «mio papà li contava quei fagioli» e per la carne avevano una volta la settimana
la tessera per cui davano 50 gr. di montone “puzzolente”, inoltre il sale non c’era. La madre era
impegnata a far la spesa, cucinare e leggere libri, mentre il padre oltre a leggere i giornali studiava
con Rosemarie l’inglese.
Per nascondere la loro origine ebraica la protagonista la domenica andava in chiesa e faceva finta di
essere cattolica, i genitori invece pregavano per conto loro. Questo segreto, cioè che erano ebrei,
non lo svelarono neppure a guerra finita e questo per parecchio tempo ancora; forse la paura fu così
grande che li segnò dentro profondamente.
Questi fatti oggi fanno dire alla scrittrice: «di essere ebrea non me ne vantavo da bambina e non me
ne vanto oggi come fanno molti ebrei. Essere ebrei non è nè vanto, né colpa. Si è nati così.
Semplicemente».
Rosemarie Wildi Benedict nasce il 3 maggio del 1924 a Fiume, ed è solo una ragazzina quando nel
1938 vengono firmate le leggi razziali che la costringeranno ad abbandonare il sogno di frequentare
il liceo scientifico. Il primo provvedimento discriminatorio tocca al padre che, in quanto ebreo,
perde il posto di direttore tecnico alla ROMSA (raffineria di oli minerali SA, con sede a Fiume) poi
alla famiglia, che fu costretta a lasciare la bella abitazione, la fabbrica e l’impossibilità di avere
persone di servizio.
Il problema della scuola fu ben presto risolto poiché gli ebrei organizzarono una scuoletta ebraica
dove gli insegnanti erano studenti o neo laureati come il fratello di Rosemarie, Tibi.119
Per passare gli esami del secondo anno di liceo fu necessario prendere lezioni private che
naturalmente costavano profumatamente e che venivano effettuate di sera quando la scuola ariana
119
Tibi era il fratello maggiore di Rosari, aveva 22 anni, si era laureato in fisica a Bologna nell’ottobre del 1938: ebbe
il punteggio di 110 su 110 ma niente lode, era proibito dare la lode agli studenti di razza ebraica. Una volta ricevuto il
documento (affidavit) partì per l’America il 3 agosto 1939.
124
era vuota. Nel giugno del 1940 superò ancora da privatista gli esami di ammissione alla terza liceo,
proprio nel giorno (10 giugno) in cui il Duce, per radio, annunciò l’entrata in guerra dell’Italia.
Il 17 giugno 1940 il padre e lo zio vengono radunati e rinchiusi a gruppi di 40 – 45 nelle aule della
scuola di Torretta. Verrà poi liberato, il padre, grazie all’aiuto di alcuni suoi ex-dipendenti. Lo zio
invece verrà inviato a Ferramenti in Calabria; questa per lui sarà la prima tappa di un lungo
percorso che lo porterà alla camera a gas di Auschwitz.
Il 31 marzo del 1941 i fiumani vengono evacuati dalla città e per gli ebrei c’è pronto un treno, sono
in 270, l’ordine è di presentarsi in stazione alle 21,30.
Il viaggio è effettuato durante la notte, con lunghe fermate e la nonna ormai anziana e malconcia
viene adagiata in seconda classe mentre gli altri in terza.
L’arrivo a Mestre avviene di prima mattina, con le donne fasciste impegnate a distribuire il
caffelatte, e al pomeriggio a Verona, poi dirottati a Caprino veronese. Ad aprile i Benedict
ritornano a Fiume, la guerra lampo alla Jugoslavia è già terminata.
Nell’inverno 1941/42 si sentono, tramite radio Londra, le prime notizie sui lager e sulle camere a
gas.
Un anno dopo Rosemarie, passerà l’esame di maturità, ma non potendo andare all’università, la
ragazza si dedicherà per un anno intero al pianoforte per acquisire il diploma di compimento del
corso medio. In questo periodo Rosemarie conoscerà un giovane ufficiale, Michele Graglia 120 ,
studente di ingegneria a Torino, che aiuterà la famiglia Benedict nelle numerose fughe.
Il 25 luglio 1943 cade il fascismo;.tutti sono convinti che la guerra sia finita, ma non è così,
Badoglio annuncerà l’armistizio solo l’8 settembre 1943.
Nei giorni seguenti Fiume viene invasa da migliaia di soldati che rientrano, stremati, dalla
Jugoslavia, e non hanno la forza di respingere i tedeschi. La famiglia Benedict sente il fiato sul
collo, e chiede ospitalità a vecchi amici, i Poggi. Rosemarie dirà: «sono veri amici, sapevano di
esporsi ad un certo pericolo (...). Ogni qualvolta che suonano alla porta corro a nascondermi in
gabinetto…»
Ma il 27 dicembre del 1943 la fuga è necessaria, destinazione Caprino Veronese. I tedeschi hanno
cominciato a deportare famiglie ebree.
Caprino Veronese sarà fino a marzo del 1944 un buon posto per ripararsi, inoltre c’è lo zio e la
nonna che era rimasta in un ospedale. A Caprino si conduceva una vita abbastanza tranquilla «direi
addirittura tranquilla». Ma c’era comunque una spia: era un omiciattolo, pagato dai fascisti e
tedeschi: «era magrolino e giallognolo, il vero tipo di spia». Quando portarono via gli ebrei costui
corse dal dott. Ambrosiani, 121 ma il dottore, che era un gentiluomo, nonché amico della famiglia
Benedict con minacce e denaro lo fece tacere.
Il 13 marzo 1944 quando stanno deportando tutti gli ebrei, i tedeschi prendono la nonna di
Rosemarie, una signora ebrea di 85 anni che non poteva neanche più alzarsi dal letto. La vecchia
signora che seguiva la nonna corse ad avvertirli dell’accaduto e disse: «alle quattro del mattino circa
erano entrati nella loro cameretta d’ospedale due soldati tedeschi, avevano domandato chi dei due
era Rosa Docrì, le avevano intimato d’alzarsi, la suora che li accompagnava, spaventatissima, aveva
spiegato che la signora non era in grado di stare in piedi; ma già i due soldati l’avevano tirata fuori
dal letto, e la nonna, che non si reggeva, era caduta per terra. Allora l’avevano afferrata uno per le
braccia e l’altro per le gambe e l’avevano portata fuori, così com’era, in camicia da notte, e la
buttarono nel camion militare che aspettava».
Poco dopo sempre a Caprino, in un’incursione delle SS, vengono arrestati 17 “internati liberi” tra
cui lo zio di Rosemarie che era stato registrato come ebreo polacco ed era già finito in uno di quei
campi.
120
Michele Graglia, l’8 settembre aveva buttato a divisa a Fiume e rivestito di abiti borghesi era riuscito a non farsi
prendere dai tedeschi e raggiungere Ozegna Canadese (TO) dove erano sfollate moglie e suocera.
121
Farmacista, ufficiale della milizia fascista.
125
Per la famiglia Benedict divenne necessaria la fuga e il 15 marzo 1944 è il momento buono per
partire. Con un mucchio di valigie e la collana da 200 gr. d’oro della nonna in mano, venduta per
pagare la fuga, si dirigono alla stazione di Caprino, che era il capolinea della tratta che portava alla
stazione di Verona. Prima di partire le SS bloccano il treno; il padre di Rosemarie per un attimo
perde la testa e tenta la fuga scendendo velocemente dal treno, ma la ragazzina lo fa ragionare e si
trattengono sul treno. Le SS infatti, non sono lì per loro ma per un’altra signora e suo figlio; una
mezza ebrea che viveva col figlio scapolo in una grandiosa villa, probabilmente molto appetibile ai
tedeschi. Il treno parte subito dopo che i due poveretti furono portati via.
Da Verona si riparte il giorno dopo per Milano.
Come al solito il treno è strapieno, pur essendo lunghissimo, la gente che aspetta è tantissima, il
viaggio si prevede allucinante. Infatti la ragazzina ricorda: «finalmente arriva il treno, lunghissimo,
strapieno, la gente pende a grappoli dagli scalini. Qualcuno scende, ma sono più quelli che vogliono
salire. Nella confusione perdiamo la mamma. Riusciamo a buttar dentro ai diversi finestrini le
nostre valigie. Poi io riesco a salire sul primo gradino, poi sul secondo, papà dietro di me è sul
primo. Il treno si mette in moto, mi tengo stretta più che posso. Sui gradini davanti a me altre
persone, chissà quante. Mi tengo aggrappata con tutte le mie forze… se mi lascio andare è finita. Il
treno corre… che orribile sensazione! Non so quanto sia durato… un’eternità!
Ma ecco che funziona la legge fisica della compressione dei corpi: pian piano, i primi riescono a
salire, poi anch’io, ultimo papà, siamo nel gabinetto, in 14!. Dopo alcune ore di viaggio, sempre
stretti come sardine in scatola nel gabinetto si arriva a Milano. Ritroviamo la mamma, ritroviamo
anche tutte le nostre valigie» 122
L’indomani tutti e tre partono per Torino: la linea Milano-Torino funziona meglio, non c’è che poca
gente. Durante il viaggio però vengono derubati di tutti i loro soldi (15000 lire). Per fortuna, la
padrona del buffet di Porta Susa, dà loro da mangiare e li lascia andare senza fare storie, anzi offre
ancora del denaro per pagare la corsa fino ad Omegna!
Lì ritroveranno Michele Graglia, con la moglie e la suocera. Un posto incantevole, pieno di pace,
dove la famiglia Benedict potè rimanere fino a giugno.
Il 29 maggio due militi fascisti andarono a chiedere informazioni sui tre sfollati che vivevano con i
Graglia e loro dovettero svignarsela in fretta. La fuga avvenne a Torino, dove vengono nascosti da
Giuseppe fratello di Michele Graglia e da sua moglie Eliana. Lì si decide di nascondere la famiglia
a Boves.
Perché proprio a Boves?. Il 19 settembre 1943, due giorni dopo l’armistizio, Boves era stata
incendiata dalle SS, dal maggiore Jachir Pliper. Proprio per questo fatto Boves era considerata
122
Pag. 45
126
relativamente tranquilla. Inoltre Eliana conosceva bene il segretario comunale, si diceva che avesse
redatto tremila documenti falsi ad uso dei ragazzi partigiani: infatti il Segretario comunale non pose
nessuna domanda quando Eliana e Rosemarie andarono a chiedere i documenti: da quel momento in
poi diventarono i Benetti.
Fu così che nel giugno del 1944 i “Benetti” si installarono a Boves e vennero accolti molto
cordialmente dai bovesiani. La famiglia Benedict viveva dalla signora Assunta, con lei abitavano la
sua vecchia madre e la signora Pellegrino, sua sorella vedova, con i figli Liliana e Dante. Rosemarie
aveva iniziato a dare delle lezioni private a Dante poiché era stato rimandato in alcune materie ed a
settembre i risultati si videro, passò brillantemente gli esami. La notizia fece il giro del paese e la
ragazza trovò un impiego.
Ma nell’estate del 1944 Boves è per così dire “libera” non ci sono né tedeschi né fascisti, ci sono
dei “repubblichini” nella frazione vicina a Fontanelle, comandati dal famigerato capitano Salvi.
Rosemarie fa amicizia con altri ragazzi e passa le giornate a suonare al pianoforte pezzi celebri,
giocando a carte o chiacchierando e lei stessa dice di trovarsi molto a suo agio in quell’ambiente.
Ma i tedeschi ritornano a Boves con carriaggi e cavalli, insomma uno “squadrone”. Così i partigiani
del luogo non potranno più spingersi in paese; ma a parte questo i tedeschi non disturberanno i
Benetti. Tutto il paese ascolta radio Londra, ma quando qualcuno fa la soffiata ai tedeschi, questi
decidono di farsi consegnare tutti gli apparecchi radio; i bovesiani consegnano solo i modelli
vecchi, tenendosi quelli buoni nascosti. Così possono continuare a sentire radio Londra.
A febbraio, quando la vita continua serena e tranquilla, successe che l’interprete dei tedeschi, una
signora polacca che parlava benissimo l’italiano e il tedesco, si ammalò e morì poco dopo, forse per
mano tedesca, poiché era sospettata di parlare troppo. Il sabato seguente al decesso della signora,
bussarono alla porta dei Bonetti il Rittemeister e il Fieldwebel!. Ai tre si gela il sangue nelle vene,
ma in realtà la visita è di tutt’altra natura rispetto a quello che avevano immaginato, questi erano
gentilissimi, ed erano venuti a sapere che Rosemarie dava lezioni di tedesco ed a loro serviva un
interprete. Rosemarie non avrebbe potuto rifiutare, perciò lei, che era scappata da Fiume perché
ebrea, ora si ritrovava nella bocca del leone a fare da interprete: il lavoro era molto semplice ed era
anche pagata!
Rosemarie tramite la sua amica Liliana (di Boves) lo comunica ai partigiani che rispondono:«sai
quello che devi fare!»
La ragazza ogni mattina, si recava in ufficio (una spaziosa aula della scuola elementare), vi è
sempre una lunga fila di richiedenti: sono in coda per ottenere un passaporto per Cuneo e devono
spiegare fin nei minimi dettagli i motivi: ecco perché i tedeschi hanno bisogno di un interprete.
Mentre svolge questa mansione, può agevolmente ascoltare
127
quello che il comandante e il
maresciallo si dicono in tedesco, può così riferirlo ai partigiani attraverso l’amica Liliana, la quale
però è giovane ed ingenua e per sicurezza verrà tagliata fuori dai collegamenti con i partigiani.
Un mattino dalla solita fila dei richiedenti, Fiedwebel prende per un braccio tre ragazzi e manda via
tutti gli altri. I tre erano partigiani e la ragazza si stupì per come fosse riuscito a riconoscerli. Una
soffiata o solo un buon naso? Avevano rispettivamente 18 – 17 – 15 anni e avevano bisogno del
lasciapassare per portare dei messaggi ad altri gruppi. Uno alla volta venivano portati nell’ufficio e
interrogati, Rosemarie che era l’interprete traduceva le domande e le risposte. Il Fiedwebel poneva
le domande in modo da farli cadere in contraddizione, nel frattempo urlava e minacciava di metterli
al muro. I ragazzi stoicamente non confessavano e il maresciallo che assisteva all’interrogatorio
scagliò una pedata al basso ventre del più debole dei tre: questi svenne. Rosemarie, che ha la
fortuna di conoscere il bovesano, che i tedeschi conoscono ancora meno dell’italiano, riesce ad
indirizzare i tre inserendo fra le domande qualche preziosa indicazione, per consentirgli di
raccontare tutti e tre la stessa versione dei fatti. Alcune volte, con dei calci sotto il tavolo, faceva
capire che raccontavano una cosa diversa da quella che avevano raccontato gli altri e tutto andò a
buon fine, infatti alla sera tutti e tre vennero liberati.
Ormai siamo agli sgoccioli del racconto, la guerra sta per finire e la ritirata è imminente, lo
sapevano bene anche i partigiani che vollero mandare una lettera al Rittmister chiedendo la resa, la
consegna delle armi, nonché delle munizioni e della benzina nascosta in buchi dentro dei frutteti.
Il 24 aprile il comandante tedesco riceve l’ordine di partire per l’indomani ed il 25, poco prima delle
due del pomeriggio, arriva nel largo corridoio del primo piano della scuola Mons. Pellegrino. 123 Il
prete lo consegna a Rosemarie che lo passerà al comandante. La lettera è scritta in tedesco, proprio
Rosemarie l’ha tradotta. Il comandante lo legge e fa delle domande al prete, ma il reverendo dice di
non sapere niente: In tasca però ha un biglietto, da un lato c’è scritto (se si arrendono) dall’altro (se
non si arrendono).
In quest’ultimo lato c’è scritto che sarà lotta perché i partigiani stanno già scendendo dalla
montagna e arriveranno presto. Ma il comandante ragionevolmente dice di non volere la guerra e
altro sangue, la condizione è che i partigiani lascino partire i tedeschi ed in cambio si prenderanno
munizioni e benzina.
Dopo circa due ore i tedeschi sono davanti alla scuola pronti alla partenza in parte a cavallo ed in
parte con i loro carriaggi.
Il 26 aprile gran festa a Boves; erano scesi dalla montagna i partigiani; tutti in piazza si abbracciano,
amici e gente comune parlavano anche con chi non conoscevano.
123
Mons. Pellegrino è un prete in pensione, persona di gran cultura, intelligente e molto scaltro.
128
A Cuneo si combatteva ancora, partigiani contro tedeschi; a volte si sentiva un lontano brontolio di
cannoni: le truppe alleate; i liberatori, arrivarono appena quando tutto era finito ed era ormai
tranquillo.
Questa è una storia avvincente, che racconta di mille agguati, intoppi, che la rendono palpitante e
viva. Certo leggendola come appare, vista dagli occhi di una bambina, vi si ritrovano anche
momenti belli, “ironici”: è la stessa protagonista che nel libro dopo la storia dice di essersi divertita
a raggirare in quel modo i nazisti. Ma pensandoci bene è una storia che ti fa raggelare; il rischio che
ha passato con la sua famiglia era altissimo e mi viene da pensare quale orribile fine avrebbe potuto
fare se l’avessero scoperti. Ma in questi casi si dice “ tutto è bene quel che finisce bene”.
129
LE FUGHE DAI TRASPORTI
130
Nella storia della deportazione verso i Lager nazisti, vanno inseriti anche coloro che non vi
arrivarono mai in quanto riuscirono a fuggire dalla tradotta della morte.
Questa parte della deportazione non è molto conosciuta. Vi sono vari motivi che concorrono a
questo; in primo luogo influisce l’esiguo numero di coloro che riuscirono a fuggire e se a ciò
aggiungiamo il fatto che non tutti sono sopravvissuti alla fuga o alla guerra, o più semplicemente il
fatto che molti hanno preferito non raccontare, ecco spiegato il motivo. Un altro motivo è la scarsa
importanza che la storiografia ufficiale ha dato all’argomento; oggi non esistono delle trattazioni
specifiche, ma solo brevi accenni in qualche scritto.
Per questo oggi possiamo renderci conto di questo aspetto della deportazione solo tramite i brevi
accenni nelle memorie degli ex deportati e tramite qualche libro di memorie scritto da coloro che
scamparono alla deportazione tramite la fuga.
Prima di cominciare a parlare dei tentativi di fuga, è bene capire cosa fosse e in che condizioni
disumane si svolgeva un trasporto verso i campi di concentramento nazisti, dell’Europa centrale e
orientale.
Il viaggio si svolgeva in carri bestiame su cui venivano caricate dalle sessanta alle ottanta persone
che respiravano “grazie” a due piccoli finestrini, posti sui lati lunghi del vagone, che erano sbarrati
da inferriate e fil di ferro, ma in altri casi “meno fortunati” il viaggio si svolge su carri merci che
non hanno neanche delle aperture per l’aria.
Gli accessi ai vagoni, una volta effettuato il carico dei prigionieri, venivano sbarrati e sigillati o,
come si suole dire, piombati in modo che potessero essere aperti solo dall’esterno. Nei carri
naturalmente non vi erano servizi igienici e le uniche cose che vi assomigliavano lontanamente
potevano essere un buco fatto in un angolo del vagone e che dava direttamente sulle traversine dei
binari o un secchio; questi servizi igienici, anche se non credo possano essere chiamati così,
dovevano essere usati dall’intero vagone senza distinzione tra uomini e donne e per dare un po’ di
privacy a chi li usava si appendeva una coperta, che naturalmente era di qualche deportato e non
fornita da chi organizzava il trasporto, o si metteva qualcuno davanti per occultare la vista. In
qualche caso, durante le fermate, i deportati venivano fatti scendere per un breve periodo di tempo
per sbrigare i bisogni più urgenti. Questo come è facilmente intuibile era un duro colpo alla dignità
dei deportati.
Altro fattore di disumanità, era l’esigua fornitura di viveri ed acqua che veniva fornita alla partenza
e che poi veniva data in modo sporadico, e sempre insufficiente, o non era più fornita per il resto del
viaggio, questo aggiungeva altri due "passeggeri" al già carico vagone che saranno compagni
sgraditi fino alla fine dei deportati: la fame e la sete.
131
In questo parte del viaggio la solidarietà della popolazione civile fu molto importante perché
durante le fermate, ignorando le minacce dei militi, qualcuno forniva ai deportati un qualche genere
di conforto che poteva consistere in un po’ di acqua fresca o in qualche genere alimentare.
Tutti questi fattori ci fanno facilmente capire che già durante il lungo viaggio vi era un prima
selezione: i più deboli, che generalmente erano le persone anziane e i bambini, se non morivano
durante il viaggio, erano destinati ad una morte imminente. Vedere perire i propri compagni di
viaggio era un ulteriore dramma che si aggiungeva al già basso morale dei deportati.
Il peso fisico e psicologico che gravava sui deportati aumentava sempre più, man mano che si
avvicinava il confine, dove prenderà completamente il posto della già esigua speranza che si ferma
al confine.
L’unico libro di memorie scritto da un diretto protagonista di una fuga dai trasporti, di cui sono a
conoscenza è Salto nel buio di Bonfantini.
Dalla lettura di questo libro e dalle poche notizie che ho trovato sull’argomento, ho capito che sulle
fughe ha influito molto la strategia del terrore messa in atto dai nazisti e che consisteva in una vera
e propria violenza morale (ma ne parleremo più avanti) e dal fatto di tenere segreta la destinazione
del trasporto o di mascherarla con un semplice e quasi rassicurante: “Andate e lavorare per la
grande Germania”. Dopo queste parole gli animi si “addolciscono” e la rassicurazione fa sì che i
pensieri dei deportati comincino a dire pressappoco: “Beh meno male, ci portano in Germania
perché hanno bisogno di manodopera (…) Beh, forse è la soluzione migliore”124 .
Altro elemento della strategia del terrore era mantenere ignota la sorte del deportato anche ai propri
familiari o più in generale alla popolazione. Chi è deportato, salvo in rari casi, non riuscirà più a
comunicare con il mondo esterno e nessuna notizia verrà più data di lui.
Per chi parte il viaggio si svolge nell’incertezza. L’inizio del viaggio è caratterizzato dalla ricerca di
un qualunque mezzo per rompere l’isolamento, per far sapere ai parenti la propria presunta
destinazione. Il mezzo più usato è lo scrivere dei bigliettini in fretta e con mezzi di fortuna; dice Pio
Bigo: “Tutti scrivevano messaggi su fogli di carta, buttandoli dall’unico finestrino del carro nelle
stazioni, in particolare modo a Verona, con la speranza che qualcuno potesse raccoglierli e inviarli
alle nostre famiglie per informarle” 125 in cui si diceva pressappoco: “ci portano via da Torino, chi
trova il biglietto…” 126 .
E’ in questo contesto di rottura dell’isolamento che in un certo senso si inseriscono i tentativi di
fuga dai trasporti, aiutati anche dalla solidarietà esterna che però chilometro dopo chilometro si
124
Anna Bravo e Daniele Jalla, La vita offesa, 1988, Franco Angeli Storia, p. 119
Pio Bigo, Il triangolo di Gliwice,memoria di sette Lager, 1998, Edizioni dell’Orso, p. 24 . Il biglietto di Pio Bigo
arriverà a casa e sarà recapitato ai fratelli. (Testimonianza dell'autore).
126
Testimonianza di S. Barbera in La vita offesa, op. cit., p. 119
125
132
affievolisce fino a scomparire con l’attraversamento del confine che segna la fine della speranza di
aiuti esterni e anche la fine dei tentativi di fuga.
Dice Pio Bigo: " Cesare era sempre più convinto di scappare: era un uomo con qualche anno più di
noi, dai capelli rossi, molto robusto. Non intendeva rassegnarsi all'idea di andare a lavorare nella
Grande Germania(…) < Se io avessi un palanchino, una sbarra robusta- diceva- questo vagone lo
sfascerei>. D'accordo con lui eravamo tutti noi giovani, forse ancora più incoscienti, fra i quali
c'erano Andrea, Sergio, Emilio, Fulmine (nome di battaglia). Tutto questo succedeva mentre
eravamo ancora in territorio italiano, specialmente nella valle di Tarvisio." 127
Dalle letture sull’argomento ho capito, o meglio è un' opinione che mi sono fatto, che chi è fuggito
da un convoglio era preparato più psicologicamente che tecnicamente alla fuga. Infatti chi ha
evitato la deportazione tramite la fuga da un convoglio, meditava ciò da quando era stato
scaraventato sul treno e, che io sappia, nessuno che abbia mai pensato alla fuga è fuggito cogliendo
un’occasione presentatagli sul momento, senza aver prima meditato tale possibilità; anche perché
l’organizzazione dei convogli era talmente “perfetta” da fare in modo che tali occasioni non si
presentassero .
Dice Bonfantini: “Saremmo partiti per la Germania in uno di quei carri bestiame (…) e io avevo
deciso da un pezzo che in Germania non ci arrivavo: avrei “tagliato la corda” per strada”128 . Essere
preparati psicologicamente alla fuga non vuole dire avere un piano di fuga, ma essere pronti a
cogliere tutte le occasioni che la permettano; infatti progettare un piano di fuga è pressoché
impossibile in quanto, a parte il fatto che il viaggio verso i “campi di lavoro” si sarebbe svolto in
treno, nessuno conosceva il modo in cui si sarebbero svolti i trasporti verso le stazioni ferroviarie e
quale sarebbe stata la situazione una volta sulla tradotta.
Una volta saliti sul treno, i carri bestiame venivano chiusi dall’esterno e le aperture sbarrate con
inferriate e fili di ferro.
A questo punto chi ha progettato la fuga oltre a contare sulla propria intelligenza ed inventiva, può
far affidamento su due fattori che lo aiutino ad uscire dal vagone piombato: un aiuto esterno o
qualche attrezzo utile presente nel proprio bagaglio o in quello dei compagni di sventura. Negli aiuti
esterni, grande fu l’opera dei ferrovieri che, anche a scapito della loro vita, fecero di tutto per
aiutare i deportati a fuggire. Il loro aiuto poteva consistere nel nascondere attrezzi utili alla fuga o
rallentare il treno per dar l’occasione ai deportati di fuggire in condizioni di maggiore “sicurezza”.
127
128
Pio Bigo, op. cit., p.24.
Mario Bonfantini, Salto nel buio, 1975, Einaudi, pp. 10-11
133
Un ferroviere che veniva scoperto mentre aiutava in qualche modo i deportati a scappare, rischiava
la deportazione o nella peggiore delle ipotesi la morte, ma questo non è bastato a fermare l’opera
d’aiuto che essi attuarono.
Dice un deportato: “Nel carro abbiamo trovato tutto. Tutto! Una sega, un martello, dei chiodi, le
pinze. E pensare che prima di montare ci avevano persino guardato nelle scarpe. E quando siamo
arrivati nel carro abbiamo trovato tutto quel materiale. E non solamente nel nostro, anche negli altri
carri. Erano stati i ferrovieri, per aiutarci a scappare” 129 .
Dice Alberto Todros nelle sue memorie, dopo essere stati caricati sul carro bestiame che li avrebbe
portati in Germania: “Prima che chiudono i vagoni, si avvicinano alcuni ferrovieri della stazione di
Carpi, ci consegnano un fiasco di vino (…) Scopriremo subito dopo che nel fiasco di vino è
nascosto un fascetto di seghe da ferro” 130 . Queste seghe di ferro erano per un anarchico genovese
veterano delle fughe dai trasporti, ma questo aiuto non servì in quanto si decise di scappare aprendo
il portellone dall’esterno una volta che l’anarchico, uscito dal finestrino, lo aveva sbloccato.
Secondo Todros il fil di ferro che chiudeva il finestrino venne tagliato con il loro tagliafili portato
dal campo di raccolta di Fossoli 131 , mentre secondo Bonfantini, che si trovava sullo stesso
convoglio, i fili vennero scansati dopo averli sbloccati, togliendo dall'interno, con un coltello
svizzero, i chiodi che lo reggevano 132 .
Una volta che l’anarchico si calò fuori e sbloccò il portellone, cinque compagni di sventura,
compreso lui, si gettarono dal treno in corsa e si diedero alla fuga, mentre gli altri richiudevano il
portellone e sistemavano alla meglio i fili per l’approssimarsi di una stazione.
Più numerose sono le testimonianze riguardo ai ferrovieri che avvertono i prigionieri dei
cambiamenti di velocità, perché possano saltare dal treno con un minor rischio: “Alla stazione di
Verona si son messi d’accordo col capotreno e col macchinista di andar adagio adagio adagio
durante la notte e lì, tanti son saltati giù e son riusciti a scappare..”133 ; “il treno, viaggiando in salita,
rallentava quasi fino a fermarsi, come se il conducente lo facesse appositamente per aiutarci a
fuggire” 134 ; “qualcuno riesce a far circolare la voce che, quando sarà notte, il convoglio rallenterà in
tratti in cui maggiori saranno le possibilità di fuggire, anche se sarà rischioso per tutti, macchinisti
compresi, eludere la sorveglianza dei militi” 135 .
"Noi s'era progettato di buttarsi giù nelle gallerie, s'era fatto il piano, s'era tirato a sorte chi toccava,
e io…ero il quarto. Per primo s'è buttato uno di Biella,(…); poi un altro(…): So che l'ultimo prima
129
Testimonianza di F.Perosino, in La vita offesa, op. cit. p. 128
Alberto Todros, Memorie, 1999, Trauben edizioni, copia fuori commercio, p.43
131
Op. cit. nota 7, p. 43
132
Op. cit. nota 5, p. 110
133
Testimonianza di S. Bianchi in La vita offesa, op. cit., p.124
134
Op. cit. nota 2, p. 25
135
Ferruccio Maruffi, Codice sirio, i racconti del Lager, 1992, edizione a cura dell’autore, p. 5
130
134
di me voleva portare via anche il bagaglio. Nella galleria il macchinista ha rallentato ed era l’ultima
occasione, perché ci avevano detto di scappare prima del ponte del Tagliamento perché poi la zona
era invasa dai Tedeschi." 136
Continuando a seguire il racconto di Alberto Todros, troviamo un altro fattore che influì molto sui
tentativi di fuga: il così detto "terrorismo morale".
Infatti racconta Todros, arrivati alla stazione, le guardie tedesche, pur essendosi accorte che
qualcosa non andava non intervennero, ma si limitarono a ripetersi tra di loro che se effettivamente
qualcuno era scappato, sarebbe risultato dalla conta all’arrivo nel “campo di lavoro” e che ne
avrebbero fucilati dieci per ogni prigioniero fuggito; questa era la stessa cosa che si erano sentiti
dire dalle guardie di Carpi prima della partenza.
Queste parole, a cui alla partenza non era stato dato peso, diffusero il panico nel vagone. Quando il
treno ripartì, il fil di ferro venne rispostato con la medesima operazione effettuata poco tempo prima
dall’anarchico, ma l’unico che riuscì ad uscire e a fuggire fu Bonfantini, perché il tentativo di fuga
dei fratelli Todros e di chi voleva fare altrettanto, fu impedito da chi, (ed era la maggioranza)
intimorito dalla prospettiva delle fucilazioni, aveva deciso che per il bene di tutti non doveva
scappare più nessuno 137 .
Da questo episodio è semplice capire quanto la violenza morale messa in atto sui deportati abbia
influito nello scoraggiare o nell’impedire le fughe.
Per capire meglio il fenomeno è bene aprire una parentesi che ci aiuti a capire chi e perché quelle
persone fossero sulla via della deportazione.
Essenzialmente si potevano trovare su questi convogli ebrei, deportati politici, partigiani, militari
italiani catturati dopo l’8 settembre del ’43 e gente comune rastrellata per strada per i più svariati
motivi. Da questi grandi gruppi si può fare un’unica distinzione tra prigionieri partigiani e militari,
quindi gente per lo più giovane presa ancora con le armi in mano, e gente comune che non aveva
mai combattuto, non più giovani e per la maggior parte con una propria famiglia.
Tra questi due grandi gruppi non è difficile capire qual era quello propenso alla fuga e quello no.
Per i deportati ebrei va fatta un’ulteriore precisazione: i deportati in quanto ebrei viaggiavano
generalmente con le loro famiglie e questo faceva sì che praticamente nessuno che avesse la propria
famiglia al seguito, tentasse la fuga per non abbandonarla; chi era deciso a giocare questa carta
doveva essere un individuo solo che poi non dovesse convivere con il rimorso di aver abbandonato i
propri cari. Ciò che spaventava tanto questa gente, oltre alla prospettiva di future fucilazioni tra gli
136
137
Testimonianza di S. Barbera, in La vita offesa, op. cit., p.129
Op. cit. nota 7, pp. 44-45
135
stessi deportati per rappresaglia, era anche la possibilità che tali rappresaglie colpissero i parenti più
prossimi, il cui unico torto era quello di essere imparentato con qualcuno che era scampato alla
deportazione tramite la fuga; infatti i militi delle SS e delle camicie nere che si occupavano dei
trasporti conoscevano, oltre al nome del condannato alla deportazione, anche il luogo di residenza e
perciò la minaccia di ripercussioni sulla famiglia “Non dovevamo tentare la fuga, altrimenti
avrebbero colpito le nostre famiglie, perché erano in possesso dei nostri indirizzi. Intimidazione
criminale, che creò molto sgomento e paura, specialmente nelle persone più anziane, padri di
famiglia con figli” 138 .
Questo è stato un efficace freno alla fuga in quanto il gruppo che riusciva a prevalere era quasi
sempre il secondo che, convinto che la cosa migliore fosse accettare la deportazione per il bene di
tutti, con le buone o con le cattive, faceva prevalere il proprio punto di vista e le proprie idee.
Riguardo a questo si può parlare in un vero e proprio conflitto generazionale che vedeva da una
parte i più giovani, e forse anche più incoscienti, che si erano visti gettare bruscamente nella vita
“adulta” e nelle responsabilità che essa comporta e che avevano dovuto imparare presto a
sopravvivere combattendo con le armi in pugno mentre dall’altra parte vi erano, come detto, i padri
di famiglia che avevano scioperato nelle fabbriche, che conoscevano bene tutte le responsabilità che
la vita comporta e che avevano imparato con la dura lotta, cosa essa volesse dire la sopravvivenza
quotidiana della propria persona e della propria famiglia. Questa visione ci serve anche per capire
quanto l’ignoranza del futuro abbia pesato, con le minacce e i maltrattamenti, nel frenare le
iniziative di fuga e nel favorire un certo fatalismo riguardo alla propria sorte e l’accettazione della
propria condizione come la soluzione migliore per tutti e il non ascoltare chi più “illuminato” aveva
capito o conosceva pressappoco quale sarebbe stata la loro sorte.
“E lì tanti son saltati giù e son riusciti a scappare… Io dico a mio fratello: <<ma, vedi, poi prendono
nostra madre, e mia moglie, il bambino… – ah, avevo il bambino di tredici mesi! – e ce
l’ammazzano subito! Tanto noi ormai siamo segnati!>>. E lui a ascoltarmi… <<Guarda – diceva –
che ci ammazzano! Ricordati che ‘sta gente qua – perché io ero più giovane di lui, avevo ventisette
anni – ‘sta gente qua ci ammazza tutti… Vedrai che alla fine della guerra, se siamo ancora vivi, ci
gasano tutti!>>. E infatti non è più tornato” 139 .
Anche per i soldati italiani caduti in mano ai tedeschi all’indomani dell’8 settembre 1943, si
prospetta una deportazione verso i campi di concentramento nazisti all’insegna dell’ignoranza
riguardo la propria posizione ed il proprio status: quello che ha inizio è un viaggio verso l’ignoto,
verso i campi di internamento militare, ed in qualche caso finirono invece a Dora, a Buchenwald o
138
139
Op. cit. nota 2, p. 23
Testimonianza di S. Bianchi in La vita offesa, op. cit., pp. 124-125
136
in altri Lager, dove si credeva di essere internati in qualità di prigionieri di guerra, trattati secondo
la convenzione di Ginevra, ma dove invece furono trattati alla stessa stregua dei prigionieri comuni
ed in molti casi anche peggio visto il fatto che avevano tradito il grande Reich millenario.
L’ignoranza del futuro li porta a prendere poco in considerazione la possibilità della fuga visto che
“andare a fare i prigionieri vuol dire che alla fine della guerra ci manderanno a casa” 140 o dando
ascolto a notizie false e tendenziose “c’era chi suggeriva di cercare di liberarci. Invece a Milano
avevano fatto girare la notizia che Berlino era caduta e noi siamo partiti con la convinzione che la
guerra stesse per finire da un momento all’altro. La gente si rivolgeva a mio fratello dicendo: <<ma
val la pena di tentare qualche cosa?>>. E lui: <<ma siamo matti! Ma qui non arriviamo neanche a
Bolzano, ci fermeranno per strada…>>” 141 . Analoga era la situazione prima di cominciare il
trasporto; i nostri soldati venivano riempiti di false promesse e rassicurazioni che unite alla
stanchezza della guerra e alla voglia di tornare a casa furono un forte deterrente alla fuga prima del
trasporto in Germania. Ai soldati di ritorno dal fronte orientale che si trovavano in campi di riposo
nei pressi di Udine “furono distribuite dichiarazioni di congedo e tutti si preparavano per tornare a
casa” 142 ; mentre i soldati salivano sul treno che li conduceva a Mestre, tappa prima del ritorno a
casa, soldati tedeschi armati erano sempre lì che li osservavano, ma la gioia per l’armistizio da poco
dichiarato e la prospettiva di un ritorno a casa non fecero sospettare nulla.
Solo a Mestre si accorsero di essere prigionieri, quando fu fatta formare ai soldati una lunga
colonna che si muoveva a piedi scortata da carri armati e autoblindo verso una meta sconosciuta.
Ma la situazione non era ancora ben chiara e così quando la mattina dopo gli ufficiali italiani fecero
girare la voce che tutti sarebbero stati avviati verso l’Italia centrale dove tutti sarebbero stati
congedati, i soldati, pieni di nostalgia per la loro casa, stanchi della guerra e della vita militare,
cedettero a quelle parole e la colonna si avviò, quasi senza scorta alla stazione davanti alla quale era
di guardia una camicia nera.
Dal ciglio della strada la gente che guardava faceva segni ai soldati per dirgli di fuggire, ma solo
pochi lo fecero. Le ultime speranze di un imminente congedo finirono quando al momento di salire
sui carri merci designati per il convoglio, comparvero molti militari tedeschi che circondarono il
treno; la situazione divenne ancora più chiara quando il convoglio si mosse e si videro postazioni
armate di mitragliatrice sul primo e sull’ultimo vagone. Solo a questo punto i soldati cominciarono
a fare i primi tentativi di fuga quando il treno rallentava presso boschi dove ci si poteva nascondere;
dalle due estremità del treno si apriva allora il fuoco e qualche volta il convoglio veniva fermato per
dare modo alle guardie di riprendere o meglio uccidere i fuggiaschi. Quando il treno si fermava a
140
Testimonianza di G. Fioris in La vita offesa, op. cit., p. 124
Testimonianza di L. Mira D’Ercole in La vita offesa, op. cit., p. 124
142
Marco Herman, Diario di un ragazzo ebreo, 1984, L’Arciere, p. 41
141
137
qualche disco rosso, i tedeschi scendevano e sparavano in aria, questo avveniva anche quando nelle
stazioni si avvicinavano civili che gettavano viveri ai prigionieri. Anche da questo esempio si può
capire quanto l’ignoranza sulla propria sorte abbia pesato sui numeri della deportazione.
Ma le fughe, o i tentativi di fuga, non avvenivano solo durante il viaggio verso i campi di
concentramento o di sterminio, avvenivano anche durante la permanenza nei campi di raccolta.
Nelle memorie di Alberto Todros sono raccontati tre tentativi di fuga andati a buon fine per alcuni,
dal campo di raccolta di Fossoli.
Todros ci dice che ciò che alimentò i loro progetti di fuga furono alimentati dalla scarsa
sorveglianza e dalla possibilità di avvicinare le sentinelle italiane durante il lavoro fuori dalle
baracche, due fattori che sono fondamentali affinché chi voglia tentare la fuga abbia qualche
speranza di riuscita. Il primo tentativo avvenne durante un lavoro al di fuori del reticolato, dove la
sua squadra, composta da setto o otto persone, che qualche volta lavoravano lontano alcuni metri
dall’unica SS di guardia, era impegnata da qualche giorno.
Il piano era semplice: Todros con suo fratello ed un ufficiale, anch’esso prigioniero, sarebbe saltato
in uno dei tanti fossi di irrigazione che vi erano nei paraggi ed avrebbe cominciato a correre in
modo che la sentinella, che aveva solo una pistola, non potesse né sparargli né raggiungerlo, visto
che avrebbe dovuto guardare il resto del gruppo. Tutto era pronto e si aspettava solo il momento
giusto per scappare, quando l’ufficiale si getta nel fosso e comincia a correre senza che Todros e
suo fratello lo possano seguire.
Il secondo tentativo di fuga prevedeva la corruzione di una sentinella italiana che, dietro il
pagamento di centomilalire (e nel 1943 erano veramente molte), li avrebbe dovuti ignorare mentre
loro, durante il suo turno di guardia, tagliavano i fili del reticolato e fuggivano. Presi i dovuti
accordi vengono introdotti nel campo, tramite un muratore che lavora nel campo da civile, i soldi ed
il famoso tagliafili che è stato poi usato da Bonfantini per la sua fuga. Tutto é pronto, la sentinella
ha comunicato il giorno e l’ora del suo turno di guardia, i cinque futuri fuggiaschi sono usciti dalla
loro baracca e stanno per cominciare a tagliare i fili del reticolato, quando il milite che doveva
essere loro complice si avvicina e dice che non se la sente più e che se non tornano subito alle loro
baracche dà l’allarme.
Il terzo tentativo di fuga invece scaturisce da un’opportunità che si presenta: una sera nel campo
salta la luce, il buio completo che dura da ormai parecchi minuti fa sì che Todros con il proprio
gruppo, una volta ripreso il tagliafili che era stato sotterrato dopo il fallimento del precedente
tentativo di fuga, si avvicini al reticolato senza problemi; ma nel momento in cui si stava per
138
iniziare l’operazione del taglio del fil di ferro tornò la luce e con essa svanirono tutte le speranza di
una fuga 143 .
Todros non è l’unico che ha raccontato un tentativo di fuga da un campo di transito.
Dalle testimonianze raccolte da Anna Bravo e da Daniele Jalla, ne La vita offesa, emerge un
tentativo di fuga dal campo di Bolzano 144 , che ricorda tanto quelli più volte visti nei film americani
del dopoguerra.
Un prigioniero politico, che era stato assegnato ad un nuovo blocco, dopo pochi giorni, nota che il
vicino aveva bruciato tutta la paglia del suo pagliericcio e tutte le notti portava della terra nella
baracca che sostituiva alla paglia del pagliericcio. Incuriosito e dopo aver fatto qualche “indagine”
scopre che nel suo blocco si stava tentando di fare una galleria per uscire fuori dal campo e poi
scappare. Unitosi al progetto viene a sapere che quella galleria era stata cominciata da altri
prigionieri, che chissà per quale motivo non l’avevano terminata, e che ora il progetto era stato
ripreso dai nuovi “ospiti” del blocco.
Gli scavi venivano fatti con il cucchiaio, in una galleria non molto grande, alla luce di una candela
che si spegneva spesso perché mancava l’aria. Tutto era ormai pronto, la galleria arrivava fuori dai
reticolati e bastava un ultimo colpo di cucchiaio per togliere i venti centimetri che separavano la
galleria dal livello del terreno.
Si era ormai vicini al Natale e per questo si decise di scappare proprio quel giorno perché le SS
sarebbero state a festeggiare e la sorveglianza sarebbe stata meno intensa. Sennonché il mattino
della vigilia di Natale un milite SS, mentre i detenuti erano fuori per l’appello, entra nella baracca e
va direttamente verso l’entrata della galleria.
Era la vigilia ed i prigionieri furono fatti stare tutto il giorno fuori sull’attenti fino a sera inoltrata.
Qualcuno aveva fatto la spia e le SS volevano sapere chi sarebbero stati i fuggiaschi; vedendo che
nessuno parlava, neanche dietro la minaccia di una decimazione, ne presero otto a caso su ottanta
che formavano quel blocco e li misero al palo dove li tennero tutta la notte sull’attenti.
L’indomani mattina, visto che ancora nessuno parlava, chiusero gli otto prescelti in cella di
isolamento dove vi rimasero per otto giorni; furono poi riuniti al resto dei componenti del blocco,
che sarebbe partito di lì a breve per la Germania.
Un altro tentativo di fuga su un trasporto in partenza da Bolzano (che troviamo nella stessa raccolta
di memorie 145 ) racconta l’ancor più sfortunato tentativo di un partigiano calabrese che era riuscito a
sfuggire alla perquisizione e aveva nascosto un lungo coltello, con cui aveva tentato di forzare la
stanghetta che chiudeva la porta del carro bestiame su cui era stato caricato. L’idea non fu giudicata
143
Op. cit. nota 7, pp. 39-40
Testimonianze di: F. Todaro, G. Argenta, G. Perfumo in La vita offesa, op. cit., pp. 125-126
145
Testimonianza di A. Di Salvo in La vita offesa, op. cit., pp. 127-128
144
139
cattiva dagli altri compagni di sventura, ma il “lavoro” cominciò quando il treno era ancora fermo
in stazione e quindi quando le guardie che erano fuori si accorsero che qualcosa non andava,
diedero l’allarme. " Oh! Io ho mai vista una scena così selvaggia! Entrano quattro SS. Eh, l'han
pescato con il coltello in mano, allora hanno cominciato a battergli il calcio del fucile sulla testa: era
ridotto ad una maschera di sangue, caduto per terra gli pestavano la testa con gli stivali chiodati. È
cominciato così quel viaggio bestiale." 146
L’unica storia di una fuga da un convoglio resa pubblica è, come già detto, quella di Bonfantini;
naturalmente lui non è l’unico che si è salvato alla fuga, ma è il solo che ha scritto un libro in
merito.
Nel suo libro la sua storia non si conclude con il suo “salto nel buio”, ma continua fino a quando
non raggiunge la casa di amici che abitavano in un paesino sulle rive del lago di Garda dove sapeva
di trovare un rifugio sicuro e delle persone che oltre ad essere care amiche, condividevano le sue
idee.
Ma riprendiamo il suo racconto.
Una volta che Bonfantini ebbe ripreso i sensi in seguito al salto dal vagone, per la botta presa sulle
traversine dei binari, perse per la prima e l’ultima volta la calma e cominciò a comportarsi più da
bestia che da uomo, infatti cominciò a correre come un animale braccato, saltando staccionate e
cose del genere e quando dei fil di ferro gli chiusero la strada con un fare da ossesso, cominciò a
strapparli con le mani e più avanzava più ne trovava; finché l’uomo che era in lui riprese il controllo
e si fermò a ragionare e si accorse solo a quel punto che quei fili appartenevano ad una spalliera
della vigna che stava attraversando. Continuando a camminare raggiunse una grande strada che per
fortuna era deserta, si nascose qualche minuto sul ciglio per osservare bene la situazione prima di
attraversarla, infatti le montagne in cui aveva deciso di recarsi, si trovavano dall’altra parte.
Continuò a costeggiarla per quasi un’ora e quando vedeva qualcuno si nascondeva per paura di
essere scoperto, ma le persone che intravedeva erano stranamente solo dei civili; la cosa non era poi
così strana visto che non sapeva che si trovava in quella parte del nord-est dell’Italia che era stata
146
Vedi nota 22.
140
annessa alla Germania e dove non vi era il coprifuoco. Quando vide finalmente un sentiero che si
dirigeva verso le montagne, lo prese; stava piovigginando e così appena trovò un rifugio sotto una
pianta si stese e cominciò a dormire. Poche ore dopo si svegliò tutto bagnato ed infreddolito; fece
un rapido inventario di quello che aveva nelle tasche: un po’ di
viveri che consumò come
colazione, un coltellino svizzero, dei fiammiferi, una diavolina che accese per scaldarsi ed
asciugarsi, dei soldi ed il suo fedele orologio che aveva resistito al violento impatto.
Le sue condizioni fisiche erano buone, a parte un taglio sulla coscia che si era fatto durante
l’attraversamento della vigna e un indolenzimento generale. Consumata la colazione e asciugatosi
alla meglio, continuò a seguire il sentiero, finché senza fiato (e la cosa era strana visto che era un
esperto alpinista) si fermò. Dalla sua posizione poté vedere che qualcuno, forse un ragazzo, con una
mucca stava salendo in quella direzione; decise di aspettarlo per chiedergli aiuto visto che era
l’unico modo per riuscire a sopravvivere in una terra che non conosceva. Poco dopo gli si presentò
un ragazzo in età adolescenziale che portava la mucca al pascolo, Bonfantini si presentò e senza
indugi gli disse che era scappato da un treno che lo stava portando in Germania e che ora gli serviva
aiuto; il ragazzo per nulla spaventato gli disse di aspettare lì che sarebbe tornato a riprenderlo tra
qualche ora, prima doveva riportare la mucca a casa e doveva avvertire la madre. Circa tre ore dopo
Giovannino (così si chiamava il ragazzo) era tornato e così cominciarono la discesa verso il paese
sottostante. La casa di Giovannino era la prima del paese e quindi non lo vide nessuno. Dopo le
presentazioni di rito seppe che quella famiglia aveva già ospitato qualche soldato italiano dopo l’8
settembre del 1943 e così capì la facilità con cui li aveva “convinti” ad ospitarlo. La prima cosa che
chiese fu di avere un posto dove riposare perché era molto stanco e si fece accompagnare in quella
che per qualche mese fu la sua camera. Finalmente dopo tanti mesi di prigionia poteva tornare a
dormire da uomo libero e per di più su un vero materasso.
Il tempo trascorse velocemente, la famiglia che lo ospitava quasi non dava peso alla sua presenza,
praticamente non si prendevano nessuna cura di lui, era come se fosse “invisibile” ai loro occhi, ma
la cosa che inizialmente gli sembrò strana, gli parve poi più chiara visto che quello era quasi lo
stesso trattamento che i componenti della famiglia tenevano tra di loro.
La famiglia era composta da quattro persone: madre e tre figli. La madre era severa con i figli e
vedeva il loro lavoro come qualcosa di dovuto nei suoi confronti: il piccolo Giovannino provvedeva
alle faccende di casa, mentre gli altri due figli che avevano più o meno vent’anni lavoravano in
fabbrica e quando ritiravano la paga la davano alla madre. Questa famiglia di poveri contadini stava
vivendo grazie alla guerra un periodo di felicità economica.
Dopo un po’ Bonfantini si rese conto che restare in quella casa era pericoloso perché quella gente
parlava di lui in giro con troppo leggerezza e più di una volta avevano portato gente in casa per
141
vederlo; questo lo facevano non per cattiveria, ma solo perché la loro ignoranza (soprattutto della
madre) non gli faceva capire la gravità della sua situazione ed il pericolo che correvano anche loro,
comportandosi in quel modo. Per questo decise che appena si fosse rimesso dalla pleurite
traumatica (la causa della sua mancanza di fiato) riportata in seguito alla botta dopo il salto dal
treno, sarebbe partito alla volta di un paesino sul Garda, dove abitava una famiglia di amici su cui
sapeva di poter contare.
Così appena si fu rimesso, si fece comprare degli abiti nuovi e con una ragazza a braccetto passò il
posto di blocco all’uscita del paese. Si diresse alla parrocchia del paese vicino dove si fermò
qualche giorno ospite del parroco che gli indicò la strada da seguire attraverso le montagne ed i
possibili ricoveri. La sua prima tappa fu un' osteria in montagna, dove si poté fermare solo una
notte, perché l’anziana padrona, capita la sua situazione, aveva paura ad ospitarlo.
Le altre tappe furono due parrocchie ed un caseificio ed in solo sei giorni aveva attraversato la
montagna e si trovava sull’altro versante dove grazie all’aiuto di persone che gli erano stata indicate
da chi lo aveva ospitato durante la traversata, arrivò alla sua meta: gli amici che tanto aveva cercato
di raggiungere, erano lì, sani e salvi ed ora anche lui aveva speranze di poter vedere la fine della
guerra da uomo libero.
142
Scarica