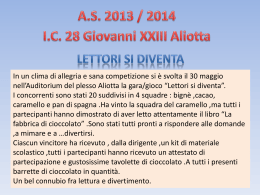FRANCES & GINGER PARK I PIACERI INTIMI DEL CIOCCOLATO Traduzione di Annalisa Carena Titolo originale: Chocolate Chocolate © 2011 by Frances Park and Ginger Park Realizzazione editoriale: Conedit Libri Srl - Cormano (MI) I Edizione 2011 © 2011 - EDIZIONI PIEMME Spa 20145 Milano - Via Tiziano, 32 [email protected] - www.edizpiemme.it Capitolo 1 Bacio Una stagnola stellata avvolge un vellutato cioccolatino fondente con un cremoso cuore di nocciola e un bigliettino d’amore per ricordo 11 gennaio 1984. «Accendi le luci, Ginge.» Era una giornata terribilmente fredda nella capitale – una giornata così fredda da incrinare le statue – e il nostro umore era come il cielo. Grigio. In un negozio messo insieme alla bell’e meglio, chiuso da lastre di vetro provvisorie così sottili da lasciar passare l’aria, le luci si accesero per la prima volta. La nostra giornata inaugurale sembrava tutt’altro che gloriosa. Ginger rabbrividì nel cappotto di lana blu. Aveva indossato il suo abito di seta nuovo per nulla; impossibile togliersi il cappotto quel giorno. I capelli di Francie, messa in piega perfetta, erano irrigiditi dal gelo, e i suoi orecchini pendenti sembravano ghiaccioli. I sette anni di differenza risaltavano anche dal modo in cui Ginger stava appiccicata alla sorella maggiore in finta pelliccia, sperando di condividere un po’ del suo calore corporeo. Chiaramente il nostro direttore lavori aveva omesso di installare un sistema di riscaldamento. E dov’era la nostra insegna? Quell’idiota non ne aveva fatta una giusta! 11 Ci lanciammo in una serie di insulti, coronati da urla assassine. «Lo odio!» «Spero che vada all’inferno!» Ammettiamolo: ci sono momenti in cui solo il cioccolato può riscattare una brutta giornata. È allora che fai appello al cioccolatino più sfavillante che ci sia in negozio, quello che parla al tuo cuore. Il chocolat du jour. Dopo una breve riflessione, Francie prese una scatola blu scuro dagli scaffali, sciolse il nastro di chiffon bianco e staccò il sigillo. Il coperchio si alzò come in una scatola di sigari, rivelando file di cioccolatini avvolti in una stagnola a stelle blu. Quelle piccole pepite erano gli strepitosi Baci Perugina. Un autentico capolavoro. «Serviti, Ginge.» Un Bacio per Ginger. Un Bacio per Francie. Persino scartare i nostri Baci era una cosa sublime. I bigliettini romantici nascosti nella stagnola erano consolatori quasi quanto il cioccolatino alla nocciola cremoso e croccante allo stesso tempo: entrambi promettevano un idillio travolgente nel prossimo futuro. Dato che nessuna delle due aveva molta fortuna in amore al momento, quei Baci erano doppiamente graditi. La vita acquistava un po’ di fulgore. L’era Reagan a Washington era un periodo di lussi e di eccessi. Le vie erano costellate di boutique eleganti, e signore mondane in visone entravano e uscivano dalle limousine. Era inverno, sempre inverno. Per due ragazze ancorate agli umili esordi dei genitori coreani in quel paese, lo sfoggio di ricchezza era quasi uno shock culturale. 12 Ciononostante, avevamo fatto le cose per bene chiedendo al nostro architetto di progettare una cioccolateria sciccosissima, all’ultima moda con lampadari italiani, pavimenti di marmo nero lucidati a specchio e tre espositori di vetro a bolle. Avevamo avuto la fortuna di prendere in affitto quel locale a un tiro di schioppo dalla Casa Bianca, in Connecticut Avenue. Ora il nostro negozietto innominato si affacciava come una Cenerentola tra Burberry e Cartier, un negozio che il nostro defunto padre avrebbe apprezzato solo in virtù del suo contenuto: cioccolatini e figlie. Fosse stato in vita, avrebbe potuto farci visita nella pausa pranzo, venendo a piedi dalla Banca Mondiale. E tuttavia, se lui fosse stato in vita, noi non avremmo mai avviato quell’attività. Qualche anno prima, la mamma aveva accompagnato papà in un viaggio di lavoro a Bangkok preceduto da una visita privata a Seul. Ma il loro viaggio aveva subito una brusca interruzione: papà era morto nel sonno al nono piano dell’Hyatt Regency Waikiki Hotel, per un attacco di cuore. A casa restammo sconvolti. Smarriti. Papà era il nostro punto di riferimento. In un mondo dov’eravamo cresciuti sentendoci fuori posto, dove persino alcuni vicini ci facevano sentire indesiderati in quanto asiatici, la presenza di nostro padre bastava a infonderci sicurezza. I suoi colleghi alla Banca Mondiale lo prendevano sempre in giro perché aveva sistemato la famiglia nel sobborgo piccolo borghese di Springfield anziché a Great Falls, e perché guidava una Gran Torino invece che una Mercedes-Benz. Ma papà si rifiutava di vivere 13 nel lusso in un pianeta dove le strade di Seul dopo la guerra erano ancora piene di orfani che chiedevano la carità. Si era lasciato alle spalle i loro volti tormentati, ma a volte lo stile di vita americano alimentava in lui un senso di colpa. La verità era che si sarebbe accontentato di un catorcio, pur di avere con sé la sua famiglia. Quell’ultima notte, se papà avesse saputo che non si sarebbe mai svegliato, non avrebbe mai preso sonno. La nostra sorella maggiore Grace e il fratello nato tra noi due, Sam, rimasero vicini, ma noi due diventammo come sorelle siamesi. E se caratterialmente eravamo come il giorno e la notte – Francie cupa, Ginger radiosa – senza papà l’unico modo per noi di sentirci intere fu di aggrapparci l’una all’altra, e così facemmo finché le nostre anime non si fusero insieme. Se fossimo rimaste unite, in qualche modo le cose sarebbero andate bene. Il nostro dolore era così profondo che solo la promessa di restare vicine e assistere nostra madre nella sua vedovanza ci permise di andare avanti. All’epoca Francie, che aveva all’attivo dei libri di poesia ma non sopportava l’ambiente letterario newyorkese, lavorava con scarso entusiasmo in un ufficio della George Washington University. Seguiva corsi specialistici di ogni tipo e usciva con un tenero professore che fumava marijuana. Visto che lei non voleva sposarsi, Jim fece le valigie, letteralmente, e andò a insegnare a Chicago. Quanto a Ginger, che frequentava un college della zona, si era invaghita del chitarrista Matt finché non si rese conto che lui teneva più alla sua chitarra che a lei. Così ben presto lo lasciò. Di colpo ci ritrovammo entrambe sole. Col nostro destino nel caos più totale. 14 Ginger viveva a casa della mamma con la nostra inconsolabile Goldie, una femmina di setter irlandese. Ogni sera alle sette in punto Goldie si piazzava sulla scala accanto al portone e aspettava che papà tornasse a casa dal lavoro. Francie aveva un appartamento in affitto più vicino alla città, anche se era da noi per metà del tempo. «Perché non vieni a vivere qui e risparmi i tuoi soldi?» le chiedeva la mamma. «Ci sono due stanze vuote.» «No grazie, mamma» rispondeva lei, con un abbraccio. A ventiquattro anni, Francie aveva bisogno di uno spazio tutto suo, un posto in cui fuggire anche solo un momento per rimuginare sui possibili scenari della sua carriera letteraria, anche se la sua frase ricorrente era: «Per ora non se ne parla». Doveva ancora riprendersi dalla morte di papà. Il cioccolato era il nostro cibo per l’anima, e passavamo le giornate sgranocchiando Baci Hershey e chiedendoci se fosse il caso di mettere in piedi un’attività insieme, investire in una nuova vita la piccola eredità lasciataci da papà. Un’idea non proprio campata in aria... Un tempo, quando eravamo la Sorella Grande e la Sorella Piccola, festeggiavamo ogni Natale intorno al finto albero argentato che la nostra famiglia tirava fuori dal solaio anno dopo anno. In uno di quei Natali, col caminetto che crepitava e scoppiettava, papà puliva la pipa mentre la mamma fumava le sue amate Virginia Slims. Ginger stava mettendo in scena uno spettacolo acrobatico per la famiglia, 15 un’emozionante sequenza di verticali, capriole e giravolte. Tra un sorso di sherry e l’altro, i nostri genitori osservavano la figlia più piccola annuendo e bisbigliando fra loro in coreano. Seduti sul divano a quadri fra le pareti di legno della nostra stanza dei giochi, si godevano quell’attimo rubato, uniti quasi come un’unica persona. A casa nostra avevamo sempre trascorso il Natale cantando canzoni coreane e mangiando caldarroste, piuttosto che scambiandoci regali costosi. Quindi Ginger non credette ai suoi occhi quando scartando una grossa scatola a strisce rosse e oro scoprì che il suo più ardente desiderio era stato esaudito: a sei anni era l’orgogliosa proprietaria di un Dolce Forno. «Non posso crederci!» esclamò, mettendosi a ballare per la stanza. «Scusa, Ginge, ma sei troppo piccola per farlo funzionare da sola» osservò Francie. La mamma sistemò il forno sul banco di formica gialla della cucina, a destra del lavello. Lì, di fronte a una finestra che dava sul cortile, passammo ogni mattina di quelle vacanze di Natale infornando a tutto spiano. La Bottega del Dolce Forno era in piena attività! A mezzogiorno tutta la casa profumava di dolce. Quando papà tornava dal lavoro, l’aroma che aleggiava, caldo e familiare, lo metteva di buon umore. «Le mie piccole fornaie si sono date da fare!» Noi sorelle ci scatenammo in quella vacanza, litigando, ridendo e leccandoci le dita, tutte prese da un forno che aveva come fonte di calore una lampadina della dimensione di un pollice. Bruciammo una lampadina dopo l’altra cuocendo torte in miniatura con gli appositi preparati, sfornandole con tale rapidità che avremmo 16 potuto metterci in affari. I preparati erano di vari tipi, ma un unico gusto dominava. Il cioccolato. Quando esaurimmo i preparati al cioccolato, fummo costrette a farci venire un’idea. Come trasformare le torte bianche in torte al cioccolato? Francie batté le mani. «Ho capito!» Mescolammo un cucchiaio o due di cacao al preparato per la torta bianca finché la polvere non assunse il colore del cioccolato. Poi aggiungemmo l’acqua e versammo l’impasto scuro nelle due mini tortiere. Col fiato sospeso infilammo le tortiere nel Dolce Forno e spiammo attraverso il vetro in attesa che le torte cominciassero a gonfiarsi. «Ci siamo, Ginge.» «Wow...» Quando le torte si furono raffreddate, Ginger diede prova del suo prodigioso ingegno in fatto di cioccolato. «Prendimi lo sciroppo!» Con un sorrisetto malizioso, distribuì col cucchiaio lo sciroppo sulla torta ormai fredda. La glassa, seppur troppo liquida, era un trionfo di cioccolato, come ogni briciola nera sul banco della cucina. Dunque, potevano la Sorella Grande e la Sorella Piccola essere socie in affari? Avevamo il vero spirito d’impresa per far funzionare la cosa? I sogni erano realizzabili. I nostri genitori, sopravvissuti alle durezze del dominio giapponese e alla guerra di Corea, ne erano la prova. Papà, costretto nell’unica stanza di una capanna di fango con una famiglia di otto persone, aveva un talento in grado di strapparlo alla miseria: un dono per le lingue. Era riuscito ad arrivare 17 all’università di Harvard e alla Banca Mondiale, finché un giorno aveva comprato la casa dei suoi sogni in un sobborgo della Virginia dove aveva creato il suo giardino e costruito la sua vita. Nel frattempo la mamma, con un inglese tutto suo personale, si era imposta come regina di casa Park, e pur essendo stata servita a tavola dalle cameriere per tutta l’infanzia, aveva imparato a cucinare banchetti coreani che i vicini potevano solo sognare. Il fatto che i nostri genitori fossero arrivati in America con nient’altro che i vestiti che avevano indosso ci portava a credere che anche noi avremmo potuto realizzare ogni nostro obiettivo. Poiché avevamo una dipendenza dal cioccolato ben prima che qualcuno diagnosticasse una simile sindrome, aprire un negozio di dolci ci parve la cosa più naturale del mondo. Cominciammo a sognare un negozio pieno di cioccolato fino all’orlo, con un aroma che si spandeva nella via attirando i passanti. Forse ci saremmo anche fatte degli amici. Avremmo costruito la nostra attività e la nostra vita, una vita piena, intorno al cioccolato. Il negozio sarebbe stato la nostra seconda casa. L’unico problema? Eravamo come due topini ciechi che non sapevano quel che stavano facendo. Come diavolo si costruisce un mitico castello di cioccolato? Non riuscivamo neppure a trovargli un nome. Chocolate Heaven? No. The Chocolate Bar? No, no. A Chocolate Affair? No, no, no. A parte la mamma, che scelse di essere la nostra socia occulta, molti pensarono che fossimo impazzite a metterci in affari, specie in un periodo in cui i tassi di interesse dei certificati di deposito bancari andavano dal 18 diciotto al ventuno per cento. Voi ragazze non avrete mai un rendimento del genere. Quanto cioccolato potete vendere, concretamente? E poi non avete alcuna esperienza. Andate sul sicuro. Continuate a fare quel che state facendo. Noi non li ascoltavamo. Avevamo trovato la nostra vocazione. Inoltre eravamo certe di avere la benedizione di papà. Nella sua vita aveva realizzato molti sogni, ma non quello più importante: tornare nel suo paese devastato dalla guerra e contribuire a cambiare le cose; forse addirittura candidarsi alla presidenza. All’ultimo anno dell’università di Yonsei, papà era stato nominato segretario personale del primo presidente eletto del paese, Syngman Rhee; dato che parlava un ottimo inglese, il suo compito era fare da intermediario tra la Corea e gli Stati Uniti. Ma la guerra avrebbe cambiato il destino di tutti, compreso il suo. Durante i suoi anni di specializzazione ad Harvard il clima politico in Corea si fece più pericoloso che mai, e lui finì non solo per rimandare il suo sogno ma anche per ridefinire i suoi progetti in America. La vita in quel paese gli dette piacere e soddisfazione. Ma nel 1979 i tempi si fecero maturi, sia dal punto di vista politico sia da quello personale. Ginger stava per prendere il diploma di scuola superiore, e a lui fu offerto un posto di governo in Corea. Era pronto ad andare a Seul per dei colloqui che, sperava, avrebbero esaudito il suo sogno. Tragicamente, fu in quel viaggio che perse la vita. Sì, avevamo la benedizione di papà momento per momento. E non lo avrebbe sorpreso scoprire che stavamo ancora pensando al cioccolato. 19 Un giorno Ginger estrasse dal forno una teglia di brownies per farli raffreddare, mentre Francie al tavolo della cucina in casa della mamma – il nostro “quartier generale” d’elezione – sfogliava cataloghi di vendite all’ingrosso arrivati da Ghirardelli di San Francisco e dall’olandese Droste. Stavamo cercando di escogitare un nome per il nostro futuro negozio. Concentrati, accidenti, concentrati... Eravamo troppo distratte dall’aroma dei brownies. Ginger tagliò per sua sorella una porzione grossa quasi come il tovagliolino di carta su cui era servita. Il primo morso di Francie fu accompagnato da uno smaccato grugnito di piacere. «Dove hai trovato questa ricetta? Sono così cioccolatosi.» «Niente ricetta» rispose Ginger con la bocca piena. «Ho solo aggiunto delle gocce di cioccolato, così sono due volte più intensi. Doppio cioccolato.» Francie leccò le briciole con occhi sognanti, semichiusi. «Chocolate... chocolate...» Ginger la guardò. «Cos’hai detto?» «Ho detto...» In quell’attimo ci venne un colpo di genio. «chocolate chocolate!» Battemmo un cinque. Ci abbracciammo. Ci lanciammo in una danza sfrenata. Ginger tagliò il resto dei suoi brownies in cubetti monoporzione. Li divorammo, affamate. «Sai, dovresti pensare a un tuo cioccolatino d’autore» suggerì Francie. «Solo uno, per farci conoscere.» «No, troppo stress.» 20 «Potrei darti una mano.» «Sei un disastro in cucina» commentò Ginger sputando briciole. «Non sai nemmeno setacciare la farina.» Leccandosi le dita, Francie rise. «Com’è vero.» Poco dopo tutt’e due rinunciammo ai nostri rispettivi impegni. Non più smarrite, avremmo progettato la nostra vita insieme; affiancate dalla mamma, naturalmente. E anche da papà, in spirito. 21 Capitolo 2 Mela di Cioccolato Una mela di cioccolato al latte che, leggermente battuta, si apre in venti spicchi perfetti Tra sognare una cioccolateria e averne davvero una c’era un’enorme differenza. Prive di esperienza nel commercio al dettaglio – a meno di non prendere in considerazione il lavoro estivo di Francie da Giant Music, dove lei era più interessata ai ragazzi coi capelli lunghi che a vendere dischi; oppure lo shopping compulsivo di Ginger – ci eravamo imbarcate in un’impresa non da poco. Prima fase, ricerca. Ci facemmo spedire degli opuscoli dal Servizio alle Piccole Imprese, studiandoli al tavolo di cucina della mamma come fossero bibbie. Attraverso il Servizio ci iscrivemmo a un corso tenuto da un’associazione di imprenditori in pensione, che ci insegnarono la regola d’oro per il successo: scegliere l’ubicazione giusta. Con la certificazione del Servizio alle Piccole Imprese, ci imbarcammo in una ricerca a tempo pieno della sede, spulciando gli annunci sul «Washington Post». Caffè, penna... Ogni mattino portava con sé una nuova speranza. «Segna questo» disse Francie indicando un’offerta a Foggy Bottom. «È uno spazio nel centro commerciale 22 di Red Lion Row al 2000 di Pennsylvania Avenue, proprio accanto al mio vecchio ufficio. Ci sono tantissimi studenti lì.» «Okay.» Ginger tracciò un cerchio. «Guarda, c’è un altro spazio in Pennsylvania Avenue.» Francie arricciò il naso di fronte a quell’indirizzo sospetto. «È la parte sbagliata di Pennsylvania, Ginge. Devi cercare a nord-ovest, non a sud-est.» La solita sorella maggiore. Gli annunci della domenica spesso riempivano tre colonne, e il supplemento economico del lunedì era pieno zeppo di possibilità. Gli innumerevoli incontri con intermediari e agenti sbruffoni ebbero l’unico effetto di farci capire come funzionava l’affitto dei piccoli esercizi. Anzi, diventammo piuttosto disinvolte nell’uso del gergo immobiliare, riuscendo a dire «Va’ all’inferno» senza fare una piega. Per mesi battemmo in macchina l’area metropolitana per controllare i negozi liberi, trovandone persino qualcuno che ci piaceva. Quando la mamma non veniva con noi, presidiava il nostro quartier generale, fumando Virginia Slims e giocando a Yamagada, il solitario asiatico. Quando iniziava un solitario, il suo mazzo di carte conteneva tutte le risposte dell’universo, o almeno la risposta alla domanda se quel giorno avremmo trovato il posto giusto. «Trovato qualcosa, ragazze?» «Oggi no, mamma.» Perché non bastava un posto qualsiasi. Doveva essere perfetto. E finalmente accadde: posammo gli occhi sul nostro Oz, un palazzo di marmo da un milione di dollari con 23 un imponente lucernario inondato di sole, affacciato su un marciapiede affollato di gente che passeggiava accompagnata dalle note di una tromba suonata dal vivo. Fu amore a prima vista. E nella nostra eccitata fantasia il locale vuoto all’angolo della lobby d’ingresso, uno spazio piccolo e scintillante come un diamante, era nostro, il luogo perfetto per il nostro castello di cioccolato. Vicino alla fermata Farragut North della metropolitana, affacciato sia sulla strada sia sulla lobby, era uno spazio con una collocazione ideale nel centro cittadino dov’erano situati quasi tutti i potenti studi legali della capitale, fatto su misura per quello che allora non era che un bel sogno: Chocolate Chocolate. Armate di una proposta, contattammo l’agente immobiliare del proprietario, che al telefono ci sembrò un subdolo e gelido squalo. Dopo averci rivelato che il proprietario aveva in mente di affittare quel particolare spazio a una cioccolateria di alto livello, lo Squalo specificò che lo interessavano solo negozi in grado di attrarre una clientela internazionale, non due ragazze ignoranti che leggevano gli opuscoli del Servizio alle Piccole Imprese. Il nostro progetto non contava niente per lui, mentre noi avevamo solo quello. In città c’erano già vari negozi che vendevano cioccolatini americani monomarca come Chez Chocolat e Fannie May. Noi invece volevamo accompagnare i cittadini di Washington in un viaggio più avventuroso, proponendo una rassegna internazionale di cioccolato che andasse da Zurigo a Bruxelles a Baltimora a San Francisco. Se gli altri patiti del cioccolato somigliavano a noi, a volte cercavano il piacere segreto di un tartufo 24 europeo ripieno al liquore, e a volte non avevano altro desiderio che addentare una classica barretta americana al caramello. «Mi spiace,» disse lo Squalo in tono piatto «quello spazio l’ha già preso Godiva.» Nel 1983, Godiva era l’azienda leader nel mercato americano del cioccolato di qualità, modellata sull’omonimo produttore belga. I loro prodotti erano meravigliosi. Con un’ultimo assalto, lo Squalo aggiunse: «Firmeranno la settimana prossima». Clic. Col cuore infranto, riprendemmo la nostra ricerca. In macchina e a piedi, cercammo invano la migliore alternativa a disposizione. Sui giornali si parlava molto della rivitalizzazione dell’area a est di quello che per noi era il centro cittadino – la zona intorno al corridoio di F Street, le cui fortune commerciali si erano estinte nel 1968 coi disordini seguiti alla morte di Martin Luther King – e dunque andammo a vedere. Ma a parte i grandi magazzini come Hecht’s, Woodies e l’elegante Garfinckel’s, dove nostra sorella Grace lavorava come buyer nel settore abbigliamento, i locali vuoti che c’erano in mezzo erano improponibili. Vetri tenuti insieme col nastro adesivo, rifiuti per la strada, cocci di bottiglie di birra ovunque. «Che posto!» esclamò Ginger passandoci in macchina. «Accelera!» Forse quella zona sarebbe tornata a vivere prima o poi, ma non adesso. Del resto, non riuscivamo ad appassionarci a quella ricerca – ripiegare sulla seconda scelta non era la stessa 25 cosa – e finivamo per tornare sempre allo stesso locale con la stessa recriminazione. «È questo il posto che fa per noi.» Una settimana dopo passammo di nuovo davanti al negozio e Ginger rallentò a passo di lumaca. Francie scosse la testa, non voleva soffrire per l’ennesima volta. «Perché farci del male? Non voglio vedere l’insegna di Godiva.» «Ehi,» osservò Ginger «non c’è ancora.» Francie annuì. «Interessante.» Passò un’altra settimana. Transitammo di nuovo lì davanti, trattenendo il respiro. «Ehi,» osservò anche stavolta Ginger «ancora nessuna insegna di Godiva.» «Molto interessante.» Morivamo dalla voglia di sapere cosa stava accadendo laggiù, così un giorno facemmo il giro dell’isolato cinque o sei volte cercando inutilmente un parcheggio. «La lascio in doppia fila,» decise Ginger, fermandosi sul lato opposto della strada «proprio qui.» Poi, scansando il traffico delle auto, andammo a spiare nel locale. Vuoto. «Chiamiamo di nuovo lo Squalo?» disse Ginger. «Cos’abbiamo da perdere?» rispose Francie appannando il vetro col fiato. Decidemmo che lo Squalo, per quanto feroce, non poteva farci del male, specialmente al telefono. «L’accordo con Godiva è saltato» ci disse lui seccamente, forse augurandosi che noi pesci piccoli andassimo a sguazzare altrove e non tornassimo più. «Ma sono in trattative con una signora che vuole aprire una filiale di Kron e sta per firmare il contratto.» Kron, un altro grosso nome nel settore, era famoso 26 per i suoi tartufi originali e per i cioccolatini a forma di parti del corpo. Lasciammo i nostri numeri di telefono allo Squalo nel caso Kron si fosse tirato indietro, convinte che li avrebbe accartocciati appena chiusa la telefonata. Poi tornammo a malincuore alla nostra routine, cercando altri locali ma continuando a sognare lo spazio d’angolo vuoto nel magnifico edificio di marmo. Il nostro spazio. Il tempo trascorse senza traccia dell’insediamento di Kron, e senza nuovi siti da amare. Proprio mentre ci chiedevamo se richiamare lo Squalo, il telefono squillò in casa della mamma. Francie, concentrata sugli annunci economici, rispose alla chiamata. Era Ben, un gentile avvocato dell’ufficio del proprietario, che sostituiva lo Squalo attualmente in vacanza. Francie fece un cenno a Ginger, che si mise in ascolto sull’altro apparecchio. La sorte doveva essersi accorta di noi, perché Ben stava per avviare un dialogo che avrebbe cambiato il corso della nostra vita. «Ho qui una nota che dice che le sorelle Park hanno chiesto informazioni sullo spazio commerciale libero in...» I nostri occhi si incollarono come calamite. «Sì.» Alleluia! Anche la trattativa con Kron era saltata. Fissammo un appuntamento per l’indomani. Non eravamo nuove agli incontri, ma questo aveva un’importanza fondamentale e di colpo fummo grate a tutti gli intrallazzatori che avevano cercato di arricchirsi a nostre spese. Ora eravamo esperte in tema di affitto e di indennità per migliorie al negozio. Ci preparammo all’incontro con Ben truccandoci e provando allo specchio le nostre controfferte e le nostre richieste. Un negoziato. Fingersi donne di mondo 27 non era facile per noi, specie con la mamma che ci osservava a braccia conserte dallo specchio, ma il nostro legame ci dava sempre forza, o almeno così speravamo. «Cosa ti metti, Ginge?» «Il mio nuovo tailleur Tahari. Mi fa sembrare autorevole, non credi?» «Sì, e pure il Siren Red» rispose Francie, svitando un tubo di rossetto per mostrarmelo. Nel frattempo la mamma agitava il dito, aveva la sua da dire. «Chiedete l’indennità per migliorie. Ventimila dollari, non un centesimo di meno.» Annuimmo entrambe allo specchio. Dopo tutto, il nostro socio occulto era il vero boss. Appena prima di uscire ci esaminammo a vicenda. «L’abito è fantastico» disse Francie, impugnando le forbici «ma sarà meglio togliere il cartellino, Ginge.» Anche l’insieme di camicetta bianca e gonna nera di Francie ottenne l’approvazione di Ginger. «Sembri proprio un pezzo grosso.» Francie si pavoneggiò nella sua tenuta. «Sono le spalline imbottite, tesoro.» Quando arrivammo all’ufficio del proprietario, eravamo truccate, imbottite e profumate con lo Chanel della mamma. Ciononostante, Ben non provò nemmeno a nascondere il suo stupore quando ci vide. «Quanti anni avete?» «Più di venti» rispondemmo. «Okay...» fece lui con aria dubbiosa. Nel frattempo ci prendemmo la libertà di riempirgli la scrivania di variopinti cataloghi di cioccolatini. Lui reagì con un sorriso controllato. «Devo supporre che queste siano le linee di prodotti che vorreste proporre.» 28 «La punta dell’iceberg» rispose Francie. «Non le sembra quasi di sentire l’aroma del cioccolato?» intervenne Ginger, prendendo dalla borsetta una piccola scatola con la famosa Mela di Cioccolato al latte Droste. «Sì,» dovette ammettere lui «è vero.» Ginger posò sulla scrivania la mela avvolta in una stagnola azzurra, le diede un colpetto con le dita, poi la scartò. Con grande sorpresa di Ben, la mela si aprì a ventaglio in venti perfetti spicchi di cioccolato. «Posso?» domandò lui, prendendo uno spicchio. «Naturalmente.» «E poi» si lasciò trasportare Francie «la nostra piccola pasticciera Ginger presenterà il suo personale chocolat de vie il giorno dell’inaugurazione!» «Devo dire» fece Ben senza accorgersi del calcio che la Sorella Piccola aveva appena sferrato alla Sorella Grande sotto la scrivania «che ho l’acquolina in bocca.» Se Ben aveva delle perplessità, queste scomparvero non appena gli sottoponemmo la nostra situazione finanziaria. Anche nella morte papà si era preso cura di noi. Cresciuto così povero in Corea da pesare meno di quarantacinque chili il giorno del suo matrimonio, aveva giurato che sua moglie e i suoi figli non avrebbero mai vissuto un solo giorno con problemi economici, e tanto meno di fame. La nostra famiglia viveva modestamente mentre lui risparmiava saggiamente. Con l’eredità che ci aveva lasciato, unita alle finanze della mamma, avevamo un portafoglio notevole. Tuttavia, quando Ben ci comunicò l’ammontare dell’affitto, deglutimmo e ci scambiammo un pizzicotto sotto la scrivania. La cifra era due volte quella di mercato per un piccolo negozio in quel quartiere. Spalleggiando29 ci a vicenda, facemmo subito una controfferta con quattrocentocinquanta dollari in meno per metro quadro. «Inoltre,» intervenne di nuovo Francie «chiediamo anche un’indennità di ventimila dollari per migliorie.» «Cosa?» «Costerà parecchio ristrutturare questo negozio, e non possiamo accollarci tutta la spesa» spiegò coraggiosamente anche se un po’ goffamente Ginger. «Ventimila dollari, è la nostra ultima offerta.» Miracolosamente, e senza consultare il proprietario, Ben accettò entrambe le nostre condizioni, dimostrando che avevano un disperato bisogno di riempire subito quello spazio tanto quanto noi lo avevamo di occuparlo. Nessuno voleva rischiare. Nei giorni successivi definimmo alcuni dettagli minori dell’accordo, e quando la Federal Express recapitò il contratto definitivo al nostro quartier generale firmammo tutte e tre negli appositi spazi. Poi la mamma stappò una bottiglia di Chablis Gallo per sé e per Francie, e una di tè freddo per Ginger, l’astemia. «Un gran giorno!» esclamò. Passo successivo: ingaggiare un architetto. Mitchell Mirage era una specie di tumore al polmone ambulante: non riusciva a dire una frase senza un violento accesso di tosse. A volte ci chiedevamo se sarebbe vissuto abbastanza da veder terminare il nostro progetto. La sua rude schiettezza, e la sua reputazione, ci rassicuravano sulle sue capacità. «Lo spazio è piccolo,» disse con un poderoso attacco di tosse, seduto al tavolo da riunioni del suo ufficio con vista sul C&O Canal «una scatola da scarpe rispetto alle vostre ambizioni. Ma io amo le sfide.» 30 Mitchell era abituato a progettare centri commerciali e ristoranti alla moda con scale a chiocciola, non boutique grandi come scatole da scarpe. Ma in qualche modo, tra una sigaretta e l’altra, riuscì a mettere su carta la nostra idea, rispettando persino tutte le leggi, i regolamenti e le esigenze burocratiche. I suoi schizzi e i suoi progetti ci entusiasmarono, e l’idea che a breve quelle immagini sarebbero diventate realtà ci parve quasi inconcepibile. Insieme a pavimenti e pareti di marmo nero lucido e alle lampade italiane, i disegni prevedevano dei faretti sopra gli espositori, le cui scaffalature cromate avrebbero prodotto un effetto di rifrazione della luce. Il retrobottega avrebbe ospitato tutti i lavelli obbligatori per i negozi di dolci – un lavello a tre scomparti, un lavamani e un lavatoio per gli stracci – lasciando nella stanza uno spazio appena sufficiente per ballare un lento, ammesso che ci fosse qualcuno con cui farlo. Un giorno di primavera del 1983, un giorno di limbo in attesa che il proprietario approvasse i progetti, andammo in centro con l’unico obiettivo di guardare semplicemente il negozio, il nostro negozio. Washington, grazie al fiume Potomac e all’architettura più maestosa del paese, è una città spettacolare in ogni stagione dell’anno. Ma in primavera è insuperabile. Immaginate la cupola del Campidoglio e il Tidal Basin, lo Smithsonian Castle e il monumento a Washington, fiancheggiati da incantevoli narcisi, tulipani e magnolie, col sole che gioca su ogni superficie. I ciliegi erano in piena fioritura quando attraversammo l’Arlington Memorial Bridge e aggirammo il Lincoln Memorial; come al solito, Ginger era al volante, 31 preferiva guidare che girarsi i pollici tutto il giorno. Col suo carattere esuberante, avrebbe voluto abbassare il finestrino e gridare «Eccoci, Washington!», ma sua sorella aveva un altro passo. Negli ultimi tempi Francie preferiva mantenere un basso profilo, fare una vita tranquilla e pacifica. Tra noi non c’era mai stato bisogno di parole, visto che eravamo perfettamente a nostro agio l’una con l’altra, un agio che risaliva alle nostre scorribande infantili da Safeway o 7-Eleven per comprarci qualcosa di dolce: Sorella Grande, Sorella Piccola. Quella parte scenografica della città – con turisti, tram e alberi fioriti – ci metteva quasi in soggezione. Sebbene la nostra famiglia vivesse nell’area metropolitana dal 1960, il sobborgo in Virginia dove abitavamo era a una trentina di chilometri di distanza sulla I-395, e ad anni luce di differenza. Era più simile a una cittadina di provincia, e probabilmente noi eravamo meno sofisticate di quanto fossimo disposte ad ammettere. Quando imboccammo Constitution Avenue si mise a piovere, e gli ombrelli spuntarono come funghi sul sentiero sinuoso che portava al nuovo monumento ai veterani del Vietnam. La pioggia si infittì, e occasionali petali rosati vennero a planare sul parabrezza. Svoltando a sinistra nella Diciottesima Strada, attraversammo il quartiere di Foggy Bottom, sede dell’università George Washington e della Banca Mondiale, alzando gli occhi verso l’edificio al 717 come se papà potesse guardarci dalla finestra del suo ufficio al settimo piano. Erano davvero trascorsi quattro anni dalla sua morte? Quattro anni. Eppure, a volte, sembrava di più... Superammo Pennsylvania Avenue, e dopo una sfilata di palazzi e 32 tende rosse e gialle girammo a destra, fino alla nostra destinazione. Il nostro Oz. «Siamo a casa, Francie.» «Lo so.» Col suo maestoso ingresso di vetro, Oz dominava un incrocio considerato la versione locale di Times Square, senza il degrado. Sì, il centro di Washington era tirato a lucido, ma quel che lo faceva risplendere davvero quel giorno, almeno ai nostri occhi, era un cartello apposto su un pannello di legno: prossima apertura: chocolate chocolate. Nella lobby contrassegnata dal viavai di impiegati in pausa pranzo, Ginger prese sottobraccio Francie. «Ascolta.» Due persone ripetevano in coro «Chocolate Chocolate», in continuazione. «Chocolate Chocolate, Chocolate Chocolate, Chocolate Chocolate...» Era un coro in cui rivivevano i nostri sogni di tanti anni. Uno di quei momenti che non capitano tutti i giorni. Come cioccolata liquida versata in uno stampo, il nostro sogno stava cominciando a prendere forma. 33
Scarica