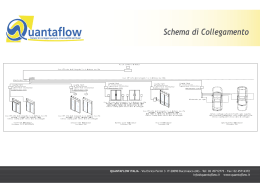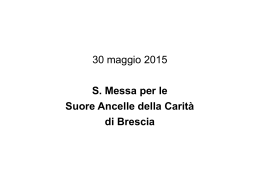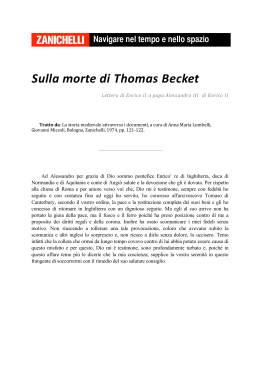DON ENRICO: UN PRETE GUIDATO DALL’AMORE di Silvio Longobardi Tutto è cominciato nel 1949 o forse nel 1941 … sembra una bella favola, e invece è la storia di un prete infiammato dalla carità. Don Enrico Smaldone fu consacrato sacerdote il 13 luglio 1941, nel contesto di una guerra che rendeva ancora più gravosa l’atavica povertà della nostra terra. In questo contesto il giovane prete iniziava il suo ministero, con tutta la passione e l’ingenuità di chi sogna di costruire un mondo nuovo. IL BUON PASTORE Il conflitto bellico aveva lasciato dovunque morti e distruzione, profonde ferite nella carne e nello spirito. Anche la città di Angri era stata duramente colpita, occupata dai tedeschi e bombardata dagli alleati che erano sbarcati a Maiori e scendevano dal valico di Chiunzi. Sono esperienze che nessuno può dimenticare, immagini che s’imprimono nella mente e nel cuore. La fine della guerra offre a tutti la libertà di ricominciare. Anche don Enrico si mette subito a lavoro: nel ’45 fonda un gruppo Scout, si reca lui stesso a Roma per prendere contatti con i dirigenti nazionali dell’associazione cattolica. Questa scelta fa emergere il suo amore per la gioventù, il desiderio di offrire ai ragazzi spazi di sana aggregazione e di spiritualità. In quegli anni è anche assistente della FUCI, la federazione universitaria dei cattolici, assistente della Confraternita di Santa Caterina, cappellano delle suore Battistine. Ma tutto questo non basta. Porta nel cuore un desiderio, lo tiene nascosto con pudore, come una madre custodisce il suo bambino quando è ancora nel grembo. Pochi anni dopo, quando darà inizio al progetto della Città dei Ragazzi, confesserà ai giovani di Azione Cattolica: “la mia idea non è un’avventura, ma il frutto di una lunga profonda meditazione. È da anni che io penso alla costruzione di una casa che avrebbe dovuto dare asilo a tanti fanciulli abbandonati nella vita cui la morte aveva strappato i sacri affetti dei genitori, ma le immani difficoltà mi hanno sempre trattenuto da questa idea”. Pronuncia queste parole l’11 febbraio 1949, ha 34 anni e da meno di otto è sacerdote. Quando dice che pensa “da anni” alla costruzione di una casa per i fanciulli abbandonati, vuol dire che quel sogno è nato nel tempo della guerra, dinanzi alle tragiche conseguenze del conflitto. Mentre gli altri guardavano rassegnati, quel che accadeva, lui si sentiva interpellato. Erano suoi quei bambini che vedeva abbandonati e senza una casa. Glieli aveva affidati il Padreterno. Aveva imparato dal Vangelo che il buon pastore non fugge dinanzi al lupo ma cerca in tutti i modi di salvare le sue pecore. Non importa se questo vuol dire mettere a rischio la propria vita. Un pastore non si rassegna, non consegna agli altri i figli che la Provvidenza affida. Risponde di persona. La carità è figlia della fede, è l’espressione matura di quella paternità che don Enrico ha ricevuto nel giorno dell’ordinazione sacerdotale. Don Enrico sente la chiamata a servire i ragazzi e i giovani. L’impegno scoutistico è solo una prima risposta di una missione che poco alla volta mette radici nel suo cuore. Non era sufficiente, lui lo sapeva. Ma aveva paura di condividere i suoi pensieri, anche con gli amici più stretti, quelli che l’avevano aiutato a iniziare l’avventura Scout. Forse temeva di essere giudicato un illuso. E, più ancora, aveva paura di illudere gli altri, di coinvolgerli in un’avventura troppo grande rispetto alle sue forze. Ma i sogni di Dio non muoiono all’alba, sono come rampicanti che si aggrovigliano attorno al cuore e non lasciano respirare. In una lettera che don Enrico scrive nel 1950 agli amici e collaboratori che condividono con lui il progetto della Città dei Ragazzi, leggiamo:“stamane alle ore 10,45 il Signore, che è il primo architetto e costruttore della nostra Città, ci ha aperto la più grande strada”. Il prete angrese si trova a Roma dove bussa a mille porte per ottenere contributi e aiuti. Ma egli sa bene – e lo comprende ancora meglio in quell’esperienza di mendicanza – che tutto viene da Dio. È questa la segreta certezza che muove don Enrico, la fonte da cui scaturisce l’audacia di sognare ideali così grandi. IL CONTESTO La decisione di costruire una casa per i fanciulli è certamente audace. Ma nasce in un contesto ecclesiale che ben conosce questa forma di carità pastorale. Don Enrico, infatti, nasce in via Ardinghi, a due passi dalla Casa Madre della Congregazione di san Giovanni Battista, che un altro prete di Angri, il beato Alfonso Maria Fusco ha avuto il coraggio di fondare nel 1878. E cresce in un ambiente nel quale si respirava ancora il profumo di quel prete santo – il Fusco era morto nel 1910, quattro anni prima della nascita di don Enrico – che tanti avevano conosciuto di persona. D’altra parte, le sue suore erano lì, silenziose e attive testimoni di quell’eroica carità che aveva fatto di Angri un luogo in cui le fanciulle povere e abbandonate potevano trovare una casa e una famiglia. Don Enrico conosceva bene anche l’opera del laico Bartolo Longo, anche lui beatificato, che aveva eroicamente intrecciato l’esperienza di fede con quella della carità, facendo di Pompei la città di Maria e dei bambini orfani e abbandonati. Va anche detto che in quegli stessi anni lo Spirito Santo aveva suscitato ovunque uomini di buona volontà che impegnarono le loro migliori energie per una ricostruzione materiale e morale. Tra gli altri spiccava la figura di don Carlo Gnocchi, cappellano militare, che nella seconda metà degli anni ’40 dava inizio all’opera Pro Juventute a favore degli orfani di guerra e dei piccoli mutilati, vittime innocenti della guerra. Questo impegno ebbe una grande risonanza in Italia e all’estero e contribuì a far maturare tante altre opere di carità. Il contesto sociale in cui vive don Enrico è dunque segnato da situazioni drammatiche ma anche attraversato da angeli vestiti con la tonaca che si prendono cura dei più deboli e, in particolare, di quelli più piccoli. Vive in una Chiesa che non si limita a predicare la carità ma sa anche praticarla, diventando così una luce che rischiara il cammino di tutti. Una legge non scritta della vita comune dice così: il bene fatto da pochi sprona anche la maggioranza silenziosa a fare di più. Don Enrico si lascia contagiare dagli altri e, a sua volta, pensa di poter contribuire allo sviluppo di una più matura coscienza civile e morale del nostro Paese. Nel manifesto pubblicato agli inizi del mese di febbraio del 1949 definisce la costruenda Città dei Ragazzi un “monumento di amore segnacolo di civiltà per il nostro paese”. Per questo, fin dall’inizio, e con ostinata insistenza, coinvolge la cittadinanza di Angri nel progetto; vuole renderla partecipe e protagonista di quella storia di carità. Ai giovani esploratori di Azione Cattolica, che hanno accolto subito e con gioia il suo progetto, don Enrico indirizza questa calda esortazione: “Miei carissimi giovani, la costruenda città dei ragazzi si avvalorerà della vostra preziosa cooperazione. Lasciate scaturire dai cuori la forza per il bene, perché chi non sa uscire fuori di sé stesso, o non sa prodigarsi del (sic) prossimo, non è degno dell’età nostra e della professione cristiana” (11 febbraio 1949). Lo sviluppo di una nazione, come aveva ben intuito il nostro apostolo, non si misura solo con le coordinate socio-economiche ma anche con un’accresciuta coscienza morale che fa nascere una concreta condivisione verso i più deboli. Don Enrico invita a vincere ogni sterile ripiegamento egoistico. Solo la carità dà alla storia un volto più umano e, proprio per questo, più evangelico. LA SCELTA Quando racconta la genesi della sua decisione, don Enrico insiste sulla visione di un film, avvenuta agli inizi del 1949. Scrive nel suo diario: “La visione del film mi accese la febbre nelle vene. Tornai a casa sconvolto. E questo turbamento mi durò per giorni”. Quel film fu solo la miccia che diede fuoco alle polveri. In realtà l’idea di fare qualcosa per i ragazzi dimorava già dentro di lui, da “molti anni”, come lui stesso confessa. Quel “nobile ideale”, così lo chiama don Enrico, appartiene intimamente alla sua vocazione e diventa un tutt’uno con la sua vita. Scrive infatti: “Ho lottato per molti giorni contro questa idea. Ma non ci sono riuscito, mi accorsi che l’idea era un altro me stesso, era tutta la vita della mia anima, per cui lottare contro l’idea significava lottare contro me stesso,rinunziare ancora a quell’idea significava rinunziare alla mia stessa vita” (11 febbraio 1949). “La visione di quel film fece rivivere più forte l’idea”. E tuttavia, ancora non si decide, combatte con se stesso. Nel mezzo di questa lotta interiore giunge un altro segno: “Meditavo a lungo. Quando una mattina picchia alla porta un bimbo di otto o nove anni. Lacero, sporco, coi capelli arruffati, portava in viso i segni della sofferenza. Gli offrii l’altra metà del caffè che stavo sorbendo e lo invitai a parlare”. L’incontro gli permette di conoscere di persona la sofferenza fisica e morale che dimora in un bambino abbandonato. Conosceva i numeri del dramma, alcuni mesi dopo parlando in una parrocchia di Pagani, disse: “Nella nostra provincia se ne contano ben diecimila di questi derelitti”. Una cosa è sapere che esiste un problema, altra cosa è incontrare qualcuno che vive quel disagio, lo porta nella sua carne. Il giovane prete sentì nel profondo del cuore che quella storia lo interessava, lo coinvolgeva; e capì che doveva investire in essa gli anni della sua esistenza. Quell’incontro fu per lui il segnale decisivo, capisce che deve rompere gli indugi. Era giunto il momento di partire. Quando vide il film don Enrico aveva da poco compiuto 34 anni. La sua scelta aveva tutta la passione e l’entusiasmo della giovinezza ma anche la forza e la maturità dell’uomo adulto che ha imparato a fare i conti con la vita. Era sacerdote da otto anni, aveva accumulato una discreta esperienza pastorale a contatto con i giovani. Ma soprattutto aveva acquisito quella vita interiore che permette di coniugare preghiera e opere, ascolto di Dio e servizio del prossimo. Don Enrico non insegue un sogno, per quanto bello e suggestivo, egli sa di rispondere ad una precisa chiamata di Dio. I sogni alimentano illusioni. Quando invece è Dio che chiama, la sua Parola ha la forza di spaccare le rocce (Ger 23,29). Se vogliamo comprendere don Enrico e l’opera che lui ha realizzato, se vogliamo capire dove attinge la forza per affrontare e vincere tante difficoltà, dobbiamo partire dalla sua esperienza più intima, dalla costante preghiera che accompagna i suoi passi. Certo, quel ragazzino cencioso interrogava la sua coscienza di uomo e di pastore, ma era Dio che lo obbligava a intervenire, quel Dio al quale aveva deciso di consacrare la propria esistenza. La sua non è solo un’opera sociale ma anzitutto una scelta di fede, come lui stesso dichiara: “E fu allora che innanzi a Dio e innanzi a questi fanciulli io assunsi decisamente l’impegno dell’istituzione di una Città dei ragazzi che avrebbe redento questi fanciulli” (11 febbraio 1949). Il prete è un uomo che ha rinunziato a fare progetti, si lascia guidare dalla Chiesa e dalla Parola di Dio che risuona nei sacri testi e che, a volte, si nasconde negli eventi. Questa coscienza dona una forza che non possiamo misurare con le categorie umane. Don Enrico non nasconde le difficoltà del progetto ma sa anche che la fede è capace di spostare le montagne. Per questo s’incammina con una decisione che all’esterno potrebbe apparire frutto di una baldanza giovanile, in realtà, la sua è solo l’audacia degli umili. OPERA DELLA COMUNITÀ ECCLESIALE Come ogni buon pastore, don Enrico vuole stare in prima fila senza essere per forza – e a tutti i costi – in primo piano, vuole combattere in prima persona la battaglia della fede e della carità, assumendosi tutti i rischi, ma non vuole farlo da solo. Il prete è chiamato a condividere con tutti i carismi che ha ricevuto in modo da suscitare un sano protagonismo nella comunità ecclesiale. È questa l’indispensabile premessa per fare di ogni opera di carità un segno di Chiesa, la visibile testimonianza non tanto dell’eroismo di qualcuno quanto della fede di un’intera comunità. Questo criterio ha sempre accompagnato la sua vita. Per questo, forse, non si è preoccupato di creare una specifica istituzione alla quale affidare le sorti della Città ma ha consegnato alla Chiesa locale i suoi beni e i suoi sogni. Il testamento, che abbiamo voluto riproporre in questo volume, parla chiaro: “Col presente testamento olografo col quale revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria, istituisco erede universale del mio patrimonio la Mensa Vescovile di Nocera dei Pagani. Desidero che i miei immobili adibiti a Città dei Ragazzi conservino la loro destinazione con le modalità che l’Eccellentissimo Vescovo pro tempore vorrà determinare”. I santi sono una risorsa per la comunità ecclesiale perché hanno il coraggio di aprire strade che altri neppure vedono; ma sono anche una sfida perché lasciano una preziosa e, talvolta, pesante eredità. Così è stato don Enrico per la Chiesa di Nocera Inferiore – Sarno. La breve esistenza non gli ha permesso di dare stabilità al suo sogno, coloro che hanno preso le redini della Città dei Ragazzi dopo di lui non hanno avuto lo stesso carisma e la stessa capacità organizzativa. E tuttavia quel sogno non ha perso la sua attualità, anzi appare oggi più vivo che mai, pur in un contesto sociale assai differente. D’altra parte, anche se quella specifica opera fu chiusa, rimane viva la memoria santa di un prete che ha donato la sua vita per i ragazzi. E rimane viva la sua voce, come testimonia questo libro che raccoglie i suoi scritti per far meglio risuonare la sua parola. Fare memoria di don Enrico Smaldone – per la Chiesa di Nocera Inferiore – Sarno – è anzitutto un gesto di gratitudine nei confronti di un prete che ha speso la sua vita per i ragazzi abbandonati e orfani. In un’epoca in cui abbondano le parole, abbiamo bisogno di far parlare i testimoni, quelli che hanno scritto con la loro vita pagine luminose che, forse, per troppi anni sono rimaste nascoste alle giovani generazioni. La memoria diventa così per noi un annuncio di quella fede che in ogni tempo si veste di carità e risponde in modo sempre nuovo al disagio sociale. L’esperienza vissuta da don Enrico è una salutare provocazione per l’oggi, invita a dare risposte concrete, pagando di persona. Il cardinale Biffi, con la consueta arguzia, nel conclave del 2005, citò Mafalda, la protagonista di un fumetto: “Ho capito – diceva quella terribile e acuta ragazzina –, il mondo è pieno di problemologi, ma scarseggiano i soluzionologi”. Troppa gente parla dei problemi, pochi s’impegnano a risolverli. Don Enrico appartiene a questa seconda categoria: non partecipa a tavole rotonde in cui si parla del disagio, s’impegna ad arginare un problema che poteva avere tristi conseguenze. Questa pubblicazione, dunque, non vuole essere solo una doverosa rievocazione storica. Vogliamo tenere accesa quella luce che ha infiammato la sua vita e, se possibile, alimentare quella lampada della carità che ha illuminato la città di Angri (e non solo) ed ha stimolato tante persone, credenti e non, a dare il proprio contributo e ad impegnarsi in prima persona per un’opera che tutti riconoscevano di grande valore umano e religioso. PERCHÉ QUESTO LIBRO Un’ultima parola introduttiva sui motivi che hanno ispirato questa pubblicazione. Che cosa sappiamo di don Enrico Smaldone? A distanza di più di quarant’anni dalla sua morte la sua vita e la sua opera non sono state ancora adeguatamente esplorate, non hanno ancora trovato qualcuno che si sobbarcasse alla fatica di compiere quel lavoro di scavo per far emergere la testimonianza luminosa lasciata dal prete angrese; manca ancora quel doveroso approfondimento richiesto da un’opera di grande respiro sociale come quella compiuta da don Enrico. La ricerca bibliografica su don Enrico non ha richiesto molto tempo: un’agile e documentata biografia scritta da mons. Mario Vassalluzzo nel 1989; alcuni opuscoli che hanno un sapore più devozionale che storico; un dvd curato dal prof. Mario Avosso, alcune tracce biografiche in altri testi dedicati alla storia di Angri. Tutto qui. Vi sono stati alcuni convegni dedicati a don Enrico ma di nessuno, a mia conoscenza, sono stati pubblicati gli atti. Questo testo vuole aprire un nuovo filone di ricerca. Gli scritti che pubblichiamo ci permettono di guardare da vicino questo prete, come se fossimo noi i destinatari delle sue confidenze. Come parlare di don Enrico senza lasciar prima parlare don Enrico? Come raccontare una storia senza prima leggere i suoi scritti, quelle pagine nelle quali possiamo ancora sentire la passione che ha animato la sua vita, possiamo quasi vedere le persone alle quali egli si è rivolto, possiamo percepire la delusione che, almeno in alcuni momenti, lo ha avvolto. CONCLUSIONE Don Enrico non voleva mettere se stesso al centro, ragion per cui in questo momento ci starà guardando con sospetto, come faceva con i suoi ragazzi quando commettevano qualche birichinata, ma sono certo che, insieme a noi, ringrazierà il buon Dio perché quell’opera mostra non tanto l’eroismo di un uomo ma la forza della fede e l’amore di un prete. A gloria di Dio. Don Silvio Longobardi Direttore del Centro diocesano di Formazione
Scarica