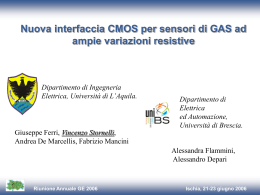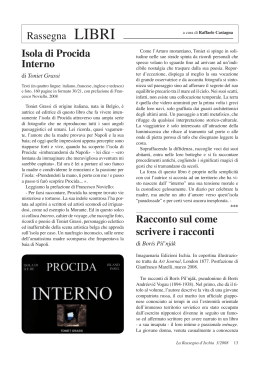Anno XXXIII N. 6 Dicembre 2012 Euro 2,00 Nell’Odissea di Omero la più antica testimonianza dei muri a secco o “parracine” Aggiornamento della flora d’Ischia Quando l’isola fa ritrovare se stessi L’arte del silenzio Casamicciola, Natale 1934 Leggere il Presepe Ex Libris Rassegna Libri Rassegna Stampa Il 9 novembre 1958 il primo getto d’acqua zampillò dall’acquedotto sottomarino Periodico di ricerche e di temi turistici, culturali, politici e sportivi Dir. responsabile Raffaele Castagna La Rassegna d’Ischia Anno XXXIII - N. 6 Dicembre 2012 Euro 2,00 Periodico di ricerche e di temi turistici, culturali, politici e sportivi Editore e Direttore responsabile : Raffaele Castagna La Rassegna d’Ischia Via IV novembre 25 - 80076 Lacco Ameno (NA) Registrazione Tribunale di Napoli n. 2907 del 16.02.1980 Iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 8661. Stampa : Press Up - Ladispoli (Roma) Sommario 3 Motivi 5 Aggiornamento della flora dell’Ischia 8 Nell’Odissea di Omero Testimonianza dei muri a secco “parracine” 10 Diplomati nautici 1962 11 Quando l’isola fa ritrovare noi stessi 12 L’arte del silenzio 14 Cinema L’intervallo di Leonardo Di Costanzo 15 Rassegna Stampa - Il primo getto d’acqua - Il Mattino 10.11.1958 - Ischia - La Lettura luglio 1929 19 I Luoghi del Cuore 20 Ex Libris 25 Antonio Di Maio “Nduniuccio ‘u russ” 27 Casamicciola - Natale 1934 29 Leggere il presepe 32 Miti Storia e Archeologia dei Campi Flegrei 36 Recital dei pianisti E. Lauro e A. Patalano 37 Fonti archivistiche (Barano) 42 Rassegna Mostre 44 Giardini La Mortella 45 Rassegna Libri 50 Tappa del Giro d’Italia (5 maggio 2013) I Luoghi del Cuore I Luoghi del Cuore è il censimento nazionale promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che chiede ai cittadini di indicare i luoghi che sentono particolarmente cari e importanti e che vorrebbero fossero ricordati e conservati intatti per le generazioni future. L’appello, con scadenza prorogata al 30 novembre 2012, è volto alla difesa di tesori piccoli e grandi, più o meno noti, che occupano un posto speciale nella vita di chi li ha a cuore. Il progetto tende a coinvolgere concretamente tutta la popolazione, di qualsiasi età e nazionalità, e di contribuire alla sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio artistico, monumentale e naturalistico. Quello attuale è la sesta edizione con i primi lanci nel 2003 e nel 2004; successivamente sono stati introdotti censimenti a cadenza biennale con un tema diverso per ogni edizione. Il terzo censimento del 2006 fu dedicato ai Luoghi di Natura, nel 2008 si chiese di cancellare ciò che deturpa i luoghi più amati dagli italiani. Nel 2010 il FAI, a 150 anni dall’unità d’Italia realizzata da Garibaldi, chiese agli italiani di votare l’Italia del loro cuore. Nel 2012 il tema è i Luoghi del Cuore con l’obiettivo di rendere potenzialmente internazionale l’iniziativa chiedendo a tutto il Mondo di partecipare e di segnalare il proprio Luogo italiano del Cuore. (continua a pagina 19) Foto copertina (I) In alto: Alle falde del monte Epomeo - Ercole Gigante (Napoli 1815-1860). In basso: Villaggio ischitano - Teodoro Duclere (1816-1869) Le opinioni espresse dagli autori non impegnano la rivista La collaborazione ospitata s’intende offerta gratuitamente - Manoscritti, fotografie ed altro (anche se non pubblicati), libri e giornali non si restituiscono - La Direzione ha facoltà di condensare, secondo le esigenze di impaginazione e di spazio e senza alterarne la sostanza, gli scritti a disposizione. conto corrente postale n. 29034808 intestato a Raffaele Castagna - Via IV novembre 25 80076 Lacco Ameno (NA) www.larassegnadischia.i www.ischiainsula.eu [email protected] [email protected] MOTIVI Il civismo diventa sempre più raro. Ciascuno di noi, se si prefigge di osservare attentamente la realtà circostante, collegandola a certi comportamenti ormai in voga, può farsi senz’altro la convinzione che il senso civico viene meno sempre più. Si affermano come normali atteggiamenti poco rispettosi verso gli elementi esterni e nei confronti del prossimo. Qualcuno parla in proposito d’inciviltà spicciola. «Alla base di tutto - scrisse gà Sergio Saviane in un articolo apparso su «L’Espresso» del 23 gennaio 1972 c’è un inespresso assioma: gli altri non esistono. In fatto di comportamento civile, l’italiano ha due personalità: una per casa sua e una per l’esterno, cioè per gli altri. La persona meticolosa che nel suo soggiorno si comporta civilmente, appena si trova in casa altrui o in ufficio o nei locali pubblici, diventa un invasore. Butta cenere e cicche dappertutto, lascia accese le luci, ruba oggetti senza valore, diventa cleptomane». Un aspetto del fenomeno che andiamo illustrando è il personale e poco corretto uso del territorio. Il cittadino che si sforza di tenere pulito il proprio marciapiede compie un gesto meritorio ma, quando ne deposita poi i rifiuti davanti alle porte altrui, può apprezzarsi ancora il precedente gesto? Si dice in proposito che in alcuni comuni si dovrebbe praticare la raccolta porta a porta ed allora che fa il cittadino “educato e responsabile (!)”? Privilegia le porte altrui consegnandovi le proprie cose ed anche a tutte le ore della giornata, compresi ingombranti e pericolosi. Né d’altra parte le autorità amministrative, emanate le proprie ordinanze, si preoccupano di difendere e proteggere coloro che devono subire determinati abusi e vedere cumuli di rifiuti lasciati senza alcun rispetto dinanzi alle proprie case. A volte l’allegria, la gioia, lo slancio festivo, sono spesso occasioni Raffaele Castagna di sfogo incontrollato ed inconscio sulle «cose» comuni, con l’esplicito scopo di distruggere o di rovinare, e nell’intento di «lasciare il segno». L’elenco delle citazioni potrebbe senz’altro continuare ed essere incrementato dal contributo di ciascun lettore. In auto, in moto ci si sente padroni della strada, si ha fretta, si sorpassa senza criterio e si mette continuamente a repentaglio la vita non solo propria, ma anche degli altri, come testimonia la frequenza sulle nostre strade di incidenti autobilistici.. E qui il discorso potrebbe essere allargato alla speculazione edilizia che ha caratterizzato un buon periodo di anni, alla scarsa manutenzione delle strade, all’abbandono in cui sono lasciati alcuni beni collettivi. In questi atteggiamenti negativi sono da coinvolgere le stesse amministrazioni degli enti preposti ai settori della vita del paese. Assistiamo così al fatto che determinati interventi sul territorio devono essere abbondantemente proposti e richiesti da stampa e associazioni, prima che chi di dovere ne prenda conoscenza ed intervenga convenientemente. Ben si può pensare che gli eletti alle funzioni pubbliche, pur abituati a far visitea a volte in tutte le case per la ricerca di voti, successivamente dimentichino di percorrere le medesime strade per rendersi conto di bisogni ed esigenze che richiede il territorio. Ma restando in un campo di maggiore e facile evidenza quotidiana, non può non colpire il modo di tappezzare strade e centri urbani con ogni forma di pubblicità, a discapito anche di esigenze paesaggistiche; la circostanza raggiunge notevole rilevanza in periodo elettorale, con la partecipazione, diretta o indiretta, di chi aspira ad essere eletto per migliorare, come si dice, il paese e nonostante l’esistenza di una specifica normativa e le ingenti spese per creare gli appositi spazi pubblicitari. Ne soffre conseguenze negative 1’estetica cittadina. Tutto ciò dovrebbe invitare alla meditazione ciascuno di noi, al fine di correggere determinate inclinazioni, anche perché ci troviamo in un’isola che lega le sue fortune economiche al turismo: ospitalità significa soprattuto offrire ambiente pulito, ben predisposto ed organizzato. Non c’è posto né spazio per la cultura, anche se a volte si è parlato (e si parla) di voler incrementare questa voce con finalità turistiche, considerato che sono in fase declinante altre voci che hanno fatto da supporto allo sviluppo dell’isola d’Ischia. E, a ben valutare le prospettive, non si può negare che le premesse (e la capacità) di dare slancio al settore culturale sono notevoli, presenti a vari livelli, ma forse sempre latenti in un contesto generale in cui hanno avuto prevalenza ed importanza altri fattori. Basti pensare allo scarso sviluppo dell’edilizia scolastica, pur in un’isola dove si è costruito liberamente e facilmente; si pensi che a volte, quando gli amministratori comunali avevano necessità di spazi per le proprie attività, non trovarono di meglio che eliminare biblioteche che erano in fase di consolidamento come frequentazione e consistenza di volumi (Lacco Ameno aveva sede nel complesso del comune; Forio aveva una sede in fitto); si consideri che non molti erano favorevoli a destinare a museo archeologico Villa Arbusto, preferendo altri interventi a favore del campo alberghiero, ed ancora oggi va balenando l’idea di spostare la sede museale e fare altro… (forse vendere per esigenze di bilancio comunale?) del complesso settecentesco, alla faccia di anni di impegno e forte volontà per la pubblica acquisizione e per sottrarlo a diversa destinazione. Vicende che sono descritte dallo stesso prof. Vincenzo Mennella, sindaco di Lacco La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 3 Ameno, nel suo libro Lacco Ameno, gli anni ’40 e ’50 nel contesto politico-amministrativo dell’isola d’Ischia, pubblicato postumo nel 1998 ed in cui l’autore richiama per notizie più diffuse la raccolta fatta nel numero di febbraio 1988 de La Rassegna d’Ischia. Stupisce peraltro il fatto che in qualche caso si parli in proposito di donazione degli eredi Rizzoli, quando Regione e Provincia sono intervenuti fortemente e finanziamente per l’acquisto del cespite. Dicevamo che le risorse offerte dall’isola d’Ischia sono molte e di vario genere nel campo storico, artistico, letterario, solo che si voglia incominciare a riconoscerne e valorizzare gli aspetti che la vasta letteratura, locale e non, suggerisce e presenta in modo concreto. «L’isola d’Ischia è universalmente nota – scriveva l’avv. Umberto Di Meglio nella presentazione della seconda edizione della Bibliografia isclana di Serra (chi la conosce?) – per la bellezza dei suoi paesaggi, per lo splendore delle sue marine, per la ricchezza dei suoi boschi e delle sue eccezionali risorse idrotermali; lo è per la mitezza del clima, per i fenomeni di origine vulcanica ed anche per i suoi vini. Lo è, viceversa, molto meno per le sue glorie antiche e recenti e per la ricca fioritura di studi, di scritti e di produzione artistica cui essa ha dato luogo». Molti studi sono del tutto ignoti e quindi mai si opera finanziariamente per incrementare il patrimonio di biblioteche da far sorgere in ciascun Comune. Rendiamo Ischia “universalmente (ma innanzituto localmente) nota”, anche per questi ultimi significativi aspetti. Si registra negli ultimi tempi un risveglio culturale-pubblicistico che è soprattutto espressione diretta isolana. Ischia, le sue vicende del passato e del presente, le sue luci e le sue ombre, i suoi aspetti più noti e meno noti sono trattati in una interpretazione naturale (forse anche 4 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 con spirito meno lucrativo) e portati verso una più ampia divulgazione. Se da una parte il patrimonio storico, artistico, letterario, ambientale merita di essere giustamente valutato, dall’altra tutti devono avere la possibilità di far sentire la propria partecipazione nella problematica che investe l’isola, nel tentativo di diradare quel clima di silenzio e di disinteresse che ha avvolto l’attività e i campi decisionali dell’intero territorio. Si evidenzia peraltro anche un altro dato: c’è a volte scarsa inclinazione verso le voci «isolane»; riscontro e considerazione più sensibili riscuotono invece le voci provenienti dall’esterno. Nella realtà, non certo piacevole per tutti, delle vicende e delle difficoltà che caratterizzano la vita moderna, in cui si avverte prepotentemente la mancanza di lavoro e di prospettive future, per il mondo giovanile soprattutto, si va cancellando anche una parte della storia con trasformazioni e mutamenti istituzionali un po’ duri da accettare in alcuni ambiti di concezioni maturate negli anni. Così meno province, meno tribunali, meno ospedali e posti letto, meno… e via di seguito; tutto da ridurre e da allinearsi piuttosto in linea sottrattiva. Voce che poi per le famiglie si concretizza anche in minori consumi di beni sia necessari sia voluttuari. A suggestiva consolazione si lascia balenare a volte la speranza aleatoria di una ripresa. Un aspetto che pure suona in contrato con i tempi è che oggi, pur di fronte ad una popolazione che aumenta, anche per immigrazione, si diminuiscono i servizi e lo stato, invece di avvicinarsi alla gente, si allontana sempre più e tende a concentrare le sue risposte di fronte a domande ed esigenze che sono in crescita per i cittadini, costretti inoltre a spostamenti e maggiori spese per un servizio che non è più presente in loco. D’altra parte c’è da dire che, nonostante tutto e i nume- rosi problemi incombenti, sull’isola sembra si vogliano annullare precedenti posizioni date dalla popolazione e volgere l’attenzione immediata ancora all’unificazione amministrativa dei comuni, proponendo a breve distanza un nuovo referendum con nuove regole maggiormente favorevoli (forse) questa volta a finalità, già in passato non approvate. Se si volesse proporre una serie di priorità per le problematiche che stanno modificando la realtà isolana, non sarebbe difficile, ma non si proporrebbe nulla di nuovo, in quanto tutto è palese e presente nella gente che ne vive le conseguenze. Cresciuta (per spinta propria ed originaria, oltre che per positiva imprenditoria), l’isola si avvia a tornare piccola in molte strutture e in molteplici servizi, che pure dovrebbero far fronte ad esigenze di una popolazione notevolmente aumentata, soprattutto nel periodo turistico: ospedale (il cui ampliamento, già programmato, tarda a realizzarsi, anzi se ne discutono certe riduzioni, e tutta l’attività sanitaria, le scuole, i trasporti marittimi e terrestri (fulcro essenziale del turismo), attività di gestione del territorio per certi servizi ed esigenze della popolazione, per cui tutto si vuole ricondurre al continente. Come ci si impegna per accorpare e unificare in loco alcuni territori, in altra sede si lavora per ulteriormente ridurre (proporzionatamente) alcune entità e concentrare molti interventi, allontanando i soggetti dalle istituzioni e dagli enti istituzionali. Ci si chiede a volte, con scarse risultanze positive, che cosa sia stato fatto da parte di politici e amministratori per lavorare insieme sul piano dei servizi da offrire ai cittadini; sono sempre prevalenti posizioni diverse, mai operanti unitariamente per rafforzare, piuttosto che far disperdere, quelle circostanze che in passato hanno avviato lo sviluppo dell’isola, sul piano sia generale che soprattutto turistico. * Aggiornamento della flora dell’isola d’Ischia di M. Ricciardi, R. Nazzaro, G. Caputo, A. Di Natale, G. Vallariello Intorno alla metà del secolo XIX, in un periodo parti- isole flegree, cioè Procida e Vivara (Caputo, 1964-65), alle Isole Ponziane (Anzalone, 1953-54; Anzalone & Caputo, 1974-75) ed a Capri (Ricciardi, 1996). Nel primo decennio del 2000 alcuni studiosi (Ricciardi, Nazzaro, Caputo, Di Natale, Vallariello) ritennero di non trascurabile interesse rivolgere l’attenzione alla flora dell’isola d’Ischia, anche al fine di portare a termine l’aggiornamento delle conoscenze floristiche per le isole del Golfo di Napoli, «sempre nell’ambito delle iniziative dirette ad una più completa e approfondita esplorazione biologica degli ambienti microinsulari». L’aggiornamento si può facilmente leggere nel sito qui riportato: http://www.herbariumporticense.unina.it/it/doc/ pdf/Flora/Ischia-flora.pdf -, da cui riportiamo le seguenti note. colarmente felice per gli studi floristici, il popolamento vegetale di Ischia fu accuratamente studiato e reso noto da Giovanni Gussone1, la cui opera e il più recente ed ampio contributo di Béguinot2, nel quale le notizie sull’isola d’Ischia sono inserite nell’ambito della monografia su flora e vegetazione delle isole ponziane e napoletane, restavano, per Ischia, le sole ma ormai antiche opere di notevole respiro a disposizione degli studiosi. Quest’isola era in effetti l’unica, tra quelle che emergono al largo delle coste della Campania e del Lazio, ad essere priva di un aggiornamento delle conoscenze floristiche. Si hanno invece studi dedicati agli isolotti Li Galli (Caputo, 1961), alle minori delle 1 Giovanni Gussone, Enumeratio plantarum vascularium in insula Inarime sponte provenientium vel oeconomico usu passim cultarum, 1855, pp. XIX-428. 2 Augusto Béguinot, La vegetazione delle isole Ponziane e Napoletane: studio biografico e floristico, Roma, 1905. L’esplorazione floristica di Ischia Come per gran parte delle aree costiere e insulari del Golfo di Napoli, anche Ischia è stata in passato più volte percorsa La flora dell’isola d’Ischia - di M. Ricciardi , R. Nazzaro a , G. Caputo b, A. Di Natale a, G. Vallariello c b La flora delll’isola di Ischia (Baia di Napoli) - Un sondaggio della flora dell’isola di Ischia, nel golfo di Napoli, Italia meridionale, è stato effettuato attraverso la ricerca sul campo e in erbari e nella letteratura. La flora trovata comprende 668 unità, di cui 150 nuove per Ischia. Ma 333 unità registrate in precedenza non sono state trovate. Questa perdita di specie della flora probabilmente riflette l’interento esteso dell’uomo fin dai tempi antichi. Sull’isola sopravvivono ancora alcune unità rare e specie interessanti da un punto di vista fitogeografico, come Limonium inarimense (Guss.) Pignatti, Woodwardia radicans (L.) Sm. e Cyperus polystachyos Rottb., mentre Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott non è stata trovata nei suoi luoghi classici sulle scogliere marittime. Analisi della flora in termini di forme di vita e aspetti fitocorologicali mostrano che la flora di Ischia è dominata da specie terofite (42%) e mediterranee (43,6%). Un minor numero di specie endemiche italiane (2,4%) sono state trovate rispetto alle altre aree del Golfo di Napoli. Questo è probabilmente legato alla giovane età dei terreni vulcanici dell’isola, mentre l’elevato numero di specie diffuse (30,7%) può anche essere probabilmente correlato al disturbo dello sfruttamento umano. Specie eurasiatiche e orientali sono meno numerose che nelle altre zone della fascia costiera del Golfo di Napoli. Rispetto alla seconda metà del secolo XIX, la flora di Ischia presenta una diminuzione di specie cosmopolite e diffuse, probabilmente a causa del diminuito sfruttamento agricolo dell’isola1. 1 The flora of the lsland of Ischia (Bay of Naples) — A survey of the flora of the island of Ischia, in the Bay of Naples, southern Italy was carried out through field research and research in herbaria and in the literature. The flora was found to comprise 668 taxa, including 150 new taxa for Ischia. But 333 taxa that had been recorded previously were not found. This loss of species from the flora probably reflects the extensive disturbance by humans since ancient times. On the island still survive some rare taxa and interesting species under a phytogeographic point of view such as Limonium inarimense (Guss.) Pignatti, Woodwardia radicans (L.) Sm. and Cyperus polystachyos Rottb. while Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott could not be found in its locus classicus on the maritime cliffs. Analyses of the flora in terms of life forms and phytochorological spectra show that the flora of Ischia is dominated by Therophytes (42%) and Mediterranean species (43,6%). A lower number of Italian endemics (2.4%) were found than in the other areas of the Bay of Naples. This is probably related to the young age of the volcanic soils of the island while the high number of widespread species (30,7%) may also be probably related to disturbance from human exploitation. Eurasian and eastern species are less numerous than in the other areas of the coastal belt of the Bay of Naples. Compared to the second half of XIX century, the flora of Ischia shows a decrease of cosmopolitan and widespread species, probably due to the decrease of agricultural exploitation of the island. Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale, Università degli Studi di Napoli Federico IIDipartimento di Biologia Vegetale Università degli Studi di Napoli Federico II. c Orto Botanico di Napoli Università degli Studi di Napoli Federico II. a b La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 5 dai floristi della scuola napoletana che le hanno dedicato studi approfonditi e dettagliati. Puntuali riferimenti alle piante dell’isola ricorrono in tutte le maggiori opere di Michele Tenore (Tenore, 1811-38; 1823; 1831; 1833; 1835; 1842) del quale va anche ricordata una breve nota dedicata specificamente alla flora di Ischia (Tenore, 1858). Opera fondamentale di riferimento, e per molti versi tuttora attuale, sul popolamento floristico ischitano, resta il prezioso e analitico contributo che Giovanni Gussone (1855) elaborò sulle piante dell’isola dove operò per conto della Reale Casa di Borbone negli anni compresi tra il 1830 e il 1854. Numerosi sono anche i riferimenti e le note critiche relative a piante di quest’area insulare che Béguinot (1905) inserì nella pregevole monografia da lui dedicata alla flora delle isole ponziane e napoletane. Un ulteriore, anche se frammentario, contributo alla conoscenza della flora dell’isola è rappresentato poi da alcune brevi note, frutto di visite sporadiche da parte di botanici interessati al suo popolamento vegetale e, più spesso, al ritrovamento e allo studio di alcune entità rare presenti sull’isola (Bollì, 1865; Matteucci, 1891; Martelli & Tanfani, 1892; Pampanini, 1911; Merola, 1957; Sarfatti, 1957; Agostini, 1959; Caputo & De Luca, 1968-69). Al fine di chiarire i dubbi su alcune indicazioni di piante per l’isola, si è fatto ricorso a indagini d’erbario e soprattutto a confronti con gli exsiccata di provenienza ischitana dell’Erbario Generale (NAP) e dei materiali raccolti sull’isola da Béguinot (RO). Questi controlli hanno consentito non solo di emendare diverse citazioni rivelatesi erronee, ma di confermare che, in passato, non poche piante, presumibilmente oggi scomparse, erano effettivamente presenti sull’isola. Nell’elenco, le entità raccolte od osservate su Ischia sono in neretto e un asterisco (*) è stato anteposto a quelle risultate nuove per l’isola. In corsivo sono invece le entità segnalate in passato da altri autori e che non sono state da noi rinvenute. Dall’elenco floristico segnaliamo: Woodwardia radicans (L.) Sm. Forre e valloni umidi. Segnalaz. preced.: Ten., 1831; Guss., 1855; Mart.&Tanf., 1892; Sarf., 1957. L’ultima segnalazione di questo relitto terziario nella stazione più settentrionale del suo areale italiano è dovuta a Caputo & De Luca (1968-69) che ne analizzano il significato fitogeografico e l’ecologia. La specie è stata da noi ritrovata in un profondo vallone sui versanti sud-occidentali del M. Epomeo. In questa stazione sono presenti una quarantina di esemplari impiantati sulle pareti verticali dove, purtroppo, l’attecchimento di nuovi individui è compromesso dalla erosione superficiale e dal conseguente smottamento e trasporto a valle del substrato da parte delle acque piovane. Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott (Kochia saxicola Guss.) Guss., 1855, sub Kochia s.; Matt., 1891, sub Kokia (sic!) s. 6 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Va purtroppo confermata l’estinzione di questa rarissima specie dal locus classicus degli Scogli di S.Anna presso Ischia Ponte, dove Gussone (1855) raccolse i materiali sui quali la descrisse precisando come, già a quel tempo, la specie fosse rara e localizzata «.. ne’ scogli di S. Anna, e propriamente nel pendio orientale di uno solo di essi». Abbiamo accuratamente esplorato questi piccoli scogli senza trovare traccia di Bassia saxicola. Ricordiamo come la specie sia stata di recente ritrovata da Ricciardi (1996) su Capri da dove era stata ritenuta ugualmente scomparsa da Guadagno (1931). Come riportato dallo stesso Ricciardi (l. c), attualmente Bassia saxicola sopravviverebbe, rarissima, anche sull’isolotto di Strombolicchio nelle Isole Eolie. Silene Giraldii Guss. Non abbiamo potuto ritrovare questa entità su Ischia dove Gussone (1855) raccolse i materiali sui quali istituì la specie. S. giraldii è da ritenersi senz’altro specie rara in quanto essa è stata segnalata, oltre che su Ischia, solo nella Sardegna Settentrionale presso il fiume Liscia e sul Vesuvio (Pigna 1982). L’area vesuviana è l’unica località nella quale la sua presenza è stata confermata abbastanza di recente (Ricciardi et al., 1986). Inattendibile invece è da ritenere, secondo Ricciardi (1996), la segnalazione, dovuta a Pasquali (1869), di questa specie per Capri. Silene italica (L.) Pers. subsp. italica Boscaglie e siepi. Barano: Fondo Ferraro, Casa Migliaccio, strada da Fontana per M. Epomeo, Buceto, ecc. Segnalaz. preced.: Guss. 1855. Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet (Silene alba (Miller) E. H. L. Krause subsp. divaricata (Reichenb.) Walters). Ambienti boschivi e macchie. Barano: Fondo Ferraro, Punta Caruso, Fontana: Rio, ecc. Segnalaz. preced.: Béguinot, 1905, sub Lychnis alba. La citazione di Silene dioica dovuta a Gussone (1855, sub Lychnis d.) va qui riferita. Descrivendo la specie infatti Gussone (l. c.) indica flores candidi che corrispondono per il colore a quelli di S. latifolia e non a quelli della S. dioica che sono rosei. D’altronde, i controlli d’erbario (NAP!) ci hanno consentito di accertare come numerosi saggi di varia provenienza attribuiti da questo autore a S. dioica siano in realtà da identificare con S. latifolia come confermano anche le revisioni di Grande di tali campioni. * Carpobrotus edulis (L.) Br.var. edulis. Coltivato per ornamento e spesso inselvatichito. Tra i Giardini Poseidon e Forio. Da riferire a questa specie Mesembryanthemum acinaformis che Bolle (1865) cita per Villa Bagni precisando che si tratta di pianta a fiori gialli. * Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. var. rubescens Druce. Coltivato e talora subspontaneo lungo la costa. Promontorio di Sant’Angelo, S. Montano, tra Pietre Rosse e Forio… Limonium inarimense (Guss.) Pignatti. Scogli e rupi marittime. Punta Caruso, Scogli di S. Anna: Scoglio “I Tre Pizzi”. Segnalaz. prcced.: Guss., 1855, sub Statice i.; Sarf., 1957, sub Statice i. È questa una delle tre specie di Limonium endemiche del Golfo di Napoli; essa è esclusiva dell’isola d’Ischia dove è tuttora presente con popolazioni ben costituite sulle rupi di tutta la fascia costiera. Limonium vulgare Miller s. 1. Guss., 1855, sub Statice limonium e sub S. limonium var. macroclada. Cakile maritima Scop. s. 1. Spiagge e arenili. S. Angelo. Segnalaz. preced.: Guss., 1855. Cakile maritima è stata da noi ritrovata esclusivamente alla fine dell’inverno, limitatamente alla località indicata e solo in un numero esiguo di individui. Non ci è stato possibile stabilire la sottospecie non avendo più ritrovato, nei successivi sopralluoghi, esemplan fruttificati in quanto la spiaggia di S. Angelo era stata sottoposta a radicali lavori di ripulitura per consentirne l’uso balneare. Vicia pseudocracca Bertol. Incolti aridi e siepi della fascia basale. Punta Caruso, M. Vico, Barano: Fondo Ferraro. Segnalaz. preced.: Guss., 1855. Kerguélen (1987) ritiene che V. pseudocracca Bertol. sia da sinonimizzare con V. villosa Roth subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen. In proposito, riprendendo quanto ipotizzato da Ricciardi (1996), riteniamo che tale inquadramento non sia proponibile. Abbiamo infatti confrontato gli exsiccata originali di V. pseudocracca dell’erbario Bertoloni (BOLO!) con quelli di Gussone (NAP!) che questo autore, nei cartellini autografi, ascrive a V. ambigua. Dall’esame di questi saggi sono emerse differenze significative soprattutto nelle dimensioni delle foglioline e dei fiori. Nei campioni di Bertoloni abbiamo riscontrato fiori lunghi da 1,1 a 1,6 mm e foglioline larghe da 1 a 3 mm e lunghe da 5 a 15 (in un solo caso 20) mm. Nei campioni di Gussone, invece, le misure dei fiori andavano da 1,9 a 2 mm e quelle delle foglie da 5 a 8 mm per la larghezza e da 11 a 20 per la lunghezza. Questo consente di ritenere ben distinte queste due entità. Quanto al rango da attribuire a ciascuna di esse, siamo del parere che esso potrà essere stabilito solo dopo più accurate indagini tenendo conto del notevole polimorfismo che caratterizza il complesso di V. villosa Roth. Rosa canina L. var. tomentella (Léman) Baker. Boscaglie rade e siepi. M. Epomeo: tra il Grotto di Mezzavia e la vetta. Segnalaz. preced.: Guss., 1855, sub R. c., sub R. c. var. vulgaris e sub R. c. var. collina. Questa entità è l’unica del ciclo di Rosa canina da noi ritrovata su Ischia. Essa è molto rara sull’isola e l’abbiamo raccolta esclusivamente sotto la vetta del M. Epomeo. In merito a Rosa ischiana descritta da Crépin (1972) per l’isola, questa appare entità di dubbio valore tassonomico. Neanche l’esame dei saggi ascritti a tale entità raccolti su Ischia e conservati nell’Erbario Gussone (NAP!) ha permesso un soddisfacente chiarimento in merito. Infatti, questi campioni presentano caratteri estremamente variabili e intermedi tra R. tomentella e R. rubiginosa, così come annotato anche da Burnat sui cartellini di tali exsiccata da lui revisionati. Ipomoea imperati (Vahl) Grisebach Guss., 1855, sub Batatas sinuata, Ten., 1858, sub Convolvolus i.; Matt., 1891, sub Convolvolus i.; Mart. & Tanf., 1892, sub I. stolonifera. Questa specie, diffusa in molte regioni tropicali e subtropicali, aveva nell’Isola d’Ischia e sulla spiaggia di Coroglio presso Napoli le uniche stazioni dell’Europa continentale. L’ultima citazione per i dintorni di Napoli risale a Cirillo (1788, sub Convolvulus stoloniferus), mentre su Ischia ci è stato possibile osservarla sulla spiaggia di S. Montano ancora intorno al 1970. La successiva edificazione in questa località di un locale pubblico ha determinato la definitiva scomparsa di questa entità dall’Europa continentale. Centaurea cineraria L. subsp. Cineraria. Stazioni rupestri costiere. Scogli di S. Anna: Scoglio “I Tre Pizzi”, Ischia Ponte: via Vecchia Cartaromana. Segnalaz. preccd.: Ten., 1823, sub C. c. e sub C. cinerea; Guss., 1855, s. l. L’unica popolazione presente sull’isola è composta da un numero ridotto di esemplari. Ciò ha comportato alcune difficoltà nell’attribuzione di questi individui ad una delle sottospecie di C. cineraria così come vengono intese da Cela Renzoni & Viegi (1982). Tuttavia abbiamo ascritto queste piante di Ischia alla subsp. cineraria in quanto, sebbene nella maggioranza degli individui prevalgano i caratteri fogliari di tale sottospecie, non mancano esemplari nei quali tali caratteri vertono verso quelli della subsp. circae (Sommier) Cela Renzoni et Viegi. Arum italicum Miller subsp. Italicum. Siepi e boschi di tutta l’isola. Segnalaz. preced.: Guss., 1855, sub A. i. e sub A. i. var. b. La varietà b viene descritta da Gussone (1855): spatha non concolore, sed rubro-punctata-maculata. Non abbiamo, però, ritrovato esemplari che presentassero tali caratteri né nelle località indicate per Ischia da Gussone (l. c.) né nei saggi d’erbario (NAP!) annotati con tale nome dallo stesso Gussone. Non siamo, perciò, in condizione di esprimere alcun giudizio sull’eventuale valore tassonomico di forme che potrebbero rappresentare delle semplici varianti nel polimorfismo di A. italicum. *Genista Gasparrini (Guss.) Macchie e siepi. Lacco Ameno, San Montano L’attribuzione a questa specie dei campioni raccolti ad Ischia è stata confermata anche da Valsecchi (in verbis).Sarebbe quindi questo il primo rinveninento di G. gasparrini, al di fuori della Sicilia dove finora è stata ritrovata solo su alcuni colli nei dintorni di Palermo (Valsecchi, 1993). La presenza di questa entità in una stazione così disgiunta dal suo areale siciliano lascia solo il sospetto che essa, come Cytisus aeolicus, che essa possa essere stata introdotta da Gussone sull’isola. * La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 7 Nell’Odissea di Omero La più antica testimonianza dei muri a secco o “Parracine” di Pasquale Balestriere Mi sono imbattuto, leggendo il ventiquattresimo libro dell’Odissea, nei versi in cui si dice che nella casa di campagna di Laerte e nell’orto circostante Ulisse, ivi recatosi per riabbracciare, dopo tanti anni e tante imprese, il vecchio padre, non incontrò alcun servo, perché - come apprendiamo - tutti erano andati a raccogliere pietre per costruire un muro alla vigna ... ἀλλ’ἄρα τοί γε αἱμασιὰς λέξοντες ἀλωῆς ἔμμεναι ἕρκος οἴχοντ’ …, (Od. XXIV, 223-25) e il vecchio padrone li aveva addottrinati sulla via da seguire per trovare il posto giusto. Nel podere Ulisse vede finalmente il padre che, solo e malvestito, zappa il terreno intorno ad un albero. Sono, questi, versi importanti perché in essi è ravvisabile con discreta limpidezza, come tenterò di dimostrare, la prima testimonianza per quanto mi risulta, almeno sotto il profilo letterario, dei muri a secco o “parracine” (come si dicono a Ischia, giacché il termine non esiste nel dialetto napoletano), di cui, nonostante il cemento trionfante, è ancora disseminata la nostra isola (e chissà quanti altri posti d’Italia e del mondo). Preliminarmente va notato: 1) che la casa di campagna del re Laerte, con il terreno circostante coltivato a vigneto e frutteto, si trova lontano dalla città (νόσφι πόληος, Od. XXIV, 212), e quindi dalla reggia, e su un luogo collinoso o, quanto meno, su un’altura, per la quale il vecchio arranca faticosamente ἑρπύζοντ᾿ ἀνà γουνὸν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο... Od. I, 193 - trascinandosi sull’altura di terra spianata coltivata a viti; 2) che tale altura è sostanzialmente piana, o magari disposta ad ampi terrazzi, visto che ἀλωή significa innanzitutto aia, terra spianata; 3) che il podere di Laerte, proprio per essere posizionato su un rilievo, è esposto ai venti e alle intemperie. Ma andiamo con ordine. 8 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Per capire bene il passo che ci interessa, occorre individuare e circoscrivere il significato di alcuni termini: αἱμασιάς, da αἱμασιά, che significa siepe di spini, recinto, materiale per recinto, maceria, riparo, argine, muro di pietra, sassi per cinta (l’espressione αἱμασιὰς λέγειν viene normalmente tradotta con raccogliere sassi per innalzare un muro di cinta); ἀλωῆς, da ἀλωή, aia, terra spianata, campo, vigna, orto, giardino, frutteto, fondo; e infine ἕρκος, che ha il valore di recinto, chiusura, sbarramento, vallo, riparo, difesa, cinta, steccato, muro, siepe. Rileggendo il passo, selezionando e combinando accuratamente i significati, emerge in modo lampante il suo vero senso: Laerte aveva intenzione di recintare il suo campo più che di contenerlo, o, più verosimilmente, di completarne la recinzione o ripararne qualche tratto franato; che il recinto non era certo costituito da una siepe di spini o da uno steccato, visto che i servi erano stati mandati a cercar sassi, ma da un muro di pietre. Né poteva essere diversamente nella “petrosa Itaca” di foscoliana memoria. Innanzitutto perché è nella mentalità del contadino (e Laerte era un re-agricoltore) che ogni opera sia il più possibile durevole e ciò, nel caso di cui si tratta, non poteva avvenire con steccati di materiale facilmente deperibile; poi perché costruire un muro di pietre a Itaca era la cosa più normale, vista la natura del territorio. E infatti Omero definisce Itaca κραναή (dura, petrosa, rocciosa, aspra, Iliad. III,201; Od. I. 247; XV, 510; XVI, 124; XXI,346); τρηχεῖα (aspra, petrosa, sassosa, selvaggia, Od. X, 417 e 463); παιπαλόεσσα (dirupata, alpestre, rocciosa, Od. XI,480); ma anche ἀμφίαλος (cinta dal mare, Od. I,386, 395; II, 293; XXI, 252); eὐδείελος (ben visibile, chiara distinta, esposta al sole, aprica, Od. II,167; IX, 21; XIII, 325; XIV, 344; XIX,132). Predomina, dunque, l’idea di un’isola rocciosa, cosparsa di pietre e sassi, aspra, scomoda, scoscesa, con vie strette e del tutto inadatta, per esempio, al cocchio e ai cavalli che Menelao (IV, 590 sgg.) voleva donare a Telemaco e che il giovane, proprio per la natura della sua isola, era stato costretto a rifiutare, sia pure con molta cortesia. Ma torniamo al muro di recinzione che Laerte intendeva far costruire e che, oltre a delimitare la proprietà, doveva avere una duplice funzione protettiva: riparare il campo dai rigori invernali e dalle tempeste di vario genere (soprattutto di vento) e difenderlo dai ladri e dagli animali, specie se questi ultimi erano riuniti in greggi, mandrie o branchi. E che si trattasse di un muro a secco già lo lascia supporre il fatto che nell’architettura micenea (e miceneo o acheo è, come tutti sanno, il mondo descritto da Omero) erano quasi del tutto assenti i materiali coesivi e, se proprio si voleva usare un collante (però molto approssimativo), si ricorreva a impasti di una sorta di calce con sabbia e ciottolini, se non, semplicemente, a qualche tipo di argilla o di fango più o meno tenace. È, infatti, del V sec. a. C. l’invenzione della malta da presa, un impasto di calce e harena, pur se la calce, come risulta da ritrovamenti archeologici, era conosciuta ed usata, non si sa quanto propriamente, già dal 7000 a.C. Quanto al muro della vigna di Laerte, è altamente improbabile che fosse sarcito con malta, sia perché si trattava di un semplice muro di campagna, e quindi di elementare struttura, sia perché si tendeva a costruire utilizzando materiali locali per ovvie ragioni, sia perché l’Itaca omerica è isola piuttosto povera o, se si vuole, molto meno ricca di città come Micene, Pilo, Sparta, Atene, Tirinto. Quest’ultimo dato è testimoniato dal fatto che a Troia Ulisse, pur capitanando i guerrieri di Samo, Zacinto, Itaca e altre isolette, conduce solo 12 navi, una vera miseria rispetto alle 100 di Agamennone (Micene, Corinto, ecc), alle 90 di Nestore (Pilo, Arene, ecc), alle 80 di Idomeneo e Merione (Creta), alle 60 di Menelao (Sparta, ecc.) e di Agape- nore (Arcadia), alle 50 di Menestèo (Atene), di Achille (Ftia, Alo, Ellade ecc.) e così via. Basta dire che solo quattro (su quarantaquattro) condottieri avevano guidato a Troia meno navi di Ulisse. E, per l’Omero dell’Iliade, Itaca, oltre che κραναή, al massimo è selvosa per il Nèrito che agita le fronde (Νήριτον εἰνοσίφυλλον, Iliad. II, 632; ma anche in Od. IX, 22), mai ricca. Ciò del resto è implicitamente testimoniato dal grande stupore di Telemaco di fronte all’estrema ricchezza di bronzi, oro, elettro, argento, avorio da cui era abbellita la sala del palazzo di Menelao nella quale si tiene un banchetto; al punto che il giovane itacese si chiede se non sia simile alla corte di Zeus (Od. IV, 71 sgg.). Tuttavia, nell’Odissea s’incontra l’espressione δῆμος πίων (regione feconda o popolo ricco, XIX, 399) riferita a Itaca o agli itacesi: ma si tratta di occorrenza rarissima e, per di più, di una di quelle “dizioni formulari”, come le chiama Carlo Del Grande, che nulla aggiungono a quanto già si sa e che appaiono, talvolta, come autentiche enfatizzazioni, per cui perfino il porcaio Eumeo diventa “divino” e “glorioso”: δῖ’ Εὔμαιε (XVI, 462; XVII, 508; XXI, 234; XXII, 157) e δῖον ὑφορβόν (glorioso porcaio, XXI, 80). Per tutti questi motivi, il muro che doveva essere costruito nel podere di Laerte non poteva essere che a secco. E dunque una “parracina”. Se ne incontrano tante sull’isola d’Ischia, soprattutto nelle zone interne, anche a ridosso della strada statale; molte sono di contenimento, alcune di recinzione e di protezione. Di quest’ultimo tipo vi sono esempi significativi nel territorio del Comune di Barano, in particolare sulla dorsale della costa Sparaìna, un luogo davvero esposto a tutti i venti, eccetto - in parte - quelli provenienti da nord, e nella zona di Forìo. Del resto l’etimologia della parola reca in sé l’idea del riparo, della difesa, della protezione, sia che si faccia derivare il termine da παράκειμαι, giaccio accanto o lungo o di costa, sia da περίκειμαι, giaccio intorno, sia da παρά (con idea di opposizione) e χεῖμα, ατος , contro la tempesta, il tempo invernale. La parracina antica anche nel nome. * Particolare di muro a secco (parracina) La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 9 Procida - La festa dei marittimi (capitani e macchinisti) Medaglia d’oro per i diplomati nautici del 1962 Festa e medaglia d’oro di lunga navigazione per i diplomati nautici (capitani e macchinisti) del 1962 dell’Istituto Nautico F. Caracciolo di Procida (in quegli anni frequentato da centinaia di ragazzi dell’isola d’Ischia). Due i momenti significativi dell’evento: il 26 giugno 2012 si è svolta la cerimonia per l’intitolazione del piazzale dell’Istituto Nautico ai figli insigniti di medaglia d’oro. «Questa targa - ha spiegato l’Amrniraglio Maurizio Scotto, a nome del comitato organizzatore - vuole essere un tributo, un doveroso riconoscimento della Comunità procidana ai suoi figli, che su tutti i mari hanno onorato la patria e la nostra isola. L’intitolazione - continua l’Ammiraglio - è stata fortemente voluta per esaltare l’alta professionalità, la dirittura morale, la laboriosità e la rettitudine della gente di mare di Procida». Erano presenti il sen. Carlo Sarro, il Sindaco Vincenzo Capezzuto, il Vice Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Sabia, la Prof.ssa Maria Longobardo, dirigente dell’Istituto Superiore “F. Caracciolo - G. da Procida” e le massime autorità cittadine e dell’intera comunità. La prestigiosa porcellana raffigurante al centro l’Ammiraglio Caracciolo, cui è intitolato l’Istituto Nautico di Procida tra un’immagine di Terra Murata di Procida e il Castello Aragonese 10 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Gruppo dei Capitani e Macchinisti del 1962, con alcuni docenti ed altri amici che hanno condiviso con i festeggiati un tratto di vita scolastica. Davanti alla “nave - torta”, da sinistra: Vito De Santis, Gennaro Aurelio, Luigi Migliaccio, Nino Calise, Maurizio Scotto Di Santolo, Peppe Monti di Ischia, Nicola Scotto di Santolo; (dietro) tra i procidani Tommaso Barone, Dino Scala, Mario Careri, Pasquale Lubrano, Antonio Assante, Adele Veneziani, Michele Aurelio, Dino Lubrano, Anna Capodanno, Letizia Scotto di Fasano, Salvatore Esposito, Antonio Ambrosino, Pasquale Sequino, Angelo Costagliola, Augusto Esposito, gli ischitani Vito Elia, Alfredo Iezzi, Giuliano Spignese, Vincenzo Catuogno, Vincenzo Trani, Antonio Napolano, G. Giuseppe Pilato, e i docenti Norbelli e Biglietto. Presenti in sala, non in questa foto, Gennaro Parascandola, il prof. Vincenzo Scotto di Vettimo e altri amici invitati. Don Michele Ambrosino ha proceduto alla benedizione della targa. Con i “Capitani e Macchinisti del ‘62” schierati “fronte bandiera” ha proceduto allo scoprimento il prof Vincenzo Scotto, docente dei ragazzi del ‘62. Principale artefice ed organizzatore dell’evento l’Amm. Maurizio Scotto, insieme con Pasquale Lubrano, caporedattore del periodico procidano, che hanno anche consegnato un prezioso “crest” in porcellana artistica della prestigiosa “NRS Capodimonte” raffigurante al centro l’Amm. Caracciolo in riferimento alla denominazione dell’Ist. Nautico tra le immagine di Terra Murata di Procida e del Castello Aragonese d’Ischia a ricordare le terre d’origine dei diplomati. È seguito un conviviale nei giardini de “La Torre” tra scenografie di alberi da frutta, fontane con zampilli di spumante proveniente dall’Istria e una torta di 25 kg, opera di un mastro pasticciere di Perugia, a forma di nave e con i colori sociali della “Carnival” in onore di Angelo Salvemini, marittimo che ha rappresentato i capitani del ‘62 ai massimi gradi della marineria mondiale e impedito a partecipare perché al comando di detta nave nelle acque americane. La serata è stata un’autentica festa dell’amicizia. Apprezzato il catering e le specialità culinarie a base di pesce preparate da “La Grotta del Saraceno” sotto la direzione di Salvatore Trapanese; animatrice della serata la cantante napoletana Marea. Sussessivamente, il 5 ottobre 2012, capitani e macchinisti sono stati in visita a Napoli sulla più grande nave della Società di navigazione “Carnival”. Particolare della nave Carnival Breeze della società di navigazione Carnival Nelle giornate di tempesta l’isola ritorna una terra racchiusa d’ogni intorno dal mare, un luogo isolato Quando l’isola fa ritrovare noi stessi di Carmine Negro Il sibilo del vento, il tintinnio dei vetri, lo scroscio dell’acqua di una fredda serata autunnale porta la mente in luoghi una volta teneramente familiari. Ora, che sono lontani nel tempo e sono rischiarati solo dalla debole luce del ricordo, riesco a mettere a fuoco alcune realtà che non riuscivo a cogliere quando erano sommerse dalle inutili inezie del quotidiano. Il pensiero corre a Forio, ridente luogo dell’isola d’Ischia. Riusciva a conquistarmi nelle giornate limpide quando la superficie azzurra del mare amplificava la luminosità e accentuava i contorni della linea di costa, rendendo netto il tratto delle case sul promontorio. Riusciva ad incantarmi con i caldi tramonti. Dallo spiazzo del Soccorso era possibile ammirare Punta Imperatore da un lato, Punta Caruso dall’altro, perdersi nel sole all’orizzonte che, mentre colorava il suo disco di un rosso fuoco, lo ingrandiva prima di calarsi nella superficie del mare e scomparire. In certi giorni qui si respirava un’atmosfera magica: era possibile scorgere in lontananza l’isola di Ventotene e mentre si sentivano il rumore e il profumo del mare si poteva assistere all’incanto del Raggio Verde, frutto della rifrazione della luce solare da parte dell’atmosfera, più evidente al tramonto, quando i raggi solari radenti attraversano uno strato d’aria più spesso. Riusciva a rapirmi quello stretto intrigo di strade e stradine che si dipanavano per il centro antico; nei giorni di tempesta riecheggiava delle onde del mare e del fischio del vento. Riuscivo ad amare Forio soprattutto nelle giornate di maltempo quando le forze della natura non consentivano il collegamento con la terra ferma e l’isola si ritrovava ad essere se stessa. Al timore diffuso per la mancanza di giornali, dei rifornimenti quotidiani, di quanti lavoravano sull’isola provenienti dalla terraferma io ero particolarmente impressionato ed emozionato da questo sentirsi isolati, e quindi realmente isola, da questo silenzio che da esterno diventava interno, da questo contatto così forte con la natura che trascurava o rendeva superfluo ogni altro contatto. Ora che vivo una realtà particolarmente rumorosa, talvolta scomposta e assordante, mi domando cosa nascondesse quel desiderio di un contatto più profondo con la natura, quel desiderio di isolamento, quella necessità di riflessione. Probabilmente un desiderio di scoperta o riscoperta del silenzio. Un silenzio che sottolinea l’attesa, che sa aspettare senza rincorrere pensieri e parole, sa dare spazio al non ancora espresso. Un silenzio capace di valorizzare l’emozione prevalente, quella del momento. Un silenzio prezioso, da godere e assaporare, pieno di significati e contenuti che sgorga dal profondo e che dice molto di più di qualunque parola, di qualunque discorso: un silenzio “autentico” reso possibile da un “vero” discorso. Restituta costruiva cestini di rafia vicino alla Chiesa del Soccorso. Rimanevo incantato a seguirla nel suo lavoro. I movimenti per quanto ripetitivi avevano una loro dignitosa autonomia nella costruzione del disegno, nell’intreccio dei fili che mani sapienti sapevano dominare con capacità ed esperienza, nel rispetto dei tempi. Un silenzio correlato alla lentezza, a un tempo vissuto con calma, un valore quasi del tutto assente nella società moderna, che potrebbe condurci ad una maggiore consapevolezza dell’azione, della cura da mettere in ogni parola o in ogni azione svolta nel quotidiano in modo da evitare soprusi e inutili sovrapposizioni di energie che il movimento inevitabilmente produce. Ma l’isola nei momenti di isolamento ci insegna a riconoscerla, ci Veduta di Forio di Jacob Philipp Hackert (1737-1807), olio su tela, 1789 (Caserta, Palazzo Reale). La veduta spazia dalle pendici dell’Epomeo fino alla baia, abbracciando un vasto pianoro attraversato dalle mulattiere e puntellato di case contadine. La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 11 aiuta ad imparare a convivere con i ritmi che la natura ci impone per necessità biologica, chiede che le sovrapposizioni culturali della società non tracimino per puro consumismo, generando rumore molesto, indesiderato e sovrabbondante. Ci ricorda che il principio del silenzio ci permetterà di concepire diversi atteggiamenti a sostegno della Terra e delle sue leggi affinché con Gandhi si possa dire «il silenzio dilata lo spazio di tempo della nostra vita». Mi sono chiesto più volte quale fosse il motivo che portasse i miei amici a non lasciare neanche per un giorno l’isola per la terraferma. Probabilmente quel silenzio che ancora L’arte del silenzio In una quotidianità sempre più caotica e rumorosa, in quella che possiamo definire la società del frastuono e della velocità è sempre più forte l’urgenza di fermarsi ad assaporare il silenzio. Secondo alcuni studiosi più di metà della popolazione mondiale vive in ambienti con un livello medio di rumorosità superiore a 60 decibel, quindi assai lontana dalla possibilità di poter godere degli effetti del silenzio. Finora ci ha rubato troppo tempo il detestato rumore, vero timbro sonoro dei nostri anni con i fragori della quotidianità, spesso fastidiosi, esasperanti e intollerabili: prima o poi, bisognerà fare i conti con il silenzio. Di fronte al vociare scomposto di alcune trasmissioni televisive alcuni hanno suggerito il ripristino dei «silentiares», guardie che tutelavano il silenzio nella sala colloqui nelle corti imperiali bizantine del IV secolo. Il silenzio sembra essere una esigenza dei nostri tempi sentita in tutti i campi espressivi. «Una volta c’era un famoso suonatore di cetra, chiamato Chao Wen, che sapeva suonare la cetra come nessun altro. Ma un giorno all’improvviso smise completamente di suonare la cetra. Aveva finalmente capito che nel suonare una nota si trascuravano inevitabilmente tutte le altre. Fu solo allora, quando smise di suonare, che riuscì a sentire la completa armonia di tutte le cose. [...] L’unica musica completa è quella dei suoni naturali». Questo è un passo di un famoso testo taoista, il Chuang Tzu, che sembra molto in tema con l’opera di compositori moderni come Anton Webern 12 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Il silenzio è un’arte e come tutte le arti deve avere qualcosa da dire per esistere, senza è solo rumore e John Cage. Anton Webern, si preoccupa di non saturare lo spazio sonoro, frammenta la composizione e sottolinea l’intervallo tra le note. Le sue composizioni sembrano aforismi in cui ciò che conta è l’atmosfera. Prima che l’ascoltatore possa assuefarsi alla melodia, essa è già terminata. Il silenzio, come assenza di suono, è anche considerato una componente della musica. Essendo naturalmente privo di tono, timbro e intensità, l’unica caratteristica che condivide con il suono, in un contesto musicale, è la durata. Famosa l’opera 4’33” di John Cage che così la descrive: «Il silenzio non è altro che il cambiamento della mia mente. È un’accettazione dei suoni che esistono piuttosto che un desiderio di scegliere e imporre la propria musica. Da allora questo è sempre stato al centro del mio lavoro. Quando mi dedico a un pezzo musicale, cerco di farlo in un modo grazie al quale esso, essenzialmente, non disturbi il silenzio che già esiste». «Nella vita, come nell’arte, è difficile dire qualche cosa che sia altrettanto alberga in alcuni momenti in questo spazio, che consente di convivere con i ritmi della natura e condividerli. Un silenzio che accoglie, custodisce, protegge. Un silenzio che ha costruito tanti silenzi carichi di saggezza e che porta in sé il mistero della vita. * efficace del silenzio». Il dito sulle labbra di Mercurio, colui che “conosce, trascrive e nasconde affinché ogni generazione compia la sua ricerca”, allude al silenzio necessario per svelare i misteri. Il gesto è diffuso nella cultura occidentale ed è noto sin dall’antichità. Simonide Di Ceo, (Isola di Ceo, 550 a.C. circa – Agrigento, 467 a.C.) poeta e lirico greco soleva ripetere “La pittura è poesia silenziosa, la poesia è pittura che parla” . Il silenzio sembra essere a un tempo un limite e la caratteristica specifica delle arti figurative. Escluse dalla soglia della parola e del suono esse sono condannate all’insonorità, a una certa “sordità” direttamente proporzionale al loro coinvolgimento con la materia. La pittura è a pieno titolo una forma di linguaggio che condivide col discorso verbale, e forse realizza in modo più efficace, il fine della trasmissione della conoscenza e della manifestazione dei sentimenti. Come la parola, però, anche la pittura incontra dei limiti invalicabili alle sue possibilità di penetrare l’essenza del reale, pur nell’apparente libertà della sua invenzione. Come la parola, tende costantemente alla pienezza della verità senza mai poterla compiutamente raggiungere. L’impercettibile movimento delle labbra della Gioconda non è infatti un sorriso; è piuttosto l’approdo finale della parola, l’indicazione della superiorità del silenzio sul verbo, della risoluzione del discorso nell’estaticità dell’intuizione, del limite ultimo in cui la parola si spegne, ma dal quale sempre di nuovo rinascerà per accompagnare la tormentata ricerca del vero. Silenzio e parola sono concetti correlativi e inseparabili. Dal silenzio nasce la parola che a esso incessantemente ritorna. E poi cosa dire dei «sovrumani silenzi» e della «profondissima quiete» di cui parla Leopardi, e dell’invito di Wittgenstein: «Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere». Il silenzio è anche una forma di rispetto nei confronti della conoscenza cui invano aspiriamo, è accettazione della propria limitatezza. Il silenzio non ci appartiene più, non lo riconosciamo. Di fronte a grandi disgrazie, ci abbandoniamo spesso a una sciagurata euforia che ci porta a sfogarci o ad applaudire. Spesso non siamo capaci di osservare un minuto di silenzio negli stadi e durante un funerale ci abbandoniamo all’applauso. Per riabituarci al silenzio dovremmo, probabilmente, tornare alle regole della vita monastica. Dalla sua cella il monaco non poteva né vedere né sentire il suo vicino, l’architettura monastica era fatta per proteggere il silenzio, la meditazione, la taciturnitas. Il silenzio è una grande cerimonia, una liturgia. Dio giunge nell’anima che fa regnare il silenzio dentro di sé, ma rende muto chi si perde in chiacchiere. Per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (maggio 2012) il Papa ha inviato un messaggio dedicato proprio al silenzio: «Il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto. Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi, nasce e si approfondisce il pensiero». Egli non ha proposto il silenzio come alternativa all’impegno nella comunicazione, non ha chiesto di spegnere la «musica passiva», quella non richiesta che ci assilla nei negozi, nei locali pubblici, negli ascensori, nelle spiagge, non ha improvvisato una di quelle lezioni in cui ci viene spiegato, da una pubblicistica improvvisata, che «in una società in cui tutti parlano, tutti tentano di esprimersi sovrapponendo la propria voce a quella degli altri e in cui gli stimoli dei soggetti emittenti si moltiplicano spesso senza raggiungere i destinatari del messaggio il rischio dell’incomunicabilità cresce a dismi- sura». No, ha voluto ricordare che il silenzio parla, anche nelle moderne forme di comunicazione. Il silenzio è una scelta e a volte può essere l’espressione più eloquente della nostra vicinanza, della nostra solidarietà, della nostra attenzione verso un’altra persona. *** In Forme del parlare, il sociologo Erving Goffman rovesciando il senso comune sostiene che «il silenzio è la norma e parlare è qualcosa che esige una giustificazione». Invece purtroppo spesso parliamo, cerchiamo affannosamente il rumore perché copra il silenzio che più ci spaventa. Il silenzio ci appare come un vuoto angoscioso, così angoscioso da preferirgli il rumore, il chiacchiericcio, eppure Ceronetti ci ricorda che: «La vita rimescola dati e dadi; l’ultima parola, su tutto, la dirà il silenzio». Molteplici sono le sfaccettature di questo grande sconosciuto del nostro tempo: dal silenzio religioso a quello che favorisce il raccoglimento e l’interiorità, dalle pause che sono parte integrante della musica e la compongono assieme alle note al silenzio suggerito dagli eccezionali spettacoli della natura. Un viaggio nel tempo e nello spazio, alla ricerca del significato profondo del silenzio così come viene percepito nelle diverse forme d’arte, nella religione, ma anche nel nostro quotidiano quando tentiamo di metterci in contatto con il mondo circostante e con noi stessi, è presente nel libro Per una storia del silenzio di Sergio Cingolani, Edizione Mursia. Il silenzio è un’arte e come tutte le arti deve avere qualcosa da dire per esistere, senza è solo rumore. Carmine Negro Guido Ceronetti, Il silenzio del corpo Edizione Adelphi 1979 Aldo Grasso, L’eloquenza del silenzio Corriere della Sera 28/10/2012 Sergio Cingolani, Per una storia del silenzio edizioni Mursia 2012 Engrammi, Storia del Silenzio in arte http://engrammi.blogspot.it/2009/10/storia-del-silenzioin-arte.html Silenzio Conosco una città che ogni giorno s’empie di sole e tutto è rapito in quel momento Me ne sono andato una sera Nel cuore durava il limio delle cicale Dal bastimento verniciato di bianco ho visto la mia città sparire lasciando un poco un abbraccio di lumi nell’aria [torbida sospesi Giuseppe Ungaretti Ho bisogno di silenzio Ho bisogno di silenzio come te che leggi col pensiero non ad alta voce il suono della mia stessa voce adesso sarebbe rumore non parole ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio esco e per strada le solite persone che conoscono la mia parlantina disorientate dal mio rapido buongiorno chissà, forse pensano che ho fretta. Invece ho solo bisogno di silenzio tanto ho parlato, troppo è arrivato il tempo di tacere di raccogliere i pensieri allegri, tristi, dolci, amari, ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi, uno ? sanno ascoltare anche il silenzio, sanno aspettare, capire. Chi di parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno, come me, di silenzio. Alda Merini La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 13 Un film di Leonardo Di Costanzo, regista di Barano L’intervallo applaudito a Venezia nella sezione “Orizzonti” Veronica e Salvatore. Due ragazzini intrappolati in un gioco da grandi. Un gioco di camorra: la reclusione. In uno stabile fatiscente, multiforme, sterminato, uno spazio per un intervallo forzato o forse, chissà, liberatorio. Veronica, scopriremo, ha un amichetto che non deve avere per logiche di clan. Salvatore è chiamato a sorvegliarla, ma è un recluso pure lui. Lei è troppo cresciuta e freme per la libertà, lui fa mostra di pacatezza, comando e controllo. Così non è. Sono uguali più che contrari, e in quell’hortus conclusus che di poetico non ha nulla sapranno trovare un locus amoenus, che di salvifico può avere qualcosa. Non mancano parentesi da Laguna blu, fughe da fermo e aneliti adolescenziali, soprattutto pensieri in libera uscita, destinazione Isola dei famosi e non solo, bloccati, controvertiti dal qui e ora di esecuzioni sommarie, tre colpi alla nuca. E se questa fosse la fine di Veronica? È L’intervallo, primo film di finzione dell’ischitano Leonardo Di Costanzo, il valente documentarista di A scuola Prove di stato. Scritto con Mariangela Barbanente e Maurizio Braucci, prodotto da Tempesta (Corpo celeste di Alice Rohrwacher), gareggia al Lido di Venezia nella sezione Orizzonti. Braucci, tra le altre cose, è il co-sceneggiatore di Gomorra, e L’intervallo potrebbe legittimamente esserne uno degli episodi per mood, location e anche per stile: caLeonardo Di Costanzo, regista, documentarista, nasce a Barano nel 1958. Si laurea all’Istituto Orientale di Napoli e si trasferisce a Parigi dove frequenta i seminari di regia degli Ateliers Varan. Lavora per la Televisione francese e realizza vari documentari. Nel 1991 partecipa all’opera collettiva “Premières Vues” con il corto “In nome del Papa”. Entrato a far parte dell’equipe pedagogica degli Ateliers, nel 1994 insieme al regista cambogiano Rithy Panh, fonda a Phnom Penh, in Cambogia, un centro di formazione per documentaristi. Nel 2000 crea un Atelier Varan all’Università di Bogotà. Ha diretto “Prove di Stato” (1998), sulla determinazione di Luisa Bossa, ex-preside di liceo, eletta sindaco di Ercolano nel 1995, dopo Mani Pulite. Nel 2003 con una troupe minima riprende un intero anno scolastico in una scuola di un rione periferico a Napoli realizzando “A scuola” che è presentato alla Mostra di Venezia. Nel 2006 con “Odessa” vince insieme al corealizzatore Bruno Oliviero il premio per la miglior regia alla quinta edizione dell’Infinity Festival di Alba nella sezione ‘Uno sguardo nuovo’. Nel 2007 su proposta di Agostino Ferrente e Mario Tronco, gli ideatori dell’Orchestra di Piazza Vittorio, il complesso multietnico nato a Roma nel quartiere Esquilino, ha realizzato uno dei documentari dedicato ai musicisti. Lui si è occupato di Houcine, seguendolo nella sua terra d’origine, la Tunisia, in “L’Orchestra di Piazza Vittorio: I diari del Ritorno”. 14 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 mera a mano, illuminazione artificiale al lumicino, tensione di cinema-verità, con l’immaginazione adolescenziale a scavalcare il muro dell’omertà, la sottomissione e la realtà coatta di tante nostrane periferie poco romanzesche e molto criminali. Un piccolo film, indipendente secondo gli stilemi italiani, affidato alla bravura dei due giovani protagonisti Francesca Riso e Alessio Gallo - scovati con un laboratorio di coaching a Napoli - e issato su una storia tragicamente ordinaria, un’attesa di scioglimento senza climax, strappata ai trafiletti di cronaca locale. Non c’è spettacolo, e come altrimenti, ma forse potrebbe esserci più emozione. Aiuterebbe a fare di questo Intervallo una pausa allettante per un pubblico più vasto, ma abbiamo un dubbio: e se fosse la realtà a non concedere altrimenti? Del resto, Gomorra non conosce intervalli. Ma qui anziché il come c’è il perché, l’atmosfera ideologica, la temperatura umana del sistema camorristico, affidato ai pensieri in libera uscita di due giovani carcerati. Romeo e Giulietta, forse (www.ilcinematografo.it). Attori: Francesca Riso (Veronica), Alessio Gallo (Salvatore), Carmine Paternoster (Bernardino), Salvatore Ruocco (Mimmo), Antonio Bull (padre di Salvatore), Jean-Yves Morard (Slavo) - Soggetto: Maurizio Braucci e Leonardo Di Costanzo - Sceneggiatura: Maurizio Braucci, Mariangela Barbanente, Leonardo Di Costanzo - Fotografia: Luca Bigazzi - Musiche: Marco Cappelli - Montaggio: Carlotta Cristiani - Scenografia: Luca Servino - Costumi: Kay Devanthey - Suono: Christophe Giovannoni * Rassegna Stampa Il Mattino dell’8 novembre 1958 Domani, domenica, alla presenza del presidente della Camera, on. Giovanni Leone, del presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno on. Giulio Pastore, del Ministro della Sanità, sen. Vincenzo Monaldi, nonché di numerose autorità e personalità di Napoli e della zona flegrea, sarà inaugurato l’acquedotto sottomarino per le isole di Procida e di Ischia, la grande opera che, finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno, viene a risolvere uno dei fondamentali problemi delle due isole del nostro Golfo. Nel quadro della manifestazione che si svolgerà alle ore 11 a Ischia Ponte e che segna una tappa di eccezionale rilievo nel progresso economico e sociale delle isole flegree, si inserisce una cerimonia che si svolgerà sul piazzale della spiaggia dei pescatori, nel punto ove sbocca ad Ischia la condotta sottomarina; qui infatti sarà scoperta una lapide dettata dal Vescovo di Ischia, Mons. Antonio Cece, a ricordo dell’avvenimento. Fontane-ricordo saranno quindi inaugurate dopo i discorsi celebrativi, a Porto d’Ischia, a Ca- samicciola, Lacco Ameno e Forio. A impartire la benedizione agli impianti dell’acquedotto sarà lo stesso Vescovo d’Ischia. A Lacco Ameno si procederà nella stessa giornata alla posa della prima pietra della strada Pannella-Fango, opera finanziata anche dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il Mattino del 10 novembre 1958 Il primo getto d’acqua è zampillato ieri ad Ischia I discorsi del Ministro Pastore, del Prof. Pescatore e di Mons. Cece alla presenza del Minisrro alla Sanità Monaldi e di molte altre personalità Un’aspirazione lunga secoli e che per secoli era sembrata destinata a non dover essere mai appagata è diventata da mezzogiorno di ieri una realtà concreta, viva e visibile, una commovente realtà che è sbocciata insieme con un alto e luminoso zampillo nel cielo dell’isola d’Ischia, la quale, finalmente, ha visto coronato dal più sicuro successo tecnico un’opera arditissima: l’acquedotto che dalle lontane sorgenti del Toreno, nel cuore del Matese, adduce milioni di metri cubi d’acqua potabile La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 15 all’isola che ne era purtroppo priva, superando con incredibili balzi i fondali sottomarini che la dividono da Procida e dalla terraferma. L’acquedotto sottomarino per le isole di Procida e di Ischia, diramazione spettacolare del grande acquedotto campano che la Cassa per il Mezzogiorno sta costruendo per 164 comuni della regione, partendo dal grande serbatoio di Bacoli, raggiunge la riva del mare sulla spaggia di Miliscola, già sacra ai miti virgiliani e già famosa per la «schola militum» che vi aveva sede per scomparire sotto il mare del Canale di Procida che raggiunge una profondità di diciotto metri e risalire quindi dalla Marina di Sancio Cattolico fino a un altro grande serbatoio dal quale ridiscende in galleria fino a Vivara e di qui, con un secondo tronco sottomarino, come il primo in doppia condotta, raggiunge finalmente Ischia Ponte, sul molo che si stende all’ombra del Castello Aragonese. Quest’acquedotto che è stato progettato e condotto a termine secondo una tecnica modernissima è indubbiamente un’opera che non ha altri riscontri, per essere essa destinata a durare nel tempo e a soddisfare le esigenze anche future delle crescenti popolazioni delle due isole flegree; e le difficoltà, certamente non poche e non lievi, che si sono dovute superare, i problemi che si son dovuti impostare e risolvere per posare su fondali battuti dalle correnti i grossi tubi e difenderli da ogni possibile minaccia, affondandoli in ben costruite trincee sottomarine, danno subito il valore e il significato dell’impresa che oggi ha segnato anche per Ischia - come due anni fa segnò per Procida - una data faustissima nella storia delle due isole. Forse soltanto i tecnici e gli esperti, convenuti ieri a Ischia per assistere alla solenne inaugurazione del primo zampillo d’acqua potabile venuto dalla terraferma, potevano giudicare dei rischi e della grande somma non soltanto di denaro ma di lavoro occorso per 16 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 questa realizzazione: perché la gran folla di isolani che assisteva giubilante alla manifestazione e che ascoltava i discorsi ufficiali e che vedeva sfilare tante autorità civili, militari e religiose mai si rendeva conto, nella prima gioia, del grandissimo dono ricevuto, del prodigioso evento che significava quell’altissimo zampillo d’acqua pura che controluce e nella leggera brezza antimeridiana si sventagliava in un velo iridiscente. Eppure, se l’acqua significa vita, Ischia da mezzogiorno di ieri riceveva proprio come una nuova vita, poteva annoverare la data del 9 novembre del 1958 fra le sue più felici, quella appunto destinata a iniziare una più sicura e vivace economia. E le fontane, le prime approntate nei comuni di Ischia, di Casamicciola, di Forio e di Lacco con il loro freschissimo e nuovissimo murmure accompagnavano le nuove certezze alle quali Ischia si avvia. A salutare l’eccezionale avvenimento erano intervenuti ieri a Ischia Ponte numerose autorità, fra le quali il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, on. Giulio Pastore; il Ministro della Sanità prof. Vincenzo Monaldi, il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno prof. Gabriele Pescatore, il Commissario al Turismo on. Romani, il Prefetto di Napoli dott. Spasiano, il Vescovo di Ischia Mons. Antonio Cece, il dott. La Grotta in rappresentanza del Questore di Napoli, il sen. Piegari, l’on. Stefano Riccio, il sen. D’Albora, l’on. Titomanlio, il prof. Lordi, preside della Facoltà di Economia dell’Università di Napoli, il dott. Orcel, direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno, l’avv. Waschimps della Provincia di Napoli, il dott. Giacomo Deuringer, presidente dell’Ente Valorizzazione di Ischia, il dott. Enzo Fiore, il Grande Uff. Renato Barendson, presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, il prof. Carlo Venditti, S. E. Nicandro Siravo, primo presidente della Corte di Appello, il comm. dott. Ali, intendente di Finanza, il Sovrintendente Riccardo Pacini, il prof. on. Cortese, l’avv. Vito Antonio Di Cagno, presidente della SME, il prof. Carrocca, il prof. Jacopetti, l’ing. Porcaro, l’avv. Cordona, il dott. Lazzara, Marino Turchi, il dott. Enrico Palla, l’ing. Grassini, l’ing. Tescione, l’ing. Celentano, l’ing. Pistilli e moltissimi altri tra i quali molte autorità militari. Nella Piazza Aragonese, ai piedi dello storico castello ed al cospetto del mare, si è svolta la cerimonia dell’inaugurazione dell’acquedotto sottomarino, una delle più grandi opere del genere realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno, tra innumerevoli difficoltà d’ambiente. L’opera è stata brevemente illustrata dal prof. Pescatore che ha preso la parola dopo il saluto dei sindaci di Porto d’Ischia e Casamiccciola e del vescovo Mons. Cece, il quale ha dettato in latino la iscrizione per una lapide-ricordo. Il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno nel suo breve discorso ha soprattutto ricordato e ringraziato gli uomini cche hanno realizzato l’opera, vincendo le avversità della natura: gli ingegneri, i geometri, gli operai e i palombari. Il Ministro Pastore quindi tra il suono delle sirene dei vaporetti e quello delle campane di tutte le chiese dell’isola, ha premuto il pulsante dando il via a un potente getto d’acqua che ha zampillato raggiungendo l’altezza di trenta metri. Il ministro Pastore ha successivamente rilevato come la importante opera inaugurata sia la conferma della validità della politica dello Stato nel Mezzogiorno e la prova più evidente di ciò che il governo democratico intende fare per le popolazioni meridionali. «È così - ha detto l’on. Pastore che lo Stato democratico intende assolvere ai suoi doveri fondamentali verso le popolazioni più bisognose, realizzando quelle opere che sono in stretta aderenza alle esigenze delle popolazioni stesse». Il Ministro ha tenuto quindi ad assicurare che sarà presto risolto il problema del fabbisogno idrico della Campania attraverso il completamento del sistema degli acquedotti in corso di realizzazione nella regione. Egli ha inoltre annunciato che attualmente è all’esame del consiglio superiore dei LL. PP. un piano generale riguardante la utilizzzione delle acque del Biferno. «A conclusione degli studi con tutta la larghezza di mezzi di cui la Cassa ha potuto disporre - ha proseguito il Ministro - tale piano generale di utilizzazione può schematicamente essere rappresentato dai seguenti piani qualificativi: alimentazione di acqua potabile per quattro milioni di abitanti (previsioni all’anno duemila); irrigazione di 25.500 ettari dei quali 20.100 in Molise e 5.000 in Campania (Sannio-Alifano); produzione di 156 milioni di kilovattore annui effettivi dei quali 38 milioni lungo l’asta del Biferno e 118 milioni in due centrali da costruirsi lungo l’asta dell’Acquedotto campano. Il costo complessivo delle opere è previsto in circa 35 miliardi di lire». Altro problema al quale l’on. Pastore ha accennato nel corso del suo discorso è la rete idrica interna e le fognature dell’isola. Egli ha assicurato che tutti i comuni e tutte le case dell’isola avranno l’acqua. «Sarà un nuovo problema - ha detto - per il quale la Cassa assume, fin da questo momento, di fronte alla popolazione interessata un preciso impegno». «A questo punto - ha esclamato il Ministro - consentitemi alcune brevi parole di commento per sottolineare l’importanza di quest’opera oggi inaugurata nel quadro della politica dello Stato democrativo a favore del Mezzogiorno, politica che trdotta sul piano reale è chiaramente illustrata dalle seguenti cifre: al 30 ottobre scorso risultavano erogati dalla Cassa fondi per 330 miliardi di lire di cui 230 miliardi riguardanti opere completate e 600 miliardi per lavori in corso di esecuzione. Se a queste cifre si aggiungono le centinaia di miliardi spesi in opere pubbliche essenziali nel resto del territorio nazionale, si ha l’idea del coraggioso sforzo compiuto, sforzo che assume un particolare significato sol che si consideri che è stato compiuto in un momento di gravissime difficoltà economiche». «Ma - ha aggiunto l’on. Pastore - a cosa servirebbe aver speso cifre tanto ingenti come quelle annunciate, se tutto ciò dovesse rimanere nella fase delle infrastrutture; se cioè da questo fervore di opere non derivasse un sostanziale miglioramento di vita delle popolazioni del Mezzogiorno? E qui sorge spontaneo l’invito che lo Stato rivolge alla privata iniziativa per- Foto da un documento della Cassa per il Mezzogiorno - Dott. Ing. Pietro Celentani Ungaro, Capo del Servizio Acquedotti e Fognature, Acquedotto sottomarino per le isole di Ischia e Procida. Oltre le varie relazioni sui lavori, vi si legge: «Il giorno 9 novembre 1958, con l’intervento del Ministro Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, si svolse la cerimonia inaugurale con un getto d’acqua di circa 40 metri di altezza al manufatto di arrivo della condotta sottomarina al Piazzale Aragonese di Ischia e con la successiva apertura di fontane nei comuni di Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno e Forio». La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 17 ché faccia avvertire la sua maggiore presenza in quest’opera di rinascita del Sud. Non può esservi secondo tempo della politica del Mezzogiorno senza un fattivo e cosciente intervento del capitale privato del sud e del centro nord che contribuisca a completare ed a consolidare l’opera iniziata dai pubblici poteri. I nuovi provvedimenti che saranno adottati prossimamente - ha concluso Pastore - aprono nuove prospettive anche all’iniziativa privata soprattutto nel settore della industrializzazione» Il gruppo delle autorità ha poi inaugurato delle graziose fontanericordo, opera del prof. Luigi Parisio nei comuni di Porto d’Ischia, Casa- micciola Terme, Lacco Ameno e Forio. Sarà adesso compito dei comuni dell’isola d’Ischia con l’apporto della Cassa d’approntare nel più breve tempo possibile una rete idraulica che possa dotare tutte le case dell’Isola, le più ricche come le più povere, dell’acqua potabile. Ed è certo che l’opera così generosamente finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno (la quale ha speso per l’acquedotto flegreo e delle isole ben due miliardi e cinquecento milioni di lire; i soli attraversamenti sottomarini, che hanno fra l’altro richiesto l’impiego di una manodopera specializzata, di palombari e di sommozzatori, sono costati complessivamente circa un miliardo di lire) sarà completata nel più breve tempo possibile. Già la prossima estate, quando il flusso turistico verso Ischia, già così imponente, avrà raggiunto una punta più alta, l’Isola sarà in gran parte attrezzata per soddisfare le accresciute esigenze anche degli ospiti stagionali. Accanto al rinomatissimo patrimonio di acque minerali e termali, accanto all’incremento dell’attrezzatura alberghiera, e al fermento delle nuove iniziative commerciali sta questa pietra basilare dell’acqua potabile a rendere il cammino di Ischia più facile e più ricco. Mario Stefanile La Lettura, rivista mensile del Corriere dell sera, 1 luglio 1929, anno VII Se ogni terra ha la sua leggenda, poche, però, possono vantarne una così bella come il mito leggendario che canta poeticamente le origini dell’isola d’Ischia, lo scoglio turrito ed or cadente, che fu eletto da Ariosto a sua dimora per studiarvi intorno al suo poema e, via via, attraverso i secoli, ospitò il Pontano, il Panormita, il Sannazzaro, Fabrizio Colonna, Torquato Tasso, Giovanbattista Vico e tutta una schiera dì principi del sangue, di guerrieri, di artisti. La leggenda e un po’ di storia La leggenda è semplice, ma venata di poesia. Giove, irritato verso Tifeo, uno dei titani ribelli, gli lanciò contro un masso enorme. Quel masso cadde presso il lago Miseno e sorse d’incanto la nuova isola, novella gemma del mare di Partenope, sotto la quale si dibatte Tifeo, che regge il monte sul petto. Ogni tanto il gigante si scuote, e tutte ne tremano le pendici dell’isola. Si spiegano così i movimenti tellurici che nei secoli hanno sconvolto l’isola, la quale è così lieta e festosa nelle sue rocce e nelle sue insenature rivestite di ville, di giardini, di casupole, e sorgenti 18 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 come d’incanto dall’onda di cupo azzurro, da giustificare pienamente l’appellativo di «Risata di Tifeo» che nel nostro immaginifico e colorito linguaggio si è voluto dare ad Ischia. La storia d’Ischia, a volerla esporre cronologicamente, occuperebbe un volume. Questo scoglio che per la potenza radioattiva delle sue acque e per la visione di stupendi scenari, glauchi di cielo e di mare, meriterebbe una notorietà assai più vasta di’ quella che non abbia, tra la temibile concorrenza di Capri e quella di Sorrento, è stato cantato ed esaltato dai maggiori poeti, da Omero a Pindaro, a Esiodo, a Strabone, a Orazio, a Virgilio, a Ovidio, a Vitruvio, al Petrarca, al Boccaccio, all’Ariosto. I suoi primi abitatori furono Osci ed Etruschi, e ad essi successero gli Enotri e, più tardi, i Fenici. Per cinque secoli vi si mantennero gli Eritrei; seguì l’occupazione dei Siracusani e, infine, il dominio dei Romani che tennero l’isola per tre secoli, fin che Ottaviano, nell’anno V d. C, la cedette ai napoletani in cambio dell’isola di Capri. Nelle orride prigioni del suo castello, fondato dai Siracusani, languiro- no, tra gli altri, Carlo Poerio, Silvio Spaventa, ed altri patrioti vittime della reazione borbonica. In quello stesso castello avevano già palpitato i cuori innamorati di Alfonso d’Aragona e di Lucrezia d’Alagno. Uno sguardo a volo d’uccello Il forestiero che, armato di Baedecker, giunge a Napoli, ha sempre in programma - tra una escursione al Vesuvio ed una visita a Pompei - una gita alla Grotta Azzurra, a quel mirabile recesso nel quale il pilota audace di Argo, per volere di Giove, si dispogliò delle sue scaglie che diedero al mare i loro fantastici colori. E dalla Grotta Azzurra il forestiero risale le straderte profumate che s’inerpicano lungo la Sella, tagliando nettamente la roccia, e si ferma estatico innanzi alla selvaggia bellezza dell’Arco Naturale, alla muta poesia dei Faraglioni, al dolce incanto della Certosa. Ma difficilmente accade che quello stesso forestiero, il quale arriva a Napoli con negli occhi la visione di Capri, che le cartoline illustrate hanno diffuso in tutto il mondo, allunghi il suo sguardo all’altro versante del golfo e senta vaghezza di visitare l’isola d’Ischia. Eppure essa è tutta una meraviglia. A due passi da Ischia è Porto d’Ischia con la Casina Reale Borbonica, ora stabilimento termale; e a mezz’ora di distanza, è Barano, famosa pei suoi vini. Sulla riviera meridionale, in altura, Serrara e Fontana (che formano un solo comune) sono la... Svizzera dell’isola. In alto, l’Epomeo, vulcano spento, che servì nei tempi passati assai spesso di rifugio agli isolani contro le invasioni barbariche o piratesche. Poco lontano, Casamicciola, dalle mille sorgenti salutari, fanghi e dalle stufe rinomatissimi, e famosa anche per il terribile terremoto del luglio 1883, di cui ancora si rammemora la violenza, e che fu l’incentivo a una mondiale manifestazione di fratellanza benefica. In collina, Forio, patria del sapido vino che tutto il mondo pregia. Accosciata ai piedi del monte Vico, la borgata di Lacco Ameno. A questo biondo paesello in ogni tempo hanno chiesto ristoro salutare sovrani, artisti, generali; Francesco I, Carlo Felice, Ferdinando II, Massimiliano I e Carlo I di Baviera, Don Carlos... Qui Enea, nel 1184 a. C, si rifugiò con i suoi compagni («poi che il superbo Ilion fu combusto»». E Caio Mario, dopo la vittoria di Silla, rimase alcun tempo nascosto in una grotta del monte Vico. L’estate mette di moda l’isola, che, se dai forestieri è quasi ignorata, non lo è dai napoletani, i quali preferiscono la sua bella spiaggia alle bizzarre grotte capresi e agli snervanti profumi di Sorrento. Sulla spiaggia d’Ischia, che si stende a perdita di vista lungo il mare, ai piedi del «vitifero monte», durante i mesi estivi, è tutta una fioritura di ombrelloni e di tende a strisce policrome o audacemente colorate in rosso e in giallo. Sono migliaia di bagnanti, che chiedono alla rena fina, soffice, dorata, qualche ora di oblio e di riposo. Vittorio Ricciuti FAI – INTESA SAN PAOLO: Il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare I Luoghi del Cuore (segue da pagina 2 di copertina) I cittadini dell’isola d’Ischia hanno partecipato al censimento con varie segnalazioni, più o meno votate. Da un esame fatto a poco tempo dalla scadenza (30 novembre 2012) delle segnalazioni, abbiamo rintracciato i seguenti luoghi, individuati nel sito www.iluoghidelcuore.it sotto l’indicazione dei comuni isolani: Significative soprattutto le numerose segnalazioni ricevute per il Pio Monte della Misericordia di Casamicciola Terme, che ha potuto giovarsi del notevole appoggio di gruppi formati ad hoc e di un progetto dibattuto e proposto in loco per l’eventuale recupero del complesso: una grande mobilitazione civile per il recupero del complesso del Pio Monte della Misericordia di Casamicciola in rovina da 40 anni, senza che l’Ente Morale proprietario e le istituzioni locali (Comune, Provincia e Regione) siano state capaci di trovare una soluzione giuridicamente e linearmente praticabile pur in presenza di una enormità di sostegni finanziari da parte dello Stato, prima, e poi dell’Unione Europea. Barano e Serrara Fontana: Spiaggia dei Maronti. Casamicciola Terme: Pio Monte delle Misericordia, Osservatorio Geofisico 1855, Bosco della Maddalena, Località Rarone. Forio: Chiesa del Soccorso, Giardini della Mortella, Baia di Citara, Baia di Sorgeto / Casa greca dell’VIII s. a. C., Chiesa dell’Arciconfraternita di Visitapoveri, Spiaggia di San Francesco, La Colombaia / Villa di Luchino Visconti, Convento di San Francesco. Ischia: Castello Aragonese, Sant’Angelo, Regno di Nettuno / Area Marina Protetta, Golfo dei Maronti, Baia di Cartaromana, Chiesetta dei Pescatori, La collina del Montagnone, Sorgeto, Pilastri antico acquedotto. Lacco Ameno: Villa Arbusto / Museo di Pithecusae, Scavi e Museo di S. Restituta. La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 19 Ex libris Nuovissima Guida dei Viaggiatori in Italia, V edizione, Milano 1839 Isole dei dintorni di Napoli CAPRI - Da Capo Miseno all’Isola di Capri, il tragitto non è più lungo di cinque ore. Quest’isola è composta di due villaggi chiamati l’uno Capri, l’altro Anacapri. Per entrare in questo secondo bisogna salire una scala stretta, composta di 500 gradini. Se il viaggiatore ama le belle viste, ascenda il Monte Solaro e non gli dorrà di averne sostenuto la fatica, essendo impossibile di dare un’idea anche approssimativa del colpo d’occhio che ivi si gode: pressoché tntti i viaggiatori si accordano nell’asserire non esservi in Italia più bella vista, il che non è poco dire. Vedesi eziandio in quest’Isola il palazzo di Tiberio attuato sopra un’altura. GROTTA AZZURRA - La scoperta di questa grotta è tanto singolare che noi crediamo di parlarne. Due inglesi nuotavano lungo le spiagge di Capri, quando un di essi, vista una caverna in uno dei massi lunghesso il lido, ebbe il coraggio di penetrarvi. Quanta fu la sua sorpresa e la sua ammirazione veggendovi un placido lago della circonferenza di quasi un quarto di miglio, in mezzo al quale tutto è azzurro: i sassi, l’acqua, la sabbia coperte dello stesso colore il quale, lungi di ferir l’occhio, vi arriva dolce e temprato, non senza maraviglia. L’acqua vi è profonda quindici piedi all’incirca ed è sì pura e limpida che pare non aversi che ad allungare la mano e raccogliervi le cose che veggonsi sul fondo. Altissima ne è la volta, la quale è formata da una rupe tutta cospersa di stalattiti. L’ingresso della Grotta Azzurra è molto difficile, non potendovisi entrare che sopra una barchetta assai piatta nella quale coricarsi col ventre in giù, aspettando che il barcaiolo cogliendo il momento in cui l’onda si precipita muggendo all’ingresso della grotta, si lasci da quella strascinare nell’interno. Si fanno più volte inutili tentativi a quest’oggetto e non di rado sarebbe temerità il tentarne l’accesso. ISCHIA - Chiamata altre volte Pithecusa, è la maggior isola che si trova nel golfo di Napoli. Secondo Strabone i primi abitatori di Ischia furono gli Eritrei, i quali dovettero poscia abbandonarla a cagione delle continue eruzioni vulcaniche, cui trovavasi esposta. Essa rimase deserta sino a 400 anni prima di Gesù Cristo. I Romani di poi stabilironsi in essa, indi la cedettero ai Napoletani cambiandola con Capri. Quest’Isola dovette naturalmente subire la fortuna della Metropoli e soffrire al par di essa frequenti vicissitudini. Alfonso di Aragona ne cacciò tutti gli 20 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 abitanti maschi, rimpiazzandoli con Catalani e Spagnuoli presi all’azzardo dal suo esercito, ai quali fece sposare le vedove e le figlie dei poveri esiliati. Ischia offre al viaggiatore molte curiosità. Benché la superficie non sia maggiore di diciotto miglia quadrate, contiene una città di 3000 e più abitanti e dieci villaggi, la cui popolazione non è minore di 20 mila anime. Il fuoco sotterraneo, da cui quest’isola è fomentata, comunica alla vegetazione una straordinaria attività e somministra molte salutari virtù alle sue acque termali. Aria, erbe, frutti, latte, ogni cosa in somma è ivi di rara qualità. I pesci delle sue coste hanno essi pure una incontrastabile superiorità a quelli del mare circostante. Il vulcano del Monte Epomeo oggi chiamato S. Nicola è iI più rimarchevole di quanti ve ne ha in tutta l’Isola. La città di Ischia è fabbricata sopra una roccia di basalto dell’altezza di 600 piedi, ma più non offre che lo spettro dell’Ischia del Medio Evo, la quale fu distrutta nell’anno 1302 da una eruzione dell’Epomeo, la quale fu sì terribile che mise in fiamme tutta l’isola per il corso di due interi mesi. Si visiterà con piacere questo monte Epomeo ora mentovato, benché la salita ne sia alquanto difficile. Sulla sommità di esso godesi una bellissima vista. Si può anche prender riposo al romitaggio, il quale si compone di una casetta scavata nel sasso e di una cappella, di cui la sola facciata è in mattoni. Questo piccolo santuario conservò sempre la primitiva sua semplicità, benché gran numero di pellegrini vadano a farvi le loro divozioni. Gli altri oggetti degni d’esser veduti sono: il campo di Lava dell’Arso, il Lago d’Ischia, le Stufe di Castiglione, i celebri bagni di Casamicia e la famosa fabbrica di cappelli di paglia. PROCIDA - Quest’isola è situata tra quella d’Ischia e iI Capo Miseno; ha una superficie di cinque miglia quadrate, è fecondissima, poco montuosa e abbonda di pernici e di fagiani. Vi si vedono molti avanzi di antichità, molte belle case di campagna e contiene circa 12.000 abitanti. Il suo castello, altre volte di qualche importanza, è oggi interamente smantellato e serve di convegno ai cacciatori. Le tristi sue mura ricordano il nome di quel crudele Giovanni di Procida, signore dell’Isola ed autor principale del famoso massacro conosciuto sotto il nome di Vespro Siciliano. Gli abitanti di quest’isola sono reputati i migliori marinai dell’Italia. Il golfo di Napoli è seminato di molte altre isolette che noi non procediamo a descrivere onde evitare lungaggini; tanto più che nulla offrono d’interessante, tranne le prospettive più o meno belle che vi si incontrano. Crediamo quindi doverci limitare alla descrizione di quelle, di cui le storie fanno più frequente ricordanza. * Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica compilato dal Cavaliere Gaetano Moroni Romano – vol. XXXVI, Venezia 1846 ISCHIA (Isclan). Città con residenza vescovile nel Re- gno delle due Sicilie nella provincia di Napoli, capoluogo di cantone, sulla costa nordest dell’isola del suo nome, ove ha una piccola baia: l’isola d’Ischia dagli antichi fu celebrata per le sue acque minerali, di cui la vestale Attilia Metella sperimentò la salutare efficacia. Tali acque, dal terremoto del 1728 in parte fatte sparire, non formano le sole celebrità d’Ischia, ch’è separata dalla costa per un canale largo due leghe, ed in uno stretto spazio presenta concentrate tutte le bellezze che leggiadro e dovizioso rendono il golfo di Napoli. Ischia, Iscla Aenaria, è situata sopra una rupe di basalto, che si eleva all’altezza di seicento piedi dal livello del mare. Troncata a mezzo nei fianchi sud ed ovest, si veggono su dolce pendio gli avanzi di una città costruitavi nel medio evo, circondata da giardini. Sono oggi quegli edifizi abbandonati, e sull’alto della rocca esiste solo la cittadella o castello. Tutto lo scoglio è unito all’isola mediante un molo, ovvero istmo artificiale, con un ponte levatoio, e si sale alla cima per una galleria coperta, praticata per lo più sul massiccio. Si riguardò nel medio evo come fortezza inespugnabile, e sulla rupe ebbero sicuro asilo nelle guerre i cittadini pacifici. Ma nel ritorno della quiete non tardarono a stabilirsi nella amena riva dell’isola posta di rimpetto, e gittarono così le fondamenta dell’odierna città d’Ischia, chiamata anche Celso. Sicura stazione hanno i bastimenti lungo le due coste del molo e specialmente nella boreale. Le strade sono larghe e dritte; fresc’acqua zampilla dalle varie fontane, recatavi dal monte Epomeo mediante un lungo acquedotto d’una lega. L’Epomeo, che occupa il centro dell’isola, è un vulcano estinto; l’ultima sua eruzione avvenne nel 1302. I migliori edifici consistono nella cattedrale, nel palazzo vescovile, nel seminario ed in altri fabbricati. Bisogna traversare il campo formato dalla lava d’Arso, detta anche di Cremato, che si eleva a cinquanta piedi di altezza, per giungere ai rinomati bagni d’Ischia, che sono per essi divisi dal paese. Si vede in una prossima collina una casa di delizia del re delle Due Sicilie, ed al piè di essa si discopre il villaggio ove sono le due sorgenti di acque termominerali, di natura muriatica, a quaranta gradi di calorico, le quali si chiamano Fontana d’Ischia e Fornello: ambedue hanno casa annessa dove si prendono i bagni. La soprabbondanza delle acque forma un ruscello, che a pochi passi si getta nel sottoposto lago d’Ischia diviso dal mare per un banco di sabbia, all’estremità del quale è praticato un canale di comunicazione. Il circuito del lago non supera tre quarti di miglio, ed è il fondo di un cratere formato all’est dal promontorio di lave di s. Pietro a Pantanello e al nord ed ovest dalle colline vulcaniche di s. Alessandro. Al sud d’Ischia si entra nella ridente pia- nura di Campagnano; la fertilità del suolo, le fonti e la vista dell’acquedotto che attraversa il villaggio, recando ad Ischia le acque di Buceto, rendono il soggiorno piacevole ed amenissimo. Nella suddetta fortezza, come luogo tenuto allora quasi inaccessibile, ritirossi nel 1496 Fedinando II re di Napoli, allorché Carlo VIII re di Francia conquistò il regno; e nel 1501 fuggì da Ischia l’infelice Federico III, mentre il re di Spagna Ferdinando V insieme al re di Francia Luigi XII dividenvasi il regno delle Due Sicilie. Nel 1807 l’isola d’Ischia fu presa dalle truppe inglesi e siciliane che poscia l’abbandonarono. Questa antichissima città, secondo Strabone e Plinio, avrebbe avuto per fondatori i Calcedonii dell’Eubea. Cadde in potere dei Greci e dei Romani; i goti, i lombardi ed i normanni l’occuparono altresì successivamente. Spesso presa e ripresa nelle guerre, di cui il regno di Napoli fu per sì lungo tempo il teatro, Ischia fu pure esposta alle incursioni dei corsari dell’Africa. Allorquando comandava in Ischia il marchese del Vasto, il pirata Ariadeno Barbarossa irritato contro quel prode capitano, che gravi perdite avea fatto soffrire a’ turchi, fece una discesa dalla parte di Forio e saccheggiò questo borgo, non che Panza, Barano e tutto il territorio sino alla porta del Castello, portando seco quattromila isolani che furono venduti come schiavi. Tuttavolta i danni della guerra, congiunti ai naturali flagelli che tanto spesso desolarono Ischia, non diminuirono la numerosa e bella popolazione, giacché i suoi abitanti sembrano partecipare alla fecondità del suolo. * Geografia medica dell’Italia – Acque minerali - Notizie raccolte dal Cav. Dott. Luigi Marieni – Milano 1870 ISCHIA. - Isola del mare Mediterraneo, situata a li- beccio del promontorio che divide il golfo di Napoli da quello di Gaeta. I Latini la chiamarono Enaria, Omero Inarime, ed i Greci Pitecusa (Plin. lib. III, c. 6). - Ha poco più di 21 miglia di circonferenza, 3 di larghezza da tramontana al mezzodì, e 5 di lunghezza dalla punta Cornacchia alla punta San Pancrazio, o sia da maestro verso scirocco. - Ed è discosta miglia 2 dall’isola Procida, 5 e mezzo dal Continente, 10 dalle ruine di Cuma, 17 da Napoli, 18 dall’isola di Capri, e 38 da Gaeta. - Il monte Epomeo (oggi San Nicola), elevato sopra il mare metri 768, torreggia nel suo mezzo, ed è circondato di colline che declinano più o meno lentamente alla marina. Ischia è l’isola più bella, e la più interessante dei dintorni di Napoli. «L’isola d’Ischia, dice Chevalley de Rivaz, vista dal Continente, o a certa distanza in mare, rassembra una piramide che sorge maestosa dall’azzurro piano delle onde, ed alta elevando il doppio vertice in cielo, compone il più grandioso e fantastico prospetto che si possa riguardare; ma varcato il canal di Procida, ti si scopre nel pieno La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 21 di sua bellezza. A scirocco ed a levante, vestite della più rigogliosa vegetazione gradatamente si estollono colline ad anfiteatro fino all’eccelso Epomeo, che fra quei colli grandeggia. Il quale quasi a piombo stagliato in cima verso settentrione, discende a ponente in un piano declive, finché termini in un piccol cono così detto di Vico. Qui verdi boschi e vigneti, che ammantano i colli e serpono per la montagna, là sterili rocce e bitumi, scemi di ogni splendore, e sopravi i due cocuzzoli dell’Epomeo in mirabil contrasto. E come ti avvicini all’isola, qui promontori, là baje, poi colli, poi monti si aprono ad uno ad uno allo sguardo, sempre nuovi, sfoggiati e dilettosi, sparsi qua e là di terre, di casali e di ville, la cui bianchezza sì ben campeggia su quella freschissima verdura. Cotanta varietà di siti, cotal ricchezza di vedute, ti effondono per gli occhi al cuore una dolcezza, una emozione inesplicabile, che al toccar del lido di quest’isola fortunata cresce a mille doppi per la salubrità dell’aere tuttor temperato da soavissimo venticello, fin nei più forti ardori dell’estate. Le quali cose attentamente osservando, non è chi subito non divisi non aver forse al mondo un’altra Ischia, ove in lido sì breve piacquesi la Provvidenza profondere a piena mano tante bellezze ed incanti, che sopra quante contrade non vaglia a ricordare prima la fanno e prediletta di natura». I poeti antichi, per indicare che quest’isola è vulcanica e soggetta ai terremuoti ed ai turbini, dissero che si trovava sepolto sotto di essa il gigante Tifeo o Tifone (Pindaro, Ode Olimpica IX e Pitia I. - Virgilio, Eneide lib. IX, v. 716). (1) - Gli Eretriesi ed i Calcidesi, che furono i primi a popolarla, ed in progresso di tempo anche coloro che vennero colà spediti da Jerone, tiranno di Siracusa, furono costretti di abbandonarla dai terremoti, dalle eruzioni di fuoco, di mare e di acque calde. - Timeo di Taormina scrisse, che poco prima dell’età sua (cioè nel secolo IV avanti l’E. V.) l’Epomeo, scosso dai terremoti, gettò fuoco e spinse in alto il terreno che si trovava fra esso e il mare. Questo terreno ricadde poi a modo di turbine, e il mare da prima ritirossi per tre stadj, poscia inondò l’isola. Gli abitanti del Continente, spaventati dal grande frastuono che accompagnò questo turbine, fuggirono addentro nella Campania (Strabone, lib. V, c. 9). - Altri scrittori citano altre eruzioni di questo vulcano avvenute sotto il consolato di Sesto Giulio Cesare e di L. Marcio Filippo (l’anno 91 av. Cristo), ed ai tempi degli imperatori Tito, Antonino e Diocleziano. - L’anno 1228, regnando Federico imperatore, l’Epomeo talmente infuriò, che Riccardo da San Germano scriveva: Eodern mense julii motis Isclae subversus est, et operuit in casalibus sub eo degentes fere septincentos homines inter viros et mulieres. - Ma più famosa fu la eruzione avvenuta, secondo l’Elisio e il Bacci, l’anno 1301, e secondo Giovanni Villani (Istorie, lib. VIII, c. 53), e Tolomeo Fiadoni di Lucca, citato da Humboldt (Cosmos t. IX, p. 478), nel 1302. Questa eruzione durò due mesi, producendo molti guasti e ruine, e obbligando parte di quegli abitanti a fuggire nelle isole di Procida e di Capri, a Napoli, a Baja ed a 22 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Pozzuoli. E vuolsi che allora sia colà rimasta sepolta la città di Geronda. - Finalmente l’isola d’Ischia soffrì molti danni dal terremoto del 2 febbrajo 1828, che distrusse in gran parte Casa-Micciola, ma il re Francesco I la fece risorgere con larghe elargizioni. Alcuni scrittori accertano che fu nell’isola d’Ischia che venne stabilita la prima fabbrica d’allume in Italia. L’isola d’Ischia è compresa nel circondario di Pozzuoli, e forma due mandamenti che sono quello d’Ischia, e quello di Forio, popolati il primo da 13416 abitanti, e il secondo da 12749. - Essa è molto ricca di acque minerali, note e molto usate anche dagli antichi, che le lodarono spezialmente nella cura della renella (Strabone, l. c., e Plinio, lib. XXXI, c. 2). E ricuperò con esse la salute anche la vestale Attilia Metella. - Sette di queste acque appartengono al mandamento d’Ischia, e quindici a quello di Forio. (1) Francesco Petrarca scriveva nel Trionfo della Castità: Non freme così ‘l mar quando s’adira; Non Inarime allor che Tifeo piagne; Non Mongibel s’ Encelado sospira. * Itinéraire de Jérome Maraund d’Antibes à Costantinople (1544) – Texte italien publié pour la première fois avec une introduction et une traduction par Léon Dorez, Paris , E. Léroux Editeur 1901. (Barbarossa e la sua flotta) Ali 18 di zugno, il signor Bassan andò in terra et fese menar in terra tuti li prisoni christiani que erano stati presi, tanto di……… (…) ….. se era partito con 60 galere di Porto Herculi. A quel giorno medes(s)mo, l’armata gionse in mezo de doe insole non troppo grande, l’una chiamata Maldeventre, et l’altra Bentiten1, et quivi dete fondo et stete fine a la diana. Quelle insole sonno fatte cussi et sonno nel mare Tirreno, deshabitate. Ali 23, a la diana, l’armata partite de l’insula di Bentiten et venete apresso d’una isola ancora lei nel mar Tirreno, propingha a la famosa cità de Napoli a 20 miglia, chiamata Iscla2. Questa insola è grande asai, habitata, 1 L’isola di Ventotene, chiamata anche Vendotena o Pandataria, si trova nel mar Tirreno (golfo di Gaeta); è di forma quasi circolare, inaccessibile quasi da ogni parte. 2 Al margine, di altra mano, si legge: «Pithecusa insula, quae et Aenaria a statione navium Aeneae dicta est. Homerus Inarime vocat; a Graecis Pithecusa a figlinis doliorum, Plin.l. 3 c. 6 – L’isola d’Ischia è situata tra il golfo di Napoli e quello di Gaeta, a 12 km da Capo Miseno. Secondo Giovio (lib. XLV, fol. 340) la città di Centocelle sfuggì al saccheggio e all’incendio solo grazie frutifera, et n’è signore il Marchese del Guasto3 (3). Vi sono 8 cassali; lo principale [è] qualle se chiama Iscla, dove è uno castello insieme con la terra fortissimo. Qui la più parte dil tempo se tiene la signora Marchisa insieme con le sue riquesse4 (4). In uno porto da tramontana d’Iscla a 3 miglia, dove sonno certi maguaseni, trovassemo Sala Rais, il qualle avea brusato la notte inanti certi casali in questa insola et preso anime utriusque sexus doe milia et 405 (5). Il castello et la vila sonno fatti cussi. Inanti di questo castello d’Iscla, l’armata stete uno poccho in giolio6 (7) et poy andò far fondo sotto di la terra de l’insola chiamata Progita7 (8), insola belissima, abondante de frute d’ogni sorte. Questa insolla è piana et competentemente granda, subdita (chomo me fu ditto) al marchese dil Guasto, et distante di terra ferma uno miglio, de la cità de Napoli 12 miglie. In questa insola vi sonno belissimi giardini di diversi gentil’homini Napolitani. Vi sono certi cassali spesialli. Vi è la terra chiamata Progita, la qualle è fatta cussì. hore dapoy mezo giorno, l’arma(r)ta partite di Baia, et andando verso di Napoli, Janetin Doria con 30 galere stava drieto dil capo più presso de Napoli. Et subito visto que hebe l’armata, se messe a fugire verso di Napoli, et la Riale nostra insieme il signor prior di Capoa et Sala Rais li donorono la cassa fin dentro dil porto di Napoli, et de le nostre galiote li furono apresso a tiro d’archibuso, et Janetin con soe galere se mese sotto dil castello di l’Ovo, et lasandolo le nostre galere feseno vella verso l’insula di Capri. * Ali 26 di zugno, li Turchi feseno loro basano sotto dil castello di Baia, de li Cristiani que erano stati presi al insula d’Iscla, qualli erano in numero anime utriusque sexus doe milia et quaranta. A quel medesimo giorno, cioè ali 26 di zugno, ale 5 I primi rimedii adoperati dagli uomini a conforto de’ mali furono senza dubbio quelli presentati spontanei dalla natura, fra’ quali le acque termali furono predilette, e tenute in tanto pregio, che venivano poste sotto la tutela di una divinità. Ancora si trovano in Ischia le statue votive ad Apollo ed alle Ninfe custodi delle acque. Poscia furono le terme naturali confidate alla cura di appositi magistrati; e da ultimo le loro virtù, segnate sulle lapidi, richiamavano da terre lontane gl’infermi disperati da’ medici. E quando ne’ tempi chiamati barbari, le scienze greche e latine decaddero, più viva surse la fede per queste acque, alle quali attribuivansi portentose virtù, e ricevevano enfatici nomi, e predicavansi rimedio di ogni disperato malore. Laonde Ludovico II imperatore nell’anno 866 andò a prendere i bagni in Pozzuoli, e Federico II nel 1227 ricercò in quelle acque un ristoro alle abbattute sue forze. Intanto questo entusiasmo che eccitava la speranza di tutti coloro che soffrivano croniche infermità, nocque alla scienza, e le acque termali sonosi lasciate, e può dirsi essere ancora in balia dell’empirismo; e le loro virtù esser dettate più dalla tradizione che dalla ragione terapeutica. Le acque termo-minerali d’Ischia, più delle altre famose, venute a grande rinomanza nei secoli passati, erano forse più delle altre, in mezzo alla stessa loro celebrità, sconosciute. Son pochi anni soltanto da che la chimica e la clinica han rivolto le loro cure alla conoscenza delle loro facoltà. L’ Accademia Reale delle Scienze destinò dotti uomini e ricchi mezzi per 1’analisi delle principali acque, ma non ottenne quanto desiderava e poteva ragionatamente aspettarsene; per modo che la più celebrata, quella del Gurgitello, non ha ancora un lavoro scientifico degno de’ tempi nostri, ed aspetta con ansia la pubblicazione dei diligenti studii che vi ha fatto il nostro chimico Raffaele Napoli. La clinica ancora vi ha guadagnato negli ultimi anni, ed il dott. Chevalley de Rivaz, raccogliendo con molta diligenza ed amore tutto ciò che si era osservato o fatto, aveva in gran parte disnebbiate le tenebre che tenevano involte le virtù te- alle suppliche di Leone Strozzi: «Indeque directo cursu in Aenariam delatus, odii sui ad Nicem in Alfonsum Davalum concepti omnem acerbitatem effudit, quum nocturna descensione facta, undique insulam complexus, omnes prope incolas, nequicquam in altissima Abacoeti montis culmina evadentes intercepisset, tresque praecipuos ejus insulae pagos, Forinum, Pansam et Varranium, evastasset. Ipsum vero oppidum Pythacusas, Davali sedem, abrupto in colle disjunctaque a mari positum, quum tormentis egregie esset permunitum, aggredi non potuit. Exinde abradens Prochitam, illato minore detrimento, quod incolae demigrantes magna ex parte Pythacusas confugissent, in Puteolanum sese intulit sinum, eo ordine ut classis a Miseno ad Avernum toto Baiano litore extenderetur, tutaque esset a tormentis ejus excelsas arcis, quae est ad Baulos, antiquis Hortensii oratoris deliciis nobilis». 3 Il Marchese di Pescara, Ferdinando Francesco d’Avalos, marito di Vittoria Colonna, era morto a 52 anni, nel 1525, lasciando i suoi beni al cugino Alfonso d’Avalos, marchese del Vasto, colui che fece proditoriamente assassinare Antonio Rincon e Cesare Fregoso nel 1541. 4 Vittoria Colonna aveva soggiornato più volte a Ischia; la sua corrispondenza l’attesta per gli anni 1525, 1526, 1528, 1530, 1531, 1532 et 1535. (V. Carteggio di V. Colonna..., raccolto e pubblicato da Ermanno Ferrero e Giuseppe Müller, Torino, 1889, e Supplemento di Tordi, 1892). – Ma si tratta qui della moglie del cugino Alfonso (cf. la nota precedente), Maria d’Aragona 5 Secondo Adriani (t. II, p. 121), che pone il saccheggio e gl’incendi di Procida prima dell’attacco d’Ischia, Barbarossa prese in quest’ultima isola «più di 1500 persone», e non oso intraprendere l’assalto alla fortezza che era considerata inespugnabile. - Segni (t. II, p. 324) dice, come Paolo Giovio, che il Bassa saccheggiò e devastò Ischia e Procida per vendicarsi degli aiuti offerti dal Marchese del Vasto a Nizza assediata 6 Giolio, per giolito. Cf. Jal, Gloss. naut., p. 783 a 7 Prochita la chiama Plinio perché staccatasi da Aenaria. Cf. Hist. nat., lib. III, c. 6. Annali Civili del Regno delle Due Sicilie, volume LX, 1857 - Statistica Medico-Chirurgica degli infermi curati con le acque termo-minerali di Gurgitello nell’ospizio del Pio Monte della Misericordia in Casanizzola nella state dell’anno 1856, scritta da Giuseppe Palma. Anno terzo, Napoli 1856. La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 23 rapeutiche delle acque, ed aveva aperta la via a studii più metodici e più diretti. Se non che troppo vaga riusciva la clinica poggiata sopra fatti sparsamente raccolti, spesso non seguiti, o ancora alterati da’ racconti d’infermi creduli e speranzosi; o da speculatori interessati, che facevano commercio di quei naturali rimedii; e 1’opera di quel culto medico, e di altri molti che lo imitavano, o tardi avrebbe conseguito lo scopo, o ancora incompiutamente. Per altra via e più sollecitamente doveva la umanità e la scienza conseguire cotanto benefizio, e l’operosa carità, guidata dal sincero desiderio del bene, ha fornito i mezzi per conoscere il vero. Vediamolo. Nel primo anno del secolo XVII surse in Napoli una istituzione di beneficenza, che onora ad un tempo la civiltà cristiana, e la carità delle più nobili e cospicue famiglie di questa città. Chiamossi Monte della Misericordia, perché, impinguandosi di ricchi legati e doni, provvedeva alle opere della misericordia, massime al conforto ed alla cura degl’infermi. Fin da’ primi anni i fondatori stessi vollero somministrare agli ammalati poveri i mezzi di profittare delle acque d’Ischia, scegliendo le più famose ed efficaci; e provvide perché in ogni anno intorno a 400 infermi vi si recassero a spese del pio Istituto. Ma i ricoveri degl’infermi ed i bagni non corrispondevano perfettamente al caritatevole scopo dell’opera, onde con provvido consiglio l’Istituto eresse, presso le sorgenti delle acque del Gurgitello, quel bellissimo ospedale conosciuto col nome di Ospizio del Monte della Misericordia, e che ora, migliorato ed ingrandito accoglie iu ogni anno meglio di 700 infermi fra uomini e donne. Questa caritatevole istituzione, facendo prescegliere ogni anno da un medico consiglio quegl’infermi pe’ quali le acque si credevano indicate, poneva tutta l’opera sua perché ne profittassero con ogni comodità, largamente provvedendo a’ poveri quei conforti, che difficile riusciva a’ ricchi procurarsi coi propri mezzi. Ognuno avrebbe creduto aver la carità fatto abbastanza in favore degli infelici; ma la intelligente pietà de’ nobili uomini deputati negli ultimi anni a reggere le opere del pio istituto, sapientemente suggerì non doversi più confidare unicamente alla tradizione ed alla opinione l’uso di quelle acque; e doversi ordinare a forma clinica quell’ospizio, dando così alla umanità ed alla scienza il frutto di una intelligente osservazione, della quale i soli ospedali sono capaci; e circoscrivendo con regole esatte la indicazione delle acque, in maniera che ne ritraessero gl’infermi quel bene che possono dare e s’impedissero i danni che spesso derivavano dalla cieca confidenza o dalla preoccupazione. Fu questo il gran passo che si diede alla conoscenza del vero; fu questo il mezzo per abbattere i pregiudizi e gli errori. Il Governo del Monte della Misericordia chiamò a consiglio i medici meglio sperimentati per determinare le malattie nelle quali le acque termominerali d’Ischia potevano riuscire utili, e deputò altri istruiti medici a ridurre l’Ospizio di Casamicciola in bene ordinata clinica. Già alcuni lavori erano stati promulgati e primi fre questi e più importanti furono quelli del dott. Raffaello Zarlenga, il quale ad una solida istruzione congiungeva uno spirito di esatta osservazione. Ma in onore del vero vuolsi confessare che l’ordinamento più metodico del servizio medico, ed una cura più intelligente e più costante nella scelta degl’infermi, e nel ragionato 24 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 uso delle acque, debbesi all’attuale Governo del pio Istituto, ed alle sollecitudini di S. E. il Duca di Laurino, maggiordomo maggiore di S. M. la Regina, che ne è il Soprantendente. Corre il terzo anno da che, sotto i suoi auspicii, il colto medico Giuseppe Palma pubblica la statistica medico-chirurgica degl’infermi curati con le acque termo-minerali di Gurgitello: Opera importantissima dalla quale molti pregiudizii sono stati distrutti, e la indicazione di quelle acque viene scientificamente determinata per mezzo di un’osservazione esatta, e spesso ancora ripetuta. E si può aggiugnere altresì che quest’opera è una delle pochissime scritte senza spirito di interesse o di parte: poiché quest’Ospizio aspira ad essere utile agl’infermi poveri, non ha bisogno di cercare avventori, ed ha il giusto desiderio di scegliere fra’ molti che si presentano quelli soli a’ quali le acque possono riuscir proficue. (...) * Istorie Fiorentine dall’anno 1527 al 1555 scritte da Bernardo Segni, vo- lume unico, Firenze 1857 Ischia rifugia i nobili di Napoli - Lautrech in questo mezzo nel principio del mese d’aprile teneva assediata Napoli, ove si eran ridotti ottomila fra Spagnuoli e Tedeschi, con tutti li capi imperiali, e con millecinquecento cavalli, dove avevano assai copia di grano, ma difficoltà della macina, perché in mano de’ Franzesi erano venute le mulina del fiumicello del Sebeto e della Clue, talmente che erano sforzati far con mulina a braccia. Del vivere delle altre cose non vi era molto provedimento, ed il vino fu consumalo e tostamente ridotto al poco dalla gente tedesca impazientissima di quel mancamento. Onde avveniva, che i nobili Napoletani fortemente patissino, essendo lor vote le case di vettovaglia, sì che molti se n’ andavano a quell’isole vicine, come a Capri, a Procida, ed a Ischia, a fuggire i pericoli della guerra, e l’insolenze de’ difensori della patria loro. Saccheggi dei Turchi - … Barbarossa, che vedendosi già alla fine dell’autunno voleva pur tornare in Costantinopoli, senza pensare a’ comodi de’ Fuorusciti o de’ Franzesi, pose l’armata all’isola dei Giglio, e vi fece molta preda d’anime. Dopo questo accostatosi a’ porti del papa senza fare alcuna offesa, fu presentato da lui magnificamente, di sorte che pareva che il papa e Barbarossa si fussero conosciuti gran tempo. Scorse dipoi con l’armata la riviera di Napoli, dove messe a sacco la bella isola di Procida e quella d’Ischia, nelle quali ultime fé maggior danno per rimunerare il marchese del Vasto in beneficar la sua patria de’ soccorsi dati a Nizza. Comandò oltre a questo a Salecho suo capitano, che battesse Pozzuolo, ed egli mentreché voleva dall’altra riva fare sbarcare l’artiglierie e le genti, comparendo dipoi il viceré con la cavalleria di Napoli e con grossa gente, s’astenne di più oltre tentare, rivolgendosi alla Calabria. * Tra Forio (Ischia) e Torre del Greco Antonio Di Maio “’Nduniuccio ‘u russ” Un feeling che avvicina Torre del Greco alla meravigliosa isola d’Ischia (antica Pitecusa), da sempre ricordata come l’isola verde, è la storia di Antonio Di Maio (Forio, 1929 - Torre del Greco, 1992) e la sua “family” di titolata origine, da Francesco (1889-1972), detto ‘U russ per la tonalità rossiccia della faccia, e da Teresa Calise. Undici furono i figli di cui, purtroppo, otto perirono per varie malattie. Francesco, che sin da giovane ostentava un paio di baffi alla Vittorio Emanuele III, di professione barbiere, emigrò in America ove si stabilì a Brooklyn, trovandovi un lavoro come aiutante barbiere. Legato ai sentimenti e valori patriottici, ritorna in Italia per difenderla in armi nella guerra italo-turca e nella prima grande guerra mondiale (1915-1918): qui assolve il compito di barelliere. Dopo un terribile scontro con il nemico, esce, insieme ad altri camerati, a raccogliere feriti che saranno, poi, trasportati in un ospedale da campo. Lo spettacolo che si presenta ai suoi occhi è terribile: corpi smembrati, arti disseminati un po’ dovunque, addomi squarciati. Rientrato al campo in condizioni fisiche precarie per l’enorme fatica, non trovando un posto per riposare, cade stanchissimo tra i feriti, riuscendo a dormire; si svegliò fra le braccia di un soldato che di vivo non aveva più nulla. Fu decorato con medaglia al valor militare per la Campagna italo-turca e per la prima guerra mondiale. Rientrato sull’Isola, aprì a Forio una bottega per parrucchiere e si iscrisse, per benefici di lavoro, al Pnf, facendo indossare ai figli la divisa di balilla negli anni ruggenti. Un suo cugino, Michele, anch’egli barelliere (guerra del 19151918) fu scelto per una missione: si tirò a sorte fra ventidue barellieri... uscì anche il suo nominativo. Arrivato sul posto, richiamato dai lamenti dei feriti, mentre si attivava a soccorrerli, una bomba esplose e i corpi furono dilaniati. Non si trovò più nulla. Antonio, ultimo figlio, vive gli anni della beata adolescenza sull’isola, frequenta le scuole d’obbligo, vestendo, quando le circostanze lo richiedevano, la divisa da balilla; impara anche i segreti del mestiere di barbiere. Nei suoi occhi rimarranno scolpiti i ricordi dell’ultimo conflitto mondiale, quella seconda guerra mondiale che sconvolse il mondo. Ischia non fu risparmiata. Alcuni torresi vi trovarono rifugio presso famiglie di pescatori, quando cominciarono i primi bombardamenti sulla città corallina; forse finirono dalla padella nella brace. Vi furono varie incursioni aeree da parte anglo-americana e tedesca. Durante un bombardamento aereo la gente trovò rifugio in vari ricoveri nei pressi del porto di Forio. Da uno di essi (deposito sotterraneo di carrozze), un amico di Antonio, ricordandosi di aver lasciato a casa dei soldi e qualche oggettino di valore, sbucò fuori e di corsa si recò presso la propria abitazione non molto distante. Nel momento in cui aprì la porta, cadde una bomba che distrusse tutto: il suo corpo non fu mai rinvenuto. Si ricorda anche un aereo inglese che nel 1945 per cattive condizioni atmosferiche andò a sbattere sul monte Epomeo: i suoi occupanti (circa un centinaio) morirono tutti e un’ala dell’aereo è rimasta ancora conficcata su di una tettoia di un vecchio casolare. Dei soldati del Regno Unito gli abitanti di Ischia serbano un altro souvenir: essi erano accampati su di un tratto di spiaggia, detta appunto la spiaggia degli Inglesi nei pressi di Ischia Porto. Fra Capri e Ischia era ancorata una portaerei (e tre nel porto di Napoli) da cui partivano i bombardieri, diversi dei quali sganciarono ordigni esplosivi su Torre del Greco. Poi vennero gli alleati che portarono un po’ di benessere; un certo Agostino Sarpone (povero mendicante), preso dai morsi della fame, si esibiva per le strade e piazze, mettendo su un piccolo spettacolo: ingoiava con un sol boccone pesche, pere, albicocche. A questo show assistevano, oltre agli abitanti, gli incuriositi militari anglo-americani: era il tempo delle Am Lire, sigarette Pall Mall e Lucky Strike. I Di Maio ebbero dei riconoscimenti dalle forze alleate; essi mai dimenticheranno i morti e i feriti causati dal bombardamento aereo in zona Porto di Forio. Durante le operazioni di recupero, la benna di una pala meccanica, mentre sollevava macerie, colpì la testa di una donna che morì sul colpo. Nel dopoguerra Antonio, detto “‘Nduniuccio ‘u russ” si arruolò in Marina Militare con la qualifica di segnalatore, era il 1948. Fu destinato a La Spezia, Chiavari, Capo Spartivento (Calabria), isole Egadi, Taranto, Livorno, Lacco Ameno e Punta Imperatore (Ischia). Nel 1957 sposò Franca Iacono, da cui ebbe tre figli: Francesco (vigile urbano del Comune di Torre del Greco), Nicola (radiotecnico) e Teresa (chef di rango a Berlino, in un locale denominato “Argentinos Steak House”). Il padre di Franca, Nicola, detto “Il conte Perazzo”, era proprietario terriero a Panza d’Ischia (contrada di Forio); militare in Esercito, richiamato, fu inviato a combattere sul fronte russo ove fu fatto prigioniero, soffrendo fame e freddo. Fece ritorno a casa nel 1944 ove finì il servizio militare. Il cognato di Antonio, Giorgio, classe 1923, ex capostazione della Circumvesuviana, nato a Pompei, durante l’ultima guerra fu preso dai tedeschi al valico del Brennero. Condotto ad Offenbach am Main, fu rinchiuso in una cella di circa sei metri quadrati insieme ad altri 27 prigionieri. I soldati tedeschi agli ordini di un comandante sadico e feroce li picchiavano di frequente e due prigionieri morirono. I poveri prigionieri, allo stremo delle forze, furono liberati da un gruppo di partigiani; l’ufficiale tedesco fu catturato e ad ogni internato fu imposto di strofinare con una grattugia il corpo del sanguinario aguzzino. Anche a Giorgio toccò quest’agghiacciarne destino e sul corpo non v’erano più spazi per lo strofinio: lo fece sotto i piedi (e il tedesco era già deceduto). Antonio andò ad abitare nel 1964 a Torre del Greco per stare vicino ai genitori: vi è rimasto per circa trent’anni, amando la città; ha dimorato in via Martiri d’Africa, via Cimaglia, Parco Giusy e Parco Merola. Da maresciallo di Marina passò nelle FS come capo squadra, lavorando a Gianturco. Era affabile con la gente torrese, gli piaceva il nostro clima. Appassionato di film western (ammirava molto Clint Eastwood), amante della musica classica e country, suonava nei ritagli di tempo libero il violino. Tagliava gratis i capelli agli amici e ai colleghi di lavoro: si divideva, lui, uomo di navigata esperienza e di esile corporatura, dall’indole isolana e vesuviana, fra Ischia e Torre del Greco. Era legato al mare e al verde. (Peppe D’Urzo nel sito www.torreomnia.com/personaggi. La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 25 26 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Casamicciola - Natale 1934 La rappresentazione del Presepe * Da un articolo di Antonina Garise De Palma (La Rassegna d’Ischia n. 10/1990 (…) Al calar delle prime ombre scendono dalla parte alta di Casamicciola personaggi e quadri viventi in corteo: ecco re Erode, superbamente assiso nella adorna portantina, trasportata a spalla; ecco uno dei Magi col suo seguito; ecco un carro allegorico rappresentante un loggiato in stile corinzio che ospita bellissime zingarelle che cantano il coro della Traviata. Autore di questa piccola meraviglia è Francesco Mazzella, detto “Rurille”, “apparatore” nelle chiese. Sono presenti anche i due rioni viciniori alla Marina, con personaggi popolari ed uno dei Magi con relativo seguito. Ma Perrone, il rione eterno rivale delle contrade di Casamicciola Alta, anche questa volta si fa onore sotto la guida della famiglia Mennella, quella della fabbrica di terrecotte. Gli organizzatori sono Mastro * Foto realizzate dallo studio d’arte di Attilio Maiorana, offerte dall’ing. Fiorenzo Conte: esse si possono vedere anche nel sito dell’Archivio storico dell’Istituto Luce (www.archivioluce. com/archivio - key words : ischia, casamicciola). La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 27 Vincenzo, Mastro Girolamo e Luigi. Nella piazzetta Vittorio Emanuele è il raduno dei vari partecipanti. Nel bel mezzo di questa troneggia il carro della Sibilla Cumana. Reminiscenze classiche, vecchi racconti isolani che vogliono la presenza della sacerdotessa a Casamicciola al tempo del tiranno Aristodemo, nonché la sicura influenza culturale, che al tempo Mons. O. Buonocore esercitava sulla gioventù studiosa, ispirano il carro allegorico: l’antro roccioso con accanto una pianta di fico si affaccia quasi sul mare rappresentato da un movimento di onde azzurrine, prodigio dell’intelligenza creativa e tecnica dei Mennella. Impersona la sacerdotessa di Apollo la bellissima Virginia Molinaro, statuaria nel suo abito bianco, mentre un velo valorizza, adombrandola, la sua bellezza classica. Ella in piedi getta al vento, anzi al mare, i suoi vaticini scritti con un’antica penna d’argento su foglie di fico. Il pescatore Ruscello (personaggio della Cantata dei pastori) dalla sua barca li raccoglie. Ruscello era il giovane Peppino Mennella, mentre suo fratello minore Gemì (diminutivo di Girolamo) era il capo degli angeli e il suo posto fu al centro della schiera bianco-alata che incorniciava la grotta. Anche San Giuseppe proveniva da Perrone, nella persona del vecchio e povero “Bicchierino”, come lo chiamavano tutti e del quale non ho mai saputo il vero nome. Il sig. Antonio Scotti di Uccio impersona uno dei magi, quello che porta l’incenso. E poi graziose “pacchiane”, come Marianna Della Monica, Maria Mennella (figlia del cancelliere don Peppe), Iduccia Molinaro, senza dimenticare zia Nunziatina orgogliosa del suo costume autentico della Ciociaria: ognuna di esse portava il suo dono al Signore. Poi c’erano le pastorelle, alcune autentiche, come Caterina e Luchetta; i caprai, come Giorgio Aiello col suo gregge belante. E ancora 28 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 tanti altri che vengono alla mente, a guardare le foto che conducono fuor dall’oblìo particolari dimenticati. Guida il corteo perronese Mastro Vincenzo Mennella, vestito da Armenzio, l’anziano pastore della “Cantata”. Nella sera tranquilla piccoli e grandi, compenetrati nel proprio ruolo, avanzano festosi, preceduti da una luminaria ad arco portata a mano e che andava dall’uno all’altro lato della stretta strada che congiungeva Perrone con la Marina. Questi particolari me li ha raccon- tai mia madre di 84 anni, nonché il sig Francesco Mennella e sua moglie Giuseppina, ai quali va il mio grazie; essi infatti mi hanno aiutata ad andare indietro con la macchina del tempo e a fermarmi per un poco in un’epoca che il ricordo ha reso più preziosa non solo a miei occhi, ma anche a quelli di coloro che vissero quell’avvenimento: una preziosità simile a quella che possiede un vecchio gioiello di famiglia. * “Leggere” il Presepe di Giulia Colomba Sannia Nella notte più buia dell’anno, nella grotta più povera della terra, nei momenti più cupi della vita, si accende la luce di Dio. È il Natale, il solstizio di inverno che segna il passaggio dalle lunghe tenebre alla rinascita del giorno che comincia ad allungarsi. In quella grotta inizia la vita. Nessuna suggestione può paragonarsi al misterioso incanto che emana dalla rappresentazione del presepe. Piccolo e indifeso, quel Bambino divino insegna la forza della fragilità. Perciò, durante le feste natalizie, il Presepe e l’albero scintillante di luci, in forme e modalità differenti compaiono in tutte le città: è il bisogno di ricreare questo incanto. Ma è specialmente a Napoli che il Presepe assume un’importanza particolare, perché attinge ad una tradizione radicata nei secoli. La strada di S. Gregorio Armeno, nel centro antico, ha un’altissima concentrazione di botteghe che si affacciano ai due lati della via, con un’esposizione straordinaria di pastori, di casette, di grotte e di oggetti e di materiali di ogni tipo per allestire il presepe. Già da novembre fino ai giorni delle feste, S. Gregorio Armeno con l’attigua S. Biagio dei Librai, diventa, di anno in anno, sempre più impraticabile. Una folla immensa vi si addensa, si inoltra lentamente lungo la via in salita, si sofferma, curiosa e smemorata, di fronte ad ogni bancarella, anche senza indulgere all’acquisto. È un fiume umano inarrestabile che travolge senza sosta chi si addentra in questa via, eppure nessuno si sottrae al rito di visitare questo luogo durante il Natale. Anche i presepi delle chiese sono molto belli, ma non eguagliano il fascino di questo piccolo tratto di strada. E se si moltiplicano le iniziative di Presepi viventi con elaborate e fascinose scenografie, con musiche e recitazioni, restano le strutture, gli oggetti e i pastori di S. Gregorio Armeno a creare il senso del Natale. Per capire le ragioni di tanto interesse, occorre ripercorrere la complessità del Presepe napoletano che nasce dall’intrecciarsi di molte componenti: quella religiosa, quella storica, quella antropologica specialmente e poi quella artistica, quella teatrale, quella letteraria. Per semplificarne la decodifica, separeremo le diverse letture, considerando, però, che quella religiosa e quella antropologica sono le più rilevanti perché legate alla tradizione. La lettura storica Il vangelo apocrifo di Giacomo costituisce la fonte delle più antiche costruzioni plastiche, ma il primo presepe noto è quello che nasce a Greccio in Umbria, nel 1223, si dice ad opera di S. Francesco. Con l’Umanesimo nel ‘400 e nel ‘500, a Napoli, compaiono i primi pastori a grandezza naturale, come ad esempio, quelli conservati nella chiesa di S .Maria del Parto, opera di Giovanni da Nola, per il presepe voluto da Iacopo Sannazaro. E non è un caso che proprio il Sannazaro l’abbia promosso, perché egli è l’autore di quel romanzo pastorale, Arcadia, nel quale ripercorre il mito di questa zona ideale della Grecia, nella quale gli dei erano scesi a mescolarsi con i pastori. Il presepe, infatti, si configura come “una nuova arcadia”, simile al luogo ideale della antichità, un’età dell’oro, nella quale si era realizzata una felice armonia sulla terra. Così, anche nel presepe, per una sospensione temporale, al pastore, all’uomo, è concessa la vicinanza col divino. Ma la diffusione capillare del presepe si ha nel ‘600, quando i Gesuiti, in tempo di controriforma, se ne servono per diffondere la fede presso i ceti più umili. È allora che avviene la sua destoricizzazione: il popolo adatta le proposte religiose alle proprie tradizioni e ai propri gusti. Cominciano, perciò, a comparire sfondi paesaggistici napoletani, come il Vesuvio, e personaggi locali: non è più Betlemme il luogo della nascita, ma Napoli. Si attua in tal modo un compromesso accomodante tra la propaganda religiosa, subita in modo continuo, e il bisogno di tenere vive le vecchie mitologie, nelle quali il paesaggio aveva sempre un carattere arcadico- pastorale, anche se legato alle attività marinare del luogo. Nel ‘700, Napoli è capitale europea con il regno di Carlo III di Borbone: si crea un clima culturale laico, di lusso e di eleganza, che continuerà fino alla fine del secolo con Ferdinando I. Il presepe, allora, si sposta dalle chiese ai palazzi aristocratici e alle regge, diventa un’esperienza «mondana, disincantata e laica, snobistica e sostanzialmente estranea a i fatti della fede, teatrino profano che la chiesa rifiuterà» (Raffaello Causa). I pastori, perfetti, saranno rivestiti di stoffe raffinate di S. Leucio mentre per tutto l’‘800 e l’inizio del ‘900 continuerà la produzione di statuette di terracotta, di fattura povera per il popolo, nella via tra S. Biagio e S. Gregorio Armeno. Negli anni sessanta, del ‘900, durante il boom economico, nella società dei consumi, l’albero, vero o sintetico, di tradizione nordica, diviene un sostitutivo comodo e frettoloso del presepe, più oggetto di arredo che segno di fede. Compaiono i primi pastori plastificati, in serie, creati a Lucca. Sembrava proprio sancita la morte di questo artigianato, non solo napoletano. Ma nel 1977, Il Mattino intitolava il proprio inserto di dicembre “La rivincita del Presepe”. La critica al consumismo, il rifiuto dello scempio di abeti, l’attento sguardo sulle radici culturali di ogni luogo, infatti, avevano fatto rinascere di improvviso l’interesse per il presepe. Questo interesse è cresciuto di anno in anno e si conserva ancora inalterato. La produzione di pastori cinesi di fattura simile a quella napoletana dimostra ormai il radicamento della tradizione che convive tranquillamente con quella dell’albero sintetico, “ecologico”, assunto a simbolo di vita Il volto teatrale del presepe Il ‘600, come si sa, è il secolo del Barocco che qualcuno ha definito il gran teatro del mondo. La teatralità, insieme con la metafora, domina, infatti, la cultura barocca e investe ogni aspetto della vita quotidiana - Napoli all’epoca era sotto il dominio spagnolo - dall’abbigliamento fastoso, alle feste, dalle cerimonie religiose al linguaggio pomposo. Il presepe diventa, così, una vera e propria scena teatrale da curare in ogni suo aspetto. Da allora e poi nel ‘700, si La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 29 diffondono tecniche scenografiche sofisticate per gli sfondi e per i paesaggi, la cui realizzazione era affidata agli stessi scenografi che lavoravano per il Teatro S. Carlo. A inizio del ‘900 si ha notizia di presepi mobili poichè i pastori si friccecano, si muovevano, manovrati sul retro con i fili come le marionette. Ancora oggi effetti di acqua che scorre, movimenti meccanici di braccia, gestualità di vario tipo fanno del presepe come una sorta di rappresentazione teatrale. Il presepe espressione di arte minore Nel ‘700 il presepe napoletano rivela insospettati e strettissimi legami con l’arte coeva arcadica e neoclassica. I pastori, vestiti con abiti di seta di S. Leucio hanno volti e mani opera del Sammartino e del Celebrano, famosi artisti attivi a Napoli e ricordano i putti di marmo o di bronzo del Vaccaro. Gli sfondi del presepe si ispirano ai paesaggi dei celebri pittori Micco Spadaro e Salvator Rosa, mentre i sontuosi cestini di frutta di cera, che arricchiscono le scene, richiamano la pittura naturalistica delle nature morte. A fine ‘700 le rovine di un tempio classico sostituiscono la grotta e Gesù nasce tra le colonne diroccate: è il gusto neoclassico che si diffonde dopo le scoperte di Pompei e di Ercolano, mentre i quadri del Coccorante suggeriscono immagini tenebrose già preromantiche. Ai confini tra arte e letteratura, invece, si colloca quella satira del villano che emerge nel vasto repertorio di figure caricaturali tra i preziosissimi pastori settecenteschi: storpi, orbi, gozzuti, pezzenti, un mondo di minorati che si inserisce tra l’eleganza delle sete e degli ori e mostra un realismo di straordinaria efficacia. La letteratura presepiale a Napoli Uno dei primi testi sul presepe è il De partu Virginis (vol II, vv. 341 segg.) di Iacopo Sannazaro (1458-1530), che, in distici elegiaci, descrive la nascita di Gesù nella grotta, tra il bue e l’asinello. È interessante rilevare il particolare inserito dal poeta che, a differenza del testo evangelico di Luca (2,7) nel quale la Vergine poggia il bambino appena nato nella mangiatoia, dice: se lo stringe 30 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 al petto dolcemente (v.39,exceptumque sinu blandeque ad pectora pressum). Il più famoso testo letterario, però, è forse la Cantata dei pastori (1699) del gesuita Andrea Perrucci (1651- 1704). È anche questo un esempio significativo della contaminazione seicentesca tra cultura religiosa alta e tessuto popolare, poiché convivono personaggi come Razzullo napoletano vagabondo, l’oste Belfagor arcidiavolo, la Madonna e S. Giuseppe. Anonime cantate e nenie a fine ‘800 e inizio ‘900 compaiono accanto alle poesie di Salvatore Di Giacomo (18601934), di Ferdinando Russo (18661927). I canti di Natale rispondono al bisogno di un’attenzione più calda alla religiosità e si collegano all’interesse per le canzoni napoletane popolari di autore. Ma è certamente il notissimo Natale in casa Cupiello (1931) di Eduardo de Filippo (1900-1984) a sancire la dimensione simbolica del Presepe come un bisogno infantile del cuore, la metafora di una fuga dal mondo che disillude e ferisce: Lucariello tutto preso dal suo presepe non vede il male intorno a sé. La lettura antropologica: i “segni” del presepe. Il presepe appaga il bisogno naturale di palingenesi, cioè di rinnovamento, che è in tutti gli uomini, credenti e non credenti. Il momento del Natale segna, infatti, quella che è stata definita “una nuova infanzia della storia”. Forse si può ricominciare, forse la speranza di rinascere non è spenta… La cultura popolare d’altro canto, ha avvertito sempre l’esigenza di umanizzare il divino: si pensi ai santi e agli angeli, alle anime del purgatorio, che rappresentano tutti un ponte tra umano e divino tra l’al di qua e l’al di là. Nel caso del presepe, quindi, ci troviamo proprio di fronte all’uso di un mito che si cala nel tessuto quotidiano. L’occasione dell’incontro tra il terreno e il divino è data, per gli strati più umili della società, dalla inversioni dei ruoli (come nel Carnevale), in cui si risolve la conflittualità sociale: un Dio povero ha bisogno di pastori e contadini, il ricco e l’intellettuale offrono omaggio al debole bambino, angeli e stella cometa, presenze soprannaturali, si mescolano con la realtà terrena. Sembra perciò, tornare finalmente la mitica età dell’oro di cui parlavano i poeti, come Virgilio, che credevano possibile realizzarsi una felicità terrena senza tempo e senza storia, nella quale tutti gli uomini, per un meccanismo compensativo, erano uguali e godevano della condizione edenica prima dell’ingresso del male nella vita umana. Si spiega, in tal modo, l’assenza di veridicità storica degli allestimenti presepiali, non solo napoletani: per esempio a Toledo, in Spagna uno dei pastori è l’incappucciato, lo stesso che segue la processione del Venerdì santo. Per questa ragione ogni anno gli artigiani di S. Gregorio Armeno creano nuove figure corrispondenti a personaggi della politica o del mondo dello spettacolo: Maradona, Berlusconi, Ciampi, Cannavaro ecc. Ma perché? Perché nel momento in cui questi, confusi tra i pastori tradizionali, entrano a far parte dell’universo del presepe si destoricizzano, diventano creature fuori del tempo e dello spazio, consegnate all’incanto di una società di uguali, in ginocchio di fronte ad un Bambino/ Dio. E tutti i mestieri vi sono rappresentati per nobilitare il lavoro umano. Solo i Magi sono isolati: sono gli intellettuali, i sapienti dell’antichità, gli unici ad essere guidati non da un angelo, ma da una cometa, loro che avevano tanta dimestichezza con le stelle. Lo sfondo, perciò, è diverso secondo il luogo: il Vesuvio a Napoli, o il monte Pellegrino a Palermo per marcare un bisogno di bene insopprimibile, per tutti senza distinzione. Un luogo, un giorno, vengono assunti fuori dalla storia come un evento, sospeso nell’eternità, eppure rassicurante nella sua ciclicità: e ogni anno nei secoli ritornerà quell’evento a riscaldare il cuore. Sul presepe napoletano - che è quello che maggiormente ci interessa - convergono anche leggende di altre tradizioni, anche se è evidente la fisionomia locale. E ogni presenza, ogni pastore, ogni immagine sono segni, assurgono cioè a simbolo di altro. Espressione dell’eterna lotta tra bene e male e del trionfo del bene, il presepe, infatti, conserva segni positivi e negativi. Vediamo i più rilevanti. A recingere i bordi del presepe spesso è usato il pungitopo, perché con le sue spine ha funzione apotropaica (= scaramantica): tiene lontano il male, come i fuochi d’artificio e i botti. La capanna di Gesù è una grotta e la grotta è, come si sa, il simbolo della nascita, della sessualità feconda, dell’utero materno: è, quindi, segno positivo di bene. Tuttavia spesso è sostituita dal tempio diroccato: in tal caso significa che il cristianesimo nasce sulle rovine dell’impero romano e della cultura classica. La grotta deve stare sempre un poco più in alto rispetto all’osteria e verso di essa dovrebbero convergere tutte le linee dell’allestimento, come ad esprimere una tensione a spirale verso l’alto, in segno di purificazione. Dall’altro lato c’è l’osteria, immancabile presenza di tutti presepi. È stata interpretata in modo opposto dal Barzaghi e dal De Simone, due noti studiosi dell’antropologia del presepe. Per Barzaghi l’osteria è «segnale positivo di abbondanza in chiave interclassista». Per il popolo napoletano, infatti, i giorni di Natale sono giorni di grande abbondanza alimentare; e così l’osteria si mostra traboccante di benessere, con pendoli di pomodoro, agli e cipolle contro il malocchio, con avventori e cuoco allegramente goderecci. Invece il De Simone vi coglie quell’immagine negativa e infernale che accompagna l’osteria nella cultura letteraria. In verità ci sembra questa l’interpretazione più corretta. Tutta la tradizione letteraria infatti, dal medioevo ai giorni nostri, presenta osti maligni e insidiosi, pronti a fare del male o a crearne l’occasione. Simbolo del male e della trasgressione, l’osteria, come quella famosa di Renzo nei Promessi Sposi, è il luogo nel quale il rischio di perdersi è molto alto. Non a caso nella Cantata dei pastori il diavolo Belfagor è l’ oste. La posizione più avanzata del bue nella grotta, rispetto all’asinello si spiega con il passo di Isaia (I,3) nel quale il bue esprime l’operosità e l’asino la stoltezza, la paziente sopportazione. S. Giuseppe è sempre collocato a sinistra , allineato con il pastore della meraviglia: è il lato dei sentimenti, di chi è disposto ad accettare la divina illogicità del messaggio, anche senza capire. Non deve mancare l’acqua che scorre o la fontana simbolo di purificazione, né il pozzo. È il pozzo un simbolo complesso, perché, nella sua profondità, sembra collegarsi col mondo degli inferi: esiste in Campania una Madonna del Pozzo e Vladimir Propp, lo studioso di fiabe rus- se, narra che secondo la leggenda nella notte di Natale, compaiano nel pozzo i volti di coloro che moriranno nell’anno. La lavandaia contribuisce all’opera di purificazione, lavando i pannolini di Gesù, e rappresenta anche la figura della levatrice con la quale, in alcune culture, si identifica. Il mulino che “schiaccia” il grano è l’icona del messaggio evangelico “se il grano non muore non dà frutto”: anche qui la Madonna del setaccio e la Madonna del mulino in Campania confermano questa simbologia. Il cacciatore e il pescatore si riferiscono alle rappresentazioni arcaiche nelle quali queste figure catturavano animali psicopompi (= accompagnatori di anime) come gli uccelli che volano tra cielo e terra, o come i pesci che nuotano negli abissi misteriosi del mare. Il pesce, poi, è il simbolo di Gesù, perché il termine greco icthiùs = pesce, è l’acronimo di Iesus Christòs Theòs Iumìn (Gesù Cristo Dio nostro). I pezzenti sono le figure dei morti che chiedono (da peto, in latino = chiedere) ai vivi le preghiere. Perciò talvolta compaiono, tra i pastori, le anime del purgatorio, busti di figure rosa tra lingue di fuoco rosse che le circondano. Non può mancare Pulcinella con il suo vestito bianco e nero e la sua ambigua figura gallinacea, col naso adunco e il cappello a punta, simbolo di vita (bianco) e di morte (nero), maschio (cappello a punta, fallico) e femmina (pancia gravida). La zingara porta a Gesù chiodi e tenaglie, invece di cibo: allo stupore della Madonna che chiede la ragione dell’equivoco dono, risponde “Tra 33 anni capirai”. Serviranno per una croce. Una leggenda narra che una ragazza nubile desiderava andare da Gesù, ma tutti le avevano detto che solo le donne con figli potevano avvicinarsi a una puerpera. E lei, la Vergine Stefania, il 26 dicembre, avvolse una pietra tra le fasce, fingendo che fosse il suo bambino. Appena si accostò alla grotta, la Madonna le disse “Benvenuta Stefania, hai portato Stefano?” E la pietra si mosse e divenne calda e viva : era diventata un bambino, Santo Stefano, appunto. Il pastore della meraviglia incarna lo stupore del mondo di fronte al miracolo di luce che c’è nella grotta, mentre Benino che dorme in solitudine rappresenta l’uomo improvvido che si lascia sfuggire il senso divino della storia. Un’altra suggestiva interpretazione di Benino è quella di Italo Sarcone: egli dorme e sogna un mondo perfetto: il Presepe è il suo sogno. I tre Re Magi, infine, per i colori diversi del volto e dei cavalli simboleggiano il corso del sole che va da oriente ad occidente: bianco per l’alba, bruno per il giorno e nero per la sera. Nei presepi pugliesi con loro appare anche la Regina Maga, simbolo della luna, la fidanzata del re Moro (= la notte). Essi vengono da Gesù. ognuno per proprio conto, dall’oriente verso Gerusalemme e, incontratisi sul Golgota, proseguono il viaggio insieme. Portano in dono oro, segno della regalità, incenso, segno della sacralità e mirra, segno della morte. La Madonna darà in cambio una fascia del bimbo, un pezzo di pane e una scatola con una pietra magica. La fascia era indistruttibile dalle fiamme, la pietra creava un fuoco sacro e il pane li avrebbe ristorati durante il viaggio di ritorno. La leggenda dice che i Persiani venerarono questi doni dopo averne sperimentato il miracoloso potere. Visualizzazione immediata del bene e del male, piccolo borgo senza tempo, fonte di speranza, il presepe si offre ancora ricco di segni da cogliere con occhi di bambino. Giulia Colomba Sannia Bibliografia essenziale AA.VV. , L’arte presepiale in mostra, Catalogo Associazione presepiale napoletana , Napoli 2005. Barzaghi Antonio,. Il presepe nella cultura del ‘700 a Napoli, Matteo editore, Treviso 1983. Bordignon Letizia, Presepi nel mondo, BeMa editore , Milano 1990. Borrelli Gennaro , Il presepe napoletano, De Luca - D’Agostino, Roma, 1970. Bosso Bianca, Presepi fatti in casa, Calderini, Bologna, 1989. Bowler Gerry, Dizionario universale del Natale, Newton ,Torino, 2003. Canzanella Claudio, Razzullo e la Sibilla, Stamperia del Valentino, Napoli,2006 Catello Angela, Pastori e presepi a San Gregorio Armeno Elio De Rosa editore, Napoli , 1992. Catello Piccoli, Marisa, Il presepe napoletano, La collezione del Banco di Napoli, ed. Banco di Napoli, Napoli, 1987. Sica E. Il presepe napoletano Newton & Compton Roma, 1996 Zeppegno Luciano, Presepi artistici e popolari, De Agostini Novara, 1967 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 31 Miti Storia e Archeologia dei Campi Flegrei di Domenico Di Spigna Questa vaga striscia di terra che si estende dalla collina di Posillipo sino alla mitica Cuma, passando per Agnano, golfo di Pozzuoli, del cui promontorio Miseno ne chiude l’arco, dopo la voluttuosa Baia, luogo di delizie dell’antica Roma, viene così chiamata per i fenomeni di vulcanesimo che la interessano, facendone assumere la denominazione di “campi flegrei”, ossia ardenti. Detti luoghi arcaici possono considerarsi un composto tra miti, cultura e archelogia. Nel contesto generale sono comprese anche le dirimpettaie isole di Procida e Ischia. La prima, pur non presentando ai nostri giorni segni di attività vulcanica, evidenzia ragionevolmente con le insenature della Chialolella e della Corricella la sua remotissima origine di tale natura, mentre la seconda anch’essa senza vulcani attivi (ultima eruzione 1301-02) conserva tutta la sua fisionomia e moderata manifestazione attraveso le acque termali, esistenti anche presso i litorali, e le fumarole. Scelti per godersi le amenità della dorata natura e gli ozii, queste zone furono sempre amate ed ammirate da Virgilio, Orazio, Svetonio, Stazio, Tacito nell’età classica e nell’Umanesimo da Giovanni Boccaccio, che ne menziona le «dilettevoli baie sopra li marini liti, del sito delli quali né più bello né più piacevole ne cuopre alcuno il cielo» e di poi Gioviano Pontano e Jacopo Sannazaro. Partiamo dunque per questo interessante viaggio descrittivo d’una parte di terra della “Campania Felix” principiando dall’isolotto di Nisida. Nisida - Una piccola isola di materiale tufaceo, posta sotto il Capo di Posillipo, alta un centinaio di metri, appartenuta un tempo a Felice Pollione, nota sopratutto più di due millenni fa per essere stata sede del famoso incontro tra Cicerone, Bruto e Cassio, per eliminare Giulio Cesare. Si ricorda a proposito la presenza a Nisida (Nesis) l’8 luglio anno 44 a.C. del famoso avvocato da una sua lettera all’amico Attico. Menzionata da Plinio per la buona produzione di asparagi, oggi è legata alla terraferma da un ponte in muratura ed è sede di un carcere per minorenni. re rimedio alla salute e respirarne le arie perché ammalato di mal di petto (tubercolosi), vi trovò la morte; era il 10 luglio dell’anno 138. Essa ha conservato, nonostante i movimenti tellurici di tutta l’area flegrea, un discreto patrimonio storico di ciò che fu la magnificenza romana. Si notano i resti delle sue terme, allora rinomate ed affollate, tanto da oscurare quelle pur conosciute della vicina Aenaria, da breve tratto di mare separata, e del tempio di Venere e Diana. Avanzi di bellisssime ville con portici e colonnati, pavimenti in mosaico giacciono in fondo al mare, sempre a causa del bradisismo che interessa tutto il golfo di Pozzuoli. Le terme della leggiadra Baia, consacrate alla pagana dea Venere, furono luogo di cura del Governatore della Galilea Ponzio Pilato, che doveva essere poi giudice di condanna di Cristo. Questi, tornato a Roma dopo qualche anno, si allontanò dalle fatiche pubbliche, cominciando a scrivere le sue memorie nella propria casa all’Esquilino, ma per gli anni che avanzavano e tormentato dai reumatismi si recò ai bagni di Baia. Come si evince dal libretto di Anatole France (del 1902) assistiamo ad una bella descrizione del luogo, posto su di un «incantevole lido di mare blu, dove i delfini affioravano con il loro gioco e in lontananza la costa dorata campana col Vesuvio che rideva». In epoca più recente, nel ‘500 rinascimentale, Baia fu ci- Giacinto Gigante - Il tempio di Venere a Baia (1830 c.) Agnano - Là dove oggi sorge il noto ippodromo napoletano, eravi nei secoli trascorsi un lago, formatosi in una conca vulcanica, al pari del lago d’Ischia. Con la zona limitrofa costituiva l’Ananium, dal nome della famiglia Ania di Pozzuoli che ne era proprietaria. Man mano con diverse bonifiche, si è portato allo stato attuale. Leggenda vuole che nei tempi remoti la gente si teneva lontano dal luogo per l’aspetto inquietante dovuto alle sue acque oscure che emanavano fumi mortali. Baia - Ridente cittadina a nord-ovest del golfo di Pozzuoli, ancor prima di Capo Miseno, prende il nome da Baios compagno e nocchiero di Ulisse, di omerica memoria; fu luogo di delizie di noti personaggi, patrizi e imperatori romani (Nerone, Adriano). Quest’ultimo qui venuto per trova32 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Le terme romane di Baia Luoghi celebrati in versi da Camillo Eucherio de Quintiis * (…) Ma della caducità delle cose prove avrai più chiare se la barchetta dai remi sospinta ti porterà di buon’ora nelle acque di Cuma, ove più mite è il mar che bagna le soffici arene con lenta onda. Questi siti non son privi di delizie, sebbene sconvolti da molte rovine; meco t’allegrerai di visitar le sedi dei Fereciadi e i porti vicini. E qui, dove le calcidiche genti in origine hanno mura innalzato grandiose con regal lusso, ancora oggi osservar si possono coi propri occhi, almeno in parte, luoghi disertati, ville del tutto in ruderi finite, che un tempo pei trofei degli antenati furono famosi; templi e sepolcri in rovina, insegne, fregi e vestigia di antichi popoli. Qui fatto scalo, il nocchiero in mezzo ai colli scoprire potrà quella rocca, dove l’augusto Apollo pose dimora, svelando gli oracoli suoi con gli arcani segni, passar cento aditi e per le cento porte, dove risuonavan le voci che l’aere intorno facevano vibrare; e ancor della fatidica Sibilla l’antro tuttora orrendo, e pure i tripodi tuoi, Timbreo, e gli inscritti monumenti della dedalea fuga, che son sparsi in giro ricoperti d’erbe, e sotto folte spinose macchie li nasconde l’ispido cardo o il paliuro tra i rovi. (…) Non ti spaventi poi il lago d’Averno, un tempo sinistro agli uccelli e causa di timor, al solo nome, pei popoli; cacciato via il contagio infatti, ora offre acque salubri e le sue rive allieta di mite clima. Così muta il fato le vicende: nuoceran quelle cose che prima giovaron, mentre saranno di aiuto quelle che nocquero. Siccome il mar che or, turbate l’onde, s’adira, or s’abbonisce, l’acque chete fattesi. (…) che s’eleva al presente con alta vetta. Ma quando tu volessi pur conoscere ciò che resta ancor del grande lusso e delle opere antiche, la mirabile Piscina2 ad un solo sguardo farà che tu resti a bocca aperta; famoso monumento del lavoro e dell’arte, tuttor dura e gli invidi fati supera del tempo; eterna fama ha e fu artefice Agrippa.... (…) Da un’altra parte potrai pur vedere quelle ville che in passato facevano la vera delizia di genti lazie, ma or tristi e squallide sono, coperte da cumuli di foglie, felci e salici; del tempo che scorre miseri avanzi. Non potrebbe sotto queste rovine riconoscere i suoi vivai Servilio3, fuggendo le ire di Tiberio: e, fatte nella roccia, le due spelonche, l’una delle quali sempre il sol riceveva e l’altra mai ‘l vedeva. Arator duro col vomere sprezza e frange, insolente, voi anche fabbriche che seguiste i fati e gli eventi del padrone, famose un tempo già, risonanti le guerre or d’Asia, or dei pirati, e i grandi trionfi di Pompeo, vincitor su Mitridate. (…) Volgi il tuo cammino verso il lido ispido della sterile alga e noia non ti prenda ad osservare i luoghi dagli studi di Minerva resi celebri: qui spesso ciò il luogo viene denominato Capo Miseno, promontorio del mar Tirreno, un tempo molto famoso per la clemenza del cielo, per la eleganza delle ville, per i famosi monumenti; fu abbellito dagli imperatori romani con palazzi e con un porto, che rappresentava un rifugio della flotta romana. 2 Di questa piscina, definita mirabile, così scrive Capaccio: “Opera regia con una vòlta sorretta da 48 colonne, lunga 250 passi, larga 160. Struttura a mattoni, pareti rivestite di intonaco resistente all’acqua. Ai due lati scale in pietra vi consentivano l’accesso. Attribuita da alcuni a Lucullo, io l’attribuisco ad Agrippa, che a Miseno costruì anche un celebre porto”. 3 Presso l’Acherusia c’era la Villa di P. Servilio, A seguir miei precetti ti richiama detto l’Isaurico dall’Isauro, regione il trombettier delle navi dardanie, dell’Asia Minore da lui conquistata, una volta vinti memorando per il lituo e per le armi, i pirati, il 677 dopo la fondazione di Roma; detto e che con valor, accanto ad Ettorre, anche il ricco per antonomasia. Consulta anche le pugne affrontava contro le argoliche Seneca (Ep. 55), che parla diffusamente di questa schiere e sul cui tumulo furon posti Villa. Perseguitato poi da Tiberio, per fuggirne la il remo e la tromba, e cioè Miseno1 crudeltà, in questa si ritirò e invecchiò. Parla di questo luogo Seneca: “Vi sono due grandi spelonche con un ampio atrio scavate a mano, delle quali una 1 Miseno, trombettiere di Enea, qui sepolto e per- non riceve mai il sole e l’altra lo tiene sino a sera”. ritornato dopo liti chiassose del foro e i graditi ossequi dei clienti, e le grida di “bravo!”, te richiama Tullio4, la Facòndia, per preparare l’imprese e discuter alte questioni; dove, sotto la tua guida, con sorte più felice, si fissò l’Accademia, lasciata ormai di Atene la cittade. Bada però di non scegliere i lidi Itachesi di Baia5, sebben la costa lunata sia invitante col tranquillo seno, un tempo salutar e placido porto, ma ora adatto solo alle barche. Infatti l’odor fetido che spira dal pestifero gorgo facilmente ridà vigore ai morbi e nuovi stimoli offre all’esitante fato. Il cammino perciò qui non fermino i templi a [Venere6 7 e a Diana sacri, né quel di Mercurio coi suoi ruderi qua e là giacenti. Il nocchier volga a sinistra ed il remo a te batta dalla sinistra parte. Mentre ritorni alle campagne apriche di Pozzuoli, la Solfatara e l’aura mite nel seren giorno ti sospingano in direzione dei sulfurei luoghi. Timor non dèstino le fumarole che vedi in questa zona ovvero i campi di nitro o di bitume sparsi e i colli ardenti di zolfo intorno diffuso. Buona è certo l’aria per chi vi giunge dall’isola d’Enaria, né v’è luogo più lieto e propizio per la salute. 4 Si indica qui la Villa di M. Tullio Cicerone presso il Lago Averno (ora Lago di Tripergola) verso Pozzuoli. Cicerone la chiamò Accademia, dalla celebre Accademia di Atene, dalla quale ebbero nome di accademici i discepoli di Platone. In questa Cicerone compose i libri detti Questioni accademiche. Dopo la morte di Cicerone, ne divenne possessore Antistio il Vecchio, e quivi si scoprirono caldi fonti, considerati salubri per gli occhi e celebrati dal canto di Laurea Tullio, un liberto di Cicerone. Vedasi Plinio. 5 Baia da Bajo, Baja (Strabone lib. 5), compagno di Ulisse ivi sepolto. Un tempo sede di piaceri: ora luogo di aria insalubre. 6 Di questo Tempio di Venere parla Marziale. 7 Tempio di Diana a Baia (v. Capaccio) - Il Tempio di Mercurio, di cui si vedono rovine. * C. E. de Quintiis, Inarime seu de balneis Pithecusarum, libri VI, 1726, di cui è stata fatta da R. Castagna la versione italiana, pubblicata nel 2003. I passi riportati sono tratti dal sesto libro Lago d’Averno La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 33 tata in una sua ecloga, per la vita licenziosa che in essa si teneva al tempo dei Romani, dal poeta napoletano Jacopo Sannazaro, mentre qualche secolo appresso fu punto di riferimento di illustri viaggiatori e uomini di cultura. La sua memoria storica ci dice che anche Poppea, moglie di Nerone, la scelse per le sue ferie estive recando seco numerose asine, che dovevano procurarle il latte per i suoi bagni corporei. Disse di Baia il poeta Orazio: nullus in orbe sinus Baiis praelucet. Pozzuoli - La fondazione di questa industriosa e storicissima città, centro principale dell’intera area flegrea, che dà il nome all’intero golfo prospiciente, risale al VI sec. a.C. da parte dei Samii esuli dell’isola greca di Samo che le diedero il nome di Dicearchia, cioè governo giusto. Avendo poi i Romani, trecento anni avanti l’era cristiana, occupato la Campania, la chiamarono Puteoli, dai numerosi pozzi termali ivi esistenti, divenendone col tempo il loro porto principale, da cui partivano gli scambi commerciali con le nazioni mediterranee. Poco ci resta di questo grande emporio a causa del bradisismo discendente. Elevata a colonia da Nerone nel 63 d.C. che vi fece anche scavare grotte sudatorie, vide i suoi fastigi sotto l’imperatore Vespasiano, che ivi costruì l’anfiteatro (terzo in Italia per ordine di grandezza, delle dimensioni 149x116 m.) e l’attuale Serapeo, meglio chiamarlo “macellum” ovvero un ampio mercato (75x58 m.), del quale ci restano ancora resti delle sue strutture. Va pure ricordato che Puteoli, altro nome della città per le esalazioni putescenti della Solfatara, possedeva già un altro piccolo anfiteatro, su modello di quello pompeiano, senza cavea per le fiere, al tempo di Augusto. Altre vestigia della Pozzuoli imperiale sono il tempio di Augusto al Rione Terra, trasformato poi in duomo dedicato al martire puteolano San Procolo, patrono principale della città decapitato assieme a San Gennaro, dopo che questi era stato in principio condannato “ad bestiam” (sbranato dalle fiere). Altri santi martiri, della prima età cristiana, legano il loro nome alla città: San Patroba (paternale) vescovo e discepolo di San Paolo, decapitato con San Gennaro; San Paolo, pilastro del Cristianesimo, prima di recarsi a Roma proveniente dall’Oriente, soggiorna una settimana a Pozzuoli coi fratelli cristiani: ne fa testimonianza una lapide posta al porto, che recita così: «Paolo di Tarso apostolo delle genti, magnifico assertore della verità, ai lidi puteolani approda e ivi trascorre sette giorni coi fratelli nella fede. La città campana ne annovera l’evento tra i fasti della sua trimillenaria storia»: correva l’anno 61 d.C. Bacoli - Altro interessante luogo prossimo a Miseno, a circa tre Km. da Baia, presentava anch’essa belle ville, tra cui quella di Quinto Ortensio, oratore e amico di Cicerone, che poi, volgendo di mano in mano passò a Nerone e ai Flavii; sembra che in essa si sia rifugiata Agrippina, prima di essere uccisa per ordine del folle suo figlio. Ai nostri giorni a Bacoli è da conoscere la “piscina mirabilis”, grandioso serbatoio d’acqua per approviggionare la flotta romana. Venne scavata in blocco tufaceo nelle dimensioni di m. 70x25,5 e m. 15 di altezza, per una capacità di 12.600 mc d’acqua. L’antico suo 34 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 toponimo era Bauli, per la leggenda ricovero dei buoi. Miseno - A questo promontorio che prende il nome dal trombettiere di Enea, richiamando la classicità del mondo virgiliano, è legata la figura dell’imperatore Tiberio per il quale rimaneva l’unico filo di contatto con la terraferma, ossia Roma, dal suo splendido isolamento di Capri. Sappiamo infatti che Tiberius Claudius Nero, una volta fatta la consacrazione dei templi, disposto con un editto che nessuno turbasse la sua tranquillità, e tenuti lontani gli abitanti delle città che accorrevano a lui, si rifugiò nell’isola di Capri. Nell’anno 37 qui trovò la morte. Fu Miseno per la sua posizione strategica sede della flotta navale di Roma, annoverando tra i suoi prefetti comandanti Caio Plinio Secondo, il famoso scienziato che fu tragi- Archi della Piscina mirabile a Bacoli La Villa Jovis sulla sommità del promontorio di Capri co spettatore dell’eruzione del Vesuvio dell’era vespasiana (24 agosto 79 d.C.). Ne abbiamo notizia dalla celebre lettera di suo nipote Plinio il Giovane scritta allo storico Tacito che gli chiedeva di tramandare ai posteri la sua figura e gli avvenimenti da lui vissuti, in occasione del disastro provocato dall’esplosione del Vesuvio. Dice di essere stato invitato a salire su di una barca, per portarsi verso Pompei e studiare i fenomeni eruttivi, ma lui aveva preferito starsene dedito ai suoi lavori in compagnia della madre. Purtroppo suo zio morì per le esalazioni gassose. Il porto di Miseno, già base marittima di Cuma, che potè di lì estendere la sua egemonia sul Tirreno sconfiggendo gli Etruschi, fu di poi ancor più importante, quando da Augusto venne designato quale porto principale del Tirreno. Era posto in comunicazione, tramite canale con un altro specchio d’acqua interno (una darsena) corrispondente all’attuale Mare Morto che fungeva da ricovero e riparazione delle navi; entrambi i porti furono opera di Marco Vipsiano Agrippa. Oltre a Plinio il Vecchio, ebbe tra gli altri comandanti Tiberius Claudius Anicetus, attore e complice del complotto ordito da Nerone per l’uccisione di sua madre. Con l’unificazione della flotta romana nel II sec. d.C. Miseno si pregiò della “Praetoria classis misenensis”. Forniva tra l’altro un centinaio di ottimi marinai a Roma, per le manovre delle tende ombrifere (il velario) nelle giornate assolate, durante gli spettacoli al Colosseo. Antichissima fu la sua chiesa, dove già nel II e III secolo si diffondeva il Vangelo di Cristo, con Sossio diacono presso il quale si era recato S. Gennaro, il quale poi sarà condannato assieme a Desiderio, lettore di Benevento, Proculo diacono di Pozzuoli, nonchè Acuzio ed Eutichete nobili puteolani. Aveva Miseno una piscina di acqua per le navi, fungente da riserva idrica a quella di Bacoli. Cuma - Fondata dai Greci, che prima si erano posti a Pithecoussai (Ischia), ma qui giunti perché fuggiti dall’isola per loro divergenze ed eruzioni vulcaniche, prende il nome dalla eubea Kyme. Dall’VIII sec. a.C. rappresenta la civiltà greca in Italia. Ebbe un’interessante acropoli con tempio, trasformato dopo dai Romani, di cui abbiamo dei resti ed un anfiteatro del quale si sono trovate delle tracce. Ben conservato a tutto oggi rimane l’antro della Sibilla, luogo delle profezie della vecchia sacerdotessa che dalla stanza posta in fondo alla galleria di m. 131 vaticinava. Nel 334 prima dell’era cristiana, subì la devastazione da parte di Annibale, rimanendo fedele a Roma. Con Miseno e Puteoli fu una delle prime comunità cristiane Lago d’Averno - Come gli altri laghetti di questa parte nord-occidentale del territorio flegreo, si è formato nel cratere di un antico vulcano, con acque limacciose, oscure e putescenti con emanazioni di gas nocivi per i volatili per cui prende il nome di “senza uccelli” in greco. Per gli antichi rappresentava la porta degli inferi e per la mitologia sotto di esso viveva in grotte oscure il misterioso popolo dei Cimmeri. Ed è proprio qui che Enea, secondo quanto scrive Virgilio nella sua Eneide, chiedendo via libera alla Sibilla, scese nel regno dei morti per interrogare suo padre Anchise. Nel I sec. a.C. col vicino lago di Lucrino venne, tramite canale, messo in comunicazione col mare diventando così un sicuro porto; era il “Portus Julius” voluto da Augusto con l’opera di M.V.Agrippa, architetto ed ammiraglio, ma dopo alcuni decenni perse di importanza e la base navale a Miseno. Lucrino - Questo laghetto, anch’esso vulcanico, ma un tempo più ampio, prende il nome dal termine latino lucrum (guadagno) per i buoni affari che vi faceva C. Sergio Orata, imprenditore romano che ivi creò un allevamento di ostriche un secolo prima di Cristo. Eravi qui una bellissima villa di Cicerone. Procida - Il nome di questa piccola isola del golfo di Napoli, dal fascino particolare che colpisce al primo impatto, prende il nome dal greco ”prochyte”, ovvero versamento o effondersi dalla vicina e più vasta Ischia, verso il continente, mentre per la leggenda il nome appartenne alla nutrice di Enea, ivi sepolta con altri compagni dell’eroe troiano. Il suo peso schiaccia il titano Mimante, ribelle a Giove. Fu suo signore quel tale Giovanni da Procida autore dei famosi Vespri a Palermo al tempo degli Angioini; subì nei secoli scorsi diversi attacchi di pirateria. Grande è la sua tradizione marinara per aver fornito alla marina mercantile tanti uomini di mare; notevole fu il tonnellaggio dei suoi velieri nell’800, che venivano costruiti alla marina di San Cattolico (con varo di murata), un centinaio circa sui trecento complessivi del Regno delle Due Sicilie e alla nascita del Regno d’Italia costituiva con le sue 45.000 tonn. di stazza, un sedicesimo dell’intero tonnellaggio nazionale. In una colonna posta nella piazzetta di Terra Murata sono riposti i nomi dei martiri della Repubblica Napoletana del 1799 che ivi furono afforcati. Nel secolo XVIII Procida era il luogo di caccia venatoria cara a Carlo III di Borbone. Ischia - Come accennato, la vulcanica Ischia è parte integrante dell’area flegrea. Ai tempi di Omero era identificata col nome di Scheria e legata al mitico eroe greco Ulisse, che secondo alcune congetture di studiosi di cose antiche (Philipp Champault), vi sarebbe giunto per riposarsi dalle lunghe fatiche addormentandosi sotto uno strato di foglie, come si evince dall’episodio di Nausicaa. Pressato dal suo peso qui giace il gigante Tifeo che vi sbuffa vapori. Altra leggenda legata a questa grossa isola vuole che i primi abitatori fossero dei rapaci malviventi, capitanati da Candolo e Atlante, ma una volta allontanati dai nuovi coloni greci, furono dal padre degli Dei trasformati in cercopi o scimmie. La euboica Pithekoussai risulta essere la più antica colonia della Magna Grecia. In essa sono state rinvenute numerose vestigia archeologiche, che si possono ammirare nel Museo di Lacco Ameno e in quello sottostante la chiesa paleocristiana di Santa Restituta. Cicerone nell’area flegrea - Il noto avvocato e filosofo Marco Tullio Cicerone, nato ad Arpino, tra le sue numerose ville ne possedeva alcune anche in questa arcaica terra campana, che sicuramente amava in modo particolare per i suoi riposi e la contemplazione del vago paesaggio, tanto che a volte, forse per invidia, gli veniva rimproverato di starsene alle terme di Baia o nella bellissima villa di Lucrino. Nella lettera scritta a Pomponio Attico (14) il 25 gennaio del 61 a.C. gli comunica che arricchirà una sua orazione con la descrizione e lo sfondo paesistico di Miseno e Pozzuoli. Domenico Di Spigna La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 35 Forio - Arte, Musica e Spettacolo Recital dei pianisti Eleonora Lauro e Antonio Patalano A Forio, lunedì 21 ottobre 2012, si è svolto un evento musicale di notevole rilievo che, senza ombre di retorica, ha entusiasmato i numerosi spettatori presenti. In occasione della presentazine del libro Le favole dell’isola d’Ischia di Daniela Pazienza, ricco delle illustrazioni scaturite dalla fantasia fervida e spigliata di Angela Impagliazzo, ha avuto luogo il recital dei pianisti Eleonora Lauro (13 anni) e di Antonio Patalano (12 anni) che studiano entrambi all’Accademia dei Ragazzi dall’età di quattro anni con la valente ed esperta Maestra Teresa Coppa. Lo spettacolo è stato presentato dal brioso e dinamico attore Eduardo Cocciardo che ha coinvolto emotivamente e divertito con le sue battute ricche di arguzia e umorismo. I due giovani artisti si sono esibiti al pubblico fin dal primo anno di studio, prova incontestabile che essi sono dotati di un talento naturale non comune. Eleonora Lauro ha debuttato nel 2009 con un recital solistico ed ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Nazionale Luigi Paduano (Cercola). Antonio Patalano studia intensamente per tenere a dicembre il suo primo concerto solipsistico. Sebbene siano solo adolescenti, entrambi i pianisti padroneggiano un ampio repertorio di brani classici, romantici e moderni e hanno costituito vieppiù l’Accademia dei Ragazzi Piano Duo, eseguendo a memoria, senza l’ausilio di alcuno spartito musicale, il loro repertorio, confermando un eccezionale grado di maturità e di giudizio, ben al di sopra della loro età anagrafica. Eleonora Lauro Sono stati eseguiti brani di: L .v. Beethoven: Allegro (Son. Op. 10 n. 2), Presto (Son. Op. 10 n. 2) - M. Moszowoski: Etude de virtuosité (Op. 72. n. 6), Etincelles (Op. 36 n. 6) - F. Chopin: Fantaisie – Impromptu (Op. 66 in Do diesis minore) - F. Liszt: Ronda di gnomi (Studio da concerto n. 2) - E. Mac Dowell:Hexentanz (Ballo delle streghe), Due studi fantastici (Op. 17 n. 2) - S. Rachmainoff: Etude tableaux (Op. 39. n. 6). I due giovani artisti hanno saputo contemperare perfettamente ritmo, melodia ed armonia, secondo i dettami di Euterpe, “la Rallegratrice”, la musa protettrice della musica, rappresentata dai moderni con un quaderno di musica in mano. E certamente i due artisti hanno “rallegrato” il pubblico presente, suonando come due Antonio Patalano esperti professionisti adulti, lasciando un ricordo indelebile della serata nella mente degli spettatori, che alla fine si sono congratulati calorosamente con loro, aspettando impazienti nuove esecuzioni dei due straordinari talenti, guidati dalla bravissima Teresa Coppa, loro punto di riferimento costante e proficuo anche sul piano della maturità globale. Ci si augura che anche gli enti locali preposti sostengano concretamente questi ed altri talenti certamente presenti sul territorio. (Nicola Luongo). 36 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Colligite fragmenta, ne pereant Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia A cura di Agostino Di Lustro La Ecclesia seu Confrateria de Santa Maria de Loreto de Forio tra XVI e XVII secolo e altri fatti coevi I luoghi sacri del territorio di Barano - II Conosciamo già sufficientemente la valenza toponomastica del toponimo Barano e l’estensione della giurisdizione parrocchiale di S. Giorgio al momento della fondazione della parrocchia di S. Sebastiano, o S. Rocco, nell’attuale centro di Barano, escludendo Moropano e la sua parrocchia, che abbiamo già esaminato1, e che ha mantenuto nel tempo una sua fisionomia particolare. Il vescovo d’Avalos, dopo aver ricordato la parrocchia di S. Giorgio «del casale di Barano», scrive: «Nel casale di Barano ci è il beneficio di S. Maria delli Lacchi, è jus patronato delli Mellusi si possede per D. Giovanni Antonio Zabatta, rende ducati 16; Nel casale di Barano vi è la cappella di Santo Sebastiano è governata da laici ci sono tre messe lette la settimana, rende in circa ducati 302». Sul primo beneficio ricordato non sappiamo molto. Doveva trattarsi di un beneficio rurale, dal momento che il vescovo non indica alcuna chiesa o cappella come sua sede. Fondata in un anno non precisato da qualche esponente della famiglia Mellusi che ne deteneva il diritto di patronato, in seguito venne annessa al beneficio di S. Tommaso Apostolo, anch’esso dei Mellusi, come si apprende da questo documento che leggiamo nel Notameto atti dei beneficiali : «Ischie 1692= Nota reddituum spectantium ad simplex beneficium sub titulo Sancti Thome et Sancte Marie de Lacchi intus Ecclesiam Cathedralem Isclanam de domo, et familia Melluso folia scripta n. 7». Di seguito vengono citati altri due documenti: il primo del 1597 circa l’assegnazione del beneficio di S.Tommaso nella cattedrale al chierico Giovan Francesco Mellusi, mentre il secondo dice: «Ischie 1749= Acta institutionis unius vel duorum simplicium Beneficiorum sub titulo Sancte Marie Gratiarum vulgo de Lacchi et S. Thome Apostoli intus Ecclesiam Cathedralem Isclanam de jure patronatus Familie Mellusi in favorem clerici D. Iosephi Mellusi per obitum D. Cesaris Mellusi folia scripta. n 11»3. Possiamo dedurre da questi pochi elementi documentari in nostro 1) Cfr. A. Di Lustro, I luoghi sacri del territorio dell’Università di Barano: Moropano –I, in La Rassegna d’Ischia, anno XXXIII n.5 settembre-ottobre 2012. 2) Platea del vescovo d’Avalos, P. Lopez, Ischia e Pozzuoli due diocesi nell’età della controriforma, Napoli Adriano Gallina Editore 1991, p. 213. 3) Archivio Diocesano d’Ischia ( A.D.I.), Notamento degli atti beneficiali della città e diocesi d’Ischia, f. 17. possesso che in origine il beneficio di S. Maria de Lacchi potesse trovarsi in una cappella ubicata nel territorio di Barano, in seguito scomparsa, oppure che il beneficio fosse privo di chiesa e che solo alle fine del secolo XVII la famiglia Mellusi lo avesse annesso a quello di S. Tommaso Apostolo ubicato in cattedrale. Non conosciamo neppure il significato esatto e il motivo per cui veniva chiamata S. Maria de Lacchi. Questo beneficio non viene menzionato nella relazione ad limina del vescovo Nicola Antonio Schiaffinati del 1° dicembre 17414 sebbene nel 1749 il beneficio esistesse e venisse ancora assegnato ai Mellusi. Negli atti della visita pastorale del vescovo Giuseppe d’Amante del 1820, leggiamo che il vescovo ordina che la soddisfazione della celebrazione di obblighi di messe di alcuni benefici esistenti nell’antica cattedrale venga effettuata all’altare maggiore della nuova cattedrale. Tra questi troviamo citato i «Beneficia S. Mariae Gratiarum, vulgo de Zacchis5, et S. Thomae Apostoli de familia Mellusi cum onere unius missae cantatae»6. La notizia viene ribadita negli atti della seconda visita pastorale dello stesso vescovo degli anni 1825-267. La seconda chiesa di Barano ricordata dal vescovo d’Avalos è quella di S. Sebastiano che dice essere «governata dalli mastri laici». Su di essa è già stato scritto da diversi autori8, ma credo che sia il caso di rifare il punto della situazione e colmare qualche lacuna anche in quello da me scritto qualche anno fa9 alla luce di documenti acquisiti in questi ultimi anni. Il culto verso S. Sebastiano nella nostra Isola è antico e molto diffuso. Basti notare che ben due parrocchie gli sono dedicate a Forio e a Barano, e che nel comune di 4) Archivio della Sacra Congregazione del Concilio (A.C.C.), in Archivio Segreto Vaticano (A.S.V.), Relazioni ad limina dei vescovi d’Ischia. 5) Da dove venga fuori adesso la famiglia Zacchi non si riesce a stabilirlo. 6) 1820= Acta Sanctae Visitationis…. ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino Joseph d’Amante nostro Episcopo, f. 3 v. in A.D.I. 7) 1825-1826 Acta Sanctae Visitationis Generalis….. habitae ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino Joseph d’Amante Episcopo Isclano, f. 3 r., in A.D.I. 8) Li citerò secondo lì opportunità che mi offrirà questa ricerca. 9) A. Di Lustro, Il convento agostiniano di Barano, in Ischia oggi, anno V nn. 14-15 (novembre-dicembre ) 1974; G.G. Cervera- A. Di Lustro, Barano d’Ischia, Melito 1988, p. 99 e ss. La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 37 Barano viene venerato e invocato come patrono principale. Abbastanza diffuso anche nel territorio della città d’Ischia, come diremo in seguito. Le tracce più antiche sembra che le troviamo a Forio, come abbiamo già detto in precedenza, in alcuni documenti degli anni 1531 e seguenti10. Nove anni dopo però troviamo un altare dedicato al Santo nella chiesa agostiniana di S. Maria della Scala che ci viene documentata dal seguente documento: Archivio di Stato di Napoli, fondo Congregazioni Religiose Soppresse, Fascio 104 f. 47 1540= Giovanni, e Domenico di Meglio fratelli, ed in nome e parte di Bartolomeo e Giovanni di Meglio loro fratelli minori, per li quali hanno promesso, ed in solidum obligati pro rata e quando saranno d’età fare ratificare l’istromento da essi fratelli minori, con permesso, e consenzo d’Isabella Bosa loro commune madre, tutti del casale di Barano, hanno alienato, e venduto in beneficio di Lonardo, e Giovanni Piro quondam Francesco di Casamicciola annovi carlini quindeci per capitale di docati ventuno, e mezzo, sopra il di loro territorio sito, e posto nel luogo detto la Finestra di capacità di un moggio, e tre quadre incirca, arbustato e vitato, giusta li beni di essi frateli redditizii all’altare di San Sebastiano jus patronatus laicorum de Domo Corbera giusta la strada publica, e vicinale, e giusta li beni di esso Giovanni e Domenico, e fratelli di Meglio, a nessuno venduto, né obligato in tutto, o in parte, ma franco d’ogni peso, e servitù, onde in solidum si sono obligati pagare, e corrispondere ogn’anno carlini quindeci in pace alli sudetti Lonardo, e Giovanni Piro quondam Francesco e volendo esso Lonardo e Giovanni, quondam Francesco Piro esimersi, ed affrancare l’annovo censo enfiteutico perpetuo pagato ogni anno a primo novembre di carlini quattordici al convento per il retroscritto territorio nominato Madonna Agnese di Casamicciola, censito dal convento a Battista, seu Vattino, ed Angelo Piro nel 1507, in affranco di sudetto cenzo di carlini quattuordeci, assegnano, e danno al convento li sudetti carlini quindeci annovi, dovuteli come sopra da Giovanni e Domenico di Meglio una con loro fratelli insolidum su del territorio detto la Finestra li Padri fatto vedere e stimare il territorio della Finestra, in affranco del cenzo di carlini quatuordeci, ricevuti li sudetti carlini quindeci, e Giovanni, e Domenico di Meglio tanto proprio nome, quanto in nome, e parte dei fratelli minori in solidum s’obligano pagare ogni primo novembre il cenzo enfiteutico perpetuo di carlini quindeci al convento, e con tutti quelli patti sogliono, ponersi nell’istromento di simil contratto, come questo ed altro si legge nell’istromento rogato per notar Polidoro Albano d’Ischia li 9 di novembre 1540 etcetera copia del quale in carta pergamena sta in nostro archivio11. 10) A. Di Lustro, I luoghi sacri dell’isola d’Ischia tra XVI e XVII secolo: Forio, in La Rassegna d’Ischia, anno XXXIII n. 1 gennaiofebbraio 2012, p. 39 e ss. 11) Archivio di Stato di Napoli (A.S.N.): Corporazioni Religiose Soppresse ( C.R.S.) fascio 104 f. 47 r. Su questa cappella cfr. an- 38 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Della chiesa di S. Sebastiano di Barano la notizia più antica si riscontra in alcuni documenti vaticani rintracciati da Mons. Agostino Lauro risalenti al 1568 e ancora inediti. Qui però troviamo che un’unica cappella è dedicata, o viene indicata, come dedicata ai Santi Sebastiano e Rocco, mentre in seguito si presenteranno come due chiese ben diverse tra loro. Riportiamo i passi più significativi di questi documenti come sono stati trascritti da Mons. A. Lauro. Archivio Segreto Vaticano, Arm. 29-30, Tomo 228 f. 121v.- 122 r. Episcopo Isclano ac ejus in spiritualibus Vicario Generali ac primae vel aliae dignitati obtinenti, seu antiquiori Canonico residentiali, salutem…… D. Salvator de Meglio casalis Barani vestrae dioecesis…. Cum D. Mutius d’Avalos, iconomus et gubernator ad vitam per nomine ejusdem casalis deputatus cappellae Sactorum Sebastiani et Rochi, vestrae dioecesis……quasdam illius terras, unam videlicet arbustatam et vitatam vitis saburneis capacitatis medii tumuli in pertinentiis dicti casalis et loco ubi dicitur Cantarello…. Sub tareni unius; aliam similiter arbustatam et vitatam in eodem loco sub granorum sexdecim ipso exponenti, ac aliam arbustatam et saburneis vitibus vitatam in pertinentiis ejusdem casalis sub carlenorum septem cum dimidio domino Joanni Dominico Papae et alium terrae petium seminatorium in eiusdem pertinentiis et loco ubi dicitur alle Costate dello Cotto….pro carolenis trium monetae istarum partium, insimul duorum ducatorum auri de Camera…… in Omnium Sanctorum cujuslibet anni festivi etate persolvendis domino Alphonso Mattiae……..in emphiteusim perpetuam….. Die IX Januarii anni 1568………… Fol. 122 r. Episcopo Isclano, Vicario Generali……..D. Bernardinus Talercius casalis Barani, vestrae dioecesis….. cum D. Mutius d’Avalos, iconomus et gubernator ad vitam pro nomine ejusdem casalis deputatus cappellae Sanctorum Sebastiani et Rochi……quasdam illius terrae petias, unam videlicet arbustatam et vitibus greci, et latinis vitatam in pertinentiis ejusdem casalis et loco ubi dicitur Starza, sub carlenorum septem cum dimidio, exponenti, et aliam seminatoriam in eisdem pertinentiis, et loco dicto alle Carane seu la Cava de Mase sub carlenorum decem Vincentio, et aliam mesiaequadre in loco ubi dicitur lo Monte di Barano…..sub granorum novem monetae istarum partium et duorum ducatorum de Camera insimul….. in festo Omnium Sanctorum persolvendis martino de Melio, et ejus uxori haeredi quondam Johannis Columnae. Die IX Januarii anni 1568….. Dopo questi documenti bisogna aspettare la Platea del d’Avalos per trovare menzione di una chiesa dedicata esclusivamente a S. Sebastiano, senza alcun cenno a S. che A. DI Lustro, Ecclesia Maior Insulana La Cattedrale d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Tipografia Puntostampa 2010, p. 151. Rocco. Anzi il d’Avalos tace sulla presenza di una chiesa dedicata a S. Rocco esistente a Barano , a meno che non l’abbia erroneamente collocata a Fontana come abbiamo accennato nelle puntate precedenti12. Il vescovo, dunque, così scrive di S. Sebastiano: «Nel casale di Barano vi è la cappella di Santo Sebastiano, è governata dalli mastri laici, ci sono tre messe lette la settimana, rende all’incirca ducati trenta»13. Anteriormente all’anno 1600 non abbiamo altri documenti su S. Sebastiano neppure nel Notamento degli atti beneficiali. Qualche anno dopo, l’università di Barano venne a convenzione con l’agostiniano fra Onofrio per la fondazione di un convento accanto alla chiesa di S. Sebastiano, stipulando il 1° aprile 1607 una convenzione per meglio regolare i rapporti tra gli stessi frati e l’Università. Presto però il padre Onofrio, impegnato anche in altri affari per il suo Ordine, dovette lasciare Ischia e rinunziare alla fondazione del convento. Al suo posto subentrò fra Cosmo da Verona. Questi doveva essere un cartografo; infatti ci ha lasciato una carta topografica manoscritta dell’isola d’Ischia, oggi conservata nella Biblioteca Angelica di Roma14. Alla fondazione del convento fu stipulata una convenzione tra i deputati di Barano Andrea Malfitano e Giovanni Antonio Malfitano e fra Cosmo agostiniano per meglio regolare i rapporti tra l’Università di Barano e l’Ordine Agostiniano sul modo di amministrare il convento Il 1° aprile 1607 si svolse un pubblico parlamento «sub die de primo mensis aprilis 1607 fuit convocato consilio in dicto Casali de ordine Regii Gubernatoris et coram magnifico Joanni Baptistae Brancia Capitaneo convocati homini predicti Casalis voce publica et condunatis in platea predicta in loco detto S. Sebastiano loco solito et consueto in quo conveniri solent pro publicis negotiis gerendis per dictos deputatos…». Si convenne dalla maggior parte degli abitanti del detto casale che la «predetta chiesa di S. Sebastiano si doni alla Religione di santo Augustino alla Provincia di Terra di Lavoro con farsi un monastero con patto che la mastranza di detta chiesa sia sempre jus patronato del detto Casale e che nelli tempi stabiliti possi eligere li mastri soliti con fede alla magior osservanza di detto Casale come elige la città nella ecclesia di Santa Maria della Gratia15 quali mastri habbiano da havere particolare pensiero del detto monistero et ecclesia acciò habbia da conservare de bene in meglio in…. et promettevi più detto Fra Cosmo…..alli predetti deputati e università farli una cappella dedicata alla congregazione del Santissimo Sacramento……. Farsi due sepolture come meglio pare12) Cfr. A. Di Lustro, I luoghi sacri di Fontana, in La Rassegna D’Ischia, anno XXXIII n. 3 maggio 2012. 13) P. Lopez, op. cit. p. 219. 14) D. Niola-Buchner, Ischia nelle carte geografiche del Cinquecento e Seicento, Ischia Imagaenaria 2000 p. 34 e ss. 15) Si riferisce certamente al convento francescano conventuale di S. Maria delle Grazie, o all’Arena, fuori il borgo di Celsa che era di patronato dell’Università della città d’Ischia. ranno venire quali sepolture habbia d’essere nell’ala deritta nell’intrare convenire quali…. detti deputati mastri si abbiano a formare in detta cappella li fratelli e sorelle della detta confraternita…16». L’arrivo di Fra Cosmo a Barano e l’apertura del convento creò qualche problema. Il parroco di S. Giorgio D. Albino di Meglio, per maggior comodo degli abitanti, conservava anche nella chiesa di S. Sebastiano il Santissimo Sacramento. La fondazione del convento e la presenza degli Agostiniani nel territorio della sua ottina parrocchiale e la concessione ad essi della chiesa di S. Sebastiano, sottratta al controllo e alla giurisdizione del parroco, non furono gradite a D. Albino per cui «Adi 28 agusto 1608 ci si sciso lo Sacramento da Santo Sebastiano a Santo Giorgio»17. Questo episodio non si inserisce nel desiderio di rendere più solenne la processione del Corpus Domini, come farebbe pensare il Monti18, ma ad un vero e proprio atto di protesta da parte del parroco D. Albino di Meglio: poiché la chiesa di S. Sebastiano non è più sotto la mia giurisdizione, porto via il SS.mo Sacramento e anche la pisside perché neppure questa appartiene agli Agostiniani. Fra Cosmo, privato anche della pisside dove riporre le Sacre Specie, fu costretto a recarsi al convento di S. Maria della Scala e rifornirsi di una nuova pisside perché necessaria alla chiesa e alla confraternita del SS.mo Sacramento che era stata fondata nella chiesa di S. Sebastiano. La vicenda però non era terminata perché a questo punto subentrò il problema «della sfera», cioè dell’ostensorio che si svilupperà negli anni successivi. La vicenda ci viene documentata dalle testimonianze di diverse persone presentate per la soluzione del caso. Infatti così leggiamo in due testimonianze del 1641. La vertenza si acuì quando nel 1640 fu fondata la seconda parrocchia di Barano nella chiesa di S. Rocco19. Questa, sia la chiesa che la parrocchia, erano di patronato dell’Università per cui si riaccese la vertenza. Dei documenti relativi, riportiamo i documenti che seguono che bene sintetizzano la vicenda. Archivio di Stato di Napoli, Corporazioni Religiose Soppresse fascio 118 f. 94 r. - Die secundo mensis martii 1641 Ioannes Antonius de Meglio Varani etatis sue annorum circa sexaginta trium ut dixit………..come il Casale di Barano non havesse sfera per asportare il SS.mo quando uscisse dalle chiese et cossì…….per maggior augumento del servitio 16) Cfr. in C.R.S. fascio 117 ff. 97-99. 17) Archivio Parrocchiale di S. Giorgio, Primo libro dei battezzati, cfr. anche G. Vuoso, La Chiesa parrocchiale di Testaccio d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio Tipografia Epomeo 1990, p. 28. 18) P. Monti, Ischia archeologia e storia, Napoli Lino-tipografia Fratelli Porzio 1980, p. 751. 19) A.D.I. Notamento cit. f. 84: Barani 1640= Decretum erectionis Parochialis Ecclesie intus Ecclesiam Sancti Rochi cum reservatione juris patronatus favore Universitatis eiusdem necnon instrumentum factum anno 1701= folia scripta n. 16. Cfr. G.G. Cervera_ A Di Lustro, op. cit. La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 39 de Iddio…..con Andrea Telese orefice di Napoli che capitandoli alcuna sfera per le mani ne li havesse fare parte perche il Casale li la voleva comprare per servitio et comodità quando esce il SS.mo et cossì dallo ……..tempo detto Andrea disse che l’era venuta in mano una sfera delle parti di Calabria al….. però con li denari di detto Casale di Varano per ducati sei, e tutto quello pigliare più detto Andrea lo donò perchè andasse in beneficio dell’anima di suo padre e portata che l’hebbe in questo Casale detta sfera se ne servirono per uso publico del sudetto Casale a tempo si asportava detto SS.mo che si conservava in potere delli deputati o vero sia nella chiesa di Santo Sebastiano di detto Casale con fede si fa la presente che poi quando la detta chiesa di Santo Sebastiano di detto Casale fu donata alla religione di Santo Augustino venne D. Albino di Meglio Paroco di Santo Giorgio et si pigliò il SS.mo con tutta la piside f. 94 v. - che stava dentro di detta chiesa di Santo Sebastiano: Il Padre Fra Cosmo di Verona andò a Santa Maria della Scala per li si fece portare la piside per mettere di nuovo il SS.mo in detta chiesa e la detta sfera restò in potere del governo di detto Casale ch’era …..perciò tenerli per servitio del publico e servire a tempo uscire il SS.mo e quello portare alli tempi detti nella chiesa di Santo Sebastiano che dalli e quel tempo uscire detto Santissimo ma hora che esce dalla Parochia se ne servia in detta Parochia ….così spettante al publico et per esser loro proprio a quel è deponere…………Et dettoli come portavano detta sfera in detta chiesa di Santo Sebastiano detto che se la prestano…….in potere del governo atteso poi il Parocho si fece la nova sfera a detto comprata da esso restò in potere del governo di detto Casale. Questo è vero io Giovanni Antonio de Meglio sono testimonio. f. 95 r. Eodem die ut supra Nicolaus de Meglio Casalis Varani etatis sue annorum circa triginta quinque…….come l’anni passati ritrovandosi esso detto sindico del Governo del casale di Varano venne un giorno a ritrovarlo Fra Francesco d’Ischia all’hora Priore di Santo Sebastiano di detto Casale et lo pregò che esso non poteva più tenere lo Santissimo Sacramento et la sfera di detto Casale perché l’erano stati dati così contro alli suoi superiori che li havessero fatto una Bissita per tenere detto Santissimo Sacramento che li tornava la sfera, et così esso come sindico a sue proprie spese fece detta Bissita. Et la consignò allo detto Padre Priore, lo quale la ricevè et piglio detta sfera, et ge la diede dicendo pigliatela perché è cosa vostra, et con……. del convento con esso se la receve et si la ritenne in suo potere, et dalla………..esso sopradetto la consignò al suo successore nel governo come presente ancora in loro potere si ritrova, et per sempre l’have inteso dire che è stata fatta dalo Casale, et è stata in potere hora delli mastri del Santo Sebastiano et hora in potere del governo per essere 40 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 stata sempre cosa loro propria con il è questo presente. Io Nicola di Meglio sono testimonio. f. 96 r. Al Signor Capitaneo d’Ischia Li Deputati del casal di Barano expongono a Vostra Signoria come nell’anno 1607 il detto casale mediante publico parlamento, et General Consenso donò alla religione di Santo Augustino in Terra di Lavoro la chiesa di santo Sebastiano sita, et fatta in esso Casale a sue proprie spese, con condizione che li Padri d’essa Religione fossero tenuti fabbricarci un nuovo Monistero per l’habitazioni di dui Padri di Messa, et …., et fu concluso darli tutte l’entrade, emolumenti et elemosine che fussero state fatte, et in futurum si facessero per detta fabrica, et anco promesero farci una cappella dedicata alla Confraternita del SS.mo Sacramento comprando il sito, et sub ministrando le spese il detto Casale con molti altri patti, et condizioni contenuto in publico instrumento, fatto tra esso Casale, et il Reverendo Padre Fra Cosmo di Verona, qual intervenne in nome della sudetta Religione, qual all’impronto si provvide, et havendos’il Casale predetto a sue spese fatto una sfera per portar il SS.mo nelle Processioni per sua Devotione non fu donat’altrimente a detti Padri ma se le serbò per esso anzi havendola l’anni passati accomodata al reverendo Padre Francesco d’Ischia allora Priore di detto luoco per ritenere dentro la custodia il SS.mo essendo venuto il Padre Provinciale a far la visita, ordinò, che si fusse fatto una Pisside, non conservandosi bene dentro detta sfera, et il Casale fece a sue spese quella et le donò alla chiesa predetta, ripigliandosi la sfera qual sin hora ha ritenuto, ritiene in poter suo et perché l’e pervenuto all’orecchie, che li Padri ch’al presente si ritrovano in detto Monistero vogliono quella, et ritenerla come lor cosa propria, contro la volontà del Casale et d’essi supplicanti, non havendo mira, che non solo detta sfera sia stata fatta per devotione loro ma che hanno havuto intentione donarcele. Perciò supplicano Vostra Signoria voglia ordinare che sia lecito a detto Casale et suoi deputati di ritenersi la sfera predetta in poter loro, disponere a lor volontà, come veri Padroni di quella, et che non si possa donare senza espresso parlamento et consenso generale di detto Casale, mentre in detto Instrumento non appare esserci stata donat’alla Religione sudetta, et a questo interponersi dato ad futuram rei memoriam, et haveranno a gratia ut Deus. La vita del convento agostiniano di Barano però fu piuttosto breve perché i frati dovettero lasciare il convento di S. Sebastiano nel 1653 in seguito alla pubblicazione della bolla «Inter coetera» di papa Innocenzo X del 17 dicembre 1649 con la quale si voleva accertare la consistenza numerica delle comunità religiose presenti in Italia, le capacità ambientali e relative risorse economiche delle comunità presenti sul territorio. Gli Agostiniani di Barano il 6 aprile 1650 presentarono la seguente relazione. Archivio Generale degli Agostiniani- Roma f. 111 r. Relatione del Convento di S. Sebastiano dell’Ordine Eremitano di S. Agostino situato nel Casale di Barano della Città, et Isola d’Ischia in conformità della Bolla di Nostro Signore Papa Innocentio , e spedita sotto li 17 di settembre 1649. La fundatione di detto Convento fu fatta nell’anno 160420 alli 16 d’Aprile il fondatore fu il Padre Fra Cosmo da Verona con consenso dell’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Indico Avelles col consenso dell’Università come da Capitoli fatti, con patto che detta fondazione habbia a tenere in quel luogo due Sacerdoti, et un servente, che havessero potuto sodisfare al popolo, et con assignatione de scudi 60, et che detti sacerdoti havessero sodisfatto agl’oblighi et mancando, che il detto Casale, et Università si possa pigliare il detto Convento come si ritrova. Ha la Chiesa sotto il titolo di S. Sebastiano, è di struttura palmi 85 di longhezza e palmi 32 di larghezza, la porta nella Piazza del Casale simile proporzione tiene il convento dalla detta chiesa vi è una porta ch’entra in un camerone et quello serve per chiostro, et Dormitorio, dove vi sono due camere, et dall’altro lato vi è un’altra stanza, serve per cocina, e dispensa. Dalla porta di detto camerone si fa uscita ad un poco di cortiglio contiguo col Giardino serve per li Padri Avertendo che detto Camerone, E Camere sono terrane, et dal cortiglio si va alla Porta del Convento sopradetto f. 111 v. Fa introito di tutto quello che tiene quali sono pesi di messe perpetue in scuti 104 D’una cerca di vino commune sempre botte due sono scudi 12 Di Messe giornaliere scudi scudi 6 1/°per provisione de morti scudi 3 in communi 9: 6 Avertendo che non si mette Casseta, la causa è che li Minimi di detta Chiesa han peso di mantenere la lampa del SS.mo. Tiene il Convento due Sacerdoti, et un Servente il Padre Baccelliere Fra Sebastiano Conti di Barano, Il Padre Fra Antonio Balestriero di Barano Servente Domenico dell’istesso Casale All’incontro ha di peso Messe il Convento per tutto l’anno 479 questi sono oblighi perpetui, et sono 379 d’un paulo l’una; et cento a baiocchi 15 Si riceve la Messa letta a 10 baiocchi, e la cantata giulij tre. Il convento è aggravato scudi 5 l’anno, che si pagano per l’hora che tiene nelle mure del convento 5 Per contribuzione per la Provincia 4 -80 Le spese di Superiori et altre occorrenze 1-50 Per cera ordinaria, et straordinaria 7-20 Di vino e vestiarij, e sosidio di Priore 95 Per li cercatori del vino 4 Per barbiero e chirurgo 1 Estraordinaria 1-50 Di Viaggio di Capitolo 2 Di lite, et Notari 2 Di zappare, e governare il giardino 2-50 D’infirmità 1-50 Noi infrascritti col mezo del nostro giuramento atestiamo d’haver fatto diligente inquisizione, e recognitione dello stato del Monistero sudetto, et che tutte le cose di sopra espresse, et ciascheduna d’esse sono vere, et reali, et che non habbiamo tralasciato d’esprimere alcuna entrata, uscita, e perso del Monistero medesimo, che sij pervenuto alla nostra notitia. Et in fede habbiamo sottoscritto la presente di nostra propria mano, e signato con il solito sigillo. Questo di 6 Aprile 1650 Io Fra Sebastiano Conti di Barano Priore del sopradetto Convento con firma ut supra Io Fra Antonio Sacerdote Balestriero di Barano affirmo ut supra Io Fra Sebastiano Napoletatno Sacerdote Deputato affirmo ut supra Io Fra Clemente Schifelci da Diano Deputato affirmo ut supra. Locus + signi Agostino Di Lustro (continua) 20) Le date riportate dai vari documenti sono un poco ballerine. La relazione ad limina presentata il 9 aprile 1604, tra i conventi presenti sull’isola d’Ischia non fa menzione di S. Sebastiano di Barano, come pure in quella dell’11 giugno 1606. Viene ricordato per la prima volta nelle relazione ad limina del 13 maggio 1609 (cfr. le varie relazioni ad limina). La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 41 Stabiae Svelata Dalle celebrazioni per il 250° degli scavi borbonici alle ultime esplorazioni Inaugurata al multisala Montil di Castellammare di Stabia la mostra Stabiae Svelata. Dalle celebrazioni per il 250° degli scavi borbonici alle ultime esplorazioni (1999-2012) che resterà aperta fino al 9 dicembre 2012. Sono esposti documenti e reperti storici attestanti le attività di scavo, restauro e ricerca condotte nel corso degli anni presso le ville romane di Stabia, frutto del prezioso lavoro svolto da tutti gli uffici della Soprintendenza ed in «Natale in casa De Angelis» Antonio Macrì Sabato 10 novembre 2012 è stata inaugurata ad Ischia Porto in Piazza degli Eroi, nella casa, già degli artisti della famiglia De Angelis una mostra, curata da Massimo Ielasi, dei dipinti di Antonio Macrì che racconta le tradizini isolane. La mostra si protrarrà sino al 6 gennaio 2013. Per Antonio Macrì il “verbo”, biblicamente inteso, è “Ischia”, e mille sirene, invitanti dalla vicina costa di Vivara, non potrebbero smuovere la sua granitica fermezza. Ancorato alla sua bitta sul porto-cratere Antonio dipinge da anni, frugando prima con occhio sorpreso, poi via via con sguardi sempre più acuti, quell’universo “perfetto, completo e assoluto” che è, come per la quasi totalità degli autoctoni, la sua antica Aenaria. Un discorso continuato, insomma, conseguente, che, oseremo definire - con una parola d’uso - corrente e barbaro, ha inconsciamente “pianificato”. Perché in verità questa lunga ricerca di una sua via alla pittura, per Macrì è sempre stata una ricerca di sé, del suo io profondo. Come se la pittura fosse per lui la risposta al gigantesco punto interrogativo che le sue nubi lattee disegnano nei suoi cieli d’azzurro infinito ma nei quali non appare mai il sole. Sarebbe avvilente limitare ad un’identificazione psicologica il lungo cammino percorso dall’artista. Diciamo che essa tuttavia ci dà modo di capire perché Macrì lavora e dipinge e come lavora e dipinge. Venuto da una vita agra in cui lavorare stanca e dietro cui la fatica mostra il suo volto disfatto senza più gli orpelli della retorica e della finzione poetica, l’artista aveva trovato tra i pennelli e i colori l’evasione riposante, il riparo tranquillo contro il suo fato d’uomo. Poesia dunque i suoi primi lavori? Fuga da una realtà? Nulla di tutto ciò o forse tutto. Forse, agli inizi, soltanto un modo di ricercarsi e ritrovarsi altrove. Basta vedere, come ci fu dato, alcune 42 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 primis del Laboratorio di Restauro di Stabia. Le ville, le nuove scoperte, i risultati delle ultime ricerche scientifiche attraverso filmati storici, ricostruzioni virtuali, foto, documenti d’epoca, calchi di oggetti e arredi: ecco quanto sarà divulgato e messo in mostra. «La mostra – ha affermato la dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro - è la dimostrazione dell’impegno rivolto a Stabia, spesso relegata nell’attenzione collettiva in secondo piano rispetto a Pompei. Di fatto per la Soprintendenza non esistono graduatorie fra i vari siti: tutto il patrimonio archeologico è meritevole di cura e attenzione, che si rimettono inevitabilmente ad una scala di priorità dettata dalle contingenze. Il lavoro di valorizzazione e promozione passa anche e soprattutto attraverso la capacità di indirizzare e coinvolgere i flussi turistici, che oggi si fermano nella sola Pompei, verso gli altri siti di competenza, e questa mostra ne è segno concreto e tangibile». «L’impegno della Soprintendenza è ora quello di lavorare alla realizzazione del Museo archeologico di Stabia, impegno che dovrà passare anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli altri Enti di competenza, in un percorso condiviso di valorizzazione». * delle sue prime tele, per capire con quanta tenerezza egli scavasse dentro le cose che rappresentava, il “suo” porto, le “sue” case attorno al porto, le “sue” navi nel porto, certi “suoi” angoli dell’isola o la “sua” Forio. Per non dire la patetica dolcezza con cui ha saputo fissare certi volti dei suoi cari. Macrì ha lavorato a lungo così, in silenzio, quasi in segreto, con una modestia che oggi può apparire francescana, interrogandosi con domande a cui, egli da solo, non poteva dare tutte le risposte. Unica certezza che non lo ha mai tradito è la stessa che ci ha dato il grande Morandi: sapere cioè che non è tanto il soggetto dipinto a fare grande un quadro quanto il modo di dipingerlo. E così come Morandi ci ha dato le sue “eterne” bottiglie, Macrì ci ha dato la sua Ischia, cruda e verde, assetata anche se gonfia d’acqua, amara anche se dolcissima, cupa anche se ridente. Dalle lontane origini ad oggi il discorso, ripeto, non è mutato., anche se, ad un certo momento della sua vita d’uomo e di pittore, qualcosa è cambiato. Radicalmente e definitivamente. Come se, attraversando il braccio di mare che divide la sua isola dal mondo, egli abbia, non ascoltato la voce delle sirene, ma preso coscienza che le sirene esistono, che la terra non finisce a punta San Pancrazio o a Punta Cornacchia e che spargere colori su una tela può essere altra cosa che un’evasione o un rifugio. Un’avventura esaltante ad esempio, una rivalsa, una rivincita, una vittoria. Questa presa di coscienza lo ha sbarazzato - lui timido ed introverso, segreto ed avulso - di quella corazza impalpabile di incomunicabilità che faceva di lui il peggior nemico di se stesso e della sua pittura. Da allora è come se il mondo si sia sciolto sotto il suo pennello. Le strutture rudi, i visi e i corpi scolpiti con l’accetta, gli oggetti duri e massicci, tutte rappresentazioni del suo mondo di amore-sofferenza su cui ci sarebbe molto da dire, si sono come “liberati” in una catarsi diluita e rarefatta. Delle sofferenze e fatiche di un tempo egli è riuscito a buttare tutte le scorie salvando, nonostante tutto, due realtà essenziali: la poesia e la sua isola. Perché anche aprendo gli occhi sull’altro mondo (quello della terraferma) Macrì ha rifiutato il canto delle sirene. Indissolubilmente incatenato all’ancora adagiata al fondo del suo porto-cratere, nonostante le evasioni e le pazziate che possono indifferentemente portarlo a Monaco di Baviera o a Venezia, a Roma o a Parigi, egli “sa” che Ischia rimane, assieme, la sua prigione e la sua fortezza. Da qui questi suoi quadri pieni di mare e di cielo con nubi bianco-grigio-dilaganti che partono per non si sa dove. Come la sua anima di moderno Sisifo, alla ricerca di nuovi cieli o come il cuore degli antichi emigranti desiderosi più di tornare che di partire? Parlare di “dolce malinconia” a proposito di Macrì ci sembra L’isola dei morti Omaggio ad Arnold Böcklin è il titolo di una mostra collettiva svoltasi nel mese di ottobre 2012 nella Galleria Ielasi di Ischia Ponte. Sono state esposte opere di: Vasco Ascolini Paolo Bacilieri Salvatore Basile Paola Casulli Francesco Cattani Marco Cortese Luigi Critone Manuele Fiore Fracesca Ghermandi Gabriella Giandelli Raffaele Iacono Max Klinger Piero Macola Antonio Macrì Franco Matticchio Lorenzo Mattotti José Muñoz Giacomo Nanni Emil Nolde Gabriele Renzullo Caterina Sansone Alessandro Tota. limitativo e, tutto sommato, banale. Tuttavia la riposante tenerezza che ci trasmettono i suoi quadri è il punto di partenza per un eventuale discorso futuro del suo iter artistico. Dietro le grandi nubi che invadono, coprono, dilagano nei suoi quadri forse, anzi, sicuramente, si nasconde il sole. Un sole senza tramonti. (Enrico Giuffredi - Parigi, luglio 1990) – da www.ischiaonline.it “Non omnis moriar” a Gabriele Mattera Tra cieli e terre traslato su cremagliere arruginite dalla salsedine assicurato per argani e pulegge robustose imbracato con clinganti anelli di roccia ciclopica recuperato da pazientosi cingoli rampinanti ormai emerso sacello cipressato su cippo basaltico olio su tavola galleggia 74x122 cm. Tra cieli e terre figura bianco-vestita bara-drappo sic goffratura in cerniera dentellata per emissioni multiple francobollo 1880 in filigrana ancora un Caronte trasfigurato promosso rimosso traghetta imbesuito surreali Marie allucinate misteriche cercinate a madonna Tra cieli e terre polene lignee incellofanate in sbuffi di vapore tridimensionali leggere visioni in dissolvenza di che si voglia immagini Pithekoussai Civetta dispettosa con obolo incastonato a fronte e/o criptato fra frenulo e lingua a dolo Tra cieli e terre tracima la scia dietro l’aratro timone a dritta nigro semen semina a manca leucodromo asettico senza motivo affiorante unico il giorno che non conosce domani tenero si lascia vivere sbiancato e zittito trapassato portato a spalla da oblati incappucciati a risalire il salto tra cirri saturnini nati da lagrime dissalate Tra cieli e terre sospiri cospirati sommesse geremiadi arrochite a ricordare la vita alla vita nel bianco della calce viva traspirata algido lucore incornicia una barca tanto in assoluta levità lontano scivola lontano Tra cieli e stelle. Luglio, 2012 Pietro Paolo Zivelli La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 43 Premio dei Grandi Giardini Italiani alla Mortella di Forio Il Premio Grandi Giardini Italiani 2012 per il più alto livello di manutenzione, buon governo e cura dei giardini visitabili si propone di offrire un riconoscimento alla professionalità e alla cura dimostrata da proprietari e curatori nella manutenzione dei giardini italiani aperti al pubblico: 500 anni di storia dell’arte e del paesaggio che arricchiscono il prestigio e l’immagine del Paese. In base a tali canoni, quest’anno sono stati assegnati: I premio a La Cervara – Abbazia di San Gerolamo al Monte di Portofino (S. Margherita Ligure, GE) II premio al Giardino La Foce (Chianciano, FI) III premio ai Giardini La Mortella (Forio – Isola d’Ischia, NA) Si legge sul sito (www.grandigiardini.it) relativamente ai Giardini La Mortella: «È un capolavoro paesag- gistico e botanico contemporaneo, creato e curato da Susana, moglie di William Walton, uno dei più importanti musicisti inglesi del Novecento. Progettata in parte da Russell Page, La Mortella occupa un’area di circa 2 ettari divisa in due zone, giardino a valle e giardino superiore, che ospitano più di 3.000 specie di piante. L’ambiente è arricchito da fontane e corsi d’acqua per specie acquatiche come papiro, loto e ninfee tropicali. Le collezioni comprendono piante originarie da diversi paesi, quali felci arboree dal continente australiano, protee e aloe dal Sudafrica, yucche e agavi dal Messico, e poi magnolie, camelie, bauhinie, palme, cicadacee. Tra le rarità botaniche si segnalano, oltre a numerose orchidee, Spathodea campanulata dall’Africa tropicale, Metrosideros dalla Nuova Zelanda, Puya berteroniana dal Cile, Dracaena draco dalle Canarie, Chorisia speciosa e Jacaranda mimosifolia dall’Argentina. Nella serra della Victoria vengono coltivate la gigantesca ninfea brasiliana Victoria amazonica e il rarissimo rampicante filippino Strongylodon macrobotrys, con fiori verde giada. Nel giardino superiore si trovano la Sala Thai dall’atmosfera orientale, circondata da fior di loto, bambù e aceri giapponesi; il Tempio del Sole, con bassorilievi di Simon Verity; la cascata del Coccodrillo; il Ninfeo, un angolo formale in mezzo alla flora mediterranea; il Teatro greco, con la splendida vista sul mare e infine la Roccia di William, dove sono custodite le ceneri del compositore. Salendo la collina si incontrano un bar accogliente, la Serra delle orchidee, il Museo, con ricordi di Walton, fotografie di Cecil Beaton e un teatrino di Lele Luzzati. La Mortella offre borse di studio per compositori in collaborazione con l’Università di Harvard, e organizza una stagione di concerti con le scuole di musica di Napoli, Roma e Firenze. Dal 2007 il Teatro greco ospita concerti estivi all’aperto». Premiazione del Premio Grandi Giardini Italiani 2012 (Isola del Garda, 10 ottobre 2012) - A sinistra il dott. Mapelli e la sig.ra Mapelli, proprietari de La Cervara, Abbazia di San Gerolamo al Monte di Portofino (S. Margherita Ligure, GE) - A destra la dott.ssa Vinciguerra, Direttrice e curatrice de La Mortella (Forio – NA). 44 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Rassegna LIBRI Il Museo Archeologico di Pithecusae di Costanza Gialanella Nuova Grafica Editrice, luglio 2012, pp. 32. In copertina: I muli della Stipe dei cavalli (località Pastola, Lacco Ameno). «Sono molto grata all’Amministrazione Comunale di Lacco Ameno per aver voluto rieditare, con un apposito finanziamento della Regione Campania, questa Guida breve del Museo Archeologico di Pithecusae, istituito nell’aprile del 1999 nell’edificio principale del complesso di Villa Arbusto in Lacco Ameno d’Ischia, costruito nel 1785 da Don Carlo Aquaviva, Duca di Atri, lì dove era la “masseria dell’arbusto”. Il Museo illustra la storia dell’isola d’Ischia, dalla Preistoria all’Età romana ed impegna, con le sue otto sale, il primo piano della villa principale del complesso. Nell’Istituto sono esposti oltre 1000 reperti, il cui nucleo più significativo è costituito dai materiali, soprattutto ceramici, che danno testimonianza dell’antica Pithecusae, fondata nel secondo quarto dell’VIII secolo a. C. sul Monte di Vico a Lacco Ameno da Greci provenienti dall’isola di Eubea. Questo stanziamento greco ha giocato un ruolo di primaria importanza per la nascita della civiltà della Magna Grecia: Pithecusae è stata infatti un centro di fabbricazione e di smercio di prodotti soprattutto metallurgici finiti, favorevole rispetto al mercato delle popolazioni emergenti dell’Italia centrale, a quell’epoca non ancora inserite in un sistema di commerci codificato e sulle quali non può negarsi la straordinaria importanz determinata dalla fondazione di Pithecusae, attraverso la quale si diffuse, tra l’altro, anche la conoscenza della scrittura alfabetica. La nostra conoscenza di Pithecusae si fonda esclusivamente sulle straordinarie scoperte di Giorgio Buchner (Monaco di Baviera, 8 agosto 1914 - Ischia, 4 febbraio 2005), grande archeologo tedesco ma italiano di adozione, che ha dedicato la sua intera vita allo studio ed alla ricerca di Pithecusae: ancora nel 1930, infatti, l’archeologo A. Maiuri confessava come l’isola d’Ischia fosse del tutto ignota, e tale essa rimase fino a che lo stesso Maiuri non assunse Buchner nel 1947, come salariato stagionale, presso l’allora Soprintendenza alle Antichità. Nel 1952 Buchner diede inizio agli scavi della necropoli, nella baia di S. Montano, svelando un universo di conoscenze che costituisce uno dei tasselli fondamentali della storia del mondo occidentale e continuando da allora a lavorare sino alla costituzione del Museo Archeologico, l’ultima sua grande opera prima della scomparsa, avvenuta pochi anni più tardi. Un Museo che egli, come già suo padre, altrettanto illustre naturalista, immaginò quale prezioso lascito tanto al mondo della cultura quanto ai suoi concittadini elettivi dell’isola, la terra che egli amò e rese illustre. Per sua esplicita richiesta, il Museo non porta il suo nome, ma amarlo, conoscerlo, sostenerlo, frequentarlo sarà il miglior modo per noi tutti per dirgli più degnamente e semplicemente grazie». Introduzione di Costanza Gialanella, Direttore scientifico del Museo Archeologico di Pithecusae Due ospiti ad Ischia: il Beato Bonaventura da Potenza e Suor Mariangela della Croce di Nunzio Albanelli Valentino Editore, luglio 2012. La pubblicazione è stata finanziata dalla Fondazione Opera Pia Iacono Avellino Conte e il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza. «Sfogliando un’elegante rivista edita dai conventuali di Ravello, fui attratto da una nitida riproduzione di un dipinto raffigurante il Beato Bonaventura da Potenza che indica a un nobile cavaliere un cesto aperto da una donna là inginocchiata, ricolmo di pane fresco. Già m’era noto quel quadro e sapevo che il cavaliere là raffigurato era il marchese Giacomo Lanfreschi e la donna Angela Diodato, di Villa dei Bagni, istitutrice dei figli del marchese. Angela, convertita da una vita frivola e dissipata, era la lunga mano di Padre Bonaventura nel soccorso dei poverelli. Avendo un giorno svuotata la dispensa per sfamare i poveri del Padre Bonaventura ed essendo stata rimproverata dalla cameriera di casa Lanfreschi, fu trovata in casa, senLa Rassegna d’Ischia n. 6/2012 45 za conoscerne la provenienza, una cesta di pane fresco e profumato. Guardando quell’immagine esclamai: - Beato Bonaventura, hai fatto tanto bene agli Ischitani nei dieci anni che vivesti in quest’isola e oggi sei tanto sconosciuto. Chissà se qualcuno si ricorderà di te, almeno quest’anno che è il terzo centenario della tua morte! In verità ero scettico pensando che, come son passate sotto silenzio tante ricorrenze, sarebbe passata anche così la data del 26 Ottobre 2011. Ma mi son dovuto ricredere e riconoscermi uomo di poca fede. Il Prof. Nunzio Albanelli, amico mio da circa sessant’anni, mi ha presentato perché lo leggessi un suo lavoro sul Beato Bonaventura. Sono rimasto sorpreso! Lo Spirito Santo ha ispirato lui, che non è un frate né un prete, ma un ottimo padre di famiglia, uno scrupoloso insegnante e un meticoloso dirigente, già titolare dei due licei isolani, a riaccendere la lampada del ricordo di un personaggio che, nel campo dello spirito, fu il più grande benefattore degli Ischitani, stimolando, attraverso questo scritto, coloro che hanno fede, a ricorre- Cogito et cano tiero dell’esistenza. «Ci accompanano il “canto” di Antonia (la protagonista), le sue parole, i suoi occhi, che scopriranno infine che l’amore è davvero qualcosa che ci colpisce inaspettato e a sorpresa, perché quello che non ci aspettiamo è destinato a cambiare il corso della nostra esistenza». Seguendo la lettura piacevole, scorrevole e accattivante, Palma «ci racconta la sua versione dell’amore, dalle alte sfere all’incredibile viaggio della vita», concludendo la sia narrazione con una massima di S. Agostino: «Quando si ama, non si fa fatica, o, se si fatica, questa stessa fatica è amata» (In eo quod amatur, di Palma Impagliazzo Albatros Editore, collana Nuove voci, marzo 2012 Cogito et cano introduce Palma Impagliazzo, nata a Lacco Ameno, laureanda in Filosofia, nel campo della scrittura con questa prima pubblicazione che è «un viaggio emozionante nella storia di un cuore e di un’anima che cresce e conosce i sentimenti, il mondo, la vita». Vi concorrono quindi la famiglia, il primo amore o gli amori, le delusioni, le illusioni: tutto un insieme di aspetti che normalmente caratterizzano coloro che percorrono il sen- aut non laboratur, aut et labor amatur). Alfa Alfa Zulu Zulu “Il Semaforo” Per una storia delle telecomunicazioni della Marina Militare di Salvatore Grillo Casa Editrice Fergen, marzo 2012. In copertina Il semaforo di Punta Imperatore (dipinto di Michele Petroni) «Il presente libro, scritto con intenso sentimento dal contrammiraglio Salvatore Grillo, è meritevole di particolare considerazione, sia per la descrizione della storia, avvincente e ormai conclusa, del mondo delle stazioni semaforiche e di quelle che furono le telecomunicazioni classiche, sia per il modo in cui con manifesto amore è riportata l’intera vita professionale dell’autore, a parrire dagli inizi come allievo capo corso dell’appena costituita categoria dei “semaforisti”. 46 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 re alla intercessione del Beato Bonaventura. Il voto che facciamo in questo terzo centenario del suo ritorno a Dio è che venga proclamato Santo per aver ottenuto dal Padre della Misericordia la guarigione, insperata e umanamente inspiegabile, a un figlio o una figlia dell’isola d’Ischia, per cui si sarà pregato con fiducia e ci si sarà rallegrati per l’ottenuto favore e la glorificazione del pietoso intercessore». Presentazione di Mons. Camillo D’Ambra La vicenda storica delle pagine che descrivono in modo avvincente i paricolari, in larga parte sconosciuti, di un mondo che è stato per lunghi anni il cardine della salvaguardia delle coste nazionali, e l’esposizione degli accadimenti di una categoria così caratteristica e gloriosa, anch’essa ormai non più esistente, rendono quest’opera degna di un’attenta lettura» (Dalla Prefazione di Bruno Branciforte, ammiraglio di squadra e capo di Stato Maggiore della Marina). Particolare rilievo assume il racconto della permanenza del giovane semaforista Grillo presso il semafoo di Punta Imperatore a Forio: un «ritratto interessante della vita in un’epoca ormai superata dalla tecnologia». Vi sono menzionati personaggi e vicende di vita del tempo; infatti il Grillo si era ben inserito anche nel contesto sociale locale con le sue amicizie: partecipò per esempio ad una compagine calcistica impegnata nei campionati provinciali. Tra i suoi amici ricorda particolarmente Masino Manna, detto “Masidò”, segnalatore di leva: un personaggio allegro, simpatico e pieno di energia, e un ragazzo affabile che diventerà poi un eccellente pittore, e cioè Michele Petroni, alias Peperone. * Lo sport a Pozzuoli, storia e leggenda di Gennaro Gaudino Tipolitografia “Grafica Montese”, Monte di Procida, 2012, pp. 144. È dal lontano 1994, con la pubblicazione del suo primo volume (Diavoli Rossi. La tradizione calcistica flegrea, Ed. Riccardi) che Gennaro Gaudino, giornalista pubblicista, nonché accreditato ed esperto studioso del calcio campano, ci diletta e ci nutre di cultura – è proprio il caso di dire – con le sue pregevoli pubblicazioni, cariche di un lavoro oculato e certosino, di documenti, di notizie e foto sovente inedite, scovate tra la polvere e la muffa di archivi e biblioteche o tra le pagine ingiallite dal tempo di giornali d’epoca: unico protagonista dei suoi lavori, il calcio flegreo. Queste pubblicazioni avvalorano anche il contesto socioculturale dove essi nascono e attingono notizie, il più delle volte (anzi, quasi sempre) riscontrando una vacua disponibilità e sensibilità da parte delle amministrazioni locali ed imprenditoriali. Eppure la cultura di un luogo, di una città, si divulga soprattutto attraverso i libri, anche se l’argomento è lo sport. Nel leggere questa ennesima fatica di Gaudino, si ha ancor più netta la convinzione – se mai ce ne fosse bisogno – che la cultura di una città, come accennato all’inizio, passi anche attraverso lo sport, non fosse altro che per i personaggi legati ad esso che hanno contribuito negli anni a scrivere pagine importanti e/o eccezionali, sovente assurti alla ribalta nazionale. Infatti, l’autore, con un linguaggio senza fronzoli, che bada al sodo ma piacevole nella sua fluidità, ci dà riscontro, dopo accurate ricerche, di alcuni personaggi ed eventi puteolani che, specie nel secolo scorso, hanno maggiormente dato lustro alla città di Sophia Loren: Luigi Fasulo, che arrivò alla soglia del titolo italiano dei pesi Gallo; il compianto Enzo D’Angelo, protagonista della pallanuoto mondiale; il presidente della Puteolana anni ‘50 Alfonso Artiaco, divenuto senatore della Repubblica; la mitica Fulgor Puteoli che partecipò alla Seconda Serie Nazionale di basket, etc. (Giorgio Moio). L’importante è non arrendersi di Luciano Di Meglio Allegato al settimanale Il Dispari, settembre 2012. Allegato al settimanale Il Dispari, è stato pubblicato il 13 settembre 2012 l’agile e interessante libro di 32 pagine “L’importante è non arrendersi” dello scrittore Luciano Di Meglio, già noto ai lettori per alcune altre pregevoli pubblicazioni che riguardano pescatori e gente d’Ischia, gli “umili”, veri protagonisti della storia, secondo una visione verghiana della vita. I protagonisti sono Sebastiano Di Meglio e Girolamo Santella, coetanei e pescatori, le cui vite si intrecciano in saldi legami di amicizia e di affetti. Sebastiano Di Meglio è un personaggio realmente esistito, essendo stato il guardiano del faro del porto d’Ischia e che recapitò a Gaeta la bandiera dell’ultimo sovrano del Regno delle Due Sicilie, Francesco I. Il capitano degli ussari, cioè il soldato di cavalleria leggera tipico dell’esercito ungherese e in seguito diffuso in tutti gli Stati europei, è il secondo protagonista del libro. Egli apparteneva a una famiglia aristocratica, era un dongiovanni e restò sempre fedele ai Borboni, e si rivelò tanto modesto da stringere amicizia La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 47 con Sebastiano Di Meglio, appartenente a un ceto sociale tanto inferiore al suo. Intanto tra Sebastiano e Carolina, anch’essa figlia di povera gente, sboccia l’amore, ma nel contempo le vicende belliche, con la discesa al Sud delle truppe garibaldine, ostacolano ogni tipo di rapporto umano ed amoroso. Il testo manifesta una chiara simpatia dell’autore pei i Borboni su cui pesa il giudizio degli storici sentimentali, tra cui quello di un lord inglese, il quale, dopo avere visitato le prigioni borboniche, definì il Regno di Napoli “la negazione di Dio sulla terra”. Eppure nessuno può negare che essi fecero molto per la nostra isola, prima del 1855 pressoché inaccessibile: la costruzione di nuove strade, come la Borbonica, via a mezza costa che da Forio arriva al Maio; l’apertura del porto, che offrì nuovi orizzonti all’economia ischitana e che costituisce ancora oggi l’approdo più importante dell’isola, offrendo sicurezza a qualsiasi natante. Resta accertato che la caduta dei Borboni per Ischia fu una calamità, oltre a determinare per quello che fu uno degli stati più avanzati d’Europa una condizione di emarginazione e di pseudo colonialismo. La sroeia narrata attira e coinvolge emotivamente il lettore fino all’ultima pagina, lasciando nella sua mente un ricordo indelebile dell’opera. Infine, credo che la componente principale del testo sia una lezione di “coerenza”, ossia la fedeltà alle proprie idee, convinzioni, principi, anche se tale modus vivendi costa sempre rinunce e delusioni. Ma «l’importante è non arrendersi», come dimostra lo stimato Luciano Di Meglio. Nicola Luongo Antichi crocefissi lignei dell’isola d’Ischia di Serena Pilato Progetto Culturale della Diocesi di Ischia - Istituto Europeo del Restauro Ischia Un volume sulle pregevoli opere di scultura lignea presenti nell’isola d’Ischia, scritto da Serena Pilato, docente dell’Istituto Europeo del Restauro, Isola d’Ischia, e direttore dell’Ufficio Progetto Culturale della Diocesi d’Ischia. All’interno sintesi delle schede di restauro, oltre che suggestive immagini delle opere presentate. Presentazione di Agostino Di Lustro, che qui pubblichiamo. «I Crocifissi di Gaetano Patalano “Un progetto culturale che parte nel nome del Crocifisso”. Può sembrare un fatto devozionale frutto della spiritualità di certi ambienti pietistici di movimenti di base di sapore ancora medievale e di ispirazione francescana. Si tratta, invece, dell’avvio di un itinerario culturale nel senso pieno della parola che parte dalla teologia per finire alla pietà popolare attraverso la sublime espressione dell’arte, questa volta della scultura in modo particolare. Queste mi sembrano le linee ispiratrici di questa prima fatica della dottoressa Serena Pilato, direttrice dell’Ufficio Progetto Culturale della Diocesi d’Ischia, attraverso la proposta di un filone di ricerca nuovo per la nostra isola considerato che quanto è stato scritto sui Crocifisi presenti sul nostro territorio non supera lo spazio di una paginetta. Gli studi che in questi ultimi tempi 48 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 vengono condotti sui tre Crocifissi più famosi e venerati dell’isola d’Ischia: quello della cattedrale, del santuario del Soccorso e della chiesetta del Cretaio, soprattutto dopo il restauro del primo realizzato dal prof. Teodoro Auricchio dalla dottoressa Pilato, hanno dato un contributo notevole per una più approfondita conoscenza del nostro patrimonio artistico e religioso. Attraverso lo studio del Crocefisso del Cretaio abbiamo assistito al risveglio anche ad Ischia dell’interesse per i fratelli Gaetano e Pietro Patalano per cui possiamo ben dire che la loro patria non li ha dimenticati, anzi è fortemente interessata ad approfondire, eventualmente, qualche altra loro opera esistente e dimenticata in qualche chiesa della nostra Isola. La ricerca sui Patalano in questi ultimi anni sta attraversando un periodo veramente entusiasmante, soprattutto per quanto riguarda la figura e l’opera di Pietro, e ne sta rivelando una personalità artistica di spessore sempre più nell’ambito della storia della scultura lignea devozionale napoletana del primo Settecento. Lo studio attento ed entusiasmante della dott.ssa Pilato sul Crocifisso del Cretaio, posto accanto a quello di Cadice di Gaetano Patalano, è certamente di grande portata scientifica perché ci permette di approfondire l’opera dei due scultori lacchesi ed eventualmente riconoscere altre opere da loro realizzate e ancora conservate nelle nostre chiese. A venti anni dalla pubblicazione del mio saggio sui fratelli Patalano, constato, con somma gioia e un pizzico di soddisfazione, che quel lavoro ha dato i suoi frutti e grandi soddisfazioni forse non tanto a me quanto maggiormente agli studiosi che hanno continuato ad approfondire l’argomento. Nel caso specifico perché è riuscito a spingere una giovane e promettente studiosa dell’Isola d’Ischia ad approfondire l’opera dei due fratelli scultori, dimenticati dalla loro patria per oltre due secoli. I fratelli scultori Patalano per noi diventano sempre più importanti e preziosi per la storia, l’arte e, perché no?, la religiosità di noi Ischitani. Le prospettive per il futuro partono da ottime premesse e l’entusiasmo della giovane studiosa potrà conseguire risultati di notevole valenza scientifica ai quali dobbiamo augurare il massimo e il meritato successo» (Agostino Di Lustro). Nero paradiso di Andrea Esposito Graus Editore, novembre 2012 Anni ’90, ex Jugoslavia, Guerra nei Balcani: Un gruppo di periti dell’Esercito Italiano si ritrova “ad avere un posto in prima fila all’inferno”, dopo essere stato catturato dalle tigri di Arkan. Paesino del Cilento oggi: Billy Montella, giovane imprenditore salernitano, vinto il reality “Playboy”, si ritrova all’apice del successo e della fama. Un moderno “Mangiafuoco” manovra i protagonisti delle due vicende che scorrono davanti agli occhi del lettore, così come nella favola di Collodi, intrecciando i fili e i loro destini. Soltanto il Commissario Senese e i membri dell’UCS – già protagonisti de Il paese nasconde – potranno tagliare i fili e sciogliere la matassa, perché c’è “un momento in ogni indagine nel quale i pezzi iniziano improvvisamente ad andare al loro posto”. (dalla copertina del libro). L’Ischia Film Festival al Nordische Filmtage Lübeck L’Ischia Film Festival è stato tra i partecipanti alla 54esima edizione del Nordische Filmtage di Lubecca in Germania, il più importante appuntamento con la cinematografia dei paesi nordici. Un incontro che si ripete da oltre mezzo secolo in cui gli stati del Nord Europa: Norvegia, Danimarca, Lettonia, Finlandia, Estonia, Islanda, Svezia, propongono i loro ultimi lavori cinematografici ad una platea internazionale. Il direttore dell’IFF Michelangelo Messina ha dichiarato che è molto importante la presenza dell’Ischia Film Festival ad una kermesse come quella di Lübeck, dove si ha l’opportunità di conoscere opere di paesi del nord che raramente abbiamo occasione di vedere in Italia e che grazie a questa sinergia tra festival si potranno diffondere meglio: «Il cinema rappresenta infatti un potente strumento per fotografare l’uomo nel contesto ambientale che lo circonda. Inserire nel nostro festival opere provenienti dai paesi più lontani e diversi tra loro contribuisce a raccontare la diversità culturale e favorire il dialogo e l’integrazione in una società come quella europea che è sempre più interrazziale». L’occasione ha anche permesso di scoprire, presso la casa di Thomas Man e in alcune strade ed un museo circostanti, tutte le location della serie “I Buddenbrook” che presto saranno mappate nel sito web www.cineturismo.it che individua le location dei film più famosi per favorirne la visita da parte degli appassionati cine-viaggiatori. Questa ed altre novità sul settore saranno certamente oggetto del prossimo convegno sul Cineturismo che si svolgerà ad Ischia in seno alla XI edizione dell’Ischia Film Festival dal 29 Giugno al 6 Luglio 2013. Una storia delle isole di Cristoforo D’Ascia Graus Editore, novembre 2012 Un “rompicapo impossibile” atta- naglia le isole e la loro popolazione. Ritenute da sempre un paradiso, perché lì “si era tutti uniti, con forza, perché si era un popolo in mezzo al mare”, si sono trasformate in un inferno, in uno stato di guerra perenne. Grazie al contatto intimo con la natura, Surtsey riesce a trovare una via d’uscita in quel rompicapo. Senza saperlo è un predestinato e il suo nome è stato scelto da un “uomo ricco di speranze e di ideali”; ma deve ricordare che “diventare un’isola non era un diritto divino che gli spettava, ma qualcosa che avrebbe dovuto conquistare lottando faticosamente”. (dalla copertina del libro). Leggete e diffondete La Rassegna d’Ischia Periodico di ricerche e di temi turistici, culturali, politici e sportivi La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 49 Ritorna all’isola d’Ischia il Giro d’Italia 2013 5 maggio 2013 2a tappa Ischia - Forio (cronomero a squadre, 17, 4 km) Ritorna all’isola d’Ischia il Giro d’Italia, dopo l’esperienza del 1959, quando in una cronometro individuale su tutto il circuito stradale dell’isola vinse contro ogni pronostico il siciliano Antonino Catalano. 50 La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 Edizioni La Rassegna d’Ischia Raffaele Castagna - Calcio Ischia - Storia, risultati, classifiche, protagonisti delle squadre isolane negli anni 1957/1980 - Supplemento al n. 1/aprile 1981 de La Rassegna d’Ischia. Giovanni Castagna - Guida grammaticale del dialetto foriano letterario – 1982. Giovanni e Raffaele Castagna - Ischia in bianco e nero - 1983. Giuseppe d’Ascia - Caterina d’Ambra (dramma storico del 1862) - Introduzione e note a cura di Giovanni Castagna - 1986. Giovanni Maltese - Poesie in dialetto foriano: Cerrenne I, II, III; Ncrocchie; Sonetti; Poesie inedite - Ristampa con introduzione, note, commento e versione in italiano a cura di Giovanni Castagna - 1988. Raffaele Castagna - Lacco Ameno e l’isola d’Ischia: gli anni ‘50 e ‘60, Angelo Rizzoli e lo sviluppo turistico (cronache e immagini) - 1990. Vincenzo Cuomo - La storia attraverso i suoi personaggi - Supplemento al n. 1-Febbraio 1991 de La Rassegna d’Ischia (edizione fuori commercio). Francesco De Siano - Brevi e succinte notizie di storia naturale e civile dell’isola d’Ischia (1801) - Ristampa Supplemento de La Rassegna d’Ischia / giugno 1994. Pietro Monti - Tradizioni omeriche nella navigazione mediterranea dei Pithecusani - Supplemento de La Rassegna d’Ischia n. 1/Gennaio 1996. Pietro Monti – Pithekoussai, segnalazione di siti archeologici - Parte I - La Rassegna d’Ischia n. 1/1997. Venanzio Marone - Memoria contenente un breve ragguaglio dell’isola d’Ischia e delle acque minerali (1847) - Ristampa con introduzione di Giovanni Castagna - Supplemento de La Rassegna d’Ischia/giugno 1996. Pasquale Balestriere - Effemeridi pithecusane (Poesie) - Giugno 1994 (edizione fuori commercio). Vincenzo Pascale - Descrizione storico-topografico-fisica delle Isole del regno di Napoli (1796) - Ristampa allegata a La Rassegna d’Ischia, aprile 1999. Vincenzo Mennella - Lacco Ameno, gli anni ‘40 - ‘80 nel contesto politico-amministrativo dell’isola d’Ischia, gennaio 1999 (edizione fuori commercio). Raffaele Castagna - Ischia e il suo poeta Camillo Eucherio de Quintiis, allegato a La Rassegna d’Ischia (edizione ridotta), settembre 1998. Chevalley De Rivaz J. E, - Déscription des eaux minéro-thermales et des étuves de l’île d’Ischia (1837) - Ristampa in versione italiana curata da Nicola Luongo, 1999. Philippe Champault - Phéniciens et Grecs en Italie d’après l’Odyssée (1906) - Ristampa in versione italiana curata da Raffaele Castagna con il titolo L’Odissea, Scheria, Ischia, 1999. AA.VV. - Il Castello d’Ischia: la rocca fulgente - scritti vari ed in particolare: Stanislao Erasmo Mariotti - Il Castello d’Ischia (1915). Raffaele Castagna (a cura di) - Ischia: un’isola nel Mar Tirreno... - Raccolta di articoli vari già pubblicati su La Rassegna d’Ischia (storia - archeologia - folclore....), settembre 2000. Antonio Moraldi - Ferdinando IV a Ischia (1783-1784) - Ristampa (allegato de La Rassegna d’Ischia n. 5 / Settembre 2001). Paolo Buchner - La Villa Reale presso il porto d’Ischia e il protomedico Francesco Buonocore (1689-1768) Ristampa (allegato de La Rassegna d’Ischia n. 5 /Settembre 2001). Assoc. Pro Casamicciola - Sotto il sole di Casamicciola - Raccolta di scritti vari sulla cittadina isolana, a cura dell’Associazione Pro Casamicciola Terme - (Edizione fuori commercio, distribuita ai partecipanti al Premio Ciro Coppola 2001). Camillo Eucherio de Quintiis - Inarime (poema in latino di oltre 8000 versi), pubblicato nel 1727. Versione integrale italiana curata da Raffaele Castagna, gennaio 2003. Rodrigo Iacono, Raffaele Castagna – La Flora dell’isola d’Ischia, la letteratura floristica (stampato in proprio ed edizione fuori commercio. Raffaele Castagna – Isola d’Ischia, tremila voci titoli immagini, gennaio 2006. Giovanni Castagna – La Parrocchia della SS. Annunziata alla Fundera di Lacco Ameno, supplemento allegato a La Rassegna d’Ischia n. 3 del 2007. Raffaele Castagna – Lacco Ameno e l’isola d’Ischia, gli anni ’50 e ’60, Angelo Rizzoli e lo sviluppo turistico (cronache e immagini). Ristampa dell’edizione 1990, dicembre 2010. La Rassegna d’Ischia n. 6/2012 51 Alfonso Di Spigna (1697-1785) - Natività (Confraternita di Visitapoveri di Forio)
Scarica