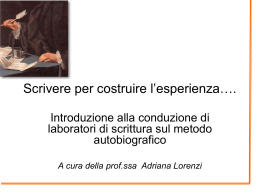Sociologia delle comunicazioni di massa (4 CFU) Prof. Giovannella Greco Comunicazione Media e Educazione 3. Esperienza e senso comune Un fatto della nostra vita ha valore non perché è vero, ma perché ha significato qualcosa. Johann Wolfgang Göethe Esperienza è un termine che si presta ad una grande varietà di usi e significati, a seconda dei contesti in cui si trova inserito. I suoi svariati utilizzi, nel linguaggio comune, indicano in modo generico la conoscenza del mondo ottenuta attraverso il rapporto con le cose e gli altri nella vita quotidiana (1). Utilizzata in riferimento al know-how, esperienza vuol dire aver attraversato una serie di eventi che, accumulati, hanno sviluppato un arricchimento interiore. (1) Jedlowski P., (2005), Un giorno dopo l’altro. La vita quotidiana fra esperienza e routine, Il Mulino, Bologna. In questo senso, ritenendo che la maggior parte dell’esperienza si accumula con l’avanzare del tempo, si tende ad associarla alla maturità o alla vecchiaia o, ancora, alla perizia che si raggiunge attraverso la consuetudine o l’applicazione costante in una determinata tecnica o professione (tanto che si è soliti chiamare “esperto” una persona dotata di una considerevole esperienza in un certo ambito). Ma si può anche associare l’esperienza a ogni singolo atto che ci permette di conoscere un particolare aspetto del mondo o della vita quale, ad esempio, un viaggio, un dolore, un amore. Limitandoci a considerare la storia di questo concetto nell’ambito della cultura moderna, possiamo osservare: • la sua capacità di offrirsi a continue trasformazioni e la sua disponibilità a funzionare come elemento ricorrente di una de-strutturazione dei saperi consolidati (1); • il rapporto che l’esperienza intrattiene con il senso comune (2). (1) Jedlowski P., (1994), Il sapere dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano, p. 70. (2) Ibidem. Nella vita quotidiana, teatro di una «tensione costante» tra ciò che viviamo in prima persona e ciò che tendiamo a routinizzare, esperienza e senso comune sono, infatti, profondamente intrecciati. Il senso comune è tutto ciò che diamo per scontato, ovvero «l’insieme di ciò che ognuno considera ovvio, all’interno di una certa comunità, e in un dato momento della storia» (1). Si tratta di un sapere fondato sui taciti presupposti che sottendono il nostro agire quotidiano, di quella forma di comprensione (e autocomprensione) che crea il substrato d’immagini e significati senza i quali non potremmo interagire e comunicare (2). (1) Jedlowski P., (1994), op. cit., p. 19. (2) Greco G., (1997), Comuncazione Cultura e Rappresentazioni sociali, Rubbettino, Soveria Mannelli. Una conoscenza, dunque, essenzialmente pragmatica che «consiste nel “saper fare” irriflesso che accompagna la nostra vita di tutti i giorni, e nel “saper riconoscere” immediato con cui interpretiamo abitualmente le cose che ci circondano e i comportamenti delle altre persone» (1). Questa forma di conoscenza si configura come una sorta di sapere sociale che ci fornisce le istruzioni per vivere e per comprendere, mediante una costante «sospensione del dubbio» (2) che la realtà possa essere diversa da come ci appare. (1) Jedlowski P., (1994), op. cit., p. 19. (2) Schutz A., (1989), Saggi sociologici, Torino, UTET. Questo «senso» è «comune» perché la struttura della vita sociale è intersoggettiva. Come sostiene Heidegger, vivere è necessariamente con-vivere; i significati sedimentati nel senso comune si sono costituiti, infatti, nel corso di innumerevoli interazioni. «In termini sociologici, ciò significa che ogni comprensione del mondo che un soggetto può mettere in atto è radicata in una struttura di pre-comprensione socialmente data» (1). (1) Jedlowski P., (1994), op. cit., pp. 34-35. Il senso comune è perciò, al tempo stesso, una memoria sociale e una costruzione sociale, il cui elemento determinante consiste nell’atteggiamento che dà il mondo per scontato. Nessuno di noi può prescindere da ciò che è dato per scontato nell’ambiente sociale in cui viviamo né, tanto meno, da quel bagaglio d’istruzioni e interpretazioni che il senso comune ci fornisce. Ma ciascuno di noi sa che la propria esperienza è altra cosa rispetto a ciò che tutti sanno. Il significato originario della parola esperienza, proveniendo dal sostantivo latino experientia, a sua volta derivato da experiens, participio presente del verbo experiri, indica al tempo stesso un «venire da» e «un passare attraverso»: esperienza è, pertanto, sia ciò da cui la persona proviene, sia ciò che la persona attraversa. Comunque sia intesa, essa rimanda al senso di un vissuto e di un sapere «situato e parziale», che appartiene alla persona e la caratterizza nella sua singolarità: «Quello che so io ha un tono particolare: è ciò che sperimento “in prima persona”. Può anche essere “ovvio”, ma, poiché è ciò che io so perché lo vivo io, non è esattamente “quel che sanno tutti”. (…) in entrambi i casi si tratta di un’organizzazione dei vissuti. Ma laddove il senso comune li organizza enfatizzando l’accordo intersoggettivo, sviluppando un atteggiamento che dà per scontato il riconoscimento, e riportando il nuovo ogni volta al già noto, l’esperienza tende a sottolineare la specificità di ciò che il soggetto attraversa, a non dare tutto per scontato, ed è tipicamente aperta al dubbio» (1). (1) P. Jedlowski, (1994), op. cit., pp. 63-64. La radice dell’esperienza sta, infatti, nel dubbio o, per meglio dire, in una domanda di senso che il soggetto pone a se stesso, dunque nell’ascolto della propria presenza nel mondo, nel «prendere atto di ciò che viviamo e farcene responsabili» (1). La complessità di questo concetto sta proprio nel fatto che «esperienza è… sia ciò che si vive (solo in parte consapevolmente), sia il processo attraverso cui il soggetto si appropria del “vissuto” e lo sintetizza» (2): (1) P. Jedlowski, (1994), op. cit., p. 11. (2) Ivi, p. 69. «L’esperienza è ciò che ciascuno vive e conosce, ma è anche il processo attraverso cui il soggetto diviene consapevole di sé. Questa duplicità rende conto del suo carattere paradossale: perché l’esperienza è qualcosa che si fa sempre, e contemporaneamente qualcosa che si può non avere mai» (1). (1) P. Jedlowski, (1994), op. cit., p. 13. Il concetto di esperienza ha una storia piuttosto articolata. Limitandoci a considerare la storia più recente, un primo passaggio epocale può essere individuato nel concetto moderno di «scienza», con il quale intendiamo «il binomio scienza-tecnologia, cioè l’unione inscindibile e necessitata tra funzione conoscitiva e funzione tecnologica della scienza» (1). (1) Greco G., (1995), “Sulla costruzione di un’alternativa in ambito scientificotcnologico”, in D. Barazzetti, C. Leccardi (a cura di), Fare e pensare. Donne, lavoro, tecnologie, Rosenberg & Sellier, Torino, p. 180. Il processo che ha dato vita all’ideale scientifico moderno è il risultato di una visione del mondo in cui si esprime «la continuità di un progetto di dominio sulla natura che, a partire dall’epoca moderna, ha ispirato la corsa alla tecnologia come impresa capace di ri-creare il mondo, dando vita, nel contempo, ad un processo di reciproca legittimazione tra scienza e tecnologia che, dalla modernità in poi, si sono autorappresentate insieme come conoscenza certa e fattualmente utile» (1). (1) Greco G., (1995), op. cit., p. 177. Con l’avvento della scienza moderna, l’esperienza diventa esercizio metodico dell’osservazione, ovvero esperimento, e da questa trasformazione prende forma un nuovo ideale di conoscenza: la conoscenza cui la scienza mira è una conoscenza razionale; in quanto tale, deve essere verificabile intersoggettivamente, «indipendentemente dalle disposizioni soggettive, dai “pregiudizi” e dalle “passioni” di ciascuno, e anche dalle “deformazioni” dovute all’approssimazione dei sensi. Questa conoscenza si fonda sull’“esperienza” nel senso in cui questa sia un esercizio rigorosamente controllato, ripetibile, e, per così dire, depurato da ogni tratto soggettivo» (1). (1) Jedlowski P., (1994), op. cit., p. 71. Dalla nascita della scienza moderna fino a tutta la stagione del positivismo, l’esigenza di privilegiare la dimensione oggettiva della conoscenza comporta una progressiva svalutazione tanto dell’esperienza soggettiva quanto del senso comune, perché il sapere al quale mira la scienza non ammette alcuna vicinanza alla vita concreta delle persone e delle comunità. L’esperienza subisce, così, una metamorfosi e da nozione che rimanda al vissuto soggettivo, alla pratica dei mestieri e alla vita quotidiana, si trasforma in metodo di ricerca, strumento di verifica e capacità di osservazione sistematica. Verso la fine dell’Ottocento, prende avvio in Germania la discussione sul metodo delle scienze storico-sociali, posto come radicalmente differente da quello delle scienze fisiche e naturali. Nel corso di questa discussione, il concetto di esperienza subisce un ulteriore slittamento semantico che sancirà la dissoluzione del modello precedente, la cui crisi, tanto per le scienze fisiche quanto per quelle umane, avviene nel momento in cui alla nozione ingenua di «osservazione» si sovrappone la consapevolezza del ruolo costitutivo del soggetto in ogni operazione conoscitiva: I «fatti» non esistono: esistono percezioni che attribuiscono una forma al reale nel momento stesso in cui apparentemente lo «rispecchiano». Questa consapevolezza muta nuovamente i caratteri dell’esperienza. Perché, se è vero che osservare è conoscere attivamente, allora «fare esperienza» non può significare registrare dei fatti, ma viene a intendere un attivo processo di elaborazione dei dati dei sensi e di organizzazione di forme e di significati. L’esperienza è ora relazione, un rapporto tra il soggetto e l’oggetto, la cui linea di demarcazione reciproca diventa problematica (1). (1) Jedlowski P., (1994), op. cit., pp. 72-73. Il nuovo concetto di esperienza prende forma nel Romanticismo, e più in particolare nell’ambito dell’idealismo tedesco (1), dove esso acquisisce l’idea di un movimento che s’incarna nella metafora del viaggio, di un percorso volto alla realizzazione del sé che si configura come attraversamento di una biografia: «Questa non è più – come poteva essere in seno alle comunità tradizionali – svolgimento di un destino segnato da ruoli immutabili: è un cammino, il cui senso è la formazione dell’individuo in quanto tale» (2). (1) Hegel G.W.F., (1974), Fenomenologia dello spirito, La Nuova Italia, Firenze. (2) Jedlowski P., (1994), op. cit., p. 98. Per usare le parole di Max Weber (1), nel passaggio da un mondo del destino a un mondo della scelta, l’esperienza diventa realizzazione e scoperta del sé, ovvero un percorso che corrisponde alle fasi di un processo di individuazione: «…il riferimento al concetto di individualità è cruciale. Di fatto, il soggetto che le società moderne pongono in essere è “individuo” in un senso sconosciuto alla massa degli uomini e delle donne dei mondi tradizionali. Questo soggetto… è ciò che è capace di realizzare, ed è chiamato a sviluppare, in un modo mai prima inteso, il senso della propria unicità, a dispiegare ciò che ritiene di essere: a farsi» (2). (1) Weber M., (1980), Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino. (2) Jedlowski P., (1994), op. cit., p. 99. Dopo la stagione del Romanticismo, l’esperienza va i frantumi e si trasforma in un oggetto perduto: con il progressivo dissolvimento dei mondi stabili, relativamente chiusi e culturalmente omogenei che accompagna il procedere della modernità, ogni tradizione tende ad eclissarsi, cresce il contatto con persone che provengono da mondi diversi, le relazioni in gran parte anonime e mediate da istituzioni impersonali assumono un carattere per lo più funzionale, sfumano progressivamente i contorni delle appartenenze e le norme a queste connesse. Nel corso del Novecento, prende avvio la formulazione di un nuovo concetto di esperienza, che W. Dilthey (1) ha definito Erlebnis, un termine che allude all’esperienza vissuta e nel cui nome si decreta la distanza delle scienze storico-sociali, che si occupano di produzioni di significato, da quelle fisiche e naturali, il cui oggetto è costituito da fenomeni materiali. Per comprendere appieno il senso e la portata di questo ulteriore cambiamento di significato, si può risalire alla differenza, nella lingua tedesca, tra due termini che, in italiano, si traducono entrambi con la parola «esperienza», ma che alludono a due significati profondamente diversi: (1) Dilthey W., (2004), “‘Erleben’ espressione e comprensione”, in Id., Scritti filosofici (1905-1911), UTET, Torino. Il termine Erlebnis, che deriva dal verbo Erleben, significa «essere in vita (Leben) mentre una cosa accade»; il termine Erfahrung, che proviene dal verbo Erfahren, significa invece «passare attraverso». (…) Se l’Erlebnis è… un vivido esserci, l’Erfahrung è un processo che si dilata nel tempo: un processo in cui la memoria è attiva come facoltà di connettere diversi vissuti in una continuità dotata di senso. Questo processo si realizza in una «maturazione» che può apparire come una dote – o una «qualità» – della persona: chi ha «fatto esperienza» in questo senso ha anche esperienza (1). (1) Jedlowski P., (1994), op. cit., pp. 81-82. È interessante osservare che i due termini, oltre a rimandare a due diverse concezioni di «esperienza», non sono coevi: Erfahrung è un termine più antico di Erlebnis; quest’ultimo risale alla seconda metà dell’Ottocento, quando si afferma anche il termine «modernità». Allo slittamento tra queste due parole corrisponde secondo Walter Benjamin (1) - il venir meno delle condizioni storiche e sociali che rendevano possibile pensare all’esperienza come ad un processo di maturazione nel corso della vita. L’Autore evidenzia, infatti, un «declino dell’esperienza» (nel senso dell’Erfahrung), dovuta al fatto che la sua esistenza era legata alla stabilità di un mondo materiale e simbolico (quello delle comunità tradizionali) che scompare con l’avvento della modernità. (1) Benjamin W., (1962), “Di alcuni motivi in Baudelaire”, in Id., Angelus Novus, Einaudi, Torino. La moltiplicazione degli ambiti di vita e delle sfere di senso fra cui ora si muovono le persone comporta una relatività dei costumi, dei valori, delle spiegazioni del mondo. Ciò che caratterizza la società moderna è, infatti, la complessità, il pluralismo, il mutamento perpetuo. In questo nuovo scenario: l’esperienza non può più essere qualcosa che «si ha», ma soltanto qualcosa che «si fa», senza sosta (1). (1) Jedlowski P., (1994), op. cit., p. 92. Oltre a ciò, la crescente pervasività della tecnologia che, incorporata in oggetti di uso quotidiano, ci esonera da gesti, competenze e sforzi precedentemente richiesti, modifica profondamente le modalità e il significato stesso dell’esperienza, per via della frattura efficacemente descritta da Georg Simmel (1) - tra cultura oggettiva e cultura soggettiva, ovvero della «dissonanza» prodotta dal fatto che le cose diventano sempre più «colte» e le persone sempre meno capaci. (1) Simmel G., (1957), “Wom Wesen der Kultur”, in Id., Bruckee und Tur, Koehler, Stuttgart. Ma l’aspetto cruciale della profonda trasformazione che l’esperienza subisce nella modernità consiste, secondo Simmel, nella sua «introversione» e «intellettualizzazione». I ritmi incalzanti e il surplus di stimoli posti dalla vita moderna esigono lo sviluppo di facoltà mentali più che corporee: in un mondo dominato dalla razionalità tecnica dei suoi apparati è più importante, infatti, essere intelligenti che abili o forti o sensibili. Così, mentre il «sentimento» viene meno e si potenzia unilateralmrente l’«intelletto», l’esperienza tende sempre più ad intellettualizzarsi. L’accorata denuncia del poeta angloamericano T.S. Eliot (1) contro la «dissociazione della sensibilità» che affligge l’uomo moderno costituisce un esempio emblematico della perduta capacità di coniugare intelletto e sentimento. Tale concetto, interpretato come una conseguenza della modernità, allude al tramonto di una collaborazione armonica tra i sensi, alla perdita di quella «sensibilità unificata», tipica delle società premoderne (2). (1) Eliot T.S., (1921-1932), “The Metaphysical Poets”, in Selected Essay 1917-1932, Faber & Faber, London. (2) Greco G., Amor, amor, amor…, (1987), «SE. Scienza Esperienza», 49, pp. 32-33. Oggi l’esperienza è chiamata in causa dalla difficoltà di dare per scontato come si debba vivere. Infatti, quanto più il senso comune diventa instabile, tanto più cresce l’importanza dell’esperienza, chiamata incessantemente a costruire percorsi di senso, stabilità, orientamento. Ma all’indebolirsi dell’unicità e della tenuta del senso comune corrisponde una difficoltà di costruzione dell’esperienza, due fenomeni correlati e generati dal fatto che la vita quotidiana tende sempre più a configurarsi come un caleidoscopio: «Sia nel senso che appare costituita da frammenti difformi e apparentemente slegati; sia in quello per cui la nostra prospettiva può mutare a ogni istante, generando così configurazioni di senso diverse» (1). (1) Jedlowski P., (2005), op. cit., p. 46. L’avvento, lo sviluppo e la crescente pervasività dei media comportano una dilatazione degli eventi, delle immagini, dei suoni, delle informazioni di cui possiamo essere in qualche modo testimoni. Essi costituiscono il nuovo ambiente nel quale viviamo e dal quale prendono forma gran parte delle nostre esperienze cognitivo-emotive e socio-relazionali (1). In questo nuovo contesto, mutano le caratteristiche della vita quotidiana e l’esperienza si fa sempre più mediata. (1) Greco G., (2004), op. cit. Nasce, così, una nuova forma di esperienza che si configura come una esperienza da spettatore, nella quale: «… la presenza del corpo, l’interazione con l’ambiente fisico, il “fare”, sono ridotti ai minimi termini; al contrario, si ampliano i contenuti di ciò che veniamo a sapere, che possiamo immaginare, o al cui suono possiamo “vibrare”. Sapere, immaginare, vibrare emotivamente hanno sempre fatto parte dell’esperienza… ma mai si erano sganciati a questo modo dal fare, dal rischiare – almeno un po’ – in prima persona…» (1). (1) Jedlowski P., (1994), op. cit., pp. 119-120. Assumendo l’esperienza come un processo di apprendimento grazie al quale, interpretando ciò che attraversiamo, impariamo come comportarci, un processo che non ci lascia mai identici a noi stessi, ma ci trasforma, la questione che si pone è se e come possiamo considerare esperienza quella mediata. Secondo Daniele Del Giudice (1), la condizione di spettatore indotta dai media, pur consentendoci di «partecipare» a una quantità di eventi infinitamente maggiore di quella che avremmo potuto vivere nella prima metà del secolo scorso, non può dar luogo ad alcuna esperienza poiché questa «partecipazione» non ci modifica. (1) Del Giudice D., (1992), “Gli oggetti, la letteratura, la memoria”, in A. Borsari (a cura di), L’esperienza delle cose, Marietti, Genova. Secondo Jedlowski, invece, l’essere spettatori non ci lascia immutati poiché i media influenzano l’attuale conformazione del senso comune e la stessa costituzione della nostra esperienza, soprattutto grazie a quel processo di «compressione spazio-temporale» o di «sganciamento» dello spazio dal tempo che consente una simultaneità despazializzata (1), ovvero una inedita forma di esperienza, impensabile prima dell’avvento dei media elettronici. Se in qualsiasi periodo storico precedente lo «stesso tempo» implicava «lo stesso posto», oggi i media consentono di sperimentare come simultanei eventi che accadono in luoghi diversi. (1) Thompson J.B., (1998), Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, Il Mulino, Bologna, 1998). Si tratta di «una parziale de-fisicizzazione dell’esperienza» e, al tempo stesso, di «un emanciparsi del senso comune da legami univoci col territorio»: «Lo spazio a disposizione dei movimenti di ognuno pare dilatato e insieme compresso… le distanze cessano di essere rilevanti, mentre la percezione della simultaneità di eventi diversi provoca la sensazione di vivere tutti a stretto contatto reciproco. Appartenenze e identità possono ridefinirsi sulla base di interessi, valori o immaginari comuni, senza più corrispondere necessariamente a spazi fisici condivisi» (1). (1) Jedlowski P., (2005), op. cit., p. 68-69. Ciò comporta uno sradicamento dal contesto originario di determinati elementi della vita sociale e una loro ricollocazione in contesti diversi, un doppio processo che produce una inevitabile modificazione di quegli elementi e delle loro relazioni con l’insieme: «In queste condizioni, l’esperienza si trasforma in un curioso equilibrio fra sentimenti di presenza e di assenza, fra la percezione di “essere lì” e di “non essere lì”. E ciò ha effetti che concretamente trasformano le persone e i loro orizzonti di azione e di senso. (…) Ma il punto principale, riguardo all’esperienza, è forse questo: che i media permettono una prossimità mediata nei confronti di ciò che percepiamo grazie a loro» (1). (1) Jedlowski P., (2005), op. cit., pp. 144-145. Quest’ultimo concetto si richiama a quello di «intimità non reciproca a distanza», coniato da John B. Thompson per descrivere il tipo di rapporto che intratteniamo con i personaggi dei media, nessuno dei quali abbiamo mai incontrato di persona e che, se ci capitasse d’incontrare, non potrebbe mai riconoscerci, mentre noi sappiamo molto di lui e con lui abbiamo un rapporto speciale, anche se asimmetrico e non reciproco. I personaggi che incontriamo nei media non sono persone in carne ed ossa, così come le situazioni e le emozioni cui partecipiamo non si svolgono in luoghi e contesti in cui siamo fisicamente presenti. (1) Thompson J.B., (1998), op. cit. Ma - come osserva Jedlowski - nei media «incontriamo quanto meno noi stessi. E non è detto che ciò non ci trasformi. In ogni caso, tra la vita e le sue rappresentazioni si stabilisce una circolarità: ciò di cui siamo edotti grazie ai media è reincastonato nella quotidianità tanto quanto la quotidianità lo è nei testi mediali; quello che si instaura è un gioco di citazioni reciproche che non lascia nessuno immutato» (1). (1) Jedlowski P., (2005), op. cit., p.148.
Scaricare