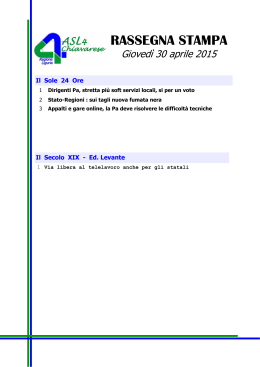RASSEGNA STAMPA venerdì 18 aprile 2014 ESTERI INTERNI LEGALITA’DEMOCRATICA RAZZISMO E IMMIGRAZIONE SOCIETA’ BENI COMUNI/AMBIENTE INFORMAZIONE CULTURA E SCUOLA INTERESSE ASSOCIAZIONE ECONOMIA E LAVORO CORRIERE DELLA SERA LA REPUBBLICA LA STAMPA IL SOLE 24 ORE IL MESSAGGERO IL MANIFESTO L’UNITÀ AVVENIRE IL FATTO REDATTORE SOCIALE PANORAMA L’ESPRESSO VITA LEFT IL SALVAGENTE INTERNAZIONALE L’ARCI SUI MEDIA Da ReggioTv del 17/04/14 Ricordate le vittime innocenti Demetrio Quattrone, ingegnere, e Giuseppe Macheda, vigile urbano A Reggio la carovana antimafia di Libera,Arci e Avviso Pubblico Reggio Calabria - Partita da Roma martedì 8 aprile, la Carovana antimafie giungerà a Reggio Calabria oggi presso la sede della Cooperativa Rom 95 in via Reggio Campi, con un’iniziativa intitolata “Le mani sulla città. Impronte di cittadinanza negata”. La tappa di Reggio Calabria sarà dedicata al tema della corruzione, intesa come ostacolo alla libera esplicazione dei diritti di cittadinanza, focalizzando l’attenzione dei partecipanti sulle ricadute che le dinamiche corruttive hanno sui diritti fondamentali dei cittadini. All’ingegnere Demetrio Quattrone e al vigile urbano Giuseppe Macheda – che proprio per la lotta all’abusivismo e alla corruzione pagarono con la vita – sarà dedicato un importante momento di riflessione. “Per Avviso Pubblico questa tappa reggina rappresenta l’occasione per lanciare una nuova sfida agli amministratori in vista delle prossime elezioni – ha dichiarato Salvatore Mafrici, Sindaco di Condofuri e Vicepresidente di Avviso Pubblico -. Chiederemo loro di fare un passo in più, di sottoscrivere il nostro codice etico-comportamentale, la Carta di Pisa, per far capire da che parte vogliono stare e continuare a rafforzare la barriera contro il dilagare di nuove forme di illegalità, contro la corruzione e l’infiltrazione mafiosa ”. http://www.reggiotv.it/notizie/attualita/36683/reggio-carovana-antimafia-libera-arci-avvisopubblico Altre notizie su Carovana Antimafie ai link http://www.newz.it/2014/04/17/la-mafia-del-cemento-al-centro-della-carovana-antimafia2014-in-memoria-di-quattrone-e-macheda/192583/ http://www.newz.it/2014/04/17/le-mani-sulla-citta-oggi-la-tappa-della-carovana-antimafiededicata-alla-memoria-di-quattrone-e-macheda-partecipera-anche-cafiero-deraho/192520/ 2 ESTERI del 18/04/14, pag. 11 Una road map per Kiev Putin confida nell’Italia A Ginevra deciso il disarmo delle milizie illegali, lo sgombero degli edifici e l’amnistia ● Il presidente russo: «Il semestre italiano ci riavvicinerà alla Ue» Umberto De Giovannangeli Il bastone e la carota. Un palleggio mediatico tra Mosca e Ginevra. Inizia Putin, concludono il duo Lavrov-Kerry. Quel one-man-show non ha tradito le attese. Al centro della scena, mattatore assoluto, c’è lui: «zar Vladimir». Uno spettacolo mediatico destinato al mondo è quello offerto ieri da Putin. Alternando toni minacciosi a declamazioni suadenti, il presidente russo parla dell’uso della forza contro i manifestanti russofoni in Ucraina come di un «grave crimine» «Spero tanto di non dover usare il diritto, concessomi dal Consiglio della Federazione, di impiegare la forza in Ucraina, e che la situazione possa essere risolta con mezzi politico-diplomatici », afferma Putin che si è mostrato fiducioso sulla possibilità di «una soluzione di compromesso» che allevi la tensione. Insomma, bastone e carota. Ma la «carota» funziona. E prende corpo in terra svizzera. Un accordo per «ridurre la tensione» in Ucraina è stato raggiunto al vertice a quattro di Ginevra tra rappresentanti della stessa Kiev, della Russia, degli Stati Uniti e dell’Unione Europea: ad annunciarlo è il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, secondo cui l’intesa prevede tra l’altro lo «scioglimento dei gruppi armati illegali » in tutte le regioni ucraine, la «riconsegna » degli edifici governativi occupati, lo «sgombero» di strade e piazze presidiate e una «amnistia per tutti i manifestanti », tranne per coloro che hanno commesso «gravi reati». Inoltre, ha proseguito Lavrov, dovrà essere avviato un «dialogo nazionale » nel quale siano coinvolti tutti i «gruppi»e tutte le zone del Paese, e spetterà ai «partiti ucraini» attivarsi per superare l’attuale crisi. Un «ruolo-guida di mediazione »andrà infine assegnato all’Osce, l’Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa. DIPLOMAZIA ATTIVA La diplomazia ha battuto un colpo. Importante. L’intesa sull’Ucraina raggiunta a Ginevra rappresenta «il buon lavoro di un giorno» ma le «parole sulla carta» hanno poco significato se non sono seguite dalle azioni da parte di tutti per calmare la situazione sul terreno, rimarca il segretario di Stato americano John Kerry in una conferenza stampa dopo l’incontro di Ginevra con il suo omologo russo, l’Alto rappresentante per la politica estera e la difesa dell’Unione europea, Catherine Ashton e il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Deschytsia. «Abbiamo trovato un accordo Per una immediata missione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa» per stabilizzare la situazione in tutte le aree dell’est del Paese in cui si stanno verificando scontri, puntualizza il segretario di Stato Usa. Ma, avverte Kerry, «ho detto chiaramente a Lavrov che se non vedremo passi in avanti (per normalizzare la situazione, ndr) dovremo imporre nuove sanzioni». «La riunione di Ginevra sulla situazione in Ucraina ha concordato su passi iniziali concreti per ridurre le tensioni e restaurare la sicurezza per tutti i cittadini». Lo afferma il documento concordato tra i ministri degli esteri Usa, Russia, Ue e Ucraina. Nel documento si precisa che «tutte le parti devono astenersi da qualsiasi azione di violenza, intimidazione o provocazione». Poche ore prima della sigla dell’accordo a «quattro», il 3 presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, aveva approvato l’invio di aiuti militari in Ucraina «non letali», cioè elmetti, materassini da campo, sistemi di purificazione d’acqua, tende e medicine da destinare all’esercito di Kiev. Quanto a Putin, il capo del Cremlino punta su Roma. L’Italia, che da luglio sarà alla guida dell’Unione europea, «èunodei nostri partner tradizionali in Europa» e «uno dei nostri partner economico-commerciali più importanti», rimarca il capo del Cremlino. Putin ribadisce l’importanza dei rapporti della Russia con il nostro governo:Mosca«tiene da conto le relazioni » con l’Italia, «anche con il nuovo premier » Matteo Renzi. Sul campo, la tensione non si allenta. Prima dell’annuncio di Ginevra, l’Ucraina aveva deciso di vietare l’ingresso sul suo territorio ai cittadini russi di sesso maschile e di età compresa tra i 16 e i 60 anni. L’annuncio è arrivato dalla compagnia aerea di bandiera russa Aeroflot. «In linea con l’ordine ufficiale ricevuto dalla compagnia, tutti i cittadini maschi russi di età compresa tra i 16 e i 60 anni verranno respinti alla frontiera ucraina», ha comunicato Aeroflot, specificando che verranno fatte eccezioni in casi estremi. Almeno tre persone sono morte e 13 sono rimaste ferite nel corso di nuovi scontri armati tra le forze di polizia ed esercito ucraino e miliziani filorussi scoppiati ieri sera e proseguiti nella notte a Mariupol, nella regione ucraina orientale di Donetsk. A renderlo noto su Facebook è il ministro degli Interni di Kiev, Arsene Avakov. Del 18/04/2014, pag. 1-31 IL CASO L’ANALISI Ucraina l’accordo della speranza “Disarmiamo i ribelli” LUCIO CARACCIOLO A Ginevra intesa Usa-Russia ma Obama è scettico Putin: non voglio usare la forza CIASCUNO faccia un passo indietro, prima di finire tutti insieme nell’abisso. Ecco il senso dell’accordo raggiunto ieri a Ginevra dai capi delle diplomazie russa e americana per evitare in extremis la guerra civile in Ucraina. Presenti anche il primo ministro del governo provvisorio di Kiev, oggetto più che soggetto della mediazione, e la baronessa Ashton, a nome di quei comprimari europei che un mese e mezzo fa avevano patrocinato un accordo fra le fazioni ucraine subito rigettato dai rivoluzionari di Majdan. Andrà meglio stavolta? Ci sono alcune ragioni per sperare e almeno altrettante per dubitare. La speranza sta nel fatto che per la prima volta tutte le parti in causa si proclamano d’accordo per avviare la “de-escalation”. In termini concreti: le milizie separatiste russe o filorusse che hanno occupato edifici pubblici e installazioni militari nell’Est e nel Sud del paese devono sgombrare, venendo automaticamente amnistiate; tutte le milizie devono essere disarmate, incluse quelle allestite dalle formazioni ultranazionaliste ucraine, decisive nella liquidazione del regime di Yanukovich. È NECESSARIO riformare la costituzione per garantire la massima autonomia alle regioni a forte insediamento russo; una missione dell’Osce veglierà sull’avvio del processo di pacificazione e stabilizzazione. Il dubbio deriva dalla volontà e dalla capacità delle forze in campo di realizzare un programma tanto ambizioso in un contesto così volatile. Lo Stato ucraino è in decomposizione. E non solo perché la Russia ha annesso la Crimea e Sebastopoli. Fatto è che il governo di Kiev è troppo debole per affermare la sua autorità anche su quelle 4 vaste aree dell’Ucraina orientale e meridionale a forte insediamento russo, nelle quali la propaganda e le operazioni coperte di Putin si sono rivelate alquanto efficaci. Il tutto sullo sfondo di un paese sull’orlo del collasso economico e finanziario, nel quale tuttavia gli oligarchi continuano a detenere l’influenza determinante, con grande scorno del “popolo di Majdan”. L’intesa di Ginevra aprirà la strada alla pacificazione o sarà ricordato come una nota a piè di pagina nella guerra civile ucraina, esito inevitabile dello scontro attuale se la “de-escalation” non funzionerà? Non bisogna sopravvalutare l’importanza degli attori più o meno esterni — russi e americani, con gli europei di contorno, in ordine sparso. Una volta partita la valanga delle provocazioni e delle reazioni, i “protettori” delle fazioni in conflitto possono poco. Spetterà agli ucraini decidere la sorte del loro paese. Di fatto, nessuno oggi è in grado di disarmare le milizie. Il paese è fra i massimi produttori di armi al mondo e vi circolano almeno quattro milioni di kalashnikov. Nel caos è più facile armarsi che disarmare il prossimo. Questa crisi conferma e accentua la precarietà della repubblica ucraina, sorta nel 1991 grazie al collasso dell’Unione Sovietica. Dalla disintegrazione sono nate, insieme all’Ucraina, diverse repubbliche più o meno precarie, segnate dallo stigma della provvisorietà, pressate dai nazionalismi etnici d’impronta razzista e dal revanscismo grande-russo. Colpisce il fatto che mentre Lavrov e Kerry stavano trattando il documento di Ginevra, Putin enunciasse il progetto di riportare sotto la sfera d’influenza moscovita Kharkiv, Lugansk, Odessa, Donetsk. Per Kiev, purissima Ucraina. Per Mosca, “Nuova Russia”, nella definizione zarista rispolverata dal presidente russo. La strada del compromesso, che sancisca l’unità e la neutralità dell’Ucraina indipendente come ponte fra Europa e Russia, resta lunga. Il tempo per impedire che il convoglio deragli è sempre più breve. Del 18/04/2014, pag. 7 Ucraina: accordo precario a Ginevra Vertice Usa-Russia-Ue-Ucraina. Disarmo dei gruppi armati e evacuazione degli edifici occupati. Dopo ore di negoziato, raggiunta un'intesa di disescalation della tensione. La Ue accetta la proposta di Putin di discutere sulla sicurezza delle forniture di gas Anna Maria Merlo Un accordo sul disarmo dei gruppi armati in Ucraina e l’evacuazione degli edifici occupati nell’est del paese, raggiunto attorno a un tavolo quadrato per quattro interlocutori, all’Hotel Intercontinental di Ginevra, impegnati in un negoziato che è durato molto più del previsto, mentre sul terreno la tensione continua a crescere. Il segretario di stato Usa John Kerry, i ministri degli esteri di Russia e Ucraina, Serguei Lavrov e Andrii Deshshitsa, che si sono incontrati per la prima volta, e l’Alta rappresentante della Ue per la politica estera, Catherine Ashton hanno cercato per ore di trovare una via alla disescalation in Ucraina. “Tutte le parti devono astenersi da azioni violente atti di intimidazione o azioni provocatrici”, dice il testo dell’accordo. La Russia chiede la garanzia che l’Ucraina non entrerà nelle Nato e punta a un “dialogo nazionale” per arrivare ala decentralizzazione. Gli Usa vogliono che la Russia smetta di sostenere i separatisti nell’est dell’Ucraina e ritiri le truppe ammassate alla frontiera. In “assenza di applicazione” dell’accordo di disarmo, Washington “prepara attivamente” nuove sanzioni contro Mosca. Ieri, il Parlamento europeo ha chiesto alla Ue di “rafforzare” le sanzioni mirate contro personalità russe e invitato “a prepararsi” a passare a un livello superiore di sanzioni economiche: Bruxelles, pero’, per il momento 5 dovrebbe soltanto annunciare “nei prossimi” giorni l’aggiunta di qualche nome alla lista delle 33 personalità penalizzate. I 28 paesi dell’Unione europea restano divisi sull’azione nell’immediato futuro e non dovrebbe esserci un vertice straordinario dei capi di stato e di governo della Ue la prossima settimana. A parole, resta la minaccia di sanzioni. François Hollande, da Parigi, invita al “ritorno alla ragione”, ma afferma che se Ginevra fallisce, “bisogna alzare il livello di sanzioni”. La Francia assicura che “la nostra volontà è fare di tutto per arrivare a una disescalation”, sostiene che esiste una “possibilità di dialogo” messa pero’ a rischio da “operazioni che possono portare a un’azione di forza”. Per Parigi, la “soluzione” passa per il “rispetto dell’agenda politica”, cioè dalla tenuta delle elezioni presidenziali in Ucraina, previste il 25 maggio, che Mosca sta cercando di far saltare. “Bisogna che questo voto possa aver luogo nell’insieme del territorio e possano svolgersi in condizioni di trasparenza e di completa libertà”, ha precisato Hollande. La Gran Bretagna è uno dei paesi più intransigenti e preme per il passaggio a un livello di elevato di sanzioni. I paesi baltici manifestano ormai chiaramente la loro irritazione nei confronti delle incertezze e della debolezza europea. La crisi ucraina e la paura della Russia ha spinto ieri la Lituania ad approvare una legge che prevede l’entrata di Vilnius nell’euro nel 2015, per rafforzare i legami con la Ue. La Francia ha annunciato che entro la fine di aprile saranno operativi quattro caccia Rafale, ne quadro della missione Nato di “polizia dei cieli” nei paesi baltici. Putin usa l’arma del gas e minaccia la Ue, che è dipendente dalla Russia su questo fronte. Ieri, il presidente della Commissione, José Manuel Barroso, ha accettato la proposta di Putin di aprire delle discussioni sulla sicurezza delle forniture di gas. Per Barroso, “l’affidabilità della Russia è in gioco”. Barroso, che ha riposto a nome dei 28 paesi Ue a una lettera di Putin inviata solo a 13 paesi dell’Unione (tra cui Germania, Francia e Italia), afferma che “è nostro interesse comune avviare rapidamente queste discussioni, includendo l’Ucraina”. Il commissario Ue all’energia, Günther Oettinger, si è detto “pronto” a incontrare “immediatamente” i responsabili russi e ucraini del settore energetico. La Germania, che importa il 30% del gas dalla Russia, propone di “aumentare la pressione” su Mosca, ma “senza rendere il dialogo impossibile” per trovare una soluzione alla crisi ucraina. L’altra carta giocata dall’occidente è l’isolamento internazionale di Putin. Ieri, il ministro degli esteri giapponese, Fumio Kishida, ha annunciato, ufficialmente “per problemi di agenda”, di dover rimandare a data da definirsi il previsto viaggio a Mosca, dove doveva incontrare il vice-primo ministro, Igor Shuvalov, nell’ambito del comitato bilaterale per il commercio e le questioni economiche. Il Giappone dipende al 10% dalle importazioni di gas russo. del 18/04/14, pag. 10 Algeri, Bouteflika in sedia a rotelle verso la rielezione Scontri ai seggi dopo una campagna elettorale avvelenata: 70 feriti ● Il presidente uscente, colpito da un ictus, corre per il quarto mandato. Non appariva in pubblico da 2 anni ● Timore di brogli Anna Tito Scambi verbali di rara violenza e un candidato invisibile - ovvero il Presidente uscente Abdelaziz Bouteflika, 77 anni di cui 15 a capo dell’Algeria, che, seppure gravemente ammalato, si presenta per un quarto mandato - hanno caratterizzato la campagna 6 elettorale per il primo turno delle elezioni presidenziali svoltesi ieri in Algeria. E anche la giornata elettorale è stata segnata dallo scontro: a Bouira, a sud-est di Algeri, sono scoppiati incidenti all’apertura dei seggi. Gruppi di giovani hanno saccheggiato le urne con l’intento di impedire le operazioni di voto, gli agenti non hanno lesinato i lacrimogeni. Si contano 70 feriti, secondo fonti ufficiali 28 sarebbero poliziotti. Ad Algeri la polizia dispiegata in modo massiccio ha arrestato cinque persone perché scandivano slogan ostili al potere. Un riflesso prevedibile di una campagna elettorale rovente. L’attuale numero uno del Paese ha accusato di «terrorismo » il suo principale avversario Ali Benflis, unico sfidante potenzialmente pericoloso, in grado mettere i bastoni fra le ruote alla sua riconferma. Benflis ha a sua volte denunciato il rischio di brogli, definendo Bouteflika il «partito della frode», per dirla con il quotidiano francofono indipendente El Watan. L’annuncio ufficiale della candidatura di Bouteflika è arrivato in novembre dal Comitato centrale del Fronte di Liberazione nazionale (Fln), il partito che domina la scena politica algerina e che è al governo fin dai primi giorni che seguirono l’indipendenza del 1962. Quando tutto lasciava credere che l’ictus che lo ha colpito nel 2012 avesse posto fine a qualsiasi ipotesi di ricandidatura, l’anziano presidente ha cambiato tutto con un atto d’imperio, così come nel 2008 emendò la Costituzione del 1996 per potersi candidare per la terza volta. Bouteflika si esprime con difficoltà e non compariva in pubblico da due anni: ieri si è presentato ai seggi sulla sedia a rotelle. Forte dell’appoggio - di cui gode da sempre - delle forze armate, dei servizi di sicurezza (Drs) e dell’establishment che gestisce le industrie statali, durante la campagna elettorale ha sguinzagliato i suoi luogotenenti ai quattro angoli del Paese per mobilitare gli elettori. Ma anche domenica scorsa, nel complesso olimpionico di Chéraga, a ovest di Algeri i sostenitori lo hanno atteso invano per il comizio di chiusura della campagna elettorale. E l’entusiasmo elettorale è scemato: presenti all’ultimo appello non i trentamila annunciati, ma un terzo appena, per la stampa francese. Oggi i risultati dello scrutinio. Ma se fino a pochi giorni fa l’esito appariva scontato, da alcuni giorni l’ipotesi di una vittoria di Benflis «non appare più tanto stravagante», come rileva Le Point. Contro ogni aspettativa il sessantanovenne candidato, cha ha promesso un piano di aiuti economici e azioni concrete per risanare il Paese e contrastare la disoccupazione record, nonché la riforma della Costituzione, sembra adesso godere di un ampio sostegno da parte degli elettori. Già segretario del Fnl e capo del governo negli 2000 - 2003, cadde in disgrazia per aver nutrito velleità presidenzialiste contro Bouteflika; nel 2004 uscì umiliato dallo scrutinio con solo il 6% dei voti, mentre il suo avversario ottenne l’85% già nel primo turno. Anche allora Benflis accusò il potere di brogli elettorali, e questa volta ha dispiegato 60.000 osservatori negli altrettanti seggi elettorali allestiti nel Paese, non solo per garantire il corretto svolgimento della votazione, ma anche per poter annunciare le sue cifre prima dei risultati ufficiali. RISCHIO INSTABILITÀ Se a più riprese i partigiani del presidente sono stati insultati e costretti ad annullare un meeting per timore dei disordini, i fedeli del rivale vengono quasi sempre acclamati. Un’eventuale quarta elezione del raìs potrebbe quindi avere dimensioni assai più contenute che nel 2008. Nel mirino del governo non soltanto Benflis accusato di terrorismo, ma anche i movimenti dei cittadini, quale Barakat (Basta!), costituitosi di recente, i fautori dell’astensione - quasi tutti giovani che costituiscono l’80% della popolazione - quanti manifestano contro un quarto mandato: non sono considerati oppositori, ma «nemici da abbattere», «spie al servizio delle potenze straniere» denuncia El Watan. Anche se la classe politica attualmente al potere non si dimostra in grado di stilare un programma politico a misura dei bisogni reali del Paese e in particolare di mettere fine alla 7 corruzione dilagante, un’eventuale uscita di scena dell’anziano presidente potrebbe dare il via a violenze e di scontri che vedrebbero contrapposte le numerose anime della realtà tribale algerina. «Non importa se il Presidente non c’è, il suo cervello funziona ancora commentavano domenica i sostenitori, aggiungendo - non vogliamo che il nostro Paese diventi come la Libia, l’Egitto, la Siria… lui ha riportato la pace». Già, la pace: Bouteflika infatti appare ancora oggi come il paladino della riconciliazione nazionale, dopo la guerra civile che negli anni 90 che vide opporsi fra loro laici e islamici causando oltre centomila morti. Il politico che proveniva dalle forze armate emerse come fattore chiave per la stabilità dell’Algeria, e pervenne in parte a risollevare l’economia attraverso due piani quinquennali. Del 18/04/2014, pag. 6 Unasur, conclusi i primi accordi di pace tra governo e opposizione Venezuela. Intesa sull’istituzione di una «Commissione per la verità» che faccia luce sui fatti violenti delle proteste Geraldina Colotti In Venezuela, la Unasur ha concluso i primi accordi di pace tra governo e opposizione. Lo ha comunicato il ministro degli Esteri ecuadoriano Ricardo Patiño, rappresentante della missione regionale, al termine del secondo incontro fra le parti. «Non credevo che in sole tre ore fosse possibile avanzare in modo tanto significativo nei dialoghi di pace. Gloria al bravo pueblo», ha scritto Patiño in twitter riprendendo la prima frase dell’inno nazionale venezuelano («Gloria al bravo pueblo che el yugo lanzó…»). I rappresentanti di Unasur (per l’occasione Brasile, Colombia e Ecuador) hanno viaggiato una prima volta in Venezuela il 25 e il 27 marzo scorso e si sono incontrati con diversi settori sociali: governo, opposizione, studenti, autorità economiche ed ecclesiastiche (il Vaticano è a sua volta mediatore nel conflitto). Il primo punto di coincidenza tra le parti si è ottenuto nella «condanna reciproca della violenza e nell’impegno a rispettare la costituzione» come base per i prossimi accordi. Una sconfessione, di fatto, di quelle parti oltranziste dell’opposizione che chiedono “la salida”, la rinuncia a furor di piazza del presidente Nicolas Maduro. Per rimuovere un capo di stato o altri rappresentanti eletti democraticamente, esiste la possibilità di raccogliere le firme e convocare un referendum, a metà mandato. E questo, nel caso di Maduro, eletto un anno fa fino al 2019, è possibile farlo nel 2016. Nel frattempo, nel 2015 si svolgeranno le elezioni parlamentari. Un altro accordo è stato raggiunto per la messa in campo di una Commissione per la verità che faccia luce sui fatti violenti verificatasi durante le proteste contro il governo, iniziate a San Cristobal (capitale dello stato Tachira) il 4 febbraio e culminate nella manifestazione del 12 a Caracas. Da allora, ci sono stati 41 morti e 674 feriti. Circa 2.000 persone sono state arrestate, e in carcere ne rimangono 175. Il governo ha messo sotto inchiesta 97 esponenti della Forza armata e della polizia, denunciati dai manifestanti per “maltrattamenti e tortura”: ma sono solo “una piccola parte dei quasi 100.000 militari che stanno difendendo il governo da un tentativo di golpe”, ha detto il generale Vladimir Padrino, capo del Comando strategico operativo. Si è trovato un accordo anche sulle nomine di nuovi rappresentanti dei poteri pubblici, dal Consejo nacional electoral (Cne), al Tribunal supremo de justicia (Tsj), al Contraloria general, le cui massime cariche sono da rinnovare. L’opposizione cerca, anche per questa 8 via, di garantirsi più spazio di potere chiedendo la presenza di figure “neutrali”: cosa assai improbabile in un paese altamente politicizzato come il Venezuela. E vale ricordare che, durante le contestazioni del voto, seguite all’elezione di Maduro il 14 aprile del 2013, l’unico a prendere posizione pubblica, dichiaratamente a favore di Capriles, è stato uno dei rettori del Cne, Vincente Diaz. La presidente, Tibisay Lucena (la cui casa è stata attaccata dagli oltranzisti nelle violenze post-elettorali), si è limitata a comunicare i risultati del lavoro, avallati da tutti gli osservatori internazionali. La Costituzione venezuelana stabilisce che tre dei cinque componenti il Cne provengano dalla società civile, gli altri sono nominati dal parlamento, in cui il chavismo ha la maggioranza. L’opposizione ha chiesto un’amnistia generale per tutti gli arrestati, il rientro dei ricercati, che definisce “esuli”, e il “disarmo dei collettivi” che appoggiano il governo. Luiz Alberto Figuereido, ministro degli Esteri brasiliano, della missione Unasur, ha spiegato: “Parlare di amnistia è prematuro, ma c’è la volontà del governo a esaminare le detenzioni caso per caso, ed entrambe le parti concordano che chi abbia causato morti, commesso delitti, resti in carcere”. In questo quadro, si è deciso di affidare a una equipe di medici il compito di stabilire le condizioni di salute di Ivan Simonovis. L’ex commissario era segretario alla Sicurezza cittadina dell’Alcaldia metropolitana di Caracas nell’aprile del 2002, durante il colpo di stato contro Hugo Chavez. E’ stato condannato per delitti di lesa umanità per le sue responsabilità nel massacro di Puente Llaguno, in cui diversi cittadini di opposte fazioni caddero per gli spari di cecchini appostati negli edifici vicini al palazzo Miraflores, sede del governo. Si ascolteranno però anche le vittime delle azioni violente perpetrate durante il golpe del 2002. I rappresentanti del governo hanno anche chiesto al cartello di opposizione (La Mesa de la unidad democratica – Mud -) di integrarsi alla Conferenza nazionale per la pace in tema di economia, a cui Unasur assisterà con i suoi ambasciatori e non con i ministri degli Esteri. Una iniziativa lanciata da Maduro unilateralmente, prima che scoppiassero le violenze di piazza. L’esecutivo ha inoltre approvato 148 progetti speciali a 74 organismi politici e amministrativi dell’opposizione, a cui verrà destinato un milione di bolivar. Accordi che si tratterà di verificare in concreto. La Mud è un carrozzone difficilmente rappresentabile al completo. I settori più oltranzisti non hanno accettato il dialogo e continuano a chiedere «la salida», di Maduro e mantengono in piedi le proteste nei settori benestanti del paese. Tra questi, il partitoVoluntad Popular. Il loro leader, Leopoldo Lopez, è in carcere dal 18 febbraio con l’accusa di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. In galera anche alcuni sindaci del suo partito, destituiti dall’incarico (alle elezioni indette per maggio si candidano le loro mogli). Della loro liberazione non si è parlato nei colloqui. Nella Mud è in atto uno scontro per il potere che alcuni, come Lopez e Maria Corina Machado tentano di giocarsi cavalcando tendenze golpiste vecchie e nuove e violenze di piazza. Gli altri – i partiti tradizionali della IV repubblica – vogliono riprendersi il campo secondo vecchie logiche consociative. Henrique Capriles, candidato perdente contro Chavez e Maduro, tenta di rimanere in sella, smarcandosi dal suo antico sodale Lopez. Assenti anche gli studenti «guarimberos»: non ci sono le condizioni, hanno detto. Intanto, il fil di ferro teso sulle strade di Caracas dalle “guarimbas” (blocchi stradali di detriti e spazzatura data alle fiamme) ha quasi sgozzato un altro pony express (diverse persone sono morte così). E nella parte est della capitale sono stati accoltellati i figli di un personaggio caratteristico del chavismo, una signora anziana onnipresente, soprannominata “cappuccetto rosso”. Assente dai colloqui soprattutto Maria Corina Machado, principale animatrice delle proteste. La deputata di estrema destra è stata destituita per aver accettato di sostituire il Panama all’Organizzazione degli stati americani (Osa) a cui voleva chiedere l’intervento nel suo paese. Ha continuato però a girare, aizzando le destre: in Perù (su invito dello scrittore Vargas Llosa), al parlamento brasiliano, e anche a quello Europeo. A Strasburgo ha 9 dipinto un paese strozzato da una feroce dittatura. Il livello e la complessità della partita in corso in Venezuela si può intendere dal commento del partito social-cristiano Copei all’annuncio di Maduro su una prossima riforma tributaria: “Chi più ha, più deve pagare”, ha detto il presidente. Ma il Copei, di certo poco incline a difendere gli interessi delle classi popolari, questa volta ha accusato il governo di voler attingere “al portafogli già vuoto” degli operai. Del 18/04/2014, pag. 6 Sull’uranio l’Iran rispetta i patti Rapporto confidenziale. L'Agenzia Atomica internazionale conferma lo stop parziale all’arricchimento. MA Washington attacca gli accordi commerciali tra Tehran e Mosca Giuseppe Acconcia L’Agenzia internazionale per l’Energia atomica (Aiea) ha confermato lo stop parziale dell’arricchimento dell’uranio da parte di Tehran. Secondo un report confidenziale dell’Aiea, che sarà reso noto integralmente la prossima settimana, l’Iran ha abbassato del 50% il suo livello di arricchimento dell’uranio a partire dal 20 gennaio scorso. In quella data è entrato in vigore l’accordo sul programma nucleare, siglato a Ginevra il 24 novembre 2013, e che permette all’Iran di arricchire l’uranio al 5% per la produzione di energia atomica a scopo civile. La possibile intesa ha prodotto già primi segnali positivi per le esportazioni iraniane di greggio. Secondo l’Agenzia internazionale per l’Energia, che raggruppa i principali paesi importatori di petrolio, l’Iran ha esportato 1,65 milioni di barili di petrolio al giorno, nel febbraio scorso, il livello più alto degli ultimi 20 mesi. Fino al prossimo 20 luglio, quando dovrebbe essere siglato l’accordo definitivo tra Iran e P5+1 (paesi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e Germania), l’Aiea proseguirà un’intensa attività ispettiva nelle centrali nucleari iraniane, come stabilito nei round negoziali di Vienna. L’ultimo incontro si è chiuso lo scorso 9 aprile nella capitale austriaca, dopo una fase di gelo tra Mosca e i paesi coinvolti nei negoziati, a causa della crisi in Ucraina. Secondo gli Stati uniti, Russia e Iran stanno negoziando un accordo per petrolio in cambio di beni del valore di 20 miliardi di dollari, che potrebbe mettere a repentaglio il buon esito dei colloqui. Non solo, Tehran e Mosca hanno sottoscritto un contratto che impegna la Russia a costruire quattro nuove centrali nucleari in Iran. Il mese scorso, Asghar Zarean, dirigente dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica, aveva annunciato l’imminente avvio della costruzione della seconda parte dell’impianto nucleare di Bushehr. Nel progetto è coinvolta la russa Rosatom. La guida suprema Ali Khamenei, scettico rispetto al raggiungimento di un accordo finale che metta fine alle sanzioni internazionali contro Tehran, aveva assicurato, per contenere il malcontento dei radicali iraniani, che mai il paese avrebbe rinunciato al suo programma nucleare. Il capo dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica, Ali Akbar Salehi aveva assicurato solo pochi giorni fa che l’Iran ha bisogno di altre 30 mila centrifughe per l’arricchimento dell’uranio necessario ad alimentare la centrale nucleare di Bushehr. «Se vogliamo utilizzare il sito di arricchimento di Natanz per produrre ogni anno il combustibile destinato alla centrale di Bushehr dobbiamo costruire 30 mila centrifughe di nuova generazione», aveva detto Salehi. L’Iran dispone di circa 19 mila centrifughe di prima generazione (di cui quasi 10 mila in funzione) e di mille macchinari di seconda (IR-2m). 10 Ma a rendere sempre estremamente fragile l’intesa tra Tehran e comunità internazionale è il caso Hamid Aboulatebi. Gli Stati uniti hanno rifiutato di concedere il visto al diplomatico iraniano, ex ambasciatore in Italia, Australia e Belgio, per la sua partecipazione nel rapimento di 52 cittadini americani per 444 giorni nella sede diplomatica statunitense a Tehran, nel 1979. L’Iran ha presentato una contestazione ufficiale alle Nazioni unite in seguito alla decisione del Senato Usa di non concedere né gradimento né visto ad Aboulatebi. Il vice rappresentante di Tehran all’Onu, Hossein Dehghani ha assicurato che gli Usa hanno violato i loro obblighi legali. «La decisione potrebbe creare un pericoloso precedente e influire negativamente sul lavoro degli organismi internazionali», ha dichiarato Deghani. Secondo i diplomatici iraniani, Aboulatebi avrebbe agito per favorire il rilascio degli ostaggi come traduttore e non come parte del commando che fece irruzione nell’ambasciata Usa. Infine, dure sono state le reazioni dei politici iraniani in seguito alle critiche del parlamento europeo alle violazioni dei diritti umani in Iran. 250 deputati hanno condannato la risoluzione, mentre un gruppo di paramilitari ha protestato alle porte dell’ambasciata greca a Tehran. Del 18/04/2014, pag. 6 Minurso, l’unica missione Onu che non tutela i civili Sahara Occidentale. A breve il Consiglio di sicurezza sarà chiamato a decidere sul futuro delle Nazioni unite nel dramma del popolo sahrawi. Uno stallo che dura da oltre 22 anni Vittorio Bonanni Sembra quasi l’emblema di un mondo ormai incapace di risolvere quei conflitti decennali che vedono da un lato poteri troppo forti da mettere in discussione e dall’altro popolazioni da tempo private di ogni diritto. Parliamo del popolo sahrawi, del Fronte Polisario che lo rappresenta, del Marocco che occupa i suoi territori e della Missione delle Nazioni unite nel Sahara occidentale (Minurso), installata nel 1991 col fine di organizzare un referendum che stabilisse una volta per tutte il destino di quella terra e di chi ci abita. Sono passati oltre ventidue anni da quella decisione e la Minurso, sul cui mandato dovrà decidere entro il prossimo 30 aprile il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, non ha organizzato alcun referendum, limitata nel suo agire dal boicottaggio del Marocco e dall’indifferenza del Palazzo di Vetro. Un miliardo di dollari, questo il suo costo, gettati letteralmente al vento, se consideriamo inoltre che questa è l’unica missione di pace dell’Onu in corso priva del mandato di proteggere i civili. Malgrado queste premesse dovrebbero spingere le Nazioni unite a dare più forza alla propria missione di pace, estendendo per esempio il suo impegno alla tutela dei diritti umani, e superando in questo l’opposizione della Francia che ritiene il Marocco capace di vigilare da solo su questo punto, la recentissima relazione del segretario Ban Ki-moon si caratterizza per la presa d’atto di una situazione drammatica, alla quale non corrisponde però nessuna proposta concreta e nessun passo avanti. Si fa cenno della richiesta di estendere il mandato della missione sul tema citato ma non la si fa propria. Senza dimenticare il disincanto che trapela dalle pagine del rapporto realizzato con il contributo fondamentale del diplomatico americano Christopher Ross. Atteggiamento che ha infastidito sia la maggioranza dei sahrawi che spera ancora in una indipendenza dal Marocco, ma anche coloro che hanno rite11 nuto opportuno accettare come alternativa una autonomia regionale, preferibile evidentemente a un immobilismo che favorisce solo Rabat e i suoi alleati. Con queste premesse, la già citata estensione del mandato della Minurso alla tutela dei diritti umani, sulla quale come dicevamo si dovrà esprimere il Consiglio di sicurezza entro il mese, resterà verosimilmente lettera morta. Peccato che le proteste che i sahrawi organizzano a Laayoune, capitale del Sahara Occidentale, e negli altri centri della regione ogni 15 del mese, vengano, come è successo anche pochi giorni fa, puntualmente represse con estrema brutalità e con conseguenze giudiziarie molto gravi nei confronti di chi è perseguitato dalla polizia e dall’esercito marocchino, dimostrando ancora una volta la necessità di vigilare su questo punto. «Il Marocco non vuole nessuna soluzione — ha denunciato Fatima Mafud, vice-presidente del Fronte polisario in Italia – non vuole organizzare alcun referendum e vuole continuare a tenere 160mila soldati lungo il muro del Sahara Occidentale relegando fuori dai confini i nostri profughi». Sul fronte della repressione parlano chiaro anche le denunce di Amnesty International e di osservatrici come l’avvocata Francesca Doria più volte testimone oculare di episodi di ritorsione contro chi, tra i sahrawi, si azzardasse a parlare con stranieri recatisi in Marocco per denunciare quello che succede. Lo scorso anno 23 militanti sahrawi sono stati condannati chi all’ergastolo, 9 per l’esattezza, chi a pene variabili tra i 20 e i 30 anni, per gli scontri che si erano verificati l’8 novembre del 2010 quando le forze di sicurezza marocchine smantellarono il campo di protesta di Gdim Izik. Il bilancio fu di 11 membri delle forze di sicurezza e 2 sahrawi uccisi e di centinaia di arresti. Quel campo era stato realizzato per chiedere diritti, lavoro e alloggi adeguati e ospitava 20.000 persone. A questo dobbiamo aggiungere l’impunità per i crimini commessi dalle forze marocchine contro donne, uomini e bambini sahrawi nei decenni passati, quando centinaia di persone scomparirono e i cui resti ogni tanto vengono ritrovati in campagna. Il tutto senza che quegli organismi per i diritti umani dei quali la Francia si fida si muovano per individuare i responsabili. Vale la pena ricordare che la Repubblica democratica araba Sahrawi è stata fondata nel 1976 e riconosciuta da circa 80 paesi, in maggioranza africani e latino-americani. L’Europa, pur manifestando a parole buone intenzioni, non si è mai spinta a riconoscere la Rasd. 12 INTERNI del 18/04/14, pag. 7 Il caso Bruti-Robledo apre la campagna per il Csm L’inchiesta sullo scontro tra il procuratore e l’aggiunto di Milano sarà sdoppiata ● La I Commissione valuterà l’assegnazione dei fascicoli. La VII sull’eventuale incompatibilità Claudia Fusani L’esplosione sarà ritardata. E rischia di condizionare in maniera pesante la campagna elettorale per l’elezione del prossimo Csm prevista nella prima settimana di luglio. L’affaire Robledo versus Bruti Liberati, due toghe doc che hanno firmato indagini che hanno segnato la storia degli ultimi vent’anni del Paese, è una brutta storia che forse era il caso di risolvere in fretta e chiuderla lì. Tenerla in piedi, addirittura raddoppiarla come ha deciso ieri il Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, ha invece l’effetto neppure troppo nascosto di farne oggetto di regolamento di conti tra due delle correnti storiche dalla magistratura: quella di sinistra, Area, che raccoglie Magistratura democratica e Verdi; quella di centrodestra, Magistratura indipendente, che anche le primarie per la selezione dei candidati togati hanno dato in forte crescita. Non è certo per questo, per fini diciamo cosi - politici, che è cominciata la guerra tra Alfredo Robledo e Edmondo Bruti Liberati. Il primo è uno dei sette procuratori aggiunti della procura di Milano nonché - per dirne una - il pubblico ministero che per primo nel 2006 tirò il filo rosso delle società off shore della Fininvest e puntò il dito contro l’avvocato inglese David Mills. Più di recente Robledo, 64 anni, coordinatore del pool di magistrati contro la pubblica amministrazione e legato alla corrente di Magistratura indipendente, ha firmato le inchieste sulla Lega Nord e su Formigoni. Edmondo Bruti Liberati guida da quattro anni la procura di Milano ed è da anni mente pensante nonché leader di Magistratura democratica. Il 17 marzo il Corriere della sera rivela che tra i due è in atto uno scontro di vertice senza precedenti sia per la qualità dei protagonisti che per la tipologia delle accuse. Robledo infatti ha presentato tre esposti (titolo assai evocativo: «Fatti non foste per vivere come Bruti») al Csm, alla sua diramazione distrettuale milanese e al capo della procura generale di Milano Manlio Minale con accuse feroci. Nell’esposto si parla di «non più episodici comportamenti» con i quali il procuratore Bruti «ha turbato e turba » la normale conduzione dell’ufficio svuotando il pool di reati contro la pubblica amministrazione guidato da Robledo e privilegiando l’assegnazione dei fascicoli più delicati (il processo Ruby a Silvio Berlusconi per concussione; l’indagine su San Raffaele- Formigoni per corruzione e il fascicolo sulla turbativa d’asta Sea-Gamberale) agli aggiunti Ilda Boccassini (capo dell’antimafia) e Francesco Greco (pool reati finanziari). «Alcune scelte fatte da Bruti sono in contrasto con l’obbligatorietà dell’azione penale», ha scritto Robledo nell’esposto. Una bomba, appunto. Anche perché, tre giorni dopo, lo stesso Bruti ha ammesso che in effetti ci fu un ritardo nell’assegnazione del fascicolo su Vito Gamberale per turbativa d’asta: da inizio dicembre 2011 a metà marzo 2012. «Per una mia esclusiva deplorevole dimenticanza », ha ammesso il procuratore. Tra imbarazzi e silenzi, il Consiglio superiore della magistratura ha subito avviato un’indagine. All’inizio di questa settimana la Prima Commissione presieduta dal laico di centrodestra Annibale Marini ha sentito il procuratore generale Minale (che ha minimizzato: «Tra i due c’è un rapporto compromesso da reciproci pregiudizi ma non c’è mai stato alcun ostacolo alle indagini») e poi Bruti e Robledo. Il 13 quale ha rincarato la dose raccontando che quattro anni fa, quando palazzo dei Marescialli lo ha nominato aggiunto, Bruti gli rinfacciò di essere stato eletto con un voto di scarto. Voto che era arrivato da Magistratura democratica e che, se solo Bruti avesse voluto, non sarebbe mai stato espresso. Non solo: secondo Robledo «ci sono state tensioni anche nell’inchiesta Podestà», l’ex presidente della Provincia di Milano, membro del Pdl, al centro dell’inchiesta sulle firme false per le regionali del 2010. L’INDAGINE SI SDOPPIA Ieri la Prima commissione che si occupa di eventuali incompatibilità doveva decidere fra tre opzioni: un supplemento di istruttoria; archiviazione; trasferimento d’ufficio per incompatibilità funzionale. Tra le toghe, proprio per l’avvicinarsi del rinnovo della consigliatura, l’auspicio era la risoluzione del conflitto per mancanza di presupposti. Ma non è andata così. L’indagine è stata sdoppiata: la VII commissione dovrà accertare se alla procura di Milano - come sostiene Robledo nel suo esposto - sono state violate le regole nell’assegnazione dei fascicoli. Tra l’altro, nella stessa Commissione, ci sono pratiche analoghe (esposto di Formigoni e un altro contro il pool antimafia guidato da Boccassini). La Prima, dovrà accertare se di fronte allo scontro in atto, si siano determinati i presupposti che richiedono il ricorso allo strumento del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale o funzionale. È quasi escluso che gli accertamenti possano essere conclusi da questo Csm che scade a fine giugno, e nei fatti tra feste, ponti e settimane bianche (quelle di pausa in cui si studiano i fascicoli) ha davanti a sé poco più di un mese di attività. Che poi è anche il mese della campagna elettorale. A luglio, tra l’altro, scade anche l’incarico di Bruti alla guida della procura. Può essere confermato per altri quattro anni. Anzi, questa è la convinzione. Ecco che la bomba innescata può essere usata da chi vuol condizionare la campagna elettorale nella battaglia, neppure troppo segreta, tra Magistratura indipendente e Area. Ma può anche essere usata per farla pesare nella valutazione che il prossimo Csm dovrà fare sulla conferma di Bruti alla guida della procura di Milano. Che nel manuale Cencelli della giustizia pesa tanto quanto quella della Capitale. Del 18/04/2014, pag. 17 Le aveva ricevute dall’ex prefetto trovate durante una perquisizione Il riesame: deve rimanere in carcere Caserta, la Reggia era di Cosentino “Le chiavi in tasca per fare jogging” DARIO DEL PORTO NAPOLI. Alla Reggia di Caserta Nicola Cosentino si muoveva come a casa sua. Poteva andare a correre nel parco senza preoccuparsi di guardare l’orologio perché, del monumento Vanvitelliano famoso in tutto il mondo, aveva addirittura le chiavi, gentile omaggio del prefetto. Le hanno trovate i carabinieri durante la perquisizione del 3 aprile, giorno dell’arresto dell’ex coordinatore del Pdl indagato per estorsione nell’inchiesta sulle presunte pressioni denunciate da un imprenditore dei carburanti concorrente delle aziende di famiglia. La busta era sulla scrivania dell’ufficio, all’interno di un portaoggetti. Mittente, “il prefetto di Caserta”. Destinatario, “Illustrissimo onorevole dottor Nicola Cosentino, sottosegretario di Stato Economia e Finanze”. All’interno, tre chiavi, ciascuna con un’etichetta: “Cancello lato Reggia”, “Lucchetto cancello alloggio” e “chiave cancello garage”. Nella busta c’era anche un biglietto intestato al prefetto Ezio Monaco (estraneo 14 all’indagine), che è stato a Caserta dal 2008 al 2012. In calce, la scritta “Affettuosamente, Ezio”. I carabinieri avevano ipotizzato che le chiavi servissero per accedere ai locali della prefettura. All’udienza di Riesame celebrata mercoledì, la difesa ha replicato spiegando che le chiavi erano state date a Cosentino per evitare che l’allora sottosegretario restasse chiuso all’interno dell’edificio quando si attardava a correre nel parco. Ieri il Riesame ha confermato l’ordinanza chiesta dai pm Antonello Ardituro, Francesco Curcio e Fabrizio Vanorio. Cosentino dunque resta in cella, mentre le indagini vanno avanti. Secondo gli inquirenti Cosentino è ancora potente e continua «a tessere le trame della politica regionale». La Procura ha depositato altra documentazione raccolta dai carabinieri di Caserta diretti dal colonnello Giancarlo Scafuri. Durante la perquisizione è stata rinvenuta, oltre ad appunti di persone verosimilmente in cerca di raccomandazioni, una lettera manoscritta attribuita al sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio (non indagato) che si riferisce a vicende politiche e si chiude così: «Sono tuo amico, mi hai fatto diventare sindaco, sono legato a te. Sarò sempre un tuo riferimento». Depositate anche nuove intercettazioni. Il 30 gennaio Cosentino parla con Denis Verdini, il colloquio però è interamente omissato. A febbraio contatta l’assessore regionale forzista alle Attività Produttive Fulvio Martusciello. Secondo gli inquirenti, Cosentino si muove per sbloccare la pratica, che stava a cuore al fratello Giovanni, sul collaudo di un distributore di metano e gpl. L’assessore (che, come Verdini, non è indagato) nega però questa ricostruzione. Intanto gli avvocati di Cosentino, Stefano Montone e Agostino De Caro, preparano ricorso in Cassazione. E affermano: «Rimaniamo convinti della estrema fumosità del quadro indiziario. La nostra perplessità aumenta sul fronte della valutazione cautelare: si manda in carcere nel 2014 per fatti del 2000. Non solo: i giudici — grazie proprio ai tabulati acquisiti dalla procura — avevano la prova provata che gli arresti domiciliari fossero adeguati visto che Cosentino non ha avuto alcun contatto con alcuno durante gli arresti domiciliari. Appronteremo ogni misura difensiva per consentire ai magistrati incaricati delle indagini, nei quali abbiamo fiducia, di verificare e correggere essi stessi rapidamente l’errore nel quale — con la complicità del pregiudizio — sono incorsi». Del 18/04/2014, pag. 30 I PARTITI AL LIBERO MERCATO DELLE SCELTE INDIVIDUALI NADIA URBINATI HA DETTO Matteo Renzi al festival del volontariato di Lucca che “tutti i partiti politici e tutti i sindacati che accedono ai contributi pubblici devono avere gli stessi standard di comunicazione dei dati”. Ottima proposta. Ma sarebbe desiderabile che includesse anche il riferimento ai contributi privati: trattandosi di associazioni che contribuiscono alla vita delle istituzioni, nessun contributo dovrebbe restare non rivelato. La riforma della politica passa anche di qui. E l’inchiesta di Repubblica sui finanziamenti privati ai partiti politici dal 1992 ad oggi (pubblicata il 2 aprile) ne è una prova ulteriore. L’intensità e la recidività del malaffare ha prodotto un’opinione ostile al finanziamento pubblico, nella convinzione che lasciare ai privati il mercato dell’opinione politica sia meno esoso. L’inchiesta di Repubblica mostra come i soldi seguano le fortune elettorali dei partiti facendo sorgere il sospetto che leader e governi non siano indifferenti ai desideri dei donatori, i quali ovviamente non danno soldi solo per scopi assistenziali. 15 È ovvio che la politica nelle democrazie abbia bisogno di soldi perché inclusiva di tutti, anche di chi soldi non ne ha. Ha per questo bisogno di regole che ci tutelino dagli effetti che la necessità del denaro può produrre: la corruzione. Benché le leggi non riescano a cambiare la natura umana, possono essere dispositivi di deterrenza capaci di neutralizzare i piani di corruzione. Sono due le forme di corruzione delle quali preoccuparsi: l’uso improprio di risorse pubbliche e la violazione dell’eguaglianza politica di cittadinanza, ovvero l’uso di risorse private per favorire o impedire decisioni pubbliche. La prima è quella che sta a cuore a chi si oppone in Italia al finanziamento pubblico dei partiti e che ha ispirato la legge approvata nel febbraio scorso per la quale i cittadini stessi scelgono di destinare il 2% dell’Irpef ai partiti di loro gradimento. L’idea guida è che privatizzando la scelta alla sorgente si possa controllare meglio l’operato dei partiti. Se non che, affidare l’esistenza dei partiti alla volontà dei privati (oltretutto non di tutti egualmente, ma solo di coloro che pagano l’Irpef) può facilmente legare il potere dell’influenza politica alla diseguaglianza delle possibilità economiche dei singoli cittadini, generando una corruzione ancora più radicale. Per scongiurare questo scenario, le legislazioni dei paesi europei si sono dotate di misure di controllo. La Germania, che contrariamente all’Italia tratta i partiti come organi di diritto pubblico, prevede l’intervento del legislatore per controllare sia l’aspetto economico sia l’ordinamento interno così da renderlo “conforme ai principi fondamentali della democrazia”. Ciò ha consentito, come sappiamo, di escludere i comunisti e i nazisti dalla vita parlamentare, ma ha anche permesso di controllare il finanziamento. In conformità ai principi democratici, la Germania ha statuito un contributo pubblico ai partiti proporzionale ai voti ricevuti e in rapporto ai voti validi, e stabilito un tetto minimo di voti necessari per accedere ai finanziamenti. La Commissione Bozzi (19831985) si era ispirata a questo modello quando aveva proposto un’aggiunta all’articolo 49 della Costituzione che si riferiva esplicitamente al finanziamento pubblico. La proposta non ebbe esito. Legare il destino dei partiti al mercato delle scelte individuali non pare essere una strategia saggia. L’esempio degli Stati Uniti dovrebbe farci riflettere. I partiti americani sono associazioni libere, finanziati solo con i soldi privati e il sistema politico americano (incardinato sulle primarie) rende le campagne elettorali un pozzo di San Patrizio e la politica un affare nel “libero mercato delle idee”, dove il denaro è un’indicazione di libertà di parola, secondo una nota interpretazione del primo emendamento alla costituzione. Il finanziamento privato è una spina nel fianco della democrazia americana, un passaporto all’ingiustizia politica oltre che a spese sconsiderate e infine per nulla al riparo dalla corruzione, che è anzi resa lecita. La nostra nuova legislazione che ridefinisce il finanziamento pubblico come sostegno privato volontario da parte dei contribuenti si iscrive in una visione del partito politico come associazione privata o extra-statale e con un rapporto conflittuale rispetto allo stato democratico. Il paradosso è questo: sappiamo che il sistema rappresentativo necessita di partiti, eppure ci rifiutiamo di accettare che il partito sia un’associazione in parte pubblica. L’Italia, convinta di seguire il modello tedesco nella riforma del Senato, si ispira al modello americano nel modo di intendere i partiti. Il sistema tedesco, molto meno corrotto del nostro e di quello statunitense, riposa su partiti che sono concepiti e regolati come protagonisti della “partecipazione libera e duratura” alla vita dello Stato, non lasciati alla forza degli interessi privati e al potere diseguale di chi ha più voce nel mercato. del 18/04/14, pag. 9 Bellaria, la destra rimuove la Resistenza 16 Onide Donati A una settimana dal 25 aprile il sindaco fa togliere dalla piazza del Comune l’installazione dedicata ai morti nella lotta al nazifascismo Bello? Brutto? La disputa sulla «Gabbia dei sassi», grande e da sempre discusso monumento alla Resistenza, è stata superata. Ci hanno pensato una pala, una sega da ferro, un flessibile e qualche altro attrezzo a risolvere la disputa trentacinquennale sull’opera che il maestro Luigi Poiaghi aveva realizzato davanti al municipio di BellariaIgea Marina. La destra al potere è andata alla radice del caso distruggendo il problema, ammesso che di problema si trattasse. L’ha fatto nottetempo, a dieci giorni dal 25 Aprile, con la rimozione della installazione. «Gabbia dei sassi» è il nome attribuito a furor di popolo ad un monumento molto particolare, per dimensioni e stile, che nel 1978 vinse un concorso nazionale. L’identità vera è «Passatopresente » e, nella catalogazione che ne ha dato l’Istituto per i Beni Culturali dell’Emilia-Romagna è costituita da «una figura simbolica» in pietra, cemento e ferro per esaltare i valori «della lotta e dei sacrifici sostenuti per l’Indipendenza e la Liberazione del nostro Paese». In pratica, sopra un basamento bianco di 50 metri quadrati vi era posta una imponente gabbia contenente grossi massi di fiume. Il basamento aveva impresso orme di piedi e la scritta «Parliamo di uomini e in questo senso parliamo di eroi». Lo stesso IBC descrive il monumento come «opera dura, forte, tutta maturata nelle esperienze concettuali milanesi; da considerare, in questo artista più predisposto ad una ricerca poetica, un gesto di radicale adesione ad una militanza dell’arte, che i tempi invocavano. Opera che trovò presso il pubblico romagnolo non poche difficoltà di lettura ». Di quello strano monumento ora è rimasta solo la base: nel progetto di «rivisitazione » dell’area che sta davanti al Comune su di essa poggeranno tante bandiere a corredo di una scenografia di più facile impatto, in linea con le luci colorate stile Las Vegas messe un po’ ovunque in centro. Già, perché come ha scritto con una mail il sindaco Ceccarelli allo stesso Poiaghi 48 ore prima che la ruspa si mettesse in moto, quell’opera proprio non veniva capita dai cittadini. E poi era arrugginita, sporca, e dava un senso di tristezza. Poiaghi, che dopo la realizzazione del monumento si era affermato come artista importante, aveva rilanciato: «Capisco i problemi emi rendo disponibile a ragionare per un recupero della struttura ed anche per una sua più facile interpretazione». Che poi l’interpretazione non era per nulla misteriosa, come ricorda l’Anpi locale: «La gabbia metallica che premeva, al suo interno, le pietre evocava l’opposizione tra due forze, ossia la costrizione subita e la tensione sempre inappagata verso la libertà, così come le impronte dei passi rimandano al cammino incessante che deve compiere l’uomo verso la liberazione da ogni forma di oppressione». Tutto inutile: alla destra bellariese interessava portare a casa il risultato e lanciare la sua provocazione prima del 25 aprile e a poco più di un mese dalle elezioni. E se un anno fa il sindaco di Cesenatico (l’altro primo cittadino della destra balneare «dura») aveva dovuto arrendersi alle proteste e rinunciare all’esposizione del busto di Mussolini in Comune, quello di Bellaria-Igea Marina ha tirato dritto tra il tripudio dei suoi e la sponda offertagli dal Resto del Carlino che ha indicato una sprezzante destinazione per i massi: usiamoli per ricaricare le scogliere davanti alla spiaggia. Ora che i «nuovi barbari» - come li ha definiti il candidato sindaco della lista Bene Comune, Alessandro Zavatta - hanno completato il lavoro sporco, quella parte di società civile che ha vissuto come una ferita la distruzione di un simbolo della Resistenza si interroga su cosa fare. A chi gli ha espresso solidarietà, l’artista ha risposto con poche e semplici parole: «Ho cercato inutilmente di contrapporre la ragione alle ruspe. Forse quella scultura non a caso è “Passatopresente”. Resistiamo. Portiamo lì nostri fiori il 25 Aprile». Ed è quel che l’Anpi e i partiti di sinistra sono intenzionati a fare. 17 LEGALITA’DEMOCRATICA del 18/04/14, pag. 4 Stato-mafia via da Palermo, la Cassazione decide OGGI IL VERDETTO SULL’ISTANZA DEGLI EX UFFICIALI DEL ROS MORI, SUBRANNI E DE DONNO: VOGLIONO TOGLIERE IL PROCESSO A DI MATTEO di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza È davvero un venerdì di Passione per il processo sulla trattativa Stato-mafia, appeso alla decisione della sesta sezione della Corte di Cassazione che stamane si riunisce per decidere se trasferire il processo o no da Palermo. Per decidere se accogliere o respingere l’istanza di rimessione presentata il 5 marzo scorso dagli ex ufficiali del Ros Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, imputati per aver veicolato tra il ’92 e il ’93 il ricatto stragista di Cosa nostra fin dentro le stanze del governo. I tre ufficiali, pur avendo sempre negato di aver trattato con la mafia, ora chiedono allo Stato di arrendersi ancora una volta alle minacce mafiose, allontanando da Palermo il processo sulla trattativa “per motivi di sicurezza”. RISULTATO? Il dibattimento in corso nell’aula bunker di Palermo, davanti alla Corte d’assise presieduta da Alfredo Montalto, ora rischia di dover ripartire da capo. Dal giorno della prima udienza, il 27 maggio 2013, è passato quasi un anno: sul pretorio, si sono avvicendati i pentiti Francesco Onorato, Giovanni Brusca, Francesco Paolo Ferrante, Francesco Di Carlo, Nino Giuffrè, Leonardo Messina e Rosario Naimo, Gioacchino La Barbera, Fabio Tranchina e Gaspare Spatuzza, il faccendiere Paolo Bellini, ma anche i testi Rino Germanà e Susanna Lima. Se l’istanza dei carabinieri venisse accolta, però, tutto andrebbe perduto. Perché? Nelle 45 pagine depositate dai loro legali, gli avvocati Giuseppe Saccone e Basilio Milio (ora affiancati, a quanto pare, dal cassazionista Oreste Dominioni), gli ex ufficiali del Ros ricostruiscono una serie di circostanze che vanno dagli anonimi giunti un anno fa alla Procura di Palermo, alle minacce del boss Totò Riina nei confronti del pm Nino Di Matteo, fino alla misteriosa incursione dello scorso giugno nell’abitazione del pm Roberto Tartaglia, per dimostrare che lo svolgimento del dibattimento a Palermo costituisce un “pericolo per l’incolumità pubblica”. E chiedere il trasferimento ad altra sede. Nessun commento, a poche ore dalla pronuncia della Cassazione, arriva dalla Procura di Palermo. Non parla l’aggiunto Vittorio Teresi, coordinatore dell’indagine, che un mese fa ipotizzò che gli ordini di morte di Riina contro il pm Di Matteo potessero puntare proprio a uno spostamento del processo. Non parla nemmeno Di Matteo, bersagliato da mesi da un’escalation di minacce, per il quale – ovviamente – il rischio di attentati non diminuirebbe affatto nel caso di un allontanamento del dibattimento ad altra sede. NELL’UDIENZA numero 29 del processo sulla trattativa, che potrebbe essere l’ultima, ieri la Corte d’assise di Palermo ha preso atto della nuova condizione dell’imputato Marcello Dell’Utri, che non è più “libero, assente, contumace”, ma “detenuto per altra ragione”. Il presidente Alfredo Montalto, rilevando che “tale condizione” non è sufficiente a far scattare il “legittimo impedimento”, ha fissato la prossima udienza al prossimo 15 maggio. Ma il processo potrebbe subire uno stop se Dell’Utri chiedesse, come è suo diritto, di assistere al dibattimento. La difesa non ha ancora deciso le prossime mosse: presente in aula, ieri, 18 non ha voluto anticipare nulla al riguardo l’avvocato Giuseppe Di Peri, che si è brillantemente ripreso dal malanno che lo ha costretto tre giorni fa a inviare alla Cassazione un certificato medico, attestante una temporanea indisposizione, per chiedere il rinvio della sentenza definitiva sull’ex senatore nel procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa, ottenendone lo slittamento al 9 maggio. Il verdetto della Suprema Corte sul processo della trattativa è atteso, invece, entro stasera: anche se è possibile che i giudici si riservino la decisione, rinviandola di qualche giorno. Se la sesta sezione accogliesse l’istanza degli ex ufficiali del Ros, in base all’articolo 11, dovrebbe trasferire il processo a Caltanissetta dove ricomincerebbe da zero. E nel palazzo di giustizia nisseno, dov’è già in corso il nuovo processo per la strage di via D’Amelio, che tra i possibili moventi ha anche il dialogo tra Cosa nostra e lo Stato, diventerebbero due le Corti di assise a occuparsi in parallelo della trattativa Stato-mafia. 19 RAZZISMO E IMMIGRAZIONE Del 18/04/2014, pag. 5 «Espulso», ma è nato in Italia Assurdità dei Cie. Jovanovic Daribor è nato ad Aversa ma per lo Stato un immigrato irregolare. Per questo vuole espellerlo in Bosnia. Peccato però che per l’ambasciata bosniaca non si tratta di un suo cittadino Carlo Lania <<Ma che ci vado a fare in Bosnia? Lì non conosco nessuno, non parlo neanche il bosniaco. Mi sentirei perso. L’unica cosa che potrei fare è cercare di tornare al più presto qui, in Italia». Parla bene la nostra lingua Jovanovic, e non potrebbe essere altrimenti. Il nome, Jovanovic Dalibor, è infatti l’unica cosa che lo identifica come uno straniero, perché per il resto è italianissimo. E’ nato 23 anni fa ad Aversa, da genitori bosniaci fuggiti in Italia. Da dicembre scorso, però, è rinchiuso nel Cie romano di Ponte Galeria, in attesa di essere espulso in Bosnia. Una decisione che non riesce a capire, visto che è nato qui da noi, ma che soprattutto lo spaventa molto. «Davvero non conosco nessuno, non saprei proprio da dove cominciare». Il caso di Jovanovic è un paradosso, una delle tante assurdità che è facile trovare nei centri di identificazione ed espulsione in cui vengono rinchiusi gli immigrati sprovvisti di permesso di soggiorno e in attesa di essere rispediti come pacchi nel proprio paese. Già, per chi ce l’ha un paese dove tornare. E non è il caso di Jovanovic. Intendiamoci. Non che lui i suoi errori non li abbia fatti. Nel 2011 la polizia lo ha sorpreso mentre cercava di svaligiare un appartamento a Villaricca, grosso centro di 30 mila abitanti in provincia di Napoli. I due anni successivi li ha passati a Poggioreale, da dove è uscito il 17 dicembre dell’anno scorso. Con un biglietto di sola andata per la Bosnia, frutto di un ordine di espulsione deciso dal tribunale di sorveglianza di Napoli. Nel frattempo, la tappa intermedia in attesa di essere imbarcato, è il Cie Ponte Galeria, dove si trova rinchiuso ormai quattro mesi. «Un’assurdità», commenta l’avvocato Serena Lauri che assiste Jovanovic. «Fa paura pensare che ha decidere l’espulsione sia stato un tribunale di sorveglianza: dove dovrebbe essere espulso visto che è nato qui?», è la domanda che si pone anche il legale. «La corte di Strasburgo ha più volte condannato gli Stati che hanno espulso gli stranieri residenti da lungo tempo e gli immigrati di seconda generazione, anche a seguito di reati», prosegue l’avvocato. Il principio seguito è quello che l’esigenza di tutelare la società da un presunto pericolo non è tale da giustificare la lesione del diritto di mantenimento dell’unità familiare. «Tanto più nel caso di Jovanovic, visto che la sua famiglia risiede in Italia», conclude l’avvocato Lauri. A complicare ulteriormente le cose ci si è messa nei giorni scorsi l’ambasciata bosniaca a Roma. Alla richiesta di identificare Jovanovic in modo da poter poi procedere con l’espulsione, l’ambasciata ha dato la sola risposta possibile: ha negato che il giovane sia bosniaco, come infatti è, e reso impossibile di conseguenza il rimpatrio. A questo punto la situazione, già paradossale, si è bloccata. Che fare di Jovanovic? La risposta più sensata sarebbe quella di rimetterlo in libertà, tanto più che ha già pagato il suo conto con la giustizia e quindi non avrebbe alcun motivo per essere trattenuto ulteriormente. Già, ma così sarebbe troppo semplice per la burocrazia che governa i Cie. E così pochi giorni fa il giudice di pace ha prorogato di altri due mesi il trattenimento di Jovanovic a Ponte Galeria. Privato della libertà per altri sessanta giorni. E’ chiaro che in questo modo, di proroga in proroga, Jovanovic rischia di passare a Ponte Galeria fino a un anno e mezzo, vale a dire il tempo massimo che per legge uno straniero può essere trattenuto in un Cie prima di essere liberato. Una carcerazione dal sapore 20 oltremodo ingiusto. L’avvocato Lauri ha chiesto al giudice di pace una sospensiva dell’espulsione, che se accettata consentirebbe a Jovanovic di raggiungere Napoli, dove vive la madre. Nel frattempo è stata anche avanzata al tribunale di Roma una domanda di riconoscimento dello status di apolide, cosa che permetterebbe a Jovanovic di poter finalmente regolarizzare in maniera definitiva la propria situazione. «Sarebbe una cosa bellissima», commenta il giovane. «Con il passato ho chiuso. Il carcere mi ha cambiato, mi ha fatto capire i miei errori e adesso l’unica cosa che voglio è trovarmi un lavoro. Se solo riuscissi a uscire da qui». Del 18/04/2014, pag. 5 Milano, riapre in estate la prigione per stranieri di via Corelli Razzismo. Nonostante molte voci "contro", tra cui quella del Comune di Milano e di alcuni esponenti del Pd nazionale, il governo ha deciso di riaprire il Cie milanese. Alla fine dell'anno la struttura concentrazionaria simbolo del fallimento delle politiche per l'immigrazione verrà affiancata da un Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Le associazioni milanesi e i sindacati protestano e preparano una manifestazione di protesta Luca Fazio L’immigrazione? Non c’è più. Il turbo governo di Renzi ha risolto la “questione” eliminandola dal discorso politico, così come sono spariti una ministra e un ministero nel silenzio generale. E non c’è nemmeno lo straccio di una delega a qualche sottosegretario. Non è un disimpegno ma un’indicazione precisa: ordine pubblico e galere regoleranno la “materia”, in attesa di nuovi sbarchi e tragedie annunciate (per l’operazione militare Frontex nel Mediterraneo l’Europa ha appena stanziato 7,1 milioni). Ne è una prova anche la riapertura del Cie milanese di via Corelli prevista in estate. La struttura concentrazionaria addirittura raddoppia: entro la fine dell’anno la prigione per stranieri che non hanno commesso alcun reato — aperta nel ’98 con la legge TurcoNapolitano e chiusa mesi fa perché distrutta da una rivolta — verrà affiancata da un Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo). Con buona pace dei “democratici” del Pd che si sono sbilanciati in chiave antirazzista contro una mostruosità non solo giuridica, come Emanuele Fiano qualche mese fa (“via Corelli va chiuso), Khalid Chauki qualche giorno fa (“mi opporrò e mi farò sentire”) e l’assessore del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino (“un’occasione persa”). La nuova prigione per stranieri da 140 posti verrà gestita dalla società Gepsa di proprietà del colosso francese Gdf Suez, un’azienda leader nel settore carcerario, “uno dei partner principali dell’amministrazione penitenziaria francese”. Un esperimento, il primo passo verso la privatizzazione delle carceri. Gepsa si è aggiudicata l’appalto al ribasso per via Corelli (40 euro al giorno per detenuto), cifra che aveva scoraggiato la Croce Rossa dopo sedici anni di gestione impossibile e contestata, tra rivolte, pestaggi, violenze e tentativi di fuga e suicidio. Via Corelli, come gli altri Cie sparsi per l’Italia (quasi tutti chiusi o in ristrutturazione), è la prova di un fallimento generale che coinvolge anche chi non ha più avuto la forza o la voglia di battersi contro un simbolo piuttosto ingombrante dell’ingiustizia che domina il mondo, perché muri e celle sono qui, nelle nostre città. Il Cie è inutile, non funziona, è anti economico, e la sua stessa esistenza è una violazione dei diritti umani, senza bisogno che vi si commettano violenze. 21 A Milano però non c’è aria di rivolta, anche se qualcosa si sta muovendo, non fosse altro che per una questione di toni. Inusuali, per esempio, quelli di Cgil-Cisl-Uil che protestano definendo il Cie “luogo di segregazione su base razziale che non può essere più tollerata”. I sindacati chiedono a prefettura e Comune di Milano che la struttura venga riconvertita in un centro di accoglienza per rifugiati, “perché si esca finalmente da una visione securitaria e punitiva del fenomeno dell’immigrazione per attivare, al di là delle belle dichiarazioni, politiche di integrazione e di accoglienza”. Luca Cusani, presidente del Naga, parla di “vuoto abissale della politica” e teme il peggio: “Dato che la ristrutturazione è avvenuta in seguito a una distruzione da parte dei detenuti e visto che le ribellioni sono state l’unica vera forma di contrasto ai Cie, immaginiamo che la nuova versione conterrà strumenti e dispositivi che tenteranno di neutralizzare ogni forma di rivolta attraverso meccanismi di sottomissione e costrizione”. Via Corelli non è ancora aperto. Nei primi giorni di maggio, con una manifestazione ancora da preparare, alcune associazioni proveranno ad inaugurare una nuova stagione di resistenza antirazzista. Difficile. Ma tutti si augurano almeno che possa accadere con a fianco il Comune di Milano. del 18/04/14, pag. 8 “I genitori sono razzisti” Il preside lascia la scuola ACCADE A DRONERO (CUNEO): “LE FAMIGLIE ISCRIVONO I BAMBINI IN ALTRE STRUTTURE PER VIA DEGLI EXTRACOMUNITARI”. NELLE ELEMENTARI SOPRAVVIVE SOLO UNA CLASSE DI STRANIERI di Andrea Giambartolomei Torino Il giovane direttore lascia. Troppo difficile fare il preside, soprattutto se ci si mette il razzismo di alcuni genitori che iscrivono i propri figli nelle altre scuole per “una diffidenza aggressiva nei confronti del diverso”. E così a settembre nella sua scuola elementare ci sarà solo una classe prima e sarà una classe “ghetto”, con 12 studenti stranieri su 14 allievi. Succede a Dronero, principale centro della Val Maira in provincia di Cuneo, dove Graziano Isaia, 37 anni, da due anni preside di nove scuole della valle (un totale di circa 600 allievi e 150 dipendenti), ha chiesto di tornare a fare il maestro. Dopo essersi dimesso però ha denunciato una situazione: “A cosa serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?”, dice al telefono citando don Lorenzo Milani. Lui ha tirato le sue mani fuori dalle tasche per scrivere una lettera aperta al sindaco Livio Acchiardi e al presidente del consiglio d’istituto, una lettera in cui ha denunciato il razzismo latente di alcuni genitori che discreditano la scuola elementare di piazza Marconi e minano la vita civile. MA COSA è successo in questo centro delle valli occitane, terre di tolleranza e di lotta partigiana? “Tre madri hanno agito per destabilizzare la situazione”. Si spieghi meglio, direttore. Isaia racconta. Il comitato genitori delle elementari di Dronero stava organizzando una marcia per raccogliere fondi a sostegno della scuola: “Lo Stato ci passa solo 4 mila euro all’anno e la loro iniziativa è apprezzabile, se non fosse che in quest’occasione ho saputo che alcuni genitori hanno iscritto i loro figli alle classi prime di altri istituti”. I motivi? “Criticano gli insegnanti basandosi su pregiudizi, criticano l’adozione 22 dei libri di testo e, soprattutto, non apprezzano la presenza dei figli degli stranieri in classe. Quest’ultimo problema cova sotto”. A Dronero il 5 per cento della popolazione è di origine ivoriana, persone arrivate negli anni Novanta per la lavorazione del legno, la raccolta della frutta e la fabbricazione di biciclette. Il preside Isaia vuole capire meglio e organizza un’assemblea coi genitori che dovranno iscrivere i figli alle classi prime, ma nessuno fa emergere questi problemi. Nel frattempo però l’azione di tre madri continua: “Alla fine hanno convinto undici famiglie di italiani ad andare altrove – spiega –. Non potremo costituire due classi prime, ma solo una con dodici stranieri e due italiani. Ho l’85 per cento di stranieri, ben oltre il 30 per cento imposto da una circolare del ministro Gelmini: una classe così deve essere autorizzata dall’Ufficio scolastico territoriale”. NELLA SUA LETTERA aperta il direttore attacca con chiarezza: “Nessuno lo ammetterà mai, ma alla base della fuga dal capoluogo non c’è soltanto avversione per alcuni metodi d’insegnamento, c’è anche una diffidenza aggressiva nei confronti del diverso”. Aggiunge che per alcuni genitori “in piazza Marconi c’è lo sporco, il fastidio, il peso morto, la puzza, l’ignoranza scimmiesca. Con questi usurpatori del suolo natio chi si sente superiore non si vuole mescolare”. Al telefono aggiunge che questo è “un danno culturale che non potrà essere compensato da nessuna raccolta fondi”. Per il sindaco di Dronero, Acchiardi, tornato da poco da una gita con le terze medie a Mauthausen, la situazione è molto spiacevole: “In questi anni abbiamo fatto di tutto per non discriminare nessuno e inserire tutti”. 23 SOCIETA’ Del 18/04/2014, pag. 1-8 LA POLEMICA Lorenzin: troppi tagli così la sanità muore ROSARIA AMATO TAGLI alla sanità di quasi 2,4 miliardi di euro in due anni. Riduzioni che si abbattono sulla spesa farmaceutica, sull’attività ospedaliera convenzionata, sugli “ausili”, cioè le protesi e i supporti per i malati. Non una razionalizzazione, contesta con forza il ministro della Salute Beatrice Lorenzin nella riunione di governo cominciata ieri pomeriggio per mettere a punto il Dl Irpef, e andata avanti fino a tarda notte, ma un taglio voluto dal Tesoro che ha il solo obiettivo di reperire risorse. QUI cambiano i numeri ogni giorno. — dice il ministro — Prima ci hanno parlato di 400 milioni di tagli, poi di 700. Non c’è visione strategica, entrano a gamba tesa». Il ministero, d’accordo con le Regioni, si era detto pronto nei giorni precedenti a reperire risorse attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, ma ieri pomeriggio di quest’ipotesi non c’era traccia nella bozza del decreto. Invece si parla di riduzione di posti letto e chiusura di piccoli ospedali e presidi territoriali, e di interventi sulle tariffe delle convenzioni, oltre che di riduzione della spesa farmaceutica. I tagli sono suddivisi in 860 milioni di euro per quest’anno e un miliardo e mezzo per il 2015: una mannaia che, contesta il ministro, mette a rischio i Lea, i livelli essenziali di assistenza, e il Patto della Salute con le Regioni, quasi in dirittura d’arrivo, in un’intervista all’ Espresso il ministro ne ha annunciato la chiusura entro i primi di maggio. Ma adesso può saltare. Un’ipotesi che il ministro Lorenzin non intende accettare: il braccio di ferro con il ministero dell’Economia ieri è apparso durissimo. «Io sono per le cose razionali, di buonsenso. — è esplosa il ministro — Sulla sanità dovevamo decidere cosa fare con Cottarelli, ora arriva il Mef e ci dice quanto e dove tagliare. Allora che facciano loro il nostro lavoro, mettano il ministero della Salute sotto un dirigente di secondo livello che si occupa della politica sanitaria del Paese ». Il problema non è solo l’entità dei tagli, ma anche l’utilizzo delle risorse risparmiate, che non vengono reinvestite in servizi sanitari, ma utilizzate per andare in aiuto di altre voci di spesa. Il provvedimento infatti sarebbe legato ad una stima previsionale al ribasso del Pil, che dovrebbe comportare un ridimensionamento complessivo della spesa pubblica. Il ministero, se il decreto passasse così com’è in Consiglio dei ministri, non avrebbe alcuna voce in capitolo né sul reperimento dei risparmi né sulla loro allocazione. Durissimo anche il giudizio del maggiore sindacato dei medici dirigenti, l’Anaao-Assomod, che parla di «un taglio lineare al fondo sanitario nazionale», e di Federfarma, che ricorda che «la spesa farmaceutica convenzionata, a seguito dei tagli apportati in questi anni, oggi è già a livelli inferiori a quelli di 14 anni fa». 24 BENI COMUNI/AMBIENTE del 18/04/14, pag. 4 L’acqua fa gola, torna l’assedio Andrea Palladino Acea. Il Messaggero (Caltagirone): per risanare i conti di Roma vendere il 21% di azioni. All'assemblea del 5 giugno andrà in scena lo scontro sulla natura sociale del gruppo: il sindaco Marino aveva chiesto il ricambio del management La curva delle azioni della multinazionale romana Acea è il vero termometro delle intenzioni politiche sulle privatizzazioni. Nel giugno del 2011 — dopo i referendum sull’acqua — le azioni iniziano una repentina discesa verso i minimi storici. Il management nominato dai soci privati era nel panico, il progetto di allargare a dismisura la gestione dei beni comuni rischiava di saltare definitivamente. La prima reazione fu dura: bloccare tutti gli investimenti, creando una pressione, discreta ma soffocante, per correre ai ripari. La prima mossa fu la richiesta di un parere legale a un avvocato di eccezione, il figlio del presidente Napolitano, Giulio, che presentò una relazione su come recuperare almeno una parte di quel profitto garantito abrogato dai referendum. La preoccupazione degli investitori d’altra parte era evidente. Nei mesi precedenti il voto dell’articolo 23 bis della legge Ronchi — poi abrogato — che avrebbe obbligato il comune di Roma a cedere buona parte di quel pacchetto del 51% delle azioni ancora in mano pubblica, aveva risvegliato l’interesse dei grandi gruppi finanziari. Con Caltagirone in prima fila. Erano gli anni della gestione Alemanno, il sindaco che aveva in tasca il progetto di cessione di quel poco di sovranità sui servizi pubblici ai suoi grandi elettori. Poi, per i soci privati del colosso dell’acqua, primo operatore del settore idrico in Italia, iniziarono mesi difficili. Con il cambio della guardia al comune di Roma. Oggi — a tre anni dal voto popolare del giugno 2011 — Acea torna a scalare le vette della Borsa di Milano, con un nuovo record storico. La curva delle azioni ha ripreso a salire spinta da due asset: l’arrivo di Matteo Renzi e la discussione sui conti romani, appesi al decreto che dovrebbe salvare il sindaco Marino dal crack. Qualcosa si muove per gli ideologi della gestione privata a tutti i costi, partiti alla riconquista delle posizioni perdute. Partendo proprio da Roma. Ovvero dalla madre di tutte le privatizzazioni. La porta d’ingresso oggi si chiama bilancio comunale, e il suggerimento-diktat per Ignazio Marino è arrivato puntuale dal giornale romano il Messaggero, controllato da Francesco Gaetano Caltagirone, il principale socio della holding romana, con in mano il 16% delle quote. «Vendere il 21% delle azioni di Acea» è la soluzione per sanare i conti, spiegava ieri il quotidiano, dedicando ampio spazio alle dimissioni dell’assessora capitolina al bilancio Daniela Morgante. Nei mesi scorsi Marino aveva provato a imporre il suo peso di principale azionista ad Acea, scontrandosi con un muro. E l’impressione è che Renzi non stia proprio dalla sua parte. L’ex sindaco Acea la conosce bene: da anni Firenze è il socio di riferimento di Publiacque, il gestore degli acquedotti di buona parte della Toscana e l’attuale presidente Erasmo D’Angelis — vicinissimo al premier — è un fervido sostenitore della presenza dei privati nella gestione del sistema idrico integrato. Una tempesta perfetta, preannunciata da un emendamento — poi caduto — di Linda Lanzillotta (assessora all’epoca Rutelli, quando il Campidoglio firmò la prima privatizzazione alla fine degli anni ’90) che tentava di imporre la cessione delle quote di Acea sul mercato. 25 Poche ore dopo la moral suasion del Messaggero, sono arrivate le parole del presidente della holding romana Giancarlo Cremonesi, uomo del cerchio magico di Caltagirone: «Io temo che una partecipazione pubblica importante nelle società erogatrici dei servizi pubblici locali — ha commentato durante un incontro alla Camera di commercio — faccia diminuire il grado di attenzione e di verifica sulla qualità dei servizi: è come se il concedente verificasse se stesso. Quanta voglia ha il concedente di decidere se la società in questione dev’essere sanzionata o meno?». Parole che anticipano quale sarà la strategia del gruppo Caltagirone nei prossimi giorni, che si annunciano di fuoco. Il 5 giugno l’assemblea dei soci si dovrà confrontare con la posizione di Marino, che nei mesi scorsi aveva chiesto un ricambio deciso del management. Mentre si prepara lo scontro sulla natura sociale del gruppo — all’indomani dell’approvazione della legge della regione Lazio, ispirata da principi molto vicini ai referendum — la gestione non sembra aver cambiato corso. Ieri si è tenuta davanti alla sede Acea di via Ostiense una manifestazione di protesta dell’Usb per il licenziamento di due lavoratori «che nel 2010 avevano denunciato smaltimenti illeciti e irregolarità di gestione nell’impianto di depurazione di Roma Nord», spiega Oscar Tortosa, consigliere regionale. Pessime notizie anche sul fronte delle bollette, dopo l’approvazione da parte dell’autorità per l’energia e l’acqua delle nuove tariffe, con aumenti retroattivi. Su questo fronte la gestione mista pubblico-privata ha un segno di riconoscimento ben visibile: chi non riuscirà a pagare non avrà più accesso all’acqua potabile, senza nessuna tutela. La revisione del regolamento di utenza avviato più di un anno fa dai sindaci è per ora rimasto lettera morta, mentre nella capitale sono centinaia le famiglie con i contatori sigillati. Una politica — questa — ritenuta chiave per garantire i gruppi finanziari privati e gli investitori. Presenti e futuri. 26 INFORMAZIONE Del 18/04/2014, pag. 15 Se la neo presidente di Poste lascerà Viale Mazzini la Vigilanza eleggerà il sostituto cambiando gli equilibri Rai, ipotesi ribaltone Todini pronta all’addio la maggioranza del cda torna al centrosinistra FRANCESCO BEI ROMA .Togli un bastoncino e tutta la costruzione viene giù. Funziona così nel Mikado e sta per accadere in Rai dopo la nomina di Luisa Todini a presidente di Poste italiane. Perché l’imprenditrice è stata eletta due anni fa da Pdl e Lega nel Consiglio di amministrazione della tv di Stato. E, benché nessuna norma di legge la obblighi a scegliere una delle due poltrone, è evidente che prima o poi ragioni di opportunità politica le potrebbero imporre di abbandonare il suo posto al settimo piano di viale Mazzini. Lasciando aperto un varco per far spazio a un esponente designato dalla nuova maggioranza. Vale a dire gradito a Matteo Renzi. Visti i numeri, sarebbe un Rai-baltone. A palazzo Chigi infatti il dossier Rai finora è stato messo in fondo agli altri, non rientrava tra le priorità dei cento giorni. Ma il tempo scorre e fa ingiallire sempre di più la fotografia di un Cda nominato in epoca berlusconiana, quando il centrodestra era maggioranza in Parlamento. Nove sono i membri attuali, così ripartiti. Quattro di centrodestra: Antonio Verro, Antonio Pilati, Guglielmo Rositani e Luisa Todini. Due di centrosinistra: Benedetta Tobagi e Gherardo Colombo. Uno dell’Udc: Rodolfo De Laurentiis. Due nominati dal governo tecnico di Monti: la presidente Anna Maria Tarantola e l’uomo dell’azionista (il ministero dell’Economia), Marco Pinto. Uno squilibrio troppo forte a favore del centrodestra, sebbene sulle decisioni importanti il direttore generale Luigi Gubitosi abbia sempre potuto contare sul voto della Todini. I consiglieri di centrodestra ancora masticano amaro per il «tradimento» dell’imprenditrice quando si trattò di deliberare maggiori poteri alla presidente Tarantola. Verro, Pilati, De Laurentiis e Rositani si astennero, ma la delibera passò ugualmente proprio grazie al voto della Todini. Tuttavia, nonostante l’autonomia di Todini, è chiaro che il Cavaliere ha potuto finora dormire tra due guanciali. Adesso la musica è destinata a cambiare. Il problema semmai è capire chi potrà prendere il posto della neo presidente di Poste italiane. Nella maggioranza infatti non è soltanto il Pd a reclamare una maggiore rappresentatività al vertice dell’azienda. Il Pdl infatti non esiste più e tutti i consiglieri attuali fanno riferimento a Forza Italia. Il nuovo centrodestra è rimasto a bocca asciutta. A rafforzare l’ipotesi che possa essere lasciata ad Alfano la nomina del sostituto di Todini c’è poi una considerazione legata ai numeri della commissione di Vigilanza. A cui, per legge, spetta di nominare sette dei nove membri del Cda. Nell’organismo, guidato dal grillino Roberto Fico, per Forza Italia sedevano infatti Paolo Bonaiuti, passato tre giorni fa all’Ncd, e Giorgio Lainati, anche lui in grande sofferenza. Due potenziali voti in più per la maggioranza, che potrebbero far pendere la bilancia a favore di un nuovo consigliere alfaniano. Del resto, sempre che Renzi non lo reclami per uno dei suoi, anche il Movimento 5 Stelle potrebbe insistere per essere rappresentato al settimo piano. L’elezione di Fico alla presidenza della Vigilanza non ha infatti portato quella ventata di novità che gli stessi grillini si aspettavano e poter disporre di una sentinella ai piani alti dell’azienda televisiva di Stato potrebbe indurre il M5s alla battaglia. Certo, la partita potrebbe anche andare per le lunghe. La legge Gasparri concede trenta giorni alla commissione di Vigilanza per eleggere il nuovo 27 membro del Cda dal ricevimento delle dimissioni della Todini. E solo allora inizieranno le danze. Anche perché non è detto che l’imprenditrice abbia tutta questa fretta di lasciare la doppia poltrona. «Gubitosi - riferisce una fonte interna - farà di tutto per non farla dimettere. Per lui è un indebolimento forte rispetto a un governo che già lo sente come un corpo estraneo». Raccontano infatti di una certa freddezza del premier verso il direttore generale, nonostante quest’ultimo abbia cercato in tutti i modi di ingraziarselo. Una distanza certo non diminuita dalla strenua resistenza del Dg al piano di tagli da 170 milioni di euro che Carlo “mani-forbice” Cottarelli, commissario alla spending review, ha in mente per il gigante di Stato. Tanto che per far cassa, come ha scritto ieri l’agenzia di stampa il Velino, Gubitosi starebbe rispolverando un vecchio dossier: vendere una quota di minoranza di Rai Way. Un patrimonio industriale pesante (2.300 siti, 23 sedi e 600 dipendenti tra ingegneri, tecnici specializzati e personale operativo) che nel 2001 i texani della Crown Castle avevano valutato in totale 1.750 miliardi di lire (circa 900 milioni di euro). E che oggi Mediobanca stima intorno ai 600 milioni. Basterà questo tesoretto a placare il premier? 28 CULTURA E SCUOLA del 18/04/14, pag. 3 Def, la scuola conta meno delle imprese Anna Angelucci Nonostante i tagli draconiani, anche quest’anno le scuole italiane hanno regolarmente funzionato e garantito la loro offerta formativa a centinaia di migliaia di studenti. Fortemente sottodimensionato, il personale Ata ha lavorato a pieno ritmo e i docenti hanno svolto le loro funzioni strumentali, di coordinamento, di recupero e di potenziamento della didattica. Oggi ci troviamo tuttavia in una situazione gravissima: il fondo d’istituto delle scuole italiane non ha la consistenza economica per coprire tutte le attività di intensificazione, aggravio e straordinario che il personale docente e non docente ha effettuato durante l’anno per garantire il regolare funzionamento dei Piani dell’Offerta Formativa, previsti dalla legge sull’autonomia. Poche migliaia di euro erogate come anticipo all’inizio dell’anno scolastico dal ministero dell’Istruzione sono oggi l’unica consistenza economica di cui le scuole dispongono. In molte scuole la contrattazione integrativa si sta chiudendo con una fortissima riduzione dei compensi, assurti a cifre simboliche, in molte altre non si apre neppure. In molte scuole si sta attingendo al contributo volontario delle famiglie per pagare personale e docenti! Dov’è finito il miliardo e trecento milioni di euro di crediti che le scuole vantano da anni nei confronti dell’amministrazione centrale? Quel credito che alcune circolari ministeriali in passato hanno vergognosamente chiesto alle scuole di inserire nell’«aggregato Z» del bilancio, così da renderlo inesigibile? Nel Documento di Economia e Finanza 2014 in discussione in parlamento neanche una parola. E nessun deputato e senatore, impegnato in questo momento nella sua battaglia pro o contro il Def, ricorda che l’amministrazione centrale ha debiti non solo nei confronti delle imprese ma anche con tutte le scuole d’Italia, messe oggi in condizione di non poter pagare i lavoratori. Com’è possibile che nonostante gli otto miliardi di risparmi effettuati nel comparto scuola solo con la legge 133/2008 (il 30% dei quali avrebbe dovuto essere reinvestito nella scuola), il mancato rinnovo dei contratti degli insegnanti, il blocco degli scatti di anzianità, la progressiva riduzione dei fondi per il funzionamento della scuola e per le attività di recupero e sostegno, siamo oggi di fronte possibilità che il nostro salario accessorio, a fronte di un lavoro regolarmente effettuato, non venga erogato? Il governo deve dirci se abbiamo lavorato pro bono. Deve dirlo a centinaia di migliaia di lavoratori. Deve avere il coraggio di dirci che, mentre i politici e i boiardi di Stato continuano ad accumulare introiti e pensioni da favola, noi, docenti e non docenti delle scuole italiane, con uno stipendio medio di 1.200 euro al mese, abbiamo fatto, a nostra insaputa, un volontariato coatto. * docente Liceo Pasteur Roma del 18/04/14, pag. 4 Pompei 29 Franceschini: «L’area archeologica va data ai privati». A chi? Agli sceicchi Adriana Pollice Nel giardino della domus di Romolo e Remo il ministro Dario Franceschini accetta di fare una breve sosta per i giornalisti, quasi impossibile fare domande. L’occasione per farsi fotografare ieri agli scavi di Pompei l’ha fornita l’apertura delle tre case restaurate, quella di Romolo e Remo, di Trittolemo e di Marco Lucrezio Frontone. La legge Valore cultura ha sovrapposto l’Unità Grande Progetto alla soprintendenza speciale, rallentando le procedure burocratiche, ma il ministro è sereno: «Abbiamo creato un’ottima sinergia tra le due strutture, si fa lavoro di squadra». I fondi, 105milioni, vanno spesi entro il 2015 oppure andranno persi, dei 39 cantieri attualmente ne sono aperti sette con un impegno di 40milioni: «C’è terreno da recuperare, ho incontrato qualche settimana fa a Parigi il commissario Ue e ne abbiamo discusso». Gran finale con «in epoca di tagli alla spesa ci vuole l’ingresso dei privati. Vorrei che si superasse un dibattito ideologico assurdo. Stiamo lavorando a una convenzione-tipo, prendendo spunto da Ercolano dove opera il Packard Humanities Institute, con incentivi fiscali per i privati che fanno un atto di liberalità». Squadre di calcio o compagnia aerea, quando si tratta di trovare investitori si pensa agli emiri e anche Franceschini ha pronto il suo: «Ho ricevuto l’ambasciatore del Kuwait, lo sceicco Ali Kahled Al-Sabah. Il loro interesse nei riguardi di Pompei è forte e sincero». Come Angela Merkel, il ministro ha pagato il biglietto per sé e per lo staff e, lanciandosi verso l’uscita, si è buttato tra le braccia di una comitiva germanofona per sottolinea, forse, l’amicizia con Berlino. Peccato, erano austriaci. A telecamere spente l’incontro con lavoratori e sindacati: il corpo di vigilanza è sottorganico di 200 unità, quello che si inaugura poi viene richiuso perché non c’è personale per gestire i turisti. Fino al primo maggio è stata siglata una tregua: due ore di straordinario volontario pagato in attesa che a maggio vengano distaccati 30 custodi dall’Ales, società in house del Mibact, per rendere accessibili di mattina le prime due domus aperte ieri e, di pomeriggio, la terza. Sperando che la tregua con i lavorati regga. La casa di Marco Lucrezio Frontone è uno scrigno di bellezze, l’affresco che ritrae l’uccisione di Neottolemo è ancora in restauro. Sulle pareti del giardino le scene di caccia sono pericolosamente sbiadite a causa delle intemperie. Per le tre domus sono stati spesi solo fondi ordinari, niente Grande Progetto: «Quando mi sono insediato a marzo – spiega il soprintendente Massimo Osanna – ho fatto una ricognizione con i funzionari per individuare le case che potevano essere riaperte in tempi brevi. In due casi i lavori sono stati fatti dal nostro personale, per la domus di Trittolemo abbiamo incaricato una ditta esterna». Mentre il dibattito scivola da un ministro all’altro intorno alla visione di Pompei come un grande parco a tema con fondi privati, restano inevasi due nodi: un organico ridotto così all’osso da rendere il sito ingestibile e la qualità dei restauri, affidati tramite appalti al massimo ribasso a ditte esterne. La procura di Torre Annunziata ha appena aperto un nuovo fascicolo su gli ultimi cinque cantieri mentre, secondo la stampa svizzera, i lavori alla domus del Criptoportico l’hanno resa simile a una pizzeria. «Coinvolgerò istituti di ricerca e università, come faceva il mio predecessore Pietro Guzzo – replica Osanna -. Dobbiamo aprire un dibattito sotto la guida della soprintendenza. Le critiche alla domus del Criptoportico sono infondate. L’approccio progettuale ha tenuto conto delle esigenze prioritarie come la protezione degli ambienti». Quanto alle assunzioni? «La discussione è in corso col ministro. Mancano restauratori, progettisti, personale amministrativo. Vedremo». 30 Del 18/04/2014, pag. 32 Ciao Gabo Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano premio Nobel, padre del realismo magico, è morto nella sua casa di Città del Messico Romanziere e reporter, attivista politico e amico di Fidel Castro, ha incantato milioni di lettori con il suo capolavoro “Cent’anni di solitudine” IRENE BIGNARDI GABRIEL García Márquez, Gabo per tutti quelli che lo hanno sfiorato nel corso della sua bellissima vita, conclusasi ieri a 87 anni, amava dire che tutti hanno una vita pubblica, una vita privata e una vita segreta. Nel suo caso, nel caso di un uomo simpaticissimo, vitale, seducente, allegro e generoso, nel caso di uno scrittore che ha inventato un mondo, lanciato una moda di raccontare, rappresentato l’ambasciatore e il simbolo di un continente, è difficile dire qualcosa circa la sua vita segreta. Ma certo vita privata e vita pubblica si sono intrecciate in un’unica, sola leggenda, storie e storie si sono fuse in un unico paesaggio avventuroso e magico, ricordi e fantasie si sono coniugate in un monumento al raccontare. Da tempo le condizioni di Márquez si erano aggravate. La settimana scorsa era stato dimesso dall’ospedale, a Città del Messico, dove era stato ricoverato, ufficialmente per una polmonite, anche se da tempo si parlava di un male più grave, mai confermato dalla famiglia. Ieri sera intorno alle 22 italiane le voci sulla sua morte si sono susseguite sul web, fino alla conferma da fonti vicine alla famiglia. «Mille anni di solitudine e tristezza per la morte del più grande dei colombiani di tutti i tempi», ha detto il presidente della Colombia Juan Manuel Santos. Nel corso di una delle molte interviste che mi ha concesso a nella capitale messicana, nella sua Cartagena, a Bogotà, all’Avana, attraverso le quali ho avuto la fortuna di diventare una specie di amica di famiglia, o, almeno, così ti faceva sentire lui, Gabo, una volta che si parlava della morte, disse con la sua consueta aria ironica che sì, in aereo alla morte ci pensava sempre, Ma che «seriamente (e intanto sorrideva sornione), l’unica cosa che mi dispiace della mia morte è che non potrò essere lì a raccontarla». E certo lui l’avrebbe raccontata bene. E ci si sente inadeguati a ripercorrere al posto suo la sua vita meravigliosa. Salvo ricorrere ancora a lui, al suo modo di raccontarsi. Per esempio la nascita di Cent’anni di solitudine. «Andavamo da Città del Messico ad Acapulco con la nostra vecchia Opel, io e Mercedes, e i nostri due bambini, Rodrigo e Gonzalo. E come per una folgorazione, mentre guidavo, ho capito come dovevo raccontare la storia, anzi, le storie, che mi seguivano da almeno dieci anni, da quando avevo scritto per una rivista colombiana La Casa de Los Buendía. Apuntes para una novela . Dovevo raccontare le storie come le raccontava la nonna Tranquilina». Il libro, diceva Gabo, era maturo e pronto, «come se qualcuno gli dettasse dentro». Non c’era che metterlo sulla carta. Girò il muso della macchina, tornò a casa, si mise a scrivere, incaricò Mercedes di occuparsi della vita quotidiana, si chiuse in casa e ne uscì un anno dopo. Per campare fece debiti e vendette la Opel. Mercedes, di suo, sacrificò anche l’asciugacapelli. E nel 1967, quando il libro uscì, in Argentina, e fece fuori tutta la tiratura in una settimana, Gabo si ritrovò improvvisamente famoso. «Un’esplosione », diceva, stupito, pensando anche ai cinque libri, tra cui Nessuno scrive al colonnello e I funerali della Mamà grande , che aveva già dato alle stampe, che erano stati ignorati, e che sarebbero risorti magicamente. 31 Un po’ per celia e molto sul serio diceva anche che lui Cent’anni di solitudine lo odiava. «Lo odio», sosteneva «perché penso che abbia sbarrato il passo agli altri libri. Lo odio perché è diventato un mito e io ho voluto scrivere un libro e non un mito. Preferisco essere ricordato per sempre per L’amore ai tempi del colera. Quello è il mio libro con i piedi sulla terra. L’altro è mitologia». Quella di Macondo (che altro non è, si scoprì poi, se non il nome di un albero), di Aureliano Buendía, di Ursula che continua a vivere perché non sa di essere morta, di Remedios, di Arcadio. Una mitologia fatta di «ricordi e di sentimenti, ma non della mia vita. È la storia della mia gente, del mio paese, nutrita delle memorie provenienti dalla casa di Aracataca dove viveva la mia famiglia, dove abbandonato da due genitori erranti ho vissuto la mia infanzia in una famiglia di sedici fratelli (anche l’ultimo si chiamava Gabriel)... Il mondo magico della nonna Tranquilina... Per anni sono stato prigioniero di Cent’anni di solitudine. Qualsiasi cosa scrivessi, diventava Cent’anni di solitudine ». E allora? «Allora ho scritto qualcosa di assolutamente diverso, L’autunno del patriarca , che è stato un fiasco clamoroso. I lettori volevano Cent’anni di solitudine ». Amato è stato, e tanto, Gabo Márquez. Girare con lui la Colombia era come viaggiare con Garibaldi a Caprera. Ai semafori la gente gli raccontava delle storie che trovava «degne di Márquez ». Le hostess degli aerei andavano in deliquio. I ragazzini lo inseguivano con copie pirata dei suoi libri – che lui firmava, senza mai tirarsi indietro, con il suo nome e un fiore, a volte autografando anche libri di altri, purché ci fosse un libro di mezzo. Un eroe nazionalpopolare? No, meglio, un eroe internazionalpopolare. E un grande giornalista “empirico” («Non c’è nessuno dei miei romanzi che non abbia una base nel reportage, nella realtà»). E un generoso insegnante, come dimostra la sua esperienza alla scuola di cinema della Fondazione del nuovo cinema latino americano di San Antonio de los Baños, che finanziava grazie ai proventi delle interviste televisive, cinquantamila dollari a botta. «Con me fanno spettacolo sì o no? E io i soldi li giro alla scuola» dove teneva dei vivacissimi corsi di sceneggiatura, in un avvincente ping pong di idee tra il professor Márquez e i suoi affascinati studenti. E, a proposito di Cuba, Gabo è stato anche l’amico personale (cosa discussa, cosa criticata) di Fidel Castro. Un’amicizia che non amava commentare. Un discorso, quello sul socialismo reale, che cercava di schivare: «Non sono mai stato comunista. Non ho studiato il marxismo, anche perché non pensavo potesse applicarsi a una realtà particolare come quella del Sudamerica. A dire il vero, non ho studiato proprio niente. Quello che so l’ho imparato vivendo, comprese le necessità dell’America latina, compresa la mia simpatia per Cuba e la rivoluzione cubana». Quanto all’amicizia con Fidel nata, raccontava, con uno scambio di libri ( Il diario dell’anno della peste di Defoe e il Dracula di Stoker) è stata «un’amicizia molto personale, che si è tradotta in un’amicizia per il paese». Il cinema è stato l’amore non sempre corrisposto di Márquez, che da ragazzo è stato allievo del Centro sperimentale a Roma, amico di Zavattini, di Carlo Di Palma e di Pontecorvo, ultimo assistente («il miracolo è avvenuto ») di Blasetti sul set di Peccato che sia una canaglia , sceneggiatore di film come il suo Tiempo de morir e Edipo alcalde trasposizione colombiana dell’ Edipo redi Sofocle («un modello assoluto, una scoperta abbagliante: l’unica storia che conosco in cui l’investigatore scopre di essere lui stesso l’assassino»), ambedue tiepidamente accolti, ispiratore di film belli e meno belli come Cronaca di una morte annunciata e L’amore ai tempi del colera. Ma un amore, quello per il cinema, che non ha mai ceduto di fronte al fascino della scrittura. «Quando scrivo» diceva in quella sua prosa sempre poetica, anche quando parlava nel suo deliziosamente imperfetto italiano, «sono un uomo libero, solitario nella mia isola. Non devo farmela con nessuno, tantomeno con i soldi. Sì, credo di aver scritto Cent’anni di solitudine contro il cinema, per dimostrare che con la scrittura si può fare di più». E tantissimo ha fatto. Inventando meravigliose favole del reale che sono diventate una moderna mitologia per 32 tutti. Dando voce a un continente. Restando fedele alla sua terra. Unico tra i premiati del Nobel (signore a parte) a presentarsi alla cerimonia di Stoccolma non con il frac, che Gabo considerava il vestito dei morti e dei becchini, ma con il caraibico liquiliqui , la camicia bianca a piegoline che, con lui, è diventata la bandiera della cultura dello Stato libero di Macondo. 33 INTERESSE ASSOCIAZIONE Da il Venerdì di Repubblica del 18/04/14, pag. 65 È PACE NELL'ARENA Il 25 aprile, anniversario della Liberazione, sarà celebrato quest'anno con lo slogan «La liberazione oggi sì chiama disarmo»: l'intero movimento pacifista, laico e religioso, si riunirà dalle 12 alle 20 all'Arena di Verona, per lanciare una nuova campagna contro le armi. L'Italia è ancora tra le prime dieci potenze militari del Pianeta (arenapacedisarmo.org). 34 ECONOMIA E LAVORO Del 18/04/2014, pag. 6 Bonus in busta paga a 15 milioni di italiani 80 euro per metà di loro trenta agli incapienti Il top degli sconti ai redditi tra 18 e 25 mila euro Operazione da 7 miliardi, aliquota Irap al 3,5% ROBERTO PETRINI ROMA . Un bonus-Irpef per 15 milioni di contribuenti. Arriverà a 80 euro (620 per otto mesi) nella fascia più ampia, tra i 18 mila e 24.500 euro lordi all’anno. Risorse anche per gli «incapienti», i più poveri che guadagnano fino ad 8.000 euro lordi, e che avranno dai 22 ai 35 euro al mese netti in più busta paga. Una platea che si allarga, dal tetto dei 25 mila euro previsti inizialmente, fino a coloro che guadagnano 28 mila euro lordi annui (44 euro per chi guadagna 26 mila euro lordi). Il tutto a partire da maggio e finanziato anche per il 2015 (ci sarà il medesimo beneficio mensile): senza contare che il decreto conferma anche il bonus-Letta che eroga in media una quindicina di euro che si sommeranno al nuovo beneficio fiscale. Il consiglio dei ministri varerà il decreto, composto per ora di 41 articoli, in giornata. Ieri Renzi si è visto a lungo con il ministro dell’Economia Padoan, il sottosegretario Delrio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Boschi e i tecnici della Ragioneria. Ma al Tesoro si è lavorato per tutta la notte per mettere a punto i dettagli. «Non ci spaventa l’ira dei mandarini», è la battuta più gettonata. L’operazione Irpef costa circa 7 miliardi, di cui 700 milioni destinati ai cosiddetti «incapienti», coloro che non pagano tasse perché hanno redditi troppo bassi e che non avrebbero avuto la possibilità di beneficiare di un aumento delle detrazioni. Per ovviare a questo ostacolo (ed anche per evitare l’effetto distorsivo delle curve delle detrazioni) si è studiato il meccanismo di un credito d’imposta Irpef che viene dato in forma fissa. Sarà erogato a partire dalla bustapaga di maggio dai datori di lavoro che, a loro volta, lo riavranno dal fisco in sede di compensazione. Scatta anche l’annunciato e, in bilico fino all’ultima ora, taglio dell’Irap, imposta pagata da imprese e professionisti: il taglio sarà del 5 per cento a partire da maggio (l’aliquota scende dal 3,9 al 3,75 per cento) e del 10 per cento nel 2015 (ulteriore discesa fino al 3,5 per cento). Per circa 4,5 milioni di imprese il risparmio medio, calcolato dalla Cgia di Mestre, quest’anno sarà di 402 euro e di 804 per il prossimo. L’operazione verrà finanziata con l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie (esclusi i titoli di Stato) dal 20 al 26 per cento. La spending review, per 4,5 miliardi, investe la «casta», i manager superpagati e incide su rendite e sprechi. Ma colpisce anche la sanità e il ministro Beatrice Lorenzin è già sul piede di guerra. Il Servizio sanitario sarà chiamato a versare circa 868 milioni nel 2014 con la riduzione dei rimborsi sui farmaci (468 milioni) e un taglio all’acquisto di beni e servizi. In due anni l’accetta cala per 2,4 miliardi. Il previsto colpo ai manager si allarga e si consolida. Dal 1° maggio prossimo scatta il tetto-Quirinale alle retribuzioni dei dirigenti della pubblica amministrazione (con riduzioni per scaglioni anche per gli stipendi immediatamente inferiori). Tagliola per magistrati, medici, alti gradi dell’esercito, docenti universitari. Il tetto Quirinale riguarderà anche i manager delle società (anche quelli recentemente nominati) partecipate dallo Stato e dai Municipi. Ma è prevista anche la riduzione degli 35 stipendi di Bankitalia, delle autorità indipendenti e della Corte costituzionale, di Camera e Senato. Colpiti anche i gabinetti dei ministri che dovranno dimagrire del 20 per cento e le consulenze che dovranno essere rinegoziate entro 30 giorni. Circa 24 milioni verranno dal taglio delle spese della Presidenza del Consiglio. Affitti e auto blu (al massimo 5 auto per ministero) completano il quadro. Mentre i partiti non potranno più godere delle agevolazioni postali per le campagne elettorali. L’operazione Consip su beni e servizi darà in tutto 800 milioni: tutte le spese delle amministrazioni pubbliche dovranno essere messe su Internet. Palazzo Chigi valuta l’intera operazione anti-casta in 600 milioni. Alcuni dei temi più dibattuti nelle ultime settimane entrano nel decreto: deciso il taglio al programma F35 (150 milioni nel 2014 e 900 l’anno prossimo). Previsto anche il taglio per 1 miliardo delle agevolazioni alle imprese. Si dispone inoltre il trasferimento del pubblico registro automobilistico dall’Aci alla Motorizzazione e la riforma dell’Enit, l’agenzia per il turismo. Le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, dello Stato dovranno tagliare i costi dal 2 per cento nel 2014. Sforbiciata anche ai Caf e ai patronati per l’assistenza fiscale e previdenziale, mentre torna l’Imu sui fabbricati rurali a partire dal 1° gennaio di quest’anno. Nel menù anche i trasferimenti alle Regioni e ai Comuni. I Municipi dovranno risparmiare anche sull’illuminazione pubblica: 100 milioni dagli «interruttori spenti» per giardini e monumenti. Confermate, tra le coperture, anche l’incasso dell’Iva per l’operazione di pagamento dei debiti alle imprese e l’aumento delle tasse sulle plusvalenze delle banche sulle quote Bankitalia (1,4 miliardi). del 18/04/14, pag. 6 Rinvio del pareggio con Sel ed ex M5S Lavoro, Alfano frena sulle modifiche Andrea Ducci ROMA — Ultime curve per il via libera al Def (Documento di economia e finanza) in vista del Consiglio dei ministri di oggi. La giornata di vigilia è servita ad assolvere agli ultimi passaggi formali e tecnici del provvedimento che consentirà al premier Matteo Renzi di varare il decreto per lo sgravio Irpef, destinato ai lavoratori dipendenti. Per approvare il bonus serviva il voto in Aula alla Camera e al Senato sul Def. L’esito era abbastanza scontato a Montecitorio (348 voti favorevoli, 143 i contrari ), un po’ meno a Palazzo Madama. Per cui non sorprende il risultato al termine delle votazioni dei senatori. Pur approvato, il documento è stato votato da una maggioranza risicata. Al vaglio del Parlamento, oltre al via libera del Def, c’era da approvare la richiesta del governo per rinviare il pareggio di bilancio al 2016. A poco è servita l’audizione del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che in Senato si è limitato a ricordare «nonostante i segnali di ripresa dell’anno in corso, anche nel 2014 il gap rimarrà molto negativo, la ripresa economica ancora fragile e la situazione del mercato del lavoro difficile». Il ministro ha ripetuto che «per favorire il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione il governo ha intenzione di avvalersi della procedura eccezionale», chiedendo il rinvio del pareggio. L’Aula del Senato ha approvato con 170 voti (era richiesta la maggioranza assoluta) a favore dello spostamento del pareggio. Il punto è che solo 162 voti sono stati espressi dalla maggioranza che sostiene il governo, gli altri 8 sono arrivati dalle forze di opposizione. Ad allinearsi alla truppa governativa sono stati il leghista Roberto Calderoli (primo firmatario della risoluzione con la quale Palazzo Madama ha recepito la richiesta dell’esecutivo), 5 esponenti di Sel e, infine, 2 degli ex M5S. Sul Def i risultati di voto hanno 36 registrato 156 voti a favore e 92 no. La votazione è finita sotto la quota 161, quella che assicura la certezza di sopravvivenza all’esecutivo. I numeri della maggioranza, insomma, seppur sufficienti hanno ricordato ancora una volta la precarietà del governo a Palazzo Madama. Tanto che Renato Brunetta, capogruppo del Pdl alla Camera, si è subito spinto a sottolineare che il provvedimento è passato «con l’aiuto di una decina di voti da parte di sedicenti opposizioni». Un ulteriore scollamento tra le forze di maggioranza è emerso in Commissione lavoro a Montecitorio, dove i deputati di Ncd non hanno partecipato al voto sul decreto legge predisposto dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Tutta colpa di un emendamento, presentato dal Pd, che ha ridotto da 8 a 5 le possibili proroghe riservate ai contratti a tempo determinato nell’arco di tre anni. Secondo Maurizio Sacconi e Sergio Pizzolante, entrambi di Ncd, il Pd avrebbe smontato e stravolto il decreto Poletti contestando l’introduzione di «irrigidimenti» e «meccanismi punitivi su apprendistato e formazione. Sacconi si è spinto a dire, «non siamo alla crisi di governo, ma c’è un trauma che non possiamo non segnalare». In serata è intervenuto Poletti per ricucire lo strappo. «Credo che l’esame svolto dalla Commissione lavoro, pur apportando alcune modifiche al testo, si sia concluso senza stravolgerlo e rispettandone i contenuti fondamentali», ha spiegato . Andrea Ducci del 18/04/14, pag. 3 Tutti i tagli per finanziare il bonus elettorale: si comincia dalla sanità Roberto Ciccarelli Indiscrezioni, o quasi. Sembra confermata la riduzione anche del programma di acquisto degli F 35 Lungo vertice ieri tra il presidente del consiglio Matteo Renzi, il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan con l’aggiunta dei fedelissimi Maria Elena Boschi, Graziano Delrio e Luca Lotti. Più di tre ore per trovare calibrare meglio i tagli alla spesa pubblica per finanziare il bonus elettorale del taglio dell’Irpef. Per tenere calmi i giornali, sui quali impazzano previsioni di ogni tipo (l’ultima sul taglio alle detrazione che ha aperto diversi giornali ieri è stata smentita di buon mattino), il governo ha dato in pasto alle agenzie una bozza semiufficiale dei tagli che andranno a finanziare la campagna elettorale del Pd. E ha precisato: «potrebbe cambiare nelle prossime ore». Al momento i tagli della spending review sono i seguenti: oltre 5 miliardi nel 2014, oltre 20 per il 2015 e oltre 30 per il 2016. Il salasso verrà inferto alla sanità pubblica un altro colpo: circa 2,4 miliardi di euro di tagli in due anni. Le risorse per finanziare il Servizio sanitario nazionale saranno infatti ridotte di 868 milioni quest’anno e 1,5 miliardi dal 2015. C’è la limitazione dei farmaci rimborsati inseriti in fascia A che non verrà applicata ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal Ssn è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso. Sarebbe inoltre previsto che le regioni autonome e le province di Trento e Bolzano riducano le spese per l’acquisto di beni e servizi per 200 mln nel 2014 e per 500 mln a partire dal 2015. Il tetto per la spesa farmaceutica territoriale passerà dall’attuale 11,35% all’11,25% del Fondo sanitario nazionale, mentre quella ospedaliera viene rideterminata dal 3,5% al 3,4%. A decorrere dal 2015, i tetti saranno rispettivamente dell’11,20% e del 3,35%. Le 37 spese militari subiranno una riduzione non inferiore a 200 mln per il 2014 e a 900 mln a partire dal 2015. Sarebbe previsto un risparmio anche sul programma di acquisto degli F35. Quanto alle imprese, è prevista una riduzione dei trasferimenti e del credito di imposta che deve essere ancora determinata. Confermato l’aumento al 26% dell’aliquota sulle rendite finanziarie. Nel mirino anche buoni taxi e noleggio di auto per la P.A., le authority e le società controllate dalle amministrazioni. Sono stati inseriti anche i tetti agli stipendi dei dirigenti di amministrazioni e società pubbliche. Nessun compenso potrà superare quello del presidente della Repubblica (240 mila euro) in base al quale (con riduzioni in percentuale) saranno calcolati anche i salari delle fasce più basse. Tra questi ci sono i magistrati (l’Anm ha alzato la voce contro questo «taglio unilaterale») e i docenti universitari. Il dl Irpef-spending review elimina dal primo gennaio di quest’anno l’esenzione Imu per i fabbricati rurali ad uso strumentale, uno dei capitoli della saga del governo Letta-Berlusconi. Tagli lineari sono previsti per le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta dello Stato che dovranno inoltre risparmiare non meno del 2% nel 2014 e il 3,5% nel 2015». Questa misura non si applica a quelle in via di privatizzazione, al momento Poste e Enav (per non rovinare il mercato, a quanto sembra). Tra le molte reazioni sollevate dai nuovi annunci renziani scegliamo quelle dell’opposizione interna al Pd. Per Stefano Fassina, Alfredo D’Attorre e Cesare Damiano manca la svolta contro l’austerità, si continua a precarizzare il lavoro e i tagli sono insostenibili. Propongono di rivedere l’articolo 81 della Costituzione che non permette di derogare al pareggio di bilancio neppure per spese di investimento. Per Gianni Cuperlo invece «il Def va nella giusta direzione». Tante voci e posizioni divergenti. Renzi dorme sogni tranquilli. del 18/04/14, pag. 1/2 Il pareggio è un abbaglio Riccardo Realfonzo Con la manovra economica descritta nel Documento di Economia e Finanza (Def), il governo riconosce che il pareggio di bilancio strutturale (al netto del ciclo economico) non potrà essere conseguito il prossimo anno. Prevede dunque di posticipare di un anno, al 2016, il raggiungimento dell’obiettivo. Perciò, il ministro Padoan ha scritto alla Commissione Europea e il Parlamento ha dato il suo placet, il tutto secondo quanto previsto dai trattati europei e dal principio del pareggio di bilancio introdotto di recente nella nostra Costituzione. La domanda è: saremo in grado di raggiungere l’obiettivo tra due anni? Per farcene un’idea, forse è bene ricordare che quando negli Usa, nel 2011, la destra repubblicana spinse per introdurre nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, cinque premi Nobel e altri autorevoli economisti scrissero a Obama. Spiegarono che «inserire un tetto alla spesa pubblica peggiorerebbe le cose» e «chiudere il bilancio in pareggio aggraverebbe le recessioni ». Il pareggio di bilancio è dunque una «pericolosa camicia di forza» che «impedirebbe al governo di ricorrere al credito» quando ce n’è bisogno e «favorirebbe dubbie manovre finanziarie, quali la vendita di beni pubblici». Obama ascoltò l’allarme dei Nobel e si guardò bene dall’inserire il pareggio in Costituzione. In Italia, invece, abbiamo zelantemente recepito il principio e inseguiamo da anni con pervicace coerenza un fantomatico obiettivo di «sana finanza pubblica», sforzandoci di comprimere la spesa statale e segnando il record europeo degli eccessi delle entrate fiscali sulla spesa al netto degli interessi. Abbiamo così ridotto la spesa pubblica di oltre sei punti di Pil negli ultimi 38 venti anni, portando la spesa complessiva per cittadino, in termini reali, ampiamente al di sotto della media dell’eurozona. E ciò con risultati desolanti, soprattutto in termini di bassa domanda aggregata di beni e servizi, bassa produzione e alta disoccupazione; ma anche per gli stessi obiettivi di finanza pubblica che i diversi governi si erano posti: in pratica, più abbiamo applicato il principio del pareggio e più gli obiettivi ci sono scappati di mano. Nel settembre 2011 la coppia Berlusconi- Tremonti, incalzata dall’Europa, aveva assicurato che, con le manovre impostate, il pareggio strutturale si sarebbe conseguito due anni dopo, nel 2013. Cosa che naturalmente non è avvenuta. Del resto, anche le loro previsioni per il 2012 risultarono erronee: avevano previsto una riduzione del Pil di appena lo 0,6% ed invece cadde di ben 2,4 punti, con il debito pubblico che schizzò quasi 9 punti più in alto di quanto avevano annunciato. Con il governo Monti da questo punto di vista le cose non mutarono. Nel Def del 2012, con l’aggiornamento autunnale e addirittura con il Def del 2013 di aprile, Monti e Grilli si incaponirono nel sottolineare l’effetto taumaturgico della manovra Salva-Italia e in generale dei «compiti a casa», prevedendo costantemente di raggiungere il pareggio strutturale nel 2013. Anche questa volta un nulla di fatto. Anzi, il Pil precipitò ancora di 1,9 punti, mentre il governo nella primavera dell’anno precedente aveva addirittura previsto una crescita di mezzo punto. Quanto al debito pubblico, crebbe di ben undici punti in più rispetto alla previsione. Con la Nota di Aggiornamento di Letta e Saccomanni del settembre scorso la previsione di pareggio strutturale è stata ancora spostata nel futuro, questa volta al 2015, e le loro previsioni sulla crescita del Pil nel 2014 (+1%) e sul debito (132,9%), apparse subito ottimistiche, sono già state smentite dallo stesso governo Renzi, che ha provveduto a spostare ancora una volta in avanti l’obiettivo di pareggio strutturale, al 2016. I motivi di questi clamorosi fallimenti previsionali - ma anche di quelli di altri governi europei e di importanti istituzioni internazionali - sono presto detti. Si è costantemente sottovalutato il fatto che insistere con tagli della spesa determina, soprattutto in fasi recessive, una violenta caduta della domanda aggregata di merci e servizi. E se cala la domanda le imprese riducono i livelli di produzione, con il risultato che l’occupazione, il reddito e le stesse entrate fiscali si contraggono. Finché continueremo a muoverci in questa assurda direzione, il risanamento delle finanze pubbliche sarà un po’ come il miraggio per chi si è perso nel deserto: una splendida oasi che appare nitida, verso cui ci si muove, ma che continua ad allontanarsi. del 18/04/14, pag. 2 Se 3 anni vi sembran pochi Antonio Sciotto Contratti a termine. Poletti vince la battaglia sul tempo determinato: restano i 36 mesi senza causale. Ma alla Camera si introducono correttivi e garanzie: dal diritto di precedenza alle assunzioni degli apprendisti Alla fine il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha ottenuto che la Commissione Lavoro della Camera non intervenisse su quello che riteneva un paletto invalicabile, i 36 mesi senza causale per i contratti a termine. La commissione, presieduta dal Pd Cesare Damiano, ha approvato un testo che però modifica il suo decreto, migliorandolo in alcune parti pur lasciando inalterato appunto il «totem» dei tre anni di precarietà. E lo ha fatto con il solo sì del Partito democratico, mentre Ncd – in forte polemica con l’alleato di 39 maggioranza – non ha partecipato alla votazione. Scelta civica e Forza Italia si sono astenute, mentre Sel, M5S e Lega Nord hanno votato no. L’accordo sui contratti a termine, che peraltro incassa l’ok da Poletti – «Non è stato stravolto, adesso passi all’ok dell’Aula» – si aggiunge a un altro espisodio piuttosto grave, ovvero il rinvio al ddl delega (cioè, se va bene, a metà 2015) della legge sulle dimissioni in bianco. Sel aveva fatto di tutto per reintrodurre questo principio di civiltà nella legislazione: la prima legge, dell’allora ministro Damiano, risale al governo Prodi, ma poi il successivo esecutivo Berlusconi l’aveva cancellata («troppa burocrazia», aveva detto il ministro Sacconi); infine c’era stata un parziale, ma debole, ripristino sotto Monti. Il nuovo testo alla Camera era passato grazie all’alleanza Sel-Pd, ma al Senato gli equilibri si sono capovolti, e il Pd ha deciso di appoggiare l’idea di Forza Italia di infilare la riforma nel ddl delega. Quanto al «decreto Poletti», la novità principale riguarda la riduzione delle proroghe possibili: da otto passano a cinque. L’emendamento del relatore Carlo Dell’Aringa, quello che è stato approvato e che ha quindi introdotto le modifiche, prevede inoltre che il congedo di maternità «concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza» nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte dell’azienda. Alle stesse lavoratrici è anche riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, «con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine». La proposta di modifica passata in Commissione Lavoro della Camera, prevede, inoltre che il datore di lavoro «è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza» attraverso «comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione». I contratti a tempo determinato potranno raggiungere il tetto massimo del 20% rispetto al numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. La sanzione prevista per chi non rispetta la regola è l’assunzione a tempo indeterminato di tutti i nuovi assunti oltre quel 20%: «I lavoratori assunti a termine, in violazione del limite percentuale, sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro». Garanzie sono state introdotte anche nei contratti di apprendistato: è stato reinserito l’obbligo di formazione pubblica, ma esso decade dopo 45 giorni dall’assunzione nel caso in cui la regione non abbia attivato le procedure. La formazione svolta in azienda dovrà avere un programma scritto. Ancora: le imprese con più di 30 dipendenti dovranno assumere almeno il 20% degli apprendisti, prima di poter stipulare nuovi contratti. Interessante il fatto che tra le modifiche introdotte c’è una sorta di norma di «principio», quasi a giustificare l’urgenza della legge Poletti: le nuove regole vengono introdotte «in considerazione della perdurante crisi occupazionale», per «rafforzare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro». Ma si precisa anche che «il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro». Se la Cgil protesta per le dimissioni in bianco – «Si è persa un’importante occasione» – le modifiche alla legge Poletti poste alla Camera non piacciono a Ncd, che annuncia battaglia: si dovrà vedere ovviamente come andrà ora in Aula, e poi appunto al Senato. Boccia le modifiche anche Rete Imprese per l’Italia: «Si torna alla logica delle sanzioni, tornano le norme penalizzanti per le assunzioni». del 18/04/14, pag. 6 Rete imprese: «gli ultimi ritocchi sono un passo indietro» 40 Il congedo di maternità varrà per il posto fisso Le ultime novità del «Job acts». Solo 5 rinnovi per i contratti a termine. Obbligo di formazione per gli apprendisti MILANO - Contratto a termine: da otto rinnovi in tre anni si scende a cinque. Apprendistato: torna la formazione nero su bianco, in forma scritta e obbligatoria. Questo il maquillage apportato ieri in commissione lavoro della Camera al decreto lavoro del ministro Poletti. Inoltre sarà più facile per le donne che hanno una maternità durante il contratto a termine ottenere una nuova assunzione. Rallenta, invece, la normativa sulle dimissioni in bianco. Nonostante un testo di legge approvato dalla Camera, ora la materia rientrerà nella delega che sarà conferita al governo in materia di lavoro. Tornando al decreto Poletti, il testo emendato passerà martedì all’Aula. Dentro alla maggioranza i deputati di Ncd non hanno partecipato al voto e quelli di Scelta civica hanno preferito astenersi. Sono le novità sull’apprendistato a non piacere a Maurizio Sacconi, presidente dei senatori del Nuovo centrodestra. Sul fronte sindacale le modifiche non hanno cambiato gli schieramenti: Cisl favorevole al decreto, Cgil e Uil sempre contrarie. Come contraria, con motivazioni opposte, è Rete imprese Italia. Le associazioni di commercio e artigianato dicono all’unisono: «Con gli emendamenti di oggi il decreto rischia di essere un’occasione sprecata». Nel dettaglio delle novità introdotte ieri, per quanto riguarda il contratto a termine, oltre alla riduzione dei rinnovi possibili, è stato stabilito che le aziende che esagerano con i dipendenti a tempo determinato superando il limite del 20% siano tenute ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori in eccesso rispetto a questa soglia. Fin qui Ncd poteva digerire le novità. Quello che proprio non è andato giù al Nuovo centro destra è che il Pd abbia voluto ripristinare il progetto formativo in forma scritta per l’apprendistato. Altrettanto indigesta la reintroduzione della formazione obbligatoria che non esisteva nel testo Poletti: dopo l’assunzione dell’apprendista, le Regioni avranno 45 giorni per comunicare all’azienda le modalità della formazione. Se nessuno si farà vivo allora l’impresa sarà liberata dall’incombenza. Visto che Regioni come il Veneto organizzano i corsi nel 65% dei casi, contro il 3% della Calabria, in alcuni territori la formazione si farà e in altri no. Per finire, per assumere apprendisti, nelle imprese con più di 30 dipendenti, il 20% di quelli ingaggiati in precedenza dovrà essere stato riconfermato. «Lo Stato spende ogni anno due miliardi per gli sgravi sull’apprendistato - fa notare Carlo Dell’Aringa, Pd, relatore del testo -. Era giusto chiedere un impegno alle imprese». Per finire, le mamme con contratto a termine. Qui bisogna ricordare che già oggi chi ha lavorato a tempo determinato per almeno sei mesi, nell’anno successivo ha diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni nelle stesse mansioni. La novità è che le donne che restano incinta mentre sono a termine possono conteggiare anche la maternità come durata del contratto (in questo modo sarà più facile superare la soglia chiave dei sei mesi). Inoltre, se nell’anno successivo l’azienda assume, hanno la precedenza. «Finalmente un’operazione concreta di tutela della maternità - esulta la vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli -. Tanto più importante perché parliamo di donne che non hanno un lavoro stabile». 41 del 18/04/14, pag. 3 Contratti a termine tagliate le proroghe I rinnovi ridotti da otto a cinque, maggioranza divisa, Ncd vuole il vecchio testo ● Modifiche contestate anche per l’apprendistato: più garanzie per la formazione e le assunzioni Giuseppe Vespo Le modifiche ai contratti a termine e all’apprendistato spaccano la maggioranza in Commissione Lavoro alla Camera, tanto che sul decreto legge del ministro Poletti il governo potrebbe dover mettere la fiducia. In Aula la discussione generale si apre oggi, il voto è previsto tra martedì e mercoledì. A far saltare gli equilibri sono i ritocchi ai contratti a tempo, voluti dal Pd e approvati dalla Commissione. Il testo del governo prevedeva la possibilità di rinnovare per otto volte in tre anni i contratti a termine senza «causale», ovvero senza specificare il motivo, il perché di un’assunzione per un periodo determinato. Adesso le possibili proroghe diventano cinque. La cosa ha mandato su tutte le furie il Nuovo centro destra, che non ha partecipato al voto in Commissione, e in particolare l’ex ministro Maurizio Sacconi, attuale presidente della Commissione Lavoro del Senato. Insieme al suo leader Angelino Alfano, Sacconi ha convocato una conferenza stampa per dire che «sul tema del lavoro il Pd non tiene e questo non è un aspetto secondario. Non siamo alla crisi di governo ma c’è un trauma che non possiamo non segnalare: c’è stato un problema alla prima curva. Sarà necessario un chiarimento politico sulla lealtà parlamentare del Partito democratico agli atti di governo». DA OTTO A CINQUE È chiaro che per l’ex ministro del governo Berlusconi quelle apportate dai Democratici non possono essere migliorie al testo del governo, così come le ha definite tra gli altri Gianni Cuperlo. Cinque non è meglio di otto per Ncd, neanche se si considera che con la riforma Fornero i contratti a tempo senza causale potevano essere rinnovati una sola volta in dodici mesi. In Aula sarà battaglia promette il centro destra, che lamenta la presenza di troppi ex sindacalisti tra i banchi della Commissione. Una considerazione che ha trovato la replica del presidente Cesare Damiano, «orgoglioso della sua vita sindacale». Damiano si è detto sicuro che «se il governo porrà la fiducia lo farà sul testo della Commissione», visto che «ogni emendamento approvato è stato condiviso dal relatore e dal governo». E in serata è arrivata la conferma dello stesso ministro Poletti, che ha definito le correzioni della Camera in linea con il decreto, «senza stravolgerlo e rispettandone i contenuti». Tra le novità sempre in tema di contratti precari, un emendamento introduce il tetto limite del venti per cento, oltre il quale le aziende non potranno ricorrere a nuovi tempi determinati. «I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto di lavoro ». La norma sarà in vigore dalla fine dell’anno. Ritorna pure il diritto di precedenza dei lavoratori e delle lavoratrici precarie e in maternità, sulle eventuali assunzioni a tempo indeterminato che il datore di lavoro dovesse prevedere nell’ambito delle stesse mansioni. STABILIZZAZIONI Altro tema caldo resta l’apprendistato. Anche in questo caso le modifiche apportate hanno trovato le critiche di parte della maggioranza. I cambiamenti riguardano il ripristino della 42 quota di formazione pubblica, la redazione di un piano scritto di formazione da inserire nel contratto di assunzione dell’apprendista e la stabilizzazione del venti per cento degli apprendisti nelle aziende che occupano trenta o più persone. DIMISSIONI E mentre alla Camera il Pd veniva attaccato dal Ncd, al Senato Sel denunciava, anche per bocca del presidente Nichi Vendola, il tentativo di affossare il decreto sulle «dimissioni in bianco», ovvero firmate sotto ricatto al momento dell’assunzione. Il disegno di legge, già passato a Montecitorio, mercoledì è stato affidato dai senatori della Commissione Lavoro al «Jobs Act». Per Loredana De Petris, senatrice di Sinistra ecologia libertà, «inserire tale norma nella legge delega sul lavoro equivale a prendere in giro i lavoratori, in particolare le donne, vittime principali di questa pratica vessatoria ». «Non è così», dice Rita Ghedini del Pd: «La maggioranza dei gruppi parlamentari è risultata a favore del percorso di confluimento nel Jobs Act, ma non rinunceremo per questo alla battaglia». Di «occasione mancata» parlano pure la Uil e la Cgil, quest’ultima critica nei confronti delle modifiche sui contratti a tempo: «Manca la svolta sulla precarietà. Si intuisce la volontà di mitigare gli interventi del decreto, ma in misura ancora insufficiente». «Bene i miglioramenti» per la Cisl, che chiede di favorire le stabilizzazioni. Il decreto scade il venti maggio. Entro mercoledì il voto alla Camera, poi si passa al Senato. Del 18/04/2014, pag. 2 Evaso 1 euro ogni 4 pagati sottratti 120 miliardi all’anno peggio di noi solo la Grecia Stime dall’elaborazione dei dati Bankitalia e Istat Gdf: Iva perno degli illeciti, falso in bilancio torni reato FEDERICO FUBINI ROBERTO MANIA INTREd ecenni la sua forza di fuoco in termini finanziari è quasi triplicata. Oggi l’evasione vale circa l’8 per cento del Pil, rispetto a un livello inferiore al 4 per cento dei Paesi europei più efficienti e capaci di conciliare crescita, conti in ordine e equità. Secondo la maggior parte delle stime, peggio dell’Italia fa solo la Grecia. Ma non c’è alcun dato certo perché nessun governo ha mai osato una stima pubblica e ufficiale della massa di risorse sottratte al fisco, o meglio delle tasse scaricate sui contribuenti onesti o incapaci di sottrarsi da quelli che invece sono capacissimi di farlo. Per quanto incredibile possa sembrare, questo Paese colpito e affondato dall’evasione non ha mai fatto lo sforzo di misurarla e poi informarne i cittadini. «Non esistono stime ufficiali», ha spiegato di recente ai membri della Commissione Finanze del Senato il generale della Guardia di Finanza Saverio Capolupo, augurandosi che presto si arrivi a formularla. Non dev’essere impossibile, dato che per esempio ogni anno in Gran Bretagna il governo calcola con precisione (e pubblica) la sua stima. Qui, niente. In realtà la cosiddetta delega per la riforma fiscale appena approvata in parlamento prevederebbe che si cominci a farlo, ma per attuarla servirà almeno un anno. Per ora si sa solo che l’Agenzia delle entrate ha stimato un «tax gap» (mancato gettito da evasione) intorno agli 80 miliardi, tenendo conto di Irpef, Ires, Irap e Iva. Ma non dell’evasione contributiva e di quella relativa alle imposte locali. Un’elaborazione sui dati forniti da Banca d’Italia e dall’Istat permette comunque di fissare fra i 100 e i 120 miliardi di euro il volume delle risorse sottratte grazie alle più svariate forme di evasione e elusione illegale. Per intendersi, è una somma superiore al 43 costo degli interessi sul debito pubblico, al monte retribuzioni lorde dell’intero personale dello Stato centrale, e pari a tre volte il bilancio dell’istruzione in Italia. Alla commissione Finanze del Senato, di recente Salvatore Chiri e Paolo Sestito della Banca d’Italia hanno ricordato che il gettito evaso dell’Irap, l’imposta regionale sulle imprese, è quasi un quinto di tutto ciò che dovrebbe essere pagato. Per l’Iva, il prelievo sui consumi, l’Agenzia delle Entrate stima l’evasione al 28%. E dell’Irpef, l’imposta sui redditi personali che nel 2013 da sola ha portato 157 miliardi all’erario, sparisce circa il 14%. Visto il gettito di queste voci, significa che ogni anno mancano all’appello (almeno) 5 miliardi di Irap, circa 40 miliardi di Iva e altri venti o 25 di Irpef. Fino a settanta miliardi di tasse evase su tre sole voci che pesano circa due terzi del totale delle entrate tributarie dello Stato. Nel complesso, è dunque molto probabile che l’evasione sottragga almeno cento miliardi l’anno. Poiché le entrate fiscali nel 2013 sono state di 426 miliardi, di fatto ogni quattro euro regolarmente pagati in tasse dagli italiani uno è illegalmente sottratto. La situazione è tale che anche la Guardia di Finanza chiede ormai al governo interventi precisi. Quello più delicato è la revoca delle scelte compiute da Silvio Berlusconi più di dieci anni fa: è ora di fare (di nuovo) del falso in bilancio un reato penale, qualcosa per cui si può andare in prigione, in modo da dissuadere un’infinità di piccole frodi sull’Iva. Ha ricordato il generale Capolupo nella sua audizione in Senato: «Se le misure cautelari amministrative si sono rivelate finora poco efficaci, gli strumenti offerti dalla legislazione penale invece ci hanno permesso di arrivare a risultati importanti ». Le Fiamme Gialle chiedono poi al governo anche di scoraggiare ulteriormente l’uso del denaro contante, ben oltre il tetto a mille euro. Resta da vedere se questa maggioranza sarà pronta a recepire il messaggio di chi combatte l’evasione in prima linea o prenderà una strada diversa. Nell’ultimo Documento di economia e finanza la lotta all’evasione fiscale compare, ma legata all’attuazione delle delega fiscale in tempi non immediati. Non c’è alcuna enfasi e l’intero tema dell’evasione fiscale appare scolorito nell’agenda della politica. L’approccio rispetto ai precedenti governi a maggioranza di centro sinistra è diverso, come spiega il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti: «Questo governo non intende usare la lotta all’evasione fiscale come scusa per evitare la spending review», dice il sottosegretario di Scelta Civica. «Pensiamo anche che i blitz anti-evasori, tipo quello di Cortina, possano essere utili purché scompaia quella deleteria spettacolarizzazione. È come se l’Agenzia delle Entrate pensasse ad operazioni di marketing anziché al risultato, come dovrebbe fare un’istituzione», è la sua accusa. Non che l’Agenzia delle Entrate non abbia avuto dei successi negli ultimi anni. Gli incassi derivati da quella che definisce l’»attività di controllo» sono progressivamente saliti da 2,1 miliardi di euro del 2004 fino a 13,1 miliardi del 2013. Ma non tutti sono convinti che si stia facendo tutto il possibile. «La verità è che dopo l’ultimo governo Prodi non si è più seguita una linea di controllo dell’evasione », sostiene l’ex ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, oggi tornato all’insegnamento universitario. Con il suo centro di ricerca Nens, Visco sta preparando un rapporto analitico sull’evasione con alcune proposte per combatterla. Peraltro anche l’ex ministro è critico sui metodi seguiti di recente. «C’è stato un blocco della lotta contro l’evasione, compensato con i blitz modello Cortina, che non danno risultati — dice — . Invece, andrebbe ripresa con una strategia di medio-lungo periodo agendo su più leve: modifiche alle leggi, incrocio delle informazioni e delle banche dati, rapporto preventivo con i contribuenti». Nel frattempo l’evasione fiscale continua ad agire sulla società come una sostanza tossica che ne erode i connotati. Basta dare un’occhiata al confronto europeo per capire fino a che punto l’evasione stia producendo disoccupati in questo Paese. L’Italia è ai vertici, seconda nell’Unione europea a 28 Paesi dopo il Belgio, per il peso del fisco sul costo del lavoro: oltre il 30. Dunque le imprese fanno meno assunzioni e quando si possono si liberano del personale. Per un motivo, fra gli altri, si cui 44 sono responsabili esse stesse: evadono l’Iva, dunque lo Stato tiene alte altre imposte, soprattutto sul lavoro. L’Italia è infatti fra le ultime (dopo Spagna e Irlanda) per gettito Iva nella Ue. E il perno dell’evasione è qui: circa 36 dei 100-120 miliardi di evasione. Questa è la tassa più evasa, anche per la diffusione del lavoro autonomo con oltre 5 milioni di partite Iva. «Sottrarsi a questa imposta consente di occultare base imponibile per il pagamento di altri tributi», sostiene la Banca d’Italia. Chi evade su determinate operazioni non si può che farlo, a cascata, sul reddito frutto di quelle operazioni. Nel 2013 la Guardia di Finanza ha accertato 4,9 miliardi di euro di Iva non pagata, di cui 2 miliardi riconducibili alle cosiddette “frodi carosello” basate su fittizie transazioni commerciali con l’estero. Un caso scoperto a Taranto all’inizio di quest’anno dalle Fiamme Gialle: tre società servivano formalmente ad acquistare automobili e ad emettere fatture fittizie ai reali venditori. Questi hanno dedotto l’Iva sulle fatture emesse dalle società fittizie ottenendo un vantaggio che ha permesso di rivendere le vetture ad un prezzo impraticabile per i concessionari corretti. Era un giro di 16,5 milioni di fatture false per oltre tre milioni di Iva evasa. Un caso tipico di un popolo di santi, poeti e inventori delle più innovative tecniche di evasione con cui l’Italia finirà per affondarsi da sola. 45
Scarica