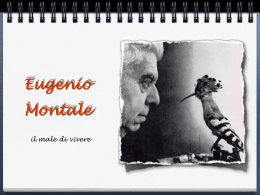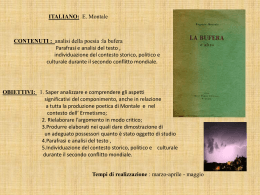« Lezione seconda » Quaderni del Centro Scolastico Diocesano –0– I Mercoledì letterari 2009-2010 INCONTRI CON LA LETTERATURA ITALIANA DEL NOVECENTO a cura di Giannino Balbis (con la collaborazione degli alunni delle classi IVa e Va) Redemptoris Mater Albenga 2010 3 I Mercoledì letterari al Redemptoris Mater “Gli studenti mangiano ciò che gli insegnanti hanno digerito” (la metafora è di Karl Kraus, autore de Gli ultimi giorni dell’umanità, il noto dramma sulla prima guerra mondiale). Così funziona la scuola – quando funziona – né può essere altrimenti. Soprattutto nel processo di trasmissione delle conoscenze, ma anche in quello di formazione delle competenze e delle abilità, i docenti fungono principalmente da mediatori. Per quanto riguarda in particolare i docenti di lettere, le mediazioni sono a vari livelli. Bisogna spiegare agli allievi (spiegare nel significato etimologico di explicare, cioè “togliere le pieghe”, “rendere piano e chiaro” ciò che è complicato), da un lato, gli autori, con le loro vicende, le loro poetiche, i loro testi innanzi tutto e, dall’altro, le interpretazioni che degli stessi autori, delle loro idee e delle loro opere sono state date nel corso del tempo. Tra i contenuti da trasmettere e i destinatari da raggiungere c’è sempre di mezzo il lavoro di altri: degli specialisti della disciplina, dei professionisti della critica letteraria; e, in prima istanza, ci sono di mezzo anche i testi scolastici, a loro volta prodotti di mediazione (ben ponderati e calibrati in genere, ma sui numeri dei tabulati delle adozioni più che sulle esigenze della didattica reale). Il docente di liceo, d’altronde, se vuole fare bene il proprio mestiere (assai più impegnativo di quanto comunemente si creda), non ha tempo e opportunità per dedicarsi alla ricerca di prima linea: deve prendere per buoni (naturalmente con tutta la libertà di verifica e di critica) i risultati di studi altrui. Insomma, tra la poesia di Pascoli in programma e l’allievo Tal dei tali ci sono di mezzo, quanto meno, l’interpretazione – poniamo – di Bárberi Squarotti (come ignorare le sue fondamentali letture pascoliane?), la volgarizzazione che ne fa il libro di testo (con tutti i suoi apparati) e infine l’adattamento che ne deve comunque fare il 5 docente nel quadro del proprio progetto didattico e alla luce della classe reale che ha di fronte quotidianamente. Ogni passaggio di questa filiera è tutt’altro che facile e scontato: va ponderato, costruito e gestito con estrema attenzione. Il tutto, poi, in un contesto generale a dir poco problematico, dove il rischio maggiore, oggi come oggi, è l’asfissia da appiatti-mento. In una scuola trasformata in “agenzia”, con alunni e genitori travestiti da “clienti”, la centralità della funzione docente posta in seria discussione, le conoscenze di base e il livello di preparazione gravemente compromessi, sembra inevitabile e incontrastabile l’adozione della visuale dal basso, il progressivo appiattimento appunto sulle sempre meno attente e qualificate aspettative dell’utenza. Se questo è il panorama scolastico generale, non tutte le scuole sono così, per fortuna. Il nostro Istituto, in particolare, si distingue per un progetto educativo ben riconoscibile, forte e rigorosamente perseguito. Anche per questo può concedersi eccellenti spazi extracurriculari, come gli Incontri musicali curati da Alessandro Collina (negli ultimi anni sono stati ospiti del nostro Istituto, fra gli altri, i Berliner filarmonici, Paul Jeffrey, Philippe Petrucciani, Glauco Bertagnin, Herb Geller) e come gli Incontri con la letteratura italiana del ’900. Questi ultimi, varati in via sperimentale nello scorso anno scolastico (con le lezioni di Giangiacomo Amoretti, Francesco De Nicola e Roberto Trovato, rispettivamente sulla poesia, sulla narrativa e sul teatro del ’900), hanno assunto quest’anno forma più completa e stabile, articolandosi in sei lezioni distribuite in due cicli (il primo tra ottobre e dicembre, il secondo tra febbraio e aprile); nell’ordine: Giorgio Bárberi Squarotti (docente emerito dell’Università di Torino), Il Novecento letterario italiano; Giangiacomo Amoretti (Università di Genova), La grande poesia ligure del ’900: Sbarbaro, Montale, Caproni; Alberto Beniscelli (Università di Genova), Letture montaliane; Francesco De Nicola (Università di Genova), Il neorealismo nella letteratura italiana del ’900; Valter Boggione (Università di Torino), Il mito in Pavese e Fenoglio; Luigi Surdich (Università di Genova), Dante nella poesia del ’900. Dicevano già gli antichi che è più buona l’acqua bevuta direttamente alla sorgente. Per l’autorevolezza dei relatori e per l’ampio riscontro di pubblico, questi Incontri ne sono stati un’ennesima conferma. 6 Di essi offre un resoconto di massima il presente opuscolo, al quale hanno collaborato gli alunni delle classi IVa e Va (le classi finali dell’indirizzo classico e dell’indirizzo socio-psico-pedagogico) e che si presenta come “numero 0” di una nuova collana di ricerca e documentazione – «Lezione seconda. Quaderni del Centro Scolastico Diocesano» – che vede la luce presso il nostro Istituto. Il suo titolo, attribuendo al termine tipicamente scolastico di lezione il doppio valore dell’agg. secondo (in senso numerale e nel significato di “favorevole”), vuole rappresentare la stretta coesione tra attività curricolari ed attività culturali extra-curricolari, con l’auspicio di un sempre più solido livello di eccellenza per entrambe. Giannino Balbis 7 La lezione di Giorgio Bárberi Squarotti (21 ottobre 2009) GIORGIO BÁRBERI SQUAROTTI Il Novecento letterario italiano Dopo aver ricordato i limiti della periodizzazione (nella storia letteraria come nella storia in generale), Bárberi Squarotti individua le radici del Novecento negli anni ’80-’90 dell’Ottocento, con particolare riguardo alla crisi del Positivismo e del Naturalismo, alla grave crisi politica ed economica dell’Italia di fine secolo e alla svolta in direzione simbolistica dell’arte e della letteratura. Protagonisti di questa svolta, in Italia, sono stati soprattutto Pascoli e d’Annunzio, seguiti da Pirandello e Svevo. Il momento attuale rappresenta invece il definitivo tramonto del Novecento. Oggi non si concepisce e non si produce più letteratura con funzioni di messaggio, conoscenza, lezione, come è accaduto con molti autori del secolo scorso (Bárberi si è soffermato in particolare su I vecchi e i giovani di Pirandello, La cognizione del dolore di Gadda, Uomini e no di Vittorini e Il partigiano Johnny di Fenoglio), ma una letteratura facilmente comunicativa, ripetitiva, di rapido consumo. C’è da chiedersi se ci sia ancora spazio nel nostro tempo per la letteratura tradizionalmente intesa. La lezione si conclude con alcuni consigli di lettura per i giovani. Oltre ai classici antichi (a cominciare da Omero e dai tragici greci) e ai classici italiani (Dante, Ariosto ecc.), Bárberi raccomanda la lettura, fra gli stranieri, di Tolstoj, Dostoevskij e Proust. *** Non è possibile datare con precisione l’inizio e la conclusione di un periodo storico: le periodizzazioni non hanno alcun valore assoluto; sono semplici costruzioni convenzionali con cui gli studiosi cercano di ordinare gli avvenimenti del passato. Il Novecento non inizia, perciò, il 1° gennaio del 1901 e non finisce il 31 dicembre 1999. In ambito artistico-letterario, le radici del Novecento sono nella crisi di fine Ottocento, che coinvolge la letteratura italiana come le altre letterature europee: bisogna guardare agli anni ’80-’90, alla crisi del Positivismo e del Naturalismo e alla conseguente svolta in direzione simbolistica, di cui sono primi protagonisti, in Italia, Pascoli e d’Annunzio (poi seguiti da Pirandello e Svevo). 9 Alla spiegazione scientifica dell’uomo proposta dal Positivismo sfuggono i sentimenti, i sogni, le passioni. A fine ’800 si diffonde la consapevolezza che la scienza positiva, pur con la sua forza e la sua capacità di analisi, non è sufficiente per spiegare l’esperienza dell’uomo e del mondo nella loro interezza. Nasce così l’idea di una poesia, di un’arte, di una scrittura che siano alternative alla realtà scientifica. Si afferma un tipo di letteratura che privilegia il tentativo di spiegare il mondo e il nostro esistere attraverso sequenze di simboli, contro la letteratura realistico-naturalistica, di cui in Italia è principale esponente Verga (ma bisogna tenere presente che neppure naturalismo e verismo producono copie perfette della realtà: insieme alla realtà rappresentano sempre ciò che l’autore con essa vuole comunicare; d’altronde, la scienza è continuamente in divenire: la sua spiegazione del mondo muta alla luce di nuove ipotesi e teorie). In ogni caso, la letteratura simbolista privilegia il simbolo in opposizione alla rappresentazione oggettiva delle cose. Il suo obiettivo è quello di dare una spiegazione più ampia e più profonda delle cose. Pascoli ne è un esempio. Si prenda il suo famoso verso il sogno è l’infinita ombra del vero (dal poema conviviale Alèxandros): il vero è la scienza e l’infinita ombra è la dimensione indefinita e misteriosa che cela la profonda spiegazione del nostro essere. E accanto a Pascoli, d’Annunzio. Fra i due ci sono vari punti in comune: in particolare, la rappresentazione del mondo e dell’uomo al di là della loro immagine scientifica e la critica radicale alla degradazione dell’economia, della società, della civiltà moderna. A questo riguardo si possono ricordare due odi – la prima di d’Annunzio (pubblicata all’inizio di agosto 1900), la seconda di Pascoli (del 20 agosto) – dedicate entrambe al re: quella dannunziana è dedicata al “Re giovane” (cioè al successore di Umberto I), quella pascoliana al defunto re Umberto I, ma entrambe rappresentano la morte, commemorano, riflettono sulle vicende italiane. [L’ode di Pascoli ha certamente subito l’influsso di quella di d’Annunzio. Le storie letterarie hanno il difetto di procedere per blocchi: prima Carducci, poi Pascoli e poi d’Annunzio. In realtà, le prime poesie di d’Annunzio risalgono al 1879 e sono di sei anni precedenti a quelle della prima raccolta di Pascoli, pubblicata nel 1891]. In d’Annunzio sono da sottolineare, in particolare, la rappresentazione della decadenza sempre più radicale della società e dell’eco10 nomia e il tema della bellezza antica e della natura penalizzate nell’età moderna o addirittura scomparse agli occhi di un popolo schiavo che non riesce più a cogliere la bellezza del mondo. È necessaria una trasformazione del modello decaduto della società borghese e, di conseguenza, del romanzo borghese romanticoottocentesco. Perciò nei romanzi di d’Annunzio ci sono personaggi nobili o borghesi che si ribellano alle norme del vivere comune o personaggi che amano la bellezza e l’età antica. Perciò in Pascoli c’è speciale attenzione al mondo contadino, come alternativa radicale e ideale al mondo moderno. Oggi assistiamo al definitivo tramonto del Novecento. La letteratura odierna non ha più funzione di messaggio, conoscenza, lezione, come è accaduto nei secoli passati (ad esempio, nel secolo XX, con I vecchi e i giovani di Pirandello, La cognizione del dolore di Gadda, Uomini e no di Vittorini, Il partigiano Johnny di Fenoglio ecc.), ma deve essere facilmente comunicativa, ripetitiva, di rapido consumo. I romanzi che possiamo definire “dei giorni nostri” sono di facile lettura e devono durare pochi mesi: è trionfata l’idea della quantità e della produttività, mentre il contenuto, il significato, il messaggio sono considerati meno importanti. Inoltre, si racconta in genere ciò che già si sa, ciò che il lettore si aspetta; il che, naturalmente, è più facile: più difficile è leggere un romanzo che racconti ciò che non sappiamo e cerchi di spiegare e aiutare a capire e suggerire valori e comportamenti. La letteratura ha sempre avuto questa funzione. Anche perché alla base della nostra letteratura c’è il modello greco, soprattutto il teatro greco, che aveva il preciso scopo di dare lezione al pubblico. Il genere del romanzo ne è erede in quanto ammaestra attraverso la rappresentazione dell’eccesso, facendo capire come bisogna comportarsi in tali situazioni. Possiamo ricordare, fra i romanzi più significativi del ’900, I vecchi e i giovani di Pirandello, che vuole spiegare l’utopia risorgimentale, ma anche il fallimento radicale della storia, e Il partigiano Johnny di Fenoglio, e ancora La cognizione del dolore di Gadda e Uomini e no di Vittorini, tutte opere in cui si rappresenta una visione della realtà e del mondo e si discute su come rapportarsi ad essa o prenderne le distanze. 11 La lezione di Giangiacomo Amoretti (11 novembre 2009) GIAN GIACOMO AMORETTI La grande poesia ligure del ’900: Sbarbaro, Montale, Caproni Si può parlare di una “linea ligustica” nella poesia italiana del Novecento? La maggior parte della critica, oggi, la ritiene una formula discutibile e superata. Tuttavia è innegabile la presenza di caratteri comuni nei tre maggiori poeti liguri del ’900 (due – Sbarbaro e Montale – propriamente liguri, uno – Caproni – ligure di adozione): soprattutto li accomuna il tema della poesia “in negativo”, la poetica del “non”. Ne è esempio primo la lirica di Sbarbaro Taci, anima stanca di godere (composta nel 1913, precede di tre anni Il porto sepolto di Ungaretti, tradizionalmente indicato come punto d’inizio della poesia italiana del ’900) e ne è esempio compiuto Non chiederci la parola di Montale (del 1923). Fra i molti percorsi della produzione di Montale (con riflessi anche in Sbarbaro e in Caproni), Amoretti si sofferma poi sulla poesia d’amore, con particolare attenzione alla figura di Clizia, ai suoi complessi significati allegorici e al suo ruolo salvifico con sfumature stilnovistiche e religiose. Ambigua e problematica è la religiosità di Montale, che in un celebre verso si definì un povero nestoriano smarrito (confidò a Gianfranco Contini di credere in Cristo-uomo ma di avere difficoltà a credere in Dio). Caratterizzata da una teologia negativa è anche la poesia di Caproni, in particolare nell’ultima raccolta, postuma, Res amissa. Puntuali ed acute osservazioni il relatore riserva a Nuove stanze, Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La frangia dei capelli che ti vela di Montale (testi composti fra il ’39 e il ’41) ed a Res amissa ed Enfasi a parte dell’ultimo Caproni. *** Esiste una “linea ligustica” nella poesia italiana del Novecento? Ovvero, un modo di far poesia che caratterizza i poeti liguri (da Roccatagliata Ceccardi a Boine, dai fratelli Novaro a Barile, da Sbarbaro a Montale ecc.) e si distingue per essenzialità, rigore, asprezza di immagini, in sintonia con il paesaggio ligure aspro e riarso? Se ne è parlato a lungo, ma oggi la maggior parte della critica la ritiene una formula superata e discutibile. I maggiori poeti liguri del ’900 – Sbarbaro, Montale e Caproni (propriamente liguri i primi 13 due, ligure di adozione il terzo) – sono comunque interpreti (ciascuno con caratteri propri) della crisi di valori e certezze che segna il passaggio dalla poesia tradizionale alla poesia novecentesca e, soprattutto, sono accomunati dal tema della poesia “in negativo”, dalla poetica del “non” (sentono di non avere nulla da dire, di non avere risposte, né per se stessi né per l'umanità), e dal rifiuto della retorica, dalla ricerca di un’espressione essenziale e rigorosa che sembra effettivamente rispecchiare i caratteri tipici del paesaggio ligure. Ne è esempio primo la lirica di Sbarbaro Taci, anima stanca di godere, che, composta nel 1913 (pubblicata nella raccolta Pianissimo nel 1914), precede di tre anni Il porto sepolto di Ungaretti, tradizionalmente indicato come punto d’inizio della poesia italiana del ’900. Prima di Ungaretti, dunque, è Sbarbaro a rompere con la tradizione e a dare inizio alla nuova poesia novecentesca. Taci, anima stanca di godere Taci, anima stanca di godere e di soffrire (all’uno e all'altro vai rassegnata). Nessuna voce tua odo se ascolto: non di rimpianto per la miserabile giovinezza, non d'ira o di speranza, e neppure di tedio. Giaci come il corpo, ammutolita, tutta piena d’una rassegnazione disperata. Non ci stupiremmo, non è vero, mia anima, se il cuore si fermasse, sospeso se ci fosse il fiato… Invece camminiamo, camminiamo io e te come sonnambuli. E gli alberi son alberi, le case sono case, le donne che passano son donne, e tutto è quello che è, soltanto quel che è. 14 La vicenda di gioia e di dolore non ci tocca. Perduto ha la voce la sirena del mondo, e il mondo è un grande deserto. Nel deserto io guardo con asciutti occhi me stesso. In questo testo ci sono alcuni elementi tradizionali: i versi sono in prevalenza endecasillabi e settenari; il topos del dialogo fra io e cuore, io e anima è fra i più tipici del genere lirico (basti pensare a Petrarca e al Leopardi di A se stesso). Ma ci sono anche fondamentali novità. L’io lirico chiede all’anima di tacere, la invita al silenzio; è un invito paradossale (il poeta dice a se stesso di non dire) e profondamente diverso da quello dannunziano della Pioggia nel pineto: d’Annunzio si rivolge ad Ermione ed invoca il silenzio delle parole comuni e profane per dare spazio alla parola poetica, mentre Sbarbaro si rivolge a se stesso e invita la propria anima a tacere perché non c’è più nulla da dire. La parola stessa è negata. E nell’angoscia del silenzio non c’è posto per nessun sentimento: né rimpianto né ira né speranza né tedio; la vita è talmente vuota che il poeta non si stupirebbe di perderla: neppure la morte produrrebbe stupore, tanto l’esistenza è ammutolita e rassegnata al nulla. Il poeta è come un sonnambulo: non proietta sentimenti sulle cose né il paesaggio riflette il suo animo; non c’è più alcun legame tra io e mondo. Le cose perciò sono totalmente al di fuori, senza rapporti con l’anima: sono soltanto quel che sono (gli alberi son alberi, le case / sono case, le donne / … son donne; anche le donne, dunque, sono reificate). Il mondo è un deserto in cui perdersi. Resta solo lo sguardo che il poeta rivolge verso se stesso, senza una lacrima, senza alcun sentimento (io guardo con asciutti occhi me stesso). Neppure Leopardi – il pessimista e nichilista Leopardi – aveva concepito un tale distacco dalla realtà. Con Sbarbaro, dunque, siamo di fronte ad un nuovo modello di lirica, che rovescia completamente il modello tradizionale. Montale è il primo ad adottare il nuovo modello lirico sbarbariano – e a svilupparne compiutamente la poetica del “non” – 15 elaborando poi su questa base un discorso poetico fra i più complessi e ardui del ’900. Il testo più significativo (e noto) è, al riguardo, Non chiederci la parola, composto nel 1923 e compreso negli Ossi di seppia (prima raccolta montaliana, del 1925). Non chiederci la parola Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah l’uomo che se ne va sicuro, agli altri ed a se stesso amico, e l’ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro! Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. La visione in negativo di Sbarbaro è portata alle estreme conseguenze, in sintonia col clima relativistico del decadentismo europeo (si pensi anche a Pirandello): se non ci sono più certezze né a riguardo dell’io né a riguardo del mondo, non si potrà che dire ciò che non si è, ciò che non si vuole. Da notare la polemica contro gli uomini “sicuri” (ovvero contro i poeti “sicuri”: il bersaglio principale è d’Annunzio): coloro che vedono solo il positivo e il luminoso (la canicola), credono in valori da affermare e trasmettere, senza neppure accorgersi della propria ombra stampata su un muro scalcinato. Dal “troppo pieno” di d’Annunzio al “troppo poco” di Montale, dall’anima che vive come diecimila al vuoto dell’anima e alla sua difficoltà di comunicare. Non si possono chiedere al poeta messaggi e rassicurazioni: neppure egli sa chi è, che cosa vuole. Con sofferta consapevolezza la poesia deve ammettere i propri limiti, in mancanza di contenuti da trasmettere, di valori e certezze da affermare. 16 Partendo da questa coscienza del negativo, la poesia di Montale si dirama in vari percorsi tematici, fra i quali anche l’amore, tema apparentemente più tradizionale, ma con risvolti complessi (in particolare in relazione alla figura di Clizia) e con sviluppi anche in direzione lato sensu religiosa. Clizia (la donna-girasole del mito, senhal di Irma Brandeis) è personaggio di natura allegorica, con un ruolo salvifico in qualche modo assimilabile a quello della donna stilnovistica e addirittura a quello di Cristo. Ambigua e problematica è la religiosità di Montale, che in un celebre verso si definì un povero nestoriano smarrito (confidò a Gianfranco Contini di credere in Cristo-uomo ma di avere difficoltà a credere in Dio). Tra le poesie dedicate a Clizia, particolarmente significative sono tre liriche composte fra il ’39 e il ’41, subito dopo la partenza della donna per l’America (di origine ebrea, Irma Brandeis lascia l’Italia nel ’38 per sfuggire alle leggi razziali) e lo scoppio della seconda guerra mondiale: Nuove stanze, Ti libero la fronte dai ghiaccioli e La frangia dei capelli che ti vela. Nuove stanze è del ’39 e fa parte della prima edizione delle Occasioni (il titolo fa riferimento al tipo di strofa utilizzata). Nuove stanze Poi che gli ultimi fili di tabacco al tuo gesto si spengono nel piatto di cristallo, al soffitto lenta sale la spirale del fumo che gli alfieri e i cavalli degli scacchi guardano stupefatti; e nuovi anelli la seguono, più mobili di quelli delle tue dita. La morgana che in cielo liberava torri e ponti è sparita al primo soffio; s'apre la finestra non vista e il fumo s'agita. Là in fondo, altro stormo si muove: una tregenda d'uomini che non sa questo tuo incenso, 17 nella scacchiera di cui puoi tu sola comporre il senso. Il mio dubbio d'un tempo era se forse tu stessa ignori il giuoco che si svolge sul quadrato e ora è nembo alle tue porte: follia di morte non si placa a poco prezzo, se poco è il lampo del tuo sguardo ma domanda altri fuochi, oltre le fitte cortine che per te fomenta il dio del caso, quando assiste. Oggi so ciò che vuoi; batte il suo fioco tocco la Martinella ed impaura le sagome d'avorio in una luce spettrale di nevaio. Ma resiste e vince il premio della solitaria veglia chi può con te allo specchio ustorio che accieca le pedine opporre i tuoi occhi d'acciaio. Clizia è rappresentata in chiave domestica e quotidiana (fuma, gioca a scacchi, ha i soliti anelli alle dita), ma con allusioni allegoriche al dramma storico della guerra. La spirale di fumo della donna si contrappone alla geometria della scacchiera, mentre fuori un altro stormo di alfieri e cavalli (i soldati reali) produce ben altri fuochi (la guerra). Il dramma della storia entra attraverso la finestra che s’apre e agita le volute di fumo. Solo il poeta, grazie a Clizia, capisce il senso della tregenda; solo Clizia conosce il senso oscuro della scacchiera della storia: gli altri uomini non sanno e non capiscono. Ma neppure Clizia può bastare a placare la tragedia (la follia di morte non si placa a poco / prezzo). La campana di Palazzo Vecchio a Firenze (la Martinella) annuncia la guerra: ci vorrebbero gli occhi d’acciaio di Clizia per sconfiggere l’incendio procurato dallo specchio ustorio del conflitto, e nuovi aspiranti cavalieri in solitaria veglia di preghiera; il poeta proietta sulla donna la propria ansia di salvezza, ma lei è lontana e forse non in grado di interpretare fino in fondo il ruolo salvifico che il poeta le attribuisce. 18 Ti libero la fronte dai ghiaccioli è del ’40 e fa parte della seconda edizione delle Occasioni. Ti libero la fronte dai ghiaccioli Ti libero la fronte dai ghiaccioli che raccogliesti traversando l'alte nebulose; hai le penne lacerate dai cicloni, ti desti a soprassalti. Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo l'ombra nera, s'ostina in cielo un sole freddoloso; e l'altre ombre che scantonano nel vicolo non sanno che sei qui. Qui Clizia ha caratteri che la avvicinano alla donna-angelo stilnovistica: discende dal cielo, attraversa le alte nebulose, vola con le ali (penne) come un angelo, per far visita al poeta. Ma ha anche diversi caratteri ironico-grotteschi: il gelo siderale le riempie la fronte di ghiaccioli che le devono essere tolti dal poeta; è dunque un povero angelo che ha bisogno di aiuto (ha le ali lacerate, ed incubi che la fanno destare a soprassalti): l’oltre ha bisogno dell’uomo per manifestarsi. È mezzogiorno (mezzodì), ma non c’è nessuna luce meridiana: il sole è freddoloso e l’ombra del nespolo è nera (Dante Isella ha parlato di “buio a mezzogiorno”). Gli esseri umani scantonano e nulla sanno di Clizia; solo il poeta può vedere l’angelo (situazione elitaria ed esoterica, come quella dei poeti stilnovisti). Clizia è personaggio allegorico, ma la sua allegoria è ambigua, dimidiata (come nella Metamorfosi di Kafka): l’autore non ne dichiara l’esatta chiave di lettura. La salvezza recata da Clizia è problematica e non per tutti: riguarda solo il poeta, è una salvezza personale, minima; la donna, d’altronde, pur rappresentando la divinità, non ha caratteri e non produce effetti realmente “divini”: è l'uomo ad aiutare lei, non il contrario. La frangia dei capelli che ti vela, del 1941, è un sonetto elisabettiano (tre quartine e un distico, con rime – o assonanze o consonanze – ABBA, CDDC, EFFE, GG). 19 La frangia dei capelli che ti vela La frangia dei capelli che ti vela la fronte puerile, tu distrarla con la mano non devi. Anch’essa parla di te, sulla mia strada è tutto il cielo, la sola luce con le giade ch’ài accerchiate sul polso, nel tumulto del sonno la cortina che gl'indulti tuoi distendono, l'ala onde tu vai, trasmigratrice Artemide ed illesa, tra le guerre dei nati-morti; e s'ora d'aeree lanugini s’infiora quel fondo, a marezzarlo sei tu, scesa d'un balzo, e irrequieta la tua fronte si confonde con l’alba, la nasconde. Di nuovo il significato di Clizia è ambiguo. La donna è una dea (Artemide), trasmigra (dall’America dove si trova), porta la salvezza al poeta. Ma, come Artemide, è una dea crudele, terribile, cacciatrice; e inoltre: mostra la via del cielo o nasconde la visione del cielo? S’identifica con l’alba (cioè con la salvezza) o la nasconde (come dice il verso finale)? Si tratta di un’ambiguità tipicamente montaliana. Il “varco” sembra aperto verso una dimensione sacra e ultraterrena, ma Montale non concepisce salvezza se non nel qui e ora; così anche in Iride, dove è più evidente la funzione cristologica di Clizia. Ma, come già ricordato, la particolare religiosità di Montale è propensa a credere in Cristo in quanto uomo molto più che nel Cristo figlio di Dio (per questo si definisce nestoriano: l’eretico Nestorio credeva che in Cristo ci fossero due nature in due persone, non due nature in una sola persona). Una religiosità problematica – una sorta di teologia negativa – caratterizza anche la poesia di Caproni, in particolare nella raccolta postuma Res amissa, di cui sono testi particolarmente significativi quello che dà il titolo alla raccolta (Res amissa appunto) ed Enfasi a parte 20 Res amissa Non ne trovo traccia. ...... Venne da me apposta (di questo sono certo) per farmene dono. ....... Non ne trovo più traccia. ....... Rivedo nell'abbandono del giorno l'esile faccia biancoflautata... La manica in trina... La grazia, così dolce e allemanica nel porgere... ....... ....... Un vento d'urto – un'aria quasi silicea agghiaccia ora la stanza... (È lama di coltello? Tormento oltre il vetro ed il legno – serrato – dell'imposta?) ....... ....... Non ne scorgo più segno. Più traccia. ....... ....... 21 Chiedo alla morgana... Rivedo esile l'esile faccia flautoscomparsa... Schiude – remota – l'albeggiante bocca, ma non parla. (Non può – niente può – dar risposta.) ....... ....... Non spero più di trovarla. ....... L'ho troppo gelosamente (irrecuperabilmente) riposta. Il discorso “religioso” di Montale è ripreso in termini più essenziali e tragici, come dice già il titolo (che fa riferimento a qualcosa che è perduto e irrecuperabile) e come suggeriscono i molti puntini di sospensione (indici di mancanza e silenzio). Come in Sbarbaro, anche qui la parola è in stretta connessione col silenzio. La poesia è costruita intorno ad un vuoto, ad un’assenza. Non c’è più traccia di qualcosa (res) e di qualcuno: si tratta forse di una donna (indeterminata come un miraggio: morgana) o di un angelomessaggero, che ha portato qualcosa ora per sempre perduto (che cosa? la voce di Dio? un’alba di salvezza?). Enfasi a parte “Enfasi a parte: deo amisso, che altro può restare in terra a far da coperchio all'abisso?” Così, levato alto il boccale, m'apostrofò il cantiniere nel vuoto del locale. 22 Gli avevo chiesto da bere per scaldarmi. Nient'altro. Non gli risposi. Nemmeno sorrisi del suo latino. Stavo male. Era il giorno – gelido – di Natale. Il testo prende spunto da una situazione verosimile (un bar, un cantinere) ma paradossale: il cantiniere è una sorta di teologo e conosce il latino, mentre l’io lirico è banalmente realistico. Raggiunge il suo acme nel finale, con la rivelazione del giorno… di Natale, che non è tuttavia festoso ma gelido. La scena è in effetti tutta nel segno del freddo (…da bere / per scaldarmi), dell’assenza di dialogo, della solitudine. Qui però è chiara l’identità della res amissa: quel che è perduto è Dio (deo amisso). Il mondo moderno è come un Natale senza Dio. Caproni è ateo, ma insoddisfatto: non rinuncia alla ricerca, alla tensione; il suo ateismo problematico e aperto è sintetizzato da un altro suo famoso verso: mio Dio, mio Dio, perché non esisti? 23 La lezione di Alberto Beniscelli (9 dicembre 2009) ALBERTO BENISCELLI Letture montaliane La lezione è incentrata sulla lettura di una delle poesie più impegnate e impegnative di Montale, La bufera, introduttiva ed eponima della sua terza raccolta (La bufera e altro), dove al tema conduttore della guerra (la seconda guerra mondiale ma anche la guerra cosmica del male ontologico) si intreccia e si oppone il tema d’amore: Clizia (Irma Brandeis) è partita per l’America nel ’38 per sfuggire alle leggi razziali (il distacco è rievocato nel finale de La bufera), ma torna a far visita al poeta in qualità di donnaangelo, con un ruolo salvifico che infine – si veda La primavera hitleriana, uno dei testi più alti della poesia del ’900 – acquista valenza religiosa e coinvolge l’intera umanità (come Cristo, Clizia si sacrifica per tutti). De La bufera il relatore dapprima ricostruisce la vicenda editoriale (dalla prima uscita su “Il Tempo” nel febbraio del ’41 all’edizione svizzera di Finisterre e a quella de La bufera e altro nel ’56), poi spiega il significato dell’epigrafe introduttiva (le parole contro la terribilità della guerra dello scrittore cinque-seicentesco Agrippa d’Aubigné) e quindi analizza capillarmente e puntigliosamente il testo, illustrando di ogni lassa i principali caratteri formali, contenutistici e semantici, in un esemplare percorso critico-interpretativo. Muovendo da La bufera, infine, opera una serie di richiami intertestuali, che riguardano in particolare Lo sai: debbo riperderti e non posso, Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Nuove stanze, La frangia dei capelli e culminano nella lettura e nel commento de La primavera hitleriana. *** La lezione propone un percorso di lettura, analisi, approfondimento testuale e intertestuale di alcune liriche – da La bufera a La primavera hitleriana – che sono fra le più ardue di Montale ma anche fra le più alte di tutta la poesia del Novecento: meritevoli perciò di speciale attenzione a livello scolastico, anche se il loro studio esige qualche fatica in più (sono testi non banalizzabili: le esigenze didattiche, d’altronde, non danno mai il diritto di banalizzare la poesia). 25 In questi testi – e in generale nella raccolta di cui essi fanno parte, La bufera e altro, terza raccolta montaliana – il tema conduttore è l’amore nel mondo della guerra: al motivo della guerra (la bufera della seconda guerra mondiale ma anche la guerra cosmica del male ontologico) si intreccia e si oppone, infatti, il tema d’amore: Clizia (Irma Brandeis) è partita per l’America nel ’38 per sfuggire alle leggi razziali (il distacco è rievocato nel finale de La bufera), ma torna a far visita al poeta in qualità di donna-angelo, con un ruolo salvifico che infine – in particolare ne La primavera hitleriana – acquista valenza religiosa e coinvolge l’intera umanità (come Cristo, Clizia si sacrifica per tutti). La bufera è la lirica introduttiva ed eponima della raccolta La bufera e altro, del ’56, ma la sua composizione risale a quindici anni prima. Pubblicata la prima volta sul settimanale “Il Tempo” nel febbraio del ’41, è compresa poi nella plaquette Finisterre (15 poesie composte fra il ’40 e il ’42), che, tramite Gianfranco Contini (che la propone al Bernasconi), esce in Svizzera, a Lugano, nel ’43 (Montale stesso dirà che quell’opuscolo non si sarebbe potuto pubblicare allora in Italia); Finisterre diventa, infine, la prima sezione de La bufera e altro. La bufera Les princes n’ont point d’yeux pour voir ces grand’s merveilles, Leurs mains ne servent plus qu’à nous persécuter… Agrippa d’Aubigné, À Dieu La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine, (i suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono, dell’oro che s’è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre) il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella 26 eternità d’istante – marmo manna e distruzione – ch’entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l’amore a me, strana sorella,– e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango, e sopra qualche gesto che annaspa… Come quando ti rivolgesti e con la mano, sgombra la fronte dalla nube dei capelli, mi salutasti – per entrar nel buio. L’epigrafe introduttiva riporta le parole con cui lo scrittore francese cinque-seicentesco Agrippa d’Aubigné, all’epoca del conflitto tra cattolici e ugonotti, denuncia la terribilità della guerra: i “principi persecutori” di Montale sono, ovviamente, Hitler e Mussolini. La bufera si presenta subito, dunque, con una forte angolatura morale e civile, nonostante sia anche, come si vedrà, una poesia d’amore. Ed è anche un testo stilisticamente raffinato, prezioso, come altri della sezione e della raccolta (si pensi solo a Gli orecchini, celeberrimi e infinitamente discussi, o a La frangia dei capelli che ti vela, dove Montale sperimenta il sonetto elisabettiano): si possono notare, in particolare, lo schema metrico (basato su endecasillabi piani, ma con i vv. 3, 10 settenari, il 9 quinario e i vv. 3, 9, 16 sdruccioli), le figure di suono (una sola rima finale, ma molte rime interne, quasi rime, rime al mezzo, assonanze, consonanze ecc.) e la lunga costruzione ellittico-nominale (vv. 1-19, con la sequenza La bufera… i suoni… il lampo… lo schianto… che solo alla fine trova un appoggio sintattico: Come quando…). Dal punto di vista tematico, si può dividere in tre momenti: il primo, più lungo, comprende i vv. 1-15; il secondo, i vv. 16-19; il terzo, che è una sorta di congedo, i vv. 19-22. L’attacco è nel segno del tipico realismo montaliano destinato a girarsi in allegoria. L’ambientazione è reale, sia nella prima strofa, che richiama il giardino di casa Montale a Monterosso, con il suo albero di 27 magnolia, sia nella seconda, che evoca la residenza americana di Clizia; ma la bufera – tema ricorrente in Montale (si pensi solo ad Arsenio, Tempi di Bellosguardo, Il ritorno, L’arca) – allude ovviamente alla tempesta della guerra, come spiega Montale stesso in una lettera del ’65 a Silvio Guarnieri: la guerra storica (la seconda guerra mondiale: proprio “quella” guerra dopo “quella” dittatura…) e la guerra cosmica (il male ontologico, che coinvolge tutti, cifra inestirpabile della natura umana); la magnolia, poi, è portatrice in Montale di segni di un’umanità sconvolta o funge da albero protettivo dei morti (si vedano ancora, ad esempio, Tempi di Bellosguardo e L’arca). Da notare il salto dall’ambientazione esterna nella prima lassa (vv. 1-3) all’ambientazione interna nella seconda (vv. 4-9). È un gioco frequente in Montale: si vedano, in particolare, Notizie dall’Amiata e Nuove stanze, dove però è l’interno a dominare sull’esterno, mentre qui è dominante l’esterno e l’interno è posto tra parentesi. Perché? Perché diversa è la funzione di Clizia. La donna non è più “presente”, come in Nuove stanze, e non è più “attesa”, come in Notizie dall’Amiata: è partita, è lontana; per qualche tempo il poeta pensa addirittura che lei possa essere morta in un campo di concentramento (nel finale de Gli orecchini, le squallide mani travolte che fermano gli orecchini ai lobi di Clizia sono forse quelle dei prigionieri di un lager). L’interno della seconda strofa è precisamente la stanza del college americano in cui dorme Clizia, il suo nido notturno appunto. Un luogo ben lontano, dunque, dalla bufera che si abbatte sul giardino di Monterosso: eppure la bufera arriva fin là, coglie di sorpresa Clizia e la sveglia. Dunque nessun luogo può essere protetto dalla bufera della guerra. La possibilità di creare fulminei collegamenti tra eventi e luoghi diversi è, d’altronde, un carattere tipico di Clizia: quando è evocata, la donna ha il potere di muoversi in uno spazio-tempo di simultaneità, di essere contemporaneamente in luoghi e tempi diversi; Clizia è l’eternità d’istante del v. 12. Con la terza lassa si passa più chiaramente dal piano realistico al piano allegorico. Il flash del lampo che candisce alberi e muri (cioè li rende candidi, li sbianca, ma anche li confetta, li trasforma in canditi) è ancora un tratto realistico, ma serve a introdurre l’immagine di Clizia, che diventa ora il perno tematico della poesia. Il lampo è un 28 attributo tipico di Clizia (cfr Nuove stanze), che porta scolpita in sé l’eternità d’istante della sua luce folgorante (vv. 12-14). Clizia è anche marmo manna e distruzione (vv. 12-13), inciso quanto mai arduo da decifrare (lo stesso Montale dice a Contini: marmo manna e distruzione sono le componenti di un carattere [=del carattere di Clizia], se tu le spieghi ammazzi la poesia): il marmo simboleggia fermezza e resistenza; la manna è nutrimento dolce e divino (nella Bibbia è inviata da Dio al popolo eletto nel deserto); tutta la poesia, letta in verticale, è nel segno del bianco, del duro, del dolce; distruzione è invece immagine bivalente: richiama ancora il lampo della guerra e la sua potenza devastatrice, ma anche il bagliore degli occhi di Clizia, la loro potenza salvifica (condanna, forse, richiama il sacrificio di Cristo). Clizia è in effetti colei che distrugge (l’angelo che si oppone al male della guerra: cfr ancora Nuove stanze) e colei che si distrugge (la donna-girasole che, come Cristo, si sacrifica per tutti: cfr La primavera hitleriana). Ma con La bufera con siamo ancora nel pieno di questi valori: in questo testo vale soprattutto, in Clizia, il carattere della mutabilità, della trasformazione (anch’esso sancito poi nei celebri versi de La primavera hitleriana: …tu / che il non mutato amor mutata serbi). Nel secondo momento (vv. 16-19) di nuovo l’immagine iniziale è realistica (lo schianto del tuono), ma subito rimpiazzata da immagini allegoriche: il tutto rinforzato da elementi fonico-visivi che danno idea di accelerazione, esagitazione (è stato notato, fra l’altro, che sistri e tamburelli sono presenti nella Carmen di Bizet, il fandango nella Bohème di Puccini: Montale, come è noto, ha una grande competenza musicale, ha studiato canto – da baritono – ed è stato critico musicale del “Corriere della sera”); la fossa fuia e i gesti disperati di chi annaspa richiamano l’Inferno di Dante (la stessa bufera è immagine dantesca). Il timbro è funereo e infernale. La bufera è ormai definitivamente l’inferno della guerra. Il congedo (vv. 19-22) si configura, dunque, come un ingresso nell’Ade. Clizia saluta il poeta e si immerge nel buio della lontananza e, forse, anche per lei, della guerra, della deportazione, della morte (si è già ricordato che il poeta, per qualche tempo, teme che la donna sia morta in un lager). La domanda finale – implicita – è allora questa: Clizia tornerà prima o poi o non tornerà mai più? La risposta è: sì, tornerà, ma non in persona fisica; tornerà in termini 29 petrarcheschi e, ancor più, stilnovistici: tornerà cioè come donnaangelo, a portare un messaggio di salvezza, dapprima soltanto al poeta (in Ti libero la fronte dai ghiaccioli “appare” al poeta dopo aver attraversato alte nebulose; ne La frangia dei capelli ritorna dopo aver attraversato la guerra dei nati-morti, la zona infernale della bufera) e infine a tutta l’umanità, con una valenza salvifico-religiosa che richiama espressamente la figura di Cristo (ne La primavera hitleriana). In tal senso, La bufera è un testo di passaggio, dove il rinforzo di Clizia in direzione religioso-salvifica, non presente nei Mottetti, anticipa e prepara il traguardo de La primavera hitleriana. La primavera hitleriana Né quella ch’a veder lo sol si gira… Dante (?) a Giovanni Quirini Folta la nuvola bianca delle falene impazzite turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, stende a terra una coltre su cui scricchia come su zucchero il piede; l’estate imminente sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta, negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai. Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso e pavesato di croci a uncino l’ha preso e inghiottito, si sono chiuse le vetrine, povere e inoffensive benché armate anch’esse di cannoni e giocattoli di guerra, ha sprangato il beccaio che infiorava di bacche il muso dei capretti uccisi, la sagra dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue s’è tramutata in un sozzo trescone d’ali schiantate, di larve sulle golene, e l’acqua séguita a rodere le sponde e più nessuno è incolpevole. Tutto per nulla, dunque? – e le candele romane, a San Giovanni, che sbiancavano lente l’orizzonte, ed i pegni e i lunghi addii 30 forti come un battesimo nella lugubre attesa dell’orda (ma una gemma rigò l’aria stillando sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi gli angeli di Tobia, i sette, la semina dell’avvenire) e gli eliotropi nati dalle tue mani – tutto arso e succhiato da un polline che stride come il fuoco e ha punte di sinibbio… Oh la piagata primavera è pur festa se raggela in morte questa morte! Guarda ancora in alto, Clizia, è la tua sorte, tu che il non mutato amor mutata serbi, fino a che il cieco sole che in te porti si abbàcini nell’Altro e si distrugga in Lui, per tutti. Forse le sirene, i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda, si confondono già col suono che slegato dal cielo, scende, vince – col respiro di un’alba che domani per tutti si riaffacci, bianca ma senz’ali di raccapriccio, ai greti arsi del sud… La prima parte (vv. 1-19) è composta nel ’39, la seconda (vv. 20-43) nel ’46. Il poeta rievoca la visita di Hitler a Firenze nel maggio del ’38, con la primavera piagata e la natura stravolta dalla sua presenza: un’invasione di falene impazzite (fatto realmente accaduto), come una nevicata fuori tempo, trasforma l’estate imminente in stagione morta. Hitler è acclamato dagli scherani fascisti ed ossequiato anche dai bottegai, che chiudono in suo onore i negozi, in un’inconsapevole festa di morte che presto si muterà in palese tragedia. Di fronte ad essa più nessuno potrà dirsi incolpevole. Nell’orrido dramma della storia, l’unica speranza giunge da Clizia, caricata di un ruolo salvifico ad immagine di quello di Cristo. Non può giungere salvezza dalla storia, ma solo da Clizia e solo in termini di speranza: dalla Clizia che il non mutato amor mutata serba, capace cioè, nella sua lontananza, di trasfigurare l’amore terreno in amore divino, di farsi “abbagliare” da Dio e annullarsi in Lui, nella sua misteriosa volontà, in sacrificio per tutti, proprio come Cristo. 31 La lezione di Francesco De Nicola (10 febbraio 2010) FRANCESCO DE NICOLA Il neorealismo nella narrativa italiana del Novecento Il Neorealismo è un comune sentire in cui si riconoscono diversi artisti dei primi anni del secondo dopoguerra. È preannunciato, nel ventennio fascista, da alcune opere che si distinguono dal gusto dominante per l’attenzione alla realtà socio-economica: Gente in Aspromonte di Alvaro, Il garofano rosso di Vittorini, Tre operai di Bernari, il film Acciaio di Walter Ruttmann (sceneggiato da Pirandello e Soldati). Il Neorealismo nasce con Ossessione di Luchino Visconti (’43) e con un importante intervento critico di Mario Alicata e Giuseppe De Santis (’41). Ha il suo culmine negli anni ’45-’50 con i films di Rossellini (Roma città aperta, Paisà, Germania anno zero), De Sica (Sciuscià, Ladri di biciclette), Visconti (La terra trema). La prima produzione letteraria neorealista è rappresentata invece dai racconti di vita vissuta, vicende di guerra e Resistenza, ospitati sulle terze pagine dei quotidiani domenicali. Si afferma un nuovo concetto di “impegno”: nel primo numero del Politecnico (settembre ’45) Vittorini assegna all’arte una finalità non consolatoria ma di denuncia delle “sofferenze” sociali e di lotta per il loro superamento. Il primo romanzo neorealista è Uomini e no (’45) dello stesso Vittorini, seguito da Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, Se questo è un uomo di Primo Levi, L’Agnese va a morire di Renata Viganò (solo in parte neorealista, invece, è il romanzo d’esordio di Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno). Con gli anni ’50 inizia la fase discendente, simboleggiata dalla scena finale, fiabesca e surreale, di Miracolo a Milano di De Sica (’51). In letteratura la fine è sancita dal romanzo Metello di Pratolini (del ’55). Il salutare bagno di realtà prodotto dal Neorealismo ha però effetti duraturi anche sugli scrittori successivi, che parzialmente lo recuperano (come Cassola con La ragazza di Bube o Bassani con Il guardino dei Finzi Contini) o lo superano in varie direzioni (come lo stesso Calvino e Fenoglio). *** Tra i molti -ismi che caratterizzano l’Otto-Novecento (“scatole” critiche di comodo, spesso responsabili di appiattimento e semplificazione) c’è anche il Neorealismo: non un movimento 33 definito e costituito, ma piuttosto un comune sentire nel quale si riconosce un certo numero di artisti (in ambito cinematografico e letterario soprattutto) nel clima dell’immediato dopoguerra, tra gli orrori ancora vivi del secondo conflitto mondiale e la volontà di superarli in una nuova prospettiva politica, sociale e culturale. Il Neorealismo è dunque strettamente legato al momento storico del dopoguerra. Ma è preannunciato in qualche modo, nel ventennio fascista, da alcune opere che si distinguono dal gusto dominante – il dannunzianesimo, i romanzi d’evasione (Pitigrilli, Guido da Verona, Luciano Zuccoli), i film d’evasione (i telefoni bianchi) o di genere e di regime (La cieca di Sorrento, Mille lire al mese, Scipione l’Africano) – per l’attenzione diretta e non convenzionale alla realtà socio-economica (a quella del meridione in particolare). Fra queste, tre romanzi ed un film: Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro, che recupera la lezione di Verga; Il garofano rosso di Elio Vittorini, romanzo di formazione ambientato in una cittadina del sud; Tre operai di Carlo Bernari, sulla vita di fabbrica e i suoi problemi; Acciaio, drammatica storia operaia ambientata nelle acciaierie di Terni (regia di Walter Ruttmann, sceneggiatura di Luigi Pirandello e Mario Soldati; il film è prodotto da Emilio Cecchi, uno dei fondatori della “Ronda”, la rivista del “bello scrivere”). Segna la nascita del Neorealismo, nel 1943, il film Ossessione di Luchino Visconti (tratto da Il postino suona sempre due volte di James Cain), ambientato nella bassa padana. Da non trascurare l’influsso del cinema americano e francese degli anni ’30: La grande illusione di Jean Renoir è del ’37; Il porto delle nebbie di Marcel Carné è del ’38. Da ricordare anche un importante articolo di Mario Alicata e Giuseppe De Santis – Verità e poesia: Verga e il cinema italiano (pubblicato nel ’41 sulla rivista “Cinema”) – in cui si affermano tre fondamentali principi in chiave neorealistica: l’importanza del modello verghiano, l’unità delle arti (senza distinzioni e gerarchie), il ruolo dell’arte come documento di realtà. Gli anni dal ’45 al ’50 sono segnati in Italia da una grande produzione cinematografica. La riapertura delle sale è di per sé indice di libertà ritrovata e rinnovata voglia di vivere. I film più importanti raccontano l’accaduto e il presente, con volontà di documentazione e denuncia. Nell’ottobre del ’45 esce Roma città aperta di Roberto Rossellini (girato però nel ’44, subito dopo la 34 partenza dei nazisti da Roma): il film, girato all’aperto (non negli studi di Cinecittà), tra le macerie di Roma (bombardata nel ’43), racconta la drammatica resistenza all’occupazione nazista da parte di alcuni cittadini (un sacerdote, un ingegnere comunista, un tipografo); da sottolineare l’uso realistico dei linguaggi (il tedesco e il romanesco). Seguono, dello stesso Rossellini, Paisà nel ’46 e Germania anno zero nel ’48. Vittorio De Sica gira Sciuscià nel ’46 e Ladri di biciclette nel ’48 (dove gli attori sono uomini della strada). Sempre del ’48 è La terra trema di Visconti, ispirato ai Malavoglia di Verga. Come si riaprono le sale cinematografiche, così si riaprono le edicole. Tornano i giornali (ben 8 quotidiani a Genova e 22 a Roma): semplici fogli (due facciate), che nei numeri domenicali raddoppiano e accolgono, in terza pagina, anche qualche racconto di vita vissuta, vicende della guerra appena conclusa, vicende partigiane (e perfino qualche poesia). È questa la prima vera produzione letteraria neorealistica. Sui giornali e sulle riviste si apre un nuovo dibattito delle idee, incentrato sul concetto di “impegno”: l’artista è chiamato ad essere protagonista della realtà, non soltanto osservatore. In questo consiste la fondamentale differenza tra Verismo e Neorealismo: il primo si era proposto di rappresentare la realtà senza dichiarate finalità sociali (in ciò distinguendosi dal Naturalismo francese), mentre il secondo vuole documentare la realtà per denunciarne i problemi, evitare che si ripetano, contribuire ad avviarli a soluzione. Un importante ruolo svolge in tal senso Il Politecnico di Elio Vittorini, che, nell’editoriale del primo numero (uscito il 29 settembre del ’45), assegna all’arte neorealista una finalità non consolatoria bensì di denuncia delle “sofferenze” sociali e di lotta per il loro superamento; da notare nello stesso primo numero – di cui De Nicola mostra una copia in suo possesso – l’uso del colore nei titoli, la presenza di foto, un disegno di Guttuso e, in appendice, una puntata del romanzo di Hemingway Per chi suona la campana (con il titolo Per chi suonano le campane). Sul Politecnico pubblicheranno racconti, fra gli altri, Calvino, Venturi, Caproni. Il romanzo, in un primo tempo, è meno praticato dai neorealisti perché ritenuto un genere costruito e artificiale. Si punta soprattutto sul racconto di vita vissuta, sulla cronaca, sul documento diretto (per 35 questo Vasco Pratolini tiene a sottolineare in alcuni suoi titoli l’elemento cronachistico: Cronaca di poveri amanti, Una cronaca familiare). Il recupero del romanzo è opera dello stesso Vittorini, che in Uomini e no (del ’45) rappresenta l’ambiente della lotta partigiana a Milano, premurandosi di distinguere graficamente le parti propriamente narrative (in tondo) da quelle di riflessione e interpretazione (in corsivo). Anche Calvino torna al romanzo, quando si accorge – e dichiara espressamente – che i propri racconti tendono a ripetersi e in sostanza sono tutti uguali; nasce così Il sentiero dei nidi di ragno, dove il mondo della Resistenza, però, è visto e interpretato con gli occhi di un personaggio di invenzione, un ragazzo (Pin), con tratti di fiaba e avventura. Fra i più importanti romanzi neorealisti vanno annoverati Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi (pubblicato nel ’45, non a caso in una collana di “saggi”), Se questo è un uomo di Primo Levi (del ’47) e L’Agnese va a morire di Renata Viganò (storia di una contadina delle valli di Comacchio che si oppone alle violenze gratuite dei tedeschi). Nel cinema, da ricordare Riso amaro di Giuseppe De Santis (del ’49), ambientato nelle risaie vercellesi. Non tutta la narrativa di quegli anni è da ascrivere al Neorealismo: basti ricordare La favolosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati o Tempo di uccidere di Ennio Flaiano o gli stessi romanzi di Guareschi. Con gli anni ’50 inizia la fase discendente del Neorealismo: la guerra è definitivamente alle spalle e ai problemi dell’immediato dopoguerra subentrano altri tipi di problemi. Si può prendere a simbolo del tramonto del Neorealismo la scena finale, fiabesca e surreale, di Miracolo a Milano di Vittorio De Sica (del ’51): i barboni di Milano partono in volo verso un mondo migliore sulle scope degli spazzini di piazza del Duomo. Al cinema neorealista subentra la commedia all’italiana. In letteratura, la fine del Neorealismo – esplicitamente riconosciuta dallo stesso Vittorini nel ’54 – si può individuare nel romanzo Metello di Vasco Pratolini (del ’55), che punta l’obiettivo sul passato (le lotte sociali nella Firenze di fine ’800) e mette in primo piano la vicenda sentimentale rispetto alla vicenda sociale. In conclusione, si può dire che tutti gli -ismi del ’900 – compreso il Neorealismo (e lo stesso Futurismo) – hanno durata relativamente breve e non producono capolavori assoluti. Sono tuttavia tappe 36 importanti di crescita. Il Neorealismo, in particolare, rende obbligatorio e scontato il confronto con la realtà e cambia definitivamente il linguaggio letterario. È un salutare bagno di realtà, sia per gli scrittori che in seguito parzialmente lo recuperano (come Carlo Cassola con La ragazza di Bube o Giorgio Bassani con Il guardino dei Finzi Contini) sia per quelli che lo superano in varie direzioni (come lo stesso Calvino o come Beppe Fenoglio). 37 La lezione di Luigi Surdich (14 aprile 2010) LUIGI SURDICH Dante nella poesia del Novecento Dante è per lunghi tratti una presenza carsica nella storia della poesia italiana, dominata dal modello petrarchesco; riemerge però fra ’700 e ’800 (con Alfieri, Foscolo e Leopardi), si consolida nell’Ottocento ed è fondamentale nel Novecento. Lasciando da parte Pascoli e d’Annunzio (per entrambi i richiami danteschi richiederebbero specifiche e complesse analisi), il relatore ha preso le mosse da Gozzano (dove Dante si incrocia spesso con Petrarca, alla luce di un duplice atteggiamento, di recupero e di parodia) per soffermarsi quindi su Ungaretti (in particolare sull’Allegria), Saba (per il quale Dante è il culmine della poesia italiana, mentre Petrarca ne è il guasto), Rebora (Frammenti lirici), Quasimodo (Alle fronde dei salici, Ed è subito sera), Luzi (prima più vicino alle Rime di Dante, poi alla Commedia) ed approdare infine a Montale e Caproni, nei quali la presenza di Dante è particolarmente significativa: Montale è poeta dantesco per eccellenza, Caproni prende da Dante i titoli delle raccolte Il seme del piangere e Il muro della terra. *** Per lunghi tratti Dante è una presenza carsica nella storia della poesia italiana, dominata del modello petrarchesco. Riemerge tuttavia fra ’700 e ’800 – con Alfieri, Foscolo e soprattutto Leopardi (basti pensare alla canzone Sopra il monumento di Dante), si consolida nell’Ottocento ed è fondamentale nel Novecento. Lasciando da parte Pascoli e d’Annunzio (per entrambi i richiami danteschi richiederebbero specifiche e complesse analisi), la rassegna della presenza dantesca nella poesia del Novecento può cominciare con Gozzano. In lui Dante si intreccia spesso con Petrarca, tanto che Sanguineti parla di ermafroditismo espressivo ovvero di una sorta di linguaggio “dantese-petrarchese”, dove quella di Dante sarebbe la lingua del padre e quella di Petrarca la lingua della madre. Fra i molti esempi possibili, si vedano in Totò Merùmeni il termine parolette e l’espressione il suo Petrarca (rinvii petrarcheschi) accanto ad esilio e bello tacere (che rinviano al testo 39 dantesco Tre donne intorno al cor mi son venute, canzone per eccellenza dell’esilio, e al canto XXV del Purgatorio): Totò Merùmeni I Col suo giardino incolto, le sale vaste, i bei balconi secentisti guarniti di verzura, la villa sembra tolta da certi versi miei, sembra la villa-tipo, del Libro di Lettura.... Pensa migliori giorni la villa triste, pensa gaie brigate sotto gli alberi centenari, banchetti illustri nella sala da pranzo immensa e danze nel salone spoglio da gli antiquari. Ma dove in altri tempi giungeva Casa Ansaldo, Casa Rattazzi, Casa d’Azeglio, Casa Oddone, s’arresta un automobile fremendo e sobbalzando, villosi forestieri picchiano la gorgòne. S’ode un latrato e un passo, si schiude cautamente la porta… In quel silenzio di chiostro e di caserma vive Totò Merùmeni con una madre inferma, una prozia canuta ed uno zio demente. II Totò ha venticinque anni, tempra sdegnosa, molta cultura e gusto in opere d’inchiostro, scarso cervello, scarsa morale, spaventosa chiaroveggenza: è il vero figlio del tempo nostro. Non ricco, giunta l’ora di «vender parolette» (il suo Petrarca! ...) e farsi baratto o gazzettiere, Totò scelse l’esilio. E in libertà riflette ai suoi trascorsi che sarà bello tacere. Non è cattivo. Manda soccorso di danaro al povero, all’amico un cesto di primizie; non è cattivo. A lui ricorre lo scolaro 40 pel tema, l’emigrante per le commendatizie. Gelido, consapevole di sé e dei suoi torti, non è cattivo. È il buono che derideva il Nietzsche: «… in verità derido l’inetto che si dice buono, perché non ha l’ugne abbastanza forti…» Dopo lo studio grave, scende in giardino, gioca coi suoi dolci compagni sull’erba che l’invita; i suoi compagni sono: una ghiandaia rôca, un micio, una bertuccia che ha nome Makakita... III La Vita si ritolse tutte le sue promesse. Egli sognò per anni l’Amore che non venne, sognò pel suo martirio attrici e principesse, ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne. Quando la casa dorme, la giovinetta scalza, fresca come una prugna al gelo mattutino, giunge nella sua stanza, lo bacia in bocca, balza su lui che la possiede, beato e resupino... IV Totò non può sentire. Un lento male indomo inaridì le fonti prime del sentimento; l’analisi e il sofisma fecero di quest’uomo ciò che le fiamme fanno d’un edificio al vento. Ma come le ruine che già seppero il fuoco esprimono i giaggioli dai bei vividi fiori, quell’anima riarsa esprime a poco a poco una fiorita d’esili versi consolatori... V Così Totò Merùmeni, dopo tristi vicende, quasi è felice. Alterna l’indagine e la rima. Chiuso in sé stesso, medita, s’accresce, esplora, intende la vita dello Spirito che non intese prima. “Perché la voce è poca, e l’arte prediletta 41 immensa, perché il Tempo – mentre ch’io parlo! – va, Totò opra in disparte, sorride, e meglio aspetta. E vive. Un giorno è nato. Un giorno morirà. All’atteggiamento di recupero si affianca talora quello della parodia. Si veda, ad esempio, la poesia Ketty (composta da Gozzano all’epoca del soggiorno in India), con la voce tracotanza (di matrice dantesca) e il latin sangue gentile (citazione dalla canzone petrarchesca Italia mia, benché ’l parlar sia indarno). Ketty I Supini al rezzo ritmico del panka. Sull'altana di cedro, il giorno muore, giunge dal Tempio un canto or mesto or gaio, giungono aromi dalla jungla in fiore. Bel fiore del carbone e dell'acciaio Miss Ketty fuma e zufola giuliva altoriversa nella sedia a sdraio. Sputa. Nell'arco della sua saliva m'irroro di freschezza: ha puri i denti, pura la bocca, pura la genciva. Cerulo-bionda, le mammelle assenti, ma forte come un giovinetto forte, vergine folle da gli error prudenti, ma signora di sé della sua sorte sola giunse a Ceylon da Baltimora dove un cugino le sarà consorte. Ma prima delle nozze, in tempo ancora esplora il mondo ignoto che le avanza e qualche amico esplora che l'esplora. Error prudenti e senza rimembranza: Ketty zufola e fuma. La virile 42 franchezza, l'inurbana tracotanza attira il mio latin sangue gentile. II Non tocca il sole le pagode snelle che la notte precipita. Le chiome delle palme s'ingemmano di stelle. Ora di sogno! E Ketty sogna: “...or come vivete, se non ricco, al tempo nostro? È quotato in Italia il vostro nome? Da noi procaccia dollari l'inchiostro...” “Oro ed alloro!...” - “Dite e traducete il più bel verso d'un poeta vostro...” Dico e la bocca stridula ripete in italo-britanno il grido immenso: “Due cose belle ha il mon... Perché ridete?”. “Non rido. Oimè! Non rido. A tutto penso che ci dissero ieri i mendicanti sul grande amore e sul nessun compenso. (Voi non udiste, Voi tra i marmi santi irridevate i budda millenari, molestavate i chela e gli elefanti.) Vive in Italia, ignota ai vostri pari, una casta felice d'infelici come quei monni astratti e solitari. Sui venti giri non degli edifici vostri s'accampa quella fede viva, non su gazzette, come i dentifrici; sete di lucro, gara fuggitiva, elogio insulso, ghigno degli stolti più non attinge la beata riva; 43 l'arte è paga di sé, preclusa ai molti, a quegli data che di lei si muore...” Ma intender non mi può, benché m'ascolti, la figlia della cifra e del clamore. III Intender non mi può. Tacitamente il braccio ignudo premo come zona ristoratrice, sulla fronte ardente. Gelido è il braccio ch'ella m'abbandona come cosa non sua. Come una cosa non sua concede l'agile persona... - “O yes! Ricerco, aduno senza posa capelli illustri in ordinate carte: l'Illustrious lòchs collection più famosa. Ciocche illustri in scienza in guerra in arte corredate di firma o documento, dalla Patti, a Marconi, a Buonaparte... (mordicchio il braccio, con martirio lento dal polso percorrendolo all'ascella a tratti brevi, come uno stromento) e voi potrete assai giovarmi nella Italia vostra, per commendatizie...” - “Dischiomerò per Voi l'Italia bella!” “Manca D'Annunzio tra le mie primizie; vane l'offerte furono e gl'inviti per tre capelli della sua calvizie...” - “Vi prometto sin d'ora i peli ambiti; completeremo il codice ammirando: a maggior gloria degli Stati Uniti...” L'attiro a me (l'audacia superando per cui va celebrato un cantarino 44 napolitano, dagli Stati in bando...) Imperterrita indulge al resupino, al temerario - o Numi! - che l'esplora tesse gli elogi di quel suo cugino, ma sui confini ben contesi ancora ben si difende con le mani tozze, al pugilato esperte... In Baltimora il cugino l'attende a giuste nozze. Si veda anche L’ipotesi (sorta di cartone preparatorio della Signorina Felicita), il cui finale ricalca la figura dell’Ulisse dantesco, in chiave parodicamente autobiografica. L’ipotesi […] Il Re di Tempeste era un tale che diede col vivere scempio un bel deplorevole esempio d'infedeltà maritale, che visse a bordo d'un yacht toccando tra liete brigate le spiaggie più frequentate dalle famose cocottes... Già vecchio, rivolte le vele al tetto un giorno lasciato, fu accolto e fu perdonato dalla consorte fedele... Poteva trascorrere i suoi ultimi giorni sereni, contento degli ultimi beni come si vive tra noi... Ma né dolcezza di figlio, né lagrime, né pietà del padre, né il debito amore per la sua dolce metà gli spensero dentro l'ardore della speranza chimerica 45 e volse coi tardi compagni cercando fortuna in America... - Non si può vivere senza danari, molti danari... Considerate, miei cari compagni, la vostra semenza! Vïaggia vïaggia vïaggia vïaggia nel folle volo vedevano già scintillare le stelle dell'altro polo... vïaggia vïaggia vïaggia vïaggia per l'alto mare: si videro innanzi levare un'alta montagna selvaggia... Non era quel porto illusorio la California o il Perù, ma il monte del Purgatorio che trasse la nave all'in giù. E il mare sovra la prora si fu rinchiuso in eterno. E Ulisse piombò nell'Inferno dove ci resta tuttora... Quanto a Ungaretti, il suo interesse per Dante si manifesta anche nell’ambito dell’esperienza di docente in Brasile (eccellente, per esempio, la sua lettura del canto I dell’Inferno). Per restare solo all’Allegria e solo ad un paio di esempi, si vedano i versi Foglia appena nata (in Fratelli), che riprende la similitudine di Purg. VIII, 28, e Come questa pietra / è il mio pianto (in Sono una creatura), che richiama il canto di Ugolino (Io non piangea, sì dentro impetrai). Fratelli Di che reggimento siete fratelli? Parola tremante nella notte Foglia appena nata 46 Nell’aria spasimante involontaria rivolta dell’uomo presente alla sua fragilità Fratelli Sono una creatura Come questa pietra del S. Michele così fredda così dura così prosciugata così refrattaria così totalmente disanimata Come questa pietra è il mio pianto che non si vede La morte si sconta vivendo Per Saba, poi, Dante rappresenta il culmine della poesia italiana, mentre Petrarca ne è il guasto. In Via della Pietà, la gente morta riprende Inf. VIII e Purg. XXX: Via della Pietà Accennava all’aspetto una sventura, sì lunga e stretta come una barella. Hanno abbattuto le sue vecchie mura, e di qualche ippocàstano si abbella. 47 Ma ancor di sé l’attrista l’ospedale, che qui le sue finestre apre e la porta, dove per visitar la gente morta preme il volgo perverso; e come fuori dei teatri carrozze in riga nera, sempre fermo ci vedo un funerale. Cerei sinistri odori escon dalla cappella; e se non posso rattristarmi, pensare il giorno estremo, l’eterno addio alle cose di cui temo perdere solo un’ora, è perché il rosso d’una cresta si muove fra un po’ d’erba, cresciuta lungo gli arboscelli in breve zolla: quel rosso in me speranza e fede ravviva, come in campo una bandiera. La gallinella che ancor qui si duole, e raspa presso alla porta funesta, mi fa vedere dietro alla sua cresta tutta una fattoria piena di sole. Nel sonetto Vivevo allora a Firenze (decimo dell’Autobiografia), Saba sarcasticamente paragona il proprio incontro con d’Annunzio a quello di Dante con papa Celestino V (Inf. III): ne è spia l’uso dei verbi vidi e conobbi. Vivevo allora a Firenze Vivevo allora a Firenze, e una volta venivo ogni anno alla città natale. Più d’uno in suoi ricordi ancor m’ascolta dire, col nome di Montereale, i miei versi agli amici, o ad un’accolta d’ignari dentro assai nobili sale. Plausi n’avevo, or n’ho vergogna molta; celarlo altrui, quand’io lo so, non vale. Gabriele d’Annunzio alla Versiglia vidi e conobbi; all’ospite fu assai egli cortese, altro per me non fece. 48 A Giovanni Papini, alla famiglia che fu poi della “Voce”, io appena o mai non piacqui. Ero fra lor di un’altra spece. Di Clemente Rebora si può ricordare la poesia Per Ezra Pound, dove Dante è messo in scena in chiave scherzosamente attualizzata; è da riportare a Dante anche, nei Frammenti lirici, l’uso di verbi parasintetici. Quasimodo predilige, almeno in un primo tempo, il Dante più “umano” dell’Inferno e del Purgatorio a quello più “spirituale” della Vita nuova e del Paradiso. Nella lirica Alle fronde dei salici, la bella sinestesia dell’urlo nero / della madre è da riportare (come suggerisce lo stesso Quasimodo nell’appunto di una lezione) al verso Io venni in loco d'ogne luce muto (Inf. V), con rovesciamento incrociato muto>urlo, luce>nero. Alle fronde dei salici E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze sull’erba dura di ghiaccio, al lamento d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo? Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Il verso trafitto da un raggio di sole di Ed è subito sera richiama invece Purg. XXX, 40-42 (Dante trafitto dall’alta virtù di Beatrice). Ed è subito sera Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera. 49 Luzi è in un primo tempo più vicino alla linea petrarchesca che a quella di Dante, di cui comunque tiene presente le Rime più della Commedia; si veda la sua prima poesia, Alla Vita, che richiama, almeno a livello tematico, il sonetto Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io (il motivo della lontananza e dell’assenza è, d’altronde, tipico dell’ermetismo). Alla Vita Amici ci aspetta una barca e dondola nella luce ove il cielo s’inarca e tocca il mare, volano creature pazze ad amare il viso d’Iddio caldo di speranza in alto in basso cercando affetto in ogni occulta distanza e piangono: noi siamo in terra ma ci potremo un giorno librare esilmente piegare sul seno divino come rose dai muri nelle strade odorose sul bimbo che le chiede senza voce. Amici dalla barca si vede il mondo e in lui una verità che procede intrepida, un sospiro profondo dalle foci alle sorgenti; la Madonna dagli occhi trasparenti scende adagio incontro ai morenti, raccoglie il cumulo della vita, i dolori le voglie segrete da anni sulla faccia inumidita. Le ragazze alla finestra annerita con lo sguardo verso i monti non sanno finire d’aspettare l’avvenire. Nelle stanze la voce materna senza origine, senza profondità s’alterna col silenzio della terra, è bella e tutto par nato da quella. Il recupero del Dante della Commedia (dell’Inferno e del Purgatorio in particolare) comincia con la raccolta Nel magma, una fra le più 50 importanti di tutto il ’900 (è del ’63 e si può considerare un’anticipazione di Satura, che Montale pubblica nel ’71). Notevole è in questa raccolta la presenza del modello narrativo di Dante e di una tendenza alla teatralità di matrice dantesca; si veda, ad esempio, la lunga poesia Presso il Bisenzio, dove il tema politico è svolto attraverso un colloquio che riprende chiaramente quello di Dante con Farinata in Inf. X. Presso il Bisenzio La nebbia ghiacciata affumica la gara della concia e il viottolo che segue la proda. Ne escono quattro non so se visti o non mai visti prima, pigri nell'andatura, pigri anche nel fermarsi fronte a fronte. Uno, il più lavorato da smanie e il più indolente, mi si fa incontro, mi dice: «Tu? Non sei dei nostri. Non ti sei bruciato come noi al fuoco della lotta quando divampava e ardevano nel rogo bene e male». Lo fisso senza dar risposta nei suoi occhi vizzi, deboli, e colgo mentre guizza lungo il labbro di sotto un'inquietudine. «Ci fu solo un tempo per redimersi» qui il tremito si torce in tic convulso «o perdersi, e fu quello». Gli altri costretti a una sosta impreveduta dànno segni di fastidio, ma non fiatano, muovono i piedi in cadenza contro il freddo e masticano gomma guardando me o nessuno. «Dunque sei muto?» imprecano le labbra tormentate mentre lui si fa sotto e retrocede frenetico, più volte, finché è là fermo, addossato a un palo, che mi guarda tra ironico e furente. E aspetta. Il luogo, quel poco ch'è visibile, è deserto; la nebbia stringe dappresso le persone e non lascia apparire che la terra fradicia dell' argine e il cigaro, la pianta grassa dei fossati che stilla muco. E io: «E difficile spiegarti. Ma sappi che il cammino per me era più lungo che per voi e passava da altre parti». «Quali parti?» Come io non vado avanti, mi fissa a lungo ed aspetta. «Quali parti?» I compagni, uno si dondola, uno molleggia il corpo sui garetti 51 e tutti masticano gomma e mi guardano, me oppure il vuoto. «E difficile, difficile spiegarti». C'è silenzio a lungo, mentre tutto è fermo, mentre l'acqua della gora fruscia. Poi mi lasciano lì e io li seguo a distanza. Ma uno d'essi, il più giovane, mi pare, e il più malcerto si fa da un lato, s'attarda sul ciglio erboso ad aspettarmi mentre seguo lento loro inghiottiti dalla nebbia. A un passo ormai, ma senza ch'io mi fermi, ci guardiamo, poi abbassando gli occhi lui ha un sorriso da infermo. «O Mario» dice e mi si mette al fianco per quella strada che non è una strada ma una traccia tortuosa che si perde nel fango «guardati, guardati d'attorno. Mentre pensi e accordi le sfere d'orologio della mente sul moto dei pianeti per un presente eterno che non è il nostro, che non è qui né ora, volgiti e guarda il mondo come è divenuto, poni mente a che cosa questo tempo ti richiede, non la profondità, né l'ardimento, ma la ripetizione di parole, la mimesi senza perché né come dei gesti in cui si sfrena la nostra moltitudine morsa dalla tarantola della vita, e basta. Tu dici di puntare alto, di là dalle apparenze, e non senti che è troppo. Troppo, intendo, per noi che siamo dopo tutto i tuoi compagni, giovani ma logorati dalla lotta e più che dalla lotta, dalla sua mancanza [umiliante». Ascolto insieme i passi nella nebbia dei compagni che si eclissano e questa voce venire a strappi rotta da un ansito. Rispondo: «Lavoro anche per voi, per amor vostro». Lui tace per un po' quasi a ricever questa pietra in cambio del sacco doloroso vuotato ai miei piedi e spanto. E come io non dico altro, lui di nuovo: «O Mario, com'è triste essere ostili, dirti che rifiutiamo la salvezza, né mangiamo del cibo che ci porgi, dirti che ci offende». Lascio placarsi a poco a poco il suo respiro mozzato dall'affanno mentre i passi dei compagni si spengono 52 e solo l'acqua della gara fruscia di quando in quando. «È triste, ma è il nostro destino: convivere in uno stesso tempo e luogo e farci guerra per amore. Intendo la tua angoscia, ma sono io che pago tutto il debito. E ho accettato questa sorte». E lui, ora smarrito ed indignato: «Tu? tu solamente?». Ma poi desiste dallo sfogo, mi stringe la mano con le sue convulse e agita il capo: «O Mario, ma è terribile, è terribile tu non sia dei nostri» E piange, e anche io piangerei. se non fosse che devo mostrarmi uomo a lui che pochi ne ha veduti. Poi corre via succhiato dalla nebbia del viottolo. Rimango a misurare il poco detto, il molto udito, mentre l'acqua della gora fruscia, mentre ronzano fili alti nella nebbia sopra pali e antenne. «Non potrai giudicare di questi anni vissuti a cuore duro, mi dico, potranno altri in un tempo diverso. Prega che la loro anima sia spoglia e la loro pietà sia più perfetta». La presenza di Dante è particolarmente forte e significativa in Caproni e in Montale. Due raccolte del primo, addirittura, hanno per titolo altrettanti sintagmi danteschi: Il seme del piangere (da Purg. XXXI) e Il muro della terra (da Inf. X). Si può vedere, fra tutte, l’ultima poesia di Caproni (uscita sul numero di dicembre 1989 di Famiglia cristiana; Caproni muore il 22 gennaio 1990), dal titolo lunghissimo: Dinanzi al Bambin Gesù pensando ai troppi innocenti che nascono derelitti nel mondo: vi è l’espressione terra guasta, che riprende il paese guasto di Inf. XIV (e insieme la Waste Land, la terra desolata – in realtà guasta-guastata – di Eliot). Dinanzi al Bambin Gesù… Nel gelo del disamore senza asinello né bue quanti, con le stesse Sue fragili membra, quanti Suoi simili, in tremore, nascono ogni giorno in questa Terra guasta!... 53 Soli e indifesi, non basta a salvarli il candore del sorriso. La Bestia è spietata. Spietato l’Erode ch’è in tutti noi. Vedi tu, che puoi avere ascolto. Vedi almeno tu, in nome del piccolo Salvatore cui, così ardentemente, credi d’invocare per loro un grano di carità. A che mai serve il pianto - posticcio - del poeta? Meno che a nulla. È soltanto vano orpello. È viltà Montale è poeta dantesco per eccellenza. Non a caso tiene, nel 1965 a Firenze, il discorso conclusivo delle celebrazioni per il settimo centenario della nascita di Dante. La memoria dantesca è già presente nella prima poesia, Meriggiare pallido e assorto, che Montale scrive a 20 anni: nel verso spiar le file di rosse formiche (che in prima redazione era seguir le file di rosse formiche) c’è un richiamo a Purg. XXVI, 34-36 (s'ammusa l'una con l'altra formica, / forse a spïar lor via e lor fortuna). Meriggiare pallido e assorto Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d’orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo o su la veccia spiar le file di rosse formiche ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano a sommo di minuscole biche. 54 Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com’è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Un solo altro esempio: in Spesso il male di vivere ho incontrato il verso il rivo strozzato che gorgoglia (in prima redazione il rivo ingorgato che gorgoglia) richiama Inf. VII, 125 (gorgoglian ne la strozza). Spesso il male di vivere ho incontrato Spesso il male di vivere ho incontrato: era il rivo strozzato che gorgoglia, era l’incartocciarsi della foglia riarsa era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina Indifferenza: era la statua della sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. Dante è per Montale un fondamentale punto di riferimento nella costruzione del mito femminile di Clizia, la donna-angelo – o, meglio, l’angelo che si fa donna – portatrice di salvezza e miracoli come la Beatrice dantesca; si veda per tutti Ti libero la fronte dai ghiaccioli: Ti libero la fronte dai ghiaccioli Ti libero la fronte dai ghiaccioli che raccogliesti traversando l'alte nebulose; hai le penne lacerate dai cicloni, ti desti a soprassalti. 55 Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo l'ombra nera, s'ostina in cielo un sole freddoloso; e l'altre ombre che scantonano nel vicolo non sanno che sei qui. Si vedano anche, nel primo mottetto (Lo sai: debbo riperderti e non posso), le parole oscura, selva, smarrito che rinviano apertamente ai primi versi della Commedia (nel verso finale, poi, si parla esplicitamente di inferno): Lo sai: debbo riperderti e non posso Lo sai: debbo riperderti e non posso. Come un tiro aggiustato mi sommuove ogni opera, ogni e anche lo spiro salino che straripa dai moli e fa l’oscura primavera di Sottoripa. Paese di ferrame e alberature a selva nella polvere del vespro. Un ronzìo lungo viene dall’aperto, strazia com’unghia ai vetri. Cerco il segno smarrito, il pegno solo ch’ebbi in grazia da te. E l’inferno è certo. 56 VALTER BOGGIONE Il mito in Pavese e Fenoglio1 Il binomio Pavese-Fenoglio è ricorrente ma poco plausibile, per la profonda diversità fra i due autori. Il mito è un importante tema che li accomuna e ne attesta le differenze. Pavese elabora le proprie idee sul mito alla luce delle teorie di secondo ’800 e primo ’900: quella intellettualistica della scuola antropologica britannica, quella evoluzionistica di James Frazer e quella della scuola etnologica tedesca; in particolare è influenzato da Il ramo d’oro di Frazer (che lui stesso fa pubblicare nella “Collana viola” di Einaudi), ma anche da d’Annunzio, Pirandello, Bontempelli, Nietzsche e soprattutto Vico. La visione pavesiana del mito è regressiva: il mito recupera la spontaneità originaria, la visione primigenia del mondo; inoltre è ripetitivo: produce archetipi che si ritrovano in diverse culture. In tutti i romanzi di Pavese c’è un ritorno al passato, ai luoghi d’origine, che implica sempre la scoperta del negativo: il mondo del mito è anche un mondo di violenza, morte, distruzione. Così il viaggio alla fine fallisce: si ritorna per ripartire di nuovo e definitivamente. Pur con la sua parte di orrore, comunque, il mito è una fuga dalla storia: la violenza del mito è finalizzata, ha una ragione ontologica (nella natura non c’è vita senza morte), mentre la violenza della storia non è giustificabile. I miti di Fenoglio sono più semplici: sono quelli imparati a scuola (attraverso i poemi omerici innanzitutto). A Fenoglio non interessa capire che cos’è il mito e come funziona, ma riattualizzare i miti antichi – o crearne di nuovi – per innalzare l’esperienza quotidiana a livello assoluto ed esemplare: Johnny, ad esempio, è fatto diventare una sorta di supereroe della storia occidentale, un novello Ettore; il partigiano insepolto richiama il mito di Antigone; la battaglia di Valdivilla è assurta al rango delle Termopili, e così via. Il confronto Pavese-Fenoglio si appunta infine sul mito specifico di Ulisse. Ne La luna e i falò Anguilla è un Ulisse apparente, che fallisce sia nella fuga in America sia nel ritorno a Santo Stefano Belbo: alla fine gli resta solo la consapevolezza di non poter avere un’identità e di non potersi integrare. Nella Malora, invece, Agostino è un Ulisse autentico, seppur in 1 Programmata per il 10 marzo 2010, la lezione, a causa di diversi impedimenti, è stata poi rinviata al 12 maggio 2010. 57 minore: dopo l’esperienza negativa al Pavaglione, torna a casa consapevole delle proprie radici e della propria identità. La luna e i falò si conclude con una ripartenza definitiva e senza meta; La malora, con l’immagine dell’albero che dopo l’inverno riprende vita e ributta le gemme. *** Il binomio Pavese-Fenoglio è poco plausibile, nonostante sia continuamente riproposto, vista la profonda diversità fra i due autori, al di là di alcune superficiali consonanze. Fra i temi che li accomunano e, proprio per questo, possono attestarne la diversità, il più significativo forse è quello del mito. Qual è l’atteggiamento di Pavese e di Fenoglio nei confronti del mito? Per rispondere a questa domanda, il relatore richiama le tre principali teorie sul mito fiorite in Europa tra secondo ’800 e primo ’900: quella della scuola antropologica britannica (la teoria intellettualistica di Edward Taylor, per la quale il mito è la spiegazione inadeguata della realtà prodotta dall’uomo primitivo), quella evoluzionistica di James Frazer (nella storia dell’umanità, il mito rappresenta il primo modo per capire il mondo, seguito dal tentativo di modificare la realtà attraverso la magia, quindi dalla religione degli dèi e infine dall’età della ragione e della scienza) e quella della scuola etnologica tedesca (Karol Kerenyi e Leo Frobenius, per i quali il mito esprime l’energia primaria dell’uomo a contatto con la natura, prima che la ragione lo cambi e lo snaturi). In particolare Pavese è influenzato dal testo di Frazer (Il ramo d’oro, letto, postillato e pubblicato a sua cura nella “Collana viola” di Einaudi); fondamentale per Pavese l’idea della necessità di uno studio comparativo dei miti al fine di capirne il significato ultimo ovvero di ritrovare gli archetipi che accomunano i miti di ogni luogo e tempo; ma Pavese è influenzato anche da d’Annunzio, dall’ultimo Pirandello, da Bontempelli, da Nietzsche e soprattutto da Vico: si può dire che sovrapponga il pensiero di Vico all’evoluzionismo di Frazer. Pavese ha una visione regressiva del mito. Il mito è la forma di cultura del passato, è l’infanzia dell’individuo e dell’umanità. Le cose che davvero contano sono quelle viste per la prima volta. Dunque bisogna tornare indietro. All’opposto delle religioni positive (che sono “progressive”), il mito va all’indietro: punta al recupero 58 della spontaneità originaria, della visione primigenia del mondo (dell’umanità primitiva, dell’infanzia). Inoltre è ripetitivo: produce archetipi che si ritrovano in diverse culture. In tutti i romanzi di Pavese (si potrebbe dire che egli scriva sempre lo stesso libro) c’è un tentativo di ritorno al passato, configurato come viaggio di fuga dalla città alla campagna e/o di riscoperta dei luoghi d’origine. Così è per Berto, protagonista del primo romanzo di Pavese, Paesi tuoi, come per Anguilla de La luna e i falò, l’ultimo romanzo. Berto si trasferisce a Monticello perché è convinto che le Langhe siano un mondo incorrotto, dove si può ritornare alla condizione primitiva dell’uomo, comunicare col mondo e con la natura, ritrovare la purezza originaria. L’unione sessuale con la donna è il simbolo e il tramite dell’incontro con il mondo, con il tutto: non a caso il primo rapporto tra Berto e Gisella è rappresentato con significativi tratti dannunziani (del d’Annunzio pànico di Alcyone). Ma un imprevisto – la scoperta di una ferita sul corpo di Gisella, procurata da un attrezzo agricolo – rompe l’incantesimo, rivelando la presenza del male, della violenza: Gisella, come si saprà, ha subito violenza dal fratello, è vittima di un incesto, ha perso la purezza. Dunque quel mondo non è il paradiso sognato: è fatto anche di violenza, morte e distruzione. Nel mondo del mito non ci sono soltanto dèi apollinei ma anche divinità ctonie. Pavese allude al mito greco del rapimento di Persefone, al rapporto incestuoso tra Ade e Persefone e soprattutto tra Posidone e Demetra (fratelli, come Talino e Gisella). Gisella finisce uccisa da Talino, che le pianta un tridente in gola, il giorno della trebbiatura, in un anno di scarso raccolto: come una vittima propiziatrice (Pavese prende da Frazer anche l’idea che tutti i miti, alla fine, siano miti di fertilità; si veda anche, ne La luna e i falò, la morte di Santa, uccisa dai partigiani perché sospettata di doppio gioco e bruciata, in abito bianco, sui sarmenti di vite, in una terra magra che però è rigogliosa nel luogo del rogo). Dunque il viaggio di Berto sfocia nella scoperta inaspettata della violenza e della distruzione. Tutti i viaggi pavesiani alla fine sono fallimentari. Il ritorno è sempre problematico e terribile: si ritorna per ripartire di nuovo e definitivamente. Lo schema è: ritorno > scoperta inaspettata > fuga. In Pavese c’è anche l’idea che il mito, pur con la sua parte di orrore, sia una fuga dalla storia (questo lo prende in particolare da 59 Kerenyi). La storia è una sequenza di orrori. Pavese ne ha paura. Non ha strumenti per un’analisi storico-politica: perciò non capisce a fondo la storia contemporanea. Fugge dalla storia attraverso il mito. La violenza del mito, almeno, è finalizzata, ha una sua ragione ontologica (nella natura non c’è vita senza morte), mentre la violenza della storia non è giustificabile. Il mito giustifica ciò che sul piano storico non è giustificabile: offre dunque una spiegazione ed un conforto. In Fenoglio la teoria del mito è più semplice, ingenua, di tipo scolastico. I suoi miti sono quelli imparati a scuola, sui libri di testo (i poemi omerici innanzitutto). A Fenoglio non interessa capire che cos’è il mito e come funziona, ma ricreare, riattualizzare i miti antichi – o crearne di nuovi – per innalzare l’esperienza quotidiana a livello assoluto ed esemplare. Johnny è una sorta di supereroe della storia occidentale, un novello Ettore; nel Partigiano Johnny e nelle altre opere resistenziali si ritrovano i modelli di vari eroi omerici, come il mito di Antigone (l’eroe insepolto) o quello della battaglia delle Termopili (applicato alla battaglia di Valdivilla, del ’45: uno scontro modesto, che Fenoglio trasforma in un evento bellico capitale, con i partigiani protagonisti di un’eroica e sfortunata resistenza). Il confronto Pavese-Fenoglio si appunta infine su un mito specifico: quello di Ulisse. Ne La luna e i falò Anguilla è in apparenza un Ulisse che parte dalla sua Itaca (Santo Stefano Belbo) alla scoperta del mondo. Ma in realtà è un senza patria (è un bastardo, non sa l’origine dei propri genitori) e il suo viaggio non è un’anabasi ma una catabasi (non è in cerca di esperienze, ma della propria identità). Va in America alla ricerca della terra-madre, della terra primitiva e incontaminata (l’America sognata da Anguilla è quella dell’Inno ai Patriarchi di Leopardi: …fra le vaste californie selve / nasce beata prole), di un altrove che gli consenta di fuggire dal chiuso del paese. Ma l’America che scopre è una delusione: non selvaggia e primitiva ma popolata di contadini (magari di origine piemontese), più civilizzata delle Langhe e piena di violenza; fin che può, spinge sempre un po’ più in là la frontiera, finche giunge a San Francisco e di fronte all’oceano, come l’Alexandros di Pascoli, capisce infine che il viaggio è stato inutile (“quelle stelle non sono le sue”). Non gli resta che tornare indietro, con la consapevolezza di 60 non poter avere un’identità, di non potersi integrare; il mondo di Santo Stefano, per altro, al suo ritorno è completamente cambiato. Nella Malora Agostino è costretto ad andar via di casa, ma per necessità, non per scelta come Anguilla: il padre lo manda a lavorare come servo alla cascina del Pavaglione (interna alle Langhe, non esterna e lontana come l’America di Anguilla). Lì vive molte esperienze negative: incontra il dolore (si ammazza di lavoro, mangia poco e male), l’amore (il rapporto con Fede, che però deve sposare un altro), la morte (l’impiccato putrefatto). Il suo è un viaggio di esperienza: parte inconsapevole e alla fine, quando torna a lavorare la terra di casa sua, “ha capito”. Il suo ritorno è davvero come quello di Ulisse ad Itaca. La sua storia è un Billdungsroman. All’opposto, il fratello Stefano, che è stato militare a Oneglia, torna senza più voglia di restare e di lavorare, e farà la fine di Anguilla. Agostino non riparte più, per non tradire – come dice – la memoria di suo padre. Ha trovato le radici, l’identità, la sua Itaca. Perciò nella Malora non c’è disperazione; si veda l’immagine finale dell’albero che alla fine dell’inverno riprende vita e ributta le gemme. 61 La lezione di Valter Boggione (12 maggio 2010) Indice I Mercoledì letterari al Redemptoris Mater…………... p. 5 Giorgio Bárberi Squarotti, Il Novecento letterario italiano…………………………………... p. 9 Gian Giacomo Amoretti, La grande poesia ligure del ’900: Sbarbaro, Montale, Caproni….. p. 13 Alberto Beniscelli, Letture montaliane…………….… p. 25 Francesco De Nicola, Il neorealismo nella letteratura italiana del Novecento………………….. p. 33 Luigi Surdich, Dante nella poesia del Novecento…… p. 39 Valter Boggione, Il mito in Pavese e Fenoglio………. p. 57 63 Finito di stampare nel mese di ottobre 2010 presso la Tipolitografia F.lli Stalla di Albenga
Scarica