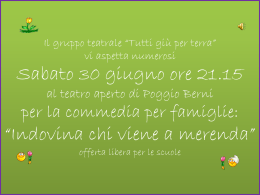Introduzione al teatro latino G. Chiarini – F. Mosetti Casaretto prima edizione: Mondadori Università, 2004 1 CARATTERI GENERALI DEL TEATRO LATINO 1.1 PRIMA DEL TEATRO SCRITTO Ludi Romani (festa di metà settembre) del 240 a.C.: Livio Andronico mette in scena una fabula di argomento greco riadattandola dal repertorio attico. La novità fu voluta dagli edili curuli in omaggio a Giove Ottimo Massimo per il successo contro Cartagine (I^ guerra punica, 241 a.C.). Questa data d’inizio del teatro latino scritto, non avrebbe segnato una svolta se non fosse stata anticipata da un secolo di teatro accolto nelle feste: un teatro come quello attico (secoli V-IV a.C.) non avrebbe potuto essere riproposto senza una tradizione preesistente. La tradizione risaliva al 364 a.C.: fu introdotto nella festa una forma di teatro, vicino al varietà, chiamata satura (cioè, farcito di numeri), costituita da scenette farsesche, parodie, canti e danze, forse in una scenografia essenziale. Ma anche questa forma era preceduta da secoli di performance musical-teatrali nelle feste agricole dell’entroterra laziale. Qualsiasi forma teatrale è preceduta da un qualche rituale di danza, dalla quale tale forma si è, nel tempo, sviluppata. Dobbiamo pensare quindi a antiche danze a carattere apotropaico, con lo scopo di allontanare il malocchio. Le occasioni per queste cerimonie erano le scadenze del calendario agricolo (aratura, semina, primavera, vendemmia). Il carattere apotropaico-protettivo era congiunto a quello propiziatorio: gli dèi dovevano proteggere fecondità di terre e donne. Il tema della festa è la sopravvivenza della comunità. La danza è espressione di gratitudine per il passato e tentativo di controllo dei meccanismi riproduttivi, liberazione di energie psichiche, attenuazione dei contrasti sociali, mimesi dei rituali interfamiliari, incontro tra i giovani della comunità per nuovi legami. 1.2 LA DANZA DELLE DANZE Grazie a testimonianze, ricostruiamo le due coreografie essenziali di queste danze: l’Iliade (libro XVIII, vv. 590-602) descrive la danza del labirinto, com’è raffigurata dal fabbro divino Efesto sullo scudo di Achille. La prima forma è quella “in tondo”, ancor oggi praticata in molte parti, comporta movimenti circolari. La seconda immagine è in file contrapposte, che si corrono in contro e si allontanano (a ogni movimento, ne corrisponde sempre un altro uguale e contrario). Sui significati si erano già interrogati gli antichi, come il grammatico Aftonio che individua negli antichi canti una strophé (evoluzione), un’antistrophé (controevoluzione) e un epodòs (canto eseguito sul posto) finale. Quale fu l’origine di questi movimenti? Le ipotesi sono due: alcuni dicono che sia stata istituita da Teseo che, ucciso il Minotauro, cantò imitando nella danza il percorso del labirinto, girando in vari sensi. Altri che col canto così ripartito l’uomo imiti l’universo: dapprima verso destra, perché il cielo dall’alba al tramonto ruota verso destra, poi verso sinistra, come la luna, infine stando fermi, come la terra. In realtà queste due origini sono simili: scampati al caos, gli uomini avevano ripreso a danzare in sintonia con gli astri. Come molti tuttora sono convinti che la danza sia la prima forma di piena espressione artistica, nel monto antico si era convinti che la prima danza fosse stata quella dei corpi celesti alla nascita del mondo ordinato, imitata poi dall’uomo. Secondo Licinio (nel dialogo Sulla danza di Luciano di Samosata, II secolo d.C.) «la danza nacque con Eros l’Antico, contemporaneamente all’universo». Eros Primigenio ha spinto gli elementi ad aggregarsi, e l’equilibrio delle rotazioni garantisce l’armonia dell’universo. Che vi sia connessione tra danza del labirinto e movimenti celesti, lo conferma il testo omerico. La similitudine col “vasaio” designa la danza “in tondo”: è la figura-base più diffusa, ancor oggi, e il “girare” di tali danze è figura imitante del “girare” dei corpi celesti. Anche la figura dei due semicori che si incontrano e allontanano è diffusa nella danza popolare, specialmente in tondo, e anch’essa ripetizione dei movimenti astrali. Quale significato aveva la danza del labirinto? Tesero da Creta approdò a Delo, eseguì sacrifici ad Apollo e danzò coi compagni liberati dalla prigionia del Minotauro. “La danza ancor oggi praticata a Delo – racconta Plutarco – dicono sia un’imitazione dei meandri del labirinto, e gli abitanti di Delo la chiamavano gru. Questa denominazione pare dovuta ai danzatori che si tengono per mano, spostandosi in formazione, come le gru. 1.3 CORTEGGIAMENTO, CONTRASTO Quindi le origini della danza hanno a che fare anche con un’immedesimazione col mondo animale, e entrambi questi aspetti, celeste e animale, sono al servizio degli equilibri interni alla comunità, prestandosi a esprimere, tramite l’avvicinamento e l’allontanamento, l’incontro/scontro positivo dell’amore sia quello negativo politico e militare. Le due dimensioni sono collegate: il giovane maschio si vanta anche del suo essere destinato a un ruolo militare, così le danze di guerra sono anche di corteggiamento, come sembra essere quella descritta nell’Iliade. A questa doppia tematica sembrano rinviare i Fescennini versus (etimologia forse connessa con Fescennia, città laziale di cultura affine ai latini), scambi di battute in metriche improvvisate, con accompagnamento di musica elementare. La caratteristica era il motteggio: nel clima euforico della festa agreste era lecito rievocare i fatti del passato recente e criticare i personaggi più in vista. Così trovavano sfogo le tensioni quotidiane. L’insistenza su precisi temi anatomici, la volgarità delle metafore, predisponevano lo scambio fescennino anche ad argomenti sessuali: a esercitare la vena scurrile a servizio del contrasto dei sessi. Quando i fescennini passarono alla scena meno tollerante della cittàcapitale, la “licenza fescennina” divenne insulto, fattore di disordine: scomodi in particolare per i senatori e i magistrati, i fescennini furono presto vietati. Banditi dalle occasioni pubbliche, a Roma restarono a ravvivare il rito privato delle nozze. Evidentemente è la funzione apotropaica delle oscenità di cui erano farciti ad averne favorito la conservazione laddove andava propiziata la fertilità. La donna andava difesa dal malocchio, e pare che l’oscenità fosse la forma più efficace. Plutarco spiega che è il carattere bizzarro degli amuleti che indebolisce il malocchio, basta una forma insolita, disarmonica, a proteggere dalla malìa e lo sguardo nemico viene reso innocuo. Negli orti si collocavano statue di Priapo perché il suo membro gigantesco si credeva scacciasse i ladri. L’immagine del fallo era appunto il miglior rimedio per il malocchio. Il carattere apotropaico dei fescennini era talmente evidente da far pensare che accanto alla dipendenza etimologica da Fescennia, il termine derivasse da fascinum. Il mantenimento di scambi fescennini nei matrimoni conferma non solo la loro funzione ma anche la pertinenza alla sfera del corteggiamento: non è difficile immaginare contrasti tra giovani contadini e contadine, o tra rivali in amore. Dall’aggressività, dalla libertà di parola, ce ne parla anche Orazio in relazione ad una festa della mietitura (Epistole, II 1, 134-155). Nella prospettiva del classicista Orazio, la forza politica dei fescennini avevano toccato punte di aggressività tali da costringere il potere a prendere provvedimenti: questo giovò all’arte, preparando il terreno all’accoglimento del raffinato teatro attico. A causa del potenziale aggressivo, i politici tennero i fescennini lontano da occasioni festive, e Roma si provò per secoli dell’unica forma di teatro di cui disponeva. Seppur ruzza, era comunque una forma di teatro, con parole, dialoghi, camuffamenti, mimica (NB: gli antichi non distinguevano tra danza e mimica): anzi, una caratteristica era la congruenza tra parola e gesto (con accompagnamenti musicali). Quello che mancava ai fescennini era qualità dei versi e assoggettamento ad una disciplina artistica. 1.4 LA NASCITA DELLA SATURA L’incontro dei fescennini con l’arte avvenne nel 365/4 a.C., a causa di un’epidemia di peste (fonte: Tito Livio): furono per l’occasione istituiti i primi ludi scenici con ballerini venuti dall’Etruria. L’importanza di queste danze accompagnate dai flauti fu provocare la gioventù romana a dare dignità artistica ad una forma autoctona che non aveva trovato spazio nella festa cittadina. Grazie all’importazione, l’improvvisazione fescennina divenne una arte scenica accolta ufficialmente nei ludi. Non sappiamo in che consistesse la satura di questa fase preletteraria, forse una serie di scenette slegate, comunque certamente radicò il teatro in Roma e determinò il formarsi di una tradizione, preparando il terreno per l’arrivo di elementi stranieri. 1.5 L’INTRODUZIONE DEL TEATRO ATTICO Tito Livio racconta come Livio Andronico per primo prese le mosse dalle saturae per elaborare un dramma a soggetto e che fu anche attore di queste composizioni. In questa occasione (240 a.C., convenzionalmente data d’inizio del teatro latino letterario) cantò e recitò «con movimento assai vivace. […] Si cominciò a cantare accompagnando i gesti degli istrioni, e alla voce di questi si lasciarono soltanto i dialoghi». Anche Cicerone racconta che Livio Andronico ha per primo messo in scena un dramma [fabulam] proprio in questo periodo. Da questi passi si ricavano due dati certi: 1) con Livio Andronico si passa dalla forma antologica slegata della satira preletteraria all’unità del dramma a soggetto (e al modo greco-attico, interamente scritto); 2) alla complessità di veri e propri copioni si accompagnò la studiatezza di modi lontani dalla rusticità fescennina. I Romani per primi trapiantarono un genere (in questo caso, teatrale tragico e comico) in una nuova sede. Così, inventarono la traduzione “artistica”. Già con la comparsa dei ludiones, i danzatori etruschi, abbiamo visto come la novità straniera subisse immediato adattamento, portando prima un incrocio coi fescennini e poi una forma più complessa (satura). Adesso, l’intervento di Livio Andronico utilizza un repertorio straniero che, in quanto scritto, poco si presta a un riadattamento latino, allontanandosi dalla lucidità rituale caratteristica del teatro greco. La gioventù romana torna allora in parte alle origini rifacendosi a una forma non scritta, la farsa Atellana. Ciò mostra che, in una cultura che ha accolto più di un genere, sia generi nuovi che già sperimentati tendono a raggiungere tra loro un equilibrio, che è pur sempre instabile, date le evoluzioni delle esigenze di qualsiasi cultura. Per il teatro latino medio-repubblicano, l’affiancarsi degli exodia alle rappresentazioni regolari di tipo attico non è che uno degli episodi che caratterizzano la presa di possesso della nuova drammaturgia: si pensi alla saltuaria apparizione della [fabula] praetexta (tragedia d’abito e d’argomento romani) il cui compito era sopperire alle mancanze della [fabula] cothurnata (tragedia d’abito e d’argomento greci, che nei limiti era stata romanizzata). Si pensi anche al tentativo di giustapporre alla [fabula] palliata (commedia d’abito e costume greci) una commedia regolare in costume romano (la togata). Volgiamoci ai due modelli importati dalla Grecia: la tragedia (V sec. a.C.) e la commedia (IV sec. a.C.) prodotta ad Atene. 1.6 LA TRAGEDIA ATTICA L’etimologia di “tragedia (tragodìa) è poco chiara, non letteralmente (tragòs “capro” e odé “canto”) ma per il significato: perché “canto del capro”? Già gli antichi annaspavano pensando ora che il coro fosse formato da satiri (ma i satiri delle origini erano mezzi cavalli, non caprini), ora che nella preistoria agreste delle gare tragiche si mettesse in palio un capro. È interessante l’origine del teatro tragico ateniese. Aristotele fa riferimento al ditirambo, termine di etimo incertissimo: forse una danza per Dioniso affidata a un coro di satiri. Il primo passo fu del poeta lirico Arione di Lesbo (VI sec. a.C.) che aggiunse alla musica e alla danza il canto delle storie mitiche in versi, non legate alla storia ma ad altri dèi ed eroi. Il passaggio successivo fu di Tespi (metà VI sec. a.C.): oltre a un prologo, trasformò il capocoro in un personaggio indipendente (protagonista, “primo agonista”, cioè “primo attore”) che dialogava col coro. A Tespi si attribuisce la prima rappresentazione alle Grandi Dionisie di Atene del 534 a.C. In Tespi il coro dei satiri era stato soppiantato in un coro umano, che variava identità, a seconda del mito trattato: con il protagonista di stirpe regale a avrà dialogato un coro adatto (di cittadini, soldati, donne, prigionieri, ecc.). L’origine satiresca non andrò perduta: il drammaturgo Pratina di Filunte, città dell’Arcadia, prese a comporre drammi satireschi interamente scritti, con protagonista e coro di satiri: il tema restava mitico e i personaggi erano eroi, ma la trattazione era più vicina a quella delle origini. L’esordio di Pratina autore di drammi satireschi è fissato al 515 a.C. La commedia non aveva trovato ancora posto e il pubblico accettò uno spettacolo comico in chiusura di una trilogia tragica, con finalità distensive. Tuttavia, in ragione del soggetto alto e della sua natura comica (bassa) il dramma satiresco rimase prerogativa gli autori tragici. Il balzo verso la pienezza, la tragedia lo aveva compiuto grazie a Eschilo (525-456 a.C., primo di cui abbiamo opere intere). Tecnicamente, le sue innovazioni furono due: 1) affiancò un “secondo attore” al protagonista (deuteragonista); 2) impose una trilogia tragica coerente (le trame delle tre tragedie erano collegate). La presenza di due attori e un coro moltiplicava il numero di personaggi che agivano, grazie a cambi di maschera. Per esempio, nella prima tragedia pervenutaci, i Persiani, oltre al coro di Vecchi compaiono quattro personaggi (agiti da due attori): la regina Atossa, un messaggero, lo spettro di re Dario e il re sconfitto Serse. Si riduce l’importanza del coro a vantaggio di più personaggi, e le trame si complicano. Sofocle (circa 496-406/405 a.C.) realizzò altre due innovazioni: introdusse un “terzo attore” (tritagonista), moltiplicando la complessità delle trame, e portò il coro da 12 a 15 elementi. Il terzo grande tragediografo, Euripide, furono “di atmosfera”: in metà dei casi opta per un deus ex machina, un dio calato dall’alto per sciogliere un nodo inestricabile, e in molti altri il riconoscimento finale e il “lieto fine”. Sottopose a un’analisi disincantata il mito, umanizzandolo e rendendolo imperfetto. Raggiunse così una tragicità accentuata, creando nodi molto complessi. Ma l’ironia dell’autore si compiacque di esaltare il caso, dimostrandone la superiorità sulla volontà divina. Anche se il lieto fine non riuscì a fare di alcune tragedie di Euripide come l’Elena, l’Alcesti o lo Ione delle commedie, è certo che prepararono schemi e soluzioni per la successiva commedia “borghese” dove non resteranno che uomini ad agire in balìa della Tyche (il “Caso”: il campione in questo sarà il commediografo Menandro). Ospitando il mito, la tragedia era in dialogo con la poesia epica (poemi omerici soprattutto) e con altri generi maturi (come la lirica corale, dalla quale forse deriva il ditirambo). Ma essa era originale nell’organizzazione dei materiali mitici: prologo iniziale (recitato da uno o più), parodo (“canto d’ingresso”), serie di episodi, ciascuno separato dal successivo, o stasimo, e infine l’esodo (“uscita”, del coro). Il coro poteva prendere parte all’azione dialogando coi personaggi per bocca del corifeo, oppure intercalando col canto il dialogo tra i personaggi. Ciascuna parte aveva metri specifici. Nella scelta dei soggetti, la tragedia preferisce vicende di re e prìncipi mossi da ambizione, avidità, eros, spesso imparentati, che infrangono le leggi della natura o della società. La gravità dell’infrazione non dipende dalla consapevolezza: per fare un esempio, le colpe di Edipo che uccide il padre Laio e sposa la madre Giocasta non sono mitigate dal fatto che non conosce le identità dei due. Tale crimine contro il sangue familiare è pagato a caro prezzo, anche dai figli: i due finiranno per uccidersi in duello. 1.7 LA COMMEDIA ATTICA I satiri, personaggi dell’allegro seguito di Dioniso, erano versati nella critica sociale, politica, come nell’impresa erotica. Essi partecipavano insieme ad altri personaggi camuffati con sederi, pance e falli posticci, a quelle cerimonie della fertilità dette “fallororie” (phallikà), cioè processioni che portavano in giro il “fallo”. Tali cortei legati alla mimica dell’esuberanza dionisiaca, erano detti kòmoi, e da tale nome deriva komodia (cfr. Aristotele), nel senso di “canto festoso”. Poiché kòme significava “villaggio”, altri interpretano commedia “canto del villaggio”. La carica aggressiva di questi cortei, la loro funzione provocatrice ma anche equilibratrice, spiega perché all’inizio della sua storia, la commedia (introdotta negli agoni delle Grandi Dionisiache del 486 a.C.) si occupasse di politica, trascurando l’altra tematica fondamentale, della donna e della famiglia, poi fondamentale nel IV sec. a.C. A illustrare questo aspetto della prima commedia ci restano molti scritti di Aristofane, che rispondono ad uno schema: un protagonista si ribella al degrado della vita cittadina ed escogita un’idea paradossale che gli consente di rigenerare la polis. Il balzo all’utopia riesce davvero: nella Pace Trigeo vola su uno scarabeo, negli Uccelli Pistetero e Evelpide fondano una città in cielo, Nubibaggiania. Sebbene l’introduzione della commedia come forma teatrale d’alta qualità nelle Grandi Dionisie del 486 a.C. rappresenti già un adeguamento alla tragedia, a ciò non corrisponde un adeguamento strutturale. Mentre a tragedia con Eschilo (vincitore del concorso tragico) aveva raggiunto la sua forma, la commedia fu a lungo libera. Una commedia di Aristofane è divisa in due: una prima parte con prologo, parodo, agone e parabasi; la seconda da scene che proseguono l’azione principale dove si realizza il progetto utopico. Il prologo, in forma di dialogo, descrive la situazione di partenza e la nascita dell’idea. La parodo integra, non secondo uno schema fisso, quanto appreso nel prologo, nelle forme più consone; il coro entra di corsa come negli Acarnesi, a passo lento come nelle Vespe. L’agone è la parte centrale in cui l’eroe utopista si confronta col suo antagonista, il nemico del nuovo ordine, in un confronto politico erede dei contrasti delle feste campagnole, è qui che i personaggi in vista vengono attaccati per nome e sconfitti dai buoni. L’agone è esclusivo della commedia attica antica, scompare già nell’ultimo Aristofane. Solitamente, la parabasi seguiva l’agone, il coro qui, toltasi la maschera, si rivolgeva al pubblico: replicando alle critiche per un precedente lavoro, spiegando cose rimaste non chiarite – una funzione che non scomparirà nella commedia latina di imitazione greca, la palliata, però sarà confinata nel prologo. Fin dagl’inizi, il repertorio elevato della tragedia ha costituito il modello di quello irriverente della commedia, grazie alla parodia dei termini ricercati, delle inarcature nelle frasi, remote al linguaggio d’ogni giorno. Ciò era già accaduto nei contrasti campagnoli, in relazione al linguaggio dei capi. Lo stesso accadrà a Roma, dove i servi parleranno come senatori. Già nell’ultimo Aristofane si avverte un indebolimento di alcuni meccanismi: il coro si riduce (sparisce la parabasi), il linguaggio è più misurato, le trame si semplificano. Dal Pluto di Aristofane (388 a.C.) al Bisbetico di Menandro (317 a.C.) poco ci è giunto, ma in quei decenni (di commedia di mezzo) l’evoluzione verso la tragedia euripidea si è compiuta. Euripide aveva umanizzato gli eroi inserendoli nel gioco del caso e analizzandone psicologicamente il carattere. La commedia menandrea (massima espressione della commedia attica nuova) eleva il basso quotidiano alla dignità della classe media dei benpensanti, calando i personaggi nella dimensione “borghese” di una vita distante dalle battaglie politiche, analizzandone i caratteri e le reazioni al Caso: la Tyche diventa divinità dominante di questi intrecci e pieni di riconoscimenti finali. L’altezza dei risultati raggiunti in questa fase spenda della commedia garantì la sopravvivenza, accanto a molto Aristofane, ad un po’ di Menandro: a lui guardiamo come tipo imitato da Plauto e Terenzio. In Menandro, la metamorfosi della commedia è compiuta: il pubblico è scomparso, così come il coro, e assistiamo al trionfo del privato. E col recedere del contrasto politico, balza quello amoroso. Dall’innamoramento alla rivalità, dai fraintendimenti dovuti al caso alla saggezza di quei pochi che non perdono la testa. Anche in Menandro le trame sono intricati, ma la sua forza sta nei sentimenti e nelle reazioni dei caratteri. L’idea-guida è che l’amore anche tra parenti, vicini, ecc. – deve vincere, e chi gli si oppone dev’essere aiutato a riconoscere i suoi sbagli. 1.8 LA TRAGEDIA A ROMA La tragedia romana non può vantare uno o più generi precedenti. Essendo la tragedia attica arrivata a Roma nel 240 a.C., nasce già adulta, frutto di una decisione artificiale: sia pure per innalzare la qualità del teatro da offrire agli dèi, come gratitudine per la vittoria nella Prima guerra punica. Il coturno (cothurnus) era, nel teatro attico, il calzare a suola alta e allacciato, caratteristico dei personaggi tragici. Ad esso si contrapponeva il socco (soccus), tipo un sandalo, a suola bassa. Il primo finì per designare a Roma il genere tragico mutuato da quello attico, d’abito e argomento greco. Livio Andronico, che introdusse la fabula cothurnata, fu un vero maestro della tragedia e ne designò le caratteristiche: 1) indicò la via nella scelta dei soggetti, con preferenza per quelli del “ciclo troiano”; 2) ampliò l’uso dei metri tragici greci; 3) contribuì ad un linguaggio tragico. Per questo Livio Andronico poté attingere solo alla lingua delle preghiere, delle leggi, degli elogi funebri: a Roma mancava una letteratura “alta”, una poesia epica che ispirasse. Per questo, molti furono i suoi meriti acquisiti per un linguaggio tragico latino, con la traduzione in metro saturnio dell’Odissea. Dopo di lui Nevio allargò la gamma dei soggetti, con temi legati a Bacco (di attualità durante la Seconda guerra punica), proseguì la sperimentazione metrica, compose (in metro saturnio) il primo poema epico, il Bellum Poenicum, e inventà anche una tragedia in abito romano, la fabula praetexta (toga orlata di porpora usata dai magistrati in momenti solenni). Ennio sarà un innovatore decisivo, riformatore sia in ambito epico (con l’introduzione dell’esametro dattilico) sia tragico: stabilì i canoni validi non solo fino ad Accio (l’autore che chiude la fase del teatro latino) ma fino all’ultimo in assoluto, Seneca. Questi autori ci sono arrivati in frammenti, solo in citazioni di altri. Il favore accordato dai Romani, alle tragedie sul “ciclo troiano” e quindi alle vicende della preistoria di Roma, stava a indicare che anche a Roma si sentiva l’esigenza di un collegamento coi fatti rappresentati. L’impulso a mettersi in scena rimaneva la molla del far teatro. Presto, alla fabula cothurnata si affiancò la fabula praetexta. Diomede, grammatico del IV secolo d.C., definì le preteste drammi nei quali si trattava di condottieri e fatti della comunità romana: vicine alle tragedie per dignità dei personaggi. A differenza dei Greci, i Romani non avevano occasioni di incontro col loro passato mitico: la fabula praetexta, che per la lingua e il metro non si distingueva dalla c., contribuì a consolidare l’identità nazionale. Gli autori di p. non si limitarono al solo passato remoto: spinti dagli accadimenti e alle simpatie per i vari partiti o famiglie, scelsero anche temi attuali, e fu il pericolo di un coinvolgimento politico che condizionò la fortuna di questo tipo di tragedia. Nevio ed Ennio composero p. sulle origini di Roma; Accio celebrò la nascita della repubblica; nella prima età imperiale Publio Pomponio Secondo scrisse un Enea. E non mancarono riferimenti al tempo presente. I Romani dell’età repubblicana furono ossessionati dal terrore della tirannia. Non c’era momento pubblico che non fosse dominato dalla preoccupazione per i miti personali. Nevio si divertì a cogliere Scipione Africano, vincitore di Annibale, l’uomo più potente di Roma, in una situazione di normalità, così come Catone il Censore non cessò di osteggiarne l’egemonia politica. Identica funzione troviamo nel cerimoniale del trionfo. Nel momento più alto della carriera, sulla quadriga, il generale vittorioso, cinto di alloro, aveva accanto uno schiavo col compito di ammonirlo: “Guardati indietro, ricorda che sei uomo!”. 1.9 SENECA E IL TIRANNO Sebbene si possa tracciare una storia della tragedia romana, non dobbiamo dimenticare che l’unico autore pervenutoci è Seneca. Tra i suoi temi c’è quello dell’avversione per la tirannia, che in epoca imperiale diventò di rischiosa attualità. Se è probabile che, per la spietatezza neroniana, nessuna tragedia di Seneca sia stata mai rappresentata, la forza con cui egli produsse l’atrocità tirannica fu la causa della sua fortuna umanistica e rinascimentale. Il Tieste è la tragedia-chiave. I segni della sua priorità sono evidenti fin dall’inizio: affidato all’ombra di Tantalo, che ha lasciato il supplizio di eterna fame e sete cui condannata per portare nuovo strazio nella reggia di Argo, suscitando nuovi mali fra Atreo e Tieste, figli di suo figlio Pelope. Il furore dello spettro è lo stesso che a breve si impadronirà dei vivi (nel mondo tragico, il crimine si propaga all’intera famiglia). A subire il fascino del furor di Tantalo sarà Atreo. Questi figura come parte lesa: il fratello gli ha sedotto la moglie e sottratto il potere. Adesso che si è ripreso il potere, Atreo si vuole vendicare: per questo ha invitato Tieste coi suoi figli, fingendo un rappacificamento. In realtà trama di ucciderli e imbandire le carni. Le vittime stanno per arrivare e Atreo, pervaso dal furore, si rivolge alla sua anima chiamando a raccolga il male. Poco dopo, Atreo escogita la vendetta. Mentre è al culmine del delirio di vendetta, il coro (depositario, per Seneca, della riflessione) esalta non la regalità della stirpe ma quella della coscienza). La rivalità dei fratelli ha nel potere la causa motrice, ed un’ultima esitazione di Tieste lo rivela senza ambiguità. Atreo cerca poi di convincere il fratello delle sue buone intenzione, per sancire il rappacificamento con la prova più certa: metà del regno. Nel farlo, rovescia quanto sentenziato da Tieste: “Questo regno basta per due re”. I due hanno un solo pensiero, il potere, e usano le stesse parole, ma il non capit dell’uno è sincero, il recipit dell’altro è falso. Tieste ci crede e accetta. È la volta del coro che medita sull’instabilità della sorte e del potere. Intanto Atreo uccide i figli di Tieste e realizza il piano, un servo che ha assistito all’orrore lo descrive nel dettaglio. Il coro, sgomento per tanta nefandezza, interpreta un improvviso buio notturno come un ritorno al caos cosmico. In un “Inno al Sole che non c’è più” vengono tratte le conclusioni. Dopo il monologo in cui Atreo si esalta come re, ha luogo l’incontro con Tieste per un trionfo finale della vendetta: la rivelazione (le teste dei figli erano state tenute da parte per questo). L’opera di Atre è compiuta, la missione di Tantalo anche, il chiarimento serve ad aumentare il dolore di Tieste ed il trionfo di Atreo. La tragedia si chiude con uno scambio di maledizioni. Col salvataggio delle tragedie di Seneca, un vasto repertorio di orrori viene trasmesso al teatro umanistico e rinascimentale, in particolare elisabettiano. Interessante episodio della tragedia come genere scritto è rappresentato dalla tragedia centonaria, tipica del tardo-antico. Si ebbero composizioni centonarie greche, in versi omerici, sia pagane che cristiane, e composizioni latine, in versi virgiliani, sia pagane che cristiane. Tra i centoni latini pagani, alcuni riprendono temi già trattati: come l’Alcesta (162 esametri) e la Medea di tal Osidio Geta (II-III sec. d.C.). La Medea osidiana è un centone virgiliano di 461 esametri, con l’eccezione dei cori in paremiaci (dimetri anapestici catalettici, dotati di un ritmo adatto alla sentenziosità delle parti corali). L’adozione di un metro diverso per il coro, dimostra che il tardo autore intendeva scrivere una tragedia. Di notevole ricordiamo la parte del Nunzio che racconta l’evocazione della furia infernale ad Aletto compiuta da Medea dopo gli incontri con Creonte e Giasone, per trarne la forza necessaria a vendicarsi (vv. 321-337); la scena in cui Medea uccide i figli dialogando con loro (vv. 382-407); e il dialogo tra Giasone e Medea (vv. 438-461). 1.10 LA COMMEDIA A ROMA Fino all’ingresso di Ennio, vero fondatore della tragedia romana, le preferenze per il pubblico romano vanno verso la commedia greca (palliata). Come per la tragedia, dove la cothurnata si portò dietro anche una tragedia in costume romano (praetexta), così anche la palliata sarebbe stata affiancata da una commedia romana, la togata, che però fu tardiva e di vita breve. Sappiamo anche perché: nelle commedie in abito nazionale, non era consentito rappresentare servi più intelligenti dei padroni. Ciò contrastava con la scoperta che erano proprio le trame in cui erano i servi a tramare, che riuscivano di più. A valorizzare questa figura a Roma fu Nevio. I frammenti utili sono due. Uno ci mostra uno schiavo che si vanta delle sue imprese (Tarentilla, fr. XXX). L’altro consiste in una dichiarazione di intenti, sempre di uno schiavo: «Con libera lingua parleremo nella festa di Libero. [Bacco] Questa tensione alla libertà era propria dell’autore, che fu imprigionato per la sua troppa libertà di lingua e come tale fu rievocato da Plauto. Nel Miles gloriosus il servo furbo Palestrione si arrovella per trovare un’idea che gli consenta di uscire da un impasse. Vuole convincere il servo del soldato che non ha visto quel che ha visto (cioè l’amica appena acquistata dal soldato che si baciava con un altro – in realtà col suo innamorato. La lunga meditazione è descritta dal vicino, il libertino Periplectomeno (vv. 200-215). Nel momento più difficile, Palestrione ha appoggiato il mento sulla mano: il gesto del pensieroso. Per magia, una dissolvenza fa apparire a Periplectomeno e al pubblico, al posto del servo in scena, Nevio, l’autore del Bellum Poenicum e di tragedie, preteste e soprattutto commedie palliatae, anche lui in atteggiamento pensieroso, in prigione. La magia si dissolve non appena Palestrione abbandona quella posizione per assumerne una sospesa di chi forse, anzi sì, ha trovato. Questa evocazione di Nevio valeva come professione di fede nella libertà del teatro oppure era un segnale di allineamento al potere di Plauto? Da una parte il dispiacere per Nevio, dall’altra l’assicurazione che i suoi servi tirano dritto? Non è semplice rispondere, ma i suoi servi furono dei veri “re della scena”. Essi potevano vantare un avo reale: Ulisse, il multiforme re di Itaca, il furbo più famoso. Lo rivela Crisalo, il servo delle Bacchides. Dopo aver sottratto del denaro al padrone (Nicobulo) per consentire al padroncino (Mnesiloco) di riscattare la meretrice di cui è innamorato (Bacchide), Crisalo, sul punto di esser punito, riesce con un secondo inganno a portargli via altri soldi e a togliere di mezzo il rivale di Mnesiloco, il soldato Cleomaco. Questa seconda impresa è paragonata da Crisalo esultante alla presa di Troia da parte di Ulisse (Bacchides, 925-952). Questo brano basta a delineare il ritratto del servo furbo. Non abbiamo a che fare solo con la “regalità” del servo, in Plauto, ma anche con la “regalità” linguistica del personaggio, la sua facoltà di attingere, dal linguaggio della tragedia, dal linguaggio dei re: «O Troia, o patria, ecc.» è una parodia di «O padre, o patria, o reggia di Priamo!» dell’Andromaca di Ennio. Dobbiamo includere anche la pretesta nel repertorio del servus callidus plautino, perché, non di rado, se ne esce inneggiando nella lingua degli elogia dei condottieri. Il servo furbo plautino, oltre che inventore di canovacci, oltre che console-regista di un esercito che guida alla vittoria, è anche altro: lui stesso è capace, in Plauto, di innamorarsi. Ecco Tossilo all’inizio del Persiano, preso nei lacci di un amore che rischia di finir male (Persa, 1-6). La conoscenza mitologica del servo innamorato traduce comicamente, anche perché claudicante, lo stato d’animo esaltato di Tossilo, che si fa portatore di un principio della comicità plautina: ogni carattere non vale per la sua analisi psicologica, quanto per quantità e qualità deli spunti comici che ne può ricavare. Qui Tossilo, sebbene servo, ha una parte di innamorato, quindi fa l’innamorato, spiritosamente: idea beffe, poi guida la compagnia dei collaboratori, come un bravo regista, infine inneggia alla vittoria come un console a capo dell’esercito. Questa tendenza riguarda il servo furbo perché è lui l’erede latino degli eroi della commedia di Aristofane: un erede che non fonda più città nel cielo, non stipula paci separate, non domina la scena politica, ma quella privata. Il principio che uno stato d’animo anormale, esasperato, funziona da pretesto comico vale, seppur in misura minore, anche per altri personaggi. Il personaggio “sopra le righe” della palliata è il giovane (libero) innamorato (amans ephebus). Prototipo è Alcesimarco della Cistellaria (cfr. vv. 203-224). Ancor più sopra le righe è il vecchio che si innamora di una giovane, che l’etica destinerebbero a un concorrente d’età giusta (amans ephebus), peggio che mai se il vecchio è posato. È il caso del senex della Casina che, invaghitosi della giovane dal nome profumato (Casina = ragazza dal profumo di cannella) canta il proprio amore (cfr. Casina vv. 217-228). Il vecchio s’illude sul conto della ragazza (cui non piace), ma non su quello della moglie: lei stringe alleanza con la vicina e organizza la beffa punitiva delle “nozze maschie”. Un altro personaggio sopra le righe, illuso e vanesio, è Pirgopolinice (“Brancatorrione”), il soldato spaccone. L’interessata adulazione del parassita Artrotrogo (“Rodipagnotta”) gli fa credere di essere il più grande guerriero e tombeur des femmes (cfr. Miles, vv. 9-68). Un perfetto tipo di pazzo è anche Euclione, l’avaro dell’Aulularia, in azione nella scena in cui insegue il ladro della sua pentola d’oro (vv. 715-717). È una trovata scenica (la pazzia dell’avaro assorbe nel suo mondo anche chi non è nell’azione, in una rottura della quarta parete inversa) che ripropone quel filo diretto autore-pubblico che in Aristofane era nella parabasi e in Menandro rarissimo. Una libertà che Plauto ricava dal suo operare drammaturgico, e consiste in una capacità di mescolare elementi della commedia attica (quella che traduce) con elementi più liberi del repertorio italico. Quanto avviene nella Lisistrata di Aristofane (donne alleate contro i mariti), torna in Plauto. Ad esempio nella Casina, dove all’intesa del vecchio col vicino risponde la lega della moglie, Cleostrada, con la moglie del vicino, Mirrina. Il piano del vecchio è dare Casina in moglie al proprio fattore Olimpione e poi godersi la ragazza, ma le matrone fanno in modo che s’infili negli abiti nuziali Calino, uno scudiero. Si celebrano le nozze, si recano tutti in campagna, e di notte sia Olimpione che il vecchio cadono nel tranello. La scena in cui le donne e la servetta Pardalisca, aspettano al varco i due sposi, è comicissima (vv. 855.914). Terenzio, per la sua indole meno esuberante, e per la comunanza di intenti con gli Scipioni in un’apertura filo-greca, rappresentò un ritorno alla commedia attica nuova (Menandro). Più equilibrato nel rapporto di versi tra scena e scena, più misurato con la musica, fu grande psicologo e in grado di rielaborare le trame grazie a un montaggio raffinato, prendendo scene da commedie di trama affine e inserendole in quella prescelta, senza sbavature: un procedimento che i rivali censurarono. Uno dei tratti originali fu crearsi uno spazio in cui rispondere a tali accuse: tolse al prologo la funzione informativa e ripristinò uno dei compiti della parabasi aristofanesca (il dibattito critico). Celebre, il prologo dell’Andria (vv. 1-27), il cui invito finale (cercate di seguire la vicenda: / capirete così cosa sperare / dalle nuove commedie del poeta, quelle che scriverà / negli anni che verranno. E capirete / se vorrete vederle, o rifiutarle.) non fu sempre seguito dal pubblico: l’anno dopo (165 a.C.) e 5 anni dopo, la sua Hecyra (La suocera) cadrà malamente. La scelta dei personaggi impegnati non incontrava un pubblico che voleva divertirsi. Non venivano apprezzate la perfezione della lingua, la complessità della trama, la psicologia dei personaggi. 1.11 MIMO E PANTOMIMO Tra repubblica e impero il teatro conosce una crisi. Non ci sono più i grandi poeti scenici, la togata e forme minori come l’Atellana sopravvivono senza lasciare traccia, il gusto degli spettatori sembra incline verso altro (il circo, l’arena, il mimo). Pare che gli autori preferiscono adattarsi al pubblico, più vasto e meno raffinato, invece di creare un teatro nuovo. Al massimo si manteneva in vita il repertorio tradizionale, in forma sempre più dispendiose. Si continuano a scrivere tragedie e commedie alla greca destinate alla lettura, o interpretate in forma antologica in recital di attori famosi. Si ha notizia di una pretesta e qualche togata. Ma era più di moda cantare brani dalle Bucoliche o dall’Eneide. In questo clima di strumentalizzazione teatrale della poesia, il genere più diffuso era il mimo. Legato ai toni schietti ma pesanti della comicità popolare, in età augustea fu convertito dal greco Filistione in pornografia, e sotto Caligola giunse a esibire la vista di sangue autentico: nel Laureolo del mimografo Catullo (41 d.C.) la trama, imperniata su un bandito condannato a morte, fu presa con troppo realismo dagli attori. Peggio si fece 40 anni dopo, all’inaugurazione del Colosseo (80 d.C.), quando l’attore fu sostituito da un vero condannato, crocefisso in scena. Ma la novità del mimo era la presenza di donne, a differenza del teatro letterario, affidato solo a maschi: la presenza di attrici conferiva tratti realistici anche nelle scene più erotiche. Nelle Metamorfosi di Apuleio, Lucio in figura d’asino riesce a trovare la libertà in uno spettacolo in cui avrebbe dovuto unirsi ad una donna. Il titolo del mimo è Il giudizio di Paride (Metamorfosi X 29-32; 34-35). Successo maggiore arrise ad uno spettacolo mimico particolare, inventato nel 22 d.C. da Pilade di Cilicia, liberto di Augusto, e Batillo di Alessandra, liberto di Mecenate: la pantomima. Un ballerino interpretava, accompagnato da flauti, nacchere e scabellum tutte le parti, mentre un coro cantava il resto. I libretti per pantomimo (su soggetti mitologici) rendevano più delle composizioni impegnate: Lucano lasciò incompiuta una coturnata su Medea, ma scrisse 14 libretti per pantomimo, così come Stazio. 2 LO SPETTACOLO TEATRALE 2.1 LE OCCASIONI I ludi romani (o magni) si svolgevano dal 15 al 17 settembre in onore di Giove Ottimo Massimo, e restarono a lungo legati a circostanze eccezionali. Nell’anno 367 a.C. furono resi annuali per festeggiare la pace tra patrizi e plebei, e fu aggiunto un quarto giorno (cfr. Tito Livio). L’estensione rientrava in un potenziamento ad maiorem Iovis gloriam che a fine repubblica portò la durata a 16 giorni. Più ricca era la festa, più stretto il legame tra il dio e il popolo. Così, a due anni di distanza, nel 365/64 a.C., per riannodare un legame indebolito vennero introdotti nel programma alcuni elementi teatrali. Adottare nuove forme era come adottare nuove preghiere per gli dèi, per ringraziarli e ottenerne la protezione. I ludi romani allargarono presto il programma sportivo: secondo Dioniso d’Alicarnasso, venne a comprendere gare di quadrighe, bighe e cavalli singoli, più una gara a “tre cavalli” e una a piedi, riservata ai desultores (assistenti degli aurighi); seguivano gare di corsa, pugilato, lotta. Nel 364 a.C. divennero ludi scenici e un secolo più tardi (264 a.C.) furono introdotti, per i giochi funebri di Giunio Bruto, i combattimenti gladiatori, destinati a immensa fortuna. Nel 240 fu introdotto il teatro regolare alla greca (nel 161 i ludi Romani ospiteranno la prima del Phormio di Terenzio). Nel 220 a.C. furono istituiti i ludi plebei, curato dagli edili plebei nel Circo Flaminio, resi poco più tardi scenici (forse nel 200). Questi si svolgevano a metà novembre e in età imperiale duravano 14 giorni. Presto le occasioni si ampliarono ancora: nel 212 furono istituiti i ludi Apollinares dedicati ad Apollo, curati dal praetor urbanus, ospitati nel Circo Massimo e resi scenici nel 199. Nel 204 si istituirono in aprile i ludi Megalenses, curati dagli edili curuli, sul Palatino, resi scenici nel 194. Tra aprile e maggio aveva luogo una parodia dei ludi circensi chiamata Florales (238 a.C.): invece di gladiatori e atleti si esibivano le prostitute, combattevano contro lepri e capre e gareggiavano tra loro, in particolare in danze, spogliarelli e mimi licenziosi. Ulteriore ampliamento era offerto dall’usanza della instauratio ludorum, la ripetizione di festività nella cui celebrazioni venissero ravvisate imperfezioni. Da ricordare anche i ludi trionfali e quelli funebri di grandi personaggi. Per il trionfo di Marco Fulvio Nobiliore (187 a.C.) fu rappresentata la pretesta celebrativa, l’Ambracia di Ennio. 2.2 I LUOGHI La maggior produzione drammatica fu rappresentata in teatri di fortuna, ricavati cioè in strutture lignee temporanee, all’interno degli spazi destinati ai ludi (il Circo Massimo per i Romani e gli Apollinares, il Flaminio per i Plebeii) e accanto ai templi o altri edifici. Nel 194 a.C. gli edili curuli Aulo Scauro e Lucio Libone resero scenici i Megalenses: quell’anno “i senatori assistettero ai ludi in posti separati dal popolo” (cfr. Tito Livio, XXXIV 54, 3-4). Nel 179 il pontefice massimo e princeps senatus Marco Emilio Lepido fece costruire “presso l tempio di Apollo un teatro, in legno, smontato al termine delle rappresentazioni, ma pur sempre il primo costruito a Roma. Nel 174 a.C. i censori Quinto Flacco e Aulo Albino intrapresero la costruzione di un teatro, ma ancora temporaneo. Nel 155 a.C. i censori Gaio Longino e Marco Messala diedero inizio ad un primo teatro in pietra, ma il console Publio Cornelio Nasica ne bloccò i lavori, impedendo anche che a Roma si potesse assistere seduti agli spettacoli, per dimostrare che il maschio vigore dello stare in piedi, proprio della gente romana, si doveva affermare durante i divertimenti. Il primo teatro stabile fu costruito nel 55 a.C. a spese di Pompeo, nelle vicinanze del Campo dei Fiori, e si ispirava alla forma semicircolare del teatro greco. Era un edificio imponente (diametro della cavea: 150 metri), ricco di marmi e colonne. Come altri teatri del I sec. a.C., presentava alcune differenze rispetto allo schema attico: lo spazio per l’orchestra era ridotto all’emiciclo, verso cui convergevano i cunei delle gradinate, poiché l’altro emiciclo era invaso dal palco. Quest’ultimo non era più un pulpito limitato ma sopraelevato, che sovrastava l’orchestra e sul quale s’ergeva la skene attica, ma aveva un’ampia pedana – secondo i canoni vitruviani, due volte il diametro dell’orchestra – che fungeva da luogo unico della recitazione. Si andava delineando una forma adatta ad un teatro che aveva abolito la presenza del coro. La scena ci è nota grazie a testimonianze archeologiche d’età augustea: rappresentava la facciata di una casa o palazzo dove, al primo livello, si aprivano tre porte (la centrale più grande). Un secondo piano presentava una serie di nicchie con tettoie o cornicioni. Il tutto era arricchito da colonne, statue, piante. Una delle caratteristiche del teatro romano imperiale era la concezione come complesso autonomo, indipendente dalla conformazione del terreno. Raggiunse presto una struttura conclusa, con le gradinate che si saldavano con la parete della scena. Gli accessi all’orchestra divennero veri corridoi a volta. A fine repubblica si affermò l’uso di velaria sopra la cavea per proteggere gli spettatori: basterò sostituire questi teli con un tetto in travi per far nascere l’edificio teatrale moderno. Secondo il grammatico Elio Donato, il sipario è apparso nel 133 a.C. sul modello dei veli dipinti in uso nella reggia di Attalo, una tela rettangolare, sostenuta da aste (aulaeum) che calava (raccogliendosi in un solco) all’inizio e si alzava alla fine. Dentro l’aulaeum ci poteva essere un siparium, un secondo telo azionato lateralmente, che forse serviva per i cambi scena, ma taluni particolari sono incerti. Probabilmente in quel periodo la scena consisteva in qualcosa di più semplice della scena imperiale a più livelli: di certo vi dovettero essere solo tre porte su fondale, utilizzate e ridefinite contestualmente, a seconda che si trattasse di una tragedia (facciata di un palazzo, un tempio, una grotta) o di una commedia (con una, due o anche tre case). Di fisso, sul palco, c’era solo un altare. Quinte girevoli e scenografie dettagliate saranno tardo-repubblicane e imperiali, ma ciò non significa che non si potessero avere invenzioni “registiche” estemporanee che non lasciarono traccia. Per entrare in scena gli attori disponevano, oltre alle porte del fondale, di due accessi laterali (le parodoi greche). Nel rispetto della prassi attica, l’uscita dalla quinta di sx recava ad portum (cioè “all’estero”) o “in campagna” (rus) e quella di dx “in piazza” (ad forum). Ciò valeva per tragedia e commedia alla greca, non sappiamo se nei drammi romani si fossero imposte diverse convenzioni più connesse con Roma o al concreto orientamento del palco. Per informazioni su numero di attori e uso delle maschere, è possibile dire qualcosa di certo solo sulla palliata, l’unico genere di cui ci siano rimaste testimonianze integre (20 di Plauto, 6 di Terenzio). 2.3 NUMERO DEGLI ATTORI, USO DELLA MASCHERA, TIPI FISSI I copioni della commedia attica “nuova” (Menandro, Difilo, Filemone i più famosi) erano composti – a differenza di quelli di Aristofane, ma come era già stato per la tragedia di Sofocle – per tre attori, anche dove i titoli di scena indicano quattro personaggi. Ciò imponeva una stessa parte divisa tra più attori, che fa pensare a una versatilità degli attori greci, ma anche ad una recitazione poco realistica, stilizzata, e all’uso della maschera, che consentiva veloci sostituzioni di personaggi. Nel teatro plautino i personaggi erano interpretati da uno stesso attore, si potevano sostenere più parti solo se ben differenziate. Nel Miles gloriosus l’attore A faceva il soldato Pirgopolinice e la particina del servo Lurcione, in scene diverse (si noti che la partizione in atti è umanistica, in Plauto, come in Terenzio e gli altri, l’azione si sviluppava senza soste). L’attore B faceva il parassita Artotrogo, la meretrice Acroteleuzio e il puer. L’attore C il servo Palestrione e nel finale la particina del cuoco Carione. L’attore D il vecchio Periplectomeno e la meretrice Filocomasio; l’attore E il servo Sceledro e l’ancella Milfidippa. L’attore F, il giovane innamorato Pleusicle e nel finale l’Aguzzino. In certi casi era la diversità canora a decidere che un medesimo attore sostenesse parti simili. A volte, la differenza dei ruoli affidati a un medesimo attore poteva essere di età, sesso, grado sociale: questo criterio che voleva per ciascun personaggio la stessa voce, la stessa presenza e modo di gesticolare, nel teatro romano portò all’infrazione della regola attica dei tre attori. Non è difficile supporre una regola già radicata nella tradizione anteriore: è probabile che nell’Atellana ogni “maschera” venisse interpretata da un singolo attore specializzato. La regola dei tre attori, resa non vincolante da una marcata diversità culturale, dovette soccombere. Abolito il limite e non essendovi restrizioni alla consistenza di una troupe, diveniva possibile introdurre personaggi nuovi. Tale possibilità venne sfruttata e portò a innovazioni. Questo maggior realismo va posto in relazione con un’altra innovazione del teatro romano: l’assenza della maschera. Molti respingono l’idea (suffragata da testimonianze) che i Romani avessero accolto il teatro attico in toto, senza aver accolto la maschera. Ma un esame di entrate e uscite dei personaggi rivela che i tempi previsti nella palliata per i cambi di ruolo erano doppi di quelli della commedia menandrea, e che tale durata era proporzionale alla difficoltà dei cambi: se si doveva passare da un ruolo maschile a un altro, i tempi erano più brevi, se si passava a un ruolo femminile, più lunghi. Questo sembra costituire un indizio contro l’uso della maschera: un mutamento di parrucca e trucco comportava tempi più lunghi della sostituzione di una maschera. Dall’assenza di maschera sembra riconducibile l’importanza assunta dalla mimica: guardar sottecchi, annusare, storcere la bocca. Nel De oratore Cicerone afferma che “i Romani di un tempo” avrebbero preferito senza maschera persino un Roscio (grande attore comico morto nel 62 a.C.), poiché attribuivano importanza alla mimica del volto. Solo presupponendo un teatro senza maschera acquista senso la notizia di Festo che Nevio avrebbe scritto una Personata: erano personati (“mascherati”) gli attori di farse atellane. Quindi una “Commedia delle maschere” dove eccezionalmente comparivano maschere dell’Atellana accanto a personaggi (senza maschera) da palliata. La presenza di un teatro mascherato può esser la causa del mancato accoglimento della maschera greca. Ma vi furono anche altri motivi: la commedia nuova attica disponeva di un repertorio ricco e sfumato di maschere, e perciò di ruoli fissi. Nella classificazione di Polluce (cfr. Onomasticon) i “vecchi” sono 9, i “giovani” 11 e i “servi” 7. A questa complessità, spiegabile solo alla luce della storia interna del teatro attico, dovette corrispondere un numero ristretto di tipi riconoscibili grazie a parrucca, belletto e abito (compresi indicatori come il bastone per il vecchio, il coltello per il cuoco, lo spadone per il soldato). Da questi, l’autore o l’attore potevano esercitare la propria fantasia con trovate funzionali alla vicenda: ivi incluse eventuali allusioni alle maschere della farsa osca. I ruoli di base sono i seguenti: - il senex, “vecchio”: padre di famiglia all’antica, tirchio, perseguitato da una moglie di ricca dote (uxor dotata). A volte è vedovo, gaudente e disponibile (senex lepidus, “vecchio libertino”); se ad assumere questi toni è un pater familias, è destinato a subire uno smacco; - l’adulescens, “giovane”: nello scontro generazionale proposto dalla palliata si oppone al senex, sempre innamorato e al verde; - la meretrix, “meretrice” o “cortigiana”: desiderata dall’adulescens; - il leno, “ruffiano”: beona, da cui la meretrix dipende, altro rivale dell’adulescens, il leno è assimilabile alla categoria dei senes, la lena a quella delle anus; - il servus, “schiavo”: presente nelle varianti del servus callidus, “servo astuto”, che cogli intrighi appoggia i progetti amorosi dell’adulescens cui è legato, e il servo senza specifiche, onesto e allocco, che difende i padroni; - l’ancilla, “ancella”: al seguito della meretrix come apprendista, ma a volte anche della matrona, “donna sposata” nemica del senex e talvolta del figlio, del quale può diventare alleata contro le scappatelle del marito. Altre figure sono il miles gloriosus, “soldato spaccone”, sfortunato in amore; il parasitus, spiantato che si abbassa ai servigi più umili; il sykophanta, “sicofante”, doppione in peggio del parassita; e la fidicina, “citarista”, e il cocus, “cuoco”, indispensabili alla riuscita del banchetto, e il puer, “schiavetto”, figura tutta romana per i riempitivi. Altre figure occasionali sono il Banchiere, l’Aguzzino, il Marinaio, il Pescatore, il Medico e l’Eunuco. Compaiono talvolta, prologanti, anche divinità o soggetti astratti, come il dio Soccorso, il Lare di famiglia, eccetera. 2.4 IL CONTESTO FESTIVO (RISO E PIANTO) Uno dei particolari che più colpiscono è il riproporsi di uno schema misto con momenti seri e solenni, arcaicizzanti, e altri momenti carnevaleschi sorretti dall’improvvisazione fescennina. Ciò è evidente nelle cerimonie nuziali: da una parte la deductio, il rito della soglia con l’unzione della porta, l’assaggio della focaccia di farro, la cena nuziale; dall’altra, i versi licenziosi a carattere apotropaico durante la pompa nutialis. Ancor più evidente è nella pompa funebris, dove il banditore precedeva delle prefiche, che cantavano in onore al defunto, seguite da danzatori in abiti burleschi che, al suono dei flauti, eseguivano pantomime comiche. Talvolta uno di essi impersonava il defunto imitandolo. Seguivano poi i familiari, i clienti, i liberti e infine le immagini di cera degli antenati; il corteo era chiuso dalla salma. E non si dimentichi la pompa triumphalis, dal Campo Marzio al Campidoglio: dopo la banda militare, che suonava strumenti musicali militari e il carro dell’imperator triumphans con toga di porpora con banda dorata, scarpe dorate e scettro, veniva una schiera di istrioni che eseguivano danze comiche e dietro la moltitudine dei soldati che improvvisavano scambi fescennini su vizi e virtù del trionfatore. Chiudevano il corteo bottino e prigionieri. Ma è da ricordare soprattutto la pompa circensis, che apriva i ludi Romani, secondo la descrizione di Dioniso d’Alicarnasso (VII 52). Abbiamo riassunto tutte le possibilità spettacolari delle processioni. Anche in questo caso, il riso fescennino, la mimica, la danza, trovano posto accanto a elementi solenni. Sappiamo da Festo che, oltre ai danzatori, partecipavano e scherzavano con la folla anche personaggi carnevaleschi come il battidenti Manducis e l’ubriacona Petraia. Oltre alla compresenza di serio e faceto, si nota il ricorrere a personaggi mascherati. L’intero calendario era fitto di occasioni che prevedevano travestimenti: come le Quinquatrus minusculae (13 giugno) coi flautisti in vesti femminili e mascherati, che vagavano ebbri per la città. Il motivo dell’inversione dei ruoli e dei sessi ricorreva dal primo giorno di gennaio (Capodanno dal II sec. a.C.) attraverso i Lupercalia (15 febbraio), le carnevalate dei Matronalia (1 marzo) e le schiave vestite da padrone nelle Nonae Caprotinae (7 luglio). 2.5 MUSICA E MODELLI (ESTERNI E INTERNI) Comune e importante è la componente musicale (connessa con la danza). Da lì abbiamo visto prendere le mosse la storia del teatro romano, com’è raccontata da Tito Livio (i ludiones etruschi del 365/364 a.C.). Ma l’anamnesi dello storico non va disgiunta da quanto sappiamo sull’importante ruolo svolto dalla musica fin dalla prima introduzione del teatro “alla greca” (240 a.C.). La fisionomia già matura è caratterizzata dalla metrica (di origine greca) in Livio Andronico e ci fa presupporre una confidenza coi metri teatrali greci. Affievolendosi l’egemonia etrusca e consolidandosene una romana, la sede più idonea a ospitare versi scenici come il senario giambico (dal trimetro giambico greco) e il settenario trocaico (dal tetrametro trocaico catalettico) dovette essere quella, non documentata, della satura. Il vero nodo riguarda se e come la tradizione romana abbia avuto subito, fin dalla fase preletteraria, gli influssi esterni. È il come a costituire oggi un problema per la critica, chiamata a spiegare l’immediata maturità metrica del teatro romano. È a influssi del teatro siceliota e magnogreco che si deve pensare, nonché a una precoce conoscenza dei modi ellenistici: come ha indicato Bruno Gentili, l’uso di introdurre intere scene mutuate da altre commedie e di musicare e cantare parte destinate alla recitazione, erano già stati greci. I modelli riconosciuti dei drammaturghi latini furono i copioni della tragedia attiva del V sec. e della commedia del IV sec. a.C. Tuttavia dovettero influire le varie forme di quel sottogenere comico che è la farsa: Tito Livio accenna alla farsa osca, o Atellana, introdotta a Roma a fine II a.C., ma ben nota nella sua forma originale sin da fine IV sec e che doveva a sua volta aver accolto altri influssi etrusco-campani. Si saranno poi aggiunti (dalla presa di Taranto, 272 a.C.) contatti col fliace tarentino e col mimo, esso pure introdotto letterariamente più tardi (nel I sec. a.C.) ma già noto dal III sec. Il quadro sarebbe incompleto se non aggiungessimo che questo gioco di modelli non è scindibile dal contesto cultuale cui i drammi erano destinati. Si può affermare che furono proprio gli elementi culturali, riconoscibili nelle varie occasioni, a essere ripresi e rispecchiati nelle tragedie e nelle commedie latine. Roma medio-repubblicana matura una cultura adeguata alle proprie ambizioni, anche grazie alla vitalità del suo teatro.
Scaricare