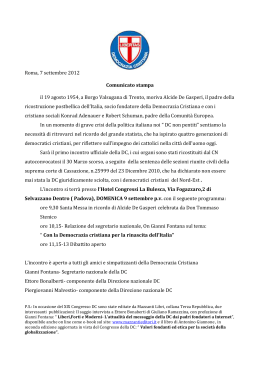Civitas Rivista quadrimetrale di ricerca storica e studi politici • Fondata e diretta da Filippo Meda (1919-1925) • Diretta da Guido Gonella (1947) • Diretta da Paolo Emilio Taviani (1950-1995) Quarta serie, n. I - 2004 • Diretta da Gabriele De Rosa «Civitas» “riprenderà il difficile impegno con la serietà ed il rigore che la hanno contraddistinta nei momenti più travagliati e complessi. I temi riguarderanno problemi, eventi, prospettive della politica internazionale con un particolare riguardo alla vita italiana ed all’unità europea. ... Il XX secolo ha lasciato tracce e impronte in Italia, in Europa e nel mondo, che solo in gran parte da scoprire e, per un certo verso, se non addirittura, da correggere, da meglio interpretare. Sarà anche questo un importante compito della nuova «Civitas»”. Paolo Emilio Taviani, 18 febbraio 2000 Registrazione Tribunale Civile di Roma n. 152 dell’8.04.2004 Direttore - Responsabile Gabriele De Rosa Condirettore Franco Nobili Vicedirettore Agostino Giovagnoli Coordinatore editoriale Amos Ciabattoni Redazione • Comitato: Andrea Bixio Amos Ciabattoni Nicola Graziani Flavia Nardelli Giuseppe Sangiorgi Costo di un numero €10,00 • Sede: Abbonamento a tre numeri €25,00 Via delle Coppelle, 35 00186 Roma Tel. 06/6809223-6840421 Fax 06/682219960 E-mail: [email protected] C/c postale: 15062888 intestato a Rubbettino Editore Viale Rosario Rubbettino, 10 88049 Soveria Mannelli (Catanzaro) Pubblicità: • IV di copertina € 1.200,00 • Pagina b/n € 1.000,00 • Per tre numeri € 2.500,00 Editore Rubbettino Viale R. Rubbettino, 10 88049 Soveria Mannelli Tel. 0968/662034 Fax 0968/662055 E-mail: [email protected] 2 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Indice 5 Da Meda a Taviani - di Gabriele De Rosa 9 Continuità nella coerenza - di Franco Nobili 13 «Civitas» e De Gasperi - di Giorgio Tupini 15 Una rivista... non necessaria, ma utile - di Luigi Giraldi 17 Europa: senza anima non andrai lontano - di Gabriele De Rosa e Achille Silvestrini 27 Ma quali sono i confini dell’Europa? - di Jean-Dominique Durand 37 Allargamento dell’Europa occidentale o ricongiungimento tra due tradizioni? di Roberto Morozzo della Rocca 47 Il cammino verso il Trattato Costituzionale: luci ed ombre - di Giorgio Bosco 57 Una questione attuale: il futuro dell’Europa - di Agostino Giovagnoli 65 La Turchia nell’Ue: islamizzazione dell’Europa o europeizzazione dell’Islam? di Paola Pizzo 79 Dall’idea di Europa all’integrazione europea - di Marisa Ferrari Occhionero 89 La cultura giuridica come specifico europeo - di Simona Andrini 97 Ritratto di statista: le radici dell’europeismo di Alcide De Gasperi di Stefano Trinchese RUBRICHE COLLOQUI a cura di Giuseppe Sangiorgi 109 POLITICA INTERNA a cura di “Spectator” 112 POLITICA INTERNAZIONALE a cura di Mario Giro 119 ECONOMIA a cura di Gianni Locatelli 128 RELIGIONI E CIVILTÀ a cura di Agostino Giovagnoli 133 RICERCHE a cura di Andrea Bixio 138 FUORI SCAFFALE a cura di Aldo Laganà 154 STATISTICHE a cura di Corrado Barberis 160 NOMI CITATI 164 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 3 Da Meda a Taviani La lunga vita di «Civitas» La nostra rivista raccoglie ambiziosamente il prestigioso antico titolo della rivista che Filippo Meda, già allievo di don Davide Albertario, direttore de «L’Osservatore Cattolico», poi leader di quel che si disse il “cattolicesimo liberale lombardo”, fondò a Milano nel 1919 e che Paolo Emilio Taviani ha guidato e diretto negli ultimi quarantacinque anni (1950-1995). Meda fu il primo cattolico che entrò, durante la Prima Guerra Mondiale, a far parte di un governo liberale, quello di Paolo Boselli, ricoprendo la carica di Ministro delle finanze. La sua azione politica, fondata sull’adesione ai fatti compiuti, preparò ed accompagnò il passaggio del movimento cattolico dalla fase dell’astensionismo elettorale (non expedit ) a quella che il gesuita Antonio Pavissich chiamò dell’«azione sociale sul terreno costituzionale». Ciò non significò per Meda che i cattolici dovessero restringersi ad essere una ruota di scorta per il liberalismo giolittiano, dovessero confondersi, cioè, come sosteneva anche Luigi Sturzo, nell’anonimato dei blocchi clerico-moderati. Meda intuì che dalle repressioni di Bava Beccaris a Milano, nel maggio 1898, sarebbe mutato il corso della vita politica del Paese. Si convinse allora ancora di più che i cattolici dovessero uscire dal non expedit, per creare un partito aconfessionale di centro, alla maniera del Centro dei cattolici tedeschi di Windthorst. Fece sua la formula della «preparazione nell’astensione» al posto della formula rigida, «né eletti né elettori», di don Giacomo Margotti e dei cattolici intransigenti. In altre parole, Meda dette il via ad una lotta per una politica fuori da ogni vincolo confessionale e da ogni suggestione integralista. Era il terreno comune e contemporaneo delle lotte che in Sicilia aveva ingaggiato Luigi Sturzo: sulla questione delle autonomie comunali, del suffragio universale e della Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 GABRIELE DE ROSA Presidente Istituto Luigi Sturzo ≈ “... Meda dette il via ad una lotta per una politica fuori da ogni vincolo confessionale e da ogni suggestione integralista.” ≈ 5 Gabriele De Rosa proporzionale e, soprattutto, sulla necessità del partito programmatico, autonomo, aconfessionale dei cattolici. Si pensi ancora al contributo notevolissimo che Filippo Meda dette, con la sua azione parlamentare prima, e con la sua azione di governo poi, a quella distinzione di compiti tra azione cattolica e azione civica e politica dei cattolici, che rappresentò il preludio alla nascita del Partito Popolare Italiano di Luigi Sturzo. Meda fu, dunque, un popolare, non alla maniera di Luigi Sturzo, più tattico, più empirico, più gradualista, ma indubbiamente sempre convinto di appartenere a quel movimento dei “liberi e forti” che era stato enunciato nel messaggio indirizzato da Sturzo agli Italiani, quando fondò il Ppi. Meda, in un’intervista del gennaio 1919 su «L’Idea nazionale» così commentò quell’evento: «Credo sia un largo consentimento di fare ormai per la politica nazionale quello che un po’ dappertutto già da tempo – nella mia città di Milano, per esempio, da quasi un trentennio – si è fatto per la vita locale: costituirsi cioè in organizzazione libera e autonoma, all’infuori della gerarchia ecclesiastica, in nome del diritto e del dovere di cittadini, di propugnare nella vita pubblica quegli indirizzi che corrispondono ai propri convincimenti, in collaborazione, in concorrenza, in contrasto, a seconda dei casi, con gli altri partiti esistenti nel paese». Era il suo stile di vita, il suo attestato di uomo della moderazione, quella dei grandi nomi del Risorgimento, cattolici e non cattolici, da Cavallotti a Moneta a Stefano Jacini – che gli fu amico –, a Ruggero Bonghi, al vescovo Calabiana. Lo scrivere di Filippo Meda non ha nulla di ideologico, non è mai sentenzioso, giudica il presente troppo nervoso, agitato, lontano dalla memoria continua, metodica, che egli conservava del passato risorgimentale. Schivo degli onori, fornito di una preparazione culturale non comune, di notevole levatura morale, affrontò il periodo fascista con un forte sentimento di distacco, non disgiunto da fine spirito ironico e allusivo. Filippo Meda non cedette alle suggestioni di Mussolini, non accettò il suo invito a far parte, nelle elezioni del 1921, del listone, come anche non si dichiarò disponibile per la nomina a senatore. Come Giolitti, anche Meda ritenne che con la «pazienza», con un metodo gradualista, alieno da ogni opposizione di principio, si sarebbero potute spuntare le asprezze, le rigidità antidemocratiche della politica fascista. Egli consigliava ai suoi, a cominciare dal figlio Gerolamo, che aveva votato a favore della linea sturziana della non collaborazione con Mussolini, al congresso di Torino del Ppi nel 1923, di non assumere atteggiamenti espliciti di resistenza, di cercare, invece, «rifugio e difesa in qualche porte, finché il cielo avesse incominciato a rischiararsi», ma il cielo non «si rischiarò», né per il figlio Gerolamo né per lui, per Filippo Meda. 6 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Gabriele De Rosa Sul numero della sua rivista «Civitas», del 16 gennaio 1923, appariva una sua lettera con il titolo Sul terreno della realtà, che rappresenta il massimo contributo che egli credette di poter offrire, in nome della sua infinita pazienza, alla ipotesi di una “pacificazione nazionale”: «Il partito (Ppi), attraverso i suoi organi centrali – la direzione e il gruppo parlamentare – si è in sostanza messo su questa via: non fare nulla che possa ritardare la pacificazione nazionale, fare, invece, anche a costo di rinunce, tutto quanto può giovare, tutto quanto può giovare ad un simile risultato: favorire ed aiutare, senza abbandono del proprio programma nei punti fondamentali, quell’opera di rinnovazione e di restaurazione che il governo si propone, dando alle critiche doverose e ai ragionevoli dissensi non una portata demolitrice, ma uno scopo di libertà e un’onesta collaborazione per il meglio e, quando sia possibile, di correzione». Purtroppo non fu questo il terreno della realtà da lui auspicato. Ancora due anni circa di vita, poi la lettera di congedo, nel numero 21-22 dell’1-16 novembre 1925, della quale pubblichiamo uno stralcio: “Toltaci ormai la possibilità di esprimere liberamente il nostro giudizio critico sui temi della attuatilità politica, questa rivista, non ha più ragion d’essere: perché l’abbandoniamo, lasciando libero il campo ad altri che con maggior spirito di adattamento alle contingenze storiche, sappiano dar vita ad un periodico, il quale pure tenendo fede alle stesse idealità, non sia vincolato ai nostri precedenti. Un giorno, forse, nelle nostre sei annate, qualcuno troverà delle note e delle traccie utili per ricostuire l’atteggiamento del pensiero politico-sociale di quel gruppo di amici i quali, senza vincoli di formali adesioni, ma per propensione spontanea sorreggevano delle loro simpatie e dei loro consensi il pubblicista e il parlamentare che aveva concesso il proprio nome a Civitas, perché nelle sue pagine si continuasse la difesa di un indirizzo ideale e pratico di condotta pubblica rispondente alla imanenza sostanziale della dottrina cattolica ed alle evoluzioni istituzionali operantisi per virtù di democrazia”. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 7 Continuità nella coerenza • Con questo numero inizia la “Quarta Serie” di «Civitas». La lunga vita della Rivista, fondata da Filippo Meda nel 1919, ha dell’eccezionale e del profetico. Eccezionale, perché avendo attraversato indenne nel prestigio e nel ricordo, per oltre ottant’anni i periodi più significativi della vita politica, sociale e culturale dell’Italia, dimostra di poggiare su solide basi di idee e di coerenti ideali e quindi di essere uno strumento “utile” e perfino “necessario”. Profetico, perché da Filippo Meda che l’ha fondata (1919–1925), a De Gasperi che l’ha sempre sostenuta, a Gonella e G. Tupini (1947), a Taviani (1950-1995) – che l’hanno tutti in successione, alimentata di ideali e di cultura, – a Gabriele De Rosa che ne assume oggi la nuova Direzione, si è perpetuata e tramandata, seguendo il percorso di una “staffetta” che oggi riprende la corsa. La Quarta Edizione • La “Quarta” Edizione di «Civitas», che si inaugura con questo numero, è quindi la continuità fedele, convinta, tenacemente vitale, dell’impegno di tanti grandi personaggi della storia d’Italia che le hanno dato vita e dei quali è stata vivace palestra di dibattiti e confronti che hanno alimentato la storia stessa del pensiero e dell’impegno del più avanzato laicato cattolico democratico, che è poi la storia della democrazia e della libertà del nostro Paese. In questa circostanza ci sembra doveroso ricordare alcuni tra i più assidui collaboratori del passato: A. De Gasperi, L. Sturzo, V. Bachelet, P. Bargellini, G. Bo, K. Adenauer, R. Bontempelli, P. Campilli, B. Mattarella, E. Vanoni, V. Colombo, G. Pastore, C. Donat-Cattin, V. Veronesi, Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 FRANCO NOBILI Vice Presidente dell’Associazione per la valorizzazione della democrazia in Italia e della Fondazione Alcide De Gasperi ≈ “La quarta edizione di «Civitas» è la continuità fedele, convinta, tenacemente vitale dell’impegno di grandi personaggi della storia d’Italia...” ≈ 9 Franco Nobili A. Zoli, G. Dossetti, A. Fanfani, F. Guala, L. Gui, A. R. Jervolino, G. La Pira, P. Malvestiti, A. Moro, M. Pedini, F. Piccoli, G. Petrilli, M. Rumor, M. Scelba, A. Segni, F. Storchi. Il nostro grato ricordo va a tutti i numerosi e attivi Amici di «Civitas» con i quali avremo certamente modo di riprendere il colloquio. • In questa significativa circostanza, il pensiero commosso e grato va soprattutto all’Amico Paolo Emilio Taviani, che prima di lasciare la vita terrena interamente spesa per servire i più nobili ideali cristiani, volle lasciare la sua “creatura” molto amata, appunto «Civitas», all’Istituto “L. Sturzo” – e in particolare nelle mani del suo amico stimato Gabriele De Rosa – certo così di assicurare alla pubblicazione una sicura successiva nuova rinascita. L’eredità di Taviani • Ciò che più di ogni altra preoccupazione assillava Taviani, era la tutela dell’autonomia e del livello della Rivista e quindi la salvaguardia della sua natura di strumento di formazione, di conoscenza, di riflessione e di studio, offerto come contributo alla maturazione sociale, politica e cristiana degli italiani. Ricorda nel suo contributo Luigi Giraldi, che Taviani, nella certezza dell’avvenire di «Civitas» oltre la sua vita personale, aveva dettato nel febbraio del 2000, una breve commovente sorta di profetica presentazione per l’eventuale primo numero di una auspicata nuova Serie: «Civitas» riprenderà il difficile impegno con la serietà e il rigore che lo hanno contraddistinto anche nei momenti più travagliati e complessi. I temi riguarderanno problemi, eventi, prospettive della politica internazionale con un particolare riguardo alla vita italiana e all’unità europea. Un notevole spazio verrà ancora dedicato alla storia dei movimenti sociali e politici di ispirazione cristiana. Il Ventesimo secolo ha lasciato tracce e impronte in Italia, in Europa e nel mondo che sono in gran parte da scoprire e, per un certo verso, se non addirittura da correggere, da meglio interpretare. Sarà anche questo un importante compito della nuova «Civitas». L’impegno “Istituto Luigi Sturzo-Fondazioni” • L’intesa tra l’Istituto “L. Sturzo” e l’“Associazione per la Valorizzazione della Democrazia in Italia”, che è alla base della nuova impresa editoriale, è quindi garanzia suprema del rispetto della volontà di Taviani. Sia per lo spessore culturale e rigoroso dell’Istituto e il ricco patrimonio di cultura e di storia che conserva e alimenta, sia per l’impegno che l’Associazione si è assunto per tale compito, con il concorso delle diciannove fondazioni aderenti che si richiamano alla vita, all’azione e alle opere dei più grandi personaggi del pensiero cattolico, sociale, democratico e che è d’obbligo citare: l’Istituto Luigi Sturzo, la Fondazione Vittorino Colombo, la Fondazione Alcide De Gasperi per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale, la Fondazione Carlo Donat-Cattin, la Fondazione 10 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Franco Nobili Fuci per la formazione della gioventù universitaria, la Fondazione Giorgio La Pira, l’Associazione Popolo, Parlamento e Istituzioni A. Moro, C. Mortati, A. Piccioni, la Fondazione Giulio Pastore, la Fondazione Antonio Segni, la Fondazione Nuovo Millennio, la Fondazione Aldo Della Rocca, il Centro Giovanni Gronchi, l’Associazione per la costituzione della Fondazione Giovanni Goria, la Fondazione Opera Giuseppe Toniolo, la Fondazione Roberto Ruffilli, l’Istituto di Sociologia Luigi Sturzo, il Circolo Verso l’Europa, la Fondazione Mariano Rumor. Il mondo “nuovo” • È certo che oggi il compito che ci siamo assunti quali garanti della “continuità nella coerenza” di «Civitas», è particolarmente arduo. Sono profondamente cambiati i contesti politici e storici dell’Italia e del mondo intero. Le priorità assunte dai problemi sociali di tutti i popoli sono del tutto nuove. La “mondializzazione” modifica sostanzialmente i tradizionali concetti di cittadinanza e di “patria-nazione”. L’Unione Europea (argomento monografico di questo numero) richiede generazioni preparate per nuovi compiti e confronti. Il “localismo” conserva e accresce il suo valore di palestra di formazione dei giovani, per concorrere, con l’apporto di civili tradizioni, alla crescita culturale della civiltà occidentale e cristiana. • Mario Falciatore, collaboratore fedele di Taviani e per lunghi anni responsabile di «Civitas», così chiudeva l’ultimo numero della “Terza Serie” (Ottobre-Novembre 1995): “Allo stato esistono motivi concreti per ritenere che, fra non molto, vedrà la luce – grazie all’intervento di una prestigiosa istituzione – una quarta serie. Con tale serie, dopo un’opportuna pausa per individuare e impostare nuove forme di impegno, avrà inizio una nuova fase. L’augurio migliore che possiamo farci oggi è che essa coincida con una nuova e più intensa stagione di rinascita civile e morale del nostro Paese”. • Così è stato e così sarà. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 11 12 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 «Civitas» e De Gasperi “Multa renascentur quae iam cecidere”. Con queste parole Filippo Meda concludeva nel 1925 l’avventura della sua bella rivista ormai soffocata dalla censura del regime fascista. Con le stesse parole iniziava, ventidue anni dopo, l’editoriale del primo numero della rinata «Civitas». De Gasperi aveva convocato Gonella e me e ci aveva chiesto di far risorgere l’antico periodico. Ci aveva spiegato le ragioni del suo proposito, che si possono riassumere così: era in corso una lotta decisiva tra due concezioni della vita, che travalicava la “piccola politica”, la polemica quotidiana; occorreva una politica culturale, che si affiancasse a quella laica e fronteggiasse quella comunista, che attraeva “gli intellettuali dei Littoriali” bisognosi di restauro; che non lasciasse la presunzione di superiorità “sapienziale” alla corrente facente capo a «Cronache Sociali» che aveva molti esponenti maturatisi negli anni “del corporativismo pseudocattolico” senza aver vissuto le esperienze formative dei Popolari. De Gasperi stimava Dossetti e i “professorini”. Chi ha seguito da vicino o ha studiato gli atteggiamenti di De Gasperi sa che ha sempre cercato, invano, la sintonia con Dossetti. In quella fase difficile, però, si preoccupava che una dialettica interna troppo acre portasse a divisioni nel momento sbagliato e che i socialcomunisti strumentalizzassero, come fecero, le posizioni della giovane sinistra della Dc. (Vi è stata una singolare rimozione tra molti democratici cristiani degli errori politici di Dossetti, che angustiavano De Gasperi. La storia ha dimostrato senza incertezze che erano errate e pericolose le riserve sull’adesione italiana al Patto atlantico – più tardi accettato anche dal Pci – o sulla rottura della collaborazione con Togliatti e Nenni nel 1947 o sull’interclassismo – a favore della maggiorità operaia – che è la realtà delle democrazie mature. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 GIORGIO TUPINI Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con dicasteri ≈ “... C’è bisogno di non effimeri punti di riferimento ideali e storici... uno di questi potrebbe essere la nuova «Civitas»...” ≈ 13 Giorgio Tupini Dunque la «Civitas» voluta da De Gasperi uscì nell’aprile 1947 con Gonella Direttore e chi scrive redattore capo. Sulla copertina erano i nomi dei collaboratori originari, da Sturzo a De Gasperi a Dossetti, Fanfani, Giordani, Cappi, Gronchi, La Pira, Jacini, Piccioni, Scelba, Vanoni, ecc. Nell’editoriale citato, Gonella indicava le finalità della rivista: costituire un cenacolo di studi politici tra uomini che si propongono di lavorare, con metodo critico; per una più alta coscienza politica dei cattolici rinnovando la tradizione e le esperienze della Democrazia Cristiana di Murri e del Partito Popolare di Sturzo; aiutare la nuova Democrazia Cristiana a essere all’altezza del duro compito di ricostruire e ammodernare il Paese. Ciò comportava l’approfondimento dei problemi infiniti della ricostruzione, della Costituzione allora in cantiere, del superamento della demagogia facile, della preparazione della nuova classe dirigente. Alcuni articoli potrebbero essere riletti con interesse degli studiosi di quel periodo. Ricordo gli eleganti e penetranti interventi di Cappi sulla valenza dell’interclassismo e sulle cause ultime della fine delle coalizioni nate nella Resistenza, che consentiva il pieno ritorno alla democrazia parlamentare; l’eco delle discussioni alla Costituente trasmessa a quelle pagine da La Pira e Moro; l’architettura, tutta gonelliana, delle Rassegne, delle Cronache, delle Documentazioni, delle Recensioni. Purtroppo, la nostra «Civitas» ebbe vita breve. Il lungo scontro elettorale e poi la vittoria del 1948 assorbirono i suoi collaboratori in altri impegni. Il redattore capo fu catapultato da De Gasperi alla direzione della Spes, già guidata da Fanfani, per preparare quelle elezioni. Lo stesso direttore Gonella era sempre più immerso nelle responsabilità di Ministro della Pubblica Istruzione. Ma, multa renascentur… Seguì quindi per oltre quarant’anni la dignitosa presenza della «Civitas» di Taviani, che ebbe inizialmente come redattore capo Vittorio Bachelet. Ora, dopo la «Civitas» di Filippo Meda, dopo la «Civitas» di De Gasperi, dopo la «Civitas» di Taviani, la rivista rinasce per la quarta volta sotto la direzione di De Rosa. Ci sarà pure un motivo se questa rivista risorge continuamente dalle sue ceneri. Forse, le ragioni che le danno vita sono nel DNA della tradizione democraticocristiana, che l’ha sempre ispirata. Forse oggi a quelle ragioni si aggiunge il deficit di cultura e di visione, che caratterizza la prassi corrente. Forse, nella stagione della diaspora degli uomini che militarono nella Dc del dopoguerra, c’è bisogno di non effimeri punti di riferimento ideali e storici. Uno di questi potrebbe essere – io me lo auguro – la nuova «Civitas» dell’anno 2004. 14 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Una rivista ... non necessaria ma utile “Qualcuno dirà che di una nuova rivista non si sentiva il bisogno”. Così il 16 dicembre 1919 iniziava la presentazione del primo numero Filippo Meda per spiegare in poche righe del “perché «Civitas»”. Paolo Emilio Taviani, trent’anni dopo, dando vita alla nuova serie, userà ancor meno parole per motivarne la ripresa nel 1950. Per Meda, «Civitas» – “non necessaria ma utile” – si era scelto un “campo suo”, quello degli argomenti che attengono alla politica sociale sotto tutti i punti di vista, nessuno escluso. Pensando con ciò di fare “appunto” cosa utile “alla cultura di quella parte del pubblico italiano che già in materia politica segue le direttive nostre”. Per Taviani “l’azione politica va affiancata da uno studio di largo respiro che, da un lato ne approfondisca e ne elabori i fondamentali principi ispiratori o ne rilevi i legami storici e, dall’altro, possa, senza fretta e senza momentanee preoccupazioni, esaminare i diversi fenomeni nei cui confronti si applicano concretamente i principi”. Conclusa la sua breve esperienza (1948-49) di segretario nazionale della Democrazia Cristiana. – “in nome e per conto di De Gasperi”, amava ripetere agli intimi – non aveva chiesto posti nel governo o nel sottogoverno. Chiese ed ottenne dal partito di rieditare la rivista di Meda che, causa il fascismo, aveva cessato le pubblicazioni nel 1925 per tornare, dopo la guerra, con una sporadica riapparizione su iniziativa di Guido Gonella. Taviani mantenne l’impegno preso in quel lontano 1950 per quarantasei lunghi anni: negli anni della sua costante permanenza in vari ministeri, ma anche – a partire dal 1975 – quando dal ‘potere’ si sarebbe allontanato e la fatica di trovare sponsorizzazioni per la stampa e gli abbonamenti lo costringevano ad attingere alle sue risorse personali. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 LUIGI GIRALDI Collaboratore di Paolo Emilio Taviani ≈ “... «Civitas» riprenderà il difficile impegno con la serietà e il rigore che l’hanno contraddistinta anche nei momenti più travagliati e complessi... Anche questo sarà un importante compito della nuova «Civitas»” ≈ 15 Luigi Giraldi “La sobrietà a tratti scarna, talora neppure invogliante” – come nota argutamente Italo De Curtis nel saggio celebrativo dei quarant’anni di «Civitas» (n. 4/luglio-agosto 1989) – è stata uno dei connotati tipici della rivista: un invito per quanti seguono con interesse l’attività politica o a essa si sono dedicati, a un momento di pacata riflessione. Ma è stata anche la condizione per garantire a «Civitas» quella autonomia che altrimenti la quotidianità politica avrebbe fortemente condizionato. E Taviani fu sempre geloso di questa autonomia, di questo voler riflettere, studiare, approfondire a prescindere dall’assillo delle scelte politiche contingenti. Un esempio che è anche una testimonianza. Nella sede storica della rivista in via Tirso, “in quelle stanze sobrie ed essenziali” per stare sempre al racconto di De Curtis, Taviani andava saltuariamente solo per discutere della rivista; a volte per qualche incontro ‘riservato’, lontano da occhi indiscreti; mai per fare ‘politica quotidiana’. Una sola volta riunì solennemente lo ‘stato maggiore’ della sua corrente, i cosiddetti pontieri, in via Tirso: quando li rese partecipi, nel 1973, della sua decisione di scioglierla considerandola ormai solo uno strumento di potere e non più un amalgama politico. Chi avesse la pazienza di scorgere i saggi ma anche le cronache di «Civitas», troverà sempre, accanto alla sobrietà un ‘volar alto’ un raccontare la politica per fame materia di approfondimento continuo senza lasciarsi condizionare dalle vicende politiche personali: per questo Taviani usava altri strumenti, dalle agenzie di stampa ai giornali ‘ispirati’. Ma teneva sempre fuori e al di sopra «Civitas». Proprio per questo, quando fu costretto a deciderne la chiusura (1995), volle subito, senza esitazione alcuna, trasferire la proprietà della testata all’Istituto Sturzo, certo che, semmai un giorno ne fosse stata decisa la ripresa, ne sarebbe stata garantita l’autonomia e il livello di “strumento di approfondimento e di studio”. Negli anni a seguire, fino alla sua morte (2001), mai ha fatto pressione alcuna perché se ne accelerasse la ripresa. Eravamo noi, amici di «Civitas», a premere e lui, prudente, a stemperare. Fino al giorno in cui – sembrava proprio che ce se la potesse fare! – lo invitammo a scrivere una possibile presentazione per il primo numero della ‘nuova «Civitas»’. Ce la consegnò il 18 febbraio del 2000: secondo uno stile ormai consolidato, era ancora più breve ed essenziale della sua precedente del giugno 1950, e ancor più di quella di Meda del 1919. “«Civitas» riprenderà il difficile impegno con la serietà e il rigore che l’hanno contraddistinta anche nei momenti più travagliati e complessi. I temi riguarderanno problemi, prospettive della politica internazionale con un particolare riguardo alla vita italiana e all’unità europea. Un notevole spazio verrà ancora dedicato alla Storia dei movimenti sociali e politici di ispirazione cristiana. Il ventesimo secolo ha lasciato tracce e impronte in Italia, in Europa e nel mondo che sono in gran parte da scoprire e, per un certo verso, se non addirittura da correggere. da meglio interpretare. Sarà anche questo un importante compito della nuova «Civitas»”. 16 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Europa: senz’anima non andrai lontano L’Italia rischia di perdere il contatto con l’Europa, e l’Europa rischia a sua volta l’irrilevanza internazionale. Per ridare vita e continuità al processo di integrazione non basta rifarsi ai successi economici, più che politici o culturali, degli anni scorsi. Occorre ritrovare le radici del progetto politico che fu di De Gasperi, come ricordano in questo colloquio con «Civitas» il professor Gabriele De Rosa ed il cardinale Achille Silvestrini. Che lanciano una provocazione: affidiamo a Tony Blair la presidenza della Commissione Esecutiva. CIVITAS: Con il maggio 2004 l’Unione Europea è passata da quindici a venticinque paesi. Nella sua lunga storia il Vecchio Continente non aveva mai visto niente di simile: un processo di unificazione politica che, senza spargere una goccia di sangue, coinvolge un territorio più esteso di qualsiasi impero dai tempi di Carlo Magno. Il sogno dunque continua. Bisogna vedere però quali sono ora i problemi legati alla nuova prospettiva dell’integrazione europea, anche di fronte all’emergere di episodi che fanno pensare a nuovi tentativi di costituire una sorta di direttorio all’interno dell’Unione. GABRIELE DE ROSA Presidente Istituto Luigi Sturzo ACHILLE SILVESTRINI Prefetto emerito della Congregazione per le Chiese Orientali Colloquio raccolto da: NICOLA GRAZIANI GIUSEPPE SANGIORGI ≈ “... il cuore antico dell’Europa è la sua cultura, la sua tradizione che è anche una tradizione cristiana...” ≈ DE ROSA: L’allargamento dell’Unione Europea è oggi la prospettiva più suscettibile di un grande sviluppo delle istituzioni comunitarie, quella su cui maggiormente verte l’attenzione dei politici. Gli interrogativi sono tanti: cosa essa può comportare? Con quali modalità si farà? C’è il rischio di una specie di menomazione delle origini dell’Unione Europea – o meglio di uno sfilacciamento dell’Unione – che le faccia perdere quello slancio e quella Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 17 De Rosa - Silvestrini consistenza che ha avuto nella fase iniziale dell’integrazione? La fase iniziale era approdata alla costituzione della Ceca (premessa dell’Unione attuale) che aveva due significati: il primo, economico, era mettere in comune il carbone e l’acciaio e il secondo, l’aspetto politico, che ebbe grande risonanza all’epoca e spinse Adenauer a dichiarare a Robert Schuman (come quest’ultimo avrebbe ricordato): «è da tanti anni che l’aspettavo». La nascita della Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio fu un’esplosione di novità, veramente di straordinaria novità sarebbe potuta scaturire finalmente quell’Unione Europea tanto invocata anche dalla grande tradizione cattolica e democratico-cristiana già all’epoca di Luigi Sturzo. L’idea dell’unificazione, dunque, è partita da lontano, accolta, al suo annunzio, con entusiasmo e con la sensazione che, dopo la tragedia del secondo conflitto mondiale, finalmente si imboccava la strada giusta. Il porre in comune quelle risorse da cui erano scaturiti i grandi armamenti della seconda guerra mondiale – carbone e acciaio, appunto – è stato il nodo centrale della prima unificazione Ma questo è un aspetto che oggi, mi pare, sia passato nel “dimenticatoio” dei giovani europei. CIVITAS: De Gasperi puntava anche alla creazione di una difesa comune. DE ROSA: De Gasperi aveva capito – come sempre succede quando si scopre improvvisamente che si è aperta una strada, una strada che deve essere percorsa fino in fondo – che il nodo centrale era rimuovere finalmente in maniera strutturale – lo sottolineo: strutturale – uno dei fattori che avevano portato al conflitto, rendendo comune lo sfruttamento di quelle due principali risorse industriali ed energetiche, che poi hanno finito col diventare le risorse comuni di tutto il meccanismo dell’Unione Europea. CIVITAS: Sembra, da questo punto di vista, che nell’allargamento attuale sia venuto un po’ meno lo spirito originario dell’unificazione – che era quello di mettere insieme cultura, politica e risorse materiali – e che i paesi che si sono avvicinati in questi ultimi anni all’Unione Europea vivano il loro ingresso come tentativo di partecipare più che altro a un successo economico. DE ROSA: Sì. È prevalsa tutta una certa pubblicistica che ha celebrato solo i successi dello sviluppo del mercato comune. Ma non si fa l’Europa unita solo con la dilatazione del mercato, almeno stando a quello che era il pensiero di Jean Monnet, di Schuman per non parlare di Adenauer e di De Gasperi, ossia del gruppo che ha avuto l’intelligenza e l’intuizione di imboccare la via dell’integrazione economica non certo con l’intenzione di assolutizzare il mercato come fosse la vera espressione dell’Unione Europea. Certo, esiste anche il problema del mercato ed è importante 18 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 De Rosa - Silvestrini cercare di dilatare l’area del benessere. Però in assenza di una sovrastruttura ideale e ragionevole che crei partecipazione morale ed entusiasmo, si finisce più che altro con l’avvantaggiare i grossi imprenditori, oscurando le ragioni vitali che stavano tanto a cuore a De Gasperi e a Schuman. Per loro era decisivo fare qualcosa che rendesse chiara l’importanza di un’Unione valida e civile basata sui valori morali e non sull’assolutizzazione della legge del mercato. CIVITAS: Si dice spesso che il “futuro ha un cuore antico”. Il cuore antico dell’Europa è la sua cultura, la sua tradizione che è anche fortissimamente una tradizione cristiana. Si pensi ai grandi itinerari, ai grandi pellegrinaggi a partire dall’Anno Mille: il Cammino verso Santiago, la Romea, la Francigena. In che modo tutto questo entra a far parte del processo di integrazione? Consideriamo anche che, con l’ingresso dei paesi dell’Est europeo, si apre un nuovo problema, quello di come si fonderanno le due anime dell’Europa cristiana in una comune identità europea. SILVESTRINI: Nonostante le apparenze, la Polonia, l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovenia, la Slovacchia non sono paesi orientali ma centro-europei e di civiltà, potremmo dire, cristiana occidentale, anzi cattolica. La Polonia è cattolica, così la Slovacchia e lo è in gran parte anche l’Ungheria. A mio avviso rimane a margine di questo nuovo ingresso l’Europa ortodossa. Subentreranno la Romania e la Bulgaria, ma non immediatamente. Per quanto con l’allargamento entreranno nuove identità nazionali slave, ma dal punto di vista religioso non ci sarà un’alterazione della componente cristiana. Il problema è, piuttosto, che tipo di rapporto c’è tra la Chiesa cristiana e la società europea. Sotto un profilo di memoria storica non si può discutere che l’Europa sia nata tutta con dei battesimi, da Clodoveo nel 480 al principe di Kiev nel 989: un periodo di esattamente 500 anni in cui sono tanti battesimi a dar vita ad altrettante nazioni. Questa è la memoria storica. Ora la domanda è: che Cristianesimo c’è in questa nuova entità pluralista, federalista, che si profila? Qual è l’uomo europeo che noi cristiani pensiamo possibile, qual è l’uomo europeo che nasce? Guardiamo allora alla cultura europea come si è sviluppata storicamente, al pensiero greco-romano, alla filosofia classica, allo sviluppo dell’età della scienza, da Galileo fino ai giorni nostri. Si tratta di una complessità culturale di cui il Cristianesimo non solo fa parte, ma che esso stesso genera. Anche quando si parla dell’Illuminismo, del culto della ragione, si deve ricordare che c’è stato pure un Illuminismo cristiano. Il problema è adesso l’uomo europeo attuale, la sua identità, anche in considerazione del fatto che il problema non è dato dai popoli che entrano nell’Unione come paesi membri, ma dai popoli che immigrano, che dovranno trovare un’identità europea, ma che non saranno comunque essi a costruire. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 19 De Rosa - Silvestrini CIVITAS: La Chiesa come può aiutare questi processi? Si può parlare della necessità di una pastorale europea da parte della Chiesa? SILVESTRINI: Certo. Il Papa ha più volte chiesto di inserire nel preambolo della Costituzione il riferimento alle origini cristiane dell’Europa. Senza esagerare l’importanza di questo preambolo, sarebbe comunque ingiusto inserire una cosa (Tucidide e l’Illuminismo) e trascurarne un’altra: il problema concreto è come siano considerate in Europa le Chiese in quanto comunità religiose, se venga conservato alle Chiese il trattamento che hanno nei differenti Stati dove esistono concordati (per esempio in Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Austria). Vi è poi il problema della libertà religiosa, che comunque non è in discussione poiché essa è inscritta fra i diritti umani fondamentali in cui l’Europa si riconosce. Alla fine il punto di fondo è: qual è il contributo che possono dare i cristiani? Occorre che si svolga un dialogo ecumenico orientato al bene dell’Europa. Possiamo osservare che anche gli ortodossi condividono le stesse nostre valutazioni e aspirazioni e, come noi, credono che per l’Europa occorra una nuova evangelizzazione. Sarebbe necessario collaborare, procedere insieme. Si tratta del grande tema dei rapporti tra la Chiesa cattolica e le comunità cristiane di rito bizantino. Poi ci sono, naturalmente, anche le comunità della riforma che vanno coinvolte. Il paradosso è che fra noi cattolici, i luterani e i calvinisti ci sono differenze teologiche importanti ma c’è la stessa mentalità occidentale; con gli ortodossi invece ci sono dei punti fondamentali di fede che sono identici, l’Eucarestia, il sacerdozio, la successione apostolica, ma è la mentalità che è diversa. Per questo occorre sviluppare un ecumenismo europeo, che è in atto con degli organismi propri. CIVITAS: Ciò in vista anche dell’incontro, che sarà di là negli anni, con paesi portatori di un’identità religiosa diversa, come la Turchia. SILVESTRINI: Dico francamente che non vedrei la Turchia come un problema. Il problema se lo deve porre l’Europa: la Turchia risponde ai parametri fondamentali dell’Europa? Le comunità cristiane in Turchia hanno delle richieste motivate. Anche se c’è la libertà di culto, tutta l’organizzazione ecclesiastica non ha un riconoscimento legislativo. Una Chiesa non è iscritta come persona morale, come avviene in ogni altro paese europeo. Oggi i beni non sono riconosciuti come appartenenti a una Chiesa, ma a società private. Lo stesso patriarcato di Costantinopoli vive in una condizione ristretta e limitata. La soluzione di questi problemi dovrebbe ricollegarsi ai parametri generali del diritto comune europeo. CIVITAS: Abbiamo appena accennato al preambolo della Costituzione. Quello che colpisce, in quel documento, non è tanto il mancato richiamo alle radici cristiane, quanto semmai una lunga citazione tratta da Pericle che ne potrebbe prendere il 20 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 De Rosa - Silvestrini posto. Quasi una scelta in favore dell’Acropoli rispetto all’Agorà. In Tucidide, poi, Pericle è l’uomo della distruzione della città di Melo, e della riduzione in schiavitù dei suoi cittadini rei solo di aver rivendicato le loro libertà democratiche. Insomma, aprire la Costituzione con quel passo può quasi apparire una scelta in linea con il tanto conclamato deficit di democrazia all’interno delle istituzioni europee. DE ROSA: Per arrivare ad una democrazia come la definiva Tucidide – cioè la vera autentica democrazia che non può essere di pochi ma deve essere dei più – occorre l’impegno della parte più autenticamente esecutiva, dirigente dell’Unione Europea. Non basta Bruxelles. Bruxelles fa quello che può sul piano dell’amministrazione, della gestione dell’esistente, ma non svolge un’azione di vera creazione di un’anima europea. Sono i vari parlamenti – non parlo dei governi – che in quanto espressione della volontà democratica dei rispettivi paesi, dovrebbero coordinare le loro forze per far sì che la locuzione “Unione Europea” non abbia un senso di generalità e di astrattezza, ma possa diventare abitudine, parte di una mentalità comune e diffusa. Esiste questo sentimento di democrazia partecipata? Dev’esserci una convivenza che sia molto di più del semplice rispetto delle diversità culturali, ma sia convivenza produttiva, operativa al fine di conoscersi meglio ed edificare un’Unione intesa soprattutto come Comunità, cioè una società nuova che, com’è nell’aspirazione di tanti, realizzi l’unità politica. CIVITAS: Qual è la via migliore per arrivarci: il federalismo, il funzionalismo? Qual è l’approccio più efficace per questa costruzione? DE ROSA: Forse un po’ di funzionalismo e insieme un po’ di confronto tra le varie prospettive federative potrebbe essere la ricetta adeguata. Quello di cui c’è bisogno è una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali. Non basta Strasburgo. Inoltre dobbiamo chiarire preliminarmente cosa intendiamo per Unione Europea, quali sono le aree che ne fanno parte e dove collochiamo il Mediterraneo. L’Europa comincia dal Bosforo e arriva a Gibilterra. Questo rilievo era già stato mosso da Luigi Sturzo, esattamente citando questa delimitazione geografica. Denunciava: «voi avete portato tutto a Strasburgo», ed in tal modo toccava quello che è ancora oggi il punto debole: l’esistenza di un’Unione Europea senza Mediterraneo o con poco Mediterraneo. CIVITAS: Per spiegare l’Europa ai giovani bisogna anche ricordare che sono ormai 60 anni che in questo continente non ci sono più guerre, proprio in questo continente nel cui cuore sono scoppiate le due guerre mondiali. L’Europa è dunque ora un’area di pace, o quanto meno di non tensione. Bisogna coinvolgere in quest’area i Balcani, o anche Israele, per allargare le condizioni strutturali della pace? È un sogno o l’allargamento a queste aeree può rappresentare una politica? Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 21 De Rosa - Silvestrini DE ROSA: Amplierei il discorso, visto che anche i giornali e le opinioni pubbliche sottolineano la necessità di un’azione più concreta, e non solo di proposta. Primo: soltanto una sollecita integrazione dei parlamenti dell’Unione Europea farebbe sentire i rispettivi esecutivi più vincolati ad una maggiore democrazia “ravvicinata”. È questo un problema molto importante. Secondo: l’attrazione che esercita l’Unione Europea non può essere intesa solo in termini di mercato ma anche di solidarietà. Non si può garantire soltanto il benessere al proprio interno quando a soli 80 chilometri dalla Sicilia si apre un continente che è per tre quarti povertà. Deve cominciare una fase nuova in cui l’Europa impari a dare; a dare senza ricevere, perché ha ricevuto già molto. CIVITAS: Dei tre “pilastri” dell’Europa di Maastricht, il terzo, ossia la creazione di un’Europa sociale, è però quello più disatteso. Quando si parla del rilancio dell’Europa, quello che si fa è generalmente enunciare la necessità di tornare agli esiti del vertice di Lisbona del marzo 2000, quindi ad una impostazione puramente liberista. DE ROSA: È necessario che l’Europa non si chiuda in se stessa alla ricerca di un benessere più diffuso e garantito quando ai suoi confini meridionali c’è disparità e discriminazione. Ecco perché l’Europa dovrebbe incominciare a fare una politica in cui il termine principale – semplifichiamolo pure – è donare. L’Europa ha già ricevuto. SILVESTRINI: L’Europa non è un articolo di fede per la Chiesa, perché il Suo messaggio è rivolto a tutta l’umanità, anche oltre i confini europei. Quando la Santa Sede partecipò alla Conferenza di Helsinki per la sicurezza e la cooperazione in Europa, lo fece perché ne aveva titolo in quanto soggetto che ha base in Europa, ma la sua azione fu rivolta a promuovere un’iniziativa di pace con uno sguardo come sempre universale. La visione della Chiesa è quella della Populorum Progressio di Paolo VI: la pace è lo sviluppo. Per quanto riguarda l’Europa, essa ha confini storicamente fluttuanti, non definibili su base geografica. Con l’età della scienza e della tecnica avviata con Galileo è cominciata l’europeizzazione del mondo e, contemporaneamente, la mondializzazione dell’Europa. Come dice Edgar Morin, l’Europa è una «comunità di destino», cioè di valori e non un’entità geografica. Perciò deve guardare al di fuori dei suoi confini convenzionali. CIVITAS: L’idea forte dell’Europa unita è spesso concisa con la presenza ugualmente forte dei partiti della Democrazia Cristiana, oggi o finiti, o scarsamente influenti. La loro scomparsa influirà negativamente sul processo d’integrazione europea? 22 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 De Rosa - Silvestrini DE ROSA: È innegabile che esiste qualche ristrettezza ideologica, i cui effetti si vedono. C’è la mancanza di una visione ampia, che permetta di valutare le cose più in termini di civiltà che non in termini di rapporti tra forze politiche circoscritte, magari ad una data epoca e a un dato territorio. A un certo punto, anche nel nostro Paese, non si è saputo rinnovare lo slancio che c’è stato inizialmente con De Gasperi. I discorsi di De Gasperi sull’Europa non erano legati a una formula, erano legati alla percezione di un’identità europea a cui fare capo per svolgere una politica di respiro culturale. Rileggendo i suoi ultimi discorsi, anche quelli meno noti o rimasti inediti o parzialmente inediti, non possiamo non rilevare la sua passione per l’Europa, da grande europeista convinto, che nasceva dall’esperienza sofferta della Seconda Guerra Mondiale, una lezione che era identica a quella vissuta da Schuman e da Adenauer. Di qui la non casualità del loro incontro. CIVITAS: Recenti fatti internazionali come l’intervento in Iraq hanno dimostrato una non sintonia tra le visoni del mondo, della pace e dei rapporti internazionali fra Stati Uniti e paesi europei. Ciò rappresenta un elemento di tensione che occorre ricomporre? Con quale attenzione guardate a questo problema e come pensate di muovervi? SILVESTRINI: Io penso che ha detto bene Giovanni Paolo II quando ha espresso una visione universale della pace: l’incertezza dell’Europa ha il suo peso. CIVITAS: “Vecchia Europa”, ha detto l’amministrazione Bush. “Saggia Europa”, è stato risposto da qui. SILVESTRINI: Esatto. Non c’è solo l’Europa come tale da considerare ma anche i problemi che si agitano nell’ambito geografico intorno all’Europa. Per esempio la questione israelo-palestinese risente molto della carenza di unità politica dell’Unione Europea, della sua incapacità di prendere una posizione di aiuto e di soccorso affinché si trovi una soluzione pacifica. Anche volendo agire, l’Europa non ha ancora i mezzi per farlo. Il conflitto israelo-palestinese è il focolaio più grave in Medio Oriente. Occorre che ci sia qualcuno che se ne faccia carico. Se pensiamo che gli israeliani sono in gran parte una popolazione di origine e cultura europea e che l’Europa, e l’Italia in modo particolare, è così vicina al Medio Oriente, si capisce come una garanzia e un sostegno possano venire solo dal nostro continente. Ma l’Europa con che mezzi si esprime senza accordo sulle regole e sulle strutture anche militari? È una carenza che si sente molto. Occorre che agli Stati Uniti giunga, da parte degli europei, un apporto di pensiero, di consiglio e di esperienza. La popolazione degli Stati Uniti, del resto, non è in gran parte di origine europea? E quanti grandi cervelli europei hanno finito per trasferirsi negli Stati Uniti! Ma finora l’Europa non ha un’autorità politica e culturale, e questo è grave. L’Italia, ad Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 23 De Rosa - Silvestrini esempio, dopo tanti anni, si mostra oscillante, debole rispetto all’idea unitaria, a differenza invece della Francia e Germania che, lungi dall’essere un “direttorio”, sono ai vertici dell’Unione Europea per un potere reale, per efficienza e per preparazione. Che l’Europa possa perdere il contributo e il valore che l’Italia ha sempre assicurato a partire da De Gasperi è qualcosa che deve preoccupare. CIVITAS: L’Italia, appunto. Che cosa devono fare i politici italiani per uscire dal provincialismo che pare connotarne l’azione, e per avere più senso della politica europea, anche in termini di crescita del nostro paese? SILVESTRINI: Tornare alla grande tradizione del nostro Paese. De Gasperi è un caso a sé perché egli esprimeva dopo la guerra, a proposito dell’Unione Europea, una visione di nazionalità, maturata da italiano nell’Impero Asburgico, che non era nazionalismo. Era una esperienza che egli aveva. Ma anche altri, lo stesso Moro e i politici italiani in generale, condividevano tutto questo. Oggi, per misurare l’Unione Europea, non ci si può basare solo sul criterio della maggiore o minore convenienza della moneta unica. Il Presidente Ciampi ha sottolineato che l’Italia, quando si trovava ad un passo dall’annegare nei suoi problemi, è stata salvata dall’Europa, e lo sarà ancora in futuro. Se c’è qualche problema non risolto a sud dell’Europa, è l’Italia a viverlo continuamente. DE ROSA: Io voglio rivolgere una grande, calda preghiera, quella di uscire dai pettegolezzi provinciali e di ignorare gli aspetti deleteri, meschini, del battibecco quotidiano per passare alla valutazione dei fatti così come stanno scorrendo. Sono fatti di enorme difficoltà. C’è in atto una crisi dell’Unione Europea, provocata anche dall’irruzione del concetto di guerra preventiva, e non si riesce ancora a trovare la strada giusta per uscirne. E qui tocchiamo un tasto importante: l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Non sento più parlare attivamente, nella nostra politica estera, del tema della riorganizzazione delle Nazioni Unite. Manca ormai la dimensione aperta, carica di preoccupazioni civili ed etiche, che fu propria invece di De Gasperi ma anche dei suoi successori, come Aldo Moro, la cui fine è una fine registrata nella progettazione squallida di chi odiava l’uomo. Siamo in un momento in cui i personaggi della nostra politica hanno a che fare con problemi di una dimensione notevolissima, mondiale, come il Medio Oriente e l’Iraq, che rendono difficile una prospettiva di collaborazione internazionale. Si tratta di problemi solo apparentemente lontani da noi. L’azione dell’Italia si limita ora alla sufficienza, al ruolo della comparsa sulla scena internazionale; non c’è un’autentica rispondenza all’appello, ai richiami, alla protesta. CIVITAS: L’Europa è nata con la Democrazia Cristiana ed è cresciuta quando è stata fatta propria dalla tradizione socialista. Ma poi è sembrata accontentarsi di 24 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 De Rosa - Silvestrini vivere di rendita; infine, al momento di creare qualcosa, nel decennio del liberismo in cui dominava la filosofia del diritto all’egoismo, il progetto unitario si è come sgonfiato. Un liberismo, tra l’altro, che abbiamo importato d’Oltremanica. Se in questo dialogo c’è un convitato di pietra, questo è il Regno Unito. Non si è ancora capito se la Gran Bretagna giochi un ruolo costruttivo nei confronti dell’Unione Europea o se sia ancora contraria alle prospettive dell’unificazione politica. Nonostante i molti buoni propositi enunciati e più volte ripresi da Tony Blair. DE ROSA: Non penso che ci sia un capovolgimento di prospettive da parte della Gran Bretagna, malgrado l’attenzione recentemente rivolta all’euro. Per avvicinarsi all’Europa, Londra dovrebbe ridimensionare la sua inclusione nella strategia americana e svolgere un’azione diplomatica di carattere correttivo nelle scelte interveniste del suo alleato. Mi pare che la Gran Bretagna guardi oggi più al di là dell’Oceano che all’Europa. CIVITAS: E la Chiesa inglese ha una sua autonoma idea dell’Europa? SILVESTRINI: La Chiesa Cattolica è minoritaria in Gran Bretagna e non può determinare interventi in questo campo. Non credo che la Chiesa anglicana sia antieuropea ma ritengo che essa partecipi della mentalità del Regno Unito e dell’opinione pubblica inglese, il cui atteggiamento costituisce un tema di grande interesse storico: non vuole staccarsi dall’Europa né entrare nell’Europa. In passato l’Inghilterra ha contrastato, in nome dell’equilibrio continentale, tutte le egemonie che cercavano di prevalere in Europa e ha avuto un ruolo anche nell’unificazione italiana, impedendo che all’egemonia austriaca nella penisola si sostituisse quella di Napoleone III. L’errore fatale di Mussolini è stato proprio di illudersi di poter sfidare l’Inghilterra piuttosto che tenersi in disparte come fece Franco per la Spagna. Nella fase storica attuale, in cui l’Unione Europea potrebbe davvero rappresentare la garanzia di quell’equilibrio tanto invocato in passato, l’Inghilterra non riesce, però, ad essere né con l’Europa né contro l’Europa. Arriva spesso in ritardo sulle grandi scelte europee senza mai abbandonarle del tutto. Io penso che arriverà in ritardo anche questa volta. Un colpo paradossale sarebbe di affidare la presidenza della Commissione Europea a Tony Blair per vedere cosa fa. Sappiamo in effetti che Churchill era arrivato a chiedere che l’Inghilterra dopo il 1940 si unisse in federazione con gli Usa con lo scopo di salvare la civiltà occidentale del suo paese. Però è stato proprio Churchill a tenere il discorso di Fulton ed è stato sempre lui ad essere ricevuto da Pio XII, il pontefice che lavorava attivamente per l’unità europea e per la riconciliazione franco-tedesca. Non bisogna essere pregiudizievoli con la Gran Bretagna, ma affidarle delle responsabilità. Un esempio potrebbe essere la prossima presidenza della Commissione esecutiva. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 25 De Rosa - Silvestrini CIVITAS: Il nodo centrale, per noi, è anche quello del rapporto non solo tra Gran Bretagna ed Europa, ma anche tra Italia ed Europa. C’è il rischio che l’Europa possa fare a meno dell’Italia, mentre invece l’Italia non può fare a meno dell’Europa? SILVESTRINI: Secondo me la stessa Europa non può fare a meno dell’Italia, anche se l’Italia può divenire l’anatra zoppa della situazione. Ad ogni modo l’Italia non può fare certo a meno dell’Europa. Fermo restando che l’Europa ha bisogno dell’Italia, e per tante ragioni: storiche, morali, religiose e culturali. Non può vivere senza la cultura italiana. DE ROSA: Come non può vivere senza il Mediterraneo. E l’Italia è il collegamento naturale con quest’area, come con l’Africa e i paesi emersi con la loro identità nel secondo dopoguerra. Soprattutto quelli dal Medio Oriente a Gibilterra. CIVITAS: L’Italia non è “colpevole” di aver dimenticato una tradizione di politica estera che era particolarmente sensibile nei confronti dei paesi arabi – si pensi all’azione di Aldo Moro – di grande attenzione nei loro confronti? DE ROSA: Manca da parecchio tempo l’attenzione ai paesi arabi ed in generale a quelli emergenti. Penso alla necessità di un rapporto più stretto con il Marocco. Poi c’è l’Africa: manca una visione realistica di quella che oggi è l’Africa. E la percezione dei problemi, enormi, posti dalla sua povertà. Non è, diciamolo, una presenza attiva, operativa quella dell’Italia nel continente africano. CIVITAS: Insomma, rischiamo di essere un mattone in un muro piuttosto che in un ponte… DE ROSA: Penso alle nostre delegazioni parlamentari, che tornano dai loro viaggi soprattutto in Africa. Non è che tornino con una certa visione, con l’impegno a capire quale sia oggi il grande dramma dell’Africa. Anche se non possiamo dimenticare che in tutto questo dramma, in questo susseguirsi di guerre tra paesi poveri, c’è un grande assente: Le Nazioni Unite. CIVITAS: Bisogna dire che c’è tanto da lavorare, tanto da sollecitare, e allora speriamo che «Civitas», che con questo numero riprende le pubblicazioni, possa essere uno strumento per affrontare questi problemi. DE ROSA: Secondo la sua tradizione, del resto. 26 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Ma quali sono i confini dell’Europa? L’allargamento dell’Unione Europea del maggio di quest’anno porta ad una quasi coincidenza tra l’Europa istituzionale (l’Unione in senso stretto) e l’Europa geografica (dall’Irlanda alla pianura polacca). Si pone quindi la questione dei confini europei. Già il problema dell’adesione della Turchia ha sollevato in termini acuti la questione del rapporto fra integrazione nell’Europa intesa come istituzione, e come insieme umano e geografico. Certamente il tema sarà l’oggetto di ampi e difficili dibattiti negli anni che vengono. • Sono anni in cui l’aspetto dell’Europa è molto cambiato, come se avesse subito qualche intervento chirurgico: dalla piccola Europa dei Sei, delle prime Comunità del Carbone e dell’Acciaio, dell’Euratom e della Cee, nate negli anni Cinquanta (a lungo il “nucleo duro” dell’Europa in costruzione), all’Europa “senza rive” cara all’economista francese François Perroux, alla grande Europa “dall’Atlantico agli Urali”, sogno profetico del Generale de Gaulle, che respirerebbe con i suoi “due polmoni” occidentale e orientale, come infine la vede oggi Giovanni Paolo II. I cambiamenti introdotti durante questi ultimi cinquant’anni nei confini del Continente, esterni così come interni, permettono di sottolineare quanto l’Europa resti ancora un oggetto di studio, come fu nel passato e come lo è nel presente, di una grande complessità, che pone un difficile problema metodologico. Considerata dall’esterno, presenta un’unità culturale apparente: il viaggiatore europeo risente la sua appartenenza all’Europa particolarmente quando si trova in un altro continente: allora capisce la sua europeità. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 JEAN-DOMINIQUE DURAND Università di Lione ≈ “... I confini interni non sono soltanto limiti materializzati, ben visibili: attraversano anche gli spiriti e le mentalità degli europei” ≈ 27 Jean-Dominque Durand • Il significato della parola “Europa” La parola “Europa” è stata usata da papa Nicolò V nel 1453, dopo la caduta di Costantinopoli, per esprimere la necessaria unione delle forze cristiane di fronte all’espansionismo islamico e al pericolo rappresentato dall’Impero Ottomano. Il termine “Europa” prendeva così il posto di “Cristianità” nel definire unitariamente la parte ad ovest dell’Ellesponto. Paolo VI aggiunse che l’Europa è nata dalla Croce, dal libro e dall’aratro: trittico che ricorda l’opera dei monasteri, in particolare benedettini, nei campi spirituale, culturale ed economico. “Nel formarsi del concetto d’Europa e del sentimento europeo”, ha scritto Federico Chabod, “i fattori culturali e morali hanno avuto, nel periodo decisivo della sua formazione, preminenza assoluta, anzi esclusiva”. Un collega francese di Chabod, René Rémond, osserva che l’Europa ha la peculiarità di essere l’unico continente completamente cristianizzato, e sottolinea che per molti popoli europei, la conversione al cattolicesimo ha coinciso con la nascita stessa della nazione, legando indissolubilmente identità nazionale e identità religiosa: «Cette commune appartenance chrétienne – scrive – est une composante de l’identité européenne. Elle crée une différence originelle avec les autres continents, qui s’atténuera avec le mouvement missionnaire par lequel l’Europe apportera sa foi aux autres mondes. Le christianisme a imprimé sa marque sur le continent. L’Europe s’est couverte d’un grand manteau blanc d’églises. Partout des monastères se sont fondés dont les religieux ont contribué à défricher la terre. L’espace a été quadrillé, des humbles croix érigées aux carrefours des chemins jusqu’aux cathédrales et aux basiliques les plus altières. Le christianisme a imposé son empreinte dans le temps aussi avec son calendrier liturgique». • L’idea di Europa del cardinal Wojtyla Di questa unità fondamentale la Chiesa si è voluta fare portatrice. È per questa ragione che il cardinale Karol Wojtyla, poco prima della sua elezione, pubblicò nell’estate del 1978 un saggio nella rivista dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Vita e Pensiero, intitolato “Una frontiera per l’Europa: dove?”. Il cardinal Wojtyla si opponeva all’idea di un’Europa puramente occidentale e insisteva sull’unicità del continente sulla base del comune patrimonio cristiano. Nel 1988 l’ormai Papa Wojtyla parlava della “nostra patria europea” e del suo sogno di vedere l’Europa “un jour se déployer aux dimensions que lui ont donné la géographie et plus encore l’histoire”. D’altra parte – altra dimensione fondamentale per il Pontefice – l’unione politica favorisce l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 28 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Jean-Dominque Durand Eppure l’Europa presenta al suo interno una notevole diversità che implica per l’osservatore il dovere di una attenzione alla successione cronologica degli eventi, con uno sguardo in permanenza diretto verso la storia tanto ampio quanto quello che si suole dedicare agli spazi. Bisogna, insomma, costantemente praticare ciò che i geografi chiamano il cambiamento di scala. • Quali confini dell’Europa Tale osservazione implica di porre la questione dei confini dell’Europa. Si è molto parlato dell’Europa dall’Atlantico agli Urali, o dall’Islanda al Bosforo o anche dal Capo Nord a Gibilterra, per sottolineare “l’anima comune”, i legami di cultura e di civiltà, con tanti motivi di confronto, con una storia spesso crudele, ma anche con una innegabile unità mentale ed etica. Ma queste espressioni che ricercano una definizione geografica della realtà europea nella geografia naturale non sono assolutamente convincenti perché gli Urali non sono una frontiera né politica né geografica, non hanno mai funzionato come una barriera tra i popoli (al contrario dell’Himalaya, per esempio) o nemmeno come i Pirenei che separano la Francia dal mondo iberico. All’Ovest il confine atlantico, con l’inclusione o no delle Isole Britanniche, è venuto cambiando nel tempo non dal punto geografico ma dal punto di vista politico, perché il Regno Unito è spesso più vicino al Commonwealth o all’America del Nord, che non all’Europa. Resta comunque che il confine occidentale è piuttosto ben identificato, anche se le cose non sono così semplici quando si osserva che il Canada e gli Stati Uniti partecipano ai lavori dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce). Questa organizzazione, istituita come Csce dall’Atto Finale della Conferenza di Helsinki nell’agosto 1975 e poi istituzionalizzata in Osce dopo la caduta del Muro di Berlino, racchiude 55 Stati dell’Europa, del Caucaso, dell’Asia centrale e dell’America del Nord. Il suo “territorio” si estende da Vancouver a Vladivostock. • Il confine orientale Invece, il vero problema sta nella parte orientale, con l’immensa questione mai risolta nella storia dei rapporti del mondo russo con l’Occidente, tra il Cattolicesimo e l’Ortodossia, tra la Santa Sede e il Patriarcato di Mosca, tra Roma e Mosca. L’Europa non è un fatto naturale, come gli altri continenti. Addirittura in questo senso non esiste, non è nemmeno “un’espressione geografica” come era l’Italia nel 1815 per un Metternich impegnato a ricostruire la sua Europa. È la minuscola propaggine occidentale dell’Asia sterminata. Eppure esiste in virtù di un atto di volontà, come unione di popoli che hanno scelto un certo modo di vita, fondato su una certa visione della persona umana. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 29 Jean-Dominque Durand Se ci accontentiamo, per ragioni di comodità, di prendere in considerazione il periodo posteriore al 1945, constatiamo che l’Europa si è istituzionalmente costruita dapprima all’Ovest per ragioni legate alle vicissitudini della storia. L’Europa distrutta dalla guerra si era spaccata in due parti. Lo spirito del tempo era uno spirito conflittuale. Da parte cattolica l’idea era di difendere la civiltà cristiana insieme alla democrazia e alla libertà. Fu il momento in cui sull’altro versante della Cortina di Ferro si vide nascere la “Chiesa del silenzio” e si apriva il tempo di un nuovo martirologio. Non a caso la Chiesa di Pio XII sosteneva allora tutte le iniziative per l’unità : “non c’è tempo da perdere “disse il Pontefice all’Unione Europea dei Federalisti in una data altamente simbolica, l’11 novembre 1948. Il ruolo assai importante dei cattolici e in particolare dei democratici cristiani, a cominciare dalla dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950, è ormai ben conosciuto, come sono anche ben noti il sostegno e gli incoraggiamenti che hanno sempre ricevuto dal Vaticano. • Paolo VI: l’Europa è un dovere Nel 1964 Paolo VI diceva ai giovani democristiani che l’Europa è un “dovere” e che “la Chiesa Cattolica vuole che il processo d’integrazione europea si realizzi senza ritardo”. Lo stesso anno San Benedetto fu proclamato Patrono d’Europa, come simbolo di unità: «Ha portato il progresso cristiano dal Mediterraneo alla Scandinavia, dall’Irlanda alle pianure di Polonia». Per il Pontefice, l’Europa era innanzitutto una pedagogia, perché fondata sulla libera adesione degli Stati membri, e come scrisse nell’enciclica Populorum Progressio nel 1967, un apprendistato di solidarietà nuove, tra i popoli europei, e con i popoli del mondo. Comunque la preoccupazione per la divisione dell’Europa era alta. Nel 1969 Agostino Casaroli, Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, in una conferenza a Milano su “La Santa Sede e l’Europa” ebbe a dire che la divisione interna era stata imposta dagli eventi, e che sarebbe stato necessario riprendere il dialogo, ricercare i punti di convergenza e organizzare una conferenza internazionale europea. Nel 1964, Paolo VI aveva creato il Segretariato per i non credenti. Si trattava di aprire le finestre e di lanciare dei ponti tra le due Europe, come diceva lo stesso Giorgio La Pira, per superare le divisioni. • Giovanni XXIII: l’Europa una comunità vera Ancor prima di questi eventi Giovanni XXIII invitava a costruire in Europa “una comunità vera”, cioè aperta, e la Chiesa del Concilio Vaticano II prendeva coscienza che l’Europa non corrisponde al cattolicesimo né la Chiesa all’Occidente. E 30 Civitas / I - Luglio 2004 Jean-Dominque Durand così facendo seguiva quanto già detto nel 1925 da Jacques Maritain: «l’Europe n’est pas la foi et la foi n’est pas l’Europe; l’Europe n’est pas l’Eglise et l’Eglise n’est pas l’Europe». La costituzione pastorale Gaudium et Spes adottata dal Concilio nel 1965 andava esattamente in questo senso quando affermava che la Chiesa era stata destinata a tutti i popoli di tutti i tempi e di tutti i luoghi, senza essere legata esclusivamente a una razza o a una nazione. Per Paolo VI, ormai, il compito sarebbe stato di aiutare a costruire una coscienza europea. Diceva, il Pontefice: “l’Europa sarà vissuta, prima di essere definita”. In questo senso la Conferenza di Helsinki fu considerata dalla Santa Sede come un progresso notevole sulla strada del superamento delle divisioni ereditate dal passato. Il Consiglio Pontificio della Cultura, che assunse nel 1982 il ruolo del Segretariato per i non credenti, è espressione di questa volontà di sottolineare l’unità intrinseca dell’Europa, come testimonia anche il discorso pronunciato dal suo presidente, il Cardinale Paul Poupard, a Berlino, nel 1984 alla IV Conferenza dei ministri europei dei Beni culturali: «Un discours, à Berlin, sur la culture de l’Europe, ne peut omettre une référence obligée à l’ensemble de ce continent, dont le destin historique a été marqué par une spécificité culturelle tout à fait distincte dans le monde. Les divisions politiques et idéologiques des pays de l’Europe ne peuvent faire oublier leur commune identité, quel que soit leur régime gouvernemental. (…) Il est nécessaire de rappeler, sans cesse, que la grande famille européenne s’étend par-delà toutes les frontières particulières ou régionales du Continent». • I limiti Nord/Sud dell’Europa La questione Occidente/Oriente dell’Europa non deve far dimenticare l’altra questione importante dei limiti Nord/Sud dell’Europa, aspetto piuttosto raramente trattato, forse perché sembra ovvio: l’Europa evidentemente si stende tra il Polo, l’Oceano Artico e il Mar Mediterraneo. Eppure la questione è fondamentale perché dietro di essa si cela il problema del rapporto con l’Islam. La Comunità Economica Europea si è allargata poco a poco verso sud (Grecia, Portogallo, Spagna) e verso nord (paesi scandinavi), ma queste estensioni successive non sono state scontate per ragioni differenti legate alle culture, alle singole economie ed alla storia recente. Il problema, oggi, è di sapere se il Mediterraneo costituisca ancora un confine, nel momento in cui tante persone venute dalla sua sponda meridionale (che nel passato era parte integrante dello spazio romano) emigrano verso la riva settentrionale. Si è molto parlato di uno spazio euro-meditteraneo, e già nel 1950 Robert Schuman evocava le responsabilità dell’Europa verso il sud. Ma guardare il confine meridionale dell’Europa è anche prendere in considerazione lo statuto del Bosforo – frontiera o ponte? – tra Europa e Asia, e il posto della Turchia all’interno o al di fuori dell’Unione Europea. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 31 Jean-Dominque Durand • Le frontiere interne L’identità dell’Europa è anche legata alle sue frontiere interne, rigide ma nello stesso tempo in costante movimento nel corso della storia, rafforzate nell’Ottocento e all’inizio del Novecento, nel 1919 dal Trattato di Versailles. Gustav Stresemann, che da ministro degli esteri tedesco che aveva ricevuto insieme al suo omologo francese Aristide Briand il Premio Nobel della Pace nel 1926, sottolineò la loro assurdità quando prese la parola dinanzi l’Assemblea della Società delle Nazioni il 9 settembre 1929, poco prima della sua morte : «Il Trattato di Versailles ha creato un grande numero di nuovi Stati. (…) Nuove frontiere, nuove monete, nuove misure, nuovi pesi, nuovi usi, una sosta permanente del traffico e degli scambi. È grottesco osservare che, mentre si lavora a ridurre la durata del viaggio tra la Germania meridionale e Tokyo, quando uno attraversa l’Europa in treno è continuamente costretto a fermarsi, in qualunque luogo a qualsiasi ora, perché ogni volta c’è un nuovo confine da attraversare e formalità doganali da espletare». L’osservazione fatta da Stresemann con sdegno è stata certamente quella dei primi costruttori dell’Europa, all’indomani di una nuova e terribile guerra che aveva ridotto l’Europa a un campo di rovine. De Gasperi, Schuman, Adenauer, erano degli uomini di frontiera: il trentino, il lorenese ed il renano sapevano concretamente cosa significava la guerra per un pezzo di territorio, ed essendo tutti eredi di una storia di conflitti, conoscevano il carattere molto relativo dei confini il cui tracciato è il risultato delle guerre. Schuman, nato tedesco, e De Gasperi, nato austriaco, diventati rispettivamente francese e italiano in età matura, ne avevano una forte coscienza. La loro politica europeistica ha portato allo smantellamento dei confini; la caduta del comunismo ha provocato la fine della Cortina di Ferro. Ma altri confini sono nati, sempre problematici, come lo dimostrano i nuovi Stati creati dalla fine della Jugoslavia e dell’Unione Sovietica, e con l’affermazione della potenza economica europea con l’allargamento verso l’Oriente. Interessante è l’osservazione di Vsevolod Chaplin, vice presidente del Dipartimento per le Relazioni Estere del Patriarcato di Mosca che affermò alle Giornate della Pace organizzate dalla Comunità di Sant’Egidio, a Palermo, nel settembre 2002 : “The Iron Curtain has given way to a Silver Curtain”, e questa si è spostata sul confine occidentale della Russia. Era chiara la preoccupazione, la paura della nuova frontiera. • I “confini” delle mentalità I confini interni non sono soltanto limiti materializzati, ben visibili : attraversano anche gli spiriti e le mentalità degli europei. È possibile distinguere le frontie- 32 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Jean-Dominque Durand re imposte dalle parole, legate alle difficoltà di traduzione dei concetti da un punto all’altro dell’Europa: la nazione, la nazionalità, il popolo, la laicità, corrispondono, sotto un vocabolario in apparenza simile, a realtà molto diverse. Ci sono le frontiere imposte dai luoghi: da Roma, da Costantinopoli, da Mosca, da Ginevra o da Canterbury, non si vede la stessa Europa, perché da una capitale all’altra, le memorie storiche si oppongono le une alle altre. Dal punto di vista religioso, i cristiani battezzati sono la maggioranza, due terzi della popolazione europea; ma in alcuni paesi i cristiani sono una minoranza rispetto all’Islam (Turchia, Albania), o rispetto ai non credenti (Repubblica Ceca). L’Europa è storicamente approdata al pluralismo religioso. C’è poi una memoria ebrea fatta di dolori, dall’espulsione dalla Spagna alla Shoah, e ci sono le memorie degli scismi. La divisione tra Est e Ovest è determinante per capire la situazione odierna dell’Europa, come anche i massacri, le persecuzioni, la memoria del martirio cristiano, le memorie nazionali da Kosovo Polje a Verdun e Stalingrado. Mi chiedo: uno dei problemi dell’identità europea non sarebbe quello di disporre, oltre che di una bandiera e di un inno, di una memoria vera comune, di luoghi del ricordo, dove si possano ricomporre le fratture del passato? Non meno vivaci sono le divisioni tra popoli, etnie, gruppi linguistici, a volte mescolati inscindibilmente tra di loro. L’Europa è caratterizzata da una grande pluralità culturale, che proviene da tante eredità, siano esse greca, latina, ebrea, cristiana, musulmana, razionalista. • È possibile costruire una casa comune Eppure la storia di questo mezzo secolo dimostra che è possibile sorpassare le difficoltà e di costruire una casa comune: a un certo momento, in un’Europa distrutta, alcuni uomini di Stato, come Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, hanno preso la decisione politica di dare al Continente un destino nuovo. Uomini dei confini, uomini di fede, cattolici che vivevano la loro fede profondamente, hanno dimostrato che la tragedia non è per forza il destino dell’Europa. Da questo punto di vista, l’evoluzione a partire dagli anni Cinquanta, delle relazioni tra la Francia e la Germania, mostra cosa può fare la volontà politica nutrita dalla fede da cui emerge una certa idea della persona umana. Questa evoluzione maggiore della storia recente dell’Europa conferma che ricominciare è possibile a condizione di sorpassare la memoria, per renderla parte della memoria storica, e grazie a questa dominarla, trasformandola in una base positiva per l’avvenire dei popoli. Non si tratta di dimenticare, ma di storicizzare il passato, attraverso un processo in cui la memoria permetta di controllare le pulsioni collettive e di proteggere dagli eccessi del cosiddetto “dovere della memoria”. Quest’ultimo talvolta diventa una sorta di patologia della memoria, che è cosa diversa perché, come dice Paul Ricoeur, “L’histoire est une volonté de comprendre, Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 33 Jean-Dominque Durand sans accuser”. Qui sta “il lavoro di memoria” sul quale il filosofo insiste tanto, che apre la strada al pentimento voluto da Giovanni Paolo II durante l’anno del Grande Giubileo del 2000, e alla purificazione della memoria. • Culture e Religioni Il periodo attuale sembra paradossalmente segnato: mentre l’allargamento dell’Unione Europea vede la sua realizzazione, una nuova rigidità dei confini viene formandosi. Ad est, la Russia ortodossa con le sue relazioni, sempre complesse, con il Cattolicesimo e con l’Occidente, invita a percorrere di nuovo la storia delle grandi correnti degli intellettuali russi, dallo slavofilismo all’occidentalismo per evitare errori che potrebbero rivelarsi drammatici. Allo stesso tempo, all’interno dell’Unione, è l’ora della diversificazione delle culture: l’Europa è più che mai terra del pluralismo religioso, non soltanto a causa della presenza delle sue religioni storiche (Cristianesimo, Ebraismo, in una certa misura l’Islam), ma anche con l’arrivo delle religioni venute dall’Asia, fino alla riapparizione di un preoccupante neopaganesimo (senza parlare del ritorno ambiguo di un sacro mal definito, del relativismo, delle sette…). Si apre qui la sfida di una rischiosa coabitazione, nel momento in cui l’Europa non costituisce più ormai il centro per le sue religioni storiche, ma un luogo qualunque rispetto a molti altri che hanno assunto una nuova importanza. Un fenomeno sviluppatosi ad un punto tale che si può parlare di un ridimensionamento dell’Europa nell’ambito delle regioni internazionali: l’Ebraismo si è diseuropeizzato mentre l’asse portante del Cattolicesimo si sposta sempre più verso sud, come testimonia del resto l’evoluzione del fenomeno vocazionale. I confini tra le religioni in Europa sono una realtà molto complessa, fatta di un miscuglio di fedi, di liturgie, di appartenenze nazionali o etniche, di memorie storiche e di modi di vivere la memoria che costituiscono una vera sfida alla coabitazione, quintessenza dei problemi del Continente. Ma qui risiede anche il grande successo dell’Europa: nonostante le guerre, le divisioni, i conflitti di ogni genere, il fatto è che l’Europa non si riduce alla razza né alla geografia. Esattamente perché non si lascia facilmente definire, la sua filosofia culturale fondamentale è l’apertura, per portare la sua civiltà al mondo, ma anche per accogliere quelli che si riconoscono nei suoi ideali. Questa è la sua visione universalistica. È europeo chi accetta tale ideale di fraternità universale portata dal Cristianesimo. • L’Europa: una guida per l’umanità Per questa ragione è difficile parlare di una patria europea. Invece l’Europa costituisce nel mondo lo spazio più denso di incontri e di scambi tra i popoli e le tra- 34 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Jean-Dominque Durand dizioni culturali. I confini dell’Europa si trovano in questo intreccio di unità offerto dalla tradizione e dalla cultura giudaico-cristiana, arricchito da tante diversità. Così l’Europa resta un modello, una guida per l’umanità. Paolo VI lo diceva nel 1977 al Consiglio dell’Europa: il Continente «conserva una responsabilità particolare per testimoniare, nell’interesse di tutti, di valori essenziali, come la libertà, la giustizia, la dignità personale, la solidarietà, l’amore universale e reciproco». Come anche affermò Giovanni Paolo II ai presidenti dei Parlamenti dell’Unione Europea il 24 settembre 2000: l’Unione Europea non deve dimenticare che è la culla delle idee di persona e di libertà, e che queste idee scaturiscono dal suo essere stata a lungo impregnata di ideali cristiani. L’Europa si identifica con l’Umanesimo che affonda le sue radici nel Cristianesimo e che si distingue per la centralità della persona e per i diritti umani, dai quali nasce il principio moderno di democrazia nel quale la persona è rispettata per se stessa e partecipa all’opera comune. Ma l’Umanesimo europeo pianta le sue radici anche nella pluralità delle origini dell’Europa che ha portato a tanti conflitti. Denis de Rougemont nota nei suoi Ecrits sur l’Europe, che «cet état de polémique permanente portant sur les principes fondamentaux de toute culture ou civilisation n’a pas produit seulement de l’anarchie et des guerres. La contraint les élites, par elles la partie agissante des masses européennes, à développer ce que je voudrais appeler les trois vertus cardinales de l’Europe: le sens de la vérité objective, le sens de la responsabilité personnelle, et le sens de la liberté». Nei dibattiti sull’adesione di tale o tale Stato, che è poi il piú ampio dibattito sui confini dell’Europa, è quest’umanesimo, questo concetto di persona come Jacques Maritain lo definiva in Christianisme et démocratie, che fornisce la migliore risposta a chi cerca di delimitare l’Europa. Allora i suoi limiti non sarebbero né geografici né politici, ma culturali, provenienti dalla cultura della persona come centro e obbiettivo di ogni costruzione sociale. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 35 Allargamento dell’Europa occidentale o ricongiungimento tra due tradizioni? Il processo di integrazione europea è entrato in una fase notevolmente delicata con l’allargamento (o il ricongiungimento, nell’ottica dei paesi centro-orientali) ad ad un cospicuo gruppo di paesi soprattutto dell’Est del continente, avvenuto senza che l’Unione Europea avesse prima definito con certezza le strutture politiche e istituzionali su cui reggersi in avvenire. • A lungo, in seno alla Commissione esecutiva, nelle tante discussioni sui criteri e sulle dimensioni dell’allargamento, si è ripetuto che esso andava compiuto soltanto dopo l’attuazione della riforma politica dell’Unione Europea. Molti hanno sostenuto la necessità di varare prima una Costituzione europea, ad opera dei vecchi membri dell’Ue, capace di garantire un governo centrale, riducendo i poteri dei singoli Stati, nella prospettiva ultima di giungere, prima o poi, a superare una Europa delle nazioni per fondare una sorta di Stati Uniti d’Europa. Era ben chiaro, a Bruxelles, che prima dell’allargamento dovevano essere poste le solide premesse di un’Europa che, pur in maniera graduale, non costituisse più un insieme di Stati e staterelli gelosi delle loro prerogative sovrane in qualsiasi materia, attirati dalla costruzione brussellese essenzialmente per convenienze economiche e altri vantaggi pratici (come la libera circolazione delle persone). Ma la scelta di subordinare l’allargamento alla riforma interna è poi venuta meno. ROBERTO MOROZZO della ROCCA Università di Roma Tre ≈ “... L’Europa è un continente al plurale e come tale è occidentale e orientale ad un tempo....” ≈ • La scarsa valutazione delle diversità I vecchi membri della Ue hanno ragionato sull’allargamento senza tenere conto delle caratteristiche dei nuovi Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 37 Roberto Morozzo della Rocca membri e della particolare fase storica da essi attraversata. C’era l’illusione che i “nuovi” si sarebbero volentieri e docilmente adeguati agli standard europei occidentali e si sarebbero lasciati assimilare, nell’economia come nella politica, dai vecchi membri. Ma i paesi dell’Europa centro-orientale, già sovietici o di area sovietica, hanno culture nazionali ed esigenze geopolitiche alquanto differenti dai paesi che tradizionalmente compongono il nucleo portante della Unione Europea (ex Cee, e ancor più ex Mec). Lo si è visto chiaramente negli schieramenti strategici creatisi in occasione della guerra irachena. La Polonia, che pure ha gran parte dei suoi scambi commerciali con la Germania e con paesi di area Ue, nella sua politica estera considera ad esempio prioritaria la sicurezza. L’alleanza con l’unica superpotenza mondiale è stata ritenuta a Varsavia molto più pagante che l’addentrarsi nei meandri della burocrazia brussellese per ottenere vantaggi per l’una o l’altra produzione nazionale. Il peso della storia, dimenticato o trascurato dagli europei occidentali, è riemerso prepotentemente nella priorità accordata dai paesi dell’Est all’associazione alla Nato rispetto a quella (dalle modalità peraltro assai più complicate) all’Ue, e poi nella loro adesione, spontanea o allettata che fosse, alla “nuova Europa” di Rumsfeld. Un polacco consapevole della propria storia nazionale ha costantemente il cauchemar del grande orso russo. Secoli di spartizioni e occupazioni sostanziano questo incubo. A Bruxelles forse si era sottovalutato questo dato della storia e altri simili. • Le due facce dell’europeismo C’è una specificità della storia dei paesi dell’Europa centro-orientale che rende la loro adesione alla Ue di natura ben diversa da quella dei paesi dell’Europa occidentale. Si pensi solo che l’europeismo si è affermato, nell’immediato secondo dopoguerra, nel triangolo Bonn-Parigi-Roma, come una reazione alle devastazioni materiali e spirituali del conflitto. In sintesi, come una reazione ai nazionalismi. Nei paesi che stanno ora entrando in Europa, o chiedono di entrarvi, non c’è tanto anelito europeista quanto il desiderio di agganciarsi ad un sistema economico. Dell’integrazione politica, a questi paesi, importa poco o nulla. E ben si può capire. Essi sono reduci da una lotta per l’affermazione della propria sovranità, mortificata dal comunismo sovietico o da altri sistemi multinazionali (si pensi alla Slovenia che ha sostenuto persino una brevissima guerra per emanciparsi da Belgrado). Perché questi paesi dovrebbero essere disposti a sacrificare pezzi della propria sovranità dopo averla appena reintegrata e restaurata? Perché dovrebbero essere paladini di quell’unità politica prefigurata – e richiesta – dall’unità economica del libero mercato interno e della moneta unica? Se Adenauer, De Gasperi, Schuman, pensavano l’Europa come un superamento dei nazionalismi, molti paesi e popoli che ora vi entrano o vorrebbero entrarvi a breve non hanno alcuna intenzione di limare i loro 38 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Roberto Morozzo della Rocca ritrovati nazionalismi. Hanno lottato, talvolta duramente, per poterli esprimere e sbandierare di nuovo. Come sostiene esemplarmente P. S. Wandycz, i popoli di Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia, a differenza dei popoli dell’Europa occidentale, non si sono distinti negli ultimi secoli né per il successo economico, né per genialità scientifica, né per raffinatezza di civiltà, né per elevatezza degli standard giuridici e sociali, bensì per l’incessante lotta per la libertà della patria, per l’amore verso le proprie terre, per il sangue versato in difesa della nazione lottando contro nemici più grandi e più potenti A popoli che hanno questa idea di se stessi, l’Unione Europea vorrebbe ora chiedere di sacrificare, a favore di organismi sopranazionali europei, elementi di sovranità, orgoglio etnico, prestigio nazionale, controllo di settori della vita interna. È manifesto che tali popoli hanno chiesto di partecipare all’integrazione europea per godere dei suoi benefici materiali, non per sottomettersi politicamente a entità superiori. È per entrare nel grande mercato comune europeo e per ricevere aiuti al proprio sviluppo che i nuovi membri dell’Ue hanno accettato di adeguare legislazioni e regole economiche interne. • Europa delle nazioni o stato federale? L’Europa unita dell’immediato futuro non potrà che essere una Europa delle nazioni, rispettosa delle singole sovranità statuali, non uno Stato federale. Ormai, solo il medio o lungo periodo ci dirà la possibilità di realizzare lo Stato federale sognato dagli europeisti della prima ora e, oggi, da quanti vorrebbero un’Europa che conti nel mondo. L’Europa delle nazioni, comunque, non è desiderio dei soli nuovi membri dell’Est. Paesi come la Gran Bretagna desiderano da sempre un’Europa politicamente disunita e impotente, e al tempo stesso economicamente remunerativa. Altri paesi vogliono un’Europa che sia coesa politicamente soltanto a intermittenza, in relazione all’alternanza un po’ ovunque di governi idealmente europeisti e ministeri che invece fanno dell’Europa un luogo dove soddisfare interessi campanilistici. Non sarà il tramonto avvenuto del governo di Aznar, o quello che presto o tardi avverrà del governo di Berlusconi, a sospingere l’Europa ad unirsi anche politicamente. È facile prevedere che altri governi saranno a loro volta indifferenti al processo federativo oppure lo ostacoleranno, preferendo le relazioni con Washington agli impegni con Bruxelles, o ponendo pregiudiziali di sovranità. Si pensi solo ai nuovi membri dell’Europa centro-orientale, così mutevoli nei loro orientamenti. In molti di questi paesi, dal 1989 ad oggi, le maggioranze di governo sono cambiate pressoché ad ogni tornata elettorale. Opposte coalizioni si sono alternate costantemente, e neppure è stato facile capire se fossero più europeiste le destre o le sinistre, perché i dati ideologici e programmatici sono divenuti relativi e prevale il pragmatismo. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 39 Roberto Morozzo della Rocca • Conoscere la complessità del continente Non si deve generalizzare troppo. L’Europa è un mosaico di paesi, di popoli, di culture. Chi vuole lavorare per l’Europa unita deve conoscere questa straordinaria complessità del continente. Evidentemente ogni progresso dell’integrazione europea in senso politico non potrà prescindere da un’opera di faticosa tessitura, di mediazione, di arte del compromesso. Come già è stato negli scorsi decenni per l’economia, anche per la politica non si potrà che seguire un percorso step by step. Il fallimento del 13 dicembre 2003 può servire da lezione di umiltà e di pazienza. Nondimeno lo smacco rimane. Un grave passo falso è stato compiuto e se ne pagheranno le conseguenze quanto alla possibilità di una unificazione politica. L’ultimo, corposo allargamento è stato effettuato in maniera, seppure non frettolosa, quantomeno superficiale, senza una preparazione politica strutturale, senza avere precedentemente deciso una architettura costituzionale definitiva, senza avere demandato sufficienti poteri decisionali ad un governo centrale europeo, senza avere snellito i macchinosi processi di bilancio, senza avere stabilito chiare regole di governabilità che mettessero ai margini le minoranze riottose di volta in volta recalcitranti ai provvedimenti di utilità comune. Occorreva definire in precedenza il quadro istituzionale stabile cui invitare i nuovi membri. E magari, forti di questa preparazione sostanziale, mettere a disposizione maggiori risorse per l’economia dei nuovi membri. Si sono volute le nozze senza la dote, ma il disagio si è ritorto anche sulle famiglie di origine che disorientate dagli atteggiamenti del nuovo parentado, cooptato in blocco nella buona vecchia società. In ogni caso, conviene riflettere sulla necessità di ripensare le relazioni fra le varie identità europee. Ancora si ragiona di Europa occidentale ed Europa orientale, secondo la ripartizione geopolitica esistita fino ai rivolgimenti del 1989. Oggi tuttavia molti popoli che anni fa si classificavano come appartenenti all’Europa orientale affermano di essere occidentali. Così sostengono soprattutto polacchi, cechi, ungheresi, sloveni, croati, albanesi, romeni, lituani, lettoni, estoni. La qualificazione di orientali è intesa da questi popoli come spregiativa. Solo i russi sembrano veramente convinti di non essere occidentali (ma neanche orientali: sono russi). Per un neoslavofilo come Aleksandr Solgenitsin, la Russia non è Ovest e non è Est: è semplicemente la Russia. Sempre più il linguaggio comune occidentale colloca i popoli un tempo attribuiti all’Est Europa in una risorta Europa centrale, o del Sud Est, o del Nord. In ogni caso a Est dei tedeschi e degli italiani c’è una pluralità di popoli diversi, con intrecci e sottoinsiemi etnici e culturali: slavi occidentali e slavi orientali, balcanici e baltici, magiari e romeni. 40 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Roberto Morozzo della Rocca • Quali i confini dell’Europa continente? Non solo l’Est e l’Ovest, ma la stessa estensione geografica dell’Europa non è un concetto stabile. Nella cultura italiana e francese l’Europa giunge fino agli Urali. Ma per i tedeschi l’Europa finisce con la Polonia (secondo frontiere definite politicamente, non geograficamente e storicamente, essendo l’Est europeo definito proprio dall’inesistenza di barriere naturali, dalla continuità di grandi pianure, dalla sovrapposizione e coabitazione di popoli differenti). Anche per i polacchi la Russia è Asia. Al contrario, vi sono russi, partigiani dell’appartenenza del loro paese all’Europa, secondo i quali l’Europa giunge fino a Vladivostok, poiché la civiltà della Russia europea si sarebbe estesa lungo l’Asia senza scolorire i suoi caratteri, fino all’Oceano Pacifico. Giocando sul paradosso, si potrebbe dire che per i polacchi l’Europa orientale non esiste, dal momento che ritengono la Polonia non ne faccia parte, benché il loro Stato confini direttamente, ad Est, con la barbara Asia del nemico russo. Ma i paradossi polacchi potrebbero continuare. Se la Polonia è, come oggi si dice, il più sicuro alleato degli Stati Uniti in Europa, con un legame fortemente e passionalmente sentito, i polacchi possono ben ritenersi i più occidentali e i più atlantici degli europei. E come tali sono recepiti dall’attuale amministrazione statunitense. Evidentemente l’Europa è un continente al plurale e come tale è occidentale e orientale ad un tempo. Scriveva dell’Europa il grande Lucien Febvre nel 1944, nel momento di una delle crisi più violente della sua gestazione: “Vediamo subito che unità europea non è uniformità. Nella storia d’Europa il capitolo delle diversità resta importante quanto quello delle somiglianze”. Febvre non dubitava dell’appartenenza della Russia all’Europa, anzi vedeva nell’espansione russa in Asia un’espansione dell’Europa. Nella sua visione di lungo periodo il fondatore delle Annales notava il ruolo dei russi nel contenimento, col proprio sangue, dei popoli asiatici. Non avendo sopportato il tremendo urto dei tartari e solo in parte quello dei turchi, gli europei d’Occidente non riconoscevano i meriti dei russi. “È la Russia ad alzare il muro, il bastione dell’Europa verso l’Est, contro l’Asia. Solo che gli occidentali questa storia che si svolge laggiù, così lontano, oltre la Polonia, sulle rive del Dnepr e oltre, non la conoscono più. La conoscono male”. Quando le nazioni europee occidentali scoprono le Americhe, si espandono al di là dei mari, colonizzano i continenti, scrive ancora Febvre, “la Russia dei Romanov veglia su di esse a Est. È lei la fedele guardiana della pianura orientale, alle porte della steppa; è lei a […] scagliarsi contro il nemico implacabile e detestato, contro il tartaro e il turco; è lei che non solo ferma sulla sua strada gli orientali sempre tentati dalle ricchezze e dalle facilità dell’Occidente, ma che spinge ancora verso Est, sempre più avanti, una civiltà che dopotutto, nella misura in cui è greca e nordica al tempo stesso, è a pieno titolo una civiltà d’Europa, è la civiltà europea”. A prescindere dai debiti di gratitudine, le differenze esistono. Un esempio Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 41 Roberto Morozzo della Rocca classico riguarda la democrazia. Questa suona diversamente nell’Ovest cattolico e protestante e nell’Est slavo e ortodosso. Ad Occidente, democrazia è sistema politico fondato su dottrina, ragione, opinione comune, libero pensiero. Ad Est è sistema fondato sulle persone. Per un inglese, la democrazia funziona a prescindere dalle persone. Per uno slavo, significa rapporto viscerale con gli esponenti politici. Perché Eltsin o Milosevič sono rimasti così a lungo al potere? C’è un particolare rapporto tra le popolazioni slave e i loro leader. In Occidente, Eltsin e Milosevič sarebbero durati poco. • Le diversità nelle regioni e nel concetto di democrazia Accade in politica, nelle due parti d’Europa, quello che si può osservare nelle due Chiese latina e ortodossa, a proposito della guida spirituale. In Occidente, il fedele cattolico si confessa, e non importa chi sia il confessore, perché importa la dottrina morale che ogni confessore conosce e applica. La teologia morale è il riferimento. Nella Chiesa ortodossa c’è il rapporto personale con lo staretz, il padre spirituale. Il riferimento a una dottrina è scarso, perché lo staretz interpreta i sentimenti, il cuore, ed è tutto. Qui i princìpi, là il rapporto personale. Si capisce poi che la democrazia, nell’Oriente europeo, funziona stentatamente, o almeno la democrazia come noi occidentali la intendiamo. Tutto è personalizzato, le regole sono secondarie. Ma prima di dire che questo è negativo, dovremmo capire che è un tratto della mentalità slava, orientale. Del resto a livello di piccole unità umane, di villaggio, di distretto, sebbene l’antico mir sia scomparso, la democrazia è più compiuta di quanto si immagini, per la solidarietà e l’unità nella popolazione. Il livello statuale dell’Est slavo, invece, agli occidentali appare spesso catastrofico. “Democrazia” ha significati diversi ad Ovest e ad Est. Gli occidentali applicano all’Oriente europeo parametri propri su democrazia, diritti umani, valore della legge, ma non conoscono le società europee orientali che hanno altro rapporto fra individuo e collettività, e altro pensiero (la filosofia, la logica, la dottrina politica sistematica, sono creazioni dell’Occidente, della Francia cartesiana e della Germania hegeliana, e prima ancora di Machiavelli). I fondamenti dell’Europa occidentale, al di là delle radici greche e poi cristiane, si possono rinvenire dal Cinquecento in poi in un discorso politico. Ossia gli occidentali da mezzo millennio tendono a definire se stessi sulla base di una vita politica considerata ragionevole, misurata, regolata, equilibrata, soprattutto libera dal dispotismo. Il termine di confronto tradizionale per gli europei occidentali (l’identità nasce sempre e si rafforza nel confronto col diverso) è l’Asia, considerata il continente del dispotismo, ma anche quanto viene classificato come asiatico e dispotico all’interno dell’Europa (ma Amartya Sen contesta questa idea di superiorità occidentale, sottolineando le profonde radici dell’idea moderna di democrazia presenti anche in altre aree e in altre culture). 42 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Roberto Morozzo della Rocca Alcuni paesi europei non occidentali sono oggi poco attraenti per la Ue in ragione dell’eredità culturale del totalitarismo comunista, dell’asprezza della lotta politica, del manifesto disprezzo di compromessi e sfumature, della scarsa attenzione alle regole, dell’accentuata personalizzazione della politica. • Lo spirito slavo e occidentale In realtà proprio la radicalità nella lotta politica che vede netti vincitori e netti perdenti, che è radicalità nell’affermazione delle proprie ragioni, è connaturata con lo spirito slavo e orientale. È un gusto, è un valore positivo. Tomas Spidlik lo spiega ricorrendo a una metafora artistica: “La grande arte di un politico democratico è di saper trovare un compromesso fra le diverse opinioni opposte, pacificare i contrari, trovare una soluzione accettabile, almeno parzialmente, da tutti. Gli slavi per lo più non possiedono questa arte. Se sono di carattere conciliante, cedono agli altri, ma con tristezza e con la coscienza di aver perduto la causa. Mi pare di poter illustrare questa affermazione con espressioni artistiche. Guardiamo per esempio un quadro del Rinascimento italiano, quante e di quale finezza sono le sfumature dei colori. E nei quadri olandesi, quanti diversi riflessi di luce! Del tutto diversi sono i ricami e gli ornamenti popolari slavi. Qui il rosso è rosso, il blu è blu, il verde è verde. Non vi sono le minime sfumature. E quando il rosso è denso, senza la minima sfumatura, nel russo la parola è divenuto sinonimo di ‘bello’ (krasnyj - krasivyj ).” E ancora: gli europei dell’Est sono genti degli imperi. Sono marcati dall’aver vissuto millenni nel quadro di Stati imperiali: il bizantino, l’ottomano, lo zarista, l’asburgico, il sovietico, lo jugoslavo. L’Impero Bizantino più che millenario è il maggiore impero della storia europea. Negli imperi si ragiona in altro modo che negli Stati-nazione, che nelle società democratiche, che nel mondo della autonomie urbane e borghesi. Negli imperi si vive un forte rapporto con le identità locali (Heimat è termine fondamentale, tanto impregnato di sentimento quanto poco di razionalità). Lo Stato centrale è lontano. La politica è largamente delegata. Nel lungo periodo gli imperi sono strutture più tolleranti degli Stati-nazione, e favoriscono la mescolanza e convivenza di popoli diversi. Ma le genti degli imperi sono impreparate, sprovvedute, dinanzi al nazionalismo e ai problemi degli Stati-nazione. Quando gli imperi crollano, popoli vissuti insieme pacificamente per secoli passano a combattersi furiosamente. Il virus nazionalista dilaga tra le genti degli imperi, come in organismi mai abituati a combatterlo, senza alcun anticorpo. Così è stato nell’Ottocento nei Balcani, poi dopo il 1918, e poi ancora dopo il 1989, per i successivi crolli degli imperi ottomano, zarista, guglielmino e asburgico, sovietico e jugoslavo. Dalle spropositate dimensioni degli imperi si è passati all’opposto, alla frantumazione de- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 43 Roberto Morozzo della Rocca gli staterelli. Sono nati 15 nuovi Stati in Europa centro-orientale dopo il 1989. Lo Stato-nazione creato dagli occidentali nel lungo periodo di secoli, attraverso la complessa gestazione dell’età moderna, e finalmente diffuso ovunque, con l’apparato della cultura francese della Rivoluzione del 1789 e dell’età napoleonica, è stato recepito dagli europei orientali con il consueto radicalismo politico, se non come mito. • I limiti dell’allargamento Certo, un allargamento dell’Europa brussellese fino a Mosca e Kiev, mentre la si estendeva fino a Tallinn e Nicosia, sarebbe stato impensabile: quantomeno per una naturale questione di gradualità nell’aumento delle sue dimensioni corporee. Di fatto, però, l’allargamento attualmente in corso, le cui problematiche vicende fomentano scetticismo sul futuro allargamento a paesi del mondo europeo di cultura cristiana ortodossa come Serbia, Bulgaria, Romania, Ucraina, Bielorussia, Russia, viene ad approfondire ulteriormente una storica e infausta divisione dell’Europa. Tra i nuovi membri dell’Unione Europea vi sono significativamente alcuni paesi cosiddetti slavi occidentali, o per meglio dire slavi cattolici (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia). Nessun paese slavo ortodosso invece è entrato ora nell’Ue. Se non è più la “Cortina di Ferro”, dall’Elba a Trieste, a dividere, sembrano piuttosto farlo le differenze culturali e religiose tra l’Europa occidentale da una parte e l’Europa slava e ortodossa, russa e balcanica, dall’altra. In questo senso una effettiva partizione dell’Europa passa adesso nel mondo slavo, tra slavi cattolici e slavi ortodossi, quasi a riprodurre le frontiere dell’impero asburgico. Anche il circoscritto mondo europeo più tipicamente ex ottomano, o almeno con tracce di quel secolare passato ottomano che certo non usufruisce del marchio di qualità rappresentato per altri dal passato asburgico, rischia di venire allontanato dall’Europa dopo le delusioni e le difficoltà provocate dall’attuale allargamento. Le aspirazioni all’integrazione europea di Albania, Bosnia, Macedonia e Turchia rischiano di essere ulteriormente frustrate. Pesa su questi paesi anche il loro addossamento alle posizioni statunitensi nella politica internazionale, benché Ankara in particolare si sia distanziata da Washington sulla guerra irachena. Dopo la crisi nervosa suscitata a Parigi e Berlino dalla “nuova Europa” trionfalmente vantata da Rumsfeld è difficile immaginare che altri paesi ascrivibili in qualche modo alla “nuova Europa” abbiano ingresso facile a Bruxelles, almeno a breve termine. Tuttavia esistono fattori che motivano e giustificano ulteriori allargamenti. Può l’Unione Europea lasciare fuori dal suo controllo e protezione paesi che rischiano di diventare crocevia di traffici neri di ogni genere? E può ignorare che i processi di allargamento sono per se stessi vettori di progresso civico e risanamento sociale per gli aspiranti nuovi membri? Valga l’esempio di alcuni dei paesi baltici, dove gli standard dei diritti umani lasciavano molto a desiderare quanto al tratta- 44 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Roberto Morozzo della Rocca mento inflitto alle cospicue minoranze russofone. Qui l’adesione all’Ue ha coinciso con il forzato abbandono, fermamente richiesto da Bruxelles, di pratiche pesantemente discriminatorie delle minoranze. Difficilmente a Riga si ripeteranno pubbliche parate di lettoni ex combattenti nelle formazioni Ss naziste, come se ne sono viste negli anni Novanta, e non solo per il naturale progressivo venir meno di una generazione di anziani reduci. • La priorità della preparazione politica In effetti, il problema dell’Ue non deriva dall’allargamento in se stesso, né dalle sue dimensioni, ma nell’allargamento senza adeguata preparazione politica. A Bruxelles alcuni Stati si sono battuti per procrastinare nel tempo gli effetti dell’attuale allargamento, prevedendo minori aiuti economici di quanti se ne siano dati a paesi precedentemente entrati, come il Portogallo o l’Irlanda. E hanno posto clausole limitative della libera circolazione delle persone. Così facendo si è inteso attutire l’impatto dei nuovi ingressi. Ma sarebbe piuttosto occorso predisporre e riformare le strutture della Ue in vista dell’allargamento anziché attuarlo in maniera condizionata per alcuni aspetti psicologicamente impopolari. In questo senso, i problemi non vengono forse tanto dalla fierezza nazionale ed etnica dei nuovi membri, o dal loro americanismo, quanto dall’avere invitato gente in casa prima che la costruzione della casa stessa fosse ultimata. All’Ue, in realtà, conviene allargarsi. Non solo ai nuovi membri del 2003 ma anche a bulgari, croati, serbi, romeni, ucraini, bielorussi, russi, albanesi, bosniaci, turchi… Entrino pure tutti i popoli europei nell’orizzonte dell’Ue, e vi si integrino, beninteso nel rispetto degli standard di diritti umani, e di minimali parametri di politica economica, che verranno loro richiesti. L’Ue nel suo insieme ne otterrà vantaggi economici e maggiore peso internazionale. Tuttavia prima di ulteriori allargamenti occorrerà risolvere il nodo della riforma costituzionale europea non con una soluzione di basso profilo bensì con un accordo tra Stati che conferisca ad un governo centrale europeo almeno alcuni poteri decisionali essenziali. Non fosse che per il governo dell’economia già in parte unificata nei meccanismi e nelle regole. • La coesistenza tra “vecchia” e “nuova” Europa Se esistono una “vecchia” e una “nuova” Europa, come pure esiste una civiltà europea occidentale e una slavo-ortodossa-bizantino-ottomana, ciò non significa che sia ad esse precluso il coesistere, il convivere, il collaborare, l’integrarsi. Possibilmente delegando tratti di sovranità politica ad una autorità federale comune. Di certo non si deve credere a quanto meccanicamente previsto da Samuel Hunting- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 45 Roberto Morozzo della Rocca ton quando profetizza anche sul suolo europeo uno scontro di civiltà. Non a torto, il politologo americano individua un limes tra l’Europa occidentale e l’Europa orientale, che passa per le differenze di civiltà indotte dalle confessioni religiose e dalle demarcazioni asburgico-danubiane. Ma questo limes non implica automaticamente che si vada allo scontro e alla guerra tra europei. Né impedisce la costruzione di una Europa più coesa politicamente, magari facendo tesoro degli attuali insuccessi. Indubbiamente una positiva unità europea potrà realizzarsi solo nel pluralismo. Stefano I re d’Ungheria, poi canonizzato dalla Chiesa cattolica, affermava mille anni fa che “soltanto i paesi deboli e arretrati hanno una sola lingua comune ed un insieme di usi e costumi uniformi”. Ma ciò non gli impediva di sognare grandi aggregazioni di popoli sotto una politica comune. Così come oggi l’attuale pluralismo di popoli e culture non contraddice l’ipotesi di una federazione comune, di Stati Uniti d’Europa. Se una simile federazione, in un prossimo avvenire, prenderà corpo, sarà all’insegna di un grande pluralismo culturale, previa la costruzione di una struttura politica comune come è avvenuto a fine Settecento per gli Stati Uniti d’America. 46 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Il cammino verso il Trattato Costituzionale: luci ed ombre “L’Europa non si farà d’un tratto, né in una costruzione globale. Si farà attraverso realizzazioni concrete, creando, anzitutto, una solidarietà di fatto”. • Queste ispirate parole di Robert Schuman – uno dei “Padri dell’Europa”, pronunciate il 9 maggio 1950 nella notissima Dichiarazione che aprì la strada alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio – sono tornate alla mente di qualcuno in tutta la loro pregnanza profetica, al leggere i rattristati commenti alla mancata approvazione del Trattato costituzionale, a metà dello scorso dicembre. Non ci si sente di condividere gli aspetti negativi di tali commenti, non certo per fare dell’ottimismo ad ogni costo, ma proprio perché il lungo contatto con uomini e cose dell’Europa fa constatare che stiamo attraversando una delle tante fasi di transizione che ci hanno portato fin qui. Alcuni fili conduttori possono aiutarci a ripercorrere il cammino compiuto. Uno di essi si fonda sulla consapevolezza dell’irreversibilità della via sin qui intrapresa. Anche nei momenti più difficili e delicati, quando uno Stato membro attuava la politica della cosiddetta “sedia vuota”, impedendo agli altri di prendere delle decisioni, è sempre stata presente la sensazione che ormai non si potesse tornare indietro sulla strada dell’integrazione europea. V’è poi un’altra constatazione: il cammino dell’integrazione è sempre stato contrassegnato dal difficile contemperamento dell’interesse europeo e degli interessi nazionali. Si va a Bruxelles col desiderio di superare gli ostacoli in nome dell’europeismo, ma poi alla riunione (di qualsiasi livello: Consiglio dei Ministri o semplice comitato di esperti) si cerca in primo luogo di difendere le posizioni del proprio Pae- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 GIORGIO BOSCO Ministro Plenipotenziario già docente di Diritto e Relazioni Internazionali alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma ≈ “... L’Europa si è fatta e si fa a piccoli passi, senza lasciarci scoraggiare da eventuali battute d’arresto...” ≈ 47 Giorgio Bosco se; e dall’incontro delle volontà confliggenti scaturisce il faticoso compromesso, spesso dopo aver fermato gli orologi per proseguire la seduta ad oltranza. Infine – e forse ciò è la conseguenza delle prime due circostanze – l’Europa si sta compiendo e si compie a piccoli passi. In questo mezzo secolo, tutti gli eventi che si sono verificati hanno rispecchiato il coronamento di un lungo e difficile negoziato, ed è uno stato di cose tutt’altro che scoraggiante. Se si riflette sul fatto che per secoli gli Stati europei si sono fatti la guerra l’un l’altro (tra le tante, la guerra dei Cento anni, la guerra dei Trent’anni, la guerra di successione spagnola, la guerra di successione austriaca) e che dal Medioevo in poi è stato un susseguirsi di conflitti, l’odierna Unione Europea appare un vero e proprio miracolo. • Le “ombre” dei grandi padri Europa a piccoli passi, dunque; Europa che al momento supremo di darsi una Costituzione e di realizzare un’unione quale mai si era vista dai tempi di Carlo Magno, ha esitato ed ha avuto una battuta d’arresto. Ma la grande ombra di Robert Schuman – e con lui quelle di Adenauer, De Gasperi, Jean Monnet – ci invitano a non disanimarci per questo. E il nostro Paese, non mancherà di contribuire al rilancio dell’impresa e al compimento del prossimo passo. Non dobbiamo infatti dimenticare la nostra profonda vocazione europeista, che risale – tralasciando epoche più remote – ai tempi del famoso Manifesto di Ventotene, redatto in piena guerra, nel 1941, da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, ed intitolato Per un’Europa libera ed unita. Nel 1943 fu costituito il Movimento federalista europeo, che come tale non era solo italiano, ma aveva ramificazioni in altri Stati d’Europa, e che per molti anni fu ispirato e guidato da Spinelli (chi non ricorda con nostalgia le amabili riunioni di Strasburgo del “Club du Crocodile”?). La vocazione europeista italiana si è sempre confermata nel corso degli anni e, in certi momenti, l’Italia è stata addirittura determinante per la ripresa del processo d’integrazione: basti qui rammentare la felice ispirazione di Gaetano Martino, che nel 1955, dopo il fallimento della Ced, convocò la Conferenza di Messina, ormai passata alla storia come “la Conferenza del rilancio europeo”. E non fu certo un episodio isolato: in tempi recentissimi, citiamo l’iniziativa della nostra dichiarazione, condivisa dalla Francia e dal Belgio ed annessa al Trattato di Amsterdam del 1997, in cui si legge: “Belgio, Francia ed Italia osservano che il Trattato di Amsterdam non soddisfa la necessità di un sostanziale progresso verso il rafforzamento delle istituzioni”. • La vocazione europeista dell’Italia Fin dall’approvazione dell’Atto Unico, l’Italia ha manifestato il suo desiderio di un rafforzamento delle istituzioni. Questo conferma che la vocazione europeista 48 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Giorgio Bosco italiana non è di facciata, ma profondamente sentita. Se non avesse realmente rispecchiato le intenzioni del Governo, del Parlamento e del popolo italiano, questa aspirazione non avrebbe resistito per mezzo secolo e al susseguirsi di una cinquantina di governi. Certo, anche una vocazione europeista così spiccata come quella dell’Italia, avrà difficoltà in questo particolare momento, in cui i problemi della svolta costituzionale si sommano a quelli dell’allargamento. Forse l’esperienza dell’ultimo trentennio (il 1973 è l’anno del primo allargamento), avrebbe potuto suggerire di diluire nel tempo i nuovi ingressi, che in passato si sono svolti alla spicciolata: 1973 (Regno Unito, Danimarca e Irlanda); 1979 (Grecia); 1985 (Spagna e Portogallo); 1995 (Austria, Svezia e Finlandia). Si sarebbe probabilmente attenuato il contrasto che ha provocato la battuta d’arresto sul problema della maggioranza nelle votazioni: ed è un vero peccato che il criterio della doppia maggioranza non sia passato fin dall’inizio, perché esso, nel tener conto dell’elemento della consistenza della popolazione, introduceva per la prima volta un sistema più democratico, basato sui popoli oltre che sugli Stati. Processo decisionale, adozione delle decisioni: punto critico, che questa volta ha rappresentato la pietra d’inciampo. E che il punto sia fondamentale, basterebbe a dimostrarlo l’abbondanza degli studi al riguardo, di cui per brevità citiamo solo due esempi. Il primo è fornito dall’Eipa, l’“European Institute for Public Administration”, importante istituzione con sede in Maastricht, che ogni anno organizza quattro seminari interdisciplinari sulla questione del processo decisionale in seno all’Unione Europea. Il secondo vede come protagonista il Collegio Europeo di Parma, che nel giugno 2003 ha indetto una ricerca sul tema “Chi deve governare l’Unione Europea e in che modo”. • Europa liberale o dirigista Governare, decidere, ma per raggiungere quale risultato? Verso che tipo di Europa ci orienteremo: liberale o dirigista? Ecco il grande dilemma, ecco le “due anime” dell’Europa, che ne hanno accompagnato la vita fin dall’inizio, come già nel 1958 non era sfuggito a Wilhelm Roepke, uno degli artefici del modello economico della Germania del dopoguerra, la cosiddetta “economia sociale di mercato”. Nel suo saggio “Jenseits von Angebot und Nachfrage”, pubblicato a Zurigo, egli vedeva nelle istituzioni comunitarie la via verso una pianificazione economica e politica generalizzata, un saintsimonismo su scala europea che avrebbe potuto essere molto più pericoloso della pianificazione a livello nazionale. V’è, effettivamente, una visione dell’Unione Europea come replica su scala continentale degli Stati nazionali, come nuovo luogo e nuova fonte della sovranità nel nostro continente, dove i Membri dell’Unione, i loro governi e i loro parla- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 49 Giorgio Bosco menti dovrebbero diventare l’equivalente di quelli del Nevada o della Louisiana negli Stati Uniti. Ma v’è pure chi ha una visione opposta, e senza naturalmente prendere partito per l’una o per l’altra, vorremmo qui farne una breve analisi. Chi manifesta favore per un’Europa non dirigista, non si nasconde che da una visione obiettiva risulta che l’Europa è oggi in declino. Lo è dal punto di vista materiale, con economie caratterizzate da una crescita debole e da un’alta disoccupazione. Lo è dal punto di vista demografico, con una popolazione stagnante e che invecchia rapidamente. Lo è dal punto di vista scientifico e tecnologico, campi in cui il primato che aveva sino agli anni Trenta non è stato più raggiunto, se non in aree e settori limitati. Lo è dal punto di vista della capacità di condurre una politica estera e di difesa adeguata alla protezione dei suoi interessi vitali. Di fronte ad un tale stato di cose, il problema del ristabilimento del primato europeo richiede che lo sviluppo dell’Unione Europea sia guidato non dalle contingenze del compromesso, ma da una visione politica precisa. • Quale visione politica unitaria? Quale può essere questa visione politica? Evidentemente è qui il punto cruciale, sul quale è aperto il legittimo e democratico confronto di opinioni: confronto in cui non può mancare la consapevolezza di un’essenziale innovazione introdotta dal Trattato di Maastricht, e cioè quella del concetto della sussidiarietà (art. G 5 del T.U.E.). La sua applicazione è vista come garanzia che l’Unione manterrà un carattere decentrato, e che non si trasformerà in una riedizione su scala continentale dello Stato-nazione. Giova qui ricordare che la sussidiarietà non è un concetto classico della politica, ma deriva dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica. La sua formulazione più chiara è forse data nell’Enciclica Quadragesimo Anno di Pio XI (1931): “Siccome non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si puoi fare”. Il concetto è stato poi ribadito dalla Pacem in Terris (1968) e dalla Centesimus Annus (1991). Nell’Unione Europea il principio di sussidiarietà non è di facile applicazione. Resta sempre una questione interpretativa lo stabilire se “gli obiettivi dell’azione prevista” (come si esprime il citato art. G 5) possano essere meglio ottenuti attraverso un’azione a livello nazionale o un’azione a livello dell’Unione. Vantaggi e svantaggi dell’azione collettiva a livello dell’Unione devono venire valutati e comparati con i vantaggi e gli svantaggi dell’azione a livello dei singoli Stati, e non è agevole precisare in che modo stabilire il bilancio finale. Come che sia, v’è da sperare che una corretta applicazione del principio di sussidiarietà ci liberi in futuro da direttive aberranti, sul tipo di quelle adottate sulla larghezza delle gabbie per le 50 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Giorgio Bosco galline ovaiole o sul colore dei fari delle automobili: normative che spiegano la disaffezione e il malcontento dei cittadini europei nei confronti delle istituzioni comunitarie, come risulta dai vari sondaggi di opinione effettuati da Eurobarometro. • La ricerca di una identità europea D’altro canto, i fautori di un’Europa maggiormente “decisionista” potrebbero essere confortati nelle loro prese di posizione se fosse possibile stabilire i contorni e le caratteristiche di una “identità europea”. Ma esiste un’identità europea? V’è un “quid” per cui un cittadino di Stoccolma ed uno di Palermo possano entrambi sentirsi europei? L’Ambasciatore Roberto Ducci, che tanto aveva operato per l’edificazione della costruzione europea fin da prima dei Trattati di Roma, ci ha lasciato un profondo saggio, scritto a quattro mani con Bino Olivi, dal titolo L’Europa incompiuta. Rileggendolo, mi sono domandato se l’identità europea non si celi proprio in quel senso di incompletezza, nel non sapere esattamente che Europa vogliamo. È questa una domanda che si pone a tutti i livelli. Essa si ritrova nel titolo del volume che raccoglie i vari contributi dei partecipanti all’annuale incontro italotedesco di Villa Vigoni nel 2002, titolo emblematico: Welche Europa?, Quale Europa?. Gli scritti, non che risolvere, pongono dei problemi, come quello del Presidente Federale Johannes Rau, da cui cito un brano: “Quale immagine dell’Europa hanno coloro che vi arrivano dalla Turchia o dalla Tunisia? Che immagine ha dell’Europa il musulmano ortodosso che viene nell’Occidente cristiano? Cosa penserà un giovane tedesco che si rende conto che la prima persona nella quale fede e vita quotidiana coincidono è un musulmano? E che conseguenze avrà tutto ciò in un’Europa che ha vissuto fratture così profonde? Come vogliamo creare l’Europa? Deve essere l’Europa della riforma protestante e dell’Illuminismo? È così tedesca come sembra? Oppure è l’Europa della filosofia classica e del diritto romano? O quella del liberalismo nordico?”. È una serie d’interrogativi, un richiamo molto severo a riflettere sugli errori commessi e sui correttivi da apportare. Dopo il lungo esercizio della Convenzione prima, della Conferenza Intergovernativa poi, ci si potrebbe chiedere se il progetto di Trattato Costituzionale possa aiutare a stabilire il concetto di identità europea, e quindi riassumiamo brevemente il contenuto del documento. • Lo “schema” della Convenzione Esso è suddiviso in quattro parti. All’inizio, un preambolo richiama i principi fondamentali su cui l’Unione poggia le proprie basi ed evidenzia gli obiettivi che Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 51 Giorgio Bosco la stessa si pone; ribadisce che l’Europa è un continente che, forte della propria diversità e delle proprie radici culturali, religiose ed umanistiche, riconosce la fondamentale importanza del ruolo della persona umana, dei diritti inviolabili e del rispetto del diritto. Partendo da queste premesse l’Unione si fa portatrice di civiltà e di prosperità per tutti i suoi cittadini, si impegna ad accrescere il carattere democratico e trasparente della sua vita pubblica e, facendo leva sul valore aggiunto che le proviene dalle diverse identità nazionali dei popoli che la compongono, assicura il proprio impegno a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo. La Parte I, a differenza dalle altre tre, non ha un’intitolazione, di guisa che per comprenderne il contenuto occorre riferirsi ai nove titoli in cui è divisa, e che abbracciano nozioni generali: definizione e obiettivi dell’Unione, sue competenze e istituzioni, le cooperazioni rafforzate, la vita democratica dell’Unione, ed altre. La Parte II contiene la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione, che come è noto, era già stata approvata dal Vertice di Nizza del dicembre 2000, e che dopo l’inserimento nel Trattato Costituzionale, diverrebbe parte integrante, e perciò vincolante, dei Trattati dell’Unione. Tra la Parte II e la Parte III si situano tre importanti Protocolli: il primo, sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione Europea; il secondo, sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; il terzo, sulla rappresentanza dei cittadini nel Parlamento europeo e sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio Europeo e al Consiglio dei Ministri. Nella Parte III, “Le politiche e il funzionamento dell’Unione”, confluiscono quelli che salavano essere denominati i tre pilastri, ossia le varie politiche economiche comuni, la politica estera e di sicurezza comune, e lo spazio di libertà sicurezza e giustizia. È un imponente “corpus” di 338 articoli, che accorpano in un testo unico tutta. la normativa esistente, da Roma a Maastricht, da Amsterdam a Nizza. Seguono tre allegati: un progetto di Protocollo che modifica il Trattato Euratom, un Protocollo sul gruppo Euro e una Dichiarazione sulla creazione di un Servizio europeo per l’azione esterna. Infine la Parte IV s’intitola “Disposizioni generali e finali”, che concernono il campo d’applicazione, la ratifica, l’entrata in vigore e le altre usuali norme poste a conclusione di un trattato. • I segni dell’identità dell’Europa nella Carta dei Diritti Orbene, dall’insieme di questo “acquis communautaire” potremmo forse ricavare che ciò che dà un’identità all’Europa è il suo patrimonio spirituale e morale, fondato sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, nonché sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto: tutto ciò è racchiuso nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. 52 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Giorgio Bosco La Carta rappresenta il punto d’arrivo di un lungo processo che ebbe inizio il 12 aprile 1989, quando il Parlamento europeo approvò, con voto unanime, la “Dichiarazione dei Diritti e delle Libertà fondamentali” in 28 articoli, annessa ad una risoluzione recante lo stesso titolo. Nel lungo cammino dell’umanità verso un sempre maggiore rispetto della persona umana, questo documento rappresenta una pietra miliare. Non a caso, esso fu elaborato nel bicentenario della Rivoluzione Francese e conseguente “Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen”. Visto a posteriori, esso assume una luce significativa. Qualche mese dopo, crollava il Muro di Berlino e con esso tutto un sistema che offendeva e mortificava la dignità umana, quella dignità la cui inviolabilità è proclamata all’articolo 1 della Dichiarazione. Dalla Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conclusa nell’ambito del Consiglio d’Europa, alla Carta di Nizza del dicembre 2000, è trascorso mezzo secolo, durante il quale si è assistito ad un’evoluzione della problematica, ed all’affermarsi di nuovi valori. Data la limitatezza della mente umana, che nel suo sforzo di sistematizzazione ha bisogno di procedere per schemi e per categorie (anche se talvolta è difficile dividere dei concetti con un taglio netto) soccorre qui la dottrina del noto studioso Karel Vasak, il quale teorizza l’esistenza di tre generazioni di diritti umani. La prima consiste nei diritti civili e politici dell’individuo, che lo Stato non deve violare, così come non deve conculcare la libertà di pensiero, di religione ed altre per le quali John Locke manifestava il timore degli abusi statali. La seconda generazione di diritti umani sono quelli economici, sociali e culturali: diritto al lavoro, alla sanità, all’istruzione, ed altri. A differenza di quelli di prima generazione, per i quali si chiede allo Stato un atteggiamento di “non facere”, cioè di astenersi da violazioni, per questi si chiede allo Stato una condotta positiva, consistente nell’adoperarsi per fornire all’individuo certi diritti economici e sociali. La terza generazione di diritti umani è basata sul concetto di solidarietà. Essi includono il cosiddetto diritto allo sviluppo, il diritto alla pace, ad un ambiente sano, nonché quello di partecipare al godimento del patrimonio comune dell’umanità, ed altri che potranno via via essere elaborati. Si può, quindi, dire che con i suoi 54 articoli, che spaziano nei campi più svariati, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea abbraccia completamente le tre generazioni di diritti umani, cui abbiamo ora accennato. • L’Unione e la Convenzione di Roma Vi è, però, un punto critico, che a nessuno sfugge: quello della relazione, del coordinamento tra le istanze dell’Unione Europea e il sistema di Strasburgo di tutela dei diritti umani, nel quadro del Consiglio d’Europa. Se ne è preoccupato il Parla- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 53 Giorgio Bosco mento Europeo, il quale ha recentemente confermato la sua nota posizione, secondo cui l’Unione Europea dovrebbe sottoscrivere e ratificare la Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 e tutti i suoi protocolli, avendo peraltro presente alla mente il parere consultivo n. 2/94 emesso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Ciò, tuttavia, non dissiperebbe il timore che se l’Unione divenisse Parte contraente della Convenzione di Roma, si rischierebbero conflitti e sovrapposizioni tra le Corti di Lussemburgo e di Strasburgo. In passato, quando ancora esisteva la Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo (abolita a seguito della riforma del 1998) questo organo, normalmente, si pronunciava in senso contrario alla sindacabilità, da parte di Strasburgo, di atti comunitari o di norme facenti parte dell’ordinamento comunitario. In presenza di ricorsi contro norme comunitarie, quindi, la Commissione li dichiarava irricevibili. Questo atteggiamento era basato su di un giudizio di sostanziale equivalenza tra le garanzie in materia di diritti fondamentali, assicurate dalla giurisdizione comunitaria, e quelle offerte dal sistema della Convenzione di Roma del 4 novembre 1950. Con la nuova Corte istituita dopo la riforma, per la prima volta si è avuta una pronuncia di condanna di uno Stato membro dell’Unione Europea in relazione a norme ed atti comunitari. È il caso della sentenza Matthews (18 febbraio 1999), con cui il Regno Unito è stato condannato per una violazione della Convenzione di Roma, derivante da un comportamento tenuto da quello Stato in adempimento di una disposizione del diritto comunitario. • Due casi critici Ma v’è di più. Recentemente sono stati presentati alla Corte europea dei diritti dell’uomo due ricorsi individuali (Guérin Automobiles e Dsr Senator Linea) contro tutti i 15 Stati membri dell’Unione Europea, in relazione a decisioni a suo tempo prese dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia nel quadro dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza; decisioni dalle quali i ricorrenti allegano di essere stati lesi nei propri diritti fondamentali. Questi due casi si presentano ancor più critici del caso Matthews. In quest’ultimo erano in discussione i comportamenti di un singolo Stato membro, in attuazione di una norma di diritto primario. Nei casi in questione, invece, sono messi in gioco direttamente atti delle istituzioni, sia pure attraverso un ricorso indirizzato a tutti gli Stati membri. Vengono a confronto due diversi sistemi di tutela, con rischio di conflitti tra la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte di Giustizia delle Comunità europee. Vi è, peraltro, da confidare che tali difficoltà possano essere sormontate. Il cammino verso l’integrazione europea non è stato e non è facile, e il ricordo dei numerosi ostacoli superati fa bene sperare per il futuro. 54 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Giorgio Bosco • Il contributo del semestre italiano In questa ottica si era posto il programma di obiettivi prioritari da tener presenti durante il semestre di presidenza italiana, da poco concluso. Le mète a cui tendere erano innanzitutto la Conferenza Intergovernativa, poi il perseguimento degli scopi fissati dalla strategia di Lisbona, che mira a rendere l’economia europea la più dinamica del mondo entro il 2010. Inoltre, proseguire nel cammino verso il completamento del grande processo di unificazione europea, nonché verso un più consono bilanciamento del peso specifico dell’Unione, trasponendone l’attuale asse verso le aree meridionali del continente e rilanciando il partenariato euro-mediterraneo (il cosiddetto “Processo di Barcellona”), nell’intento di coinvolgere più a fondo le due sponde del Mediterraneo in comuni progetti di sviluppo. Altro importante obiettivo, continuare ad adoperarsi affinché l’Europa diventi un soggetto forte ed autorevole sul piano internazionale, che si esprima con una sola voce ed intervenga nelle principali aree di crisi del pianeta, ai fini del mantenimento della sicurezza e della pace nel mondo. Per raggiungere questo obiettivo, l’Europa deve dotarsi di adeguate capacità nel campo della difesa, in un rapporto sinergico e non antagonistico con le strutture dell’Alleanza Atlantica. Sul piano interno, obiettivo del nostro semestre di Presidenza era di rafforzare la sicurezza dei cittadini europei mediante la lotta al terrorismo internazionale accompagnata da efficaci misure di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e all’immigrazione clandestina. Ciò, attraverso il costante e coordinato controllo delle frontiere esterne, la definizione di norme comuni in materia di asilo, l’intensificazione dei rapporti di collaborazione con i Paesi di origine o di transito dei flussi migratori ed il miglioramento della cooperazione tra Stati membri dell’Unione nel settore dei visti. Del programma qui brevemente riassunto, molto è stato fatto; parecchio rimane da fare. Secondo quanto avevamo constatato all’inizio, considerando mezzo secolo di storia dell’integrazione europea, l’Europa si è fatta e si fa a piccoli passi, senza lasciarsi scoraggiare da eventuali battute d’arresto. E, prima o poi, il Trattato costituzionale non mancherà agli appuntamenti delle ratifiche e dell’entrata in vigore. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 55 Una questione attuale: il futuro del’Europa L’Europa si trova davanti ad un dilemma insuperabile tra costruzione comunitaria e sovranità nazionali? Questa appare agli occhi di molti la principale questione politico-istituzionale che emerge dagli scontri intorno alla “carta costituzionale” europea o al patto di stabilità. Da una parte, i difensori delle prerogative del Consiglio e dall’altra quelli della Commissione, da una parte i seguaci del metodo intergovernativo e dall’altra le vestali del federalismo. Tertium non datur e poiché viviamo in una stagione che esalta gli egoismi degli individui e delle nazioni, si pensa che o l’Unione Europea riuscirà, nel migliore dei casi, a sopravvivere stentatamente o i paesi europei confluiranno in ordine sparso in una più vasta identità occidentale a guida americana, ora che gli Stati Uniti hanno abbandonato il loro antico sostegno al processo di integrazione europea. • Apparentemente, dunque, niente di nuovo sotto il sole. L’alternativa tra federalismo e funzionalismo ha, infatti, accompagnato il percorso europeista fin dalle origini e in concreto l’integrazione europea è cominciata solo quando il sogno federalista degli Stati Uniti d’Europa è stato formalmente accantonato. Si tratta di una scelta poi confermata successivamente dal fallimento, nel 1954, della progettata Comunità Europea di Difesa, che ha aperto la strada alla fondazione, nel 1957, del Mercato Comune Europeo, una creatura decisamente funzionalista, da cui è poi sorta, sempre attraverso negoziati multilaterali, l’attuale Unione Europea. L’alternativa tra il metodo del negoziato intergovernativo e quello incentrato sulla costruzione di istituzioni sovranazionali non costituisce dunque una novità e probabilmente non Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 AGOSTINO GIOVAGNOLI Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ≈ “... Il futuro dell’Europa è un problema sempre più collegato anche alla questione della sua collocazione nel mondo...” ≈ 57 Agostino Giovagnoli si trova qui il principale problema che il processo di integrazione europea si trova davanti. Tale dilemma, infatti, non ha impedito, fino ad oggi, di raggiungere risultati sempre più rilevanti. Si tratta di un’alternativa indubbiamente molto importante sotto il profilo istituzionale ma non altrettanto decisiva sotto quello politico e soprattutto, ciò che più conta nel lungo periodo, sul piano storico. La scelta di seguire la strada dei piccoli passi realizzando di volta in volta solo le cose possibili è stata avversata dai federalisti, che l’hanno considerata un’opzione minimalista, decisamente al di sotto delle loro aspettative: la comune gestione del carbone e dell’acciaio o il coordinamento delle politiche agricole sembrava poca cosa rispetto ai loro sogni di unificazione europea. In questo modo, però, è stato possibile fare molta strada: ogni volta che sorgevano impedimenti o si verificavano insuccessi, il percorso dell’integrazione ha poi ripreso a svilupparsi, magari cambiando strada o adottando metodi nuovi. • Integrazione aperta La pratica funzionalista, inoltre, ha lasciato aperta la questione dell’unificazione europea, senza pregiudicare l’esito finale, che viceversa il massimalismo dei federalisti avrebbe messo in pericolo imponendo passaggi prematuri. I protagonisti del processo di integrazione europea sono stati in genere molto attenti ad impedire che venissero introdotti limiti insuperabili o preclusivi di ulteriori sviluppi. Tale attenzione non è stata casuale. In molti casi, infatti, la via funzionalista non è stata percorsa dai governi europei in opposizione all’obiettivo finale, di giungere, prima poi, a un’unione completa sotto tutti i profili: istituzionale, politico, economico, sociale, culturale… Molto spesso, tale opzione è stata praticata in un’ottica implicitamente federalista: vari attori del processo di integrazione europea l’hanno considerata il solo modo concreto di mantenere aperta la speranza di realizzare, prima o poi, gli Stati Uniti d’Europa o qualcosa di simile. La collaborazione tra Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli appare in questo senso eloquente. Invece che pretendere tutto e subito, ai loro occhi è sembrato meglio realizzare di volta in volta qualcosa, anche a costo di deludere molti, per preparare però un risultato finale più pieno: dopo che fossero stati costruiti molti piani, gli oppositori dell’unificazione europea non avrebbero potuto più impedire il completamento dell’edificio. Lo confermano anche i risultati finora raggiunti, che in molti casi hanno comportato una limitazione delle sovranità nazionali: il passaggio alla moneta unica europea ne costituisce l’esempio più clamoroso ma non l’unico. Si deve, insomma, riconoscere che se il cammino dell’unificazione è andato avanti, ciò è avvenuto perché il metodo funzionalista è stato costantemente accompagnato, sfidato, innervato dal sogno federalista o da un sogno assai simile a quello dei federalisti. 58 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Agostino Giovagnoli • L’equilibrio tra realismo e utopia La via all’unificazione europea è stata funzionalista nelle scelte concrete, ma la volontà di andare sempre avanti è stata alimentata da una speranza incondizionata non inferiore a quella dei federalisti: l’integrazione europea si è concretamente realizzata mantenendo costantemente un equilibrio difficile ma essenziale tra realismo e utopia. Al di là del metodo impiegato e delle scelte compiute, infatti, anche lo spirito che ha animato l’uno e le altre ha avuto un concreto rilievo storico. Ma tale spirito è ancor oggi operante? Il dibattito sul sogno europeista – ancora vivo e attuale oppure vuoto simulacro di un passato definitivamente tramontato – non costituisce in questo senso una mera esercitazione accademica, come dimostrano le polemiche che periodicamente tornano ad emergere su questo terreno. Proprio nel momento di crescita tanto rilevante con l’ingresso di importanti paesi dell’area orientale del continente, l’Europa comunitaria sembra aver perso lo slancio che in passato ne ha sorretto lo sviluppo. In passato, non tutto è stato facile e lineare. Anzi. Si è già ricordato il fallimento della Comunità Europea di Difesa bloccata da un vento nazionalista ancora forte nell’Europa degli anni Cinquanta, più tardi la politica gaullista ha bloccato a lungo l’allargamento dell’Europa e successivamente la Gran Bretagna ha lavorato spesso per frenare, dall’interno, l’integrazione europea. Ma, presto o tardi, tutti i diversi ostacoli sono stati superati e il percorso è sempre ripreso verso traguardi più impegnativi. • Le difficoltà sul cammino comune Negli ultimi anni, invece, tutto è sembrato sempre più difficile, proprio mentre antichi impedimenti venivano meno e l’Europa è apparsa sempre più evanescente proprio mentre da tante parti si invocava la presenza di un più forte soggetto europeo. I singoli governi nazionali hanno cercato di imporre il loro punto di vista, anche a costo di restare isolati e di compromettere il cammino comune, pur di conservare qualche specifico vantaggio. Hanno poi pesato negativamente le assenze dell’Europa sul piano internazionale, ad esempio per quanto riguarda i Balcani o il Medio Oriente, e la facilità con cui gli europei si sono divisi sulla questione dell’Iraq. Più di tutto, ha influito una crescente diffidenza verso una costruzione sovranazionale che inevitabilmente pone limiti alle sovranità nazionali proprio quando tali sovranità sono in declino per effetto della globalizzazione e sempre più gli Stati nazionali possono difendere i loro interessi estendendo le aree di cooperazione. Insomma, qualcosa sembra essersi rotto proprio quando sono venute meno le ragioni dell’antica resistenza nazionalistica contro i disegni federalistici e mentre le circostanze della storia obbligano gli europei a coltivare progetti sempre più am- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 59 Agostino Giovagnoli biziosi. Ma ai sogni non si comanda e proprio quando è apparso sempre più ragionevole sognare l’Europa unita, gli europei si sono rifiutati di prendere in mano il loro futuro, scivolando in un ripiegamento autodistruttivo. • L’Europa ha un’anima Qualcuno si è chiesto se l’Unione Europea abbia perso la sua anima. È una domanda singolare sotto il profilo politico e si potrebbe considerarla non pertinente: che ha che fare l’anima dell’Europa – un’entità peraltro molto difficile da definire – con il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo o con il sistema di voto e la composizione della Commissione Europea? Si tratta però di un interrogativo direttamente collegato alla sensazione che l’Europa sia esposta oggi a rischi più gravi di quelli corsi in passato, suscitata da carenze, contraddizioni, defaillances dei principali attori del processo di integrazione europeo che emergono con tanta frequenza da far dubitare della reale volontà di questi attori di proseguire sulla strada intrapresa. Ci si chiede con preoccupazione, se la Germania, fin dalle origini, tra i più convinti sostenitori del processo di integrazione europea, sia ancora su questa linea, se l’asse franco-tedesco, per molti anni vero “motore” di questo processo, giochi oggi a favore o contro nuovi sviluppi, se l’Italia sia diventata euroscettica e così via. In questo senso, la maggiore novità rispetto al passato sembra costituita non tanto dallo scontro tra federalisti e intergovernativi, che c’è sempre stato, ma dalle incertezze degli attuali governanti dei diversi paesi europei, i quali paiono meno disposti di quanto lo siano stati i loro predecessori a impegnarsi nella prospettiva europea per paura di “bruciarsi”. Non sono, insomma, le difficoltà e i problemi a preoccupare ma una troppo debole volontà di superarli: la questione dell’anima dell’Europa, in questo senso, non è né marginale né peregrina. • Passato e presente Il confronto con il passato è inevitabile. Indubbiamente, la costruzione di istituzioni comunitarie è stata avviata, subito dopo la seconda guerra mondiale, da padri fondatori – come Monnet, Schumann, Adenauer, De Gasperi – animati da lucida consapevolezza storica, grande spinta ideale e convinzioni fermissime riguardo alla necessità di avvicinare tra loro i diversi Stati europei. Grazie alla loro ferma volontà e al sostegno dei partiti politici di cui erano alla guida, i padri fondatori dell’Europa sono riusciti a prevalere sulle opinioni pubbliche dei diversi paesi europei, allora ancora fortemente animate da passioni nazionalistiche. Si deve invece ritenere che gli attuali uomini di governo siano meno europeisti e più nazionalisti dei loro predecessori? Stanno davvero lottando per affermare le rispettive sovranità na- 60 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Agostino Giovagnoli zionali contro le “ingerenze” delle istituzioni comunitarie? Negli ultimi cinquant’anni, la capacità di presa del principio di sovranità nazionale è andata progressivamente declinando, in Europa come in tutto il mondo, per motivi diversi dall’integrazione europea, in seguito ai cambiamenti nelle relazioni internazionali e allo sviluppo dei mercati. Se oggi fossero davvero in corso tentativi di riportare la sovranità nazionale agli splendori del passato, tali tentativi sarebbero destinati al fallimento: è difficile perciò ritenere che gli uomini politici europei stiano davvero rincorrendo simili illusioni. • I vantaggi dell’Europa unita In realtà, non esistono oggi contrasti insuperabili tra interessi nazionali e integrazione europea: la costruzione di un’Europa unita e forte è vantaggiosa per tutti i popoli e per tutti gli Stati europei. Il vero problema non è dunque la propensione nazionalistica delle classi dirigenti europee ma la loro debolezza rispetto ad opinioni pubbliche contraddittorie, insieme più esigenti e più preoccupate di quanto lo fossero in passato. Mentre i padri fondatori hanno imposto il loro progetto di unificazione europea all’interno dei loro paesi ancora permeati da una tenace spinta nazionalistica, grazie alla lezione tremenda sull’esito dei nazionalismi rappresentato dalle due guerre mondiali, oggi i governanti europei si trovano davanti ad elettori che vogliono un’Europa più capace di far sentire il proprio peso sul piano internazionale e che al tempo stesso temono di perdere sempre più la loro capacità di influenzare decisioni relative alla loro esistenza quotidiana. È uno dei paradossi della globalizzazione, che da una parte rende sempre più impaurite, incerte e miopi le opinioni pubbliche nazionali, dall’altra rende sempre più urgenti convergenze internazionali e istituzioni sovranazionali. Tra le conseguenze c’è anche quella che spesso, dietro lo scontro sul patto di stabilità o sul sistema di voto, non ci siano contrastanti disegni d’insieme sull’architettura delle istituzioni europee o sul futuro dell’Europa. Se fosse in corso un dibattito così elevato tutto sarebbe più semplice: anche in presenza di contrasti fortissimi intorno a visioni opposte, infatti, ci sarebbe comunque un interesse comune più forte, destinato prima o poi ad imporsi, come è avvenuto in passato tra federalisti e funzionalisti. Invece, prevalgono altri fattori più limitati e contingenti, come la rielezione di questo o di quel leader o il successo di questo o di quel partito, in uno o nell’altro degli Stati europei. • I progressi dell’Europa unita Dietro le scelte o le non scelte delle classi dirigenti c’è dunque il problema degli umori delle popolazioni europee. L’emergere di tale problema rappresenta anzitut- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 61 Agostino Giovagnoli to un successo del processo di unificazione: da un’idea d’Europa condivisa da pochi spiriti illuminati si è passati a un’identità europea concretamente percepita da milioni di persone. Sotto il profilo storico, si tratta di uno dei risultati più rilevanti del cammino percorso negli ultimi cinquant’anni. Questa nuova situazione, però, suscita oggi problemi sconosciuti in passato: senza un convinto consenso della grande maggioranza degli europei prima o poi il percorso verso l’Europa unita rallenterà, si fermerà o addirittura tornerà indietro. È stato notato che l’Europa soffre di un deficit di democrazia: finché gli europei non avranno la sensazione di poter influire direttamente sulle istituzioni comunitarie e sui loro responsabili, ispirandone le decisioni, è difficile che possa determinarsi un sentito coinvolgimento degli europei nello sviluppo delle istituzioni comunitarie. In altre parole, si pone il problema di realizzare in modo pieno una cittadinanza europea. Ma non è solo un problema di procedure elettorali, di equilibri istituzionali o di rappresentatività degli organismi europei: non si tratta, insomma, solo di ingegneria costituzionale. È in gioco anche il problema di quale sarà il futuro complessivo dell’Europa. Gli europei sanno, infatti, che questo futuro li riguarderà direttamente, qualunque siano il sistema adottato per eleggere il Presidente della Commissione europea o il sistema di voto che prevarrà nelle istituzioni comunitarie. Il problema di elaborare un comune “progetto europeo” appare spesso trascurato da una logica di costruzione istituzionale troppo ingenieristica, concentrata sulla questione dei mezzi ma singolarmente disinteressata della questione dei fini. Ma è difficile che il cammino di integrazione europea riprenda slancio senza una larga convergenza sui fini. • Il dibattito sul Preambolo Non appare casuale in questo senso il dibattito che si è acceso sul Preambolo del progetto di Costituzione europea elaborato dalla Convenzione presieduta da Valery Giscard d’Estaing. Si tratta della parte giuridicamente meno rilevante, in quanto i preamboli non contengono norme o disposizioni e non hanno un impatto pratico immediato: vi si richiamano valori fondanti, riferimenti storici o prospettive per il futuro che i costituenti affidano alla “buona volontà” di chi sarà chiamato ad applicare il testo costituzionale. Com’è noto, il dibattito intorno al Preambolo della Costituzione europea è stato animato soprattutto dalla questione del riferimento alle radici cristiane dell’Europa o al nome di Dio. Al di là del merito della questione, tale dibattito è servito anche a richiamare l’attenzione su un problema di fondo: quale disegno deve ispirare il futuro dell’Europa? Dovrà privilegiare il riferimento alla tradizione cristiana o ai valori illuministici, favorire la coabitazione tra religioni diverse o affermare una rigorosa laicità? Oppure: dovrà fondarsi esclusivamente sulle regole del libero mercato, con il rischio di separare 62 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Agostino Giovagnoli l’Europa dei ricchi da quella dei poveri, o porsi l’obiettivo di sviluppare forme di solidarietà tra i cittadini europei, per aumentare la coesione sociale? Sono questioni cruciali, che una discussione limitata alle singole norme rischia di trascurare, con implicazioni importanti anche per ciò che riguarda la piena legittimazione democratica delle istituzioni europee e la creazione di un consenso diffuso intorno ad un governo unitario dell’Europa. • L’Europa, il suo futuro e il mondo È un problema sempre più collegato anche alla questione della collocazione dell’Europa nel mondo. Non a caso, negli ultimi anni tale collocazione ha suscitato tante inquietudini e molte discussioni e la mancanza di una politica estera unitaria è apparsa sempre più intollerabile. L’insoddisfazione per l’inerzia europea sul Medio Oriente o nei Balcani negli anni Novanta o la grande mobilitazione dei cittadini europei contro la guerra in Iraq costituiscono in realtà elementi di novità nella storia europea: le generazioni precedenti non spingevano così lontano il loro sguardo. Ma a modo loro, all’interno di uno scenario storico molto diverso, i padri fondatori dell’Unione Europea hanno sviluppato la loro opera tenendo conto dell’orizzonte internazionale complessivo e hanno affrontato con chiarezza l’interrogativo sul futuro dell’Europa. Di ciò, c’è bisogno anche oggi. La loro azione, infatti, si è sviluppata all’indomani della seconda guerra mondiale intorno al nesso tra pace e democrazia. Si tratta dei due pilastri su cui è fondato tutto il processo di integrazione europea, nel contesto di un’inedita influenza della tradizione cristiana nella politica europea. Com’è noto, molti dei padri fondatori dell’Europa provengono dai partiti democratico-cristiani, nel cui Dna la causa europea è profondamente radicata. Non si tratta di una coincidenza casuale: più di altre forze politiche, tali partiti hanno incontrato le aspirazioni del loro tempo e uno spirito europeo profondamente abbattuto dalla guerra più tremenda nella storia del continente, coniugando realismo e speranza, azione delle élites e aspirazioni popolari, saldezza delle istituzioni e progresso sociale, identità nazionale e cooperazione internazionale, frenando furori militaristi o di eccessi ideologici. Su questa strada hanno saputo indirizzare la costruzione comunitaria, offrendo all’Europa occidentale cinquant’anni di pace e di sviluppo in netto contrasto con tutta la sua storia precedente. • Le “nuove” culture politiche Oggi, com’è noto, la presenza di questo tipo di partiti si è molto ridotta e al Parlamento Europeo hanno un ruolo preminente altre famiglie politiche, come quella liberale, quella socialista e anche quella popolare, sempre più lontana dalle Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 63 Agostino Giovagnoli sue origini, espressive di tendenze diverse dalla tradizione democratico-cristiana. Forse anche per questo, le scelte dei leaders politici europei sono oggi spesso schiacciate su problemi di consenso immediato e configurano una sorta di navigazione a vista carente di una chiara progettualità. Le culture politiche cui si inspirano, infatti, non forniscono loro un background adeguato su cui costruire scelte politiche necessarie per completare il processo di integrazione europeo e per adeguarlo alle nuove esigenze del mondo contemporaneo. I loro partiti, inoltre, non sono in grado di raccogliere il consenso necessario per seguire con continuità un progetto che supera gli interessi immediati dei cittadini dei diversi paesi, anche se in realtà li riguardano profondamente. Tornare al passato non è possibile e neppure auspicabile: fortunatamente, la seconda guerra mondiale è lontana nel tempo e la situazione europea è radicalmente cambiata. Ma che cosa debba essere l’Europa e quale ruolo deve occupare nel mondo costituisce anche oggi, ovviamente, un problema aperto. È perciò necessario interrogarsi anche sul vuoto lasciato dalla scomparsa di forze politiche omogenee e unite da un comune progetto europeista, in grado di attirare un sufficiente consenso transnazionale, come accadde nel secondo dopoguerra. La politica di integrazione europea, infatti, è sempre stata rivolta al futuro e per realizzarla è anche oggi necessario contrastare le tendenze distruttive presenti nelle diverse opinioni pubbliche nazionali. Ma è difficile che gli europei possano appassionarsi ad una costruzione istituzionale apparentemente lontana dai loro interessi immediati senza la possibilità di discutere tra progetti diversi e di scegliere tra forze politiche che si propongano credibilmente di realizzarli. 64 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 La Turchia nell’Ue: islamizzazione dell’Europa o europeizzazione dell’Islam? “L’Occidente ha avuto sempre pregiudizi contro i turchi… Ma noi turchi siamo sempre stati attratti dall’Occidente… Per essere annoverati tra le nazioni civilizzate non v’è alternativa” scriveva Kemal Atatürk. Turkey belongs in Europe ha titolato il settimanale The Economist, sottolineando come l’eventuale ingresso della Turchia nell’Unione Europea potrebbe costituire un messaggio importante per il mondo islamico di oggi: dimostrerebbe, infatti, che l’Occidente, come del resto l’Islam stesso, non considera il mondo musulmano incompatibile con i valori democratici. PAOLA PIZZO Università di Chieti • Attrazione e pregiudizi I recenti sviluppi della vita politica turca sembrano, in questo senso, incoraggiare una visione ottimista, o almeno possibilista, del rapporto tra la civiltà occidentale e quella orientale, che non è fatta solo di Islam, non necessariamente condannate allo scontro. Ai confini sud-orientali dell’Unione, la Turchia rappresenta un grande paese, erede di un impero secolare. In tutte le fasi della sua storia il rapporto con il continente europeo è stato decisivo. Diceva uno storico dell’Impero Ottomano che il possesso dei territori europei aveva fatto grande il califfato ottomano, laddove i precedenti califfati erano rimasti localizzati alle tradizionali aree di influenza del mondo islamico. La perdita di tali territori, con il sorgere dei nazionalismi, doveva segnare inevitabilmente l’inizio del declino della potenza ottomana. Oggi, a ottant’anni dalla proclamazione della Repubblica (29 ottobre 1923) e dall’abolizione del Califfato (3 marzo 1924), la Turchia affronta nuovamente la sfida del rapporto con l’Europa. Se ottant’anni fa il nazionalismo dei Giovani Turchi la spinse a creare una realtà nazionale il più possibile omogenea e indi- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 ≈ “... La sfida sarà... come conciliare le radici islamiche con le aspettative di democrazia e laicità dell’Europa... ma anche di diversi settori del mondo musulmano...” ≈ 65 Paola Pizzo pendente, oggi la leadership turca guarda al possibile ingresso del paese nella cornice dell’Unione allargata, dove la Turchia verrebbe a rappresentare il primo paese a maggioranza musulmana, retto da un’élite di governo che si ispira esplicitamente ai principi della fede islamica. La questione dell’ingresso della Turchia nell’Ue è rilevante sia per l’Unione sia per la Turchia stessa. Non pochi osservatori hanno sottolineato, talvolta con preoccupazione, l’anomalia rappresentata dalla candidatura turca, non solo e non tanto per le questioni ancora aperte legate al rispetto dei diritti umani o a questioni particolarmente delicate e ancora irrisolte come quella cipriota o ai rapporti con la Grecia, oltre all’andamento altalenante dell’economia turca negli ultimi anni. L’argomento che genera maggiori preoccupazioni e cautela sembra essere rappresentato dall’identità stessa del grande paese mediterraneo e dalla sua appartenenza, per religione e cultura, al mondo musulmano. La Turchia, paese grande due volte la Germania, porterebbe in Europa oltre 67 milioni di nuovi cittadini di religione musulmana, assieme all’eredità e al peso di una delle tre grandi civiltà che hanno fatto la storia musulmana, dopo l’araba e la persiana. Si aprirebbe un rilevante problema politico-demografico: la Turchia costituirebbe, per popolazione, il secondo paese dell’Unione dopo la Germania, con prospettive di crescita ben superiori a quest’ultima. L’Unione conta già circa venti milioni di musulmani entro i suoi confini, ma in Europa vi sono anche altri paesi musulmani che potrebbero essere potenziali candidati all’ingresso nell’Unione politica, come l’Albania e la Bosnia. Importanti minoranze musulmane sono presenti nei paesi europei sia in qualità di immigrati sia autoctoni. L’ingresso dei musulmani turchi sposterebbe l’ago della bilancia della composizione religiosa dei cittadini dell’Unione verso una maggiore presenza dell’Islam e ciò costituisce materia sia di riflessione sia di preoccupazione. Un altro aspetto su cui convergono gli interrogativi degli osservatori è costituito dalla solidità dell’esperienza democratica turca. La Turchia è una nazione relativamente giovane, ma il paese in quanto entità statale e centro di un impero più vasto possiede una lunghissima tradizione. In questo senso, molti candidati o membri dell’Unione possono vantare esperienze di autonomia e di indipendenza assai più brevi, come nel caso dei paesi sorti dalla dissoluzione dell’impero sovietico. • La Repubblica turca: ottant’anni di storia Nell’ottantesimo anniversario della Repubblica Turca è perciò utile rileggere le sue vicende alla luce sia degli interrogativi riguardanti il carattere più o meno musulmano di questo stato, sia di quelli concernenti la qualità della sua democrazia. La storia contemporanea della Turchia comincia all’indomani della prima guerra mondiale quando essa, attraverso la rivoluzione repubblicana, cerca di affermare il suo riscatto assieme con l’affermazione di una nuova identità che rompe definitiva- 66 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Paola Pizzo mente con la storia passata. Se la storia della Turchia fino ad allora era stata anche, e forse soprattutto, storia dell’impero islamico, con l’abolizione del Sultanato nel 1922 e del Califfato ottomano nel 1924, essa entra nella storia delle nazioni moderne. Su impulso delle idee nazionaliste, la nuova leadership turca mette in discussione le istituzioni classiche del mondo musulmano, in cui la Turchia si era identificata per secoli. Il nazionalismo fornisce un nuovo quadro di identità e di affermazione statale in senso moderno, una nuova opportunità che Mustafa Kemal Atatürk, il padre della Turchia moderna, coglie con grande attivismo. Non è stato certamente facile imporre a un paese fermo nelle sue tradizioni un mutamento di rotta così marcato. Si trattava di scardinare un ordine religioso e amministrativo, forse obsoleto, ma che aveva resistito per secoli e nella cui cornice generazioni e generazioni di cittadini ottomani, turchi e non solo, si erano identificati. Nuove categorie vengono introdotte per definire la nuova identità della Turchia, non più islamica, non più ottomana, non più imperiale, non più garante delle minoranze nazionali, linguistiche e religiose. La nuova Turchia trova giustificazione e fondamento nella razza turca, nella sua lingua, nella sua terra. La dimensione religiosa, da cui i leader almeno all’inizio non prescindono, viene tuttavia relegata nella sfera del vissuto privato dei cittadini, sancendo fin dalle origini dello stato turco moderno la divisione tra stato e religione, rompendo così una sorta di tabù agli occhi dell’Islam tradizionale e del semplice fedele. Come è noto, la storia del mondo islamico si intreccia a volte in maniera inestricabile con la storia stessa dell’Islam in quanto religione e civiltà. Si è proposta in tal senso l’identificazione dello stato musulmano con la religione, din wa-dawlah, proprio a significare lo stretto legame di dipendenza dell’uno dall’altra. E per un caso significativo in arabo il sostantivo “religione” è maschile, mentre lo “Stato” è femminile. Al di là dell’aderenza ai principi della religione manifestata dal califfo ottomano o anche della legittimità stessa del titolo califfale, lo Stato restava, agli occhi dei musulmani in ogni parte del mondo, il garante della tradizione e della continuità dell’Islam. Il passaggio dall’impero alla repubblica scardina la base tradizionale dello stato islamico in quanto din wa-dawlah, introducendo – per via di legge e nel giro di appena due anni – la distinzione tra potere secolare e autorità religiosa, che l’Occidente ha conquistato con secoli di lotte e con lenta maturazione. Naturalmente, un passaggio così determinante ha generato profonde reazioni in tutto il mondo musulmano e non soltanto in Turchia. Dall’India all’Egitto, nel maghreb e nel mashreq, milioni di musulmani, orfani del califfato cominciavano a dibattere sull’opportunità e le modalità per ridare vita all’antica istituzione islamica. Sono interessanti, in questo senso, alcuni tentativi in ambito arabo per ripristinare il Califfato. Il re dell’Egitto Fu’ad, discendente da un ufficiale albanese di Macedonia, Muhammad ‘Ali, il creatore dell’Egitto moderno, non nascondeva la sua ambizione di aggiungere al recente titolo di re dell’Egitto, il ben più prestigioso titolo califfale. Lo sceriffo della Mecca, Huseyn, erede dell’antica e nobile tribù ara- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 67 Paola Pizzo ba degli hashimiti, fu addirittura proclamato nuovo califfo. Altri sostennero che il califfato dovesse comunque restare all’interno della dinastia ottomana. Altri ancora proposero il re dell’Afghanistan, unico paese musulmano ad aver resistito alla colonizzazione occidentale. Nello stesso tempo i saggi musulmani dell’autorevole università cairota di al-Azhar annunciarono l’imminente tenuta di un congresso sul califfato, che avrebbe risolto la questione. Mentre Kemal e i suoi collaboratori gettavano le basi della Turchia moderna, laica e repubblicana, il mondo musulmano in fermento viveva ore di drammatica attesa in cui si confrontavano posizioni molto differenti e distanti tra loro. In questo gioco, tra l’altro, non mancò l’intervento di alcune potenze europee in appoggio ora di un candidato ora dell’altro. Tra le varie ipotesi allora proposte, ci fu anche quella che auspicava la permanenza del Califfato come autorità spirituale, libera dal legame col potere politico di qualsivoglia nazione, che in tal modo avrebbe potuto garantire autorevolezza morale sopra tutti i musulmani. Una sorta di “papato” islamico, che si sarebbe configurato proprio come un’autorità morale e spirituale. Naturalmente accostare le due istituzioni è una forzatura, ma in quei mesi agitati, in cui l’Islam sembrava smarrire l’orientamento, alcuni osservatori espressero profondo sconcerto per la perdita di un centro di riferimento quale, per analogia, poteva essere considerato il papa di Roma per l’universo cattolico. Davanti all’emozione suscitata in tutto il mondo islamico dall’abolizione del califfato, l’atteggiamento turco fu risoluto: “Il Califfato si trova ormai personificato nel Parlamento e nel Governo”. La distinzione tra la dimensione politica e quella religiosa era stata peraltro già sancita all’atto dell’abolizione del Sultanato nel 1922. La Grande Assemblea turca nel novembre aveva stabilito la separazione del potere temporale da quello spirituale, mantenendo il Califfato in questa seconda veste. Nel disegno di Kemal, tuttavia, questo atto era soltanto il primo passaggio verso un graduale processo di laicizzazione delle strutture statali. Il passo ulteriore venne poi compiuto due anni dopo, come abbiamo visto, con il passaggio delle prerogative califfali nella stessa Assemblea. • Un nuovo rapporto con l’Islam La Turchia si è dotata, dall’ottobre 1923, di una Costituzione repubblicana. A partire da quest’anno Kemal avviò un complesso iter di riforme dell’ordinamento statale volto a definire in senso laico le istituzioni del paese. In questo senso nel 1925 furono emanate una serie di leggi tese a “laicizzare” lo stato e le istituzioni, che toccarono direttamente la vita stessa dei cittadini turchi. È lungo l’elenco delle riforme che, nei primi anni di vita della repubblica, crearono le basi di uno stato laico, moderno, al passo con i tempi, che voleva porsi al livello delle altre grandi nazioni. 68 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Paola Pizzo Apparentemente, alcuni provvedimenti possono sembrare superficiali o marginali; in realtà, molti di essi intaccarono tradizioni consolidate e legate a un’immagine della Turchia che si voleva relegare nel passato. È il caso delle nuove norme circa l’uso di determinati oggetti di abbigliamento, percepiti come segno forte di appartenenza confessionale e di identità: il fez e il turbante vengono banditi e sostituiti da copricapo di foggia occidentale. Ci furono molte reazioni popolari contrarie alla novità e imbarazzi legati all’impaccio che tali indumenti causavano nel compimento della preghiera rituale musulmana. A queste misure si accompagnava il tentativo di scoraggiare le donne dall’indossare il velo islamico, un tema che appare oggi di grande attualità in Europa. Altre disposizioni intaccarono più profondamente la struttura islamica della società turca come quella che sopprimeva le confraternite mistiche, da sempre un autorevole punto di riferimento e di aggregazione per i musulmani ottomani. L’esperienza confraternale rappresentava una ricca e feconda espressione nella spiritualità dell’islam turco. Accanto a questo, la chiusura delle scuole confessionali garantì l’esclusiva formazione dei giovani nelle scuole statali i cui programmi vennero riformati sulla base della nuova dottrina nazionalista. Cambiò anche il computo del tempo, col passaggio dal calendario egiriano a quello gregoriano e l’introduzione dei caratteri latini al posto di quelli arabi, fino ad allora utilizzati nella scrittura della lingua turca. Venne quindi abolita la poligamia, norma che fa della Turchia, insieme alla Tunisia di Bourghiba e ora al Marocco, con la recente riforma del diritto di famiglia, uno dei pochi paesi musulmani che hanno realizzato una riforma così profonda. A coronamento di questo processo, nel 1928 viene approvata una modifica costituzionale che abolisce il riferimento all’Islam come religione di Stato. Questa riforma è tanto più significativa se si pensa che in alcuni stati appartenenti all’Unione Europea, tale separazione è avvenuta lentamente e in modo incompleto. Il cammino della Turchia dagli anni Venti ad oggi attesta indubbiamente un’evoluzione interessante del rapporto tra din wa-dawlah, religione e Stato, non solo per il mondo musulmano, ma anche per la stessa Europa. Alcuni osservatori, però, hanno ravvisato in questo processo non propriamente una separazione tra religione e stato, ma piuttosto il tentativo da parte di quest’ultimo di porre la religione sotto il suo diretto controllo. Anche tale tendenza, però, è largamente presente pure nella storia europea. • La costruzione del moderno stato turco Per quanto riguarda il secondo elemento del binomio, la forma di stato cui aspira e comincia a modellarsi negli anni Venti la nuova Turchia è quella di uno stato laico e repubblicano, a partito unico fino al 1946, se si escludono due brevi parentesi. La Turchia rompe in un solo processo con la tradizione islamica e monar- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 69 Paola Pizzo chica. Il collante del nuovo Stato è l’ideologia nazionalista che si incarna in uno Stato accentratore del potere, in cui a garanzia della svolta repubblicana e laica si pone l’esercito. L’apparato militare turco non ha mancato, lungo questi ottant’anni, di intervenire nei momenti in cui credeva minacciata l’identità della nuova Turchia. L’architetto di questa nuova costruzione statale fu Mustafa Kemal, primo presidente della neonata Repubblica Turca, che assume dal 1934 il cognome Atatürk, “padre dei turchi”. Con un processo di epurazione, egli elimina i rivali all’interno del vecchio schieramento del Comitato per l’Unione e il Progresso, fino a restare l’unico leader del nuovo Partito del Popolo. Il monopolio del potere serviva a Kemal e ai suoi collaboratori per imporre le riforme laicizzanti di cui si è detto, ispirate in parte anche dal positivismo europeo. Il suo profondo attaccamento all’identità turca spiega anche l’atteggiamento ostile nei confronti delle minoranze etniche e linguistiche che, a suo avviso, costituivano una minaccia al progetto di turchizzazione dello stato. Atatürk muore nel 1938, ma il cammino intrapreso dalla Turchia è ormai segnato. Per spiegare l’ingresso della Turchia nella sfera degli interessi occidentali occorre richiamare le vicende belliche: questo paese costituì uno snodo fondamentale per la strategia nei due schieramenti contrapposti. Nel corso della seconda guerra mondiale, riuscì a giostrarsi tra le potenze europee, mantenendo una difficile neutralità, nello sforzo di contenere la pressione dell’Unione Sovietica, erede del tradizionale antagonista russo. Anche all’indomani della guerra, in un quadro internazionale in cui la potenza statunitense comincia a stagliarsi come egemone e alternativa a quella sovietica, l’atteggiamento turco fu ancora un volta improntato alla difesa dei suoi maggiori interessi nazionali, vale a dire la gestione dei rapporti con il potente vicino russo. La posizione strategica della Turchia, tra Oriente e Occidente, al confine tra i due blocchi e, allo stesso tempo, ponte con il Medio Oriente, fece di essa un importante elemento nel disegno difensivo e geopolitico dell’Alleanza Atlantica, di cui anche la Turchia entrò a far parte nel 1952. In questo nuovo quadro di alleanze la Turchia vide garantiti aiuti per bilanciare le pressioni provenienti dall’Unione Sovietica, che mirava, com’era tradizionale nella politica russa, allo sbocco nel Mediterraneo e al controllo degli Stretti sul Mar Nero. In questo senso vanno lette anche le riforme interne che miravano a dare alla Turchia istituzioni più vicine ai modelli occidentali. In primo luogo, la nascita di partiti di opposizione (1946) e la riforma del sistema elettorale in senso più democratico (1950). Nelle prime elezioni libere della Turchia indipendente avvenne un rovesciamento negli equilibri politici con la vittoria del partito di opposizione, il Partito Democratico. Quest’ultimo, con le sue successive denominazioni di Partito della Giustizia, della Madrepatria e della Retta Via, si impose tra gli anni Cinquanta e Ottanta come il rappresentante degli interessi di tutte quelle classi che erano state fino ad allora emarginate dalla politica: non burocrati o funzionari statali, ma rappresentanti del ceto medio e dell’emergente classe industriale del paese, come delle élite rurali. Tra 70 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Paola Pizzo i maggiori rappresentanti di questo schieramento si trovano Menderes, Demirel e Özal, tutti sostenitori dell’economia di mercato e dell’apertura al settore privato negli investimenti. Già per questa classe politica liberista in economia – è interessante notarlo – l’approccio ai temi religiosi cominciò però ad assumere una connotazione diversa rispetto all’era kemalista: non si assiste più all’emarginazione del fatto religioso, anzi gli stessi Demirel e Özal non hanno disdegnato di manifestare in pubblico la fede islamica, tanto da ingenerare timore nei settori più laici, come l’esercito e l’élite colta occidentalizzata. A partire dalla fine degli anni Ottanta la Turchia ha conosciuto un periodo di crisi economica e politica, dovuta alla frammentazione degli schieramenti politici sia di destra sia di sinistra e alla conseguente instabilità dei governi. A ciò si aggiunge l’inizio della lotta condotta a partire dal 1984 dal Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), formato all’ideologia marxista, che mirava al riconoscimento dei diritti fondamentali per la minoranza curda del paese. La politica di repressione, scarsamente attenta alla tutela dei diritti umani, attuata dalla Turchia per contenere la minaccia del Pkk continua a rappresentare ancora oggi uno degli ostacoli maggiori sulla via dell’integrazione nell’Unione Europea, anche se cambiamenti importanti sono stati compiuti in questi ultimi anni nella gestione della questione curda. • La Turchia cerca l’Europa In questo contesto di crisi economica, che ha evidenziato i limiti dei partiti tradizionali, è gradualmente emerso un movimento politico che, salvaguardando e recuperando l’identità islamica, si è posto come alternativo alla classe politica dominante. La richiesta di adesione all’Unione Europea, formulata nel 1987, è stata perciò avanzata dalla Turchia, in un clima di nascita o rinascita di un approccio politico dell’Islam o, in altri termini, in una fase che ha visto la creazione di una sintesi politica turco-islamica, sotto lo sguardo vigile dell’istanza militare. Si tratta, evidentemente di una fase di svolta nella storia contemporanea della Turchia, in cui emerge un problema di definizione identitaria, peraltro ancora non del tutto risolto, che ripropone l’elemento confessionale musulmano come parte rilevante dell’identità turca, accanto ad altri fattori che spingono per l’integrazione nel più ampio consesso europeo. Com’è noto, a partire dal 1987 la richiesta turca ha seguito un iter complesso, con alterne vicende legate sia agli sviluppi interni della Turchia sia a condizioni esterne. La domanda di piena adesione alla Ue si colloca, infatti, al culmine di un processo di riforme economiche, intrapreso dalla Turchia a partire dalla metà degli anni Ottanta, che hanno indirizzato il paese verso una maggiore liberalizzazione. La Commissione rispose alla richiesta mettendo in luce alcuni ostacoli, tra cui fattori economici, differenze strutturali, bassi livelli di protezione sociale, inadeguatezza nel campo dei diritti umani, problemi ancora aperti con uno stato membro: Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 71 Paola Pizzo la Grecia. I problemi evidenziati erano di carattere economico, politico e sociale, ma non vi era alcun riferimento a questioni culturali e religiose. La Commissione suggerì di realizzare un’unione doganale e di posporre la questione della piena adesione. È stata proprio questa la strada percorsa in questi anni. La caduta del Muro di Berlino e il crollo del Blocco Sovietico hanno poi influito in questo processo, allentando le pressioni e i timori turchi verso nord, ma, allo stesso tempo, modificando la centralità turca nell’ambito del sistema di difesa europeo e nord atlantico. Gli osservatori più scettici suggeriscono che l’idea dell’unione doganale, mentre si rimandava sine die la questione dell’adesione, sia stata una mossa strategica per mantenere la Turchia nell’orbita degli interessi europei, evitando altre derive, senza tuttavia impegnarsi più di tanto, mentre la Turchia perdeva di centralità per gli interessi del Vecchio Continente. Contemporaneamente, però, la costante instabilità dell’area mediorientale assieme alla prima e seconda guerra del Golfo, hanno mostrato che la Turchia mantiene un ruolo fondamentale per la pacificazione di tutta la regione. In questo senso, il recente riavvicinamento con la Siria, accanto al rapporto con Israele, testimoniano la vitalità diplomatica del paese e la sua rilevanza come partner nel Medio Oriente. Il cammino dell’unione doganale tra Turchia e Ue ha fatto passi in avanti portando all’abolizione delle tariffe doganali per le importazioni dall’Europa e fungendo da motore per l’industrializzazione del paese. Questo movimento ha creato qualche difficoltà all’economia turca, che non pare però insormontabile, provocando uno squilibrio della bilancia commerciale a favore dell’Europa. Gli effetti politici che ci si attendeva dall’unione doganale hanno portato a una maggiore vicinanza ai valori di democrazia europei, specialmente per quanto attiene alla questione dei diritti umani. L’abolizione della pena di morte in tempo di pace sembra un frutto di questa politica di avvicinamento all’Europa. Altri ancora, però, sono gli ostacoli che il paese è chiamato a superare. Oltretutto, la situazione speciale in cui la Turchia si trova nei confronti dell’Ue ha suscitato, a partire dal 1997, un raffreddamento delle sue posizioni verso l’Unione. La Turchia, infatti, si considera discriminata rispetto agli altri paesi candidati in quanto non ha mai avuto un calendario preciso di adesione. L’anno 2004, in questo senso, rappresenta un momento decisivo. Il Consiglio Europeo di fine anno dovrebbe, infine, proporre una data per l’integrazione turca. In quella sede saranno valutati i passi che la Turchia ha compiuto per adeguarsi ai principi stabiliti dal Consiglio europeo di Copenhagen nel 1993, cui essa è stata chiamata ad attenersi e che riguardano: a) la stabilità delle istituzioni garanti della democrazia, il rispetto della legge, i diritti umani e la protezione delle minoranze; b) l’esistenza di un mercato economico vitale, capace di cooperare con le competitività delle forze di mercato attive in Europa; c) la capacità di tener fede agli impegni degli stati membri riguardanti la politica, l’economia e l’unione monetaria. 72 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Paola Pizzo Resta inteso che l’Unione Europea non è il solo scenario su cui si gioca oggi il futuro della Turchia. Fin dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica con la nascita delle repubbliche turche dell’Asia centrale, essa ha aspirato a giocare un ruolo egemone nell’area, recuperando quella che era stata una tradizionale zona della sua influenza o delle mire di un certo panturanesimo. In questo senso, la creazione del Consiglio di Cooperazione Economica del Mar Nero su iniziativa della Turchia nel 1991 rappresenta un tentativo per emergere come potenza regionale dell’area. Ed è indubbio che essa aspiri a colmare quel vuoto di potere e di autorevolezza lasciato dall’Urss, soprattutto nell’ambito delle cinque nuove repubbliche a maggioranza musulmana dell’Asia Centrale. • L’ascesa dei partiti islamici Gli ultimi sviluppi della vicenda turca si intrecciano con l’ascesa al potere nel 1996 della prima coalizione di governo a guida islamica, capeggiata da Necmettin Erbakan. L’avvento al potere di Erbakan nel 1996 come leader del Partito Refah non è però un evento estemporaneo. Tutt’altro che improvvisa, la comparsa della corrente politica islamica in Turchia è stata preparata fin dalla fine degli anni Sessanta, con la formazione di movimenti che si richiamavano ai principi dell’Islam in un primo tempo soprattutto tra i commercianti, gli artigiani e il ceto medio fortemente deluso dalle politiche dei governi di centro-destra. Nel corso degli anni il Refah ha avuto il merito di conquistare il favore dei ceti poveri delle grandi città come Istanbul, come anche della classe media e degli ambienti rurali. La svolta islamica della Turchia non ha sorpreso gli osservatori che da anni seguono le vicende del grande paese del Mediterraneo orientale. In questo processo ha esercitato un ruolo importante lo stesso esercito repubblicano che in diversi casi nella storia di questi ultimi ottant’anni di vita ha ritenuto di dover intraprendere un’azione diretta nelle vicende dello stato a garanzia della Costituzione laica e repubblicana dello stesso. L’intervento dell’istituzione militare nel 1980 si colloca in una fase molto critica della storia turca. Il suo scopo era di porre fine ad una lunga scia di atti terroristici compiuti dagli estremisti di destra e di sinistra. Nei primi anni Ottanta il paese ha vissuto un periodo di forte instabilità anche a causa dell’irrisolta questione curda. A ciò si aggiunse la crescente influenza che esercitava il movimento islamico del Partito della Salvezza Nazionale, guidato da Erbakan, ispirato da un Islam radicale che aspirava ad un ruolo politico nella società. In questo difficile contesto il regime militare, instaurato tra il 1980 e il 1983, se da un lato ottenne il risultato di fermare la violenza politica e gli estremismi di destra e di sinistra, dall’altro non bloccò l’avanzata del movimento islamico. Agli occhi dell’istanza militare sembrava che la crescita di tale corrente costituisse, tutto sommato, un basso prezzo da pa- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 73 Paola Pizzo gare per salvaguardare la stabilità e l’integrità della Turchia. Questo spiegherebbe perché nel corso degli anni Ottanta la corrente dell’Islam politico turco abbia continuato a raccogliere consensi attorno a sé. Alcuni analisti arrivano a spiegare il fenomeno con la volontà da parte dell’establishment militare di creare una sorta di nuova sintesi dell’Islam turco. Schematizzando si può affermare che, con una strategia non dissimile da quella adottata in alcuni paesi arabi del maghreb nei confronti delle correnti di sinistra, i militari turchi avrebbero creduto che il rafforzamento dei sentimenti islamici nella popolazione, attraverso la crescita del partito islamico e dell’influenza di quello tradizionale e conservatore, potesse controbilanciare i sentimenti rivoluzionari presenti soprattutto tra i giovani curdi, ma anche tra gli estremisti di ogni colore. Una conferma in tal senso sembrerebbe essere costituita dalla scelta di Turgut Özal come primo capo del governo civile dopo la parentesi militare. È noto, infatti, il legame di quest’ultimo con l’Islam confraternale turco, in particolare con l’ordine della nakshabandiyyah, quindi con una delle espressioni più antiche e radicate del sentimento religioso dei turchi. Nell’ottica della creazione o, se si preferisce, del risveglio del sentimento religioso islamico, egli ammetteva pubblicamente che l’Islam, assieme ai valori della rivoluzione kemalista e alla via irrinunciabile della laicità, rappresentava un elemento fondante dell’identità turca. Il tentativo di rifondare quello che da alcuni è stato definito come la sintesi turco-islamista è passato negli anni di premierato e poi di presidenza Özal attraverso la creazione di fondazioni e associazioni a carattere islamico, nonché la pubblicazione di giornali e riviste in cui prevale il tema religioso. Hanno inoltre visto la luce una serie di radio e televisioni autorizzate a diffondere trasmissioni a tema religioso. In questo modo la corrente islamica ha guadagnato spazi importanti soprattutto nel settore dell’educazione e dei massmedia. Un’altra espressione in cui si è incarnato, nel corso degli anni, il sentimento islamico turco è rappresentata dalle istituzioni e fondazioni che fanno capo a Fethullah Gulen, da alcuni considerato un modello di relazione e di sintesi culturale tra modernità e Islam. Il tentativo messo in atto da Gulen e dai suoi seguaci, a partire dai primi anni Sessanta, si propone di sviluppare il discorso religioso islamico, senza per questo dover rinunciare ai valori della democrazia e della laicità. Una certa élite laica guarda al modello Gulen come ad una proposta valida per la Turchia e non solo, mentre altri vi scorgono soltanto una copertura e lo giudicano alla stregua degli altri gruppi dell’Islam politico. Al di là dei giudizi di merito, il movimento di Gulen appare molto incisivo nella società turca per il numero e la potenza delle istituzioni che vi aderiscono, in gran parte scuole, che, tra l’altro, offrono un alto grado di istruzione, raggiungendo contemporaneamente un alto numero di studenti. Un’originalità di questo movimento risiede nella sua capacità di aggregare le persone più diverse: poveri delle grandi periferie urbane, come giovani colti, professionisti, turchi e curdi, musulmani e persino non musulmani farebbero rife- 74 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Paola Pizzo rimento alle varie attività dispiegate dal movimento. Gulen sembra aver esercitato una certa attrazione anche sulla classe politica turca, specialmente a destra. Alcuni leader di partito hanno avuto contatti con l’associazione, tra questi Demirel ed Ecevit. Ma non si può affermare che egli sia organico a qualcuno dei partiti dello schieramento parlamentare; anzi, in alcuni casi, la sua attività è stata vista con sospetto da parte delle istituzioni. Il movimento di Fethullah Gulen mostra come l’Islam turco, analogamente a quanto avviene in altre regioni del mondo islamico, sia lungi dall’essere un monolite e comprenda anime differenti, talvolta anche in contrasto o in concorrenza tra loro. Il movimento non si presenta, infatti, come un partito tradizionale in cerca di consensi o di posizioni da occupare, a differenza dell’Akp, attuale partito di maggioranza, che fin dal principio ha elaborato un progetto politico mirante alla conquista dell’elettorato. Accanto a queste due anime dell’islam turco bisogna registrare la presenza di gruppi e movimenti radicali che, sebbene di limitata consistenza numerica, rappresentano una minaccia ben maggiore alla stabilità delle istituzioni laiche e repubblicane del paese, come si è visto nei recenti attentati che hanno devastato il paese. Com’è noto, alcuni settori dell’establishment turco ebbero timore che l’avvento del partito islamico in Turchia ponesse in pericolo il regime laico e democratico dello stato. Così nel 1998 la Corte Costituzionale mise al bando il Refah con l’accusa di aver minato i principi laici della repubblica. In passato i militari avevano intrapreso la via dell’azione diretta nelle vicende di governo quando temevano che tali principi fossero minacciati. Era avvenuto nel 1960, poi nel 1971, infine nel 1980. Questa volta, invece, i militari turchi adottarono un altro mezzo per disfarsi della minaccia che a loro giudizio costituiva l’atteggiamento islamico radicale e anti-occidentale del Refah. Per prevenire la reazione popolare esso si sentiva così in dovere di impedire per via giudiziaria il proseguimento dell’attività politica del partito. In effetti, il Refah ha conosciuto in una decina d’anni, dal 1987 al 1995 un crescita fortissima in termini di consenso elettorale, passando da una percentuale del 7% al 21,3%. La crescita si è avuta soprattutto nelle zone più massicciamente colpite dal terrorismo curdo. La spiegazione potrebbe risiedere nella via proposta come alternativa alla soluzione del problema curdo. Gli islamici del Refah, infatti, proponevano una nuova definizione dell’idea nazionale, ricorrendo all’antico concetto ottomano della divisione della comunità in millet, nazioni, a base religiosa. In quest’ottica i curdi venivano a essere inglobati nella più ampia nazione musulmana, al di là delle loro diversità etniche e linguistiche, facendo cadere ogni presupposto di discriminazione e risolvendo il problema alla radice. Evidentemente, questo linguaggio semplice, tradizionale e innovativo allo stesso tempo, deve aver riscosso una certa attrattiva nell’elettorato, dove i sentimenti di appartenenza alla comunità musulmana non sono stati del tutto sostituiti dalla retorica nazionalista. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 75 Paola Pizzo • Tra Islam e democrazia, tra Oriente e Occidente, tra Asia ed Europa Nonostante il successo elettorale, la vita del primo governo di coalizione guidato dal leader di un partito islamico non è stata né facile né di lunga durata. Il Refah e il Partito della Giusta Via della Ciller hanno trovato molte difficoltà a lavorare insieme: addirittura era diventato difficile convocare le stesse riunioni del Consiglio dei Ministri, che saltavano per lunghi periodi. Infine, nel giugno del 1997, Erbakan fu costretto a dimettersi. Se il tentativo compiuto da Refah alla metà degli anni Novanta sembrò acerbo e iniziale, non così appare l’attuale governo assicurato dal Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Recep Tayyip Erdogan, ex sindaco di Istanbul negli anni Novanta. Più maturo e strutturato è il progetto politico dell’attuale governo turco e del suo leader, il primo capo di partito che proviene veramente dal basso e non fa parte di un’élite affarista o politica di professione. L’Akp è giunto al potere dopo la vittoria elettorale del 3 novembre 2002, assicurandosi una maggioranza assoluta nel nuovo parlamento, con dinanzi a sé soltanto un forte partito di opposizione. L’Akp può disporre di 363 deputati su un totale di 550. Il dato è senz’altro significativo da più punti di osservazione. Al di là del colore islamico del partito di maggioranza, è da notare che la Turchia con la vittoria dell’Akp ha la possibilità di avviarsi, dopo undici anni di governi di coalizione di breve durata e di difficile convivenza, verso un periodo di stabilità politica. Il condizionale è d’obbligo perché fin dai primi passi l’attuale governo ha dovuto affrontare l’ostilità di ampi settori istituzionali, preoccupati per la presenza degli islamici al potere. Tra le istanze con cui l’Akp si trova a dover fare i conti ci sono anzitutto quelle della Presidenza della Repubblica cui spetta l’ultima parola, tra l’altro, sulle nomine governative, che non ha mancato di esercitare il suo potere di veto su molti provvedimenti governativi. Ma non solo. Lo “Stato profondo”, come viene comunemente chiamata l’istituzione militare, esercita anch’esso il suo potere di veto e di controllo sull’azione di governo attraverso il Consiglio di Sicurezza Nazionale. Sull’Akp pesa, infatti, come prima sul Refah, il sospetto che l’adesione ai principi democratici e laici su cui poggia la repubblica sia soltanto di facciata e che esso, una volta al potere, possa in qualche modo minare alla base l’identità stessa del paese. In questo senso, com’è noto, Erdogan stesso, quando era sindaco di Istanbul tra il 1994 e il 1996, fu accusato di tendenze anti-democratiche contrarie ai principi della laicità dello stato per aver letto in pubblico alcuni brani di un poema in cui si paragonavano i minareti alle baionette e le cupole delle moschee agli elmi di guerra. Egli fu incriminato nel 1998 e soltanto a governo avviato ha potuto accedere alla presidenza del Consiglio dei Ministri. I critici di tendenza laica hanno anche accusato il premier di non avere assunto una chiara posizione contro il terrorismo islamico quando, nel momento in cui la Turchia è stata scossa lo scorso novembre da sanguinosi attentati, egli ha condannato sì il terrorismo, ma non ha mai accostato ad esso il termine “islamico”. Gli ambienti più laici hanno chiesto al premier, proprio 76 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Paola Pizzo in ragione della minaccia del terrorismo che ha colpito il paese, di denunciare e prendere le distanze in maniera chiara e netta dalle dottrine wahhabite e salafite che sarebbero alla base dell’ideologia dell’estremismo islamico contemporaneo. I critici di parte laica, però, non riconoscono sufficientemente che il bersaglio di questo estremismo è oggi soprattutto una nuova visione dell’Islam, incarnata in Turchia dall’Akp, favorevole ad un rapporto costruttivo tra un’istanza politica di radice islamica e il sistema laico e democratico. Ciò che in altre regioni del mondo islamico è forse più sfumato, appare in Turchia in modo chiaro: è oggi in corso, all’interno di questo mondo, una lotta tra almeno due tendenze e approcci diversi all’azione politica, divise sul ruolo e sull’importanza delle istituzioni della democrazia e sulla laicità delle istituzioni. L’attacco alla Turchia, in questo contesto, rappresenta una contestazione alla sua funzione di ponte tra l’Islam e l’Occidente. Pensando a Istanbul e alla sua collocazione geografica tra Asia ed Europa, il ponte sul Bosforo potrebbe essere preso come metafora di un cammino che il paese sta compiendo per attuare uno scambio, auspicabilmente proficuo per entrambe le parti coinvolte, tra Islam e valori democratici, tra Oriente e Occidente, tra Asia ed Europa. All’indomani della vittoria elettorale del 2002, molti osservatori hanno parlato dell’avvento di una democrazia islamica o di un Islam democratico. Anche se ha trovato molte critiche nella stessa Turchia, questa definizione pone in rilievo la questione che tutti preoccupa: se cioè la Turchia riuscirà a proporsi come una “terza via” tra l’Islam ufficiale e immutabile dei vari regimi arabi, più o meno democratici, e l’ala estremista radicale, che ne critica la legittimità con mezzi tutt’altro che pacifici e democratici. Lo scontro in atto in Turchia costituisce un crinale importante per tutto il mondo islamico, in cui si assiste ad una lotta tra un Islam che ha scelto pragmaticamente per la democrazia – e perciò ha cambiato il suo linguaggio e le sue priorità – e un Islam estremista, che teme, forse, il successo di tale tentativo di conciliazione. Al di là quindi delle definizioni, sembra che la questione non sia se l’Akp possa o meno rappresentare l’equivalente della Democrazia Cristiana nel mondo islamico, ma piuttosto quella di vedere come il partito riuscirà ad affrontare la duplice sfida che si trova davanti: quella della democrazia e quella dell’Islam, ovvero come conciliare le sue radici islamiche con le aspettative di democrazia e laicità che le giungono non solo dall’Europa, ma anche dalla stessa opinione pubblica turca e, più in generale, da diversi settori del mondo musulmano. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 77 Dall’idea di Europa all’integrazione europea L’idea di Europa come organizzazione e unione politica affonda le sue radici nel passato. Sembra, pertanto, opportuno chiedersi quale valore concettuale abbia oggi il termine “Europa” ed in che cosa esso differisca da quello che aveva nel passato, dal mondo antico a quello moderno e contemporaneo. MARISA FERRARI OCCHIONERO Università di Roma “La Sapienza” • L’“idea” di Europa ed il suo processo storico Va, in primo luogo, chiarito che l’espressione, nel suo valore storico, è cosa ben difforme dalla sua definizione e delimitazione geografica. Dal punto di vista geografico l’Europa è un continente con determinati caratteri e confini; ma la storia non è una realtà statica bensì creazione umana, continuamente mutevole con il mutare del pensiero e dell’azione. Si tratta, quindi, di scorgere se al di là dei limiti geografici sia esistita ed esista una Europa come unità storica. Scriveva Erodoto: “Dell’Europa nessuno al mondo sa se sia circondata dal mare, né dove abbia tratto questo nome, né si conosce chi glielo abbia dato”. Analogamente Erodoto discorre anche dell’Asia, ben differenziandola dall’Europa ma in un senso geografico. Celebrando le guerre vittoriose dei greci contro i persiani, Erodoto contrappone gli Elleni ai Barbari. Solo successivamente tale contrapposizione assurgerà a simbolo di due civiltà, o meglio di due mondi: d’Europa e d’Asia. Un esatto concetto d’Europa non può quindi scaturire dal pensiero greco come, peraltro, resta estraneo a quello romano. Nel Medioevo ciò che domina è la christianitas con la sua concezione ecumenica, non l’Europa. Comunque, il graduale configurarsi di un’Europa cristiana romano-germanica già Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 ≈ “... È di grande interesse dare vita ad un processo di democratizzazione della politica e del politico in una Europa integrata...” ≈ 79 Marisa Ferrari Occhionero prelude, nelle sue linee principali, all’Europa moderna. L’Europa centro-occidentale diviene il fulcro di questa unità spirituale e culturale. Pur nei suoi limiti, il Sacro Romano Impero rispondeva all’istanza unitaria. Con l’Età Moderna, la nozione di respublica christiana subisce una forte incrinatura, surrogandosi ad essa nuovi concetti animatori e regolatori della vita europea: col declino dell’auctoritas si rafforza, di contro, il senso d’indipendenza dei singoli stati, favorito dal sentimento di nazionalità, cioè di quella natio che costituiva l’elemento etico-razziale degli Stati barbarici nati dal dissolvimento di Roma. L’Europa cessa di essere il solo continente cristiano a ragione del fatto che turbe sempre più numerose ed eterogenee di popolazioni extraeuropee abbracciano la religione di Cristo; il continente viene in tal modo a perdere una sua tipica ed esclusiva caratterizzazione. Per quanto concerne l’aspetto politico, l’Europa diviene un sistema di Stati sovrani e indipendenti; dal punto di vista spirituale, una unità di cultura. Assurge a canone cardinale della politica europea, dopo il ’400, il “principio dell’equilibrio”, parallelamente alla convinzione di una comunità politica in cui gli interessi di un paese sorgono, si mantengono e si sviluppano “in reazione” agli interessi di altri paesi. Non sembra superfluo ricordare come questo principio sia stato assunto a base della politica negli Stati italiani prima che negli Stati Europei, tanto che il signore della Firenze medicea, Lorenzo il Magnifico, veniva definito l’ago della bilancia politica italiana. I trattati di Westfalia (1648) segnano un primo riconoscimento ufficiale della solidarietà d’interessi degli Stati moderni, i quali, contrari ad ogni autorità estranea alla propria, debbono necessariamente cercare in se stessi e nei mutui rapporti d’alleanza un rimedio contro ogni abuso ed ogni minaccia egemonica; il principio dell’equilibrio, posto in primo piano, diventa quindi garanzia di stabilità e di sicurezza. Va sottolineato, poi, quel faticoso sforzo di riorganizzazione generale che fu il Congresso di Vienna, il quale, nel tentativo di imprimere nuova vita al vecchio sistema, fece chiaramente intendere come la garanzia dell’equilibrio non dovesse essere più lasciata ai singoli stati, ma affidata ad un gruppo di grandi potenze e ad un sistema di alleanze. Ha così origine il cosiddetto “concerto europeo” che, con grande varietà di criteri, ha operato nella vita internazionale fino alla prima guerra mondiale. Ha notato molto esattamente Federico Chabod che “la prima chiara formulazione dell’Europa, come di una comunità dai caratteri ben specifici e puramente laici, non religiosi, si ha col Machiavelli; e, naturalmente, trattandosi del Machiavelli, non può essere che una formulazione di carattere politico”. In Rousseau il senso dell’Europa è colto in tutti i suoi elementi e così pure, sebbene in maniera difforme, in Voltaire ed in Montesquieu, tanto che Chabod sostiene che nel ’700 si giunge finalmente all’idea di Europa quale entità morale e civile. 80 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Marisa Ferrari Occhionero Eppure è nel clima liberale e romantico del primo Ottocento che la coscienza europea compie un decisivo passo innanzi perché essa si storicizza: si precisa, infatti, la consapevolezza che l’Europa è una formazione storica. Inoltre, l’idea di Europa attraverso le prime lotte di nazionalità, si politicizza più fortemente; in tal senso l’idea dell’unità (come proposito o volontà di unificazione) acquista nella prima metà del secolo XIX una profondità di tono precedentemente sconosciuta. • L’inizio del “pensare europeo” Per dirla con Madame de Staël si cominciava, politicamente, “a pensare in europeo”, ad intuire seriamente, cioè, la necessità di organizzare in senso unitario la vecchia Europa. Al Congresso di Vienna, che inaugurava proprio allora la prima e disturbata serie dei suoi lavori, veniva rivolto il monito di dedicarsi ad un’opera di feconda ricostruzione e l’invito “ad unire i popoli europei”. Si trattava, quindi, di creare un “governo europeo, che esercitasse un effettivo potere, anche a costo di sacrificare o limitare le prerogative sovrane di ogni Stato”. Il problema europeo tocca il suo apice con Mazzini: la stessa vicinanza non casuale di due date, la fondazione della Giovane Italia (1831) e della Giovane Europa (1834) offre una eloquente testimonianza. Il Mazzini, ponendo il problema europeo in termini di “nazioni” e non di “nazionalismi”, intuiva la necessità di un sacrificio comune a tutti i popoli per la costituzione di un’Europa unita. Tra i tentativi unionistici, tutti di valore essenzialmente utopistico, si precisa sempre meglio il concetto di una comunità interstatuale, come società uniforme di soggetti giuridicamente uguali, ma si smarrisce il senso profondo dell’altra “comunità” quella morale e politica, cui si era tanto guardato nella prima metà del secolo decimonono. Il concetto dell’unità europea attraversa così la sua crisi più grave: si comincia col respingere l’idea dell’unità per sostituirvi quella di unione: non più, dunque, uno Stato federale sul modello americano, ma una federazione di Stati, così come essi sono, dispotici o liberali, laici o clericaleggianti. A questo punto la storia dell’idea unitaria devia ancora una volta e si complica perché interferisce e si innesta con un’idea nuova che albeggia: quella dell’unità intercontinentale. Vari eventi, soprattutto di carattere bellico, fanno sì che la storia del mondo non venga più a coincidere con quella del Vecchio Continente; la storia d’Europa si dissolve ormai in quella del mondo, tanto da far osservare, nel 1922, ad uno studioso tedesco, W. Schücking, che gli Stati europei avevano ormai troppi interessi vitali fuori dal Vecchio Continente perché fosse possibile creare tra essi un legame federativo, senza associarvi in pari tempo le altre parti del mondo. L’unione europea sembrava ormai corrispondere ad una epoca superata. La fine della prima guerra mondiale segnava il tracollo dell’egemonia dell’Europa e l’inizio Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 81 Marisa Ferrari Occhionero di una nuova fase. Il crollo finanziario di Wall Street del 1929, che di lì a poco doveva coinvolgere gran parte dell’Europa in una crisi economica di ampiezza prima sconosciuta, con profondi e gravi riflessi sociali, era un segno negativo e quasi premonitore del peggio; al tempo stesso doveva però porsi come un incentivo per i politici a dare vita ad un legame effettivo, permanente, tra i paesi europei. Numerose le iniziative in proposito: dall’unione paneuropea, favorita dal Conte Coudenhove-Kalergi a Vienna (prima in ordine cronologico), al comitato di cooperazione europea e all’unione doganale europea, sorti a Parigi. È, comunque, ad uno statista francese, Aristide Briand, Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, che si deve la fase culminante dell’azione sul piano internazionale. Il memorandum Briand, che reca la data del l maggio 1930, fu indirizzato alle cancellerie europee il 17 dello stesso mese: esso postulava la necessità di un patto generale, sia pure élémentaire, affermante il principio dell’unione morale europea e consacrante la solidarietà fra gli Stati; inoltre, insisteva sulla necessità di un mécanisme idoneo ad assicurare all’unione europea gli organismi essenziali al perseguimento dei suoi fini. Il documento, pur assumendo nella fattispecie la veste di un’iniziativa politica rispecchiante l’aspirazione diffusa nella élite dirigente europea, si preoccupava, e ciò era palese nelle pieghe del linguaggio diplomatico, di non urtare la suscettibilità dei governi. II progetto Briand perdette di lì a poco il suo mordente e finì, allorché venne affidato dalla Società delle Nazioni ad un “Comitato di studi per l’Unione Europea”, con l’insabbiarsi. A questa esperienza altre se ne aggiunsero nel ventennio fra le due guerre, atte a dimostrare che non vi poteva essere “una politica” come espressione “di una società sopranazionale e internazionale allo stesso tempo, ma vi erano varie politiche che corrispondevano ai vari punti di vista che gli stati più attivi e potenti riuscivano a far valere”. La situazione europea al termine del primo conflitto mondiale era tale da fare ritenere a molti, ivi compreso Norberto Bobbio, che la guerra avesse distrutto, forse irreparabilmente, il sentimento di una coscienza europea. Il sistema degli stati nazionali europei appariva ormai antiquato e insufficiente: nessuno Stato che fosse esclusivamente europeo, poteva in ultima analisi dirsi indipendente perché le sue forze (e non solo quelle militari) erano troppo modeste ed il suo stesso “spazio” troppo angusto. • Il concretizzarsi dell’“europeismo” dopo il secondo conflitto mondiale È solamente nel secondo dopoguerra che la questione europea è andata gradualmente passando dal piano problematico a quello risolutivo, trasformandosi, finalmente, nell’ambito delle iniziative pratiche. La guerra, quella che è stata chiamata la “tragica esperienza” del Continente, è valsa a dare un nuovo avvio all’idea politica europea. Già durante il conflitto si erano andate precisando le iniziative, ma sempre su di un piano generico, di una 82 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Marisa Ferrari Occhionero “unità” europea. Ma il lungo iter del divenire politico dell’Europa trova il suo atto di battesimo nel discorso pronunciato da Winston Churchill a Zurigo nel settembre 1916. Per Churchill il problema fondamentale consisteva nel constatare l’attuale lacuna europea quale “assenza” politica in una disposizione di forze ormai ben determinate nel mondo e nel provvedere in tempo optando decisamente per l’unico rimedio possibile: “Ricostruire la famiglia europea significa che occorre creare un qualcosa come gli Stati Uniti d’Europa; il primo passo in questo senso sarà di costituire un Consiglio d’Europa”. Egli auspicava, quindi, l’organizzazione di un’Europa così come, precedentemente, l’avevano intravista Briand e Coudenhove. Al Congresso dell’Aja, nel maggio 1948, Churchill affronta per la prima volta il problema di una organizzazione politica raccomandando l’abbandono, che egli ritiene condicio sine qua non, di una parte della sovranità nazionale e reclamando la convocazione di un’assemblea europea. Seguono quasi subito iniziative concretizzantisi in movimenti europei tra i quali ricorderemo l’Unione Europea dei Federalisti, l’Unione Parlamentare Europea (tendente a realizzare l’intesa dei Parlamenti nazionali europei e a promuovere la costituzione di un Parlamento europeo, eletto dalle Assemblee nazionali) e infine, sollecitato dal Comitato di Coordinazione dei vari movimenti europei, il Movimento Europeo, avente nella sua linea la funzione di coordinare tutte le tendenze e le forze europeistiche che almeno in parte divergevano. L’argomento politico dell’unità europea nella prospettiva di un Parlamento sovranazionale era il punto fondamentale dell’interesse e della controversia. Dall’inizio del ’48, dopo i ripetuti fallimenti di un’intesa fra Oriente e Occidente si delineano delle manifestazioni di solidarietà europea sempre più concrete; nel marzo del 1948 il Patto di Bruxelles suggella l’intesa, sul piano militare, tra Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, intesa atta a prevenire un’eventuale ripresa della Germania ma anche, ed è questo senza dubbio l’aspetto più interessante, valevole a rinsaldare i legami economici, sociali e culturali già esistenti fra i Cinque, e a costituire, quindi, una base solida per la ricostruzione dell’economia europea. Nascono così un Consiglio Consultivo (dei Ministri degli Affari Esteri), un organo permanente, un comitato militare e, ancora, una serie di comitati di esperti. Questa unione costituì poi il nucleo di quello che sarà il Patto Atlantico. Contestualmente si poteva assistere alla riabilitazione della Germania Occidentale ed alla sua partecipazione alla politica europea. Nel 1948 sembrò improvvisamente che gli europei avessero capito: meno di un anno dopo, le potenze firmatarie del Patto di Bruxelles proponevano alle altre potenze del continente di creare il Consiglio d’Europa. Esso nacque agli inizi del 1949; nell’agosto dello stesso anno si riunivano, per la prima volta, a Strasburgo, le assise europee: il Comitato dei Ministri e l’Assemblea. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 83 Marisa Ferrari Occhionero • Verso la formazione di un diritto sovranazionale La catastrofe che, attraverso le due guerre mondiali, ha condotto gli Europei dall’essere il centro ideale, politico, economico e militare dell’umanità all’attuale condizione di forza politica in certo modo gregaria e di secondo ordine, di sistema economico impossibilitato in parte a sviluppare i metodi produttivi che la scienza e la tecnologia contemporanee vanno delineando, non proveniva da altro che dalla anarchia internazionale europea, secondo la logica del sistema degli stati nazionali sovrani. Il principio di sovranità spingeva ogni stato europeo ad armarsi nel tentativo di assoggettare paesi minori ed a cercare per i propri cittadini mercati economici riservati, e ciò in omaggio ad una educazione improntata a criteri assolutamente nazionalistici e ad una cultura essenzialmente di tipo egemonico. L’esperienza della prima guerra mondiale non era valsa a porre fine al sistema degli Stati nazionali sovrani che, anzi, avevano finito per assumere le forme più estreme ed illiberali. Questo stato di cose, perdurato per tutto il ventennio successivo al primo conflitto mondiale, è stato acutamente reso in un’opera di Altiero Spinelli, che scrive: “Fra le mostruosità rivelate da questa guerra, quella che più ha affascinato molti europei è stata la capacità per lo Stato nazionale moderno di spazzare via ogni freno ed ogni controllo democratico, di impadronirsi in modo totale dell’anima, del corpo, del lavoro, dei beni di tutti i suoi cittadini, di ridurli a strumenti della propria potenza”. La seconda guerra mondiale, che era consistita in una corsa sfrenata per la conquista dell’egemonia in Europa e nel mondo, doveva dare inizio ad un singolare processo di “autodistruzione”, cui il vecchio regime degli Stati nazionali sovrani costringeva il continente: “In mezzo al sangue e alle fiamme della seconda guerra mondiale è crollato vergognosamente il vecchio regime degli Stati nazionali sovrani” scrive enfaticamente Spinelli. Infatti, l’Europa era uscita da questo conflitto impoverita e spossata ed il principio della sovranità nazionale, così solidamente stabilito nell’Ottocento, veniva a frantumarsi, ingenerando il convincimento di essere giunto al suo naturale epilogo. Il sistema degli stati nazionali si delineava ormai superato dagli eccezionali avvenimenti dell’ultimo dopoguerra. La mutilazione della Germania, il ritiro della Gran Bretagna in una posizione vieppiù secondaria, la situazione di prostrazione e di assoluta mancanza di autosufficienza economica e politica di ciascuno stato europeo erano realtà di fatto tali da far nascere l’idea della necessità, ormai più che evidente, di una federazione degli stati europei, di un’unione, cioè, in campo politico che permettesse ad un governo comune di trattare gli affari pubblici di generale interesse senza, naturalmente, cancellare dalla carta politica le singole nazioni. Il problema dell’anarchia internazionale europea era ormai avvertito dai più. Anche nel campo economico si evidenziavano le medesime insufficienze: lo stato di im- 84 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Marisa Ferrari Occhionero poverimento delle varie economie nazionali ne rendeva necessaria la cooperazione e il coordinamento atti a consentire una ripresa dell’economia complessiva. L’idea di sovranità, contrapposta all’idea di integrazione, ha tuttavia, in certi Stati, radici profonde: si può citare, per addurre un esempio significativo, la Francia, che come è noto, è ricca di un’antica tradizione nazionale. Mirabile fa osservare che, per quanto si possa essere contrari ai passati nazionalismi, “sarebbe antistorico ed anacronistico misconoscere le funzioni e certi aspetti positivi del nazionalismo”. Egli pone in rilievo una osservazione fatta da Hans Kohn, nella sua celebre opera L’idea del nazionalismo: che il nazionalismo “sorto in Europa occidentale nel secolo decimottavo, si è diffuso negli angoli più remoti della terra, e dovunque sia andato esso ha plasmato il pensiero e la società degli uomini secondo la propria fisionomia. L’epoca del nazionalismo si è manifestata su scala mondiale e, sebbene il nazionalismo non sia che una delle forze determinanti di quest’epoca, è abbastanza importante e comprensivo da consentire di definire l’epoca che comincia con Rousseau e Herder, con le rivoluzioni americana e francese, l’epoca del nazionalismo”. Tuttavia – è sempre Kohn – “il nazionalismo non è che una forma transitoria di integrazione, benefica e rinvigorente, la quale diventa però facilmente distruttrice della libertà umana per la sua stessa esagerazione e per il suo stesso dinamismo”. Fu così coniato il termine di “Ente sopranazionale”. Secondo Schuman “Le supra-national se situe à égale distance entre, d’une part, l’individualisme international qui considère comme intangible la souveranité nationale et n’accepte comme limitations de la souveranité que des obligations contractuelles, occasionelles et révocables; d’autre part, le federalisme d’Etats qui se subordonnent à un Super-Etat doté d’une souveranité territoriale propre”. • L’importanza della Ceca Tale neologismo fu appunto ripreso nel trattato istitutivo di quella importantissima organizzazione supernazionale in campo economico che è stata la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (Ceca). Il suo carattere “supernazionale”, come d’altronde quello delle altre due, la Ced e l’Euratom, consiste: nell’affidare l’esecuzione e l’attuazione delle disposizioni convenute dalle Alte Parti Contraenti ad organismi (istituzioni comuni) indipendenti dai governi e da ogni altra autorità degli Stati membri; nel sottrarre alcune materie alla competenza degli Stati membri per affidarle alla competenza della Comunità; nell’attribuire alle istituzioni stesse non soltanto un mero potere di esecuzione, ma, altresì, un vero e proprio potere normativo, un potere di giurisdizione, un potere di iniziativa ed un controllo politico. Tali principi, tutt’altro che trascurabili militano, quindi, attualmente, in modo ancora più imperioso che nel passato, in favore di una più estesa integrazione verso la sovranazionalità. Il primo grande passo in questo senso fu, quindi, compiuto con la ratifica del “Trattato istitutivo” del pool carbo-siderugico. Un secondo passo, del pari impor- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 85 Marisa Ferrari Occhionero tante, stava per giungere al suo epilogo allorché naufragò con la mancata ratifica del trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa. Abbiamo poi assistito, da quella data, al costituirsi di vari organismi internazionali a carattere europeo: l’Oece (poi Ocde), primo in ordine di tempo, avente lo scopo di istituire una forma di cooperazione assolutamente nuova per l’Europa, aperta a tutti i paesi che ne avevano riconosciuto il carattere d’urgenza; la Ceca già menzionata (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) di qualche anno successiva all’Oece, concretizzante lo sforzo di agire per settori, giacché, per il momento, il problema dell’integrazione europea si dimostrava senza prospettiva alcuna di soluzione. Sorto per ultimo, dal Trattato di Roma, ma con fini di grande portata e proiettati nel futuro, il Mercato Comune Europeo segna un grande passo avanti sul piano della integrazione economica. Convinti che la potenza politica scaturisca da quella economica, i sei paesi della “Piccola Europa” hanno dato vita ad un Comitato che si è prefisso il compito di costituire il mezzo per un riavvicinamento progressivo delle politiche economiche degli stati membri che porti, a suo tempo, ad una vera politica comune. Ma oltre ai successi riportati sinora dalla Comunità nel campo strettamente economico, non vanno trascurati i risultati positivi che, per quanto non sempre direttamente visibili, sono stati ottenuti sul piano politico. La conferma più appariscente ci viene dall’esterno. Basti pensare all’alone di indifferenza e di scetticismo incontrato dalla Comunità al suo nascere e guardare oggi, invece, al grande movimento di coloro che ad essa si accostano o per entrarvi o per associarvisi o, infine, per regolare con essa le linee direttrici del sistema commerciale ed economico del mondo libero. All’interno, le conseguenze politiche dell’azione comunitaria si esprimono in alcuni termini semplici ma molto significativi: consolidamento della solidarietà fra gli Stati membri, riconoscimento da parte dell’opinione pubblica della necessità di un’azione comune con i vantaggi ed i sacrifici che esso implica, adesione più ampia all’obiettivo d’unificazione, esperienza dei metodi d’integrazione. Tutti questi elementi formano la base per una cooperazione tra gli Stati membri estesa ai settori della politica estera, della difesa e delle relazioni culturali, cooperazione che, superando l’atteggiamento diffidente di qualche paese, ci si auspica possa presto estendersi, nel modo più completo, a tutti i paesi europei. • Il cammino successivo: dal Trattato di Roma a Maastricht, a oggi Seppure brevemente, si è tentato di delineare il percorso storico dell’“idea di Europa”, cercando di evidenziarne le radici culturali, ivi comprese quelle cristiane che ci appaiono in tutta la loro indiscutibile priorità. Oggi dobbiamo, comunque, confrontarci con un’“idea” che è profondamente cambiata per l’evoluzione e le di- 86 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Marisa Ferrari Occhionero namiche dello stesso processo europeo e per i numerosi cambiamenti intervenuti non solo nel continente europeo ma nel mondo intero. Così che l’Europa dei sei paesi, nata dal Trattato di Roma più di mezzo secolo fa, è “altra”, diversa dall’Europa di oggi, nata dal Trattato di Maastricht e formata da quindici paesi. Il Vecchio Continente ha seguito un percorso non facile, spesso, anzi, molto complesso, essenzialmente basato sul consenso, sul dialogo, sul rispetto delle “differenze” che, dopo tutto, costituiscono la ricchezza dell’Europa. L’Unione, che registra oggi la presenza di paesi cattolici e protestanti, è pronta ad accogliere in tempi molto brevi, con il suo allargamento ad altri paesi, paesi di religione ortodossa e musulmana. Il progetto politico europeo che, necessariamente, deve oggi tener conto dei profondi mutamenti di un mondo sempre più globalizzato, con tutti i suoi rischi e le sue innumerevoli sfide, può avere un ruolo fondamentale nel dare un grosso contributo al rafforzamento delle istituzioni di governance mondiale e del rispetto dell’ordine internazionale. Se davvero l’Unione Europea vuole diventare un “attore globale”, con un ruolo chiave nell’organizzazione di un mondo nuovo, caratterizzato da maggiore libertà, più giustizia e sicurezza, deve necessariamente migliorare le sue capacità civili e militari, i suoi strumenti di collaborazione tra i suoi partners. Il suo futuro si giocherà proprio sulla realizzazione di questi obiettivi oltre che sulla sua abilità di stabilire un dialogo con i nuovi paesi di differente cultura. A voler tracciare un bilancio degli obiettivi finora conseguiti, si può senza dubbio affermare che sino ad oggi molti di essi siano stati realizzati: essi includono gli ingredienti di uno Stato, cioè il territorio, una moneta, una politica comune in materia di sicurezza e, non ultima, la cittadinanza. L’obiettivo della moneta unica è stato realizzato con l’euro, che ha definito uno spazio economico comune, mentre gli altri obiettivi, più difficili da realizzare, sono in corso di attuazione. Il problema della cittadinanza sembra essere, in questo contesto, molto complesso per il fatto che, nella sua più ampia accezione, dovrebbe implicare la partecipazione dei cittadini all’elaborazione dei processi decisionali concernenti le norme e le politiche della Comunità: in altri termini, la salvaguardia dei diritti civili e politici. Ma anche qualcosa di più, perché esiste un’altra importante dimensione della cittadinanza, essenziale per completarne il concetto: quella che riguarda i diritti sociali, cioè la necessità di organizzare una vera democrazia sovranazionale in questa fase di costruzione europea. È di grande importanza dar vita ad un processo di democratizzazione della “politica” e del “politico” in un’Europa integrata, concepita come unione democratica di popoli che mettono insieme, sinergicamente, le loro risorse umane, intellettuali, in una concezione condivisa di quelli che devono essere i valori etico-politici e la qualità civile delle istituzioni. Presupposti tutti per un’integrazione europea, per la creazione di quegli “Stati Uniti d’Europa” così caldeggiati da Luigi Einaudi, Alcide De Gasperi, Altiero Spinelli e dallo stesso Luigi Sturzo. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 87 La cultura giuridica come specifico europeo Scriveva Pietro Rescigno: “Io credo che il tema della cultura, dello Stato di cultura, per usare una formula nota agli studiosi di diritto, debba intendersi (ed è forse compito del giurista contribuire a sottolineare questa accezione) anche nel senso che il diritto è un momento della cultura; e mi pare che la conciliazione dei sistemi giuridici nel rispetto delle peculiarità dei diritti nazionali vada visto come un capitolo, una fase, della più ampia vicenda della realizzazione dell’unità europea”. • Non cultura giuridica europea in generale, ma cultura giuridica in quanto “specifico” europeo. Considerando la materia dal punto di vista della sociologia del diritto non si può non avvertire la presenza di una certa colorazione weberiana, di quel “Nur im Occident”, “solo in Occidente”, che stigmatizzava i modi di formazione del diritto moderno e la peculiarità della sua razionalità. Weber parlava comunque di Occidente e non di Europa, mentre noi è di questa che siamo chiamati a parlare. Se, però, si tiene conto del fatto che vi sono strettissimi legami fra il termine occidente e la tradizione europea, si può ben comprendere come il motto weberiano tocchi il cuore del nostro tema. • L’etimologia di “Europa” SIMONA ANDRINI Università di Roma Tre ≈ “La cultura suggerisce e spiega la particolare funzione che il diritto ha avuto nella storia europea...” ≈ Mi piace allora richiamare alla memoria una antica etimologia di Europa, poi caduta in disuso ed abbandonata, secondo la quale Europa deriverebbe dal semitico Ereb che significa appunto Occidente forse in contrapposizione ad Asia, nome che si faceva pure derivare dal vocabolario semitico, dove Açu significava Oriente. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 89 Simona Andrini Recuperare questa etimologia, richiamare l’attenzione sul significato più profondo delle parole mi sembra importante se si vuole dare senso sostantivo a quanto asserito nell’enunciato del nostro titolo, in un momento storico – quale quello che noi attualmente viviamo – che appare aver progressivamente umiliato l’idea di Europa, paradossalmente, proprio quando sembra portarla al suo massimo apice. L’esempio delle dispute intorno al preambolo della Costituzione europea mostrano bene il senso di quanto vogliamo dire. Se da un lato il rumore di fondo sull’Europa è altissimo, dall’altro lato la sensazione che se ne ricava è quella che, viceversa, si stia perdendo progressivamente il senso pregnante di questa parola; che si stia perdendo il suo significato autentico strettamente legato appunto al concetto di Occidente e a quel “Nur im Occident” weberiano che si sostanzia nel rivendicare il valore primario della cultura (viceversa, fin troppo si parla di Europa funzionale, di Europa degli interessi, di Europa economica). Nella lezione weberiana, infatti, “solo in occidente” si producono le forme ed i modi di sviluppo del diritto moderno, si produce quella cultura giuridica europea della quale nel prosieguo andremo a parlare. E questo appare possibile perché solo in Occidente si sviluppa una certa forma di razionalità. • Significato di cultura e specifico europeo Voler affrontare il tema della cultura giuridica come specifico europeo significa, allora, prima di tutto, weberianamente parlare – senza tema della potenza delle parole – del destino dell’Occidente e del valore della sua cultura. Occorre allora partire da una definizione del termine “cultura”. Werner Jaeger nella sua splendida opera Paideia, parlando del concetto di cultura, affronta il tema della trasformazione (e banalizzazione) del moderno concetto di cultura, l’odierno volgersi del concetto dal suo singolare nel suo plurale (dalla Cultura alle culture). Operazione certo non solo grammaticale, perché in essa, viceversa, si consuma lo sradicamento di un concetto di valore e la trasformazione, la trasfigurazione, di quest’ultimo, in una categoria puramente descrittiva. Jaeger insiste sulla necessaria distinzione tra il concetto di “cultura” inteso come concetto semplicemente antropologico, che significa tutto il modo di vita o il carattere di una particolare nazione, e “cultura ”come consapevole ideale di umana perfezione. In questo ultimo senso umanistico di “ideale di cultura” (in greco areté e paideia) la parola usata è una particolare creazione del pensiero greco. Viceversa, il concetto antropologico di cultura è un’estensione moderna del concetto originario; ma con questa si è trasformato un concetto di valore in una categoria puramente descrittiva che può essere applicata ad ogni nazione, anzi anche alla cultura dei primitivi. “Nel logoro uso verbale odierno, noi siamo soliti applicare il concetto di cultura per lo più non nel senso di ideale appartenente alla sola umanità post- 90 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Simona Andrini greca” (senza l’idea greca della cultura non vi si sarebbe una antichità classica quale unità storica, né un “mondo civile occidentale”) ma, con significato reso assai banale, generalizzandolo, a tutti i popoli della terra, compresi i primitivi; intendiamo, cioè, per cultura nient’altro che l’insieme delle manifestazioni e forme di vita caratteristiche di un popolo. La parola cultura si contamina e decade in tal modo a concetto antropologico meramente descrittivo e non rappresenta più un altissimo concetto di valore, un ideale consapevole. (Posizioni analoghe saranno sostenute da Karl Löwith a proposito della decadenza dell’università). In questo significato vago e sbiadito, di mera analogia, è allora lecito parlare di cultura cinese, indiana, babilonese, ebraica o egiziana, sebbene in nessuna di tali lingue si trovi un vocabolo corrispondente e la consapevolezza del relativo concetto; può essere in tal modo applicata ad ogni nazione, anzi anche alla cultura dei primitivi, perché ha interamente perduto il suo vero significato normativo. Ma cosa intendere con “significato normativo”? Criticando la definizione di cultura data da Matthew Arnold, “il meglio che sia stato pensato e detto in ogni età”, Jaeger fa notare che in questa definizione ciò che viene ad essere oscurato è proprio il senso originale (educativo e normativo) della parola, il suo significato più profondo: la cultura come educazione, affinamento, miglioramento teso allo sviluppo della più autentica umanità dell’uomo. Questa definizione, infatti, – dice ancora Jaeger – tende a fare della cultura una specie di museo cioè è paideia nel senso del periodo alessandrino, quando venne a designare erudizione. Viceversa, come vedremo, il senso originale (educativo) della parola è insito già e proprio nell’etimologia della stessa parola cultura. Di questa funzione normativa della cultura è proprio Jaeger a farci comprendere il significato grazie al rinvio al mondo greco. Se vi è stato un momento in cui la cultura intesa come ideale di perfezione umana ha dominato sullo stato e sulla religione, questo coincide con la grecità (l’Atene di Pericle) còlta nella sua massima fioritura. La cultura è stata il più alto lascito del mondo greco ed è stata lo strumento che ha consentito di unificare quel mondo quando tale unificazione non era possibile in senso politico. La cultura greca ci ha insegnato che la vera unità è quella spirituale, prima ancora che quella politica. E allo stesso modo sempre la cultura e in particolare la lingua per molti secoli hanno sostenuto e promosso l’unità spirituale dell’Italia. Dunque, l’unità deve essere prima di tutto una unità spirituale, perché questa consente quella dialettica della libertà intellettuale che non è possibile avere attraverso lo strumento della politica. • Cultura, lingua e unità spirituale Non è possibile certo in questa sede svolgere compiutamente un tale discorso, va però ricordato come questo insegnamento percorra tutta la storia spirituale eu- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 91 Simona Andrini ropea. Basti pensare a Burckhardt e all’idea di Kulturstaat presente nelle sue Weltgeschichtliche Betrachtungen; oppure sempre a Jaeger, quale erede e sostenitore del valore della cultura; a loro va inevitabilmente aggiunto il nome di Goethe. E il diritto? E l’importanza del diritto nella storia europea? È, come si vedrà, sempre la cultura a suggerirci le ragioni che spiegano la particolare funzione svolta dal diritto in tale storia. Cultura è parola polisemica che muta a seconda della lingua che la esprime. In italiano abbiamo solo la parola cultura, per parlare di due concetti che la lingua francese esprime con le parole culture e civilisation. Parlando di cultura e di cultura giuridica noi parliamo di cultura nel senso che la lingua francese attribuisce alla parola civilisation e quella tedesca alla parola Kultur. Un discorso a parte sarebbe quello di affrontare, dal punto di vista giuridico, il significato del concetto tedesco di Bildung e del suo rapporto con quello di Kultur. A partire dallo splendido capitolo sul trascendimento della dimensione estetica (Die Transzendierung der ästhetischen Dimension) ed in particolare a partire dal paragrafo sui concetti guida umanistici (Humanistische Leitbegriffe) presenti in Wahrheit und Methode di Hans Georg Gadamer. Purtroppo la fascinazione di questo discorso ci porterebbe troppo lontano dai brevi cenni di questa relazione. Kultur allora nel senso di civilisation. Infatti, per civilisation si intende non solo l’accezione di un’opera di civilizzazione, d’incivilimento, ma anche quella del risultato di essa, frutto di un’azione secolare, in virtù della quale i costumi degli uomini si dirozzano sempre più. È in questa seconda accezione che civilisation non è diverso dal tedesco Kultur. Questa accezione traduce però sempre una connotazione giuridico-normativa, che può essere rilevata facilmente grazie all’etimologia stessa del termine. In francese Civil (XIII secolo), Civilité (XIV) sono giustificati senza difficoltà dai loro antecedenti latini (Civis ). Civiliser è più tardo e lo si trova nel XVI secolo in due accezioni: 1) Mener à la civilité, rendre civiles et douces les moeurs et les manières des individus ; 2) En jurisprudence: rendre civile une cause criminelle. Ora, è questa seconda accezione che fornirà la base del sostantivo Civilisation che il Dictionnaire Universel, Trevoux del 1743 definirà come Terme de jurisprudence. C’est un acte de justice, un jugement qui rend civil un procès crimine. Di poi l’accezione giuridica non verrà più menzionata (perché quell’opera di incivilimento nel diritto è ormai compiuta), ma, a ben vedere rimarrà presente concettualmente. Leggiamo insieme cosa troviamo in Snetlage nel 1795 alla voce “Civilisation”: Ce mot, qui ne fut en usage qu’en pratique, pour dire qu’une cause criminelle est faite civile, est employé pour exprimer l’action de civiliser ou la tendance d’un peuple de polir ou plutôt de corriger ses moeurs et ses usages en portant dans la société civile une moralité lumineuse, active, aimante et abondante en bonnes oeuvres. (Chaque Citoyen de l’Europe est aujourd’hui parti dans ce dernier combat de civilisation. Civilisation des moeurs). 92 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Simona Andrini • Cultura giuridica e civilizzazione Cosa ci insegnano queste brevi, ma significative citazioni? Che a ben vedere, trasformare in civile una causa penale, ovvero il passaggio da un diritto penale ad un diritto civile esprime proprio quel senso dell’azione di dirozzamento dei costumi che il termine civilisation ancora una volta evoca sebbene svincolato dalla sua menzione giuridica. Detto altrimenti, se noi pensiamo al passaggio dal diritto primitivo al diritto moderno, e dunque al passaggio da un diritto solo penale (ad esempio dal diritto repressivo proprio delle società primitive del quale ci parla Durkheim, la legge del Taglione) ad un diritto “civile” appunto (il diritto restitutivo – del quale sempre ci parla Durkheim – proprio delle società moderne), non è difficile vedere che in esso si compie quel “degrossissement des moeurs”, dirozzamento dei costumi, che la parola civilisation porta con sé e che comporta una “civilizzazione” del diritto che si sostanzia, come noto, nella riconosciuta distinzione tra “delitto” che reclama vendetta e “torto” che obbliga al risarcimento. Non è difficile vedere, qui, il compiersi di quel passaggio – analizzato nella sua Sociologia del diritto da Max Weber – da una dimensione indifferenziata del diritto (ogni azione giudiziaria è sempre ex delicto) ad una dimensione “civile” (differenziata) del diritto che “conosce” l’obbligazione ed il contratto. Dunque, il diritto è prima di tutto civilizzazione, è prima di tutto cultura. Lo è, però, sempre? O lo è solo quando assume una particolare funzione, una specifica collocazione? Se si è compreso il significato della cultura rispetto alla tradizione europea, sarà agevole intendere anche la funzione del diritto. Poiché se prendiamo in considerazione la funzione che nel mondo latino ha svolto il diritto possiamo subito vedere come il diritto stesso sia riuscito entro certi limiti a svincolarsi dall’imperium, a non confondersi con questo e a semmai condizionarlo grazie alla sua natura autenticamente culturale. Il diritto romano, infatti, è stato prodotto prima di tutto – come ancora una volta ci ricorda Weber – dai giuristi, dalla loro intelligenza autonoma, dal loro senso del justum. Questo diritto, perciò, è stato prima di tutto opera di cultura. Ed è stata, – va di nuovo sottolineato – proprio quest’opera di cultura a rendere possibile l’unificazione di una società tanto complessa, piena di differenti tradizioni ed etnie come quella antica. Dunque il diritto nella nostra tradizione è nato e sostanzialmente resterà prima che comando (imperium) cultura giuridica. Che cosa è infatti la cultura giuridica? E perché è uno specifico dell’Europa o, nel senso da noi indicato, dell’Occidente? Cosa deve intendersi per “cultura giuridica”? La risposta non è facile come sempre accade ogni qualvolta si tenti di definire un rapporto che implichi più di una determinazione. L’espressione cultura giuridica, infatti, assumerà significati diversi a seconda del valore che vorremo di volta in volta dare, rispettivamente, all’espressione “diritto”. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 93 Simona Andrini Se pensiamo al diritto, (la cui asperrima definizione rende da sempre insonni le notti dei giuristi) assumendo la definizione di esso più restrittiva possibile, quella che fa coincidere il diritto con lo ius positum, con il diritto positivo e che, positivisticamente, accetta l’equazione: diritto eguale norma, allora rischiamo di perdere l’autentico suo significato proprio rispetto alla nostra migliore tradizione. Si schiude, in tal modo, di nuovo, un’antica querelle riguardo al rapporto tra scienza del diritto e diritto che trovava il suo analogo corrispettivo nella vexata quaestio dei problemi della conoscenza della storia del diritto che tentavano di distinguere tra Storia interna e storia esterna, tra historia iuris e antiquitates iuris, tra diritto popolare e diritto scientifico, tra storia della legislazione e storia della giurisprudenza, storia delle fonti del diritto e storia del diritto. • La scienza giuridica In tale prospettiva cultura giuridica diviene solo scienza del diritto. Ma cultura giuridica non può solo essere ridotta al significato di scienza del diritto, perché essa è anche il risultato ad esempio dell’esperienza giuridica, ed ancora, essa risulta strettamente legata anche ai modi della sua produzione; in tal senso, cultura giuridica diviene espressione di quell’elemento cardine che segna la mutazione profonda che si produce all’interno del diritto: la materia giurisprudenziale (ed oggi è proprio la dimensione normativa nella sua espressione meno codificata, quella appunto giurisprudenziale, che più produce cultura giuridica). Ed infine, riprendendo un paradigma caro allo ius commune, che mai come oggi appare attuale, il diritto è stato prima di tutto stile, ovvero modalità di elaborazione della giustizia e del diritto nelle antiche corti europee e dunque di nuovo cultura. il richiamo allo stile ci permette di sottolineare la dimensione autonoma delle procedure e della formazione del diritto. Infatti, lo sviluppo dello ius commune, delle sue modalità, forme ed attuazione non fu applicazione passiva, ma creativa eseguita in assoluta spontaneità. Vale la pena di citare un passo di Artur Duck, giurista inglese della prima metà del Seicento, Obsequium quod praestant Romanis Legibus est spontaneum, non ex potestate imperantium, sed vi Rationis, cui omne genus Humanum, teste Baldo tenetur obedire. Dunque, la ripresa del diritto romano in Italia ad opera dei Glossatori, la fondazione di uno studium iuris di Piacentino a Montpellier, come segno della cultura romanistica, l’influenza del breviario alariciano sulla legislazione di Guglielmo il Conquistatore quale origine della common law in Inghilterra, la ricezione del diritto romano sotto Massimiliano in Germania, i commentari alle Pandette che hanno consentito lo sviluppo della razionalità del diritto svincolata dalle esigenze immediate del dominio (imperium) (quicquid non agnoscit glossa, non agnoscit forum) costituiscono il segno rivelatore del fatto che l’Europa per lungo tempo ha potuto esperire la sua unità grazie alla cultura giuridica e alla sua relativa autonomia. 94 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Simona Andrini È bene qui ricordare per la Francia l’opera di Portalis, il quale trasfuse nel codice proprio il suo lavoro di commentatore delle Pandette. Ma corre l’obbligo anche di ricordare la lotta di Savigny (critico rispetto alla codificazione) in favore del primato della cultura giuridica intesa come unico elemento capace di garantire, in Germania, una unificazione del diritto non strumentale all’imperium e prima ancora Io ius cosmopoliticum di Kant, oggi così rivalutato dopo un lungo periodo di oblio. Tradizioni queste che non tramontano neppure quando in Europa si affermano definitivamente le codificazioni e il primato dello Stato (ovvero del politico). Si pensi a Léon Duguit in Francia, per il quale il diritto fu inteso come espressione del sociale e della sua cultura, penso all’opera di Hans Kelsen critico della feticizzazione dello Stato (ma prima di Kelsen, vanno ricordati Georg Jellineck e di nuovo Weber), e si pensi infine – ma le citazioni potrebbero continuare a lungo – a quando, nel corso di quella che fu chiamata “la guerra civile europea”, la difesa della funzione autonoma del diritto e della sua razionalità venne difesa, proprio contro le invasioni più irrazionali della politica. È possibile, allora, affermare che, se l’Europa ha potuto godere nel corso della propria storia di una grandiosa fioritura della cultura giuridica, la cosa di maggior rilevanza è che tale fioritura si è potuta sviluppare in autonomia condizionando per molti secoli la vita europea e indirizzando quest’ultima verso una sostanziale, e non meramente formale, unità spirituale. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 95 Ritratto di statista: le radici dell’europeismo di Alcide De Gasperi Alcide De Gasperi, ovvero “Degasperi” secondo l’imperialregia anagrafe, primo di quattro figli, visse in maniera piena e partecipe una lunga stagione di crescita e di impegno civile sotto l’egida rassicurante dell’aquila bicipite: dalla nascita nel 1881, al crollo dell’Impero nel novembre 1918; trentasette anni, più della metà della sua stessa esistenza. Eppure, per questo complesso di profonde radici e di solide ragioni, egli fu accusato di austriacantismo e di antipatriottismo dai nazionalisti prima della Grande Guerra e poi dai fascisti nel primo dopoguerra e, nel secondo dopoguerra, fu bollato col marchio d’infamia dell’anti-italianesimo e additato come reazionario ultramontano e nostalgico dalla destra nazionale repubblicana. • In realtà, De Gasperi dovette moltissimo alla sua remota ma fondamentale formazione sotto l’Impero Asburgico. Visse fino quasi ai quarant’anni – un’età in cui evidentemente un uomo ha già compiuto le scelte di fondo della sua esistenza – sotto la Duplice Monarchia: fra Trento, dove trascorse un’infanzia serena ma non esente da stenti e dove ricevette, presso il collegio vescovile, la prima educazione scolare, e Vienna, dove conobbe le difficoltà della condizione di migrante e dove si laureò in filologia presso l’Università rudolfina. Sempre a Vienna partecipò alla travolgente crescita politica dei cristiano-sociali di Karl Lueger, assorbendo dal magnetico leader viennese non poche suggestioni, senza peraltro condividerne tutte le scelte. In questo periodo della sua vita fu anche giornalista, brillante e inattesamente polemico, sulla stampa diocesana e civile trentina e tirolese. Ebbe inoltre contatti non effimeri coi cattolici italiani, segnatamente coi democratici-cristiani, del cui leader Romolo Mur- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 STEFANO TRINCHESE Università di Chieti-Pescara ≈ “... De Gasperi seppe mantenere una fondamentale distinzione tra nazionalità come sintesi di elementi linguistici, culturali,spirituali e religiosi, tali da creare l’identità storica...” ≈ 97 Stefano Trinchese ri fu ammirato lettore prima di assumere una più distaccata posizione (dopo le prime avvisaglie della reazione anti-modernista della Curia romana). Fu poi solerte e ascoltato assessore alla Dieta tirolese di Innsbruck nonché alfiere coraggioso e fiero del Partito Popolare trentino al Parlamento di Vienna dal 1911 al 1918, dove si distinse come deputato dinamico e libero. Prese infine parte a missioni ufficiose presso il governo italiano nel 1915, a margine dei tentativi di Vienna di mantenere la neutralità italiana a costo di un’eventuale sacrificio del Trentino. Da ultimo, seguì e assistette con dolente passione al biblico esodo dei profughi trentini verso i campi di internamento boemi dopo la dichiarazione di guerra del 24 maggio e prese parte, in maniera appassionata e disincantata, alla drammatica discussione sulle sorti del tramontante impero sullo scorcio finale del 1918. • De Gasperi e l’Italia Passò quindi in Italia, a rappresentare le esigenze autonomiste dei suoi compatrioti trentini, divenendo deputato del Partito Popolare Italiano di Luigi Sturzo. Anche nel Parlamento della nuova patria continuò a sostenere- con uguale acribia e fermezza – le coerenti ragioni di una politica di vaste autonomie e in favore di più ampi diritti sociali. Al dibattito politico italiano apportò come contributo personale quel senso di piena libertà partitica, e quell’esigenza di mediazione fra le opposte tendenze, che gli derivavano dalla peculiarità del cammino dei cattolici austriaci. A questi era infatti sconosciuta, a fronte della distanza della Questione Romana, l’alienante esperienza italiana di estraneità e avversione alle politiche dello Stato, e ai quali l’eredità giuseppinista aveva invece inculcato una decisiva coscienza di appartenenza e un più sicuro senso dello Stato. Proprio la diversità di provenienza, l’estraneità e l’alterità delle sue letture rispetto a quelle dei cattolici italiani, la differenza dei modelli – si pensi al ruolo esercitato nella sua formazione da un teologo come Ernst Commer e di un pubblicista come Friedrich Funder – e la stessa formazione di cattolico democratico e non confessionale, alla scuola del cattolicesimo tridentino impersonata dalla decisiva figura del vescovo Endrici, marcavano la diversità di De Gasperi. Rispetto alla più circoscritta dimensione del cattolicesimo politico italiano, ne scaturiva una forte caratterizzazione in senso europeo. Da quell’esperienza non gli pervennero, se non indirettamente – quasi “onde sulle sponde opposte” – i contrasti persino laceranti, mentre del conflitto intorno all’obbedienza alla Chiesa gli mancarono tanto le profondità del rovello, che il tormento della sua inadeguatezza, come ha ricordato Gabriele De Rosa. Il movimento trentino non ereditava una funzione, quasi definitoria, di condanna dello Stato moderno, non ebbe un movimento intransigente e astensionista, non fu toccato dal modernismo: partito possibilista, quello trenti- 98 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Stefano Trinchese no, capace di continua mediazione fra gli opposti, non ammettendo “che il criterio della nazionalità escludesse ogni altra rivendicazione”, trasmetteva alla stagione sturziana il discrimine tra fedeltà di dottrina e libertà di azione. • I valori del cattolicesimo di De Gasperi Il cattolicesimo degasperiano era legato ai valori arcaici e semplici della cultura delle montagne, distante da quei “trentini degeneri che non credono quello che insegnano le nostre mamme, non ascoltano più la voce delle nostre campane” (Due monumenti, “Fede e lavoro”, 1902). È importante sottolineare questa permanenza del cattolicesimo riformato tridentino, capace di opporre resistenza alle invadenze riformatrici e giuseppiniste, laddove le tradizioni della Controriforma non erano state intaccate dallo spirito dell’Aufklärung, come ricorda Angelo Gambasin. Quanto è restato e, soprattutto, quanto ha pesato la radice asburgica nel giovane deputato e giornalista trentino, al fine della realizzazione dei più tardi ideali europeisti del maturo statista della Dc? Molto, si ha ragione di credere: sicuramente molto più di quanto omesso da parte dei suoi agiografi. Infine molto di più di quanto sino ad ora tralasciato dalla storiografia corrente: appare in verità difficoltoso collocare in modo corretto la dimensione europeista del futuro costruttore dell’Unione Europea, se si prescinde del tutto dalla sua origine culturale e dalla sua provenienza ambientale da una regione di confine di quella complessa e immensa realtà sovranazionale, inglobante molteplici e multiformi etnie, culture e religioni, rappresentata dall’Austria-Ungheria fino all’alba degli anni Venti. • L’apertura culturale europea La condizione di appartenenza al variegato mondo mitteleuropeo, e insieme la posizione di marginalità del Trentino, ne segnarono la sensibilità al dimensionamento europeo dei problemi politici e, nello stesso tempo, l’apertura alle grandi e rischiose questioni, derivanti dal tumulto delle nazionalità e delle minoranze etniche linguistiche e culturali, conferendo a De Gasperi un’autentica statura europea e distanziandolo dalla dimensione invero provinciale e riduttiva di altri personaggi del panorama politico italiano, e non solo di parte cattolica. Forse non si è riflettuto abbastanza sulla coincidenza della simile provenienza degli altri due artefici dell’idea europea egualmente da regioni di confine, sempre contese tra popoli limitrofi: entrambi figli di periferie imperiali, Robert Schuman, dall’AlsaziaLorena, strappata dalle carni francesi dalle armi prussiane nel 1870 e nuovamente dall’aggressione tedesca nel 1940; e Konrad Adenauer, figlio del Reno, sangue e oro della Germania, minacciato dai francesi dopo il tracollo del Reich tedesco nel 1918. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 99 Stefano Trinchese Conta dunque in modo determinante, nel De Gasperi della giovinezza, quella lezione di nazionalità positiva, secondo la quale occorreva collocare nella più aperta dimensione di un’entità sovrastatale il lacerante conflitto delle emergenti nazionalità. In questo ambito, come sottolinea Umberto Corsini, pesa in misura speciale la distinzione tra nazione culturale e nazione territoriale, la prima coincidente coi confini etnici e linguistici, la seconda inserita all’interno di un superiore contesto statale di struttura sovranazionale. • La “pace” dei nazionalismi e il “nazionalismo positivo” Nel deflagrare dei nazionalismi, il giovane Degasperi (il cui cognome recava ancora il segno dell’anagrafe imperialregia) elaborò un’originale concezione di coscienza nazionale positiva, in contrapposizione anche polemica alle ideologie nazionaliste, degenerate in irredentismo, respingendo egli il concetto di Nazione inteso come apriorismo assoluto. L’inconsueta formulazione degasperiana contemplava pertanto la tutela della rappresentanza nazionale, all’interno della dimensione sovranazionale dell’Impero Asburgico. Egli distingueva con nettezza il sentimento d’appartenenza nazionale dall’idea di nazione come valore supremo: secondo un fondamentale assunto di Umberto Corsini derivavano da questa distinzione “le riserve verso lo Stato italiano e la reale situazione della gente trentina nell’Impero” alla quale, più che un generico “romanticismo nazionale”, conveniva appunto una coscienza nazionale positiva. Aggiungeva Degasperi che i trentini erano, in definitiva, “prima cattolici e poi italiani, solo là dove finisce il cattolicesimo”. Sotto questa luce, per nazionalismo positivo egli intendeva la difesa delle diverse nazionalità nell’ambito dell’Impero. “Sviluppare nel popolo una coscienza nazionale positiva” – scriveva Degasperi su “Il Trentino” nel 1908 – equivaleva a promuovere “un sentimento d’affetto e attaccamento alla propria nazionalità, che non produca scatti di ribellione, né si limita all’attività negativa”. In quel modo, “la nazionalità, così intesa nel senso più ampio e più vero, bandito il concetto piccino che si limita alle lotte linguistiche”, produceva una coscienza “integrale e positiva” in una popolazione, quella trentina, presso la quale non ebbe “mai plauso quello spirito nazionale”. Quanto alle aspirazioni degli “italiani dell’Austria”, essi parevano desiderare piuttosto di “esser redenti in cospetto della costituzione austriaca”; essi anelavano, infatti, all’autonomia, all’intangibilità del territorio e della lingua, alla diffusione delle ferrovie, ad uno sviluppo economico e soprattutto a forme di più equa giustizia distributiva. In questa dimensione di equilibri tra diversità nazionali sembrava quasi sfumare, sempre secondo Corsini, il conflitto sulle terre irredente, e, sulla base della non dimenticata lezione del Riccabona, si apprezzava nella sua interezza “la funzione europea” della monarchia asburgica e del suo Parlamento plurilingue. L’Impero “agglomerato meccanico di popoli”, in altre parole l’Austria “miriade di patrie” 100 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Stefano Trinchese (l’espressione è ancora di Corsini) riscontrava la sua più intima connessione nella “comunione di beni culturali e morali” messi in comune dalle singole nazioni coabitanti, collegate tra loro da vincoli non effimeri di prossimità e di eterogenea appartenenza a un comune sostrato culturale. Questo sistema, al contempo articolato e unitario, di “Stati e nazioni integrati”, basato su una piattaforma ideologica fondatamente tradizionale – basti pensare a riferimenti diversi a La Città di Dio agostiniana – vantava una rete di libertà e d’autonomie assai ramificate, con un decentramento di poteri esterni senza pari nell’Europa del centralismo burocratico imposto dalla Nazione moderna. Fra le altre, De Gasperi respingeva, oltre all’idea di Nazione, in quanto valore assoluto, anche i concetti stessi di Umanità in senso positivista, o di classe in senso marxiano e infine dello stesso Stato hegeliano. Egli stesso lo rilevava, con deciso riferimento al trascendente: “La differenza capitale fra noi è questa: gli altri coscientemente seguono un principio che si ripresenta sotto forme dell’umanesimo e della rinascenza; per la quale agli uomini fu Dio lo Stato, poi l’Umanità, ora la Nazione. Noi ci inchiniamo solo innanzi a un Vero supremo”. Per lui il “carattere plurinazionale” dello Stato austriaco si manifestava nel Parlamento, coeso dalla “solenne promessa di equità nazionale del discorso del Trono”. Eppure, in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’ascesa al trono di Francesco Giuseppe, nel 1908, nel momento del “giubileo meraviglioso, festa della nuova era parlamentare”, oramai “inaugurata la democrazia” dopo la riforma elettorale del 1907, nel magico e breve momento della cosiddetta media aurea del Barone Beck, tutto il complesso sistema dello Stato plurinazionale pareva messo in crisi dagli eventi dell’anno luttuoso, quello della crisi di Bosnia e dei tellurici sommovimenti interni all’Impero Ottomano. Ernesto Sestan, in un non dimenticato studio su Cesare Battisti, aveva collocato il dibattito sullo Stato nazionale e plurinazionale all’interno della particolare situazione trentina: la scelta irredentista “non poteva essere solo una scelta tra Stato mononazionale o plurinazionale, ma in concreto una scelta tra Austria, paese del conservatorismo, clericale e classista, e Italia, Stato liberale e laico e neo-imperialista”. È indicativo che De Gasperi intendesse per paese il Trentino, così come egli identificava lo Stato con l’Impero Asburgico, riservando al concetto di patria una dimensione di appartenenza più intima, anzitutto linguistico-culturale e sentimentale, alla nazione italiana, al riparo dalle rivendicazioni brutali dell’irredentismo. Egli sintetizzava pertanto l’opinione dei suoi compatrioti in “sentimenti di italianità per lingua, tradizione e costumi; ma fedeltà assoluta all’Impero e all’Imperatore, fedeltà della popolazione all’Austria, inesistenza di irredentismi”. Insomma “il Trentino al Trentino”, nell’ambito della dimensione plurinazionale dell’Impero, costituiva per De Gasperi, come per i popolari trentini, l’egida di maggiori autonomie e migliorie economiche all’interno dell’orbita statuale asburgica, in luogo del motto dei patrioti irredentisti italiani: “Trento all’Italia”. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 101 Stefano Trinchese In conformità a questa originale distinzione tra Paese-Stato-Nazione, De Gasperi riusciva a prendere le distanze tanto da quelle che a lui dovevano apparire invadenti pretese dei nazionalisti, quanto dalle mire egemonizzanti dei pangermanisti del Volksbund, identificati nel gergo comune – dalla foggia dei copricapi – come lucherini: persino nei diminutivi i trentini si scostavano dunque dai patrioti irredentisti, i quali avrebbero definito nel dispregiativo crucco un’indistinta accezione di tedeschi e austriaci. Ma più interessante è annotare come, sin dal 1905, in un articolo intitolato Austriacanti, De Gasperi rimandasse al mittente alcune precoci accuse di austriacantismo, pervenutegli dagli ambienti più virulenti del patriottismo trentino: “Austriacanti, antinazionali? Ma voi siete i peggiori nemici del Trentino, sventolando il bandierone della nazionalità”. Dunque, l’identificazione nazionale precludeva, nel linguaggio asciutto e persino scabro di De Gasperi, qualsiasi indulgenza alle retoriche dell’ora, approdando a una definizione di scultoreo realismo: “Patria non è una parola vuota, ma è un Paese con il suo Popolo”. • Alle radici del suo europeismo La visione politica degasperiana apparirebbe in origine sostanziata da due elementi costitutivi: una concezione cristiana della società, intimamente connessa con l’universalismo cattolico proprio dell’ideologia di cristianità – approfondita in seguito nelle Idee ricostruttive – e inoltre l’esperienza personale di suddito dello Stato plurinazionale asburgico. Entrambi tali elementi precludevano, nel giovane De Gasperi, qualunque fascinazione per l’idea di nazione, assurta a simbolo del proprio tempo: nel momento dell’idolatria dell’ideologismo nazionalista, prevaleva in lui piuttosto un’idea europea, non teorizzata ma diremmo – semmai – vissuta e osservata all’interno dei confini fisici della Duplice Monarchia, la cui forma unitaria conciliava la limitazione del potere centrale con le autonomie accordate per via storica, e pertanto in misura incredibilmente eterogenea, alle singole nazionalità costitutive. Con dichiarato riferimento all’ideologia dantesca della Monarchia Universalis, si trattava per lui di un sistema al tempo stesso unificato e articolato di Nazioni nello Stato, integrati in un comune organismo, al cui interno le singole rappresentanze nazionali ottenevano spesso faticosamente un equilibrio dinamico di accordate garanzie e concessioni di autogoverno su materie particolari: “autorità civile somma – secondo De Gasperi – massima autonomia alle Nazioni”. • Concezione europea e universalità cristiana Letta sotto questa particolare angolatura, l’acerba concezione europea del giovane polemista trentino s’innestava nella sostanza vivente della dimensione univer- 102 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Stefano Trinchese salista del Cristianesimo romano: “Noi possiamo pensare da europei; ma vogliamo inquadrare questo pensiero nel concetto universale del Cristianesimo”. Nell’Impero formalmente ossequiente alla Chiesa di Roma, gli indirizzi laici delle ultime generazioni politiche avevano, nella realtà, alterato l’assetto tradizionale dello Stato cristiano, rovesciando l’antico equilibrio fra trono e altare attraverso la pratica giuseppinista. Derivava da quella contingenza storica la parallela avversione degasperiana tanto per il liberalismo borghese, fautore di una considerazione laicista e anticlericale della vita pubblica, quanto per il verbo nuovo del nazionalismo irredentista – fosse esso boemo o italiano, slavo o pantedesco – aggressivo e finanche deleterio per il delicato equilibrio sovranazionale del decadente Impero. Non era dunque casuale che sino all’autunno del 1918 De Gasperi opponesse alle forme “moderne” della concezione nazionale una personale valutazione della storia recente, ispirata da quell’internazionalismo cristiano, che aveva trovato realizzazione positiva nelle strutture imperiali, imperniate sulla struttura gerarchica della Chiesa cattolica. Era solo per conseguenza che, in virtù di una concezione universalista cristiana, la tematica nazionale veniva squalificata: al congresso universitario di Trento del lontano 1902, suscitò non poco clamore, misto a risentimenti anche aspri, l’inusuale e persino impolitica o inattuale considerazione del ventunenne De Gasperi a proposito della questione nazionale: “prima cattolici e poi italiani, e solo là ove finisce il cattolicesimo”. I confini territoriali, dunque, non coincidevano in modo piano o necessario con quelli culturali o religiosi o linguistici della nazione; partiva da qui il suo distacco, altrimenti equivocato o ambiguo, dai temi agitati dalle minoranze nazionali, reclamanti – e giustamente – nella evidente e prolungata insoddisfazione delle richieste autonomiste, le più fiere tendenze separatiste. • Nazioni culturali e nazioni territoriali Tuttavia quel principio di subordinazione della nazionalità a un organismo di governo sovrastante le sue componenti andrebbe inteso, come a suo tempo saggiamente suggerito dal Corsini, “nella fondamentale distinzione che De Gasperi seppe mantenere tra nazionalità come sintesi di elementi linguistici, culturali, spirituali e religiosi, tali da creare identità storica” e le nazioni erette a Stato, in altre parole tra nazioni culturali e nazioni territoriali: “le prime, erano realtà storiche essenziali, in quanto elementi di pluralismo culturale della civiltà, le seconde, organismi statuali non necessari, di un ordinamento politico da subordinare a più alti principii religiosi, morali e civili”. Era precisamente contro il “romanticismo nazionale che ritorna” e che istruiva una gioventù infervorata dal motto “la Nazione innanzi tutto”, che De Gasperi forgiava il concetto di coscienza nazionale positiva, ripetutamente utilizzato in occasione di incontri studenteschi ad inizio secolo per Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 103 Stefano Trinchese rappresentare, “nella concretezza dell’azione politica, la difesa della nazionalità, ma nel quadro dell’Impero plurinazionale”. • Il “pensare” europeo di De Gasperi Era quello l’Impero mosaico di popoli risultato lontano e precario di una complessa strutturazione plurinazionale e multiculturale, avente simbolo esplicito in quell’unicum storico rappresentato dal Parlamento plurilingue, quasi a voler premettere alla sua integrità unificata, una – la definizione è di Adam Wandruszka – “costante mediazione fra genti di diverse stirpi, razze, tradizioni, lingue e religioni”. La piena e consapevole acquisizione della forma statale sovranazionale, le cui frizioni interne – anche le più laceranti – erano interpretate da De Gasperi come difetti di funzionamento, rendeva inconciliabile la Mitteleuropa asburgica coi diritti delle singole nazionalità, ivi compresa la laicista Italia liberale, verso la quale De Gasperi non mascherava sostanziali riserve. Rientrava in questo tipo d’analisi la diversa esperienza storica dei cattolici in Italia e sotto l’Austria, laddove in quest’ultima essi vantavano una secolare stagione di partecipazione alle politiche dello Stato, mentre nella prima ne erano tenuti ai margini, a causa della mancata accettazione dello Stato unitario e del peso immane della Questione Romana. In questo senso, il Parlamento plurilingue dello Stato articolato in Stati e Länder sovrani, assolveva a una duplice funzione di rappresentanza democratica delle nazionalità e di sede di compensazione dei loro contrasti, nell’ottica di una pacifica coabitazione generale. Era nel sottosuolo profondo di questo universo di delicati equilibri che De Gasperi fondava i pilastri del suo pensare europeo. Eppure, dietro la percezione del fallimento del precario sistema di contrappesi sui cui poggiavano gli assetti della diplomazia triplicista, c’erano, proprio “in fondo a questa vecchia Europa, delle grandi forze morali da far rivivere” (L’Europa in crisi, 1913). A quel precario marchingegno di bilanciamenti andava con urgenza sostituito “un sistema di integrazione e unità federativa stabile, con organi internazionali permanenti, dotati di poteri sovranazionali”, tali da limitare la sovranità, se non l’arbitrio, degli Stati e delle nazioni, in un comune sentimento europeo: era quella, ancora secondo Corsini, la “proposta conclusiva” della sua lontana esperienza nell’Impero Asburgico. Dopo il crollo delle dittature, trascorsa la bufera di un nuovo conflitto mondiale, occorreva pensare ad un sistema federativo, sorto “non dai soliti trattati”, ma regolato da quelle “autolimitazioni di sovranità in un’Europa unita in libertà e in democrazia” e fondato su “un’associazione di sovranità nazionali, basata su istituti costituzionali democratici”. Era la vecchia Europa del precario ma prolungato periodo di pace della belle époque a tornare presente al De Gasperi della maturità; era quella stessa Europa che pure doveva al Cristianesimo “quanto di buono c’è nella 104 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Stefano Trinchese civiltà”, come egli aveva affermato in un tempo lontano, quando aveva visitato nel 1913 il Palazzo della pace, da poco inaugurato a L’Aja (Visitando il palazzo della giustizia internazionale, 1913). Quel ripetuto ricorso al Cristianesimo e ad un’autorità politica sancita dal papa per la salvaguardia del superno bene della pace, lungi dal rappresentare un seppur lontano richiamo a un ideologismo restaurativo, rispondeva, più verosimilmente, al bisogno da lui fortemente avvertito sin da allora, di “riempire di contenuto cristiano” quello che egli definiva con nettezza “umanitarismo superficiale” ovvero “moderno pacifismo”. • Coscienze libere e radici comuni Nel 1953, meno di un anno prima della morte, in occasione di un consesso di storici, avrebbe trovato conferma quanto anticipato in quel lontano anno 1913, già percorso dal sangue che scorreva dai Balcani, a proposito della necessità improcrastinabile di ricorrere a una “somma e suprema autorità civile”, per consentire “massima autonomia alle Nazioni”, in una con l’allora da lui citato pensiero dantesco: “Habent nationes regna et civitates intra se proprietates quas legibus differentibus regulari oportet”. In quei cinquant’anni di convulsa tragedia europea, dopo due guerre mondiali e persecuzioni dell’uomo contro l’uomo, “ferma restando l’aspirazione al superamento dei nazionalismi e alla realizzazione di una società integrata”, erano venuti modificandosi i riferimenti cui De Gasperi ancorava il suo sotterraneo, ma ostinatamente coerente discorso di fondo: fino al 1914, in una visione come sempre scabra e pragmatica, egli aveva individuato nell’Impero d’Austria quella funzione sociale e insieme sacrale, allora da lui avvertita come necessaria, spettante all’istituto monarchico – come egli ancora tornava ad affermare nel 1924 – “di supremo garante di libertà e diritti dei gruppi nazionali”. L’essenza culturale dell’internazionalismo europeista di De Gasperi potrebbe dunque esser letta come “sintesi storica di fattori ideologici diversi” e remoti, come egli ebbe ad affidare quasi per testamento ideale alla conferenza parlamentare europea del 21 aprile 1954, meno di quattro mesi prima della morte: non dalla “concezione liberale sull’organizzazione e l’uso del potere politico” e neppure dalla “sola idea della classe operaia” poteva derivare un’ispirazione unificatrice di popoli diversi per stirpe e di nazioni differenti per storia, ma da un incontro comunitario di coscienze libere e d’intenti eterogenei, variamente collegati a una lontana radice comune, in nome di quella che egli definiva nel Discorso alla Conferenza europea del 1954 “la responsabilità della persona umana, col suo fermento di fraternità evangelica”. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 105 Rubriche COLLOQUI a cura di Giuseppe Sangiorgi Intervista a Enzo Cheli 109 POLITICA INTERNA a cura di “Spectator” Lo scenario italiano 112 POLITICA INTERNAZIONALE a cura di Mario Giro Lo scenario mondiale 119 ECONOMIA a cura di Gianni Locatelli Un motore fermo 128 RELIGIONI e CIVILTÀ a cura di Agostino Giovagnoli Le luci di Shanghai e le ombre della Cina 133 RICERCHE a cura di Andrea Bixio – La situazione tedesca e la formazione di un’Università Europea Sintesi di una ricerca di Robert Hettlage – I protagonisti della Società Civile, [a cura di Vincenzo Cesareo] Una lettura della realtà italiana di Maria Cristina Marchetti FUORI SCAFFALE a cura di Aldo Laganà – L’Europa non è l’America – L’Occidente di fronte al terrorismo di Massimo Teodori – Il romanzo del Popolo. Storia di un giornale pericoloso di Giuseppe Sangiorgi e Carlo Danè STATISTICHE a cura di Corrado Barberis Statistiche e realtà Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 138 148 154 158 160 107 Colloqui a cura di Giuseppe Sangiorgi Intervista a Enzo Cheli • “Oggi il settore delle telecomunicazioni è tornato a essere una locomotiva del processo di sviluppo tecnologico, economico e sociale, con tassi annui di crescita compresi tra il 5 e il 7 per cento rispetto a un mero 1 per cento dell’insieme della economia europea. Le stime parlano di margini al di sopra del 35 per cento per i prossimi tre anni. La crescita dei ricavi netti è stimata al di sopra del 10 per cento l’anno e le cifre sono anche più elevate per gli incumbents…” Nel marzo scorso Mario Monti, commissario europeo per la concorrenza, faceva questa previsione di crescita delle tlc in un convegno organizzato a Napoli dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dopo la delusione e le battute d’arresto legate alla bolla speculativa di Internet, la macroarea della comunicazione elettronica (dalle tlc all’audiovisivo all’informatica) ha ripreso a generare un importante processo di crescita e sviluppo all’insegna della convergenza tecnologica e su mercati sempre più di dimensioni internazionali. Torna per tutto questo d’attualità il tema di una Autorità di regolamentazione europea della comunicazione, che affianchi e superi le Autorità nazionali del settore. Il tema non è di oggi, e, se da un lato sembra essere imposto dalla realtà delle cose e dal mercato, dall’altro viene osteggiato invece dai singoli Paesi, sempre gelosi delle proprie competenze, e dalla stessa Commissione europea perché anch’essa si vedrebbe parzialmente spogliata di poteri e competenze. Un convinto sostenitore dell’Autorità europea delle comunicazioni resta il costituzionalista Enzo Cheli, presidente dell’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni. Lo è dall’inizio degli anni Novanta, quando l’Europa iniziò la stagione delle grandi liberalizzazioni del settore. E lo è a maggior ragione oggi, spiega il professor Cheli, “avendo riguardo ai contenuti delle nuove Direttive promulgate dall’Unione Europea nel marzo del 2002 in materia di reti e di comunicazione elettronica. Queste direttive introducono nuove modalità di analisi dei mercati nazionali puntando ad accelerare la convergenza tra differenti tecnologie e tra differenti Paesi, sostenendo la necessità di una uniformità del mercato della comunicazione elettronica Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 109 europea. Diventa inutile insomma che il mercato sia efficiente in alcuni dei Paesi europei e non lo sia in altri. Per queste ragioni le Direttive fissano gli obiettivi principali da raggiungere per ridurre il gap tecnologico tra i diversi Paesi e stabilire criteri comuni per regolare le posizioni dominanti”. “Un mercato europeo – spiega ancora il professor Cheli – privo di una entità arbitrale capace di garantire il rispetto di regole comuni è un fatto illogico. Noi dobbiamo fare un cammino inverso a quello che gli Stati Uniti stanno compiendo in questi stessi anni. Loro sono partiti storicamente da una Autorità centralizzata e adesso stanno immaginando nuove articolazioni sul territorio con Autorità locali. Noi siamo partiti in Europa da Autorità locali e adesso dobbiamo realizzare una loro proiezione a livello sovranazionale. Tra noi e gli Stati Uniti ci sono due percorsi opposti, ma per arrivare a un analogo risultato”. Non è possibile realizzare in Europa questo obiettivo attraverso il semplice ampliamento dei poteri della Direzione della concorrenza della Commissione europea? “Io penso – risponde il professor Cheli – che questa non sia la strada giusta. Il modello che più correttamente va sviluppato è quello simile alla Autorità inglese, o italiana, o spagnola, che sono entità amministrative del tutto indipendenti dai Governi. Io penso per esempio che l’ampliamento dei poteri dell’Erg, lo European Group of Regulators possa essere il primo passo verso la creazione di quell’autorità europea che immagino. L’Erg è un organismo del quale fanno parte tutte le Autorità nazionali e alcuni rappresentanti della Commissione europea. Oggi è una entità ancora soltanto consultiva, incaricata di dare le proprie valutazioni alla Commissione. Ebbene, nel futuro potrebbe diventare invece un soggetto indipendente con propri poteri specifici ed esclusivi”. Quale potrebbe essere il miglior contesto all’interno del quale far emergere la proposta di una Autorità indipendente europea? “Nelle legislazioni nazionali – risponde il professor Cheli – le Autorità indipendenti rappresentano una sorta di “quarto potere”, nel senso che esse non sono dei giudici, non sono dei legislatori, non rappresentano il potere esecutivo, ma in qualche modo esercitano tutta una serie di funzioni proprie della magistratura, del legislatore, e del potere esecutivo. Per la novità rappresentata da queste loro caratteristiche, io ritengo che le Autorità nazionali debbano avere ora una “copertura costituzionale” nei singoli paesi d’origine. Per lo stesso motivo ritengo che il miglior contesto nel quale inserire la proposta di una Autorità indipendente europea poteva essere la Costituzione europea”. Qual è in definitiva la posta in gioco che è dietro la utilità di una Autorità europea? “Mi sembra del tutto naturale – è la risposta – che il valore sovranazionale della regolazione e l’obiettivo di dar vita a un mercato europeo della comunicazione elettronica debbano prevalere sulle barriere nazionali della industria delle comunicazioni. L’unica 110 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 eccezione può riguardare i contenuti – mi riferisco a quelli strettamente legati alla televisione – condizionati dalle barriere linguistiche, e perciò destinati a mantenere caratteristiche regionali. Ma per tutto il resto, le reti elettroniche, le trasmissioni in digitale devono rappresentare l’euro del sistema della comunicazione europea. La mia idea, come ho già accennato, è quella di una Autorità che non sia soltanto una entità amministrativa ma abbia anche connotazioni arbitrali e giudiziali. La Commissione europea non può avere queste caratteristiche, che sono invece indispensabili per regolare e indirizzare i processi di liberalizzazione e di privatizzazione che continuano ad accompagnare ancora oggi lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche. La posta in gioco insomma, riguarda il futuro della Società dell’Informazione, il settore ritenuto oggi quello più strategico per lo sviluppo dell’Unione Europea”. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 111 Politica interna a cura di “Spectator” I riflessi della crisi irachena sulla politica interna • L’attentato di Madrid e le elezioni spagnole hanno rivoluzionato il dibattito internazionale sull’Iraq e il terrorismo. Anche in Italia, temi che avevano attirato solo un limitato interesse – come quello della permanenza di truppe in Iraq o un più deciso intervento dell’Onu nella questione irachena – sono apparsi, improvvisamente, cruciali a tutta l’opinione pubblica e le forze politiche se ne sono occupate con grande intensità. Non sembra però inutile fermarsi a riflettere sul dibattito parlamentare che si è svolto in Italia nelle settimane precedenti, intorno alla prosecuzione o meno delle missioni militari italiane nel mondo: benché superato dagli eventi, questo dibattito offre spunti utili per una riflessione sullo stato di salute del Parlamento italiano, cardine essenziale del nostro sistema democratico. • Com’è noto, dalla primavera 2003 molte cose sono cambiate. Dopo che la guerra è sembrata concludersi vittoriosamente per la coalizione guidata dagli Stati Uniti, l’Italia ha inviato in quelle terre un contingente. Successivamente, la risoluzione 1511 dell’Onu è sembrata gettare una nuova luce sulla presenza militare occidentale. Infine, la tragedia di Nassyria ha suscitato un’emozione profonda nell’opinione pubblica italiana. Sono, insomma, cambiati i termini del problema: dalla questione della guerra contro Saddam si è passati al problema della transizione dell’Iraq alla democrazia. Di qui l’importanza di ridefinire gli scopi – e, soprattutto, i tempi – dell’occupazione militare e di interrogarsi sul ruolo dell’Onu, non più in relazione alla legittimità della guerra ma per garantire quella della pace, da raggiungersi, possibilmente, nei tempi più brevi e nei modi più efficaci. • Il Parlamento in difficoltà Il dibattito parlamentare italiano su tali questioni, però, è partito male ed è proseguito peggio. È stato, infatti, caratterizzato da una presentazione volutamente confusa delle diverse posizioni, l’utilizzo in chiave propagandistica delle istanze di 112 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 pace, l’accentuazione dei toni polemici e delle contrapposizioni a scopo elettorale, la carenza di un approccio propriamente politico. Ha cominciato il governo che, per evitare di apparire in contrasto con i sentimenti di pace diffusi nel paese, ha unito in un unico voto tutte le missioni militari nel mondo, rifiutando la richiesta dell’opposizione di separare la questione dell’Iraq dalle altre: la mossa, utile per la maggioranza, non ha certo aiutato a fare chiarezza sul problema più importante e cioè la posizione da assumere nei confronti della grave questione irachena. Quasi tutti coloro che sono intervenuti al Senato, della maggioranza o dell’opposizione, hanno poi utilizzato enfaticamente la parola pace, a prescindere dalle proprie convinzioni, con l’obiettivo di dire cosa gradita all’opinione pubblica italiana, notoriamente in larga maggioranza favorevole alla pace in Iraq: lo hanno dimostrato le imponenti manifestazioni della primavera 2003 e lo hanno confermato i sondaggi dei mesi successivi. È mancato, in questo modo, chi illustrasse chiaramente in Aula una posizione che invece era condivisa da molti parlamentari e che ha influito notevolmente sul voto della maggioranza. È stata, infatti, volutamente “oscurata” dai suoi stessi sostenitori, la posizione secondo cui la missione italiana in Iraq si iscrive in un contesto di guerra e che – non malgrado ciò, bensì proprio per questo – deve essere continuata. Paradossalmente, tale posizione e stata invece sostenuta e illustrata esplicitamente da Lucio Caracciolo su “La Repubblica”, un quotidiano vicino all’opposizione. Si tratta, di un’opinione non solo pienamente legittima ma anche fondata su argomentazioni importanti, seppure discutibili come tutti quelli emersi nel corso dibattito, quali la convinzione che la guerra in Iraq non sia affatto finita, malgrado i proclami ufficiali, e che il terrorismo islamico vada contrastato con l’uso della forza contro suoi focolai o alleati. Naturalmente, una posizione di questo genere si presta a molte obiezioni e, se fosse stata assunta, avrebbe determinato una profonda spaccatura tra maggioranza e minoranza. Ma, sebbene impopolare, era comunque essenziale discuterla in modo esplicito per chiarire fino in fondo i termini del problema e, qualora fosse risultata prevalente, avrebbe avuto il merito di far emergere una posizione chiara su un problema molto importante, contribuendo a far assumere all’Italia una posizione incisiva sul piano internazionale. Invece, ha vinto l’interesse ad occultare posizioni considerate poco produttive sul piano propagandistico. • Le influenze elettorali La prevalenza dell’interesse elettorale sulla ricerca di soluzioni politiche per la questione irachena è emersa anche dalla volontà, sia della maggioranza sia dell’opposizione, di evitare anche solo l’apparenza di una convergenza su posizioni comuni, “rischio” inevitabile all’interno di un dibattito politico serio e approfondito. Elementi per una possibile convergenza, infatti, sono emersi ma sono stati subito respinti e non hanno prodotto risultati politicamente significativi, perché è preval- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 113 so l’interesse – da entrambe le parti – ad enfatizzare la contrapposizione. Appare eloquente in questo senso la vicenda, al Senato, dell’odg che impegnava il governo italiano “ad agire in ogni sede per una piena ed effettiva applicazione della Risoluzione 1511”. Presentato dall’opposizione è stato accolto anche dal governo: all’epoca, infatti, nessuna voce all’interno della maggioranza contestava l’importanza del ruolo dell’Onu e lo stesso governo sottolineava che la Risoluzione 1511 rappresentava già una sanatio di qualsiasi eventuale difetto d’origine nell’intervento militare in Iraq e comunque una piena legittimazione della presenza militare nell’interregno post-Saddam. In questo contesto, appariva pienamente logico che sul ruolo dell’Onu si manifestasse piena convergenza tra ampi settori della maggioranza e dell’opposizione. Come nel caso di una chiara presa di posizione a favore della guerra, un esplicito atteggiamento del Parlamento italiano sul ruolo dell’Onu avrebbe rappresentato un risultato di rilievo, sia per quanto riguarda il merito di una questione così importante, sia per ciò che concerne l’assunzione da parte dell’Italia di una posizione incisiva sul piano internazionale. Nel primo caso, per schematizzare, si sarebbe configurata una posizione alla Blair, nel secondo invece una posizione alla Zapatero, entrambe capaci di contribuire in un senso o nell’altro al dibattito internazionale in corso sulla guerra in Iraq. Invece, la prima ipotesi non è stata percorsa per non contraddire un’opinione pubblica profondamente sensibile al valore della pace, mentre la seconda è rimasta ad uno stadio meramente intenzionale perché non conveniva sul piano elettorale, né alla maggioranza né all’opposizione, “rischiare” di apparire d’accordo su un tema tanto controverso: proprio ciò che è particolarmente apprezzabile sul terreno della politica estera, e cioè un largo consenso “nazionale”, viene infatti considerato poco conveniente in politica interna. • Le contraddizioni sull’Italia in Iraq Una conferma in questo senso viene dalla sorte riservata alla proposta di Andreotti, la quale, da un lato, ribadiva “il dettato dell’articolo 11 della Costituzione della Repubblica”, secondo cui l’Italia ripudia la guerra, e ricordava che “la dislocazione di unità militari italiane fuori del territorio nazionale può aversi solo per compiti derivanti da condivisione di precisi impegni internazionali o comunitari”; dall’altro, si esprimeva a favore della prosecuzione della presenza militare italiana in Iraq, ricondotta nell’ambito del dettato costituzionale. In questo modo, il senatore a vita ha fatto emergere le ambiguità sia del governo e della maggioranza – che non hanno voluto impegnarsi per sostenere concretamente il ruolo dell’Onu, pur dichiarandosi in teoria a favore di tale ruolo –, sia di quella parte dell’opposizione che non ha votato, pur dichiarandosi a favore di questa presenza se legittimata dall’Onu. Nessuno ha avuto il coraggio di respingere la proposta Andreotti, che però è stata resa “innocua” trasformandola in una raccomandazione: infatti, ha commentato ironicamente il senatore a vita, “una raccomandazione non si nega a nes- 114 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 suno”. In assenza di altri tentativi di trasformare in proposta politica concreta l’istanza della pace, fortemente sentita dall’opinione pubblica italiana e, a parole, accolte da tutti i gruppi, il Parlamento ha, in pratica, rinunciato a fare politica su una questione tanto importante, impedendo che l’Italia assumesse una posizione chiara e portasse un contributo utile sul piano internazionale. L’aula del Senato, infatti, è apparsa troppo impegnata nella contrapposizione polemica per occuparsi di politica. Uno squarcio sui motivi per cui è stata preferita la retorica della contrapposizione globale e della polemica elettorale, emerge da un dettaglio apparentemente secondario, ma in realtà rivelatore. Tale episodio si è verificato mentre il relatore di maggioranza, Pellicini (An), stava intervenendo su una delle questione politicamente più rilevanti, il già citato odg relativo alla risoluzione 1511 dell’Onu, su cui emergeva “la possibilità di un punto di contatto tra governo, maggioranza e opposizione”. Non appena Pellicini ha cominciato a spiegare “il nocciolo del problema che trattiamo oggi”, il vicepresidente Calderoli (Lega), che in quel momento dirigeva la seduta, lo ha interrotto ricordando “che vi sono dei tempi da rispettare per la diretta televisiva”. Il relatore non ha potuto perciò illustrare dettagliatamente i motivi per cui il Governo accettava l’odg dell’opposizione, né è stato possibile misurare la reale consistenza di questa convergenza intorno al ruolo dell’Onu. • Il ruolo dei mass-media Non si tratta di un dettaglio secondario: la televisione ha, infatti, condizionato e deformato tutto il dibattito. Il richiamo alle esigenze televisive ha avuto effetti che Aldo Cazzullo, sul “Corriere della Sera”, ha definito rovinosi: davanti alla diretta televisiva, “finisce la (modesta) politica e comincia la campagna elettorale”. L’effetto distorsivo sul dibattito parlamentare è apparso, ad esempio, nei toni “elettorali” con cui il relatore di Alleanza Nazionale, Domenico Nania, ha concluso il suo intervento, parlando di tasse e di euro, temi decisamente estranei al problema in discussione. Fastidioso è apparso poi il sapore strumentale di vari riferimenti alle vittime dell’attentato di Nassiryia, mentre inopportuno è sembrato il riferimento di Schifani (Fi) ad alcune parole di mons. (sic!) Ruini, estrapolate dal pensiero complessivo manifestato nei mesi scorsi dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Dal momento in cui è iniziata la diretta, insomma, gli oratori hanno cercato prevalentemente di risultare efficaci in termini “televisivi”, abbandonando la logica e le esigenze del dibattito parlamentare. La televisione, infatti, premia le posizioni contrapposte e le polemiche forti ed è in questo senso nemica della politica, intesa come ricerca della sintesi più elevata e più comprensiva possibile delle diverse posizioni in gioco intorno a problemi delicati e complessi. Così, nel dibattito al Senato sull’importante questione della presenza militare italiana nel mondo e in particolare in Iraq, chiarezza, concretezza, efficacia sono state sacrificate ad evidenti motivi di convenienza elettoral-televisiva. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 115 Nella stessa logica si iscrivono anche molti atteggiamenti assunti da quanti hanno votato contro la conversione del decreto legge: Comunisti italiani, Verdi, Rifondazione comunista, oltre ad alcuni parlamentari di Margherita e Ds. Anche queste forze hanno potuto utilizzare a loro vantaggio, sia pure da posizione opposte, la confusione provocata dal governo unificando tutte le diverse missioni italiane nel mondo. Hanno, infatti, potuto presentare, in termini televisivamente paganti, il loro voto contrario a tutte le missioni come coerente con l’opposizione alla guerra e il precedente voto contrario all’invio di militari in Iraq. In questo modo, è spettato loro lo sfruttamento – in condizioni quasi monopolistiche – dei sentimenti di pace, con due evidenti distorsioni. In primo luogo, molti di coloro che sono stati contrari alla guerra in Iraq e alla missione italiana in questo paese non lo sono alle altre missioni italiane nel mondo. In secondo luogo, i sentimenti dei due terzi degli italiani contrari alla guerra di Bush e Blair e che hanno partecipato a manifestazione come quella di Roma del 14 febbraio 2003 si sentono in minima parte rappresentati da Diliberto, Pecoraro Scanio o Bertinotti. • Il pacifismo non antiamericano È il caso, in particolare, dei tanti cattolici che – seguendo le accorate parole di Giovanni Paolo II contro la guerra – hanno fatto parte di un composito popolo della pace, senza assumere posizioni antiamericane e senza condividere orientamenti ideologici di sinistra. La posizione della minoranza parlamentare che ha votato contro il decreto legge appare, dunque, rispondente a chiari interessi propagandistici, ma priva di un chiaro significato politico: l’ipotesi Diliberto di configurare un “partito della pace” – antagonista all’interno della sinistra alla lista dell’Ulivo – ha una sua evidente logica elettorale ma non corrisponde ad una proposta politica coerente ed organica. Paradossalmente, infatti, anche i settori del Parlamento che si sono pronunciati contro la guerra in Iraq “senza se e senza ma” non hanno manifestato la volontà di sintonizzarsi davvero con gli orientamenti della maggioranza degli italiani contrari alla guerra. Su questa importante questione, insomma, i cattolici non sono stati rappresentati pienamente da nessuna posizione parlamentare: non è emersa cioè alcuna traccia di “partito guelfo”, per usare i termini di una recente discussione su “Vita e pensiero”, e, al contrario, si deve parlare di sottorappresentazione di questa importante area della società italiana. • La “sinistra” e l’Ulivo Decisamente poco televisiva è apparsa invece la posizione dei partiti della lista unitaria per l’Ulivo, al loro primo significativo passaggio politico. Il mediocre “spettacolo” offerto da questi partiti è stato oggetto di numerose critiche e di abbondanti ironie, ma molte di queste critiche e di queste ironie appaiono strumen- 116 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 tali: il ricorso a scelte televisivamente ed elettoralmente poco paganti non costituisce necessariamente un motivo di demerito. La scelta del non voto è scaturita dalla situazione anomala creata dalla mossa governativa di unificare impropriamente il dibattito su tutte le missioni italiane nel mondo e si è legittimamente avvalsa di una delle possibilità offerte dai regolamenti parlamentari. La vera debolezza della lista unitaria non è stata dunque nel non voto, di cui era chiaro il significato di rifiuto, condiviso da tutte le componenti, della posizione del governo: in questo senso, le accuse “da sinistra” agli esponenti dell’Ulivo di aver cambiato idea rispetto all’intervento in Iraq e di essere passati addirittura sulle posizioni di Bush, appaiono infondate e gratuite. Il vero problema è un altro: il non voto ha coperto un’irriducibile diversità di posizione tra i partiti e dentro i partiti dell’Ulivo. Nella sostanza, i rappresentanti della lista unitaria, non hanno assunto una posizione unitaria e dunque non c’è stata una posizione della lista su una questione di così grande rilievo sul piano interno ed internazionale. Il problema non riguarda tanto il dissenso di alcune frange dei Ds e della Margherita sulla scelta del non voto, intorno cui si è fatto molto chiasso, quanto la grande disparità delle motivazioni di quanti l’hanno sostenuta. In primo luogo, il non voto non è stato difeso sul piano procedurale: in un’intervista, Francesco Rutelli ha dichiarato il suo disinteresse per le procedure parlamentari, con un’affermazione singolare per il leader di un partito che ha un ruolo rilevante in Parlamento e in una situazione in cui proprio la procedura adottata ha avuto un peso così rilevante nel determinare l’“impopolarità” della posizione ulivista. In secondo luogo, sono emersi all’interno dell’Ulivo orientamenti profondamente diversi nel merito della presenza italiana in Iraq. Il rappresentante dello Sdi, Ottaviano Del Turco, ha fatto intendere di interpretarla come missione di pace; il relatore della Margherita, Lamberto Dini, ha sviluppato una severa analisi, dall’interno, dei limiti e delle contraddizioni della posizione italiana rispetto all’obiettivo della pace e della democrazia in Iraq; Gavino Angius, relatore ufficiale per i Ds, ha addirittura presentato la posizione del suo partito, parlando di opinioni “che possono essere condivise e apprezzate, o anche non condivise e contrastate”. Tra quanti hanno scelto di non votare c’era dunque chi pensava che la missione italiana in Iraq fosse già una missione di pace e chi riteneva al contrario che si iscrivesse in una logica di guerra; tra questi ultimi, poi, c’è stato chi riteneva che la missione andasse mantenuta solo a determinate condizioni, in primo luogo l’intervento dell’Onu, e chi, al contrario, riteneva che dovesse comunque essere interrotta. In particolare, la posizione assunta dal segretario dei Ds, Piero Fassino, a favore della soluzione Zapatero – ritiro entro il 30 giugno se non c’è un intervento dell’Onu – non è stata di tutto l’Ulivo: solo dopo le elezioni spagnole, tale posizione ha conosciuto una crescente popolarità nella sinistra italiana, curiosamente anche da parte di chi l’aveva contrastata precedentemente, come il “correntone” Ds. Tra i partiti della lista unitaria non c’è stata insomma una fusione di posizione ma una semplice collezione di posizioni diverse: anche in questo caso, è mancata un’iniziativa politica capace di trasformare tante “ragioni” parziali in una sintesi ricca ed efficace. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 117 • L’effetto dell’attentato di Madrid Il dibattito sulle missioni militari italiane nel mondo è proseguito, più o meno sulle stesse linee, anche nelle settimane successive, fino al voto conclusivo della Camera, mentre tutto è cambiato, come si è detto dopo l’attentato di Madrid e le elezioni spagnole. Nel complesso, questo dibattito non ha certo rappresentato una delle pagine più alte nella storia parlamentare italiana. Sacrificate alla logica non solo semplificatrice ma anche mistificatrice della televisione e agli interessi immediati della polemica elettoralistica sono, infatti, mancate in primo luogo la chiarezza e in secondo luogo la politica. La discussione è apparsa sostanzialmente falsata dall’intento di non far emergere quali fossero realmente le diverse posizioni e il dibattito è stato strozzato dalla paura dei diversi attori di far apparire convergenze elettoralmente poco paganti. Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. Al congresso delle Acli, il Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, ha manifestato la sua preoccupazione per l’attività del Parlamento nella situazione attuale, esprimendo nostalgia per le “battaglie che erano sorrette su principi e valori ideali che erano forti. Oggi il rischio è che ci sia un pragmatismo privo di ideali e l’esistenza di un processo mistificatorio alimentato reciprocamente dalla destra e dalla sinistra”. Ci si chiede se i comportamenti mostrati dai parlamentari italiani nel corso di questo dibattito siano adeguati alla gravità della situazione determinata dal terrorismo. Proprio il caso spagnolo dovrebbe insegnare qualcosa: com’è noto, in Spagna il governo in carica è stato penalizzato dall’impressione che stesse occultando la verità a fini meramente elettorali. Non è bastato ad Aznar una notevole capacità di influenza sul mezzo televisivo: nella situazione di elevata tensione determinata dalla strage dell’11 marzo, la comunicazione spontanea via internet e cellulari ha prevalso sul mezzo televisivo. La televisione, grande strumento di informazione, non è più sufficiente quando si avverte un acuto bisogno di verità. È una lezione da cui i parlamentari italiani potrebbero trarre un insegnamento utile, perché si può presumere che, davanti ad una questione tanto grave come il terrorismo, la domanda di verità sia destinata a crescere. 118 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Politica internazionale a cura di Mario Giro • La crisi transatlantica: persistenze e ricongiungimenti Il 2004 si è aperto sullo sfondo del perdurare delle divergenze transatlantiche, che si sono approfondite dopo i gravi attentati terroristici di Madrid dell’11 marzo, che fanno più di 200 morti, e il ritiro delle truppe spagnole dall’Iraq. Da oltre un anno – periodo dell’inizio della crisi sulla guerra in Iraq e del contrasto sul tema della lotta contro il terrorismo – all’interno del campo occidentale sembrano prevalere contrasti su numerose materie politiche. Tale situazione non rappresenta un’assoluta novità: nel passato recente spesso Stati Uniti e paesi europei si sono scontrati su questioni talvolta di rilievo. Le varie suscettibilità nazionali e le differenze di sensibilità politica e sociale, sono state l’occasione di dissapori e di controversie fin dalla fine del secondo conflitto mondiale, anche se il quadro bipolare attutiva ogni possibile duratura conseguenza. Tuttavia, dall’inizio del 2004 si osserva un’apparente persistenza di tali divergenze, percepite dalla maggioranza delle rispettive popolazioni con una certa acquiescenza e senza drammi. Il solco tra le due sponde non provoca reazioni intense. Le elezioni spagnole del 15 marzo, che capovolgono il quadro politico e riportano i socialisti al governo, avvengono nel clima di polemica interna a causa del tentativo del governo uscente di coprire le responsabilità del terrorismo islamico in favore dell’ipotesi Eta, ritenuta più favorevole alla destra in termini elettorali. Il calcolo del governo si rivela errato e il voto riporta alle urne una considerevole massa di elettori astenutisi nelle precedenti consultazioni. Il rapido ritiro delle truppe spagnole dall’Iraq, già annunciato in campagna elettorale, da un ulteriore scossone al fragile equilibrio delle relazioni transatlantiche e allontanando le possibilità di ricucire. • Le percezioni dell’opinione pubblica Malgrado l’agitato dibattito sul dissapore tra le due sponde dell’Atlantico che ferve negli ambienti della politica, dei media e degli intellettuali, la massa dell’opinione pubblica non se ne appassiona. Non vi sono movimenti popolari in favore Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 119 del riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti, non appaiono all’orizzonte slanci pubblici in favore (o contro) tale eventualità. Sembra che le imponenti manifestazioni europee contro la guerra in Iraq abbiano lasciato nell’immaginario collettivo europeo la consapevolezza che gli Stati Uniti siano un “altro mondo”, sensazione confermata in seguito con orrore davanti alle torture nel carcere di Abou Ghraib e dalle violente polemiche sull’attenuarsi negli Usa delle garanzie dei diritti individuali in favore di una legislazione più severa indotta dalla lotta al terrorismo (Patriot Act). Le elezioni europee del 13 giugno confermano anche l’opinione dei cittadini contrari alla guerra e dalle urne escono sconfitti o ridimensionati i leader che l’hanno appoggiata, in particolare Tony Blair. D’altro canto in America non si comprende tanto la sensibilità europea riguardo certe questioni ritenute vitali, come la lotta al terrorismo. Talvolta si ha l’impressione di un’incapacità a comunicare o forse del venire alla luce di differenze antiche, e in un certo senso ormai accettate come usuali. Tale incomprensione va oltre l’amministrazione in carica e scavalca il quadro politico attuale (sul quale invece si concentra l’attenzione dei media). Anche laddove ferve nella classe politica un acceso dibattito tra chi è considerato vicino alle scelte americane e chi al contrario se ne distanzia (è il caso italiano, inglese o polacco), la maggioranza dell’opinione pubblica non ne sembra particolarmente coinvolta: i cittadini europei non si sentono anti-americani né pro-americani). Ribadiscono però la loro contrarietà alla guerra. Dal canto loro, i cittadini Usa non hanno mutato la generale percezione sull’Europa, considerata vicina e lontana allo stesso tempo. Malgrado le campagne stampa durissime suscitate dalla rottura sull’Iraq, non sembra che le opinioni pubbliche si lascino trascinare dalla disputa, mentre mantengono le proprie opinioni tradizionali e rimangono sostanzialmente indifferenti. • “Una certa incomunicabilità” Forse ci troviamo di fronte alla constatazione di diversità già presenti nell’immaginario collettivo, in qualche modo già assorbite, visto che non suscitano scalpore né scandalo. Ci si adatta ad una certa incomunicabilità. Lo stesso “ritorno verso l’Onu” messo in atto dall’Amministrazione Bush nel corso del mese di maggio (dopo un aprile estremamente letale per le truppe in Iraq) attraverso la missione dell’inviato di Kofi Annan, Lakhdar Brahimi, e la nuova risoluzione votata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza, non ha suscitato in Europa un’ondata di simpatia né ha riavvicinato le sensibilità. La generale consapevolezza delle conseguenze nefaste della guerra e dell’accrescersi delle reti terroristiche, lascia la massa dei cittadini europei in un sentimento misto tra preoccupazione e rassegnazione. Si assiste a quello che alcuni osservatori hanno chiamato lo “scisma filosofico” dell’Occidente attorno alla questione della legittimità del potere e della leadership 120 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 degli Usa. Ciò non dipende solo dagli “errori” imputati a Washington da parte europea: anche durante la guerra del Vietnam o altre operazioni militari vi è stata forte opposizione senza però mai mettere in discussione il ruolo guida degli americani. La fine della guerra fredda ha mutato una condizione di fondo: fino ad allora l’America era considerata in Europa la “superpotenza necessaria”, a cui si poteva perdonare qualche disavvertenza. Oggi tale legittimità è rimessa in discussione, anche davanti al pericolo terrorista. La minaccia di quest’ultimo non è percepita allo stesso modo: per gli americani si tratta di una minaccia globale e ideologica, l’emersione di un nuovo nemico globale come lo fu il comunismo. Per gli europei invece di una minaccia localizzata e definita nel tempo e nello spazio, da non trattare assolutamente come un nemico globale, pena il suo rafforzamento. Ne consegue che la volontà americana di continuare ad essere il “leader del mondo libero” assume in Europa il sapore di una pretesa fuoritempo. Malgrado ciò l’Europa è cosciente delle sue debolezze strutturali, militari e strategiche. Paradossalmente tale condizione non la spinge solo a non rompere del tutto con gli Usa, ma la porta a essere meno aggressiva nei confronti del mondo arabo-islamico. Se ne è visto un chiaro esempio allorché i leader europei non hanno sottoscritto del tutto l’idea del Broader Middle East, avanzata da Bush al G8 di Savannah ad inizio di giugno. Tale progetto prevede un processo di “democratizzazione” dei paesi arabi secondo le linee (invero assai moderate nella stesura finale del documento) del pensiero neoconservatore americano: la democrazia e i valori del liberalismo si possono e si devono esportare. • L’Europa e l’approccio storico Tale non è l’opinione della maggioranza degli europei che preferisce un approccio storico a tali questioni. La stessa frustrazione di Blair sulla Road Map per una soluzione della crisi in Medio Oriente, e la sua incapacità a convincere gli americani a fare pressioni sul governo Sharon, possono essere lette nello stesso quadro. Sulle maggiori questioni internazionali le diversità politiche tra Usa e Europa sono in realtà note da tempo. La questione delle regole globali e delle istituzioni internazionali (in primis il controverso ruolo delle Nazioni Unite), la crisi del Medio Oriente (compreso l’Iraq), la competizione economica e il peso delle monete, l’influenza in altre zone del mondo, le operazioni di peace-keeping, l’atteggiamento verso un paese chiave come la Turchia: si tratta di argomenti che dividono i due alleati. Il 2003 ha visto la svalutazione del dollaro nei confronti dell’euro, senza che sia chiaro se tale vicenda rappresenti una scelta o sia il prodotto di dati economici autonomi. Da una parte certamente le esportazioni Usa se ne avvalgono. Dall’altra lo spostamento di ingenti capitali verso la zona euro (in particolare dalla zona del Golfo che detiene una grossa fetta della liquidità mondiale) e un nuovo assetto della spartizione del commercio mondiale tra le tre aree forti (Usa, Europa e Asia), Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 121 può spiegare lo stesso fenomeno. Non va dimenticata nemmeno la forza del mercato interno americano e l’espansione del debito interno, anche a causa della politica fiscale dell’amministrazione Bush e dell’aumento vertiginoso delle spese militari, giunte a 447 miliardi di dollari per il prossimo bilancio. D’altro canto sulla più antica crisi internazionale, quella del Medio Oriente, non sembra che le opinioni occidentali riescano a trovare una sinergia utile a favorire una soluzione. Diversità di sensibilità si avvertono anche nelle relazioni con Siria e Iran, che ha sperimentato una recente tornata elettorale controversa, a causa del boicottaggio dell’ala riformista e la conseguente sconfitta dei centristi vicini al presidente Khatami, in favore dei conservatori. Né la cattura di Saddam Hussein né, su un altro versante, l’accordo firmato a Ginevra tra autorevoli esponenti del mondo politico e della società civile israeliana e palestinese (entrambi fatti accaduti alla fine del 2003), sembrano aver giovato a Bush né provocato un riavvicinamento tra posizioni che rimangono distanti. Ciò accade proprio mentre l’approssimarsi delle elezioni americane pone l’amministrazione attuale sotto pressione. Durante la sua campagna, lo sfidante John Kerry ha messo più volte l’accento sugli errori di Bush che hanno provocato una divisione dall’Europa. È forse la prima volta da moltissimo tempo che, nel dibattito elettorale americano, l’argomento della politica estera diviene terreno di scontro tra i candidati. Anche per questo motivo il presidente Bush ha fortemente voluto il recente viaggio in Europa per partecipare ai festeggiamenti del sessantesimo anniversario del D-Day in Normandia. Ben sapendo di andare incontro ad viaggio difficile, sia nella visita al Papa che negli incontri con Chirac, Bush ha voluto fare un gesto di buona volontà nei confronti degli ormai “necessari” alleati europei e assicurarsi anche una mossa favorevole per il suo potenziale elettorato cattolico. Da tale complessa situazione si osserva che Usa e Europa non vogliono dividersi ma stanno affrontandosi sui temi della legittimità della leadership americana (che gli europei vedono ormai come una partnership e vorrebbero influenzare) e dell’idea di democrazia liberale. Lo scisma si può consumare su quale sia la vera “fonte del potere” nel complesso mondo multipolare di oggi. La questione dei detenuti di Guantanamo e del vuoto giuridico in cui si trovano – tra cui alcuni di cittadinanza europea – divide Washington dalla stessa Londra, oltre che dal mondo dei diritti umani. • Incertezza europee e americane L’Europa ha incontrato molte difficoltà per l’approvazione della carta costituzionale. Le divergenze europee conseguenti alla crisi irachena e al fallimento del vertice di dicembre, hanno reso difficili le relazioni tra gli Stati membri. Ciò è dimostrato dalla convocazione della riunione a tre di febbraio, tra Germania, Francia e Gran Bretagna (o alla decisione americana di appoggiare la candidatura della Germania tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu). Malgra- 122 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 do le ripetute assicurazioni agli altri partner sulla volontà di non rompere il metodo “comunitario” per passare a quello a “doppia velocità”, gli accordi industriali e militari tra i tre maggiori Stati dell’Unione prefigurano il passaggio a una nuova fase dell’integrazione europea. La necessità di trovare soluzioni credibili alla sfida dell’Unione Politica (l’unica e l’ultima rimasta sul tavolo) provocherà necessariamente un approfondimento del solco tra le varie idee di Europa. Il primo maggio si è compiuto il grande passo dell’entrata dei 10 nuovi paesi nell’Unione. È certo che l’allargamento a 25 non può avvenire nell’impasse sui meccanismi decisionali che rischiano di far fallire tutto l’impianto. Tuttavia lo scetticismo pervade ancora in maniera preoccupante l’opinione pubblica europea sia a ovest che a est. I cittadini non vedono (ma va detto che non è stato loro spiegato) quali saranno le istituzioni di domani e come funzionerà un’Europa più grande. Le elezioni europee, troppo utilizzate ancora come sondaggio a grandezza naturale per ragioni di politica interna, hanno visto l’aumento dell’astensionismo che ha toccato punte estreme proprio ad est. D’altra parte l’evento storico dell’entrata dei nuovi paesi è stato accolto con apatia in quasi tutti i vecchi paesi membri, salvo il grande raduno di cattolici e protestanti a Stoccarda promosso tra gli altri dal Movimento dei Focolari e dalla Comunità di Sant’Egidio. Tali fatti sono emblematici degli interrogativi che sorgono attorno all’idea di Europa e della mancanza di una visione condivisa. Dal punto di vista sociale, il 2004 è iniziato in Europa con la disputa sul sistema sociale e del Welfare State. La riforma delle pensioni avvenuta in Francia e in Germania rilancia il tema in tutti i paesi. Soprattutto emerge la situazione dei working poors, la classe media impoverita a cause delle riforme in senso liberista che l’avvento dell’euro (ma soprattutto il suo recente rafforzamento rispetto al dollaro) ha reso ancor più evidente. Sul modello americano, si allarga il precariato lavorativo anche in Europa, dando vita a nuove forme di contratti a termine (lavoratori atipici, interinali, flessibili, in partecipazione, in prestito, para-subordinati, prestatori d’opera, coordinati continuativi, a progetto) che generano nella popolazione – e in special modo nei giovani – un senso di insicurezza rispetto al futuro. D’altro canto, negli Usa le primarie democratiche hanno fatto emergere in maniera consistente le divergenze interne della società e gettato una nuova luce sulla natura complessa dell’opinione pubblica americana. L’emergere di John F. Kerry come candidato del partito democratico ha messo in luce come non esista unanimità sulle cruciali questioni della sicurezza interna e della lotta al terrorismo. Ciò non significa un immediato riavvicinamento alle tesi europee. Dimostra al contrario quanto sia semplicista una certa percezione europea della società americana, considerata erroneamente statica e non articolata. Il dibattito all’interno della grande potenza ferve su tutte le questioni che riguardano il suo futuro: naturalmente su economia e guerra ma anche povertà, assistenza e modello di sviluppo. Il quadro è complesso: da un lato più di 40 milioni di americani sono senza assistenza sanitaria, dall’altro lapolitica di regolarizzazione e di entrata di nuovi immigrati fa degli Stati Uniti un paese più giovane e dinamico dell’Europa. Tra qualche anno Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 123 la forbice dell’età media tra le due sponde si allargherà in maniera consistente: 35 contro oltre 50 per l’Europa. Inoltre negli Usa il problema del ruolo dello Stato è in permanente discussione, tra chi crede in un intervento massiccio degli organi federali e i sostenitori di un “governo leggero”. La complicata articolazione della lotta d’influenza tra le numerosissime rappresentanze degli interessi, rende la politica americana molto più vivace e contraddittoria di quanto si creda. Le questioni sociali e di morale comune accendono continue polemiche che hanno al centro la questione dei valori fondamentali della società. Un fenomeno recentemente portato alla luce dai media riguarda, ad esempio, l’“homeschooling”. Più di 2 milioni di studenti americani (uno su 25) studiano a casa, con i genitori. Molti stati hanno adottato leggi per facilitare tale scelta. Il fenomeno pare essere in espansione e si contrappone alla scuola pubblica (molto criticata negli Usa) ma anche a quella privata, fondando le sue ragioni sui valori familiari di radice religiosa e conservatrice. • Un certo ripiegamento interno Le inquietudini delle società occidentali avvengono per lo più in una prospettiva interna ed esclusiva, in assenza di uno sguardo ampio sul mondo. La stessa attuale sovra-esposizione internazionale americana – militare e politica – è spiegata dal Presidente Bush come una forma di difesa dell’integrità territoriale e dei valori americani. Allo stesso modo, la crisi dei lavori della Convenzione europea è avvenuta per ragioni endogene e il testo costituzionale non ha innescato un dibattito su quale sia l’idea europea sul mondo. Ciò malgrado il “bisogno di Europa” espresso da molti protagonisti nei vari quadranti mondiali. Tale spinta introspettiva e di ripiegamento sulle questioni interne non contribuisce alla soluzione della crisi della democrazia rappresentativa, che tuttavia molti denunciano, sia a livello nazionale che internazionale. Il dibattito sulla riforma delle Nazioni Unite e sulle “regole” internazionali non trova una sufficiente eco nel mondo politico occidentale. I ripetuti fallimenti dei vertici sul commercio mondiale (Omc) – tra cui l’ultimo di Cancun – non sembra aver provocato alcuna accurata riflessione su quale siano le nuove regole eque della mondializzazione economica. Le decisioni prese ai vari vertici del G8, per esempio sull’Africa e l’Aids, non si sono concretizzate in fattivi programmi di aiuto. L’ultima riunione del G8 negli Usa si è risolta in una lunga discussione sul futuro dell’Iraq e del progetto sul Grande Medio Oriente di Bush senza peraltro giungere a conclusioni concrete né a portare avanti il programma per l’Africa iniziato al G8 di Genova. L’Occidente, nelle sue due versioni, non offre una seria visione del futuro globale e appare scarico di ambizioni e progetti politici a lungo termine, se si omette quelli di potenza espressi dagli Usa. L’annuncio di Kofi Annan di inizio d’anno sulla riforma delle Nazioni Unite non ha provocato nessuna reazione di rilievo, né i tentativi africani con la Nuova Partnership (Nepad) hanno incontrato l’appoggio sperato, seppure siano stati ideati 124 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 sulla base delle regole liberiste in vigore. Il World Economic Forum ha svolto la sua seconda riunione regionale in Africa, a Maputo, dove si è molto discusso di tali temi in attesa del Vertice dell’Unione Africana di luglio. Anche la questione della giustizia internazionale è rimasta al palo, irta di contraddizioni. Da un punto di vista giuridico, la Corte Penale Internazionale (Icc) non ha risolto i suoi problemi, in special modo la costituzione di un foro o di un’avvocatura internazionale della difesa. La Corte affronta l’anno nuovo, quello della sua fase operativa, senza uno dei pilastri giuridici fondamentali e si trova nella stessa situazione delle corti speciali per la ex Jugoslavia e del Rwanda che non hanno ottenuto gli effetti sperati. D’altro canto, da un punto di vista politico il 2003 è trascorso in maniera ambigua. Alcuni paesi, tra cui in particolare gli Usa, hanno tentato in tutti i modi di evitare di essere legati alla nuova giurisdizione internazionale. Gli Stati Uniti hanno chiesto e ottenuto da circa 40 stati l’impegno all’esenzione dei loro cittadini dal mandato della Corte. In vari casi – vedi quello dell’ex leader liberiano Charles Taylor ma anche di Milosevič – le corti internazionali speciali non hanno dato buona prova di sé perché impropriamente utilizzate. Invece di concentrarsi e limitarsi a fatti precisi, si è cercato di dire una parola definitiva e di risolvere alcuni conflitti utilizzando il metodo della “rilettura giuridica” degli avvenimenti. Di conseguenza alcuni osservatori ora contestano che il “tutto giuridico” possa essere il metodo giusto per districare annose crisi politiche, distribuendo torti e ragioni storiche davanti ad un tribunale. • La controversia sulla globalizzazione Ai due forum mondiali, quello economico di Davos (Wef ) e quello sociale di Mumbay (Wsf ) del gennaio scorso, si è assistito alla fine dei tentativi di dialogo immaginati l’anno precedente. I due Forum si sono svolti nella sostanziale vicendevole indifferenza. A Davos la questione più importante ha continuato ad essere la relazione tra Usa ed Europa, dopo le forti polemiche dell’edizione 2003. L’appuntamento di Mumbay invece ha dimostrato in maniera forse definitiva che il Social Forum non desidera trasformarsi in un movimento politico mondiale ma vuole rimanere un vasto momento di incontro e di scambio dove convogliare le varie anime del mondo “no global” (o “new global”) e l’articolata area del malcontento coagulata dagli effetti della liberalizzazione dei mercati e dei comportamenti delle imprese transnazionali. Mumbay è stata anche l’occasione per il manifestarsi della società civile indiana e dell’area del sub continente, in tutto il suo variopinto vigore. Si tratta di un fenomeno interessante perché completamente endogeno e non legato a reti occidentali. Forse ciò rappresenta l’emersione del primo vero e autonomo movimento sociale originato (culturalmente e politicamente) nel sud del mondo, al di fuori di ogni influenza occidentale. A Davos il grande business mondiale si è interrogato sull’efficacia degli strumenti messi recentemente in opera per contrastare gli effetti perversi della globaliz- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 125 zazione economica. L’ex Presidente americano Bill Clinton, è stato particolarmente chiaro indicando come la scarsità di risultati dipenda non tanto dall’assenza di “buone idee” ma dalla mancata “messa a sistema” di queste ultime. Una certa critica è stata diretta contro la diminuzione delle risorse dedicate all’aiuto pubblico allo sviluppo e ai programmi concepiti nel corso dell’ultimo biennio, come il Global Fund contro l’Aids (Gftam) che, a fronte di un bisogno di circa 9 miliardi di dollari, ne ha raccolti meno di 3 e spesi a fine gennaio circa 300 milioni. Si è ancora alla ricerca di un accordo globale tra le risorse devolute dagli Stati ricchi e quelle elargite dalle grandi multinazionali, a riprova di una difformità di interessi e dell’assenza di una vera politica del Nord del mondo verso il Sud. • Il mondo delle crisi Il 2004 è il decennale di due avvenimenti di diversa portata: il triste anniversario del terribile genocidio in Rwanda (aprile 94) e l’inizio dell’insurrezione zapatista in Messico. Oltre il conflitto in Iraq e la guerra contro il terrorismo, molte sono le crisi ancora aperte in particolare in Africa dove, a fronte di alcune notizie di accordi avvenuti e in corso di applicazione, si registra il perdurare di vecchie crisi e la generale instabilità degli Stati. In Repubblica Democratica del Congo, Costa d’Avorio e Liberia, l’applicazione degli accordi di pace varati nel 2003, procede lentamente e le fragilità sono molteplici. In particolare ad Abidjan – malgrado la presenza della forza di stabilizzazione militare francese – le forze politiche nazionali non sembrano ancora aver maturato la decisione finale del disarmo delle parti. L’arrivo dei primi caschi blu delle Nazioni Unite non ha ancora provocato quel salto di qualità richiesto dagli accordi. Tuttavia la crisi ivoriana è stata bloccata sul nascere e il numero delle vittime degli scontri iniziali è molto lontano dalle tragiche cifre del Congo (forse 3 milioni di morti dal 1997) e della Liberia (forse 250.000 dal 1980). A inizio giugno alcuni attacchi ad est nella città congolese di Bukavu hanno visto riaccendersi la crisi della Rdc, in particolare con scontri tra varie etnie. Così anche per la Liberia è stato necessario un’ulteriore riunione tra le parti, mediata dalla Comunità di Sant’Egidio, che si è svolta a Roma nel maggio allo scopo di ricucire alcuni strappi nella difficile coabitazione del governo di unità nazionale. Parziali buone notizie provengono dal Sudan, un paese dove infuria la più antica guerra civile africana, che ha provocato oltre 2 milioni di morti. Un primo accordo è stato ottenuto ad inizio d’anno (sulla distribuzione delle risorse) e i negoziati sono ripresi dall’inizio di marzo. Malgrado tale avanzamento, una nuova crisi nell’ovest del paese (Darfur) rischia di mettere a repentaglio l’opera dei negoziatori, sostenuti attivamente dagli Stati Uniti, e sta creando una vera emergenza umanitaria con oltre un milione di nuovi profughi. 126 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Resta tesa invece la situazione nel Corno d’Africa dove, oltre al disastro somalo ancora irrisolto, la conflittualità tra Etiopia e Eritrea rimane alta, malgrado i vari interventi Onu. Ciò che preoccupa di più gli esperti di cose africane è la cronica debolezza degli Stati in Africa, schiacciati tra le regole delle istituzioni finanziarie internazionali e l’utilizzo nepotista o patrimoniale da parte di gruppi di potere, etnici o politici che siano. In assenza di un settore privato forte e con un’arretrata struttura economica del continente – basata cioè solo sulla vendita di materie prime (agricole o minerarie) e quindi in balìa delle variazioni dei prezzi – in Africa lo Stato rimane ancora oggi il più importante datore di lavoro oltre che l’unica realtà unificante che possa contrastare la frammentazione su base etnica. In febbraio l’Unicef ha reso noti gli ultimi dati sull’infanzia in Africa, da dove si desume che oltre il 70% dei bambini africani non è iscritto all’anagrafe e quindi ufficialmente non esiste. In Asia le vere novità d’inizio 2004 provengono dall’India. L’avvio di negoziati tra India e Pakistan sulla questione del Kashmir sembra avere una prospettiva positiva. Inoltre l’inaspettata vittoria della coalizione attorno al Partito del Congresso guidata da Sonia Gandhi, ha dimostrato come le contraddizioni sociali non siano state assorbite dal pur forte sviluppo della “shining India”. Sonia non è tuttavia riuscita ad accedere al posto di primo ministro a causa delle critiche numerose sulla sua estrazione italiana. In Sri Lanka lo stallo dei colloqui (sostenuti dalla Norvegia) tra Tigri Tamil e governo centrale è una cattiva notizia per un paese martoriato da una lunga guerra civile dove – non va dimenticato – è stata inventata per la prima volta anni fa la figura del terrorista-suicida, armato di giubbetto esplosivo, che in seguito ha fatto scuola anche in Medio Oriente, a dimostrazione di come il lasciar deteriorare le crisi possa avere degli effetti non previsti anche in zone lontane e in diversissimi contesti. In America Latina, l’anno del bicentenario (1804-2004) di Haiti – il primo paese colonizzato a rendersi indipendente – ha paradossalmente portato nell’isola caraibica un nuovo sommovimento insurrezionale, con la cacciata a inizio marzo del presidente Aristide. Quest’ultimo è accusato di violenze e di violazione dei diritti umani anche se i suoi nemici provengono dalle sue stesse fila e non sembra che il paese sia ancora in grado di uscire dalla sua cronica instabilità. Rimane grave anche la situazione della Colombia, dove il governo di Bogotà non controlla che una parte del paese mentre ampie zone sono sotto il comando delle guerriglie e gruppi paramilitari dediti al narcotraffico. Migliora la situazione economica dell’Argentina dopo il caos dell’anno precedente, e si prefigura un’alleanza con il Cile e il Brasile di Lula al fine di ottenere un peso maggiore durante i negoziati per l’Alca, la zona di libero scambio economico che gli Usa hanno proposto per l’intero continente. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 127 Economia a cura di Gianni Locatelli Europa “nuova”, Economia “vecchia” Vecchia, stanca, ingessata. Se si ha il coraggio (doveroso innanzitutto verso se stessi) di ripulire dei tanti belletti retorici la fotografia dell’Europa attuale, questa è l’immagine reale del nostro continente. Oggi l’Europa è vecchia sotto molti aspetti ma quello che più impietosamente ne denuncia le rughe è l’anagrafe dei suoi abitanti: un continente di vecchi, che pensano da vecchi e si preoccupano solo di conservare le loro vecchie abitudini contro i loro stessi (pochi) figli, contro i loro nipoti (pochissimi) e soprattutto contro le masse (giovani e vitali) che tumultuosamente bussano alla loro porta. È inevitabile che questa vecchia Europa sia stanca. Stanca soprattutto di rischiare, di ricercare, di espandere le proprie virtù civili (che vivono solo nella libertà) e di esercitare le proprie virtù militari (che servono per la pace e non solo per la guerra). Per questo, per difendere la sua stanca vecchiaia, l’Europa ha pensato bene di ingessarsi il più possibile. Esaurita la forza morale e politica dei suoi padri fondatori, ha messo al centro della propria unificazione una fabbrica di norme e di vincoli affidandola alla gestione di una casta di euroburocrati in perfetta sintonia con le caste burocratiche dei loro omologhi nazionali. Così, dal diametro delle susine ai parametri dei conti pubblici è un unico, imperturbabile patto di stabilità contro le sorprese della realtà. La quale, purtroppo per noi europei, ha il brutto vizio di entrarci in casa senza chiedere permesso, infischiandosene dei nostri parametri e costringendoci a guardare una fotografia dell’Europa quale essa realmente è. • I numeri dell’economia Messe da parte le belle parole, a parlare sono allora i numeri e, con voce più preoccupante, i numeri dell’economia. Limitiamoci per semplicità a quelli dello sviluppo ossia della capacità di produrre nuova ricchezza con cui rinnovare quella esistente e accrescere quella futura. Ebbene, contro una Cina che cresce al ritmo dell’89% annuo trascinando l’intera area estremo-orientale; contro gli Stati Uniti che cre- 128 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 scono attorno al 5% annuo; esclusa (non per caso) un’Inghilterra che viaggia vicino al più 3,5% troviamo un’Europa continentale che non sa più crescere: Germania 0%; Francia +1,5; Italia +0,5. Questo il nostro sparuto ritmo di crescita nel 2003, cioè nell’anno annunciato come il primo di una robusta ripresa anche per l’Europa. Qualcuno potrebbe obiettare che lo sviluppo non è tutto perché l’economia è soltanto uno dei colori dell’immagine collettiva di una comunità particolarmente complessa come quella europea. D’accordo, purché non diventi un alibi per continuare a conversare in giardino mentre la casa brucia. Poiché anche l’economia e i suoi numeri crescono sulla politica e le sue idee, il richiamo alla realtà deve valere per entrambe, per l’economia non meno che per la politica, se non altro per evitare che, continuando a ignorarsi, la politica si riduca a semplice pratica comandata dalla forza non delle idee ma delle situazioni. Per fare un esempio concreto, quante volte si è chiesto alla politica di avere una “politica economica” ottenendone in cambio solo un’economia senza politica? Il motivo è ormai chiaro: la “politica economica” è una soluzione in attesa dei problemi e non viceversa. Quando i problemi esplodono e la politica non ha soluzioni idonee o ne ha solo di vecchie e formali, finirà inevitabilmente per andare a rimorchio della realtà invece di governarla come dovrebbe. • I “casi” italiani Inevitabile, a questo punto, parlare di Parmalat. Con una operazione alla Michelangelo Antonioni di Blow up sulla fotografia dell’Europa, possiamo mettere più a fuoco il caso Parmalat per individuare meglio alcune caratteristiche dello specifico declino italiano. Depurata dei particolari di cronaca, in attesa che si completino l’azione giudiziaria e il percorso legislativo per la migliore tutela del risparmio, stemperata l’emozione dei mercati in una più realistica valutazione del “rischio Italia” è il momento adatto per leggere nella realtà dei fatti accaduti e cercar di capire il da farsi. Anche per non alimentare equivoci, la prima verità da ribadire è che il crac Parmalat è un’autentica catastrofe nazionale per la natura dei protagonisti e uno scandalo internazionale per la dimensione degli interessi coinvolti. Non può essere ridotta quindi a una storia individuale, di ladri e di mariuoli travestiti da imprenditori, perché è la storia del primo gruppo alimentare italiano con presenze in cinque continenti, con 36mila dipendenti, con un fatturato di oltre 7 miliardi di euro. Quindi per favore, signori imprenditori, controllori e governanti, non minimizziamo parlando di caso isolato, di controlli aggirati e di norme solo da migliorare. Gli interventi attesi e da fare sono in alcuni punti radicali e da coordinare sia a livello nazionale per quanto riguarda i controlli sia a livello internazionale per quanto riguarda le responsabilità. Senza entrare qui nei dettagli, è ormai attesa generale che sul piano legislativo nazionale si ripristinino norme serie sul falso in bilancio e si rimetta mano alla nuova legge sulle società che, Parmalat dimostra, è del tutto inadeguata. Nessuno è tanto superficiale da pensare che la truffa Parmalat sia conseguenza della legge con cui il Governo Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 129 Berlusconi ha ridotto il falso in bilancio a reato minore, facendo dell’Italia un’anomalia nel contesto dei Paesi più industrializzati. Sempre sul piano legislativo nazionale, i mercati si aspettano un inquadramento più coerente ed efficace delle responsabilità e dei poteri sia della Banca d’Italia sia di Consob nonché una diversa impostazione dei rapporti tra imprese e banche, tra azionisti e amministratori, tra controllori e controllandi. • Conflitti di interessi e banche d’affari Non solo. Poiché Parmalat è un caso anche internazionale o più precisamente italo-americano (perché almeno due terzi dei suoi inghippi sono made in Usa) è ugualmente diffusa l’attesa che anche sul piano internazionale si lavori per prevenire altri scandali del genere. Rimuovendo per esempio i conflitti di interesse che inquinano troppe banche d’affari, rifondando cultura e regole delle società di revisione, imponendo regole di “governance societaria” che smontino il superpotere dei presidenti-amministratori delegati, impedendo l’utilizzo di veicoli off-shore per emettere titoli di debito. Evidentemente si tratta di un lavoro complesso, che l’Italia non può fare da sola ma che, proprio perché ustionata dal crac Parmalat, l’Italia dovrebbe avviare per prima. Il dubbio è se abbia la cultura e le volontà per farlo. Ingrandendo ulteriormente, sempre come Antonioni in Blow up, alcuni dettagli di fondo dell’immagine Italia è possibile mettere a fuoco qualche riflessione. La prima riguarda le cause o, per meglio dire, gli interessi nascosti dietro il cumulo di rigidità, ingessature e lacci che impediscono a questo Paese di rinnovarsi e di crescere. In ordine sparso: le corporazioni professionali, i sindacati dei lavoratori e degli imprenditori, banche e istituzioni varie del credito, i partiti e gli organismi assimilati, la burocrazia d’ogni livello, i media che contano. Intendiamoci, non è che tutti questi professionisti dell’immobilità non siano anche dei combattenti per il cambiamento. Ma lo sono a parole, alimentando la quotidiana produzione di polveroni che una volta diradati lasciano le cose come stavano e le intelligenze sempre più ottuse o distratte. • Le intelligenze distratte Per fare qualche esempio, sappiamo tutti ormai che, senza concorrenza, sono i cervelli (ossia le idee e i meriti) a essere maggiormente danneggiati e a cercare quindi una salvezza nella fuga. Eppure siamo tutti pronti a barricarci dietro lo status quo della macchina universitaria (a quando l’abolizione del valore legale dei titoli?) avvertendo la politica e i suoi uomini che se si azzarderanno a cambiare davvero qualcosa verranno sonoramente puniti. Ugualmente, sappiamo tutti che un sistema pensionistico come l’attuale non potrà reggere fino ai nostri figli, ma nessuno è 130 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 disposto veramente a rischiare qualcosa oggi per il loro domani, avvertendo il sindacato e i suoi leader che non si impegnino troppo nella riforma se vogliono continuare a marciare incolumi. Quanto agli industriali, stabilito che Tanzi è solo un alieno, il loro problema principale è come proteggersi dalla concorrenza non facendo concorrenza al resto del mondo, ma coltivando buone relazioni in grado di assicurare la gestione di pubblici servizi a tariffe garantite. Un sistema economico che vive di relazioni e non di mercato ha bisogno ovviamente di due condizioni: che nulla si muova e che poco sia trasparente. A cominciare dagli organi pubblici di controllo, per i quali l’unica riforma accettata è quella che ridistribuisce compiti e poteri quando invece l’unica riforma seria sarebbe quella di stabilire prima come devono essere esercitati compiti e poteri. Perché altrimenti cambieranno gli attori ma non il copione dell’arbitrio e della discrezionalità. Le vicende recenti e ancora attuali del nostro sistema creditizio e finanziario la dicono lunga in proposito. • Il nuovo “dovere” dei cattolici-democratici Essendo questa la realtà dell’Europa e dell’Italia di cui ci tocca ragionare, ci tocca anche l’obbligo di uscire dallo sfondo indistinto in cui finiscono sempre per rifugiarsi le velleità di rinnovamento, di crescita, di protagonismo globale di questa Europa e di questa Italia. Parlo di quanti sono, cattolici, laicamente educati all’impegno della testimonianza e del dialogo nel lavoro, nella professione, nella società, nella politica; convinti non per interesse ma per responsabilità del contributo da dare alla laicità della politica oltre che del ruolo dei cristiani nella crescita della società, dell’economia, della cultura attraverso la politica. Parlo insomma a quanti, consapevolmente o meno, hanno radici culturali che affondano nella grande testimonianza del cattolicesimo politico partendo da Manzoni, Rosmini, Murri, Meda e poi Sturzo, Ferrari, Donati, De Gasperi, la Sinistra cristiana, Moro... Oggi che i grandi partiti storici sono scomparsi e nuove forme di aggregazione o di rappresentanza occupano la scena politica, la parte sostanziale e tuttora attuale della tradizione cattolico-democratica non può sottrarsi al dovere di dare il proprio contributo. Certo, si tratta di trovare le forme adatte perché questo contributo possa esprimersi concretamente e sia riconoscibile oltre che riconosciuto anche sul piano elettorale. Ma la premessa di tutto ciò è proprio quell’uscire “dallo sfondo” che è possibile solo parlando chiaro e agendo di conseguenza. A cominciare dall’economia, che ha certamente le sue leggi e le sue tecniche ma che ha anche un suo comandamento, il Settimo: “non rubare”. Un comandamento tanto importante da suggerire al Padreterno di ribadirlo in chiusura di decalogo: “Non desiderare la roba d’altri”. Ridotte alla loro sostanza e spogliate dei loro formalismi, la regole del mercato sono tutte qui e il loro rispetto non è un problema di Consob o di Banca d’Italia ma solo un problema di cultura civile e di responsabilità personale. Poi naturalmente c’è an- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 131 che la dottrina sociale della Chiesa, che altro non è se non l’adattamento ai tempi dei principi fondamentali contenuti nei grandi testi sacri dell’umanità. In questa Europa e in questa Italia vecchie, stanche e ingessate, il compito dei democratici cristiani è oggi quello di non consentire alla politica di ridursi a pura prassi, a occasionale gestione del contingente. E ciò per evitare che a egemonizzarla siano l’egoismo di un profitto fine a se stesso e le regole di un mercato senza responsabilità. La proprietà come bene individuale da utilizzare come bene comune in un disegno politico coerente e la responsabilità delle scelte di ciascuno verso se stesso e verso gli altri sono due concetti essenziali della dottrina sociale della Chiesa ma sono anche due concetti essenziali della moderna economia di mercato. Pertanto la riforma più radicale che i democratici cristiani possono immaginare oggi in materia di economia è proprio il recupero di una matrice ideale, di una tradizione culturale, in sintesi di una politica che sappia costruire una realtà nuova e non solo parare i colpi di realtà invecchiate. Anche a costo di scuotere dalle fondamenta consolidate abitudini come quella che “ai nostri mali ci pensa l’Europa” con i suoi “vincoli”nella moneta, nel fisco o nelle imprese. In passato da questi vincoli l’Italia ha avuto molto, ma oggi che l’Europa è in crisi, oggi che l’Europa è stanca non possiamo incartapecorirci con lei. Forse è il caso di riprenderci in mano il nostro futuro specie se qualche terremoto tipo Parmalat ci aiuta a capire meglio i nostri mali. “Reformers need to hurry” ammonisce Business Week. Bisogna fare in fretta. E soprattutto bisogna essere riformatori, non basta fare i riformisti. 132 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Religioni e civiltà a cura di Agostino Giovagnoli Le luci di Shanghai e le ombre della Cina Shanghai è oggi la città più nuova del mondo: New York o Tokyo appaiono, al confronto, già vecchie. Una volta il Bund, sul fiume Huangpu, era il cuore della città coloniale e il centro del traffico dell’oppio; qui si congiungevano i settlements inglese e americano e ancora vi si trovano, ben conservati e sapientemente illuminati, i pesanti edifici delle compagnie marittime occidentali, dove ora hanno sede le principali banche cinesi. Ma davanti a chi passeggia sul lungofiume si apre uno spettacolo straordinario: al di là dello Huangpu, dove una volta c’era la vasta distesa delle misere casupole di Pudong, si staglia un avveniristico panorama di grattacieli, bombardati da spettacolari giochi di luci. Sulle due sponde del fiume, si affacciano dunque la Cina del futuro e quella del passato e la prima è talmente sicura di sé da trasformare in attrazione turistica le tracce dell’umiliazione coloniale che fino a pochi anni fa cercava furiosamente di distruggere. • Il grande cantiere L’immagine del grande cantiere potrebbe sembrare di maniera: eppure, nel caso di Shanghai, è vera alla lettera. I tantissimi luoghi dove si costruiscono, per lo più, edifici di enormi dimensioni, non rinviano ad un futuro ancora indefinito ma rivelano plasticamente il febbrile presente della città. Si parla di più di duemila grattacieli in costruzione, mentre moltissimi altri sono stati appena ultimati. I due aeroporti, per i voli nazionali e internazionali, sono stati radicalmente rinnovati come pure le autostrade che portano downtown e il centro cultural-gastronomico di Xintiandi – dove si assaggiano tutte le cucine del mondo – è stato costruito in soli tre anni. Viceversa, la People’s Square, la più grande piazza della città, appare già vecchia: l’architettura del museo di Shanghai, che ne occupa il centro, non regge al confronto con gli edifici nuovissimi che le sono stati costruiti intorno per ospitare il teatro, l’auditorio e un grande magazzino. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 133 Concepita prima del 1989 per dare alla città un luogo simbolo di orgogliosa identità socialista, piazza Renmin – è questo il nome cinese – è stata precipitosamente segmentata da giardini e aiuole per impedire grandi manifestazioni di massa come quelle di Piazza Tiananmen di quindici anni fa. Ma l’eventualità di concentrazioni pericolose sembra oggi improbabile: ogni domenica pomeriggio convergono qui famiglie con bambini, fidanzati a passeggio, gruppi turistici che vengono dall’interno del Paese di Mezzo per imparare a ripetere ovunque il miracolo shanghaiese. Del resto, gli avvenimenti del 1989 sono sempre più lontani: il primo ministro Wen Jabao si è lasciato interrogare pubblicamente sulla repressione attuata allora dal governo cinese contro gli studenti che chiedevano democrazia ed egli ha risposto che quell’atteggiamento va ricondotto al clima di allora e agli sconvolgimenti internazionali che erano in corso nel 1989. Domanda e risposta sono per più versi significative: una domanda tanto esplicita e una risposta così soft sono segni inequivocabili che una revisione è in corso, anche se con tempi non prevedibili. • Commercio e affari Il cuore pulsante di Shanghai non è oggi in piazza Renmin, ma altrove, nei luoghi del commercio e degli affari. Milioni di persone scorrono come un grande fiume in movimento tra vie che ospitano migliaia di negozi a buon mercato o magazzini di gran lusso, insieme a borseggiatori e venditori di orologi falsi, altra novità rispetto alla “sicurezza socialista” garantita ovunque dal regime fino a pochi anni fa. È il caso della mitica Nanjing Road, arteria principale della città negli anni Trenta, e altro esempio di “recupero” senza complessi del passato coloniale di Shanghai. Nel giro di cinque anni è radicalmente cambiato anche il Giardino del mandarino Yu, che ospitava una volta antichità a buon mercato per i turisti alla ricerca di tracce della Cina tradizionale. Oggi i turisti ci sono ancora, anche se la qualità delle antichità in vendita è molto scaduta, ma sono diventati una minoranza: Yu Garden è oggi uno spazio affollatissimo, con file interminabili di cinesi che guardano, comprano, mangiano, si divertono. • La Old City Naturalmente, a Shanghai non si svolge solo una grande festa consumistica, ventiquattro ore su ventiquattro: appena dietro il Giardino del mandarino Yu, c’è la città vecchia. Qui, accanto ad enormi condomini appena costruiti, si snoda un intrico di viuzze su cui si affacciano ingressi, cortili, case o meglio abitazioni minime, con spazi limitatissimi e senza bagni, in un sovraffollamento che ricorda la Cina di una volta, coloniale o socialista: ma la Old City di Shanghai testimonia che quelle condizioni di vita sono prevalenti anche nella Cina di oggi. Nell’enorme cantiere di questa città, lavorano almeno tre milioni di edili, che vengono dalle 134 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 campagne e che spesso fanno la fame, non solo perché il lavoro finisce quando l’opera è pronta ma anche perché le grandi imprese di costruzioni non pagano mai nei modi e nei tempi pattuiti. Le famiglie degli ex operai, spinti in città dalla forza delle illusioni, sono costrette alla miseria e cercano di sopravvivere, tra furti e prostituzione, riproponendo in una forma nuova l’immagine di un’altra Shanghai, la città dannata, tanto famosa negli anni Trenta. • Comunisti senza comunisti La Cina di oggi è comunismo senza comunisti, ha detto il Presidente del Consiglio italiano durante la sua visita nell’ottobre 2003, sintetizzando così l’evidente dissociazione tra parole e fatti che caratterizza la Cina odierna. Ma si potrebbe anche dire il contrario: a dispetto, infatti, di tante bandiere rosse sui tetti delle abitazioni appena ultimate, c’è molto poco comunismo nella forbice tra ricchi e poveri che si allarga ogni giorno. Negli ultimi anni la Cina sta perdendo gran parte del “vantaggio” acquisito nei decenni passati nei confronti dell’altro gigante asiatico, l’India, sul terreno dell’istruzione o della sanità: la durata media della vita è ancora più alta nella Repubblica popolare cinese, ma la differenza si sta riducendo. Il Paese di Mezzo è attraversato perciò da convulsioni prima sconosciute, da manifestazioni di protesta per motivi economici e sociali che non hanno precedenti nella storia della Repubblica Popolare: le autorità guardano tutto ciò con preoccupazione e hanno assunto il riequilibrio dello sviluppo come un obiettivo prioritario. • La competitività cinese Shanghai è una piccola isola nel grande mare di un paese ancora in gran parte contadino ed arretrato. Eppure, la minoranza che si arricchisce e consuma, è oggi in Cina una minoranza cospicua in termini assoluti: corrisponde ad un paese ben più grande dell’Italia intera. A Shanghai si può vedere come ogni giorno la Cina stia vincendo la sua sfida al mondo: non cambiare niente perché tutto possa davvero cambiare, esattamente il contrario del gattopardismo italiano secondo cui tutto deve cambiare perché nulla cambi. Gli osservatori si accapigliano nelle interpretazioni del miracolo cinese: ha futuro oppure non lo ha, è destinato ad esplodere o si sgonfierà. Ma su un punto sono tutti d’accordo: la Cina sta davvero cambiando e lo fa molto in fretta. Ciò che cambia di meno o con grande ritardo è invece la nostra percezione di tale cambiamento e la capacità di adattarci. Ciclicamente, la tardiva “scoperta” della competitività cinese suscita in Italia una ventata di “protezionismo” (peraltro problematico da realizzare per un paese integrato nell’Unione Europea). Ma in un mondo sempre più globalizzato si può essere liberisti a giorni alterni? Esistono altri modi realistici di contrastare la concorrenza sleale al di fuori di un’estensione delle regole anche al mercato cinese, già Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 135 cominciato con l’ingresso della Cina nel WTO? Difficilmente, gli enormi interrogativi provocati da un mercato potenziale di 1.300.000 persone possano essere risolti da qualche misura artigianale adottata da un paese sempre più “periferico” nell’economia mondiale. Davanti alla Cina emerge quello che forse è il nodo più profondo del declino italiano, dovuto non tanto a fattori economici, a ritardi tecnologici o strozzature finanziarie, ma soprattutto all’inadeguatezza di un approccio sempre più provinciale. • L’interscambio Italia-Cina La crescita cinese pone all’Italia problemi che molte discussioni cercano di mascherare invece di affrontare. Piuttosto che cercare di sbarazzarsi di un concorrente ineliminabile converrebbe guardare alle opportunità offerte dal mercato cinese. L’interscambio Italia-Cina è oggi di notevole consistenza, ma riguarda soprattutto piccole e medie imprese italiane facilmente in difficoltà davanti ad una concorrenza imperniata su tecnologia limitata e bassi costi di manodopera. Viceversa il mercato cinese è aperto alla penetrazione di una grande industria di cui però l’Italia sembra oggi scarseggiare. Ma si tratta di problemi cinesi o italiani? Forse varrebbe la pena di affrontarli in concreto, anche per evitare che le visite in Italia di esponenti cinesi, come l’ultima di Wen Jabao risultino prive di risultati concreti analoghi a quelli che puntualmente sono seguiti alle cinque visite in Cina in cinque anni del Cancelliere tedesco Schroeder. • Il piano religioso Difficile appare anche comprendere i cambiamenti in atto sul piano religioso e trarne pienamente tutte le conseguenze. Si tratta, infatti, di cambiamenti meno evidenti e perciò più sfuggenti, ma profondi e probabilmente decisivi, che investono indirettamente anche la Chiesa cattolica. Silenziosamente, negli ultimi anni si è realizzato in quest’ultima un capovolgimento profondo: la maggior parte dei vescovi della cosiddetta Chiesa patriottica, eletti illegittimamente perché senza il mandato del papa, hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento di Roma, senza sostanziale opposizione delle autorità cinesi. Tutti i cattolici, clandestini e patriottici, benché spesso in conflitto tra loro, si sono dunque “compattati” intorno al papa, svuotando dall’interno il progetto scismatico perseguito a partire dal 1957 attraverso l’Associazione patriottica dei cattolici cinesi. Il governo di Pechino è perciò oggi consapevole che la soluzione della questione cattolica in Cina passa obbligatoriamente attraverso un accordo con Roma. Indubbiamente, questo accordo tarda a venire e tutto, almeno all’apparenza, sembra bloccato, anche se nessuno riesce bene a capire perché. A Pechino è ancora viva la memoria di tanti problemi, antichi e recenti, come la canonizzazione dei 136 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 martiri cinesi il 1 ottobre 2000, mentre a Roma preoccupa molto la questione delle nomine dei vescovi. Ma queste difficoltà non sono insormontabili. Forse, dall’una e dall’altra parte si fa ancora fatica a prendere coscienza del progressivo esaurimento delle conseguenze, sul piano religioso, della guerra fredda, che in Cina non è finita nel 1989. La spaccatura tra la (cosiddetta) Chiesa clandestina e la (cosiddetta) Chiesa patriottica ricalcava infatti la “cortina di bambù”, prolungamento della Cortina di ferro che divideva il mondo in due blocchi contrapposti e che ha attraversato anche l’interno dell’universo comunista cinese facendo apparire la presenza cattolica come totalmente inaccettabile. Oggi, in Cina, il Partito Comunista è ancora al potere e forse lo sarà ancora per molti anni, ma questo paese ha un bisogno sempre più forte di sviluppare le sue relazioni con l’esterno: anche una Chiesa che ha il suo centro a Roma può essere accettata, purché rientri, in qualche modo, negli interessi nazionali cinesi. • Giovanni Paolo II e la Cina Subito dopo la sua elezione, Giovanni Paolo II sorprese molti dissociandosi dall’espressione “Chiesa del silenzio” riferita alle situazioni dell’Europa orientale. È venuto forse il tempo che in Cina la Chiesa esca dalle catacombe, mentre la società cinese sta cambiando vorticosamente e si affacciano i problemi della secolarizzazione, come ha sottolineato recentemente un vescovo molto legato alla sede romana, il vescovo Li Duan di Xi’an. Nessuno più di Giovanni Paolo II è in grado di capire i problemi del passaggio dalla persecuzione comunista alla secolarizzazione consumista e avvertire l’urgenza che la Chiesa possa intraprendere presto una grande opera di evangelizzazione della Cina. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 137 Ricerche a cura di Andrea Bixio La situazione tedesca e la formazione di un’Università europea Sintesi di una ricerca di Robert Hettlage (Università di Ratisbona) In Europa si è avviato un processo certamente molto articolato diretto a costituire uno spazio di formazione e di alta formazione tendenzialmente omogeneo, analogo a quello relativo agli scambi economici e alla circolazione del lavoro. Raggiungere questo risultato non è certo facile; anzi costringe ad intraprendere un percorso pieno di ostacoli e di problemi di difficile soluzione. Questi problemi, le ipotesi di soluzione sono stati fatti oggetto, in Germania, di riflessione attenta da parte degli studiosi più avvertiti mediante un tavolo di confronto ed una ricerca di cui qui cercheremo di rendere sinteticamente conto. Poiché anche l’Italia in questo momento è impegnata a dibattere pressoché le stesse tematiche, penso sia di interesse comune esporre le questioni di maggior rilevanza, quali sono emerse in una esperienza come quella tedesca, che è sempre stata attenta agli sviluppi culturali che si venivano affermando al di là delle Alpi. I Sezione: il progetto europeo di uno “spazio economico fondato sul sapere” La commissione della Ue (e anche il consiglio dei ministri) ha sempre posposto il problema di una cultura europea. Opinione della commissione era che una simile dimensione culturale si sarebbe alla fine concretizzata quasi spontaneamente, grazie ai molteplici processi di integrazione. Sapeva certo anche che questo sistema parziale sarebbe stato il più difficile e il più delicato da integrare. A tutt’oggi è ampio il disaccordo sulla fattibilità, anzi sulla necessità, di una integrazione culturale, e su quali aree all’interno di questo siano le più accessibili. 138 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Finalmente, con il cosiddetto Processo di Bologna, ha cominciato a muoversi qualcosa nel campo dell’educazione e della formazione. A quanto pare si è scoperto che il settore dell’istruzione è quello in cui – almeno dal punto di vista formale – una europeizzazione è indispensabile. L’occasione concreta per l’avvio di questo progetto prende spunto da tre circostanze: 1. Il carattere di “scuola popolare” delle università di massa Almeno dal punto di vista tedesco l’università di massa è diventata sempre più oggetto di forti critiche. Inizialmente – verso la fine degli anni ’60 – fu grande l’euforia suscitata da una riforma democratica dell’istruzione che rompeva con i privilegi propri di alcuni strati sociali e che permetteva di attingere a nuove riserve per l’ampliamento della formazioni universitaria. Mentre prima solo il 4% dei nati in un determinato anno si iscriveva a un corso di studi universitario, oggi la percentuale è del 35%. Rispondendo alla necessità della moderna società industriale, le università sono state trasformate in “scuole popolari”. Oggi la politica mira ad innalzare questa percentuale al 40% (e più). Ma la formula, di per sé corretta, di una “istruzione come diritto civile” per il maggior numero possibile di destinatari, anche per gli strati inferiori della società, non è stata in seguito all’altezza delle aspettative. L’autoreclutamento delle classi medie attraverso le scuole superiori è stato arginato solo in piccolissima parte. Il sistema ginnasiale non è stato riformato a suo vantaggio. Nelle nuove università di massa ha cessato di esistere la “comunità dei docenti e degli studenti” di humboldtiana memoria. Dopo la riforma delle facoltà non è stato più trovato un modello realmente sostenibile per le discipline di massa. In termini di qualità la riforma dell’istruzione non è venuta a capo dei suoi compiti, provocando un livellamento verso il basso della qualità dell’insegnamento. Volendo tener conto delle componenti sociali, i voti non vengono più dati in base alla prestazione, ma in base ai valori statistici medi. Conseguenza di ciò è una “economia degli attestati di frequenza” su tutti i lati, che Pornschlegen ha riassunto nell’efficace formula di un “diritto democratico all’ignoranza e a buoni voti”. Poiché il concetto di uguaglianza è stato sempre più interpretato nel senso di “tutela dalla selezione e nello stesso tempo di tutela dalla responsabilità della selezione”, l’università ha perso la propria reputazione, quella tedesca la sua fama mondiale. Sono rimasti la demotivazione, il cinismo e un impegno modesto da una parte, ma anche – ancor sempre – un sovraccarico di impegno e un’alta costosa quota di abbandoni dall’altra (40% nella media dell’Unione Europea). In altri paesi la situazione non è sostanzialmente migliore – fatta eccezione per le università d’élite in Inghilterra (Oxford, Cambridge), Francia (Ecole Polytechnique, Ena), Italia (Scuola Normale di Pisa). Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 139 È venuta completamente a mancare una necessaria promozione di élite, non nel senso di una ingiustificata reputazione, ma nel senso di un gruppo necessariamente piccolo di persone capaci in termini di prestazioni e di decisioni, che abbiano superato con successo una dura selezione. Di promozione democratica di talenti si può parlare in termini solo molto limitati. Le università, cui non è stato concesso di disporre di un proprio filtro di selezione in aggiunta a quello previsto al termine della formazione scolastica (Maturità), si sono così trasformate in istituzioni prive di criteri di ingresso e di uscita. Il concetto di élite è stato cancellato dal vocabolario. Anche nel contesto europeo la politica tedesca ha sempre ostacolato la creazione di “super-università”. Tutto ciò comincia a costare caro. Ci stiamo muovendo in una nuova “catastrofe culturale” di diverso tipo. Al proposito vanno ricordati: un ottuso fiscalismo che cerca solo di ridurre l’università a un comparto qualsiasi della pubblica amministrazione. Per poter abbassare la quota di spettanza allo stato, le sue spese al consumo (in questo caso: per la formazione, la scienza e cultura) devono scendere. Chi, tuttavia, nell’ottica di far sostenere in egual misura da tutti i settori l’onere del risanamento delle finanze, sottrae capitali alla formazione di una società, pianifica con tali risparmi la nuova rovina. Senza investire nelle sue teste l’Europa “si risparmia” la sua capacità di futuro. Le università vengono ritagliate sul modello delle scienze naturali. Vengono richiesti formatori professionali dal profilo univocamente definito, cosa peraltro molto discutibile nell’odierno volatile panorama professionale. La corrispondenza punto per punto tra percorsi formativi e occupazioni è possibile solo per poche carriere altamente specializzate. Si parte dal pregiudizio di una efficienza e rilevanza d’impegno immediate, che può derivare da altre culture disciplinari ma che a guardar bene non caratterizza nemmeno loro. Non riescono a capire che “rilevante dal punto di vista professionale” non vuol dire “formare per una determinata professione”. Le migliori prospettive vengono trasmesse proprio attraverso “qualificazioni-chiave” dalle possibilità d’impiego ampie e variabili. Grazie a questa valutazione errata nel definire la rilevanza, intesa in senso molto ristretto, le università e gli istituti superiori universitari vengono rifunzionalizzati in termini di scuole professionali – senza presumibilmente migliorare nella sostanza le opportunità professionali. 2. La nuova riforma dell’università degli anni ’90: sulla via della scuola professionale Le università che mettono al sicuro i loro finanziamenti e la reputazione grazie alle discipline di massa e i grandi numeri non hanno un grande interesse a una riforma da cima a fondo, anche se esigono nello stesso tempo, doverosamente, un incremento della qualità. Le università si fanno la concorrenza per assicurarsi risorse limitate e devono garantirsi la propria nicchia con la creazione di una propria immagine. Ma secondo questa concezione guadagnano in immagine mettendosi al servizio della società, nel senso della rilevanza della prassi. 140 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 La riforma dell’università interpreta il requisito classico dell’autonomia nel senso che gli istituti universitari dovrebbero atteggiarsi come grandi imprese che devono rendere buoni i profitti. Ma questi si ottengono quando il prodotto, fabbricato dall’università, trova riscontro sul mercato delle prestazioni. La riforma deve innalzare la permeabilità tra università e società – ciò vuol dire l’economia. In tal modo hanno il sopravvento sulla qualità delle scienza e della formazione criteri decisionali del tutto estranei, quali la pubblicità per ottenere sovvenzioni da parte di terzi, il numero dei diplomandi, le relazioni di assistenza, le valutazioni scientometriche, ecc. Questa svolta manifestamente pragmatica viene per giunta venduta come progresso. Secondo la logica delle “percentuali di audience” le materie capaci di dar prestigio sono le materie di massa, in cui vengono creati prodotti conformi alle richieste dell’economia (ad es. informatica economico-aziendale) e le scienze naturali, nelle quali l’intreccio con la ricerca industriale è comunque, tradizionalmente, già molto alto. In questi settori la differenziazione disciplinare è rimasta comprensibile. Accanto a questi ci sono ancora delle materie di massa che producono, per così dire, senza rapporti col mercato (Pedagogia, Psicologia, Insegnamento, Lingua e Letteratura, ecc.) – nonché discipline “esotiche”, che ci si deve permettere per ragioni premoderne di conservazione del patrimonio culturale e per omaggio allo spirito dell’epoca (Filosofia, Filologia classica, gender studies). Ma queste – complessivamente considerate dal punto di vista del budget e dell’immagine – sono irrilevanti, non contano in termini di efficienza. Si salvano per il fatto che costano relativamente poco. A quanto pare il miglior istituto universitario è quello che “porta sul mercato del lavoro il maggior numero di diplomati nel tempo più breve con il minor numero di personale docente. Un simile atteggiamento in verità non ha niente a che fare con la natura della scienza e della sua più importante istituzione, l’università”. In generale le scienze dello spirito vengono spregiativamente classificate come “scienze della discussione” inutili e improduttive. Vengono però subito chiamate in aiuto quando si rende necessaria qualche consulenza politica. Attualmente a causa del terrorismo islamista proprio le scienze dell’Islam sono tornate in grande considerazione, mentre in precedenza le cattedre venivano soppresse senza esitazione. Negli ultimi dieci anni l’immagine delle università si è complessivamente modificata in modo radicale. Si uniforma sempre più nell’obiettivo formativo alla tipologia delle (importantissime) accademie tecniche e finisce a causa di queste sotto una particolare pressione competitiva. Per questo, a mo’ di mendacio per autodifesa, si continua a far circolare la tesi che “Humboldt è morto”. È stata livellata la vecchia distinzione tra cultura e formazione professionale, sapere e informazione, sapere funzionale e sapere orientativo. Mittelstraß al proposito ha preso la parola con veemenza. L’informazione non è una forma di sapere autonoma. Segue il sapere. Non è né identica al sapere né lo precede come peculiare forma di sapere. Per esser correttamente informati, cioè per poter correttamente scegliere, si deve aver già una testa intelligente. Altrimenti ci si lascia impastoiare da ciò che è immaturo, dalla menzogna, dalle bassezze o dalla banalità. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 141 Recentemente anche la Ue, con il suo progetto di uno “spazio economico basato sul sapere”, sembra esser d’accordo con questo punto di vista. La lettura di questa proposta rafforza il sospetto che anch’essa faccia proprio un “economismo epistemico”, secondo cui “il sapere arriva dalle reti dei computer come la luce dalla presa”. 3. La Ue e il “posto delle università nell’Europa del sapere” Nel 2000 a Lisbona il consiglio Europeo ha formulato l’intento di voler fare della Ue lo “spazio economico fondato sul sapere più dinamico del mondo”, uno spazio capace di realizzare una crescita economica durevole con più e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. A tal fine i sistemi d’istruzione europea dovrebbero diventare entro il 2010 un riferimento mondiale di qualità. Lo sfondo di queste considerazioni è chiaramente la crescente importanza del sapere nel complesso processo innovativo, la competitività della Ue e l’appianamento delle disparità regionali. La competizione totale per l’accaparramento dei migliori talenti sarebbe in pieno corso. L’Europa pertanto dovrebbe partecipare alla competizione con le migliori università del mondo. A tal fine si rende necessaria la creazione di uno spazio europeo per “l’apprendimento permanente”, la garanzia della qualità della formazione generale e professionale, il miglioramento della compatibilità dei sistemi di formazione professionale e universitaria (Processo di Bologna). Nel suo più recente documento (febbraio 2003) di presa di posizione sulla “società fondata sul sapere” la commissione Ue fa luce su questo sfondo nei termini seguenti: – Le università devono essere punti di sutura tra ricerca, formazione e innovazione, tali da accrescere la competitività della società della Ue. – A tal fine il sapere deve esser riorganizzato in senso interdisciplinare – trasversalmente rispetto alla crescente specializzazione. D’altra parte si attenuano i confini tra la ricerca di base e la ricerca applicata. – Oltre a ciò l’università deve tener conto della crescente richiesta di formazione tecnico-scientifica. – Infine le università vanno più fortemente vincolate nella cooperazione con l’ambiente delle città in cui si trovano. Allo scopo vanno sostenute le reti di eccellenza, i progetti integrati, i piani operativi per l’applicazione dei risultati della ricerca, la promozione della mobilità, le reti tra accademie tecniche che cooperano sui temi specifici, l’organizzazione di campus virtuali, il riconoscimento degli studi universitari, ecc. A uno sguardo superficiale c’è ben poco da obiettare. Tuttavia gli stessi redattori di questa “comunicazione” non si sentivano, a quanto pare, del tutto a loro agio nello stilare queste osservazioni su un’“Europa del sapere”. Essi stessi infatti temono da una parte una troppo forte concentrazione sulla ricerca applicata che potrebbe mettere a sua volta in pericolo la capacità dell’università di creare nuovo sapere. Dall’altra non si spende alcun pensiero sulla possibilità per le università di diventa- 142 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 re nello stesso tempo “luoghi di riflessione sul sapere stesso” e piattaforme della discussione civica. Non si può allora far a meno di constatare che anche la Ue fa proprio il modello di un sapere dimensionato sulla tecnica e l’economia, resta dunque prigioniera dei caratteri distintivi di una comunità economica. Non si dice nulla sul ruolo delle università come luoghi di formazione e riflessione di una società europea ovvero di una coscienza europea. II Sezione: la costruzione dell’Europa e la necessità di una “università europea” Nella forma della Ue l’Europa è un’impresa collettiva particolare, in certo senso un prodotto artificiale e una struttura unica nel suo genere per quanto riguarda i confini, la separazione dei poteri e i metodi di negoziato intergovernativo (comitologia). Ma appare soprattutto sempre più evidente che viene ignorata un’autocomprensione europea complessiva, al di là degli interessi economici – o che al massimo se ne parla in termini vaghi. Anzi, si avverte addirittura un profondo disagio nel formulare l’Europa in termini di specificità culturale. In altre parole: si preferisce, per quanto possibile, rinunciare a dare i contorni a una parte essenziale di una socialità europea. Ne segue che la Ue non riesce ad andare al di là di un’identità da spazio economico. 1. La coscienza europea Le società invero non si definiscono solo attraverso gli interessi economici, le regole di procedura amministrativa e le routines di negoziato politico. Devono costituire, ad esempio, contesti di orientamento e di memoria, che vengano trasmessi alla generazione successiva in forma di simboli, dunque di rappresentazione collettiva dei loro valori e delle loro norme (il cosiddetto mito europeo, ad esempio). Su questo punto una costituzione come quella europea deve prender posizione. Tutte le istituzioni – a cominciare dalla scuola, attraverso i mass-media, fino alla politica e al diritto – trasmettono necessariamente un intenso destino comune, che alimenta prospettive e progetti di vita nonché le azioni concrete dei singoli sotto forma di ideali, di impegni storici, di un habitus mentale ed emozionale. Da tutto ciò emerge innanzitutto una base – anche se inizialmente vaga – per un durevole sentirsi parte di una comunità, per l’identificazione e la solidarietà. Resa consapevole, questa base poi è il criterio di valutazione del passato e di riflessione sul futuro comune, e deve diventar patrimonio del discorso pubblico e far parte del lavoro educativo. Solo in tal modo può essere trovato un equilibrio europeo “Io-Noi- (-Essi-)”. Ogni identità in grado di reggere è un’identità “stratificata”. Essa viene resa stabile e ulteriormente sviluppata sulla base di procedure che creano consenso secondo convinzioni comuni (necessità operative, bisogni, tradizioni, ecc.) e del loro reciproco rinforzo. Questo è quel che ha voluto dire Habermas nella sua più recente iniziativa sull’opinione pubblica europea. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 143 L’Europa ha finora trascurato un tale dibattito sui principi culturali della propria autointerpretazione. I vaghi cenni sulla “molteplicità delle culture” non hanno avuto ulteriore sviluppo. Non da ultimo è proprio questa la ragione per cui son diventati tanto preponderanti gli aspetti indubbiamente importantissimi del mercato interno, delle considerazioni sulla crescita e il mercato del lavoro e della competizione globale. Non c’è nemmeno da stupirsi se le considerazioni della Commissione su un’Europa basata sul sapere si concentrano in termini del tutto formali e tecnocratici – come i programmi-quadro della Ue – sul collegamento in rete delle università e dei team di ricercatori. Non essendo stato condotto un dibattito di principio sull’idea di Europa, e poiché finora non si è formata una identità sociale complessiva che le sia propria, la Commissione è dovuta andare a prendersi altrove i criteri atti a stabilire le prestazioni dell’Europa basata sul sapere: concorrenza, professionalità, cooperazione con l’economia, preminenza dell’utilizzabilità. 2. I centri di eccellenza in quanto portatori di un’Europa basata sulla cultura Il discorso dei “centri di eccellenza” assume un significato completamente diverso. Esso deriva dalle modalità comunicative e operative delle scienze naturali. Ma la modalità delle scienze dello spirito è un’altra. Diversi sono gli interrogativi che si propongono e i temi che si trattano. Gli stili di apprendimento e di elaborazione sono differenti e il ruolo del sapere spesso è un altro (cfr. funzione di orientamento). A. Il ruolo delle scienze umane H.J. Meyer ha presentato a questo proposito una chiara tavola prospettica. Per lui le scienze umane e le scienze sociali sono necessariamente scienze dello spirito e viceversa. Queste ultime legano insieme tutti i settori del sapere e della conoscenza che spiegano e chiariscono all’uomo il suo rapporto con gli altri e la sua posizione nella società: – il senso della sua esistenza – la responsabilità verso se stessi – la responsabilità verso i propri simili e la società, concretamente per il proprio paese e l’umanità – il sapere del passato della propria terra nel contesto internazionale – la buona conoscenza della sua lingua e la cura nel suo uso – la buona conoscenza e il rapporto rispettoso con la sua cultura – il rivolgersi verso altre lingue e culture con l’intento di comprenderne ricchezza e profondità – la comprensione del contesto, fertile, ampio e addirittura globale, in cui solo possono vivere e prosperare la propria lingua, la propria cultura e la propria storia. Questo programma in otto punti sarebbe un buon inizio per una società europea effettivamente basata sul sapere e sull’identità, nella quale Humboldt non sarebbe affatto morto. 144 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 In un’epoca in cui si parla tanto di mancanza di senso storico, di orientamento etico e di coesione sociale, tali tematiche dovrebbero stare non solo al centro dell’interesse nazionale, ma anche di un interesse pubblico europeo. Ma a peggiorar le cose sta il fatto che l’Unione Europea non può ancora attingere a una base di orientamento simile, tale da coinvolgere l’insieme dei paesi membri. Un tale fondamento del sapere essa deve appena iniziare a svilupparlo. Deve ancora trovare il suo Humboldt (e ancora ritrovare i suoi Platone e Aristotele, i suoi Hume, Kant e Leibnitz, i suoi Cartesio e Montesquieu, i suoi Vico, Mosca e Pareto – solo per nominare alcuni, pochi, “fari” europei) per includerli in un comune lavoro di memoria europea. B. Lo scopo dell’“Università Europea”: la formazione di gruppi di sostenitori dell’Europa di cultura elevata L’Unione Europea non ha ancora sviluppato la sua memoria collettiva. Per questo non è nemmeno in grado di definire in termini di contenuto il ruolo delle sue università e dei “centri di eccellenza”. Ed è proprio compito degli intellettuali europei – discostandosi dalle mode legate allo spirito del tempo – proporre ad oggetto di dibattito tali questioni e a tenerle vive come potenziale di riflessione. Da questo punto di vista la loro posizione marginale è semmai un vantaggio. La riflessione istituzionalizzata dagli intellettuali operanti nella cultura, nell’amministrazione, e nella tecnica sui fondamenti e le mete dell’agire solidale e socialmente necessaria. Il “lavoro sul concetto” tuttavia – come appare dalla realtà delle università di massa – non è cosa da tutti. La società – anche quella europea – ha bisogno della formazione di personalità colte e “resistenti alle intemperie”, che non pensino alla giornata, capaci di gettare ponti, riuniscano competenze generali e specifiche e siano, senza mezzi termini “all’altezza dell’Europa”. La cultura infatti non è solo fattore di produzione ma anche mondo di dialogo e potenza creativa di coscienza. Il modello di università di Humboldt ha avuto tanta efficacia perché traduceva un’idea in una struttura adeguata e perché il suo sovrano comprese che esso era importante per la posizione della Prussia. In seguito si indebolì perché le istituzioni delle origini non erano più all’altezza delle nuove necessità sociali. Bisogna dunque riprendere a pensare sulla linea di Humboldt per la nuova società europea. Essa ha bisogno di un orientamento centrale non solo sul piano di ciò che è innanzitutto utile (conoscenze tecniche) ma anche per quanto concerne ciò che è necessario in senso lato (conoscenze di orientamento). È ora dunque di rielaborare il quadro strutturale delle vecchie università di massa dalle fondamenta, per poter fruttare in modo nuovo questo potenziale in Europa. I cambiamenti verificatisi nella situazione europea e internazionale non ammettono più rinvii. L’Europa non può rinunciare all’“eccellenza degli eccellenti”. “I grandi ostacoli sulla strada dell’autodeterminazione europea non derivano dalle crisi sociali e dalle piccole miserie della politica; risultano piuttosto dalla paralisi spirituale e morale che ha assalito questa parte della terra. I concetti con cui la Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 145 civiltà europea ha articolato la propria autocomprensione sono: renovatio, renaissance, riforma, rivoluzione. Con lo sguardo rivolto a questa grande tradizione il mondo attende un rinnovamento europeo”. III Sezione: linee guida sulla strada di una “università europea” Chi vuol percorrere questa strada suscita per lo più uno stupore incredulo e compassionevole, o per il coraggio che lo spinge ad affrontare tale fatica di Ercole proprio tra le attuali restrizioni, oppure perché si crede che i campo è già coltivato da tanti progetti culturali europei e si pensa che in tal modo si vogliano sfondare porte già aperte. La prima supposizione è giusta, la seconda sbagliata. 1. Le attuali iniziative europee delle università Uno sguardo alle iniziative di formazione europea permette di individuarne cinque tipi diversi: – Accademie del business o di élite che si fregiano del titolo di “europee” – reti europee (o globali) di ricercatori d’alto livello – istituti universitari europei (Firenze) e collegi europei (Bruges) – corsi universitari europei presso le università tradizionali – infine l’autentico tentativo di una università europea bilingue “Viadrina” a Frankfurt/Oder e Subotica Ma con il concetto di Europa si intendono cose diverse. Le scuole di affari soffrono del fatto che le scienze economiche prendono consapevolmente le distanze dall’“economia europea”. Il loro progetto-Europa consiste nel voler saper quali sono le conseguenze dell’applicazione di regole economiche universali sul campo europeo. Per il resto sono “solo” accademie di affari, che non pretendono d’essere un’università nel senso completo del termine. La stessa cosa vale per le reti di élite, che possiedono il vantaggio delle transnazionalità, ma agiscono spesso in modo troppo mirato su un tema specifico. Alcune interessano solo il segmento dei corsi di perfezionamento post-laurea. Gli istituti europei ampliano sicuramente il catalogo delle discipline ma per la ristrettezza delle risorse possono a loro volta impegnare solo prospettive sociali limitate, anche se di più ampio respiro. Le cose vanno in modo simile per i corsi universitari europei, nei quali si cerca attraverso la didattica per moduli di ampliare le prospettive sull’Europa. Spesso manca loro la massa critica. Viadrina si nomina università europea, ma sviluppa “solo” un modello, anche si di grande importanza, basato su due Stati. Un’università europea non deve inventar la ruota per una seconda volta ma trar profitto dalle esperienze dai tentativi citati ed adottarne le procedure consolidate (“best practices”). (Queste vanno innanzitutto analizzate in modo sistematico). Essa 146 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 prova a dare ulteriore sviluppo agli approcci che vengono giustamente posti in primo piano nel dibattito attuale: 1) Il pensiero dell’eccellenza e l’interdisciplinarietà È vero che l’Europa deve diventare una società basata sul sapere. Ma ciò può aver successo solo se il piano dei saperi non viene concepito in termini troppo ristretti, come è avvenuto nelle comunicazioni dell’Ue. Le attuali strutture scientifiche sono ad alta complessività. Il sapere deve andare al di là delle frammentazioni delle discipline, per crescere, per esser flessibile e mantenere la sua concorrenzialità (aperture creative, prospettive di outsider, arricchimento reciproco). Ma sappiamo anche quanto sia difficile organizzare una effettiva interdisciplinarietà. 2) Comparatistica: una nuova base per la ricerca è il sapere dell’Europa Cosa sappiamo delle altre società che sono i nostri vicini europei e con le quali forniamo presumibilmente una comunità europea? La lacuna di informazioni e di priorità nell’informazione è già per se stessa gigantesca, senza parlare della comprensione approfondita delle rispettive lingue. Prospettive scientifiche, storia, e interpretazioni. In assenza di una maggior vicinanza reciproca, cioè senza conoscenze e riflessione comparativa degli stili di vita e delle particolarità l’Europa come società non starà mai in piedi. Solo così i futuri temi e conflitti di comunità potranno essere affrontati con maggior competenza: – che si tratti di punti nodali circa i confini interni ed esterni, di inclusioni ed esclusioni, di problemi di partecipazione sociale, di disuguaglianze sociali e disparità regionali, – che si tratti di concezioni relative alla qualità della vita, di presupposti storici del rispettivo patrimonio culturale, delle rispettive immagini di sé, di rappresentazioni dall’interno e dall’esterno, di identità locali, regionali, nazionali e sovranazionali, di richiesta di tutela, di sensibilità etniche, nazionali, religiose, – che si tratti infine dei differenti tempi richiesti da determinati cambiamenti e delle loro conseguenze, dei processi relativi a trasformazioni tecniche ed economiche (ambiente, ecologia) e di tante altre cose. Su questi problemi, temi, motivi e richieste la costruzione dell’Europa può crescere o fallire. Tanto più che l’integrazione europea non è un progetto stabilito e solidamente legittimato con strutture inamovibili, ma un sistema sempre aperto a nuove strutturazioni e contrattazioni. 3) Traguardo da raggiungere in questa prospettiva: una nuova classe dirigente europeacosmopolitica Eccellenza, interdisciplinarietà e comparazione devono esser predisposti per la formazione di determinati gruppi di cittadini europei che ne sono i principali destinatari. Ne fanno parte gli “opinion leaders”, alti funzionari dell’amministrazione, Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 147 l’élite dell’economia, i moderatori di pubblici dibattiti, gli operatori dei media, gli specialisti delle commissioni, i ricercatori, gli insegnanti ecc.. Essi devono tendere le prime reti di coesione culturale su un’Europa che diventa sempre più grande. Da una parte si tratta della conoscenza di regole di comportamento europeo all’interno del quadro operativo della Ue (conoscenze giuridiche, culture del diritto, pratiche quotidiane, routines, canali). Dall’altra si tratta della conoscenza delle strutture sociali, dei grandi raggruppamenti sociali e strutture delle comunicazione (partecipanti, interessi, organizzazioni, lobbies, élites, ecc.). L’impegno di studio e conoscenza va infine indirizzato sulle condizioni di vita, l’opinione pubblica, gli stili di pensiero e sull’acquisizione del dovuto rispetto nell’operare con queste differenze. Solo in tal modo può solidamente affermarsi nel tempo una cultura del concordato, una solidarietà e del rispetto nei confronti delle minoranze, solo per questa via si può agire efficacemente contro la permanente tentazione dell’esclusione. Ogni società è una forma di interazione sociale. Anche una società europea si definisce inevitabilmente attraverso l’intreccio delle sue interazioni. Iniziamo sul terreno di un’autentica formazione europea col pensare ad una nuova socializzazione accademica all’europea e a farla partire dal punto di vista organizzativo! Abbiamo urgente bisogno della vostra collaborazione. Non abbiamo tempo da perdere. Altrimenti saranno altri che manderanno a segno i loro obiettivi e li dichiareranno de facto “destino europeo”. I protagonisti della società civile [a cura di Vincenzo Cesareo] [Rubbettino 2004] Una lettura della realtà italiana di Maria Cristina Marchetti La nozione di società civile costituisce attualmente il nodo centrale di un dibattito che investe in maniera trasversale esponenti del mondo scientifico e politici di professione, nel tentativo di individuare le linee guida di un mutamento culturale, le cui implicazioni non sono state ancora analizzate in tutta la loro portata. Da una parte, la crisi di una nozione tradizionale di politica, ruotante attorno al sistema dei partiti e dall’altra la fine dello stato sociale e del suo sistema di garanzie, hanno avviato un processo di ridefinizione degli attori tradizionali della società civile e del loro rapporto con le istituzioni e con il mercato. Quasi una sorta di laboratorio di sperimentazione di un modo nuovo di vivere la politica e l’impegno so- 148 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 ciale, la società civile diviene un serbatoio di risorse umane e progettuali, al quale attingere per ripensare le regole “nuove” del vivere associato. In questo filone di studi si inserisce il volume curato da Vincenzo Cesareo: I protagonisti della società civile, che raccoglie i dati di una ricerca condotta a livello nazionale, volta ricostruire l’attuale fisionomia della società civile italiana. • Società e istituzioni La ricerca, finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, ha impegnato in un progetto biennale nove atenei italiani (Calabria, Campobasso, Milano Cattolica, Palermo, Pisa, Roma “La Sapienza”, Teramo, Trento, Trieste). Si è trattato di un’indagine empirica condotta attraverso la realizzazione di 2.200 interviste con questionario ad esponenti del mondo dell’associazionismo su tutto il territorio nazionale. Le diverse tipologie di attori della società civile sono state raggruppate in sei macro categorie, così composte: 1) Movimenti sociali, comprendenti principalmente i movimenti ecologisti, quelli per i diritti civili, i movimenti giovanili e quelli della terza età; 2) Mediatori culturali, cui fanno capo le associazioni culturali e quelle religiose, gli operatori dei media (diversi da quelli istituzionalizzati), le radio locali; 3) Gruppi di consumatori e imprese, categoria composta principalmente dalle associazioni di imprese e dei consumatori, dal commercio equo e solidale, dalle fondazioni; 4) Reti comunitarie, comprendenti il mondo del volontariato e dell’associazionismo spontaneo; 5) Terzo settore, composto da Ong, Onlus e associazioni no profit operanti nei settori dei servizi sociali; 6) Corporazioni, cui fanno capo gli ordini professionali e i sindacati minori. La prima constatazione generale che è possibile fare è che l’accresciuta frammentazione interna che caratterizza la società italiana, unita ad una maggiore complessità dei fenomeni sociali contemporanei, si traduce in un dinamismo della società civile che si colloca ben oltre la tradizionale tripartizione che la oppone alla sfera delle istituzioni pubbliche e a quella del mercato. Come afferma Cesareo nell’Introduzione al volume, i risultati “consentono di sostenere che la società civile italiana non si pone in conflitto con le diverse sfere istituzionalizzate che costituiscono la nostra vita sociale, anche se essa entra in tensione con ognuna di queste. Proprio questa tensione è ciò che è distintivo della società civile, dato che essa genera e promuove un rinnovamento delle istituzioni stesse, istituzioni che si desidera diventino sempre meno ritualizzate e sempre più capaci di assorbire e di adeguarsi ai cambiamenti in atto nella nostra società”. Si vengono infatti a delineare degli spazi interstiziali di frizione tra la società civile e le sfere istituzionalizzate, che lasciano intravedere un margine di autoregolamentazione rispetto alla sfera delle istituzioni pubbliche che, nelle ipotesi più avanzate, finisce per fornire spunti interessanti al dibattito sul futuro della democrazia (Hirst 1999). Sempre più infatti si evidenzia l’esigenza di individuare nuove forme di partecipazione politica che concorrano alla ridefinizione della nozione di spazio pubblico, come luogo di confronto delle diverse posizioni nei confronti della cosa pubblica. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 149 • La mediazione stato-mercato-società La stessa tradizionale contrapposizione stato-mercato-società civile, viene pertanto ad essere superata mediante la ricerca di una “mediazione”, riconducibile al fatto che gli stessi attori della società civile sono consapevoli di doversi confrontare con queste diverse sfere dell’agire collettivo per il raggiungimento dei propri obiettivi. Allo stesso tempo però, si evidenzia l’esistenza di una tensione strutturale tra la disponibilità ad avere rapporti con l’esterno e i valori che orientano il proprio agire. In nessun caso infatti, la non estraneità della società civile alle dinamiche proprie della sfera istituzionale e del mercato può essere interpretata come un’adesione ai valori che esse esprimono. Alla domanda “quali sono i valori ai quali si ispira attualmente il suo gruppo”, “solidarietà” e “partecipazione” si collocano infatti ai primi posti tra le risposte fornite, seguiti a notevole distanza dal “dialogo” e dall’altruismo; quasi il 50 % degli intervistati ha indicato come finalità del proprio gruppo quella di “farsi carico dei problemi concreti delle persone ricostruendo così la solidarietà”. La spinta solidaristica rimane pertanto il principale motore della società civile, lasciando emergere una sostanziale diversità rispetto all’esperienza del mondo anglosassone: “la tradizione associativa italiana pro-sociale risulta, in termini di atteggiamento condiviso dai partecipanti, più vicina allo Stato – come d’altronde nella cultura continentale europea – che al Mercato, come avviene invece nella tradizione anglosassone”. I valori universalmente riconosciuti come caratteristici del mercato – “successo” e “soddisfazione personale” – si collocano agli ultimi posti nelle risposte date. Da questo punto di vista, se la nascita della società civile affonda le sue radici nell’affermazione del mercato (Giner 1998; Pellicani 1994), questo è attualmente qualcosa di diverso dal luogo ideale, teorizzato dall’economia classica, all’interno del quale si incontrano la domanda e l’offerta, in vista della definizione dei prezzi: esso è la rappresentazione di un modello di società che ha fatto dell’utilitarismo una prassi dell’agire. Come aveva già sottolineato la sociologia classica, il mercato diviene la manifestazione estrema di quel processo di oggettivazione dei rapporti sociali, avviato dalla modernità: estendendo la sua azione molto al di là della sfera economica, esso segna il progressivo restringimento del margine di libertà interiore dell’agire. • La tendenza sostitutiva delle Istituzioni Pertanto, le prime dinamiche conflittuali si evidenziano nel momento in cui gli attori della società civile entrano a diretto contatto con la dimensione economica dell’agire per quella che a tutti gli effetti può essere definita come un’attività di fund raising. Ben lontani dalle analisi che fanno propria l’identificazione, fin troppo data per scontata anche all’interno delle scienze sociali, tra “terzo settore”, “no profit”, “volontariato” e “società civile”, i protagonisti di quest’ultima, manifestano un’insolita capacità di muoversi nei meandri dei finanziamenti pubblici e privati e 150 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 di agire in sostituzione delle istituzioni. Circa il 30% degli intervistati ha dichiarato infatti di aver bisogno di oltre 100 milioni di lire all’anno per lo svolgimento delle proprie attività, se questo dato si somma al 9,5% relativo a coloro che hanno dichiarato di aver bisogno di una cifra compresa tra i 51 e 100 milioni, si supera il 40% dei soggetti che hanno bisogno di un budget annuo che parte dai 51 milioni fino a superare i 100. Per quanto riguarda la fonte di tali finanziamenti, se le “quote sociali” continuano a rappresentare la principale entrata per i soggetti della società civile, è ben più interessante che oltre il 35% riceva contributi dagli enti pubblici e quasi il 30% abbia convenzioni con enti pubblici locali. Diverso è il discorso per quanto riguarda la costituzione di reti transnazionali: davanti agli scenari individuati dalla globalizzazione, gli attori della società civile italiana presentano ancora un netto radicamento locale, malgrado non manchino realtà che si muovono a livello globale. Il bisogno di partecipazione e la spinta solidale che anima le loro attività, li porta in alcuni casi a percepire come distanti eventuali risultati conseguiti in una dimensione globale. A ciò si aggiunge il fatto che la globalizzazione è essenzialmente percepita come la causa di nuovi squilibri economici e sociali da circa il 40% degli intervistati. • Società civile e globalizzazione Il rapporto tra società civile e processo di globalizzazione da l’avvio ad una riflessione, le cui implicazioni non sono state ancora sufficientemente indagate, circa la possibile affermazione di una società civile globale. Tale aspetto assume una notevole rilevanza nel momento in cui una serie di questioni di ordine politico-sociale non possono più essere affrontate a partire dalla considerazione unilaterale dei singoli stati nazionali. Il dibattito guerra/pace, i rapporti con i paesi in via di sviluppo, ma anche la costituzione di reti di solidarietà internazionali, chiamano in causa una diversa nozione di società civile che ridefinisca i suoi obiettivi primari a partire dalla costituzione di una cultura dei diritti. Ed è proprio al livello dei rapporti con la sfera politica che emerge un dato interessante riconducibile al fatto che, indipendentemente dall’attività svolta, i soggetti intervistati manifestano una tendenza spiccata a percepire la loro attività come “politica”, anche se non nel senso tradizionale del termine. Circa il 40% degli intervistati percepisce il proprio gruppo come soggetto di “azione politica”, in quanto soggetto di costruzione del bene comune. Ciò che il gruppo tutela, sviluppa, costruisce, progetta, è la maniera, per costoro, attraverso cui si esprime il proprio contributo alla politica. In quest’ambito, la solidarietà, in quanto capacità di dare risposte ai bisogni immediati delle persone, diviene un canale attraverso il quale si realizza la partecipazione politica. Le stesse modalità di partecipazione presentano un’interessante contraddizione, dovuta al fatto che oltre il 40% degli intervistati “sembrano concepire la propria azione come assolutamente non relazionabile al mondo della politica”. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 151 • Una nozione “nuova” di politica Ne deriva una nozione “nuova” di politica che, al di là di formule fin troppo abusate – “politica che riparte dal basso”, “recupero della base” – fa dell’agire politico un impegno che coinvolge il cittadino in prima persona, rendendo la partecipazione il nucleo centrale della moderna nozione di cittadinanza (Donati 1993). Da questo punto di vista, non si tratta più di trovare in seno alla società civile una nuova linfa per rivitalizzare la politica tradizionale, sia sul piano delle risorse umane che dei contenuti, quanto di ridefinire i termini dell’appartenenza degli individui alla collettività e della loro partecipazione alla gestione della cosa pubblica. Il rischio implicito in tale impostazione è quello di confondere la politica con l’attività di gestione: ciò che interessa non è mischiare la propria attività con le finalità della politica, quanto trarre da quest’ultima tutti gli strumenti possibili, essenzialmente in termini economici, per il raggiungimento dei propri obiettivi. L’interesse pertanto, non va al politico di professione, ma all’amministratore. • La comunicazione Uno dei cambiamenti di prospettiva più interessanti tra quelli evidenziati dalla ricerca riguarda il rapporto che intercorre tra gli attori della società civile e la comunicazione. Quella che comunemente viene percepita come una reciproca estraneità, si concretizza invece in un interesse diffuso per la dimensione comunicativa dell’agire: oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato infatti di porre in essere azioni finalizzate a far conoscere all’esterno le proprie attività, con modalità che vanno dal contatto personale ai mezzi di comunicazione di massa. Se da questa ampia dichiarazione d’intenti si passa alla considerazione di ciò che gli attori intendono con il termine “comunicazione”, si evince che essa si identifica essenzialmente con il dialogo e la copresenza fisica, secondo le modalità proprie della comunicazione face-to-face. Di conseguenza i mezzi di comunicazione, sebbene utilizzati, sono percepiti come una realtà esterna, non particolarmente attenta alla società civile: circa il 40% degli intervistati lamenta un deficit di visibilità e circa il 10% veri e propri casi di censura, più o meno volontariamente perpetrata ai loro danni. • Il “Sud” e le dinamiche nazionali Le dinamiche nazionali presentano alcune conferme e qualche interessante elemento di novità rappresentato dal Sud della penisola. Malgrado sul piano economico le associazioni meridionali siano quelle con minori fondi a disposizione, emerge una generale tendenza al recupero del margine di azione della società civile, a fronte di una radicata debolezza delle istituzioni in queste aree. Da una condizione che fino a qualche decennio fa è stata sinonimo di corruzione e di arretratezza, 152 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 scaturiscono invece elementi di un rinnovato dinamismo della società civile che avverte in maniera forte la responsabilità di farsi artefice di un cambiamento. Nell’insieme, la varietà dei soggetti coinvolti permette di restituire il quadro di una serie di dinamiche in atto nella società civile italiana che a loro volta, permettono di prendere le distanze dall’idea, accreditata da un filone della letteratura sul tema, volta a evidenziarne l’intrinseca debolezza, a fronte della tradizionale tenuta della rete relazionale familiare (Putnam 1993). Senza dubbio, rispetto ad altre realtà europee o all’esperienza del mondo anglosassone, la società civile italiana presenta un minor livello di strutturazione e formalizzazione dei soggetti collettivi che la compongono: lo spontaneismo a base solidale continua ad essere la sua caratteristica fondamentale. Semmai la novità è rappresentata da un certo disincantato pragmatismo che permea l’attività della società civile: nel momento stesso in cui, non senza una vena polemica, riconoscono che il mercato è il vero motore della società, non esitano a sfruttarne i meccanismi per il raggiungimento dei loro obiettivi; se per loro la comunicazione è essenzialmente “dialogo”, non mancano di ricercare quella visibilità che solo l’accesso ai mezzi di comunicazione di massa può garantire alle loro iniziative. Se il dinamismo che li caratterizza possa costituire un serbatoio di risorse umane per un rinnovamento della politica resta un incognita tutta da verificare: gli attori della società civile infatti non vogliono entrare in politica, ma vogliono essere “la” politica, facendosi portavoce di un’esigenza latente di rifondazione della politica che stenta ad individuare i suoi canali di manifestazione. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 153 Fuori scaffale a cura di Aldo Laganà L’Europa non è l’America L’Occidente di fronte al terrorismo di Massimo Teodori [Mondadori 2004] Nei due precedenti libri Maledetti Americani e Benedetti Americani l’autore si era impegnato in una approfondita analisi del diffuso fenomeno dell’antiamericanismo, ricercandone le origini, le specializzazioni e le finalità; il successo editoriale dei due libri aveva aperto un dibattito, in pubblico e in privato, mai scemato, che ora calza a pennello come introduzione al terzo libro per costituire un insieme coerente che si può ben definire trilogia. Teodori prende atto, con profondo rammarico, dell’attuale stato dei rapporti tra l’Europa e l’America caratterizzante una specie di divorzio, una separazione non consensuale, un divario con gravi rischi per il futuro della pace del mondo di fronte all’incalzare del terrorismo del fondamentalismo islamico al quale sono entrambe esposte in prima linea, ma che non risparmia gli altri tre Continenti. • Il Terzo Libro Nel terzo libro L’Europa non è l’America l’autore ci offre un ampio quadro delle diversità tra le due entità, ritrovandone i germogli nella cultura, nella storia, nelle tradizioni, nelle pratiche istituzionali per capire e far capire dove sia nato e come si sia sviluppato nuovo corso di reciproche incomprensioni sfumanti in veri e espliciti atti di avversità. E lo fa da par suo, perché Teodori, prolifico, europeista e filoamericano, si ciba tutti giorni del pane della cultura politica e a sua volta ne informa e distribuisce a iosa dalla cattedra universitaria dove insegna e sulla stampa di cui è assiduo collaboratore. 154 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Reginald Bartholomew, già ambasciatore degli Usa a Roma e sincero amico dell’Italia, con un aggettivo onnicomprensivo, ha giudicato il libro coraggioso, perché è un libro che non vuole piacere a tutti, ma a tutti mostra uno spiraglio di luce perché vedano meglio e meglio capiscano i fatti di oggi e le inquiete prospettive del prossimo futuro. Citando Madeleine Albright, braccio destro dell’ex Presidente Clinton, Bartholomew, in occasione della presentazione del libro di Teodori, ha detto epigraficamente “multilaterali quando possiamo, unilaterali quando dobbiamo”. Una teoria secondo cui sarebbe saggio ricordare che nel 1938 prevalse a Monaco l’appeasement che è la forma imbelle della pace, ma poi, per combattere e sconfiggere il nazismo, l’Europa fu costretta a ricorrere a Roosevelt. Ugualmente il terrorismo che oggi abbiamo di fonte e che è richiamato nel sottotitolo del libro che sarebbe una sorta di nuovo totalitarismo che si è insinuato tra di noi a macchia di leopardo, difficile da isolare e combattere. • Il legame Europa-America Nel breve capitolo introduttivo al suo libro del quale qui di seguito cercheremo di enucleare l’essenza, Teodori ha voluto ricordare all’Europa che il posto in prima fila sulla scena mondiale non si ottiene gratuitamente restando alla finestra; l’incombente e già attiva minaccia sul mondo richiede che Europa ed America tornino in piena sintonia perché l’America isolata difficilmente potrebbe conservare il suo ruolo di superpotenza democratica con il consenso delle popolazioni, mentre l’Europa finirebbe per estraniarsi dal mondo ripiegando sugli sterili nazionalismi che la dividono al suo interno. Fino al Novecento gli Americani erano territorialmente isolazionisti mentre gli Europei erano colonialisti; l’America un nano politico e un gigante economico, l’Europa era terra di giganti politici (Inghilterra, Francia, Germania, Russia) che manovravano il gioco internazionale mentre già si profilava il loro declino economico. Oggi l’Europa è politicamente debole e assente e lo ha dimostrato con la sua incapacità di risolvere i conflitti balcanici cosicché la Nato a guida americana è dovuta intervenire massicciamente. Dunque diversità, diffuse e radicate. • Le diversità La diversità americana emerge in una serie di considerazioni storiche che riguardano la sua nascita come nazione per realizzare, una volta liberatasi della Corona inglese, valori ed interessi condivisi; la sua Costituzione che ha l’elemento centrale nell’attribuire una comune identità a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro origini; la sua leadership con un forte esecutivo in grado di affrontare gli Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 155 eventi internazionali; la democrazia interna a tutti i livelli del potere; l’omogeneità dell’homo americanus nonostante le disparità etniche, religiose, linguistiche e culturali; il riconoscimento di una missione nazionale come mito di riferimento. La diversità europea invece emerge dall’avere una Unione che è ancora solo monetaria ed è priva di un’anima profonda, dalla mancanza di un quadro istituzionale per i cittadini che restano legati alle loro Costituzioni, dalla mancanza di un forte governo centrale in grado di esprimere un influente riferimento all’esterno, dalla struttura tecnocratica che non ha una regolamentazione democratica, dalla permanente conflittualità con gli extracomunitari. Il Parlamento Europeo nella sua venticinquennale esperienza non ha acquisito la fisionomia di un organismo democraticamente vivo nel cuore dell’Unione, la sua leadership debole non riesce a concepire un efficace esecutivo in grado di rendere l’Unione protagonista mondiale come potrebbe ambire di essere per dimensioni e capacità economica e culturale. Esiste una opinione diffusa tra storici e politici nel ritenere che la forma presidenziale dell’America è stata uno dei principali ingredienti del successo del paese; il fatto che l’uomo della Casa Bianca rappresenti gli Usa nel mondo gli attribuisce autorità e rispetto in politica estera consentendogli di affrontare crisi militari secondo le aspettative dell’opinione pubblica. • L’Europa saprà darsi una leadership? Teodori, pur nel suo conclamato ed antico europeismo, appare scettico sulla capacità dell’Unione Europea di darsi una leadership con forte proiezione politica verso l’esterno; il progetto costituzionale europeo studiato dalla commissione di Giscard d’Estaing non sembra rassicurarlo abbastanza e dubita che l’Europa su quella strada possa giocare un ruolo internazionale di primo piano. Il successo dell’esperimento americano sta nello spirito democratico che ha improntato le sue origini, mentre in Europa, fatta salva l’Inghilterra, le tracce democratiche sono ben più labili. Il senso di appartenenza dell’homo americanus alla Patria comune è forte negli Usa e manca del tutto al cittadino europeo; l’indiscusso principio della maggioranza numerica e l’alternanza al potere, sono gli altri ingredienti basilari della democrazia sui quali si fonda il senso di appartenenza convinta. Ci vorranno decenni perché oltre ai ceti colti europei, che hanno accettato razionalmente la nuova cittadinanza, siano le popolazioni ad accettarla superando l’ancora forte identificazione con gli Stati-nazione. Osserva Teodori che la carta vincente dell’America continua ad essere l’accoglienza verso chiunque bussi alla sua porta e dimostri di voler diventare cittadino americano in una società laica senza pregiudizi ma al tempo stessa intrisa profondamente dei valori religiosi invocati dai Padri fondatori. 156 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 • Le divisioni dell’Europa Il popolo europeo si è sentito parte di una comune identità solo durante la Guerra Fredda di fronte al pericolo comunista, quando era tenuto insieme dalla rassicurante presenza statunitense. Ma ora l’antisemitismo mascherato da antisionismo sarrebbe ritornato a mostrare i denti e a dividere l’Europa, ha voluto accusare Ehud Gol, ambasciatore d’Israele in Italia, assai deluso dal nuovo corso europeo che egli accusa di aver dimenticato l’Olocausto, di non vedere e di non capire la gravità del terrorismo che insanguina il Medio Oriente. Scrive Teodori che nella presente realtà segnata dalla sfida terroristica che si è manifestata in varie parti del mondo, il maggior vuoto è costituito dal pacifismo che è riuscito a creare negli Europei una ipnosi tanto felice quanto ingannevole. Secondo questa logica dietro lo slogan pacifista si cela il nulla e quindi ecco l’impotenza che caratterizza anche l’atteggiamento dell’Onu rivelatosi strumento sempre più obsoleto, bisognoso anch’esso di una efficace riforma democratica. Lo sviluppo della vicenda irachena, comunque, è tale da lasciare fortemente in sospeso il giudizio finale. Gli stessi Americani negli ultimi tempi, sono tornati a rivolgersi al Palazzo di Vetro per ottenere una legittimazione alla loro permanenza la cui necessità avevano prima, apertamente negato. Alla conclusione della crisi, forse, i vincitori potrebbero essere proprio l’Onu e la vecchia, lenta, poco decisionista Europa. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 157 Il romanzo del «Popolo» Storia di un giornale pericoloso di Giuseppe Sangiorgi e Carlo Danè [Gangemi Editore] Il romanzo del «Popolo» di Carlo Danè e Giuseppe Sangiorgi (Gangemi Editore, Roma 2002) è la storia di un giornale – un giornale pericoloso come recita il sottotitolo del volume, riprendendo una espressione di Mussolini – fissata nei suoi primi tre anni di vita, fino alla chiusura disposta dal regime, e ripresa nel biennio della clandestinità 1943-44. Si tratta di un lavoro che è stato reso possibile grazie in particolare a tre fonti di notizie: le carte dell’istituto Luigi Sturzo; i ricordi delle due figlie viventi di Giuseppe Donati, Suor Severa e Maria Grazia; la storia della famiglia Sangiorgi la cui casa ospitava la redazione de «Il Popolo» clandestino. La prima parte del volume ruota attorno alla figura del padre nobile del cattolicesimo politico italiano del ’900, Luigi Sturzo, ed alla figura di Giuseppe Dossetti, da Sturzo chiamato all’impresa di dare vita e dirigere il quotidiano «Il Popolo». Di Donati, in particolare, il libro restituisce un ritratto nitido, pennellandone – attraverso le vicende della fondazione del giornale, del suo radicamento e della sua definitiva costrizione al silenzio, che si intercalano con la storia del paese e con il suo disperante precipitare verso la dittatura – i tratti della personalità, il coraggio civile, il rigore morale, la tempra straordinaria del combattente indisponibile al compromesso quando esso significa cedimento sui principi fondanti della democrazia e del vivere civile. Sono anni in cui, come ricordano gli autori, “il giornale fu l’anima del partito, ne rappresentò l’impressione più visibile, la proiezione esterna più conosciuta, ma non ne fu mai l’organo ufficiale, né una simile qualifica comparve mai sotto la testata”. Questo rapporto dialettico tra il partito ed il suo quotidiano risalta particolarmente in virtù della forza di chi concepisce, costruisce ed incarna il giornale. “Quel binomio Sturzo-Donati – ricorda Gabriele De Rosa nella prefazione – era troppo scoperto: il vigore morale e civile della loro prosa li individuavo subito. Dov’era il partito? In questa prosa, che entusiasmava Gobetti, Pier Giorgio Frassati, Ferrari, Salvemini? O nel partito ufficiale, che credeva nella possibilità di una sopravvivenza, sia pure con qualche cedimento alle richieste di Mussolini a proposito della votazione sulla legge Acerbo?”. La seconda parte del libro testimonia invece le speranze e le paure di ogni periodo di transizione, raccontate attraverso le vicende della coraggiosa rinascita del giornale nei mesi della clandestinità. Siamo nel biennio 19443-44: alle prime disfatte del nazifascismo sui fronti d’Europa fa da corollario il declino della dittatura in Italia, la caduta del regime nei luglio del 1943, i mesi terribili, ed esaltanti insie- 158 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 me, dell’occupazione nazista, dell’avanzata del fronte Sud, dell’inizio della Resistenza. Su questo sfondo drammatico risaltano le vicende di un gruppo di coraggiosi, appartenenti alla vecchia guardia del Partito Popolare come De Gasperi e Spataro o alla generazione successiva come Gonella e Scelba, che vogliono a tutti i costi riprendersi il diritto di parola. Lo faranno attraverso «Il Popolo» clandestino le cui vicende si intrecciano con questo scorcio di storia disgraziata del Paese, le attraversano, le riflettono. L’epoca è un’altra, tuttavia, e il rapporto giornale-partito è esattamente rovesciato rispetto a venti anni prima. «Il Popolo», sorprendentemente non riprende le pubblicazioni nel periodo che va tra il 25 luglio e l’8 settembre del ’43. Nell’intervista che Paolo Mieli rilascia in apertura di volume, questa circostanza emerge con chiarezza ed è spiegata con grande lucidità. “In un momento delicatissimo e complicato della storia del Paese – osserva Mieli – Alcide De Gasperi ha questa consapevolezza: sa che il giornale dei Popolari è stato più importante del Partito. E dunque decide di rieditarlo soltanto quando le cose all’interno del partito che si sta rifondando sono ben chiare. De Gasperi non intende conferire al giornale autonomia nel prendere posizioni diverse da quelle del partito. È una scelta di prudenza – secondo me condivisibile – che va studiata come tale. Il fatto che «Il Popolo» tra il 25 luglio e l’8 settembre non uscì, è probabilmente il modo per riformulare un patto fondamentale: sia chiaro che questa volta viene prima il partito e poi il giornale. Rispetto al ’23 registriamo questa novità significativa: il giornale sarà ugualmente importante, ma il partito viene prima ed il giornale risponde direttamente alla segreteria del partito. Non è una cosa che riguarda solo «Il Popolo»: sarà così anche per gli altri giornali di partito”. La novità che Paolo Mieli registra nel rapporto tra il partito e il giornale non tocca, tuttavia, il tratto distintivo e l’originalità del libro di Danè e Sangiorgi che consiste nell’aver rovesciato l’ottica con la quale siamo abituati a leggere quel pezzo di storia del nostro Paese. Come raccontano nella prefazione al volume gli stessi autori “non più le vicende di grandi personaggi, o di periodi cruciali del Paese, e attraverso essi un richiamo al giornale. Al centro del racconto è stavolta la vita de «Il Popolo» e, attraverso essa, i personaggi e i periodi che si muovono sullo sfondo”. La storia del Paese letta attraverso la storia del giornale che diventa esso stesso un pezzo di storia del Paese perché quella storia esso rappresenta, riflette e commenta, in modo originale e fecondo. Per dirla con gli autori, si tratta di “una ricerca che riempie un vuoto”. Quello di un giornale che non c’è più, ma i cui ottanta anni di storia meritavano di essere ricordati e meritano di essere letti. Fernando Bruno Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 159 Statistiche a cura di Corrado Barberis La Rubrica, affidata a Corrado Barberis, sociologo e giornalista, si propone di offrire valutazioni e pensieri sugli “effetti” anche psicologici delle attività economiche, produttive, di mercato così come in effetti risultano, se depurate dalla freddezza delle statistiche e dagli incantamenti che le abbelliscono. Le riflessioni di questo numero sono dedicate al settore economico-produttivo della nostra agricoltura: Cresce o cala? In definitiva resiste? Cresce o cala? In un’economia dove l’agricoltura contribuisce per non più del tre per cento alla formazione del prodotto interno lordo (Pil), spaccare il capello in quattro per conoscere l’effettivo andamento del settore primario può sembrare una pretesa eccessiva. Pure quando è la stessa fonte – nella fattispecie l’Istat – a fornire l’immagine di due tendenze divergenti, qualche interrogativo merita di essere sottolineato. • Dentro le statistiche Prendiamo l’Istat che chiameremo numero uno. Esso è costituito dal censimento agricolo 2000 che, rispetto al censimento di dieci anni prima, segnala un calo di 427.000 aziende e un minore utilizzo di superfici agricole per 1.833.000 ettari. Nessuno si straccerà le vesti, beninteso, per la scomparsa di qualche minifondo, ma gli ettari abbandonati non furono sempre costituiti tutti da prati permanenti e pascoli di basso reddito. Si deve infatti prendere atto che la recessione ha investito colture pregiate o comunque importanti e cioè: – 420.700 ettari per i cereali – 300.600 per le foraggere – 215.600 per la vite – 97.600 per gli alberi da frutto – 64.100 per le colture industriali – 49.700 per gli agrumi – 44.600 per le ortive – 33.600 per le barbabietole – 23.500 per le patate. 160 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Per gli allevamenti la falcidia è di: – 870.700 vacche da latte – 659.900 bovini da carne – 1.939.300 ovini – 395.600 caprini - 4.008.500 conigli - 1.998.200 polli, specie da carne. A fronte di ciò le uniche note positive sono rappresentate: – dai legumi secchi, cresciuti di 7.500 ettari circa – dall’olivo (+ 47.279 ettari) – dai vivai (+ 5.774 ettari) – dai suini, cresciuti di 207.500 capi. Piluccando all’interno constata anche del volume si che crisi risparmiato e i fiori (– 1.000 e più ettari) o i castagneti (– 31.700 ettari). • Oltre le statistiche Né l’avanzata delle lenticchie, né quella, davvero significativa, dei vivai compensano i crolli di altri comparti. E gli stessi successi dell’olivo sembrano da ridimensionare considerando che hanno avuto per protagonisti i minifondi. Infatti nelle aziende al di sotto dell’ettaro la superficie olivata è cresciuta di 52.700 ettari, coprendo largamente l’incremento registrato dal comparto nell’intero decennio. Per contro nelle aziende di oltre cento ettari, teoricamente meglio in grado di affrontare i problemi della commercializzazione, la perdita della superficie si ragguaglia in 13.500 ettari. È quindi evidente che i progressi dell’ulivo sono dovuti a pensionati che, nel ricevere la liquidazione, hanno ritenuto opportuno investirla nell’acquisto di un pezzetto di terra olivato. Si è quindi registrato un aumento non dell’imprenditorialità ma dell’autoconsumo e di quelle vendite porta a porta che sarebbe del resto sciocco disprezzare. La piccola Caporetto, particolarmente grave nel comparto dell’ortofrutta, non ha allarmato più di tanto gli addetti ai lavori. Confortati, forse, da altre serie Istat che mostrano, nonostante tutto, un costante incremento della produzione. In peso, beninteso, e non in lire soggette all’andamento dei prezzi. Infatti, secondo i nostri uffici di contabilità nazionale, che chiameremo l’Istat numero due, in contrapposizione all’Istat censimento numero uno, l’evoluzione della produzione è così configurabile. (Tab. 1). • Le colture industriali Solo nelle colture industriali si trova una consistente traccia della piccola Caporetto. Nel vino è dovuta ai nuovi criteri di calcolo introdotti su suggerimento dell’Eurostat. In base ad essi non si tiene più conto dell’uva ceduta alle industrie e alle stesse cooperative di produttori. Viene così conteggiata solo quella direttamen- Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 161 Tab. 1 - Migliaia di quintali (o di ettolitri per vino e latte) prodotti tra 1990 e 2000. Cereali Patate Ortive Barbabietole Industriali (1) Frutta (2) Agrumi Vino Olio (3) Carni bovine Carni suine Pollame Latte vacca e bufala Latte pecora e capra Uova (milioni di pezzi) Miele 1990 156.096 20.888 111.054 114.684 24.624 58.217 27.845 54.866 4.016 15.260 14.960 17.060 97.550 6.172 11.870 140 1995 191.155 20.809 108.190 129.344 13.906 49.870 31.803 24.554 5.895 15.911 16.019 13.674 100.867 7.461 12.423 100 2000 200.356 21.553 138.668 115.612 15.502 57.397 36.556 23.638 4.593 15.852 17.483 13.610 105.721 7.083 12.700 110 (1) tabacco, girasole, soia; (2) esclusa l’actinidia, compresa l’uva da tavola; (3) media 1990/91. (N.B. per il 1995 e il 2000 i dati sono ricavati da ISTAT Valore aggiunto ai prezzi di base dell’agricoltura per regione, Roma, maggio 2001. Per il 1990, e per legumi secchi di ogni anno da Annuario INEA 1991, con dati della stessa fonte). te trasformata in azienda. Anche per l’olio il meccanismo è uguale, ma essendo i trasferimenti alle cooperative di importanza assai inferiore (10-15% circa) rispetto al 50% dell’uva, i contraccolpi sono evidentemente meno forti. • Risultati soddisfacenti Se si escludono da questi due comparti, dominati da problemi metodologici, e se si fa una eccezione per il pollame, gli altri settori si attestano tutti su risultati soddisfacenti (patate, barbabietole, frutta, carni bovine, latte, tanto di vacca quanto di pecora, uova) o addirittura eccellenti con i cereali, le ortive e gli agrumi. Come se il calo delle superfici coltivate, precedentemente esposto, fosse stato del tutto indifferente. Ora è ben noto che, grazie alle moderne tecnologie, è possibile intensificare la produzione per ettaro o per capo di bestiame. Ma le serie dei due Istat (quello del censimento e quello della contabilità nazionale) sembrano davvero un po’ troppo divaricate. Ecco una andamento sul quale agronomi e statistici potrebbero fare utili riflessioni. Caso per caso. 162 Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 • La risposta dei giovani In mancanza di questa verifica, quale delle due serie sia la più veritiera è difficile stabilire. A meno che non si voglia lasciare la risposta ai giovani che mai come tra il 1990 e il 2000 sono, negli ultimi decenni, scappati all’agricoltura. Nel 1990 le aziende dotate di un giovane inferiore a trent’anni a pieno tempo, attivo cioè per più di duecento giornate all’anno, si contavano in 55.000. Nel 2000 sono scese a 29.000. È proprio il caso di dire, come i latini, che essi sono andati pedibus in sententiam, hanno raggiunto il verdetto con i propri piedi. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 163 Nomi citati Acerbo G., 158. Adenauer K., 9, 18, 23, 32, 33, 38, 48, 60, 99. Albertario don D., 5. Albright M., 155. Andreotti G., 114. Andrini S., 89. Angius G., 117. Annan K., 120, 124. Antonioni M., 129, 130. Aristide J.B., 127. Aristotele, 145. Arnold M., 91. Aznar J.M., 39, 118. Bachelet V., 9, 14. Barberis C., 160. Blair T., 17, 25, 114, 116, 120, 121. Bargellini P., 9. Bartholomew R., 155. Battisti C., 101. Bava Beccaris F., 5. Beck, 101. Bontempelli R., 9. Berlusconi S., 39, 130. Bertinotti F., 116. Bixio A., 138. Bonghi R., 6. Bo G., 9. Bobbio N., 82. Bosco G., 47. Boselli P., 5. Bourghiba H., 69. Brahimi L., 120. Briand A., 32, 82, 83. Burckhardt J., 92. 164 Bush G., 27, 116, 120-122, 124. Calabiana, 6. Calderoli L., 115. Campilli P., 9. Cappi, 14. Caracciolo L., 113. Carlo Magno, 17, 48. Cartesio, 145. Casaroli A., 30. Casini P. F., 118. Cavallotti F., 6. Cazzullo A., 115. Cesareo V., 148-149. Chabod F., 28, 80. Chaplin V., 32. Cheli E., 109-110. Chirac J., 122. Churchill W., 25, 83. Ciampi C. A., 24. Clinton B., 125, 155. Clodoveo, 19. Colombo V., 9, 10. Commer E., 98. Corsini U., 100, 101, 103, 104. Coudenhove-Kalergi R., 82, 83. Dané C., 158, 159. De Curtis I., 16. De Gasperi A. (v. anche Degasperi), 9, 10, 13-15, 17-19, 23, 24, 32, 33, 38, 48, 58, 60, 87, 97-105, 131, 159. De Gaulle C., 27. De Rosa G., 5, 9, 10, 14, 17, 18, 21-26, 98, 158. Del Turco O., 117. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Demiral N., 71, 75. Diliberto O., 116. Dini L., 117. Donat-Cattin C., 9, 10. Donati G., 131, 158. Donati M. G., 158. Donati S., 158. Dossetti G., 10, 13, 14, 158. Ducci R., 51. Duck A., 94. Duguit L., 95. Durand J.D., 27. Durkheim E., 93. Ecevit B., 75. Einaudi L., 87. Eltsin B., 42. Endrici C., 98. Erbakan N., 73, 76. Erodoto, 79. Falciatore M., 11. Fanfani A., 10, 14. Fassino P., 117. Febvre L., 41. Ferrari, 131, 158. Ferrari Occhionero M., 79. Francesco Giuseppe, imperatore, 101. Franco F., 25. Frassati P. G., 158. Fu’Ad, 67. Funder F., 98. Gadamer H. G., 92. Galileo, 19, 22. Gambasin A., 99. Gandhi S., 127. Giner, 150. Giolitti G., 6. Giordani, 12. Giovagnoli A., 57, 133. Giovanni XXIII, 30. Giovanni Paolo II, 23, 34, 35, 116, 122, 137. Giraldi L., 10, 15. Giro M., 119. Giscard d’Estaing V., 62, 156. Gobetti P., 158. Goethe W., 92. Gol E., 157. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Gonella G., 9, 14, 15, 159. Graziani N., 17. Gronchi G., 14. Guala F., 10. Guglielmo il Conquistatore, 94. Gui L., 10. Gulen F., 74, 75. Herder J.G., 85. Hirst, 149. Humboldt A., 141, 145. Hume D., 145. Huntington S., 45. Huseyn F., 67. Hussein S., 112, 114, 122. Jabao W., 134, 136. Jacini S., 6, 14. Jaeger W., 90-92. Jellineck G., 95. Jervolino A.R., 10. Kant I., 95, 145. Kelsen H., 95. Kemal M. (Atatürk), 65, 68, 70. Kerry J. F., 122, 123. Khatami M., 122. Kohn H., 85. Laganà A., 154. La Pira G., 10, 11, 14, 30. Leibnitz G.W., 145. Li Duan di Xi’an, 137. Locatelli G., 128. Locke J., 53. Lorenzo il Magnifico, 80. Löwith K., 91. Lueger K., 97. Lula L.I., 127. Machiavelli N., 42, 80. Madame de Staël, 81. Malvestiti P., 10. Manzoni A., 131. Margotti don G., 5. Maritain J., 31, 35. Martino G., 48. Massimiliano, 94. Mattarella B., 9. Matthews, 54. 165 Mazzini G., 81. Meda F., 5, 6, 9, 13-16, 131. Meda G., 5. Metternich K., 29. Meyer H. J., 144. Mieli P., 159. Milosevič S., 42, 125. Mirabile, 85. Mittelstraß J., 141. Moneta, 6. Monnet J., 18, 48, 60. Montesquieu C.L., 80, 145. Monti M., 109. Morin E., 22. Moro A., 10, 14, 24, 26, 131. Morozzo della Rocca R., 37. Mosca, 145. Muhammad’Ali, 67. Murri R., 14, 97, 131. Mussolini B., 6, 25. Nania D., 115. Napoleone III, 25. Nenni P., 13. Nicolò V, 28. Nobili F., 9. Olivi B., 51. Özal T., 74. Paolo VI, 22, 28, 30, 31, 35. Pareto V., 145. Pastore G., 9. Pavissich A., 5. Pecoraro Scanio A., 116. Pedini M., 10. Pellicani, 150. Pellicini P., 115. Pericle, 20, 21, 91. Perroux F., 27. Petrilli G., 10. Piacentino, 94. Piccioni L., 14. Piccoli F., 10. Pio XI, 50. Pio XII, 25, 30. Pizzo P., 65. Platone, 145. Pornschlegen, 139. Portalis, 95. 166 Poupard P., 31. Putnam H., 153. Rau J., 51. Recep Tayyip E., 76. Rémond R., 28. Rescigno P., 89. Riccabona, 100. Ricoeur P., 33. Roepke W., 49. Roosevelt F. D., 155. Rosmini A., 131. Rossi E., 48. Rougement de D., 35. Rousseau J. J., 80, 85. Ruini C., 115. Rumor M., 10. Rutelli F., 117. Salvemini G., 158. San Benedetto, 30. Sangiorgi G., 17, 109, 159. Savigny F.K. von, 95. Scelba M., 10, 14, 159. Schifani R.G., 115. Schroeder G.R., 136. Schücking W., 81. Schuman R., 18, 19, 23, 30-33, 38, 47, 48, 60, 85, 99. Segni A., 10. Sen A., 42. Sestan E., 101. Silvestrini A., 17, 19, 20, 22-26. Snetlage, 92. Solgenistin A., 40. Spataro, 159. Spidlik T., 44. Spinelli A., 48, 58, 84, 87. Stefano I re d’Ungheria, 46. Storchi F., 10. Stresemann G., 32. Sturzo L., 5, 6, 9, 10, 14, 18, 21, 87, 98, 131, 158. Tanzi C., 131. Taviani P. E., 5, 9, 10, 11, 14-16. Taylor C., 125. Teodori M., 155-158. Tamil T., 127. Togliatti P., 14. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Trevoux G., 92. Trinchese S., 97. Tucidide, 20, 21. Tupini G., 9, 13. Vanoni E., 9, 14. Vasak K., 53. Veronesi V., 9. Vico G.B., 145. Civitas / I - Luglio-Ottobre 2004 Voltaire, 80. Wandycz P. S., 39. Wandruszka A., 104. Weber M., 89, 93, 95. Wojtyla K., 28. Zapatero R., 114, 117. Zoli A., 10. 167 Finito di stampare nel mese di ottobre 2004 dalla Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali per conto di Rubbettino Editore Srl 88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)
Scaricare