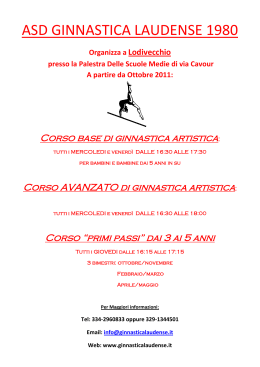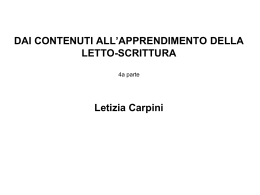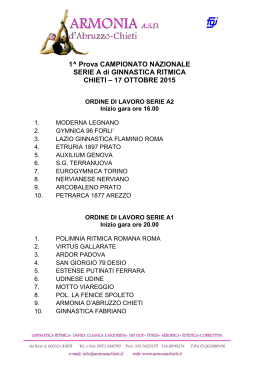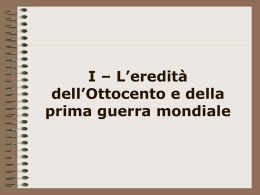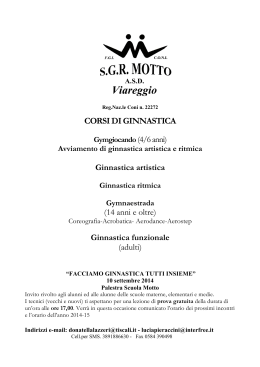Corriere del Ticino 30 a cura di CARLo LeoTTA LETTI PER VOI Sabato 27 Settembre 2014 manfred hardt daniele dell’agnola I numeri nella Divina Commedia Tracce da seguire per individuare i punti nevralgici dell’opera: ecco come si configurerebbero i numeri nella Commedia dantesca, secondo Manfred Hardt. Si aprirebbe così la possibilità di cogliere e interpretare brani lontani fra loro come se fossero vicini. I numeri sarebbero anche garanzia di perfezione. Una nuova era per la dantistica italiana? Salerno, pagg. 323, euro 23. A scuola tra amori e falsi miti Una quarta media di un paese della Svizzera italiana. Classe difficile, indisciplinata, attraversata da conflitti razziali. Le sfide di una giovane supplente di italiano: suscitare interesse e abbattere le barriere culturali. In mezzo il Baracobamà, ritrovo in cui le differenze si fondono per trovare nuove forme di svizzeritudine, di incontro e di convivenza. Infinito, pagg. 211, euro 14. autori vari Cronache dai decenni inutili Un vortice che ha travolto ogni certezza. Così è stato avvertito il decennio 1980-1990 dagli autori del libro (fra i quali Aldo Nove e Antonio Scurati) che, nati a metà anni 1960, erano allora studenti universitari. Le pagine ripercorrono con qualche occhiata alle spalle quel periodo, vissuto con l’interrogativo: siamo di fronte alla fine della storia? Bompiani, pagg. 157, euro 15. CULTURA L’inTeRvisTA zxy mauro natale* «Le opere d’arte sono oggetti artigianali» Lugano celebra il Bramantino, rinnovatore della pittura tra Quattro e Cinquecento nATAsChA fioReTTi zxy L’arte nuova del Rinascimento lombardo. Perché la scelta di questo titolo? «Il titolo stabilisce una connessione tra il personaggio, che è il protagonista di questa epoca, e il ruolo che questo protagonista ha avuto sulla cultura figurativa negli anni di passaggio tra il Quattrocento e il Cinquecento. Quello del Bramantino è stato un ruolo di rinnovamento importante di riforma formale, esteso naturalmente anche ai contenuti». Può spiegarci meglio in che cosa consiste questo cambiamento? «Le opere di Bramantino sono incredibilmente dense ma anche molto spoglie, molto forti rispetto alla tradizione Quattrocentesca, che è una tradizione molto più ornata con una attenzione molto particolare ai materiali preziosi, le dorature, i rilievi in pastiglia. Tutto questo scompare con lui intorno al 1500». Qual è lo scopo dell’esposizione? «La mostra illustra l’evoluzione, il percorso del Bramantino a partire dalle prime opere, ancora legate alla tradizione quattrocentesca, fino alle ultime, che invece sono quasi spettrali, spoglie, con dei colori acrilici, molto manieristi. Si inizia con la meravigliosa Madonna con il Bambino del Museo di belle arti di Boston, probabilmente il primo quadro del Bramantino. C’è una grande attenzione alla luminosità e alla profondità dello spazio, un naturalismo un po’ intellettuale ma ancora fedele a certi schemi quattrocenteschi. Vi è, inoltre, un certo ricordo di Mantegna, della pittura bolognese e ferrarese del Quattrocento». È una mostra che ha potuto contare su prestiti notevoli? «Tantissime opere provengono da musei e istituzioni importanti come la National Gallery di Londra, il Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid e la Galleria degli Uffizi di Firenze. Questi musei hanno prestato le loro opere perché hanno creduto nel progetto, hanno capito che è una mostra pensata e basata sulla ricerca». Non solo un valore espositivo dunque, ma anche di ricerca e restauro? «C’è stato un lavoro materiale importante dal punto di vista della conservazione. Significativi i restauri fatti sulla Madonna del Sasso di Orselina. È un quadro che ha subito alcuni danni dovuti probabilmente al pittore stesso, cioè al modo con il quale Bramantino ha preparato la tavola e ha dipinto usando leganti oleosi, che si sono contratti molto rapidamente creando una screpolatura vistosa in alcune zone del dipinto. L’elemento appassionante, importante anche per la cultura ticinese, è la ricostruzione attenta della storia dei vari restauri. Notevoli anche gli interventi fatti sull’opera Madonna in trono con il bambino e santi i cui colori non sono più smorzati: l’azzurro del cielo è di un vibrante incredibile». Perché visitare questa mostra? «Per l’elemento di novità che risiede nell’illustrare e accentuare il cambiamento radicale dello stile di questo pittore intorno al 1500. Un cambiamento non solo formale, visto che è il frutto anche di una congiuntura politica e religiosa particolare. In quegli anni c’era la speranza che avvenisse una vera riforma di tipo religioso». Qual è il nesso tra il contesto politico-religioso e l’opera del Bramantino? «Bramantino dà forma a queste aspirazioni. Il suo è un costante richiamo alla Chiesa primitiva senza ori, un ritorno agli abiti semplici, un richiamo alla povertà e alla dignità della Chiesa dei primi secoli. Non c’è una pennellata d’oro». Come curatore, quali soddisfazioni le ha dato l’allestimento della mostra? «L’idea di ricostruire il percorso è stata coinvolgente. È importante fare delle mostre di questo tipo anche se rischiose per via dei costi e della specificità del tema. Esse fanno capire che le opere d’arte sono degli oggetti materiali e artigianali». Oggi di questo forse ci si dimentica? «Completamente, perché le immagini hanno sostituito le opere in sé stesse. C’è nella realtà delle opere un elemento arcaico legato all’uso del colore, alla preparazione della tavola e della tela, che va messo in valore. Sono incredibilmente appassionato da questa identità materiale dei dipinti; anche quelli danneggiati raccontano una storia, se uno sa leggerla». * storico dell’arte, Università di Ginevra Bramantino. l’arte nuova del rinascimento lomBardo museo cantonale d’arte di lugano da oggi all’11 febbraio 2015. museo cantonale in alto da sinistra: «madonna con il bambino», 1485 ca.; «adorazione dei magi», 1495-1500 ca. Qui sopra: «Giove e mercurio in visita a Filemone bauci, 1490-1495. (Foto © Museum of Fine Arts, Boston; Rheinisches Bildarchiv Köln; The National Gallery, Layard Bequest) fUoRi dALL’AULA zxy adolFo tomaSini L’importanza della messa in moto per il cittadino consapevole P arliamo di Gaia, la giovane allieva della scuola media di Gordola che ha rimediato una risicata sufficienza in educazione fisica a fine anno scolastico, giusto due mesi prima del suo 13. rango ai Giochi olimpici giovanili estivi in Cina. La ragazza, un talento nazionale della ginnastica artistica, frequentava la scuola media a Gordola, per la vicinanza col Centro sportivo della gioventù, nell’ambito degli speciali programmi di scolarizzazione di talenti in campo sportivo e artistico promossi dal DECS. Si può immaginare che quel misero 4 in ginnastica avrebbe rimediato solo qualche moccolo in famiglia, se non avesse contribuito a tenere la media globale della ragazza sotto la fatidica soglia del 4.6, che le avrebbe consentito l’iscrizione al liceo per sportivi d’élite. La famiglia dell’atleta ha già inoltrato un paio di ricorsi, entrambi respinti. Fin qui la scarna sintesi della vicenda, che ha scatenato un fiume in piena di scrollate di capo. «Com’è possibile – si chiedono in molti – che la giovane campionessa non vada oltre una misera sufficienza proprio in ginnastica?». Non so voi, cari lettori, ma anch’io, prima di leggere questa storia, ero convinto che l’educazione fisica fosse uno spazio di sano e utile movimento all’interno di quelle 33 ore settimanali della scuola media. Credevo, in altre parole, che le tre ore settima- nali di ginnastica rispettassero l’Ordinanza federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica, che stabilisce come a livello di scuola dell’obbligo devono essere impartite almeno tre lezioni settimanali di ginnastica, con l’obiettivo principale di incrementare l’attività fisica e sportiva. Invece non è così, o lo è solo in parte: basta leggere il «Piano di formazione della scuola media», oltre otto pagine fitte, per rendersene conto. Intanto solo due discipline, italiano e matematica, hanno più ore della ginnastica. Poi si scopre che si insegnano tante di quelle cose importanti che in questa sede ci starebbe neanche una sintesi ridotta all’osso. Basti pensare che «la specificazione programmatica mette in rilievo le implicazioni emotive ed esistenziali dell’attività fisicosportiva»: insomma, mica solo una corsetta o un’infuocata partita di pallavolo. Da questo punto di vista, quindi, la decisione del Consiglio di Stato che ha respinto il secondo ricorso non fa una grinza: dura lex, sed lex. Il fervore dipartimentale per la promozione di atleti, musicisti e danzatori non mi ha mai infiammato. Mi sfugge il senso di questo blandire gli sportivi d’élite al posto, che so?, dei matematici d’élite, che se sono bravi non ricevono neanche i complimenti del Consiglio di Stato, assieme a qualche biglietto da mille. Ci sarà qualche motivo misterioso. Se le tre ore di educazione fisica – quelle imposte dalla confederazione – fossero state soltanto delle ore dedicate alla pratica sportiva e al movimento, mi sarei chiesto come mai questi talenti non siano semplicemente esonerati. Invece, per stare alle peripezie scolastiche della nostra olimpionica, ho scoperto che «Gaia ha svolto una sola prova di creazione di una messa in moto con la musica, valutata dalla docente sufficiente nella parte pratica e insufficiente nella parte teorica, ciò che ha portato all’assegnazione della nota finale 4». Già: saper dar vita, in teoria e in pratica, a una messa in moto con la musica è un obiettivo fondamentale e se non lo sai fare l’età adulta sarà molto problematica e cosparsa di bufere corporee ed esistenziali.
Scarica