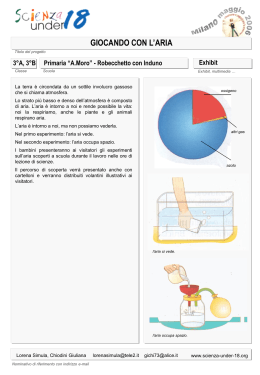Approcci allo studio della personalità Un dilemma arduo con cui partire: “Scienza o unicità: questo è il problema” (G.W. Allport) • C’è una difficoltà di parlare di “personalità”, perché il concetto allude a qualcosa di soggettivo, che mal si presta ad essere descritto dalla scienza oggettivante… → Questa difficoltà è stata spesso espressa parlando di approcci di tipo idiografico (in cui l'oggetto di studio è unico [idios = particolare], irripetibile, come nelle scienze umane) ed approcci di tipo nomotetico (in cui è possibile formulare leggi generalizzabili [nomos = legge], come nelle scienze naturali). – Gli approcci idiografici si oppongono alla metodologia positiva tipica delle scienze naturali e puntano la loro attenzione alla soggettività e agli argomenti del cuore che la ragione non può comprendere; se si volesse criticare questo approccio si potrebbe affermare che tali teorici sono, come suggeriscono Cervone, Pervin (2008), dei “romantici”; – Gli approcci nomotetici hanno sviluppato le loro teorie soprattutto nell’ambito della “psicologia differenziale”, ovvero quella psicologia della personalità che si è occupata innanzitutto di classificare e spiegare scientificamente perché fra le persone sussistano delle differenze (ad esempio nel percepire, nel reagire a stimoli ecc.), poi confluita nella psicologia dei tratti. I tratti rappresentano organizzazioni relativamente stabili di conoscere, sentire, agire. Ma, se si volesse anche qui elevare una critica, si potrebbero chiedere loro: lo specifico individuale che fine fa? • Per Eysenck: “per lo scienziato, l’individuo singolo e unico è soltanto il punto di intersezione di un certo numero di variabili quantitative” (Eysenck 1953). per Allport tale approccio non considera la “struttura” interna della personalità, la sua organizzazione “L’individualità”, per Allport, è la caratteristica principale dell’uomo”. La difficoltà nel definire in “positivo”, e non “per differenza” rispetto alle altre persone, cosa sia la personalità di un individuo si evince ad esempio da tale definizione …la personalità è l’organizzazione dinamica, interna alla persona, di quei sistemi psicofisici o modi caratteristici di comportarsi, pensare e sentire (Allport 1961) Gordon W. Allport (1897-1967) è stato uno dei più celebri e riveriti psicologi della personalità. Animato da una «profonda tensione umanistico religiosa» (Caprara-Gennaro, 1999, p. 315) e dal desiderio di cogliere il «Proprio» specifico di ogni persona, che a parere di Allport non è innato, ma è esito dello sviluppo, distinguendo tratti cardinali, centrali e secondari a seconda che caratterizzano più o meno profondamente la persona, a pare di alcuni (cfr. CervonePervin, 2008, tr. it. 2009, p. 284) i suoi contributi sono stati limitati. In particolare, per Cervin e Cervone, pur avendo Allport sostenuto che le persone sono caratterizzate da pattern unici e coerenti collegati a tratti di personalità, non ha poi fornito nessun modello preciso per spiegare come le singole azioni siano collegate a un certo tratto. Per G.W. Allport comprendere il “giusto equilibrio” fra questi due approcci è un “problema di base” nell’ambito della psicologia della personalità (Allport, Psicologia della personalità, 1961). Più noi ricerchiamo e scopriamo ciò che è uniforme nella natura umana, più è urgente e necessario che ci rendiamo conto della unicità nella forma e nella struttura del complesso della persona. […] Quello che voglio sottolineare è l’organizzazione interna dei motivi, dei tratti e dello stile personale, […] Tale convinzione mi induce ad oppormi alla riduzione della personalità a fattori comuni rilevabili in tutti gli uomini e inoltre a una questione di ruoli, a relazioni interpersonali, ad avvenimenti in seno al sistema socio-culturale. […] Naturalmente la personalità si forma in un determinato ambiente sociale e in esso si esprime, ma nello stesso tempo è un sistema autonomo e indipendente, e come tale merita di essere studiato per se stesso. […] Sono pienamente convinto che il settore più debole della odierna ricerca empirica è proprio […] lo studio della struttura concreta, dell’ordine interno di una singola personalità (Allport 1961). Egli conclude affermando: “scienza e unicità: ecco il problema”. • Si possono individuare tre approcci allo studio della personalità (Cervone, Pervin, 2008, tr. it. 2009, pp. 52 ss) 1. Lo studio dei casi e la ricerca clinica: • molti psicologi ritengono che solo lo studio dei “casi” individuali possa assicurare una presa di contatto con la complessità della personalità umana. Si tratta di metodi implicitamente idiografici (si veda dopo), miranti a ottenere un ritratto del singolo individuo → Quando si deve indagare tutta la complessità della personalità, la sua organizzazione interna, le relazioni fra individuo e ambiente, l’approccio clinico può essere l’unica strada percorribile. • Gli svantaggi del metodo clinico sono: • una difficile generalizzabilità di quanto osservato nel singolo caso estendendola ad altri soggetti; • la difficoltà a passare dalla descrizione dettagliata di una persona a una chiara spiegazione causale; • il basarsi su impressioni soggettive, così che uno stesso caso potrebbe essere descritto in modo diverso da ricercatori differenti. 2. Approccio basato sui questionari e la ricerca correlazionale. • Questo approccio si basa sull’uso di questionari, che permettono di raccogliere una grande quantità di informazioni. • L’obiettivo degli psicologi che utilizzano questo approccio è: – di stabilire innanzitutto le “differenze” fra le personalità degli individui (se uno è più o meno timido, socievole ecc.); – inoltre, tentano di capire quali variabili (socievolezza, timidezza, ecc.) sono “correlate” fra di loro, ovvero “si muovo assieme” (ad esempio se la somministrazione di tanti questionari mostra che gli individui socievoli sono anche poco timidi allora fra le due variabili c’è correlazione). → Lo scopo è di arrivare a descrivere alcune variabili fondamentali, non correlate reciprocamente, capaci di descrivere la personalità. Psicologia differenziale La psicologia, tuttavia, non intende indagare solamente le differenze fra le persone, ma anche scoprire i tratti di personalità, ossia quei «modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell'ambiente e di se stessi». (DSM-IV [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders], APA, 1994) Nell’ambito della ricerca correlazionale, negli ultimi anni un consenso crescente è stato accordato ai cosiddetti “Big Five”, cinque grandi fattori Energia [Estroversione]: è inerente ad un orientamento fiducioso ed entusiasta nei confronti delle varie circostanze della vita, la maggior parte delle quali sono interpersonali; Amicalità [Gradevolezza] include, ad un polo, caratteristiche come l'altruismo, il prendersi cura, il dare supporto emotivo, e, al polo opposto, caratteristiche come l'ostilità, l'indifferenza verso gli altri, l'egoismo; Coscienziosità: fa riferimento a caratteristiche come la precisione e l'accuratezza, l'affidabilità, la responsabilità, la volontà di avere successo e la perseveranza; Stabilità emotiva [Nevroticismo]: è una dimensione molto ampia comprendente una varietà di caratteristiche collegate all'ansietà e alla presenza di problemi di tipo emotivo, quali la depressione, l'instabilità di umore, l'irritabilità, ecc.; Apertura mentale: fa riferimento all'apertura verso nuove idee, verso i valori degli altri e verso i propri sentimenti. Per ognuno dei Big Five sono state individuate due sottodimensioni, ciascuna delle quali fa riferimento ad aspetti diversi della medesima dimensione. (C. V. CAPRARA, C. BARBARANELLI, L. BORGOGNI, http://www.psibo.unibo.it/test/bfq.htm) Per ogni sottodimensione la metà delle affermazioni sono formulate in senso positivo rispetto al nome della scala, mentre l'altra metà è formulata in senso negativo, al fine di controllare eventuali risposte date a caso. In totale il BFQ consta di 132 item e le dieci sottodimensioni sono: dinamismo, dominanza, cooperatività, cordialità, scrupolosità, perseveranza, controllo dell'emozione, controllo degli impulsi, apertura alla cultura e apertura all'esperienza. (C. V. CAPRARA, C. BARBARANELLI, L. BORGOGNI, http://www.psibo.unibo.it/test/bfq.htm) Nella seguente lista trovi degli aggettivi che descrivono alcune caratteristiche delle persone. Indica in che misura ritieni di possedere ciascuna caratteristica. Cerca di rispondere onestamente, anche se ci sono alcune caratteristiche di te che non ti piacciono. Esprimi i tuoi giudizi considerando la seguente scala: Non mi corrisponde per niente A volte mi corrisponde a volte no Mi corrisponde completamente 1 2 3 4 5 6 7 Ti ritieni una persona…. Fantasioso/a 1 Irritabile 2 3 4 5 6 7 1 Riservato/a 7 1 Negligente 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Silenzioso/a 1 Premuroso/a 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 Preciso/a 2 3 4 5 6 1 Preoccupato/a 7 1 Gentile 2 3 4 5 6 1 Versatile 7 1 Chiuso/a 2 3 4 5 6 1 Organizzato/a 7 1 Permaloso/a 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Loquace 1 Innovativo/a 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 Introverso/a 2 3 4 5 6 1 Ordinato/a 7 1 Pauroso/a 2 3 4 5 6 1 Artistico/a 7 1 Simpatico/a 2 3 4 5 6 1 Timido/a 7 1 Disponibile 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Sistematico/a 1 Comprensivo/a 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 Scrupoloso/a 7 1 Nervoso/a 2 3 4 5 6 1 Riflessivo/a 7 1 Piacevole 2 3 4 5 6 1 Creativo/a 7 1 Agitato/a 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 • • Neuroticism (instabilità emotiva). Detto anche emotività negativa (Negative emotionality) o bisogno di stabilità (Need for stability), riguarda il livello di ansia e di volubilità che caratterizza una persona. Può essere considerato come una misura del numero e della forza degli stimoli necessari a suscitare emozioni negative nella persona (più è alto il valore di questo fattore, minore è il numero degli stimoli necessari). Riguarda l’attitudine più o meno spiccata a preoccuparsi, arrabbiarsi e scoraggiarsi, nonché l’impulsività e la vulnerabilità. Valori bassi su questa scala indicano una persona elastica (resilient): emotivamente stabile, ha la capacità di rimanere calma anche in situazioni difficili in quanto le affronta in modo razionale e tende a presentarsi come una persona composta. Valori alti indicano invece un carattere reattivo (reactive): la persona si altera, si imbarazza e si innervosisce facilmente, sperimenta di frequente emozioni negative e di sfiducia che la portano a essere tendenzialmente insoddisfatta. Tra i due estremi, vi è chi reagisce alle situazioni (responsive), alternando atteggiamenti pacati e nervosi a seconda del contesto. Extraversion (estroversione). Riguarda l’interesse verso gli altri, verso la vita sociale e la facilità nelle relazioni interpersonali. Valori alti su questa scala indicano una persona estroversa (extravert), che cerca la compagnia altrui, tende ad avere un atteggiamento allegro e ottimista e si propone come leader del gruppo. Valori bassi indicano un carattere introverso (introvert), più timido, riservato, per niente desideroso di mettersi in mostra. Valori intermedi sono associati a chi si dimostra capace di partecipare attivamente alla vita sociale, ma anche di sentirsi a proprio agio nella solitudine ed è definito come ambiverso (ambivert). Dei 5 fattori, quello di estroversione è il maggiormente visibile nel corpo: una persona estroversa tende a fare movimenti più ampi e vigorosi, a parlare con un tono di voce più alto e a prendere l’iniziativa nei rapporti interpersonali (ad esempio, salutando per primo o iniziando una conversazione). • • • Openness (apertura all'esperienza). Riguarda la varietà di temi che attraggono una persona e la profondità con cui questi interessi sono coltivati. Questi due aspetti appaiono inversamente proporzionali: più è alto il numero di interessi più è difficile esplorarli tutti in profondità, mentre chi possiede pochi interessi può coltivarli con maggiore cura. Valori alti su questa scala indicano una persona esploratrice (explorer) che si dimostra curiosa, fantasiosa, originale, attratta da tutto ciò che è nuovo, mentre valori bassi indicano un conservatore (preserver) che preferisce ciò che conosce già e non ama perdersi in fantasie. L’apertura mentale si manifesta nella curiosità e quindi nella maggiore o minore attenzione rivolta sia verso l’ambiente circostante sia verso le emozioni provate. Agreebleness (gradevolezza o anche socievolezza). Riguarda il grado di adattamento che una persona mostra nei confronti degli altri. Va a considerare da dove la persona attinge le regole di corretto comportamento, dagli altri oppure da se stessa. Valori bassi su questa scala indicano un carattere detto challenger, concentrato su se stesso, sulle proprie opinioni e bisogni: la persona intraprende faticosi rapporti con gli altri, con i quali si dimostra cinica, egocentrica, competitiva e testarda e manifesta atteggiamenti di superiorità. Valori alti individuano invece una persona adattabile (adapter) che tende a uniformarsi alle idee e alle norme del gruppo, da cui dipende e verso cui prova una certa fiducia e si dimostra altruista e disponibile. Valori intermedi indicano un negoziatore (negotiator), capace di imporre la sua opinione o di accettare quella degli altri a seconda della situazione. Conscientiousness (coscienziosità). Riguarda il numero di scopi che una persona si prefigge e la perseveranza con cui li persegue. Alcuni degli aspetti legati alla coscienziosità sono, ad esempio, l’autodisciplina, la metodicità e la razionalità nelle decisioni. Valori alti su questa scala indicano una persona mirata (focused), che si dedica ad un limitato numero di obiettivi perseguendoli in modo organizzato ed efficiente. Valori bassi indicano una persona flessibile (flexible), che si pone molti obiettivi ma non si dedica seriamente a nessuno, che si distrae facilmente, è perennemente in ritardo sulla tabella di marcia (se ne ha una), risulta spesso impreparata e preferisce dedicarsi al relax o agli svaghi. [Luca CHITTARO, 2009] • I limiti di questo approccio sono: – che fornisce indicazioni molto limitate sui singoli individui, limitandosi a fornire informazioni sui punteggi che il soggetto ottiene nei diversi test; – inoltre, al pari dell’approccio basato sui casi, è difficile giungere a conclusioni definitive sulla causalità: il fatto che due variabili siano correlate non significa necessariamente che una variabile sia causa dell’altra; – inoltre, il modo in cui le persone rispondono ai questionari potrebbe dipendere da ragioni non relative al reale contenuto delle domande (ad esempio le persone potrebbero avere difficoltà a rispondere positivamente alla domanda: “hai mai rubato in un supermercato?”); – inoltre, tramite un questionario può essere difficile capire se le persone rispondono utilizzando il loro autentico modo di essere o delle concettualizzazioni difensive (la persona si defisce “felice” perché lo è veramente o pensa solo di esserlo?) (Cervone, Pervin, tr. it. 2009, 56-69) 3. Approccio sperimentale: utilizza l’esperimento di laboratorio, controllato, che permette di isolare le variabili che si vogliono esaminare. Questo è un grande vantaggio dell’esperimento di laboratorio. - Ad esempio, è stato visto che se si chiedeva ad un gruppo di studenti di razza bianca e nera di indicare la loro appartenenza razziale prima di un test, gli studenti neri ottenevano performance meno positive che se questa indicazione demografica veniva omessa. Ciò indica che gli studenti neri sentivano “pesare” su di sé la “minaccia dello stereotipo”. • I limiti della ricerca di laboratorio sono: – la sua “artificiosità”, il suo non considerare la reale complessità del comportamento umano in situazione reale; – inoltre, possono innescarsi altri meccanismi che influenzano il comportamento dei soggetti, come la tendenza del soggetto a comportarsi in modo da confermare le ipotesi dell’esperimento “nell’interesse della scienza” o la tendenza a soddisfare le aspettative dello sperimentatore; – inoltre molti esperimenti di laboratorio non tengono presente del dispiegarsi di alcuni comportamenti nel tempo (Cervone, Pervin, tr. it. 2009, pp. 63-71) Due esperimenti celebri: - l’esperimento Milgram - l’esperimento carcerario di Stanford L’esperimento Milgram • L'esperimento psicologico noto come «esperimento Milgram» fu condotto nel 1961 dallo psicologo statunitense Stanley Milgram che consistette nell’indurre soggetti ingenui a somministrare degli elettrochoc a altri soggetti complici. – L'esperimento cominciò tre mesi dopo l'inizio del processo a Gerusalemme contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. Milgram concepiva l'esperimento come un tentativo di risposta alla domanda: "È possibile che Eichmann e i suoi milioni di complici stessero semplicemente eseguendo degli ordini?". • I partecipanti alla ricerca furono reclutati tramite un annuncio su un giornale locale o tramite inviti spediti per posta a indirizzi ricavati dalla guida telefonica. Il campione risultò composto da 40 maschi fra i 20 e i 50 anni, maschi, di varia estrazione sociale. Fu loro comunicato che avrebbero collaborato, dietro ricompensa, a un esperimento sulla memoria e sugli effetti dell'apprendimento, con la precisazione che la somma di denaro spettava loro per il semplice fatto di essersi prestati a venire in laboratorio indipendentemente da quanto sarebbe successo dopo. • Bisognava trovare un pretesto per giustificare la somministrazione di elettrochoc. Per cui si ricorreva a una spiegazione di copertura. Dopo una introduzione generale sulla presunta relazione fra punizione e apprendimento si diceva ai soggetti: per la verità, sappiamo ben poco circa l’effetto che la punizione ha sull’apprendimento, perché studi veramente scientifici di questo genere non sono stati quasi mai compiuti sugli esseri umani […] Vogliamo scoprire proprio gli effetti reciproci che si verificano tra persone diverse nel ruolo di insegnanti e allievi, e come influisce la punizione sull’apprendimento in questa situazione. Perciò questa sera chiederò a uno di voi di fare l’insegnante e all’altro di fare l’allievo. Avete delle preferenze?» (Milgram, 1963) • Il sorteggio era truccato e al soggetto ignaro capitava sempre il ruolo di insegnante. I due soggetti venivano poi condotti nelle stanze predisposte per l'esperimento. L’allievo era legato a una specie di sedia elettrica. • A esperimento iniziato, l’insegnante doveva somministrare un impulso elettrico a ogni risposta sbagliata. Inoltre, il soggetto deve spostare la leva del generatore di corrente ad una tensione superiore a ogni risposta sbagliata, leggendo prima ad alta voce il voltaggio. Quando si ragiunge il livello «choc 300» l’allievo batte i piedi sul muro. Oltre questo livello, non si sentono più reazioni da parte dell’allievo Se il soggetto si dimostra riluttante, lo sperimentatore utilizza una sequenza di «stimoli»: 1. “continui, per favore” 2. “l’esperimento richiede che lei continui” 3. “è assolutamente essenziale che lei continui” 4. “non ha altra scelta, deve andare avanti”. • Quali risultati? Contrariamente alle aspettative, nonostante i 40 soggetti dell'esperimento mostrassero sintomi di tensione e protestassero verbalmente, una percentuale considerevole di questi (circa i 2/3), obbedì allo sperimentatore. Questo «stupefacente grado di obbedienza» (Wikipedia), che ha indotto i partecipanti a violare i propri principi morali, è stato spiegato in rapporto ad alcuni elementi, quali l'obbedienza indotta da una figura autoritaria considerata legittima, la cui autorità induce uno stato eteronomico, caratterizzato dal fatto che il soggetto non si considera più libero di intraprendere condotte autonome, ma strumento per eseguire ordini. I soggetti dell'esperimento non si sono perciò sentiti moralmente responsabili delle loro azioni, ma esecutori dei voleri di un potere esterno. Alla creazione del suddetto stato eteronomico concorrono tre fattori: – percezione di legittimità dell'autorità (nel caso in questione lo sperimentatore incarnava l'autorevolezza della scienza) – adesione al sistema di autorità (l'educazione all'obbedienza fa parte dei processi di socializzazione) – le pressioni sociali (disobbedire allo sperimentatore avrebbe significato metterne in discussione le sue qualità oppure rompere l'accordo fatto con lui). • Il grado di obbedienza all'autorità variava però sensibilmente in relazione a due fattori: la distanza tra insegnante e allievo e la distanza tra soggetto sperimentale e sperimentatore. Furono infatti testati quattro livelli di distanza tra insegnante e allievo: nel primo l'insegnante non poteva osservare né ascoltare i lamenti della vittima; nel secondo poteva ascoltare ma non osservare la vittima; nel terzo poteva ascoltare e osservare la vittima; nel quarto, per infliggere la punizione, doveva afferrare il braccio della vittima e spingerlo su una piastra. Nel primo livello di distanza, il 65% dei soggetti andò avanti sino alla scossa più forte; nel secondo livello il 62,5%; nel terzo livello il 40%; nel quarto livello il 30%. • Grazie all'esperimento, Milgram arriva a dimostrare che l'obbedienza dipende anche dalla ridefinizione del significato della situazione. Ogni situazione è infatti caratterizzata da una sua ideologia che definisce e spiega il significato degli eventi che vi accadono, e fornisce la prospettiva grazie alla quale i singoli elementi acquistano coerenza. La coesistenza di norme sociali contrastanti (da una parte quelle che inducono a non utilizzare la forza e la violenza e dall'altra quelle che prevedono una reazione aggressiva a certi stimoli) fa sì che la probabilità di attuare comportamenti aggressivi venga di volta in volta influenzata dalla percezione individuale della situazione (che determina quali norme siano pertinenti al contesto e debbano pertanto essere seguite). Dal momento che il soggetto accetta la definizione della situazione proposta dall'autorità, finisce col ridefinire un'azione distruttiva, non solo come ragionevole, ma anche come oggettivamente necessaria (fonte: Wikipedia). – Le numerose ricerche che hanno successivamente utilizzato il paradigma di Milgram (come quelle di David Rosenhan), hanno tutte pienamente confermato i risultati ottenuti dallo studioso, che sono stati ampiamente discussi anche nell'ambito di quel cospicuo filone di studi interessati a ricostruire i fattori che hanno reso possibile lo sterminio ad opera dei nazisti. “La psicologia sociale di questo secolo ci ha dato una grande lezione: a volte non è tanto il tipo di persona che siamo, ma la situazione in cui ci troviamo a determinare le nostre azioni” (Milgram, 1974). “Persone normali, che fanno il loro lavoro e senza alcuna particolare ostilità nei confronti delle vittime, possono diventare terribili parti attive in un processo di distruzione: anche quando gli effetti si rivelano in tutta la loro gravità, poche persone hanno le risorse necessarie per resistere ad una autorità” (Milgram, 1974). Siamo tutti figli di Eichmann? di Umberto Galimberti (la Repubblica, 12.03.08) Siamo soliti pensare che il bene e il male siano due entità contrapposte e tra loro ben separate, così come i buoni e i cattivi che riteniamo tali per una loro interna disposizione. Per effetto di questa comoda schematizzazione che ci rende innocenti a buon prezzo, noi, che ci pensiamo «buoni», escludiamo di poterci trasformare nel giro di poco tempo in carnefici crudeli, attori in prima persona di quelle atrocità che ci fanno inorridire quando le leggiamo nei resoconti di cronaca o le vediamo in tv. Per rendercene conto, e lo dobbiamo fare per conoscere davvero noi stessi, è sufficiente che leggiamo il libro di Philip Zimbardo, L’effetto Lucifero (Raffaello Cortina, pagg. 650, euro 35). Lucifero, prima di diventare Satana, il principe del male, era il portatore di luce, l’angelo prediletto da Dio. Ciascuno di noi può trasformarsi da Lucifero in Satana, non per predisposizione interna come crede la psicologia quando distingue il normale dal patologico, al pari della religione quando distingue il buono dal cattivo, ma per altri due fattori che sono il «sistema di appartenenza» e la «situazione» in cui ci si viene a trovare. Non erano dei criminali per natura Heinrich Himmler e Adolf Eichmann quando portarono a compimento con abnegazione lo sterminio degli ebrei, ma dei «burocrati» con uno spiccato senso del dovere al loro sistema di appartenenza che era l’ideologia nazista. Lo stesso si può dire di Franz Stangl, direttore del campo di concentramento di Treblinka che aveva il compito di eliminare tremila deportati al giorno perché l’indomani ne giungevano altri tremila. «Il metodo l’aveva ideato Wirt. E siccome funzionava, mio compito era di eseguirlo alla perfezione», rispose a Gitta Sereny che in una serie di interviste (oggi pubblicate da Adelphi col titolo In quelle tenebre) gli chiedeva che cosa provava. La stessa risposta la diede il pilota americano che sganciò la bomba atomica su Hiroshima a Günther Anders che gli poneva analoga domanda: «Che cosa provavo? Nothing. That was my job (Niente, quello era il mio lavoro)». Quando la responsabilità si restringe e, da responsabilità nei confronti degli effetti delle nostre azioni, si riduce a responsabilità nei soli confronti degli ordini ricevuti, queste risposte sono corrette, così come ci sentiamo tutti noi quando, negli apparati di appartenenza ci limitiamo a eseguire perfettamente il nostro mansionario, i programmi ministeriali nelle scuole a prescindere dalle condizioni culturali in cui si trovano i ragazzi che le frequentano, gli interessi dell’azienda a prescindere dalle condizioni in cui si effettua il lavoro (compresi i morti sul lavoro) e dai prodotti finali del lavoro (più o meno corrispondenti a quello che la pubblicità vorrebbe farci credere). Quando la responsabilità non si estende agli effetti delle nostre azioni, ma si restringe alla semplice osservanza degli ordini che ci provengono dagli apparati di appartenenza, allora, come recita il titolo di un libro di Günther Anders, siamo tutti «figli di Eichmann» e come tali subiamo quello che Philip Zimbardo chiama: «L’effetto Lucifero», dove persone perbene, per effetto del «sistema di appartenenza» o per le «situazioni» in cui ci veniamo a trovare, diventiamo, indipendentemente dalla nostra indole, degli oggettivi criminali, capaci di compiere quelle azioni che, fuori dal sistema di appartenenza o dalla situazione concreta, ci farebbero inorridire. Philip Zimbardo è uno psicologo sociale dell’Università di Stanford che nel 1971 tentò un curioso esperimento di «prigionia simulata». Con un annuncio sul giornale scelse, tra le centinaia che si erano presentate, ventiquattro persone che, per quindici dollari al giorno, accettassero di fare le guardie e i detenuti in una prigione simulata nell’edificio dell’Università. I prescelti erano i più stabili psicologicamente, senza trascorsi di alcol e droga, senza pendenze penali, senza problemi medici o mentali. Insomma ragazzi normali, bravi ragazzi si direbbe se l’aggettivo non fosse denso di pregiudizi. A quelli incaricati di fare la guardia furono assegnati i compiti in uso per gli arresti veri, con la sola avvertenza che dovevano evitare abusi e violenze fisiche. Dopo una settimana l’esperimento fu interrotto perché le guardie, che avevano preso molto sul serio il loro ruolo, in un’istituzione altrettanto seria come poteva essere l’università, per una prova seria quanto lo può essere un esperimento scientifico, non per la loro «indole», ma per effetto del loro «ruolo» e della «situazione» in cui si trovavano a operare, si abbandonarono alle più feroci aggressioni fisiche e psichiche non dissimili, scrive Zimbardo, dai modelli nazisti. La constatazione ha consentito allo sperimentatore di concludere che la pratica del male o, come lui la chiama: «l’effetto Lucifero», non è una prerogativa di un’indole piuttosto che di un’altra (come ritiene la psicologia, che a sua insaputa ha ereditato lo schema religioso che distingue i buoni dai cattivi), ma è la prerogativa di tutti che, a partire da una «struttura di appartenenza» (una fede, un’ideologia, un apparato aziendale) e da una «situazione concreta» in cui ci si trova a operare (in un gioco vero o simulato di tutori dell’ordine e criminali, o in una guerra che vede contrapposti in nostri ai nemici) chiunque, anche il più buono fra noi è portato a compiere i crimini più orrendi. La conclusione è che il bene e il male non sono prerogative di alcuni e non di altri, ma, compresenti in ciascuno di noi si scatenano indifferentemente in tutti a partire dal «sistema di appartenenza» e dalla «situazione» in cui ci si viene a trovare. Inorridito da quanto aveva constatato Philip Zimbardo non riuscì a scrivere il resoconto di quanto aveva visto negli anni immediatamente successivi all’esperimento, ma solo quando, nel 2004, fu chiamato in qualità di perito a dare una spiegazione del perché bravi ragazzi, ritenuti tali dopo accurate verifiche, inviati come militari in Iraq, avessero potuto compiere nel carcere di Abu Ghraib abusi così orrendi quali risultarono dalle registrazioni che Zimbardo ebbe modo di visionare dove si vedevano scene ben più aberranti di quelle che le televisioni di tutto il mondo hanno poi diffuso. In gioco, scrive Zimbardo, non è tanto l’«indole» di questi militari, quanto l’appartenenza al «sistema esercito» inviato per una «giusta causa» (contro il terrorismo), in una «situazione» che nella fattispecie è di guerra. Ma perché un uomo possa uccidere un altro uomo è necessario che lo «de-umanizzi», che lo riduca a «cosa», in modo che non appaia più come un suo simile, perché solo così può trovare la forza di togliergli la vita. A ciò concorre il patriottismo, che spesso è solo una forma appena velata di autovenerazione collettiva, perché esalta la nostra bontà, i nostri ideali, la nostra clemenza e la perfidia di chi ci odia. Creando un quadro in bianco e nero, la guerra sospende il pensiero, soprattutto il pensiero autocritico, e, così mitizzata, diventa una divinità che, come ci hanno insegnato gli antichi greci, per essere adorata esige sacrifici umani. Ma oltre all’autovenerazione per noi stessi, la guerra ci impone di svilire il nemico, per cui veneriamo e piangiamo i nostri morti e restiamo stranamente indifferenti a quelli che ammazziamo noi. I nostri morti e i loro morti non sono uguali. I nostri morti contano, i loro no. Di fatto la guerra scatena la nostra latente necrofilia, non solo perché ammazza, ma perché richiede a ciascun combattente una certa familiarità con la propria morte. La necrofilia è fondamentale per il mestiere delle armi, così come lo è per la formazione dei kamikaze. Essa getta in quello stato di frenesia in cui tutte le vite umane, compresa la nostra, sembrano secondarie e soprattutto insignificanti. Oltre alla necrofilia, la guerra scatena la lussuria più sfrenata, carica di un’energia sessuale cruda e intensa che ha il sapore della voluttà autodistruttiva della guerra stessa. Perché in guerra gli esseri umani diventano cose, cose da distruggere o da usare per gratificazioni carnali. Quando la vita non vale niente, quando non si è sicuri di sopravvivere, quando a governare gli uomini è la paura, si ha la sensazione che a disposizione rimane solo la morte o il fugace piacere carnale. Dopo la guerra c’è l’immane fatica per guarire le ferite che non sono solo quelle fisiche. E c’è chi non ce la fa, e sono i più, perché tutto ciò che era familiare diventa assurdamente estraneo, e il mondo, a cui si sognava di tornare, appare alieno, insignificante al di là di ogni possibile comprensione. L’accumulo di distruttività, vista e seminata, diventa autodistruttività che non conosce limite. A questo punto vale ancora la contrapposizione tra il bene e il male? E davvero noi possiamo dividerci in buoni e cattivi? O, come sostiene Zimbardo, la nostra ferocia non è tanto da attribuire alla nostra indole, quanto piuttosto al sistema di appartenenza e alla situazione concreta in cui ci si trova a operare? Se così è, vero eroe non è chi compie le azioni più rischiose o più feroci che i posteri magnificheranno, ma chi sa resistere al sistema di appartenenza o alla situazione concreta che gli chiedono quelle azioni. L’avvertimento di Zimbardo è ovviamente rivolto a tutti noi che, in un modo o nell’altro, sempre ci troviamo in un qualche sistema di appartenenza o in qualche situazione che ci chiede di scegliere se stare o non stare al gioco. Di fatto la guerra scatena la nostra latente necrofilia, non solo perché ammazza, ma perché richiede a ciascun combattente una certa familiarità con la propria morte. La necrofilia è fondamentale per il mestiere delle armi, così come lo è per la formazione dei kamikaze. Essa getta in quello stato di frenesia in cui tutte le vite umane, compresa la nostra, sembrano secondarie e soprattutto insignificanti. Oltre alla necrofilia, la guerra scatena la lussuria più sfrenata, carica di un’energia sessuale cruda e intensa che ha il sapore della voluttà autodistruttiva della guerra stessa. Perché in guerra gli esseri umani diventano cose, cose da distruggere o da usare per gratificazioni carnali. Quando la vita non vale niente, quando non si è sicuri di sopravvivere, quando a governare gli uomini è la paura, si ha la sensazione che a disposizione rimane solo la morte o il fugace piacere carnale. Dopo la guerra c’è l’immane fatica per guarire le ferite che non sono solo quelle fisiche. E c’è chi non ce la fa, e sono i più, perché tutto ciò che era familiare diventa assurdamente estraneo, e il mondo, a cui si sognava di tornare, appare alieno, insignificante al di là di ogni possibile comprensione. L’accumulo di distruttività, vista e seminata, diventa autodistruttività che non conosce limite. A questo punto vale ancora la contrapposizione tra il bene e il male? E davvero noi possiamo dividerci in buoni e cattivi? O, come sostiene Zimbardo, la nostra ferocia non è tanto da attribuire alla nostra indole, quanto piuttosto al sistema di appartenenza e alla situazione concreta in cui ci si trova a operare? Se così è, vero eroe non è chi compie le azioni più rischiose o più feroci che i posteri magnificheranno, ma chi sa resistere al sistema di appartenenza o alla situazione concreta che gli chiedono quelle azioni. L’avvertimento di Zimbardo è ovviamente rivolto a tutti noi che, in un modo o nell’altro, sempre ci troviamo in un qualche sistema di appartenenza o in qualche situazione che ci chiede di scegliere se stare o non stare al gioco. Zimbardo (2007), Lucifero, tr. it. 2008, Raffaello Cortina – Prefazione Vorrei poter dire che scrivere questo libro è stato per me un piacere; ma non lo è stato un solo istante dei due anni che mi ci sono voluti per portarlo a termine. Anzitutto, è stato emotivamente doloroso rivedere tutte le videoregistrazioni dell'Esperimento Carcerario di Stanford (ECS) e leggerne e rileggerne le trascrizioni. Il tempo aveva affievolito in me il ricordo di quanta fantasiosa cattiveria avessero dimostrato molte guardie, di quanto avessero sofferto molti prigionieri, e di quanto io fossi stato passivo nel permettere che gli abusi si protraessero così a lungo: un peccato di inerzia. Avevo anche dimenticato di avere già incominciato a scrivere la prima parte di questo libro trent'anni fa, per un altro editore. Ma poco dopo avevo smesso, perché non ero pronto a rivivere quell'esperienza ancora così vicina. Sono felice di non aver perseverato e di non essermi imposto, allora, di continuare, perché il momento giusto è adesso. Ora sono più saggio e capace di affrontare questo difficile compito in un'ottica più matura. Inoltre, le analogie tra gli abusi perpetrati a Abu Ghraib e gli avvenimenti dell'Esperimento Carcerario di Stanford hanno conferito più validità a quella nostra esperienza, la quale a sua volta illumina le dinamiche psicologiche che hanno contribuito a produrre i raccapriccianti abusi di quel vero carcere. Un secondo fattore emotivamente pesante che mi ha impedito di scrivere è stato ritrovarmi personalmente e intensamente coinvolto nello studio approfondito degli abusi e delle torture di Abu Ghraib come consulente tecnico per la difesa di una delle guardie carcerarie, appartenente alla polizia militare. Da psicologo sociale mi sono trasformato in reporter incaricato di un'inchiesta. Mi sono impegnato a scoprire tutto ciò che potevo su quel giovane, attraverso colloqui intensivi con lui e conversazioni e scambi epistolari con membri della sua famiglia per ricostruire il suo passato nelle carceri e nell'esercito, nonché con altri membri del personale militare che avevano prestato servizio in quella prigione. Ho finito per provare che cosa significasse essere nei suoi panni durante il turno di notte della sezione Tier 1 A, dalle sedici alle quattro del mattino, ogni notte per quaranta notti, ininterrottamente. In quanto consulente tecnico chiamato a dimostrare, al processo, le forze situazionali che avevano contribuito agli specifici abusi perpetrati dall'imputato, mi era stato dato accesso alle varie centinaia di immagini di depravazione fissate su supporto digitale. Sgradevole e sgradito compito. Mi erano inoltre stati forniti tutti i rapporti allora disponibili redatti da vari comitati d'inchiesta militari e civili. Poiché mi avevano detto che non sarei stato autorizzato a portare al processo appunti dettagliati, avevo dovuto memorizzare quanto più possibile delle loro osservazioni e conclusioni. A quella sfida cognitiva si è aggiunto il terribile stress emotivo dopo che al sergente Ivan "Chip" Frederick è stata comminata una dura condanna e ho assunto l'incarico informale di consulente psicologico suo e di sua moglie Martha. Nel corso del tempo sono diventato per loro lo "zio Phil". Le valutazioni di Fromm sugli esperimenti Milgram e Stanford (da Anatomia della distruttività umana, 1973, tr. it. 1985) • Per Erich Fromm (1973, tr. it. 1985, pp. 78 ss) l’esperimento di Milgram è assai interessante, pure per le connessioni che ha con i fatti della seconda guerra o la storia del tenente Calley e di alcuni suoi subordinati in Vietnam. Egli tuttavia dubita che si possano trarre in maniera così diretta delle conclusioni per quando attiene la vita reale. Infatti lo psicologo è «un rappresentante della Scienza e di una delle più prestigiose istituzioni dell’educazione superiore negli Stati Uniti. Tenuto conto che, nella società industriale contemporanea, la scienza è generalmente considerata il valore supremo, la persona media ha molta difficoltà a credere che essa possa impartire ordini sbagliati o immorali. Erich Fromm (1900-1980), dopo un periodo «freudiano», iniziò a sviluppare una propria visione dell’uomo e delle forze che ne determinano la vita psichica. A suo parere questi è caratterizzato dal suo essere «emerso» dall’unione con la natura e dal dover vivere in quanto individuo separato, cioè libero, col peso che questa libertà comporta. Vivendo, l’uomo dovrà fornire una risposta al problema della libertà, cercando nuovamente l’unione (con la natura, con gli altri, con la vita); potrà farlo o «regredendo» verso forme di appartenenza simbiotiche o «progredendo» verso forme mature di unione, caratterizzate dallo sviluppo della propria individualità e dalla produttività a tutti i livelli: interpersonale (amore, solidarietà), cognitivo (creatività), personale (integrità), spirituale (biofilia). La distruttività, quando non abbia come obiettivo la difesa e la sopravvivenza, ma sia un «tratto di personalità», viene vista da Fromm come un fallimento dello sviluppo con il quale l’uomo, non riuscendo a ad amare, a creare e a «essere», possiede («avere»), domina e distrugge. • Un altro elemento ha destato l’attenzione degli sperimentatori: la grande tensione che manifestavano i soggetti. Per Fromm, lo sperimentatore si aspettava che «ciascun soggetto semplicemente interrompesse, oppure continuasse secondo il diktat della propria coscienza». Ma, si chiede Fromm, è questo il modo in cui la gente risolve i propri problemi o non costituisce piuttosto la «tragedia» del comportamento umano il non affrontare i conflitti, non scegliendo consapevolmente fra ciò che si desidera fare, per paura o avidità, e quello che la coscienza proibisce di fare? L’individuo spesso rimuove la consapevolezza del conflitto con la razionalizzazione, sicché il conflitto si manifesta solo inconsciamente, con un aumento di stress, di sintomi nevrotici, di sensi di colpa ingiustificati. Sotto questo aspetto i soggetti di Milgram si comportano in modo del tutto normale. • Inoltre, argomenta ancora Fromm, Milgram pensa che i soggetti si trovino in una situazione conflittuale, perché intrappolati fra l’ubbidienza all’autorità e gli schemi di comportamento appresi dai tempi dell’infanzia, che recitano: «non far del male al prossimo». Ma è questa la verità? Abbiamo imparato a «non far del male al prossimo» Forse questo lo si dice ai bambini durante il catechismo. Ma nella vera scuola della vita i giovani imparano che devono perseguire il proprio vantaggio anche a scopo degli altri. (p. 79) • La scoperta più importante, continua Fromm, è l’intensità del contrasto che le persone ebbero nei confronti del comportamento violento. Certo, il 65% si comportò con crudeltà, ma la maggior parte manifestò chiaramente una reazione di indignazione o di orrore contro tale comportamento sadico. Purtroppo Milgram non fornisce i dati di coloro che rimasero completamente calmi durante l’esperimento: erano sadici o talmente alienati e psicopatici da non essere capaci di provare qualsiasi tipo di reazione morale? Quelli che manifestarono reazioni forse non erano né sadici né distruttivi. → Fromm conclude che… il risultato principale emergente dallo studio di Milgram sembra essere proprio quello che lui non enfatizza: la presenza di una coscienza nella maggior parte dei soggetti e la loro sofferenza quando erano costretti ad agire contro questa coscienza. Così, mentre l’esperimento può essere interpretato come un’ulteriore prova della facile disumanizzazione dell’uomo, le reazioni dei soggetti dimostrano invece il contrario: la presenza di forze intense che rendono la crudeltà intollerabile. (p. 80) • Relativamente all’esperimento Stanford, Fromm dice: Lo scopo dell’esperimento era quello di studiare il comportamento di gente normale trasportandola, in una situazione particolare, e cioè dentro un «carcere per finta», a recitare rispettivamente il ruolo di guardie e detenuti. Secondo gli autori, l’esperimento conferma la loro tesi centrale per cui, inserendosi semplicemente in una certa situazione, molti, forse la maggioranza, possono essere condizionati a fare praticamente qualsiasi cosa, a dispetto della loro morale, delle loro convinzioni e valori personali (Zimbardo, 1972); più specificamente, durante questo esperimento, la situazione del carcere trasformò la maggior parte di coloro che indossavano la divisa di detenuti in uomini sottomessi, abietti, spaventati, al punto che alcuni dovettero essere congedati dopo qualche giorno a causa di pesanti squilibri mentali. In realtà le reazioni di entrambi i gruppi furono così intense da provocare dopo sei giorni l’interruzione dell’esperimento, che doveva invece durare due settimane (p. 81). • Fromm ha dubbi che l’esperimento abbia confermato la tesi comportamentistica per le seguenti ragioni: Nonostante i soggetti fossero stati preavvertiti che aderendo all’esperimento dietro compenso avrebbero trascorso un periodo di 2 settimane in carcere, sottoposti a test psicologici, informati della mancanza di intimità che avrebbero patito, della possibilità di scegliere il ruolo di guardia o carcerato ecc. le informazioni che venivano loro fornite erano più «edulcorate» rispetto a ciò che avrebbero dovuto effettivamente affrontare. – Ad esempio, cita Fromm da Zimbardo, è vero che ai detenuti era stato detto di «tenersi pronti» ma, quando poi venne il momento di iniziare l’esperimento, con la collaborazione della polizia di Palo Alto, furono «arrestati» senza preavviso nelle loro residenze, furono accusati di essere colpevoli di rapina a mano armata, ammanettati, perquisiti da capo a piedi, spesso sotto lo sguardo incuriosito dei vicini, bendati e condotti nella prigione (che era collocata nell’università di Stanford). Per tutta la durata della procedura di arresto, gli ufficiali di polizia mantennero un atteggiamento formale, serio, evitando di rispondere a qualsiasi richiesta di chiarificazione sul rapporto esistente fra l’ «arresto» e l’esperienza nella prigione per finta. Arrivato nel carcere, ciascun detenuto fu spogliato, irrorato con un preparato contro i pidocchi e lasciato a nudo per un po’ nel cortile antistante le celle. Rivestito con l’uniforme e messo in cella, con l’ordine di stare zitto. – Come potevano sapere, osserva Fromm, i detenuti, che l’arresto era finto? Inoltre, riprendendo a citare da Zimbardo, i detenuti avevano delle strane divise, sorta di camicioni, senza biancheria intima, che induceva ad assumere atteggiamenti strani, più femminili che maschili. Attorno alla caviglia c’era una catena e un lucchetto. In testa portavano una calza-copricapo. Tutte misure che inducevano sottomissione e sgomento. – Durante i sei giorni dell’esperimento, cinque detenuti furono rilasciati per lo stato di estrema depressione emozionale, crisi di pianto, furia e ansietà acuta. Lo schema dei sintomi fu lo stesso per i detenuti. Gli altri dichiararono di non voler rinunciare al compenso. Tutti furono felici quando l’esperimento si interruppe anticipatamente. – Le guardie invece erano angosciate dall’interruzione dell’esperimento: erano rimaste coinvolte dal senso di potenza che il ruolo conferiva loro. – Si osservarono delle differenze individuali nelle reazioni: metà dei detenuti sopportò l’atmosfera opprimente e non tutte le guardie arrivarono all’ostilità. Certe furono dure ma leali («osservarono le regole del gioco»), altre si spinsero ben al di là del loro ruolo, diventando crudeli; altre rimasero passive e non esercitarono un controllo coercitivo sui detenuti. • Per Fromm non ci sono indicazioni chiare su quante guardie ebbero un comportamento sadico, quante uno passivo o «leale». La mancanza di dati precisi e circostanziati è deprecabile anche perché in una comunicazione successiva Zimbardo fece dichiarazioni diverse: calcolava in circa 1/3 le guardie attivamente sadiche; i restanti 2/3 erano suddivisi fra guardie «dure ma leali» e «buone dal punto di vista dei detenuti, dato che facevano loro dei piccoli favori ed erano amichevoli», descrizione ben diversa dall’essere «passive». • Per Fromm è rimarchevole che nonostante l’atmosfera opprimente i 2/3 delle guardie non commisero atti di sadismo e quindi l’esperimento conferma il contrario di ciò che propone dimostrare. Inoltre, per Fromm, un conto è comportarsi secondo regole sadiche, altro è diventare sadico. «L’assenza di questa distinzione priva l’esperimento di gran parte del suo valore, così come ha stravolto l’esperienza di Milgram» (p. 86)
Scarica