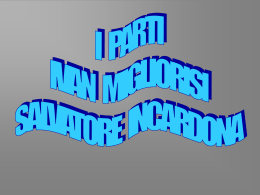Umberto Occhialini OFM Io o ho un nome, è il mio nome. Anche altri porteranno lo stesso nome, ma per ognuno di noi quello è il nome mio, il nome che mi designa, mi identifica, mi distingue dagli altri, fa di me un soggetto unico, una persona inconfondibile, soggetto e oggetto di amore o di odio, di onore o disprezzo, di scelta o dimenticanza, di attenzione o indifferenza, insomma di tutto ciò che io faccio o subisco. Posso essere un genio o uno sciocco, forte o debole, amabile o detestabile, posso avere qualsiasi qualità, ma io sono io, questo io che porto questo nome, mi presento con questo nome, agisco con questo nome, sono chiamato e designato con questo nome. Non per nulla nella Sacra Scrittura il "nome" assume un grande valore, rappresenta la persona più realisticamente di quanto pensiamo noi, indica la sua natura e la sua funzione e missione: dal nome di Dio rivelato a Mosè, al nome di Gesù predetto dall'angelo, al nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo con cui i credenti dovranno essere battezzati, al nome di Pietro (Kefa) dato da Gesù a Simone. È Dio stesso che chiama per nome: "Abramo!" (Gn 20,18), "Mosè, Mosè!" (Es 4,4), "Samuele" (1 Sam 3,4). Ma c' è un brano del vangelo di Giovanni che riguarda tutti noi. Quando Gesù si propone come il pastore buono che dà la vita per il gregge, dice che "egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori" (Gv 10,3). Anch'io quindi, pecorella del gregge di Cristo, vengo chiamata per nome dal mio Pastore. Chiamati per nome da Dio, chiamati per nome da Gesù: quali considerazioni trarre da questa verità? La più stupefacente, la più consolante, è che agli occhi di Dio io non sono uno nella massa, non sono uno qualsiasi: sono un suo figlio, amato Dio chiama per nome Abramo, Mosè, Simone… e chiama anche me. personalmente, amato per me stesso. Il mio rapporto con lui è unico, incomunicabile, non è e non può essere quello di nessun altro. Il Signore fin dall'eternità mi ha chiamato e mi chiama per nome: io sono tu per lui e lui è tu per me; il suo amore per me attende il mio amore per lui, non l'amore che hanno gli altri, ma il mio, proprio il mio. E se io non accolgo e non gli dono amore, egli continua ad amarmi, ma il mio rapporto unico, incomunicabile, con lui resta compromesso e può rimanere compromesso per sempre: l'olio per la lampada delle vergini stolte non può essere chiesto in prestito a quelle prudenti. La stessa cosa accade nel nostro rapporto con Cristo, nostro pastore e redento re. Certamente Gesù è il pastore di tutti, il redentore di tutti, ha dato la vita per tutti, dona a tutti il suo corpo e il suo sangue. Non pensiamo però che davanti ai suoi occhi, davanti al suo cuore, si estenda una massa anonima, l'umanità o l'uomo astratto. Su ognuno di noi si posa il suo sguardo, ognuno di noi è chiamato per nome. San Paolo sa bene che "tutti hanno peccato, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù" (Rm 3,23-24). Ciò non toglie che esclami: "Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me" Gai 2,20). "Mi ha amato e ha dato se stesso per me": sono autorizzato, anzi sono costretto a credere che se io fossi l'unico peccatore del mondo, Gesù si sarebbe incarnato e si farebbe crocifiggere da me, per salvarmi. Non si è identificato con il pastore che lascia le novanta nove pecore al sicuro nel suo ovile e va in cerca dell'unica pecora smarrita? Forse che un buon padre o una buona madre non sono disposti a sacrificarsi per un solo figlio come lo sono per dieci figli? Non è la stessa cosa pensare che tra i miliardi di peccatori lavati dal sangue di Cristo c'è anche uno sconosciuto che sono io, o pensare che quel sangue è stato versato tutto per me con inconcepibile carità. E sono io che dovrò rispondere all'amore di Gesù con inesprimibile riconoscenza e incondizionato amore. Se la fede, la certezza, di essere chiamati per nome da Dio, di essere amati personalmente da colui che "per me" ha dato a vita fosse ben radicata in noi, non ci rammaricheremmo di non essere presi in considerazione, magari di non essere nessuno per gli altri. Quando c'è il Signore con me, cosa mi può mancare, cosa posso desiderare di più grande, di più consolante, di più rassicurante? Si potrebbe obiettare che l'accentuazione del rapporto unico interpersonale tra Dio e il singolo fedele favorisca l'intimismo e faccia dimenticare la dimensione comunitaria della fede e della vita cristiana. Se tutto questo dovesse avvenire, non crediamo che avverrebbe a causa della coscienza di essere amati da Dio ed essere in comunione d'amore con lui ciascuno personalmente, inconfondibilmente. Una tale consapevolezza deve piuttosto portare a considerare tutti gli altri amati così da lui. Come è scritto nel vangelo: "Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli" (Mt 18,10). Così, se Gesù chiama ogni pecora per nome, dice pure: "E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore" (Gv 10,16). Il gregge di Cristo è la sua Chiesa e la Chiesa non è una massa, ma una comunione di credenti, ciascuno è piccola parte dell'unico corpo di Cristo, tutti nutriti dell'unico pane di vita: "Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all'unico pane" (lCor 10,17). Il rapporto personale con Cristo non impedisce neppure minimamente l'impegno apostolico del cristiano. Ricordiamo che la prima apparizione del Risorto è stata riservata a una donna che sola cercava il corpo dell'amato Maestro al sepolcro. E soltanto quando Gesù la chiama per nome: "Maria" (Gv 20,18), ella lo riconosce e per prima è inviata ad annunziare ai fratelli di aver visto il Signore. È la prima testimone della sua risurrezione. Gesù chiama singolarmente le pecorelle, che sono le membra della sua Chiesa
Scaricare