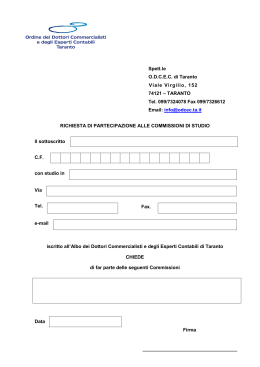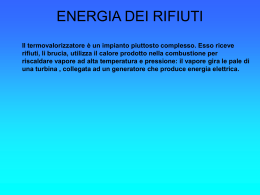Focus Ambiente Storie di soprusi, di ambiente devastato e di lotte per preservare tutto quello che ci circonda: Italia, mondo, multinazionali e comitati cittadini www.firstlinepress.org Per i rifiuti si sceglie la strada breve: bruciarli nei cementifici Redazione | 31 gennaio 2013 Cementifici e spazzatura: parola al prossimo Parlamento. Cos’è “Legge Zero Rifiuti”? Lorenzo Giroffi | 12 febbraio 2013 Di certo non sono attesi slanci di onestà in campagna elettorale e neanche una silenziosa consapevolezza a riguardo della salute dei cittadini. Tuttavia il Decreto Presidenziale dello scorso 26 Ottobre, che regolamenta la combustione dei rifiuti negli impianti adibiti a cementifici, andrebbe discussa pubblicamente, oltre ogni retorica. Il campo è sempre il solito: gli interessi di chi nasconde le soluzioni attaccando isterici ambientalismi. Un precedente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, del Luglio 2012, aveva già liberalizzato la produzione di energia prodotta da impianti a biomassa agricola. Ad Ottobre però si è andato oltre l’utilizzazione energetica derivante dal combustibile derivato rifiuti (C.D.R.), che ha trovato un nuova definizione C.S.S. (combustibile solido secondario), che non ha più una classificazione da rifiuto urbano, ma da rifiuto speciale, quindi non è più obbligatorio smaltirlo all’interno dei confini regionali, dove è stato prodotto, perché considerato vero e proprio prodotto industriale, libero di circolare e pronto a sostituire i combustibili che tradizionalmente finivano all’interno dei cementifici. Tutto ciò sembra una tremenda scorciatoia, che da un lato limita l’avvio industriale del riciclaggio e dall’altro dà ai cittadini l’ennesima certezza di avvelenamento, con polveri sottili nell’aria e patologie cancerogene già note a chi vive nei pressi di cementifici, pronti a bruciare anche rifiuti. Non che gli inceneritori siano rose prive di rischi, ma addirittura bruciare rifiuti lì è meno dannoso che farlo nei cementifici, perché almeno dotati di sistemi che eliminano in parte le polveri. Inoltre gli inceneritori hanno anche limiti di emissioni più alti. Molti cementifici in Italia sono a ridosso di centri abitati, come Barletta e Taranto in Puglia, Rezzato in Lombardia, Maddaloni in Campania, Coleferro nel Lazio e Monselice in Veneto, pronti a far riesplodere nuove contaminazioni. Centocinquanta associazioni locali, regionali e comitati cittadini hanno indetto una campagna nazionale, “Legge Rifiuti Zero”, che è pronta a lottare per bloccare il decreto, che deve passare l’esame della Commissione Ambiente, con al vaglio anche il Testo di Legge Iniziativa popolare che fino al 2020 prevede la moratoria per inceneritori e cementifici che utilizzano rifiuti. www.zerowastelazio.it è il sito web della campagna Siamo in settimane dense di storicità, tra chi si dimette anacronisticamente e chi è pronto a proporsi come salvatore dello Stivale. Poco interessanti per le pagine di storia, ma decisive per le vite umane, la quotidianità di decreti legge che mutano la vivibilità del Paese. Nelle scorse settimane vi abbiamo scritto di un decreto legge, passato al passo d’addio dei tecnici, che potrebbe rendere protagonisti i cementifici italiani, oltre che dei danni già prodotti al territorio, dello smaltimento dei rifiuti. Affinché i membri della Commissione Ambiente del Parlamento fossero sensibilizzati sono stati contattati, con un modello preformato, via e-mail, da tanti e forse decisivi liberi cittadini, volenterosi di bloccare sul nascere questa possibilità. Lunedì 11 Febbraio il decreto è stato bloccato dalla Commissione, che dunque ha negato la possibilità ai cementifici di incenerire rifiuti, anche se, più che una bocciatura, è stato solo un rinvio. Infatti il decreto dovrà essere discusso e vagliato dal Parlamento che si insedierà dopo le elezioni del prossimo 24 e 25 Febbraio. Dall’incapacità o dalla netta volontà di distanza di chi detiene il potere decisionale è sempre più scontata la nascita di una rivalsa popolare, fatta di proposte e scenari legislativi alternativi. È così partita la campagna nazionale “Legge Zero Rifiuti”. Incontriamo Massimo Piras di No Waste Lazio, per capire cosa quest’iniziativa popolare proponga e per porre anche una lente d’ingrandimento sugli scenari dei cementifici in supporto degli inceneritori. Cosa propone la campagna “Legge Zero Rifiuti”? <<L’iniziativa è partita lo scorso giugno, dopo un lungo periodo di elaborazione. Ci prefiggiamo un sentiero nuovo in Italia, che possa raccogliere la risoluzione europea del 24 maggio, che ben pochi conoscono, ma che in pratica pone fine, entro il 2020, a tutte le discariche ed inceneritori. Questa risoluzione è stata votata dal Parlamento Europeo, quindi anche dall’Italia. Tutto ciò è il primo passo per il settimo piano d’azione proposto dalla Comunità Europea, che fisserà le nuove linee di raccolta e riciclo, perché la prospettiva futura è proprio indirizzata verso il recupero di materia, che sostituirà quello di energia, divenuto secondario. In Italia siamo ancora all’anno zero e per noi è importante fermare subito tutti gli inceneritori presenti, perché quando si va a 2 smaltire in questi tipi di impianti si brucia solo un terzo di tutto, gli altri due li si porta in discarica, dunque l’operazione di smaltimento, che è definita ultima operazione, diventa quella decisiva, perché si salta il riuso ed il riciclo. Sostanzialmente si è fatta dell’illegalità una legge>>. Questa campagna però deve fare i conti con i tanti incentivi di cui gode l’ingranaggio dei termovalorizzatori … <<I certificati verdi e gli incentivi economici per questo tipo di impianti, diramati lo scorso anno con un Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico, Corrado Passera, vengono abrogati dalla nostra proposta di legge. Di contro proponiamo incentivi al riciclo ed al recupero, basandoci su due capisaldi: è fondamentale una moratoria per l’incenerimento, perché, come dice l’Europa, se nel 2020 dovremo chiuderli, abbiamo a disposizione soli sette anni e quest’impianti hanno bisogno di 15-20 anni di ammortamento di capitale, quindi è irragionevole andare ad autorizzare impianti che tra sette anni andranno chiusi; proponiamo che il CONAI, il consorzio nazionale di imballaggi, esca fuori dalla logica monopolistica. Ad oggi il CONAI sta abbassando i costi delle materie prime, ma a nostro avviso questo consorzio non può restare all’interno di un percorso chiuso. C’è la necessità di una remunerazione, al pari della media europea, delle materie prime e seconde riciclate. Dobbiamo creare le condizioni per avere un mercato economico all’interno di questo settore: chiudere agli incentivi alla distruzione ed aprire agli incentivi sui recuperi>>. restare avvinghiati a tali introiti. Sui motivi invece che hanno spinto a tirare in ballo i cementifici, possono essere riconducibili alle difficoltà di costruire nuovi inceneritori, perché molti comitati cittadini stanno impedendo, con ricorsi anche ai vari TAR, tali operazioni o comunque le rallentano. Questo provvedimento invece avrebbe già cinquantasei impianti funzionanti ed a disposizione, che con la solo comunicazione, perché non c’è più bisogno dell’autorizzazione integrata ambientale (la valutazione di impatto ambientale non è più obbligatoria) potrebbero bruciare rifiuti. Così facendo i cementifici guadagneranno ancora di più con i certificati verdi, lucrando nel tempo previsto (quindici anni) e continuando a contaminare l’ambiente con diossina ed altri composti organici>>. Eppur si brucia: cementifici e spazzatura Lorenzo Giroffi | 9 aprile 2013 Come si è arrivati a quella che appare una semplificazione della gestione rifiuti in Italia: affidarsi ai cementifici? <<Non ha alcun senso dare autorizzazioni ai cementifici per la distruzione dei rifiuti, perché questi sono ancora più dannosi. Gli inceneritori hanno una normativa più stringente per le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto, zolfo e diossina. I cementifici invece non hanno dei sistemi filtranti. Questo è molto pericoloso, perché su tutto il territorio abbiamo cinquantasei cementifici, di cui molti inseriti nel tessuto urbano: è un attacco alla salute! Un decreto dell’ex Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, diede ai CSS, combustibili solidi secondari, una legittimazione a circolare, essendo rifiuti speciali e non più urbani. I rifiuti, prima di questa modifica, andavano gestiti nell’ambito regionale, perché i CDR, combustibili derivati dai rifiuti, non potevano circolare liberamente, vista la loro natura di rifiuti urbani selezionati. Invece con questo marchingegno tecnologico, tramutando i CDR in CSS, si è fatto in modo di creare un nuovo tipo di carbone o petrolio sintetico, spendibile e bruciabile ovunque. Con la nostra proposta di legge chiediamo che il CSS ridiventi rifiuto urbano, quindi non libero di circolare e che sia vietata la combustione in quanto tale. È stato dimostrato che compiere tutto ciò in cementifici, inceneritori o centrali termoelettriche è un processo economicamente svantaggioso e dannosissimo per l’ambiente. Noi invece ci battiamo affinché si giunga alla chiusura ed al blocco di tutti questi impianti, che dovranno subire una riconversione impiantistica>>. Perché si è intrapresa nuovamente una strada contraria ad un ciclo di rifiuti proiettato verso il futuro e che è utile solo ad un certo tipo d’industrializzazione del settore? Al di là degli ovvi interessi economici, quali sono i motivi del ripescaggio dei cementifici per risolvere l’emergenza rifiuti? <<C’è una lobby industriale che guadagna solo dall’assistenza pubblica dei contributi. Questi soggetti non possono perdere il loro giro d’affari e chiaramente si studiano tutti i mezzi per Video-reportage disponibile nel canale FirstLinePress al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=MtFwA3aBk9I Youtube In Italia si discute sulla velocità dei tempi della politica, ma oltre ogni dissertazione, i suoi provvedimenti scorrono. Un decreto passato in sordina, perché a “fine” Legislatura Monti, potrebbe dare ai cementifici presenti in Italia (Paese europeo col più grande numero di impianti operativi) parte della gestione dei rifiuti. I cementifici potrebbero fungere da inceneritori, ma quali i rischi? Perché si potrebbe adottare questa soluzione? Il decreto ha ricevuto una valutazione negativa da parte della Commissione Ambiente del Parlamento, ma il parere non è vincolante e quindi tale decreto Clini dovrà essere perpetuato o bloccato dal prossimo Esecutivo. Il video-reportage Eppur si brucia: cementifici e spazzatura viaggia in Italia tra pareri medici e proposte dalla cittadinanza attiva, fino a fermarsi nel territorio della provincia di Caserta, lì dove ci sono due cementifici, che possono rendere chiara l’incidenza della loro attività, al di là del possibile impiego nel ciclo dei rifiuti. Per non dimenticare mai quante piccole Ilva ci siano in Italia e quanto le emergenze non scoppino 3 casualmente od improvvisamente. Di seguito sono disponibili i testi elaborati dalla Commissione Ambiente inerente alla valutazione del provvedimento: Commissione_Ambiente_-_Camera_-_Atto_529__Resoconti_11Febb2013 Commissione_Ambiente_-_Camera_-_Atto_529__Resoconti_22genn2013 Veolia: tra Palestina e boicottaggi a Londra Lorenzo Giroffi | 20 novembre 2012 collegare direttamente Gerusalemme ai territori occupati dagli israeliani. In Cisgiordania Veolia gestisce già tre linee di autobus, su cui però, e qui torna l’apartheid, i palestinesi non possono viaggiare. A parte la vicinanza umana, perché una campagna di boicottaggio a Londra potrebbe influire sugli affari di Veolia in Palestina? Un gruppo di abitanti della capitale britannica fino al 6 Dicembre ha organizzato una serie di appuntamenti, dinanzi a luoghi strategici, per sensibilizzare le istituzioni dell’area nord della città. Tutto questo perché il 6 Dicembre potrebbe siglarsi un accordo tra le municipalità nord della città di Londra e per l’appunto la multinazionale francese. L’appalto farebbe rientrare nelle casse di Veolia 4,7 miliardi di sterline, quindi ecco che il collegamento è ottenuto: Londra-Palestina (questi milioni sarebbero utilizzati anche nella costruzione della metropolitana menzionata precedentemente). I promotori della protesta vogliono sensibilizzare i consiglieri della loro città affinché possano essere consapevoli delle politiche adottate da questa compagnia in Palestina e rendere così impossibili accordi con essa. Le retoriche sulle multinazionali, sugli agenti invisibili che lentamente stanno deteriorando gli Stati nazionali, sull’impunità di chi ha affari in mezzo mondo, lasciando le sedi centrali delle proprie imprese pulite nella parte ricca dell’emisfero, sono già zeppe di cantori, quindi ogni precisazione sarebbe di troppo. È certo però che l’apartheid ed i soprusi non possono fare a meno di lotte congiunte tra politica e decisioni economiche. Per potersi sentire detentori di democrazia, ammesso che questa abbia una denotazione ben definita, bisogna compiere scelte democratiche. Servizio video disponibile all’interno del canale Youtube FirstLinePress: http://www.youtube.com/watch?v=ebocZQBLH94 (nei sottotitoli del video compare “accordo per 4,7 milioni di sterline” è un refuso perché sono 4,7 miliardi di sterline) Ci sono attori economici che esagerano e coi loro affari toccano sia il sud che il nord del mondo, sia i ricchi che i poveri, trascinando su di loro i proventi e le perdite del mercato mondiale, la soddisfazione dei suoi manager e le sofferenze di chi subisce e forse denuncia. Veolia, la spazzatura di Londra ed i diritti umani in Palestina Lorenzo Giroffi | 29 gennaio 2013 Impossibile tracciare un profilo dettagliato su tutti gli affari compiuti da Veolia, che apre il suo raggio alla depurazione di acqua, alla gestione di spazzatura, ma che si occupa anche del trasporto pubblico e di opere infrastrutturali, come fognature, insomma una multinazionale che ha molti multi e che magari ottiene ottimi risultati, tenendosi al passo con le misure ambientali, ma che, come se non fossero passati anni di lotte e di diritti civili consolidati, continua a elaborare piani aziendali in sintonia con l’apartheid. Non è un articolo datato, proveniente magari dal Sudafrica, ma è purtroppo specchio di quanto succede ad oggi in Palestina. La Veolia in quella terra tormentata controlla i servizi idrici per gli abitanti israeliani ed importa spazzatura, prodotta da questi ultimi, nei campi occupati dai palestinesi nella Valle del Giordano. La francese Veolia, che a dire il vero in questo momento finanziariamente non se la passa proprio bene, in Palestina dirige anche il sistema dei trasporti pubblici. Sta pianificando la costruzione di una linea metropolitana leggera per Il servizio video è disponibile nel canale Youtube FirstLinePress al seguente indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=I77ONWdVM48 Inevitabilmente le campagne di boicottaggio verso colossi aziendali, per i possessori di concretezza, si portano dietro sempre un peso d’inconsistenza, fatto di poca lucidità, troppi ideali e 4 mancanza di consapevolezza degli interessi da smuovere. È impossibile elencare tutti gli affari che la francese Veolia compie in giro per il mondo (opera in 77 Paesi), con un giro largo di tutto quello che è il servizio pubblico, lì dove il privato può metterci le mani: servizi idrici, trasporti pubblici e gestione dei rifiuti. Non è un periodo felice per questa multinazionale tutto fare, che economicamente ha dovuto fare i conti con un collasso, frutto di sanzioni e di ammanchi di alcune filiali statunitensi. In particolare per Veolia il Regno Unito in questi ultimi anni, dopo essere stato terreno di conquista e di diversificazioni d’affari (per le varie sfere in cui opera), non è stato proprio un campo agevole: è stata inseguita eticamente già a seguito dell’ustione di un proprio lavoratore all’interno di un impianto presente a Deptford (nel sud di Londra); ha dovuto svendere tre aziende idriche per crisi economica; si è vista contro una campagna mediatica che ha visto coinvolti anche esponenti di spicco delle Nazioni Unite. Perché liberi cittadini di Londra ad un certo punto hanno trovato la forza di unirsi e di opporsi a Veolia? Ritornando all’incipit iniziale, le campagne di boicottaggio per essere efficaci devono dotarsi di strumenti di comprensione per la comunità che abita il territorio. First Line Press nei mesi scorsi ha seguito alcune delle manifestazioni di questa campagna, svoltesi dinanzi le municipalità di Londra. Qui vi abbiamo già scritto dei motivi per i quali il comitato londinese si oppone agli affari di Veolia nella propria città, che sono legati alle violazioni dei diritti umani che questa compie verso il popolo palestinese, prevedendo, in società con il consorzio Citypass, una linea di metropolita leggera, Gerusalemme Light Rail Transit, che collegherà Gerusalemme con gli insediamenti in Cisgiordania, attraversando territori palestinesi, ma senza che i suoi abitanti possano usufruire di questo servizio, o la discarica, sempre gestita da Veolia, poco rispettosa della salute dei palestinesi nei territori occupati a Tovlan, od ancora le linee di autobus, sempre legate a questa compagnia, che circolano negli insediamenti israeliani. Come ha fatto ad incidere una causa così lontana da Londra? Se si presta attenzione agli angoli delle strade di Londra, nella sua parte nord, oltre i marciapiedi, le luci dei pub, l’odore della pioggia ed i mille suoni di lingue differenti, si possono facilmente vedere raccoglitori di spazzatura, inservienti o camionette con la scritta Veolia ed i suoi loghi. Il legame insomma è ben visibile e proprio nelle municipalità di Londra Nord Veolia aveva in sospeso, pronto per essere siglato, un contratto utile ad ottenere i servizi ambientali e di produzione di combustibile con la North London Waste Authority, che per l’appunto comprende lo smaltimento rifiuti per Enfield, Barnet, Hackney, Camden, Islington, Waltham Forest e Haringhey. Il contratto avrebbe permesso tale gestione per trentacinque anni, con il completo affidamento dell’impianto di gestione dei rifiuti di Pinkham, a New Southgate, che avrebbe voluto dire l’incasso per Veolia di 4,7 milioni di sterline. Cosa si è messo di mezzo quest’affare? Per il movimento di boicottaggio è stato complicato arrivare a coinvolgere una parte consistente della popolazione di Londra spingendo solo sulla sensibilizzazione per la causa palestinese, è stato sicuramente più avvolgente quando ha allargato il proprio focus sulle metodologie di lavoro che Veolia attua nella capitale inglese, rendendo un’opera di informazione su tutto quello che concerne il lavoro dell’azienda. Nella video–intervista a due dei maggiori attivisti londinesi, Yael Kahn, con alle spalle una lunga storia di campagne a favore dei diritti umani in Palestina, e Rob Langlands, ingegnere che per anni ha lavorato nel settore dello smaltimento dei rifiuti, si rende chiara la natura di un progetto che ha dovuto ramificare i propri obiettivi. Il contratto con Veolia non sarebbe stato solo poco etico, ma anche dannoso per la stessa Londra, visto il modo in cui opera la compagnia. Ci sono molti i comitati cittadini in opposizione ad opere di combustione dei rifiuti. Così Rob Langlands:“Bruciare energia per realizzare energia elettrica non è assolutamente salutare, considerando i vantaggi del riciclaggio ed i costi differenti. Dotarsi di alta tecnologia per una buona individuazione dei materiali da riciclare ha un costo elevato solo nella fase iniziale, ovvero quando si deve investire, poi dopo è tutto guadagno. Senza voler parlare delle dinamiche ambientali, che a questo punto possono interessare davvero a pochi”. Veolia è un’azienda che sull’immagine punta molto. I presidi dinanzi gli uffici delle municipalità di Londra; i volantini esplicativi sui crimini di guerra; le parole del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi, Richard Falk, che dichiarò come l’azienda francese è complice di violazioni del diritto internazionale, a proposito del sistema di trasporti progettati, che viola il diritto internazionale umanitario e la quarta Convenzione di Ginevra, articolo 49, per quanto riguarda la protezione delle persone civili in tempo di guerra. Tutto ciò non ha lasciato indifferenti i dirigenti della compagnia francese, che, vedendo sgretolare la propria immagine, con una campagna che da Londra metteva in luce crimini lontani e vicini, hanno preferito tirare via la propria offerta per i contratti con la North London Waste Authority. Sul finire di Dicembre 2012 le municipalità avrebbero dovuto decidere a chi concedere la gestione dei servizi descritti precedentemente e Veolia indubbiamente era la più accreditata, tra le pretendenti, ad intascarsi i 4,7 miliardi di sterline. Tuttavia il progressivo coinvolgimento di alcuni consiglieri delle municipalità alla campagna di boicottaggio ed una protesta che stava portando sempre di più il nome Veolia ad essere associato a qualcosa di dannoso hanno consigliato un mossa di prevenzione del rifiuto: Veolia si è ritirata dalla trattativa. Così, dopo due anni di lotta, il movimento di boicottaggio ha potuto esultare, con la consapevolezza che la sensibilizzazione verso tutti i cittadini è stata possibile anche grazie agli interessi per la propria salute, sicuramente più determinanti per l’immaginario comune, rispetto alle nobili cause dei diritti per i palestinesi. L’attivista Yael Kahn è felice perché oggi qualcuno in più conosce quello che Veolia compie nei territori occupati illegalmente da Israele, anche se la causa palestinese è ancora lontana dagli interessi della politica mondiale: “La gente può riconoscere questa multinazionale comunque come dannosa per la propria comunità. Se l’unico valore che questi colossi conoscono è il profitto, allora le aziende in combutta con i crimini di guerra israeliani soffriranno molto per una pena finanziaria”. In effetti il profitto cercato è realmente sfumato, Al momento non si conosce chi brucerà i rifiuti, ma in fiamme sono già andati i 4,7 miliardi di sterline previste per Veolia. 5 Ilva di Taranto: l’acuto della Un afoso giorno d’estate… Il Comitato magistratura Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti Cosimo La Gioia | 26 novembre 2012 di Taranto Andrea Leoni | 28 marzo 2012 Sette arresti ed ennesimo ricatto: “Chiudiamo il sito di Taranto”. Si è rotto il silenzio che da qualche tempo avvolgeva l’operato della Magistratura tarantina: come un colpo di mannaia, oggi gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito 7 arresti nei riguardi dei vertici della società Ilva S.p.A, di politici e funzionari pubblici (Fabio Riva vicepresidente del Gruppo, Girolamo Archinà ex Responsabile delle relazioni esterne, Michele Conserva ex Assessore all’Ambiente della Provincia, Lorenzo Liberti ex Preside della Facoltà di Ingegneria e Consulente della Procura di Taranto, il patron Emilio Riva, Luigi Capogrosso ex direttore dello stabilimento, Carmelo Delli Santi rappresentante della Promed Engineering). L’accusa è di associazione a delinquere, disastro ambientale e concussione. Parallelamente a tale inchiesta, le Fiamme Gialle si sono portate sul luogo del Porto di Taranto e hanno proceduto al sequestro di tutta la merce prodotta dall’ILVA: i prodotti non possono essere commercializzati in quanto derivanti da attività produttiva di impianti posti a sequestro giudiziario. Mentre il Procuratore Capo di Taranto Dott. Franco Sebastio in conferenza stampa presso gli uffici della Guardia di Finanza rimarcava l’importanza del diritto alla salute prima del profitto, i vertici ILVA diffondevano un comunicato stampa nel quale hanno dichiarato la loro estraneità alla situazione ambientale ormai compromessa dichiarando la sospensione dell’attività produttiva dalle ore 23.00 di Lunedì 26 Novembre, con riferimento però all’area a freddo (non quella a caldo incriminata per aver provocato l’emergenza sanitaria). Da stasera, circa 6000 operai sono in ferie forzate per mancanza di commesse (strano che tale deficit occupazionale sia coinciso con le decisioni della Magistratura). Intanto cominciano le proteste degli operai e si mobilitano i sindacati che domani incontrano l’azienda. Sciopero selvaggio come quello dello scorso Luglio? Vedremo… Parere condiviso in molti è che oggi abbiamo assistito al primo passo del disimpegno della famiglia Riva a Taranto. Nelle prossime ore, tutto può succedere … Alla fine dell’articolo un’anteprima del fotoreportage disponibile al seguente indirizzo: http://firstlinepress.org/un-afoso-giorno-destate-a-taranto/ Come promesso, torniamo su un’esperienza di movimento che funziona: il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti di Taranto. Si battono per la dignità della città, per i diritti dei lavoratori e dei cittadini nel caso Ilva ed è una vera forza. Abbiamo chiesto loro un’intervista e ci hanno risposto collettivamente a dimostrazione di come, al di fuori di svociate, un movimento dal basso e partecipato da tutti è possibile. Un esempio per tutti quanti e che noi siamo veramente onorati di ospitare. E’ da tempo che seguiamo, con molto interesse, la loro lotta e che grazie al nostro blogger Cosimo La Gioia ha sempre rilievo nel nostro portale. Come nasce il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti? Il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti nasce nell’afoso luglio 2012, quando la firma di due ordinanze da parte della magistratura a seguito dell’incidente probatorio sull’inquinamento causato dall’Ilva, stabilì il sequestro di sei impianti e la custodia cautelare agli arresti domiciliari di otto indagati, portando scompiglio in un’intera comunità. Tra le parole usate dal Gip si legge chiaramente «malattia e morte perché chi gestiva e gestisce l’Ilva ha continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza». I sindacati confederali decisero di proclamare sciopero ad oltranza, invitarono pertanto i lavoratori dell’azienda a bloccare le strade, dalla 106 al ponte girevole, e quindi a seminare ansia e smarrimento all’interno della città. Ed è così che ci siamo trovati, cittadini comuni e operai dello stabilimento siderurgico, armati della stessa sete di risposte ma al contempo spaventati e smarriti. Alcuni dei lavoratori si resero conto che mentre molti bloccavano le strade, impedendo a gente diretta all’ospedale Giuseppe Moscati di compiere il proprio ciclo di terapie e profilassi antitumorale, altri lavoravano producendo a gran ritmo. Ci sentimmo presi in giro ed ancora una volta strumento di questo sistema corrotto che ha spremuto Taranto, così da pochi lavoratori ci ritrovammo poi a discuterne in tanti, stanchi di 6 doverci piegare al ricatto salute o lavoro, stanchi di dover credere che il nostro destino fosse già scritto per i profitti di altri. E così si decise di creare un fronte comune, forte e saldo dove tutte le realtà locali potessero avere voce e creare scambio d’idee. E la prima idea condivisa fu quella di poter prendere parte al comizio dei sindacati FIOM FIM UIL il 2 agosto in piazza della Vittoria. Il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti diventa famoso in tutta Italia dopo l’azione di protesta nella manifestazione dei sindacati che cercavano il loro palchetto. Vengono zittiti da un apecar: come ricordate quell’episodio? L’esperienza di quella mattinata, e delle giornate che la precedettero, rimane impressa nella pelle di chiunque vi abbia preso parte. La notte prima, pochi di noi avranno dormito, eravamo poche decine a stilare il discorso e a parlare di come articolarci in corteo, ma sentivamo che qualcosa sarebbe cambiato. La nostra richiesta di partecipare, faxata il giorno prima all’organizzazione dell’evento sindacale, non fu presa in considerazione. Non pervenne neppure alcuna risposta. Il giorno successivo, sotto un sole cocente d’agosto tarantino, ci siamo ritrovati di fronte l’arsenale e tutti insieme abbiamo iniziato la nostra sfilata in coda al corteo sindacale. E da trenta diventammo quaranta, poi cinquanta, poi cento, tra donne lavoratori studenti e professionisti dietro il nostro treruote a gridare verità completamente cacofoniche in un contesto costruito e per niente genuino come quello in cui ci trovavamo. Poi l’arrivo in piazza, la folla che si apre guardando incuriosita il nostro apecar e ascoltando i nostri cori. La goliardia è diventata frenesia, speranza di poterci fare sentire e bisogno imminente di raccontare a Taranto cosa stesse succedendo all’interno della fabbrica e cosa non sarebbe, invece, dovuto accadere mai più. C’è stato chi addirittura tagliò i cavi del microfono del palco per evitare che noi prendessimo parola sul pulpito, e di questo gesto ha anche incolpato noi. O chi, come i segretari dei sindacati, sparì dalla vista non appena arrivammo. Ma c’era una piazza, gremita di lavoratori e cittadini. E quella piazza ci ha ascoltato: dopo il nostro intervento, per il quale si erano scomodati molti caschi antisommossa (che di fatto però non ebbero ragione di “rompere le righe”), la piazza si svuotò e la gente seguì la nostra scia di novità. Fu una giornata infinita, difficile da dimenticare. Il CCLP è diventato poi sempre più forte: una forte organizzazione dal basso che vede una partecipazione nutrita di gente stanca di sopportare ricatti. Com’è organizzato il CCLP, quali sono le altre organizzazioni (vedi no carbone) o movimenti sociali che stanno supportando la battaglia? Le vostre assemblee sono molto partecipate, un vero esempio di democrazia condivisa o che altro? La forza, maturata nel tempo, del CCLLP si basa sulla consapevolezza che la democrazia rappresentativa non ha mai funzionato e che per rispondere alle esigenze di una città non si possa prescindere dal parere, dalle azioni, di ogni singolo cittadino, il quale attraverso il principio del “IO NON DELEGO, IO PARTECIPO” è coinvolto quotidianamente nel costruire quel percorso di democrazia partecipata e diretta, unica ancora di salvezza e punto di partenza per scenari futuri che solo in questo modo potranno restituire dignità a questa territorio, da troppo tempo ormai abbandonato a scelte imposte, mai condivise, che nei decenni lo hanno del tutto svilito. L’azione del Comitato quindi si fonda proprio sul voler individuare soluzioni alternative e condivise all’attuale modello di sviluppo. La costante partecipazione alle assemblee di cittadini, lavoratori, disoccupati, precari, studenti, ci rende tutti più consapevoli del percorso che andremo a definire, partendo proprio da quelle che sono le esigenze della collettività. Per raggiungere tale obiettivo il Comitato studia e approfondisce le problematiche del territorio per poi vagliare una o più proposte sulle tematiche in questione; le proposte vengono poi discusse in assemblee popolari che rimangono comunque unico contesto di approvazione di qualunque decisione. Più che di organizzazione ci piace parlare di principi basilari, definiti in un’apposita carta, condivisa da chiunque voglia portare il proprio contributo alla stessa causa, e di “modus operandi”: vi è lo strumento unico di valutazione e decisione, l’assemblea appunto, ed i contenuti e riflessioni che in essa fuoriescono, da cui prendono il via le azioni sul territorio, auto-coordinate, mediante gruppi di lavoro che coinvolgono gli stessi cittadini, che a loro volta si gestiscono, in tempi e modalità d’azione, in base agli obiettivi prefissati. Inoltre cerchiamo di diffondere ogni assemblea con tutti i mezzi informativi possibili, per permettere l’espressione del parere anche di chi è fisicamente distante dal luogo dell’assemblea. Infine è’ importante sottolineare ancora una volta che il Comitato non ha leader e non sono riconosciute deleghe permanenti. Ogni delega, per il confronto con le istituzioni, per l’intervento sui media o per qualunque altra occasione, è autorizzata di volta in volta dall’assemblea e i “portavoce” riferiscono quella che risulta essere una posizione comune, questo perché crediamo fermamente che nessuno possa o debba portare da solo il peso della contrapposizione ai gruppi di potere. Il Comitato ricerca e promuove le aggregazioni territoriali, consapevole che ogni città, ogni paese e ogni quartiere ha la propria specificità. In questa direzione va letta la nostra massima apertura al dialogo e al confronto con qualsiasi realtà apartitica, movimenti comitati o centri che siano, si muova in linea con quelli che sono i principi sui quali si basa la nostra azione sul territorio. La condivisione, a livello locale e nazionale (come si è potuto constatare in ogni nostro intervento in contesti distanti e anche differenti) riteniamo sia stimolante, fondamentale e, come già sottolineato più volte, necessaria a quel processo avviato sette mesi fa e che porteremo avanti tutti insieme. Qual è la situazione ora a Taranto e come si sta muovendo ora il CCLP e quali saranno le iniziative a lungo termine? Dopo l’impeto travolgente che il Due Agosto ha investito questa città, ancora all’orizzonte da qualunque angolo ti affacci al mare non puoi non sentirti assediato da fabbriche di morte. Come sempre incontrastato lo scenario più desolante sono le ciminiere sempre in marcia del’ILVA, che mai hanno rallentato la produzione dal 1995 ad oggi nonostante le sentenze del Gip. Ma è impossibile non notare come in lontananza si scorgano tristi e fieri gli altri otto stabilimenti ad alto impatto ambientale che risiedono in quello che un tempo era ilmeraviglioso porto di Taranto: l’ENI, la Cementir la discarica più grande del Mezzogiorno, Italcave, l’inceneritore di Massafra la cui produzione è stata raddoppiata appena un anno fa. La città intera ormai lo sa, la battaglia iniziata il due agosto non potrà dirsi conclusa fino a quando ogni impianto nocivo non lascerà il territorio! Ci siamo interrogati più volte su quale fosse la parola d’ordine, il percorso e la strategia più utile per ridare un futuro alla nostra terra la cui vocazione storica è stata completamente alterata e che vanta il triste primato di vedere i suoi terreni, il suo mare e la sua aria avvelenata fino almeno al ventesimo chilometro dal siderurgico. Siamo per ora convinti che l’unico modo per invertire lo sviluppo assassino imposto a questa provincia sia costruire dal basso una “Vertenza Taranto” non come quelle fin ora propinate dalle istituzioni, ma una linea guida che porti la città ad interrogarsi su quali siano le 7 reali necessità ed esigenze e che produca conseguentemente un percorso attivo di e con tutti i cittadini per costruire nuove forme alternative di lavoro che valorizzino il percorso turistico, culturale e storico di quella che fu una delle città più importanti della Magna Grecia. In questa vertenza affronteremo il problema delle bonifiche, che non potranno essere espletate fino a quando le fonti inquinanti non cesseranno di esistere, cercando di incanalare le competenze e le conoscenze dei cittadini per dare il via a un percorso di sviluppo di comunità che produca nella pratica autonomia e autogestione da parte dei cittadini del loro bene comune: Taranto. Il Primo Maggio 2013 abbiamo deciso di costruire un palcoscenico per questa Vertenza, un luogo in cui con autentica oggettività si riconosca la crisi del mercato del lavoro italiano e si cominci a pensare alla costruzione di modelli di sviluppo differenti che siano più in armonia con il territorio e che gli permettano di vivere e svilupparsi e soprattutto che non siano mera pratica di sfruttamento da contorni post-coloniali che tanto caratterizza anche altre situazioni simili alla nostra nel Sud. Il Primo Maggio a Taranto non sarà una festa, non una ricorrenza ma la constatazione che nonostante le infinite promesse di una vita migliore oggi siamo di fronte a tassi di disoccupazione impressionanti (oltre il 50%) con un continuo dilagare di lavoro nero in condizioni pessime e ai limiti della soglia di povertà. Sarà la partenza della Vertenza Taranto che nel suo svilupparsi cercherà di racchiudere in sé un’intera città stimolandola alla partecipazione e all’annullamento della delega. Un ringraziamento doveroso al Comitato. 8 sindacale, non fu presa in considerazione. Non pervenne neppure alcuna risposta. Il giorno successivo, sotto un sole cocente d’agosto tarantino, ci siamo ritrovati di fronte l’arsenale e tutti insieme abbiamo iniziato la nostra sfilata in coda al corteo sindacale. E da trenta diventammo quaranta, poi cinquanta, poi cento, tra donne lavoratori studenti e professionisti dietro il nostro trerruote a gridare verità completamente cacofoniche in un contesto costruito e per niente genuino come quello in cui ci trovavamo. Poi l’arrivo in piazza, la folla che si apre guardando incuriosita il nostro apecar e ascoltando i nostri cori. La goliardia è diventata frenesia, speranza di poterci fare sentire e bisogno imminente di raccontare a Taranto cosa stesse succedendo all’interno della fabbrica e cosa non sarebbe, invece, dovuto accadere mai più. C’è stato chi addirittura tagliò i cavi del microfono del palco per evitare che noi prendessimo parola sul pulpito, e di questo gesto ha anche incolpato noi. O chi, come i segretari dei sindacati, sparì dalla vista non appena arrivammo. Ma c’era una piazza, gremita di lavoratori e cittadini. E quella piazza ci ha ascoltato: dopo il nostro intervento, per il quale si erano scomodati molti caschi antisommossa (che di fatto però non ebbero ragione di “rompere le righe”), la piazza si svuotò e la gente seguì la nostra scia di novità. Fu una giornata infinita, difficile da dimenticare.” Liberi e Pensanti E da quel giorno non si sono fermati, basta vedere quanta gente è stata mobilitata e anche se i media nazionali non ne hanno data l’importanza che meritava, l’eco del loro evento è arrivato: attraverso i social network e attraverso i media alternativi (ci piace citare Radio Onda Rossa). Centinaia di ragazzi che con una maglietta rossa, coordinavano un’organizzazione perfetta, centinaia di ragazzi che hanno unito le varie realtà di Taranto, e non solo, che si sono mobilitate con l’unica volontà di veicolare un messaggio diverso e indipendente rispetto a quello dei soliti sindacati o dei partiti, che hanno perso l’appoggio del popolo. A Taranto, invece, il popolo c’era e che avesse suonato Fiorella Mannoia o i Ricchi e poveri scommettiamo che la gente ci sarebbe stata ugualmente. Redazione | 3 maggio 2013 Proprio Fiorella Mannoia dal palco ha voluto sottolineare un aspetto molto importante: vietato dividersi. E sì, perché non bisogna cedere al ricatto del lavoro, ma neanche a quello del protagonismo. Bisogna piuttosto diffonderla questa lotta, bisogna parlarne in Italia perché quello che succede a Taranto lo si può vedere e ascoltare solo se si arriva fino a laggiù. Proseguiamo il racconto della stupenda giornata del Primo Maggio, vogliamo continuare a farlo sia per tenere alto l’interesse verso quello che sta succedendo a Taranto, sia per supportare la lotta che portano avanti migliaia di tarantini. Così, non possiamo non parlare degli organizzatori del Comitato dei Cittadini Liberi e Pensanti. Iniziò tutto da un afoso giorno d’estate, come ci raccontarono loro stessi in un’intervista collettiva: “L’esperienza di quella mattinata, e delle giornate che la precedettero, rimane impressa nella pelle di chiunque viabbia preso parte. La notte prima, pochi di noi avranno dormito, eravamo poche decine a stilare il discorso e a parlare di come articolarci in corteo,ma sentivamo che qualcosa sarebbe cambiato. La nostra richiesta di partecipare, faxata il giorno prima all’organizzazione dell’evento Quello che c’è piaciuto, poi, sono state le toccanti testimonianze che sono state lette dal palco: storie di gente normale, cittadini di Taranto che hanno avuto un’unica sfortuna, quella di dover convivere con una fabbrica che uccide vicino. Come quella di un ragazzino di 13 anni che ha lottato, fino a quanto ha potuto, contro “la malattia”, che oramai a Taranto è diventata la “normalità”. La gente ne parla come se fosse normale ammalarsi di tumore o avere una malattia simile, tanto che ne parlano come fosse “il male di Taranto”. Ne parlano lucidamente e chiaramente affermando dal palco e per la strada che nonostante tutto vogliono rimanere qua (anche se qualcuno sa che magari dovrà trasferirsi in Germania dati i numerosi problemi). Rimanere qui e affollare il quartiere Tamburi non con l’incoscienza di voler sfidare qualcuno o un male e neanche perché si debba rimanere qui. Rimanere a Taranto ha assunto un altro valore per molti, è amore per la propria città, ma soprattutto per la libertà: è Resistenza. Come ci hanno insegnato veramente le troppe testimonianze dal palco, dirette o quelle dell’anno scorso alla manifestazione contro Clini. Libera e Pensante Resistenza. 9 L’astensione della paura made in Il sequestro del patrimonio Riva Taranto Cosimo La Gioia | 2 giugno 2013 Cosimo La Gioia | 18 maggio 2013 Non ci voleva un mago o una cartomante. L’esito del referendum del 14/04/2013 era scontato. Ha rappresentato solo l’ennesima occasione per ribadire quanto la città sia piegata dal ricatto occupazionale salute – lavoro. Non è possibile porre dinanzi i cittadini ad una scelta tra il posto di lavoro e la salute. Sarebbe stato più opportuno porli dinanzi ad una scelta tra la riconversione dell’economia tarantina e la “fumosa” attività dell’ILVA che genera solo ricchezza in mano di pochi. Forse, se il quesito referendario avesse avuto un tenore di questo tipo, il suo esito non sarebbe stato così scontato. Il quorum non è stato raggiunto perché ha vinto la paura di cambiare, il terrore di lasciare la strada vecchia senza che ci sia qualcuno o qualcosa che rassicuri la città e che la protegga e la accompagni nel difficile cammino del cambiamento. Lo Stato non è con noi e con rammarico apprendiamo ogni giorno di più che anche i politici locali ci hanno voltato le spalle (vedi le accuse al sindaco Stefano e l’arresto del Presidente della Provincia di Taranto Florido con riferimento al filone di inchiesta “Ambiente Svenduto”). D’altro canto, dobbiamo anche dire che la città ha mostrato probabilmente di essere ancora acerba, immatura per una scelta così importante. I tarantini sono abituati a subire le scelte degli altri e di sottostare alle stesse senza muovere ciglio. La tanto famosa teoria tarantina del “ce me ne futt a me” (cosa me ne importa) è purtroppo radicata nella nostra mentalità e sarà difficile rimuoverla. La grande industria è entrata prepotentemente nella vita della città e ad oggi pare ci siano poche possibilità che si verifichi una presa di coscienza vera da parte di tutti. E’ troppo facile parlare. Se solo tutti i presenti al concerto del 1° Maggio si fossero recati alle urne forse oggi staremmo a parlare di altro. Ma si sa, per votare ci si mette il nome e la faccia. Troppo facile nascondersi nella folla. Proprio mentre in pochi se lo attendevano, quando l’azienda da rottamare aveva ormai ricevuto l’ok per continuare a produrre senza intoppi e fastidi, su richiesta della Procura di Taranto, in applicazione della Legge 231/2001 sulla responsabilità giuridica delle imprese, il 24 Maggio 2013 il pm Patrizia Todisco ha disposto il sequestro di beni della società Riva Fire S.p.A (che controlla la società Ilva S.p.A) per un ammontare di 8,1 miliardi di euro. La misura del sequestro è stato adottato per equivalente nel senso che l’autorità giudiziaria ha stimato in tale cifra i costi per il risanamento delle aree gravemente inquinate dal mostro ILVA. Tali fondi quindi sono a garanzia delle opere di disinquinamento necessariamente da eseguire. Il Gip di Taranto ha disposto i sigilli sui beni per tale cifra affidando la custodia degli stessi a Mario Tagarelli, ex presidente dell’Ordine dei commercialisti di Taranto. E pensare che qualcuno aveva affermato che i fondi per risanare la fabbrica e l’ambiente non c’erano. E’ chiaro che è inutile attendere un’opera di magnanimità da parte della famiglia Riva. I patti non sono stati rispettati e le disposizioni dell’AIA non sono ancora minimamente messe in atto. Vi è un grave ritardo nella realizzazione delle opere che mostra la scarsa volontà dell’ILVA di ridurre realmente gli effetti dannosi della sua attività (scandalosa la realizzazione di una recinzione con rete da calcetto per ridurre le polveri e minerali). L’unica soluzione è mettere in pratica le leggi che ci sono e devono essere quindi rispettate senza sconti per nessuno. L’ILVA S.p.A a nome del suo amministratore delegato Enrico Bondi ha presentato dinanzi al Tribunale del Riesame di Taranto, il ricorso al provvedimento di sequestro. Prontamente giungono le voci “terroristiche” che gli stipendi degli operai del prossimo mese sono a rischio in quanto le casse aziendali sono vuote. E’a rischio l’approvazione del piano industriale ILVA 2013-2016 avviato da mesi e la vocazione industriale del Paese. Se il futuro della fabbrica maledetta sarà ancora nelle mani della famiglia Riva o chi per essi, dovrà essere rispettoso per la gente che la ospita. Bellissima la frase rilasciata su un social network da parte di uno dei più grandi giornalisti Gad Lerner: “Riva guadagnava miliardi e con gli spiccioli si comprava Taranto”. La realtà dei fatti è 10 conoscibile anche da chi non vive l’assedio e l’occupazione delle fabbriche della morte sul nostro territorio, basta solo un po’ di onestà intellettuale e fare giornalismo, per chi ne è capace, al soldo di nessuno. Avanti Taranto! “Buongiorno Taranto”: l’Ilva e Taranto in un film, intervista al regista Paolo Pisanelli Redazione | 2 giugno 2013 Come si strutturerà il film? <<Il film è ancora un work in progress, siamo quasi alla fine delle riprese e contemporaneamente abbiamo avviato il montaggio già da un po’ di tempo. Lo strumento narrativo utilizzato è quello della webradio. È un viaggio attraverso le tensioni e le passioni di una città immersa in una nuvola di smog. Le rabbie e i sogni dei suoi abitanti sono accompagnati dalla cronaca di una radio nomade e intermittente, che ogni mattina si collega alla città e saluta i radioascoltatori: “Buongiorno Taranto!”. È una radio svalvolata, fatta di parole, musica e tante immagini, un cineocchio digitale che scandisce il ritmo del film e insegue gli eventi che accadono ai confini della realtà, tra rumori alienanti e odori irrespirabili. Un viaggio surreale accompagnato da esplosioni di bellezza sommersa e ipnotici tramonti sul lungomare>>. Come vede la situazione di Taranto e dei tarantini ricattati dal lavoro? <<Dal punto di vista teatrale si potrebbe pensare di essere precipitati in un dramma shakespeariano: salute o lavoro? Lavoro o salute? Essere o non essere? Il finale di questo dramma riguarda il presente e il futuro degli abitanti e non è ancora stato scritto, anche se molto influenzato dalle scelte fatte>>. Quali sarebbero le speranze di una Taranto senza l’Ilva? Li abbiamo incontrati a Taranto, il primo maggio, mentre pubblicizzavano il loro film. Abbiamo chiesto un’intervista al regista, Paolo Pisanelli, e con molto piacere la pubblichiamo. Si parla di un film che ha attraversato le problematiche che a Taranto sono quotidiane: l’Ilva, la disoccupazione, la saluta, l’ambiente e molto altro. Due parole sugli autori: chi c’è dietro il progetto <<“Buongiorno Taranto” è un progetto del laboratorio di comunicazione Big Sur e l’associazione OfficinaVisioni. Il progetto si articola in un film documentario e un videoblog, ideati dal filmaker Paolo Pisanelli (vedi credits completi). Da sempre impegnati nella comunicazione sociale, raccontare la storia di una città come Taranto è un gesto di naturale evoluzione del percorso seguito finora. Come Big Sur, infatti, abbiamo portato il cinema documentario in piazza con il progetto di Cinema del reale, siamo entrati nei Centri diurni per incontrare e valorizzare le risorse creative di persone in difficoltà, abbiamo varcato la soglia dei Centri di accoglienza per Immigrati per dare voce alle paure e alle speranze di tante persone alla ricerca di un futuro migliore, siamo stati tra le macerie dell’Aquila per raccontare la storia di una città distrutta dal terremoto. Abbiamo filmato per raccontare le storie di oggi, storie che viviamo>>. Com’è partita l’idea del progetto? <<A luglio 2012, la magistratura di Taranto ha ordinato il sequestro e il blocco delle lavorazioni in alcune aree dell’impianto siderurgico. È come se la città si fosse svegliata da un torpore in cui è rimasta incastrata per oltre 50 anni e noi siamo partiti dal 2 agosto 2012 per filmare gli eventi che accadevano in città. Il progetto è nato così, dalla nostra necessità di documentare la realtà e le trasformazioni politiche e sociali che riguardavano Taranto>>. <<E’ un periodo ipotetico dell’irrealtà… L’ILVA c’è, prima era ITALSIDER, e la sua presenza si fa sentire molto bene da cinquant’anni a questa parte. In questi cinquant’anni sono stati prodotti in Italia molti più disastri ambientali rispetto a quanto prodotto nei millenni precedenti>>. Nel film avete incontrato anche gente che sostiene l’Ilva altrimenti, sostiene, “ci sarebbe solo disoccupazione”. Come si può sostenere una tesi simile? <<Purtroppo per molti l’ILVA rappresenta l’unica boa a cui aggrapparsi, non ci sono molte alternative e la percentuale di disoccupazione a Taranto è impressionante, nonostante sia il primo polo siderurgico italiano. La “cultura della fabbrica” che permette di vivere ai lavoratori e ai loro familiari, è stata inculcata per anni ai giovani e soprattutto ai bambini, è celebrata anche nel mosaico della chiesa di Tamburi>>. Nel trailer ci sono molte immagini che si riferiscono al Comitato Cittadini Liberi e Pensanti che noi abbiamo apprezzato molto. come vede questo comitato (e gli altri)? Hanno fatto parecchio rumore… come i tarantini si stanno mobilitando per la battaglia contro l’ilva? <<I tarantini ormai hanno capito che devono svegliarsi dal sonno e riconquistare il potere di decidere il loro futuro, per anni alcune associazioni (Donne per Taranto, PeaceLink…) hanno avuto il merito di denunciare l’inquinamento e le morti per malattie, poi dal 2 agosto 2012 il Comitato dei cittadini liberi e pensanti ha fatto un lavoro di sensibilizzazione e mobilitazione eccezionale, arrivando a recuperare il Parco Archeologico delle Mura Greche e organizzando un bellissimo concerto del Primo Maggio con la partecipazione gratuita di artisti provenienti da tutta Italia: da questa cura e tutela dei luoghi e da questa esperienza creativa bisogna ripartire>>. 11 Come si può sostenere il progetto? <<Il progetto finora è stato interamente autoprodotto da Big Sur e OfficinaVisioni. Per sostenere la fase di post-produzione, chiediamo un contributo collettivo attraverso il crowfounding. L’obiettivo è il raggiungimento della quota di 5.000 euro, da ottenere grazie a una community in rete, che riteniamo fondamentale anche per la futura distribuzione del film. La fase di montaggio e post-produzione si concluderà il 15 agosto 2013 e l’uscita del film è prevista per settembre 2013. Per aiutarci a completare questo viaggio è possibile prenotare una quota di sostegno al progetto grazie al portale produzioni dal basso cliccando il pulsante “SOSTIENI” e seguendo le istruzioni. Il link si può trovare sul sito di Buongiorno Taranto. Sono a disposizione 500 quote da 10 euro. Chi decide di acquistarne più di una avrà a disposizione una serie di rewards relativi al progetto, dal dvd, alla maglietta, alla locandina. Il ritorno commerciale è molto relativo, ma è importante capire che Taranto è lo specchio dell’Italia di oggi e che dobbiamo puntare l’attenzione su quello che accade lì. Siamo tutti tarantini!>> timoniere: gli operai protestano davanti ai cancelli e protestano contro l’assenza di tute da lavoro di ricambio e delle mascherine (alcuni degli addetti alla manutenzione ordinaria lamentano addirittura l’assenza di bulloni utili ai fini dell’espletamento delle operazioni basilari). Come direbbe qualcuno, siamo alla frutta. Se manca la sicurezza sugli impianti gli operai devono fermarsi, ripeto, devono fermarsi. Si teme che quella fabbrica diventi quello che qualcuno, seppur vandalo, ha scritto su un muro presso il Porto: Morte e Disoccupazione. Brindisi, i danni ambientali in Puglia non sono solo ILVA Redazione | 1 marzo 2013 Spiccioli in cassa Cosimo La Gioia | 16 giugno 2013 Nonostante il ricorso avanzato dalla Riva Fire, società che controlla il colosso siderurgico tarantino, il riesame ha confermato il maxi-sequestro di qualche settimana fa di 8,1 miliardi di euro. Nelle casse della holding i finanzieri però hanno trovato pochi spiccioli, 250 mila euro circa, che, di fronte a quanto serve per avviare le bonifiche e i risanamenti, fanno il solletico. A questo punto pare che i Riva abbiano due scelte: ricorrere a prestiti da parte degli istituti di credito o chiedere una proroga (l’ennesima) per completare quanto disposto dai giudici. E’ ovvio che nel caso i vertici aziendali richiedessero una proroga per i lavori, si aprirebbe un nuovo scontro con la magistratura che porterebbe sicuramente ad una decisione atta a sequestrare gli impianti senza facoltà d’uso degli stessi. L’azienda afferma che il mercato dell’acciaio sta attraversando un periodo difficile a causa della crisi economica mondiale e alla congiuntura sfavorevole degli ultimi anni (è strano come però la produzione negli ultimi tempi sia accelerata a dismisura). In realtà l’Ilva di Taranto in questo momento è una nave senza Oltre al caso Ilva in Puglia c’è un’altra spinosa vicenda ambientale che scuote le coscienze e le preoccupazioni dei cittadini. A Brindisi un comitato cittadino, fatto per lo più di madri, si sta battendo affinché la centrale Enel di Cerano (contrada di Brindisi) cessi di bruciare carbone, deleterio per tutti gli abitanti della zona. I metodi che vengono adottati troppo spesso si avvicinano ad illeciti, come lo sversamento in ambiente senza recinzioni di acque contaminate col carbone, che si disperdono in tutta la zona. Il comitato denuncia anche le fiamme giornaliere e le emissioni piene di tossicità, con la concomitanza di un’altra centrale, l’Edipower, che poco fuori Brindisi ha ripreso la propria attività di combustione di carbone. Anche in questo caso il tutto avviene con una preoccupante lontananza da ogni sorta di legittimità, visto che il carbonile dell’azienda è stato sequestrato dalla magistratura, quindi si utilizzano le navi carboniere presenti nel porto. I rapporti in merito all’impatto ambientale di queste attività, elaborati dal CNR di Lecce e Pisa, hanno dimostrato disfunzioni cardiache e respiratorie nell’area circostante gli impianti. Per questo il comitato delle Mamme No al Carbone chiede al sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, di pronunciarsi contrario al prossimo progetto di Termomeccanica, utile ad un ulteriore impianto industriale nella zona: termovalorizzatore. Il diniego al nuovo investimento industriale è dettato dalla poca chiarezza delle attività già presenti ed alla voglia di salvaguardia della propria salute. 12 Polvere nera non separabile Gianni Delle Gemme | 13 luglio 2013 Contrada Cerano (Brindisi), 2007. Un gruppo di contadini salgono sui loro trattori con i carrelli carichi di uva nera appena raccolta e si dirigono verso il palazzo del Municipio con l’intento di riversarla davanti all’ingresso. Stanno per compiere un atto simbolico, di protesta, verso l’ordinanza emessa a giugno con cui viene vietata la coltivazione di prodotti agroalimentari nei pressi di Cerano per possibile rischio di inquinamento. 400 ettari di terreno, adiacenti al nastro trasportatore e al carbonile, interdetti alle coltivazioni e decine di aziende agricole messe alle corde. Gli agricoltori vengono bloccati dalla Digos un attimo prima di arrivare a destinazione e tutto il carico d’uva viene sequestrato per permettere ai laboratori dell’Arpa di effettuare dei campionamenti. I risultati di quelle analisi (molto tardivi e più volte sollecitati) sono però deludenti: il referto dell’Arpa classifica quella patina nerastra che ricopriva l’uva semplicemente come “polvere nera non separabile”, senza nemmeno specificare se fosse polvere di carbone o no. Anzi, paradossalmente fa recapitare al contadino una fattura di 600 euro per le analisi svolte e un avviso di garanzia per violazione dell’ordinanza che vietava il prelievo del prodotto. Ma i contadini non mollano, le indagini proseguono e due anni dopo, nel 2009, partono i campionamenti e le analisi, sia dei periti di parte Enel, sia di quelli delle parti lese. Contrada Lazzaro (Reggio Calabria) , 2009. I rifiuti provenienti dalla centrale Federico II, (ceneri tossiche e altri materiali pericolosi), vengono smaltiti illegalmente in Calabria. Tra il 2006 e il 2007 sono state circa 100mila le tonnellate di rifiuti tossici occultati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale a poca distanza dal mare e adiacente a terreni agricoli. Un profitto per Enel di oltre 6 milioni di euro l’anno, rispetto alla spesa stimata per lo smaltimento del materiale in discariche idonee. Disastro ambientale e associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti pericolosi sono stati i reati ambientali che hanno portato all’arresto di 10 persone, tra cui anche dipendenti e dirigenti dell’Enel. Ma questa è un’altra storia. Un altro processo. Torniamo a Brindisi. Il movimento No al Carbone presenta un esposto in Procura chiedendo di accertare le cause e le responsabilità per l’inquinamento dei terreni e due mesi dopo, il 22 febbraio 2010, l’Amministrazione comunale con delibera di giunta, rinuncia a qualsivoglia azione giudiziaria e pretesa risarcitoria nei confronti dell’Enel, nelle cause esistenti, solo a condizione che la società eroghi un contributo di circa un milione e 200mila euro per il completamento del parco Magrone ed effettui il risarcimento dei proprietari e residenti dell’area agricola adiacente l’asse attrezzata e la Centrale Federico II. Brindisi, 2011. Viene depositata la perizia superpartes che finalmente fa luce sulla misteriosa “polvere nera non separabile”. Una perizia in cui si dice una volta per tutte che il carbonile di Cerano è sprovvisto di qualsiasi misura idonea ad evitare le dispersioni di polveri di carbone e che queste sono presenti sulle abitazioni e sulle colture confinanti. Si concludono le indagini del Pubblico Ministero e si fissa la prima udienza del processo Enel al 12 dicembre 2012. Si dice che il lupo perde il pelo ma non il vizio, e infatti dopo le contrade calabresi è toccato alle campagne brindisine. Scoperto a ottobre un traffico illecito di trecentomila tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi provenienti da alcune aziende brindisine tra cui la centrale Federico II, interrati in discariche abusive nelle campagne brindisine. Il solito giro insomma, rifiuti tossici con documentazioni false, grossi guadagni per la mafia locale e risparmi immensi per le aziende. Dicembre, 2012. Parte la prima udienza del processo Enel a carico di 13, tra dipendenti e manager, e due imprenditori che avevano in carico la movimentazione del carbone. L’accusa, secondo il decreto di citazione a giudizio, è quella di aver messo in atto un DISEGNO CRIMINOSO che ha portato alla dispersione di polveri di carbone oltre il recinto aziendale causando gravi danni ambientali. Dalle indagini emergerebbero, infatti, diversi punti di questo disegno criminoso che vedeva i dirigenti Enel ai massimi livelli, pienamente consapevoli del fatto di avere un nastro trasportatore non a tenuta stagna, un carbone di pessima qualità e un carbonile a celo scoperto, capace di contenere 750mila tonnellate di minerale, dove il fenomeno dello spolverio era incontrollabile. Un processo che ha molte analogie con quello dell’Ilva di Taranto e dei parchi carbonili in principio sequestrati dal GIP Todisco, ma anche molte differenze: una su tutte, la decisione della procura di Brindisi di non sequestrare la fonte inquinante. Tante le responsabilità: della magistratura, che non emettendo il sequestro del carbonile permette di fatto ,ancora oggi, il protrarsi del reato, i sindaci di Brindisi che in quanto garanti e responsabili della salute dei cittadini avrebbero potuto prendere decisioni invece di dimostrarsi indifferenti come tutto il testo delle istituzioni, ma anche dei mass media tradizionali, che dovrebbero fare informazione e denuncia e invece raccontano altro. Tribunale di Brindisi, 12 dicembre. Tantissime le richieste di costituzione di parte civile (circa 50) nella prima udienza di quello che è certamente un processo a degli imputati, ma soprattutto è il processo ad uno spietato sistema produttivo incentrato solo sui grandi profitti provenienti dalla produzione di energia da carbone, a discapito del territorio e della salute dei suoi abitanti. Circa cento milioni di tonnellate di carbone bruciate da Enel in questi decenni, che hanno portato profitti lordi per Enel per circa 5 miliardi di euro pari a diecimila miliardi di vecchie lire, lasciando invece danni immensi al territorio, sul piano ambientale e sanitario come certificato dallo studio dell’Agenzia Europea sull’Ambiente. Tra le associazioni e i movimenti a presentare richiesta di costituzione di parte civile c’è il Movimento No al carbone, Salute Pubblica, Medicina Democratica, Greenpeace, Il comitato regionale di Legambiente, il Wwf, Italia nostra e Federutenti. Ma anche alcuni comuni e la provincia di Brindisi. 13 Tra i grandi assenti c’è lo Stato che è azionista di maggioranza Enel, ma ancora più pesante l’assenza della regione Puglia del presidente Niki Vendola, colui che in campagna elettorale dal palco di piazza Vittoria a Brindisi urlò queste parole: ”Il primo tempo lo giochiamo a Taranto con l’Ilva, ma signori dell’Enel: il secondo tempo lo giocheremo con voi a Brindisi”. Belle parole, solite belle parole da campagna elettorale. Niki Vendola a Brindisi non c’è più tornato. Brindisi, 15 Luglio 2013. Lunedì alle 9.30 si tornerà in aula per la quinta udienza in cui probabilmente ci saranno le deposizioni degli uomini della Digos che hanno condotto le indagini. Speriamo dunque che si possa finalmente entrare nel vivo del dibattimento e speriamo soprattutto che non si arrivi alla formula indegna della prescrizione, come troppo spesso accade nei tribunali Italiani, riuscendo ad ottenere un po’ di verità e giustizia per un territorio che da decenni è vittima di un devastante sfregio ambientale e sanitario. Lunedì sera è bruciata anche una parte di me. Ora c’è da riaccendere la dignità di Napoli Domenico Musella | 10 marzo 2013 un luogo simbolo. Lì c’era stata la grande fabbrica. Un ammortizzatore sociale, una bestia inquinante, ma anche la culla della “mitica” classe operaia. Ero troppo piccolo, non l’ho mai vista in funzione, o comunque non lo ricordo. Solo più avanti l’ho rivissuta con i racconti di chi l’aveva vista e l’ho immaginata con le pagine del bellissimo La dismissione di Ermanno Rea (da leggere assolutamente, per capire; Rea tra l’altro ha scritto il suo commento ai fatti di Città della Scienza in questo editoriale su il manifesto). La Città della Scienza ho cominciato a frequentarla più assiduamente al liceo, ci sono stato varie volte. Ho fatto lo scientifico, e per un periodo con dei compagni di classe mostravamo ai visitatori del museo degli esperimenti di chimica; poi con un altro progetto studiammo il territorio e le acque dell’intera area. D’estate cominciai ad andare ai concerti che facevano nel piazzale all’aperto. Conferenze, seminari, dibattiti, mostre si sono susseguiti negli anni. Era viva e vissuta, la nostra Cité des sciences ricavata da un’ex-fabbrica di fertilizzanti della Federconsorzi, che una volta era stata la più antica fabbrica in zona, la vetreria LeFèvre. Un posto con enormi potenzialità di riscatto Bagnoli, per una città che da sempre deve riscattarsi (chissà se è davvero mai esistito nella Storia dei napoletani un momento in cui non ci si dovesse “riscattare”…). Un luogo dove davvero si può costruire un futuro da zero, e un futuro fatto per bene, umano e rispettoso del meraviglioso ambiente che abbiamo. E in più che abbia come cardine la cultura, quel bagaglio di anticorpi che ci rende (o almeno dovrebbe renderci) non manipolabili e non vendibili. Un luogo dove dal letame, dalla monnezza e dall’amianto che oggi ci sono possono nascere dei fiori, dove dalle ceneri può risorgere l’Araba fenice. Chiunque mi viene a trovare, dall’Italia o dall’estero, e mi chiede di portarlo in giro per la città, ha questo quartiere come tappa obbligata. Per me è imprescindibile: puoi pure evitare il Maschio Angioino, ma se vuoi avere un contatto profondo ed intimo con la Napoli contemporanea e le sue infinite contraddizioni, devi andare a Bagnoli. Non c’è scampo, altrimenti devi cambiare Cicerone: chi mi conosce lo sa. E Bagnoli ora senza la Città della Scienza, praticamente l’unica struttura finora nata dalla trasformazione (più che ventennale e incompiuta) dell’ex area industriale, non è più la stessa. Ma che occasione, ma che affare! Vendo Bagnoli, chi la vuol comprare? Colline verdi, mare blu: avanti, chi offre di più?… (Edoardo Bennato, Vendo Bagnoli, 1989) Scusatemi se il tono sarà molto sul personale e sull’autoreferenziale, ma parlando della Città della Scienza andata in fumo qualche giorno fa non riesco ad evitarlo, è più forte di me. E ciononostante ho la presunzione di dire che servono tutte le testimonianze, anche una emotivamente molto coinvolta, su quanto rappresenta questo vergognoso atto per Napoli, per i napoletani e per il loro futuro. Non riesco a stare zitto, lo devo a me e al posto dove sono cresciuto. Sfrutterò queste pagine, non me ne vogliate, per raccontarvi un po’ di me. Ci sono stato la prima volta alle elementari, o forse alle medie, alla Città della Scienza di Bagnoli. Mi ha sempre affascinato Bagnoli: un posto bellissimo, tra i più affascinanti di Napoli, forse per me “il” più affascinante. Crescendo, è diventato per me Indignazione, rabbia, dolore, tristezza, e tutta una serie di sentimenti non certo incoraggianti mi hanno colto qualche sera fa vedendo le fiamme e il fumo. Mi sono sentito bruciare anch’io, i piromani sono stati talmente bravi da far propagare il fuoco anche in una parte di me e di tutti i napoletani. E se è successo a me, che non vivo in quel quartiere, figuriamoci ai residenti. Non oso immaginare poi quanto quelle sensazioni che elencavo sopra siano state amplificate per i 160 lavoratori che dedicavano le loro giornate a quel posto. Che grazie a quel lavoro hanno sostentato fino ad oggi le loro famiglie, anche se negli ultimi tempi un po’ a stento, con la fondazione in crisi e gli stipendi in ritardo di vari mesi. Io non so chi è stato a compiere questo gesto che definire ignobile è francamente riduttivo, non ho la palla di cristallo. Ma come tanti napoletani, so perché l’ha fatto. La costa ovest di Napoli, dove si trova Bagnoli, è l’unica parte di costa non edificata. Lo stabilimento siderurgico con tanto di enorme indotto, quell’Italsider che l’ha avvelenata per un secolo, l’ha anche 14 paradossalmente “salvata” dalla speculazione edilizia. Gli appetiti della malavita legata ad imprenditori senza scrupoli legati alla malapolitica sono grossi e ventennali. Bagnoli, come ironicamente aveva previsto il bagnolese Edoardo Bennato, è diventata territorio di conquista, con gli avvoltoi appollaiati sulle sue spalle fin dalla chiusura della fabbrica. C’è chi Bagnoli la vuol comprare, non solo con i soldi ma con l’arroganza e la violenza. Stamattina il flash mob per una “Città della CoScienza” (sotto, qualche scatto dall’evento) in una bella giornata di sole ha raccolto migliaia di persone per dire che non siamo in vendita e che nonostante le scottature non intendiamo arrenderci. Un segnale importantissimo di vitalità, che un po’ di speranza l’ha riaccesa in tutti noi. Ma bisogna continuare, un momento di allegria e unità purtroppo non è sufficiente. E un luogo di cultura proprio lì sul mare a via Coroglio dava fastidio. Così come hanno dato fastidio i vari progetti di parchi, spiagge ed aree culturali, artistiche e sportive che avrebbero dovuto seguire una seria bonifica ambientale. Il tutto, ovviamente, rimasto solo sulla carta dal 1991 a oggi. Napoli sta vivendo un periodo molto difficile, mai come in questo momento. Sta morendo, dice qualcuno. Disoccupazione e povertà alle stelle, servizi essenziali non sempre garantiti (dai trasporti pubblici, all’assistenza sociale e sanitaria, alla scuola etc.), speculatori e camorristi che sparano sulle macerie. La violenza diventa un problema sempre più quotidiano (la testata Il Mattino ha dedicato tra l’altro al tema un interessante dibattito in settimana). Le speranze di cambiamento che ho trovato quando sono tornato dal mio soggiorno all’estero (era il periodo della grande mobilitazione popolare che ha fatto vincere il Sì ai referendum su acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento nel 2011: la città cominciava a riempirsi di biciclette, per strada circolava una speranza colorata e una voglia di partecipare e riscattarsi che mi sorprese, una vitalità riscoperta dopo anni) in pochissimo tempo sono svanite. Siamo tornati ad essere abbastanza egoisti, opportunisti, frammentati e violentemente contrapposti. Orgogli, settarismi, miopie, tra le tante cose, ci tengono disuniti e quindi deboli quando insieme potremmo essere forti. Lo smembramento invece ha ripreso vita, lui. Complice chi vuole del male a questa città perché vuole troppo bene ai suoi affari, ai suoi interessi. Complici tutti noi, quando lo accettiamo come un dato di fatto e vendiamo a buon prezzo la nostra dignità. Giorno per giorno dobbiamo riscattarci, ritrovare la coesione e riaffermare la nostra dignità. Dobbiamo interessarci a ciò che è comune, impedire che lo distruggano. Dobbiamo interessarci agli altri, non tirare a campare senza scegliere una direzione migliore. Il cuore, la nostra “ricchezza” come dice una di quelle canzoni classiche partenopee che riescono a cogliere l’anima profonda della città, almeno quello non dobbiamo perderlo. Sì, si tratta di uno sfogo, lo leggete. Ci sono tante realtà che fanno sentire la loro voce in direzione ostinata e contraria quotidianamente, e che mantengono viva la città. Ma spesso la voce grossa della violenza e della sopraffazione le sovrasta.Napoli la vedo come una speranza disattesa (per ora). Napoli è stanca. Ma dobbiamo rialzarci. E attenzione: come mi piaceva dire con degli amici un po’ di tempo fa, Napoli non ha bisogno di supereroi. Men che meno di capipopolo, urlatori o burattinai. Napoli ha bisogno dei napoletani. Ha bisogno che tanti piccoli gesti della vita quotidiana ci riportino ad una dimensione umana dell’esistenza. Bastano cose anche molto piccole: dal sorridere al vicino, al rinunciare alla competizione sfrenata per accaparrarsi un posto in metro, all’evitare di scannarsi per la precedenza ad un incrocio. Ma anche al farsi sentire se ledono un diritto nostro o di chi sta a fianco a noi, al non tollerare le ingiustizie, al predisporci all’ascolto dell’altro… insomma mi avete capito, l’elenco può essere chilometrico. Tutt”a ricchezza ‘e Napule era ‘o core… dice ch’ha perzo pure chillu llà… (Galdieri-Barberis, Munasterio ‘e Santa Chiara, 1945) 15 «Indagini e bonifica a Bagnoli, ma anche partecipazione e spazi sociali»: come ripartire dalla Bancarotta Domenico Musella | 25 aprile 2013 Il servizio video è disponibile sul canale FirstLinePress http://www.youtube.com/watch?v=LblV3kwagyA Youtube Dal 2 giugno 2012 e fino all’11 aprile scorso Bancarotta ha rappresentato per Bagnoli e per Napoli uno spazio pubblico aperto e autogestito, una riappropriazione positiva di un’area abbandonata dopo 20 anni e più di speculazione e immobilismo, lì dove per un secolo fino al 1991 sorgeva il complesso industriale dell’Italsider-Ilva (che a Taranto continua ancora oggi a far danni). Anche a livello simbolico lo spazio di Bancarotta ha un suo significato molto forte: tecnicamente l’edificio era una filiale della banca Intesa-San Paolo all’interno della grande fabbrica: occuparlo e farlo vivere di questi tempi ha voluto dire anche riconvertire l’idea di economia e socialità in qualcosa di diverso da quello che i grandi poteri economico-finanziari impongono. Laboratorio, sede di assemblee e iniziative culturali, sociali e sportive, per quasi un anno Bancarotta ha resistito agli sgomberi grazie al collettivo che se ne prende cura e agli abitanti del quartiere che l’hanno vissuta e popolata. Come per tutti gli stabili occupati il rischio di sgombero era sempre presente, essendo inoltre il locale sotto la giurisdizione della Bagnolifutura, la “società per azioni di trasformazione urbana” che non ha trasformato granché nell’ex area industriale. E lo “sfratto” è arrivato, ma nella più paradossale delle maniere: l’11 aprile scorso la magistratura ha posto sotto sequestro una superficie di tremila ettari dell’ex Italsider (e tra questi anche Bancarotta) nell’ambito proprio delle indagini su quella mancata bonifica che il collettivo dalla sua nascita ha sempre denunciato. A pagare per le responsabilità di disastro ambientale, truffa ai danni dello Stato e false certificazioni della bonifica di un pugno di dirigenti sono stati, quindi, i cittadini e gli attivisti che avevano dato vita a una delle poche iniziative (insieme ad esempio a Città della Scienza, per ironia della sorte vittima recentemente di un rogo) che avevano ridato vita a Bagnoli, sottraendola per un po’ alla desolazione e alle tante speranze non realizzate. Pur avendo perso temporaneamente la sede, il collettivo che animava lo spazio Bancarotta non ha perso lo spirito, la volontà di cambiare il quartiere in maniera partecipata. La scorsa settimana (denominata della “rabbia”, un termine che rimanda, con le dovute differenze, ai venerdì delle recenti rivolte nel mondo arabo) non sono stati fermi un attimo, dando vita a tante iniziative che hanno visto una forte partecipazione del quartiere, che nonostante i tanti torti subìti, dall’inquinamento al rogo di Città della Scienza all’abbandono nel degrado, dimostra di non mollare e di resistere, con la voglia di riappropriarsi del territorio. Oltre a continuare per strada attività e lezioni (come quelle di musica nella foto, molto frequentate dai ragazzi del quartiere), il collettivo Bancarotta ha recentemente occupato la X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, ha sottoposto a “sequestro popolare” la sede di Bagnolifutura (foto sotto) incontrando anche il favore dei suoi dipendenti che il giorno successivo si sono anch’essi ribellati e hanno poi dato vita con Bancarotta e gli abitanti di Bagnoli ad un corteo che ha attraversato il quartiere. Il 18 aprile si è tenuto un sit-in davanti al Consiglio Comunale di Napoli, che ha tenuto una seduta interamente dedicata al tema Bagnoli. In quell’occasione First Line Press ha incontrato i ragazzi del collettivo, realizzando l’intervista che trovate nel video in alto prima che una delegazione entrasse a portare la sua testimonianza nel palazzo di via Verdi, sede dell’assemblea cittadina. Al momento da parte delle istituzioni c’è ancora un nulla di fatto, mentre le indagini della magistratura sono in corso e ai cittadini del quartiere non è stata data ancora pienamente la voce, né risposte concrete, né la possibilità di una reale partecipazione alle decisioni sul destino dell’area. Nel frattempo, però, i bagnolesi si sono dati da fare: il 21 aprile dopo un’assemblea popolare di quartiere si è costituito un Comitato cittadino di lotta per la bonifica, un ambito di partecipazione e azione con degli obiettivi molto chiari: dar vita a un osservatorio, composto dalla cittadinanza, che monitori la bonifica; requisire i beni mobili e immobili e i capitali di coloro che per un ventennio hanno gestito Bagnolifutura e la fantomatica riqualificazione ambientale del quartiere; la chiusura immediata della stessa Bagnolifutura per istituire invece un tavolo permanente sulle fondamentali tematiche di lavoro, casa, ambiente, servizi, beni e spazi sociali. La volontà del Comitato (a destra, un momento dell’assemblea) è aprire un fronte di lotta come altri di livello nazionale (dai No Tav in Val Susa, a quello che riguarda un’altra Ilva aTaranto, al No Muos a Niscemi), perché quello dell’area di Bagnoli è un problema che riguarda tutti, non solo i bagnolesi e i napoletani. Parliamo di un disastro ambientale e di un territorio che da anni non è più a disposizione di chi ci vive: qualcosa che ha molto a che fare con il futuro di tutta l’Italia e che, affrontato in maniera giusta e partecipata, può rivoluzionare le modalità del vivere insieme e del senso di termini come “pubblico”, “sociale” e “comune” oggi poco valorizzati in una Repubblica democratica che in quanto tale, invece, dovrebbe averli come punti di riferimento. Del resto sono ancora tanti gli interrogativi ancora senza riposta della cittadinanza e c’è ancora molta chiarezza da fare sulla situazione dell’area. La magistratura si è accorta improvvisamente dello stallo dei lavori dopo decenni di inattività denunciata dalla popolazione, e inoltre non sono state neanche sfiorate dai sigilli degli inquirenti né Bagnolifutura, né gli arenili e lidi privati presenti sul litorale di Coroglio (che una forte mobilitazione cittadina ha rivendicato come spiaggia pubblica, raccogliendo anche lefirme per un referendum comunale), né l’area della Cementir, di proprietà dell’industriale Caltagirone (che “inspiegabilmente” non è mai neanche rientrata nei terreni espropriati dagli enti locali e gestiti da Bagnolifutura). È evidente che alcuni interessi sono talmente forti da non poter essere toccati 16 nemmeno dallo Stato. Nonostante anch’essi stiano in piedi su suoli ugualmente inquinati dopo un secolo di produzione industriale ad alto impatto. In più, sono ancora da accertare le responsabilità politiche dei fallimenti di ogni progetto per l’ex area industriale, e a tutt’oggi le istituzioni non hanno le idee chiare su come dare slancio al quartiere e non hanno dato seguito alle proposte provenienti dalla cittadinanza. I fumi delle acciaierie non ci sono più da oltre vent’anni a Bagnoli, ma la puzza della speculazione e di grossi appetiti economici sulla zona è ancora forte, c’è da stare molto vigili. A Bagnoli non c’è nulla da festeggiare Carmine Conelli | 5 maggio 2013 prendere la parola. È il destino dei subalterni meridionali: chiedono diritti, ricevono mazzate. Gli organi d’informazione fanno il resto: il travaglista Il Fatto Quotidiano.it apre il suo articolo con un eloquente «alla fine l’hanno avuta vinta i violenti» e prosegue riportando le dichiarazioni di un esponente della sinistra “istituzionale”, secondo cui «quattro giovanotti che giocano alla rivoluzione hanno sporcato un evento gioioso come la festa dei lavoratori». Chissà se Arturo Scotto, coordinatore regionale e deputato di SEL, abbia di nuovo il coraggio di ripetere queste parole ai cassintegrati FIAT e IRISBUS che, a causa della crisi e degli ultimi licenziamenti, come hanno ribadito a gran voce sotto il palco di Città della Scienza, non hanno proprio nulla da festeggiare. A margine dell’accaduto, credo che i tempi siano eccessivamente maturi per porsi alcune domande. Bisognerebbe riflettere innanzitutto su ciò che è stata Bagnoli. Le aree ex Italsider ed ex Eternit, a più di vent’anni dalla chiusura, non sono state ad oggi bonificate. Il territorio subisce ancora oggi le drammatiche conseguenze dell’illusione sviluppista, che ha imposto al Meridione un modello industriale composto da mostri ambientali a capitale settentrionale. Bagnoli, primo maggio. I sindacati confederali decidono di tenere nell’ex quartiere operaio situato a ovest di Napoli la versione locale della kermesse musicale organizzata in occasione della festa dei lavoratori. Una scelta simbolica, dato che il quartiere mai come negli ultimi mesi è al centro delle cronache politiche cittadine. La sciagura di Città della Scienza (a proposito, sono già finiti gli interrogativi e l’ondata d’indignazione rispetto alle responsabilità del rogo) prima, il sequestro dell’area ex Italsider per “disastro ambientale” poi, infine il paventato scioglimento di Bagnolifutura, società creata ad hoc per la bonifica e la ricostruzione. Sullo sfondo di questo scenario, l’incomunicabilità prolungata tra cittadini e istituzioni: i primi che richiedono a gran voce la bonifica e che paghi chi ha causato lo scempio ambientale; le seconde che ristagnano eternamente nel pantano della riqualificazione, tra gravi illeciti e rallentamenti di sorta. Un Sud che deve dunque essere considerata come la “pattumiera” del capitale settentrionale, come si evince dalle recenti inchieste sullo smaltimento di rifiuti tossici in Campania e dalla presenza di impianti industriali che fanno emergere sempre più drammaticamente le contraddizioni tra salute e lavoro (il caso di Taranto è da questo punto di vista tristemente attuale). Vorrei infine tentare di mettere a fuoco il dispositivo morale attuato contro i manifestanti. Come accade sempre,è sufficiente bollare come violento chi protesta per svuotare tali rivendicazioni di ogni dignità. Nonostante le immagini (facilmente reperibili sul web) mostrino il contrario, la maggior parte dei media, ricostruendo l’accaduto, affibbiano ai manifestanti un’etichetta insostenibile secondo cui «un gruppo di facinorosi e di violenti ha interrotto il concerto disturbando la tranquillità delle famiglie e dei bambini accorsi a Città della scienza». Rimane da chiedersi chi sono i violenti: chi chiede a gran voce la bonifica o chi, tentando di dissipare ogni voce fuori dal coro, si rende complice dello stupro di un territorio e di una popolazione? Primo maggio, dicevamo. Nel bel mezzo di quella che, svuotata dell’originario carico ideologico, può essere definita a tutti gli effetti una “festa”, un gruppo di manifestanti ha osato rivendicare le ragioni di un quartiere che non ne può più di promesse e di parole vuote su temi di vitale importanza come ambiente e lavoro. I sindacati, avvertito il pericolo di vedersi rovinata la “festa”, hanno risposto militarizzando letteralmente il palco, dispiegando il proprio servizio d’ordine e lasciando poi che la polizia caricasse i dissidenti. Il concerto viene prima sospeso e poi definitivamente annullato, vietando così tra l’altro ai gruppi di manifestanti di 17 Venezuela: può un modello di sviluppo tutelare l’ambiente, coinvolgere la Cina regionale del Latinoamerica e l’indipendenza dagli Stati Uniti. Il dibattito è in corso, nei prossimi anni poi vedremo anche effettivamente che direzione prenderà questo desarrollo soberano. In gioco, poi, ci sono anche gli equilibri internazionali e le sorti della presidenza, con la malattia di Chávez che rende incerto il fatto che tali politiche continuino ad essere applicate anche in futuro, senza il carismatico leader. e usare il petrolio? Redazione | 21 gennaio 2013 Grecia, l’assalto all’acqua pubblica è un affare che riguarda tutti gli europei Redazione | 10 maggio 2013 La repubblica bolivariana sta provando a conciliare l’inconciliabile, sfruttando nello stesso tempo le sue riserve di petrolio orgogliosamente nazionalizzate, la biodiversità del suo territorio, e rapporti privilegiati con Pechino. Da più parti ferve il dibattito sulla via inseguita dal Paese di Chavez. Le notizie che arrivano da Caracas sembrano contrastanti. Già da diversi anni il gigante cinese ha puntato l’America Latina come una delle aree di espansione, assieme all’Africa. In questo contesto, il principale partner è proprio il Venezuela, con il quale si cerca una sorta di complementarietà, di integrazione. È ciò che dichiara anche il ministro del petrolio Rafael Ramírez (qui una dichiarazione su El Universal). Smarcandosi dal modello neoliberista targato Usa e che vede protagonisti il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, il Venezuela sta progettando dal 2007 Piani di sviluppo socialista. Sia economicamente che ideologicamente, quindi, le vicinanze con la Cina sono molte. Contemporaneamente, tuttavia, il governo venezuelano vuole rafforzare i rapporti “non piramidali” con i lavoratori, risollevare la popolazione dalla povertà e salvaguardare oltre alle persone anche l’intero pianeta con una politica che sia sostenibile. Negli ultimi giorni, per citare alcuni esempi, sono stati varati programmi sia per tutelare la flora e la fauna, sia per proteggere le coste (dal sito Rinnovabili.it). Le suddette tematiche non sembrano per nulla essere nell’ottica di Pechino: violazioni dei diritti umani, sfruttamento dei lavoratori, noncuranza pressoché totale per il clima e l’ecosistema sono all’ordine del giorno e da un lato costituiscono anche dei “vantaggi” a breve termine per i cinesi, come arma di concorrenza. Altra incongruenza, il ruolo del petrolio: è la principale risorsa naturale ed economica del Venezuela, ed è quello che consente di poter contrarre debiti e fare investimenti: ma ha poco a che fare con programmi innovativi, rispetto dell’ambiente, modelli di produzione alternativi. Eppure c’è chi ci vede un modello tutto sommato coerente, che inoltre è mirato ad un altro obiettivo importante: l’integrazione Vittima numero uno del “piano di salvataggio” imposto dalla Trojka (Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea), la Grecia rischia di perdere i suoi beni comuni, svenduti in cambio di denaro per far quadrare i conti pubblici. Ma la popolazione invita alla mobilitazione e chiede sostegno al resto dei cittadini del Vecchio Continente. In una lettera pubblicata sul portale francese dedicato alle lotte ambientali e sociali Bastamag.net il comitato Save Greek Water parla della prevista privatizzazione della gestione dell’acqua nel Paese. Una privatizzazione pubblicamente incoraggiata dal presidente francese François Hollande (alla faccia della gauche e del cambiamento!) nel febbraio scorso durante l’incontro con il Primo ministro greco Samaras. L’inquilino dell’Eliseo ha invitato in quell’occasione le imprese francesi a investire in Grecia nel settore idrico e della terra. Il pensiero corre subito a Veolia e Suez, le due multinazionali dell’Esagono che hanno procurato danni a mezzo mondo proprio gestendone il patrimonio idrico, con l’ormai nota e triste formula di “privatizzazione dei guadagni e socializzazione dei costi”. La gestione di un bene pubblico secondo le modalità del privato – ricorda Save Greek Water – ha significato aumento vertiginoso dei prezzi dell’acqua per i cittadini, accesso ineguale ai servizi idrici, diminuzione degli investimenti nella manutenzione della rete, pratiche monopolistiche. Si parla di “ritorno al protettorato” e di progressiva perdita di sovranità e indipendenza, ritornando indietro a precedente del 1925, quando l’acqua greca era gestita dalla società privata americana Ulen. Società pubbliche come l’EYATH a Salonicco e 18 l’EYDAP ad Atene rischiano seriamente la privatizzazione, e i cittadini con il supporto di alcuni enti locali stanno provando a mobilitarsi con soluzioni come il referendum popolare. Nell’appellarsi agli esempi positivi della cittadinanza europea, come appunto i referendum italiani del 2011, la ripubblicizzazione attuata da diverse città francesi tra cui la capitale Parigi, la protezione dell’acqua come patrimonio pubblico in Olanda e Germania, Save Greek Water invita ad una mobilitazione comune in rete, dimostrando la vera essenza dell’Europa, da basare sulla partecipazione e non su di una oligarchia antidemocratica. Il destino della Grecia – affermano – è anche il destino dell’Europa (non foss’altro per la Storia, che vede il nucleo della civiltà europea nascere proprio tra gli ellenici). Tenendo presente, come recita un’aforisma di Tucidide, che «Si definisce demos (popolo), quello che si oppone ai tiranni». Benvenuti sotto i monti del Cairo: il villaggio del riciclaggio, ma a che costo? Minoranza copta, raccolta dei rifiuti e compagnie estere Lorenzo Giroffi | 29 maggio 2013 Ci sono posti che saturi di significato rischiano di subire una descrizione per stereotipi o semplificazioni: Manchiyet Nasr fino a Mokattam, sotto i monti che costeggiano Il Cairo, villaggio meglio conosciuto come Garbage City. Un luogo che quando i tassisti l’ascoltano come destinazione sgranano gli occhi, chiedono se vuoi entrare fino a dentro e se segue una risposta affermativa ti fanno scendere, rifiutandosi di accompagnarti. Una minoranza etnico-religiosa; una complicata gestione dei rifiuti nella Cairo abitata da più di dieci milioni di persone; il riciclaggio in una catena di montaggio umana fatta di mani, piedi, occhi e nasi immersi nella spazzatura. Bambini, donne ed uomini che distribuiscono il proprio lavoro come in uno di quei film nei quali ci sono città in funzione di un oggetto o di un’azione, in cui tutto è in funzione di meccanismi univoci. Arrivo preparato a Mokattam perché la si è raccontata più volte o con toni sensazionalistici, di una realtà alienante e di degrado, o come un’attività a sfondo tradizionale, nella quale i cristiani copti d’Egitto hanno creato il proprio business, oppure ancora come il racconto di un fatto di discriminazione razziale, per chi ha dovuto accontentarsi di quest’impiego. Prima di ogni considerazione bisogna riflettere sugli ingranaggi economici di questo posto e degli zabbaleen (garbage people), abitanti del posto. I capi famiglia raccolgono la spazzatura nella megaolopoli Cairo, ma senza che ci sia alcun accordo con le autorità egiziane, che durante l’era Mubarak hanno preferito affidare il servizio a compagnie private estere, chiaramente inefficienti nella raccolta e con un servizio di differenziata praticamente inesistente. Con il nuovo Governo post-rivoluzione la situazione non è cambiata e ciò vuol dire che la raccolta continua a compiersi in maniera preoccupante per gli zabbaleen, col corpo a contatto diretto con ogni tipo di rifiuto. Altra tesi, sposata anche dal papa della Comunità cristiana copta, Teodoro II, è che la nuova classe dirigente dei Fratelli Musulmani non abbia alcuna intenzione di integrare e legittimare i lavoratori della spazzatura per ragioni religiose. Tutto quello che arriva a Mokattam viene poi riciclato per l’ottanta per cento, ma verrebbe da pensare che lo si faccia sulla vita delle persone, nonostante chi scriva pensa che il riciclaggio sia un processo necessario. Dopo una lunga ricerca del tassista, riesco ad attraversare le strade di Mokattam, con le imprecazioni dell’autista per le innumerevoli dune sulle quali saltiamo e per l’odore insopportabile che inizia ad insinuarsi dai finestrini chiusi. Un rumore infernale di forni, sacchi tirati, lattine ammassate, mezzi a motore di ogni genere che trasportano spazzatura e bambini che saltano fuori da contenitori: tutti a compiere azioni da ingranaggio, dentro una città che vive comunque la propria quotidianità, quindi spazzatura sull’uscio di casa, di bar e cucine. Ognuno seleziona il proprio rifiuto, mentre io raggiungo Bakhit Mettry dell’organizzazione non governativa “Environment A.P.E.”, che dal riciclaggio elabora materiale di ogni genere, tramutandolo in lampade, collane, vestiti e tanto altro. Si spalanca un portone dentro il quale m’infilo col taxi. Qui mi preleva Bakhit, che mi conduce lungo un viale che si allontana dal chiasso infernale, dall’odore nauseante e dagli animali di ogni genere che t’invadono le orecchie. Mi mostra i laboratori della sua ONG. Macchinari ed un orto ben curato: un paradosso rispetto allo scenario appena attraversato. C’è anche un campo di calcio che costeggia una scuola, dove forse i bambini con un destino lievemente diverso dagli altri custodiscono qualche ora per lo studio. <<La nostra associazione Environment A.P.E. è nata nel 1994, partendo dal compostaggio base per poi estendersi. La nostra missione primaria, oltre ai temi di natura ambientale, è quella di dare un’istruzione adeguata ai bambini. Grazie all’aiuto di molti volontari siamo riusciti a dare continuità a corsi d’istruzione per i ragazzini poveri di tutta la zona. Abbiamo corsi con più di duecento bambini al mattino ed altri duecento durante il pomeriggio>>. Come mai qui si concentra la minoranza copta? <<In realtà parliamo di un flusso migratorio di circa sessanta anni fa, quando molti contadini dell’Egitto del sud, per lo più copti, si recarono al Cairo in cerca di fortuna e lavoro. Erano diretti a Shubra e Imbaba, ma poi il Governo pensò bene di dirottarli qui, perché credeva che in questa zona deserta e con l’area montuosa vuota non ci sarebbero state tante prospettive di permanenza. Invece s’iniziarono a costruire le prime abitazioni, ma soprattutto la comunità copta iniziò a sviluppare l’attività di raccolta dei 19 rifiuti, con la quale poi i capi famiglia hanno potuto sostenere tutta l’area, cominciando a comprare vari macchinari utili al lavoro>>. Per gli zabbaleen cosa è cambiato dopo la rivoluzione? Prima lo Stato supportava questo tipo di lavoro? Ora che rapporti ci sono con il Governo? Forse è errato parlare di quest’area come periferica, ma come al solito lo è nelle coscienze dei molti che abitano una città grande come il Cairo. In tanti non conoscono l’area da Manchiyet Nasr a Mokattam e quello che ci succede, quelli che ne hanno qualche informazione mi hanno raccomandato di tenermi alla larga, per la sua pericolosità, oppure hanno sparato un netto giudizio di lussuria, inerente al grosso business creato. <<Per noi non è cambiato nulla dopo la rivoluzione, se non il fatto che prima c’era qualche organizzazione privata che chiedeva al Governo di poterci supportare finanziariamente, ma ora neanche quelle ci sono. Post-regime si sono messi dei paletti più rigidi ed ora lo Stato non permette che le organizzazioni private ci aiutino. Tuttavia né pre-Mubarak, né oggi abbiamo ricevuto aiuti economici dalle autorità egiziane>>. Chiedo al mio Virgilio della monnezza di ritornare per le strade impastate di sporcizia e metodico riciclaggio. L’intervista è meglio srotolarla lì, per capire quanto l’assurdità di questa fabbrica della spazzatura sia realmente funzionale ai risultati straordinari ottenuti in termini di raccolta e differenziazione. Ricevo il suggerimento di non filmare chi si dimostra poco disponibile, ma poi finalmente parte il nostro giro, che naturalmente si carica di becera curiosità prima e di sguardo investigativo poi, per osservare al meglio tutti i passaggi di questo incredibile trattamento dei rifiuti. Il riciclaggio è sicuramente una forma essenziale del trattamento dei rifiuti, ma le condizioni di vita immagino siano complicate qui. Quali sono gli aspetti più negativi della vita a Manchiyet Nasr e quali invece quelli che rendono questo lavoro paradossalmente appetibile? Le strade sono costantemente attraversate da carretti trainati da asini o pick-up pieni di sacchi, contenenti ogni tipo di rifiuto, visto che dalle strade e dai palazzi del Cairo non viene effettuata alcun tipo di differenziazione di buste. Arriva tutto assieme, raccolto dagli uomini e dai bambini divenuti sufficientemente forti. Una volta qui vengono poi differenziati, a mani nude, dalle donne e le ragazzine, che dalle grosse buste tirano fuori i vari materiali, scartandoli o conservandoli, passandoli poi ad altri edifici. Cani rinsecchiti fanno compagnia alla mia camminata, mentre dagli angoli polverosi spuntano dei piccoli maiali neri. Una piccola nota meritano questi animali, che in passato nel processo di differenziata erano fondamentali, visto che, divorando tutto l’organico, lasciavano nelle buste solo ciò che doveva poi essere selezionato. Nel 2009 arrivò anche in Egitto l’influenza AH5N1, che creò una vera e propria pandemia. Furono individuati i maialini come portatori di tale virus ed il Governo ne ordinò l’abbattimento. I zabbaleen, furiosi, attaccarono le istituzioni, parlando di una volontà dall’alto di boicottare il loro lavoro, favorendo così affidamento totale del servizio di raccolta dei rifiuti alle compagnie estere. D’altra parte il provvedimento causò una grossa crisi dei rifiuti, vista la perdita dell’aiuto dei maiali, utili all’eliminazione dei rifiuti alimentari. A quanto pare, nonostante sia velatamente proibito, i maialini sono ritornati ad operare e li vedo divorare tutto quello che per loro è commestibile dai grossi sacchi, che vengono issati tramite grosse carrucole, per poi essere destinati ai forni o al cumulo del materiale non riciclabile (qui solo il 20%, mentre le compagnie assoldate dalle autorità fanno esattamente il contrario: il 20% lo riciclano ed il resto finisce in discarica). Il caldo e la puzza sono impressionanti. Entro in una stanza piena di alluminio, pronto ad essere assemblato in materiale di vario genere. Un gruppo di bambine mi si fa incontro, cantandomi l’unica parola inglese imparata “Hello”, mentre le donne che raccolgono nei sacchi si nascondono da sguardo e telecamera. I canti dei muezzin sono lontani, qui, su balconi e muri, si scorgono solo figure cristiane, con incitamenti alla figura di Gesù. <<L’aspetto sicuramente più difficile riguarda l’inquinamento, che è tangibile, perché naturalmente la spazzatura è ovunque e non c’è alcun tipo di precauzione. L’altro aspetto negativo è il pregiudizio su questo tipo di lavoro, giudicato negativamente da gran parte degli egiziani e quindi si riflette sul loro giudizio verso di noi. Si tratta però di un lavoro importantissimo e senza di esso ci sarebbe spazzatura ovunque. La cosa positiva risiede invece nel fatto che comunque questa è un’attività redditizia per gli abitanti del posto, che non avrebbero altre possibilità lavorative, quindi porta soldi ed autosufficienza>>. L’anteprima del fotoreportage disponibile al seguente indirizzo: http://firstlinepress.org/fotogallery-il-villaggio-deglizabbaleen-il-trattamento-dei-rifiuti-a-mani-nude-affarianche-per-una-compagnia-italiana/#prettyPhoto[slides]/0/ 20 Il villaggio degli zabbaleen: il trattamento dei rifiuti a mani nude. Affari anche per una compagnia italiana Lorenzo Giroffi | 4 giugno 2013 Continuo ad annaspare col fiato ed a cercare l’angolo d’azzurro di cielo più vicino al mio capo, per fingere di evadere da questa cappa di suoni, sguardi curiosi ed infastiditi. In questo scenario assolutamente piano, cerco di scrutare in alto, oltre i palazzi dalle finestre che accolgono i sacchi di spazzatura e quelli ancora più in alto dai vestiti stesi, dai balconi colorati e le dimore che vivono al di là di questa fabbrica della spazzatura. Radio con le antenne arrugginite, ma le casse ben funzionanti, fanno rimbombare comunque musica, per battere il tempo delle giornate di questo posto. 21 Ci sono torri altissime in legno, poche e lontane tra di esse: svettano su tutto il villaggio. Un ragazzo, mentre passeggiamo e passiamo da un lato all’altro della strada, per fa passare i mezzi pieni di sacche, mi si avvicina, dopo aver notato il mio sguardo verso l’alto. Mi chiede qualcosa come dieci pound egiziani, così da visitare la torre e soprattutto avere una vista panoramica sul Cairo: come se fosse un’attrazione quell’ammasso di legno traballante, issato su cumuli di rifiuti. Accetto perché sono curioso di capire dall’alto quale sia la prospettiva. Mi accompagna uno sciame di ragazzini, su per questa scala che s’incastra nel centro della torre, per percorrerla fino alla sua estremità. Zaino, telecamera e piedi troppo grandi per i gradini sgangherati di questa scala. Ignorando il vuoto sotto, arriviamo su, dove il ragazzo che mi ha adescato cura un allevamento di piccioni. Ci sono voliere e tavole non proprio stabili. Prima di guardare il panorama penso al fatto che la mia visita possa terminare con il crollo goffo di questa torre ed una morte tragicomica tra la spazzatura da riciclare. Il silenzio ed il cielo da quassù possono essere afferrati. I monti stendono il Cairo, che mi si prospetta piena di tetti, strade ombrate, polvere ed un incredibile odore di quotidiano orizzonte, mentre se spingo il mio collo a strapiombo c’è la routine lavorativa che ormai mi sembra assolutamente normale: una donna dal foulard rosso nei capelli ruota le sue mani tra spazzatura e speranze, mentre un cane è tramortito su una montagna di buste. È una meraviglia che sa di finzione guardare questo panorama. Ripercorro la scala al contrario e scendo. Chiedo nuovamente delucidazioni a Bakhit Mettry, dell’organizzazione non governativa “Environment A.P.E.”, del ruolo delle compagnie private estere che hanno trovato accordi finanziari con l’Egitto per la gestione dei rifiuti. Nella sostanza gli zabbaleen, dato che non sono aiutati dalle autorità egiziane, raccolgono e riciclano grazie ad accordi stipulati con le compagnie straniere? <<Le compagnie spagnole FCC ed Urbaser Enser, assieme all’italiana AMA Arab Environmental Company, entrarono nel bel mezzo della privatizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti. Naturalmente la nostra comunità si sentì tagliata fuori ed a quel punto legittimata a compiere boicottaggio verso le compagnie private che arrivarono qui per compiere tale lavoro. Dopo qualche anno però queste ditte, che avevano ottenuto l’appalto, dovettero concedere anche agli zabbaleen un subappalto, in grado di coordinare il ciclo dei rifiuti. È un accordo informale, che però integra la nostra comunità all’interno del sistema, collaborando con tali società, a seconda delle zone della città, nella raccolta, nello smaltimento e nel trattamento. Le imprese pagano a noi un subappalto, che non comprende assicurazioni sociali o mediche, ma che assicura un lavoro ed un buon business a tutte le famiglie>>. Incredibilmente l’altalena di sensazioni ancora non si è fermata. Bakhit vuole mostrarmi l’ennesima contraddizione di questo posto. La cornice di tali monti, oltre a contenere il villaggio, i suoi odori, sudori e lavoro dalle considerazioni ambigue, tra il buon senso del riciclaggio e lo sdegno per le condizioni lavorative, custodisce anche la chiesa più grande del Medio Oriente: il monastero di San Simone. Ci lasciamo il lavoriccio alle spalle, imbocchiamo l’ennesimo viale, che questa volta però è organizzato oltre ogni canone di ordine, tra ghiaia ed addirittura bidoni della spazzatura. La minoranza copta qui è maggioranza, anche se dentro questo spiazzo silenzioso, che sembra un miracolo rispetto a qualche passo dietro, ospita pure bimbe musulmane, che giocano a palla facendo svolazzare nell’aria il loro velo. La struttura enorme contiene anche un anfiteatro che può ospitare fino a ventimila persone. Tutto ricavato dalla cava di una montagna, con bombe esplose, secondo la leggenda, nel primo giorno di Ramadan del 1975, per provocare chi in tutto il resto del Paese è maggioranza. Immagini sacre, scritte bibliche: tutto incavato nella montagna. In una pulizia che oltre a rilassarmi mi pone domande. Mi riparo nell’anfiteatro per qualche minuto. In attesa di ritornare a combattere con la strada, mettermi alla ricerca di un essere che somigli ad un tassista e smettere di fare domande su cosa possa essere lecito e cosa giusto. Gli zabbaleen riciclano. Lo fanno così, ma è il loro lavoro, la loro sussistenza. Le compagnie estere invece, che stringono affari e che godono della conoscenza di questa comunità, potrebbero forse cooperare, affinché il lavoro sia sempre qualcosa di dignitoso e non di viscidamente necessario. Mokattam potrebbe essere un posto dove i rifiuti smettano di essere un problema, visti i numeri elevatissimi di recupero del materiale. Questo bisogna farlo tutti assieme, non sulla pelle di chi lavora con la spazzatura. Anche il Marocco ha la sua Tav (e la sua resistenza No Tav) Domenico Musella | 5 giugno 2013 Non solo la Val di Susa, non solo l’Italia, non solo l’Europa. Anche sull’altra sponda del Mediterraneo infrastrutture senza alcun senso (se non quello speculativo a favore di poche grandi industrie) vengono imposte alla popolazione. La Torino-Lione del Marocco si chiama Tangeri-Casablanca. 350 km di rete ferroviaria ad alta velocità (à grande vitesserecita l’acronimo francese TGV), ma a bassa sostenibilità ambientale, umana, economica e sociale. 200 di questi sono in costruzione ex novo, collegando con una nuova linea Tangeri (nel Nord del 22 Paese) a Kenitra (nei pressi della capitale Rabat), mentre gli altri 150 saranno un potenziamento della già esistente ferrovia Kenitra-Casablanca (metropoli e “capitale economica” del Regno; a lato, una cartina). Il tutto in un progetto ancor più ampio di “grande opera”, che prevedrebbe un TGV maghrebino che colleghi Casablanca sia ad altre località del Marocco (direzioni sud-ovest e nord-est) ai centri principali di tutta l’area nordafricana fino a Tripoli, passando per Algeri e Tunisi; e, nei disegni più avveniristici, persino un TGV euromediterraneo che colleghi il Paese maghrebino con Francia e Spagna. Quella marocchina, che in questo primo tratto ricalca la costa atlantica, è la prima linea ferroviaria ad alta velocità nel mondo arabo e la seconda nel continente africano (dopo la JohannesburgPretoria in Sudafrica). La spesa prevista per la prima parte del progetto da Tangeri a Casablanca (che entrerà in funzione inizialmente a fine 2015, e a pieno regime per il 2020) è di oltre 33 miliardi di dirham, pari a circa 3 miliardi di euro, mentre complessivamente per l’intera opera si parla di un investimento di oltre 100 miliardi di dirham su scala trentennale. Da notare che il finanziamento proviene per la maggior parte dallo Stato francese, sia in forma di dono che di prestito, e da aziende sempre di provenienza transalpina; partecipano inoltre Fondi d’investimento del Kuwait, di Abu Dhabi, dell’Arabia Saudita e della Lega Araba, oltre al budget messo a disposizione dalle casse del Regno, dal Fondo che prende il nome del precedente sovrano Hassan II e dalle ferrovie statali marocchine (ONCF – Office National des Chemins de Fer). Un prospetto ben dettagliato sulla questione costi è sul sito Mamfakinch.com. Gli interrogativi su questa ennesima grande opera sono parecchi Innanzitutto, perché investire cifre stratosferiche per un treno veloce (il cui biglietto, tra l’altro, se lo potranno permettere in pochi) quando le priorità del Paese sarebbero ben altre? Il Marocco infatti è tra i Paesi con gli indicatori dello sviluppo umano più bassi, nell’area maghrebina come nel mondo (è 130esimo su 186 Paesi totali) e ci è difficile immaginare come una ferrovia veloce e di lusso possa risolvere problemi urgenti come la povertà diffusa, l’accesso all’istruzione ed alla sanità, la diseguaglianza tra i generi e la discriminazione delle minoranze. Qualcuno dirà: ma si creeranno posti di lavoro, ci sarà movimento attorno alle città che farà “girare l’economia”… in realtà se si guardano le esperienze di Tav nei Paesi europei, tutto ciò non si è mai verificato, o almeno non in misura tale da giustificare gli enormi costi di realizzazione delle opere (di recente ne abbiamo parlato su First Line Press nell’articolo “Perché è inutile la Tav” rispetto all’Italia, ma diversi autorevoli rapporti facilmente reperibili in rete parlano del “fallimento” anche della tanto esaltata alta velocità francese). Al momento dell’inaugurazione del primo cantiere, il 29 settembre 2011 a Tangeri alla presenza del re Mohammed VI, dell’allora presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy e di dignitari dei Paesi del Golfo finanziatori (foto a lato), forti sono state le polemiche contro il progetto. Dal sito indipendente Mediapart il medico, oppositore e blogger marocchino in Francia Mohammed Lachkar si schiera contro il progetto, mentre è ancora più forte e senza peli sulla lingua la critica di un altro blogger, Larbi, che in una lettera aperta a Sarkozy molto ripresa dai media ha parlato per il progetto TGV marocchino di «ricatto economico». Il termine sembra per molti aspetti aderire alla realtà. Il progetto della “Tav marocchina” risale infatti all’ottobre2007, anno del primo accordo con la Francia del neoeletto presidente Sarkozy, che ha prestato 625 milioni di euro e ne ha regalati 75 per la realizzazione dell’opera. Il Marocco di Mohammed VI aveva da poco “tradito” la Francia preferendo dotarsi dei cacciabombardieri americani F16 della Lockheed-Martin (la stessa produttrice dei contestati F35) anziché di quelli Rafale costruiti nell’Esagono dalla Dassault (il cui proprietario è un noto sostenitore proprio dei gollisti dell’UMP). Il Regno alawita, per non perdere il sostegno del suo primo partner economico (viene dalla Francia oltre il 60% degli investimenti diretti esteri in Marocco, il secondo Paese dove Parigi investe di più, dopo la Cina) viene, diciamo così, “caldamente invitato” a rimediare sottoscrivendo questo impegnativo progetto. Che coinvolge le ferrovie francesi SNCF, il gestore della rete ferroviaria d’oltralpe RFF, e la multinazionale ALSTOM, tutte aziende dell’ex “colonizzatore-protettore” che a livello economico sembra essere ancora tale. Ancora una volta, un mondo che si regge o sulla guerra e su di un’economia malsana. Tantopiù che la ALSTOM, che fornirà i vagoni del TGV è la stessa impresa che con la compatriota Veolia è attiva in Israele per costruire il tram che da Gerusalemme Ovest porta, via la palestinese Gerusalemme Est, a due colonie israeliane della Cisgiordania (un progetto “in linea” con la politica di colonizzazione sionista e giudicato contrario al diritto internazionale dalla Corte di Giustizia dell’Aia e dal Consiglio di Sicurezza Onu, come riporta anche questo articolo della versione italiana di Le Monde Diplomatique del 2008). Per quanto riguarda il processo decisionale, nessun parere sull’opera è stato chiesto ai marocchini, né la popolazione è stata informata del progetto fino alla sua presentazione ufficiale (ironia della sorte, un comunicato di qualche giorno fa ci informa invece che rappresentanti delle province denominate wilayat, sindaci e altri organismi hanno invece partecipato alla giuria che ha designato i migliori progetti artistici e architettonici per le stazioni!). Gli esistenti organismi democratici marocchini non sono stati chiamati a pronunciarsi su di un progetto deciso dal monarca e dai “poteri forti” francesi e approvato all’unanimità dal connivente ceto politico. E l’elenco dei beneficiari dell’opera probabilmente non andrà molto oltre quelli sopra citati. Tra le altre cose, si è deciso di inserire nel percorso del TGV dei centri già dotati di stazioni e collegati con la rete ferroviaria, mentre sono molte le località del Marocco non servite né da questo mezzo di trasporto, né da strade rurali dignitose, creando forti disuguaglianze anche tra le grandi città e le campagne. Corruzione e scarsità di chiarezza e trasparenza sul progetto sono anche le motivazioni addotte dalla Banca Europea degli Investimenti per il suo rifiuto di contribuire al TGV TangeriCasablanca. Fondamentale, per questo rifiuto, sarebbe stato inoltre il veto della Germania, contrariata per non aver preso anch’essa la sua fetta di torta al banchetto di questo grande affaretruffa (e a proposito di trasparenza, è proprio di questi giorni la notizia che la Commissione Europea non ha voluto render noti i dati sull’utilizzo dei fondi stanziati per la Torino-Lione). Nulla di dettagliato è previsto rispetto all’impatto ambientale dell’opera (che va dalla mutazione del paesaggio al consumo di grandi quantitativi di energia elettrica), né rispetto alla previsione di biglietti agevolati per la popolazione (il TGV si configura, 23 perciò, come un mezzo di trasporto di lusso di cui pochi potranno usufruire), né relativamente alla partecipazione di imprese marocchine all’opera. La quale sarà fonte, e questa è una certezza, di un grande aumento del debito pubblico che i marocchini porteranno sulle proprie spalle per molti anni. Per reagire a tutto ciò si è costituita da qualche anno una piattaforma di resistenza a questa infrastruttura, denominata Stop TGV, formata da associazioni come Attac Maroc, Associazione Clarté Ambition Ourage, Transparency Maroc, Iniziativa marocchina di BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni contro lo Stato d’Israele) e altre, e tra i primi ad aderire c’è stato il movimento di opposizione “20 Febbraio”. La campagna ha molta difficoltà a far sentire le sue ragioni, un po’ come tutta l’opposizione marocchina. Si sa, in queste questioni molto delicate di finanza e potere gli Stati tendono a reprimere in tutti i modi le voci contrarie (si pensi solo a quello che accade contro i No-Tav in Val di Susa). E uno di questi modi è proprio fare in modo che di loro si parli solo sporadicamente (è accaduto così per gli Stop TGV, anche sulla stampa internazionale) e citarli come minoranze di fronte al consenso unanime della classe politica al progetto. Sul sito della campagna campeggia un efficace schema con le equivalenze tra la cifra spesa per il progetto di TGV TangeriCasablanca e le opere utili e necessarie che si potrebbero realizzare con la stessa enorme valanga di denaro. Si parla di 5.000 scuole o 3.000 licei in aree urbane, oppure 25.000 scuole in aree rurali, 300 istituti di formazione tecnica con le migliori attrezzature, 25 grandi centri universitari ospedalieri con 22.000 posti letto totali, 6.000 ettari di aree industriali, 16.000 biblioteche e centri culturali, 16.000 km di strade rurali. Tanti progetti molto più utili ed urgenti per un Paese come il Marocco, piuttosto che un treno che solo a livello d’immagine sembra andare nella direzione dello sviluppo. Al Forum Sociale Mondiale di Tunisi del marzo 2013 i vari movimenti contro grandi opere inutili e dannose, da Stoccarda al Marocco, appunto, passando per la Val di Susa e Nôtre-Damedes-Landes si sono conosciuti e confrontati, da come segnala anche un articolo ripreso dalla nostra testata partner MilanoinMovimento. Sta proprio nella collaborazione e nell’attenzione reciproca su scala internazionale possibilità che i territori riescano a fermare queste infrastrutture i cui benefici sono solo privati (e di pochi), mentre i danni sono collettivi (e per molti). I gestori dell’acqua, i capitali pubblici ed i profitti privati. A Torino potrebbe cambiare Lorenzo Giroffi | 12 marzo 2013 A Torino continuiamo a tracciare una mappatura della gestione acqua in Italia. Bisogna farlo considerando lo scenario di questo bene comune come un qualcosa da preservare e perseguire in qualsiasi angolo del mondo, affinché il mercato non leda un diritto naturale, ricordando però che il servizio idrico deve fare i conti con le singole realtà locali. Quella di Torino si specchia nell’efficienza e nella cura rispettata nel centro della città. Società Metropolitana Acque Torino, meglio conosciuta come SMAT, può presentarsi come un’eccellenza per i servizi idrici che offre, per la garanzia del recupero, della depurazione e dell’accesso a tutti. Tuttavia quest’azienda, pur essendo di natura pubblica, si comporta come un qualsiasi gruppo imprenditoriale, osservando l’acqua come un settore commerciale dal quale poter trarre benefici economici, spostando il proprio raggio d’azione da una gestione locale ad una imprenditoriale extra-territoriale, che si scontra con la realtà della gestione acqua, fatta di conoscenza del luogo in cui si opera e legame con esso. SMAT ha però tutto il diritto di farlo e qui nasce il grosso equivoco. I molti sostenitori del referendum 2011, che ha abrogato i decreti utili all’inserimento del bene acqua nel mercato, restano spiazzati dinanzi alla conformazione dei gestori di natura pubblica, ma non di diritto pubblico. Il comitato Acqua Pubblica Torino chiede la trasformazione di SMAT da società per azioni, ad azienda consortile di diritto pubblico. Il comitato dopo il referendum, sentendo la responsabilità di quanto accaduto in Italia, divenuto anche esempio in ambito internazionale, non ha mai abbassato la guardia. È stata infatti chiesta all’Amministrazione Comunale di Torino una delibera utile al compimento della mutazione giuridica di SMAT. Lo scorso lunedì 4 Marzo, il Comune di Torino ha avallato tale delibera, anche se la sua attuazione sarà verificabile entro novanta giorni, nei quali saranno adottate verifiche strutturali e di bilancio affinché si accerti l’effettiva concretizzazione del processo. Il comitato cittadino Acqua Pubblica Torino, dopo aver realizzato e portato avanti la proposta, sarà tenuto fuori da questo controllo di fattibilità ed a scadenza dei tempi non potrà incidere sulla decisione. Per questo motivo incontro Andrea Sacco, appartenente al movimento. 24 Negli anni come sono nate le vostre iniziative e come quest’ultima delibera? <<Il comitato nasce nel 2007, ancor prima del successo referendario, ma da sempre ha avuto un grande sostengo popolare. L’ultima delibera vuole che SMAT, gestore dell’area torinese di oltre 280 Comuni, passi da S.p.a. ad azienda speciale consortile, perché riguardante tutto l’insieme delle Amministrazioni Comunali. Per questa delibera sono state raccolte cinquecentomila firme, appartenenti a cittadini per lo più spaesati rispetto al fatto che ancora oggi l’esisto referendario non sia stato attuato. La nostra delibera è stata poi in qualche maniera osteggiata dalle commissioni tecniche dei Comuni, che in realtà dovrebbero essere imparziali, invece sono sempre apparse in linea alle volontà politiche dei loro referenti, ponendo ostacoli alla possibilità di un’azienda pubblica, interpretando in maniera fosca il codice civile. Di fatti hanno dichiarato che non si poteva chiudere una società per azioni, già esistente, per crearne una nuova, vista la spending review. Il nostro intento però non è mai stato quello di chiudere un’azienda. Semplicemente vogliamo trasformarla, senza mettere in crisi i rapporti con i suoi attuali lavoratori>>. Perché un’azienda di capitale pubblico, come la SMAT, operante nella provincia di Torino, può essere una minaccia per la privatizzazione del bene pubblico acqua? <<Bisogna chiarire la natura dell’azienda perché in questi anni una società di diritto privato, seppur con capitali pubblici, non è mai stata garanzia dell’acqua al riparo dal mercato e dagli speculatori. Questo è confortato dai fatti. A Torino, subito dopo il referendum del 2011, che oltre all’acqua ha deciso l’impraticabilità di privatizzazione per ogni servizio pubblico, è partita una campagna di dismissioni per recuperare liquidità, come successo con la società TRN, di natura pubblica, ma comunque società per azioni, gestore dell’inceneritore e legata al ciclo dei rifiuti, che è stata messa sul mercato e venduta all’80%: in pratica è stata persa dal pubblico. Così facendo magari saniamo un anno di bilancio, ma riduciamo il patrimonio pubblico. Questo è ad esempio in contrasto con quanto viene dichiarato dal vicesindaco di Torino, Tom Dealessandri, che a parole vuole preservare i beni pubblici, ma che in pratica è parte di una Giunta che li sta svendendo. Per questo noi invochiamo una società che sia di diritto pubblico, con capitali pubblici e la partecipazione dei vari Comuni, che in questo caso sono più di 280. Così si esce proprio dal rischio del mercato. Negli anni abbiamo evitato le varie ventate di privatizzazioni della SMAT, ad esempio nella scheda di presentazione di questa società, sul sito del Comune di Torino, c’era scritto che era una società con un capitale inizialmente pubblico, siamo poi riusciti a sbarazzarsi dell’avverbio inizialmente>>. Allo stato attuale quante possibilità ha SMAT di divenire azienda di diritto pubblico? <<Noi pensavamo che i comitati promotori di questa delibera potessero partecipare alle discussioni in Consiglio Comunale, invece, una volta passata, non abbiamo più titolo per parlare o difendere tale iniziativa, proprio come successo col referendum del Giugno 2011. In Consiglio Comunale sono stati proposti emendamenti utili solo a far slittare l’attuazione, perché è stata chiesta l’istituzione di un soggetto che faccia le verifiche tecniche per gli aspetti patrimoniali e di bilancio inerenti alle ripercussioni di questa trasformazione sulle casse del Comune. Il fatto è che noi abbiamo fatto tutti questi studi nei mesi passati e si potevano compiere accertamenti durante le riunioni avute con gli uffici tecnici, che sappiamo già essere dotati di queste documentazioni, tenute però nascoste. Siamo felici perché certamente questa delibera, approvata, pone una strada verso la resa pubblica di SMAT, ma ora vogliamo sapere chi farà queste indagini, visto che gli uffici tecnici si sono già dimostrati in male fede nei nostri riguardi>>. Negli anni come sono state recepite dalla classe politica italiana le spinte popolari sul tema acqua pubblica? A Torino il gestore idrico come ha risposto al referendum? <<Il secondo quesito referendario, ovvero quello inerente alla non remunerazione del capitale investito per i gestori dei servizi idrici, non è stato ottemperato dalla SMAT, che attende, dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, ulteriori indicazioni sul recupero dei soldi necessari, insomma il solito scaricabarili. Io noto un’incoerenza politica all’interno dello stesso Partito Democratico, maggioranza nel Comune di Torino, ma che sembra più propenso a politiche liberiste rispetto invece ad un altro sindaco del Pd, Graziano Delrio, che amministra a Reggio Emilia, il quale ha proposto un nuovo consorzio, tutto pubblico, togliendo la concessione ad IRE>>. Potrebbe essere rischioso destabilizzare un gestore che comunque opera bene sul territorio, affidandosi ad un soggetto completamente pubblico? Cosa si rischia con un gestore a capitale pubblico, ma di diritto privato? <<Noi riconosciamo il fatto che SMAT a livello locale gestisca bene e che dia garanzie ai cittadini di tariffe basse, però contestiamo che abbia atteggiamenti deleteri ed in linea con la concezione dell’acqua come merce. Basti vedere gli investimenti che SMAT ha fatto nella gestione dell’acqua a Palermo, dove ne è uscita con le ossa rotta e non si capisce ancora con esattezza quanto le nostre stesse casse siano state afflitte da quest’operazione, a volte si parla di 1 milione di euro, altre volte di 14. C’è inoltre da ricordare che SMAT, con la compartecipata Acque Potabili, fa gestione anche in Calabria e ciò è incoerente con una conduzione oculata. Dunque noi vogliamo che la SMAT mantenga le sue professionalità, visto che funziona sia il monitoraggio delle acque, che la depurazione, senza aggravi sulla bolletta, come in altri posti d’Italia, dove invece vengono aggiunti costi per servizi di fognatura che non esistono. Però vogliamo che venga cambiata la politica e l’essenza di quest’azienda, che deve reinvestire gli utili nel pubblico e non in altro>>. Nella sostanza cosa rischia il bene acqua se gestita dal privato? <<Quando il soggetto è privato si riducono gli investimenti per ottimizzare il profitto, inoltre si alzano le tariffe e si perde il diritto di un bene comune, stabilito anche da una risoluzione ONU. L’acqua è poi collegata all’igiene pubblica. Storicamente, osservando le documentazioni, si è rilevato che quando si sono costruite le reti idriche nelle città, le fontane e quant’altro, si è fatto soprattutto per l’accesso all’acqua potabilizzata, utile alla riduzione di epidemie. Le fontane a moneta, come la SMAT vorrebbe realizzare, mi fanno rabbrividire. Il prototipo del soggetto privato ha già dimostrato di aver aumentato bollette, perdendo inoltre il controllo di un servizio locale. Quando una società francese o come la stessa torinese va in giro per il mondo, è chiaro che non ha la conoscenza del territorio in cui opera, del sistema delle fonti, delle sue reti e le sue sorgenti. L’utente poi per qualsiasi malfunzionamento non potrebbe avere un contatto diretto con il gestore, lontano dal Comune e dalle caratteristiche 25 del territorio>>. Arsenico nell’acqua: cronaca di un’emergenza annunciata Annalisa Marroni | 16 aprile 2013 La settimana scorsa si è riaccesa l’emergenza arsenico nei Comuni del viterbese. Pietra dello scandalo: la concentrazione “fuorilegge” di arsenico nella rete idrica dell’area che supera di netto la soglia di sicurezza prevista dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e i limiti, più blandi, fissati dalla normativa europea. Un’emergenza che priva migliaia di cittadini di accedere al bene comune primario per eccellenza: l’acqua. A lanciare l’allarme è stata la diffusione dei risultati di uno studio condotto dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS) sul rischio arsenico. A seguito di un biomonitoraggio condotto su campioni di unghie e urine di 269 volontari sani residenti nelle aree a rischio è emerso che gli abitanti della provincia di Viterbo presentano una concentrazione di arsenico nelle unghie pari a 200 nanogrammi contro la media di 82 nanogrammi del resto della popolazione. Uno dei comuni più colpiti è quello di Capranica, dove la concentrazione di questo metallo nell’acqua è pari a 43 microgrammi per litro, ben 4 volte superiore al limite consentito dalla legge. I comuni della Tuscia, però, non sono gli unici interessati da questo grave problema: anche numerosi comuni nella provincia di Roma e di Latina hanno dovuto interrompere la fornitura di acqua ai loro cittadini a causa degli alti livelli di arsenico riscontrati. ( vedi la situazione a Velletri) Arsenico: questo sconosciuto L’arsenico è un metallo pesante naturalmente presente nell’ambiente, sia in forma organica che in forma inorganica. L’uomo, attraverso l’acqua e l’assunzione di alcuni cibi (come il pane e la pasta), è esposto alla forma tossica dell’arsenico, quella inorganica, considerata un elemento cancerogeno di classe prima dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. E’ stato dimostrato, infatti, che la quotidiana e prolungata assunzione di questa sostanza aumenta il rischio di incorrere in patologie gravi come tumori alla vescica, ai polmoni e alla cute, patologie cardiovascolari come l’ictus e l’ipertensione arteriosa o anche l’insorgere del diabete. provincia di Viterbo, l’acqua potabile contiene da sempre importanti quantità di arsenico: l’acqua piovana cadendo discioglie l’arsenico naturalmente presente nelle rocce e contamina le falde acquifere. Inoltre, il ricorso a pesticidi e carboni fossili da parte dell’uomo, ha contribuito ad innalzare il livello di arsenico presente nell’ambiente. Da oltre dieci anni, con l’entrata in vigore il decreto 31 del 2001 di attuazione della direttiva comunitaria 98/93/CE in materia di qualità dell’acqua destinata al consumo umano, il limite massimo consentito di arsenico nell’acqua potabile è stato portato da 50 a 10 microgrammi al litro a causa della sua cancerogeneicità. A partire da quel momento la Regione Lazio, in cui si trovano gran parte dei comuni che presentavano (e presentano tutt’ora) alti livelli di arsenico nell’acqua, ha fatto continuamente ricorso allo strumento della deroga triennale. Si tratta di un istituto che, nell’ottica del legislatore, avrebbe consentito di procrastinare l’applicazione della legge al fine di permettere agli enti gestori di attuare i piani di rientro o di individuare altre risorse idriche. Dopo essere ricorsa a tale strumento per due volte, l’Italia ha ottenuto una terza deroga per un limite massimo di 20 microgrammi di arsenico per litro, concessa dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2012. A partire dal primo gennaio di quest’anno, quindi, gran parte dei comuni che non hanno provveduto a mettere a norma la propria rete idrica (ben 50 su 90 comuni non a norma nel 2009) sono stati obbligati a vietare il consumo dell’acqua corrente anche per gli usi legati alla cucina e, in alcuni casi, addirittura per l’igiene personale. Da molte parti si è gridato all’emergenza, anche se è improprio parlare di emergenza per una situazione che si trascina da anni. Molti gestori degli acquedotti, infatti, invece di impiegare il tempo concesso dalla deroga per mettere in sicurezza la rete idrica, hanno tergiversato continuando a fornire acqua al di fuori dei limiti di legge e contribuendo ad aggravare la situazione. Non sorprende, infatti, il dato rivelato dalla ricerca condotta dall’ISS, secondo la quale oltre all’acqua adesso sono a rischio anche gli alimenti: nel pane prodotto nell’area di Viterbo sono state rilevate concentrazioni di arsenico superiori al limite massimo consentito. Il Codacons avvierà nei prossimi giorni un’azione di risarcimento per tutte le attività commerciali danneggiate dalla vicenda. Infatti, gli esercizi commerciali che utilizzano le acque contaminate per produrre gli alimenti potrebbero essere costrette a chiudere, pagando a caro prezzo quello che è stato definito dal referente dell’Associazione italiana medici per l’ambiente della zona di Viterbo, Antonella Litta, il “menefreghismo” delle istituzioni regionali su un argomento di primaria importanza come la salute dei cittadini. Un’emergenza annunciata L’alta concentrazione di arsenico nell’acqua di numerosi comuni italiani non è un fatto nuovo, tutt’altro. Nelle zone di origine vulcanica, come l’area dei Castelli Romani e quella della 26 Sentenza Eternit: non si torni più indietro. Salute, lavoro e danni ambientali Il sindaco di Casale Monferrato, Giorgio Demezzi, si è detto soddisfatto per la sentenza, ma anche preoccupato direperire subito i soldi del risarcimento, utili a far rinascere l’area ed a ripagare, soltanto in minima parte i danni causati alle famiglie degli operai. Il sindaco si dice disposto anche ad una trattativa con Schmidheiny, questa volta però chiara e limpida per tutti. Redazione | 3 giugno 2013 Venezia si mobilita per dire No alle grandi navi e alle grandi opere Redazione | 10 giugno 2013 La giustizia: un stadio umano troppo spesso da inseguire. Oggi però sembra essersi compiuto a Torino. L’Italia è il Paese dell’Ilva e dell’Eternit, dei cementifici e delle basi militari. Arrivano però i processi che possono cambiare la storia e forse aiutare la coscienza di alcuni imprenditori, ancora convinti che tirando la corda del lavoro e della salute si possano fare buoni affari. L’eternit, materiale utilizzato per le coperture delle abitazioni, prodotto da una commistione di cemento ed amianto, messo al bando dal mercato italiano tra il 1992 ed il 1994 per accertata pericolosità, era anche il nome della compagnia che lo ha prodotto: Eternit. Chi lavorava al prodotto, portandolo poi sul mercato, era già a conoscenza, durante gli anni floridi dell’eternit, degli effetti dannosi sulla salute e sull’ambiente. L’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny è stato condannato a 18 anni di carcere, per essere stato responsabile degli impianti Eternit presenti a Torino, Bagnoli e Rubiera. L’altro imputato sarebbe dovuto essere stato il barone belga Lous de Cartier, nel frattempo però deceduto. Al Comune piemontese, maggiormente coinvolto dalla tossicità, Casale Monferrato, la corte d’appello di Torino ha riconosciuto un indennizzo di 30,9 milioni di euro. A Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, Eternit operava con lo stabilimento più grande e perciò più dannoso, per operai e cittadini, rispetto agli altri presenti in Italia. Anche la Regione Piemonte, costituitasi parte civile, si vedrà riconosciuta 20 milioni di euro. Dal 1966 al 1976 la gestione imprenditoriale Eternit non è imputabile a Schmidheiny, che è divenuto manager dell’azienda dal 1976 fino al 1986. La sentenza si conclude con l’accusa di disastro ambientale e doloso. Stiamo parlando di un processo che ha coinvolto oltre seimila persone dichiaratesi parte civile e quasi tremila morti accertati a causa della lavorazione dell’eternit. La condanna è sicuramente una cartina di tornasole per tanti disastri compiuti con consapevolezza, con la brama del guadagno facile, in Italia ed in tante altre parti del mondo. Alla mappa delle lotte contro le inutili e dannose “grandi opere” italiane, che seguiamo regolarmente sul nostro giornale, va doverosamente aggiunta Venezia, che nello scorso weekend è stata protagonista di una mobilitazione internazionale per dire no alle “meganavi” nella laguna. Il Comitato No Grandi Navi – Laguna Bene Comune, che da mesi si batte contro quella che definisce la «versione veneziana delle grandi opere» ha indetto e realizzato una tre giorni internazionale di lotta — il 7, 8 e 9 giugno — che ha visto cittadini e associazioni da varie parti del mondo partecipare a una serie di iniziative e manifestazioni per affermare con forza la sua contrarietà a dannose infrastrutture inutili, dannose e imposte dall’alto. La città lagunare è vittima da anni di un mix letale tra politica e affari che, con la completa assenza della popolazione dai processi decisionali riguardanti il proprio territorio, sta imponendo danni consistenti alla salute dei cittadini, alla sicurezza del patrimonio storico monumentale di Venezia e alla sopravvivenza dell’ecosistema della laguna. L’Autorità Portuale e la Venezia Terminal Passeggeri (VTP), gli enti responsabili della gestione del porto, permettono un’attività crocieristica e portuale al di fuori di ogni controllo e senza alcun rispetto dell’ambiente e del paesaggio (che si aggiungono ai danni prodotti dall’infrastruttura MOSE che dovrebbe “difendere dall’acqua alta”). Basti pensare che ognuna delle “meganavi” (enormi imbarcazioni che superano le 40.000 tonnellate di stazza lorda), che godono dell’autorizzazione di accedere al porto veneziano, produce lo stesso inquinamento di 14mila automobili, oltre a distruggere le fondamenta della città, incrementare il fenomeno dell’acqua alta e danneggiare la flora e la fauna della laguna. Per questo singoli e associazioni si stanno muovendo per pretendere dalle istituzioni, finora completamente asservite a lobby e multinazionali, una politica che tenga conto della sostenibilità del turismo e del 27 crocierismo per la città (qui le richieste degli attivisti). La mobilitazione è culminata domenica in due grandi manifestazioni che, prendendo in prestito un antico motto della Serenissima, hanno cercato di ostacolare i poteri forti e la speculazione «par tera e par mar» (“via terra e via mare”). In mattinata, un folto ed allegro corteo è giunto fino al porto ed ha bloccato per 5 ore l’accesso dei crocieristi alle grandi navi. Nel pomeriggio, un corteo “acqueo” ha visto decine di piccole imbarcazioni invadere il canale della Giudecca impedendo il transito alle mastodontiche navi. Insomma, un vero e proprio #OccupyLaguna in un ideale ponte di solidarietà con la piazza Taksim di#OccupyGezi. Oltre che per le proteste, il gemellaggio Venezia-Istanbul si è realizzato anche rispetto alla repressione dello Stato. Le forze dell’ordine si sono rese protagoniste di cariche contro i pacifici manifestanti, che tuttavia hanno resistito con in mano salvagenti colorati, come si può vedere nei filmati di Global Project che ha realizzato una cronaca multimediale dell’evento. Nell’ambito del percorso di #imprudenze2013 che va alla scoperta di nuove esperienze di riappropriazione e socialità, l’antropologa Silvia Jop (che abbiamo intervistato qui) ha seguito per il lavoro culturale la giornata di mobilitazione del 9 giugno in una diretta twitter. Ri-Maflow, come superare la crisi con palese di questo sistema di produzione può essere un’opportunità concreta per sperimentare nuovi modelli di lavoro, di industria e di vita d’insieme. Le cooperative di autogestione sono esperienze che esistono da sempre, ed in una situazione analoga a quella che stiamo vivendo in Europa, quella della crisi argentina dal 2006 in poi, hanno ripreso nuova linfa e sono diventate un punto di riferimento per una nuova economia ed un nuovo sistema produttivo umanamente ed ecologicamente sostenibile. Su First Line Press abbiamo accennato a Ri-Maflow proprio nel marzo scorso, con una vignetta della nostra Hobo, che ha conosciuto direttamente i lavoratori della cooperativa di Trezzano e ha realizzato gli scatti che trovate in fondo a questa pagina. Grazie a due nostri media partner indipendenti, vi invitiamo poi a scoprire più nel dettaglio questa esperienza. Per Pressenza Anna Polo ha realizzato l’intervista «Vediamo il futuro e questo è già tantissimo», ricca di spunti e con molti dettagli sulla storia di Ri-Maflow. Sulle pagine di Milano InMovimento, invece, trovate delle foto e un video dalla cooperativa, che proprio per questo weekend del 14, 15 e 16 giugno ha organizzato una tre giorni di eventi denominata Ri-PARTY. Alcune anteprime delle foto (disponibili a http://firstlinepress.org/ri-maflow-come-superare-la-crisicon-lautogestione-e-la-riconversione/#prettyPhoto[slides]/0/ ) della nostra vignettista Hobo: l’autogestione e la riconversione Redazione | 14 giugno 2013 No, non stiamo parlando dell’Argentina, ma di Trezzano sul Naviglio (Milano). Dove prima sorgeva una fabbrica di componentistica per auto, fallita grazie a una gestione orientata alla sola speculazione, ora c’è una cooperativa di lavoratori che recupera rifiuti hi-tech. Tutto questo grazie a ex-dipendenti della Maflow e di altre exfabbriche lasciati per strada, ma anche a precari, disoccupati e pensionati che non si sono persi d’animo. Al contrario, da marzo 2013 si sono messi insieme non solo per riappropriarsi del proprio destino messo a repentaglio dalla logica del profitto a tutti i costi e far ripartire un’attività economica, in un settore compatibile con l’ambiente; ma anche per dimostrare che la crisi 28 First Line Press ha iniziato la sua avventura nel novembre 2012, un modo diverso di raccontare le storie dal mondo e dall'Italia. L'abbiamo fatto proponendo documentari (uno sui nuovi metodi repressivi in Europa “Repressione ai tempi della recessione” e l’altro sulla situazione dei prigionieri politici nei Paesi Baschi “Odissea Basca”), vari videoreportages (sul caso Veolia da Londra; sui manifestanti spagnoli per l’università pubblica; sul lavoro degli immigrati in Italia, sugli intricati scenari egiziani, sulla situazione curda, su problemi ambientali italiani), reportage fotografici (dagli scontri ad Atene a quelli di Roma, dal Kurdistan all'Egitto, fino alla Cisgiordania ed alle manifestazioni studentesche italiane) e un quotidiano approfondimento su cosa succede nel mondo. _____________________ Poi c'è First Line Week che ogni martedì raccoglie articoli di approfondimento: incontri diretti dei redattori con la realtà che intendono raccontare: tra le periferie londinesi e quelle parigine, tra gli indignados a Madrid e tra le macerie di Belfast, in Egitto tra Port Said in rivolta e una Cairo che non si è placata, in un Kosovo che ancora non è pacificato, ad Atene tra gli anarchici che non dimenticano un loro ragazzo assassinato, con i migranti in Italia che non hanno un futuro, nelle istituzioni europee a Bruxelles per dialogare sulla questione curda in Turchia e un colloquio diretto col leader del PYD, partito curdo siriano. Per l’appunto tanto mondo, ma anche molta Italia. Abbiamo approfondito e stiamo approfondendo i temi come la gestione del diritto all'acqua pubblica, abbiamo raccolto testimonianze dai migranti dell'emergenza Nord Africa, delle battaglie NoTav, di quelle degli operai dell’Ilva e della gestione dei rifiuti. Il fine settimana del giornale ospita quella che un tempo si chiamava “terza pagina”, la pagina culturale, con First Line Week End, con le rubriche dei nostri bloggers. Questi parlano di disabili e di immigrazione, dell'Ilva e di Paesi in rivolta, come anche di Balcani, di musica e di cinema o anche di politica estera. Il tutto condensato da pungenti vignette, pronte a disegnare fatti di politica interna ed estera. Ci puoi trovare … sul nostro sito: www.firstlinepress.org su twitter: @FirstLinePress su facebook: First Line Press su youtube: www.youtube.com/user/FirstLinePress 29
Scarica