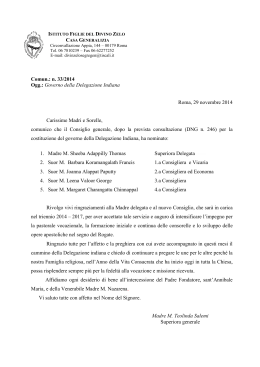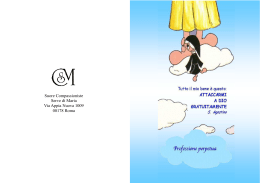S. Maria Bertilla Boscardin Tratto dal libro: RITRATTI DI SANTI di Antonio Sicari ed. Jaca Book Ci sono parole del Vangelo che noi ascoltiamo spesso, mantenendo in cuore una certa riserva; «Colui che vorrà diventare grande fra voi si farà vostro servo, e colui che vorrà diventare il primo tra voi si farà vostro schiavo» (Mt 20,26 27). E leggiamo con disagio anche la parabola degli invitati che scelgono i primi posti, mentre, secondo Gesù, è saggezza preferire l'ultimo posto, quello che ha come privilegio la possibilità che Egli, il Padrone di casa, ci guardi e ci chiami accanto a Sé, come fa un amico col suo amico. I santi, certo, hanno obbedito a questa parola. Hanno cercato con vera umiltà l'ultimo posto degli schiavi, per rassomigliare il Signore Gesù che «venne per servire e non per essere servito»; e tuttavia essi ci appaiono quasi sempre avvolti da un'aura di grandezza: grandi a volte nelle vicende della loro vita; a volte perfino nei peccati da cui dovettero essere strappati a forza; grandi per le grazie che li inondarono, o per i miracoli che li accompagnarono, o per le opere che seppero realizzare. Qualcuno di essi riuscì perfino ad essere grande nell'umiltà, nella piccolezza, come santa Teresa di Lisieux, o addirittura nella abiezione, come un san Giuseppe Benedetto Labre. Per questo a molti resta in cuore quella riserva di cui parlavamo. Che dire quando l'ultimo posto non è dato nemmeno di sceglierlo? Quando è una condizione umiliata, quotidiana, in cui si nasce e si viene a forza mantenuti, e che rovina la stessa normale crescita dell'io? Quando il «sentirsi inferiori a tutti» non è una virtù, ma un complesso che bisognerebbe affidare alle arti liberatorie dei medici della psiche? In tutti questi casi ci sembra di imbatterci in un paradosso. Coloro che sono ultimi davvero, proprio ultimi, non sono facilitati per la santità, anzi sono perfino incapaci di pensarci e di crederla possibile per sé. E poiché, nonostante le apparenze, sono in molti a sentirsi maltrattati dalla vita, ne segue che molti si sentono piuttosto esclusi dalla santità che chiamati ad essa. La Chiesa predica ai suoi figli la «vocazione universale alla santità» ma il cuore di molti obietta: ci sono condizioni e condizionamenti, che datano fin dall'infanzia e che rendono impossibile perfino una vita normale, altro che santità! Una sera d'ottobre del 1919, suor Maria Bertilla Boscardin, una suora infermiera dell'ospedale di Treviso, partecipò nella chiusa dei Carmelitani Scalzi di quella città ai festeggiamenti indetti dai Padri («triduani solenni onori» c'era scritto sulla porta del sacro edificio) per celebrare una nuova beata del loro ordine: la beata Anna di san Bartolomeo, che fu segretaria della grande Teresa d'Avila. La Chiesa sfavillava di luci, di ornamenti e di riti festosi: «facciamoci sante anche noi, sussurrò suor Bertilla alle sue compagne, ma da Paradiso, non da altare». Cercava così di mettere assieme due urgenze che le sembrava difficile conciliare: il suo profondo desiderio di santità e la coscienza della sua pochezza che nemmeno arrivava a immaginare per sé quegli onori. Ma sarebbero passati poco più di trent'anni e anche lei sarebbe stata innalzata alla «Gloria» del Bernini. La Chiesa, quando si tratta di santi, non si lascia ingannare dalle apparenze e li riconosce sia nelle vesti di un papa (Pio X visse e fu beatificato in quegli stessi anni) sia in quelle dimesse di una suora inserviente d'ospedale. Maria Bertilla aveva ricevuto questo nome, che fu di una antica e nobile badessa, al tempo dei Franchi, alla sua entrata in convento. Ma, addosso a lei, perfino quel nome solenne sembrava umile e inelegante. Al fonte battesimale l'avevano chiamata Anna Francesca; in famiglia e in paese era Annetta. Era venuta al mondo in un paesino dei Colli Berici, presso Vicenza, in una casa di contadini poveri e analfabeti. Buona la mamma, aspro e litigioso il papà. E il carattere ombroso di lui peggiorava terribilmente quando era in preda al vino e alla gelosia; allora copriva la moglie di sospetti e di rimproveri, poi di urla e di botte. I vicini sentivano le grida e scuotevano il capo; altro non potevano fare che accogliere a volte in casa loro quella bambina che fuggiva spaventata e restava lì in un angolo della loro cucina a singhiozzare e a coprirsi gli occhi con le mani. A volte Annetta si gettava in grembo alla mamma, più per proteggerla che per esser protetta; a volte riuscivano ambedue a scappare in solaio; una volta fuggirono a piedi verso Vicenza e passarono la notte sotto i portici del Santuario di Monte Berico, a piangere accanto alla Madonna. E così la bambina cresceva aggrappata alla madre, impaurita del babbo, abituata al duro lavoro di casa e dei campi, timidissima, impacciata, di scarso rendimento scolastico. Frequentò le uniche tre classi del paese e dovette ripetete la prima, una cosa strana anche per quei tempi. Così a scuola e in paese si acquistò quel nomignolo crudele, che le resterà sempre appiccicato addosso, anche in casa e in convento: «un povero oco». Se, a questo punto, dovessimo immaginare un dialogo, in cielo, tra Dio e l'Avversario (simile a quello che la Bibbia racconta a riguardo di Giobbe), potremmo dar voce alla nostra poca fede e ai dubbi di cui parlavamo, e dire al Signore dell'universo: «Ecco qua una creatura veramente umiliata; prova a farne una Santa, se ti riesce!». E Dio accettò la sfida. Non, tuttavia, traendola fuori da quella condizione di cenerentola e facendo risplendere la sua bellezza nascosta, ma semplicemente usando, nel suo disegno, proprio quelle lacerazioni che pedagogisti e psicologi sanno così bene prevedere e descrivere. Timida, impacciata, e di poco (apparente) valore, Annetta lo resterà per tutta la vita, lasciata sempre all'ultimo posto. Ma proprio là, in fondo alla tavola, Gesù la guardò con amore, come aveva promesso nella sua parabola. E la chiamò accanto al suo cuore. Se il papà era esacerbato, e la casa triste e fredda, ella imparò dalla mamma a rifugiarsi nella chiesetta del paese come in una casa. Vi andava ogni mattina, prestissimo, con gli zoccoletti sotto il braccio per non sciuparli. Là capiva davvero cosa è una famiglia e si sentiva in pace con tutti, anche con quel papi di cui nessuno l'intese mai lamentarsi. Del resto, il papà non aveva il cuore cattivo, ma era solo indurito dai dispiaceri e dal vino e a volte osservava la bimba che cercava di pregare anche in casa. Quando dovrà testimoniare, proprio lui!, ai processi canonici per la beatificazione della figlia, confesserà che, a volte, a vedere la piccina inginocchiata in qualche angolo «con le mani in cortesia» (nel modo antico di dire: «a mani giunte»), gli veniva «come un groppo in cuore» e gli pareva di «stramortire», e si sentiva spinto anche lui a dire qualche paternoster. A scuola non le badavano, considerandola un po' tarda di mente; a volte non le correggevano nemmeno i compiti e le compagne, con la crudeltà tipica dell'età, non mancavano di farglielo pesare: «Per me non fa niente», rispondeva umilmente la bambina; e davvero non provava ribellione né rabbia. Solo una volta maestra e compagne restarono a disagio davanti a lei, quasi presentendo un suo mondo sconosciuto. Durante la settimana santa l'insegnante narrò la passione di Gesù e lei, Annetta, scoppiò in un pianto sconsolato: «Piango per quello che ha patito il Signore, e gli uomini sono tanto cattivi», spiegò la bambina nel suo dialetto. E fu certo per uno sguardo più vero e profondo, posato su questa creatura, che il parroco, contro il parere e con meraviglia di tutti, l'ammise alla prima Comunione a otto anni e mezzo, quando l'età allora consentita era di undici anni. Era il 1897: a Lisieux moriva proprio in quell'anno Teresa di Gesù Bambino, la santa che avrebbe ricordato alla Chiesa e al mondo intero con quale tenerezza lo sguardo di Dio si posi su ciò che al mondo appare piccolo e debole. A dodici anni, contravvenendo ancora ai regolamenti il parroco l'accetta nell'associazione delle «Figlie di Maria», cui le ragazze potevano aspirare solo a partire dai quattordici anni. Quel santo prete le guarda nell'anima, le vuole bene e la piccola non gli sembra così ignorante. Le regala un catechismo e sembra già intuire che ella lo terrà sempre con sé e lo studierà ogni giorno: glielo troveranno addosso, nella tasca dell'abito, quando morì, a trentaquattro anni. Ma anche il parroco viene colto di sorpresa quando la ragazzina quindicenne gli dice di volersi consacrare a Dio, in un istituto qualunque, non importa, scelga pure lui. «Ma tu non sai fare niente! Le suore non saprebbero che farsene di te!». «Xe vero, sior», risponde candidamente la ragazza. E allora egli le spiega che è meglio per lei restare a casa e dare una mano nel lavoro dei campi. Ma poi il sacerdote si trova da solo davanti al Santissimo, e le cose non gli sembrano più così ovvie. Quando la rivede le dice: «Sei ancora decisa a volere entrare in convento? Di' un po': ma sai almeno pelare le patate?». «Oh sì, padre, questo si». «Va bene, non occorre altro!». Il tono burbero e allegro equivaleva alla finezza di una santa Teresa di Lisieux che in quegli stessi anni aveva osservato: «Ce n'è anche troppa di gente che sta davanti a Dio con la pretesa di esserGli utile!». E sembra di avere riascoltato, tra il parroco e la ragazza, lo stesso colloquio che qualche anno prima s'era svolto a Lourdes, tra il vescovo e l'umile Bernardette Soubirous. D'altronde tutte e tre (Bernadette, Teresa e Bertilla) sembrano davvero sorelle spirituali. Entrò dunque in convento, persuasa che le facessero un grande onore a riceverla, un favore immeritato, e che per lei l'ultimo posto sarebbe stato sempre quello giusto, quello che le toccava. E fu lieta e grata di tutto: «Mi terrò come ammessa nella casa per grazia speciale, scriveva nel suo quadernetto di appunti, e tutto ciò che mi sarà dato lo riceverò come se non lo meritassi». All'inizio il papi fu infastidito al pensiero di doverle dare quelle poche centinaia di lire ch'erano necessarie per una dote, anche la più misera, poi concluse: «Se vede che la xe destina' da quela parte... Sì, sì, ghe dago i schei e che la vada al so destin!». Così, per due volte, quel genitore che non ha saputo essere un buon padre, sa però pronunciare una parola carica di mistero e di «fede oggettiva»: intuisce un destino cui la figlia appartiene e cui egli la cede. È, in bocca sua, una forma di scontroso ma vero riconoscimento dei diritti di Dio Padre. E sarà lui ad accompagnarla al convento, tirando a mano il carrettino con la povera dote della figlia: un quadro terreno che dovette senz'altro commuovere il Padre celeste, e meriterà, a quest'uomo rozzo e poco praticante, la grazia di morire santamente, a tarda età, circondato di venerazione e di affetto a causa della figlia divenuta santa. In noviziato, ciò che Annetta, chiamata ormai suor Bertilla, avrebbe dovuto imparare a forza di ascesi e di virtù, lo conosceva già «naturalmente». Doveva imparare il fondamento di ogni vita spirituale e di ogni mistica; vale a dire: il Tutto di Dio e il nulla della creatura, su cui hanno lungamente meditato Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Giovanni della Croce e mille altri santi, e non faceva alcuna discussione né alcuna fatica. Doveva esercitarsi a conoscere Dio e a conoscere se stessa (secondo il celebre aforisma di sant'Agostino: «Noverim te, Domine, noverim me»), e lei, senza nemmeno saperlo, spiegava a una compagna quanto ciò fosse una cosa ovvia: «Quando siamo umiliate, non dobbiamo perdere tempo a pensarci sopra, ma dire al Signore: che io conosca Te, e che conosca me!». Era davvero convinta di essere «niente» e che le altre, istruite, capaci, fossero tutte migliori di lei e avessero tutte diritto alle sue premure e ai suoi servizi. Andava dalla Maestra a chiederle con una sincerità disarmante: «Io non sono buona a nulla. Sono un povero oco. Mi insegni come devo fare. Voglio farmi santa». A noi così attenti a difendere coi denti quel po' di prestigio che abbiamo guadagnato, e di cui facciamo una questione di dignità, potrebbe dare perfino fastidio vedere una creatura ridotta a tale grado di umiltà (o forse di umiliazione). Ma non dobbiamo lasciarci ingannare. Con tutta la nostra dignità noi abbiamo perfino paura o vergogna a dire di voler diventare santi. Lei lo considerava un diritto e una necessità. Come dire che la nostra pretesa dignità custodisce spesso un io fragilissimo e incerto; mentre l'umiltà e perfino l'autoumiliazione di Bertilla custodiva un io più consistente e puro del diamante. Fu il desiderio della santità, e la certezza che fosse possibile anche a lei diventarlo, con la grazia di Dio, che la protesse da ogni ripiegamento su se stessa, da ogni esaurimento nervoso o crisi esistenziale. Furono questo desiderio e questa certezza a rendere evangelico» il suo abitare all'«ultimo posto». Sempre per questo motivo, esperimentò la profonda bellezza e verità di parole come «obbedienza», «povertà», «umiltà», «silenzio», «premura». E le fu congeniale scegliere il posto meno ambito, il lavoro più faticoso, il servizio generoso e privo di lamento. «Faccio io, diceva così spesso, per compiti che nessun altro desiderava, faccio io. Tocca a me». E quando le facevano qualche torto o la trascuravano, non si crogiolava nell'offesa. Al termine del primo anno di noviziato fu destinata all'ospedale di Treviso, perché era un ambiente difficile, anche dal punto di vista morale, e si pensava che la sua umile semplicità avrebbe rinfrescato l'aria. Era un ospedale pieno di problemi, in fase di continua e lenta ristrutturazione, con reparti inadeguati e personale impreparato, teatro di lotte sindacali e politiche, di scontri virulenti tra massoni, socialisti e clericali, che spesso ricadevano sulla testa delle suore. Quando tre di esse, nel 1907, l'anno in cui giungeva Bertilla diciannovenne, furono allontanate più per dispetto che per qualche valido motivo, La voce del popolo (il settimanale diocesano) uscì con questo significativo trafiletto: «Le hanno cacciate. Erano tre angeli di carità (...) che assistevano con la massima cura e abnegazione gli ammalati (e..). Le hanno cacciate come si cacciano i ladri, dando loro otto giorni di tempo per trovare un altro tetto e un altro padrone. Le hanno cacciate il Sindaco ebreo e gli Assessori massoni, per far piacere ai farabutti socialisti...». Questo era l'ambiente e il clima. Qui trovò ad a attenderla una superiora efficiente e sbrigativa che le diede un'occhiata, la giudicò subito e la spedì nella cucina delle suore, come sguattera, senza nessuna possibilità di contatto con medici o malati. Restò per un anno intero, senza interruzioni, tra i fornelli, le pentole e l'acquaio. D'altra parte, in noviziato, ella aveva scritto questa preghiera nel suo quadernetto di appunti spirituali: «Gesù mio, ti scongiuro per le tue sante piaghe di farmi mille volte morire piuttosto che permettere che io compia una sola azione per essere veduta!». Perciò non si ribellò quando la confinarono là dove non c'era alcuna possibilità né di essere ammirati, né di compiere azioni che meritassero lo sguardo altrui. Certo, il cuore e il desiderio la spingevano piuttosto alla cura dei malati, ma le era chiesto di starsene in cucina a maneggiare stoviglie: imparò a lavare i piatti, pregando: «Signore, lavate la mia anima e preparatela alla comunione di domani». Se l'avesse fatto col lamento sulle labbra e nel cuore, allora sì sarebbe stata schiava; ma con quella preghiera, dal suo ultimo posto, guardava il Signore e questo le bastava per sentirsi invitata alla mensa stessa di Dio. Dopo un anno la richiamarono a Vicenza per la professione religiosa, benché la superiora di Treviso avesse cercato, di testa sua, di cacciarla via, tanto «era fissa nell'idea dell'incapacità di suor Bertilla». Quando fu suora a tutti gli effetti, la rimandarono ancora nell'ospedale di Treviso: «Signor, la xe ancora qua!», commentò la superiora quando se la rivide dinanzi. Lei aveva bisogno di infermiere esperte, e continuavano a mandarle quella mezza creatura. Naturalmente la rispedì un'altra volta in cucina. Ma dopo dieci giorni venne a mancare la responsabile di uno dei reparti più difficili e delicati. Dapprima la superiora scacciò come una tentazione il pensiero di affidare quella responsabilità a suor Bertilla; ma non c'era proprio nessun'altra. Pregò perfino per chiedere perdono a Dio dell'imprudenza che commetteva, poi le affidò comunque il reparto. Così, a vent'anni, Bertilla iniziò la sua missione di infermiera. Il reparto era quello dei bambini contagiosi, quasi tutti malati di difterite, da sottoporsi a tracheotomia o intubazione, bisognosi di assistenza quasi continua: una distrazione poteva costare la vita di un bambino. Oltre tutto si viveva in regime quasi continuo di urgenza, senza orari, senza contatti con l'esterno, nemmeno per la messa quotidiana. Ricordiamo che siamo in un'epoca in cui i bambini giungevano spesso «portati da lontani paesi, a notte fonda e fredda, su carrette traballanti, gravi per la setticemia in corso, cianotici per l'asfissia progressiva, bisognosi della pronta, intelligente, assistenza di tutti». Fu da un lato il contatto coi bambini, dall'altro la partecipazione a quella sofferenza così tragica e innocente che sembrarono togliere a Bertilla ogni impaccio, ogni timidezza e la resero «dolce, tranquilla, serena, sagace», come dissero i medici. Conviene rileggere le testimonianze dei dottori che la ebbero come assistente. Eccone una: «Giungono nel reparto bambini difterici; sono stati strappati dalla famiglia e si trovano in un tale stato di agitazione, di disperazione, da non poter facilmente calmarli; per due o tre giorni sono come delle bestioline, botte, pugni, rotoloni sotto il letto, rifiuto di cibo. Ora suor Bertilla riusciva rapidamente a diventare la mamma di tutti; dopo due o tre ore il bambino, prima disperato, si aggrappava a lei, tranquillo, come alle gonne della mamma, e l'accompagnava sempre nelle sue diverse mansioni. Il reparto presentava, sotto la sua azione, uno spettacolo commovente: grappoli di bambini attaccati a lei. Reparto veramente esemplare». Può sembrare solo un quadretto simpatico, ma poi i medici continuano descrivendo ciò che accadeva con i genitori quando si trattava di annunciar loro la morte del bimbo. Solo lei riusciva a trovare le parole adatte a vincere la disperazione. I dottori stessi, del resto (anche i novellini terrorizzati dal dover eseguire le prime tracheotomie» , se la trovavano accanto sempre, senza ombra di nervosismo o di stanchezza, nei momenti più critici e agitati. Succedeva perfino che, quando era ora di andarsene dall'ospedale, i ragazzini piangessero per la necessità di lasciarla e i medici si raccontavano sorridendo l'episodio di quella bambina che diceva di non poter andare via perché aveva «tanta infeziòn alla suora». «Suor Bertilla mi ha dato sempre l'impressione che sopra di lei ci fosse un essere che la spingesse e la guidasse; perché una persona che si eleva, nella sua missione di pietà e di carità, sulle altre, che pure vivono sotto le stesse leggi, agiscono sotto la stessa tensione, mentre non aveva (guardata così materialmente) nessuna qualità o d'intelligenza o di cultura che la rendesse superiore alle altre, dava realmente l'impressione che si muovesse... come dietro l'azione di un angelo che la conducesse. Non è possibile che un medico pensi a una persona la quale, come suor Bertilla, passa una, due, tre, quindici notti insonni, e si presenta sempre uguale, incurante di se stessa, senza dar segno di stanchezza e del male che la minava, se non ammettendo, ripeto, qualche cosa dentro o fuori di lei che la sublimi... Non solo, ma il fatto è che ella esercitava sugli altri una tale influenza, una tale persuasione che non è riscontrabile in altre persone...» . Da notare che il medico che così la descrive è un libero pensatore, un massone che si convertirà, come racconteremo, quando la vedrà morire «piena di gioia». Ai «contagiosi» suor Bertilla stette due anni, poi passò per tutti i reparti, lasciando dovunque, nei quindici anni della sua vita ospedaliera, lo stesso caro e santo ricordo. Raccontava una consorella che a volte, quando le suore erano a mensa, giungeva qualche nuova ricoverata. Se l'incaricata diceva: «C'è un ammalata per suor Bertilla», tutte capivano «che si trattava di una ammalata piena di miserie e di parassiti, oppure tubercolosa». Aveva abituato le altre a pensare a lei quando si presentavano situazioni particolarmente sgradevoli, da cui rifuggivano non solo gli infermieri, ma anche gli inservienti. Se la Madre le diceva di usarsi un po' di riguardo, rispondeva: «Superiora, mi pare di servire il Signore», e non si difendeva mai né dal lavoro eccessivo, né dai maltrattamenti dei malati più nervosi. Sembrava non avesse orgoglio, ma solo desiderio di amare e di servire. Nel 1915 scoppiò la grande guerra; quando il Piave divenne la linea più avanzata, il pericolo fu immediato e costante: «In questo tempo di guerra e di terrore, scrisse Bertilla nel suo solito quadernetto, io pronuncio il mio «Ecce, venio!». Eccomi, Signore, per fare la tua volontà, sotto qualunque aspetto si presenti, di vita, di morte, di terrore». Può sembrare una pia preghiera da suora. Era la scelta silenziosa ed eroica, ogni volta che i bombardamenti martellavano la città e tutti si precipitavano nei rifugi, di restare accanto ai letti dei malati intrasportabili a pregare e a distribuire bicchierini di marsala a quelli che svenivano dallo spavento. Diventava pallida, terrorizzata com'era forse più ancora degli altri, ma restava. «Non ha paura, suor Bertilla?»le chiedeva la superiora. «Non stia in pensiero, Madre, rispondeva, il Signore mi da tanta forza che la paura non la sento neppure». E così la mandarono al Lazzaretto (una dipendenza dell'ospedale), situato vicino allo snodo ferroviario, quello più preso di mira dalle incursioni aeree, a sostituire una suora che non reggeva allo spavento: «Non pensi a me, Madre, diceva alla responsabile che si sentiva un po' in colpa chiedendole questo sacrificio, mi basta di poter essere utile...». Nel 1917, dopo l'invasione del Friuli, l'ospedale dovette essere evacuato e i malati furono ripartiti in tre gruppi. Suor Bertilla partì con duecento ricoverati verso la Brianza e le affidarono gli ammalati di tifo. Poi, all'inizio del 1918 la mandarono in provincia di Como in un sanatorio per militari tubercolotici, e vi restò un anno. Raccontare come ella visse una tale Via Crucis, vorrebbe dire ripetersi; perché la santità di questa donna umile consistette proprio nella continuità, mai interrotta, di parole, gesti, atteggiamenti, decisioni che andavano sempre nella stessa direzione, con quella quotidiana fedeltà a tutta prova che è il miracolo più grande cui possiamo assistere su questa terra. E non si tratta solo di una lettera post mortem, o di una successiva rievocazione, quando si tende a veder tutto bello e buono. Già in quello stesso anno un tenente cappellano, tornato a casa guarito, sentì il dovere di scrivere una lettera alla Superiora generale, per ringraziare «per il bene che le sue Figlie operano in quella casa di pena…Fra tutte, scrisse, si distingue Suor Bertilla. Occupata presso i soldati tubercolotici, che stavano all'ultimo piano dell'albergo adibito a ospedale, ella si struggeva di cure e di carità, come farebbe una mamma per il proprio figlio, una sorella verso il fratello. Le esigenze dei poveretti, compatibili certo nel loro morbo inesorabile, erano molte, e l'organizzazione dell'ospedale rendeva assai difficile la distribuzione del necessario. Suor Bertilla che, potendo trovare del balsamo per un malato sarebbe andata sul fuoco, non si dava pace e non si sa quante volte in un giorno scendeva e risaliva la lunga scala di cento gradini per recarsi in cucina a prendere or questo, or quello...». Anni dopo, per precisare meglio, racconterà un episodio che ci fa capire, quale fosse la carità che lo meravigliava. «La crippe o spagnola aveva toccato il nostro ospedale; a decine erano le vittime del male epidemico, molti soccombettero. La febbre, da cui quasi tutti eravamo affetti, saliva a proporzioni spaventose. Si dormiva con le finestre aperte per disposizioni sanatoriali, e a temperare il freddo della notte ci si concedeva l'uso della borsa di acqua calda. Avvenne che una tarda sera di ottobre, per un guasto alla caldaia dell'acqua, è mancato quel piccolo riscaldamento. Non so dire il pandemonio avvenuto in quell'ora. A stento il vicedirettore tentò di sedare il tumulto, cercando di far convinti i soldati che, per forza maggiore, non era possibile preparare per tutti i malati l'acqua desiderata; d'altra parte gli uomini di servizio in cucina avevano diritto di riposarsi!». Ma quale fu la meraviglia di tutti quando, a tardissima notte, videro una piccola suora che girava per i letti, consegnando a ognuno la desiderata borsa d'acqua calda: «Aveva avuto la pazienza di scaldarla in piccole pentole, ad un fuoco improvvisato in mezzo al cortile... Al mattino seguente tutti parlavano di quella suora che aveva ripreso il suo ufficio senza aver riposato…». Come ricompensa trovò una superiora scrupolosa, preoccupata che Bertilla si attaccasse troppo ai suoi soldati. Certe cure le sembravano eccessive, certe preoccupazioni troppo coinvolgenti; e i malati le si affezionavano, secondo lei, esageratamente. Le tolse dunque la responsabilità del sanatorio e la destinò alla lavanderia, dove doveva secernere mucchi ributtanti di biancheria infetta. In più, siccome considerava quel lavoro di poco conto, la superiora non mancava ogni tanto di osservare (con una crudeltà di cui sono capaci i mediocri più ancora dei cattivi) che Bertilla «non si guadagnava nemmeno il pane che mangiava». Era per lei il momento della «passione». Tanto fece che la Superiora generale richiamò Bertilla alla casa-madre: «Eccomi, Madre, le disse arrivando, sono qui: una suora inutile che non può giovare alla comunità». Gesù si era servito della incomprensione delle creature per esaudire la preghiera che lei spesso gli aveva rivolto: «Per essere sempre con te, in Cielo, voglio dividere con te quaggiù tutte le amarezze di questa valle di pianto. Io ti voglio amare tanto, col sacrificio, con la croce, col patire». Chi vuole sfuggire ad ogni costo alla sofferenza, non potrà mai capire quale prodigio accada quando il desiderio di partecipare alla croce di Cristo si impadronisce di un cuore. Avviene come se la passione di Gesù per noi si rinnovasse, per la salvezza di tutti. E la Superiora generale, che le voleva bene, le affidò un compito che per Bertilla fu più che un premio. Aveva curato i bambini difterici, poi i militari tubercolotici, ora la superiora la mandava in una villa vicina a Monte Berico ad assistere i seminaristi, colpiti dall'epidemia di febbre che aveva decimato anche i seminari. Poteva così curare dei ragazzi destinati a divenire sacerdoti, le membra più preziose del Corpo di Cristo. Le note che ella segnò in quei mesi nel suo quadernetto sono tutte intrise di affetto per la Vergine Santa, come se Ella si sentisse ancora al tempo in cui la bambina s'era rifugiata con la mamma nel portico dello stesso Santuario: «O Madonna cara, io non ti chiedo visioni, né rivelazioni, né gusti, né piaceri, neanche quelli spirituali... Quaggiù io non voglio altro, se non ciò che volesti Tu nel mondo; credere pienamente, senza nulla vedere, o gustare, soffrire con gioia, senza consolazione... Lavorare assai per Te, fino alla morte». Dopo cinque mesi, poté tornare a Treviso, assegnata nuovamente ai suoi bambini contagiosi, finché fu richiesta dal primario del reparto di Medicina. Sempre la stessa bontà, la stessa umiltà, la stessa pace e lo stesso inesorabile impulso a donarsi, nonostante un tumore le divori da tempo le viscere. Ne è stata operata a vent'anni, ma il male non si è fermato. E d'altra parte lei si trascura, anche per un malinteso, invincibile senso di pudore. Spiritualmente, diventava sempre più distaccata da sé; «Io non ho niente di mio proprio tranne la mia volontà... e io, con la grazia di Gesù, sono pronta e risoluta, ad ogni costo, a non voler mai fare la mia volontà, e tutto questo per puro amore di Gesù, come se l'inferno non esistesse e neppure il paradiso, e neppure il conforto della buona coscienza...». Toccava, senza nemmeno sospettarlo, le vette cui erano giunti solo i più alti mistici. Il 16 ottobre 1922 fu a tutti evidente che non si reggeva più in piedi. A mezzogiorno la fecero visitare: il chirurgo decise di operare con urgenza, già il giorno dopo. Era stata sulla breccia fino alle ultime ore. Asportarono il tumore che ormai aveva invaso la cavità addominale, ma fu subito chiaro che non ce l'avrebbe fatta. Si sparse per l'ospedale la voce che suor Bertilla se ne moriva nella sua stanzetta e fu subito un accorrere di primari, medici, infermieri. «Neanche se fosse una santa!», disse una di quelle consorelle che l'avevano sempre creduta una scioccherella «bona da gnente». Qualcuno piangeva a vederla soffrire con tanta mitezza e lei cercava di consolarli: «Non dovete piangere. Se vogliamo vedere Gesù, bisogna morire. Io sono contenta». Parlava in dialetto, però, come aveva sempre fatto. «La ghe diga a le sorele, disse alla Madre generale, che le lavora solo par el Signor, che tuto xe gnente, che tuto xe gnente!». Il dottor Zuccardi Merli (quel libero pensatore e massone di cui abbiamo già parlato, l'osservava morire e si sentiva cambiate il cuore: «Posso affermare, testimoniò, che l'alba della mia modificazione spirituale è data dalla visione che ebbi di Suor Bertilla mentre stava per morire. Per lei infatti, alla quale baciai la mano poco prima che spirasse, il morire fu gioia visibilissima a tutti. Morì così come nessun altro io vidi morire, come chi è già in uno stato migliore di vita... Oppressa da un male dolorosissimo, dissanguata, sicura di dover morire, in quello stato in cui ordinariamente il malato si aggrappa al medico e chiede: 'salvami', udirla pronunciare con un sorriso quale io non so descrivere: 'Siate contente, sorelle, io vado presso il mio Dio', fu cosa... che mi suggerì una specie di autocritica e che ora riguardo come il primo miracolo di Suor Bertilla. Io dissi infatti tra me: 'Questa creatura è come fuori di noi, pur essendo viva. C'è in lei una parte materiale, quella che resta tra noi, che ringrazia, che conforta i circostanti; ma c'è anche una parte spirituale al di fuori, al di sopra di noi, ben più evidente e dominante: la parte spirituale che già gode di quella felicità che fu il sospiro della sua vita…». Si sente in queste parole, apparentemente difficili e complicate, il razionalista messo davanti all'evidenza del soprannaturale; colui che ha sempre negato l'anima e che è costretto quasi a vederla mentre Dio la riprende con sé e trasale di gioia, e il corpo si abbandona. Così l'umile suorina, che avevano sempre definita «un povero oco», trascinava con sé, nella sua fede, quell'intellettuale orgoglioso della sua scienza e del suo libero pensiero. Lei che moriva avendo nella tasca dell'abito il suo logoro catechismo e che era solita dire: «Io sono una povera ignorante, ma credo tutto quello che crede la Chiesa». A una consorella che l'interrogava sulla sua «vita spirituale» aveva risposto: «Io non so cosa sia 'gustare il Signore'. Mi basta essere buona a lavare i piatti e a offrire a Dio il mio lavoro. Di vita spirituale io non me ne intendo... La mia è 'la via dei carri'». Lei si sentiva sempre la contadina abituata alle strade dei campi, quelle che portano al lavoro, e sulle quali si procede alla buona, senza pretese di eleganza e senza distrazioni. Ma questa contadina sapeva scrivere, nel suo italiano pieno di errori d'ortografia, parole piene di nobiltà e di purezza: «Io e Dio solo, raccoglimento interno ed esterno, preghiera continua, questa è l'aria che respiro; lavoro continuo, assiduo, però con calma e in buon ordine. Io sono essere di Dio, Dio mi ha creata e mi conserva, ragione vuole ch'io sia tutta sua. Io cerco la felicità, ma la felicità vera la trovo solo in Dio... Devo fare la volontà di Gesù senza cercare nessuna cosa, senza volere niente, con allegrezza, con ilarità... Supplicare Gesù che mi aiuti a vincere me stessa, a capire quello che è bene e quello che è male, che mi aiuti e mi ispiri a fare ad ogni costo la Sua santa volontà, senza cercare proprio altro…». Pio XII, quando la proclamò beata nel 1952, disse: «È un modello che non sgomenta... Nella sua umiltà ella ha definito la sua strada come 'la via dei carri', la più comune, quella del Catechismo».
Scaricare