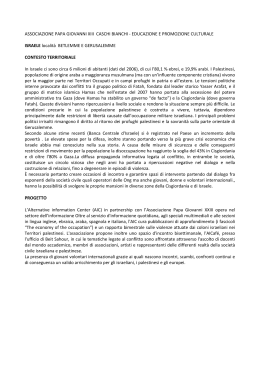RASSEGNA STAMPA giovedì 10 luglio 2014 ESTERI INTERNI LEGALITA’DEMOCRATICA RAZZISMO E IMMIGRAZIONE SOCIETA’ BENI COMUNI/AMBIENTE INFORMAZIONE CULTURA E SCUOLA INTERESSE ASSOCIAZIONE ECONOMIA E LAVORO CORRIERE DELLA SERA LA REPUBBLICA LA STAMPA IL SOLE 24 ORE IL MESSAGGERO IL MANIFESTO L’UNITÀ AVVENIRE IL FATTO PANORAMA L’ESPRESSO VITA LEFT IL SALVAGENTE INTERNAZIONALE L’ARCI SUI MEDIA Da Adn Kronos del 09/10/14 Raid israeliani su Gaza, Arci chiede l'intervento della Ue, del governo italiano e delle istituzioni internazionale per fermarli E' un appello all'Unione Europea, al governo italiano e a tutte le istituzioni internazionali a intervenire per fermare i raid e l'occupazione israeliana dei Territori palestinesi quello che viene dall'Arci, la più grande associazione italiana di promozione sociale che fa parte della 'Rete per la pace' e ha avviato la campagna 'I Say Palestina' per tenere viva l'attenzione sulle condizioni di vita dei palestinesi. Ricordando che il 9 luglio di dieci anni fa la Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato il Muro costruito in Cisgiordania illegale ai sensi del diritto internazionale, in un comunicato l'Arci denuncia che ''l'occupazione quotidiana in questi giorni si sta facendo, se possibile, ancora più feroce''. Il riferimento è alle ''rappresaglie messe in atto dal governo israeliano contro la popolazione civile palestinese'' definite ''terribili: arresti (o meglio rapimenti) di massa, bombardamenti in zone densamente abitate, raid in scuole, abitazioni, università, ospedali''. ''E questo avviene nel silenzio assordante della comunità internazionale e degli Stati Uniti'', prosegue l'associazione, che chiede ''all'Unione Europea, al nostro governo e a tutte le istituzioni internazionali di non considerare più Israele al di sopra della legge, di pretendere che cessi immediatamente il processo di colonizzazione a partire dalla demolizione del Muro con cui Israele ha realizzato una annessione di fatto di una parte rilevante di Territori palestinesi, di adoperarsi per la liberazione dei prigionieri politici''. Inoltre ''insieme alla Rete della pace, di cui siamo parte, rilanciamo l'appello di palestinesi e israeliani che ritengono che la pace sia possibile e necessaria ai due popoli, ma noi come loro siamo consapevoli che non potrà esserci nessuna pace se la comunità internazionale non interverrà e opererà per la fine dell'occupazione e della colonizzazione della terra di Palestina''. http://www.adnkronos.com/aki-it/sicurezza/2014/07/09/raid-israeliani-gaza-arci-chiedeintervento-della-del-governo-italiano-delle-istituzioni-internazionale-perfermarli_IoiSsldLY4NeEt4uGzc9IM.html Da Asca del 09/10/14 M.O.: Arci, si fermi subito processo di colonizzazione e annessione (ASCA) - Roma, 9 lug 2014 - ''Chiediamo all'Unione Europea, al nostro governo e a tutte le istituzioni internazionali di non considerare piu' Israele al di sopra della legge, di pretendere che cessi immediatamente il processo di colonizzazione a partire dalla demolizione del Muro con cui Israele ha realizzato una annessione di fatto di una parte rilevante di Territori palestinesi, di adoperarsi per la liberazione dei prigionieri politici''. Questa la posizione dell'Arci dopo i bombardamenti sui territori palestinesi. ''Insieme alla Rete della pace, di cui siamo parte, rilanciamo l'appello di palestinesi e israeliani che ritengono che la pace sia possibile e necessaria ai due popoli, ma noi come loro - si 2 aggiunge nella nota - siamo consapevoli che non potra' esserci nessuna pace se la comunita' internazionale non interverra' e operera' coerentemente, concretamente e urgentemente per la fine dell'occupazione e della colonizzazione della terra di Palestina''. red-gc/ http://www.asca.it/newsM_O___Arci__si_fermi_subito_processo_di_colonizzazione_e_annessione-1403015.html Da Redattore Sociale del 09/10/14 Raid a Gaza. Arci: “Israele non è al di sopra della legge, Ue intervenga” L’associazione chiede al governo italiano e alle istituzioni internazionali di intervenire per far cessare le rappresaglie e l’occupazione israeliana dei territori palestinesi. “Centinaia di feriti e dieci morti. Non potrà esserci la pace senza porre fine alla colonizzazione della terra di Palestina” 09 luglio 2014 - 16:57 ROMA –“Le rappresaglie messe in atto dal governo israeliano contro la popolazione civile palestinese sono terribili: arresti (o meglio rapimenti) di massa, bombardamenti in zone densamente abitate, raid in scuole, abitazioni, università, ospedali. Sono centinaia i feriti e 10 i palestinesi uccisi dalla punizione collettiva che Israele ha decretato. Chiediamo all’Unione Europea, al nostro governo e a tutte le istituzioni internazionali di non considerare più Israele al di sopra della legge”. A sottolinearlo è l’Arci in una nota. L’associazione tuona contro i raid israeliani che stanno causando vittime in queste ore nella popolazione palestinese e chiede all’Europa di “pretendere che cessi immediatamente il processo di colonizzazione a partire dalla demolizione del Muro con cui Israele ha realizzato un’annessione di fatto di una parte rilevante di Territori palestinesi, di adoperarsi per la liberazione dei prigionieri politici”. Il 9 luglio di dieci anni fa la Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato il Muro dell'Apartheid in Cisgiordania illegale ai sensi del diritto internazionale- ricorda l’Arci -. “Il muro che Israele ha voluto e costruito su territorio palestinese è una delle tante violazioni causate da 66 anni di occupazione in Palestina. Un’ occupazione quotidiana che in questi giorni si sta facendo, se possibile, ancora più feroce. Questo avviene nel silenzio assordante della comunità internazionale e degli Stati Uniti d'America”. Insieme alla Rete della pace, l’Arci rilancia quindi l'appello di palestinesi e israeliani che ritengono “che la pace sia possibile e necessaria ai due popoli, ma noi come loro siamo consapevoli che non potrà esserci nessuna pace se la comunità internazionale non interverrà e opererà coerentemente, concretamente e urgentemente per la fine dell’occupazione e della colonizzazione della terra di Palestina”. Da Globalist.it del 09/10/14 Israele non è al di sopra della legge L'Unione Europea e tutte le istituzioni devono opporsi ai raid e l'occupazione israeliana dei territori palestinesi. L'appello dell'Associazione Arci. 3 Il 9 luglio di dieci anni fa la Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato il Muro dell'Apartheid in Cisgiordania illegale ai sensi del diritto internazionale. Il muro che Israele ha voluto e costruito su territorio palestinese è una delle tante violazioni causate da 66 anni di occupazione in Palestina. Un'occupazione quotidiana che in questi giorni si sta facendo, se possibile, ancora più feroce. Le rappresaglie messe in atto dal governo israeliano contro la popolazione civile palestinese sono terribili: arresti (o meglio rapimenti) di massa, bombardamenti in zone densamente abitate, raid in scuole, abitazioni, università, ospedali. Sono centinaia i feriti e 10 i palestinesi uccisi dalla punizione collettiva che Israele ha decretato. E questo avviene nel silenzio assordante della comunità internazionale e degli Stati Uniti d'America. Chiediamo all'Unione Europea, al nostro governo e a tutte le istituzioni internazionali di non considerare più Israele al di sopra della legge, di pretendere che cessi immediatamente il processo di colonizzazione a partire dalla demolizione del Muro con cui Israele ha realizzato una annessione di fatto di una parte rilevante di Territori palestinesi, di adoperarsi per la liberazione dei prigionieri politici. Insieme alla Rete della pace, di cui siamo parte, rilanciamo l'appello di palestinesi e israeliani che ritengono che la pace sia possibile e necessaria ai due popoli, ma noi come loro siamo consapevoli che non potrà esserci nessuna pace se la comunità internazionale non interverrà e opererà coerentemente, concretamente e urgentemente per la fine dell'occupazione e della colonizzazione della terra di Palestina. http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=60254&typeb=0 Da Radio Articolo 1 del 10/10/14 ore 12:00 - Elleradio Diritti globali schiacciati dalla crisi. Intervengono S. Segio, Associazione Società informazione; L. Manconi, presidente Commissione diritti umani del Senato; F. Chiavacci, Arci; M. De Ponte, ActionAid; M. Gubbiotti, Legambiente; A.Scandurra, Antigone; Don A. Zappolini, Cnca; D. Barbi, Cgil Da Corriere.it (Corriere Fiorentino) del 09/10/14 Cecina, al via meeting antirazzista La manifestazione sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione promossa da Arci e Regione Toscana e quest’anno dal titolo Abbraccio Mediterraneo Al via a Cecina Mare la ventesima edizione del Meeting Antirazzista, la manifestazione sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione promossa da Arci e Regione Toscana e quest’anno dal titolo ‘Abbraccio Mediterraneo’. Un titolo emblematico per un evento che fino al 12 luglio tenterà di fare il punto sulla delicata questione dei flussi migratori, concentrando l’attenzione sui continui sbarchi sulle coste della Sicilia. La riflessione del Meeting si svilupperà attraverso tre tavole rotonde principali che rispettivamente affronteranno l’analisi delle cause delle migrazioni (Rotte Migranti, giovedì 10 luglio); il confronto sui percorsi di accoglienza e tutela dei diritti nei paesi del Mediterraneo (Mediterranean Civil Society: migrazioni e diritti tra nuove e vecchie democrazie; venerdì 11 luglio); la crescita, anche alla luce dell’esito delle ultime elezioni, di movimenti e partiti 4 xenofobi e razzisti in Europa (Il continente minacciato: l’Europa e il successo dei movimenti xenofobi; sabato 12 luglio). «Dobbiamo evitare che il Mediterraneo sia luogo di morte, deve essere invece un luogo dove si confrontano culture diverse» ha detto la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi durante la presentazione dell’iniziativa. Saccardi ha ribadito che «a Toscana sta continuando ad accogliere i migranti che arrivano sulle coste siciliane» ed ha annunciato che «nelle prossime ore sono in arrivo in Toscana altri 80 profughi, che si aggiungono ai 700 già previsti». E poi, in polemica verso le politiche dell’Unione Europea, ha aggiunto: «Il Mediterraneo è patrimonio dell’Europa, non soltanto dell’Italia. Speriamo che l’Europa faccia qualcosa sul fronte sbarchi e non rappresenti soltanto quell’istituzione che fa i provvedimenti sul pomodoro doc». «Abbiamo scelto di impostare questa storica edizione sull’approfondimento delle principali questioni che il Mediterraneo ci pone e crediamo che sia il momento del coraggio, affrontando una discussione seria sui canali di ingresso umanitari e sul titolo di soggiorno europeo» ha aggiunto il presidente di Arci Toscana Gianluca Mengozzi. Tra gli ospiti del Meeting ci saranno esponenti di organizzazioni e reti per la tutela dei diritti dei migranti provenienti dai Paesi della sponda sud del Mediterraneo, come Libia, Libano, Marocco, Tunisia. Tra gli appuntamenti musicali, giovedì 10 luglio ci saranno le sonorità inter-etniche di Baro Drom Orkestar e Zastava Orkestar, mentre venerdì 11 luglio giungeranno (anch’essi con venti anni di carriera alle spalle) i Modena City Ramblers. Attesi al Meeting il governatore toscano Enrico Rossi e la neopresidente dell’Arci nazionale Francesca Chiavacci. Il Meeting si svolgerà nel centro di Cecina Marina. Fulcro delle attività sarà il tendone allestito davanti al Circolo Arci II Risorgimento in piazza Sant’Andrea; gli incontri e le tavole rotonde saranno ospitati presso Villa Ginori in via Ginori 100; i concerti si terranno invece sul palco centrale di Largo Cairoli. Info su meeting.arcitoscana.it. http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2014/9-luglio-2014/cecina-viameeting-antirazzista-223541554281.shtml 5 ESTERI del 10/07/14, pag. 1/2 I razzi di Hamas sfiorano le centrali Peres: fermatevi o vi invaderemo IMPIANTI ATOMICI NEL MIRINO. OLTRE 50 VITTIME IN DUE GIORNI DI RAID AEREI ISRAELIANI DAL NOSTRO CORRISPONDENTE FABIO SCUTO GERUSALEMME SIAMO a un passo dalla guerra. Se il lancio di razzi da Gaza non cesserà Israele estenderà l’intervento e l’operazione terrestre potrebbe essere inevitabile. IL PRIMO ministro Benjamin Netanyahu, così come il presidente Shimon Peres, non nascondono i drammatici risvolti di questa crisi. Perché si fanno ogni giorno più precisi gli artiglieri di Hamas. La pioggia di razzi da Gaza ha colpito il nord, in centro e il sud di Israele fin nel cuore del deserto del Negev, dove ieri sera due M-75 si sono schiantati nella sabbia non distanti dalla centrale nucleare di Dimona. Una bordata di sette razzi ha lasciato la sua scia luminosa nel cielo buio traversando tutta la regione di Eshkol, diretti nel cuore energetico di Israele. Cinque sono stati intercettati da una batteria Iron Dome, altri due sono “passati” perché il sistema di Difesa antimissile ha stabilito che con la loro traiettoria non avrebbero colpito la centrale. È questa la nuova strategia di Hamas, della Jihad islamica e degli altri gruppi armati della Striscia che superate le divisioni adesso si dicono uniti nella “resistenza” contro l’attacco di Israele, il lancio multiplo nella speranza di “bucare” il sistema. Dagli arsenali nelle caverne scavate sotto la Striscia ieri sono usciti decine di razzi a lungo raggio, di fabbricazione cinese, russa, iraniana, siriana, contrabbandati dai tunnel sotto la frontiera col Sinai e assemblati nelle officine clandestine del braccio armato del movimento islamico. E vanno lontano. Sono arrivati fino a Hadera che dista dalla Striscia di Gaza poco meno 120 chilometri, sono in grado di tenere sotto l’incubo tutte le città israeliane, come Tel Aviv dove la giornata ieri si è aperta con altri cinque ordigni in arrivo da Gaza, intercettati tutti dalla batteria anti-missile. Ma le sirene hanno risuonato decine di volte nelle cittadine del sud a Holon, Rishon Lezzyyon, a nord a Hadera e nella zona di Haifa. Con i temibili M302s a lunga gittata: una novità che Israele imputa alle forniture dell’Iran e della Siria. Se per ora non ci sono vittime lo si deve all’ Iron Dome che ha riportato il 90 per cento di successo. Ma — come previsto dall’esercito — nessun posto in Israele sembra essere più al sicuro. Chiuso per motivi di sicurezza il piccolo aeroporto sulla Dov — alla periferia di Tel Aviv — mentre i voli al Ben Gurion arrivano e decollano solo verso nord, con cancellazioni e ritardi. Sessanta chilometri più a sud la situazione non è meno drammatica. Un diluvio di fuoco 500 tonnellate di esplosivi - si è abbattuto ieri sulla Striscia, Caccia F-16, droni con i micidiali missili “hellfire”, elicotteri da combattimento hanno martellato Gaza e con il numero dei raid è andato via via aumentando il numero delle vittime, 52 in due soli di giorni, diminuisce il numero dei miliziani uccisi mentre aumenta quello delle vittime civili. I feriti negli ospedali sono quasi cinquecento Le strade sono deserte, i negozi — tranne le panetterie — sono chiusi. L’unico luogo affollato è l’ospedale Shifa di Gaza City, dove sono trasportati i feriti. I medici affermano di non poterli assistere a dovere tutti, i più gravi andrebbero trasferiti in Egitto. Ma il valico di Rafah con il Sinai resta chiuso. Hamas ha 6 fatto appello al governo del Cairo, ma è stato inutile. Allora si è rivolto ai sentimenti più profondi del popolo egiziano. Gli ha dedicato gli attacchi condotti ieri contro Israele “nel decimo giorno del mese islamico del Ramadan”: il giorno esatto in cui, nel 1973, l’esercito egiziano sorprese Israele con una offensiva sul canale di Suez. Perché anche questo, lascia intendere Hamas, sarà un Ramadan di fuoco. Ieri sera il premier Benjamin Netanyahu ha telefonato alla cancelliera tedesca Angela Merkel, al segretario di Stato Usa John Kerry e al segretario dell’Onu Ban Ki-Moon. Per oggi è convocato il Consiglio di sicurezza. Netanyahu ha sottolineato che nessun Paese può accettare l’incessante lancio di razzi contro il proprio territorio e che Hamas è il vero responsabile dell’uccisione di civili a Gaza, poiché li usa come scudi umani. Passare all’operazione di terra resta un’opzione aperta per il premier, anzi potremmo essere proprio alla vigilia di una “Ground Operation” in grande stile. Migliaia di soldati israeliani e carri armati sono schierati ai confini di Gaza, nei campi agricoli del sud d’Israele, aspettano solo l’ordine. Ordine che potrebbe arrivare presto come ha minacciato anche il presidente israeliano Shimon Peres, tradizionalmente una “colomba” nel mondo politico israeliano. «Se non cesserà stanotte (ieri notte, ndr) il lancio di missili contro Israele, l’invasione di terra diventerà inevitabile e molto vicina», ha detto ieri sera l’anziano statista che lascerà l’incarico alla fine di questo mese. A Ramallah il presidente palestinese prosegue nella sua denuncia contro il “genocidio” del suo popolo, ha telefonato al presidente egiziano Mohammed Fattah al Sissi, ma non ha ricevuto nessuna assicurazione. Il nuovo Egitto è adesso un nemico giurato di Hamas. del 10/07/14, pag. 1/8 Il terrore di Gaza sotto i raid aerei Michele Giorgio INVIATO A GAZA Reportage. Israele sostiene di prendere di mira leader e militanti islamisti ma ci sono soprattutto donne, bambini e tanti civili innocenti tra le vittime palestinesi dei bombardamenti aerei. I morti ieri sera erano 52, 450 i feriti. La tregua resta un miraggio I dirigenti politici e i comandi militari di Israele anche ieri hanno ripetuto che «schiacceranno la testa al serpente», cioè Hamas. “Maariv” un quotidiano vicino al governo Netanyahu ha pure pubblicato le foto dei leader del movimento islamico che, al fine di costringere l’ala militare di Hamas a cessare i lanci di razzi, dovranno essere eliminati fisicamente: l’ex primo ministro di Gaza Ismail Haniyeh, Yahiya Sannour, Muhammad Dayf, Raid al-Attar, Ruhi Mishtaha e Marwan Issa. Queste intenzioni, ribadite ad ogni occasione, non trovano riscontro sul terreno. Perchè “Barriera Protettiva”, la massiccia offensiva aerea lanciata da Israele a inizio settimana sta facendo strage di civili palestinesi di tutte le età. I missili e le bombe che si abbattono sulle case palestinesi non uccidono i capi di Hamas o di altre organizzazioni armate che, sapendo di essere nel mirino di Israele, da tempo sono al riparo in rifugi segreti. Nelle quasi 60 abitazioni rase al suolo dall’aviazione israeliana nelle ultime 72 ore c’erano in prevalenza persone che non possono essere considerate un bersaglio perchè imparentate con i “ricercati”. Nelle case palestinesi inserite negli elenci di Israele ci sono soprattutto madri e bambini piccoli, che passano gran parte del tempo tra le mura domestiche. Ieri è stata un’altra ecatombe. A Maghazi la vita di Sumud Nawasrah e 7 dei suoi bimbi, Muhammad 4 anni e Nidal di pochi mesi, è terminata in un attimo, schiacciata dalle macerie della loro abitazioone centrata in pieno da una bomba ad alto potenziale. Sumud, Nidal e Mohammed meritavano di morire perchè erano figli, moglie o parenti di un esponente di Hamas o di un’altra organizzazione? Il portavoce militare israeliano spiega che a chi occupa le case viene mandato un avvertimento, via telefono. I palestinesi riferiscono anche di piccoli e poco potenti razzi che l’aereo spara contro il bersaglio prima dell’attacco vero e proprio, in modo da dare tempo ai presenti di allontanarsi. La gente spesso non scappa, perchè ritiene profondamente ingiusta la distruzione della propria casa o quella dei vicini. Oppure non si rende conto delle intenzioni israeliane. Amina Malak, una mamma di 27 anni, suo figlio di un anno e mezzo Muhammad e un ragazzo Hatim Abu Salim, 18 anni, sono morti in un attacco aereo contro un’abitazione a Zaytoun (Gaza city). I tre avevano la “colpa” di vivere nelle immediate vicinanze dell’edificio colpito. Preavvertiti gli abitanti della casa sono riusciti a mettersi in salvo: invece i tre uccisi non si erano resi conto del pericolo incombente. Sono solo alcuni fra i “casi” di questi ultimi due giorni. Non possono essere dimenticati dentro questo immenso bagno di sangue, i due fratellini di 12 e 13 anni, Amin e Mohammed Arif, 12 e 13 anni, uccisi ieri da un missile mentre erano in strada a Shajaya (Gaza city). L’elenco di vittime civili palestinesi, “danni collaterali della lotta al terrorismo”, si allunga nell’indifferenza generale: in due giorni almeno 45 morti e oltre 370 feriti. Il numero in forte aumento dei feriti, in una terra in costante emergenza umanitaria, ha subito avuto un impatto sul lavoro degli ospedali. E il ministero della salute di Gaza ha lanciato l’allarme sulla carenza di alcuni medicinali e di kit di pronto intervento. «Non ho alcuna pietà per gli israeliani, non mi importa se soffriranno perchè loro ci stanno ammazzando come bestie. Quello che voglio ora è una pioggia di razzi su Israele». Khawla Hamad pronuncia parole durissime, non prova compassione per coloro che dall’altra parte del confine fanno i conti con i razzi lanciati da Gaza. La sua rabbia è incontenibile. Poche ore prima a Beit Hanun un missile sganciato da un F-16 aveva decimato la sua famiglia. E’ stato fatto a pezzi il “bersaglio”, Hafez Hamad, un leader locale del Jihad, e assieme a lui diversi componenti della sua famiglia e un vicino: Ibrahim Mamedhmed, 26 anni, Mahdi Hamad, 46, Fawzia Hamad, 62, Mehdi Hamad 16 e Suha Hamad, 25. Poche centinaia di persone hanno partecipato ai funerali delle sei vittime. Di solito in queste occasioni i cortei funebri sono seguiti da migliaia di persone ma la gente ha paura. Teme a rimenere troppo a lungo fuori casa. E le sempre affollate strade dei campi profughi sono vuote. Come vuote sono le strade di Gaza city non risparmiata dagli attacchi aerei, decine in ogni zona della città anche se sono presi di mira soprattutto i quartieri settentrionali roccaforte del movimento islamico. In queste ore in cui i massimi leader di Israele, dal premier Netanyahu e al presidente uscente Peres, hanno chiarito che “Barriera Protettiva” non solo andrà avanti ma si espanderà presto con un’offensiva di terra, molti guardano ad Hamas per capire quali siano i suoi obiettivi a breve termine. Il movimento islamico, che ha rivendicato il lancio dei razzi a lungo raggio M360 e M75 che ieri hanno sfiorato la città di Zicron Yaacov (oltre 110 km da Gaza), chiede la fine dell’assedio di Gaza attuato da Israele (e dall’Egitto) e la liberazione delle centinaia di palestinesi arrestati dopo il rapimento in Cisgiordania dei tre ragazzi ebrei. Hamas, spiegano a Gaza, vuole anche recuperare il rapporto con l’Egitto totalmente perduto dopo il colpo di stato militare di un anno fa a danno dell’alleato presidente islamista Mohammed Morsi. Il Cairo però respinge questo riavvicinamento e i mediatori egiziani continuano a negoziare solo con il Jihad Islami. Ieri, in diretta sulle tv arabe, il leader di Hamas, Khaled Mashaal ha attribuito a Israele la responsabilità dell’escalation e condannato l’atteggiamento della comunità internazionale. 8 «Gli europei ci stanno offrendo calma per calma come se — ha protestato — avessimo cominciato noi… Netanyahu ha combattuto la riconciliazione palestinese, ha portato i negoziati di pace all’impasse e ha voltato le spalle al mondo». Infine Meshaal ha ribadito che l’ala militare di Hamas continuerà i lanci di razzi sino a quando Israele metterà per prima fine agli attacchi contro i palestinesi. A sera Hamas ha lanciato sette razzi verso Dimona (Neghev). Tre sono stati intercettati in volo, gli altri quattro sono caduti in zone desertiche. La centrale atomica non è stata colpita. Poi con l’oscurità è Gaza è stata presa dall’angoscia dei raid aerei notturni. Ieri in tarda serata giravano voci di incursioni di mezzi corazzati israeliani a nord della Striscia alla ricerca delle rampe di lancio dei razzi palestinesi. Sul sito del quotidiano israeliano Yedioth Aharonot un alto ufficiale israeliano ha affermato che i servizi segreti non dispongono di informazioni d’intelligence sui luoghi in cui sono nascosti i missili a lungo raggio. «Se sapessimo dove sono i razzi a lunga gittata – ha affermato – li avremmo già colpiti». Accanto alle operazioni militari, diversi esponenti del governo israeliano continuano a suggerire punizioni collettive contro i palestinesi. Il vice ministro della difesa Danny Danon, un falco del Likud, ha proposto di togliere immediatamente la corrente elettrica a Gaza e impedire l’ingresso nella Striscia di benzina e gasolio. Se questa minaccia fosse messa in pratica, per Gaza sarebbe un disastro simile agli attacchi aerei che sta subendo. Già oggi, per la mancanza di una produzione sufficiente, l’erogazione di energia elettrica è limitata a poche ore al giorno con gravi riflessi non solo sulla vita delle famiglie ma anche per i servizi pubblici. A cominciare a quelli sanitari e di emergenza. Del 10/07/2014, pag. 9 Pozzi contaminati e fame Gaza, carcere a cielo aperto Ora il mondo torna a ricordarsi di Gaza. Ora che ricomincia la conta dei morti e dei feriti nei raid aerei israeliani. Ora che i venti di guerra tornano a soffiare in Medio Oriente. Ma la tragedia permanente di Gaza è nella sua terribile, angosciante, invivibile «normalità». Ragazzini. Un milione e settecentomila abitanti, il 54%ha meno di 18 anni. Di quel milione e 700mila - di cui un terzo sotto la soglia di povertà - 1.303.015 sono rifugiati registrati dall’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. La fame. Tra le merci proibite anche pasta, riso datteri e marmellata. Nemmeno al tuo peggior nemico puoi augurare di «vivere» in questa prigione sventrata, con le fogne a cielo aperto, con i bambini che giocano a scalare montagne di rifiuti in una gabbia ridotta ad un cumulo di macerie, isolata dal mondo. La sete. Il caldo soffocante moltiplica il bisogno di acqua. Quasi un miraggio, un bene divenuto di lusso dopo anni di embargo. Perché nella Striscia il90%dei pozzi è chimicamente contaminato e l’acqua di casa non è potabile, per cui la gente è costretta a comprare acqua da privati. Neanche al tuo peggior nemico puoi augurare di «vivere» a Gaza. Di vivere in un paesaggio lunare, fatto di crateri che si susseguono per chilometri. «Le coste di Gaza - racconta padre Raed Abusahlia, direttore generale di Caritas Jerusalem - rappresentano ormai da tempo un disastro ecologico: tutti gli scarichi finiscono a mare, l’acqua è nera e emana un odore nauseabondo, i pesci sono tutti morti e i pescatori non possono andare a pescare in mare aperto per l’embargo. Manca la benzina, l’elettricità va via per ore e ore creando situazioni di emergenza negli ospedali». UNPAESEDI BAMBINI La realtà di Gaza supera ogni metafora - prigione, gabbia, inferno utilizzata per raccontare di una striscia di terra popolata da 1.727.069, 9 secondo l’ultimo censimento, oltre la metà minorenni. Gaza dove - secondo una recente ricerca dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi - il numero delle persone che non hanno alcuna sicurezza per l’accesso al cibo e che non dispongono dei mezzi per procurarsi i beni più essenziali come il sapone o l’acqua pulita, è triplicato dall’imposizione del blocco da parte israeliana nel giugno 2007. Gaza, dove 680mila rifugiati vivono in condizioni di povertà degradante contro 100mila all’inizio del 2007, con un tasso di disoccupazione tra i più alti al mondo: 46,8%. Gaza, dove il blocco - come denuncia la Croce Rossa «continua ad ostacolare gravemente»il trasferimento nella Striscia di attrezzature mediche essenziali, ponendo a rischio le cure immediate e le terapie a più lungo termine di migliaia di pazienti. Gaza, dove il 90% della popolazione dipende dagli aiuti alimentari distribuiti dalle agenzie dell’Onu. Gaza, uno dei territori che vanta una delle più alte densità di popolazione mondiali (5,6 abitanti per chilometro quadrato). SENZA PROTEZIONE Gaza è la più grande prigione a cielo aperto del mondo. Dalle autorità israeliane dipende il rifornimento di elettricità, di acqua e di combustibile in tutta la striscia di Gaza, le stesse autorità che presidiano i valichi e filtrano il rifornimento di generi di prima necessità, alimentari, medicinali e materiali di ricambio, bloccandone una buona parte con vari pretesti. Questa situazione di embargo ha prodotto già da molto tempo una grave crisi umanitaria per la grave carenza di medicinali e di generi alimentari presso buona parte della popolazione,maggiormente in difficoltà i bambini, i malati e le donne in gravidanza. Altissima la percentuale di mortalità infantile riscontrata a Gaza ed alto anche l’indice di malnutrizione fra i bambini, il 45% dei quali appartiene alla fascia più povera della popolazione con un elevato numero di orfani per cause di guerra. Dopo l’operazione «Piombo Fuso», che nel 2008-2009 ha provocato la morte di 1.380 palestinesi (tra cui 313 bambini), e a seguito dei bombardamenti nel novembre2012 (con174 morti, 1.399 feriti, 450case distrutte e 105scuole danneggiate nella Striscia), l’Unicef - l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia –ha condotto uno studio per la valutazione dell’esposizione dei minori alla violenza nei conflitti. Ne è risultato che a Gaza il 97% dei minori presi in esame aveva visto morti o feriti e che il 47% ha assistito direttamente all’uccisione di persone. «Per i bambini un evento così mina il senso di sicurezza. Non capiscono cosa stia succedendo e si sentono impotenti. A volte possono persino pensare di essere responsabili del disagio sofferto dalla famiglia », dice Bruce Grant, responsabile Unicef nei Territori occupati. Questa è Gaza. Semplicemente, un inferno. del 10/07/14, pag. 8 ISRAELE/PALESTINA · Egitto, Giordania, Iran e Iraq condannano Abu Mazen: «È un genocidio subito adesione alla Corte Onu» Chiara Cruciati Un genocidio. Quello in corso a Gaza è un crimine di guerra contro il popolo palestinese. Il presidente dell’Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), alza la voce e muove il primo passo a livello internazionale per fermare l’offensiva israeliana contro la Striscia. Una decisione a lungo rimandata, l’adesione alle organizzazioni e ai trattati internazionali che permetterebbero al governo di Ramallah di trascinare quello di Tel Aviv davanti alla Corte Penale Internazionale per chiedere giustizia. Ora quel passo, lasciato in standby per non interrompere il debolissimo processo di pace avviato a luglio 2013, potrebbe essere compiuto. Ieri in una riunione con i vertici dell’ANP, Abbas l’ha messo sul tavolo. Come sul 10 tavolo ha messo anche la riconciliazione con Hamas: nessuno stop, ha detto il presidente, perché «il movimento islamista è il nostro fratello di armi». «L’omicidio di intere famiglie è un genocidio da parte israeliana contro il popolo palestinese – ha detto Abbas durante il meeting d’emergenza a Ramallah – Quello che sta avvenendo è una guerra contro la gente e non contro le fazioni o i miliziani. Israele non sta difendendo se stesso, sta difendendo il progetto coloniale. Stiamo prendendo provvedimenti per fermare l’aggressione israeliana, compreso il dialogo con il presidente egiziano Al-Sisi e il segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon». Abbas ha parlato ieri mattina al telefono con Il Cairo per chiedere al nuovo presidente di mediare il cessate il fuoco, come nel novembre 2012 fece il predecessore Morsi. Ma Al-Sisi, seppur si sia subito affrettato a condannare l’offensiva israeliana, ha messo le mani avanti: l’Egitto non medierà la tregua seppure abbia mosso i propri contatti per fermare l’offensiva, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri, Badr Abdel-Atty. A monte, le cattive relazioni con Hamas, braccio palestinese dei Fratelli Musulmani, che nell’ultimo anno ha sofferto – come l’intera popolazione gazawi – delle politiche del nuovo esecutivo egiziano, figlio del golpe anti-islamista. Mentre l’esercito distruggeva i tunnel sotterranei, unico ingresso a Gaza di beni di prima necessità e carburante, fondamentale a sopravvivere all’embargo imposto da Tel Aviv, Il Cairo introduceva durissime restrizioni contro Gaza, in primis la chiusura a tempo indeterminato del valico di Rafah tra l’Egitto e la Striscia. Dall’altra parte del confine con i Territori Palestinesi, interveniva anche il secondo paese arabo che come l’Egitto ha firmato con Israele un trattato di pace. La Giordania ha fatto appello per la fine immediata dei raid dell’aviazione israeliana contro la Striscia: «Amman condanna l’aggressione militare che Israele ha lanciato contro Gaza – ha detto il portavoce governativo, Mohammed Momani – Un atto barbarico che avrà ripercussioni sull’intera regione. Israele viola il diritto internazionale e ostacola gli sforzi di pace». Parole dovute a cui sono seguite quelle del nemico numero uno di Tel Aviv, l’Iran, che ieri il premier Netanyahu ha accusato di essere il primo rifornitore di missili alle fazioni palestinesi: «Stiamo assistendo all’escalation della selvaggia aggressione sionista contro il popolo innocente di Palestina», ha commentato il portavoce del Ministero degli Esteri. E mentre a Gaza si muore, in Cisgiordania la tensione resta altissima. Le notti sono teatro di violenti scontri tra esercito israeliano e palestinesi, nei campi profughi di Aida, Dheisha, Qalandiya. La risposta israeliana è la solita: gas lacrimogeni e, sempre più spesso, proiettili veri. Ieri all’alba, vicino alla colonia di Beit El, alle porte di Ramallah, undici giovani sono rimasti feriti durante scontri con i soldati israeliani, seguiti all’incendio appiccato contro una torretta militare. Si moltiplicano i raid in Cisgiordania, da Nablus a Jenin fino a Hebron, e con loro gli arresti, in particolare di palestinesi considerati da Tel Aviv membri di Hamas o suoi sostenitori. Dietro le sbarre martedì è tornato anche Khader Adnan, ex prigioniero che condusse un lungo braccio di ferro con le autorità israeliane e che ottenne il rilascio dopo mesi di sciopero della fame. Raid anche a Gerusalemme Est, dove il target sono i minori: a Silwan, Beit Safafa e Wadi Joz in poche ore sono finiti in manette almeno cinque bambini accusati di aver lanciato pietre. Trentuno gli arresti nella Città Santa solo nella giornata di ieri. Tante le manifestazioni in solidarietà con Gaza, ma sono molto pochi quelli che immaginano un’escalation a breve delle proteste in Cisgiordania. Numerose, ma circoscritte: in tanti restano convinti che una Terza Intifada non possa scoppiare ora; il ricordo della precedente, degli interminabili coprifuoco, degli assedi violenti, delle uccisioni e delle bombe sulle città palestinesi è ancora caldo. A questo si aggiunge il ruolo finora svolto dall’Autorità Palestinese, «cane da guardia» israeliano, impegnato negli ultimi anni a reprimere ogni forma di dissenso nella consapevolezza che una possibile insurrezione 11 finirebbe per far crollare il governo di Ramallah, che ormai gode di uno scarso consenso nei Territori Occupati. del 10/07/14, pag. 1/4 LA SPIRALE INFINITA NEL CAOS MEDIORIENTALE LUCIO CARACCIOLO PARREBBE la solita storia. Hamas provoca, Israele risponde. Fitti lanci di razzi palestinesi da Gaza dapprima contro località israeliane di confine, poi verso le principali città, Gerusalemme e Tel Aviv incluse; aerei con la stella di Davide a sganciare missili “intelligenti” su Gaza, che producono decine di vittime civili; segue spedizione punitiva di Tsahal, stivali per terra nella Striscia. SALVO rientro alle basi entro un paio di settimane. Tutti pronti a ricominciare dopo congruo intervallo. Ma lo scontro in corso è davvero una replica del tragico refrain scritto dai protagonisti fin dalla crisi del dicembre 2008? Non proprio. È cambiato il contesto. E stanno rapidamente mutando i rapporti di forza all’interno delle élite dirigenti (si fa per dire) palestinesi e della leadership israeliana. Il contesto prima di tutto. Il Grande Medio Oriente si sta disintegrando. Dal Nordafrica al Levante e all’Afghanistan, trovare qualcosa che assomigli a uno Stato o anche solo a un numero di telefono contro cui vomitare minacce o con il quale tessere compromessi è impresa assai ardua. Le “primavere arabe” e le controrivoluzioni di marca saudita non hanno finora prodotto nuovi equilibri, ma guerre, miseria, precarietà. Valgano da paradigmi di questa Caoslandia il golpe egiziano con tentativo tuttora in corso di annegare nel sangue la Fratellanza musulmana; la disintegrazione della Libia; il massacro permanente sulle macerie della Siria; la mai spenta guerra civile in Iraq che in ultimo ha visto riemergere le tribù sunnite e i vedovi di Saddam, insieme ai jihadisti dell’Isis, inventori dell’improbabile “califfato” di Abu Bakr al-Baghdadi. Sullo sfondo il rischio che anche la Giordania, battuta da cotante onde sismiche, finisca per crollare. Infine i tre massimi punti interrogativi: quanto e come potrà tenere l’Arabia Saudita, che stenta a riprendere il controllo dei “suoi” jihadisti e altri agenti scagliati contro il regime di al-Assad e gli sciiti iracheni di al-Maliki - oltre che dediti a liquidare i Fratelli musulmani dovunque siano - alla vigilia di una delicatissima successione al trono? Quale fine farà il disegno dell’Iran – o di parte dei suoi leader – di rientrare a pieno titolo nella partita internazionale sacrificando le proprie ambizioni nucleari sull’altare di un accordo con gli Stati Uniti? Per conseguenza: Obama vorrà portare fino in fondo il suo ritiro dal Medio Oriente, o sarà costretto a smentirsi per non perdere quel che resta della credibilità americana nella regione e nel mondo? Nel campo palestinese, il riflesso dello tsunami regionale ha una conseguenza strategica: entrambe le sue leadership storiche sono in agonia. Per questo hanno dovuto inventare un improbabile “governo” di unità nazionale. Abu Mazen si era ridotto a fare il poliziotto per conto di Netanyahu, venendo per ciò remunerato e vezzeggiato da europei e americani. Ma la pax cisgiordana degli ultimi anni, culminata nel record del 2012 (zero morti israeliani in Giudea e Samaria), è stata minata dal recente assassinio di tre ragazzi israeliani e dalle rappresaglie che ne sono seguite. In questa vicenda è venuta in piena luce la crisi di 12 Hamas, che ha perso il controllo di centinaia di gruppuscoli jihadisti o financo “lupi solitari” che agiscono in proprio ma sono in grado di condizionare le agende altrui, Israele incluso. L’atroce uccisione di Eyal Yifrah, Gilad Shaar e Naftali Fraenkel è stata subito attribuita da Netanyahu a Hamas. Quanto meno, è una semplificazione. A compiere quel crimine sono probabilmente stati alcuni killer della tribù dei Qawasameh, basata a Hebron, che si dedica da tempo a compiere attentati per screditare la leadership di Hamas ogni volta che questa cerca di costruirsi una qualche legittimità internazionale. Una scheggia, non un referente militare della peraltro divisa leadership di Gaza. La rappresaglia contro la Striscia non potrà dunque portare a risultati duraturi, perché i mille clan jihadisti non sono bersaglio da missile. Favorirà, al contrario, la radicalizzazione di altri giovani palestinesi. Spirale infinita, ma non uguale a se stessa. A ogni giro di provocazione e rappresaglia, il gioco di violenze e controviolenze diventa più rischioso. La crisi potrà essere sedata, magari a lungo. Non risolta. Fino a ieri Netanyahu non sembrava preoccupato da tale deriva. Anzi, nel foro interno la salutava in quanto conferma dell’inaffidabilità dei “terroristi” della Striscia appena riciclati come uomini di “governo” nel patetico abbraccio con Abu Mazen e con ciò che residua del Fatah. Oggi il primo ministro israeliano rischia di fare i conti con gli effetti imprevisti del machiavellismo con cui lui, come i suoi predecessori, ha pensato di chiudere la partita palestinese giocandone le fazioni una contro l’altra. Dopo aver cercato il basso profilo nella rappresaglia contro Hamas, la pressione dell’opinione pubblica, angosciata dalla continua pioggia di razzi, lo sta spingendo ad alzare il tiro. L’estrema destra lo accusa di passività, la coalizione di governo perde pezzi (Avigdor Lieberman) e il suo aspirante successore, Naftali Bennett, affila le armi. Risultato: quarantamila riservisti sono mobilitati e una nuova campagna di terra dentro Gaza sembra imminente. Con quale obiettivo? Una soluzione radicale dovrebbe prevedere la rioccupazione della Striscia. Impossibile senza un bagno di sangue, con perdite considerevoli anche fra i soldati israeliani. Eppoi, l’ultima cosa che Gerusalemme vuole è riaccollarsi la responsabilità di quell’inferno da cui Sharon seppe smarcarsi quasi dieci anni fa. La storia non si ripete. Massimo, fa rima. E illude. Tutti i contendenti pensano di recitare un copione scritto. Anche volendo, non possono. Dentro e intorno a casa, tutti hanno preso a correre all’impazzata. Verso dove, nessuno sa. Meno che mai quelli che pensano di saperlo. del 10/07/14, pag. 9 ISRAELE · In arrivo due jet addestratori avanzati M-346 «Master» dall’Alenia Aermacchi Caccia made in Italy per i raid sulla Striscia Antonio Mazzeo Mentre nella striscia di Gaza è in atto l’operazione militare «Bordo protettivo», la più devastante degli ultimi due anni, la testata giornalistica Heyl Ha’Avir annuncia che nelle prossime ore due caccia addestratori avanzati M-346 «Master» di produzione italiana saranno consegnati alle forze armate israeliane. Si tratta dei primi velivoli prodotti dagli stabilimenti di Venegono Superiore (Varese) di Alenia Aermacchi, gruppo Finmeccanica, ordinati da Israele nel febbraio 2012. Gli M-346 giungeranno nella base di Hatzerim, nei 13 pressi di Beersheba, deserto del Negev, dove - secondo le autorità militari - saranno impiegati per la formazione di piloti e operatori di sistemi. I «Master» saranno denominati Lavi (leone, in ebraico), come il progetto per un sofisticato caccia di produzione nazionale, cancellato nel 1987 per i suoi insostenibili costi finanziari. «I Lavi consentiranno uno sviluppo qualitativo e quantitativo nell’addestramento dei futuri piloti», ha dichiarato il generale Shmuel Zucker, capo delle acquisizioni di armamenti del ministero della difesa d’Israele. Alenia Aermacchi conta di concludere la consegna dei restanti 28 esemplari entro il 2016. Il governo israeliano ha deciso di assegnare i caccia M-346 alle Tigri volanti del 102° squadrone dell’Aeronautica militare per addestrare i piloti alla guida dei cacciabombardieri di nuova generazione come «Eurofighter», «Gripen», Rafale, F-22 ed F-35, ma potranno essere utilizzati anche per attacchi al suolo con bombe e missili ariaterra o antinave. I velivoli di Alenia Aermacchi prenderanno il posto degli obsoleti TA-4 Skyhawk di produzione statunitense, alcuni dei quali furono utilizzati nei bombardamenti di Gaza nel 2010. Il primo addestratore M-346 è stato presentato il 20 marzo scorso nel corso di una cerimonia tenutasi presso lo stabilimento Alenia Aermacchi di Venegono Superiore, alla presenza di alti ufficiali del Ministero della Difesa e dell’aeronautica militare israeliana e dei partner industriali stranieri. Alla produzione dei caccia (la cui copertura finanziaria è assicurata dal gruppo UniCredit) concorrono infatti importanti aziende internazionali. Northrop Grumman Italia fornisce il sistema per la misura di assetto e direzione «Lisa 200», basato su giroscopi a fibre ottiche realizzati nello stabilimento di Pomezia; Elbit Systems, grande azienda israeliana specializzata nella realizzazione di tecnologie avanzate, sviluppa il nuovo software caricato sugli addestratori per consentire ai piloti di esercitarsi alla guerra elettronica, alla caccia alle installazioni radar e all’uso di sistemi d’arma all’avanguardia. In vista del nuovo Lavi, Elbit Systems ha costituito con Iai (Israel Aircraft Industries) il consorzio denominato «Tor», ottenendo dal governo israeliano finanziamenti per 603 milioni di dollari. Il consorzio ha già comunicato di aver completato nella base di Hatzerim la costruzione del centro di addestramento a terra destinato ad accogliere i simulatori di volo. Parte del supporto logistico e le attività di manutenzione e riparazione degli M-346 saranno garantite in loco da personale di Alenia Aermacchi, grazie ad un contratto di 140 milioni di euro sottoscritto lo scorso anno con le imprese israeliane. Altra azienda impegnata nella produzione di componenti per l’M-346 è Honeywell Aerospace Europe, con sede a Raunheim (Francoforte) ma controllata interamente dalla statunitense Honeywell International, Inc. del 10/07/14, pag. 32 L’autunno di Obama L’ultimo sondaggio dice che è “il peggiore presidente della storia americana”, la destra vuole l’impeachment, Hillary prende le distanze. Colpa delle troppe riforme che annaspano. Ma anche della crisi della politica FEDERICO RAMPINI DAL NOSTRO CORRISPONDENTE NEW YORK «MORE Jobs, Less War, Low Polls: The Obama Disconnect». La Cnn descrive così la stupefacente «sconnessione » tra i risultati di Barack Obama e il giudizio degli americani. Più occupazione, meno guerre, sondaggi a picco. «Con l’economia in crescita da cinque 14 anni, una Borsa ai massimi storici, di solito arrivano alti consensi — constata il servizio della Cnn — . Riportare a casa i soldati dal fronte ha sempre rafforzato la popolarità dei nostri presidenti. Non questa volta, non con questo presidente». Il più duro da ingoiare fra tutti i sondaggi negativi è quello dell’autorevole Quinnipiac University. Obama ne viene fuori come «il peggior presidente dalla seconda guerra mondiale». Lo considerano tale il 33% degli intervistati. Hanno meno giudizi negativi di lui perfino George W. Bush (28%), Richard Nixon che dovette dimettersi per lo scandalo Watergate (13%) e Jimmy Carter, distrutto dalla crisi degli ostaggi a Teheran (8%). Mike Allen, blogger di Politico.com e uno dei più acuti analisti politici, sottolinea un altro numero allarmante: «Il 54% considera Obama incompetente come uomo di governo, e questa percentuale va al di là del tradizionale schieramento di destra». Lo stesso presidente vede la “sconnessione” di cui parla Cnn. Nell’ultimo mese l’economia americana ha creato altri 288.000 posti di lavoro, «ma troppi americani — riconosce Obama — sono ancora in difficoltà; io spero che capiscano, anche alla luce di questi numeri, che siamo nella direzione giusta». A conferma che la situazione è grave, Hillary Clinton sta cominciando a prendere le distanze dal presidente che la nominò segretario di Stato. «La maggioranza degli americani — dichiara lei — non pensa che la ripresa economica degli ultimi cinque anni li abbia aiutati». Con cautela e diplomazia, la frase è una critica del bilancio di questa Amministrazione. La Clinton sta vivendo il dilemma tipico del (futuro) candidato che succede a due mandati di un presidente del suo stesso partito: conviene rivendicare continuità, o invece è indispensabile prendere le distanze? Meno diplomatica è la leader della destra populista Sarah Palin, ex candidata vicepresidente nel 2008: «È ora di avviare l’impeachment di Obama». Le ragioni per l’impeachment variano a ogni stagione, questa volta l’incriminazione dovrebbe scattare per la crisi degli immigrati clandestini che affluiscono dal Sud. La Palin omette un dettaglio: l’attuale emergenza-clandestini, con gli arrivi di minorenni che sperano di ottenere la regolarizzazione, è legata a una legge permissiva varata nell’ultimo anno di presidenza Bush. Nel bilancio disastroso dei sondaggi su Obama influiscono una serie di sconfitte, interne o di politica estera. La Corte suprema a maggioranza repubblicana gli ha appena inflitto due colpi: ha autorizzato l’obiezione di coscienza dei padroni se «per ragioni religiose» non vogliono pagare ai propri dipendenti l’assistenza sanitaria che includa anticoncezionali e interruzioni di gravidanza; gli stessi giudici costituzionali hanno ridotto i diritti sindacali nel pubblico impiego. Le più importanti riforme di Obama — aumento del salario minimo e nuove regole per l’immigrazione — sono arenate al Congresso, dove la destra controlla la Camera e non gli fa passare nulla. Sempre alla Camera i repubblicani usano la propria maggioranza per moltiplicare le commissioni d’inchiesta su scandali veri o presunti: ultimo in data è l’affaire degli accertamenti fiscali mirati contro organizzazioni politiche vicine alla destra (in realtà quelle organizzazioni abusano dei privilegi fiscali, raccolgono donazioni esentasse che usano in modo illecito). All’estero le difficoltà sono perfino maggiori. Obama è stato accusato di avere “perso”, a turno, prima la Crimea e poi l’Iraq. L’escalation tra il governo israeliano e Hamas nella striscia di Gaza mette a nudo l’inutilità delle mediazioni Usa in Medio Oriente. In generale l’egemonia globale degli Stati Uniti viene percepita in declino. Un giornale tradizionalmente amico come il New York Times pubblica un commento intitolato: «La politica estera di Obama è troppo europea?». La tesi: «Il presidente ha voluto abbracciare l’approccio europeo fondato sul soft power nelle relazioni internazionali. Ma non funziona». Una parte dei guai di Obama è la conseguenza di una crisi del sistema politico. L’America soffre per la sindrome che The Economist ha definito il “Mito Presidenzialista” (un male comune con la Quinta Repubblica francese). La sua Costituzione crea l’illusione che la 15 Casa Bianca sia onnipotente. Le aspettative sull’esecutivo sono enormi. In realtà gran parte dell’attività di governo — e tutto ciò che riguarda la politica di bilancio — si ferma se il Congresso non ci sta. Anche la Corte suprema ha poteri di veto e d’indirizzo molto estesi. Tutto questo genera frustrazioni e delusioni infinite in una congiuntura politica come quella attuale: con una polarizzazione estrema, e una destra che fin dal primo Inauguration Day (gennaio 2009) si è data come obiettivo principale quello di «abbattere Obama». Lontani sono i tempi delle convergenze bipartisan che consentirono a Ronald Reagan di negoziare grandi riforme con il presidente democratico della Camera, Tip O’Neill. C’è un’altra causa dell’impopolarità di Obama, evocata dal commento di Hillary Clinton sulla ripresa. La «sconnessione » che cita la Cnn ha qui la sua spiegazione. È vero, l’America entra nel suo sesto anno consecutivo di crescita economica. Qualsiasi leader europeo sarebbe felice di esibire una simile performance. E tuttavia questa ripresa è molto diseguale nella ripartizione dei benefici. Il reddito della famiglia media americana oggi è più basso del 3,7% rispetto al livello del 2009, quando la nazione era nel mezzo della recessione. Per questo una parte dei giudizi severi su Obama vengono dalla sua constituency di sinistra, da quei lavoratori che si aspettavano molto di più, quelli che la ripresa la vedono nelle statistiche ma non nelle proprie buste paga. È possibile che il giudizio futuro sia più clemente verso Obama. A consolarlo c’è questo dato: oggi il secondo miglior presidente della storia (nello stesso sondaggio Quinnipiac) è Bill Clinton, che invece alla fine della sua presidenza era odiato da metà degli americani, macchiato da scandali e quasi-impeachment. Ma perché il bilancio su Obama possa migliorare in futuro, qualcosa deve cambiare nel capitalismo americano. del 10/07/14, pag. 16 Brasile Pioverà ancora Il giorno dopo lo storico 1 a 7, il Paese galleggia in un limbo. Sulla graticola la verdeoro e l’intero sistema calcistico nazionale. Ci si aspetta che qualcosa domani accadrà. La gerontocrazia militare, che qui da sempre è padrona del calcio e dello sport, per la prima volta è accerchiata. In attesa del messaggio della presidente Dilma, che si è limitata a qualche tweet, i movimenti di protesta tornano a fremere e nelle favela di Rio si ricomincia ad accusare i politici degli sprechi. Per domenica prossima, diversi gli appuntamenti in programma. Domenica è il giorno della finale, avrebbe dovuto esserci la seleção, quasi per diritto divino Ivan Grozny MORRO DO VIDIGAL (RIO DE JANEIRO) Quando in televisione è cominciata la sfilata di commentatori e soprattutto di ex calciatori, la sensazione è che nessuno davvero, pure realizzando che qualcosa di enorme era appena accaduto, avesse capito l’entità del disastro, la portata dell’evento. Perché un passo falso del genere nessuno se lo poteva realmente aspettare. In Brasile si è portati a 16 essere sempre ottimisti quando si parla di seleção. Chi veste la maglia della nazionale è considerato speciale, quasi per diritto divino. È il sogno di tutti indossarla. Il maledetto giorno della semifinale per le strade di Rio, indistintamente dall’età e dal sesso, si vestiva solo quella maglietta. Verdeoro ovunque. Le aspettative erano tali che mai i brasiliani potevano presagire quanto accaduto. Così chi in questi mesi non ha lesinato commenti e supporto alla squadra, come la stessa presidente Dilma Roussef, da ieri è entrato in un assordante silenzio. Si aspettano a ore le sue prime dichiarazioni dopo quella che non è solo la sconfitta di una squadra ma di un intero sistema calcistico. Per ora, però, alla nazione è arrivato solo un tweet presidenziale: «Mi dispiace immensamente per tutti noi, per i tifosi, per i giocatori, ma non dobbiamo abbatterci». Come è possibile che il Brasile che sfornava craque a ripetizione oggi non riesca a esprimere se non giocatori di buono o medio livello? Se in Sudafrica si era scaricata la colpa su Felipe Melo, il capro espiatorio della spedizione del 2010, oggi la stessa operazione non si può proprio fare. A chi attribuire tutte le responsabilità? All’allenatore Felipe Scolari? Ai giocatori? Chi dei non convocati avrebbe potuto salvare la missione Coppa del Mondo? Nel tentare di dare una risposta a questi interrogativi, ci si rende conto che quanto accadrà nei prossimi giorni sarà decisivo per tante cose. La gerontocrazia militare che da sempre è padrona del calcio e dello sport in Brasile è per la prima volta nella condizione di accerchiamento. Non è ancora scattato l’attacco vero e proprio, ma si sente nell’aria. Quando parlava di calcio negli ultimi tempi in cui era in vita, Socrates, non mascherando la sua delusione, aveva sovente criticato l’atteggiamento di Lula rispetto ai dirigenti del calcio nazionale. Non capiva perché Ricardo Teixeira, allora presidente della Federazione calcio brasiliana (Cbf), nonostante il passato fortemente «antidemocratico» e gli evidenti abusi compiuti durante la sua decennale gestione, non fosse messo in discussione dalla politica. Un po’ quello che Romario ha sostenuto in quest’ultimo anno a proposito della gestione di José Maria Marin, al vertice della Cbf dal 2012. Legato anch’egli ai militari e accusato di essere il mandante dell’uccisione del giornalista V. Herzog nel 1974. Non è affatto un personaggio popolare in Brasile; è bersaglio dei manifestanti che in questi mesi hanno portato le vertenze sociali in piazza. Criticità che adesso sembrano essere tornate sul tavolo della discussione. Non ancora in maniera esplicita perché il giorno dopo l’1 a 7 si vive come in un limbo, ma la sensazione, anche solo seguendo gli account sui social network delle realtà di movimento, è che qualcosa stia ricominciando a muoversi. Per domenica prossima ci sono diversi appuntamenti in programma, in diverse città. Domenica è il giorno della finale, avrebbe dovuto esserci la seleção per quel diritto divino di cui sopra. Mancando invece la squadra nazionale e soprattutto, dopo quanto è accaduto allo stadio Mineirão di Belo Horizonte, che già ci si è affrettati a ribattezzare Mineiraço, quasi a sostituire la ferita del campionato del mondo del 1950, tutto può accadere. Anche perché durante e dopo la partita tra razzi e fuochi d’artificio sparati quasi per esorcizzare quella che è una vera e propria onta, nelle favela di Rio non solo si ricominciava ad accusare i politici degli sprechi e del resto, ma ci si sentiva fortemente offesi perché messi alla… berlina di fronte a tutto il mondo. Chi scrive si trovava a Vidigal, favela a sud di Rio de Janeiro, durante la semifinale. Una giornata di piogge torrenziali con disagi in tutta la città. I luoghi solitamente adibiti alla visione collettiva del match erano quasi vuoti a causa del maltempo. Per le strade e nei bar meno gente che nelle altre occasioni. In tanti, rimasti bloccati nel traffico, non sono riusciti a rientrare nelle case in tempo per l’inizio della partita. Visto quanto è durato l’equilibrio tra le due squadre, chi ha poi raggiunto uno schermo per la visione collettiva della partita, è arrivato a cose irrimediabilmente fatte. Mentre fiumi d’acqua invadevano le strade proprio quando la formazione di Scolari mostrava tutti i suoi limiti. Qualcuno 17 scherzando ha detto che la pioggia non era altro che lacrime dei calciatori della seleção. Pioverà ancora, di sicuro. 18 INTERNI Del 10/07/2014, pag. 4 Per il referendum abrogativo serviranno 800mila firme È PASSATA in commissione Affari costituzionali una proposta che riguarda le firme necessarie per dar luogo al referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 della Costituzione. I relatori avevano presentato un emendamento che portava il numero di sottoscrizioni dalle attuali 500 mila a un milione. La proposta che è stata approvata fissa il numero a 800 mila. L’emendamento prevede anche un giudizio preventivo di ammissibilità sul quesito da parte della Corte costituzionale, una volta raggiunta la metà delle firme necessarie, e cioè 400 mila. L’emendamento pone anche dei limiti alle materie che potranno essere oggetto di referendum: il quesito dovrà riguardare o un’intera legge o un suo articolo purché abbia un valore normativo autonomo. Vengono quindi esclusi quelli che in gergo sono chiamati “referendum manipolativi”, che abrogano solo una singola parola o una singola parte di un articolo di una legge. Maurizio Migliavacca (Pd), primo firmatario dell’emendamento che ha abbassato il numero delle firme rispetto all’ipotesi iniziale ritiene che si tratti di una “soluzione positiva”. del 10/07/14, pag. 7 LA GIORNATA Ecco il nuovo Senato: cento membri SEBASTIANO MESSINA ROMA . Il traguardo è vicino. Oggi pomeriggio la riforma del Senato approda in aula, anche se ieri sera la commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama non ha votato la fine del Senato elettivo. Lo farà stamani: garantisce il capogruppo dem Luigi Zanda. Serrati i tempi, come voleva Renzi. Lunedì dibattito no-stop dalle 11 alle 22, mercoledì già si comincia a votare. Intanto in commissione via libera a due emendamenti che cambiano il quorum per l’elezione del capo dello Stato e il numero di firme necessarie per il referendum popolare. Passano cioè da 500 mila a 800 mila. I Radicali protestano: «È contro la democrazia». Il “patto del Nazareno” tra Renzi e Berlusconi tiene, nonostante tutti i malumori. A finire ko sono le opposizioni e i “frondisti” del Pd e di Forza Italia. Avevano chiesto più tempo per il dibattito, uno slittamento di almeno una settimana. Non l’hanno ottenuto. Vogliono il Senato elettivo. Ma la forma della futura Camera delle autonomie prevederà che ciascuna regione non abbia meno di due senatori e il restante dei seggi saranno attribuiti con criterio proporzionale tenuto conto della composizione di ciascun consiglio regionale. A indicare i nuovi senatori saranno i consiglieri regionali che voteranno una lista composta anche da un sindaco. La giornata è fatta di botta e risposta e di nuove tensioni tra il governo e la maggioranza che accelerano e i dissidenti. Alla cena di mercoledì prossimo a Bruxelles per le ultime nomine Ue, il premier vuole arrivare con un primo voto sul nuovo Senato per dimostrare che l’Italia fa sul serio e ha già cominciato a 19 cambiare l’architettura istituzionale. E le riforme provocano maretta tra i 5Stelle. Forza Italia è nel caos. I Dem sono divisi e la minoranza apre il fronte Italicum, la nuova legge elettorale, che vuole sia modificata. ( g. c.) ELETTIVITÀ DI SECONDO GRADO Gli italiani non lo voteranno più 500 milioni di indennità in meno SE STAMATTINA la commissione approverà l’emendamento più scottante, gli italiani non voteranno più per il Senato. Almeno non nelle cabine elettorali. Saranno i consiglieri regionali a indicare — con una elezione di secondo grado: eletti che eleggono altri eletti — i nuovi membri di Palazzo Madama. Che non saranno più 315 ma 100, ovvero 95 tra consiglieri regionali e sindaci più 5 senatori di nomina presidenziale. Il meccanismo contenuto nell’emendamento depositato ieri pomeriggio dai relatori Finocchiaro e Calderoli prevede che le elezioni si svolgano nei Consigli regionali, con un sistema rigorosamente proporzionale destinato a impedire che chi ha la maggioranza nelle Regioni si accaparri tutti i seggi disponibili. Le votazioni avverranno su liste concorrenti, e i candidati potranno essere solo consiglieri in carica o sindaci (uno per lista). Oltre a ciascun candidato andrà indicato anche un candidato supplente, che prenderà il posto dell’eletto nel caso in cui lui, per qualsiasi ragione, decadesse dalla carica di consigliere regionale o di sindaco. Per i nuovi senatori non è più prevista l’indennità (che nella nuova formulazione della Costituzione viene riservata ai soli deputati). Se si considera che oggi un senatore senza cariche particolari oggi riceve ogni mese più di 14 mila euro — tra indennità, diaria e rimborsi forfettari per viaggi e assistenti — in questo modo lo Stato risparmierà ogni anno oltre mezzo miliardo di euro. L’ITER DELLE LEGGI Modifiche in tempi strettissimi ai testi approvati dalla Camera SCOMPARE (finalmente) il bicameralismo perfetto. Sulle leggi che esulano dalle sue nuove competenze costituzionali, il Senato potrà esprimere proposte di modifica (su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, da presentare entro dieci giorni dal momento in cui la legge verrà trasmessa a Palazzo Madama), ma in tempi strettissimi: gli emendamenti dovranno essere votati entro trenta giorni, dopodiché la legge tornerà alla Camera che entro i successivi 20 giorni si pronuncerà definitivamente (e potrà anche respingere le proposte di modifica). La procedura sarà un po’ complicata per le leggi che riguardano i poteri delle Regioni e le autonomie locali: in questi casi, per respingere le modifiche richieste dal Senato, alla Camera sarà necessaria la maggioranza assoluta dei suoi componenti (e non solo dei presenti). A differenza di quanto era stato ipotizzato in un primo momento, i senatori saranno chiamati a esprimersi anche sulle leggi di bilancio, ma dovranno votare le proposte di modifica entro 15 giorni: anche in questo caso però l’ultima parola spetterà alla Camera. Il governo, inoltre, avrà il potere di chiedere che sui provvedimenti indicati come «essenziali per l’attuazione del programma di governo» la Camera si pronunci entro il termine tassativo di 60 giorni: alla scadenza del tempo, ogni provvedimento sarà posto in votazione «senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale». COMPETENZE RIDOTTE Un ponte tra lo Stato e le Regioni diritto di parola sulla Costituzione ILNUOVO Senato non potrà occuparsi di tutto. La novità più importante è senza dubbio che non potrà più esprimere la fiducia (o la sfiducia) al governo. Il suo compito prevalente sarà quello di esercitare «la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica», ovvero Regioni e Comuni. Solo per alcune materie conserverà la funzione legislativa e i poteri di sindacato ispettivo. 20 Potrà per esempio interrogare i ministri, verificare l’attuazione delle leggi, esprimere pareri sulle nomine governative e nominare commissioni d’inchiesta sulle autonomie territoriali, ma Palazzo Madama dovranno passare solo le riforme della Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi elettorali degli enti locali e le ratifiche dei trattati internazionali. Tutte le altre saranno di competenza della Camera dei deputati. Nello stesso tempo, con la modifica del Titolo V della Costituzione, lo Stato rovescia il sistema per distinguere le sue competenze da quelle delle Regioni. Mentre oggi vengono elencate tutte le materie su cui queste ultime possono legiferare, con la riforma è lo Stato a delimitare la sua competenza esclusiva (l’elenco va dalla A alla Z, partendo dalla politica estera per arrivare agli aeroporti, passando per la produzione di energia, il governo del territorio, i beni culturali, il turismo e la tutela della salute, materie sulle quali sono sorti numerosi conflitti tra lo Stato e le Regioni). ABOLITI QUELLI A VITA Senatori di nomina presidenziale saranno cinque: in carica per 7 anni SCOMPAIONO i senatori a vita, sostituiti nel nuovo Parlamento dai senatori di nomina presidenziale. Il loro numero sarà limitato a cinque, e la durata del mandato (non ripetibile) sarà fissata in sette anni. Non cambia, invece, il criterio di scelta: dovranno essere «cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ». E gli attuali senatori a vita, che fine faranno? Oggi sono 5 (Ciampi, Monti, Cattaneo, Piano e Rubbia) e la riforma costituzionale sembrerebbe tagliata su misura per loro, perché stabilisce «la permanenza in carica dei senatori a vita già nominati». Ma ai cinque bisognerà aggiungere anche Napolitano, che alla fine del suo mandato presidenziale avrà diritto al seggio di senatore a vita che aveva ancora prima di essere eletto al Quirinale. E quindi è probabile che il nuovo Senato abbia non 100 ma 101 senatori. QUIRINALE Regole più “rigide” per eleggere il presidente della Repubblica ANCHE il prossimo presidente della Repubblica sarà eletto con alcune importanti novità. Scompariranno i delegati regionali, ma cambierà anche il numero di votazioni per le quali sarà richiesta la maggioranza dei due terzi, un quorum altissimo che solo in pochi (e tra questi Ciampi, Cossiga e Napolitano) sono riusciti a superare. Attualmente la Costituzione impone questo quorum fino al terzo scrutinio, oltre il quale è sufficiente la maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno. La nuova norma invece il quorum dei due terzi per primi quattro scrutini, poi lo fa scendere ai tre quinti nei successivi quattro, e solo alla nona votazione (non più alla quarta) lo abbassa alla maggioranza assoluta dei «grandi elettori». Un incentivo alle larghe intese, ma nulla di più: Saragat fu eletto al ventunesimo scrutinio, e Leone al ventitreesimo. del 10/07/14, pag. 3 Renzi chiama a raccolta il partito: ora l’Italicum, la fronda rientrerà Maria Teresa Meli “‘E anche questa è andata. È finita come avevo detto io: la riforma del Senato si farà. E con la legge elettorale andrà a finire nello stesso modo. Cioè si andrà avanti, si faranno alcune modifiche opportune e poi manderemo in porto anche questa storia. I dissidenti? 21 Vedrete che si troverà la quadra, esattamente come è successo a Palazzo Madama’: al solito, Matteo Renzi fa sfoggio di grande tranquillità. Non serenità che quella parola ormai in politica si utilizza sempre meno perché rischia di portare male. “Sono tranquillissimo” dice il premier conversando con i collaboratori, mentre sembra dare già per tracciato l’iter della riforma del senato. Non a caso ha convocato la direzione del Partito democratico proprio per il 24 luglio. Per quella data si deciderà della segreteria unitaria. Per quella data si vedrà chi intenderà andare contro una linea ‘discussa in riunioni su riunioni e assemblee su assemblee’. Renzi non crede che siano in molti. (…) La fronda sull’Italicum si presenta più insidiosa. E pure più ampia. Ma anche questa scadenza non sembra impensierire più di tanto il presidente del Consiglio. La maggior parte delle modifiche al testo, a dire il vero, è già stata concordata con Forza Italia e alla fine, secondo i renziani, verrà accettata dal Pd e dagli alleati. Per questa ragione il premier conta di portare a casa pure ‘questo risultato’, benché sappia che la partita in questo caso sarà più lunga. Non tanto per le interferenze grilline. Il motivo è un altro: sono in molti ad avere paura che, una volta approvata la riforma elettorale, si vada alle elezioni in primavera, magari in abbinata con le regionali. C’è chi ritiene, nel Pd, ma anche tra gli alleati di Renzi, e non solo lì, visto che Silvio Berlusconi non fa mistero di darlo per scontato, che il presidente del Consiglio a quel punto preferirà andare al voto, in modo da avere finalmente una maggioranza salda e omogenea e dei parlamentari che non siano più quelli nominati da Pier Luigi Bersani. Per questa ragione, l’altro giorno Nico Stumpo, bersaniano, veloce di comprendonio e di lingua, commentava ironico alla buvette della Camera con alcuni deputati del Pd: ‘Secondo me le riforme non si faranno troppo in fretta... certo non in tempo per sciogliere la legislatura e andare a votare nel 2015. Ci vorrà un po’ di tempo’”. Ed è esattamente il tempo che Renzi non vorrebbe perdere. E che, invece, avrebbe volentieri perso per le elezioni in Emilia-Romagna, il piano originario, infatti, era quello di andare a votare a marzo-aprile, come nelle altre Regioni, preparando le primarie per Matteo Richetti, un esponente della nuova generazione del Pd, nonché un politico che non viene dai Ds. Insemina, una bella rivoluzione per una delle Regioni rosse per eccellenza. Adesso si andrà a votare a novembre. E perciò Renzi rischia di essere costretto ad andare sull'usato sicuro (Poletti, per esempio). Non solo. Con le dimissioni di Errani, dopo la sua condanna in appello, si è aperto un contenzioso all'interno, della Conferenza Stato-Regioni. Chi la guiderà adesso che il governatore dell'Emilia se ne è andato? Enrico Rossi, presidente della Toscana, spesso e volentieri in polemica con Renzi, punta alla ricandidatura e quindi vorrebbe quella poltrona, perché lo rafforzerebbe. Per lo stesso identico motivo la desidera anche la governatrice dell'Umbria, Katiuscia Marini. Nicola Zingaretti potrebbe essere un altro candidato, visto che guida una regione importante. Ma c'è chi sostiene che tra il presidente del Lazio e il premier non corrano buonissimi rapporti. Comunque Renzi affronterà questa vicenda a tempo debito. Ieri, anche in vista del Consiglio dei ministri di oggi, si è concentrato sul problema dei decreti attuativi. E ha sollecitato soprattutto quelli sulla riforma delle Province che avrebbero dovuto essere emanati ai primi di luglio. Del 10/07/2014, pag. 4 Caos sull’assemblea, Forza Italia si spacca Ma basta, sembriamo il Brasile!». Alle otto di sera di una giornata di follia politicoorganizzativa, Maurizio Gasparri sbotta. «La gestione di questo partito è inadeguata, non possiamo andare avanti così, serve al più presto un gruppo dirigente che sostenga 22 Berlusconi nella sua guida. Attenzione, perché anche i pompieri diventano prima osservatori e poi incendiari… ». Lo sfogo è quello di chi ha assistito attonito, come buona parte dei colleghi, al confusissimo intreccio di convocazioni, sconvocazioni, riconvocazioni di gruppi di Senato e Camera, con e senza la presenza di Berlusconi, che hanno fatto tracimare la tensione nel partito oltre il livello di guardia. Perché i malumori già diffusissimi per la linea che il Cavaliere pretende sulle riforme (un sì senza defezioni) si sommano e si intrecciano ormai a battaglie personali, politiche, familiari senza fine e soluzione. Ricapitolando: la mattinata si apre con la convocazione per stamattina da parte del capogruppo Paolo Romani di una riunione del gruppo del Senato per mettere a punto la linea sulle riforme. Una scelta «obbligata, per tentare di pararsi dall’ira dei senatori» — spiega chi lo contesta — visto che peraltro una raccolta di firme per la convocazione del gruppo, animata da senatori vicini a Raffaele Fitto, aveva già raccolto oltre 20 adesioni, un terzo del gruppo. Il segnale era chiaro: il dissenso a Palazzo Madama è molto più ampio di quello visibile ed esplicito rappresentato da Minzolini, Bonfrisco e pochi altri. Anzi — alimentata anche dal nutrito gruppo di chi si riconosce nelle posizioni di Fitto che ieri ha contestato le riforme («Avrei problemi a votarle») e preteso una riunione dei gruppi congiunta così come era stato promesso una settimana fa — l’onda della protesta si è alzata anche alla Camera. Lì, raccontano, Renato Brunetta — uno dei più duri sulla linea del no a una riforma imposta in tutto e per tutto da Renzi — ha fatto fuoco e fiamme. Convocando a sua volta una riunione del suo gruppo, alla stessa ora di quella del Senato perché «queste materie riguardano tutto il partito », e in attesa di quella «che mi attendo nei prossimi giorni, congiunta, con Berlusconi». E mentre il Cavaliere veniva dato per presente a quella del Senato prevista per stamattina, e subito dopo a pranzo con gli eurodeputati (Fitto compreso, appuntamento confermato), la tensione saliva alle stelle. Tanto da obbligarlo a mettere uno stop alle proteste montanti e a chiedere ai suoi due capigruppo di sconvocare entrambe le riunioni: «Ne faremo una congiunta martedì prossimo ». «Bene, ha vinto la leadership di Berlusconi!», ha esultato subito Brunetta. Ma sul terreno restano i cocci. Anche perché a gettare altra benzina sul fuoco ieri ci sono state anche le varie interviste a Francesca Pascale nelle quali oltre ad auspicare la discesa in campo di Marina Berlusconi, ha menato fendenti a Santanchè e Gasparri. Parole taglienti, che — raccontano — non solo hanno innervosito i due parlamentari e tanti altri, ma non sono piaciute per niente nemmeno a Marina, che avrebbe comunicato il suo fastidio alla fidanzata del padre, perché in un momento così delicato non vorrebbe né essere chiamata in causa, né veder sollevate nuove polemiche che dividono il partito e mettono in difficoltà lo stesso leader. In questo clima, si capisce che anche il voto sulle riforme torna a rischio. Berlusconi è netto: «Si devono votare», ripete, usando per Renzi — a cena — parole di comprensione. Ma il suo partito è in subbuglio, e nonostante ieri le varie anime del centrodestra si siano ritrovate al banchetto della Meloni per firmare la richiesta di primarie di coalizione (c’erano tanti azzurri, da Fitto a Toti, da Ravetto a Carfagna, ma anche Quagliariello, Cicchitto, Lupi, De Girolamo per Ncd), l’aria non è quella dei grandi abbracci: divisi gli alfaniani,divisi gli azzurri, e uniti tutti solo su un punto: «Qui — dicono — c’è poco da rimettere assieme, bisogna rifondare. Tutto». E Berlusconi, a sera, chiosa: «Con i partiti alleati c’è difficoltà a mettersi d’accordo anche sulle piccole cose…». 23 del 10/07/14, pag. 10 Berlusconi vuole eleggere il suo avvocato alla Corte costituzionale in cambio dei voti per il dem Violante L’accordo riguarda anche il Csm. In corsa Brutti (Pd) per la successione a Vietti. La prossima settimana le votazioni Consulta, spunta il patto Violante-Ghedini LIANA MILELLA DETERMINANTE è la non smentita di Paolo Romani, da sempre prudente politico berlusconiano, adesso con il delicato incarico di capogruppo al Senato. Alla trasmissione In onda su La7 ecco che a Romani viene chiesto se sia vera la voce di un Ghedini in procinto di diventare giudice costituzionale. Un leggero imbarazzo, poi Romani riconquista il suo gelido aplomb e risponde: «È una voce». Non smentisce quindi, come avrebbe potuto fare se l’ipotesi non avesse realmente alcun fondamento. Smentita che invece arriva, e pure con una certa durezza, dal diretto interessato, Niccolò Ghedini, il ben noto avvocato di Berlusconi. «L’ho già detto alle agenzie una settimana fa, non sono candidato alla Corte. Ho appena vinto un processo importante per me e per Berlusconi come Mediatrade, e quindi resto dove sono» risponde un adirato Ghedini al telefono. Eppure i boatos del palazzo sono altri. Descrivono un altro pezzo del patto del Nazareno: sulla giustizia, e quindi sulla Consulta e sul Csm. Da una parte il Pd propone per la Corte Luciano Violante, dall’altra Berlusconi gli contrapporrebbe Ghedini. L’entourage politico dell’ex premier racconta proprio questo ragionamento fatto dall’ex Cavaliere: «Se loro vogliono mandare alla Corte Violante, noi allora ci mandiamo Ghedini ». Un proposito politico comprensibile visto che i democratici, per la Corte e per il Csm, puntano su due uomini forti, da una parte Violante, dall’altra l’ex senatore Massimo Brutti, noto per le sue battaglia sulla giustizia e la sicurezza, e soprattutto per il suo rapporto solido con la magistratura. Due nomi così necessitano di un contraltare forte, che vedrebbe in Ghedini il candidato migliore. Altri nomi, come quello di Donato Bruno, capogruppo forzista alla commissione Affari costituzionali del Senato, o dell’ex sottosegretario alla presidenza di Monti ed ex presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà, certo non reggono il confronto con quello di Ghedini. Che, qualora Berlusconi dovesse insistere nell’ipotesi, potrebbe trovare un ostacolo nel fatto di ritrovarsi nell’inchiesta Ruby ter con un’ipotesi addosso di corruzione di testimone attualmente in mano ai pm milanesi. La partita della Corte e del Csm non si chiuderanno oggi in Parlamento dove pure, dalle 13 in poi, si svolgerà l’ennesima votazione per i due giudici e per gli otto membri laici del Csm. Ma anche questa, come le precedenti tre, è destinata a saltare perché l’accordo politico ancora non è chiuso e soprattutto perché il palazzo della politica preferisce aspettare che il parterre dei togati sia definito. Si è votato tra domenica e lunedì, e i primi risultati non definitivi già danno una sorpresa. Il candidato più votato tra i pubblici ministeri, con ben 1.254 consensi su 9mila magistrati votanti, è Luca Forteleoni, pm a Nuoro, segretario di Magistratura indipendente, uno dei due protagonisti dell’sms che il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri ha mandato prima del voto sollevando una forte protesta, tra le toghe e a palazzo Chigi. Ieri sera, quando mancavano ancora 1.550 schede, lui era il primo, seguito dall’ex presidente dell’Anm Luca Palamara di Unicost con 998 preferenze. A seguire i candidati di Area Fabio Napoleone 24 (939) e Antonello Ardituro (907). Poi Sergio Amato, un Mi anti-Ferri, con 638 voti. Oggi toccherà allo scrutinio dei giudici, ma la politica è ferma in attesa del risultato definitivo. Si voterà di nuovo la prossima settimana e a quel punto dovrà essere chiusa, oppure superata, l’intesa se mandare Violante, ma anche Ghedini a palazzo della Consulta. 25 LEGALITA’DEMOCRATICA del 10/07/14, pag. 21 Inchino al boss, parla il maresciallo che ha fatto scoppiare il caso: “Qui a Oppido odiose sopraffazioni da parte delle cosche” Identificati 25 portatori della Madonna delle Grazie. E il sindaco invita Fiorello: “Facciamo di #iononmiinchino un evento” “Grazie agli onesti, nel paese di ’ndrangheta” GIUSEPPE BALDESSARRO OPPIDO MAMERTINA . « La ’ndrangheta a Oppido esiste», «Uccide ed è venditrice di morte », «Il piagnisteo non giova a nulla, al pari del “nascondimento”. Servono azioni concrete». Tra appello e sfogo ecco le parole del maresciallo Andrea Marino. Ieri il comandante della stazione dei carabinieri di Oppido Mamertina che ha fatto scoppiare il “caso” dell’inchino della Madonna delle Grazie lasciando la processione e avviando gli accertamenti, ha scritto sulla sua pagina Facebook. Non entra nel merito del “saluto” della statua alla casa del boss Giuseppe Mazzagatti del 2 luglio, ma invita gli oppidiesi onesti «feriti dal clamore mediatico» a «non avere paura di vivere liberi». Marino scrive che «la ‘ndrangheta è una forma odiosa di sopraffazione fra esseri umani, basata su regole poco democratiche, uccide ed è venditrice di morte». Aggiunge poi che «Oppido e gli oppidesi hanno vissuto passivamente ed ammutoliti cruente faide i cui oggi ancora in tanti portano addosso i segni. Il piagnisteo non giova a nulla, al pari del nascondimento. Servono azioni concrete». Ringrazia «coloro i quali hanno manifestato apprezzamento per quanto fatto nel corso della processione ». E fra tutti, «gli oppidesi onesti, che sono tanti: pubblicamente e non, hanno comunque scalfito quel muro di silenzio che qui è più duro del cemento armato ». Quindi l’appello: «Li invito a perseverare, a non aver paura di vivere liberi, a dimostrare che i cambiamenti sono frutto dei fatti e dei sacrifici e non solo delle belle parole. Il gesto non aveva dietrologia né era mirato a gettare fango sull’intera comunità in cui vivo con la mia famiglia da sei anni». Secondo il maresciallo, si tratta della «stessa gente che oggi soffre perché sente addosso il peso del fango mediatico che spesso dipinge Oppido come il paese degli orrori. In parte, purtroppo, lo è e lo sarà sempre fin quando i tanti cittadini onesti sopporteranno passivamente, lagnandosi di essere additati come comunità di criminali incalliti». Intanto sul fronte investigativo il fascicolo aperto dalla Dda di Reggio Calabria si fa corposo. Nelle ultime ore l’indagine affidata al pm Giulia Pantano si è arricchita dei nomi di 25 portatori della vara della Madonna. Persone che non appartengono a organizzazioni o congregazioni religiose, ma scelte in un gruppo di volontari, compreso colui che ha dato l’ordine di fare “l’inchino”. Si tratta, al momento, soltanto di persone che gli inquirenti stanno “studiando” acquisendo profili personali e familiari. Si cerca di capire in altri termini se vi siano dei collegamenti diretti o indiretti con i clan di Oppido. Il Procuratore Federico Cafiero De Raho ha parlato «dell’atto da cui parte l’indagine». Aggiungendo che «il fatto è indicativo di una contiguità di tali soggetti con la cosca». La giornata è stata poi caratterizzata anche da un hashtag di Firorello che su twitter ha lanciato #iononmiinchino! Secondo il sindaco di Oppido, Domenico Giannetta, si è trattato di un appello virtuale che l’amministrazione comunale intende raccogliere. Tanto da proporre a Fiorello di renderlo reale: «Vorrei che mi desse la sua disponibilità per incontrarci e per organizzare insieme un evento annuale che possa coinvolgere tutti coloro 26 i quali si impegnano quotidianamente nel sociale e da sempre si battono contro ogni tipo di mafia». Un’iniziativa di «musica, danza, cultura, sport e divertimento per dire con gioia e insieme, qui ad Oppido, “io non mi inchino” e per sensibilizzare tutti, soprattutto i giovani, sul delicatissimo tema della legalità. Potrebbe coincidere proprio con i festeggiamenti in onore di Maria delle Grazie». 27 RAZZISMO E IMMIGRAZIONE del 10707/14, pag. 5 ALFANO: «RIDURREMO LA PERMANENZA NEI CIE» I tempi di permanenza nei Cie potrebbero presto tornare a un limite massimo di 180 giorni, contro i 18 mesi attuali. Ad annunciarlo è stato ieri il ministro degli Interni Angelino Alfano in Commissione Diritti umani del Senato. Se in parlamento si raggiungono intese sull'abbassamento del tempo massimo di permanenza nei Cie il governo è pronto a farsi carico di un ulteriore alleggerimento, ha detto Alfano. Il ministro ha ricordato che i Cie «stanno operando ben oltre la loro capacità ricettiva e si punta ad accelerare le procedure per l'esame delle domande di asilo. Saranno incrementate le Commissioni territoriali per l'asilo ed il circuito Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo) salirà a 20mila posti». Attualmente sono 5 i Cie aperti (Bari, Caltanissetta, Roma, Torino, Trapani Milo) per circa 500 posti. Nel 2013 sono stati trattenuti 6.016 stranieri, di cui 2.749 sono stati rimpatriati. Quest'anno gli ospiti dei Cie sono stati 2.124, 1.036 rimpatriati. La permanenza media è stata di 55 giorni a Bari, 24 a Caltanissetta, 32 a Roma e Torino, 50 a Trapani. 28 SOCIETA’ del 10/07/14, pag. 5 All’amministrazione penitenziaria serve un capo Patrizio Gonnella Va a tutti ricordato che il sistema penitenziario italiano è ancora sotto osservazione europea. Nel giugno del 2015 il Consiglio d’Europa dovrà valutare la tenuta delle riforme, verificare se le condizioni di vita nelle carceri sono umane o disumane, accettabili o degradate. Dovrà esprimersi sullo stato dei diritti umani nelle prigioni del nostro Paese. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una decrescita della popolazione detenuta. Nonostante questo il tasso di affollamento è ancora alto. La qualità della vita negli istituti penitenziari è migliorata ma integrità psico-fisica, salute, lavoro, istruzione, affettività sono ancora diritti quotidianamente a rischio. Un processo di riforme nel segno delle garanzie, affinché abbia una qualche chance di riuscita, richiede volontà politica ferma e capacità di resistere alle pressioni dei media, degli umori delle piazza nonché delle micro-corporazioni interne al sistema carcerario. Le riforme le fanno le persone. È questa una fase cruciale. Bisognerà consolidare un percorso, dimostrare che si crede nei diritti; basta poco perché si torni nella melma. In questo momento, per l’appunto decisivo per il sistema delle pene in Italia, l’amministrazione penitenziaria (Dap) non ha un capo. A fine maggio 2014, in concomitanza con la scadenza imposta dalla Corte europea con la sentenza Torreggiani, non è stato confermato ai vertici del Dap il giudice Giovanni Tamburino. Da allora non c’è stata la nomina del nuovo capo. Ogni tanto radio carcere rumoreggia su qualche nome. Tutti rigorosamente magistrati, spesso pm. Si sentono anche impropri ragionamenti intorno a chi spetterebbe la nomina tra le correnti della magistratura. Noi vorremmo invece un altro metodo, dove il capo sia scelto in base al mandato politico e culturale deciso. Se il mandato è quello di garantire il rispetto delle regole europee in materia di umanità del trattamento penitenziario, di modificare prassi sclerotizzate, di modernizzare il sistema, la via non può essere quella di affidarsi a un investigatore o a un giudice con esperienza procedimentale. Ci vorrà qualcuno che per storia e competenza risponda a quel mandato. Che sia un esperto penitenziario, un direttore di carcere, un umanista, un manager o un giudice poco importa. L’importante è che sappia e voglia perseguire gli obiettivi riformatori nel nome della dignità umana. Gli stessi che devono essere alla base della nomina del garante nazionale delle persone detenute. La legge c’è da sei mesi, il Garante non è mai stato nominato. A ottobre saremo sotto il giudizio del Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu. Non è bello a 11 anni dalla firma del protocollo alla Convenzione sulla tortura che lo prevedeva essere ancora sul banco dei negligenti. Del 10/07/2014, pag. 1-15 Carceri, se l’Italia sembra la Guinea LUIGI MANCONI LEGGO DELLO SCIOPERO DELLA FAME INIZIATO IL 30 GIUGNO SCORSO, DA RITA BERNARDINI, SEGRETARIA DEI RADICALI ITALIANI E VENGO PRESO DA UN 29 SENSO DI SMARRIMENTO. Lei nel proporre ancora una volta il tema del carcere - con tutta la sapientissima follia che è virtù propria delle persone razionali e pragmatiche - ha dedicato particolare attenzione alla questione dell’assistenza sanitaria per i reclusi. Si tratta di un problema gigantesco, che non sembra presentare differenze troppo acute tra gli standard di cura e di terapia garantiti nelle carceri del nostro Paese e quelli presenti, per esempio, nella prigione di Bata, città della Guinea equatoriale, dov’è rinchiuso Roberto Berardi, un prigioniero italiano che ho iniziato a conoscere. Da qui quel mio senso di smarrimento. A scanso di equivoci, il nostro è un Paese di solida democrazia pur afflitto da una grave crisi di rappresentanza politica e da un antico deficit di garanzie nel processo penale, mentre la Guinea equatoriale è dominata dal 1979 da un despota di nome Teodoro Obiang. Di conseguenza lo stato dei diritti nel nostro Paese e lo stato dei diritti in quella nazione dell’Africa centrale sono incomparabilmente diversi. Ci mancherebbe. Ma qui si verifica un atroce paradosso: la profonda differenza tra i due sistemi e la superiore qualità della vita sociale, dei diritti individuali e collettivi, delle tutele e delle libertà in Italia tendono via via ad attenuarsi se osserviamo alcuni particolari gruppi sociali e alcuni particolari luoghi. Per un verso le condizioni degli strati più vulnerabili di popolazione e, per l’altro, la debolezza delle garanzie negli istituti del controllo e della repressione sembrano rassomigliarsi qui e in Guinea. In altre parole, per quanto sia doloroso riconoscerlo, a un derelitto recluso in una cella dell’Ucciardone o internato nell’Opg di Aversa e affetto da una qualche patologia può accadere di non essere trattato in modo troppo diverso (ovvero migliore) di come viene trattato Berardi nella sua cella nel carcere di Bata dove la temperatura è stabilmente sui 40 gradi e dove le condizioni igienico-sanitarie determinano il cronicizzarsi della malaria. Berardi sta in quel carcere dal gennaio del 2013 e si trova in stato di isolamento da oltre sette mesi, sottoposto a percosse, violenze e sevizie, dopo una condanna a due anni e quattro mesi e al pagamento di un milione e 400mila euro. Gli è stata promessa la grazia dal presidente Obiang, mal’atto di clemenza potrebbe sospendere l’esecuzione della pena senza rimetterlo in libertà, perché quella sanzione pecuniaria costituisce la vera merce di scambio. L’integrità del suo corpo (e la stessa possibilità di salvezza) “vale” oggi un milione e 400mila euro. E quanto vale la vita - e quanto valgono i corpi malati, febbricitanti, affetti dalle più diverse patologie, debilitati dalla cattiva alimentazione, scossi da infermità mentali o annichiliti dalla follia - di migliaia di detenuti italiani? Per questo Rita Bernardini ha intrapreso lo sciopero della fame finalizzato a interrompere la tragedia delle morti in carcere e a denunciare la carenza di cure che riguarda anche i reclusi incompatibili con la detenzione. Alla Bernardini si sono affiancati nel digiuno altri 200 cittadini: e condividono il suo allarme tantissimi giuristi, sindacati della polizia penitenziaria, cappellani e direttori di carcere, tutte le associazioni che operano nel sistema penitenziario, alcuni (purtroppo pochi, pochissimi) parlamentari e quel Giorgio Napolitano che, alla bella età di 89 anni, conserva tutta intera la capacità di scandalizzarsi. Le prime parole e i primi atti del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, fanno ben sperare: e i provvedimenti presi dagli ultimi governi - che alcuni irresponsabilmente hanno annunciato come “svuota carceri” - hanno ridotto il sovraffollamento. Ma non in misura sufficiente: siamo ancora ben oltre la capienza regolamentare. E rimaniamo lontani dal garantire alla gran parte dei reclusi quelle otto ore di “celle aperte” che costituiscono una indispensabile opportunità di socializzazione e di libertà di movimento. Ciò comporta - oltre alla sofferenza di corpi ristretti in spazi angusti, addensati entro perimetri soffocanti, abbracciati loro malgrado e promiscui per necessità, allo stesso tempo intimi e ostili - anche la decadenza di tutti i servizi, a partire proprio da quelli della salute. Oggi i detenuti italiani che si trovano in questo stato sono oltre 58mila.Aessi vanno sommati i 3300 nostri connazionali reclusi in prigioni di Stati 30 stranieri. Si tratta di Paesi che, fortunatamente, non assomigliano sempre alla Guinea equatoriale, ma ci sono anche quelli che ne rappresentano una versione ancora più feroce. Ciò che, invero, appare non troppo dissimile è, come si è detto, la condizione dei penitenziari. E di quei connazionali che si trovano detenuti all’estero nulla, o quasi nulla, sappiamo. Quanto ci viene raccontato a proposito di Roberto Berardi non può che inquietarci. E costituisce una ragione in più per sostenere l’iniziativa di Rita Bernardini e di quanti credono nella giustizia giusta. 31 BENI COMUNI/AMBIENTE del 10/07/14, pag. 11 SAGGI · «Il territorio bene comune degli italiani» di Paolo Maddalena La trinità della buona vita inscritta nella Costituzione Giuseppe De Marzo Dignità, libertà, uguaglianza: valori da perseguire attraverso la partecipazione popolare e una diversa relazione con il territorio, bene comune dal quale discendono razionalmente la misura del diritto e della giustizia. L’ultimo testo di Paolo Maddalena, Il territorio bene comune degli italiani (Donzelli, pp. 210. euro 18), introdotto da Salvatore Settis, offre un importante contributo per affrontare e risolvere la crisi. Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, di cui è stato giudice dal 2002 al 2011, sostiene come la causa della crisi sia nello squilibrio generato dal prevalere della proprietà privata su quella collettiva. Il testo capovolge la visione attuale che vede nell’interesse pubblico un limite alla proprietà privata, affermando in maniera rigorosa come in realtà sia la proprietà collettiva del territorio a precedere storicamente quella privata. Dallo studio della Costituzione emerge una vera e propria «strategia costituzionale» in cui «l’utilità sociale» diviene misura di legittimità e subordinazione per la stessa proprietà privata. È dal prevalere della proprietà privata su quella collettiva e dallo svilimento del nesso tra sovranità e territorio che Maddalena fa dunque discendere il progressivo e brutale impoverimento materiale e spirituale delle ultime tre decadi in Italia e nel resto del continente europeo. Strategie costituzionali Nel testo l’autore mette più volte in relazione la crisi finanziaria ed ambientale come originate dallo stesso vulnus giuridico: la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi. La Costituzione, come ricorda Maddalena, avversa e condanna questa eventualità, indicando nella ridistribuzione della ricchezza il motore dello sviluppo economico. Il prevalere invece delle teorie economiche della supply side - economia dell’offerta - e dell’ideologia neoliberista fondata su privatizzazioni, mercificazione della natura e finanziarizzazione dell’economia hanno per l’autore relegato nel dimenticatoio i principi capisaldi della Costituzione. Maddalena, insieme ad altri giuristi, ci rammenta come l’aumento delle diseguaglianze e della povertà siano considerate nel nostro ordinamento la più grave e devastante illegalità. Per l’autore se le diseguaglianze sociali hanno originato la crisi il motivo per cui queste non sono state combattute attraverso i precetti contenuti nel nostro ordinamento è a causa di una distorto utilizzo del concetto di proprietà privata portato avanti dai ceti dominanti a svantaggio di quella collettiva. Da qui discende lo svilimento giuridico della comunità politica che Maddalena ci ricorda essere costituita dal popolo, dal territorio e dalla sovranità. Questi elementi costitutivi della comunità politica agiscono all’interno di un ordinamento pubblico economico puntualmente delineato attraverso una strategia costituzionale tesa al bene comune. Una prospettiva che si fonda da un lato sulla ridistribuzione della ricchezza e dall’altro sulla salvaguardia e gestione dei servizi pubblici essenziali e delle fonti di energia. Sfavorendo accentramenti di ricchezza e latifondo la Costituzione indica chiaramente come motore dello sviluppo economico la redistribuzione della ricchezza. Ma nel suo testo Maddalena sostiene, insieme a Stefano Rodotà, come l’elemento di maggiore innovazione della nostra Carta sia in realtà nell’intangibilità della dignità umana, determinando un nuovo Statuto della persona ed un nuovo quadro di doveri costituzionali. 32 Maddalena ripercorre e amplia la trama che vede intrecciarsi libertà, uguaglianza e dignità, denunciando come il modello culturale neoliberista non garantisca affatto un’equilibrata relazione tra questi principi ed abbia invece lavorato alla loro rimozione rispetto al senso previsto dal nostro ordinamento. Rimozione che evidentemente è stata possibile anche grazie allo svilimento degli istituti di partecipazione pubblica, altro caposaldo della nostra Carta. La nuova «istituzionalità sociale» di cui spesso le nuove soggettività sociali e politiche si sono fatte interpeti trova nel testo di Maddalena legittimità e misura. Abbiamo, questo il senso politico delle argomentazioni dell’autore, il diritto e la responsabilità di agire proprio in una fase in cui la crisi economica, sociale ed ambientale rendono la democrazia un organismo debole e facilmente attaccabile dai germi del razzismo e del nazionalismo. La Costituzione potrebbe inoltre allargare lo status di cittadinanza legittimando «azioni popolari» espressione non solo di interessi pubblici ma di «interessi diffusi». Nell’ultima parte del testo Maddalena non si sottrae al dibattito, ormai planetario, sulla crisi ecologica e su come affrontare giuridicamente i nodi posti da quanti rivendicano giustizia ambientale ed ecologica. L’autore definisce l’ambiente un bene comune ed individua nel territorio e nel «pensiero creativo» le basi descritte e definite dalla Costituzione come premessa per realizzare lo sviluppo attraverso il quale perseguire l’interesse generale ed il bene comune. Partendo dal «nomos della terra», richiamato da Carl Schmitt come «la legge del diritto», Maddalena indica nella razionalità della natura e delle sue regole la fonte della razionalità del diritto. Giusnaturalismo terraneo Un’origine «terranea» che l’autore utilizza per proporre un nuovo «giusnaturalismo» sul quale incontrare ed intrecciare il lavoro del «costituzionalismo sperimentale » latinoamericano che ha riconosciuto ed introdotto in alcune carti costituzionali i «Diritti della Natura», definendo il «buen vivir» come l’ordinamento pubblico economico attraverso il quale promuovere lo sviluppo. L’essere umano e la Terra sono per l’autore «consustanziali». La Terra è quindi la madre del diritto. Da questa interpretazione discende anche un concetto diverso di libertà, «finalizzata» nel nostro ordinamento al patto sociale. Una libertà indirizzata alla solidarietà ed al bene comune. È questo che consente a Maddalena di rifiutare l’idea di Stato inteso come persona giuridica, definito invece come una «universalità concreta», dove l’essere umano dismette i panni dell’«homo oeconomicus» per ritornare a quelli dell’amministratore della casa comune. Un testo denso e ispirante che contribuisce a rendere meno opaca e frammentata la fase della storia che stiamo attraversando. 33 INFORMAZIONE Del 10/07/2014, pag. 1-16 Ai lettori «Siamo rimasti toccati dall’appello dei lavoratori de l’Unità e non rimaniamo indifferenti di fronte alla situazione esistente. Siamo consapevoli del valore storico della testata e abbiamo a cuore quanti, ogni giorno, a dispetto delle difficoltà esistenti, garantiscono con la massima professionalità un importante servizio per l’informazione italiana... ». Apprezziamo queste parole del tesoriere del Partito democratico Francesco Bonifazi, riferite a una redazione che da sola, senza tutele né stipendi, garantisce la presenza in edicola del giornale. Così come da soli i giornalisti de l’Unità hanno difeso la testata fondata da Antonio Gramsci dalle avances della Santanchè. Continueremo a dirlo con ostinazione: il giornale si deve salvare oggi con un piano industriale ed editoriale solido, che rispetti la storia de l’Unità, la comunità dei suoi lettori, e che salvaguardi l’occupazione. Non è più tempo di parole. 34 CULTURA E SCUOLA Del 10/07/2014, pag. 5 DECRETO CULTURA Art Bonus passa alla Camera, senza voti contrari L’Art Bonus è passato alla Camera: dal credito d’imposta per i privati che investono in cultura, alla assunzioni di operatori. Ieri l’aula della Camera ha dato il via libera al decreto legge Franceschini sulle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. La novità è che non ci sono stati voti contrari: 285 sì, nessun noe 159 gli astenuti. A favore Pd, Ncd, Sc. Mentre M5S, Fdi, Fi e Sel si sono astenuti. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. «Dalla politica del “con la cultura non si mangia” a un Paese che finalmente può vivere anche di cultura», ha commentato Manuela Ghizzoni, vicepresidente Pd della commissione Cultura. Soddisfatto anche il ministro Franceschini: «Il Parlamento ha migliorato ed arricchito la portata delle norme del decreto cultura e turismo». ecco i punti principali: per i privati che investono o per le donazioni il credito d'imposta è del 65%. Più trasparenza nelle procedure di gara per gli appalti a Pompei enorme anticorruzione più dure. Più snelle invece le procedure per gli interventi di decoro nelle città d’arte; tax credit per ristrutturazione delle piccole sale cinematografiche e di quelle storiche. Per l’occupazione, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici potranno assumere, a tempo determinato, professionisti sotto i40 anni in deroga alle norme sui limiti per le assunzioni a Td. E altro ancora... Del 10/07/2014, pag. 11 Atenei sempre più precari «Vogliamo stabilizzazione» La ricerca della Cgil è la prima sugli atipici nelle università. Negli ultimi dieci anni solo il 6,7% di loro ha avuto un contratto a tempo indeterminato MASSIMO FRANCHI L’università italiana è, letteralmente, tenuta in piedi dai precari. I dati del Miur - del 2012, gli ultimi disponibili - danno un’idea delle dimensioni: i docenti sono oltre 52mila strutturati,maerano60mila nel 2008; i docenti temporanei sono 32mila, ma erano meno della metà - 15mila - nel 2005. Nello stesso periodo c’è stato un boom degli assegni di ricerca, passati dai 10.251 del 2005 ai 20.078 del 2012. La curva è ancora più inclinata nella duplicazione dei ricercatori a tempo: erano solo 6 nel 2004, sono 2.871 nel 2012. Ma il dato che dà l’idea di quanto il precariato sia una malattia incurabile nell’università italiana è quello che riguarda la percentuale di stabilizzazione di questo esercito di precari: solo il 6,7 per cento di loro ha avuto un posto a tempo determinato nell’arco degli ultimi dieci anni. Se questi sono «i grandi numeri», per la prima volta qualcuno ha cercato di fare un’analisi qualitativa del precariato universitario: la Flc-Cgil ha 35 commissionato una ricerca ad un pool di ricercatori - rigorosamente precari - coordinati da Emanuele Toscano per capire meglio chi sono e cosa si aspettano dal futuro. Il quadro che esce dai 1.861 questionari compilati è sconfortante. L’età media è di 35 anni, sono in prevalenza donne (57 per cento), quasi il 27 per cento ha figli, ma il 28 per cento non ha una casa. Il dato che più colpisce rispetto alla loro carriera universitaria è quello del numero dei contratti: in media sono 6,2, ma oltre il 10 per cento può annoverare più di 13 contratti con punte - si spera inarrivabili - di addirittura 31 contratti. Il percorso lavorativo di questi dottori è una specie di calvario, acuito dall’autonomia che ha trasformato i singoli atenei in aziende in cui bisogna far tornare i conti tagliando naturalmente sul costo del personale: si passa senza soluzione di continuità da assegni di ricerca - la forma contrattuale che va nettamente per la maggiore rappresentando quasi il 50 per cento del totale - a co.co.pro, da dottorati a posti da ricercatore a tempo determinato, mentre le cattedre sono sempre più un miraggio anche a causa di baroni inamovibili che vedono la pensione come una iattura da scansare a qualunque costo. La docenza - tenere corsi, lezioni ed esami - quindi è spesso un optional naturalmente non retribuito: lo fa l’80 per cento dei ricercatori a tempo indeterminato, oltre il60per cento dei ricercato a tempo determinato e - questo il dato più allarmante - quasi il 50 per cento dei precari con contratto parasubordinato. L’altra faccia della medaglia è quella della risposta con cui il 30 per cento dei precari ammette di aver «spesso» «svolto lavoro non retribuito». Contratti dunque come roulette, quasi sempre mettendo da parte la competenza e il merito. Un intervistato su tre specifica che il contratto attuale «utilizza poco o per nulla le competenze professionali acquisite lavorando all’università ». Peggio stanno comunque il 16 per cento di intervistati che non lavorano più nell’università. E le motivazioni per questo addio non sono solo strettamente di contratto - il mancato rinnovo lo è per il 55 per cento delle donne e il 53% degli uomini - visto che per circa il 40 per cento è dovuto al fatto di «non avere alcuna possibilità di crescere professionalmente » 19,3 per cento - o «per una scelta legata all’instabilità professionale » - 18,5 per cento. Territorialmente i precari sono più presenti nelle università del Nord - 50per cento - e negli atenei più grandi - il 54 per cento si concentra nelle università con più di 20mila studenti. Chi ha ancora un contratto non è comunque soddisfatto: il 62 per cento si definisce «poco» o «per nulla soddisfatto » della propria condizione contrattuale, mentre il 53,2 per cento non riesce a immaginare il proprio futuro professionale fra 10 anni e conseguentemente sono pronti ad irrobustire la schiera dei cervelli in fuga: ben il 60 per cento dei dottorandi «considerano molto o del tutto probabile lasciare l’Italia per lavorare all’estero in ambito accademico». «RISPOSTE O MOBILITAZIONE» La ricerca è stata presentata ieri mattina alla facoltà di Architettura di Roma Tre ed è stata l’occasione per la Flc Cgil di lanciare la mobilitazione sull’intero comparto scuola-università. «Ormai infatti anche nelle scuole i docenti entrato con contratti da co.co.co e le chiamate dirette delle scuole premiano il clientelismo e mai il merito», sottolineano dal sindacato. «Vogliamo rilanciare il tema della stabilizzazione del precariato che è ormai sparito dal dibattito politico - spiega il segretario generale Mimmo Pantaleo - perché in questi anni sono i precari ad aver garantito il funzionamento di scuola e università. Per questo chiediamo il ripristino del 100 per cento del turn over e una flessibilità nell’età pensionabile. Se non avremo risposte dal governo - chiude Pantaleo – in autunno lanceremo una grande mobilitazione nazionale». 36 del 10/07/14, pag. 3 Il falò dei 63 mila cervelli espulsi dagli atenei italiani Roberto Ciccarelli ROMA Università. Presentati ieri a Roma i dati dell’indagine Flc-Cgil «Ricercarsi». Dal 2003 formati 68 mila ricercatori, solo 4500 gli assunti. Sembra la trama del film "Smetto quando voglio", ma è la storia vera di migliaia di persone È un falò dei cervelli. Tra il 2003 e il 2013 l’università italiana ha formato 68 mila ricercatori e ne ha assunti all’incirca solo 4500, il 6,7%. Nel mezzo borse di studio da fame, lavoro gratis con l’ansia del rinnovo del contratto, poche o nessuna garanzia di svolgere alla fine un lavoro per cui daresti anche l’anima. Non è la trama di un film come «Smetto quando voglio», ma la fotografia di una generazione di ricercatori precari che hanno iniziato a lavorare nei laboratori o in aula mentre sull’università italiana si abbatteva la scure dei tagli della legge 133: 1,4 miliardi in meno al fondo ordinario di finanziamento degli atenei. Quello della ricerca scientifica o umanistica è un lavoro precario, impegnativo, sottopagato, sottovalutato. Ma anche stimolante, interessante, appassionante. Sono questi gli aggettivi ambivalenti usati dai 1861 ricercatori precari intervistati nell’indagine «Ricercarsi», promossa dalla Flc-Cgil. I primi risultati sono stati presentati ieri a Roma nel corso dell’assemblea nazionale dei precari della conoscenza «Jobs map» organizzata dalla Flc-Cgil. Dei 68 mila precari ufficialmente censiti, il 93,3% è stato espulso da una casa ormai deserta. Per dare agli studenti, e alle loro famiglie, l’apparenza di una normalità, gli atenei hanno fatto ricorso al lavoro a termine, come in un fast food qualsiasi. In dieci anni i contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, co.co.pro o post-doc sono quasi raddoppiati, passando da 18 mila nel 2003 a 31 mila nel 2013. Una scelta obbligata, considerato il blocco del turn-over quasi totale, ma anche funzionale allo sfruttamento del lavoro precario, e gratuito, erogato per ottenere in cambio una borsa, una cattedra, la promessa di una stabilità qualsiasi. L’età media dei ricercatori precari analizzati è di 35 anni, il 57% è donna e nel 70% non hanno figli. La metà del campione analizzato è altamente specializzato, vanta esperienze di lavoro all’estero, vive in una situazione familiare, convive o è sposato. In media, nella loro vita questi ricercatori hanno avuto 6,2 contratti. Ma il 10,4% ne ha avuti tra 13 e 31. Considerato che si inizia a lavorare verso i 28–29 anni, si può dire che la mortalità dei contratti è elevatissima, così come il loro rinnovo che però, ad un certo punto, si ferma. Il 16% dei 1861 precari non lavora più all’università. Uno su tre ha abbandonato le competenze acquisite nel lavoro di ricerca. Il 30% è disoccupato, mentre il 45% ha maturato una professione in un altro campo. Dall’indagine emerge così una doppia categoria. Da un lato, ci sono i «sommersi», coloro che sono disoccupati e basta. Dall’altro lato, c’è chi ha trovato un buon lavoro. Le più penalizzate sono le donne. Per chi guadagna fino a 10 mila euro la loro percentuale è del 26%, il 15% tra gli uomini. Il 49% guadagna tra 10 e 20 mila euro annui. Solo il 6% ha un reddito oltre i 30 mila euro. Un altro dato interessante è il reddito familiare di chi è precario. Più è alta la qualifica professionale dei genitori, più è alta la possibilità di continuare a fare i precari 37 all’università. Il lavoro di ricerca resta in Italia un’attività classista: se lo può permettere solo chi ha un welfare familiare. Tutti gli altri possono andare a infornare pizze. Diamo un’occhiata anche alle condizioni di chi è rimasto. Il 60% sostiene di avere svolto attività al di fuori delle sue competenze. Questo significa che ha dovuto cedere al ricatto di svolgere mansioni improprie in vista di un rinnovo contrattuale. È stato anche elaborato un indice dello sfruttamento precario negli atenei. Le aree disciplinari che sfruttano i precari per altre mansioni non accademiche sono quelle che hanno un collegamento agli albi professionali: scienze giuridiche, mediche, biologiche ed agrarie. Gli avvocati impongono il lavoro nel loro studio. I biologi nei laboratori di analisi, e i medici nelle cliniche private. Lo sfruttamento diminuisce tra le professioni senza albi: matematica e fisica. del 10/07/14, pag. 3 Inizia l’estate calda della scuola made in Renzi Roberto Ciccarelli Istruzione. La prossima arriveranno in Consiglio dei ministri i provvedimenti sulle 36 ore di lavoro per i docenti, mentre si pensa di dare ai privati il ruolo di chi tiene aperti gli istituti fino alle 22, 11 mesi su 12 L’anno scolastico è finito, ma la stagione dei riformatori della scuola non conosce tregua. L’estate del 2014 verrà ricordata per i monologhi del sottosegretario Roberto Reggi, già sindaco per 10 anni a Piacenza, sull’aumento a 36 ore dell’orario di lavoro dei docenti e sull’allungamento dell’orario di apertura degli istituti scolastici. Propositi di riforma dell’universo annunciati con la tradizionale intervista a tutto campo sul quotidiano di riferimento del centro-sinistra, smentita, perfezionata, ritrascritta nei giorni successivi. Nel silenzio del ministro Stefania Giannini (nella foto), un po’ in ombra dopo il risultato di Scelta Civica alle europee, da giorni la scuola italiana è soffocata da un polverone che ha preoccupato sindacati e insegnanti. E i precari ai quali Reggi sembra avere detto di volere cancellare le supplenze brevi per darle ai docenti di ruolo. Ieri sera si è appreso, stavolta dall’Ansa, che un «pacchetto di interventi» arriverà sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri. Considerati i precedenti, e tenendo presente che la capacità dell’esecutivo Renzi di presentare atti legislativi organici e razionali non è esattamente una sua peculiarità, come ha compreso il Quirinale in occasione della riforma «epocale» della pubblica amministrazione, è consigliabile aspettare perlomeno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di quanto verrà deciso. Al «pacchetto» di mischia per riformare la scuola avrebbero lavorato per alcuni mesi — si apprende dall’Ansa, non da Reggi — due gruppi di lavoro. Gli interventi riguarderebbero la formazione, il reclutamento e la «valorizzazione» della professionalità degli insegnanti. È il «piano scuola» promesso da Renzi, subito dopo il piano sull’edilizia scolastica, per il quale disse di avere stanziato 3,7 miliardi, in seguito ridotti a 244 milioni divisi tra il 2014 e il 2015. La stella polare è sempre l’impegno di aumentare a 36 ore settimanali il lavoro dei docenti. Reggi ha voluto precisare di non avere sostenuto di raddoppiare l’orario di lavoro, «ma 38 solo di differenziare i carichi di lavoro nell’ambito degli orari previsti e che già oggi molti fanno». È quanto sostenuto, sin dall’inizio del suo mandato, da Giannini ed è un’idea fissa sin da quando un commando di neoliberisti si è impadronito del Miur con il progetto di introdurre la «meritocrazia» nella scuola. In realtà si vuole solo differenziare i salari tra i docenti, mettendoli in competizione, gravandoli di incombenze burocratiche derivanti dai crescenti carichi di lavoro legati alla psicosi valutativa che, a partire dai test Invalsi, sta sommergendo anche la scuola. I «riformatori» vogliono arrivare ad un «contratto flessibile», basato sui carichi di lavoro e non più sull’anzianità di servizio, attribuendo bonus produttività sul modello manageriale che si è impadronito della scuola. In questo modo anche il governo Renzi vuole superare «l’attuale dicotomia tra organico di diritto e organico di fatto e arrivare a un organico funzionale». Quanto alle scuole aperte dalle 7 alle 22, e 11 mesi su 12, si tratta di capire chi metterà il lavoro. L’impianto del governo sembra essere chiaro. Non sarà probabilmente il personale Ata a tenere aperte le scuole, di notte e d’estate, ma saranno privati, associazioni e i volontari (la figura emergente nel lavoro in Italia: chi lavora gratis «per la comunità») a farlo. A tutti gli effetti, sempre che venga realizzata, la riforma potrebbe essere la «svolta» di Renzi: la privatizzazione del lavoro pubblico per eccellenza, quello scolastico. Immancabile è il riferimento al «modello tedesco» della scuola. Non si tratta di un omaggio calcistico alla super-potenza europea, è un’aspirazione ideologica. L’alternanza «scuola-lavoro» significa professionalizzare l’insegnamento, impendendo alla scuola di esplicitare la sua funzione di «ascensore sociale». Il sindacato Gilda è sul piede di guerra, mentre l’Unicobas ha indetto per il 14 luglio un sit-in sotto al ministero a Roma e ha invitato gli altri sindacati a una controffensiva unitaria. Sarà l’estate più calda della scuola italiana. Del 10/07/2014, pag. 16 Al cinema trionfa la sala vuota I DATI DEL BOTTEGHINO SONO SCONFORTANTI L’ULTIMO WEEK END: IL PEGGIORE DELL’ANNO Come sta il nostro cinema? Se qualcuno buttasse un occhio in sala in questi giorni, la diagnosi sarebbe impietosa: malissimo. Lo scorso weekend è stato il peggiore dell’anno: 1.760.143 euro l’incasso totale al botteghino, con una flessione del 45% rispetto all’analogo fine settimana del 2013, già tutt’altro che lusinghiero. Siccità in sala, e Mondiali, caldo e “tutti al mare!” non spiegano questa miseria, perché il problema è a monte: “Oramai la stagione cinematografica – dice Andrea Occhipinti di Lucky Red –dura da ottobre a marzo, nel resto dell’anno non c’è quasi nulla”. Eppure, potrebbe andare diversamente, e l’exploit di Maleficent con Angelina Jolie lo attesta senza tema di smentita: uscito il 28 maggio, dopo sei settimane di programmazione sfiora i 13 milioni di euro e ha scippato la vetta degli incassi 2014 al nostrano Un boss in salotto uscito il 1° gennaio. Insomma, il prodotto paga e si fa pagare, d’estate come d’inverno, ma quando latita…Provocazione, da aprile a settembre che facciamo delle italiche sale: bingo, sale da lettura climatizzate, ostelli della terza età? Lo stesso Occhipinti, tuttavia, sconfessa allarmi a mezzo stampa sullo stato dell’arte, e invita al campo lungo sull’ultima annata cinematografica: “Un’annata eccezionale”, secondo il Rapporto 2013. Il Mercato e 39 l’Industria del Cinema in Italia edito dalla Fondazione Ente dello Spettacolo con la Direzione Generale Cinema del MiBACT. Ma è davvero così? La quota di mercato del cinema italiano risale al 30% dal 25% del 2013, ma senza i 51,3 milioni di euro incassati da Sole a catinelle con Checco Zalone che risultato avremmo avuto? Puntualmente snobbato dai premi, è il salvatore della patria, ma un Checco multimilionario fa primavera? Il botteghino complessivo del 2013 è stato di 618.353.030 euro, superiore ai 609 del 2012, ma nettamente inferiore ai 661 del 2011 e ai 734 del 2010: vale a dire, senza quei 50 milioni di Sole a catinelle avremmo pianto miseria. Eccezione che invalida la regola, Checco ha drogato il comparto, addirittura raddoppiando l’incasso del top player del 2012, quel Benvenuti al Nord che totalizzò 24.645.462 euro. SE NON RIDIAMO, altri lo fanno per noi: gli Stati Uniti guadagnano ulteriori fette di mercato passando dal 48.46% del 2011, per il 53,21 del 2012, al 53,72% del 2013. Direte, ma noi abbiamo vinto l’Oscar! Vero, e La grande bellezza di Paolo Sorrentino se l’è cavata egregiamente anche in sala, ma i prestigiosi riconoscimenti internazionali come si riverberano sul box office? Le meraviglie di Alice Rohrwacher, ottimo film, s’è aggiudicato il Grand Prix a Cannes, ma dopo sette settimane di programmazione arriva appena a sfiorare il milione e, rivendica Domenica Dinoia della FICE, “senza le nostre sale cittadine e d’essai chi l’avrebbe messo in cartellone?”. Se l’alfabetizzazione cinematografica, scolare in primis, rimane una chimera, viceversa, c’è un troppo che stroppia: le opere prime, passate dalle 364 del 2012 alle 453 del 2013. Qui ce la giochiamo, con i nostrani debutti levitati dai 127 del 2012 ai 161 dell’anno scorso, ma è un dato univocamente positivo? Tutt’altro: “La distribuzione delle opere prime e seconde è un grido di dolore”, lamenta l’ad di Cinecittà Luce Roberto Cicutto, con Occhipinti – “Pro - durne meno e mettere risorse per distribuirle, perché così sono sprecate, invisibili” – e l’ad di Medusa Giampaolo Letta – “Servono criteri più stringenti per selezionarle” – a rincarare la dose. Crollati gli investimenti (da 493,1 a 357,6 milioni), in via d’estinzione le monosale (dalle 713 del 2006 alle 530 del 2013), in contrazione il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), il sole del nostro cinema è a catinelle, eppur ci si bagna. dl 10/07/14, pag. IX (Roma) Nella sala di via Nazionale si sono riuniti da ieri molti appassionati una cordata di nuovi soci potrebbe consentire lo slittamento Teatro Eliseo, oggi lo sfratto braccio di ferro con la proprietà Amici e abbonati in assemblea RODOLFO DI GIAMMARCO UNA quarantina di persone sono in assemblea permanente negli uffici del teatro Eliseo di Roma, per scongiurare lo sfratto esecutivo per morosità annunciato oggi. Contro questo sfratto, che metterebbe a rischio lavoratori e compagnie in cartellone nel 2014/2015, si sono dati appuntamento amici e abbonati del teatro, e un produttore teatrale, Francesco Bellomo, ha concentrato oggi all’Eliseo tutti i provini a lui necessari per la prossima stagione. Non è un gesto isolato, il suo, perché Bellomo, 51 anni, agrigentino, è notoriamente anche il capofila della cordata più attendibile di nuovi soci che apporterebbero un sostanziale aiuto al teatro di via Nazionale, aiuto che negli ultimi giorni 40 è purtroppo però incappato in problemi fatti nascere da una parte della società proprietaria dell’immobile. «Io ho da tempo - confida Bellomo un rapporto bello e privilegiato con l’Eliseo, fin da Uno sguardo dal ponte con Michele Placido nel 1997, cui è seguito ancheun Così è( se vi pare) ancora con Placido, ed erano miei, sempre all’Eliseo, anche recenti spettacoli di Giancarlo Sepe e di Monica Guerritore. Due mesi e mezzo fa vengo a conoscenza delle problematiche del teatro, e reputandomi amico del direttore Massimo Monaci e del padre Vincenzo costituisco una cordata con esponenti della finanza, dell’università, dell’imprenditoria, del sistema bancario e, per il mondo della scena, con Paolo Valerio, sensibilizzando anche Placido». Che tipo di proposta avete fatto? «Una prima ipotesi, del 22 maggio, verteva sull’affitto delle mura e della gestione. Poi abbiamo offerto di più, comunicando un interesse all’acquisto delle mura. Ma non riceviamo una risposta unanime. La società della gestione è della famiglia Monaci, e sarebbe favorevole. Ma l’Eliseo Immobiliare è per il 34% di Vincenzo Monaci, per il 33% di Stefana Marchini (gruppo Corsi, immobiliaristi, n. d. r.), e per il 33% della Doppia D srl (dietro cui c’è il gioielliere Carlo Eleuteri, n. d. r.), e visto che per statuto le decisioni devono prenderle all’unanimità, siamo a uno stallo, perché la Doppia D srl non accetta di affittare o vendere le mura del teatro». La morosità della gestione, e lo sfratto, sembrano al dunque dover favorire altri pretendenti, altri disegni con cambio di destinazione. «Ma Massimo Monaci lavora bene, il teatro va salvato, e lo sfratto può essere rinviato». 41 INTERESSE ASSOCIAZIONE del 10/07/14, pag. 12 Oggi il disegno di legge delega con uno sforzo iniziale di 300 milioni Sarà stabilizzato il 5 per mille, fisco più leggero per i “titoli finanziari etici” Arrivano i bond sociali più forza al terzo settore servizio civile per 100 mila ROBERTO MANIA ROMA . «È una rivoluzione anche questa», dice Matteo Renzi, presidente del Consiglio dei ministri. L’altra è stata la riforma della pubblica amministrazione. Ora spetta al Terzo settore, dove ci sono 4,7 milioni di volontari (+ 43,5 per cento dal 2001 al 2011), 681 mila dipendenti, 270 mila lavoratori esterni, 5 mila lavoratori temporanei. Una mega-holding di servizi complementare al welfare statale. Il governo punta a riorganizzare tutto il settore, a dare identità alle imprese sociali, a utilizzare i social bond per finanziarle, a stabilizzare l’istituto del 5 x mille, a far decollare un grande piano per il servizio civile dei giovani (obiettivo 100 mila nel primo triennio). La riforma (una legge delega) dovrebbe essere varata oggi dal Consiglio dei ministri dopo che a metà maggio Renzi aveva indicato le linee guida degli interventi, e poi avviato la discussione online (760 le mail arrivate a Palazzo Chigi). L’approvazione è slittata di alcuni giorni perché andavano trovate le coperture finanziarie: 200-250 milioni circa per il servizio civile, più 60-70 milioni per il 5 x mille: in tutto un primo stanziamento intorno ai 300 milioni. Ma ce ne vorranno di più in seguito. Le associazioni del Terzo settore hanno stimato una cifra vicina a 1,5 miliardi. Dopo l’approvazione da parte del Parlamento, il governo avrà sei mesi di tempo per varare i decreti delegati. La riforma dovrebbe entrare in vigore nella prima parte del 2015. Perno della riorganizzazione del settore diventa l’impresa sociale, incentivate da trattamenti fiscali favorevoli, cosa che ora non accade. C’è anche una componente “ideologica” nel rafforzamento dell’impresa sociale: rompere la dicotomia tra pubblico e privato, tra Stato e mercato e attribuire all’imprenditoria sociale un posto tra pari nel sistema dell’offerta dei servizi. Perché, come ha scritto l’economista Stefano Zamagni, ci si sta avviando «verso un modello di ordine sociale tripolare: pubblico, privato, civile». Tutti coloro che opereranno nel sociale dovranno assumere lo status di impresa sociale (oggi sono solo poco più di 800). E una delle novità riguarda la possibilità di forme limitate di remunerazione del capitale sociale. Sarà possibile anche usare la leva finanziaria con l’emissione, da parte di banche, di bond sociali, obbligazioni a rendimento garantito con una quota (tra lo 0,5 per cento e l’1 per cento, probabilmente) destinata a un soggetto del Terzo settore. Una formula diversa da social bond anglosassone il cui rendimento finanziario è strettamente collegato al raggiungimento di un obiettivo di natura sociale. Decisivo sarà il ruolo di arbitro e garante che svolgerà l’Authority del Terzo settore, prevista dal progetto legislativo perché tra gli scopi del governo c’è anche quello di sfoltire il settore e renderlo più trasparente. Il piano per il Servizio civile nazionale universale si muove nella stessa logica del progetto “Garanzia giovani”: far sì che nessun giovane resti a casa senza far nulla ma abbia, al contrario, un’occasione di formazione o per il lavoro o per una coscienza civica con 42 l’impegno nella difesa della cultura, del patrimonio artistico o in interventi con finalità umanitario. Nell’arco del primo triennio il governo Renzi pensa che possano essere coinvolti 100 mila giovani (tra i 18 e i 29 anni) nel servizio civile contro i 15 mila attuali. Sarà aperto anche ai giovani stranieri residenti regolarmente nel nostro Paese. Il servizio durerà al massimo dodici mesi (8 più 4 di eventuale proroga). Poco più di 400 euro l’indennità mensile, ma anche la possibilità di acquisire — come per tutti gli altri volontari — crediti formativi universitari. del 10/07/14, pag. 6 La riforma premia il profit e la competizione Giulio Marcon La riforma . In discussione alla Camera, il nuovo testo di legge è un’occasione mancata con diverse ombre In questi giorni sta andando in discussione alla Camera, in seconda lettura, la legge di riforma della cooperazione allo sviluppo. Riforma attesa da anni (la vecchia legge è del 1987) — dopo la malacooperazione della seconda metà degli anni Ottanta e di tangentopoli e i tagli che hanno azzerato gli interventi — il nuovo testo sulla cooperazione è un mezzo passo in avanti rispetto alla vecchia legge, ma un’occasione mancata con diverse ombre. È una legge che mette enfasi sulle imprese e toglie spazio al volontariato, che sposa il partenariato pubblico-privato, ma non riconosce alcun ruolo delle organizzazioni del sud del mondo, che lascia sullo sfondo il peace-building e ripropone l’ambiguità del rapporto tra azione umanitaria e intervento militare. È una legge che non tocca gli antichi equilibri istituzionali che hanno condotto nel pantano la cooperazione negli ultimi venti anni. Infatti — nonostante l’introduzione di un’Agenzia ad hoc — il ministero Affari Esteri rimane il dominus della cooperazione, facendone ostaggio della diplomazia della Farnesina e di una politica estera condizionata dagli interessi geopolitici e — magari — dagli interventi militari. L’Agenzia, introdotta dalla legge (che doveva essere la novità più importante e dare autonomia alla cooperazione), è semplicemente un contraddittorio strumento operativo, una sorta di service (che tra l’altro rischia di lasciare a casa una parte del vecchio personale), cui la legge esternalizza le funzioni tecniche. E il ministero dell’Economia e Finanze continuerà a gestire gran parte dei fondi, senza una logica coerente e finalizzata alla realizzazione degli obiettivi della legge. Infatti, il testo evita di introdurre il Fondo unico per la cooperazione, che avrebbe permesso di riportare a coerenza e a un comune indirizzo tutte le risorse, le politiche e gli interventi che fanno riferimento a quanto previsto dalla legge. Questo sarà l’alibi per continuare sulla vecchia strada, ognuno per la propria strada, nella frantumazione delle politiche, delle scelte e degli interventi. Le imprese diventano soggetti di cooperazione, che potranno attingere dai fondi pubblici per realizzare — in nome della cooperazione — una strategia di internazionalizzazione del loro business. Il volontariato, che era uno dei perni della legge del 1987 diventa poco più di una citazione nel nuovo testo. La società civile dei paesi del sud del mondo può essere al massimo beneficiaria degli interventi e non uno dei soggetti della cooperazione: questo sarebbe stato il vero partenariato da promuovere, non quello delle imprese. In questa legge c’è in filigrana l’assunto (molto liberista) che ai paesi del sud del mondo serve più mercato e competizione. E poi è vero che la legge esclude che con i fondi pubblici della cooperazione si possano finanziare gli interventi militari — e ci mancherebbe — ma è 43 altresì evidente che non viene sciolta l’ambiguità e non viene esclusa la collaborazione tra cooperazione e forze armate in cui l’Italia è presente con operazioni militari di natura bellica. Rimane, infine, la questione dei soldi. E su questo la legge non ci dice granché, se non prevedere qualche clausola di salvaguardia su fondi accantonati e struttura dei bilanci. Da anni i fondi per la cooperazione sono massacrati e ridotti al lumicino. Siamo il fanalino di coda dei paesi Ocse per fondi destinati all’aiuto pubblico allo sviluppo. Il ministero degli Affari Esteri fa bandi per i progetti delle ong in cui non garantisce di poter pagare la seconda tranche. Gli organici sono ridotti al minimo indispensabile. Un disastro. E all’orizzonte non ci sono novità: vedremo cosa ci sarà scritto nella legge di stabilità, ma non c’è da sperarci molto. La nuova legge è un’occasione mancata: priva di coerenza tra le politiche, senza soldi, succube della politica estera, ambigua con gli interventi militari. Con in più un’attenzione eccitata alle imprese e al mercato. Il volontariato e le ong — e soprattutto i paesi del sud del mondo — meritavano qualcosa di meglio. 44 ECONOMIA E LAVORO del 10/07/14, pag. 1/3 L’ascensore sociale funziona. In giù Angelo d'Orsi Una storia operaia. Hanno un lavoro, ma fanno fatica a mantenerlo, sottoposti a ricatti, costretti a condizioni iugulatorie. Storia di una famiglia proletaria a Torino E parliamo un po’ di classe operaia, raccontiamo come vive, giorno dopo giorno, tirando la vita coi denti. Parliamo non di giovani disoccupati, la grande tragedia nazionale, ma di gente che il lavoro ce l’ha — a quali condizioni… — e fatica a mantenerlo, sottoposta a ricatti, costretta a condizioni iugulatorie, con salari al minimo; e quando lo perde, per l’incessante chiusura di officine, aziende, imprese, fa ancora più fatica a rimediarne un altro. Non voglio offrire statistiche e sguardi di insieme, ma raccontare una storia, una vicenda come tante, esemplare, ritengo. Famiglia proletaria, nell’ex capitale: del Ducato di Savoia, del Regno d’Italia, dell’automobile, della Fiat. Il padre operaio specializzato giunto al reparto progettazione auto, aristocrazia operaia, insomma, che al lavoro ha sempre guardato con rispetto e persino con amore; qualche sciopero, ma via via sempre meno nel corso dei decenni; una moglie con un lavoro non qualificato, due figli, che fanno le scuole tecniche. Il maschio frequenta l’Istituto per Geometri, ma comincia a frequentare i cantieri, nel tempo libero e nelle vacanze, si impratichisce del lavoro, e quando finisce trova subito un impiego. Lavora sodo negli anni seguenti, diventa capocantiere, per la ditta che lo ha assunto, mette su famiglia: compra una casetta, col mutuo, fuori città, nel luogo dove ha sede la sua ditta: casa e bottega. Come suo padre vive per il lavoro, lo ama, si impegna, e non bada a straordinari. Il babbo è orgoglioso, ha fatto studiare il primogenito, che è salito nella scala sociale; ma c’è di più. Il nostro operaio specializzato ha una seconda figlia, che fa le scuole commerciali, prende il suo diploma, e vuole a tutti i costi andare all’università. Il babbo le dice d’accordo, ma non possiamo permettercelo. E lei si mantiene lavorando per tutto il periodo degli studi. E dopo la laurea — ottenuta nei quattro anni, e bene — continua, avrebbe aspirazioni intellettuali, ma sa di non poterselo permettere; conserva la passione per i libri, per lo studio, e rifiuta le proposte di continuare nella vita degli studi, che il suo relatore di tesi le fa.Le riesce impossibile conciliare quella dimensione, a cui pure terrebbe, con la vita reale. Una vita reale nella quale è passata ormai dai lavoretti nelle fiere o come aiuto parrucchiera, ad assunzioni a tempo determinato in un’azienda, con rinnovi semestrali. È seria come tutti in famiglia: sarà l’etica del lavoro tipica della cultura piemontese? E i datori di lavoro le rinnovano il contratto, fino a che si stabilizza: è una lavoratrice che si fa sfruttare fino in fondo. Piega la testa, ed è brava: perciò, a un certo punto il lavoro a tempo indeterminato arriva. Il miraggio diviene realtà. E questo le fa credere che può, come suo fratello, comprare un piccolo appartamento, con un mutuo trentennale. Ma fa fatica, troppa fatica, i costi aumentano mese dopo mese, le utenze, le spese condominiali, il cibo, i detersivi, e il suo compagno che ha messo su un’attività nel momento sbagliato, con la crisi galoppante, non ce la fa ad aiutarla. Anzi: chiede un fido bancario, e le rate strozzano lui e lei, che intanto vende gli oggettini d’oro, salta il pasto di mezzodì e usa i buoni pasto della ditta per fare la spesa a fine settimana. In casa i pranzi 45 sono ridotti a farinacei, patate e, di rado, proteine, a cui provvedono perlopiù i genitori nei pasti domenicali, quando i due “giovani” (ormai entrambi sui 40) ritornano nelle dimore di nascita; le mamme li provvedono con cibarie, olio, caffè. Una vita di stenti. E lei sa di doversi considerare “fortunata” con i suoi circa 1.100 euro mensili, anche se alla quarta settimana non riesce ad arrivare, e cerca occupazioni per arrotondare. Va a fare le pulizie in una dimora privata dopo l’ufficio un paio di volte alla settimana. Intanto, la crisi ha colpito il fratello maggiore: la ditta ha perso mese dopo mese, le commesse in precedenza numerose. E un anno e mezzo fa ha chiuso. Era una piccola, ma fiorente azienda. Kaputt. Il geometra quarantenne viene messo con gli altri dipendenti in cassa integrazione: finita la cassa, comincia a cercare. Prima fa il giro dei cantieri, poi manda curricula alle ditte edili: non riceve risposte. Quando gliene danno sono sconsolate e sconfortanti. Spulcia gli annunci sui giornali: ma settimana dopo settimana allarga il raggio della sua ricerca. Cerca qualunque cosa. Va a scaricare frutta ai mercati generali, quando capita. E continua a salir l’altrui scale. A bussare a porte che rimangono ostinatamente chiuse. I genitori condividono le ambasce del figlio, e le difficoltà della figlia. Sono impotenti. E probabilmente il padre pensa che suo figlio che era la prova del miglioramento della condizione familiare, ora testimonia un fallimento, una sconfitta. Ma arriva infine la buona notizia: forse il figlio sarà “preso”, ossia assunto. In una ditta metalmeccanica. Come operaio semplice, manovale. Ma avrà un salario. Basso, poco più di 900 euro trattandosi di un primo impiego, ma pur sempre un salario. Infine, non sarà superfluo aggiungere che questo posto, se sarà davvero confermato, è stato ottenuto solo grazie al fatto che all’Ufficio del personale della ditta c’è qualcuno che è amico di un amico che è amico di…Insomma, anche per essere assunti, come operaio generico, in una grande azienda del Nord, occorre una raccomandazione. Ma questo è solo un dettaglio: siamo pur sempre in Italia. Quello che conta è la forza simbolica di questa piccola storia, una come tante. Sentiamo parlare di “cambio di passo”, di mobilità, di riforme, di modernità, di ascensore sociale, della generazione di Telemaco che sostituisce quella di Ulisse (che sciocchezza, Renzi!): ebbene, l’ascensore quando funziona, va in discesa. del 10/07/14, pag. 2 Rapporto Inail/CALANO (21%) I DECESSI RISPETTO AL 2012 Meno infortuni e morti sul lavoro ma è conseguenza della recessione Giorgio Salvetti Cala il numero di morti sul lavoro. Ma c’è poco di cui essere soddisfatti. Perché si tratta pur sempre di una strage: una media di due vittime al giorno. E poi perché, proprio come l’inflazione bassa, anche questo dato - reso pubblico ieri dall’Inail nella sua relazione annuale al parlamento - è uno dei tanti indici che testimoniano la crisi. Si lavora meno, dunque si muore meno. Tutto qui. Questo senza pensare al fatto che molti lavoratori non sono coperti dall’Inail ma da altri sistemi assicurativi e che molti non sono coperti affatto perché lavorano in nero. E in questo caso la recessione economica nasconde il numero degli infortuni mortali che passano dal lavoro regolare a quello sommerso. I morti sul lavoro coperti dall’Inail nel 2013 sono stati 660, in calo dell’21% rispetto all’anno prima e al minimo storico dal 1954. Gli infortuni mortali denunciati sono stati 1175 (-11,7%) ma ne 46 sono stati riconosciuti poco più della metà, 36 sono ancora sotto istruttoria. Di questi 376 sono avvenuti fuori dalle aziende (57%). Le denunce di infortuni sono state 695 mila (-7% rispetto al 2012 e -21% rispetto al 2009). Gli infortuni riconosciuti però sono circa 460 mila (-9,4%). Gli infortuni sul lavoro hanno provocato 11 milioni e mezzo di giornate di inabilità a carico dell’Inail. Aumentano invece le denunce di malattie professionali: quasi 52 mila (5.500 in più rispetto al 2012, +12% sul 2012, +47% sul 2009). Hanno riguardato 39.300 lavoratori ammalati. Di queste ne è stato riconosciuto il 38%: i lavoratori morti per malattie professionali sono stati quasi 1500 (-33%), il 62% aveva più di 74 anni al momento del decesso. Il calo degli infortuni mortali riguarda tutti i settori produttivi: 560 nell’industria e nei servizi (-22,22%), 85 nell’agricoltura (-18,27%). E i morti sono diminuiti quasi su tutto il territorio nazionale: 180 nel nord-ovest contro i 224 del 2012, 134 nel nord est contro 211 dell’anno precedente, 148 al centro (-13), 133 al sud contro 175 del 2012. Sono quasi invariati solo nelle isole: 165, uno in più dell’anno prima. Il bilancio dell’Inail registra entrate per più di 10 miliardi e uscite per poco meno di 9 miliardi. Un miliardo di disavanzo ogni anno ha migliorato il patrimonio che ha superato i cinque miliardi e mezzo. Nei prossimi anni l’istituto dovrà rinunciare a 500 mila euro l’anno per effetto della riduzione dei premi e dei contributi assicurativi decisi dall’ultima legge di stabilità. Ma il suo tesoretto fa gola al governo. Lo ha detto ieri il ministro del lavoro Poletti che ha parlato di «utilizzare le riserve tecniche dell’Inail per costituire un fondo da usare per investimenti a sostegno dello sviluppo». Poletti ha mostrato un cauto ottimismo, ha detto che i dati attesterebbero una riduzione degli infortuni anche al netto della crisi e ha aggiunto: «Si tratta di un buon dato ma non è un punto di arrivo. Dobbiamo fare in modo che le cose migliorino. La soddisfazione arriverà quando non ci saranno più morti sul lavoro». Molto più prudenti i sindacati. La Uil sostiene che il calo è dovuto alla diminuizione del 25% della produzione dal 2008 ad oggi. Un parere quasi condiviso anche dalla Cgil: «Il combinato disposto precarietà, aumento della disoccupazione e della cigs, abbatte il numero delle denunce, senza considerare che ci sono ancora molti settori in cui i lavoratori non sono iscritti all’Inail». Ancora più allarmato il commento della Filca-Cisl: «Nel settore delle costruzioni si sono persi 800 mila posti di lavoro dal 2007 e gli infortuni di questo settore rappresentano da soli il 25% del totale». Ma forse il dato più allarmante riguarda i controlli sulle aziende: l’Inail ne ha effettuati 23.677 e nell’87,65% dei casi sono state riscontrate irregolarità. Sono stati regolarizzati oltre 70 mila lavoratori di cui quasi 8 mila erano in nero. Del 10/07/2014, pag. 7 Eni taglia raffinerie e chimica Migliaia di posti a rischio MASSIMO FRANCHI Il nuovo corso dell’Eni parte con una rottura forte con i sindacati e con oltre 5mila posti di lavoro a rischio in Italia, soprattutto al Sud. Il primo incontro tra il neo amministratore delegato Claudio De Scalzi e i segretari generali di Filctem Cgi, Femca Cisl e Uiltec, martedì sera, ha messo in allarme i 3.500 operai - tra diretto e indotto - della raffineria di Gela, che già da quattro giorni erano in presidio davanti allo stabilimento siciliano. L’impianto in provincia di Caltanissetta è praticamente fermo da oltre 4 mesi: dopo il grave incendio che lo colpì l’azienda lo tiene in manutenzione. Ma è il futuro a preoccupare sindacati e lavoratori. De Scalzi ieri ha confermato i rumors delle settimane scorse: il 47 nuovo corso Eni prevede il blocco del progetto delle tre nuove linee di produzione, e vengono revocati i 700 milioni di investimenti destinati alla programmata riconversione produttiva. In cambio verrebbe proposto un nuovo progetto come alternativa, ma i sindacati non hanno voluto sentire nemmeno le linee generali della proposta perché, come pregiudiziale, hanno preteso dall’azienda, «il rispetto integrale degli impegni sottoscritti appena un anno». IL “ROSSO”DELLA RAFFINAZIONE Per la Sicilia le brutte notizie non sono finite. Anche la raffineria di Priolo - che assieme a Gela copre il 40% della produzione italiana - è a rischio. E lo sono anche Taranto, Livorno e la seconda fase della riconversione di Porto Marghera. De Scalzi infatti ha denunciato un “rosso” pesante per la raffinazione in Italia: ben 850 milioni di euro, anche a causa di un surplus europeo di 120 milioni di tonnellate. In questo quadro negativo, il manager ha quindi garantito la continuità operativa solo per la raffineria di Sannazzaro (Pavia) e della propria quota del 50% su quella di Milazzo. «La sensazione che abbiamo avuto - spiega il segretario generale della Filctem Emilio Miceli è che De Scalzi voglia ridurre la presenza industriale in Italia sia nella raffinazione che nella chimica, colpendo soprattutto il Mezzogiorno ma mettendo in forse gli investimenti di Porto Marghera che in fatto di produzione di etilene è in alternativa a Taranto. Ma l’Eni non è un’azienda, è un sistema complesso che governa gli equilibri nazionali e abbiamo il sospetto che sia incoraggiato da un ministro dell’Economia che vede in Eni solo un modo per fare cassa con la privatizzazione, senza tener conto che si tratta dell’energia del Paese: un asset fondamentale. Più che un piano di ristrutturazione quello di De Scalzi è un piano di smantellamento», attacca Miceli. «A fabbrica chiusa – rincara la dose il sindacalista – non si può fare alcun progetto e non si può discutere. Chiederemo al governo di convocare un tavolo urgente, perché se è vero che l'Eni perde sulla raffinazione per effetto anche dei suoi mancati investimenti nel settore, è altrettanto vero che l'Italia ha bisogno della sua presenza industriale. Non possiamo assistere inerti ad un grande gruppo che rischia di uscire dall'industria: ci batteremo fino in fondo perchè ciò non avvenga». «Non possiamo accettare fermate o il non riavvio degli impianti», sottolinea il segretario generale Uiltec Paolo Pirani. «Il quadro che ci è stato presentato è molto pesante e non potevamo non esprimere il nostro dissenso, ribadendo la necessità di condivisione di ogni progetto di riorganizzazione. Vogliamo affrontare il profilo industriale di Eni in Italia, sia per la raffinazione, che per la chimica», ha aggiunto. Pirani ha anche ribadito la «necessità di richiedere l’apertura di un tavolo con il Governo sulle politiche industriali di Eni e sui punti di crisi a partire da Gela». Filctem, Femca e Uiltec hanno quindi deciso di convocare per venerdì 18 luglio il coordinamento nazionale unitario di categoria per stabilire le iniziative di lotta da intraprendere non solo nelle raffinerie ma in tutti gli stabilimenti produttivi di Eni. DE VINCENTI RASSICURA CROCETTA Sulla situazione della Sicilia, i sindacati territoriali hanno chiesto un incontro urgente al presidente della Regione Rosario Crocetta che ieri ha attaccato: «Non permetterò la chiusura di alcun impianto dell’Eni, Gela non sarà una nuova Termini Imerese». A questo proposito è intervenuto il viceministro allo Sviluppo Claudio De Vincenti, che alla fine di una riunione al ministero dedicata proprio all'insediamento Eni di Gela, ha rassicurato: «Capisco le preoccupazioni che trovano sensibile il governo. Tuttavia Eni ha dato indicazioni di investire nell'area di Gela. Proprio per questo ho invitato Eni a presentare quanto prima un piano industriale». De Vincenti ha infine confermato che per proseguire il confronto è già stato messo in agenda per i prossimi giorni un nuovo appuntamento fra le parti. 48
Scarica