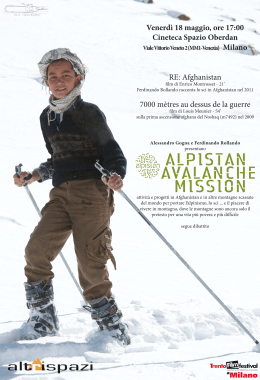www.rivistaindipendenza.org Dal blocco allegato di "Notizie dal mondo" 1-15 giugno 2006: a) Stavolta esordiamo con l’Afghanistan. Un conflitto molto meno seguito ma nient’affatto irrilevante per le strategie imperiali di Washington in Asia centrale. Un significativo banco di prova per il governo di centrosinistra italiano. Saranno proni anch’essi, dopo il centrodestra, a sua maestà imperiale? Basta pensare ai trascorsi e alla triade Prodi-Parisi-D’Alema per darsi una risposta. Una raffica di notiziole comunque perché non ci si accusi di prevenzione: Italia / Afghanistan (1, 10, 15); Afghanistan (2, 8, 15); Italia (4). Un’occhiata a Italia (9) sull’Iraq. Sul ritiro dall’Iraq, asserito dall’attuale governo di centrosinistra, è da tenere a mente quanto prefigurato dal precedente governo di centrodestra che aveva annunciato la stessa cosa per fine anno (cfr. blocco di notizie 15-30 maggio: Italia / Iraq. 17 maggio. Un illuminante scritto di Stefano Chiarini). Istruzioni per l’uso: nella fase imperialista il mondo è una scacchiera ed i teatri di guerra ne sono solo i quadratini. Ah, sul tema Afghanistan un’occhiata a Francia / Afghanistan (14). A buon intenditor nessuna parola. b) Corno d’Africa. Somalia (6, 8, 14). Un USA / Somalia all’11. Scenari lontani. L’Africa solitamente fuori dall’attenzione internazionale, carità pelosa a parte. A Mogadiscio arrivano le Corti islamiche. Sembra un deja vu. Comunque da seguire. c) Dal caldo africano al freddo himalayano. Nepal (3, 11) con i maoisti ad un passo dal governo. Situazione interessante anche per le contaminazioni (maoiste) sulla confinante India (3). A Washington hanno già aperto la pratica e l’India interessa in funzione anti-Cina. Il fantasma di Mao potrebbe intralciare certi disegni imperiali della Casa Bianca già avviati di recente con lo sdoganamento nucleare di Nuova Delhi. d) Situazione molto delicata in Palestina. Sul referendum di Abbas cfr 7, 11. Ma anche, d’accompagno, Israele (12) e Palestina / Israele (14). Tra l’altro: Euskal Herria (2, 8, 13, 14, 15 giugno) Iraq (5, 8, 9, 15 giugno) Siria (3 giugno) USA / Iraq (14 giugno) USA / Iran (2 giugno) Iran (3, 4 giugno) Venezuela (1 giugno) Bolivia (3 giugno) Perù (8 giugno) Ucraina (6, 13 giugno) Ucraina / Russia (6 giugno) Ci fermiamo qui. Stavolta siamo stati clementi. Italia / Afghanistan. 1 giugno. L’intervento in Afghanistan? Diverso e peggiore rispetto a quello in Iraq. Gino Strada, fondatore di Emergency, intervistato da il Manifesto, è perentorio: «mi permetto di ricordare che l’intervento in Afghanistan inizia il 7 ottobre 2001, portato avanti dall’aviazione di un paese senza nessun coinvolgimento, neanche tentato, delle Nazioni Unite. Il 12 settembre una risoluzione dell’ONU assicurava che il Consiglio di Sicurezza si sarebbe impegnato ad assicurare alla giustizia gli attentatori e i mandanti degli attacchi terroristici, di tutti gli atti di terrorismo, secondo la Carta delle Nazioni Unite. Venticinque giorni dopo un paese decide di bombardare un altro paese con un atto che è stato di terrorismo internazionale, esattamente come è stato quello al World Center (...). Gli interventi di tamponamento ex post [l’avallo successivo dell’ONU, ndr] non sanano la situazione di illegalità che, ripeto, è particolarmente grave per gli italiani [il riferimento è alla violazione dell’art. 11 della Costituzione, ndr]». Italia / Afghanistan. 1 giugno. Gino Strada difende anche l’azione di Emergency. Le organizzazioni umanitarie stanno subendo una progressiva «militarizzazione» e le pressioni aumentano su quelle riottose a schierarsi con l’attuale autorità imperiale di Washington. Su Repubblica Guido Rampoldi tira fuori appunto il caso dell’ospedale di Emergency a Kabul: «Aprire un centro sanitario che rimette in sesto i combattenti d’un regime spaventoso», scrive il giornalista di Repubblica, «a noi non pare un grande affare per la pace e per l’umanità». Replica Strada: «Nei nostri ospedali curiamo tutti, questo è certo: non abbiamo mai chiesto a nessuno come la pensa, chi è, cosa vota, che cosa ha fatto nella sua vita. E di questo siamo orgogliosi. D’altronde ci ispiriamo, semplicemente, alla Dichiarazione universale dei diritti umani e alla deontologia medica. Mi inorridisce sentire parlare, di nuovo, di pallottole o bombe umanitarie. C’è una logica terrificante dietro quello che scrive Rampoldi, che non soltanto va contro i princìpi di Emergency –sarebbe poca cosa– ma contro ogni deontologia medica e contro qualsiasi diritto umanitario internazionale. È la logica del fai-da-te, del cow boy, la logica della barbarie». Russia. 1 giugno. Il Pentagono mira a schierare una base di missili intercettori in uno dei Paesi dell’Europa orientale. Mosca replica preannunciando postazioni anti-missile ai confini. Secondo il vice premier e ministro della Difesa, Sergei Ivanov, questo intendimento diventerà esecutivo nei piani per lo sviluppo dello strumento militare dal 2006 al 2010. «Siamo al corrente di piani per la creazione di postazioni anti-missile in Polonia. Questi progetti ci preoccupano molto e li teniamo in considerazione nei nostri piani per i prossimi cinque anni», dice Ivanov all’agenzia Itar-Tass. Aggiunge che le spese di ammodernamento e di gestione raggiungeranno entro il 2010 il rapporto di parità, mentre «attualmente il 60% del bilancio è devoluto alle spese di gestione dell’esercito e della marina e il 40% allo sviluppo». Questo rapporto cinque anni fa era pari al 70 e 30%. Venezuela / Russia. 1 giugno. La Russia costruirà in Venezuela due stabilimenti per la produzione di armi e munizioni. Ieri, il presidente venezuelano Hugo Chávez ha annunciato che Mosca ha già sottoscritto un contratto per la fornitura al Venezuela di 100mila fucili di assalto Kalashnikov. «Così potremo difendere ogni strada, ogni collina, ogni angolo», ha detto Chávez in visita in Ecuador, dove ha firmato una serie di contratti per forniture energetiche. Secondo l’agenzia Associated Press, la società Rosoboronexport avrebbe confermato che le trattative sono in corso senza però fornire dettagli sui tempi e sulla capacità di produzione dell’impianto. Chávez ha detto anche ai giornalisti che un primo lotto di 30mila Kalashnikov dovrebbe arrivare in giugno, notizia confermata dall’industria russa. L’accordo non è visto di buon occhio dagli USA che considerano Chávez una presenza destabilizzante nella regione. Nel mese di maggio il dipartimento di Stato USA ha bandito la vendita di armi al Venezuela per i contatti di quel Paese con l’Iran e Cuba e per la «mancanza di supporto nella lotta al terrorismo». Secondo fonti di stampa gli USA sarebbero preoccupati dalle iniziative del Venezuela volte al rafforzamento del suo apparato militare. In aprile il Venezuela ha ricevuto tre elicotteri militari russi, primi di un lotto di 15 ordinati a Mosca. Secondo Chávez, contribuiranno alla protezione del Venezuela nell’eventualità di una invasione USA. Il governo venezuelano ha ripetutamente accusato Washington di tentare di destabilizzare il governo ed il paese. Venezuela. 1 giugno. Tagli alla produzione petrolifera per mantenere il prezzo del greggio su un livello di poco inferiore ai 70 dollari al barile. Lo ha chiesto oggi, invano, il capo di Stato venezuelano Hugo Chávez, nel corso del 141° incontro dei paesi produttori di petrolio appartenenti al cartello dell’Opec in corso a Caracas. Il tetto di produzione giornaliera si manterrà quindi sui 28 milioni di barili decisi in precedenza. Secondo il ministro dell’Energia iraniano Kazem VaziriHamaneh e quello del Qatar, Abdullah al-Attiyah, con l’attuale tendenza al rialzo dei prezzi, un decremento della produzione non è una misura praticabile. Secondo Frederic Lassere di SG Securities di Parigi, con l’attuale costo al barile vicino ai 70 dollari, se il direttivo dell’Opec avesse deciso di diminuire la quantità di petrolio estratto, avrebbe lanciato un segnale politico negativo difficile da far accettare ai consumatori. Soprattutto in considerazione del fatto che nei prossimi mesi, in concomitanza con l’arrivo dell’estate e della stagione degli uragani, la domanda di petrolio da parte degli Stati Uniti tenderà ad aumentare molto, con forti pressioni inflattive sul costo del greggio. Venezuela. 1 giugno. Chávez è favorevole ad una politica di alti prezzi dell’oro nero per diverse motivazioni, di natura interna ed internazionale. Prima di tutto le ragioni di politica nazionale. La sostanziale mancanza di sufficienti investimenti tecnologici negli apparati produttivi e i contrasti tra Chávez e i dirigenti della società petrolifera di Stato, la Pdvsa, seguiti al golpe contro di lui del 2002, hanno determinato una notevole compressione delle capacità produttive, scese da 3,5 milioni di barili al limite degli attuali 2,2-2,5 milioni di barili al giorno. Dopo il tentato golpe contro Chávez dell’aprile 2002 e il rapido ritorno al potere dell’ex colonnello, i vertici della Pdvsa avviarono una serrata della produzione che costrinse Chávez a sostituirli in blocco con esponenti a lui politicamente vicini. Da allora, però, i livelli produttivi non sono mai riusciti a risalire ai picchi precedenti a tali vicende. In un simile contesto, un elevato prezzo del petrolio sui mercati internazionali può compensare difficoltà strutturali e di relazioni tra governo e holding petrolifera di Stato. In secondo luogo, se i prezzi dell’oro nero rimangono elevati, il leader venezuelano può continuare a finanziare al meglio i programmi di natura sociale volti a migliorare i livelli di alfabetizzazione della popolazione, i servizi sanitari e l’incremento di alloggi popolari. Venezuela. 1 giugno. Vi sono poi ragioni di politica internazionale dietro la richiesta di Chávez di tagliare la produzione di greggio. Sin dalla sua visita in Cina alla fine del 2004, Chávez ha iniziato a utilizzare l’arma del petrolio come un vero e proprio strumento diplomatico, funzionale alla realizzazione dei suoi obiettivi di politica estera. Mentre i paesi del Medio Oriente, membri dell’Opec, sono consapevoli che accettare un taglio alla produzione significherebbe innescare forti tensioni che porterebbero a sostanziali aumenti del prezzo del petrolio e a una possibile spirale inflazionistica mondiale e sul mercato statunitense, già provato dalle polemiche sulla questione nucleare iraniana, Chávez non ha simili timori. Anzi, il suo obiettivo è proprio quello di usare la Oil Diplomacy, come qualcuno l’ha già definita, contro gli Stati Uniti. Con la stagione degli uragani alle porte e la probabile crescita della domanda di energia nel corso dei mesi estivi, mantenere il costo del petrolio a livelli elevati significherebbe indebolire ancora di più la dirigenza statunitense, costretta a fronteggiare pressioni inflazionistiche, e magari indurla ad assumere un atteggiamento diverso verso Caracas. Non è un caso che non appena si è diffusa la notizia dell’apertura di Condoleezza Rice a un possibile dialogo con l’Iran per la questione nucleare, il prezzo del petrolio al barile è immediatamente sceso di due dollari. La repentina discesa del costo del greggio induce quindi a ritenere che, tra le motivazioni congiunturali alla base della calcolata apertura della Casa Bianca sull’Iran, vi siano anche considerazioni di natura petrolifera e di costi della materia prima. Venezuela. 1 giugno. Se il prezzo del petrolio resta elevato, le chance di Chávez di usare le riserve energetiche a sua disposizione per ulteriori finalità diplomatiche aumentano di molto. Per esempio, potrà continuare a fornire greggio a costi ridotti a nazioni come quelle caraibiche o ad altri paesi latino-americani in temporanea difficoltà come recentemente con l’Ecuador, accrescendo le proprie risorse di influenza ‘dolce’ internazionale. E potrà utilizzare i fondi ottenuti dalla vendita del petrolio per sostenere i grandi progetti infrastrutturali come il gasdotto del sud che dovrebbe essere utilizzato per trasportare il gas naturale dal nord al sud del cono latino-americano e favorire così l’integrazione energetica dell’America Latina, da lui considerata un passo essenziale per la successiva integrazione economica. Non solo, con un prezzo del greggio elevato, diverrebbe economicamente conveniente estrarre le, attualmente poco utilizzate, immense risorse petrolifere presenti in Venezuela presso la valle del fiume Orinoco, dove, secondo recenti prospezioni effettuate dalla Chevron, si troverebbero riserve accertate per almeno 275 miliardi di barili, una quantità tale che, se confermata, potrebbe permettere al Venezuela di rivaleggiare con l’Arabia Saudita nel primato mondiale delle riserve possedute. La caratteristica del petrolio dell’Orinoco è quella di essere particolarmente pesante e denso e quindi richiedere processi di raffinazione più costosi. Ma se i livelli internazionali del prezzo del greggio restassero alti potrebbero rendere economicamente competitivo anche tale tipo di petrolio, accrescendo in proporzione geometrica il peso specifico del Venezuela sulla scena mondiale. Le scelte e gli obiettivi politici perseguiti da Chávez verrebbero considerati con un’altra prospettiva e lo stesso presidente potrebbe quantomeno ridurre di intensità le crescenti critiche dell’opposizione interna sulle enormi risorse finanziarie venezuelane spese all’estero per solidarietà con governi o movimenti politici considerati dai bolivariani amici. Venezuela / Ecuador. 1 giugno. L’offensiva politica, via petrolio, continua: Chávez firma a Quito, con il presidente ecuadoriano Alfredo Palacio, un accordo di cooperazione petrolifera. L’Ecuador, che pochi giorni fa ha dichiarato decaduto il contratto con la statunitense Oxy, potrà raffinare fino a 100mila barili al giorno del suo greggio nelle raffinerie venezuelane, con un risparmio di 200-300 milioni di dollari l’anno. Nonostante sia produttore ed esportatore di petrolio, l’Ecuador è costretto ad importare i derivati petroliferi, il gas e la nafta, per 1.8 miliardi di dollari l’anno. L’accordo prevede anche un’integrazione energetica e accordi di cooperazione fra le due compagnie statali, Pdvsa e Petrocuador. L’Ecuador «recupera le sue risorse energetiche», ha detto Chávez e Palacio ha parlato di «un giorno memorabile nella storia dell’Ecuador». Euskal Herria. 2 giugno. Misure cautelari solo per Permach. Degli otto dirigenti di Batasuna, la Procura obbliga solo Joseba Permach a presentarsi quotidianamente ai commissariati per la firma e gli vieta di uscire dallo Stato spagnolo. Il giudice Fernando Grande-Marlaska ha quindi rimandato liberi Arnaldo Otegi, Jon Gorrotxategi, Karmelo Landa, Rufi Etxeberria, Joseba Alvarez, Juan Kruz Aldasoro, Pernando Barrena, specificando però che non muta la situazione processuale degli imputati adducendo, come motivazione, tra le altre, il fatto che «le norme devono essere interpretate attendendo alla realtà sociale del momento nel quale si applicano». Della serie: come si usa la cosiddetta “giustizia”. Il magistrato ha motivato le misure restrittive per Permach per aver il portavoce di Batasuna detto, la scorsa settimana, che, se gli otto dirigenti fossero stati incarcerati, il processo di pace sarebbe entrato «in una situazione di blocco». In un’intervista a Radio Euskadi (26 maggio scorso), Permach aveva criticato «Rubalcaba (ministro dell’Interno, ndr) e gli assistenti di Zapatero» perché «stanno tirando molto la corda» e avvertito l’esecutivo spagnolo che stava ponendo «al limite del colasso» la possibilità di aprire un processo politico in Euskal Herria con l’accentuare le persecuzioni nei confronti degli indipendentisti. Euskal Herria. 2 giugno. Il reato commesso dagli otto esponenti di Batasuna è quello di aver convocato una conferenza stampa in un hotel di Iruñea, il 24 marzo, ed esposto il punto di vista della formazione indipendentista rispetto al cessate-il-fuoco decretato dall’ETA. Il solo Otegi non era presente perché a casa, malato. Lo scorso venerdì il giudice aveva allargato l’imputazione a un «reato di minacce terroriste», legando l’intervista a due rappresentanti di ETA pubblicata da Gara, la presentazione della commissione negoziatrice di Batasuna e dichiarazioni di Joseba Permach che poneva l’attenzione sulla gravità del momento politico (per una serie di atti persecutori contro la sinistra abertzale) e la possibilità di un «blocco» nel processo negoziale in via di apertura. Euskal Herria. 2 giugno. Per il giudice Fernando Grande-Marlaska tutte le iniziative della sinistra abertzale (patriottica) «sono conseguenza di un piano orchestrato dall’insieme della rete dell’organizzazione terrorista ETA, al fine di obbligare i poteri legittimi a negoziare e ad assumere le sue esigenze come condizione indispensabile del cessate definitivo dell’esercizio della violenza». Per questo respinge la tesi che i divieti alle manifestazioni di Batasuna e le iniziative giudiziarie contro i suoi membri «chiudano o limitino l’esercizio legittimo dei diritti civili e politici». Euskal Herria. 2 giugno. Batasuna critica la politica della UE in Sri Lanka. L’inclusione della guerriglia tamil, LTTE, nella lista delle organizzazioni «terroriste» dell’Unione Europea (UE) è un attacco al processo di pace in Sri Lanka. Secondo il movimento basco la decisione è «conseguenza della pressione esercitata dal governo di Colombo e degli Stati Uniti», il che suppone, aggiunge, «un chiaro allineamento della UE contro una delle parti integranti il processo di pace dello Sri Lanka». La UE «criminalizza l’LTTE, mentre il ricorso sistematico alla guerra sporca e alle organizzazioni paramilitari da parte di Colombo contro il popolo tamil prosegue impunito». USA / Iran. 2 giugno. Senza clamori la Casa Bianca stringe il cerchio intorno all’Iran. Washington ha già adottato, unilateralmente, un insieme di misure economiche e finanziarie tendenti a soffocare l’Iran impedendogli di accedere al sistema bancario internazionale. Negli ultimi mesi la svizzera Ubs Ag e l’olandese Abn Amro Holding hanno annunciato di aver posto fine ad ogni operazione con il governo iraniano dopo che nei loro confronti erano state aperte due inchieste del Dipartimento della Giustizia USA. Parallelamente, agitando lo spauracchio iraniano-sciita, Washington sta cercando di legare ancor più a sé i paesi arabi –sunniti– del Golfo, la Giordania e l’Egitto, da un lato per imbarcarli nella «crociata contro il terrorismo» e convincerli ad abbandonare al loro destino i palestinesi e la resistenza irachena e dall’altro a sostenere il tentativo americano-francese –tramite la Hariri Inc. l’ultradestra libanese e Walid Jumblatt– di disarmare la resistenza libanese e palestinese e portare al potere in Siria, al posto dell’attuale regime alawitasciita del presidente Bashar, l’ex vicepresidente sunnita Abdel Halim Khaddam e i fratelli musulmani. Quasi un risarcimento di Washington ai sunniti per aver dato agli sciiti la Mesopotamia. USA / Iran. 2 giugno. Il governo di Teheran, da parte sua, si è dichiarato pronto a colloqui diretti con Washington ma ha respinto l’approccio di Washington che ha posto condizioni non trattabili. Ieri il ministro degli Esteri iraniano, Manucher Mottaki, ha detto che le proposte USA non sarebbero altro che «un tentativo della Casa Bianca di riparare le smagliature con gli alleati europei» e «un pretesto per coprire i fallimenti statunitensi in Iraq e nella regione». Il braccio di ferro si è quindi spostato nella riunione dei cinque grandi più la Germania. Qui gli USA hanno fatto passare un pacchetto di «incentivi», se Teheran decide di piegarsi; in caso contrario, un impegno collettivo a rimandare il dossier al Consiglio di Sicurezza per l’adozione di sanzioni. Mosca e Pechino hanno salutato positivamente l’apertura di Washington ma non sembrano ancora del tutto convinte ad accettare il varo di misure punitive contro Teheran; in particolare respingono il richiamo all’articolo VII della Carta ONU, che implica l’uso della forza, primo passo per azioni belliche. Gli USA, con la loro «apertura senza condizioni» che Teheran non poteva che respingere, intendono superare formalmente le perplessità europee e il “no” di Cina e Russia all’adozione di misure coercitive contro l’Iran. L’«apertura» deriverebbe inoltre dalla necessità di costruire un fronte internazionale in grado di sostenere l’assedio a Teheran e, un domani, un’eventuale blitz, in un momento di grave difficoltà per l’Amministrazione, a causa dell’andamento disastroso della guerra in Iraq e in Afghanistan, e a pochi mesi dalle elezioni di medio termine di novembre negli States. USA / Iran. 2 giugno. Secondo la BBC, gli USA avrebbero raggiunto un accordo con Russia e Cina (i paesi che si sono sempre opposti a sanzioni contro l’Iran): qualora a Teheran rifiutino il loro ultimatum-proposta, Mosca e Pechino appoggerebbero una dura risoluzione dell’ONU. Afghanistan. 2 giugno. La vittoria dei taliban «è solo questione di tempo». Lo ha detto il responsabile militare del movimento insorgente afgano, il mullah Madadallah. Nella prima intervista rivolta all’Occidente dal ritiro talebano nel dicembre 2001 sotto i bombardamenti a tappeto USA, la guerriglia riconosce eccessi nei suoi anni di governo e ricorda agli alleati europei che il loro nemico sono gli Stati Uniti. All’emittente Al Jazeera, il dirigente talebano ammicca e allo stesso tempo avverte le truppe della NATO, il cui numero sta crescendo nel paese, assicurando che «noi non consideriamo come nostri principali nemici gli altri paesi che fanno parte della coalizione straniera distaccata in Afghanistan; il nostro nemico numero uno sono gli Stati Uniti». Ha quindi aggiunto: tornando al potere applicheremo una politica meno dura. «Abbiamo appreso molte cose che dobbiamo avere in considerazione in futuro. La nostra attuazione, con la volontà di Dio, sarà differente per soddisfare tutti gli strati del popolo afgano». Ha quindi affermato di essere in permanente contatto con la guida talebana, il mullah Omar. La guerriglia è protagonista in questi mesi di una crescente offensiva contro l’occupazione del paese. Cina / Palestina. 2 giugno. Pechino riceve il governo palestinese. Il ministro degli Esteri cinese, Li Zhaoxing, si è incontrato ieri con il suo omologo palestinese, Mahmud al Zahar. Lo riferisce l’agenzia Xinhua. La Cina, come ha fatto la Russia, rompe così il blocco imposto da USA ed Israele all’attuale Esecutivo palestinese. Al-Zahar si recherà poi anche in Iran, Indonesia, Malesia e Sri Lanka. Non sono riferiti i termini dell’incontro, ma analisti ritengono sia stato incentrato sulla posizione del governo di Hamas di fronte all’iniziativa di pace araba, adottata al vertice di Beirut nel 2002. Questa stabilisce che i paesi arabi normalizzeranno le proprie relazioni bilaterali con Israele se questi si ritira dai territori occupati nella guerra del 1967 e riconosce uno Stato indipendente palestinese con Gerusalemme come capitale. Il portavoce ministeriale ha sottolineato che il governo cinese non ha mai considerato Hamas un’«organizzazione terrorista» e ribadito che il principio di “pace in cambio di terra” deve essere la base per dare soluzione al conflitto. Germania. 3 giugno. Le riforme neoliberiste stanno creando problemi alla Grande Coalizione tedesca (socialdemocratici e democristani al governo). Il governo di Angela Merkel vuole restringere le norme per gli aiuti ai disoccupati. L’Esecutivo prepara dure ripercussioni per chi non accettasse la terza offerta di impiego ed il lavoro gratis di coloro che dipendono dall’aiuto pubblico. Si tratta dei tagli più duri dalla Seconda Guerra Mondiale. Montenegro. 3 giugno. Il Montenegro ha proclamato oggi la sua indipendenza in una sessione straordinaria del Parlamento divenendo pertanto un nuovo Stato dei Balcani. Sancita così la fine della Jugoslavia. Siria. 3 giugno. In un discorso registrato, il capo di al Qaeda in Mesopotamia, Abu Musab al Zarqawi, differenziandosi da quanto sostenuto dallo stesso Bin Laden, ha invitato i sunniti a portare avanti una vera e propria crociata contro gli sciiti non solo in Iraq (contro ogni ipotesi di unità nazionale per combattere le truppe straniere) ma anche –in questo in perfetta sintonia con i piani di USA e Francia– contro la resistenza libanese degli Hezbollah, della quale ha chiesto il disarmo. Hezbollah, dice al Zarqawi, sarebbe diventata «lo scudo che protegge l’esercito sionista dagli attacchi dei mujaheddin in Libano». Libano. 3 giugno. Cresce la tensione nel paese. Venerdì scorso l’uccisione, a Sidone, con un’autobomba, di due esponenti della Jihad islamica. Due giorni dopo i più duri scontri di confine tra Hezbollah ed esercito di Tel Aviv che si siano avuti dal 2000. Giovedì sera, una trasmissione satirica alla televisione libanese Lbc (vicina al leader delle falangi cristiano-maronite di estrema destra, Samir Geagea) nella quale si metteva in ridicolo il segretario degli Hezbollah, sheik Hassan Nasrallah, ha dato fuoco alle polveri. Migliaia di giovani sono scesi in piazza nella periferia sud di Beirut, a maggioranza sciita, bloccando per ore le strade che vanno verso l’aeroporto. I manifestanti si sono diretti poi verso la centrale piazza dei martiri e si sono scontrati con i militanti della destra falangista guidati dal figlio di Amin Gemayel, Sami, a rue Monot. Sassaiole e incidenti anche sulla linea di confine con il quartiere di Ain Rumaneh. Solamente il dispiegarsi dell’esercito lungo la “linea verde” che divideva in due la capitale libanese durante la guerra civile (1975-1990) e gli appelli alla calma dello stesso Nasrallah, hanno evitato, per ora, il peggio. Iran. 3 giugno. «L’Occidente non può costringere l’Iran a rinunciare al proprio diritto di avere tecnologia nucleare per scopi civili. Per questo la nazione e il governo iraniani sono decisi ad acquisire energia nucleare», ha affermato ieri il presidente Mahmoud Ahmadinejad durante un incontro con il segretario generale dell’Organizzazione della conferenza islamica (Oci), Ekmeleddin Ihsanoglu. Alcuni osservatori fanno però notare che il governo iraniano non ha ancora ufficialmente risposto all’accordo raggiunto giovedì dal gruppo 5+1 (i 5 grandi del Consiglio di Sicurezza più la Germania) su un «pacchetto sostanziale» di incentivi in cambio della sospensione immediata di ogni attività di arricchimento di uranio e dell’assicurazione che non saranno adottate misure da parte dell’ONU. Perentoria la segretaria di Stato statunitense Condoleezza Rice: l’Iran non può tergiversare e deve rispondere «nel giro di settimane» alla proposta-ultimatum, ribadendo che la sospensione dell’arricchimento dell’uranio «non è negoziabile», altrimenti «la parola passerà al Consiglio di Sicurezza dell’ONU». Iran. 3 giugno. Non usa mezzi termini lo “zar” dell’intelligence statunitense, John Negroponte. L’Iran è «il principale Stato sponsor del terrorismo nel mondo» e «potrebbe avere la bomba nucleare entro il 2010», ha affermato in un’intervista alla britannica BBC. Indirettamente gli risponde Ahmadinejad: «La ragione della loro posizione non è la preoccupazione per le armi nucleari, ma l’accesso dell’Iran alla tecnologia, che significa aprire la strada a tutti i Paesi indipendenti, specialmente i Paesi islamici, per avere tecnologia nucleare». In attesa di una risposta ufficiale del governo iraniano, però, la Russia ha messo le mani avanti. Il presidente Putin ha affermato che «è troppo presto» per parlare di sanzioni contro l’Iran nel caso in cui Teheran si rifiuti di accogliere le richieste della comunità internazionale sul suo programma nucleare. E ha escluso l’ipotesi di un ricorso alla forza. Nepal. 3 giugno. Prova di forza ieri a Kathmandù. Convocati dal Partito Comunista del Nepal Maoista, che si levò in armi dieci anni fa, 300mila persone, molte delle quali arrivate da diverse aree del paese, sono scese in piazza nella capitale nepalese. Era la loro prima manifestazione autorizzata da tre anni a questa parte. Ressa sul piazzale, poi, per cercare un varco e vedere i volti praticamente sconosciuti dei dirigenti della guerriglia che si succedevano nei loro discorsi, udibili grazie ad un gigantesco sistema di altoparlanti. Una stazione radio mobile diffondeva le loro parole per tutta la valle di Kathmandù. È la prima grande manifestazione pacifica della guerriglia dopo il ridimensionamento del re Gyanendra. Più che un semplice corteo si è trattato di una prova di forza: la dimostrazione che la guerriglia gode di un forte appoggio popolare e che non è dunque solo truppa di montagna ma corpo attivo nella società nepalese. Si è svolta pacificamente e rispettando gli accordi presi con il governo. Il corteo si è attenuto a un percorso che ha evitato alcuni luoghi sensibili, come il palazzo reale. Nepal. 3 giugno. I maoisti chiedono un’accelerazione nel processo di cambiamento. Chiedono che il voto per l’assemblea costituente, che dovrà scrivere una nuova Costituzione, non sia gestito da un governo legittimato dalla vecchia. Krishna Bahadur Mahara, il capo negoziatore dei maoisti, prendendo la parola alla manifestazione di ieri, ha accusato il nuovo governo di frapporre ostacoli e di non decidere la data per le elezioni della speciale assemblea che dovrà redigere una nuova Costituzione. Ha inoltre denunciato l’inadempimento, da parte dell’esercito, della tregua bilaterale e chiesto l’immediata dissoluzione dell’attuale Parlamento, «incapace di rappresentare il paese». Il parlamento attuale è stato eletto nel 1999 durante la monarchia e dal re dissolto nel 2002 prima dello scadere del suo mandato quinquennale. Alla fine di aprile, dopo un mese di proteste popolari, il re ha gettato la spugna ed ora, dicono i maoisti, parlamento e governo sono l’espressione di una stagione ormai passata. I maoisti vorrebbero un governo ad interim nel quale, anche se la richiesta non è esplicita, i guerriglieri siano rappresentati più che simbolicamente. C’è chi pensa che i maoisti puntino alla guida del governo. Il governo provvisorio attuale, espressione dei sette partiti che con i maoisti formarono la famosa agenda dei 12 punti siglata in India nel novembre scorso per rovesciare re Gyanendra, è guidato da Girija Prasad Koirala, leader del partito del Congresso. Nepal. 3 giugno. Il 18 maggio scorso è già stata messa nero su bianco la svolta storica che fa del Nepal una repubblica, anche se il re vi mantiene un ruolo decorativo. Le «reali» forze armate hanno smesso di essere reali e la corona ha perso prerogative politiche e privilegi. Secondo Pushpa Kamal Dahal, meglio noto come Prachanda, il leader dei maoisti, è però troppo poco. Non solo il Nepal non è ancora la repubblica che la guerriglia prefigura ma, stando a quanto riporta la stampa, la coalizione del governo starebbe, ha detto Prachanda in un’intervista, «marginalizzando, bypassando e minimizzando» il ruolo del movimento. La manifestazione di ieri è stato un chiaro messaggio di avvertimento. Al momento, comunque, la tregua decretata dalle due parti tiene, il governo non chiama più «terroristi» i maoisti e i processi in tribunale a loro carico saranno chiusi. Una commissione mista di sei persone (per il governo ci sarà il ministro dell’Interno Krishna Sitaula) dovrebbe sedersi a breve ad un tavolo negoziale. Uno dei punti nodali sarà la smobilitazione dell’esercito guerrigliero ma anche il capitolo impunità per le uccisioni del passato da ambe le parti. I maoisti vorrebbero una supervisione ONU. Ma per adesso su quello che è uno dei punti nodali del processo di pace non c’è ancora nessuna indicazione. India. 3 giugno. Prosegue e si intensifica l’azione politico/militare del movimento Naxalita, di ispirazione maoista. «La più grande minaccia alla sicurezza interna mai affrontata», li ha definiti un mese e mezzo fa il primo ministro indiano Manmohan Singh (cfr “notizie dal mondo” 16 aprile). Efficiente la loro struttura militare ed in crescita il numero dei militari e poliziotti morti a causa della guerriglia Naxalita che opera ormai in diversi Stati indiani: Orissa, Maharashtra, West Bengal, Chattisgarh, Madhya Pradesh e Andhra Pradesh. Nato nei primi anni Ottanta nella cittadina di Naxalbari (da cui il movimento prende nome e in cui troneggia ancora un busto di Charu Mazumdar, padre ideologico dei guerriglieri maoisti), il movimento di ispirazione maoista mira ad instaurare un governo del popolo nella repubblica indiana e fornisce appoggio alle rivendicazioni dei contadini e dei gruppi tribali degli stati in questione. Per molto tempo, i guerriglieri maoisti sono stati considerati poco più che banditi, disperati che assaltavano granai e caserme della polizia per ottenere cibo o visibilità. Liquidata per anni come fenomeno marginale e anche un po’ folkloristico, la guerriglia maoista è stata, secondo gli esperti, ampiamente sottovalutata. Talmente sottovalutata da avere avuto la possibilità, nell’ultimo anno, di compiere una serie di attacchi senza precedenti. Attacchi compiuti secondo il modello, ormai consolidato, dei maoisti del vicino Nepal: assalti a posti di polizia e caserme, uniti a operazioni populiste alla Robin Hood di grande effetto, come rubare quintali di riso ai ricchi per distribuirlo gratuitamente ai poveri. Gli scontri con la polizia sono ormai all’ordine del giorno. India. 3 giugno. I guerriglieri Naxaliti sono una vera e propria struttura militare, gerarchicamente organizzata in “Commissioni” (Centrali, Statali, di zona, di distretto e di area) e in “Squadre combattenti di guerriglia”: ciascuna squadra comprende alcuni dalam, battaglioni composti da nove o dodici guerriglieri. In ciascun dalam combattono almeno quattro o cinque donne, e sono sempre più numerose le militanti che ottengono addirittura il comando. Ultimamente, a Narayanpur, «per rafforzare la disciplina tra le truppe» è stato creato un dalam composto esclusivamente da donne, sotto il comando di Nirmal Ekka, una dottoressa. Essere donna, in effetti, facilita l’accesso alle abitazioni dei tribali e ai villaggi, e garantisce una maggiore libertà di azione: le guerrigliere hanno giocato un ruolo decisivo, ad esempio, durante le campagne elettorali e le elezioni locali e regionali facendo propaganda, dando suggerimenti agli elettori e indottrinando le donne lavoratrici sugli obiettivi e i programmi della guerriglia. Si battono inoltre contro la discriminazione nei confronti delle caste più basse, per i diritti delle donne e incoraggiano i matrimoni intercastali. Proprio la povertà, la rabbia e l’insoddisfazione di contadini e degli strati più disagiati della popolazione in genere, unite alla pressoché totale latitanza delle istituzioni nelle regioni in questione, hanno fornito ai Naxaliti una solida piattaforma su cui operare più o meno indisturbati contro le diseguaglianze sociali ed economiche della popolazione. E di programmare, secondo gli analisti, una vera e propria strategia a lungo termine che dovrebbe portare, nelle intenzioni dei ribelli, a risultati analoghi a quelli ottenuti dai maoisti nepalesi. «È un problema di sicurezza», dichiara Ajay Sahni, portavoce dell’Institute for Conflict Management di Delhi, «ma è soprattutto un problema di politiche economiche e di responsabilità di cui il governo deve farsi carico se non si vuole rischiare di ritrovarsi con una situazione analoga a quella nepalese. Secondo le nostre previsioni, difatti, nonostante l’apparente anacronismo storico e ideologico, la guerriglia di stampo maoista, se non viene fermata in tempo, dilagherà in India e nel subcontinente indiano come e più della guerriglia integralista islamica». Bolivia. 3 giugno. Parte la rivoluzione agraria. Definendola più ampia e profonda della riforma nazionale iniziata in questo settore nel 1953, il presidente Evo Morales ha dato il via ufficiale alla «vera rivoluzione agraria». Con una cerimonia a Santa Cruz de la Sierra sono stati dati i primi 30mila km quadrati di terre. Qui, nel bastione dell’opposizione, con un forte movimento che chiede l’autonomia o addirittura la secessione, sede del più forte organismo dei terratenientes, ferocemente contrario a ogni ipotesi di riforma agraria, è iniziata la distribuzione delle terre ai contadini poveri, con l’assegnazione dei primi titoli di proprietà. Proprio a Santa Cruz Morales aveva tentato di trovare un accordo con i proprietari terrieri cruceños, ma senza alcun risultato e finito male, con la rottura dei negoziati e la minaccia di formare una sorta di guardia bianca armata a difesa delle proprietà. Le terre distribuite sabato appartenevano allo Stato ma presto toccherà anche alle proprietà private, che saranno acquisite dallo Stato, senza compensazioni, fra i latifondi improduttivi. Secondo il governo, quasi il 90% delle terre è appannaggio di 50mila famiglie e nel dipartimento di Santa Cruz l’80% sarebbe nelle mani di 12 famiglie. Bolivia. 3 giugno. Ai terratenientes di Santa Cruz, che assicurano che si difenderanno con la forza «dall’orda di contadini degli altipiani che non sono nati qui e ora pretendono di rubare la nostra terra», sabato Morales ha risposto che dovranno abituarsi all’idea che le terre «rubate dai loro predecessori durante la Conquista spagnola ritornino ai loro proprietari originali». Oltretutto molte delle famiglie latifondiste ottennero le terre proprio con la riforma agraria del 1953, a beneficiare della quale furono però più gruppi di potere che piccoli produttori, per poi espandersi illegalmente generazione dopo generazione, anche attraverso accordi illegali con imprese straniere. Il viceministro dell’agricoltura, Alejandro Alvarez, ha detto che la redistribuzione delle terre «non pone alcun problema giuridico», ma ha voluto precisare che neppure il governo scarta l’uso della forza nel caso ci sia resistenza ad abbandonare la terra confiscata. Ai contadini ora il compito di avviare produzioni ecologiche, senza fertilizzanti né agenti chimici. Bolivia. 3 giugno. I medici boliviani hanno scioperato giovedì in segno di protesta contro il recente arrivo di 700 loro colleghi cubani, che presteranno assistenza nelle zone depresse del paese. In favore della missione cubana si erano invece mobilitati centinaia di infermieri. Si è appreso intanto che il consorzio indiano Jindal Steel and Power si è aggiudicato la concessione del giacimento di ferro di El Mutún, uno dei più grandi del mondo, con una promessa di investimento iniziale di 2.300 milioni di dollari. Nei giorni scorsi Morales aveva sigillato «l’alleanza strategica» con La Habana e con Caracas accogliendo il presidente venezuelano Chávez e il vicepresidente cubano Lage. Tra gli accordi sottoscritti, la costruzione di impianti petrolchimici ad opera della compagnia boliviana Ypfb e di quella venezuelana Pdvsa, l’appoggio ai produttori rurali, l’assegnazione di borse di studio a giovani boliviani. Bolivia. 3 giugno. Il progetto di Costituzione del presidente della Bolivia, Evo Morales, per l’Assemblea Costituente che sarà eletta il 2 luglio, antepone i diritti collettivi di indigeni e contadini, nazionalizza la terra e le risorse naturali. Viene affermata la «volontà indeclinabile» di avere uno sbocco sul Pacifico, che la Bolivia ha perso nel XIX° secolo. Oltre al castigliano, saranno idiomi ufficiali l’aimara ed il quechua, e la bandiera indigena multicolore, la whipala, avrà lo stesso riconoscimento dell’attuale rossa, gialla e verde, secondo il documento “Rifondare la Bolivia”, editato dal Movimento al Socialismo, che, assicura l’agenzia Efe, sta finora circolando in via riservata. «Dal 1826 ad oggi, la Bolivia ha visto oltre una dozzina di assemblee costituenti. In tutte queste, gli indigeni, i contadini ed i settori maggioritari sono stati marginalizzati dalla vita repubblicana», dicono le prime righe della proposta. «La storia della Bolivia è la storia della resistenza indigena-popolare di fronte alla discriminazione e alla povertà», è scritto ancora nell’introduzione del documento, e segnala che i popoli indigeni «hanno diritto all’autodeterminazione e alla territorialità». Italia. 4 giugno. Subito dopo la visita di D’Alema a Washington sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero il governo emanare un decreto legge sulle missioni militari, un decreto unico su tutte le missioni: dal finanziamento del rientro dall’Iraq agli impegni di spesa per i contingenti impegnati dall’Afghanistan ai Balcani e all’Africa. Sarà imbarazzante perché la tecnica del decreto unico, che priva il parlamento di qualsiasi opportunità di discussione strategica sulle diverse missioni anche nella fase successiva di ratifica di un provvedimento già in vigore, è quella adottata dal centrodestra dal 2003 in poi e sistematicamente contestata dal centrosinistra finché è rimasto all’opposizione. Iraq. 5 giugno. Il certificato di morte delle 24 vittime civili di Haditha smentisce la versione ufficiale fornita dai marines. A rivelarlo è il Washington Post in una lunga riscostruzione di come è stata finora gestita la vicenda all’interno delle forze armate statunitensi. Alle cinque del pomeriggio del 19 novembre 2005 furono chiamati dei camion per portare via i corpi di 24 civili. «L’unità che arrivò nella cittadina di Haditha», scrive il quotidiano, «trovò bebè, donne e bambini, ai quali era stato sparato alla testa e al petto. Tutti erano stati uccisi da colpi d’arma da fuoco, secondo il certificato di morte che è stato redatto». Tuttavia il giorno dopo il capitano Jeffrey Pool, un portavoce dei marines in Iraq, affermava: «quindici iracheni sono stati uccisi ieri dall’esplosione di una bomba sul ciglio della strada ad Haditha». Malgrado quello che i marines videro una volta arrivati sul posto, nota il Post, la versione ufficiale è stata mantenuta per sei mesi. A gennaio arrivò il generale Peter Chiarelli, nuovo numero due militare USA nel Paese. Il suo atteggiamento, nota il giornale, è diverso da quello di altri ufficiali. Fu lui a scoprire che l’inchiesta sull’accaduto non era mai stata fatta. Il colonnello Gregory Watt fu incaricato d’indagare e il 9 marzo informò Chiarelli che il certificato di morte dei 24 iracheni uccisi riferiva che erano morti per colpi d’arma da fuoco, mentre la versione ufficiale parlava di una bomba e di uno scontro con insorti. I marines non hanno ancora corretto quel loro comunicato su Haditha del 20 novembre e al momento rimane ancora da chiarire come gestirono quella vicenda e se contribuirono a quello che appare un tentativo di nascondere quanto accaduto, conclude il giornale. Irlanda del Nord. 6 giugno. Paisley chiede ancora più tempo per formare l’esecutivo. Il dirigente del Partito Democratico dell’Ulster (DUP), Ian Paisley, ha chiesto ai governi britannico ed irlandese di far slittare di due settimane, dal 24 novembre all’8 dicembre, l’ultimatum per la formazione dell’Esecutivo. Questa proroga allungherebbe ulteriormente i tempi, comportando la modifica dell’attuale legislazione, che include la minaccia di dissoluzione dell’Assemblea l’amministrazione diretta, da parte di Londra e Dublino, di questa parte di isola irlandese. e Somalia. 6 giugno. Mogadiscio in mano alle corti islamiche. Le milizie dei Tribunali sconfiggono i “signori della guerra”, che abbandonano la capitale. Dopo diverse settimane di combattimenti e circa 350 morti, le milizie delle Corti islamiche hanno assunto ieri il controllo di tutti i punti strategici della città, decretando la sconfitta di quella strana “Alleanza per la restaurazione della pace e contro il terrorismo” che riuniva sotto le stesse insegne i principali “signori della guerra” del paese. Primi contatti tra i vincitori e il governo di transizione somalo guidato da Mohamed Ali Gedi. L’esponente principale delle corti, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, ha rassicurato la popolazione: «L’unione delle Corti islamiche non è interessata a continuare le ostilità e concorrerà pienamente alla restaurazione della pace e della sicurezza dopo la vittoria del popolo con il sostegno di Allah». Intervistato dalla France Presse, Ahmed ha detto: «Comincia una nuova era per Mogadiscio, senza i “signori della guerra”». La Somalia soffre la legge del più forte da quando, nel 1991, fu rovesciato il dittatore Mohamed Siad Barre. Questi tribunali islamici sono emersi a partire dal 2004. Somalia. 6 giugno. Ex insegnante, studioso di arabo e letteratura in Libia e in Sudan, Sheikh Sharif è a capo dell’Unione dei Tribunali islamici dal 2004. Nelle sue frequenti uscite alla radio o in televisione, non ha mai nascosto di voler instaurare uno stato islamico basato sulla shari’a. Lo stesso movimento che dirige è nato dall’esigenza di portare ordine all’interno della capitale somala, sostituendo la legge della giungla con quella coranica. Ha progressivamente conquistato l’appoggio di fette consistenti della popolazione, stanche dell’anarchia e dello strapotere dei “signori della guerra”. L’Unione riunisce ufficialmente 12 corti, ma i tribunali islamici starebbero proliferando, assumendo in alcuni casi una connotazione clanica. Hanno le loro milizie, con compiti di polizia. Secondo quanto denuncia Washington, darebbero riparo a combattenti stranieri e presunti membri di al Qaeda. Un punto, quest’ultimo, su cui permangono molti dubbi, ma che ha spinto gli Stati Uniti a finanziare massicciamente i “signori della guerra” dell’Alleanza. Somalia. 6 giugno. Il futuro del paese è avvolto nell’incertezza: i “signori della guerra” usciranno di scena? Le Corti troveranno un modus vivendi con il premier di transizione Mohammed Ali Gedi e, soprattutto, con il presidente Abdullahi Yusuf Ahmed, che nel 1992 sbaragliò in una battaglia epica nel Puntland i miliziani di Al Itihaad, antesignani delle Corti? Ma, soprattutto, gli Stati Uniti e l’Etiopia potranno sopportare nel Corno d’Africa uno Stato a forte impronta islamica? Dalla città di Baidoa (250 chilometri da Mogadiscio), dove il governo si riunisce per ragioni di sicurezza, Gedi ha licenziato i suoi quattro ministri-“signori della guerra” (tra cui Qanyare Afrah e Muse Sudi, già responsabili rispettivamente del dicastero della sicurezza interna e del commercio) e ha detto che vuole instaurare un dialogo con le Corti. Queste ultime gli hanno risposto di essere interessate e avrebbero avanzato la candidatura del loro membro anziano, Sheikh Hassan Dahir Aweys, per occupare uno dei dicasteri lasciati vuoti dai “signori della guerra” caduti in disgrazia. Il vento sta cambiando a Mogadiscio. Resta da vedere se gli USA sono disposti a ingoiare una nuova disfatta, sia pur indiretta, nello stesso paese da cui furono costretti a ritirarsi ignominiosamente nel 1993. Ucraina. 6 giugno. La Crimea si dichiara «NATO-free» dopo proteste per l’arrivo di marines USA. Il parlamento della Crimea, regione autonoma dell’Ucraina, ha dichiarato la penisola territorio «NATO-free», ossia libero dalla presenza e dall’influenza dell’Alleanza Atlantica. I deputati hanno votato all’unanimità –61 a 0– la risoluzione. Il Parlamento ha così chiesto, ieri, l’annullamento delle manovre militari (Sea Breeze 2006) previste prossimamente nella penisola, nel quadro della crescente collaborazione del governo ucraino con la NATO, e che si tengono da qualche anno nel mar Nero. Il suo presidente, Viktor Yushenko, ha accusato la Russia di aver fomentato questa decisione. Di fatto sulla presenza dei marines lo scontro è ora anche giuridico: la presenza è «illegale» perché non autorizzata dal Parlamento nazionale (Rada), benché prevista in un decreto firmato proprio da Yushenko, che tuttavia la Rada ha rigettato più volte. Un nuovo voto è stato rinviato al 14. Molti temono che Sea Breeze faccia da cavallo di Troia all’ingresso effettivo della NATO in Ucraina, da sempre caldeggiato da Yushenko. La penisola di Crimea, ceduta dall’URSS all’Ucraina negli anni Cinquanta, è un bastione dell’opposizione. Qui, a Sebastopoli, Mosca tiene ancora ormeggiata dopo il crollo dell’URSS la flotta del Mar Nero, il cui ritiro dal territorio ucraino (previsto per il 2017) è oggetto di interminabili negoziati con Kiev. Ucraina / Russia. 6 giugno. Yushenko è sempre più in difficoltà, dopo la spaccatura del fronte arancione e il risorgere del filorusso Yanukovich. A più di due mesi dalle elezioni non c’è ancora un governo. La costa ucraina si presenta inquieta anche più a est, sul mar d’Azov che segna il confine con la Russia, dove in questi giorni si è riacceso il contenzioso tra i due paesi per la proprietà del piccolo ma strategico stretto di Kerch. Sempre a est, nelle province a maggioranza russofona di Kharkov e Luhansk e in città come Dnipropetrovsk e Nikolaiev, le autorità locali hanno deciso di ripristinare l’uso del russo come lingua ufficiale, accanto all’ucraino. Uso cancellato –con poca lungimiranza visti i gravi problemi burocratici che ne sono scaturiti– proprio dalla rivoluzione arancione. Ora il Partito delle Regioni di Yanukovich cavalca la protesta di Feodosia (dove in un hotel sanatorio di stampo sovietico sono acquartierati 249 marines USA), chiedendo le dimissioni del ministro della Difesa, Gritsenko, mentre Mosca ventila ritorsioni economiche contro Kiev. Persino i socialisti di Moroz, alleati di Yushenko, minacciano di uscire dalla proposta coalizione di governo «arancione» che sbloccherebbe la crisi, se il presidente insisterà sull’opzione pro-NATO. Per via di questa delicata situazione, si continua a rimandare la visita di Putin nel paese. Stessa sorte per quella del presidente statunitense, George W, Bush, prevista questo stesso mese. Mosca, intanto, ha annunciato per il 30 giugno un forte aumento del prezzo del gas. Nelle negoziazioni, però, rileva il quotidiano Den, avrà di fronte «un paese senza governo». Palestina. 7 giugno. Il Documento di Riconciliazione Nazionale che il presidente Mahmud Abbas (Abu Mazen) intende sottoporre a referendum è stato elaborato da membri dei principali movimenti palestinesi incarcerati in Israele. Prevede un riconoscimento implicito di Israele. Questo documento, che Hamas nega di dare per buono al 100%, prevede la fine degli attentati in territorio israeliano e la creazione di uno Stato palestinese nei territori occupati nel 1967, il che, appunto, presuppone un riconoscimento implicito di Israele. Tra i principali punti del testo: diritto al ritorno dei rifugiati; Stato indipendente nei territori occupati nel 1967 con Gerusalemme capitale; modernizzazione e riattivazione dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), con adesione di Hamas e Jihad Islamica; diritto a resistere con tutti i mezzi, anche con le armi quindi, ma limitato ai territori occupati nel 1967; rafforzamento dell’Autorità Palestinese; governo di unità nazionale con la partecipazione di tutti i gruppi, particolarmente Al Fatah e Hamas; le negoziazioni (con Israele) sono competenza dell’OLP e del presidente dell’Autorità Palestinese, a condizione che ogni accordo cruciale sia approvato dal Consiglio Nazionale Palestinese (il Parlamento dell’OLP) o sottoposto a referendum. Tra gli estensori del documento: Marwan Barghouti (Al Fatah), Abdelkhaled Al-Natche (Hamas) e membri della Jihad, del FPLP (Fronte Popolare) e del FDLP (Fronte Democratico). Iraq. 7 giugno. Il Pentagono intende inviare a breve in Iraq 3.700 uomini di stanza in Germania, per rafforzare il contingente iracheno. Lo afferma la Cnn, citando fonti militari anonime. Le truppe dalla Germania devono avvicendare le unità che stanno terminando la loro missione, ma il generale Casey, comandante del contingente, aveva sperato di poterle tenere di riserva, se la situazione della sicurezza nel Paese lo avesse permesso. Gli USA hanno in Iraq circa 134mila militari. Brasile. 7 giugno. Irruzione in Parlamento. Oltre 500 membri del Movimento de Libertação dos Sem Terra (Mlst, una dissidenza del Movimento Sem Terra) hanno lanciato un’automobile contro il portone della Camera dei Deputati e hanno poi fatto irruzione all’interno, armati di pietre e bastoni. La protesta, originata dal rifiuto dei parlamentari di ricevere una delegazione del movimento, si è conclusa con 23 feriti, di cui uno grave, e centinaia di arrestati. Tra questi il leader del Mlst, Bruno Maranhao, esponente del Partido dos Trabalhadores del presidente Lula. Da tempo le organizzazioni contadine premono perché vengano superate le lungaggini nell’applicazione della riforma agraria e nella distribuzione delle terre. Euskal Herria. 8 giugno. La Polizia spagnola irrompe durante una conferenza stampa di Batasuna e ne ordina la sospensione. Convocata ieri ad Iruñea, mirava a rendere pubblica la proposta di soluzione politica della formazione patriottica basca illegalizzata sul conflitto nei Paesi Baschi. Il provvedimento è stato disposto dal giudice Fernando Grande-Marlaska. Sconcerto tra i giornalisti presenti in sala. Molti di loro hanno protestato e sostenuto di non aver mai assistito a niente di simile nel corso della loro carriera giornalistica. Fonti giuridiche dell’Audiencia Nacional hanno spiegato che il giudice ritiene illegali tutte le attività di Batasuna, incluse le conferenze stampa, anche se realizzate in locali chiusi. Il provvedimento mostra che non si è interrotta l’offensiva contro Batasuna guidata da Grande-Marlaska, nonostante la scorsa settimana non abbia imposto misure cautelari significative contro gli otto dirigenti di Batasuna. Somalia. 8 giugno. George Bush annuncia di voler preparare una risposta statunitense per evitare che la Somalia diventi un rifugio per Al Qaeda. Gli ha risposto il capo delle corti islamiche di Mogadiscio, Sheihk Sharif Sheikh Ahmed: le sue milizie, ha detto in un’intervista, potrebbero «dare una lezione agli americani». Intanto, alti funzionari legati all’amministrazione Bush, lo riporta la stampa USA, hanno confermato oggi, sotto anonimato, che Washington sosteneva i “signori della guerra”. Una posizione mai esplicitata ufficialmente, quantunque fosse evidente a tutti gli osservatori ed analisti dell’area. USA / Iraq. 8 giugno. Stati Uniti sotto choc: turbe psichiche per un soldato su dieci. È il senso del reportage che USA Today ha dedicato ieri ai soldati che tornano dall’Iraq con turbe mentali. Sono uno su dieci, raccontano al giornale i medici che li esaminano al ritorno, ricordando che in base alla «turnazione» sono almeno 500mila i soldati che hanno «servito» laggiù. C’è quindi un potenziale di 50mila giovani «trasformati in spostati», ma siccome al rientro non presentano ferite «visibili» il loro problema è di fatto ignorato. Afghanistan. 8 giugno. La NATO punta ad aumentare la sua presenza militare in Afghanistan per far fronte all’aumento degli attacchi della guerriglia soprattutto nel sud del paese. È quanto emerge dalla due-giorni dei ministri della difesa della NATO a Bruxelles, argomento principale appunto l’Afghanistan. Secondo quanto preannunciato nei giorni scorsi, la NATO è pronta a portare le truppe sul campo dagli attuali 9mila soldati a un numero che si aggira tra i 15mila e i 17mila entro il prossimo luglio, e potrebbe ulteriormente accrescere la sua presenza entro la fine dell’anno. «Non ci illudiamo che il nostro compito sia facile», ha detto il segretario generale della NATO, Jaap de Hoop Scheffer, in una conferenza stampa al termine del consiglio ministeriale. A conferma, il ministro della difesa afgano, Abdul Rahim Wardak, per la prima volta presente ad un vertice della NATO, ha previsto un incremento ulteriore dell’attività guerrigliera, sulla base di informazioni a sua disposizione, nel sud del paese, durante la prossima estate, quando avverrà la parziale sostituzione delle truppe presenti attualmente nella missione “Enduring freedom” con quelle fresche della NATO. Perù. 8 giugno. Nelle sue prime dichiarazioni alla stampa straniera, Alan García si mostra conciliante verso Caracas, dopo gli attacchi a Chávez che avevano mosso in campagna elettorale. García ha escluso in maniera decisa di volersi porre alla testa di un fronte regionale antichavista, come qualcuno aveva pronosticato, e ha anzi auspicato il mantenimento di buoni rapporti con il Venezuela. Del resto né García né Chávez hanno interesse a una rottura delle relazioni diplomatiche. Come scrive l’analista politico Isaac Bigio, «la guerra verbale condotta dai due è servita all’aprista (il partito di García, ndr) per assicurarsi il voto della destra e al bolivariano per far sì che Humala lo seguisse e si spostasse a sinistra. Oggi entrambi hanno raggiunto il loro scopo. García è arrivato al governo, Chávez è riuscito a creare per la prima volta un movimento di massa affine in Perù (dove in precedenza non esisteva nulla)». Intanto, alle “aperture” di García, lo sconfitto Ollanta Humala ha risposto scartando qualsiasi ipotesi di accordo e promettendo di portare in piazza l’opposizione al governo. «La lotta continua», ha affermato l’ex militare. Perù. 8 giugno. La vittoria di García e l’ondata chavista. Domenica Alan García ha vinto in 10 dei 25 dipartimenti e a Lima (un terzo dell’elettorato) ha avuto il 66%. Humala, invece, ha vinto negli altri 15 e nei 6 della sierra del sud, con più del 60%. Il paese è spaccato geograficamente ed elettoralmente in due. Sul piano politico, il voto degli indigeni e dei poveri (il 52% della popolazione), per Humala, appare più coeso e convinto mentre per Garcia ha votato in termini significativi, turandosi il naso, anche la destra spaventata dal discorso chavista e anti-liberista di Humala. Analisti osservano che il nuovo governo nasce stretto in una tenaglia (da destra e da sinistra) e che il vero sconfitto di domenica è prima di tutto la destra peruviana. Stando ai numeri Humala non ha vinto, ma per dire che abbia effettivamente vinto Alan e che l’ondata chavista si sia fermata, in Perù, è ancora presto. Perù. 8 giugno. Alan García è tornato al potere dopo la sua prima esperienza nel periodo 1985-90, conclusasi tra accuse di corruzione e violazioni dei diritti umani, con il paese in preda a un’inflazione galoppante (i prezzi erano aumentati fino a 33mila volte) e una violenza politica in continua crescita. Nonostante questo saggio di malgoverno, il leader dell’Apra ha ottenuto la vittoria grazie al voto del ceto medio-alto, che ha fatto convergere i suoi consensi su di lui per far fronte alla «minaccia Humala», l’ex militare nazionalista considerato vicino a Chávez e a Morales. Ad assicurare il trionfo di García sono stati gli elettori di Lima (un terzo del totale), che al primo turno si erano espressi a favore della candidata della destra Lourdes Flores, e quelli della costa settentrionale. Per Ollanta Humala si sono pronunciati invece in modo massiccio i dipartimenti del sud del paese, le zone più povere e più indie dove il suo discorso radicale e messianico ha trovato terreno fertile: Ayacucho, Arequipa, Puno, Cuzco, Apurímac e Huancavelica. Se Garcia ha vinto con 6 milioni e 100 mila voti, Humala, in soli 5 mesi, ne ha raccolti ben oltre 5 milioni. Per questo, anche se l’onda radicale dell’America latina non è riuscita a proiettarlo al palazzo di Pizarro a Lima, gli ha dato un peso politico molto consistente. Perù. 8 giugno. La composizione del Congresso emerso dal voto del 9 aprile vede la maggioranza relativa dei seggi (45 su 120) assegnata al partito di Humala (Unione per il Perù), mentre il Partito Aprista Peruviano del suo antagonista Alan García figura al secondo posto con 36 parlamentari. Seguono Unidad Nacional, la coalizione della neo-liberista dura Lourdes Flores, con 17 seggi, la fujimorista Alleanza per il Futuro dell’ex presidente fuggiasco Fujimori con 13, il Fronte del Centro (5), Perù Possibile del presidente uscente Toledo (2), il religioso evangelico Restaurazione Nazionale (2). A condizionare ancora di più l’operato del nuovo capo dello Stato sarà l’appoggio che l’ex presidente Fujimori gli ha assicurato dal Cile, dove si trova in attesa di estradizione. Nel corso della campagna elettorale Humala aveva denunciato il «patto di impunità» tra García e Fujimori, un patto confermato anche dalla presenza, tra le fila dell’attuale vincitore, di numerosi ex collaboratori dell’uomo forte del passato regime, tra cui Vladimiro Montesinos. Quanto al futuro vicepresidente, l’ammiraglio a riposo Luis Giampietri, non si è distinto solo nel periodo Fujimori: nel 1986, durante la prima presidenza di Alan García, diresse l’assalto militare al penitenziario di El Frontón, durante il quale furono massacrati centinaia di prigionieri politici. Perù. 8 giugno. Alcune valutazioni sul voto peruviano. Il quotidiano messicano La Jornada pubblica un’analisi del sociologo Carlos Reyna, per il quale «il voto di Humala è più solido del voto di García perché il suffragio per il vincitore è venuto per paura, mentre il voto al nazionalista è stato dato nonostante la campagna di paura orchestrata contro Humala; in altri termini, questo consenso è espressione di una scelta più sentita». Altri analisti peruviani rilevano la sconfitta dei partiti che apertamente hanno difeso le tesi della destra, cioè i partiti legati all’ex presidente Alberto Fujimori e a Lourdes Flores. Quest’ultima, sconfitta al primo turno delle presidenziali, informa alaiamlatina, si è premurata di ricordare a García che ha vinto «con i voti prestati e con quelli della paura». In un’intervista al sito di Rebelión, il sociologo statunitense James Petras ricorda la grande avanzata di Humala, che ha dovuto far fronte «a tutti i partiti della destra e del centro destra, a tutti i mezzi di comunicazione di massa, a tutte le multinazionali e all’ambasciata degli Stati Uniti». Ed ha aggiunto: «i risultati elettorali vanno sempre dietro le lotte sociali». Il che, aggiunge, non impedirà che queste lotte si impongano anche sul terreno elettorale in una prospettiva a medio termine. Italia. 9 giugno. «Il ritiro del contingente italiano non avrà un impatto significativo sullo sforzo della coalizione». Con poche, sprezzanti parole Rumsfeld liquida l’addio all’Iraq annunciato dal nuovo governo Prodi. All’ok infastidito del capo del Pentagono, Donald Rumsfeld, nella sala stampa della NATO fa seguito una grande risata. Il ritiro sarà indolore, dice Rumsfeld. Una battuta che sottintende che l’impegno dello Stato italiano nel Golfo non è poi così essenziale come continua a ripetere il vecchio governo. Subito dopo il dileggio, Rumsfeld si spende in parole di comprensione con Roma: «ogni paese può fare ciò che crede appropriato quando lo crede appropriato». Il ministro alla Difesa, Arturo Parisi, alla sua prima ad una riunione della NATO, smorza i toni e si avventura, imbarazzato, in piroette diplomatiche. «È evidente che sul tema Iraq siamo portatori di due punti di vista diversi, veniamo da due storie diverse. Arriviamo a questo confronto partendo da storie diverse, non c’è nessun segreto da svelare ma c’è un confronto che tiene conto del fatto che nel tempo siamo sempre stati alleati e amici. Ho avuto già occasione di dire che anche nelle migliori famiglie si registrano delle divergenze, quello che conta è che si svolgano in un quadro che non ignori l’Alleanza (Atlantica, ndr) che ci lega come Italia e come Europa». Iraq. 9 giugno. Sì del parlamento ai ministri degli interni e della difesa. Il parlamento iracheno ha approvato ieri i candidati del premier Maliki per i ministeri degli interni e della difesa. Agli interni va Jawad al-Bolani, uno sciita che controlla Bassora; alla difesa il generale Abdel Qader Jassim, un sunnita finora a capo dell’esercito, che ha guidato i reparti iracheni che insieme agli statunitensi attaccarono Falluja. Iraq. 9 giugno. «Una vittoria di Pirro. Anzi avrà un effetto negativo, perché un mito non si uccide con la forza ma con l’intelligenza». A sostenerlo è Loretta Napoleoni, consulente della Homeland Security, l’antiterrorismo USA, autrice di un libro su Abu Musab al-Zarqawi (Al Zarqawi. Storia e mito di un proletario giordano, edito da Marco Tropea). Iraq. 9 giugno. Di Zarqawi si è scritto e detto di tutto. Ben poco c’è da aggiungere, molto invece da chiarire, scrive Michele Giorgio su il Manifesto di oggi. Innanzitutto Ahmed Fadeel Al Khaleyleh, il suo vero nome, non era un palestinese come da tempo il suo clan familiare in Giordania ha chiarito. Inoltre non è chiaro se sia stato luogotenente di Osama bin Laden. Senza dubbio Zarqawi fu uno delle migliaia di combattenti arabi che parteciparono, accanto ai mujaheddin afghani, alla lotta contro i sovietici in Afghanistan. Tuttavia non è stato mai accertato che sia stato un collaboratore di bin Laden. «Zarqawi», spiega l’analista egiziano Diaa Rashwan, uno dei massimi esperti arabi di islamismo radicale, «in realtà è andato in Iraq per combattere il suo Jihad, per diventare un comandante importante, e solo nel 2004 ha chiesto di entrare in al Qaeda. Bin Laden ha accettato ma la posizione di Zarqawi è rimasta più quella di un alleato che di un dirigente effettivo di al Qaeda». Il giordano infatti ha presentato la propria ‘bayat’, l’atto di sottomissione, a bin Laden solo nell’ottobre 2004 e il suo gruppo si è trasferito definitivamente in Iraq solo nell’estate 2003. Non sono peraltro secondarie le differenze «ideologiche» che esistevano tra i due. Zarqawi è descritto come un takfiri, ovvero un estremista islamico che tende a considerare gli altri musulmani come apostati poiché non vivrebbero nel rispetto assoluto dei principi coranici e dell’Islam. «Se davvero era takfiri, Zarqawi lo manifestava a modo suo», precisa Rashwan, «i takfiri (da Takfir wa hejra, una piccola organizzazione nata in Egitto ma presente anche in Giordania, in particolare nella città meridionale di Maan, ndr) si isolano dal resto della società islamica che condannano in blocco. Zarqawi no, lui era selettivo, colpiva solo alcuni musulmani e non altri. Ha passato più tempo a colpire gli sciiti che le forze anglo-americane. La sua era una ossessione, nei suoi comunicati parlava soprattutto del pericolo sciita. Bin Laden invece è più interessato al jihad contro gli Stati Uniti e, fatto non secondario, non ha mai preso di mira gli sciiti». Zarqawi riuscì a incontrare per la prima volta bin Laden dopo il 1999 a Kandahar. Secondo testimoni al capo di al Qaeda non piaceva l’irruenza del giordano e la sua insistenza sul fatto che «tutti gli sciiti vanno giustiziati». Iraq. 9 giugno. La sparizione di Zarqawi «potrebbe supporre un fatto decisivo in favore dei gruppi di resistenza iracheni». Lo dichiara Diaa Rashwan, uno dei massimi esperti arabi di islamismo radicale, all’emittente Al Jazeera. Al Qaeda, peraltro, nella terra dei due fiumi di recente aveva perduto forza rispetto ad altre formazioni armate. «Quando parliamo della lotta armata in Iraq», precisa l’analista, «dobbiamo tenere presente che non si deve confondere il terrorismo con la resistenza all’occupazione. Zarqawi e i terroristi, che colpiscono civili, sequestrano e uccidono ostaggi, sono responsabili di un 20% delle azioni armate in Iraq. L’80% è rappresentato da organizzazioni che prendono di mira solo i militari delle forze di occupazione nel loro paese». Italia / Afghanistan. 10 giugno. Prodi conferma a De Hoop Scheffer il «pieno impegno» dell’Italia alla missione in Afghanistan. Jaap de Hoop Scheffer, segretario generale della NATO, è arrivato ieri a Roma per avere rassicurazioni per il piano già approvato in sede NATO, cui l’Italia è obbligata a dare il proprio contributo: l’allargamento della missione ISAF nel sud del paese, nelle zone già di competenza della missione statunitense Enduring Freedom. «L’Afghanistan resta la nostra priorità operativa numero uno», ha ribadito nei suoi incontri con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il presidente del consiglio Romano Prodi e il vice-premier e ministro degli esteri Massimo D’Alema. Lo Stato italiano ha comunque assicurato che sarà della partita. Prodi, secondo il portavoce del segretario NATO, «ha sottolineato con forza il pieno impegno dell’Italia in Afghanistan». In questo contesto, recita il comunicato dell’Alleanza Atlantica, «l’ISAF si espanderà a sud (dell’Afghansitan, ndr) più avanti, nel corso dell’estate, portando altre Prt (Provincial reconstruction team, i settori in cui dagli occupanti USA è stato suddiviso il paese, ndr) sotto guida NATO e incrementando significativamente i livelli generali dell’ISAF. Le forze ISAF saranno robuste, ben equipaggiate e opereranno con le necessarie regole d’ingaggio per rispondere con forza a qualsiasi minaccia e sfida alla sicurezza che possa emergere». Durante l’incontro, si è discusso inoltre di Darfur, Iraq e allargamento della NATO. Turchia / Kurdistan. 10 giugno. Sindaco kurdo condannato a quindici mesi di carcere per un’intervista. Aydin Budak, sindaco di Cizre, cittadina kurda al confine con l’Iraq, è stato ieri condannato a 15 mesi di reclusione dalle autorità turche per «propaganda terrorista». Budak avrebbe espresso solidarietà al Partito dei Lavoratori Kurdi (PKK) in un’intervista alla Roj Tv, emittente televisiva curdo-danese dalle autorità turche definita «canale di al-Qaeda». È l’ultimo episodio di una campagna in corso in Turchia ai danni del DTP, Partito della Società Democratica, da sempre solidale verso le minoranze etniche in Turchia e del quale Aydin Budak è esponente di spicco. Assoluzione invece, l’altroieri, per la sociologa turca, Pinar Sedek, che ha passato due anni e mezzo in carcere. Si era rifutata di rivelare, nonostante le torture, i nomi di guerriglieri del PKK presenti nelle sue inchieste sociologiche. La procura aveva chiesto l’ergastolo. Vista la sua «non collaborazione» era stata accusata di aver partecipato all’organizzazione di un’esplosione avvenuta nel 1998 nel Bazar Egizio di Istanbul, esplosione che Ankara attribuì al PKK e dovuta, invece, ad una fuga di gas. Palestina. 11 giugno. Hamas ha condannato la decisione del presidente Abu Mazen di convocare un referendum a Gerusalemme, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, il 26 luglio prossimo, sul “documento dei detenuti”. «È un colpo di stato contro le scelte del popolo palestinese e la legittimità conferita dagli elettori al governo», ha affermato il leader di Hamas Mushir al-Masri, precisando che il movimento utilizzerà tutti i mezzi giuridici per impedire la consulta. In ultima istanza chiederà alla popolazione di boicottare la consultazione. «Chi ha convocato il referendum dovrà assumerne le gravi conseguenze», ha avvertito, tra queste il fatto che «lo scrutinio marcherà una divisione storica del popolo palestinese». Il primo ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese, Ismail Haniye, in una dichiarazione al quotidiano tedesco Der Spiegel, ricorda che tra le attribuzioni del presidente non c’è quella di convocare questo tipo di consultazioni. Altre organizzazioni della resistenza, come Jihad Islamica, hanno respinto la convocazione del referendum. I gruppi della sinistra, FPLP e FDLP, insistono nel chiedere ad Abbas che non compia questo passo e che permetta il prosieguo di negoziazioni non vincolate. L’iniziativa di Abbas mira da obbligare Hamas a far sua la proposta negoziale, con i suoi grossi limiti inclusi, che la direzione palestinese porta avanti da 15 anni a questa parte. Mira a legare mani e piedi ad Hamas prima dell’inizio di qualunque negoziazione seria. Palestina. 11 giugno. Abu Mazen, se riuscirà a vincere il referendum, si rafforzerà nettamente sul piano interno. Più di tutto pensa di ritrovarsi in posizione più forte per esigere da Israele una ripresa dei negoziati e il blocco del piano unilaterale che il primo ministro israeliano Ehud Olmert intende attuare in Cisgiordania. Questa però è solo un’ipotesi, se non addirittura un sogno. Le previsioni indicano ben altro. Abu Mazen rischia di andare ad una spaccatura violenta del fronte interno palestinese senza per questo ottenere il risultato che vuole: riportare Israele al tavolo delle trattative. Olmert infatti ha definito «senza significato» e «un gioco interno» l’iniziativa del presidente palestinese in un’intervista pubblicata ieri dal Financial Times, in anticipo sul tour che effettuerà in Europa. «Il referendum è un gioco interno tra una fazione e un’altra. È senza significato (...) per quanto riguarda le possibilità di dialogo fra noi e i palestinesi». Secondo Olmert in futuro non ci saranno negoziati «perché i palestinesi non sono pronti ad assumere le loro responsabilità dato che il governo estremista, fondamentalista e religiosamente radicale di Hamas non è disposto e perché Abu Mazen è troppo debole», ha detto il primo ministro dello Stato teocratico d’Israele. Olmert, nell’intervista, ribadisce che il suo piano di ritiro unilaterale da una parte della Cisgiordania include il mantenimento e rafforzamento delle colonie sioniste più importanti e la giudeizzazione di Gerusalemme. La sua intenzione, riaffermata nell’intervista, di incontrarsi a fine mese con Abbas, ha il fine speculativo dichiarato di scatenare la guerra civile inter-palestinese. Dice infatti: «Voglio discutere e ricercare con lui la forma per aiutarlo a far fronte alla sfida di Hamas e dei terroristi nel seno della comunità palestinese». Nepal. 11 giugno. Il parlamento nepalese ha tolto il diritto di veto delle leggi al re Gyanendra, la cui funzione diventa esclusivamente protocollare. Lo si è appreso oggi da fonte ufficiale. La misura decisa dal nuovo governo ad interim insediato a fine aprile è stata adottata ieri sera e la notifica del parlamento è stata resa pubblica oggi. Il potere esecutivo appartiene ora al Consiglio dei ministri e quello legislativo al Parlamento, ha spiegato il presidente del parlamento Subash Nemwang. USA / Somalia. 11 giugno. Washington non ci sta ad accettare il fallimento dei suoi piani nel corno d’Africa e propone la messa in moto di un “Gruppo di Contatto sulla Somalia”. Già individuati Gran Bretagna, Norvegia ed Italia per difendere i suoi interessi geostrategici nell’area. Washington ha sostenuto i “signori della guerra”, che si disputano da diversi anni il potere nel paese, con l’obiettivo di frenare l’espansione dei tribunali islamici. Dopo quattro settimane di combattimenti questi “signori della guerra” sono stati cacciati dalla capitale, Mogadiscio, e le violenze all’ordine del giorno in città sono come d’incanto sparite. Il presidente dei tribunali islamici, jeque Sharif Sheikh Ahmed, ha tenuto a chiarire che la Sharia (legge islamica) non sarà imposta se non dopo decisione del popolo somalo. Ha quindi ribadito che i tribunali non proteggono gli attivisti di Al Qaeda, come sta propagandando l’amministrazione statunitense. Israele. 12 giugno. L’esercito israeliano «è il più etico del mondo». A poche ore dall’ennesima mattanza di palestinesi (un’intera famiglia massacrata sulla spiaggia di Beit Lahia ed altri tre palestinesi uccisi in altrettanti raid aerei) il primo ministro israeliano, Ehud Olmert, senza sprezzo del ridicolo, ha inteso così difendere Tsahal, l’esercito d’Israele, dalle ondate di critiche che si sono levate anche all’interno di Israele. La Presidenza dell’Autorità Palestinese ha denunciato «la persistenza di questi assassinii». Il ministro dell’Interno e dirigente di Hamas, Said Siam, ha inscritto questi attacchi «nella guerra continua dei sionisti contro il popolo palestinese». Il braccio armato di Hamas ha continuato, in risposta ai continui attacchi, a lanciare decine di razzi artigianali contro città israeliane ed ha avvertito che la sua risposta potrebbe non fermarsi qui. USA. 12 giugno. Il relatore dell’ONU contro la Tortura, Manfred Nowak, ha qualificato come «cinismo assoluto» gli argomenti che utilizza l’amministrazione Bush per mantenere centinaia di persone incarcerate a Guantanamo senza processo e senza nemmeno sapere se e quando recupereranno la libertà. Argentina. 12 giugno. Soldati, non poliziotti. Il presidente Kirchner ha regolamentato la Legge di Difesa Nazionale che respinge la teoria delle cosiddette “nuove minacce” (terrorismo, narcotraffico, delinquenza organizzata). I problemi della sicurezza interna, ha spiegato la ministra della Difesa Nilda Garré, resteranno fuori dalla competenza delle forze armate, che dovranno limitarsi alla difesa dei confini nazionali o a missioni internazionali nell’ambito dell’ONU. La legge era stata approvata nel 1988, ma mancando la regolamentazione non era diventata esecutiva. Euskal Herria. 13 giugno. «Presentarci come popolo». Batasuna invita le forze abertzale (patriottiche) basche a convergere su un’unica candidatura e lista in vista delle elezioni presidenziali e legislative che si celebreranno il prossimo anno, in primavera, nello Stato francese. Ieri Xabi Larralde, accompagnato da altri tre membri della Mesa Nacional, ha avuto incontri nei territori baschi sotto occupazione francese. Ucraina. 13 giugno. Crisi nella coalizione arancione. Il partito del presidente dell’Ucraina, Viktor Yushenko, ha dato ieri per rotte le negoziazioni con i suoi alleati della «rivoluzione arancione». Quasi tre mesi dopo le elezioni generali (26 marzo), Nostra Ucraina, di Yushenko, ha constatato che le negoziazioni, aperte il 13 aprile, «non hanno alcun futuro». A fungere da detonatore di questa situazione è il mancato accordo su chi debba ricoprire le varie cariche, dalla guida del governo alla Presidenza del Parlamento (Rada). Ad accapigliarsi in merito sono il Partito Socialista (socialdemocratico, 33 seggi), Nostra Ucraina (86 seggi) ed il partito di Julia Timoshenko (129 seggi). Portavoci di Nostra Ucraina hanno evocato la possibilità che si ricerchi un accordo, per la formazione del governo, con il Partito delle Regioni di Viktor Yanukovich, la formazione più votata alle elezioni e che ha 186 seggi. Questa formazione, erede del rovesciato regime dell’ex presidente Leonid Kuchma, ha dato la sua disponibilità per un accordo. Un accordo che, in ogni caso, rappresenterebbe una ferita mortale per la già moribonda «rivoluzione arancione», che ha portato le élite più pro-occidentali al potere a Kiev. A rischio, ora, sono l’ingresso nel WTO (l’Organizzazione Mondiale del Commercio) e i negoziati con la NATO. Euskal Herria. 14 giugno. Lakua considera una vergogna giuridica ed un atto altamente irresponsabile la querela del TSJPV. Il Tribunale Superiore di Giustizia del Paese Basco (TSJPV) ha accolto la querela presentata dal Foro Ermua (associazione di “resistenza costituzionalista” spagnola contro il nazionalismo basco) nei confronti del governatore basco Juan José Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena e Juan Joxe Petrikorena, per l’incontro avuto il 19 aprile scorso nel palazzo governativo. Ibarretxe avrebbe cioè avuto un incontro ufficiale con persone poste fuori legge. L’Esecutivo autonomico, che ha sede a Lakua, ha replicato, così, ad una parte della querela, quella che riguarda il lehendakari (governatore, ndr), perché dei tre dirigenti di Batasuna non dice nulla. Di fatto non fa menzione di questa formazione, il cui nome è sostituito da quello generico di sinistra abertzale (patriottica, ndr) nella dichiarazione letta dal portavoce di Ibarretxe, Miren Azkarate. Batasuna è una formazione illegalizzata dalla “democrazia” spagnola. Sul piano politico, Lakua osserva la «responsabilità ultima» di chi ha dato impulso ad «una Legge dei Partiti [predisposta espressamente per mettere fuori dalla legalità Batasuna, che ha peraltro larghi consensi elettorali, ndr] che costituisce una aberrazione politica e democratica». Francia / Afghanistan. 14 giugno. Parigi sempre più accodata a Washington. Il 26 maggio è iniziata la seconda fase delle operazioni aeree in Afghanistan del contingente francese. Lo riferisce l’agenzia Afis News. Con il nome in codice Operation Serpentaire (Mangiatore di Serpenti), i piloti francesi stanno effettuando missioni di “close air support” e ricognizione tattica in supporto alla operazione Enduring Freedom (Oef) e alla International Security Assistance Force (ISAF). Questa fase di operazioni in supporto alle forze della coalizione, terminerà a ottobre. Un contingente di militari francesi a Bagram coordina da terra le forze aeree francesi. Somalia. 14 giugno. Africa dell’Est sanziona i “signori della guerra” somali. Sei paesi dell’area (Kenia, Uganda, Sudan, Djibouti, Etiopia, Eritrea) hanno fatte proprie le sanzioni annunciate dal Kenia contro i “signori della guerra” somali (congelamento dei conti ed interdizione del territorio) ed esigono che siano giudicati per crimini contro l’umanità. Il governo di Nairobi, promotore dell’iniziativa, ha criticato velatamente gli Stati Uniti per aver dato il loro appoggio a questi gruppi, sconfitti dalle milizie islamiste. Il ministro keniano degli Esteri, Raphael Tuju, ha detto, in un incontro tra i rappresentanti dei paesi su citati, che il paese che ha aiutato i “signori della guerra” ha contribuito ad aggravare il conflitto a Mogadiscio e sta sabotando «gli sforzi della comunità per aiutare il popolo della Somalia a ricostruire il proprio paese». Tuju ha ricordato, quindi, che i “signori della guerra” «hanno terrorizzato» Mogadiscio negli ultimi 15 anni. Somalia. 14 giugno. Le truppe delle scuole coraniche hanno preso stamane anche Jowhar, 90 km a nord di Mogadiscio, già sede del governo provvisorio. Lo si apprende, a Nairobi, da fonti considerate attendibili. Quasi non c’è stata battaglia, tranne sparatorie marginali. In realtà i signori della guerra che vi si erano asserragliati dopo essere stati sconfitti a Mogadiscio, l’avevano abbandonata ieri sera puntando con i loro miliziani verso nord, mentre uno o due erano rientrati nella capitale esprimendo la disponibilità a collaborare con i tribunali coranici. A quanto si apprende da fonti vicine al premier del governo federale Alie Gedi –attualmente a Nairobi– la presa di Jowhar era stata annunciata all’esecutivo, con modalità di fatto concordate. Si trattava di dare un’ulteriore spallata ai “signori della guerra”, e su questo tutti erano d’accordo. Gli accordi prevedono che le corti islamiche abbiano sì il controllo militare, ma non vi prendano il potere (niente sharia, ad esempio), che sarà invece gestito d’intesa tra i clan locali, allo stato riuniti pacificamente a Jowhar. La città riveste una posizione strategica significativa in caso si volessero muovere attacchi militari verso il nord della Somalia. Palestina / Israele. 14 giugno. Hamas denuncia l’indifferenza mondiale di fronte alla continua mattanza di Israele contro i palestinesi. Il suo portavoce Sami Abu Zuhri ha aggiunto che «Hamas e tutti i gruppi della resistenza armata non hanno altra opzione che difendere il nostro popolo, ed il mondo deve assumersi la responsabilità per l’esplosiva situazione nella quale si trascina tutta la regione». Palestina / Israele. 14 giugno. Quel che dice l’ONU è «indifendibile». Il primo ministro israeliano, Olmert, ha dichiarato ieri alla Camera dei Comuni britannica che il suo governo non accetterà «mai» di ritirarsi da tutti i territori palestinesi (Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est) come prevedono varie risoluzioni dell’ONU. Questo perché le frontiere che esistevano prima della loro occupazione da parte di Israele nel 1967 oggi sono «indifendibili». Iran. 14 giugno. I Non Allineati rivendicano il diritto dell’Iran all’energia nucleare. Il Movimento dei Paesi Non Allineati ha presentato alla giunta dei Governatori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica una dichiarazione nella quale rivendica che tutti i paesi del mondo, incluso l’Iran, devono avere, senza discriminazioni, diritto di acceso all’energia nucleare per fini pacifici. Si tratta del principale disaccordo della giunta che si celebra questa settimana. Russia e Cina hanno ribadito di essere contrari a sanzioni. USA / Iraq. 14 giugno. Bush preme sulle dirigenze dei Paesi europei, asiatici e mediorientali perché diano maggiore aiuto alle operazioni in Iraq. Il presidente statunitense George W. Bush ha detto oggi, in conferenza stampa alla Casa Bianca, che dei 13 miliardi di dollari promessi per la ricostruzione dell’Iraq durante una conferenza di donatori a Madrid, solo tre sono stati effettivamente versati. Euskal Herria. 15 giugno. ETA invita lo Stato francese alla negoziazione e al dialogo politico. In un comunicato a vari mezzi di comunicazione, Euskadi Ta Askatasuna (Patria basca e Libertà) invita le autorità francesi a mostrare la loro volontà di dare soluzione al conflitto politico mediante dialogo e negoziazione. ETA si rivolge anche all’opinione pubblica francese perché «non collabori con il processo di colonizzazione territoriale contro Euskal Herria». Parigi «abbandoni la via della repressione contro i cittadini baschi ed Euskal Herria nel suo insieme» e «si coinvolga nelle discussioni e negoziazioni per risolvere il conflitto». Parte dei territori baschi, tra l’altro, sono sotto occupazione francese. ETA rileva che «l’oppressione della Francia verso Euskal Herria e la lotta della cittadinanza basca per i suoi diritti» è una realtà «sconosciuta» per gran parte della cittadinanza francese. «Quello che più si conosce sono le azioni di ETA», così come, prosegue il comunicato, le situazioni derivate da questa attività armata. «Ma censura e silenzio non faranno sparire l’esistenza del conflitto», dichiara l’organizzazione politico/militare basca, prima di assicurare che questo continuerà finché lo Stato francese non riconoscerà Euskal Herria. Non viene comunque meno il cessate-il-fuoco iniziato lo scorso 24 marzo «nella convinzione che la risposta che riceviamo sarà in consonanza con il passo intrapreso. Per superare un conflitto di molti anni, è necessario edificare una pace basata sui diritti di Euskal Herria e sulla giustiza. Questa è la volontà di ETA». Euskal Herria / Francia. 15 giugno. «La ricerca di una soluzione politica nel Paese Basco spagnolo dipende dalla sovranità spagnola». Lo Stato francese risponde così, a stretto giro di posta, tramite il suo ministro degli Esteri, all’ETA. Parigi circoscrive il suo sostegno a Madrid solo nell’ambito della lotta contro ETA e lascia intendere che non sente Euskal Herria come un affare interno. Fonti del Quai d´Orsay fanno sapere che lo Stato francese «appoggia senza riserve il governo spagnolo nella sua volontà di chiudere con tutte le forme di violenza nel Paese Basco». Il primo ministro francese, Dominique De Villepin, in visita a Madrid lo scorso 13 marzo, in conferenza stampa insieme al presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, aveva sostenuto che «non è affare della Francia intervenire in una questione che corrisponde alla sovranità spagnola». Euskal Herria / Spagna. 15 giugno. Zapatero ribadisce che quest’estate inizierà contatti con l’ETA, dopo che avrà comunicato questo mese al Congresso l’inizio del dialogo. Il presidente del governo spagnolo, José Luis Rodríguez Zapatero, lo ha detto nel corso di un’intervista rilasciata stasera all’emittente SER. Ha detto di aver già in testa quando comparire al Congresso per dar conto di questo dialogo, ma non ha fornito precisazioni. Ha quindi riconfermato i suoi sforzi per ottenere il sostegno del Partito Popolare nel processo di “normalizzazione politica”. Serbia. 15 giugno. Il governo della Serbia ha riconosciuto formalmente l’indipendenza del Montenegro, separatosi da Belgrado con il referendum del 21 maggio scorso. Il risultato del referendum era stato di fatto già accolto nei giorni scorsi, con la proclamazione da parte del parlamento di Belgrado di uno “Stato indipendente serbo” subito dopo la dichiarazione ufficiale di sovranità del Montenegro fatta dal parlamento di Podgorica. Successivamente l’indipendenza montenegrina era stata riconosciuta da Russia, Unione Europea e USA. L’esecutivo di Belgrado assicura ora di voler dar vita a «relazione amichevoli e di buon vicinato» con Podgorica, nonostante la contrarietà alla secessione espressa durante la campagna referendaria dal primo ministro serbo Vojislav Kostunica e le perplessità dichiarate –insieme all’opposizione montenegrina unionista– sullo svolgimento dello scrutinio di maggio. Belgrado ha preso anche l’impegno di non dar corso a conseguenze –ventilate nei mesi scorsi– nei confronti della diaspora montenegrina residente stabilmente in Serbia (almeno 300mila persone), cui il governo Kostunica afferma di voler anzi proporre la cittadinanza serba. Italia / Afghanistan / USA. 15 giugno. «Entro ambiti ragionevoli e in relazione alle nostre possibilità la nostra presenza militare in Afghanistan potrà anche avere un certo incremento». Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Massimo D’Alema, nel corso della sua lunga audizione, ieri pomeriggio, davanti alle commissioni esteri riunite di camera e senato. Alla vigilia della sua partenza per Washington, dove è atteso dalla segretaria di Stato statunitense Condoleezza Rice, Massimo D’Alema ha illustrato a deputati e senatori le linee della politica estera del governo Prodi. Sull’Afghanistan ha offerto una certezza, opposta a quella della sinistra della sua coalizione che chiede da tempo di ridiscutere la missione. «La presenza militare italiana non è in discussione», ha detto. A Washington Massimo D’Alema si presenta preceduto da un articolo pubblicato ieri dal Wall Street Journal nel quale, nelle prime righe, ricorda di essere stato l’ultima volta alla Casa Bianca nel 1999 «quando ero primo ministro e il problema era quello dell’intervento umanitario in Kosovo». A buon intenditor... Italia / Afghanistan / USA. 15 giugno. Più o meno nelle stesse ore si esprimeva il presidente del Consiglio, Romano Prodi, a Berlino davanti ai giornalisti tedeschi. «Dall’Iraq non ci ritireremo alla spagnola ma alla olandese», ha detto Prodi, aggiungendo che la notazione non è sua ma del segretario generale della NATO, Jaap De Hoop Scheffer. Nel momento in cui decise il ritiro delle truppe dall’Iraq, l’Olanda fu «caldamente invitata» dalla NATO a incrementare la sua presenza militare in Afghanistan. Cosa che fece, mandando nella regione sud altri 1.400 soldati. Al prezzo di una spaccatura nella coalizione di governo. LA NATO preme sull’Italia non tanto per i caccia Amx quanto per truppe specializzate (gli italiani sono al momento circa 1.400) che operino sul terreno. Il ministro Parisi ieri, sul Corriere della Sera, ha scritto che sull’Afghanistan «definiremo l’entità del nostro contributo sulla base dei problemi che si pongono alla comunità internazionale (cioè agli Stati Uniti, ndr)». Italia / Afghanistan. 15 giugno. Su Kabul, sul ri-finanziamento della missione in Afghanistan prevista per il 30 giugno, i “no war” si dividono in governisti e non. «Non possiamo rischiare di far cadere il governo perché altrimenti torna il centrodestra e ce lo teniamo per altri 60 anni», sostengono i realpolitik pronti ad indossare l’elmetto con buona pace delle grandi adunate contro la guerra, delle strade e le piazze di mezza Italia colorate d’arcobaleno, delle roboanti conferenze stampa per annunciare contestazioni e proteste contro la violazione dell’art. 11 della Costituzione. «Una logica terrificante», tuona Piero Bernocchi dei Cobas, tra i pochi a non avere peli sulla lingua e a rivolgersi a muso duro ai parlamentari pacifisti della sinistra: «Si stanno assumendo una responsabilità enorme. Se il governo esordisce facendo la guerra in Afghanistan che senso ha difenderlo? Non possono minimizzare la questione come se niente fosse». Italia / Afghanistan. 15 giugno. «L’impiego delle forze armate non può essere mai identificato con l’intervento umanitario, che deve essere condotto con forze civili anche per non riproporre vecchie politiche di potenza e di intervento unilaterale che non aiutano la causa della pace né quella dello sviluppo». A pagina 106 del programma dell’Unione giace sepolto un chiaro codicillo che dovrebbe impegnare tutti i parlamentari dell’Unione. Almeno sulla carta, quindi, il no ad un aumento delle truppe in Afghanistan, come ventilato ieri da D’Alema, è il Rubicone da non attraversare per tutti. Ma a ben vedere lo è anche la riproposizione del decreto di finanziamento così come scritto dal precedente governo Berlusconi. Il verde Mauro Bulgarelli è esplicito: «Basta con le ipocrisie, quello che era sbagliato all’opposizione lo è anche oggi. L’Afghanistan è un fallimento completo dell’amministrazione Bush e va chiamato con il suo nome: guerra. Le nostre truppe vanno ritirate prima che il prezzo di vite umane diventi ancora più alto. Karzai», aggiunge, «non è nemmeno il sindaco di Kabul. In difesa di quali interessi siamo lì? Terremo fede ai nostri impegni pacifisti e se la missione resta questa voterò no». Anche Loredana De Petris, un’altra ambientalista, concorda sulla necessità di un chiarimento: «La discussione dei capigruppo non basta, o la missione cambia o noi non la votiamo. La situazione sul terreno peggiora di giorno in giorno. E se siamo lì per la ricostruzione certo non possiamo mandare cacciabombardieri e truppe speciali». Piero Di Siena, sinistra Ds e senatore dell’Ulivo, dalla sua posizione di confine vede un’aria pesante: «L’intesa o è di tutta l’Unione o non è. Se la maggioranza non è autosufficiente in politica estera il governo crolla». E poi aggiunge sibillinamente: «Lavoriamo tutti su giusti e responsabili compromessi». Italia / Afghanistan. 15 giugno. «Via dall’Afghanistan? Devo ancora decidere». La pacifista doc, Lidia Menapace, intervistata oggi da il Giornale, si avventura in contorcimenti e capziosità per distinguere l’impresa in Iraq da quella in Afghanistan; e questa da quella in Jugoslavia portata avanti dal governo di centrosinistra del 1999 con gli USA del “democratico” Clinton. Richiesta su come si stia orientando sulla sua scelta di voto in Senato, la senatrice esordisce dicendo: «Trovo la questione mal posta». Ritiene che si stia assistendo «ad una sorta di ribaltamento dei ruoli, come se i media volessero prendere loro una decisione in vece del parlamento, che è sovrano». Al giornalista che le riferisce che «per il Corriere della Sera lei ha già deciso di votare contro», replica perentoria: «Io ho smentito il Corriere della Sera. Quindi...». Cosa intende fare in Parlamento, allora? «Deciderò al momento del dibattito, in Parlamento. Adesso sto riflettendo, su un argomento complesso che non può essere affrontato con una battuta». Il giornalista incalza, le chiede se «trovi punti di distanza apprezzabili fra la missione dell’esercito italiano in Irak e quella in Afghanistan». Risponde: «È evidente che li trovo, scusi». Quali sono dunque queste «differenze su cui sta riflettendo», chiede il giornalista, che prova a suggerire: «Il tipo di mandato internazionale, diverso da altre missioni?». «Ci sono tante missioni e tanti diversi mandati», risponde la Menapace accogliendo nella «diversità» anche la missione nella ex Jugoslavia. In relazione alle sue riflessioni dell’oggi afferma: «Un nodo è il passaggio di ruolo tra le Nazioni Unite e la NATO, che non appare documentato». Legittimamente esterrefatto per questa argomentazione che la Menapace peraltro ribadisce, come se il problema sia giuridico-formalistico, alla domanda («Quindi questo è il nodo più rilevante per lei?») la senatrice mette le mani avanti: «Sì, ma non vorrei che lei prendesse un singolo dettaglio nel quadro di un ragionamento complessivo e lo adoperasse per spararci sopra un titolo!». Poi, richiesta ancora sull’argomento principale dell’intervista («E se le chiedo a che punto è la sua riflessione sull’Afghanistan lei cosa mi risponde?»), la sua risposta è un emblematico (in tutti i sensi!) «no comment». Quindi? «Deciderò il giorno del dibattito, ma solo dopo aver discusso nel mio gruppo». Italia / Afghanistan. 15 giugno. Lidia Menapace. Giovanissima prende parte alla Resistenza partigiana e nel dopoguerra è impegnata nei movimenti cattolici e con varie organizzazioni progressiste. Insegnante, simpatizza per il Partito Comunista Italiano ma nel 1969 è tra le fondatrici de il Manifesto. Rappresenta una delle voci più importanti del femminismo italiano, dei movimenti della cosiddetta “società civile” e del cammino verso la nonviolenza. Nelle elezioni politiche del 2006 si candida con Rifondazione Comunista al Senato e risulta eletta. La sua candidatura è resa possibile in sostituzione di Marco Ferrando, l’esponente di una delle correnti di minoranza di Rifondazione Comunista. Ferrando è stato protagonista di una polemica che ha comportato la rimozione dalle liste del partito per volontà della sola segretaria del partito. Il 13 febbraio 2006 rilascia un’intervista al Corriere della Sera in cui sulla guerra in Iraq, ferma restando la sua contrarietà agli «atti di terrorismo di matrice fondamentalista», si dice convinto del «diritto alla legittima resistenza dei popoli aggrediti» contro i contingenti militari, anche quello italiano; inoltre, accennando alla strage di Nassiriya in cui morirono 19 italiani (molti dei quali carabinieri), denuncia un collegamento tra l’invio di militari nella città irachena e gli interessi dell’ENI nello sfruttamento di pozzi di petrolio nell’area. Fausto Bertinotti e il responsabile dell’Area Organizzazione del partito, Francesco Ferrara, escludono Marco Ferrando dalle liste di Rifondazione: le sue idee sono incompatibili con le tesi non violente della maggioranza. Lo rimpiazzano appunto con Lidia Menapace. Afghanistan. 15 giugno. La più imponente offensiva militare di USA e “alleati” dopo il 2001 ha inizio ufficiale oggi. Operation Mountain Thrust (Assalto alla Montagna) vuole «bonificare» le roccaforti taliban prima del passaggio alla NATO. Il generale Benjamin Freakley, comandante delle forze USA in Afghanistan, ha detto che coinvolgerà oltre 11mila soldati della coalizione guidata dagli USA, di cui 2.300 statunitensi, 3.300 britannici, 2.200 canadesi e 3.500 afghani; mobiliterà artiglieria pesante, mezzi corrazzati e supporto aereo e si concentrerà nei distretti montagnosi delle province meridionali e orientali di Kandahar, Helmand, Uruzgan e Zabul. Sono le roccaforti dei combattenti taliban, e sono le zone che il prossimo luglio passeranno dal controllo delle truppe USA alla NATO-ISAF (la Forza multinazionale di «stabilizzazione dell’Afghanistan»). Nel corso dell’estate circa 6mila soldati della NATO dunque giungeranno in Afghanistan, e il ridispiegamento nella parte meridionale del paese permetterà alle truppe USA di ridimensionarsi da 23mila a 20mila uomini. L’obiettivo strategico dell’operazione lanciata oggi è appunto «bonificare» la zona prima del passaggio. I comandi USA dicono che l’offensiva permetterà di «estendere l’autorità del governo centrale di Kabul», il che significa quantomeno ammettere che il presidente Hamid Karzai non controlla il paese. Afghanistan. 15 giugno. Ma i ribelli sono sempre più forti. Uccisi ieri due marines. I combattimenti più pesanti sono previsti nelle montagne tra l’Uruzgan occidentale e il Helmand nord-orientale, dove lo scorso fine settimana le truppe britanniche hanno avuto i loro primi caduti in combattimento da quando si sono dispiegate nella zona. Il fatto è che in maggio anche i taliban hanno lanciato la propria offensiva, «preventiva» al dispiegamento della NATO. Ma se le offensive di primavera-estate sono ricorrenti in Afghanistan, sembra che ogni anno le forze dei taliban si presentino più forti. Il comandante Taleban Mullah Dadullah afferma di avere una forza di 12mila uomini armati (erano poche migliaia l’anno scorso) e di controllare una ventina di distretti delle province di Kandahar, Helmand, Zabul e Uruzgan. È appunto là che le truppe USA e “alleate” concentreranno la loro offensiva. Afghanistan. 15 giugno. «Sono in corso violenti scontri a fuoco nel sud dell’Afghanistan»: con queste parole il portavoce delle milizie islamiche talebane, Muhammad Hanif, ha confermato alla tv satellitare Al Jazeera l’offensiva della coalizione a guida statunitense. «Stiamo combattendo nella zona di Qala Moussa, nella provincia di Helmand», ha affermato Hanif, «e nella stessa zona abbiamo distrutto diversi veicoli militari americani». Un portavoce statunitense, il tenente colonnello Paul Fitzpatrick, ha spiegato che l’attacco prende di mira soprattutto i vertici dei taliban. Ora si è aperta la «fase successiva», ha spiegato Fitzpatrick: «Stiamo spostandoci nelle province settentrionali dell’Afghanistan meridionale». Afghanistan. 15 giugno. Cinque anni dopo la guerra che ha scalzato il governo Taleban e doveva sbaragliare al Qaeda, l’Afghanistan è ancora in guerra, con una forza Taleban riorganizzata e in crescita. L’uomo di fiducia degli Stati Uniti, con il loro avallo, ha tollerato che i «signori della guerra» responsabili della guerra civile dei primi anni ’90 mantenessero le proprie ariee di influenza (e milizie) in veste di governatori. Nel frattempo la ricostruzione non è decollata. Molte le promesse, molto poco si è mantenuto e quando si cerca di capire cosa, saltano fuori iniziative d’immagine. Non una sola centrale elettrica è stata costruita, non c’è stato alcun investimento nell’infrastruttura rurale. La principale attività economica del paese è tornata a essere la produzione di oppio e derivati (eroina), i narcotrafficanti offrono agli agricoltori redditi ben più alti delle agenzie internazionali che si affannano a «eradicare» le coltivazioni di papavero. E l’oppio arricchisce i “signori della guerra” ed alimenta corruzione nel governo. Iraq. 15 giugno. Gigantesca operazione militare contro la Resistenza. È cominciata ieri a Baghdad un’offensiva del governo iracheno coadiuvato dalle truppe d’occupazione. Secondo le cifre ufficiali sono impegnati 50mila effettivi locali e 7.200 occupanti stranieri. Il piano include l’imposizione del coprifuoco nella capitale e nelle sue vicinanze dalle 21.00 alle 06.00. Si tratta del più consistente dispositivo militare nella capitale dalla caduta della città nelle mani degli invasori nell’aprile 2003. Cina. 15 giugno. Vertice di Shanghai. Oggi Cina, Russia e quattro Repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale hanno sottoscritto una dozzina di accordi di cooperazione economica, politica e militare che permetteranno ai sei dell’OCS –l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai– di lavorare insieme su diversi terreni in modo più pragmatico ed efficace, manovre militari comprese, previste per il 2007 in territorio russo. Presente il presidente iraniano Mahmud Amadinejad, invitato come osservatore assieme ai leader di Mongolia, India e Pakistan. A Washington c’è chi non nasconde il timore che l’OCS diventi un’alleanza strategico-militare anti-USA. USA. 15 giugno. Altri 66 miliardi di dollari per Iraq e Afghanistan. Li ha stanziati il Senato degli Stati Uniti che ha votato oggi un bilancio suppletivo da 94 miliardi di dollari e mezzo, di cui 66 miliardi, appunto, per sostenere le occupazioni di Iraq e Afghanistan. Il voto del Senato, che segue quello della Camera martedì, è definitivo. Il provvedimento attende ora solo la firma del presidente George W. Bush. Con i nuovi stanziamenti salgono a 410 miliardi di dollari le somme complessivamente stanziate ad hoc dal Congresso degli Stati Uniti per la «guerra al terrorismo» (320 miliardi per l’Iraq e 89 miliardi per l’Afghanistan, secondo i dati del centro studi parlamentare).
Scaricare