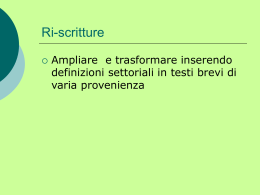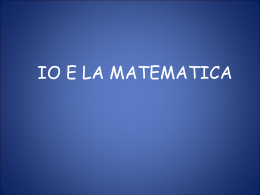Artù è ormai giunto al termine del suo apprendistato e, con la spada ricevuta in dono da Merlino, si accinge ad affrontare la sua prima campagna militare in difesa della Cambria. Ma la furia di Peter Ironhair, nemico giurato dei Pendragon, non è il solo ostacolo sul cammino del giovane Artù, costretto a districarsi in una fitta maglia di congiure e intrighi. Merlino è vittima di una terribile imboscata che lo segnerà per sempre, trasformandolo nel personaggio di innumerevoli leggende: il terribile stregone. Solo lui saprà liberare le terre a ovest di Camelot dal deforme e gigantesco mostro Carthac, solo lui sarà in grado di far estrarre ad Artù la mitica Excalibur dalla roccia, consacrandolo così Alto Re di tutta la Britannia. Ma dure prove attendono il giovane sovrano, che, alla testa di tutte le tribù celtiche, dovrà opporsi alla più grande invasione che abbia mai minacciato l'isola. www.edizpiemme.it VOLUME DLB 149 Jack Whyte è poeta, regista cinematografico e romanziere. Nato in Scozia, vive da molti anni in Canada. Ha raggiunto uno straordinario successo con Le Cronache di Camelot, ormai considerate un bestseller in tutto il mondo. A questo ciclo appartengono anche i titoli La pietra del cielo, La spada che canta, La stirpe dell'aquila, Il sogno di Merlino, Il forte sul fiume, Le porte di Camelot e La donna di Avalon. L'autore sta lavorando a una nuova appassionante serie dedicata a Lancillotto, di cui sono già disponibili in Italia i primi due titoli: Il cavaliere di Artù e II marchio di Merlino. Della serie Le Cronache di Camelot hanno detto: «Sono i romanzi storici più belli che abbia mai letto. E credetemi, ne ho letti tanti!» Marion Zimmer Bradley «Uno splendido mix di realtà storica e leggenda.» La Stampa In sovraccoperta: Illustrazione di Silvia Fusetti Titolo originale dell'opera: The Sorcerer: Metamorphosis © 1999 by Jack Whyte © 2006 - Edizioni Piemme Economica © 2002 - EDIZIONI PIEMME Spa 15033 Casale Monferrato (AL) - Via Galeotto del Carretto, 10 Tel. 0142/3361 - Fax 0142/74223 www.edizpiemme.it A mia moglie, Beverly, e a mio nipote, David Michael Johns, finalmente abbastanza grande da leggere i libri del nonno. La leggenda della pietra caduta dal cielo Dal cielo notturno cadrà una pietra che cela una fanciulla nata da profondità tenebrose, una fanciulla i cui femminili misteri, nutriti dal fuoco, daranno vita a una spada scintillante, baluginante. Una spada fiammeggiante e splendente la cui potenza genera guerrieri. Ma quest'arma conterrà anche le astuzie di una donna e traccerà terribili fatti di uomini; darà il nome a un'epoca; incoronerà un re, che prenderà il nome da un popolo della montagna, che crede di essere stato generato dal seme di un drago; uomini vigorosi e feroci, eroici, prodi e forti, e nelle loro anime vi è grandezza. Questo re, questo monarca, potente oltre l'immaginabile, forgiato nella gloria, cantando un canto di spade, confondendo i mortali con magica follia, darà vita a una leggenda, e tuttavia non lascerà nessuno a condurre al trionfo il suo esercito dopo di lui. Ma la morte non svilirà mai il suo destino che, non morendo, vivrà per sempre, per essere ricordato. Nomi geografici La terra che i Romani chiamavano Britannia era soltanto la terra che noi oggi chiamiamo Inghilterra. La Scozia, l'Irlanda e il Galles erano separate e venivano chiamate rispettivamente Caledonia, Ibernia e Cambria. Esse non erano considerate parte della provincia della Britannia. Le antiche città della Britannia romana esistono ancora, ma oggi hanno nomi inglesi. Londinium Verulamium Galava Glevum Aquae Sulis Lindinis La Colonia (Camulod) Deva Lindum Mamucium Mediobogdum Corinium Venta Silurum Isca Silurum Nidum Moridunum Cicutio Glannaventa Manx Brocavum Londra St. Albans Ambleside Gloucester Bath Ilchester Camelot Chester Lincoln Manchester Il Forte Cirencester Caerwent Caerleon Neath Carmarthen Y Gear Ravenglass Isola di Man Brougham Introduzione Pesanti minacce alla vita del giovane Artù Pendragon hanno costretto Caio Merlino Britannico a portar via il ragazzo da Camelot. Con un piccolo gruppo di fedelissimi Merlino raggiunge il porto di Ravenglass, nella parte nordoccidentale della Britannia, sperando di trovarvi rifugio. In cambio della promessa di aiuto militare, il re Derek di Ravenglass gli consente di stabilirsi con la sua gente in un forte romano da tempo abbandonato, noto con il nome di Mediobogdum (che vuol dire "sull'ansa del fiume"), un luogo isolato su un altipiano tra le montagne. Per non dare nell'occhio, Merlino rinuncia alla sua identità di capo della piccola comunità, e per gli estranei diventa semplicemente "mastro Cay", un contadino che si prende cura del suo giovane pupillo, Artù. Con l'aiuto degli amici più cari e dei compagni più fidati, Merlino si occupa dell'educazione di Artù istruendolo su temi quali la giustizia, l'onore, la fede cristiana e le responsabilità di governo. Artù comincia ben presto a dar prova di quelle doti - saggezza, equilibrio e senso della giustizia - che un giorno lo renderanno leggendario e Merlino vede avvicinarsi il momento in cui il ragazzo dovrà cingere la spada regale, Excalibur. Infine, Artù apprende le tecniche che gli consentiranno di combattere con la nuova spada. Intanto, i fabbri di Camelot, nel più rigoroso segreto, forgiano due nuove spade con ciò che resta della Pietra del Cielo, due armi che dovranno essere identiche a Excalibur in tutto tranne che nel suo magnifico aspetto. A Mediobogdum Merlino trascorre anni sereni, godendosi l'amore di Tressa, una giovane donna incontrata a Ravenglass, e occupandosi dell'educazione di Artù che, insieme agli amici di sempre - Gwin, Ghilleadh e Bedwyr - si avvia a diventare un uomo. Connor Mac Athol, la cui flotta ha trasportato gli Scoti di re Athol ad Alba, nelle loro nuove terre sulle isole nordoccidentali, si reca spesso a Ravenglass e riporta quanto avviene nell'Eire, mentre Ambrogio, il fratellastro di Merlino, viene a trovare quando può la piccola comunità, portando confortanti notizie sulla fiorente Camelot. A tormentare Merlino c'è però una preoccupante macchia che da qualche tempo gli è apparsa sul petto; c'è il timore che possa essere lebbra, finché il medico Lucano ha la possibilità di consultare i suoi autorevoli testi medici e di dichiarare che la macchia non è dovuta a lebbra, tranquillizzando finalmente Merlino. Ma al di fuori del loro pacifico isolamento, forze violente sono in subbuglio e minacciano di porre fine alla precaria pace di Camelot. Un giorno Ambrogio fa sapere che in Northumbria, la terra del re Vortigern, sono scoppiati gravi disordini. L'alleato danese di Vortigern, Hengist, è morto e la fragile pace che aveva retto fino a quel momento è ora minacciata dalle pretese del figlio di Hengist, Horsa, violento e impulsivo, e dei suoi guerrieri, scontenti e privi di terre. Ma c'è qualcosa di ancora più pressante: le possenti forze di Peter Ironhair, il vecchio nemico di Merlino, si stanno radunando in Cornovaglia, mentre in Cambria, Dergyll ap Griffyd, che dopo la morte di Uther si era messo a capo del popolo di Pendragon, è stato ucciso dall'alleato di Ironhair, il mostruoso Carthac, che avanza pretese sul regno di Cambria. In seguito Merlino viene a sapere che, quando ancora erano insieme a Camelot, un suo vecchio compagno, Owain delle Grotte, potrebbe essere stato una spia al servizio di Ironhair. Ironhair sa dove si nasconde Artù? E cercherà di far uccidere il ragazzo, poiché crede che le pretese di Artù sulla Cambria costituiscano un grave ostacolo alle sue ambizioni. Temendo per la vita di Artù e rendendosi conto che nel remoto rifugio di Mediobogdum l'educazione del futuro re non può procedere oltre, Merlino comprende che è giunto il momento di partire: in primavera farà ritorno a Camelot con i suoi fedelissimi e si preparerà a scontrarsi in battaglia con Peter Ironhair. PARTE PRIMA CAMELOT I. Nella vita di un uomo non c'è giorno più importante di quello in cui per la prima volta impugna ufficialmente una spada. In quel momento fatidico e tanto atteso in cui un giovane, in presenza degli adulti e dei suoi coetanei, per la prima volta allunga la mano e afferra l'impugnatura della spada che gli apparterrà, la sua vita e il suo mondo cambiano per sempre. Agli occhi della collettività è diventato un uomo: la sua infanzia è pubblicamente e irrevocabilmente abbandonata, un po' come la pelle del serpente quando avviene la muta. Molto più importante e traumatico del primo incontro con una donna, impugnare la spada costituisce l'ultimo e più significativo rito di superamento di quell'ampio golfo che divide la fanciullezza dalla piena virilità. La transizione di Artù Pendragon e il rituale che comportò furono, almeno per me, motivo di gioia, di stupore, di grande soddisfazione e di un immenso, profondo orgoglio. Condensare tutto questo in semplici parole è stato estremamente difficile. Infinite volte mi sono messo all'opera con l'intenzione di descriverlo e ho finito con il ritrovarmi con le dita sporche di inchiostro, con un foglio di papiro macchiato e cancellato più e più volte e una penna rovinata, con l'estremità rosicchiata, arruffata e imbevuta della saliva della mia stessa bocca. Solo di recente, e dopo molti tentativi, sono riuscito a mettere insieme un racconto coerente dell'occasione e degli eventi che l'hanno preceduta, partendo da innumerevoli scarabocchi, da brandelli e annotazioni senza fine. Anche così, però, temo che assomigli a un'antologia di avvenimenti e di impressioni più che a una vera cronologia. Ciò nondimeno tutti questi fatti, nessuno escluso, ebbero un impatto diretto sul modo in cui Artù giunse alle soglie della virilità. È forse mai esistito un golfo più ampio di quello che separa un ragazzo dall'uomo che diventerà? Non c'è dubbio che per un uomo nel pieno della propria virilità, poche cose possono rivelarsi più difficili o fastidiose del tentativo di ricordare che cosa provava, o come si sentiva, quando era ancora ragazzo. Sono due periodi della vita in cui si parlano lingue completamente diverse. Un ragazzo nel pieno della sua fanciullezza, nell'età compresa tra gli otto e i dodici anni, è ancora ignaro della sessualità; in lui sono presenti altre forme, non meno importanti, di curiosità, mentre il suo interesse è rivolto a imparare e a scoprire tutto ciò che c'è da sapere sull'essere maschi e forti, potenti e vincitori. Al contrario, quando è nel fiore degli anni, un uomo può non cessare di essere curioso, ma tutta la sua curiosità è inficiata dalla sessualità, poiché per la massa degli uomini, tutte le azioni sono dominate dall'urgenza di soddisfare i propri bisogni sessuali. Grazie ai rapporti davvero unici che mi hanno legato ad Artù Pendragon nel corso di tutta la sua vita, ho avuto la possibilità di osservarlo da vicino nel periodo in cui avveniva la transizione da uno stadio all'altro; tuttavia, per quanto mi sforzi di ricordare, non riesco a individuare nessun momento determinante che abbia segnato il passaggio dalla fanciullezza all'età adulta in quel giovane uomo che avevo finito con il considerare un figlio. Il fatto esteriore, il momento pubblico appartiene alla storia, ma a tutt'oggi non sono in grado di dire quando il ragazzo divenne un uomo nel proprio intimo. So soltanto che fui grato, e ancora lo sono, per il semplice fatto che ciò che più amavo nel ragazzo rimase immutato e vibrante nell'uomo. E da adulto la sua sensualità, per quanto spesso sia apparsa travolgente, non si spinse mai oltre i limiti imposti dalla sua natura generosa e dal suo fiero, fanciullesco senso della giustizia e della correttezza. Negli anni intercorsi tra la distruzione della flotta dei Figli di Condran, a Ravenglass nel corso di una furiosa tempesta, al giorno in cui Artù Pendragon cinse la spada, molte delle mete che avevo posto a me stesso erano state raggiunte; al contrario, svariati progetti erano ancora in corso e numerosi avvenimenti previsti non si erano verificati affatto. Per esempio, non avevo avuto occasione di allontanarmi da Mediobogdum e di viaggiare con Artù, come invece sarebbe stata mia intenzione. Da ultimo, il timore di mettere a rischio la sua incolumità e una minaccia alla sicurezza della nostra Colonia su due fronti, in Cambria e nelle terre di Vortigern, a nordest, avevano reso indispensabile il nostro ritorno a Camelot quella primavera stessa. Così era giunto il nostro ultimo inverno a Mediobogdum, un inverno che passò con una velocità che mai avrei creduto possibile. Connor arrivò in febbraio, oltre un mese prima di quanto fosse ragionevole aspettarsi di vederlo spuntare. Infatti, sebbene una nevicata decisamente fuori stagione avesse distrutto gran parte dei nostri raccolti, facendoci temere un inverno difficile, la stagione seguente si era poi rivelata talmente mite da non poter essere definita inverno. In realtà, a Mediobogdum, gli scuri mesi invernali che trascorsero tra quella prematura nevicata e i primi timidi annunci di primavera portarono semplicemente una pioggia quasi incessante e una pesante cortina di nuvole che si diradava raramente. Soltanto le alte vette delle Fells mostravano il consueto candore. Infine, anche le violente burrasche invernali, che normalmente infuriano sulle zone costiere, quell'anno non ci furono affatto: sembrava proprio che tutta la Britannia godesse di un tepore e di una quiete senza precedenti. Connor, che non era certo il tipo d'uomo da restare in ozio quando c'erano cose che potevano richiedere la sua attenzione, aveva approfittato dell'inverno mite per tenere in acqua tutto l'anno gran parte della sua flotta, ed era la prima volta che, a memoria d'uomo, avveniva qualcosa di simile. Normalmente le sue imbarcazioni venivano tirate in secco all'inizio dell'inverno per la consueta raschiatura annuale delle chiglie; quell'anno invece, sfidando gli dèi del mare e della tempesta, Connor le aveva impegnate nel pattugliare in lungo e in largo le centinaia di miglia di costa dei nuovi territori settentrionali di suo padre; le galee venivano tirate in secco a rotazione, per la raschiatura e la manutenzione delle chiglie, ogniqualvolta lui stesso o i suoi comandanti trovavano un tratto di spiaggia adatto. Arrivò dunque a Ravenglass senza alcun preavviso e il giorno seguente comparve sotto le nostre mura, accompagnato da un sorridente Derek, sfilando baldanzosamente sul suo imponente carro alla testa della consueta pattuglia. E naturalmente, come sempre accadeva, anche quella volta la sua venuta portò un'allegra confusione, causata dalla vulcanica presenza di Connor e dall'eccitazione per l'arrivo imprevisto, oltre che dal comportamento dei suoi vivaci compagni. Come al solito arrivò carico di regali: per me aveva portato un coltello a serramanico, fatto di bronzo e ferro, con il manico rivestito di lucide placche di corno d'ariete montate in argento. Me lo lanciò non appena mi precipitai a dargli il benvenuto, quasi correndo nella fretta di salutarlo prima di chiunque altro. Non era ancora sceso dal carro e per lanciarmi il regalo si era fermato a mezz'aria, con la gamba di legno a penzoloni. Per un attimo, proprio dietro le sue spalle intravidi un viso sconosciuto, eppure stranamente familiare. Tuttavia gli diedi soltanto un rapido sguardo, concentrato com'ero ad afferrare il magnifico coltello; non riuscivo a smettere di ammirarlo, premendo la leva di bronzo per liberare la lama di ferro dal manico, poi muovendo rapidamente il polso per permettere alla lama di aprirsi. Connor si fece subito avanti con quella curiosa andatura ondeggiante impostagli dalla gamba di legno e con un gran sorriso mi gettò le braccia al collo proprio mentre stavo alzando la testa per ringraziarlo del dono. Mentre lo abbracciavo cercai con gli occhi il viso sconosciuto che avevo intravisto alle sue spalle e vidi Donuil accogliere affettuosamente lo straniero: l'aria di famiglia era inconfondibile. «Benvenuto, vecchio amico» mormorai all'orecchio di Connor, mentre lo stringevo con forza. «Vedo che hai portato con te un altro dei tuoi fratelli. Che fratello è?» «Quello è Brander.» Mi lasciò andare e si voltò per guardare Donuil e Brander che chiacchieravano, osservandosi l'un l'altro nel modo inconfondibile con cui si scrutano le persone che si rivedono dopo molti anni. «Brander! Su, vieni a conoscere un uomo che avresti dovuto incontrare già molto tempo fa.» Brander e Donuil si avvicinarono a noi, continuando a parlottare tra di loro come se Donuil dovesse finire di dire qualcosa di importante al fratello maggiore. Brander rise e poi mi guardò dritto negli occhi, allungando le mani verso di me. «Merlino Britannico, finalmente! Era ora, mi sento come se fossimo amici da anni.» Strinsi le sue mani, provando un'immediata simpatia nei suoi confronti. «Brander Mac Athol, ammiraglio dei Mari Settentrionali, sei il benvenuto qui, a Mediobogdum, come lo sarai a Camelot se un giorno deciderai di andare da quelle parti. I tuoi fratelli, e certamente anche tuo padre quando ho avuto occasione di incontrarlo, mi hanno detto un gran bene di te, e quanto hai fatto per la tua gente non può che garantirti un posto d'onore in mezzo a noi.» Brander inclinò leggermente la testa e sorrise. «Hanno proprio ragione, i miei fratelli. Mi avevano detto che hai una lingua di miele e più fascino di quanto te ne serva per nascondere il ferro che c'è in te. Grazie, comunque, per la tua gentilezza.» Si fermò, con la testa leggermente piegata di lato. «Merlino, sembri... perplesso. C'è qualcosa che non va?» «No, assolutamente no! Perdonami, ma quello che hai visto è più curiosità che stupore.» Mi voltai verso Connor, poi tornai a guardare Brander, scrollando le spalle. «Il fatto è che non avrei mai pensato di vedere tutti e due gli ammiragli di re Athol nello stesso posto e senza le rispettive flotte. Chi avete lasciato al comando, lassù nel nord?» I due uomini scoppiarono a ridere; tuttavia per un attimo, ma solo per un attimo, mi parve di percepire uno sprazzo, poco più di una fuggevole impressione, di qualcosa di non detto, di una qualche tensione, sia pur minima, che li dividesse. «Oh, la flotta è in buone mani» mi rispose Brander. «Ho sempre pensato che la cosa migliore che i Romani hanno lasciato a uomini come me e mio fratello fosse un'unica parola: delegare. Ovvero l'autorità del comandante viene direttamente trasmessa agli inferiori; è questo quello che significa, non è vero?» «Già, è così.» Dovetti reprimere un sorriso. «Devo ammettere, ammiraglio, di non aver udito questa parola da parecchi anni e di non aver mai pensato di sentirla in bocca a uno che appartiene al popolo degli Ersi.» «Non appartengo al popolo degli Ersi, Merlino Britannico, io faccio parte del popolo dei Gaeli». Lo disse senza rimprovero, come se avesse voluto ricordare il nome del paese che si estende dall'altra parte del Mare Meridionale, la Gallia. «Tutti noi, un tempo, siamo arrivati dalla Gallia. Non lo sapevi? Giulio Cesare lo sapeva bene! Così abbiamo ricominciato a chiamarci con l'antico nome, per distinguere noi e i nostri discendenti da gente come i Figli di Condran o i Figli di Gar, che sono a malapena umani, e che restano, come potete notare, nell'Eire mentre noi ci trasferiamo in una nuova terra. Dunque, da questo momento in poi noi ci chiameremo Gaeli.» «Perché non Scoti?» Mi guardò corrugando la fronte, come se stesse meditando sulle mie parole, poi annuì. «È un nome romano, ma suona bene.» Attesi, anche se era chiaro che, dal suo punto di vista, l'argomento era chiuso. «Allora,» guardai i due ammiragli, prima uno e poi l'altro, «che cosa vi ha portati qui?» «La libidine» disse Connor, ridendo rumorosamente tanto che tutti si girarono verso di noi. «Finalmente anche a Brander è toccato il destino comune a tutti gli uomini: si è sposato.» «È vero» ammise Brander. «Fino a ora non avevo mai preso moglie. Mai avuto tempo di cercarne una. Ma adesso la guerra ci concede una tregua. Negli ultimi tre anni i Figli di Condran e gli altri che vivono nell'Eire non hanno avuto il coraggio di farsi vedere, e si guarderanno bene dal farlo anche in seguito, almeno questa è la mia opinione. Così ho avuto del tempo da trascorrere a riva, e ho incontrato...» si interruppe, guardandosi attorno e suo fratello tagliò corto. «...la bella Salina! Merlino, purtroppo ho dovuto assistere alla triste rovina di quest'uomo, di questo guerriero intrepido, fin dal primo momento in cui ha posato gli occhi sulla donna che ora è sua moglie!» «Salina? E un nome romano. È dunque...?» «No, appartiene al popolo dei Pitti e proviene dalla terraferma, da quella che voi chiamate Caledonia» rispose Connor. «A dire la verità, non è esattamente così.» Brander si stava guardando attorno, in cerca della moglie, ma a quel punto si voltò verso di me. «Appartiene alle Genti Dipinte, come li chiamano loro, ma non della terraferma. Mia moglie proviene da una delle isole più lontane, su nel nord, oltre il continente, un posto chiamato Orcenay. Ah, eccola là, con le altre donne. Vado subito a chiamarla.» Quando tornò era accompagnato da due donne, la più giovane era alta e appariva meravigliosamente bella anche da lontano; la più matura, riccamente vestita, stava leggermente dietro di loro, con la testa abbassata come se fosse intenta a guardare qualcosa che teneva tra le mani. «È stupenda» proruppe Donuil. «E così giovane!» Connor sbuffò. «Giovane? Ma quella è Morag, la nipote. Pensi forse che tuo fratello sia un vecchio caprone? Salina è quella che sta dietro.» Quando furono più vicini, Salina alzò la testa e affrettò il passo per raggiungere il marito, e io osservai il modo in cui Brander le prendeva la mano e la faceva avanzare, appena davanti a sé, per presentarcela. Forse a causa della radiosa giovinezza della sua compagna, rimasi stupito che la novella sposa fosse così matura: "vecchia" era una parola che nessun uomo che avesse sangue nelle vene si sarebbe mai sognato di attribuire a una donna come lei. Era nel fiore degli anni, bella, con gli zigomi alti e una bocca piena e sensuale; i suoi occhi profondi erano di un azzurro così intenso da illuminarle l'intero volto. Portava un cappuccio, di una foggia che non saprei definire, che le copriva i capelli e si muoveva con grande disinvoltura e dignità. La osservai con curiosità mentre salutava il cognato, Donuil, prendendogli entrambe le mani tra le proprie e sorridendogli radiosa. Era chiaro che doveva aver sentito parlare molto di lui ed era ugualmente chiaro, dal rossore che gli si diffuse sulle guance, che Donuil era rimasto colpito dall'inatteso calore del suo saluto: sembrava confuso e agitato mentre si scusava per l'assenza della moglie che, poco dopo l'alba, si era allontanata a cavallo per raggiungere le colline e mettersi in contatto con i suoi dèi nel giorno dell'anniversario della propria nascita. Poi la donna più giovane, Morag, si fece avanti a sua volta per essere presentata a Donuil, e a quel punto mi dimenticai completamente della zia. Sentivo gli occhi di Salina fissi su di me, ma ero troppo affascinato dalla bellezza della nipote per volgere ancora lo sguardo verso di lei. Tuttavia, da vicino, Morag appariva diversa: quando, da una certa distanza, avevo posato gli occhi su di lei mi era sembrata una giovane donna di circa diciott'anni, mentre ora si rivelava una bella bambina, slanciata, snella e dalle forme incantevoli; ma se il seno, alto e turgido, faceva pensare a una donna nel pieno fulgore, il viso conservava ancora tutta l'innocenza dell'adolescenza. Era un volto incredibilmente bello, con grandi occhi grigi e una bocca ridente incastonata tra due guance vellutate che, quando sorrideva, mettevano in mostra deliziose fossette. Osservandola, potei valutarne l'età: doveva essere più giovane di Artù, a malapena tredicenne, pensai. A quel punto toccava a me essere presentato a Salina, ma mentre mi voltavo per salutarla vidi che Tress si stava avvicinando: si metteva a posto in gran fretta i capelli e sembrava agitata. Infatti, non appena aveva appreso che avevamo visitatori il suo pensiero era andato alle stanze degli ospiti, che non erano pronte, ed era corsa a farle preparare. Rivolsi un sorriso a Salina, alzando una mano come per chiederle silenziosamente di concederci la sua indulgenza, poi mi allontanai leggermente e tesi la mano per stringere quella di Tress che intanto era sopraggiunta. «Signora» dissi allora, dedicando finalmente tutta la mia attenzione alle mie ospiti e inchinandomi leggermente prima di guardare Salina negli occhi per la prima volta. «Voi e i vostri siete i benvenuti qui a Mediobogdum. La nostra dimora è la vostra, e tutto ciò che possediamo, per quanto modesto, è a vostra disposizione. Il vostro arrivo mi riempie di gioia, ancora più grande poiché assolutamente inattesa. Su vostro marito mi sono state riferite molte cose meravigliose, ma nessuno aveva mai fatto parola del suo buon gusto né del suo senso estetico.» Poi mi rivolsi anche a Brander. «Spero che il vostro matrimonio sia felice, vi auguro ogni bene e pregherò perché vi siano concessi molti anni di felicità.» Infine, spinsi avanti Tress, tenendo stretta la sua mano nella mia. «Posso presentarvi la donna che amo, la mia Tress? Anche noi ci sposeremo presto.» Sorrisi a Tressa, che era tesa e con gli occhi spalancati per l'emozione. «Tress, certamente hai sentito parlare più volte del grande Brander, ammiraglio dei Mari Settentrionali e fratello di Donuil e Connor. Eccolo qui, e questa è la sua sposa, Salina.» Mentre Tressa salutava i nuovi arrivati, cercai con lo sguardo la giovane Morag con l'intenzione di includere anche lei nel mio benvenuto, ma la fanciulla era immobile, con gli occhi spalancati, dimentica di tutto e di tutti, assorta nella contemplazione di qualcosa che stava alle mie spalle. Incuriosito, mi voltai e vidi Artù che, come paralizzato, ricambiava il suo sguardo. A quel punto, se avessi avuto tempo, avrei magari detto qualcosa ad Artù, anche se dubito che le mie parole avrebbero potuto influire in qualche modo su quanto era già accaduto. Ricordo di aver pensato di presentarlo alla giovane Morag, ma quando alzai la mano per farlo, l'espressione rapita del suo sguardo mi fece comprendere che Artù non mi vedeva nemmeno. In quel preciso istante, con la coda dell'occhio scorsi un movimento rapido e vidi Connor che sollevava Tress in un forte abbraccio: da quel momento il benvenuto formale e compassato lasciò il posto a un allegro scambio di saluti tra vecchi amici. Connor aveva portato altri regali, tra cui una cotta di maglia di ferro foderata di cuoio e orlata di pelliccia per Artù e un assortimento di armi, attrezzi e abiti per gli altri ragazzi. Quanto a Tress, era rimasta senza parole per il dono ricevuto ed era evidente che nulla avrebbe potuto farle più piacere. Si trattava di una cassetta di scuro legno di quercia, antica ed elegantemente scolpita, piena fino all'orlo di centinaia di gomitoli di filato di lana e di cotone dai colori vivaci - giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco e grigio - che erano stati tinti, sosteneva Connor, nelle montuose regioni settentrionali non lontane dalle isole dove si erano ormai stabiliti lui stesso e il popolo di suo padre. Incapace di trovare le parole adatte per ringraziarlo, Tress si limitò a sorridergli tra le lacrime e ad accarezzargli affettuosamente la guancia prima di portare il suo tesoro, con il pronto aiuto di parecchie mani volenterose, nelle sue stanze per poterselo contemplare a proprio agio. Mentre accompagnavamo Connor, Brander e il loro seguito negli alloggiamenti che avrebbero occupato durante il loro soggiorno a Mediobogdum, appresi che la venuta di Brander era, almeno in apparenza, una visita breve e tardiva al fratello Donuil, dovuta semplicemente a una serie di circostanze favorevoli. Senza una guerra che lo assorbisse completamente, Brander si era ritrovato con un po' di tempo da dedicare alla novella sposa e come dono di nozze aveva deciso di accompagnarla a far visita alla sorella, che aveva sposato il re di quei Pitti stanziatisi nella penisola nota come Gallowa, in Caledonia, a soli due giorni di navigazione da Ravenglass. Morag aveva preso il posto della madre, che non aveva potuto assistere alle nozze della sorella, e ora gli sposi stavano semplicemente riaccompagnando a casa la damigella d'onore della sposa, a Gallowa. Naturalmente, dal momento che il caso lo aveva condotto così vicino a Donuil, che non vedeva da vent'anni, Brander aveva pensato di unire un piacere all'altro e di salutare finalmente non solo Donuil e sua moglie, ma anche me. Infatti, quando, anni prima, era scoppiata la guerra con l'Eire, solo qualche ora aveva impedito il nostro incontro poiché Brander era arrivato con la flotta del padre subito dopo la nostra partenza per far ritorno a Camelot. Mi resi conto immediatamente che le conseguenze politiche di una visita dell'ammiraglio delle Isole degli Scoti a un re dei Pitti, in Caledonia, soprattutto considerando che le mogli di entrambi erano sorelle, erano troppo ovvie perché valesse la pena di parlarne mentre si facevano pochi passi. Decisi dunque di rimandare la conversazione a un momento più adatto. Gli alloggiamenti assegnati a Brander e alla sua gente erano i migliori di cui potessimo disporre. Non appena vi entrammo, il gruppo di addetti alle pulizie si affrettò ad andarsene, facendo ala al nostro passaggio. Nonostante gli alloggi fossero stati preparati in tutta fretta, notai compiaciuto che i letti erano stati rifatti con coperte pulite e asciutte, il pavimento era stato spazzato e cosparso di paglia fresca ed era stato acceso il fuoco nei bracieri sistemati sulle lastre di pietra presenti in tutte le stanze. Ringraziai Ascoridoro, il responsabile di quegli alloggiamenti, che se ne andò per ultimo. Mi sorrise e annuì, dando soltanto un rapido sguardo ai miei compagni e indirizzando un muto cenno di saluto a Connor, l'unica persona che avesse riconosciuto. Chiusi la porta alle mie spalle e diedi uno sguardo alla stanza: le imposte erano state aperte e rettangoli luminosi si stagliavano sul pavimento coperto di paglia. «Bene» dissi. «Brander, l'intera ala è completamente a tua disposizione. Sistema la tua gente come meglio credi; tuttavia, se posso darti un consiglio, sarebbe forse il caso che a te e tua moglie riservassi proprio queste stanze, all'estremità dell'edificio, dal momento che sono le più spaziose. Connor di solito si sistema all'estremità opposta, in stanze che per altro hanno le stesse dimensioni. Tieni comunque presente che tra le due estremità ci sono otto alloggiamenti e che ciascuno può ospitare comodamente quattro persone, all'occorrenza anche sei.» Brander si era avvicinato al braciere per scaldarsi le mani al fuoco appena acceso, e intanto guardava la moglie, sorridendo. Era evidente che Salina trovava di suo gusto la spaziosità e la luminosità della stanza mentre Donuil indugiava accanto alla finestra, appoggiandosi alle imposte aperte. Vicino a me Connor si tolse dalle spalle il pesante mantello da viaggio e lo ripiegò sul braccio. «Bene,» borbottò, «non so gli altri, ma io ho una gran voglia di togliermi questa dannata gamba di legno e di allungarmi comodamente nella tua piscina calda, amico mio. Ho avuto un lungo inverno e niente acqua calda, e la prospettiva di crogiolarmi nelle tue terme mi ha rincuorato fin da quando siamo partiti, quasi una settimana fa.» Sorrisi e mi inchinai di nuovo davanti a Salina. «Adesso vi lasciamo riposare dalle fatiche del viaggio; intanto darò ordine che vi venga portata immediatamente dell'acqua calda.» Vidi che all'idea le brillavano gli occhi. «Qui starete comodi, credo: questi alloggi sarebbero riservati a re Athol in persona, se mai venisse a farci una visita.» Diedi uno sguardo a Brander. «A proposito, come sta il re? Spero sia in buona salute!» Non appena ebbi posto la domanda, calò il silenzio e il mio cuore fece un balzo. Notai subito il modo in cui Brander guardava Connor, i cui occhi si volsero verso Donuil, che a sua volta si irrigidì, allarmato quanto me dal gelo che improvvisamente si era diffuso nella stanza. Infine, Connor e Brander si voltarono e mi guardarono. «Naturalmente,» disse Connor, «sapevo che sarebbe stata una delle tue prime domande, tuttavia avevo sperato che tardasse ancora un po'.» Si volse verso Donuil. «Nostro padre è morto, Donuil. È morto l'estate scorsa, mentre io ero in mare diretto verso sud, per la mia ultima visita a tuo suocero Liam, nella Cambria meridionale. Quando sono arrivato qui, durante il viaggio di ritorno, era già morto e sepolto. L'ho scoperto non appena sono tornato nella sua residenza.» Il viso di Donuil aveva perso ogni colore. Si eresse in tutta la sua altezza, inspirò profondamente, poi si allontanò dalla finestra e, per reggersi in piedi, dovette appoggiarsi al tavolo. I miei occhi andavano dall'uno all'altro dei tre fratelli, cercando... che cosa? Non sarei stato capace di rispondere neppure se da quella risposta fosse dipesa la mia vita. Ciò nondimeno continuavo a osservarli attentamente. Per alcuni, interminabili istanti, nessuno di noi si mosse: sentivo le dita nervose di Tressa artigliarmi il braccio. Finalmente Donuil parlò, ma la sua voce era incerta. «Che cosa...» tossì, schiarendosi la voce. «Che cosa è accaduto? Come è morto?» Connor guardò Brander, invitandolo a parlare, e anche il fratello maggiore dovette schiarirsi la voce. «È caduto, Donuil, è caduto mentre saliva sulla mia galea. È avvenuto tutto in pochi istanti, mentre dalla passerella scendeva sul ponte: un attacco di vertigini, una nausea improvvisa, nessuno di noi sa che cosa possa essere stato, sappiamo solo che ha portato le mani alla testa, barcollando, e poi di colpo è caduto all'indietro. Io ero lì, e sono corso in suo aiuto, ma lui è scivolato dalla passerella ed è precipitato. Cadendo si è rotto la schiena.» Ci fu qualche istante di silenzio, finché Brander parlò di nuovo. «Lo abbiamo tirato fuori dall'acqua, ma aveva perso i sensi, tanto che pensavamo che fosse morto, e lo abbiamo portato a casa. Invece sopravvisse.» «Si è rotto la schiena?» «Purtroppo. Rimase completamente paralizzato, nell'assoluta impossibilità di muoversi, anche se per alcuni giorni riuscì a muovere le mani e le braccia. Il quinto giorno morì. Abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo potuto, ma non c'era modo di alleviargli il dolore.» «È riuscito... era ancora in grado di parlare?» «Sì. Per la maggior parte del tempo era fuori di sé dal dolore, però c'erano momenti in cui riusciva a parlare, soprattutto a me, ma di tanto in tanto anche ad altri. Salina rimase con noi per tutto il tempo. Talvolta restavo ore accanto a lui, e i miei polsi diventavano blu per la stretta delle sue mani mentre cercava di lottare contro il dolore che lo attanagliava. Quando morì, ringraziai gli dèi per averlo liberato da quel tormento... Ero addirittura arrivato al punto di prendere in considerazione l'idea di ucciderlo io stesso, tanto terribile e incessante era il suo strazio. Non riuscivo a sopportarlo, non ce la facevo più a starmene lì a guardarlo, senza poter far nulla.» Donuil si voltò dall'altra parte e rimase a fissare fuori dalla finestra, prostrato, le braccia inerti e le spalle massicce incurvate. «Ha parlato molto di te,» gli disse Brander, «anche perché credo che tra tutti noi tu fossi il suo orgoglio più grande. Ed è a me che ha confidato gran parte di ciò che voleva tu sapessi. Capisco benissimo che non vorrai sentirlo adesso, ma sarò pronto a dirti tutto quando te la sentirai di ascoltarmi.» Donuil tornò a guardare verso di noi. Il suo viso sembrava senza vita mentre con gli occhi cercava Salina. «Che cosa ci facevi nella residenza di mio padre?» «Era lì per discutere i termini di un'alleanza» rispose Brander per lei, ma Donuil lo interruppe. «Lascia parlare lei» disse in tono monotono. Salina guardò prima lui, poi il marito. «Ero lì per discutere con vostro padre i termini di un trattato» cominciò. «Un trattato? Una donna che discute i termini di un trattato? Le donne non si occupano di cose simili.» «Nell’Eire può darsi che sia così, ma nel mio paese è diverso. Tra la nostra gente, nel lontano nord-est, le donne combattono a fianco degli uomini, e spesso contro gli uomini. Per il mio popolo io sono un capo, e sono anche un guerriero; sappi che nella mia terra sono un re tanto quanto tuo padre lo era nella sua. Voi ci chiamate Pitti, una parola romana che deriva dalla nostra tradizione di andare in battaglia con il corpo dipinto dei colori dei nostri antichi dèi. Vostro padre cercava possedimenti sicuri nelle terre settentrionali di Tod di Gallowa e in cambio era disposto a offrire alcune concessioni. Da parte sua, Tod riteneva che una simile alleanza potesse essere vantaggiosa, ma non poteva trattare apertamente con Athol per vari motivi, non ultimo il fatto che tutti i suoi vicini si sarebbero gettati su di lui se avessero sospettato che intendeva allearsi con un re forestiero. Al contrario, come inviata di Tod, io potevo trattare liberamente con Athol, proprio perché le popolazioni meridionali sono convinte, esattamente come te, che le donne non si occupino di queste faccende e dunque non prendono neppure in considerazione l'idea che un uomo come Tod possa servirsi di una donna come ambasciatrice. Per questo mi sono recata da re Athol. E mentre mi trovavo presso di lui, re Athol è caduto.» «E quando è caduto, il trattato era già stato definito?» Donuil sembrava ben poco convinto. «No.» «Allora non c'è alcun trattato.» «No, il trattato c'è.» A quel punto Donuil aggrottò la fronte, palesemente perplesso. «Fatto da chi?» «Dal re degli Scoti.» «Ma...» Connor tagliò corto. «Donuil, il re adesso è Brander.» Cominciai a sentire il sangue che mi pulsava nelle orecchie mentre osservavo Brander in una luce completamente nuova. «Re? Brander è re?» Donuil sembrava divertito ma continuava a tenere lo sguardo fisso a terra. «Naturalmente» disse poi sommessamente. «Ora che nostro padre è morto, deve essere così.» Guardò di nuovo Brander, poi annuì ancora una volta, in segno di assenso, prima di voltarsi e di dirigersi verso la porta. Nessuno pensò di trattenerlo, ma non appena fu uscito Salina si rivolse al marito. «Amor mio, forse dovresti andare con lui. La notizia lo ha colpito troppo duramente.» Brander annuì e seguì il fratello minore; non appena fu uscito sentii Connor sospirare rumorosamente. E quando mi voltai verso di lui, stava scuotendo la testa. «So quanto duramente ha colpito me, non appena l'ho saputo» disse poi. «Ma Donuil amava il vecchio forse ancora più di noi. Me lo aspettavo.» Si fermò, poi riprese: «Mio padre Athol ci manca molto, ma anche così, le cose sono andate avanti in fretta. Merlino, tu e io dobbiamo parlare. So che hai centinaia di domande da farmi, e io ho una marea di cose da discutere con te, ma...» si fermò e si voltò verso le due donne come per scusarsi, «...ma dobbiamo essere soli. Vi prego di perdonare quella che potrebbe apparire scortesia, Salina e Tress, ma per il momento quanto devo dire a Merlino è soltanto per le orecchie di Merlino. Quello che poi deciderà di fare con queste informazioni sarà affar suo, ma io devo riferirgliele in privato. Volete scusarci? Merlino?» si rivolse di nuovo a me. «Accompagnami al mio alloggio, se non ti dispiace.» Ci volle un bel po' di tempo prima che Connor e io fossimo veramente soli. Quando arrivammo nei suoi alloggiamenti, quattro dei suoi uomini stavano già sistemando vicino alla porta casse e cassette che erano state provvisoriamente accatastate sulla strada. Mentre aspettavamo che finissero di mettere in ordine i bagagli e se ne andassero, Connor appese il suo mantello a un gancio poi posò l'elmo sulla tavola che era sistemata non lontano dalla finestra e cominciò a togliersi l'armatura. Lo aiutai ad aprire le fibbie più difficili da raggiungere, quindi spostai due sedie accanto al braciere che ormai diffondeva un piacevole tepore. Sulla tavola su cui Connor aveva posato l'elmo c'era una brocca piena dell'idromele di Shelagh e io ne versai un po' per entrambi. La notizia della morte di re Athol mi aveva scosso e avrei voluto bere forte, ma mi trattenni, ben comprendendo che avrei avuto bisogno di tutta la mia lucidità. Intuivo infatti che gran parte di ciò che stavo per udire sarebbe stato sorprendente: potevo solo sperare che non fosse anche spiacevole. Non appena andai a sedermi, portando con me i due boccali, gli uomini di Connor si avviarono verso l'uscita, mentre lo stesso Connor teneva loro aperta la porta e li ringraziava per i loro servizi. Quando se ne furono andati, richiuse accuratamente la porta e si lasciò cadere pesantemente sulla sedia accanto alla mia; si mise a grattarsi un'ascella, immerso nei suoi pensieri, poi prese l'idromele che gli offrivo, allungò le gambe verso il braciere e per qualche tempo rimase a fissare le fiamme, portando di tanto in tanto il boccale alle labbra. «Bene,» grugnì dopo un po', voltandosi finalmente verso di me, «immagino che tu abbia la testa in subbuglio. Chiedimi tutto ciò che vuoi.» «No, per il momento è meglio che io ascolti, credo. Sei tu ad avere tutte le notizie. Non c'è dubbio che anche da parte mia ci sono questioni che voglio discutere con te, ma è probabile che anche queste dipendano in qualche modo da quanto tu stesso hai da dirmi. Su, allora, che cosa c'è di tanto grave che dobbiamo parlarne da soli?» Attesi, senza dir nulla, dandogli tempo di riflettere. «Cambiamento... o cambiamenti...» Era evidente che più che rivolgersi a me stava pensando ad alta voce; tuttavia ben presto si lanciò in un discorso torrenziale come mai mi era accaduto di sentirgli fare. «Sono passati, quanto, dieci anni da quando ci siamo incontrati per la prima volta? Forse di più, anche se mi sembrano ancor meno. In questi anni ho visto tanti cambiamenti, più di quanti avessi creduto possibile. Abbiamo lasciato l'Eire, abbandonando le nostre terre; poi abbiamo trasferito tutto il nostro popolo nel nord, e con successo per giunta. A dire il vero con tanto successo che coloro che hanno scelto di restare lassù adesso si definiscono Isolani, e ne sono orgogliosi...» Tacque per qualche istante, poi sbottò con disgusto: «Vorrei poter trascorrere tutta la mia vita in mare, Merlino, poiché non fa per me trattare con gente testarda, stupida e scontenta che cambia idea continuamente, ma da quando mio padre è morto sembra proprio che io non debba fare che questo. Talvolta vorrei persino essere un contadino, senz'altra preoccupazione che non sia un buon pasto, una bella zuffa o magari accoppiarmi con qualche femmina prosperosa e disponibile...». Si interruppe, fissando il fuoco e tirandosi nervosamente i lunghi baffi. «Ma sono nato figlio di mio padre, come tutti del resto, e questo significa che devo sobbarcarmi il fardello di mio padre... Pensa a che cosa ha comportato trasferire tutta la nostra gente dall'Eire, Merlino! È stata un'impresa tremenda, che ha richiesto uno sforzo di anni, di tutta una vita, ed è stato mio padre ad averla realizzata. Oh, certo, tutti noi vi abbiamo preso parte, ma l'idea è stata sua. È stato lui che ha dovuto affrontare la sua gente e convincerla che la loro terra non era più in grado di nutrire né loro né i loro vicini, e che guerre e carestie sarebbero state inevitabili a meno che loro stessi, il suo popolo, facessero qualcosa che mai avevano fatto prima. E poi, come se questo non fosse stato abbastanza difficile, aveva dovuto persuaderli che avrebbero potuto vivere una vita migliore altrove, lontano dai campi che i loro padri avevano strappato alla foresta, lontano dalle case in cui avevano sempre vissuto, lontano dall'Eire, in una terra remota che nessuno di loro aveva mai visto. Te lo dico sinceramente, amico mio, se fosse toccato a me, non sarei mai riuscito a fare una cosa simile. Ma Athol Mac Iain c'è riuscito; così, dopo aver acceso nei loro cuori la fiamma della speranza, li ha portati lassù sani e salvi, nonostante una guerra sanguinosa contro nemici ben più numerosi delle forze di cui poteva disporre. E poi? Dopo tutto quello che era stato fatto, quando si erano già sistemati, molti ingrati, addirittura centinaia, si sono guardati attorno, hanno guardato le isole che ormai erano diventate la loro patria e hanno deciso che trasferirli era stata un'idea sbagliata! Che lì non potevano vivere! Gridavano di voler tornare indietro, ben sapendo che la vecchia patria per loro era perduta e non avrebbero più potuto viverci. Proprio così!» «E vogliono ancora tornare, ancora adesso?» «Ma no, se ne sono già andati, e da un bel po'... alla fine dello scorso anno ne sono partiti cinquecento, senza contare i bambini...» «Ma come? Sono stati semplicemente sbarcati e lasciati a morire nella loro vecchia patria?» Mi guardò rapidamente, scuro in volto. «Per chi ci hai presi? No, sono stati sbarcati sulla costa settentrionale e si sono stabiliti lì.» «E Condran e i suoi come l'hanno presa? Quello è il loro territorio, non è forse così?» «Era il loro territorio.» La sua voce era assolutamente piatta e incolore, ma il modo in cui pronunciò quelle parole, e poi si interruppe, mi fece accapponare la pelle. Per fortuna la pausa fu breve, perché quando riprese a parlare mi accorsi che avevo trattenuto il respiro. «Anche i Figli di Condran hanno visto dei cambiamenti, anche loro; perché l'ultimo viaggio di Brander ha messo la parola fine alle loro velleità. In piena estate, Brander è entrato direttamente nel loro porto e li ha colti di sorpresa. La sua azione è stata un notevole azzardo; ha rischiato il tutto per tutto per coglierli impreparati, ma c'è riuscito. Ha pianificato l'attacco con estrema cura: ha fatto uscire il grosso della loro flotta attirandola nell'inseguimento di parte della sua, e non appena erano scomparsi oltre l'orizzonte li ha colpiti nel loro insediamento principale, che si trova nell'interno, lontano dal mare, più o meno come la nostra vecchia base nel sud. Nelle prime fasi della battaglia lo stesso Condran è stato ucciso, insieme a tre dei suoi figli naturali. E questo ha tolto ogni volontà di resistenza agli altri difensori. Poi Brander ha distrutto sistematicamente i loro cantieri navali, riuscendo anche a impadronirsi di una decina di galee senza equipaggio. Non solo, ma ha voluto essere certo che tutti i loro carpentieri e maestri d'ascia fossero stati uccisi o catturati - conosceva i loro nomi e per farsi rivelare i loro spostamenti ha pagato quelli che in città erano disposti a tradirli - infine si è premurato di identificare il cadavere di ogni caduto in combattimento. Voleva avere la certezza assoluta che in futuro non avrebbero più avuto la possibilità di costruire nuove galee. Da ultimo ha incendiato tutto ciò che poteva essere bruciato, e cioè l'intera città. Fatto questo, ha lasciato parte dei nostri uomini nei punti di vedetta nelle vicinanze della foce del fiume, in modo che, al loro ritorno, le galee nemiche non potessero sospettare che fosse successo qualcosa, dopodiché si è ritirato ancora più a sud, in attesa della flotta. L'ha attaccata alla foce del fiume e l'ha distrutta appiccando il fuoco a tutte le galee catturate in precedenza e poi spingendole contro le navi nemiche. La vittoria è stata schiacciante, completa e definitiva: i Figli di Condran non usciranno più dalle loro tane.» «Che cosa è accaduto al resto della flotta di Brander, a quelle poche navi che si erano fatte inseguire dal grosso della flotta nemica?» «Nulla. Brander le aveva avviate lungo una rotta meridionale che passasse al largo, in modo che potessero superare la base di Condran senza essere viste. Una volta arrivate, avevano immediatamente fatto dietrofront e poi, ben nascoste in una piccola insenatura, avevano atteso che si presentasse una mattinata nebbiosa. Il resto della flotta di Brander puntava intanto verso nord. Quando finalmente la nebbia era arrivata, le navi erano uscite dall'insenatura e si erano dirette anch'esse verso nord, come se fossero state di ritorno da una razzia e si fossero perse nella nebbia, finendo con il farsi scoprire. A quel punto si erano date alla fuga, inseguite dagli uomini di Condran. Le nostre galee però avevano il doppio di equipaggio ed erano sempre in testa, abbastanza vicine da essere raggiungibili, ma, grazie al maggior numero di rematori, sempre troppo lontane per essere attaccate. In questo modo sono riuscite a tenere occupato il grosso della flotta per parecchi giorni, e intanto gli incendi appiccati sulla riva hanno avuto modo di divampare e poi di esaurirsi. Infine, quando la flotta di Condran ha desistito dall'inseguimento ed è tornata alla base, è stata distrutta anch'essa.» «Dio mio» mormorai. «Sembra proprio una soluzione definitiva, quasi come se si trattasse di una vendetta romana.» «Già, invece si è trattato di una vendetta dei Gaeli» disse. «Questo però è accaduto lo scorso anno. Da allora abbiamo ripopolato la costa settentrionale insediandovi alcuni dei nostri, come ti ho appena detto. Hanno le loro galee e possono difendersi da soli; in ogni caso noi non siamo lontani, qualora avessero comunque bisogno di aiuto.» «Cambiamenti, non c'è alcun dubbio. Ma terraferma, di quel trattato cui accennava Brander.» parlami della «Beh, quello è un cambiamento di tutt'altro genere.» Connor bevve un altro sorso di idromele. «Il trattato era necessario, e io spero che sia stato soltanto il primo di altri a venire. Sarà così, lo so. Mio fratello Brander potrebbe avere tutte le opportunità per diventare un re ancora più grande di Athol Mac Iain.» «Che cosa è cambiato?» «Tanto per cominciare, negli ultimi dieci anni siamo diventati un popolo di pescatori. Quello, sì, è un cambiamento che trasforma radicalmente ogni aspetto della nostra vita. Abbiamo sempre pescato, è ovvio, visto che vivevamo vicino al mare, ma ora viviamo in mezzo al mare, dunque la maggior parte del nostro cibo proviene dall'acqua. Mangiamo pesce, molluschi e carne di foca, talvolta mangiamo persino carne di balena. Ci nutriamo di volatili che sanno di pesce. La maggior parte delle nostre terre sono rocciose e non coltivabili. Le isole più grandi hanno terra buona, è vero, ma sono interamente ricoperte da foreste e fino a quando non le avremo disboscate non vi potremo seminare nulla. Coltiviamo qualche cereale, e abbiamo persino un ortaggio, il cavolo verde, che cresce bene anche in terreni poco fertili, addirittura durante l'inverno, se non fa troppo freddo. Non è la cosa più gustosa che si possa mangiare, ma è abbastanza nutriente e sano. Abbiamo centinaia di isole dove è possibile vivere, sebbene molte siano troppo piccole per ospitare insediamenti umani. Ciò non toglie che negli ultimi anni la nostra gente vi si sia stabilita e che ci resterà. Tuttavia avevamo bisogno di terra coltivabile, il che significa che dovevamo mettere piede sulla terraferma; quanto meno per avere un avamposto nell'interno, non soltanto sulla costa che per di più è rocciosa. E infatti, subito dopo il nostro arrivo e non appena la nostra gente si fu sparpagliata qua e là, questa necessità si rivelò troppo impellente perché mio padre e i suoi consiglieri potessero ignorarla. Allora le nostre barche da pesca erano poche, troppo poche. Così abbiamo mandato degli... esploratori? Qual è la parola che usi tu? Insomma, degli inviati che andassero alla ricerca di opportunità per trattare pacificamente con altri re...» «Emissari.» Mi lanciò uno sguardo tra l'interrogativo e il canzonatorio. «Se lo dici tu. Emissari. Fa un certo effetto. Bene, allora, inviammo i nostri emissari lungo la costa perché si mettessero in contatto con i re della terraferma: erano disarmati, e recavano doni, e molti tornarono indietro vivi. Uno dei primi drappelli di emissari venne in contatto con un re della regione chiamata Gallowa, un po' più a nord, un uomo di nome Tod, che si dimostrò interessato a stringere un'alleanza: era disposto a darci della terra nei suoi possedimenti settentrionali purché le nostre galee proteggessero le sue coste meridionali. Si scoprì poi che i Figli di Condran lo avevano molestato per anni. Questo re ha un grande esercito, ma un esercito non serve praticamente a nulla contro una flotta, a meno che non si venga a sapere in anticipo dove la flotta intende colpire.» Annuii. «Lo so. I Romani avevano lo stesso problema.» Improvvisamente mi venne in mente un nome. «Conosci un re che si chiama Crandal?» «No. Dovrei conoscerlo?» «Hmm. È un re dei Pitti. Credevo che, quanto meno, ne avessi sentito parlare. Mi risulta che abbia radunato un esercito e che ora stia marciando verso sud, direttamente nella Britannia, su a nordest.» Connor scosse la testa. «Non abbiamo fatto grandi tentativi di penetrare così nell'interno. Tutta l'area interna è un miscuglio di tribù diverse, in guerra le une contro le altre, e divise da catene montuose. Qualsiasi tentativo di andarvi è una follia, persino per i Pitti, dal momento che vuol dire scontrarsi con sempre nuovi nemici, a ogni pie’ sospinto. Peggio che nell'Eire. Abbiamo sentito parlare di una grande valle che divide tutto il territorio da un mare all'altro, con montagne sia a nord sia a sud, ma ci risulta che sia densamente abitata e che le tribù siano bellicose.» «Allora, se le cose stanno così...» mi interruppi, perplesso. «Se la situazione è confusa come dici, con continue guerre...» «Razzie» Connor mi interruppe. «Sono più razzie che guerre. Nessun grande esercito, nessuna campagna militare, soltanto una razzia dopo l'altra, senza interruzione.» «Ma se le cose stanno così, come hanno fatto Salina e la sorella a essere in rapporti con quel re, quel Tod di cui mi parlavi? Hai detto che viene da Orcenay - era questo il nome? - nell'estremo nord-est.» «Certo, ma lei è come noi, è un'isolana. La sua gente ha barche, delle specie di galee, e si sposta via mare.» «Parlami di questa gente. Che cosa sai di loro?» Si strinse nelle spalle. «Non molto, ma so che non sono della stessa razza di coloro che abitano sulla terraferma. Anzi, sono molto diversi. Stando a quanto ci ha detto Salina, non sono neppure molto numerosi, in cambio però sono fieri e bellicosi.» Anticipò quello che stavo per chiedergli. «E Salina è un capo; comanda su uno dei due arcipelaghi in cui si sono stabiliti. Suo fratello Lot è il re dell'intero territorio, ma sulle sue isole è Salina che di fatto esercita il potere.» «Lot? Hai detto Lot? Spero proprio che non sia parente del tuo ex cognato della Cornovaglia.» Connor scoppiò in una risata fragorosa. «Sai che me ne ero quasi dimenticato? No, nessuna parentela. A dire la verità, non si chiama neppure Lot. Quello è il nome che usano quando hanno a che fare con gli stranieri; il suo nome vero è impronunciabile, una sorta di grugnito, una serie di suoni simili a scoppi di tosse che nessuna lingua umana riesce a emettere. Ogni volta che sento qualcuno pronunciare quel nome, ho l'impressione che sia stato colto da conati di vomito e mi avvolgo nel mantello per non rischiare di venire lordato. Anche il nome di Salina è qualcosa del genere; ma lei si è scelta un nome romano per trattare con quelli che lei chiama "stranieri", e cioè noi. Comunque sia, qualche anno fa la sorella di Salina ha sposato Tod di Gallowa e tra i due regni è in atto una sorta di commercio. Per lo più lana di pecora; almeno questo è quello che mandano i sudditi di Lot, che cosa ricevano in cambio dalla gente di Gallowa non lo so. Quando i nostri emissarii sono arrivati per la prima volta nel regno di Tod, Salina era appena giunta con quattro delle sue navi. Prese parte alle trattative e quando fu chiaro che Tod aveva dei problemi con alcuni dei suoi capi, che non sapevano nulla di noi e pertanto non si fidavano, si offrì di accompagnarci, per trattare con nostro padre per conto del cognato. Quella prima visita portò a un viaggio di nostro padre sulla terraferma, verso la fine di quello stesso anno, per incontrarsi con Tod e con i suoi capi e consiglieri. Gli incontri ebbero successo, ma ci vollero più di due anni prima che il trattato fosse siglato.» Si interruppe, ricordando. «È stato messo a punto la primavera scorsa, proprio quando la flotta di Condran stava conducendo pesanti incursioni contro le coste di Tod. Improvvisamente Tod e i suoi dovettero rendersi conto che sistemare la faccenda poteva essere un'idea eccellente. E non appena fu concluso l'accordo, Brander partì per farla finita una volta per tutte con Condran. Naturalmente all'epoca non avevamo fatto parola dell'effettiva portata della distruzione già inflitta a Condran: sarebbe stato folle annunciare l'eliminazione del motivo principale dell'alleanza. Tra parentesi, la distruzione delle forze di Condran non cambia significativamente la sostanza dell'accordo che promette la protezione della nostra flotta in cambio del diritto di coltivare le terre a nord dei possedimenti di Tod, terre che per altro sono incolte e non utilizzate.» Volevo fargli ancora una domanda: «Hai detto che ti aspetti altri trattati di questo tipo?». «Sì, abbiamo bisogno di nuovi territori sulla terraferma. Adesso Brander sta trattando con altri quattro re, che regnano ancora più a nord, sebbene loro stessi si definiscano soltanto dei capi, e credo proprio che avrà successo; se la cava molto bene con quel genere di trattative. Poi, una volta che avremo sistemato i nostri in un territorio fertile, potremo lasciare che la loro prosperità dipenda dal tempo e dalla natura umana. Tutto lascia pensare che possiamo davvero sperare di avere successo. Adesso che abbiamo sterminato Condran, per la prima volta dopo molti anni siamo finalmente in pace. È questo il motivo per cui Brander ha deciso di sposarsi e poi di mettersi in viaggio con Salina e con la ragazza. Quando partiremo di qui, loro andranno a far visita a Tod.» «E tu, dove andrai?» «A pattugliare. Adesso che Brander è re, è costretto a restare a terra. L'unico ammiraglio adesso sono io.» A quel punto gli parlai della mia decisione di tornare a sud, a Camelot, prima della fine del mese, e di abbandonare la nostra dimora provvisoria qui a Mediobogdum; gli chiesi anche se fosse disposto a prenderci ancora una volta a bordo delle sue navi per portarci a sud. Mi ascoltò in silenzio, senza interrompermi, ma quando ebbi finito di parlare fece una smorfia. «In circostanze normali avrei detto sì, ma ora mi hai fatto venire in mente quello che stavo per dirti quando mi hai distratto con tutti quei discorsi di trattati e alleanze. Ti ricordi della grande nave che vedesti in quella città sulla costa, la prima volta che incontrasti Feargus?» «Certo che lo ricordo, la bireme romana che i Berberi avevano fatto arrivare per portar via i marmi dagli edifici di Glevum. Che c'entra?» «Liam il Gobbo è arrivato nelle isole poco prima che partissimo per venire qui. Ha fatto il viaggio durante l'inverno, e con soli tre compagni, preferendo correre il rischio di imbattersi in qualche burrasca e di naufragare piuttosto che restare dov'era, sulla costa tra Camelot e la Cambria. Lui sostiene che gli invasori che vengono dalla Cornovaglia di quelle navi ne hanno due e che se ne servono per facilitare gli spostamenti delle truppe. Navi gigantesche, dice Liam, con svariati ordini di remi e vele enormi. Dice anche che hanno torri di legno a più piani, a poppa e a prua, su cui combattono soldati e arcieri; una avrebbe persino delle macchine da guerra sistemate a poppa... catapulte, l'avresti mai creduto? E hanno lunghi rostri di metallo che spuntano dalla prua, subito sotto la linea di galleggiamento, per affondare le navi nemiche. Al confronto le nostre galee sembrano barchette, sostiene Liam.» «Ironhair possiede questa roba?» «No, non ho detto questo. Di Ironhair, Liam il Gobbo non sa nulla. Ha semplicemente detto che le truppe che stanno invadendo la Cambria hanno due di queste navi incredibili e che se ne servono per fare da supporto al loro esercito.» «Già, il che vuol dire che sono di Ironhair.» Mi resi conto di aver parlato con indifferenza. In realtà le sue parole mi avevano sbalordito, ma lo stupore era stato immediatamente seguito dalla sgradevole consapevolezza che ciò che aveva detto era la pura verità. Già in passato Ironhair aveva dimostrato di non essere uno sciocco e di sapere bene, proprio come il suo predecessore Lot di Cornovaglia, quanto fosse importante il denaro piazzato al momento giusto e con larghezza. Già il fatto stesso che avesse seguito l'esempio di Lot e si fosse procurato un esercito di mercenari promettendo loro un buon bottino lo confermava, ma a questo punto era evidente che nel suo piano di alleanze era andato ben oltre e che con quelle due biremi si era assicurato una notevole superiorità, almeno sul mare. Guardai Connor con più attenzione. «Sei in partenza per il sud, non è così?» «Ho preso in considerazione l'idea.» Il suo tono voleva dire: «Sì, sto partendo per il sud». «Allora ci prenderai con te?» «No. Questa volta no. È troppo pericoloso; avete donne e bambini, tra l'altro uno di loro è mio nipote, Artù. Anche soltanto la sua presenza a bordo renderebbe questo viaggio troppo pericoloso.» «Ma...» Mi zittì con una gran pacca sulla spalla. «Siediti, Merlino, e pensa che cosa c'è in ballo adesso!» Ero furioso, offeso per quel secco rifiuto. Parole dure e sprezzanti mi venivano alle labbra, e riuscivo a trattenermi a stento. Eppure sapevo che lui aveva ragione e io avevo torto. Finalmente riuscii a dominarmi e mi sedetti, rendendomi conto che Connor aveva molte altre cose da dirmi e ben sapendo che in mare era lui a comandare, non io. Mi guardava con gli occhi socchiusi e quando mi fui seduto riprese il discorso, parlando francamente e con grande calma. «Merlino, non ho la più pallida idea di che cosa troveremo quando arriveremo laggiù, ma l'ultima cosa al mondo di cui potrei aver bisogno sarebbe di avere passeggeri a bordo, peggio ancora donne e bambini. Potrei doppiare un promontorio e di colpo trovarmi costretto a combattere. Stiamo andando a sud, dritti nel bel mezzo di una guerra e, te lo dico francamente, non ho alcun piano, alcuno stratagemma da mettere in atto per affrontare questi... aggeggi, queste biremi. Potrei essere costretto a fare marcia indietro e tagliare la corda. Magari potrei non incontrarle affatto. Oppure potrei non avere la possibilità di avvicinarmi alla costa, per non parlare poi di trovare il posto adatto e il tempo sufficiente per sbarcare te e i tuoi. E a quel punto che cosa fareste? Sareste bloccati a bordo della mia nave, in navigazione verso nord-ovest, senza alcun modo di tornare a Camelot. Molto meglio che torniate per via terra, insieme alla vostra guarnigione. In quel modo la tua gente viaggerà sicura e ben protetta, e tu potrai vedere un territorio che ancora non conosci.» Storse la bocca in un breve, ironico sorriso. «È probabile che arriviate a Camelot ben prima di quanto potrei portarvici io, visto che le rotte saranno assai affollate.» Rimasi a guardarlo, confuso e perplesso, con la spiacevole sensazione che qualcosa mi sfuggisse. Finalmente mi resi conto di cosa fosse: e per giunta era anche preoccupante. Se queste biremi spaventavano a tal punto Liam il Gobbo da averlo spinto ad affrontare i non trascurabili rischi di una navigazione invernale su di una piccola barca, era ovvio che rappresentavano una minaccia anche per Camelot, che si trovava a soli due giorni di marcia dalla fattoria di Liam. «Liam ti ha detto se ha avuto la possibilità di avvisare Camelot della presenza di queste biremi?» chiesi. «Non è stato necessario. Con Liam c'era qualcuno dei vostri quando, durante un normale pattugliamento, hanno visto questi aggeggi avvicinarsi alla costa. Avrebbero voluto che Liam andasse con loro mentre tornavano di gran carriera a Camelot per mettere in guardia la Colonia, ma per qualche ragione lui ha preferito partire per il nord e affrontare i rischi delle burrasche invernali. In ogni caso a Camelot sanno. Immagino anzi che ormai abbiano già ultimato tutti i preparativi di difesa.» A quel punto compresi finalmente che cosa, nelle parole di Connor, mi avesse lasciato perplesso. «Ma Liam era l'ultimo dei vostri a essere rimasto laggiù, non è così?» Annuì. «E allora perché vuoi tornarci? Adesso non hai più alcun interesse da quelle parti.» Storse la bocca in un sorriso forzato. «Che ne è della gratitudine nei confronti dei tuoi, di te e della gente della Cambria che ci ha permesso di usare la loro terra?» «Ammirevole, ma non necessaria. Che cosa avrebbe da guadagnare la tua gente da un simile viaggio? Dio sa che avresti molto da perdere se ti scontrassi con queste navi.» «Voglio catturarne una.» Parlò con voce così bassa che udii appena le sue parole e non fui sicuro di aver capito bene. «Vuoi che cosa?» «Mi hai sentito benissimo. Voglio una di quelle due biremi, almeno una. Tutte e due, se ci riesco.» «Sei diventato matto? Tu non hai mai visto roba del genere, ma io sì. Probabilmente due di loro potrebbero sconfiggere tutta la tua flotta, soltanto unendo la loro potenza e la loro distruttività. Le tue galee finirebbero distrutte e affondate prima ancora di riuscire ad avvicinarsi. Le catapulte di cui parlavi servono per gettare olio bollente contro le vele e il sartiame delle navi nemiche. Tu sai bene, Connor, che cosa fa il fuoco alle navi: sei stato proprio tu ad avermelo descritto, sulle mura di Ravengkss; e mi hai appena parlato di come Brander abbia distrutto la flotta di Condran usando proprio questa tecnica. In ogni caso, anche senza fuoco, i rostri di prua sfascerebbero facilmente persino la più grande delle tue galee subito sotto la linea di galleggiamento, dopodiché il peso della parte anteriore della nave, con la spinta di centinaia di remi, si abbatterebbe sulla tua galea schiacciandola come un uovo. Gli arcieri provvederebbero infine a massacrare quelli dei tuoi uomini che non fossero già annegati. No, Connor, se ti sta a cuore il bene dei tuoi uomini e la salvezza delle tue navi, togliti dalla testa di attaccare una di queste macchine da guerra. Sono state costruite dai Romani, amico mio, e progettate dai Romani per essere invincibili nel loro elemento.» «Già, Liam mi ha detto qualcosa del genere, anche se, a differenza di te, non sapeva esattamente come funzionassero. Ma tu come fai a saperlo?» «L'ho imparato dai libri. L'ho semplicemente letto. La flotta romana è stata padrona dei mari per centinaia di anni, e l'idea geniale dei Romani è stata proprio quella di portare anche sui mari la loro invincibile fanteria. Le loro navi da guerra sono state progettate come piattaforme galleggianti sulle quali i soldati potessero combattere come sulla terraferma...» Alzò una mano come per impedirmi di dire altro. «Sono lucido quanto te, Merlino. Non ho alcuna intenzione di andare incontro alla morte né di udire il fragore delle mie galee mentre vengono distrutte.» «E allora?» «Aspetterò. Devono pure attraccare, una volta o l'altra, queste bestiacce. Navigano come tutte le altre navi, e vengono utilizzate per inviare i rifornimenti alle truppe che combattono sulla terraferma. Coloro che abitano nella Cambria di Pendragon non hanno flotta, pertanto queste navi non devono fronteggiare nessuna resistenza. Tutto lascia pensare che siano utilizzate più o meno come scorta alle galee più piccole della flotta, facendo la spola tra i porti meridionali e la loro base nella Cambria; quando poi arrivano a destinazione attraccano per essere scaricate. Ed è a quel punto che le prenderemo.» Mi misi a ridere fragorosamente, per manifestare la mia incredulità. «Così avresti intenzione di salire a bordo e prendere una nave come questa? Non pensi che sarà ben custodita?» «Sarà certamente custodita, caro cognato, ma custodita quanto? Pensaci un attimo. Queste biremi non hanno eguali sul mare, per essere manovrate come si deve richiedono una esperienza non indifferente, e quando attraccano vengono ormeggiate in mezzo ad altre navi della loro stessa flotta. Saranno custodite, certamente, ma tra gli uomini dell'equipaggio, chi mai potrebbe farsi venire in mente che possa esserci qualcuno tanto matto da pensare di rubare una di queste navi mentre è agli ormeggi nel suo porto?» «Come pensi di riuscire ad avvicinarti?» «Come fossimo mercenari, Merlino. Saremo in mezzo a loro, nel loro stesso accampamento. Perché dovrebbero sospettare qualcosa? Noi non siamo loro nemici. A dire la verità, loro non sapranno né chi siamo né da dove veniamo. Saremo semplicemente dei mercenari come tutti gli altri.» «Dolce Gesù! Che cosa succederà se riuscite davvero a salire a bordo, superando le guardie? Come farete a portare fuori la bireme?» «Oh, bella, la porteremo al largo con la forza dei remi! Se possiamo essere mercenari sulla terraferma, perché non potremmo esserlo anche in mare?» Soltanto a quel punto mi resi conto che Connor stava improvvisando, mettendo a punto il piano a mano a mano che parlava. «Chi potrà mai sapere che non siamo dei loro? Sono convinti di non avere nemici sul mare, o per lo meno, io credo che siano convinti di non averne.» Aveva le sopracciglia aggrottate per la velocità e la concentrazione dei suoi pensieri. «Un piccolo numero di galee, con un equipaggio superiore alla norma, il cui arrivo coinciderà con il nostro attacco... Ma galee che siano di ritorno... galee che abbiano lasciato quello stesso porto il giorno precedente... a nessuno verrà in mente di chiedere loro perché sono arrivate, se penseranno che siano semplicemente di ritorno. E quando sarà il momento giusto, colpiremo. Prendiamo la nave e vi facciamo salire l'equipaggio delle galee passando dal lato che guarda verso il mare. Funzionerà, Merlino, deve funzionare!» Si batté le mani sulle ginocchia e si alzò, improvvisamente deciso e pronto ad agire. «Quando partirai?» Quasi quasi mi aspettavo che partisse in quello stesso istante. «Tra una settimana o giù di lì, non di più.» Si diresse zoppicando verso la finestra, con la gamba di legno che a ogni passo spostava la paglia che ricopriva il pavimento, e aprì completamente le imposte, allungando il collo per guardare fuori e poi in su, verso il cielo. Fui sorpreso di vedere che il sole era ancora alto. A dire la verità avevo l'impressione che fossimo rimasti chiusi lì dentro per ore. «C'è niente da mangiare da queste parti?» chiese. «Sto morendo di fame.» Non potei fare a meno di sorridere. «Nelle cucine troveremo qualcosa di freddo, ma fino al momento della cena di caldo non potrai avere nulla.» «Vada per qualcosa di freddo, purché sia subito.» Mentre ci dirigevamo verso le cucine, nell'ala adibita a refettorio, la mia mente cercava di tener dietro a tutto quello che avevamo appena discusso e avevo la sensazione che gran parte della settimana seguente sarebbe stata dedicata a mettere a punto lo stratagemma con cui l'ammiraglio sperava di ingrandire la sua flotta. II. Verso la fine della settimana le giornate si erano fatte calde quasi come in estate e in cielo non c'era una nuvola. L'erba nuova spuntava dovunque e i primi fiori di montagna, che in circostanze normali non sarebbero comparsi per almeno un altro mese, fecero capolino in fretta e sbocciarono in una piena fioritura tanto che tutt'attorno alle nostre mura i fianchi delle colline furono ben presto punteggiati di piccole macchie dai colori brillanti: giallo, blu e bianco. Ai lati della strada, sotto gli alberi al limite della foresta, spuntarono fitte chiazze di vegetazione che finirono per ricoprire di un verde intenso tutti gli spazi liberi: nel giro di poche settimane dal forte sottostante l'intera collina apparve come velata da una nuvola purpurea di campanule che inondavano l'aria con il loro profumo. All'interno del forte la vita continuava febbrile, con una vivacità resa ancora più intensa dalla mitezza del clima. La partenza, che Connor aveva previsto per la settimana seguente, fu posticipata di altri sette giorni e intanto venivano messi a punto piani e preparativi in vista dell'imminente viaggio verso sud. L'ammiraglio trascorreva la maggior parte del suo tempo lavorando insieme a Feargus e al grosso Logan, i suoi capitani più fidati; tuttavia ai loro conciliaboli partecipava spesso anche Brander desideroso di mettere a disposizione la propria esperienza con un entusiasmo che appariva ancora più trascinante, ammesso che fosse possibile, di quello dello stesso Connor. Certo, Brander era ormai diventato re degli Scoti, e come tale doveva essere legato alla terraferma, ma dentro di sé si sentiva ancora e sempre l'ammiraglio Brander, a tal punto che i suoi occhi brillavano all'idea di impossessarsi di una bireme romana, o magari due, da aggiungere alla propria flotta. Spesso mi univo a loro, ascoltando le loro discussioni, e parecchie volte dovetti sforzarmi di restare in silenzio e di mettere a tacere le mie perplessità, ricordando a me stesso che i due fratelli sapevano benissimo quanto il successo di tutta l'impresa dipendesse dalla disposizione della flotta nemica nel preciso momento in cui Connor sarebbe arrivato nelle acque della Cambria. Entrambi accettavano i rischi, l'alto grado di imprevedibilità della sorte e l'evidente impossibilità di condizionare il fato e gli dèi della guerra; e in questa loro accettazione si sforzavano di prevedere tutta la gamma di probabilità cui potevano trovarsi di fronte e nel contempo di mettere a punto la strategia più semplice e flessibile di cui fossero capaci. Mentre i marinai erano impegnati nel definire i dettagli della loro grande impresa, anch'io avevo molto da fare. Avevamo deciso di tornare a Camelot in primavera, e, a quel punto, la partenza non poteva più essere rimandata. La primavera era arrivata, ed era arrivata in anticipo, e nonostante i lunghi mesi di sistematici preparativi, non eravamo ancora pronti. Lavoravo quasi tutti i giorni, per tutto il giorno e spesso anche per parte della notte, obbligando ciascuno di noi a rivedere e ricontrollare più e più volte le migliaia di cose che erano già state riviste e ricontrollate, impacchettate, caricate e preparate per la partenza. In tutti questi preparativi Rufio fu tra coloro che mi diedero l'aiuto più grande. Lavorava ancora più di me. La guarigione dalle spaventose ferite inflittegli dall'orso era infatti stata più rapida e completa di quanto avessimo osato sperare. Ma Rufio non avrebbe mai più potuto combattere. Le terribili incisioni, sulla spalla e sul braccio, procurate dagli artigli della belva avevano fatto infezione e, se prima di morire il nostro abile medico e chirurgo Lucano era riuscito a impedire che il veleno mortale dalle ferite si diffondesse in tutto il corpo, il danno arrecato al braccio sinistro era stato irreversibile, tanto che l'arto sembrava ora un ramo rinsecchito piuttosto che un braccio umano. Il suo morale tuttavia non si era lasciato abbattere e nel giro di due mesi le sue gambe erano abbastanza salde da consentirgli di camminare quasi senza zoppicare. La prima richiesta di Rufio era stata che gli fossero affidati compiti che potesse portare a termine da solo, senza bisogno di aiuto. Fu a quel punto che mi venne l'idea di far sparire tutte le tracce visibili della nostra permanenza al forte. Mediobogdum era rimasto disabitato per duecento anni, o almeno così credevamo. Se fossimo riusciti a fare in modo che nessuno si accorgesse che dopo duecento anni era stato nuovamente abitato, era probabile che a nessuno venisse in mente di occuparlo ancora. In questo caso, qualora in un futuro più o meno lontano avessimo deciso di tornarvi, avremmo potuto farlo senza rischiare di trovarvi altri. Rufio pensò che si trattasse di un'ottima idea, e prese molto sul serio l'incarico che gli avevo affidato, tanto che, nelle settimane e nei mesi seguenti, una volta o l'altra tutti al forte dovettero lavorare ai suoi ordini facendo sparire qualsiasi traccia di una presenza umana recente. Per esempio, chiudemmo le terme, sistemando delle assi davanti alle porte - era così che si presentavano quando eravamo arrivati - poi bloccammo con cura l'ingresso delle fornaci proteggendole come meglio potemmo per evitare che potessero essere danneggiate e finire con l'andare completamente in rovina. Poi arrivò finalmente il giorno in cui compresi che eravamo pronti e che potevamo fissare la data della partenza. Tuttavia i nostri ospiti erano ancora immersi fino al collo nella loro pianificazione dell'attacco e questo mi poneva di fronte a un dilemma: dovevo far loro sapere che da parte nostra eravamo pronti a lasciare Mediobogdum e che saremmo dovuti partire immediatamente? Le leggi dell'ospitalità imponevano che non facessi nulla che potesse essere interpretato come un invito ad andarsene, eppure mi rendevo pienamente conto dell'urgenza di raggiungere Camelot, dove Ambrogio attendeva con ansia il nostro arrivo. Fortunatamente, né Connor né suo fratello erano così ciechi come avevo cominciato a temere che fossero. Infatti, quello stesso pomeriggio, quando li raggiunsi negli alloggiamenti di Brander, mi stavano aspettando per dirmi che sarebbero partiti per Ravenglass quando noi avessimo fissato la data della nostra partenza per Camelot. Dichiarai che saremmo partiti dopo tre giorni: speravo così di lasciare loro ancora un po' di tempo per concludere le loro faccende a Mediobogdum. Quello stesso pomeriggio, sul tardi, mentre me ne stavo nelle mie stanze impegnato a controllare un'ultima volta di non aver dimenticato nulla e a esaminare il lungo elenco che era stato preparato da Hector e dai suoi segretari, chiamai Donuil e gli chiesi se poteva andare a cercare Artù per dirgli di venire da me. Andò subito e io tornai al mio lavoro, immergendomi di nuovo nei miei elenchi e apportandovi annotazioni, finché mi resi conto che la stanza si stava facendo buia e che Artù non era ancora arrivato. Quando avevo chiesto a Donuil di andarlo a cercare era tardo pomeriggio, ma dalla mia finestra giungeva ancora abbastanza luce da consentirmi di leggere: ora invece era quasi buio. Preoccupato, mi alzai dal mio tavolo di lavoro e uscii proprio mentre Donuil stava tornando. Aveva cercato per tutto il forte senza trovare Artù, mi disse, e così aveva incaricato Gwin, Bedwyr e Ghilly di vedere se era uscito fuori dalle mura e di fargli sapere che doveva rientrare subito. Era meglio, aveva pensato, se mandava direttamente i ragazzi, che conoscevano bene i loro rifugi preferiti. Ma tutto questo era accaduto un'ora prima e da allora non li aveva più visti. Che avesse dovuto mandare i ragazzi già di per sé era una rivelazione inquietante che mi fece rabbrividire: per anni i quattro erano stati indivisibili; dove c'era uno, si poteva essere certi di trovare anche gli altri poco lontano, e questa era sempre stata una delle più ovvie realtà della vita. Fino a oggi, però. In nome di Cristo, mi chiedevo, che cosa stava facendo Artù? Dove mai poteva essersi andato a cacciare, da solo, senza i suoi inseparabili amici? E la mia mente non faceva che passare in rassegna spiacevoli eventualità. Si era forse fatto male? Era in pericolo, si era perso o giaceva ferito in qualche zona impervia al di fuori delle mura? Improvvisamente il ricordo di Rufio, sanguinante dopo essere stato aggredito dall'orso nella foresta, mi fece gelare il sangue. Ma mentre questi spaventosi pensieri mi turbinavano nella mente, vidi Artù correre verso di me, dopo aver svoltato l'angolo della strada che tagliava a metà il forte. Era rosso in faccia e senza fiato. Mi limitai a guardarlo con palese disapprovazione mentre si avvicinava, ansando come se avesse corso per miglia. «Mi dispiace, Cay» ansimò. «Non ti avrei fatto aspettare se avessi saputo che mi stavi cercando. Sono venuto non appena Bedwyr mi ha trovato.» Non dissi nulla e il suo viso si fece ancora più rosso. «Ero fuori sulla collina, subito sotto le mura. Non pensavo che potessi avere bisogno di me.» «Non pensavi proprio a nulla, questo è evidente.» Mi rendevo conto di quanto tale comportamento fosse insolito per lui, eppure non potevo permettere che la passasse liscia, senza almeno una reprimenda. «Sai bene che non devi sparire senza informare qualcuno di dove intendi andare. Ti sei dimenticato così presto di quello che è capitato a Rufio, e dei guai che ha passato?» A quel punto abbassò la testa, pieno di vergogna e senza tentare di difendersi. «Allora? Non hai nient'altro da dire?» Inspirò profondamente, poi scosse la testa, continuando a tenere gli occhi bassi: «No, nient'altro, se non che mi dispiace». Da parte mia, mi restava ben poco da dire. Il ragazzo non aveva fatto niente di grave. Non si era neppure comportato male; tutto quello che aveva fatto era stato uscire dal forte da solo. Non era dunque il caso di punirlo ulteriormente, dal momento che di una cosa mi rendevo conto benissimo: il suo viso arrossato e la sua aria colpevole lasciavano chiaramente capire che considerava quelle domande una sorta di castigo. Ringraziai Donuil, che nel frattempo era rimasto al mio fianco, e lo congedai prima di accompagnare il ragazzo nei miei alloggiamenti. Una volta entrati, rimase in mezzo alla stanza finché non gli feci cenno di sedersi, poi mi sedetti anch'io, proprio davanti a lui. «So che è raro che io ti cerchi a quest'ora del pomeriggio, dunque non c'era ragione perché ti sentissi in dovere di essere reperibile, assolutamente nessuna. Mi sono preoccupato quando ho scoperto che eri andato fuori da solo e non si riusciva a trovarti, questo è tutto. Se ci pensi ti renderai conto anche tu che è del tutto insolito, oltre che terribilmente pericoloso e sciocco, dal momento che i boschi e le colline sono pieni di animali feroci che ci considerano degli intrusi nel loro territorio. Che cosa stavi facendo?» Non appena ebbi rivolto la domanda gli feci subito cenno di tacere, avendo visto l'allarme che traspariva dai suoi grandi occhi dorati. «Non è il caso che tu mi risponda. In realtà non è cosa che mi riguardi, ma pura e semplice curiosità.» Invece rispose. «Ero qui vicino, Cay, proprio sotto le mura. Ero semplicemente... in un posto diverso. Bed mi ha trovato per caso, mentre andava a raggiungere Gwin e Ghilly. Non appena mi ha detto che mi stavi cercando sono corso subito qui. Ma non sono mai stato in pericolo e mai a una distanza che non fosse a portata di voce rispetto alle guardie che sorvegliano le mura.» «Hmm» borbottai. «Bene, questo mi consola un po', se non altro. Ora ascoltami: ho deciso che tra tre giorni partiremo per Camelot. Viaggeremo per via terra, insieme alla guarnigione che torna indietro, poiché Connor ha altri impegni e ritiene che andare con le sue galee sia troppo pericoloso di questi tempi, con le armate di Ironhair che cercano di invadere la Cambria dal mare e dunque incrociano avanti e indietro lungo l'unica rotta che possiamo percorrere.» Mi interruppi per vedere se mi seguiva attentamente. I suoi occhi erano fissi sulle mie labbra, in attesa che riprendessi il discorso. «Dunque,» continuai «finalmente adesso è tutto pronto, anche se stavo cominciando a temere che non lo sarebbe stato mai! Voglio inoltre che tu vada a Ravenglass, per portare un mio messaggio a Derek. Partirai domani mattina, non appena avrai fatto colazione. Puoi portare gli altri con te, se vuoi, ma lungo la strada non avrete tempo per giocare. Ho bisogno che tu arrivi a Ravenglass il più presto possibile, che trovi Derek e che poi gli riferisca il mio messaggio in privato, senza che nessuno senta. È chiaro?» «Sì. Che cosa devo dirgli?» «Semplici notizie, per la maggior parte. Gli dirai che Connor e i suoi partiranno domani, in tarda mattinata, per Ravenglass e che noi lasceremo Mediobogdum per tornare a Camelot il giorno dopo... Che cosa c'è che non va? Non ti senti bene?» Di colpo il suo viso si era fatto cinereo, ma quando gli chiesi se si sentiva male si raddrizzò e scosse la testa, stringendo i denti. «No! Sono...» A quel punto batté le palpebre, spalancando gli occhi, poi le batté ancora e scosse la testa come quando ci si sveglia da un sogno. «Non è nulla, Cay.» La sua voce, leggermente appannata, dava l'impressione che fosse intontito. Mi alzai, spaventato, ma Artù mi fermò alzando una mano e scuotendo la testa. «È stato... un capogiro improvviso, nient'altro.» Rabbrividì, poi si raddrizzò, facendo sforzi evidenti per riprendersi. «Forse è stata la corsa» continuò con voce più normale. Lo osservai in silenzio per parecchi minuti, poi pensai di offrirgli qualcosa da bere. Rifiutò decisamente, anche se non in malo modo, e la voce tornò a essere normale. Notai che anche le guance stavano riprendendo un po' di colore. «No, Cay, grazie, ora mi sento abbastanza bene. È stato un malessere momentaneo, ma adesso è passato. Mi stavi parlando del messaggio per Derek. Continua per favore. Perché dovrebbe essere tanto segreto? Niente di quanto hai detto lo farebbe sembrare necessario.» Rassicurato dal suo tono calmo e tranquillo, annuii. «In apparenza, può sembrare così, ma credo comunque che sia il caso quanto meno di usare molta circospezione. Quando ho parlato per la prima volta con Derek della nostra decisione di partire di qui e di tornare a casa, ha detto che sarebbe venuto anche lui e avrebbe lasciato il suo regno al figlio maggiore, Owen. Allora è sembrato decisamente intenzionato, ma poi non ne ha più fatto parola. Non so se ha cambiato idea e ha deciso di restare a Ravenglass, o se sta semplicemente aspettando che gli dica di unirsi a noi. Comunque sia, domani tu gli porterai il messaggio, semplicemente e senza aggiungere altro, ma lo comunicherai a lui soltanto, in privato, perché, anche se hai intenzione di partire con noi, è pur sempre il re di Ravenglass. È a lui solo che tocca annunciare la partenza. Se invece ha cambiato idea, potrebbe non aver piacere che si sappia che aveva preso in considerazione l'idea di partire. Capisci?» Il ragazzo annuì. «Bene. Artù, come ti senti adesso?» Annuì di nuovo, aggrottando leggermente le ciglia. «Sto benissimo. È tutto a posto. Posso andare adesso?» «Sì, naturalmente. Partirai domani mattina, non appena sarà giorno, e conto che tu sia di ritorno prima di notte.» Si alzò e fece per uscire, ma lo fermai prima che avesse raggiunto la porta. «Porterai con te Bedwyr e gli altri?» «Non so.» Esitò, con la mano sul chiavistello. «Potrei fermarmi a Ravenglass domani sera, e tornare a casa il mattino seguente?» «No, Artù, non questa volta. È il giorno prima della partenza ed è necessario che tu sia qui. Ci sarà bisogno di tutti, tutte le braccia disponibili dovranno essere impiegate a imballare e caricare. Il giorno dopo ancora, dobbiamo non solo essere fuori di qui ma è indispensabile che abbiamo superato il passo un bel po' prima di mezzogiorno se vogliamo arrivare oltre Galava prima di notte.» Il cipiglio si fece più pronunciato, facendo intuire un'aria di sfida che mi lasciò perplesso. Le sue parole, poi, mi tolsero ogni dubbio. «Ma che farà re Derek? Se deve venire con noi, arriverà il giorno seguente. Non potrei tornare indietro con lui?» Mi voltai lentamente per guardarlo dritto negli occhi, ed era la prima volta che sentivo il bisogno di imporre la disciplina al ragazzo. «Che cosa?» dissi, mantenendo un tono freddo e distaccato ma con una punta di asprezza. «E lasciare che il lavoro che toccherebbe a te sia fatto da altri mentre tu te la spassi a Ravenglass? Mi sorprende che tu possa anche soltanto pensare di chiedere una cosa del genere. No, tornerai domani pomeriggio, seguirai le mie istruzioni e arriverai prima di notte. È abbastanza chiaro?» Annuì, ma sul suo viso si leggeva chiaramente il disappunto, quasi la sfida, così inasprii il tono. «Bene, allora ci siamo capiti perfettamente. Per altro, vedrai che se re Derek ha deciso di venire con noi, sarà pronto in fretta e verrà qui con te domani. Sono mesi che conosce la nostra intenzione di partire non appena possibile. Al contrario, se invece ha intenzione di restare, verrà lo stesso con te per salutarci. Dunque la risposta alle due domande, in verità inopportune, è no e sì. No, non puoi fermarti a Ravenglass; e sì, puoi tornare indietro con Derek. Chiaro? Bene. È tutto, ragazzo. Adesso puoi andare.» Rimase sulla porta, palesemente arrabbiato e alla ricerca delle parole adatte per controbattere, poi però abbassò la testa, mordendosi il labbro. Alla fine annuì, sempre a testa bassa, e uscì senza più guardarmi, chiudendo la porta con garbo. Ebbi la chiara sensazione che volesse sbatterla, così socchiusi leggermente la porta e lo guardai allontanarsi nella penombra che si stava addensando: stringeva i pugni e tutto il suo portamento dimostrava chiaramente rabbia e frustrazione. Poi udii la voce di Tressa che lo chiamava dalla strada alla mia destra e chiusi la porta, mentre Artù si voltava per andare verso di lei. Qualche istante dopo Tressa aprì la porta ed entrò, togliendosi la lunga stola che si era avvolta attorno alle spalle. «Cay, che diavolo hai detto ad Artù? Non l'ho mai visto così sconvolto. Riusciva a stento a parlare e potrei giurare che era sul punto di piangere. Avete litigato?» «No, amore mio,» dissi con un sospiro, «non abbiamo litigato.» Le andai vicino e l'abbracciai, tenendola stretta e baciandola a lungo prima di tornare accanto al mio tavolo da lavoro. Mi sedetti e le raccontai che cosa ci eravamo detti, senza far alcun tentativo di nascondere la mia perplessità di fronte allo strano comportamento del ragazzo. Quando ebbi finito, alzando le braccia e dichiarando apertamente la mia esasperazione, lei si limitò a sorridere e a scuotere la testa. «Ribellione, era quella la parola che stavi per pronunciare un momento fa?» Non attese la mia risposta, perché mi aveva udito benissimo. «Artù non è ribelle, Cay, lo sai anche tu. È il ragazzo migliore del mondo, con un gran bel carattere, e quanto mi hai appena raccontato non fa che confermarlo. Ma quando lascia trasparire qualcosa dei suoi sentimenti le prime parole che ti vengono alla bocca sono "scontroso" ed "egoista". Tu non hai la minima idea di che cosa sia quello che non va, non è così?» Posai entrambe le mani sul tavolo e la guardai alzando le sopracciglia, rendendomi conto che stavo per scoprire qualcosa. «Non sono stato abbastanza chiaro? Se avessi capito che cosa gli sta accadendo, non mi sentirei così frustrato, non ti pare?» «Il ragazzo è innamorato, uomo ottuso, sciocco e insensibile che non sei altro!» Il suo sorriso imbarazzato, ma pieno di dolcezza e di comprensione, toglieva qualsiasi durezza alle sue parole, e dal suo tono di voce capii che quello che intendeva dire era semplicemente questo: Che cosa posso farci, se hai la testa così dura? «Ma non capisci proprio nulla, non hai occhi? Non hai un briciolo di sensibilità? È cambiato, Cay, è cambiato per sempre; l'Artù a cui eri abituato non esiste più, sparito. Qual era quella parola difficile che hai usato quando con Derek parlavi delle farfalle? Meta...» «Metamorfosi.» «Sì, è proprio così. Bene, questo è quanto è successo al ragazzo. Si è metamorfosizzato.» Non potei fare a meno di sorridere, tanto appariva convinta e concentrata. «Ha subito una metamorfosi, si dice così.» «Mah! Puoi dire come vuoi, è una parola troppo grande per me, non riesco neppure a pronunciarla. Ma è cambiato completamente, questo è quello che è accaduto, mettila come vuoi. L'Artù che hai sempre conosciuto non c'è più, Cay. L'amore lo ha trasformato, per la prima volta nella sua vita ha conosciuto l'amore e tutto quello che sa è che quell'amore sta per finire e lui non può far niente per impedirlo. Perché tu gli hai appena detto che lo farai finire domani, all'alba, separandolo dalla sua amata, mandando lei a casa sua e portando lui con te a Camelot.» «Amore?» Rimasi seduto a guardarla, alle prese con quanto mi aveva appena detto. «Artù sarebbe innamorato? Ma non ha senso. E di chi?» Nel momento in cui pronunciavo quelle parole, di colpo compresi, mentre la mia mente mi faceva rivedere ciò che nelle ultime due settimane avevo avuto costantemente davanti agli occhi e avevo deciso di ignorare: Artù che durante la cena fissava estasiato, con occhi da pesce lesso, la bella fanciulla che sedeva riservata e composta tra lo zio e la zia, voltando di tanto in tanto la testa nella sua direzione per inviargli un sorriso; Bedwyr e Gwin che sogghignando si davano gomitate e intanto osservavano Artù immerso nella contemplazione della sua bella; le due ragazzine di Ravenglass, Stella e Rena, i cui visi sembravano il ritratto del disgusto e dell'aperta ostilità mentre guardavano in cagnesco Artù che conversava da solo con Morag tra i contrafforti dei magazzini di granaglie, con i due ragazzi inondati da un torrente di luce solare che illuminava l'intero muro occidentale; e infine, la scena più significativa, il ricordo di quel momento in cui Li avevo visti guardarsi con occhi rapiti il giorno stesso dell'arrivo di lei, ciascuno dei due totalmente, immediatamente, ciecamente immerso nell'altro. Folgorato. La parola mi si affacciò alla mente, turbandomi con ricordi dolci e amari ormai lontani, dimenticati da trent'anni; folgorato era la parola che avevamo usato da ragazzi per indicare la paralizzante rapidità con cui l'amore può colpire. Anch'io ero stato folgorato una volta, e avevo perso il mio amore, una fanciulla di dodici anni dal viso luminoso il cui padre era stato bandito per aver commesso qualche crimine ai danni della Colonia, e ora ecco ritornare quel miscuglio di sentimenti che mi aveva riempito il petto - la gioia incredula e la meraviglia di dividere il mondo con lei - e per quanto irreale, la semplice, fuggevole ombra di un ricordo, la cui dolorosa dolcezza mi faceva tornare alla mente che cosa avesse significato vivere posseduto da un simile amore: terrore e sgomento, cui si contrapponeva una gioia folle e sconvolgente unita all'incredulità di essere benedetti da una così grande fortuna; follia spensierata alimentata da un'esaltazione insopportabile; crescente euforia accompagnata da una sconvolgente purezza di pensieri e di propositi e la volontà di porre il mondo intero ai piedi dell'amata. Il suo nome era Lueth, e ora, nel fuggevole istante in cui il suo viso mi tornò alla mente, mi chiesi che cosa ne fosse stato di lei. Pensai anche a Publio Varro e al modo in cui, a sua volta, era stato folgorato da una ragazza, una ragazza il cui vero nome poteva essere o non essere affatto quello che gli aveva rivelato in quell'unico, lontano, pomeriggio d'estate che avevano trascorso insieme. L'aveva persa quando l'aveva trovata, proprio in quell'unico pomeriggio, e aveva dedicato anni a cercare il suo viso per tutto l'impero. Tress venne a sedersi sul pavimento, accanto ai miei piedi, e mi si appoggiò al ginocchio; mi aveva posato un braccio sulla coscia e mi guardava sorreggendosi il viso con il palmo della mano. «Che c'è, Cay? A che cosa stai pensando?» Mi piegai per accarezzarle i capelli, poi la guardai sentendomi di colpo molto vecchio. «Al primo amore, e a quello che provoca in noi. Ci sconvolge, la prima volta in cui scopriamo che nel nostro mondo maschile esiste un'altra specie, una specie della cui esistenza non ci eravamo mai accorti: la specie divina. Il primo amore, la folgorazione, è la perdita dell'innocenza.» Mi fermai: sentivo un nodo alla gola, come non mi accadeva da anni. Poi, vedendo che Tressa mi fissava, guardandomi con occhi spalancati e assorti, feci scorrere il pollice sulla sua guancia vellutata e le dissi che cosa mi turbinava in mente. «Semplicemente finora non ci avevo ancora pensato, e anche così, se mai mi fosse venuto in mente, non avrei immaginato che avrei potuto... che sarei stato proprio io a causare un dolore simile a un ragazzo, peggio ancora a un ragazzo che per me significa così tanto. Eppure non c'è nulla che io possa fare per cambiare le cose, purtroppo non posso proprio cambiare nulla. Dobbiamo lasciare questo posto adesso, e lo stesso vale per la piccola Morag. Per tutti noi è venuto il momento di andare, e il mondo degli adulti non può fermarsi per riguardo all'amore di due ragazzi o poco più.» La malinconia che provavo in quel momento mi sembrava quasi insopportabile, ma ancora una volta Tress mi venne in aiuto. «Invece puoi fare molto per aiutarlo» mi disse, con un tono che faceva sembrare immotivata la mia pena. Ignorando le mie elucubrazioni filosofiche, aveva colto immediatamente il nodo della questione. «Certo che puoi aiutarlo a superare la sua disperazione: puoi dargli la speranza.» «E come?» adesso la stavo guardando con grande interesse. «Perdonami, Tress, ma non capisco a che cosa alludi. Speranza di che? Di incontrare un'altra dea? Non accadrà mai. Non avrà mai un altro primo amore.» «No, ovviamente no! Ma puoi dargli la speranza di rivedere Morag, sciocco. Suo padre è un re, non è così? Bene, anche il padre di Artù lo era. I figli dei re sposano le figlie di altri re, sì o no? Suo zio, sposato alla sua amata zia Salina, è anche zio di Artù, ed è anch'egli re, a buon diritto, re degli Scoti. Non hai in mente di invitarlo a Camelot un giorno o l'altro? Bene, se quando viene tu inviti anche la ragazza e conduci bene il gioco, non potrebbe accadere che una volta o l'altra re Brander e sua moglie portino anche la bella Morag come damigella di compagnia della zia? Con i tuoi amici parlate di politica, e non è forse politica parlare della possibilità di unire regni e di stringere alleanze? Fallo presente ad Artù e vedi come reagisce. Ma fallo subito, prima di domani mattina, quando dovrà partire con tutto il mondo che gli crolla addosso.» Trovai Artù nella sala da pranzo, dove per altro erano già state preparate le tavole per la cena. Se ne stava da solo in un angolo, rimuginando; davanti a sé aveva un boccale, ma dal modo in cui, non appena mi vide, si affrettò a spingerlo furtivamente di lato sospettai che potesse essere pieno di birra o di vino puro, tassativamente vietato ai ragazzi. Non mi avvicinai a lui; mi limitai a fargli un cenno con un dito, poi mi voltai per uscire, senza aspettare di vedere che cosa avrebbe fatto. Ora che conoscevo il motivo della sua pena, comprendevo anche la sua rabbia e la sua frustrazione, e non avevo la minima intenzione di provocare un'eventuale discussione in un luogo tanto pubblico. Mi avviai dunque lungo la strada lastricata, lentamente e tranquillamente, posando con circospezione i miei stivali chiodati per ridurre il rumore, e intanto tendevo l'orecchio per sentire se mi seguiva. In effetti era lì, proprio dietro di me, così rallentai ulteriormente il passo per dargli il tempo di raggiungermi. Poi però sentii Connor che mi chiamava e non potei fare a meno di imprecare sommessamente, anche se mi voltai per salutarlo e rivolgergli due parole. Lui e Brander e qualche altro si sarebbero ritrovati dopo la cena, mi disse, per scambiarsi saluti e addii davanti a un boccale di birra o a una brocca di idromele, e sperava che mi sarei unito a loro. Non appena Artù mi ebbe raggiunto, allungai un braccio per afferrarlo affettuosamente alla nuca, poi dissi a Connor che sarei stato lieto di passare la serata con loro e che forse anche Artù avrebbe avuto piacere di essere dei nostri. Ora però dovevamo discutere di una commissione che Artù avrebbe dovuto fare per me l'indomani mattina, dissi, ma ci saremmo ritrovati tutti a cena e poi avremmo trascorso insieme il resto della serata. Quando arrivammo nelle mie stanze, Tressa non c'era, ma prima di uscire aveva acceso il braciere ed era evidente che se ne era andata soltanto pochi attimi prima. Feci cenno ad Artù di sedersi e mi diressi immediatamente verso la cassapanca scolpita in cui tenevo il mio idromele. «Ti va di bere un po' di idromele con me?» Mi guardò come se temesse che fossi improvvisamente uscito di senno. In effetti, se era possibile che avesse già assaggiato l'idromele anche prima di quella sera, di certo non lo aveva mai fatto in mia compagnia. La regola era semplice e tassativa: l'idromele era per gli adulti, e lo stesso valeva per il vino. I ragazzi potevano bere birra una tazza, non di più a cena. Per il resto dovevano bere acqua, talvolta mescolata con un po' di vino, tanto per darle un po' di sapore, e occasionalmente bevevano latte e succo di frutta quando era la stagione. Ora però io gli stavo offrendo dell'idromele, nelle mie stanze, ed ero certo che il significato del mio gesto non gli sarebbe sfuggito a lungo. Finalmente annuì, molto lentamente e compostamente; era evidente che temeva di mostrarsi troppo impaziente. Versai per lui la stessa quantità che avevo versato per me, e gli porsi la coppa. La prese e mi osservò con una certa diffidenza mentre mi sedevo proprio di fronte a lui e alzavo la mia, rendendo omaggio a Bacco alla vecchia maniera. Artù portò la sua coppa alle labbra e assaggiò il liquore con cautela, come se avesse paura di quello che poteva succedergli. Forse mi ero sbagliato, pensai. Forse anche con l'idromele, come con Morag, era la prima volta. «Beh, che ne pensi? L'ha preparato tua zia Shelagh.» Da quando lo avevo trovato nella sala da pranzo, non aveva ancora detto una sola parola e sarei stato pronto a scommettere che non aveva più aperto bocca dal momento in cui aveva incontrato Tressa per strada, più di un'ora prima. A quel punto annuì ancora gustando l'idromele. «È molto dolce» disse finalmente, a voce bassa. «Ma è forte, ti prende la gola e ti fa venir voglia di tossire.» «Sì, ma se lo sorseggi scoprirai che puoi sopportarlo benissimo e che la voglia di tossire ti passa subito.» Guardai nella mia coppa. «Se bevi troppo in fretta, o se ne bevi troppo, ti verrà voglia di vomitare, e quella sì è una voglia che non si riesce a controllare. Dopodiché, a seconda di quanto ne avrai bevuto, ti sembrerà di essere sul punto di morire, e se ne hai davvero bevuto troppo talvolta potresti persino desiderare di poter morire.» Parlavo lentamente, mettendo un'enfasi eccessiva su alcune parole, nella speranza che quel tocco di umorismo potesse farlo sorridere, ma era troppo depresso, troppo immerso nella sua disperazione. Decisi allora di affrontare la questione in modo diretto. «Parlami di Morag.» Indietreggiò come se lo avessi colpito. «Cosa? Chi?» Sospirai in modo teatrale, indicando la mia coppa. «Artù, questo è idromele. È una bevanda da uomini, e io te l'ho offerta, come si fa con un uomo. Ora, credimi, dobbiamo parlare da uomini - della fanciulla Morag e della separazione che ti ho annunciato oggi. So che tu e lei siete innamorati...» «Come puoi saperlo?» La sua aria di sfida si fece più decisa e si mantenne sulla difensiva. Alzai le sopracciglia. «Me lo ha detto Tress.» «E come fa lei a sapere una cosa del genere?» «Perché, mio caro giovane cugino, perché lei è una donna. Le donne sanno questo genere di cose. Nessun uomo può illudersi di ingannarle, non a lungo, quanto meno.» Mi fermai di colpo. I suoi occhi erano terrorizzati, pieni di panico e di vergogna, fissi verso un punto imprecisato alle mie spalle, e tutto il suo corpo era teso come se fosse sul punto di scattare in piedi e correre fuori nella notte. Provai compassione per lui, per la sua inutile agonia. «Artù» dissi, infine, a bassa voce. «Guardami. Guardami negli occhi, Artù.» Le mie parole giunsero a segno e mi guardò dritto negli occhi, pallido in viso, mentre le nocche della mano con cui teneva la coppa erano bianche, tanto forte e convulsa si era fatta la stretta. Feci un cenno verso la sua mano. «Quella coppa è di argilla indurita dal fuoco, ma finirai per romperla.» Sul suo viso si diffuse l'ombra del dubbio, abbassò lo sguardo per fissarsi la mano, e poi, dopo un attimo, allentò la stretta e cominciò a chinarsi per posare la coppa sul pavimento. «No, non fare così» dissi. «Prendine un altro sorso.» Lo fece, e io osservai i suoi occhi, fissi nei miei, sopra l'orlo della coppa. Poi l'abbassò, in preda all'agitazione, lottando contro la voglia di tossire, ma nei suoi occhi il panico era scomparso. «Bene. Ora dimmi perché ti sembra tanto spaventoso che Tressa conosca i tuoi sentimenti nei confronti di Morag.» Rabbrividì, forse per via dell'idromele. «Io... io non credevo che fosse così evidente. Non immaginavo che lo sapessero tutti.» «Non lo sapevano tutti. Io, almeno, non lo sapevo di certo, perché se lo avessi saputo me ne sarei fatto carico e ti avrei avvisato di quanto stava per accadere, dando la possibilità sia a te sia alla fanciulla di prepararvi a questa separazione. Spero che tu questo lo capisca. Non avevo la più pallida idea dei tuoi sentimenti verso Morag fino a quando Tress non mi ha rimproverato la mia cecità. E dire che ti ho sottocchio in continuazione! Dunque, se non me ne sono accorto io, puoi essere certo che tra gli uomini non se n'è accorto nessuno. Se non fosse così, sicuramente me lo avrebbero fatto sapere, magari tra il serio e il faceto. Le donne lo sapevano, è vero, ma le donne non scherzano mai su cose come dolci fanciulle e baldi giovani in amore... a meno che non siano gelose, in quel caso però è puro e semplice rancore. Perciò sta in pace...» Prima di continuare gli diedi il tempo di farselo entrare bene in testa. «D'altronde, perché dovresti vergognarti? Per un uomo l'amore è ciò che ha più caro, sia che sia rivolto a una donna che a una nobile causa o a un grande ideale, e l'amore per una donna degna di questo nome è tutte e tre le cose. Che vergogna può esserci in tutto ciò, nel far conoscere questo amore, nel sentirsene appagato? L'amore corrisposto è motivo di orgoglio, Artù. Trasforma gli uomini comuni in giganti, e i giganti in divinità. Hai ascoltato almeno una parola di quanto ti ho detto?» Ora si era seduto e annuiva, con il viso trasfigurato, e questa volta quando alzò gli occhi verso di me sorrise, anche se fugacemente; subito dopo però il suo sguardo tornò a essere triste, come se temesse di lasciarsi sfuggire il sapore amaro della disperazione. «E adesso, che cos'altro c'è che non va? Suvvia, bevi un altro sorso e sputa quello che hai in mente. Qui siamo soli.» Questa volta tracannò il suo idromele e io mi tenni pronto a saltare su e dargli una pacca sulla schiena, ma il forte liquore andò giù senza provocargli niente di peggio che un rapido brivido. Poi sospirò e mi guardò negli occhi. «È la mia anima a essere malata, Cay, terrorizzata all'idea di perderla. Quando lei sarà tornata a casa e noi partiremo per Camelot, non la rivedrò mai più. Morag abita a Gallava... in Caledonia!» «Un paese lontano, certo. Ma per il resto ti sbagli, ragazzo. La rivedrai, e presto, e ti dirò come e perché. Ma prima dobbiamo chiarire alcune cose, tu e io. Per me sono importanti - a dire la verità dovrebbero essere importanti per entrambi - dunque parliamone subito e poi torneremo a occuparci di Morag. Vuoi ascoltarmi?» Annuì, bevendo ancora dalla sua coppa, questa volta però con più moderazione, e io mi chiesi quanto ci sarebbe voluto prima che si facessero sentire gli effetti dell'idromele. In realtà, la quantità che avevo versato a lui e a me era decisamente modesta, ma Artù non era abituato. «Bene, questo è il nodo della questione, dunque ascoltami attentamente.» Mi alzai e mi allontanai da lui, continuando a parlare mentre passeggiavo avanti e indietro per la stanza. «La prima cosa che desidero tu sappia è che se mi fossi reso conto dei tuoi sentimenti per la giovane Morag oggi non ti avrei comunicato la partenza così bruscamente e con così poca delicatezza. Ciò non toglie che ti avrei dato le stesse istruzioni e gli ordini sarebbero stati esattamente gli stessi. Domani mattina devi assolutamente andare da Derek e domani sera devi assolutamente essere di ritorno. Da quando ti ho dato questi ordini non è accaduto nulla che ne giustifichi un qualsiasi cambiamento. Qui tu hai dei doveri da compiere e, in tutta franchezza, tutti devono vedere che li compi davvero. In futuro dovrai essere un capo e comandare i tuoi uomini, e dunque bisogna che tutti comprendano che non pretendi privilegi che i tuoi stessi uomini non possono avere. Un capo veramente grande è un capo che divide con i suoi inferiori le fatiche di ogni giorno. Loro non possono prendere il suo posto quando è il momento delle decisioni importanti, ma lui non esita a condividere le loro tribolazioni e poi, quando arriva la crisi, è pronto a farsi carico del proprio fardello, senza aiuti. A questo punto saranno disposti a seguirlo e a combattere per la sua causa, a morire per i suoi obiettivi e per ubbidire ai suoi ordini, per amore di lui e di quanto lui rappresenta: i loro stessi interessi. Questo vuol dire essere un capo, Artù, ed è un traguardo quasi impossibile da raggiungere, sebbene molti, moltissimi, ci provino. E una delle difficoltà più difficili da superare sta proprio nelle situazioni simili a quelle che oggi stesso hai dovuto affrontare: la tentazione di anteporre i tuoi desideri, di soddisfare le tue esigenze, a scapito di coloro che dipendono da te e si fidano di te. Cedi una sola volta a questa tentazione, e lo farai ancora, e come è certo che l'acqua erode la roccia, è altrettanto certo che distruggerai la tua supremazia, il tuo diritto a esercitare il potere.» Smisi di andare avanti e indietro e mi piazzai davanti a lui, stando dietro la mia sedia, con le mani appoggiate sulla spalliera. «Questo è quanto volevo dirti. Ti pare giusto?» «Sì» disse. La sua voce era poco più di un rauco brontolio. «È perfettamente giusto.» «Bene, sono lieto che la pensi così. Ora, tra gli ordini che ti ho dato oggi pomeriggio c'era che tu partissi domani e tornassi in giornata, il che significa che lungo la strada supererai Morag e i suoi compagni di viaggio. Ma da quando ne abbiamo parlato per la prima volta, sono cambiate molte cose, e ora posso proporti qualcosa di nuovo.» Girai attorno alla sedia e gli presi la mano, portando la sua coppa verso di me. In fondo c'era ancora un po' di idromele. «Vuoi finirlo?» «No, direi di no.» Presi la sua coppa e versai nella mia il poco idromele che ancora conteneva. «Hai sentito che cosa ha detto Connor mentre stavamo venendo qui? Gli uomini si ritroveranno dopo cena, per bere idromele e scambiarsi addii e saluti. Ci sarà una festa, probabilmente lunga e rumorosa. Ci saranno anche le donne, naturalmente, si berrà molto e non mancheranno musica e canzoni. Ti ho invitato a venire con me - con gli uomini, intendo - e Connor non ha fatto obiezioni.» Bevvi un sorso. «Ora però mi viene in mente che potresti non avere voglia di passare la serata con me. Tress, lo so, ha parlato di venire qui, subito dopo cena, per mostrare i suoi lavori di cucito alla piccola Morag. Se ti interessa, sono certo che Tress sarebbe lieta e orgogliosa di mostrarli anche a te. Che ne dici?» La gioia che brillò immediatamente sul suo viso era la ricompensa in cui avevo sperato. «Benissimo, allora, vedrò di portare le tue scuse facendo notare come la tua assenza sia giustificata dal momento che devi alzarti presto e correre a Ravenglass di buon mattino. Ma non ho ancora finito, c'è dell'altro e riguarda il futuro. Morag è figlia di re, e tu sei figlio di re...» A quel punto, facendo ricorso ai ragionamenti di Tressa e usando le sue stesse parole, gli descrissi con abbondanza di particolari il modo in cui in futuro avrebbe potuto incontrare di nuovo Morag, purché lui e io riuscissimo vincitori dalle guerre che avremmo dovuto affrontare. Quando ebbi finito, si era ormai trasformato in un guerriero, i suoi occhi mandavano scintille e sapevo che l'indomani sarebbe corso a Ravenglass con la mente piena di sogni e di speranze. Posai le nostre coppe vuote sul tavolo e insieme ci avviammo verso la sala da pranzo; gli tenevo un braccio sulle spalle e il cuore mi si riempì di soddisfazione nel sentirlo parlare normalmente, pieno di eccitazione e di esuberanza. Non nominò Morag neppure una volta, ma tutto il suo fuoco, tutta la sua passione e il suo entusiasmo erano per lei e per il futuro che vedeva davanti a sé. III. Nei miei viaggi da un capo all'altro della Britannia, ho sempre trovato il tempo e le occasioni per stupirmi dell'influenza dei conquistatori romani, un'influenza che hanno continuato a esercitare ancora per molti decenni dopo la fine dell'impero. Probabilmente non ci si dovrebbe aspettare nulla di meno; dopo tutto la Britannia è stata provincia romana per quasi cinque secoli e dunque quasi genuinamente romana in tutte le manifestazioni frutto dell'influenza civilizzatrice di Roma. Tuttavia, in Britannia gli onnipresenti Romani erano prevalentemente urbanizzati; raramente infatti si avventuravano lontano dai centri abitati che si formavano attorno ai loro forti, alimentando loro stessi e la loro civiltà. In effetti, al di fuori di queste città, il territorio conosceva un altro tipo di vita, dava sostentamento ad altre popolazioni che vi si erano stabilite molto tempo prima che Giulio Cesare volgesse il suo avido sguardo verso questi lidi e che pertanto avevano continuato a vivere secondo le loro antiche usanze. Questi erano i veri Britanni, i veri abitanti della Britannia, ed erano un popolo suddiviso in tribù, forse un miscuglio di razze mescolatesi in un passato lontano e dimenticato. I Romani, con la loro passione per l'organizzazione, avevano dato un nome a ciascuno di questi clan basandosi sui territori occupati dalle varie tribù, romanizzando i suoni ostici delle denominazioni con cui le federazioni locali chiamavano se stesse ed etichettandole come Trinovantes, Belgae, Iceni, Dobunni e simili, nomi che per lo più sono ormai da tempo in disuso. L'intero settore nordoccidentale, che quella primavera attraversammo subito all'inizio del nostro viaggio, era il territorio occupato tradizionalmente dai Brigantes, il clan da cui avevano avuto origine Derek e la sua gente, e si estendeva attraverso la Britannia fino al Mare Orientale, nell'area che, a memoria d'uomo, Vortigern aveva preteso come propria e cioè la Northumbria. Avevamo lasciato Ravenglass per spingerci verso l'interno, prima a est e poi a nord seguendo la strada romana, il Decimum iter, fino a una località che era stata nota come Brocavum e che ormai era vuota e abbandonata, troppo vicina alle terre dei Pitti, oltre il Vallo, perché fosse consigliabile abitarvi. Di lì avevamo poi piegato verso sud, seguendo la strada fino a un altro forte, abbandonato e in rovina, tanto piccolo e dimenticato da così lungo tempo che il suo nome è andato perduto sebbene si trovasse vicino a un bivio. Avevamo trascorso piacevolmente un pomeriggio e una notte al riparo delle sue mure malandate, poi ci eravamo diretti a ovest, prendendo la strada che andava verso destra e seguendola per alcune miglia, prima di svoltare di nuovo verso sud, laddove c'è un ponte senza nome sul fiume che attraversa la piana. Dopo aver viaggiato per una cinquantina di miglia, avevamo raggiunto la biforcazione che punta verso occidente e che ci avrebbe portato a Deva, la grande città fortificata della Legio Vicesima Valerla Victrix. Scoprimmo che, da quando era stata abbandonata dalla sua celebre guarnigione, ben poco era cambiato. La grande fortezza che per tanti decenni era stata inviolabile non aveva ancora cominciato a piegarsi alle ingiurie del tempo e ospitava una popolazione forte e autosufficiente che non tollerava le visite di gruppi armati, neppure di quelli che venivano in pace. Questa gente, presumibilmente discendente dei Cornovii che anticamente avevano occupato questo territorio, chiamava la città fortificata in cui si era stabilita Chester, un'alterazione del vocabolo latino castra che significa "accampamento". Pur non mostrando un'aperta ostilità, si ritirarono dentro quelle mura poderose, sbarrandoci le porte in faccia e rifiutando le nostre profferte di pace e amicizia. Dispiaciuti, li lasciammo al loro volontario isolamento e continuammo in direzione sud, iniziando un viaggio di oltre duecento miglia su strade che si inoltravano attraverso una foresta, altrimenti impenetrabile, verso la città che i Romani chiamavano Corinium, e che per secoli e secoli era stata la sede più importante dei Dobunni. Da Corinium sarebbero state sufficienti una cinquantina di miglia per arrivare ad Aquae Sulis, e di lì, dopo esserci accampati un'altra notte, saremmo arrivati nei pressi di Camelot. Soltanto nelle vicinanze delle città fortificate, dove un tempo si erano stabilite le guarnigioni romane e coloro che le rifornivano di vettovaglie, avevamo visto i segni di coltivazioni agricole organizzate, anche se limitate: terre disboscate, campi ben delimitati con linee di demarcazione e confini. Tuttavia, a mano a mano che ci avvicinavamo a Corinium, la foresta si allontanava fino a scomparire tanto che a un tratto ci trovammo a percorrere quella che un tempo doveva essere stata terra fertile, senza alberi, ma con vasti prati e persino campi coltivati, alcuni dei quali, pur essendo stati abbandonati per decenni, mostravano ancora chiaramente le linee di confine che li distinguevano dal campo vicino. Per alcune miglia non vedemmo i segni di coltivazioni recenti; quelli che un tempo dovevano essere stati terreni agricoli ora erano infestati di erbacce e cardi selvatici, arbusti disordinati e distese di alberelli rigogliosi. Alla fine raggiungemmo un'area dove piccoli appezzamenti di terreno erano stati arati e coltivati di recente. In un primo momento erano pochi e molto distanziati, ma non appena fummo vicini al territorio che circonda Corinium, le aree coltivate divennero più ampie e più numerose. Certo, meno di un quarto della terra disponibile era stata arata o seminata, ma ogni campo, anche quelli abbandonati e incolti, mostravano inequivocabilmente di dovere la propria origine all'organizzazione romana. «I campi si fanno più grandi e più numerosi a mano a mano che ci avviciniamo alla città, ma non c'è traccia dei contadini.» Le parole, pronunciate vicino all'orecchio, mi strapparono alla mia meditazione e mi fecero voltare verso Filippo, il comandante della nostra colonna di cavalleria, che da più di un miglio cavalcava al mio fianco in silenzio. Evidentemente mi aveva osservato mentre contemplavo i campi coltivati e mi aveva letto nel pensiero; così, mentre riflettevo su quanto aveva appena detto, per un attimo pensai anche a quella sua capacità di comprendere i pensieri dei compagni con cui aveva rapporti più stretti. In effetti, Filippo e io avevamo trascorso molto tempo insieme, come amici e come compagni d'arme. Insieme eravamo stati semplici soldati di cavalleria e poi giovani ufficiali. Filippo era stato uno dei compagni più fedeli al punto che era venuto con me quando mi ero recato nell'Eire per pretendere la restituzione del piccolo Artù che gli Scoti tenevano in ostaggio, per garantirsi il ritorno del loro principe, Donuil Mac Athol. C'era poco da stupirsi, pensai a quel punto, che leggesse così bene nei miei pensieri. Filippo, che da più di un miglio cavalcava al mio fianco, doveva avermi osservato mentre guardavo i campi e aver capito a che cosa stessi pensando. Con una smorfia spostai le mie natiche doloranti, gemendo involontariamente e maledicendo in silenzio l'inesorabile durezza della sella che me le aveva ridotte così male. «Avevo notato che sembrano timidi» borbottai. «Ma perché non se ne vede neppure la più pallida traccia?» Prima di rispondere Filippo fece una smorfia, guardando rapidamente la mia sella. «È perché hanno imparato a stare lontano dai possibili obiettivi. Le coltivazioni, e cioè cibo fresco, attraggono i predatori a due zampe; così spariscono nei boschi non appena vedono comparire qualche faccia sconosciuta. I contadini oggi sono gente strana. Da quando le legioni se ne sono andate, hanno sempre più paura degli stranieri: chi potrebbe dare loro torto?» Colto da un crampo improvviso mi spostai di nuovo, spingendo sulle staffe e cercando invano di far finta di nulla quando il movimento mi procurò una nuova fitta che mi trapassò dolorosamente le natiche. Di fronte al mio evidente disagio, il sogghigno di Filippo si fece ancora più evidente. «Hai passato troppo tempo a piedi, negli ultimi anni, comandante Merlino!» «Sì,» ammisi seccamente, «ma siamo in sella da quattordici giorni filati. A questo punto, il mio sedere dovrebbe essersi di nuovo irrobustito.» Filippo rise e scosse la testa. «È stata una giornata lunga e faticosa. Anche a me la schiena fa talmente male da non farmi pensare ad altro che a saltare giù di sella. Comunque, già nel viaggio di andata ci eravamo accampati da queste parti, un vecchio campo mobile sulla destra, a circa due miglia da qui, vicino a un corso d'acqua pura. Attualmente quel che resta è ben poco, tanto che si vede a malapena dove erano state costruite le vecchie mura di fango, ma è un buon posto ed è ancora facilmente difendibile, qualora se ne presentasse la necessità.» «Ottimo. Allora spero proprio che lo utilizzeremo presto.» Mi chinai e spinsi la punta delle dita nella natica destra, ma le tolsi subito, sobbalzando per il dolore. «Parlami ancora dei contadini locali. Qualche tempo fa, Ambrogio mi aveva detto che avevano ripreso a concentrarsi non lontano dalle vecchie città romane, senza però andare ad abitare dentro le antiche mura. Ma allora, dove diavolo abitano?» Filippo si strinse nelle spalle, sollevandosi sulle staffe e voltandosi per controllare la colonna che si allungava dietro di noi. Soddisfatto perché tutto andava come doveva, si sedette di nuovo sulla sella e alleggerì il peso dell'elmo che gli gravava sulla fronte, allentando il sottogola e spingendo verso l'alto il bordo della visiera. «Ovunque riescano a trovare un posto che offra loro qualche protezione. E, come hai detto tu stesso, evitano le città.» Si raschiò la gola e sputò, chinandosi in avanti e allontanandosi da me. «Sembra strano, me ne rendo conto,» continuò, raddrizzandosi e riprendendo il controllo del cavallo che aveva fatto uno scarto quando aveva sentito il rumore dello sputo che gli passava accanto all'orecchio «ma è come deve essere. Le città attraggono la sgradita attenzione dei visitatori, e le mura che le circondano spesso rappresentano una prigione più ancora che una difesa. Inoltre i contadini tendono anche a evitare di raggrupparsi; raramente ci sono più famiglie che vivono vicine, e questo mi giunge nuovo, sebbene mi renda conto che ha una certa logica. Ci fu un tempo in cui l'essere numerosi era fonte di sicurezza, ma non è più così, poiché la minaccia alla propria sicurezza proviene da gruppi ancora più numerosi, meglio armati e allenati a combattere uniti. In queste condizioni, la salvezza sta nella fuga e, se si è soli, o quanto meno in gruppi molto piccoli, fuggire è più agevole. «Oggi i contadini tendono a isolarsi in piccole, ristrette unità familiari. Ciascuna famiglia si prende cura dei propri campi abitando però a una certa distanza, e andando avanti e indietro ogni giorno. È ragionevole, se poi si considerano i rischi legati alla coltivazione. Se una famiglia decide di affrontare questi rischi - e in effetti non può farne a meno - coltiverà almeno due campi, ma più spesso tre o anche più, e farà in modo che si trovino alla massima distanza possibile l'uno dall'altro. Infine, una volta che le messi sono giunte a maturazione ed è arrivato il momento del raccolto, fanno di tutto per mieterlo e portarlo al sicuro senza dare nell'occhio, un campo per volta. Se poi per qualche motivo un raccolto va perduto se, tanto per dire, viene sequestrato da banditi che obbligano la gente del posto a fare il lavoro per loro, allora a ogni famiglia non resta che sperare che gli altri campi non siano toccati e che sia ancora possibile sopravvivere con quanto resta. Nel frattempo abitano in una capanna o in rifugi di fortuna al limite del bosco. Qualora si sentano minacciati anche lì, non possono far altro che fuggire nella foresta, e se la capanna viene bruciata o abbattuta, riescono facilmente a costruirne un'altra in un giorno o poco più.» Mentre ascoltavo le parole di Filippo, mi rendevo conto, non senza una punta di vergogna, che non mi ero mai occupato dettagliatamente delle condizioni di vita della gente comune che viveva abbandonata nelle campagne, senza godere dei benefici e della protezione di una colonia o di una città fortificata. Mentre avevo sognato del futuro della Britannia nella tranquilla sicurezza del mio forte isolato tra le colline, con la protezione delle truppe di Camelot e avendo a disposizione tutte le comodità della civiltà romana, questa gente - questa stessa gente che avrebbe dovuto vivere in quel sogno e portarlo a compimento - viveva una vita dura, pericolosa e piena di paura. Mi accorsi che stavo fissando Filippo, inorridito tanto per le implicazioni delle sue parole quanto per il modo indifferente con cui le pronunciava. Ero talmente sconvolto che dovetti sforzarmi non poco per reprimere l'ingiusto bisogno di prendermela con lui. Mi costrinsi dunque a starmene seduto tranquillo e a guardarmi attorno fino a quando non fossi riuscito a mettere sotto controllo quelle emozioni improvvise e turbolente. «Così,» dissi alla fine, «non te l'ho sentito dire, ma ho l'impressione che tu sia convinto che questa gente meriti la propria sorte, non è vero?» Filippo si voltò verso di me e ora era lui che mi guardava come se stessi pronunciando parole agghiaccianti, poi aggrottò le sopracciglia e annuì, con un leggero cenno di assenso. «Vivono l'unico tipo di vita che conoscono, comandante, ed è la loro sorte, senza che noi possiamo fare nulla per cambiarla o influenzarla.» Notai che usava il titolo che mi spettava, invece di chiamarmi per nome come era autorizzato a fare, essendo un vecchio amico. «Tutto quello che possiamo fare è ringraziare Dio che la nostra vita non sia come la loro. A parte trasferire una guarnigione a Corinium, il che sarebbe impossibile, non riesco a farmi venire in mente qualcosa che potremmo fare per migliorare la loro condizione.» Borbottai una qualche risposta, poi spronai il cavallo al trotto, lasciando indietro Filippo. Non cercò di raggiungermi e per la mezz'ora seguente cavalcai da solo, rimuginando su quanto mi aveva detto. Stavo ancora pensando alle sue parole quando raggiungemmo il punto stabilito per accamparci e la nostra gente cominciò a darsi da fare montando le tende e sistemando i cavalli per la notte. Quanto a me, mi mantenni in disparte, persino a cena, prendendo il mio cibo e andando a sedermi da solo, immerso nei miei pensieri. Ovviamente Tress sapeva che c'era qualcosa che mi preoccupava o mi infastidiva, ma era abbastanza intelligente e abbastanza discreta da tenersi a distanza e lasciarmi cuocere nel mio brodo quanto volevo, ben sapendo che poco dopo sarei andato da lei. Le ero grato per questo e sapevo inoltre che mi avrebbe tenuto lontano gli altri. Filippo e i suoi commilitoni potevano tranquillamente pensare che questi contadini fossero una razza a parte, ma io mi rendevo conto che una posizione del genere non avrebbe portato a nulla. La maggior parte dei soldati di Camelot e molti dei nostri coloni più capaci provenivano da questa regione e dalle fila di questa stessa gente, tanto che eravamo stati costretti a chiudere le nostre porte in faccia agli altri, isolandoci e fortificandoci esclusivamente per la nostra sicurezza e il nostro benessere di fronte all'impossibilità di nutrire e di difendere tutti gli abitanti della Britannia. Era qualcosa che avevo sempre saputo e accettato, fin da quando ero ragazzo. Perché allora, mi chiedevo, adesso avrei dovuto sentirmi colpevole e in collera con me stesso? Continuavo a rimuginare questi pensieri sconfortanti anche mentre mi avviavo alla mia tenda, ma sembrava proprio che quella notte fossi destinato a dormire ben poco. Avevo a malapena cominciato a slacciarmi l'armatura quando udii un leggero trambusto provenire dall'esterno. Richiusi le fibbie e uscii, avviandomi verso i fuochi che illuminavano il campo e chiedendomi che cosa stesse succedendo. Dapprima non vidi nulla, anche se il suono sempre più forte di alcune voci e il rumore di passi che si avvicinavano mi dicevano che ben presto avrei scoperto di che si trattava. Mi avviai verso il centro del campo e vidi un piccolo assembramento: almeno una decina di uomini armati di lancia e, all'apparenza molto risoluti. Filippo era spuntato dalla tenda riservata ai comandanti e stava andando verso di loro, ma proprio mentre mi stavo avvicinando al fuoco che brillava al centro dell'accampamento, mi sentii chiamare per nome a bassa voce e vidi Dedalo che veniva verso di me. Alzò le mani, facendomi cenno di tacere, prima ancora che avessi avuto modo di aprir bocca e prendendomi per un braccio mi allontanò dal fuoco. «Abbiamo un prigioniero.» «Un prigioniero? Ma se non siamo in guerra!» «Bene, allora diciamo che abbiamo un "ospite forzato".» «Chi è?» «Non lo so. Uno del posto, suppongo. Gli uomini di Falvo lo hanno scovato mentre erano di pattuglia. Era solo e armato. Ha cercato di fuggire e lo hanno circondato, ma non sapevano che farsene e così se lo sono portato dietro.» «Molto bene, ma che cosa aveva di particolare quest'uomo perché Falvo decidesse di portarlo con sé? Presumo che costui non sia un contadino qualunque, altrimenti, conoscendo Falvo, lo avrebbe colpito alla testa e lo avrebbe lasciato, completamente stordito, nel punto in cui lo avevano trovato. Eppure hai detto che quel tale è uno del posto.» «Beh, questo è quello che penso io, ma non appartiene ai Celti della zona. Di questo sono sicuro. È un romano, o io sono un barbaro. E a giudicare dai suoi abiti e dalle armi, deve essere ricco.» «Che cosa intendi con romano?» La risposta fu preceduta da un gesto di impazienza. «Che cosa dovrei intendere? È piccolo, tarchiato, arrogante, ha gli occhi neri, è rasato, e ha un naso a becco come quello di un'aquila. È romano tanto quanto me.» Sospirai. «Hmm, romano, ben vestito, ben armato e ricco. Beh, direi che di tipi del genere non se ne sono visti molti da queste parti. Andiamolo a vedere, allora.» Mi fermai, guardandomi attorno e oltre il fuoco, per vedere la pattuglia di Falvo. «Prima però è forse meglio che tu mi dica esattamente che cosa è successo.» Il gruppetto di uomini che circondava il nuovo arrivato non era lontano più di dieci passi dal punto in cui ci trovavamo io e Dedalo, e sulla punta delle loro lance potevo vedere riflessi i bagliori del fuoco. Filippo, che era un ufficiale della guardia, era là insieme a Falvo, leggermente in disparte rispetto al gruppo, con la testa abbassata come se stesse ascoltando. Guardai da quella parte, sperando di poter dare uno sguardo allo straniero, ma riuscii a vedere soltanto i miei uomini. Dedalo, nel frattempo, si era lanciato nel suo racconto. «Falvo e i suoi uomini avevano raggiunto il punto più lontano della loro perlustrazione, circa dieci miglia da qui...» «Dieci miglia? Per l'Ade, che cosa stavano facendo così lontano?» Dedalo si strinse nelle spalle. «Facevano esattamente quello che dovevano fare, perlustravano. E avevano anche delle buone ragioni per essere da quelle parti. Falvo ti farà personalmente un resoconto dettagliato, ma penso che sia opportuno che tu sia messo al corrente di come sono andate le cose prima di parlare con il nostro prig..., con il nostro "ospite". Si erano allontanati di circa cinque miglia, per un normale pattugliamento, quando uno degli uomini di Falvo notò che i campi che stavano attraversando erano molto diversi da quelli che avevano visto in precedenza. Erano molto più grandi e ben coltivati. Falvo si rese conto che il soldato aveva ragione e che più andavano avanti più campi coltivati vedevano, ma non c'era l'ombra di fattorie, di case o di persone. Era incuriosito, e così decise di continuare la cavalcata. Dopo poche miglia si ritrovarono ad attraversare il terreno più fertile e ben coltivato che Falvo avesse mai visto, tanto da dargli l'impressione che qualcuno avesse organizzato dei possedimenti agricoli grandi almeno quanto quelli della nostra Colonia. Falvo e i suoi si stavano muovendo in una sorta di arco, dirigendosi verso est e seguendo una vallata attraversata da un fiume, in cerca di eventuali segni di presenza umana, ma per il momento non ne avevano visto alcuno. Era quasi mezzogiorno, e Falvo mi disse che cominciava ad aver voglia di andarsene, non perché avesse paura, ma poiché sapeva di essersi spinto ben oltre l'area in cui avrebbe dovuto trovarsi, troppo lontano per essere in contatto con noi. Chiunque avesse incontrato da quelle parti avrebbe potuto essere ostile: infatti avrebbe certamente pensato che lui e i suoi uomini non avessero buone intenzioni. E cominciava anche a temere che se ci fossero stati dei problemi, non sarebbero stati di poco conto: centinaia di campi coltivati volevano dire centinaia di persone arrabbiate. Falvo decise dunque di terminare subito la perlustrazione piegando verso est. Proprio lì, infatti, c'è una strada che porta direttamente a sud, per congiungersi poi con questa nelle vicinanze di Corinium. A quel punto scoprì che tra i campi e la strada c'era una striscia di foresta larga un miglio, evidentemente una sorta di schermo per scoraggiare i visitatori. Ma mentre si avvicinavano al limite degli alberi, cavalcando fianco a fianco in formazione serrata, uno dei suoi uomini, un certo Samuele Catone, scovò il nostro "ospite", per puro caso. Sul fatto che questo tale sia un guerriero, non c'è alcun dubbio. Infatti, non appena fu scoperto, pur essendo a piedi, attaccò immediatamente Catone, puntando direttamente contro di lui sebbene fosse armato soltanto di una corta spada. Avrebbe dovuto finire ucciso subito, invece riuscì a spaventare il cavallo di Catone e a disarcionare il cavaliere. Poi corse via, senza far alcun tentativo di ferire Catone, che era finito a terra; tuttavia prima che potesse andarsene i nostri soldati lo circondarono e vedendo come era vestito lo fecero incespicare gettandogli una lancia tra i piedi. A quanto sembra perse i sensi, e quando si fu ripreso lo avevano già fatto prigioniero.» «Che cosa indossava?» «Una corazza, una corazza romana.» «Hmm, una decisione tempestiva quella del soldato che l'ha fatto incespicare. Dovrebbe essere elogiato. Catone si è fatto molto male?» «Soltanto nell'orgoglio. In futuro starà più attento. In ogni caso, non appena ebbe notato l'aspetto dello sconosciuto, Falvo pensò che tu potessi essere interessato a parlare con lui, così lo ha portato qui sotto buona scorta, anche se gli ha permesso di tenersi le armi. L'uomo era a piedi, e aveva soltanto una corta spada e un pugnale, ma sembrava rispettabile. Questo almeno è quanto ha dichiarato Falvo, e detto da lui mi ha fatto una certa impressione. Comunque sia, Falvo gli ha parlato in latino, gli ha detto che a rigore non era prigioniero, ma che doveva venire con noi, e in cambio della possibilità di cavalcare con uno dei nostri uomini gli ha chiesto di dargli la sua parola che non avrebbe cercato di fuggire. Li ho incontrati un paio di miglia da qui, là dove la strada si biforca, e... il resto lo sai già. Se però mi chiedi quale sia la mia opinione sul da farsi, ti dico subito che non ho proprio alcuna opinione.» Sorrisi. «Non abbiamo idea di chi possa essere?» «No, e neppure da dove venga. L'unica cosa che sappiamo è che doveva essere solo, oppure gli amici che erano con lui dovevano essere dei gran vigliacchi.» «Hmm» borbottai di nuovo, e intanto galoppavano. «Bene, andiamo a vedere.» i miei pensieri Non appena ci fummo avvicinati al gruppetto che si trovava dall'altra parte del fuoco, vidi che lo sconosciuto mi aveva notato e stava fissando su di me la sua attenzione. Gli altri indietreggiarono e Dedalo si tenne alcuni passi in disparte. Ben presto dunque ci trovammo di fronte, pronti a studiarci reciprocamente. Dedalo aveva ragione: quell'uomo era un guerriero, il suo comportamento ne era un chiaro segno. E sulla sua ascendenza romana non ci sarebbe stato alcun dubbio anche se non avesse indossato la famosa corazza; la romanità traspariva dal suo viso e da tutto il suo aspetto, come fosse stata scritta a chiare lettere. Il suo atteggiamento poi dimostrava apertamente che era abituato a essere rispettato e ubbidito; più che un semplice guerriero, pareva uno abituato a occupare una posizione di comando, e il fatto che io torreggiassi su di lui con tutta la testa e magari qualcosa di più non cambiava per nulla la mia valutazione. Anni prima, Publio Varro aveva descritto il reggente dell'imperatore Onorio, Flavio Stilicone, come un falco, nato e cresciuto tra il popolo dei Vandali; l'uomo che mi stava di fronte era della stessa stoffa ed emanava aggressività, sicurezza e assoluta competenza. Era giovane, poco più che trentenne, e il suo fisico muscoloso mostrava il vigore di un uomo nel fiore degli anni. Zigomi alti e sporgenti delineavano un viso magro, con una bocca larga, labbra sottili e occhi scuri, profondamente incassati ai lati di un naso aquilino, imperioso e dai contorni ben definiti. L'ampiezza della sua alta fronte era sottolineata dal folto ciuf fo di capelli, che per un attimo mi fece ricordare Lucano, e attirò la mia attenzione sull'espressione dura del volto sottostante. Era accuratamente sbarbato e i capelli erano tagliati corti, secondo la moda romana. Dalle sue spalle ampie e forti pendeva un mantello rosso scuro, agganciato alle fibulae della corazza metallica che indossava. Portava una tunica di lana bianca, trapuntata, lunga fino alle ginocchia, e attorno alla vita una fascia di pesanti scaglie metalliche, come quelle degli ufficiali. Il mantello rosso era stato accuratamente rammendato in molti punti mentre le rosette e le incisioni che decoravano la corazza erano consumate da anni di lucidature, tanto da essere quasi lisce. La stessa cura traspariva dalle volute consumate dei foderi di bronzo della spada e del pugnale, che portava appesi alla cintura. Tornai a rivolgere la mia attenzione ai suoi occhi, che nell’osservarmi non tradivano minimamente i suoi pensieri. Annuii, mantenendo uno sguardo benevolo, senza sbilanciarmi. «Benvenuto,» dissi con calma, «sebbene mi renda conto che a questo punto potresti dubitare della sincerità delle mie parole. Posso sapere il tuo nome?» Si mordicchiò il labbro mentre mi guardava socchiudendo gli occhi, meditando la risposta. «Chiamami Abductus*» disse infine; la sua voce non tradiva alcuna emozione. [*In latino "abductus", dal verbo abducere, significa letteralmente "portato via", e quindi "catturato"] Annuii, cercando di nascondere un sorriso di ammirazione. «Non troppo adatto,» risposi pacatamente, «perché, in realtà, non sei stato catturato, e neppure preso prigioniero. Sei stato semplicemente invitato...» «Forzatamente invitato...» Annuii ancora. «Forzatamente, e immagino anche tacitamente, ma ciò nondimeno invitato a venire qui perché potessimo incontrarci. Hai ancora le tue armi, non è forse così? È raro che ai prigionieri e a chi viene catturato sia permesso tenerle.» I suoi occhi neri erano privi di espressione ed enigmatici. «Chi sei e che cosa vuoi da me?» «Parleremo anche di questo, ma prima di tutto devo chiederti perché stavi spiando i miei uomini.» «Cosa?» Sembrava al colmo dell'incredulità, non solo, ma dovette lottare con la propria rabbia prima di essere in grado di riacquistare il controllo di sé e di mostrare nuovamente un viso impenetrabile. Quando riprese a parlare, il suo tono era di nuovo calmo. «I tuoi uomini erano sulle mie terre, tra le mie messi, ma non basta: erano penetrati nei miei possedimenti e si stavano avvicinando alla mia casa.» «Capisco. Vivi solo e tutti questi campi li coltivi da solo?» Lo vidi aggrottare le ciglia, tuttavia i miei occhi tornarono al fodero consumato della corta spada che gli pendeva dal fianco. Sapevo che era sciocco da parte mia lasciarmi distrarre da quella spada, indipendentemente da quello che poteva essere il motivo della mia distrazione. «Ti sorprende che io coltivi i miei campi?» Una risposta pronta a una domanda inattesa, ma continuai ugualmente. «Vestito come sei, sì. Non sei un contadino. La tua armatura indica chiaramente che sei un bugiardo.» Guardò prima se stesso, poi di nuovo me. «Di questi tempi la indosso di rado. Sono un contadino, innanzitutto e soprattutto un contadino, come lo erano i soldati di Roma nel tempo antico. Impugno la spada soltanto quando è necessario; è stata proprio la presenza dei tuoi uomini che me lo ha fatto ritenere necessario. E come soldato ti ho dato tutte le informazioni che riceverai da me.» «Molto bene.» Potevo avvertire lo sguardo dei presenti fisso su di me. «Rispetterò il tuo desiderio di tacere. Ma ti dispiacerebbe mostrarmi la tua spada? Sono certo che avrai capito,» aggiunsi, vedendo improvvisamente diffondersi il sospetto nei suoi occhi, «che se avessimo voluto farti del male, a quest'ora saresti morto da un pezzo. Posso vederla?» Tesi la mano, ed egli esitò, ma soltanto un attimo, prima di togliersi la corta spada e di porgermela. La osservai da vicino ed esaminai il fodero, poi la estrassi parzialmente. Esattamente come mi ero aspettato, in cima alla lama, proprio sotto l'impugnatura, c'era una minuscola "V". «Come l'hai avuta?» Aggrottò di nuovo la fronte: chiaramente si stava chiedendo quale importanza potesse avere; poi batté le palpebre e si strinse nelle spalle. «Era di mio padre, e prima di essere sua era stata di suo padre.» «Dunque apparteneva a tuo nonno. Sai da chi l'ha avuta?» Sembrava proprio che avesse deciso di assecondarmi, eppure quando riprese a parlare la sua voce lasciava trasparire il disprezzo. «Come posso saperlo? Quando sono nato era già un vecchio. Accade sempre che i nonni siano vecchi, non lo sai?» «Sì, lo so.» Ignorai completamente la scortesia della sua risposta. «Tuttavia avevo delle buone ragioni per farti la domanda. Questa spada è stata forgiata dal mio prozio. Il suo nome era Varro. Forgiava spade, ma su alcune di esse, su alcune soltanto, le più belle, le più preziose, incideva il suo marchio personale, la "V" di Varro. E queste spade le dava soltanto ai suoi amici. Questa è una di quelle spade, dunque tuo nonno e il mio prozio devono essersi conosciuti. Guarda tu stesso.» Gli lanciai la spada ed egli l'afferrò con destrezza, poi estrasse parte della lama e guardò il marchio, dopo averla girata verso il fuoco per avere più luce. Rimase a guardarlo per qualche istante, infine si raddrizzò, infilò la spada completamente nel fodero e se la appese di nuovo alla cintura prima di voltarsi ancora verso di me. «Non so che cosa tu abbia in mente» disse. «Ma non ti credo. Non credo alle coincidenze, non a quelle di questo tipo. Prima hai visto il marchio e poi ti sei inventato tutto il resto.» Mi ero aspettato una reazione di questo tipo e avevo appena preso in mano il mio pugnale. «Non si tratta di coincidenze; ho semplicemente riconosciuto la mano del mio prozio. Guarda le decorazioni del fodero e poi guarda la "V".» Mentre parlavo gli gettai il mio pugnale. Fece come gli avevo detto, poi me lo restituì. Infine si schiarì la gola e per la prima volta la sua espressione indicava una qualche incertezza. «Il mio nome è Caio Britannico e nella tenda del quartier generale ho dell'eccellente idromele. Posso offrirtene un po'? Credo che noi due abbiamo parecchie cose da dirci. Grazie,» dissi poi rivolto ai miei uomini «ora potete andare.» Mi voltai e mi avviai direttamente verso l'unica grande tenda che si innalzava in mezzo al nostro accampamento; sapevo, anche senza guardare, che il nostro visitatore mi stava seguendo e cercavo di immaginare a che cosa stesse pensando. La tenda era ben illuminata e per il momento era vuota, ma non mi aspettavo che sarebbe rimasta tale a lungo. Filippo, come ufficiale della guardia sarebbe stato di ritorno in breve tempo e avrebbe avuto bisogno del tavolo e delle luci. Versai il liquido ambrato, una coppa per me e una per il mio "ospite", dalla fiasca di idromele che l'ufficiale della guardia custodiva in una cassa e riservava alle occasioni speciali. Prese la coppa che gli offrivo, quindi si accomodò sulla sedia che gli avevo indicato, muovendosi lentamente e senza staccarmi gli occhi di dosso. Poi sospirò sommessamente e bevve un sorso di liquore. Soltanto dopo averlo assaporato, tenendolo a lungo sulla lingua, si sentì in dovere di rilassarsi, appoggiandosi allo schienale. Mi sedetti di fronte a lui e attesi. «Dunque,» disse infine «tu sei Caio Britannico. Io sono Appio Niger.» Alzò la sua coppa in un rapido e ironico gesto di saluto. «I miei ringraziamenti per il benvenuto. E adesso che cosa dobbiamo fare?» Sorrisi. «Parlare.» «A che scopo?» «Per mettere fine alle ostilità, oserei pensare. Noi due abbiamo molto in comune.» Contrasse le labbra e i suoi occhi si spostarono dalla mia persona alla tenda in cui sedevamo e al suo arredamento. La tenda era quadrata - ciascun lato era lungo sei passi - ed era alta e spaziosa. Aveva una copertura a due punte sorretta da pali e tiranti, ed era fatta di strati e strati di pannelli di soffice cuoio, accuratamente cuciti insieme con filo robusto e incerato, in modo da renderla resistente all'acqua e al vento. Poteva contenere comodamente una ventina di persone ed era una tenda militare sotto tutti gli aspetti; era evidente inoltre che si trattava della tenda riservata al comando durante una spedizione. A suo credito, devo dire che il mio ospite non fece alcun commento in proposito; forse non voleva fornire nessuna informazione, anche semplicemente paragonando ciò che noi avevamo con ciò che probabilmente lui non aveva affatto. Al contrario, si limitò a commentare quanto io stesso avevo già detto. «I nostri nomi sono entrambi romani, ma i Romani se ne sono andati da tempo. Oltre a questo, trovo che in comune abbiamo ben poco.» «Bene, allora,» suggerii «lasciami fare una constatazione. Entrambi siamo di origine romana, come hai detto anche tu, ed entrambi viviamo in Britannia. Questo significa che entrambi abbiamo imparato a vivere in pace con i Celti di qui; tuttavia ci pone entrambi contro i nuovi arrivati che hanno invaso la Britannia dopo la partenza delle legioni.» Rimase seduto, senza fare alcun movimento, ancora per parecchi minuti, poi sbuffò. «I nuovi venuti. Vorresti dire i Pitti, le Genti Dipinte oltre il Vallo, su nel nord?» «In parte sì, sebbene sia improbabile che scendano così a sud in modo organizzato. Ma intendevo alludere anche ai Danesi e ai Sassoni.» «Nessuno di loro ci ha mai creato problemi. Ovviamente ne abbiamo sentito parlare, quanto meno dei Sassoni, ma sono soltanto nomi, nomi da incubo con cui spaventare i bambini.» Scrollai le spalle. «Nomi da incubo, forse, ma voi dovete essere stati eccezionalmente fortunati se siete vissuti fino a ora senza incontrare né gli uni né gli altri. Soltanto pochi anni fa, non molto più a sud di qui, a Glevum, abbiamo incontrato dei Berberi provenienti dal Mare Centrale. Corsari, venuti qui a razziare a bordo di una imponente bireme romana. Stavano portando via i marmi dagli edifici pubblici di quella città, presumibilmente per venderli oltremare; e torneranno. Quando avranno portato via dalle città della costa tutto ciò che abbia un certo valore, si spingeranno più nell'interno. Per il momento i Sassoni e i Danesi si accontentano di restare nelle aree orientali del paese, ma non ci resteranno per sempre, soprattutto quando qui, a ovest, ci sono delle terre ricche e fertili da sfruttare. Ti inganni da solo se ti illudi di non incontrarli mai.» Appio Niger bevve un altro po' di idromele, dimostrando palesemente di apprezzarne l'ottima qualità, poi mi guardò negli occhi e fece un cenno di assenso. «Non dubito che tu abbia ragione. Ma fino a ora la nostra maggiore preoccupazione sono stati i vagabondi, gente proveniente da altre parti del paese che gira qua e là per derubare le persone come me dei loro raccolti e del loro bestiame.» Si fermò, poi aggiunse: «Gente come voi». «No.» Il mio diniego fu istantaneo, ma non ostile. «Con noi non avete avuto alcun problema, e non ne avrete.» Continuai speditamente, ignorando il suo tentativo di interrompermi con qualche commento sarcastico sull'essere stato rapito. Non alzai la voce, ma mi limitai a parlare senza badare alle sue obiezioni. «Non abbiamo alcun interesse né per i vostri raccolti né per le vostre terre, se non per prendere nota della loro esistenza, dal momento che non ci aspettavamo di trovare terreni coltivati da queste parti. Quando hanno incontrato te, le nostre pattuglie di esploratori erano di ritorno da una ricognizione e avendo notato i tuoi abiti e la tua armatura, il comandante ha deciso di portarti qui, da me.» «E tu sei Caio Britannico. Dovrei sentirmi impressionato?» La sua sfrontatezza mi divertiva. Mi accorsi di trovarlo simpatico, a dispetto del suo atteggiamento sprezzante e provocatorio. «No» replicai. «Ma sono conosciuto anche come Merlino di Camelot.» L'espressione del suo viso cambiò immediatamente, anche se non avrei saputo come definirla. È certo comunque che si raddrizzò di colpo ed ebbi modo di avvertire una tensione improvvisa e acuta. La mia impressione fu che reagisse come un cerbiatto che, sempre all'erta per natura, di colpo si sentiva in pericolo. Ma quando riprese a parlare, nelle sue parole non c'era nulla di tutto questo. «Quest'ultimo è un nome che ho già sentito» disse con voce strascicata, mentre la sua voce e il suo viso erano completamente privi di espressione. «Bene, adesso hai anche un viso a cui associarlo. Che cosa hai sentito dire di me?» «Che disponi di un eccellente idromele.» Vuotò la sua coppa e me la porse. «Potrei averne ancora?» Quando ebbi finito di versarglielo ed ebbi riposto la fiasca, rimasi accanto al tavolo su cui era posata la cassa e guardai verso di lui. «E che altro?» Scosse la testa e finalmente sembrò più a suo agio. «Che hai un regno favoloso, molto a sud di qui, con un esercito invincibile, messo a disposizione dall'impero.» Scoppiai a ridere. «Non vorrai negarlo!» continuò. «Tutto quello che avete, tu e i tuoi uomini, non fa che confermarlo.» La sua uscita mi calmò, posai dunque rapidamente la mia coppa sul tavolo e feci un passo avanti per avvicinarmi di più a lui. «Non posso credere che tu sia stato così stupido da credere a simili sciocchezze, Niger. I Romani se ne sono andati da generazioni e non torneranno più.» Si voltò verso di me, senza che il suo viso tradisse la minima emozione, ma non cercò affatto di rispondere. Per alcuni interminabili momenti rimasi in piedi accanto a lui, sovrastandolo con tutta la mia statura, poi mi allontanai, ripresi la mia coppa e mi sedetti di nuovo. A quel punto cominciai a parlargli di Camelot. Gli dissi che portavamo armature romane per via della loro superiorità e poiché grazie all'eredità, tanto di mezzi che di conoscenze, lasciateci da coloro che avevano fondato la nostra colonia, Publio Varro primo tra tutti, eravamo ancora in grado di forgiarne. Continuai parlandogli di mio nonno, Caio Britannico, e del suo sogno di fondare una comunità difendibile che fosse in grado di sopravvivere alla partenza delle legioni e da ultimo sottolineai il ruolo di mio padre, Pico, che aveva organizzato la nostra quasi invincibile cavalleria. «Hai visto tu stesso i miei uomini e i loro cavalli» conclusi. «Eppure siamo soltanto un piccolo distaccamento, una semplice pattuglia in esplorazione. Ti assicuro che il mondo non ha mai visto nulla di simile alla cavalleria di Camelot dai tempi di Alessandro il Macedone, colui che veniva chiamato Alessandro il Grande poiché aveva usato la cavalleria per conquistare il mondo.» Appio mi ascoltava attentamente, con un viso rapito, e dunque continuai. «Adesso io comando l'esercito di Camelot insieme a mio fratello, Ambrogio. La cavalleria è mia, completamente ai miei ordini. La fanteria è sua, allo stesso modo. La Colonia tuttavia è governata da un Consiglio di Anziani. È un posto in cui si vive bene. Non abbiamo schiavi, non ci sono né povertà né privazioni. Siamo autosufficienti sia per il cibo sia per le altre risorse, e siamo abbastanza forti da far fronte ai pericoli che possono provenire dall'esterno, o almeno, lo siamo stati fino a ora.» Mi fermai un istante, poi ripresi. «E adesso, che cos'hai da dirmi di te e dei tuoi?» Ancora una volta la mia domanda cadde nel silenzio, accolta da un volto privo di emozioni, ma ormai la mia pazienza era al termine. «Appio Niger, pensa a quanto ti ho appena detto. Se la mia gente e io avessimo volontà di conquista, staremmo già facendo piani per cacciarvi e occupare le vostre terre. Sei stato tu stesso a parlare del nostro esercito "romano". Credimi, quando ti dico che è forte. Per noi non ci sarebbe nulla di più facile che raggiungere Camelot - che, tra parentesi, si trova a soli quattro giorni di viaggio da qui — e tornare alla testa di truppe che potrebbero agevolmente sconfiggere le forze che voi potreste mettere in campo, qualunque fossero. Vi troveremmo: non si può nascondere un insediamento, come non si possono nascondere i campi. Dunque sii ragionevole. Credimi quando ti dico che non abbiamo la minima intenzione di conquistarvi, di ridurvi in schiavitù o di portar via i vostri averi. E poi sii ancora più ragionevole e chiedimi che cosa ho in mente per te.» Allungò la mano per prendere la coppa e bere ancora, ma si fermò prima di averla portata alla bocca, poi si chinò e la posò delicatamente sul pavimento, accanto ai piedi, facendo attenzione a non versarne il contenuto. Finalmente si voltò verso di me, e ancora una volta, ben sapendo quale dovesse essere il turbinio dei suoi pensieri, non potei fare a meno di ammirare il suo autocontrollo. «Molto bene, allora, che cosa hai in mente per me?» «So che fai parte di un insediamento, semplicemente per via della vastità e della ricchezza dei tuoi campi, e sempre per lo stesso motivo so anche che deve essere ben difeso... ragionevolmente ben difeso, se non altro. Quello che ho in mente è che potrei consigliarti il modo di difenderlo ancora meglio. Non sono un mago, ma la logica, quando viene applicata opportunamente, può ottenere risultati che sembrano prodigiosi, e io mi vanto di essere logico.» «Hmm.» Non si mosse, e per alcuni, lunghi istanti continuò a guardare la parete di fronte, poi strinse le labbra e inspirò profondamente. Aveva finalmente deciso. «La mia famiglia mi chiama Nerone» disse. «Non chiedermene il perché, dal momento che nessuno lo sa più, ma questo è il mio nome.» Si chinò per prendere la sua coppa di idromele, ne bevve un sorso e apparve nuovamente assorto nei suoi pensieri: era evidente che cercava di mettervi ordine. Poi, quando finalmente si sentì soddisfatto, cominciò a parlare, e io rimasi ad ascoltarlo per un buon quarto d'ora. La storia che mi raccontò era molto simile a quella della nostra colonia di Camelot, ma c'erano molte e significative differenze. Proveniva da una ricca famiglia romano-britannica, la gens Appia, detta Niger per il colore dei capelli e degli occhi e il colorito olivastro della carnagione. Quanto a lui personalmente, era il primogenito della quinta generazione cresciuta in Britannia. Nonostante la giovane età, attualmente era pater familias, poiché, dopo la recente morte del padre, era lui il più vecchio della gens Appia. Suo nonno, mi disse, era morto da vent'anni. Più di un secolo prima, in questa fertile regione a nord e a est di Corinium la gens Appia possedeva delle tenute immense. I terreni di famiglia, che non avevano una propria denominazione, si estendevano vicino a Corinium in modo che la città fosse contemporaneamente la fonte dei rifornimenti e la destinazione dei raccolti di cui era prevista la vendita; allo stesso tempo erano sufficientemente lontani dalla città, perché questa attività commerciale richiedesse una programmazione ben precisa dei movimenti delle merci. Infine, aggiunse con un certo orgoglio, la lontananza dalla città era tale da permettere alla sua famiglia di avere il pieno controllo di una comunità che non veniva per nulla influenzata dagli abitanti di Corinium. Poi però, con la partenza delle legioni, quarant'anni prima o poco più, erano avvenuti enormi cambiamenti. Nel giro di tre anni i mercati erano scomparsi poiché le flotte che avevano trasportato il loro grano e la loro avena non navigavano più nelle pericolose acque della Britannia, per timore dei pirati che avevano iniziato a dilagare ovunque, anche prima che la flotta militare romana se ne fosse andata. Le stesse città costiere erano state ben presto abbandonate dalle popolazioni, ormai indifese, che le avevano invece abitate per secoli, protette dalla presenza romana. Dall'oggi al domani il commercio era cessato. Il denaro aveva perso qualsiasi valore. La fame si era diffusa tra coloro che non avevano né la capacità né i mezzi per produrre essi stessi il proprio cibo, mentre saccheggi e razzie andavano diffondendosi in una regione che per secoli aveva conosciuto soltanto scambi pacifici e condizioni di vita assolutamente tranquille. La comunità che faceva capo alla famiglia Niger non aveva avuto un lungimirante Caio Britannico che l'avesse preparata in tempo per una simile catastrofe, né un Publio Varro che avesse fornito alla sua gente gli attrezzi indispensabili a sopravvivere in tempi sempre più difficili. Nonostante ciò, tuttavia, era riuscita ad adattarsi molto velocemente alle nuove circostanze. C'era abbondanza di soldati e di abili dirigenti, dal momento che la famiglia Niger aveva onorevolmente servito l'impero per secoli. Il nonno di Nerone, valutando accuratamente la portata e le implicazioni dei recenti cambiamenti - una drastica diminuzione della quantità di grano seminato e coltivato e, parallelamente, il radicale aumento delle forze necessarie per proteggere i raccolti dalle razzie - aveva immediatamente indirizzato i suoi contadini, ormai senza lavoro, al recupero e alla fortificazione di un vecchio accampamento romano non lontano dalle loro fattorie. L'accampamento, un'area di sosta temporanea da tempo in disuso, era situato a oltre un miglio dalla strada più vicina ed era rimasto abbandonato per un secolo o più probabilmente per due, ma la sua pianta era quella classica ed era ancora chiaramente delineata. Era ampio, tanto che a suo tempo doveva essere stato in grado di alloggiare, sia pure spartanamente, una coorte di passaggio, formata da ben cinquecento uomini. I contadini di Appio, lieti di avere nuovamente uno scopo e un obiettivo ben definiti, in un anno avevano dunque ricostruito e adeguatamente fortificato l'antico accampamento. Infine, comprendendo quanto fosse importante la protezione e la sicurezza offerte dal vecchio forte, si erano trasferiti con le famiglie e i servi tra le mura appena restaurate e avevano ridefinito le terre arabili, facendo in modo che tutti i campi da loro coltivati fossero difendibili e facilmente raggiungibili. Il che li aveva costretti ad abbandonare molti terreni fuori mano - come in un primo momento avevamo dovuto fare anche a noi a Camelot - e a strappare nuove terre alla foresta che circondava il loro nuovo forte; in questo modo tutte le fattorie formavano una sorta di ampio, sebbene irregolare, cerchio la cui estensione era determinata dalla distanza che una colonna di uomini in marcia poteva coprire in mezza giornata, qualora dovesse correre in loro difesa. Anche questo mi richiamò alla mente molti ricordi, poiché, fino a quando non eravamo stati in grado di disporre di un'efficiente cavalleria, anche a Camelot eravamo stati legati dalle stesse limitazioni. Da quel momento in poi, tutta la loro comunità si era progressivamente adattata, facendo continui aggiustamenti e trovando le soluzioni più consone a una miriade di situazioni ed eventi. Mentre prima ogni uomo era stato un semplice contadino, adesso tutti erano stati costretti a diventare anche soldati, o quanto meno combattenti in grado di difendersi individualmente e di unirsi in modo da formare un fronte unico e compatto qualora se ne fosse presentata la necessità. Non si esercitavano regolarmente, e cioè ogni giorno, come fanno i veri soldati, mi disse Nerone, ma rispettavano la disciplina e conoscevano le tecniche adeguate alle armi di cui disponevano, quel tanto che bastava a far sì che fossero in grado di combattere insieme. Lo interruppi per chiedergli quanti uomini avesse al momento sotto le armi. Mi rispose che il nerbo del loro esercito era formato da cento uomini, e che facevano ogni sforzo perché non diminuissero. Costoro erano strettamente irregimentati, disciplinati e le loro prestazioni erano molto vicine a quelle di soldati di professione, almeno stando a quanto affermava il soldato più anziano, un veterano di una settantina d'anni che aveva fatto parte delle legioni. Il padre di Nerone aveva comandato questo contingente fino a quando era morto. Ora il compito spettava a Nerone stesso. Oltre a quel centinaio, mi disse, potevano disporre di un contingente aggiuntivo di una sessantina di uomini - ma il loro numero non era fisso - che si allenavano di tanto in tanto e individualmente, e che nominalmente venivano considerate truppe di riserva, dal momento che il loro compito principale doveva essere portato a termine sui campi di grano, piuttosto che sui campi di battaglia. Dal suo leggero sorriso potei dedurre che Nerone era assai compiaciuto dell'analogia che gli era venuta in mente. Annuii, in attesa che continuasse, ma evidentemente aveva detto tutto quello che intendeva dire. «Con quale frequenza vi capita di dover combattere?» «Non molto di frequente, grazie a Dio. Già da parecchio tempo abbiamo scoperto che un'adeguata esibizione di forza spesso è un deterrente sufficiente. Questo è il motivo per cui manteniamo i nostri cento soldati ben allenati e disciplinati. Dieci pattuglie da dieci uomini ciascuna fanno una certa impressione quando si schierano in formazione da combattimento e dimostrano di sapere il fatto loro. Nove volte su dieci gli avversari si limitano a squagliarsela, preferendo andare alla ricerca di un obiettivo più facile.» «Allora non posso fare a meno di chiederti questo: come mai eri solo quando i miei uomini ti hanno trovato?» Nerone si strinse nelle spalle. «Puro caso. Stavo cacciando, e quando ho visto i tuoi uomini, mi sono nascosto, più per curiosità che per paura. Uomini a cavallo e in uniforme erano qualcosa che non avevo mai visto prima.» «Mi stai dicendo che vai a caccia con l'armatura? In nome di Dio, ma che cosa stavi cacciando?» Questa volta scoppiò a ridere. «No, no! A dire la verità, questa mattina avevo litigato con mia moglie ed ero uscito di casa su tutte le furie, senza pensare esattamente dove stessi andando. Avevo indosso l'armatura perché avevo appena preso parte alle esercitazioni insieme ai miei uomini, ed ero armato di arco e frecce semplicemente perché le avevo con me quando ero arrivato a casa. Ma Denalda era fuori si sé ed era arrabbiatissima con me per qualcosa che in realtà non avevo fatto: sei sposato?» Scossi la testa: «Non ancora». «Allora non sposarti, mai. In ogni caso, ero furibondo - le mogli riescono molto meglio di qualsiasi nemico a ridurre un uomo nell'impossibilità di parlare - e camminai senza meta per miglia, finché il peso dell'armatura non mi fece capire che ero stanco e che mi ero comportato da stupido. Mi sedetti sotto un albero - doveva essere passato da poco mezzogiorno - e mentre ero seduto vidi in lontananza un cervo che entrava nel bosco. Abbastanza contento, mi tolsi l'armatura, presi arco e frecce, e me ne andai a caccia. Circa un'ora dopo, magari anche di più, vidi l'avanguardia dei tuoi uomini che cavalcava attraverso i miei campi. Come ti ho già detto, mi sono incuriosito e sono rimasto a guardarli per un po', cercando di scoprire se avevano intenzioni ostili. Il buon senso mi diceva che doveva essere così, tuttavia il loro comportamento, il semplice modo in cui stavano cavalcando, indicava altrimenti. Dopo un po', mi diressi verso il punto in cui avevo lasciato la mia armatura e l'indossai di nuovo, pensando di tornare a casa e allertare la mia gente. Erano passati appena pochi istanti e i tuoi uomini hanno cambiato direzione, puntando dritto verso di me. Ho cercato di nascondermi. Il resto lo sai già.» «Hmm. Dunque tu avresti, quante? Cinquecento persone, una più una meno, che vivono nel vostro forte?» «Di più. Attualmente siamo quasi un migliaio, contando le donne e i bambini. Da più di dieci anni abbiamo superato la capienza del forte, e ora molte persone vivono e lavorano fuori dalle mura. Era inevitabile. Non c'era abbastanza spazio per tutti i locali di cui avevamo bisogno: la bottega del vasaio, del bottaio e del ciabattino, il laboratorio di chi fa le tegole, la taverna e il panificio, per non parlare dei recinti del bestiame e dei magazzini in cui custodire le provviste. Certamente li avete anche a Camelot, non è così?» «Sì, li abbiamo, ma il nostro forte sorge sulla sommità di una collina. Avete allargato la cerchia delle vostre mura per proteggere il vicus, il vostro nuovo borgo?» «No. Ne abbiamo parlato per anni e tutti sono d'accordo che è indispensabile fare qualcosa. È il nostro punto debole, è lì che siamo più vulnerabili. Sappiamo che la nostra situazione attuale è pericolosa. Qualche giorno qualcuno marcerà, o cavalcherà, contro di noi e, se saremo ancora impreparati come lo siamo oggi, ne subiremo tutti le conseguenze. La verità tuttavia, per quanto sembri incredibile quando se ne discute come facciamo ora, è che non appena arriva il momento di impegnarsi seriamente per quello che si rivela un compito lungo e difficile, si ha sempre l'impressione che ci siano necessità più impellenti, e l'ampliamento delle mura viene rimandato ancora una volta.» Si fermò, meditabondo, poi aggiunse: «La gente è pigra quando non si sente minacciata... o quando manca un capo risoluto e deciso che imponga l'ubbidienza». «Tu non sei risoluto e deciso?» Mi guardò, mentre sulle labbra gli aleggiava ancora quel sorrisetto ironico. «Lo sono, ma sono anche giovane ed è troppo poco che ho assunto il comando. Troppi interessi, consolidati da tempo, finiscono con l'avere la precedenza.» «Allora devi cambiare le cose.» «Questo lo so anch'io. Quello che non so è come.» Sorrisi. «Adesso vuoi ascoltare la mia idea? Per ora è soltanto abbozzata, ma lavorandoci insieme possiamo definirla meglio.» «Credo proprio che questo sia il momento» disse, annuendo. «Poiché anch'io ho appena avuto un'idea.» «Bene. Per ora, basta idromele. Vieni, andiamo insieme a incontrare alcuni dei miei uomini e intanto ti faccio vedere come opera un accampamento di cavalleria.» IV. Trovare un accordo fu molto facile e Nerone Niger si gettò a capofitto nella proficua collaborazione che, fin dall'inizio, mi parve possibile instaurare tra di noi. Entrambi avevamo avuto la stessa intuizione: che la nostra presenza nel suo territorio, se opportunamente sfruttata, avrebbe potuto convincere i suoi della necessità di migliorare immediatamente le proprie difese. Tuttavia le nostre discussioni andarono molto oltre, indirizzandosi verso un piano che avrebbe fatto impallidire al confronto la lezione che intendeva dare alla sua gente. Come spesso accade nelle questioni veramente importanti, le parti interessate in un primo momento procedettero in modo lento e graduale, ma ben presto si fusero, combaciando perfettamente in un crescendo di intuizioni e di soluzioni brillanti. Ricordo perfettamente il mio genuino stupore quando, verso la fine delle nostre discussioni, scoprii che il problema che mi ero posto nei confronti di coloro che abitavano nelle terre fuori dai confini di Camelot era strettamente legato agli obiettivi della Colonia originaria fondata da Caio Britannico e Publio Varro: la capacità di adattarsi e di sopravvivere di fronte all'inimmaginabile. Nelle settimane seguenti, il mio inatteso, ma intenso coinvolgimento con Nerone Niger e le difficoltà del suo clan mi permise di vedere le cose con una prospettiva diversa, priva di remore. Avevo finalmente trovato il cammino che da tanto tempo stavo cercando. Avrei voluto descrivere quello che accadde in quelle settimane come un inizio, anche se, in effetti, non sarebbe stato esatto: il vero inizio era avvenuto decenni prima. Publio Varro aveva visto la fondazione della nostra Colonia nella sua notte di nozze, prima della nascita di mia madre, e l'aveva descritta come un'alba, come il sorgere della potenziale indipendenza e autosufficienza della Britannia. La partenza delle legioni romane nei primi anni del nuovo secolo era stato un altro inizio: quello della vulnerabilità e dell'incertezza in terre che per centinaia di anni erano state un avamposto dell'impero, forti e piene di vitalità; il tragico inizio delle invasioni che ora minacciavano l'esistenza stessa delle persone che per due secoli avevano definito patria questo paese. Tuttavia, ciò che accadde in quelle poche settimane trascorse con Nerone Niger fu molto vicino all'inizio di una nuova fase di progresso. La fine della prima fase, me ne resi conto molto tempo dopo, era iniziata anni addietro, quando il primo distaccamento della cavalleria di Camelot, forte di oltre cento effettivi, era stato inviato a portare aiuto a Dergyll ap Griffyd, che stava combattendo in Cambria. Quel contingente era rimasto sul campo per quasi due anni, senza essere impegnato se non marginalmente nei diversi combattimenti e vivendo per tutto il periodo negli accampamenti. Poiché i suoi movimenti erano stati costanti e avevano interessato tutta la Cambria meridionale, a nessuno sarebbe mai venuto in mente di considerare quel contingente un presidio, ma di fatto lo era, sebbene il suo ruolo fosse stato diplomatico più che militare in senso stretto: una presenza mobile, di supporto, il cui potenziale aveva impedito al nemico di scendere dalle colline prima che Dergyll fosse sufficientemente forte da sconfiggerlo. Questa spedizione, che aveva segnato la prima volta in cui un reparto della nostra cavalleria si era allontanato dalla base, operando in maniera indipendente da Camelot, era stata la prova dell'abilità della nostra Colonia di influenzare gli eventi, intervenendo su altri gruppi alleati. Analogamente, l'insediamento di una guarnigione a Mediobogdum, regolarmente rifornita di rimpiazzi, di rinforzi, di personale, di armi e di cavalli inviati da Camelot, aveva dimostrato che la Colonia era ormai abbastanza forte da potersi permettere di mantenere sia le proprie truppe sia un altro esercito, per quanto piccolo, a centinaia di miglia di distanza, e soprattutto senza eccessivi inconvenienti. Il fatto che stessimo tornando a casa, dopo aver abbandonato l'avamposto che per qualche tempo era stato la nostra base nel nord-ovest, non sminuiva per nulla il successo della guarnigione. Ciò che era veramente importante, ciò che contava di più, era che avessimo vissuto lì per oltre cinque anni, e che per tutto quel tempo la guarnigione che vi avevamo insediato avesse funzionato benissimo, integrandosi perfettamente nel territorio, coesistendo con la gente del posto in armonia e con reciproco vantaggio. La logica indicava dunque che una guarnigione di Camelot era assolutamente in grado di prosperare in qualsiasi area della Britannia. Fu questa constatazione a spingermi a occuparmi delle difficoltà del clan di Nerone, del loro piccolo esercito e delle loro mura insufficienti. Così, per quanto semplice, la soluzione da me individuata per ovviare al loro problema fu motivo di progresso. Già sul finire di quella prima notte avevamo deciso che Nerone sarebbe tornato a casa l'indomani e non avrebbe fatto parola con nessuno del suo incontro con la nostra cavalleria. Il giorno successivo, avremmo inscenato un finto attacco al suo insediamento per spaventare i suoi, spingendoli così a comprendere come in futuro un attacco del genere potesse essere reale e quanto fosse indispensabile che vi si preparassero adeguatamente. Il piano, apparentemente semplice, richiese tuttavia un'attenta preparazione a cui presero parte tutti gli ufficiali presenti; poi toccò all'intero contingente essere messo al corrente delle modalità dell'attacco. L'ultima cosa al mondo che potevamo desiderare era che nel corso di quella messa in scena fosse sparsa anche una sola goccia di sangue. Pertanto il mattino seguente radunai gli ufficiali e poi tutti i nostri effettivi per un ulteriore aggiornamento, illustrando gli obiettivi dell'esercitazione per quanto era di loro competenza e approfittandone per presentarli a Nerone Niger. Non appena l'assemblea fu sciolta Nerone si mise in marcia per tornare a casa e Dedalo e io stesso l'accompagnammo fino al limite del nostro accampamento. Sulla strada del ritorno, Dedalo era insolitamente silenzioso, tanto che non potei fare a meno di chiedergli che cosa avesse in mente. Fece ancora qualche passo senza rispondermi, poi mi guardò aggrottando la fronte. «Vuoi a tutti i costi che questo finto attacco funzioni, non è così? Questo l'ho capito benissimo, ma non mi piace affatto. È pericoloso come una baldracca con i denti affilati. Perché correre il rischio che qualcuno di questi sprovveduti si lasci prendere dal panico e metta a segno una o due frecce, colpendo qualcuno dei nostri prima che abbiamo modo di dire loro che è tutta una finta, un'esercitazione in vista di pericoli futuri? La morte anche di uno solo dei nostri uomini sarebbe un prezzo troppo alto da pagare, almeno così sembra a me, qualunque possa essere il risultato di questa azione. Cosa ci importa se costoro sono pronti o non lo sono affatto? Non sono abbastanza numerosi perché cambi qualcosa. Quanti uomini hanno, un centinaio? Non è una guarnigione, al massimo è un caposaldo, e per giunta ridotto all'osso.» Non tentai neppure di rispondergli fino a quando non fummo di ritorno al centro dell'accampamento; poi feci un cenno in direzione della tenda destinata al comando e suggerii di riprendere lì la nostra conversazione. Mi seguì senza dire una parola e si sedette sull'unica sedia comoda, accanto alla tavola destinata all'ufficiale della guardia. Quindi si appoggiò allo schienale e incrociò le braccia sul petto, appoggiandole sulla corazza, in attesa che io parlassi. Tra tutti noi, Dedalo era quello che aveva la lingua più affilata e forse l'intelligenza più vivace. In passato mi aveva colpito così tante volte con il suo intuito e la sua capacità di cogliere al volo il punto debole di ogni situazione che da lui non mi aspettavo niente di meno. Mi appoggiai dunque sul bordo del tavolo, proprio davanti a lui. «Hai ragione, Ded» ammisi. «È pericoloso. Ma ho considerato il rischio, e credo che ne valga la pena. Se riusciremo a convincere questa gente a rafforzare le proprie difese, avremo creato un'isola ben armata proprio al centro di questa regione. Sono d'accordo con te che cento uomini non fanno una guarnigione, ma potrebbero costituirne l'inizio. Sai benissimo che un tempo anche Camelot non aveva più di un centinaio di uomini d'armi e guarda qual è oggi la nostra forza!» «Sì, ma quanto c'è voluto? Sessantacinque anni? Sessantacinque anni per arrivare a essere forti. Ma queste persone non hanno tutto questo tempo a disposizione. E perché poi vorresti creare un'isola sicura da queste parti? Che differenza può fare? Questa gente potrebbe essere spazzata via domani, o la prossima settimana.» «È vero, ma forse potrebbe non essere così, se fosse aiutata.» Si irrigidì leggermente e i suoi occhi si spalancarono in modo quasi impercettibile. «Aiutata da chi, da Camelot?» «Perché no?» Distolse lo sguardo, come mi ero aspettato che facesse, mentre il suo viso si faceva sempre più scuro a mano a mano che inseguiva i pensieri che gli frullavano per la testa. Finalmente mi guardò di nuovo negli occhi. «Stai prendendo in considerazione l'idea di trattenere i nostri uomini qui, per aiutare questa gente?» «No, assolutamente no.» «Bene, che Cristo sia lodato per questo! I nostri soldati non vedono l'ora di andare a casa, e se lo sono davvero guadagnato.» «Certamente. Ma quello che ho in mente è di inviare un altro contingente, una volta che saremo arrivati a casa, che faccia esattamente quello che hai detto. Forse un centinaio di uomini.» «Ma è un lusso che non possiamo permetterci, Merlino, non abbiamo un centinaio di uomini da sprecare così. Stiamo per entrare in guerra, quanto meno in Cambria, e forse anche contro i Danesi della Northumbria.» «Non è un lusso, Ded, è una necessità. Un giorno o l'altro, avremo bisogno dell'aiuto di gente come il clan di Appio Niger e temo che non passerà molto tempo. Ma allora dovranno esserci decine e decine, forse centinaia, di insediamenti simili, sparsi su tutto il territorio. Pensaci: anche soltanto un paio di decine, che possano mettere in campo un centinaio di uomini ciascuna, ci procurerebbero una forza di duemila uomini.» «No, Merlino, usa la testa! Che ne è della tua logica? Una decina di insediamenti di questo tipo non ci procurerebbe ma ci priverebbe di un migliaio di uomini, sparpagliati in dieci diverse guarnigioni, piccole e inutili.» Mi caddero le braccia mentre dovevo ammettere l'indiscutibile verità di quanto aveva appena detto, eppure... «Dannazione, Ded, so di avere ragione. Hai letto anche tu l'ultima lettera di Ambrogio, quando parlava dei problemi che devono affrontare a Camelot. Pur con gran parte delle nostre truppe attualmente acquartierate a Dchester e con i campi che abbiamo aggiunto a quelli che già avevamo, siamo quasi al punto di avere troppe bocche da sfamare e troppe teste a cui dare un tetto. Questo potrebbe essere un modo per alleggerire l'affollamento, almeno temporaneamente, e per nutrire tutti meglio! Guarda quanti campi fertili ci sono qui intorno che, restando inutilizzati, finiranno per andare in malora e dimmi perché deve essere così! Da queste parti c'è una gran quantità di manodopera che continua a rimanere in ozio, e non sto parlando solo di combattenti. Sto pensando soprattutto ai contadini, gente senza casa che vive ai margini della foresta, gente che ha trovato riparo in capanne di fortuna nei dintorni di città ormai in rovina, migliaia di derelitti che sopravvivono come possono, vivendo isolati perché temono che raggruppandosi in insediamenti più grandi attirerebbero i razziatori. Se di questi infelici ce ne sono abbastanza da queste parti, e se possono essere radunati e portati a vivere insieme per il loro stesso bene, per la loro protezione e il loro benessere, se in qualche modo si riesce a insegnare loro a credere alla semplice possibilità di tutto ciò, allora saranno invincibili tanto saranno numerosi. Tuttavia, so anche che tu hai ragione. Da un punto di vista logistico sarebbe quasi impossibile, e su questo c'è poco da fare. Non possiamo insediare guarnigioni in tutti i centri che ci chiedono aiuto. Non disponiamo di forze sufficienti, anche se siamo forti. Da parte mia si è trattato soltanto di un pio desiderio, nient'altro. Perdonami per averti costretto ad ascoltarmi.» Dedalo rimase in silenzio ancora per un po', mordendosi il labbro; quel suo atteggiamento tanto insolito mi sorprese non poco: conoscendolo mi sarei infatti aspettato che scattasse in piedi e si congratulasse con me per aver dato ascolto alle sue obiezioni. «Bene,» disse infine pensieroso «dopo quello che mi hai appena detto, se considero tutta la faccenda da un punto di vista leggermente diverso non mi riesce più di capire quanto tu sia davvero fuori strada. Forse vale la pena di pensarci su. Tutto sommato nella tua idea c'è un bel po' di buon senso. Hmm...» Attesi mentre la sua voce si perdeva in un lungo silenzio. Poi riprese borbottando. «Non so. A dire la verità penso che l'unica cosa che non va sia la realizzazione.» «Che cosa vuoi dire?» Sbuffò, ma era quasi una risata. «Tu sei mezzo romano. Fallo per metà alla maniera romana, ma questa metà completala.» Lo guardai pieno di stupore. «Non ho idea di che cosa tu stia parlando.» «Sì che ce l'hai, se solo ci pensi un attimo. In che modo i Romani hanno creato i loro possedimenti, al tempo della repubblica e poi dell'impero?» Lo fissai, consapevole di un barlume di eccitazione che cominciava a farsi strada nel mio petto. «Trasformando i popoli conquistati in alleati, utilizzandoli come truppe ausiliarie e insegnando loro a combattere con la tecnica romana.» «Giusto. Ma Camelot non ha alcun bisogno di conquistare le persone di cui stavi parlando, dunque in questa fase non ci sarà spargimento di sangue. Tutto quello che devi fare è convincerli che hanno bisogno di aiuto e che tu sei disposto a darglielo. Non dovrebbe essere difficile. Devi ridare loro la speranza che hanno perso. Nulla di più facile, in fondo. Manda pattuglie, inviale con scadenza regolare, e ciascuna sia formata da una coorte. Ordina a ciascuna coorte di fermarsi due giorni in ogni località che deve visitare. Non appena vi sarà giunta, vi costruirà un accampamento fortificato e quando poi se ne andrà, lo lascerà, intatto, a uso della gente del posto. In ogni caso, non mancano certo gli alberi con cui costruire palizzate. Muri fatti di tronchi d'albero e robusti parapetti di terra danno una concreta sicurezza. Una volta ultimati gli accampamenti, i locali potranno costruire all'interno delle mura e fare loro stessi da guarnigione, mentre Camelot potrà fornire l'addestramento di base di cui hanno assoluto bisogno. Non sarà necessaria una base permanente di un migliaio di effettivi, ma se per fare questo designerai quattro diverse coorti e le terrai occupate, alternandole due a due in continui pattugliamenti, alleggeriremo l'affollamento nella nostra Colonia, impegnando in modo proficuo un migliaio di uomini e soprattutto tenendoli lontani da Camelot a tempo pieno. Ma il bello è che saranno anche facilmente raggiungibili, qualora ci trovassimo in difficoltà. Venti uomini per ogni accampamento, in un primo momento, un drappello di cavalleria e uno di fanteria, dovrebbero raggiungere il risultato che vuoi. Infine, ottieni il sostegno dei capi locali, degli anziani e dei maggiorenti, e il loro entusiasmo infiammerà gli altri. Non appena avranno visto che possono difendersi da soli, il nostro compito sarà quasi completato. Oltre a questo, tutto ciò che resterà ancora da fare sarà inviare regolarmente delle pattuglie che passino a controllare secondo una scadenza ben precisa e offrano la speranza di un aiuto qualora si verifichi un'invasione o un attacco. Nient'altro. Poi, se la guerra arriverà nella regione, avremo delle truppe locali con cui combattere.» Si fermò, lasciandomi il tempo di digerire quanto aveva detto, quindi aggiunse: «Funzionerà, Merlino. La tua idea era giusta, era il modo in cui intendevi realizzarla che non andava bene. Non ringraziarmi per le mie intuizioni. È terribilmente noioso dover ascoltare in continuazione espressioni di gratitudine...». Rimasi a sedere, sbalordito, meditando sui possibili sviluppi della situazione che aveva appena prospettato. Dedalo, quando fu certo di avermi dato elementi sufficienti su cui riflettere, sbadigliò, si stiracchiò, e poi scattò in piedi borbottando qualcosa sul bisogno di farsi un sonnellino, dal momento che era stato in servizio tutta la notte. Mi accorsi a mala pena che stava uscendo. Così, semplicemente e in apparenza del tutto casualmente, ebbe inizio il processo che avrebbe cambiato la terra di Britannia e trasformato il destino di Artù da quello di comandante legato delle forze di Camelot in Riothamus, sommo re della Britannia Occidentale. Che tutto questo sia potuto accadere fu strabiliante; che sia accaduto così rapidamente fu pressoché miracoloso; il fatto è che il momento e le condizioni erano adeguate alle necessità, e il lievito che ispirò il cambiamento fu la speranza. Il nostro "attacco" all'insediamento di Nerone fu un vero successo. Nonostante il terrore che provocò alla sua gente, il sollievo prodotto dalla rivelazione che si era trattato semplicemente di un espediente architettato dal loro comandante fu tale da far superare l'eventuale risentimento di alcuni membri della comunità, soprattutto dei più anziani. Durante l'incursione nessuno fu ferito, e questo era già di per sé un segno della perfetta riuscita dell'attacco e del livello di impreparazione e di inefficienza degli uomini di Nerone. Ad azione compiuta, quando Nerone ebbe spiegato all'assemblea generale della sua gente a che cosa mirassimo un'alleanza tra la loro comunità e Camelot, alleanza che nella fase iniziale sarebbe stata pesantemente sbilanciata a loro favore - fu rapidamente presa la decisione di dare inizio immediatamente ai lavori di fortificazione. Il che portò ben presto all'identificazione del vero motivo per cui fino a quel momento non si era fatto nulla: quello che mancava non era la volontà di intraprendere il lavoro, ma la capacità, dal momento che tra la gente di Nerone non c'era nessuno che disponesse delle conoscenze indispensabili per innalzare quelle mura così terribilmente necessarie. Persino il soldato più anziano, un autentico veterano delle legioni romane, non aveva mai partecipato alla costruzione di un accampamento fortificato. In parole povere, non aveva mai prestato servizio sotto Caio Britannico e Publio Varro. Mentre assistevamo alla crescente costernazione della gente di Nerone, diedi uno sguardo a Dedalo, che dapprima guardò Benedetto e Filippo, poi si consultò con loro, parlottando a bassa voce. Qualche istante dopo, si voltò e mi fece un cenno. «Due giorni» disse. «In due giorni possiamo tracciare la pianta, indicare quali alberi tagliare e come innalzare la palizzata, e infine aiutarli a iniziare lo scavo.» Si fermò, guardandomi dritto negli occhi. «Non vorrai che i miei uomini facciano lo scavo per loro, non è così?» Gli sorrisi. «Come può venirti anche soltanto in mente di fare una domanda simile?» Il terzo giorno riprendemmo il nostro viaggio verso casa, dopo aver lasciato la gente di Nerone impegnata nelle opere di fortificazione. Avevo promesso di inviare un'altra spedizione che controllasse i progressi del loro lavoro non appena fossimo arrivati a casa e avessimo presentato la nuova alleanza al Consiglio di Camelot. Se il Consiglio avesse dato la sua approvazione, promisi che la nuova spedizione avrebbe portato aiuti e rifornimenti sotto forma di armi e armature. Ci sarebbero stati anche degli istruttori che avrebbero lavorato con la guarnigione di Appio, addestrando nuove reclute e insegnando loro non solo a maneggiare le armi ma anche le più elementari tecniche di combattimento. Nel contempo, queste truppe avrebbero lavorato con Nerone e i veterani per mettere a punto le strategie necessarie per organizzare la difesa della loro comunità. Il nostro taciturno Benedetto si era subito offerto di guidare la spedizione successiva e, già di per sé, questo lasciava ben sperare. Durante gran parte dei cinque anni seguenti Camelot andò in guerra senza coinvolgere minimamente nessuno dei suoi nuovi alleati, e lo fece su due fronti distinti, il che normalmente viene considerato suicida dagli esperti di strategia militare. Eppure il cambiamento radicale che ho appena descritto continuò senza alcun impedimento, in grandissima parte agevolato dai costanti sforzi e dai continui incoraggiamenti degli uomini di Camelot. In qualsiasi altro momento e in qualsiasi altro luogo, quanto fecero i nostri eserciti in quei cinque anni sarebbe stato giudicato impossibile. Che una comunità - perché questo eravamo, una semplice comunità, non uno stato e neppure una città - potesse dedicare se stessa e tutte le proprie risorse a due guerre, su due fronti e per di più contemporaneamente, sarebbe sembrato assurdo agli occhi di persone civili e sane di mente. Nonostante tutto, fu proprio questo ciò che facemmo, e il motivo per cui ci riuscimmo, se dichiarato senza tanti giri di parole, potrebbe apparire banale: era il nostro momento. Camelot, la giovane, vigorosa Colonia in cui si realizzava il sogno dei suoi due fondatori, stava entrando nel periodo di massimo splendore. Da quando era stata creata erano passati più di sessantanni, gran parte dei quali erano stati dedicati diligentemente e incessantemente a prepararsi per far fronte alla catastrofe e per sopravvivere alle sue conseguenze. Avevamo un esercito ben disciplinato, forte di novemila uomini, oltre la metà dei quali costituita da una ben addestrata cavalleria pesante, comandati da ufficiali di prim'ordine, con comportamenti e principi modellati sugli ideali della Roma repubblicana. Avevamo costituito tre armate, piccole ma efficaci, ciascuna delle quali aveva un numero di uomini pari alla metà di una legione romana tradizionale, poiché comprendeva millecinquecento fanti e altrettanti cavalieri; anche se le dimensioni erano la metà di quelle di una legione, ciascuna armata aveva un'efficienza più che doppia di quella mai raggiunta da qualsiasi altra. La loro potenza e la loro terribile forza d'urto erano il risultato della mobilità e della versatilità della nostra cavalleria: una cavalleria pesante di mille uomini e un contingente più veloce e armato in modo leggero - un'innovazione pensata e messa a punto da mio fratello nei cinque anni da me trascorsi a Ravenglass - per ciascuna delle tre armate. L'associazione di un armamento superiore, di una disciplina ferrea e di uno stato maggiore efficiente diedero a Camelot la supremazia in Britannia, ma ciascuno di questi tre elementi dipendeva strettamente dagli altri due. V. Sebbene fossi nato e cresciuto a Camelot e, dalla morte di mio padre, ne fossi stato il comandante legato, quanto trovai al mio ritorno mi prese alla sprovvista e mi commosse fin quasi alle lacrime. Avevo lasciato una Colonia prospera, ma che, malgrado l'aspetto militare delle fortificazioni, era essenzialmente una comunità agricola, sia pure di notevoli dimensioni, dominata da una fortezza appollaiata sulla sommità di una collina. Ciò che trovai dopo i cinque anni di assenza era talmente diverso che mi riusciva difficile cogliere appieno i cambiamenti. Tutto cominciò non appena arrivammo al punto in cui la strada secondaria che porta a Camelot si congiunge con la strada principale che va a sud, verso Isca. Questa strada secondaria, pur essendo molto usata, non era altro che una semplice pista, due solchi di ruote, ampi e paralleli, divisi da una striscia centrale di terreno non spianato ed erboso, larga quanto un assale di carro. Ora invece era diventata una strada, larga il doppio di prima e perfettamente livellata, priva di tracce di erba o di solchi lasciati dalle ruote dei carri sulla sua superficie inghiaiata. Invece di puntare direttamente verso la strada principale, in modo da formare una T, la nuova strada piegava verso destra proprio all'altezza dell'incrocio, per poi confluire nella grande via romana, puntando verso sud, verso Ilchester e la nuova guarnigione, come capii più tardi. A una cinquantina di passi dalla strada principale c'era un nuovo edificio destinato al distaccamento di guardia; era una costruzione di pietra, con un tetto di spesse tegole, grande abbastanza da alloggiare una ventina di uomini e dotata di stalle per dieci cavalli. Le sentinelle uscirono immediatamente e si misero in riga non appena Dedalo, Filippo e io, che cavalcavamo alla testa del nostro gruppo, arrivammo all'incrocio. Ogni movimento era militarmente perfetto, la disciplina del distaccamento esemplare. Il comandante della guardia, un decurione a me sconosciuto, si fece avanti per dare formalmente il benvenuto a Filippo e Dedalo, poi permise a tutti noi di passare. A dire la verità aveva guardato anche me, ma senza riconoscermi; ne rimasi sorpreso e avvilito: ero a Camelot, a casa mia e non mi avevano riconosciuto! Poi mi ricordai che, subito dopo la mia partenza, avevo fatto di tutto per cambiare il mio aspetto il più radicalmente possibile, dal colore dei capelli al tipo di abbigliamento; avevo persino cercato di mutare il portamento. Avevo voluto diventare, ed ero diventato, mastro Cay, un semplice contadino quanto più diverso possibile dal comandante Merlino di Camelot. E in effetti il comandante della guardia che mi aveva guardato aveva visto soltanto un contadino a cavallo, vestito modestamente, che cavalcava a fianco dei capi di una spedizione militare di ritorno alla base. Comunque, lo smarrimento scomparve in fretta e la cosa cominciò a divertirmi. Rimasi indietro, fermo accanto al posto di guardia, in paziente attesa che i miei compagni d'arme proseguissero, lasciando che gli squadroni che avevo comandato mi sfilassero davanti finché fui raggiunto dai carri. Shelagh e Donuil e tutte le loro masserizie riempivano il primo, poi veniva Tressa, seduta a cassetta sul nostro, accanto a Derek che lo guidava. La sua cavalcatura, uno dei cavalli di Camelot che io stesso gli avevo regalato, era legata al fondo del carro e avanzava con tranquillità. Mentre passavano feci loro un cenno, poi sollevai una gamba, facendola passare sulla schiena del mio cavallo, e dalla staffa saltai direttamente sul retro del carro, legando le redini accanto a quelle del cavallo di Derek, prima di infilarmi nell'interno per cercare di raggiungere Tress e Derek; avanzavo con cautela e a un certo punto fui costretto persino ad arrampicarmi su casse e cassette. Mi sistemai alle loro spalle, inginocchiandomi su di un sacco e infilando la testa in mezzo a loro dopo aver dato un bacio sulla guancia a Tress. Derek si voltò a guardarmi. «A che cosa dobbiamo un simile onore? Noi siamo dei semplici visitatori. Per te invece questo è un ritorno a casa: dovresti essere là davanti, alla testa dei tuoi uomini.» Risi, ma si trattò di una risata amara quanto bastava perché Derek si voltasse di nuovo per guardarmi più attentamente; a quel punto dissi loro che cosa avevo appena scoperto circa il mio attuale aspetto. Dopo qualche istante Tress mi chiese perplessa: «Ma eri davvero così diverso allora?». Naturalmente Tress non mi aveva mai visto senza travestimento e dunque non sapeva come fosse l'uomo che Connor chiamava Testa Gialla. Fin dal primo momento in cui ci eravamo conosciuti ero sempre stato Cay dai capelli castani e dagli abiti semplici del contadino. Avevo appena ricominciato a ridere quando la consapevolezza della realtà mi fece morire la risata sulle labbra. «Bene,» borbottò Derek «Merlino di Camelot non esiste fuori dalla sua armatura. È forse importante in questo momento? Non credo proprio, visto che l'armatura non può fare nulla senza l'uomo che la indossa. Il fatto che non ti abbiano riconosciuto significa semplicemente che nessuno si accorgerà che sei tornato a casa finché tu stesso non deciderai di farti riconoscere; il che vuol anche dire che, per il momento, sei libero di sederti qui con noi e di spiegarci tutto quello che vediamo lungo la strada.» Feci scivolare il braccio destro attorno alla vita snella e morbida di Tress e appoggiai la mano sinistra sulla spalla di Derek. «Potrei non essere neppure in grado di fare questo, amico mio, dal momento che già ora sono assai perplesso. Quando sono partito, il posto di guardia non c'era e la strada su cui stiamo viaggiando era soltanto una vecchia pista erbosa. Per ora sono le uniche due cose che mi dovrebbero essere familiari, invece sono cambiate tanto da essere irriconoscibili. Cercherò comunque di mostrarvi quello che posso. Però dovete farmi posto: Tress, spostati verso il centro così mi potrò sedere accanto a te, dalla parte della strada.» Da quel momento in poi, lungo tutto il tragitto per arrivare a Camelot vidi novità ovunque e feci del mio meglio, almeno per qualche tempo, per mostrarle loro. Da entrambi i lati della strada, gran parte degli alberi, che un tempo erano stati tanto fitti da formare una sorta di muro, era stata tagliata e sradicata; il loro legno, lo scoprii in seguito, era stato utilizzato per costruire case e mobili, e inoltre nuovi acquartieramenti a Ilchester. L'abbattimento degli alberi aveva anche permesso di creare nuovi campi, che ora apparivano sempre più vasti e numerosi ai due lati della strada. Dovunque guardassi, vedevo case, tutte di legno, anche se alcune più robuste e meglio costruite di altre. Infine, laddove un tempo non c'erano che conigli, scoiattoli, cervi e orsi che si muovevano silenziosamente nel folto della vegetazione, ora una miriade di persone erano impegnate nelle loro attività quotidiane. A mano a mano che avanzavamo, notai intorno a me dei cambiamenti così numerosi e radicali che la mia mente faceva fatica a prenderne atto, tanto che non mi restò che proseguire in silenzio, cercando di non vedere. E i miei compagni mi lasciarono stare. Quando fummo ormai vicini al termine della strada - la fortezza di Camelot distava qualche centinaio di passi sebbene fosse ancora nascosta alla nostra vista da una fitta cortina di alberi - il risuonare di voci infantili che si facevano sempre più forti mi strappò ai miei pensieri. Eravamo arrivati in un punto in cui, a destra della strada, rimanevano solo pochi alberi giganteschi. Artù, Bedwyr, Gwin e Ghilly, in groppa ai loro cavalli, erano fermi sul ciglio della strada e guardavano in silenzio il prato che si estendeva davanti a loro. Mentre ci avvicinavamo lentamente con il nostro carro, Artù si voltò verso di me, alzando le sopracciglia in una muta domanda. Le voci dei bambini, impegnati nei loro giochi allegri e chiassosi, erano talmente squillanti da coprire lo scricchiolio dei carri e il crepitio delle pietre del selciato schiacciate dalle ruote cerchiate di metallo. Sembrava che in quel prato ci fossero centinaia di bambini di tutte le età. Davano l'impressione di spuntare da ogni parte, davanti e attorno a un edificio lungo e basso, fatto di tronchi d'albero e con il tetto di paglia; nella parte superiore i muri presentavano ampie aperture, anche se si poteva chiaramente vedere il punto in cui era possibile posizionare delle imposte nei giorni con condizioni climatiche meno favorevoli. Avrei voluto fermarmi e dare uno sguardo, ma avrei dovuto costringere a una sosta tutto il convoglio che ci seguiva; così mi accontentai di allungare il collo per vedere il più possibile strada facendo. Artù fece voltare il suo cavallo e lo affiancò al nostro carro, con la palese intenzione di farmi una domanda, ma fu Derek a parlare per primo. «Che cosa diavolo succede da quella parte? Non ho mai visto tanti marmocchi riuniti nello stesso posto. È un accampamento? Un accampamento per bambini?» Scossi la testa guardando Artù, che, lo sapevo, stava ascoltando con attenzione. «No, non credo proprio. Non è un accampamento. Credo che sia una scuola.» Il viso di Derek era del tutto inespressivo. «Una che cosa? Che roba è una scuola?» «Un luogo in cui i bambini imparano le loro lezioni, a leggere e scrivere, innanzi tutto. Più o meno come facevano Artù e gli altri ragazzi a Mediobogdum. Anche noi avevamo una scuola lassù, solo che i bambini erano pochi. Questa sembra molto meglio organizzata.» Mi rivolsi ad Artù. «Perché hai una faccia così scura?» Allontanò leggermente il cavallo dal carro in modo da potermi guardare in faccia senza dover alzare troppo la testa. «Dovrò andare in quella scuola lì?» La prospettiva non sembrava piacergli troppo. Gli sorrisi. «Ne dubito proprio. La tua prossima scuola sarà un accampamento militare, se starà a me decidere. Per inciso, il più grande di quei ragazzini avrà sì e no dodici anni. Quell'età tu dovresti averla superata, non è così?» Aggrottò leggermente le sopracciglia, finché si accorse che lo stavo prendendo in giro; allora sorrise e tirò le redini, lasciandosi superare mentre faceva dietro front per raggiungere i suoi compagni. Ben presto davanti a noi risuonò il primo penetrante squillo di tromba, subito seguito da altri che gli facevano eco in lontananza, a mano a mano che si diffondeva la notizia dell'arrivo dei visitatori. Qualche istante dopo superammo l'ultima curva, ed ecco davanti a noi Camelot, imponente sulla sommità della collina. Potei udire che Tress tratteneva il respiro, mentre Derek si lasciava sfuggire un leggero fischio. «Dunque, quella è Camelot» mormorò, più a se stesso che a qualcuno in particolare. «Sì, quella è Camelot. Siamo a casa, Tress. Che te ne pare?» «È... meraviglioso» mormorò, e io risi ancora, sentendo l'orgoglio crescere dentro di me. «Non più di quanto lo sei tu, ragazza, ed è tuo, tutto tuo.» Si voltò verso di me, credendo che la stessi prendendo in giro. «Perché dici questo, Cay?» «Perché dico cosa? Che è tuo? Ma lo è! Per lo meno, è tuo tanto quanto è mio, in altre parole, tutto e niente. Le famiglie da cui provengo, quella di Britannico e quella di Varro, hanno fondato ed edificato questo luogo Tress, e da allora noi lo abbiamo difeso e governato. È stato costruito sulle terre di Britannico, ma non abbiamo mai pensato di esserne i padroni. I discendenti di Britannico sono i custodi di questo luogo, lo hanno semplicemente in consegna, ma comunque sia è affidato a loro. E come mia moglie, tu ne sarai la castellana.» «E Ludmilla?» Il gelo, del tutto inatteso, della sua voce mi lasciò sconcertato. «Ludmilla? Tu e lei...» «Ludmilla è la padrona di casa, qui a Camelot, Cay - la castellana, come dici tu - e lo è stata fin da quando tu te ne sei andato, forse anche da prima che tu te ne andassi. È la moglie di tuo fratello e lui è stato l'unico a comandare qui negli ultimi sei, quasi sette anni, il che significa che anche lei ha comandato qui. Ti aspetti forse che oggi ti sia sufficiente entrare e mandarla via, mettendo me al suo posto?» «No, ma...» «No, ma cosa? Pensi che Ludmilla si accontenterà di ritirarsi e di rinunciare a quanto ha fatto per mandare avanti questo...» Cominciò a farfugliare, cercando la parola più adatta per completare la frase. «... questa città? Credi proprio che mi sarà grata perché io, una semplice serva di Ravenglass, sono entrata nel suo mondo e l'ho mandata via?» «Tressa!» «Tressa! Tressa! Cay, sono assolutamente seria.» Sebbene parlasse con un tono pacato, la sua disapprovazione sembrava farsi sempre più profonda a mano a mano che andava avanti. «Hai mai pensato, poco o tanto, a quella che sarà la mia situazione qui? Non sono tua moglie, non ancora. In questo posto io non ho alcun diritto, e non ti permetterò di parlare o di comportarti come se ne avessi, o dovessi averne, o potessi desiderare di averne. Io sono la tua... compagna, niente più, la tua convivente, anche se la maggior parte della gente qui dirà semplicemente che sono la tua amante, il che è la verità. Ma non voglio essere considerata una presuntuosa o una piantagrane, e non voglio che qualcuno mi faccia passare per quello che non sono, soprattutto contro la mia volontà. Mi hai sentito?» «Sì, Tress, ti ho sentito benissimo. E deve averti sentita anche Shelagh, nel carro davanti al nostro, ne sono certo.» Ero veramente sbalordito dalla reazione provocata da quelle che, a mio parere, erano semplici osservazioni, assolutamente veritiere. Le mie parole la convinsero a controllarsi di più, e a guardarsi rapidamente attorno. «Parlavo ad alta voce? Non mi sembra di averlo fatto.» «Beh, forse non ad alta voce, ma con veemenza.» La sua voce tornò ad avere un timbro normale. «Veemenza? Vorrebbe dire che mi sono espressa con forza, che ti sono sembrata decisa? Se è questo che significa, allora è così che mi sento. Non voglio essere... com'era quella parola... la castellana, qui. Il solo pensarci mi fa paura, Cay. Non so proprio come si faccia.» Le feci scivolare un braccio attorno alle spalle. «Lo so, Tress, lo so. Ma puoi imparare, e lo farai, nel modo che vorrai. Ludmilla ti insegnerà, vedrai. Non è il caso che cominci oggi o domani, e neppure la settimana prossima, amore mio. Nessuno te lo chiederà. Vivrai con me, nella mia casa, e ci sposeremo. Come mia moglie, imparerai a tempo debito come mandare avanti la casa, con calma e con il sincero aiuto di Ludmilla. Ora però calmati, c'è già qualcuno che si sta avvicinando per darci il benvenuto.» Davanti a noi, in lontananza, avevo visto colori vivaci e del movimento; un gruppo di persone era appena uscito dalla porta principale del forte e si era messo in cammino verso di noi per darci il benvenuto. Tressa guardò in quella direzione, poi si alzò immediatamente, salì con garbo sulla panca su cui era stata seduta e sparì nell'interno del carro, sotto la copertura di cuoio. Sapevo che avrebbe avuto tutto il tempo per fare quello che riteneva di dover fare, e cioè per rendersi presentabile, in base ai suoi criteri, se non altro. Infatti era evidente che la delegazione di benvenuto non ci avrebbe raggiunto ancora per un po'. Mi sistemai più comodamente sulla panca, accanto a Derek, che stava guardando sulla destra verso l'ampia spianata destinata alle esercitazioni: proprio nel momento in cui uscivamo dalla foresta diversi distaccamenti di cavalleria stavano galoppando ed eseguendo manovre. Ora però erano tutti immobili, con gli occhi fissi su di noi. Non appena mi accorsi che si erano fermati, in lontananza risuonò una voce forte e perentoria, e tutti si misero in movimento, riprendendo la manovra appena interrotta. «Quello è il luogo destinato alle esercitazioni, Derek, è lì che si allenano i nostri soldati, ed esiste da quando abbiamo iniziato a costruire il forte sulla collina. Né erbacce, né fiori, neppure un filo d'erba ha mai fatto in tempo a mettere radici prima che lo zoccolo di qualche cavallo non lo avesse calpestato o sradicato. In piena estate neanche la polvere riesce a depositarsi. Il forte è il centro delle difese di Camelot, ma la spianata in cui si esercitano le truppe è il cuore della nostra forza.» Derek non mi rispose direttamente. Mormorò semplicemente: «È davvero grande.». «Sì, è così. È molto più grande di quanto fosse quando sono partito per Ravenglass, sei anni fa. Quello è Ambrogio, alla testa dei suoi soldati. Non c'è pericolo di sbagliarsi, ti pare?» La pattuglia che veniva a darci il benvenuto aveva ormai raggiunto la testa del lungo convoglio e stava scambiando saluti con Filippo, Falvo e Dominic che cavalcavano davanti a tutti. Potei vedere mio fratello che costringeva il suo cavallo a voltarsi mentre mi cercava tra i carri, e poi galoppava verso di noi, salutando di tanto in tanto quando gli capitava di scorgere visi che gli erano noti. Non appena raggiunse il primo carro, dove a cassetta sedevano Donuil e Shelagh, fermò addirittura il cavallo per scambiare qualche parola. Mentre parlavano, Artù arrivò di gran carriera con i suoi tre amici, poi si fermò, improvvisamente intimidito, in attesa che lo zio Ambrogio lo riconoscesse. Ambrogio salutò con effusione tutti e quattro i ragazzi, poi si sporse in avanti sulla sella, mormorò qualcosa all'orecchio di Artù, infine diede una pacca sulla groppa del suo cavallo, e i quattro ragazzi partirono al galoppo verso il forte ancora lontano. Rimase a osservarli mentre si allontanavano, disse ancora qualcosa a Donuil o a Shelagh, poi saltò giù da cavallo e con il viso illuminato da un gran sorriso corse verso di noi che lo stavamo aspettando. Saltai giù anch'io per salutarlo e ci gettammo le braccia l'uno al collo dell'altro. Infine mi scostò, afferrandomi con forza le spalle, e mi fissò negli occhi. «Bentornato a Camelot, fratello» disse affettuosamente. «La tua casa ti attende e tutto è pronto per il tuo ritorno.» Il suo sorriso si trasformò in un sogghigno. «I tuoi abiti, i tuoi veri abiti, sono stati lavati e asciugati e ora sono pronti per essere indossati, e la tua armatura è più lucida di quanto sia mai stata. Finalmente è arrivato il momento di lavare via la tintura dai tuoi capelli e di riprendere la posizione che ti spetta. Non c'è posto qui per il contadino Cay. Questa è la casa di Merlino.» Guardò verso l'alto, scrutando il vagone. «Dov'è Tressa?» Ma poi di colpo spalancò gli occhi per la sorpresa. «Derek di Ravenglass! Benvenuto a Camelot.» A quel punto Tress spuntò dall'interno del carro e si fermò, tenendosi al bordo della panca e sorridendo ad Ambrogio, con gli occhi spalancati e uno sguardo timido. Ambrogio si fece avanti e appoggiò un piede sul mozzo della ruota anteriore, poi saltò su per prenderle la mano e darle un bacio sulla guancia. «Benvenuta anche tu, cara Tressa. Non vedevamo l'ora che tu arrivassi. Benvenuta. Ludmilla era preoccupata, poiché temeva che strada facendo potesse esserti successo qualcosa, ma, se avessimo saputo che con te c'era re Derek, le sue preoccupazioni sarebbero svanite.» Derek arrossì e sorrise all'udire quelle parole. Ambrogio si sistemò sull'estremità della panca e si rivolse a me, continuando a tenere la mano di Tress. «Hai visto dei cambiamenti, eh, fratello? Ti prometto che ne vedrai ancora di più. Ma di questo parleremo in seguito; per il momento dobbiamo portarvi a casa e darvi da mangiare. Dovete essere affamati e pronti per un bel bagno caldo e un energico massaggio. Dopo ci sarà tempo per rilassarsi, magari per bere un po' di idromele e fare quattro chiacchiere al caldo e comodamente. Domani sera si terrà una gran festa in vostro onore, e sarà davvero in grande stile, dal momento che tutti vogliono parteciparvi. Dovremo utilizzare la spianata per le esercitazioni perché è l'unico posto in cui ci potremo stare tutti, ma per ultimare i preparativi ci vorrà tutto il giorno.» Si rivolse di nuovo a Tressa, sempre tenendole la mano. «Ci spiace farvi attendere un intero giorno mentre dovremmo festeggiarvi questa sera stessa, mia cara Tressa, ma non abbiamo altra scelta. La spianata viene usata quotidianamente per le manovre. Per domani abbiamo deciso un giorno di vacanza, e l'intera giornata sarà dedicata ai preparativi. Bisogna tirare su tende, sistemare sedie e tavoli, accendere fuochi e cucinare. Abbiamo messo da parte una grande quantità di cibo. Pensa che ogni giorno, per una settimana e più, c'è stato chi è andato a caccia e a pesca, così nessuno resterà a pancia vuota. Possiamo offrirvi salmoni pescati nei torrenti di montagna, trote di fiume e pesce d'acqua salata, nonché abbondanza di cacciagione: cinghiale e maiale ben ingrassato, carne di capra per coloro a cui piace - a me proprio no - e un intero bue, allevato e ingrassato a grano appositamente per questa occasione. Che cosa ho dimenticato? Ah sì, gli uccelli dell'aria! Abbiamo oche, cigni e anatre, pernici, fagiani e una gran quantità di volatili più piccoli. E per rallegrare il tutto non mancheranno musici, mimi, acrobati e lottatori, e anche cavallerizzi espertissimi che non vedono l'ora di esibirsi. Nel frattempo, questo pomeriggio, dopo che avrete fatto un buon bagno e vi sarete riposati un po', vi mostreremo la nostra Colonia, o quanto meno, quel tanto che ve ne possiamo mostrare senza stancarvi. Dopodiché, il tuo uomo e io dobbiamo parlare, ampiamente e seriamente di molte cose, ti chiedo dunque di aver pazienza se te lo porterò via per un bel po'.» Tressa chinò la testa in un grazioso cenno di assenso. «Il mio uomo, come lo chiami tu, è tornato per assolvere il suo dovere di servire questa Colonia, non per far contenta me. Da parte mia, mi fa piacere essere qui con lui e non dubito che troverò modo di trovarmi un'occupazione mentre lui sarà impegnato con te.» Non potevo fare a meno di sorridere, orgoglioso della padronanza di sé di cui dava prova Tressa e compiaciuto, anche se nel contempo piuttosto divertito, della cerimoniosa accoglienza di Ambrogio. «Ci sono davvero così tante cose di cui discutere, Ambrogio?» «Oh sì, fratello, temo proprio di sì, e soltanto poche sono piacevoli. Nessuna però è tanto urgente da non poter attendere fino a questa sera. Sono questioni che si sono venute formando col passare del tempo, ma tu sei stato via quasi sette anni e dunque qualche ora in più non farà una gran differenza. Su, muoviamoci dunque e raggiungiamo il forte. Merlino, tu prendi il mio cavallo e ordina a chi è alla guida dei carri di seguirci. Io intanto resto qui a chiacchierare con questa bella donna e a godermi la soddisfazione di farmi scorrazzare da un re. Derek, se non ti spiace, accosta sulla destra e prendi quest'altra strada che ci porterà oltre il posto di blocco. I carri raggiungeranno il forte separatamente. Non appena saranno messi in libertà, sarà qui che i soldati a cavallo romperanno le righe e non c'è alcun bisogno di aspettarli.» Derek incitò il cavallo di testa per far muovere il carro e io salii in sella al cavallo di mio fratello, pensando che nel pomeriggio avrei trovato un po' di tempo per affrontare almeno alcune delle questioni che lui aveva rimandato con tanta leggerezza. Udii Ambrogio chiamare Donuil, che guidava il carro davanti al nostro, dicendogli di lasciarci passare e di seguirci. Quanto a me, mentre cavalcavo avanti e indietro, incolonnando i carri del nostro convoglio, mi accorsi che la gente di Camelot cominciava a riconoscermi, se non altro perché montavo lo splendido cavallo di mio fratello: bastava questo per dire a tutti chi ero. Il resto della giornata fu frenetico. Il nostro ritorno, come avrei dovuto aspettarmi, era considerato motivo di grandi festeggiamenti in un periodo in cui, per il resto, da festeggiare c'era ben poco. Nel corso della giornata e di quella seguente incontrai e salutai tutti coloro che conoscevo e anche un gran numero di persone che mi erano completamente sconosciute. Molte di queste ultime erano nuovi ufficiali, scelti tra i ranghi delle reclute arruolate dopo la mia partenza, e per la maggior parte mi sembrarono curiosamente giovani. Comunque, le prime ore dopo l'arrivo le trascorsi, come parecchi dei miei compagni di viaggio, godendomi le delizie delle terme di Camelot e dei suoi massaggiatori. Poi, abbigliato in abiti sontuosi per la prima volta dopo molti anni e sentendomi un altro uomo, ebbi il tempo di gustare un pasto leggero prima che mi fossero presentati i nuovi ufficiali, singolarmente e con grande solennità, in una cerimonia organizzata in precedenza da mio fratello e che si tenne nel Tribunale degli ufficiali. Di per sé il Tribunale era una novità: si trattava di una nuova costruzione eretta a ridosso delle mura posteriori del forte, con il doppio scopo di servire da tribunale, qualora fosse necessario, e di accogliere gli ufficiali della guarnigione nelle loro ore di libertà. Accettai il suggerimento di Ambrogio e per tutta la durata della cerimonia mi sforzai di mantenere un'aria di solenne gravità. Come mio fratello mi aveva fatto notare, sebbene io non conoscessi gli ufficiali che stavo per incontrare, a loro io ero ben noto, di fama ovviamente. Presto mi accorsi che la mia reputazione doveva essere cresciuta oltre quanto ritenevo possibile, e sulle prime ebbi non poca difficoltà ad adattarmi, soprattutto quando ebbi imparato a distinguere - e poi ad accettare - il timore reverenziale di cui tutti, senza alcuna eccezione, davano prova al momento della presentazione. Dovetti far forza su me stesso perché all'inizio pensai che il loro atteggiamento, così uniformemente improntato a una estrema deferenza mista a timore, fosse il risultato delle storie sul mio conto, sicuramente esagerate, che i veterani avevano raccontato alle reclute e agli ultimi arrivati. Il mio primo impulso sarebbe stato quello di sfidare un simile atteggiamento, respingendolo con decisione. Una deferenza tanto immeritata, tale era ai miei occhi, non faceva che mettermi in imbarazzo. Giungevano alla mia presenza con la massima serietà, in gruppi rigidamente costituiti, marciando in formazione perfetta sotto lo sguardo attento, e pieno di disapprovazione, di Terzio Lucca, il nostro primus pilus, ovvero il soldato più anziano. Erano suddivisi in base alla designazione delle varie coorti: Primo Cavalleria, Primo Esploratori, Primo Fanteria e così via, fino al Terzo Cavalleria. Fu soltanto in seguito, dopo essere stato presentato individualmente al primo gruppo di nove di questi disciplinati e coscienziosi giovani militari, che compresi come Ambrogio avesse visto giusto. Ero stato lontano da Camelot per molto tempo e nel mio desiderio di essere nuovamente accettato, avrei potuto facilmente esagerare nell'ingraziarmi questi uomini giovani, inesperti e impressionabili. Stando così le cose, dovetti mantenere un atteggiamento distante e pieno di severa dignità, parlando brevemente ma cordialmente con ciascuno e informandomi con sollecitudine sul rango e la posizione. Svolsi così bene il mio compito che, quando anche l'ultimo gruppo si fu congedato dopo un formale saluto, Ambrogio mi sorrise. «Bene, direi proprio che si è trattato di una presentazione formale, del tutto degna di un legato imperiale. Ben fatto, fratello. A questo punto non ti resta che incontrare i nuovi consiglieri, ce ne sono alcuni che ancora non conosci, e qualche esponente di maggior prestigio dei nuovi membri della Colonia, molto pochi, in effetti. È difficile essere nuovo, preminente e di successo nella nostra Colonia. Comunque le presentazioni non avverranno prima di domani, durante i festeggiamenti ufficiali. Questa sera ceneremo in privato, in modo più o meno informale, con i familiari e gli amici più stretti. Qualche tempo fa LudmIlla e io abbiamo deciso, permettendoci di dare per scontata la tua approvazione, che sarebbe bene riunirci a villa Britannico. È molto più adatta alle esigenze di una cena come quella di stasera, anche perché le cucine sono più grandi e meglio attrezzate. Per di più, attualmente la vecchia dimora non viene utilizzata abbastanza. Voglio dire, la usiamo spesso ma solo come edificio accessorio, se comprendi cosa intendo. Adesso i lavori sono terminati, è stata completamente restaurata, sai, dopo i danneggiamenti causati dall'attacco di Lot, undici anni fa, ed è esattamente com'era prima che la famiglia la lasciasse per andare a vivere nel forte. Ludmilla vorrebbe trasferirvisi immediatamente, ma a me sembra che il mio posto sia quassù, al centro di tutto.» Si fermò, guardandomi con una certa esitazione. «A dir la verità, mi è appena venuto in mente che a te e Tress potrebbe far piacere abitare nella villa, se non altro per qualche tempo. Che te ne pare?» L'idea di Ambrogio mi piaceva molto. Sebbene fossi nato a villa Britannico, e avessi sempre amato l'antica e sontuosa dimora, non ci avevo mai abitato. Mio nonno era morto in quella casa, brutalmente assassinato, e così pure mia madre, eppure quei tragici eventi non mi avevano mai impedito di amare quella che per generazioni era stata la residenza della nostra famiglia. Distava meno di un miglio dal forte, non una gran distanza, e ora, ricordando quanto aveva detto Tressa quel pomeriggio, mi venne da pensare che per lei potesse essere il posto ideale in cui imparare a mandare avanti una casa di notevoli dimensioni, senza temere di andare contro i desideri di Ludmilla. «Potrebbe essere un'idea splendida, Ambrogio, e a me non sarebbe mai venuta in mente. Tuttavia sarebbe meglio che fosse una decisione di Tressa. Anche soltanto le dimensioni potrebbero spaventarla; non solo Tress non ha mai abitato in una casa del genere, ma non ne ha mai neppure vista una. La casa di Derek è la più bella di Ravenglass e al confronto di villa Britannico non è che una capanna. Comunque sia, lascia che gliene parli dopo che stasera l'avrà vista e si sarà fatta un'idea di come viene gestita. A che ora è previsto che ci andiamo?» «A dire la verità, manca ancora molto all'ora di cena, il che però ci darà il tempo di fare un giro nella proprietà e di ammirarla come merita. Negli interni i nostri carpentieri hanno fatto meraviglie, e lo stesso si dica per i muratori, dentro e fuori le mura perimetrali. Sono persino riusciti a restaurare alcuni degli antichi mosaici. Ti prometto che resterai a bocca aperta. Adesso però andiamo a cercare Derek, Donuil e le donne, così possiamo scendere tutti in uno dei carri più grandi.» Nelle rare occasioni in cui quel pomeriggio mi ero trovato da solo con Ambrogio avevo cercato di interrogarlo sugli avvenimenti della Cambria e della Northumbria, ma non ne aveva voluto sapere. Feci un ultimo tentativo quando stavamo per andare alla villa, e anche questa volta mi fermò, alzando il palmo della mano prima ancora che avessi davvero cominciato. Mi fece notare che non ci sarebbe stato il tempo di discutere a fondo le questioni che invece era indispensabile risolvere: attorno a noi ci sarebbe stata gente che andava e veniva, e saremmo stati continuamente interrotti, a meno di essere molto scortesi con i nostri nuovi ospiti e di appartarci per immergerci in discorsi che potevano benissimo aspettare dopo cena. Aveva ragione, naturalmente, così misi da parte l'impazienza e mi rassegnai a sfruttare al meglio l'attesa. Ambrogio ordinò a un soldato di recarsi nelle stalle e di far preparare e mettere a nostra disposizione uno dei grandi carri con molti posti a sedere, poi ci recammo direttamente in quella che era stata la dimora di Varro, dove trovammo i nostri amici di ritorno da una passeggiata al sole del tramonto. Vedendo che si avvicinavano dalla parte del cortile centrale, mi fermai accanto alle tre grandi lastre di ardesia collocate al centro del cortile stesso e attesi che ci raggiungessero. Così potei mostrare a Tress e Derek le tombe di Caio Britannico, Publio Varro e Luceia Varro, e di mio padre, Pico Britannico. Erano stati loro, spiegai, i fondatori di Camelot, ed era grazie a loro se oggi la Colonia esisteva e prosperava. Non mi venne in mente nient'altro, ma ero certo che avrebbero capito quanto fossero importanti queste persone non solo per la mia vita, ma anche per il futuro che insieme avremmo condiviso. Derek si limitò ad annuire e per qualche istante rimase silenzioso: tenne gli occhi bassi, osservando le tre pietre tombali, poi si raddrizzò e annuì ancora. Mi voltai e accompagnai gli ospiti verso le stalle e il carro che ci stava attendendo. Durante quella prima escursione, soltanto nove di noi si recarono a villa Britannico: i nuovi venuti e coloro che mancavano da tempo. Io sedetti a cassetta, accanto al guidatore, mentre gli altri, Tressa e Derek, Donuil e Shelagh, Rufio e Turga, e infine Ambrogio e Ludmilla nella loro qualità di padroni di casa, si sistemarono sui sedili alle nostre spalle. Ambrogio spiegò che i restauri erano cominciati quattro anni prima, inizialmente come un progetto estivo che mirava a inculcare la disciplina nei ragazzi della Colonia non ancora abbastanza grandi da prendere parte alle attività degli adulti. Quella prima estate era stata infatti dedicata alla semplice ripulitura del terreno e alla rimozione delle macerie causate dall'ultima, grave incursione, quando i soldati di Lot avevano fatto irruzione nella villa nell'attacco sferrato a tradimento la notte in cui mio padre era stato assassinato nel suo letto. Molti degli edifici più esterni, che avevano subito i danni maggiori, erano stati riparati subito dopo la guerra, ma poiché la guerra stessa aveva fatto sì che molte delle attività della Colonia fossero state spostate nella fortezza sulla sommità della collina, i lavori di restauro si erano rivelati meno urgenti e non erano stati portati a termine con l'impegno necessario. Per esempio, erano stati ricostruiti muri e talvolta interi edifici, ma le macerie delle vecchie costruzioni erano state lasciate accatastate in grandi cumuli sparsi qua e là all'interno delle mura perimetrali. Pertanto, quando erano ripresi i lavori, squadre di ragazzini, accuratamente guidati e sorvegliati da adulti, avevano portato via i calcinacci e li avevano sepolti in aperta campagna. Tuttavia, poiché la Colonia aveva continuato a ingrandirsi e il ritmo di crescita si era fatto più rapido, era parso inevitabile impegnarsi sempre di più in quello che, negli anni seguenti, aveva finito con l'essere chiamato "lavoro alla villa". Camelot sembrava crescere letteralmente a vista d'occhio, e nessuno aveva ancora pensato di creare un secondo presidio. Così, da un compito di puro e semplice abbellimento, il "lavoro alla villa" aveva visto crescere la sua importanza fino a diventare un impegno prioritario; ogni possibile risorsa a disposizione della Colonia doveva essere sfruttata al massimo, e la villa era una delle maggiori. Per altro, all'interno dei confini dell'insediamento c'erano anche altre ville, quattordici in tutto, e ciascuna era già utilizzata appieno. Invece villa Britannico, la più vicina alla fortezza e la dimora più antica dell'intera Colonia, era diventata un'anomalia: una casa grande e lussuosa, completamente abbandonata. Nei due anni seguenti, la villa era dunque stata restaurata e riportata a gran parte dell'antica bellezza. Poi per qualche tempo era stata usata per alloggiare gli ufficiali della guarnigione insieme alle loro mogli e così le sue mura erano tornate a essere piene di vita. Quello stesso anno, tuttavia, era stato fondato il presidio di Ilchester e l'esodo di più di un migliaio di persone, che da Camelot si erano trasferite nel nuovo insediamento, aveva diminuito l'affollamento della Colonia, permettendo di avere di nuovo più spazio e più tempo per riflettere. A quel punto Ambrogio e Ludmilla si erano rivolti al Consiglio perché facesse in modo che i lavori di ricostruzione della villa fossero portati a termine in modo adeguato. Il Consiglio aveva dato la propria approvazione ed erano iniziati i restauri veri e propri; così villa Britannico, come faceva notare Ambrogio, era stata restituita all'antico splendore. Ambrogio non aveva affatto esagerato: villa Britannico sembrava più bella di quanto me la ricordassi ed ero veramente orgoglioso di farla visitare ai miei ospiti. Mio zio Varro, nei suoi scritti, aveva descritto l'ammirazione che aveva provato al vederla la prima volta, quando Luceia Britannico, la sua futura sposa, gliel'aveva mostrata, proprio come stavo facendo io adesso. La pianta della casa aveva la forma di un'enorme "H" allineata su un asse est-ovest e le stanze riservate alla famiglia erano disposte all'estremità occidentale, in modo da formare un quadrilatero. Tutti i quattro lati dell'edificio che si affacciava sul cortile interno a questo quadrilatero, feci notare, erano costituiti da locali di servizio nei quali, in origine, alloggiavano i domestici; vi erano sistemati i bagni, la lavanderia, le cucine, il panificio e le cantine. Sulla barra trasversale della "H" si apriva un portico sorretto da pilastri, che dava su un secondo cortile all'estremità orientale. Nell'ala nord e in quella sud c'erano le stalle, i recinti per il bestiame, i locali più freschi in cui riporre i cibi che dovevano essere conservati a lungo, una grande falegnameria con annesso il laboratorio del bottaio, un locale per la produzione di ceramiche, una tintoria e una grande fucina con numerose forge e un grande magazzino di granaglie. Tutta la villa era a due piani, e i muri che a pianterreno circondavano il cortile interno, la parte più antica della casa, erano eccezionalmente robusti e costruiti con ciottoli di duro granito, lisciati e sagomati lungo i bordi in modo da incastrarsi gli uni negli altri, e uniti con cemento. Al piano superiore, la tecnica costruttiva era simile, ma i muri erano meno spessi e i ciottoli di granito più piccoli; le pareti esterne, a intervalli regolari, erano interrotte dalle aperture delle finestre, dotate di imposte, delle camere da letto, una caratteristica tipica di questa casa che non avevo mai visto altrove. Oltre il portico, all'estremità opposta, i lunghi muri che fiancheggiavano il cortile esterno avevano una struttura di legno e gesso impastato con ghiaia di silice. Mi compiacqui nel far notare come in tutti gli edifici che fiancheggiavano il cortile interno si poteva accedere dal cortile stesso, mentre tutti quelli che si trovavano lungo quello esterno si aprivano sui campi intorno alla villa. Da questi edifici, solo quattro porticine permettevano un accesso pedonale al cortile esterno. Si trattava di un'innovazione voluta personalmente da Luceia Britannico quando, molto tempo prima di incontrare Publio Varro, aveva deciso di rendere più bello l'accesso alla casa. Aveva fatto chiudere tutti gli ingressi negli edifici che circondavano il cortile esterno e fatto aprire nuovi accessi in quelli che prima erano i muri posteriori, poi aveva fatto costruire una grande strada semicircolare, che serpeggiava attorno e in mezzo ai dodici grandi alberi che si innalzavano in quel punto: quattro querce, tre olmi e cinque grandi faggi rossi. Aveva poi fatto seminare l'erba in tutto il cortile e quando era cresciuta rigogliosa aveva voluto che tra gli alberi fossero create vere e proprie aiuole piene di fiori: rose, violette, viole del pensiero e papaveri. Non appena ebbi condotto i miei ospiti all'interno della villa, l'ammirazione cedette il posto alla meraviglia. Devo ammettere che anch'io rimasi sbalordito dall'opulenza che avevamo davanti agli occhi. Quando ero ragazzo, quella era semplicemente la casa di mio nonno, la casa in cui ero nato e in cui praticamente non abitava più nessuno. Oggi invece la vedevo attraverso gli occhi dei miei ospiti e la confrontavo con tutte le altre case che avevo avuto occasione di vedere. Ma non c'era paragone. A pianterreno, le stanze riservate alla famiglia, da cui cominciammo la visita, erano state descritte dallo zio Varro e giustamente definite sontuose. Ogni stanza aveva un pavimento diverso. I pavimenti delle stanze principali erano ricoperte da mosaici multicolori che raffiguravano scene tratte dalla mitologia greca: Europa e il Toro, Teseo e il Minotauro di Creta, Leda e il Cigno. In quello stesso piano i pavimenti delle stanze meno importanti erano invece lavorati a intaglio, con lastre di marmo disposte secondo disegni geometrici che colpivano per la brillantezza e la vivacità dei colori. Il triclinio, la grande sala da pranzo dove avremmo cenato quella sera, era pavimentata con grandi lastre quadrate di marmo verde alternate ad altre di un bianco immacolato, su cui era sistemato un assortimento di tavole da pranzo di quercia, poste a ferro di cavallo, a cui potevano trovare posto comodamente una sessantina di persone. Le pareti erano rivestite di pannelli di marmo gialli e verde pallido talmente lucidi che ci si poteva specchiare. Contro le pareti erano allineati uno accanto all'altro dei mobiletti a ripiani, alcuni aperti, altri chiusi da ante, dove venivano riposte le stoviglie e il vasellame più prezioso della famiglia. C'erano vassoi, grandi ciotole e piatti da portata, utensili d'oro, d'argento, di rame, di stagno e di bronzo, preziosa ceramica antica proveniente da Samo, lucida e riccamente decorata, coppe, bicchieri e vasi di vetro e due enormi coppe di corno di uro, lucidate e brillanti, rese lisce dal tempo e riccamente ornate, con montature d'oro finemente lavorato. Evidentemente Ludmilla aveva deciso di ricollocare tutti questi oggetti laddove erano sempre stati: in un certo senso anche questo aveva fatto parte del piano di restauro. Subito, però, non potei fare a meno di chiedermi se, stando così le cose, il fatto che Tress e io ci sistemassimo nella villa non le facesse rimpiangere di aver preso quella decisione. Forse aveva avuto intenzione di trasferirvisi lei stessa e noi venivamo a interferire nei suoi progetti? E se era così, avrebbe desiderato farsi restituire il vasellame e gli oggetti decorativi? Mentre questi pensieri mi frullavano per la testa e vedendo la mia cara Tress guardare con occhi spalancati quei tesori, di colpo il ricordo della tanto amata Cassandra mi tornò alla mente e per un attimo sentii che l'antico rimorso si agitava dentro di me. Che cosa poteva pensare di tutto questo, mi chiedevo, se in quel momento mi stava guardando, e quali potevano essere i suoi sentimenti, considerando la presenza della giovane donna che divideva ora la mia vita e le mie proprietà? Poi però mi giunse la risposta, chiara come se la stessa Cassandra me l'avesse sussurrata all'orecchio. Come Ludmilla, anche Cassandra sarebbe stata felice per me, felice che avessi trovato una donna che desse luce e calore alla mia vita. Lasciata alle mie sole cure, questa villa avrebbe continuato a decadere come era avvenuto negli ultimi quarant'anni; le sue molte ferite si sarebbero aggravate, la polvere si sarebbe accumulata negli angoli. Ora, invece, grazie a Tressa, la mia esistenza era cambiata: Tressa aveva rinnovato la mia vita, esattamente come Ludmilla aveva ridato nuova vita a villa Britannico. Dopo aver mostrato loro il pianterreno, guidai i miei amici lungo la doppia rampa della grande scala di marmo che portava alle camere da letto dei padroni di casa. L'intero primo piano aveva pavimenti in legno, solide assi di pino, variamente congiunte, rese lustre da centinaia di anni di attente cure. Ognuna delle dieci camere da letto aveva la propria finestra e a quest'ora del pomeriggio era inondata dai raggi del sole primaverile. Le finestre erano piccole, coperte da imposte di legno sia all'interno sia all'esterno; quelle interne erano provviste di strisce di legno mobili che potevano essere chiuse completamente o angolate in modo da permettere alla luce e all'aria di entrare liberamente. L'aria che circolava per la villa, lo feci notare a uso e consumo di Tressa, era uniformemente tiepida, grazie agli ipocausti, condotti in cui veniva immessa l'aria riscaldata dalla fornace accesa ininterrottamente sotto le terme e rifornita di combustibile due volte al giorno. La casa aveva inoltre due serie di bagni, per la famiglia e per la servitù, interamente rivestiti di piccole mattonelle bianche e lucide, importate da lontani paesi d'oltremare quando la casa era stata costruita. Completammo il nostro giro con una visita alle strutture di servizio, poste attorno al cortile interno, sebbene il frenetico affaccendarsi di cuochi e panettieri fosse un chiaro invito a non interromperli nella preparazione della cena. Marco, il capocuoco delle cucine di Camelot, che conoscevo fin da quando, trent'anni prima, era stato apprendista di Ludo, mi salutò affettuosamente e si mostrò lieto di conoscere Tressa. Anche Marco, come già il suo maestro Ludo, era apertamente e irriducibilmente omosessuale. Era molto abile nella preparazione di manicaretti di qualsiasi tipo, tuttavia la sua specialità erano torte e pasticcini vari. Quel pomeriggio ebbe la delicatezza di rendere un onore del tutto particolare a Tressa, permettendole di assaggiare una delle sue salse, e roteò gli occhi lusingato quando lei espresse il proprio sincero apprezzamento. Poi, con garbo, ci accompagnò fuori dalla cucina, dopo averci raccomandato di ammirare la bellezza del cortile interno e del pomeriggio di primavera. Nel cortile c'era un giardino: forse sarebbe stato meglio definirlo un frutteto, dal momento che non mancavano meli, peri, ciliegi e susini, e anche verdure ed erbe aromatiche. In alcune aiuole la terra era stata appena rivoltata, e gli avanzi della stagione invernale erano stati rimossi e ordinatamente ammonticchiati ai margini dei terreni incolti. Una volta ammirato tutto quello che c'era da ammirare, riaccompagnai nel soggiorno l'intera comitiva, ormai in gran parte silenziosa e affascinata dall'opulenza della villa. L'idea lanciata in precedenza da Ambrogio di berci una coppa di idromele e di sederci comodamente attorno a un braciere ci sembrò ora eccellente, e mentre aspettavamo che arrivasse l'ora della cena ci intrattenemmo piacevolmente, chiacchierando del più e del meno, ma soprattutto esprimendo tutta la nostra sincera ammirazione per la villa e i lavori di recupero e restauro effettuati sotto la supervisione di mio fratello e di sua moglie. Ero davvero lieto di vedere che Tress sembrava a suo agio con Ambrogio e Ludmilla. Se ne stava seduta accanto a loro e li ascoltava attentamente; quando poi Ludmilla le chiese qualcosa a proposito dei tessuti delle pareti e delle sedie, Tressa si illuminò e si lanciò in una animata risposta che, a dire la verità, non mi interessava affatto e che rapidamente mi fece smarrire in un mare di dettagli e di complicazioni tipicamente femminili. Tuttavia, vedendo come si intendevano bene, ebbi la soddisfazione di constatare che avevo avuto ragione: le due donne sarebbero diventate buone amiche. A mano a mano che si avvicinava l'ora della cena, cominciarono ad arrivare gli altri commensali, alcuni sui carri e altri, soprattutto gli ufficiali della guarnigione che era stata con noi a Mediobogdum, a cavallo. Avevamo deciso che, in quella prima sera in cui festeggiavamo il ritorno a casa, i ragazzi e gli altri bambini sarebbero stati sistemati altrove, per permettere ai loro genitori l'insolito lusso di essere se stessi, almeno per una volta, senza timore di venire uditi o disturbati durante la cena. Così, tutti i bambini, ivi compresi i quattro ragazzi che si sarebbero certamente sentiti terribilmente mortificati a essere definiti tali, erano stati affidati alle cure del personale di stanza al forte. Non appena giungevano i nuovi ospiti, Ludmilla e Ambrogio davano loro il benvenuto e Platone offriva loro vino, birra o idromele; subito dopo venivano coinvolti nella conversazione che proseguiva animatamente. A un certo punto Shelagh mi si avvicinò e mi prese per mano, sorridendo a Benedetto con cui fino a quel momento ero stato impegnato a discutere qualcosa di poca importanza, e mi condusse in un angolo, accanto alla parete, dove era possibile parlare a quattrocchi. Ero davvero curioso di scoprire che cosa l'avesse spinta a quella mossa, ma per un po' di tempo Shelagh continuò a parlare di ciò che avevamo fatto nel pomeriggio e dei cambiamenti che Ambrogio e Ludmilla avevano operato nella vecchia casa. Finalmente, spinto dalla sua evidente riluttanza a dire quello che aveva effettivamente in mente, le chiesi senza mezzi termini perché mi avesse preso da parte. Tacque, poi mi sorrise. «Perché ti viene in mente di chiedermelo? Non pensi che sia semplicemente possibile che abbia sentito il desiderio di trascorrere qualche istante da sola con te, così da ringraziarti personalmente per il piacevole pomeriggio? Su questo posto, oggi mi hai insegnato molto più di quanto avessi mai saputo.» Le ricambiai il sorriso. «Sì, certo, mia cara Shelagh, è proprio così. Dopo tanti anni che ci conosciamo, con l'attrazione che ci lega ma a cui non abbiamo mai ceduto, hai scelto proprio questa serata per dichiararmi il tuo amore, davanti a Tress, a tuo marito e a tutti i nostri amici. Suvvia, dimmi la verità, che cosa c'è che non va? Che cosa ti turba?» «No, non sono turbata, solo che... la notte scorsa ho fatto un sogno, uno di quegli strani sogni, il primo dopo anni.» Sentii che il cuore accelerava i suoi battiti e che il respiro si faceva affannoso. «Che cosa? Di che cosa si trattava?» Scosse la testa. «Ho visto te e Ambrogio, fianco a fianco, in un posto strano e pieno di fumo. Lui era in piedi, a testa nuda, la luce... una luce che proveniva non so da dove... illuminava i suoi capelli. Tu eri seduto ai suoi piedi, i tuoi capelli erano castano scuro, come lo sono ora, e tenevi le spalle curve. Ma a un tratto sei scattato in piedi andando verso di lui, poi siete diventati un'unica persona, luminosa e circondata da volute di fumo...» «Cosa? Sono scattato contro di lui, hai detto. L'ho buttato a terra?» «No, sei andato... dentro di lui. Ti sei immerso in lui e lui in te. Siete diventati un'unica persona.» «Oh! E poi che cosa è accaduto?» Scosse la testa. «Nulla. Mi sono svegliata. Questo è tutto.» Mi voltai a guardare mio fratello che stava ridendo insieme a Mark, il nostro carpentiere, e poi tornai a guardare Shelagh, che continuava a osservarmi con un'espressione che non riuscivo a definire. «Shelagh, questo a me non dice nulla. Per te ha qualche significato?» Si strinse nelle spalle. «No, ma quando mai questi sogni hanno un significato? So solo che quando capitano, li riconosco per quello che sono, una sorta di messaggio. Tuttavia la cosa che mi ha colpito di più è stato il colore dei tuoi capelli. Tornerai a essere biondo, ora che sei di nuovo a casa?» «Penso di sì. Mi limiterò semplicemente a smettere di ricorrere a quelle bacche il cui succo me li scurisce. Pensi che abbia importanza, voglio dire il colore dei miei capelli?» «Come faccio a saperlo? Cambia il tuo aspetto, ma ormai mi ci sono abituata, sono anni che li hai così. In ogni modo, staresti bene anche se fossi completamente calvo.» «Ah, davvero? Dovrei forse sentirmi di troppo tra voi due?» Mentre stavamo parlando, Donuil si era avvicinato silenziosamente per portare a Shelagh un bicchiere colmo di non so quale bevanda. Mi voltai verso di lui, ridendo, e gli dissi che stavamo parlando del colore dei miei capelli e di che cosa avrei dovuto fare ora che ero tornato a casa. Li guardò, poi annuì con finta serietà, infine mi consigliò di accettare il suggerimento di sua moglie e di tagliarli a zero. Dopodiché raggiungemmo gli altri e per un po' dimenticai il sogno di Shelagh, completamente preso dalla conversazione che si era fatta animata in tutta la sala. In diverse occasioni, alcuni degli altri uomini, soprattutto coloro che facevano parte del nostro presidio, cercarono di portare la conversazione sulla situazione politica nei territori aldilà della nostra Colonia, ma Ambrogio non ne volle sapere e disse apertamente che tutti sarebbero stati adeguatamente informati soltanto dopo che lui e io, in quanto comandanti supremi, avessimo avuto l'opportunità di incontrarci e di discutere con calma. Nessuno osò contraddirlo e la conversazione tornò a occuparsi di argomenti più innocui. Quando Platone ci comunicò che la cena era pronta, nel triclinio eravamo in trenta: tutti coloro che sei anni prima avevano lasciato Camelot, a eccezione di uno, e dodici forestieri provenienti da Ravenglass, più Ambrogio e Ludmilla. E non appena ci fummo tutti riuniti attorno alle tavole che Platone aveva disposto per noi, prima ancora che venisse servita la cena, bevemmo alla memoria dell'unico assente, il nostro caro amico Lucano, la cui morte, avvenuta di recente e tanto inattesa nonostante l'età, aveva lasciato in ognuno di noi un vuoto incolmabile. VI. «Dunque, eccoci soli, finalmente!» Ambrogio si lasciò cadere su una poltrona, sorridendo, poi si premette le mani sul viso, dapprima strofinandosi gli occhi, quindi facendole scorrere sulle guance: la pressione delle dita lasciò dei segni bianchi che scomparvero rapidamente. Infine spalancò gli occhi e sbadigliò. «Te la senti di parlare di cose serie? Io veramente no. La cena è stata troppo abbondante, e forse ho anche bevuto troppo vino. Mi sento pieno come uno dei polli farciti che Marco ha fatto rosolare infilzati sugli spiedi.» Si stiracchiò con forza. «A essere sinceri, avevo sperato di arrivare a questo punto con un'ora di anticipo, anche perché abbiamo molte cose da discutere.» «Sì, oggi pomeriggio, quando siamo arrivati, hai detto proprio così.» Mi sistemai comodamente sulla mia poltrona, accanto al braciere. «Sinceramente però, non saprei dirti se le mie condizioni sono molto più adatte delle tue ad andare avanti a parlare fino nel cuore della notte. Mi sembra che siano giorni che non dormo, e dall'ultima volta che mi sono sdraiato su un letto sono passate due settimane. Non immagini quanto mi attiri l'idea di un letto. Ciò non toglie che è meglio sfruttare al massimo la nottata, anche perché è possibile che non si ripresenti un'occasione migliore per discutere dell'infinità di cose di cui dobbiamo occuparci.» Ambrogio mi lanciò uno sguardo interrogativo. «Anche tu hai delle cose che vuoi discutere con me?» «Proprio così, e forse è meglio che ce ne occupiamo subito. Quello che devo dirti è meno urgente di quanto devi dirmi tu, immagino, tuttavia penso che sia importante. In ogni modo, cercherò di essere breve.» A quel punto mi lanciai nel racconto del modo in cui mi ero intromesso nelle faccende di Nerone Niger e del suo clan, quindi gli esposi le mie considerazioni sul modo in cui avremmo potuto sviluppare una rete di utili alleanze con la gente comune che viveva nelle vicinanze di luoghi come Corinium. Ambrogio mi ascoltava attentamente e quando ebbi finito di parlare annuì, con un'espressione pensierosa. Poi cominciò un fuoco di fila di domande, tutte finalizzate alla definizione, oltre che al miglioramento, del mio tutt'altro che lucido piano e dei metodi più adatti per metterlo in pratica. Tuttavia, avevo le soluzioni, per quanto incomplete e provvisorie, sulla punta della lingua, e Ambrogio le soppesò con grande attenzione, apportandovi dei miglioramenti o riaggiustando il tiro, ma senza mai scartarle. In un tempo incredibilmente breve, lavorando in totale armonia, avevamo trasformato le mie ottimistiche intuizioni in un progetto concreto e fattibile. Lo avremmo presentato al Consiglio nel corso della prima riunione, dopodiché lo avremmo realizzato il più rapidamente possibile. «Bene» disse infine Ambrogio, dopo che per un po' entrambi eravamo rimasti in silenzio, soddisfatti del risultato raggiunto. «Nient'altro?» Scossi la testa. «No, questo è tutto quello che avevo da dirti. Adesso parla tu: che cosa sta succedendo in Cambria? Hai notizie di Vortigern?» «No, di Vortigern nessuna notizia, e troppe notizie della Cambria. Stiamo per partire, lo sai, vero? Non appena sarai pronto, entro la prossima settimana, se possibile.» «Per la Cambria? E con quante truppe?» «Un terzo. La Prima Legione: suona bene, non è così? Ma in che altro modo potremmo chiamare le nostre truppe? Purtroppo, però, sono sono la metà di una legione romana...» «Lo so, ma probabilmente hanno una potenza tripla. So tutto, me lo hanno raccontato Benedetto e gli altri. Ma parlami di questo nuovo reparto di esploratori che hai creato.» Per molto tempo Ambrogio era stato preoccupato a causa dell'inefficienza con cui venivano sfruttate le risorse militari di Camelot. Nella Colonia, tutto ruotava intorno all'allevamento dei cavalli destinati alla nostra cavalleria e queste robuste cavalcature erano il nostro orgoglio maggiore. Ma dell'enorme numero di cavalli che allevavamo, non tutti erano sufficientemente grandi e forti da avere i requisiti adatti all'impiego militare. La cavalleria di Camelot era una cavalleria pesante, l'unica forza del genere in Britannia e forse nel mondo, e soltanto gli animali più grandi erano sufficientemente forti da reggere il peso dei nostri cavalieri armati pesantemente. Il che aveva fatto sì che nel corso degli anni si creasse una cospicua riserva di animali più piccoli, ma per il resto magnifici, che non sapevamo come utilizzare se non impiegandoli nel lavoro dei campi; purtroppo però gli esemplari migliori, ed era ciò che mio fratello pensava da tempo, finivano con l'essere sprecati. Ambrogio si rendeva perfettamente conto della scarsa considerazione in cui da sempre a Camelot veniva tenuta la cavalleria leggera, proprio quella che i Romani avevano usato durante tutta la loro storia. La cavalleria romana, costituita prevalentemente di cavalieri armati di archi piccoli e corti, ai nostri occhi era perfettamente inutile, a eccezione del ruolo per cui era stata creata: costituire uno scudo, estremamente mobile, per le grandi e ingombranti legioni nel momento in cui si disponevano in ordine di combattimento. Ma Ambrogio non era né nato né cresciuto a Camelot, e dunque non condivideva il nostro disprezzo. Al contrario, era abbastanza lungimirante da intuire come in determinate condizioni, per esempio su terreno molto inzuppato dalla pioggia e fangoso, una cavalleria meno pesante - e dunque più veloce - potesse essere estremamente efficiente. Mise dunque in pratica le sue intuizioni e creò un nuovo corpo di cavalleria, su cavalli più piccoli, con selle munite di staffe e con in dotazione armi e armature più leggere - e lo chiamò "reparto di esploratori", evitando così di definirlo "cavalleria leggera", con tutte le implicazioni negative che ciò comportava. «I loro risultati sono molto brillanti, Cay, sono in grado di colpire duramente e sono incredibilmente mobili. Ma soprattutto sono veloci, e possono andare dove la cavalleria pesante non riesce ad arrivare. Per combattere al meglio, i cavalieri armati pesantemente hanno bisogno di terreno pianeggiante, ampio e asciutto. Quando possono disporre di queste condizioni, lo sai anche tu, sono invincibili e terrificanti, ma sfortunatamente accade di rado che si verifichino tutte e tre contemporaneamente. Gli esploratori, invece, possono andare ovunque. Possono combattere su terreno pianeggiante e possono attaccare sia in salita sia in discesa poiché i loro cavalli sono più leggeri sotto tutti gli aspetti. Sono in grado di percorrere distanze maggiori e di farlo più velocemente, mentre da un punto di vista tattico, quando combattono in formazione, fanno paura quasi quanto la cavalleria pesante.» «Sembrano risultati eccellenti. Li hai organizzati allo stesso modo delle normali truppe di cavalleria, presumo.» «Naturalmente. L'unica differenza è il peso dei cavalli e, in proporzione, il peso del cavaliere e delle sue armi. L'arma principale è comunque la lancia leggera che abbiamo disegnato copiandola da quella che il tuo amico dell'Eire ha inviato dal regno di Athol.» Anni prima, mentre ero in visita presso Athol Mac Iain, nell’Eire, avevo lavorato insieme a un fabbro di nome Maddan alla progettazione di una nuova lancia per la cavalleria, un'arma che ricordava le lunghe lance usate dagli Scoti per cacciare i cinghiali. Molto tempo dopo, quando ritenne di averla perfezionata adeguatamente, Maddan me ne aveva mandata una in regalo, utilizzando una delle navi di Connor, e poiché io non c'ero era stato Ambrogio ad appropriarsene. Grazie alla particolare costruzione dell'asta, era più leggera e meno ingombrante di quanto forma e dimensioni avrebbero lasciato immaginare. Questa lancia aveva una punta metallica, stretta e letale, saldata a una piccola barra di ferro lunga quanto tutta l'arma, mentre l'asta era costruita attorno a questa barra. Si trattava di un rivestimento costituito da lamine di canne - dure, secche, leggere come una piuma, dello stesso tipo di quelle usate nell'Eire nella costruzione delle case e dai Sassoni nella fabbricazione degli scudi saldamente legato per tutta la sua lunghezza mediante strisce di pelle di cervo che venivano avvolte strettamente ancora bagnate e che, una volta asciutte, diventavano dure come il ferro. Il risultato era una lancia leggera, quasi flessibile e incredibilmente robusta: un'arma perfetta per un soldato a cavallo. A quel punto mi venne in mente che non avevo ancora riferito ad Ambrogio la triste notizia portataci da Connor e nel comunicargliela lo osservai attentamente. «Probabilmente non sai ancora che re Athol è morto, non è vero? Brander è il nuovo re.» Era evidente che non sapeva nulla. «Strano» mormorò. «La notizia dovrebbe esserci arrivata da un pezzo, se è morto parecchio tempo fa. La morte di un re è una notizia importante, di cui si parla molto.» «Sì, ma i nuovi territori di Athol sono molto a nord di qui, e sono stati conquistati da poco. Per di più si tratta di isole, e c'è stato di mezzo l'inverno a bloccare le comunicazioni. In realtà, non c'era alcuna possibilità che la notizia arrivasse a Mediobogdum e neppure a Ravenglass.» Continuai chiedendogli se sapeva qualcosa delle biremi che si diceva fossero usate dalle armate di Ironhair. Ambrogio annuì, con uno sguardo tetro. «Sì, proprio così; di quelle figlie di puttana ne ha ben due. Non le ho mai viste, ma ne ho sentito un gran parlare e so tutto. Sono le navi più grandi che mai siano comparse in questi mari, mi è stato detto, e trasportano una moltitudine di uomini e una grande quantità di merci. Biremi della flotta romana, qui in Britannia, che combattono per Ironhair! Hanno un esercito di rematori, ma su ciascuna trova posto anche un esercito di guerrieri! E poi, come se non bastasse, nei loro enormi ventri trasportano anche truppe per Ironhair. A quanto sembra hanno pure delle stive immense, all'interno della nave stessa, e trasportano persino le gru che servono per caricare e scaricare.» «Sì, ma in questo non c'è nulla di eccezionale, le gru, voglio dire. Le galee di Connor hanno gli stessi marchingegni, anche se probabilmente molto più piccoli. Da dove sono arrivate, queste navi?» Ambrogio si strinse nelle spalle. «Non ne ho idea. La nave che mi avevi descritto, quella che avevi visto mentre stavi andando nell'Eire, è l'unica di quel tipo di cui abbia mai sentito parlare, e non sono mai riuscito a immaginare a che cosa possa assomigliare. Pensare che ce ne siano due, o magari anche di più, e in possesso di Ironhair, mi lascia senza parole. Solo Dio sa dove Ironhair le abbia scovate.» «Beh, fratello, dovunque le abbia scovate, dovevano essere in vendita oppure in affitto, e ora che sono qui, trasportano la sua marmaglia in Cambria. Ma che ne è stato di Carthac, è ancora vivo?» Il pensiero di Carthac gli fece fare una smorfia di disgusto. «Sì, lo è, è ancora vivo e ancora pazzo. Comincio a temere che resterà per sempre entrambe le cose: sembra invulnerabile. Dio sa se non ci hanno provato in tanti ad ammazzarlo. Ho sentito raccontare che per ben due volte le frecce di Pendragon che gli erano state scagliate da distanza ravvicinata non sono riuscite a trapassare la sua armatura.» «Non ci credo. Chi te lo ha detto?» Scrollò le spalle. «Due persone. Due resoconti diversi, due incidenti diversi.» «Quanto da vicino erano state scagliate le frecce? Hai parlato con gli arcieri?» «No, l'ho solo udito raccontare.» «Allora sono solo voci. Chiacchiere di soldati. Questi archi sono precisi da un quarto di miglio. Se ben mirata, una freccia scagliata da distanza ravvicinata da un arco di Pendragon è in grado di trapassare qualsiasi armatura. Sono più che certo che se fosse stato colpito da una di queste frecce, a quest'ora sarebbe già morto. Non metto in dubbio che possa essere formidabile nel combattimento corpo a corpo - da quanto ho sentito raccontare è abbastanza grande e grosso da essere imbattibile - ma immortale non lo è di certo. Invece, hai detto che di Vortigern non ci sono notizie?» «Non una parola. Da nord-est il silenzio è assoluto.» «Ma Hengist è morto, ne sei proprio sicuro?» Annuì. «Bene, anni fa tu e io avevamo dubbi sul fatto che quando Hengist fosse morto Vortigern avrebbe avuto delle difficoltà con Horsa. Per quanto ne sappiamo, adesso Vortigern potrebbe essere in guerra con Horsa o potrebbe essere morto da tempo. Se invece sta combattendo, potrebbe certamente apprezzare un aiuto, per spiazzare Horsa. Al contrario, se è morto, allora Horsa ha avuto la meglio ed è al potere. Penso che dovremmo cercare di scoprire che cosa sta succedendo da quelle parti, sei d'accordo?» Ambrogio si immerse nei suoi pensieri e intanto si sporse in avanti per ravvivare il fuoco con un attizzatoio di ferro che si trovava accanto al braciere. «Sì, lo sono» mormorò infine. «Ma come? Da qui a là c'è un sacco di strada, e la logica vuole che rischieremmo solo di metterci nei guai da soli andando a ficcarci in situazioni pericolose che probabilmente non ci toccherebbero affatto.» «Stupidaggini, Ambrogio! Neppure tu ci credi, non più di quanto ci creda io. La logica vuole che tutto quello che può andare storto andrà storto se decidi di lasciare in qualche modo il tuo destino nelle mani di una testa calda come Horsa. Una volta, sei stato tu stesso a dirmi che Vortigern pensava a se stesso come al sommo re di tutta la Britannia, ricordi? Bene, qui non ha mai comandato, dunque le sue erano semplicemente delle fantasie. Ma se di queste fantasie ne avesse discusso con altri? Tutto quello che Horsa potrebbe averne ricavato sarebbe il fatto che in Britannia ci sono altri insediamenti pronti per essere conquistati, e dunque dovremmo aspettarci di vedercelo arrivare qui, alla testa delle sue orde. Non credo che possiamo permetterci il lusso di starcene qui ad aspettarlo; temo proprio che non possiamo fare a meno di andare a vedere che cosa succede in Northumbria e ritengo che dovremmo andarci passando per la costa sassone, ma ora, immediatamente.» «Cosa? Vuoi dire significherebbe...» una spedizione in forze? Ma questo «Sì, lo so che cosa significherebbe. Significherebbe dividere le nostre forze quando già dobbiamo fare i conti con una guerra che siamo costretti a combattere qui. So benissimo che in questo momento non è possibile fare le cose come andrebbero fatte, ma ciò nondimeno penso che sia una follia non andare, quanto meno per dare uno sguardo. Sta pur certo che il pensiero di un esercito di Danesi di Horsa che potrebbe piombare tra capo e collo mentre siamo alle prese con Ironhair non mi piace affatto.» «Neanche a me - e lo so da mesi - ma non me la sono sentita di impegnare le truppe in una impresa del genere finché tu eri via, su nel nord. Mi è bastato preoccuparmi all'idea di lasciare Camelot in mano ad altri qualora dovessi andare in Cambria.» Si alzò dalla sedia e si mise accanto al fuoco, in piedi, strofinandosi le mani al calore che si sprigionava dai carboni ardenti. «Detto ad alta voce suona diversamente dall'impressione che mi aveva fatto quando mi ero limitato a pensarlo, dunque ti prego di non fraintendermi. La situazione è questa: qui abbiamo degli uomini capaci; uno qualsiasi dei nostri veterani è più che in grado di mandare avanti le cose durante la mia assenza, di comandare la guarnigione e di occuparsi delle faccende quotidiane. Da un punto di vista tattico, sono tutti bravissimi. Ma in termini di abilità strategica, non so, Cay. Non c'è un solo uomo a cui affiderei volentieri - o forse, sarebbe meglio dire a cui oserei affidare - la responsabilità di prendere decisioni immediate e decisive qualora se ne presentasse la necessità.» Alzò una mano come per bloccare le mie obiezioni, ma non ne avevo alcuna poiché sapevo benissimo che cosa avesse in mente. Vedendo che non tentavo minimamente di parlare, continuò. «Lo so, dovrei essere in grado di delegare l'autorità suprema quando è necessario che mi assenti. Non è questo che mi preoccupa. Il mio problema, per dirla in parole semplici, è che nessuno dei miei comandanti di secondo livello si è mai trovato nella necessità di fare nulla del genere. Non c'è nessuno di loro che non accetterebbe i miei ordini o che rifiuterebbe di prendere su di sé la responsabilità del comando, su questo non ho il minimo dubbio. Ma sarebbe poi capace di agire con decisione qualora se ne presentasse la necessità? Impegnerebbe tutte le risorse a sua disposizione rischiando il tutto per tutto su di un nuovo fronte, qui, in casa, sotto la propria responsabilità, oppure esiterebbe restando in attesa di una sorta di avvallo da parte mia? Semplicemente, non lo so. Buona volontà e adesione formale non sono sufficienti, non quando la posta in gioco è tanto alta e finché non avrò visto con i miei occhi che chiunque io abbia scelto è capace di assumere su di sé il comando assoluto: il che però è impossibile, perché dovrei essere qui quando lui si trovasse in una simile necessità, e la mia presenza renderebbe inesistente la necessità stessa. Ah!, non riesco a venirne fuori!» Mi schiarii la gola e mi sporsi in avanti. «So che ti aspettavi che ti interrompessi, ma il fatto è che hai pienamente ragione. Il problema è reale e preoccupante, e me lo sono posto già molto tempo fa. In sostanza, suppongo che voglia semplicemente dire che gli eserciti hanno bisogno della guerra, non solo di disciplina e di allenamenti, per mostrare la loro forza effettiva, e questa è una constatazione poco allegra.» «Vuoi dire che è un problema che ti eri già posto? Come? Quando?» «Oh, pochi anni fa, prima di partire per Ravenglass. A dire la verità già allora avevo intenzione di parlartene, ma poi non se ne è mai presentata l'occasione. Mi è venuto in mente una notte, mentre riflettevo sull'ambizione e su quello che comporta. Tutto è cominciato con Peter Ironhair: mi sono reso conto che nessuno dei nostri ufficiali più esperti sembra possedere la sua ambizione sfrenata, quella bramosia che è indispensabile per diventare veramente grandi. Sono uomini onesti e capaci, in tutto e per tutto, ma sono dei gregari. E così ho cominciato a interrogarmi su quali potessero esserne i motivi.» «E ne hai scoperto qualcuno?» «Certo, ho scoperto il migliore dei motivi: non hanno un altro posto dove andare.» «Non ti seguo.» «Pensaci solo un minuto. Qui, noi abbiamo il miglior esercito di tutta la Britannia, almeno per quel che ne so. Non è forse così?» Annuì lentamente, mostrandosi divertito. «Bene, e a che cosa possono aspirare i nostri ufficiali in termini di comando supremo? Tu sei qui, io sono qui, ed entrambi siamo abbastanza giovani da avere davanti qualche decennio, a meno che non intervengano malattie o incidenti. Non siamo in guerra, o quanto meno non lo eravamo in quel periodo, dunque il rischio che uno di noi muoia sul campo di battaglia è trascurabile. Stando così le cose, per loro l'unica via per arrivare al potere sarebbe fomentare un ammutinamento qui a Camelot: e chi li seguirebbe, se mai venisse loro in mente di provarci? Come potrebbe qualsiasi malcontento portare a un ammutinamento generale? Qual è l'ultima volta che abbiamo giustiziato un soldato? Da noi, la più grave pena prevista è l'espulsione, ed è un deterrente che, da solo, basta a mantenere l'ordine tra le nostre file, poiché significa la perdizione: dove potrebbe andare un uomo che fosse stato espulso? Resterebbe in attesa fuori dai nostri confini, vivendo di quanto riuscirebbe a cacciare o a prendere con le trappole, nella speranza di essere raggiunto da altri per poi poterci attaccare? Non lo penso proprio. Dunque i nostri soldati si rendono perfettamente conto dei vantaggi di cui godono qui, e lo stesso vale per gli ufficiali, anche per quelli di grado più elevato: di fatto hanno ormai raggiunto il massimo cui possono aspirare, e sembrano esserne contenti. Soltanto tu e io dobbiamo convivere con gli svantaggi di un simile sistema, svantaggi che per altro si presentano solo in momenti come questi. Quando un uomo, qualsiasi uomo, ha raggiunto i limiti della propria camera, tende ad accettarli e a sentirsi a proprio agio. Questo è il problema.» «Hmm...» Mentre parlavo Ambrogio aveva continuato a camminare avanti e indietro, ora però tornò a sedersi di fronte a me. «Hai assolutamente ragione. Ma ora che ci troviamo nuovamente a dover affrontare una guerra, tutto questo cambierà. Il dilemma si risolverà da solo nel momento stesso in cui i vari comandanti dovranno mostrarsi all'altezza delle sfide che saranno costretti ad affrontare.» «Sì, e nel caso in cui non ci riuscissero, saranno sostituiti. Comunque vada, ben presto non ci mancheranno dei comandanti esperti. Ma torniamo al punto di partenza, e cioè alla minaccia che ci viene da nord-est, dai Danesi di Horsa. Finora hai avuto le mani legate perché non sapevi a chi lasciare il comando supremo, qui a Camelot, in considerazione del rischio di un attacco da quella parte. Adesso non è più così. Io sono qui, e c'è anche Dedalo, che, a parte noi due, è l'ufficiale migliore di cui disponiamo, il più adatto ad assumere il comando supremo sia per disponibilità sia per attitudine. Hai detto che pensi di lasciare qui due legioni e di andare in Cambria portando con te la Prima. Perché? Non sarebbe meglio che in Cambria te ne portassi due?» Alzò entrambe le mani. «Per via del pericolo che ci minaccia da nord-est, precisamente quello di cui mi parlavi poco fa. Avevo deciso che con te nel nord, se fosse successo qualcosa mentre io ero in Cambria, e se le truppe lasciate a difesa di Camelot fossero state prive di guida sicura, dovessero almeno avere forze sufficienti per tirare avanti e sopravvivere fino a quando non fossimo stati nuovamente in grado di prendere in mano la situazione. Il che voleva dire due legioni, quel che basta per difendere la Colonia e pattugliare i confini.» «Giusto. Ma adesso tutto è cambiato. Penso che sarebbe il caso che in Cambria portassi due legioni, meno un decimo.» «Perché, sarei io che dovrei portarcele? Vorresti dire che tu hai deciso di non venire? E che cosa intenderesti fare con il decimo che resta, ammesso che non lo sappia già?» Annuii. «Una spedizione in forze nel cuore della Northumbria. Tu avrai seimila uomini, meno i miei seicento. Questo ti consentirà di vincere in Cambria, sbaragliando Ironhair, e permetterà a me di entrare in Northumbria con relativa tranquillità. Avrò duecento cavalieri armati pesantemente, un centinaio dei tuoi esploratori e trecento fanti. Il che dovrebbe scoraggiare eventuali attacchi.» «Sì, dovrebbe, ma dovrai anche percorrere oltre duecento miglia, in un senso e nell'altro, in gran parte su un terreno accidentato. Spostarsi lungo le strade non varrebbe il rischio: la gente tende a radunarsi lungo le strade facilmente percorribili.» «No, in questo ti sbagli, Ambrogio. Le strade offrono i vantaggi più grandi per un avanzamento rapido, sia all'andata sia al ritorno. Certo, è possibile che ci sia gente da una parte e dall'altra della strada, magari per tutto il percorso, ma ci sposteremo molto velocemente, a tappe forzate.» «Sarai condizionato dalla velocità della tua fanteria. Le strade sono indubbiamente il percorso più veloce per la cavalleria e la fanteria, ma presentano anche infinite possibilità di restare intrappolati. La notizia del vostro arrivo vi precederà, alla velocità consentita dalle staffette che la trasmetteranno man mano. In questo modo, i vostri spostamenti e il vostro arrivo nelle varie località saranno perfettamente previsti. Il che potrebbe significare che, dovendo percorrere centinaia di miglia, potresti perdere tutti i tuoi uomini, una freccia alla volta.» «Abbastanza plausibile, suppongo, se guardi soltanto l'aspetto peggiore.» «Certo, ma dovresti farlo anche tu. È responsabilità nostra. È la responsabilità di chi comanda.» «D'accordo. Dunque mi stai dicendo che dovrei restare qui, aspettando di vedere che cosa può venirci da nord?» «No, assolutamente no. Sto pensando alla Cambria, il mio campo di battaglia. È quasi tutto montuoso, a eccezione delle zone costiere, e dunque sostanzialmente poco adatto alla cavalleria. È una cosa che so da tempo, così ho messo a punto quella che ritengo possa essere la strategia migliore per usare la nostra fanteria sulle colline, coadiuvata dalla cavalleria che opererà dal campo base nella vallata sottostante. Quello che intendo fare è snidare le truppe di Ironhair esattamente come i ragazzi snidano la selvaggina che poi i cacciatori uccidono. Una collina per volta, intendo farli uscire allo scoperto, fuori dalle alture, per spingerli verso le valli sottostanti, dritto contro la nostra cavalleria. Possiamo contare anche sui soldati e sugli arcieri di Pendragon che si uniranno a noi; oltre tutto ne abbiamo allenato noi stessi un numero sufficiente per sperare che, quanto meno, siano in grado di operare in sintonia con le nostre truppe. La nostra disciplina ci farà vincere battaglie e guerre, vedrai. Non solo, ma i nostri esploratori dovrebbero cavarsela bene anche su terreno molto accidentato, seppure in squadroni non troppo numerosi, e questo è un punto di forza.» «Benissimo, adesso tocca a me restare senza parole.» Sorrise. «Allora, considera bene quello che sto per dirti. Ho bisogno di tutti i soldati di fanteria di cui possiamo disporre. E ho anche bisogno di ogni singola unità di cavalleria pesante. Inizialmente intendo dividere le mie forze e impedire alla flotta di Ironhair di usare i porti di cui si è impadronito. Per farlo, mi occorre sia la cavalleria sia la fanteria, in modo da bloccare ogni porto da terra e poi buttare in mare i difensori. Una legione dovrebbe essere sufficiente, quanto meno nelle fasi iniziali, poi, una volta che abbiamo occupato i porti, sarà possibile ridurre il numero. Nel frattempo, non avrò alcun bisogno dell'intero reparto di esploratori, mentre a te dovrebbe far comodo. Ti suggerirei di scambiare il tuo contingente di seicento soldati provenienti da corpi diversi con cinquecento esploratori. Questo ti permetterà di muoverti il più rapidamente possibile e di scegliere la strada che intendi percorrere mano a mano che procedi. Direi che così sarai anche inattaccabile, fino a quando tu stesso non deciderai di fermarti e di combattere. Nessuno che non possieda un esercito proprio si sognerebbe mai di attaccare un drappello di cinquecento uomini ben disciplinati, armati e a cavallo. Fuori dai confini di Camelot non si è mai visto nulla del genere, credimi, Cay.» Mentre parlava il mio cuore aveva cominciato a battere all'impazzata e ora la mia eccitazione era quasi insopportabile, così mi alzai e mi misi a passeggiare avanti e indietro per la stanza. Con la coda dell'occhio vidi che la fiamma di una delle lucerne oscillava, per poi spegnersi, e capii che si era fatto molto tardi. Ambrogio mi stava osservando, senza far alcun tentativo di mettermi fretta. Mi costrinsi dunque a fermarmi e a guardarlo in faccia. «Il tuo piano non fa una piega, fratello. Ma sei proprio sicuro di non aver bisogno dei tuoi esploratori?» «Certo che ne avrò bisogno, ma ne abbiamo un migliaio, e a me ne bastano la metà. Avrò a disposizione duemila cavalieri armati pesantemente e tremila fanti di rinforzo, ricordatelo. Tu no, ma avrai comunque il vantaggio della sorpresa. Sulla strada della Northumbria nessuno se la sentirà di attaccarti.» «Come stiamo a cavalli di riserva? Ne abbiamo abbastanza?» Ambrogio rise di cuore. «Abbastanza? In questa colonia ci sono più cavalli che persone, Caio. Quanti te ne servono?» «Uno di riserva per ciascuno dei miei uomini. Dovrebbe bastare.» «Bene, allora prendine un altro cinquanta per cento in più, di scorta. Quando sei sul campo, non puoi sostituire una cavalcatura se non ne hai un'altra a mano.» Di colpo mi balenò in mente lo spettacolo della mia spedizione in marcia: più di milleduecento cavalli! «Dio mio!» dissi. «I problemi logistici saranno spaventosi!» «Allora delegali, fratello. Il personale logistico non scarseggia affatto. Avrai bisogno di carri o di animali da soma per trasportare le granaglie e gli altri rifornimenti. I carri andrebbero meglio, però ti costringerebbero a non abbandonare le strade. I cavalli di scorta possono trasportare le vettovaglie e i tuoi esploratori si prenderanno cura dei proprii animali, dunque non ci sarà alcun bisogno di una schiera di attendenti che soddisfino le vostre necessità.» «Però saremo costretti a muoverci lentamente.» Mi guardò con stupore. «Che vorresti dire? Il tuo "lentamente" sarà sempre "più velocemente" di come possa spostarsi la cavalleria pesante o la fanteria. Certamente non galopperete per tutta la strada, ma non c'è dubbio che vi muoverete abbastanza agevolmente. Allora, siamo d'accordo su questo punto? Io in Cambria con due legioni, e tu nell'estremo nord-est con cinquecento esploratori?» Annuii. «Lo siamo. Quando cominciamo?» «Abbiamo già cominciato, fratello. Tutto quello che ci resta da fare è mettere in pratica il nostro accordo. Prima della fine della settimana, saremo partiti entrambi, e Camelot sarà al sicuro nelle abili mani di Dedalo. Hai già deciso che strada prenderai? E per quanto pensi di stare via?» «Sono due domande, ma sono strettamente legate» mi fermai per un attimo, riflettendo su entrambe. «Credo che la strada migliore sia quella che abbiamo preso insieme l'ultima volta. Se non altro, la conosco bene. Inizialmente andremo a est finché non raggiungeremo i territori occupati dai Sassoni, poi abbandoneremo le strade e ci dirigeremo a nord, tagliando per campi e boschi; probabilmente arriveremo più in fretta dell'altra volta, visto che le zone occupate ormai devono essere più vaste. Perché sorridi?» Il suo sorriso si fece ancora più divertito. «Mi viene in mente la nostra "magia", il giorno in cui ci siamo mostrati vestiti allo stesso modo, identici in tutto e per tutto, e abbiamo terrorizzato quei razziatori, attaccandoli a turno da punti in cui non avremmo potuto essere se si fosse trattato di uno solo di noi... ma loro erano convinti che ce ne fosse davvero uno solo. Come si chiamava quell'anglo grande e grosso, quel contadino che abbiamo salvato, te lo ricordi?» Ci pensai un attimo, ricordando quel fatto curioso che risaliva ormai a otto, o forse nove, anni prima. «Qualcosa di quasi impronunciabile. Guth? Guth-qualcosa.» «Guthilrod, non era così? C'era uno strano "thlr" non celtico, da qualche parte.» «Gethelrud! Ci sono, era Gethelrud!» «Andrai a trovarlo, che ne dici?» «Andare a trovarlo? Pensi che io sia diventato matto? Presentarmi con cinquecento uomini e il triplo di cavalli? Posso immaginare la sua faccia, se mi vedesse arrivare nella sua fattoria! L'altra volta, quando eravamo soli, non potevamo parlarci, non riuscivamo neanche a capirci.» Mio fratello continuava a sorridere. «Nel frattempo potrebbe aver imparato la nostra lingua.» «Il latino? Oh, sì, sono sicuro che deve averlo imparato, quasi certamente. Probabilmente ha anche intrapreso una regolare corrispondenza con l'imperatore di Costantinopoli! No, fratello, non farò visite di sorta. Mi muoverò più in fretta possibile. Quanto al tempo di cui avrò bisogno prima di essere di ritorno, tu quanto pensi di dover restare in Cambria? Tornerò non appena possibile, ma non prima di aver fatto tutto quello che devo fare. Tre mesi potrebbero essere il minimo indispensabile, suppongo.» «Sì, è esattamente quello che pensavo. A quel punto è possibile che dobbiate venirmi a recuperare in Cambria.» Le sue parole mi fecero sorridere. «Lo farò, se sarà necessario e porterò con me la Terza Legione, dal momento che a quel punto la minaccia che incombe da nord non esisterà più.» Guardai mio fratello provando una grande soddisfazione e un grande sollievo di fronte alla sua sicurezza, per non parlare dell'ardore con cui stava per affrontare il compito non facile che lo aspettava. «Ti ho mai detto quanto sia felice per la tua presenza qui?» Mi guardò sorpreso e io gli sorrisi. «Non stupirti, è esattamente quello che penso. All'idea di che cosa sarebbe la mia vita se tu e io non ci fossimo incontrati, mi vengono i brividi. Avrei perso la parte migliore di me e avrei dovuto vivere con metà cervello. Spesso ringrazio Dio per il semplice fatto che tu esisti, che siamo parenti e che è accaduto il miracolo di averti incontrato.» «Parenti? Brav'uomo! Ma se siamo praticamente gemelli!» «Lo so, e questo richiede che ci beviamo su.» Mi guardai attorno. «Immagino che siano andati tutti a letto da un pezzo. Siamo rimasti qui a chiacchierare tanto a lungo da aver esaurito tutte le lucerne, il fuoco poi è quasi spento.» Ambrogio si raddrizzò e borbottò. «Sì, bene, io rifornirò il fuoco e cercherò dell'olio da mettere nelle lucerne, tu intanto vedi di trovare dell'idromele. Dovrebbe essercene ancora negli scaffali del triclinio.» Quando fui di ritorno, con una brocca di idromele e due coppe di vetro, Ambrogio aveva riattizzato il fuoco ed era intento a versare l'olio in una delle lucerne che si stavano spegnendo. Mi sedetti e versai l'idromele per entrambi, poi attesi che tornasse a sedersi e prendesse la sua coppa. «Sai, mentre cercavo l'idromele mi è venuta in mente una cosa: nel nostro piano c'è un punto debole. È l'unico, ma è enorme.» Bevve il suo idromele, e intanto osservavo la sua espressione mentre cercava di capire che cosa stessi dicendo. «Allora devi essere molto più perspicace di me, perché io non riesco proprio a vederlo. Di che si tratta?» «Tutto il piano è alla rovescia.» Corrugò la fronte, cercando di raccapezzarsi. «Non ti seguo. Che cosa è alla rovescia?» «Il nostro piano. Io dovrei andare in Cambria e tu dovresti dirigerti verso la Northumbria, visto che io non parlo le lingue in uso da quelle parti e tu sì.» A quel punto sembrò ancora più perplesso. «Ma questo non ha senso, e per tre motivi. Primo, Vortigern parla il latino...» «D'accordo, ma Vortigern e la sua gente potrebbero essere morti, e tu parli la lingua dei Danesi...» «Solo un poco, malamente, e poi non conosco neanche una parola delle altre lingue: quella degli Angli e quell'accozzaglia di suoni inarticolati che masticano gli Juti.» «Ma a preoccuparci sono i Danesi di Horsa. La lingua che ci interessa è la loro, quanto meno per capire che cosa si dicono. Non dobbiamo mica farci conversazione, ma solo ascoltarli mentre parlano tra di loro, sentire cosa vanno dicendo e capirlo. In Northumbria io non servo proprio a nulla. Sei tu che dovresti andare.» «No, non sono d'accordo. Ed ecco qual è la mia seconda obiezione. Se ci vado e trovo che Vortigern è ancora vivo, potrei avere delle difficoltà a ripartire.» Questo mi colse del tutto impreparato. «Che vorresti dire? Vuoi dirmi che potrebbe venirti in mente di restare là?» «Naturalmente no! È solo che...» Esitò, cercando le parole giuste. «Se Vortigern è vivo e mi vede tornare nei suoi territori alla testa di un migliaio di cavalieri, potrebbe provare il desiderio di... cercare di trattenermi, di fare in modo che non riparta più. Il mio contingente gli procurerebbe degli enormi vantaggi.» «Pensi che potrebbe ricorrere alla forza?» «No, assolutamente no. È più probabile che cerchi di scoraggiarmi, di convincermi a non partire... Non dimenticare che un tempo sono stato uno dei suoi comandanti più esperti e fidati. Fino a quando non ti ho incontrato e non ho deciso di venire a sud per stare con la mia gente, Vortigern ha potuto contare sulla mia assoluta lealtà. In ogni caso, cercherebbe certamente di trovare il modo di persuadermi a usare le mie truppe per dargli man forte.» «Non ci sarebbe nessuna differenza se a capo di queste truppe ci fossi io.» «Invece sì che ci sarebbe. Quando arrivasse il momento tu partiresti, e lui non avrebbe alcuna possibilità di fermarti, mentre potrebbe convincersi che io gli devo ancora la mia lealtà. Potrebbe rendermi la partenza molto... difficile. Se fosse necessario, lo sfiderei, non c'è dubbio, ma non mi piacerebbe affatto, e il solo pensiero di dover guidare i miei uomini contro i suoi, mi fa venire i sudori freddi.» Per un attimo rimasi senza parole. Avevo quasi dimenticato quanto fossero stati profondi i legami che un tempo avevano unito Ambrogio a Vortigern. Poi però, riconsiderando quanto aveva detto, proseguii. «Avevi detto che la mia idea era insensata per tre motivi. Per il momento me ne hai elencati due: qual è il terzo?» «Ah sì, non sai nulla dei miei piani di attacco in Cambria né della strategia che ho messo a punto.» «È una questione che possiamo risolvere in pochi giorni. Conosci molto bene la Cambria?» «No, per nulla.» «E ne parli bene la lingua? E quella della Cornovaglia?» Scosse la testa. «Io invece sì. Parlo entrambe le lingue e conosco bene il territorio. È sufficiente che mi illustri la strategia che hai in mente e io la metterò in pratica. Quanto al fatto che Vortigern possa essere tentato di obbligarti a restare, dubito che sia probabile. Non credo che se la senta di rischiare di inimicarsi te e i tuoi uomini. Di nemici veri e pericolosi ne ha già abbastanza. Dunque: io realizzerò quello che tu avevi progettato di fare e tu agirai come avrei agito io se fossi andato in Northumbria. Ricordati che siamo quasi identici, che vedendo uno di noi due da lontano nessuno sarebbe in grado di dire se si tratta di Merlino o di Ambrogio. L'unica cosa ragionevole è che ciascuno di noi faccia quello che sa fare meglio. Non sei d'accordo?» «Parzialmente.» In realtà era tutt'altro che convinto. «Io ho sempre comandato la fanteria, Cay, non la cavalleria.» «Sciocchezze. Gli esploratori sono ai tuoi ordini, sei tu che li hai creati; ti seguirebbero fin nell'Ade.» Mi fermai, quindi proseguii con più calma. «Ascolta, Ambrogio, è una questione troppo importante perché possiamo deciderla stanotte, in fretta e furia. Perché non dormirci su? Poi, domani mattina, se sei ancora riluttante, faremo come era già stato deciso. In realtà, ciascuno di noi può andare indifferentemente tanto in Cambria quanto in Northumbria. Semplicemente, mi sembra ragionevole sfruttare al meglio i mezzi di cui disponiamo, il che significa utilizzare le tue competenze nel nord-est e le mie nell'ovest, dove ciascuno di noi conosce bene lingue e luoghi. Non ti sembra?» Sorrise. «Non c'è alcun bisogno di pensarci su. È ovvio che hai ragione e che quanto hai detto fila perfettamente, in ogni minimo dettaglio. Faremo come hai proposto tu. Ma c'è un prezzo da pagare per avermi convinto tanto facilmente ad accettare il tuo piano e a farmi rinunciare al mio.» «E quale sarebbe?» «Voglio prendere con me il giovane Artù, vorrei che la seconda fase della sua educazione fosse affidata a me. In tutti questi anni sei stato tu a crescerlo e a istruirlo, esclusivamente tu. Penso che ora cambiare maestro potrebbe essergli utile, non solo, ma a questo punto, potrebbe anche essere più sicuro. In Cambria, andrai a ficcarti dritto dritto in una guerra, sarai costretto a combattere, con tutti i rischi che comporta. Io invece potrei non incontrare alcuna ostilità, nel nord-est. Che cosa mi rispondi?» Non era neppure il caso di esitare o di pensarci su. Era indubbio che in Cambria avrei dovuto combattere, e che avrei corso dei rischi, ma se avessi accettato il piano di mio fratello, e avessi lasciato andare lui, il rischio più grande sarebbe stato quello di mancare l'appuntamento con Ironhair. Ora, cercando di immaginare il cadavere di Ironhair disteso ai miei piedi, annuii immediatamente, ansioso di partire e di sistemare una volta per tutte la faccenda. «Penso che il giovane Artù ne sarà estasiato, e poi hai perfettamente ragione quanto ai rischi. Bene, pagherò il prezzo, e prenderò con me il giovane Bedwyr. La tua osservazione però mi ha fatto venire in mente un'altra cosa di cui ti volevo parlare. Nella piana, oggi ho visto una scuola, non è così? È davvero una scuola?» «Sì, lo è. Quattro anni fa, uno dei consiglieri di Ludmilla, una donna, ha avuto l'idea, ma la nostra scuola è entrata in funzione soltanto verso la fine dell'estate di due anni fa. Ne sei stupito?» «Parlami dei preti che ho visto da quella parte.» Parve sorpreso. «Che cosa vuoi sapere?» «Chi sono e da dove vengono. Se sono stati invitati a venire qui, e se sì, per quale motivo. Mi sembrano monaci.» Ambrogio mosse appena le labbra, ma non si trattava di un vero e proprio sorriso. «Monaci? Ci sono ben pochi monaci in Britannia, Cay, almeno a quanto ne so io.» Fece una pausa. «Il monachesimo è uno stile di vita e di preghiera che dalle nostre parti non è ancora arrivato. Gli uomini di cui parli tu, vivono isolati, in comunità tagliate fuori dal mondo... ma non sono monaci nel senso che intendi tu, almeno questa è la mia impressione... o meglio, non sono monaci del tipo di quelli che vivono oltremare.» «Fratello, mi sembra che parli di cose senza senso.» Bevve un sorso di idromele e lo trattenne per un po' in bocca, prima di inghiottirlo. «Hanno senso, eccome, Cay, e sarai d'accordo anche tu appena avrai capito di che cosa sto parlando. Quelli che hai visto oggi, sebbene non siano preti, provengono dall'antica comunità cristiana di Glastonbury, a meno di venti miglia da qui. Sono seguaci del tuo buon amico Germano che, se ben ricordi, a Verulamium ha stabilito che debbano essere create delle scuole dove venga insegnata la parola di Dio ai giovani di questa regione.» Questo mi diede modo di riflettere. Glastonbury era il più antico insediamento cristiano di tutta la Britannia, e vi si era stabilita una comunità di anacoreti fin quasi dal tempo di Cristo. Anzi, c'era persino chi diceva che Cristo stesso vi si fosse recato. L'avevo sentito raccontare un'infinità di volte, ma non vi avevo mai prestato fede. A dire la verità, l'idea che il falegname di Galilea avesse viaggiato fin nelle contrade più remote della Britannia occidentale mi era sempre sembrata ridicola, e della mia stessa opinione era anche la stragrande maggioranza. Ciò nondimeno, da quelle parti c'era sempre stata una comunità religiosa che si era stabilita in un gruppo di casupole di pietra ammassate sul fianco della collina sopra le paludi, proprio alla base del torrione di roccia che ha dato il nome alla località, sopravvivendo esclusivamente grazie all'elemosina della gente del posto. Capii immediatamente che cosa intendesse Ambrogio quando li aveva definiti monaci. Tra i religiosi d'oltremare, era venuto di moda riunirsi in comunità ristrette, vivendo in povertà e nel sudiciume, nella contemplazione di Dio e delle sue opere, fuggendo le tentazioni del demonio, del mondo e della carne. Gli anacoreti di Glastonbury avevano vissuto così per centinaia di anni, tranquillamente e senza che nessuno si occupasse di loro. «Non sono mai stato da quelle parti» dissi. «Certamente ne ho sentito parlare, ma mai in un modo che mi abbia fatto venire in mente di andarci. Come sono arrivati qui questi preti?» Ambrogio sorrise. «Li ho invitati io, quando andai da loro.» Lo guardai stupito. «Davvero? E perché ci sei andato? È un posto in cui non c'è nulla, a eccezione del torrione di roccia.» «E della comunità monastica. Abbiamo avuto un visitatore, qui, nell'estate di quattro anni fa, un uomo di chiesa di nome Ludovico, che veniva dalla Gallia, per conto di Germano, e si stava avviando verso Glastonbury. La sua nave era finita fuori rotta e aveva fatto naufragio sulla costa settentrionale della Cornovaglia; quanto a lui, aveva avuto la fortuna di essere trascinato a riva aggrappato a un relitto. Dalla costa era poi arrivato a piedi fino a noi. Le nostre guardie lo avevano trovato ai margini dei nostri confini e lo avevano portato da me. Trascorse una settimana con noi, poi lo accompagnai io stesso a Glastonbury. È lì che incontrai il mio omonimo, Ambrogio, che è il capo di quella congregazione. Germano aveva inviato Ludovico da Ambrogio per invitarlo a mandare la sua gente a fondare scuole. Si trattava di una fortunata coincidenza, dal momento che avevamo appena saputo che il Consiglio delle donne della nostra Colonia aveva espresso l'auspicio che si creasse una scuola qui a Camelot. Mi parve un segno del destino, così invitai la gente di Ambrogio a venire da noi l'anno seguente, una volta che avessimo costruito la nostra scuola, e a cominciare a insegnare.» «Insegnare che cosa?» «Religione cristiana, soprattutto, i suoi principi e le verità della fede. Tieni presente che non tutti i monaci sono dei letterati: in effetti, soltanto pochissimi lo sono. Ambrogio insegna a leggere e scrivere, e lo stesso fa Tommaso. Baloric, il più anziano del gruppo, insegna aritmetica e geometria euclidea, il che vuol dire che sono suoi allievi soltanto i ragazzi più dotati. Questi monaci si autodefiniscono Confraternita di Giuseppe, e la loro vita è fatta di lavoro e preghiera. Trascorrono l'autunno e l'inverno con noi, una volta che le messi sono state raccolte e messe al sicuro, ma ritornano alla loro comunità in primavera e vi rimangono fino alla fine dell'estate, mentre i nostri bambini lavorano nei campi insieme ai genitori.» «Hmm. E sei dell'opinione che la loro presenza qui, nella nostra Colonia, sia un bene?» «Decisamente sì.» «Perfetto, allora non parliamone più; soltanto non aspettarti che vada anch'io a fare una visita a Glastonbury. La mia religiosità non arriva a tanto.» Mi rispose con un sorriso sulle labbra: «Ciascuno di noi manifesta le proprie convinzioni a suo modo». «Che vorrebbe dire?» «Tutto quello che puoi desiderare che significhi. Alcuni di noi mantengono chiuso nel proprio cuore ciò in cui credono, altri lo mostrano più apertamente. Questo è tutto.» «Sì, bene...» Guardai verso il fuoco, che stava di nuovo per spegnersi, ridotto a poche braci rosseggianti sul fondo del braciere. «È tardi, però dobbiamo ancora parlare di Artù.» «Artù si è fatto alto. Non c'è dubbio che sia uno di noi. E si sta irrobustendo parecchio.» «Sì, e si è anche innamorato.» Gli raccontai brevemente del colpo di fulmine di Artù; insieme ne ridemmo affettuosamente prima che Ambrogio mi chiedesse: «Pensi sia giunto il momento che impari ad andare in guerra?». «Sì, e gli ho anche promesso che lui e i suoi amici, Bedwyr, Gwin e Ghilly potranno cavalcare con noi. Ormai ne hanno l'età. Però dobbiamo separarli. Impareranno meglio se non stanno insieme. Porterai Artù con te, nel nord-est, per la sua prima sortita. Quando sarete di ritorno, insieme gli faremo da maestri. Sa che deve cominciare come semplice servitore e portaordini. Si occuperà delle nostre armi, luciderà le nostre armature, striglierà i nostri cavalli, porterà i nostri messaggi e imparerà a cavarsela da solo e a fare affidamento sul proprio giudizio. Nel frattempo porterò Bedwyr con me in Cambria, e forse anche Ghilly, sebbene abbia un anno di meno. In fin dei conti, Ghilly durante la campagna, potrebbe prestare servizio con Filippo, dal momento che è rimasto molto colpito dal modo in cui ha comandato la nostra guarnigione.» «Non ho nulla da obiettare. E dell'altro ragazzo, Gwin, che ne facciamo?» «Lo lasceremo qui, a Camelot, agli ordini di Dedalo. In un primo momento, non ne sarà affatto contento, anzi, proverà un gran dispiacere a non partire con gli altri, ma non potrà avere un maestro migliore di Ded. Poi, quando saremo tornati, i ragazzi cambieranno superiori, e toccherà a Gwin partire per la prossima spedizione. Pensi che funzionerà?» «A questo punto, penso che ci siano solo tre cose più sicure.» «E quali sarebbero?» «Che è molto tardi, che ho finito il mio idromele e che sto per andare a letto. Dormi bene, fratello, perché domani sarà una giornata lunga. Sarà certamente un giorno di festa, ma alla fine non vedrai l'ora di andare a dormire. Spegni le lucerne quando esci di qui, e non essere tanto egoista da svegliare Tress quando ti infili nel letto.» Sbadigliai, e lo seguii verso le scale che portavano al piano superiore, e intanto spensi le ultime due lucerne. Il giorno seguente fu lungo proprio come aveva previsto Ambrogio, ma paradossalmente volò via in un soffio, da quando all'alba suonarono le trombe con cui venne ordinato alla guarnigione di andar a preparare la spianata per i festeggiamenti, fino agli ultimi assembramenti accanto ai falò, quando a tarda notte i canti e i suoni degli strumenti a corda finivano col diventare un insieme indistinto di suoni. Di quella giornata due ricordi sono rimasti impressi maggiormente nella mia mente. Uno fu il constatare, subito dopo lo spuntare del giorno, che in effetti a Camelot avevamo migliaia di soldati. Era stato decretato un giorno di festa e l'intera guarnigione era stata esonerata dal servizio, a eccezione di un contingente ridotto al minimo che rimanesse di guardia durante la giornata. I soldati a cavallo furono ancor meno impegnati, anche se toccò a loro il compito di preparare la spianata per la festa del pomeriggio e la possibilità di spassarsela fu strettamente limitata dal divieto di bere prima del tramonto. Li guardavo dall'alto, da una curva della strada che si inerpicava su per la collina, mentre si sparpagliavano per la vasta spianata sottostante, trasformandola in poche ore da una distesa spoglia e polverosa in una vasta tendopoli punteggiata da grandi fuochi, che aspettavano solo di essere accesi. Erano stati sistemati in cavità poco profonde attorno alle quali erano stati collocate tavoli e panche, delle semplici assi di legno, in modo da formare cerchi concentrici. Al centro della spianata avevano lasciato uno spazio rettangolare, di sessanta passi per quaranta, in cui verso la fine della giornata si sarebbero tenuti gli spettacoli più importanti. La notte precedente alcuni di loro avevano scavato delle buche in cui accendere i fuochi per cucinare, a lato della tendopoli principale, vicino alla fila di alberi che delimitava il lato meridionale. Il lavoro per arrostire allo spiedo gli animali più grandi era iniziato molto prima dell'alba, sotto lo sguardo attento di Marco e della sua squadra di cuochi. L'intera area meridionale, lungo le distese erbose che fiancheggiavano la vera e propria spianata delle esercitazioni, era stata delimitata da steccati, e delle guardie tenevano lontano i curiosi, impedendo loro di avvicinarsi al luogo in cui si preparavano i cibi. Il numero delle persone che si davano da fare dentro la staccionata era notevole, ma quello di chi si trovava nella spianata era addirittura inimmaginabile. Prima di allora, non avevo mai visto tanti soldati lavorare nello stesso posto. Il secondo ricordo furono le gare di equitazione e di abilità nell'uso delle armi che si tennero nel pomeriggio. Poi, per la prima volta, ebbi modo di vedere che cosa potesse fare un contingente di uomini a cavallo, i nostri esploratori, con le nuove lance leggere. Uno squadrone dopo l'altro si fecero avanti i cavalieri, coperti da armature di cuoio indurito e, galoppando a tutta velocità, eseguivano acrobazie impensate: si sporgevano dalle selle, tenendosi soltanto con le redini e le staffe, e riuscivano a raccogliere da terra con la punta delle loro lance dei bersagli colorati a cui erano stati fissati nastri multicolori. Poi altri squadroni sopraggiunsero a ondate, galoppando anch'essi a tutta velocità verso una fila di scudi appesi a dei pali conficcati nel terreno; poi facevano impennare i cavalli simultaneamente e invertivano la direzione mentre i cavalieri, aggrappati alle redini scagliavano le lance oltre gli scudi, come dovessero colpire gli uomini che, sul campo di battaglia, li avrebbero usati come riparo. Dopo lo "scontro" galoppavano via, evitando abilmente i cavalieri che a loro volta sopraggiungevano in ondate successive. Ogni cavaliere brandiva una nuova lancia, presa da una sorta di grande faretra che gli pendeva dietro la sella. Osservando quelle manovre sapevo di assistere a una nuova forma di tecnica militare. Durante tutta l'esibizione, Dedalo era rimasto accanto a me, e così pure Rufio, e ora, dopo che l'ultimo squadrone si fu allontanato accompagnato dallo scrosciare degli applausi, Rufio disse: «Vedete che cosa hanno imparato i nostri compagni mentre noi eravamo lontani, rintanati tra i monti? Le loro evoluzioni vi fanno sentire inadeguati, non è così?». Dedalo lo guardò di traverso, sorridendo. «Rufio, se tu non avessi incontrato quel dannatissimo orso, avremmo potuto dare una dimostrazione di come si maneggia la spada, facendo loro vedere la nostra tecnica di combattimento con i due bastoni e allora sì che li avremmo lasciati senza parole.» Mentre Rufio annuiva e sputava sconsolato, Ded si voltò verso di me. «I ragazzi però potrebbero farlo, non ti pare? Non con due bastoni, non ne sono ancora in grado, ma se la cavano più che bene con un bastone di noce ciascuno, almeno quanto basta per sbigottire tutta questa gente. Che ne pensi, Cay?» A dire la verità, era venuto in mente anche a me, ma avevo scartato l'idea. «No, Ded, non penso che sia il caso. Innanzitutto, potrebbe essere interpretato male: potrebbe dare l'impressione che ci sentiamo inferiori e cerchiamo di non darlo a vedere mettendoci in mostra. In secondo luogo, non credo che per i ragazzi sarebbe bene essere costretti a esibirsi. Meglio non fare nulla che richiami l'attenzione su Artù.» Ded si strinse nelle spalle e annuì. «Come credi, il comandante sei tu.» Alzò la testa e annusò. «Dio mio, la carne ha un profumino delizioso. Sto morendo di fame. Andiamo a vedere se sono quasi pronti a servire.» Insieme ci avviammo verso l'area destinata alla preparazione dei cibi e questo costituisce l'ultimo ricordo preciso di quella memorabile giornata. So che Tress si divertì moltissimo, poiché mi è rimasto impresso nella memoria il suo viso arrossato e ridente, gli occhi luminosi, il respiro leggermente affannato per aver danzato a lungo con uno dei giovani ufficiali; so che il cibo fu vario ed eccellente, perché non ho dimenticato che Marco fu portato in trionfo da una rumorosa schiera di soldati e cuochi; e so anche che nel corso della giornata incontrai molti visi nuovi, ma non ne ricordo nessuno in dettaglio così come non riesco a ricordare di essere poi andato a letto quella notte. Il giorno seguente fu dedicato a cancellare le tracce dei festeggiamenti e ancora una volta furono i soldati a cavallo a invadere la grande spianata. Verso sera, nel breve crepuscolo primaverile, era ormai sparita ogni traccia della tendopoli del giorno precedente; persino i cerchi scuri lasciati dai fuochi erano stati cancellati dagli erpici, mentre il suolo era stato nuovamente spianato e le ceneri seppellite o disperse. Il giorno dopo ancora, quando sorse il sole, l'enorme spianata era tornata alla normalità e l'intera superficie era quasi completamente coperta da formazioni perfettamente allineate di uomini immobili: la metà posteriore era costituita da squadroni di cavalleria pesante, sui fianchi erano schierate piccole unità di esploratori mentre le fila anteriori e centrali erano composte interamente di fanti. Stavo attraversando la porta anteriore del forte in compagnia di Ambrogio - eravamo diretti verso la spianata per passare in rassegna le truppe - quando fermai di colpo il cavallo. Anche Ambrogio si fermò lanciandomi uno sguardo interrogativo. «Che c'è?» «Sono tutte marroni.» Si voltò subito per osservare l'esercito schierato nella spianata, cercando di capire che cosa intendessi, poi guardò di nuovo verso di me. «Le armature, è questo che vuoi dire?» «Sì, osservandole tutte insieme, come un blocco unico, mi ha colpito notare che c'è poco metallo.» «È proprio così, di metallo ne abbiamo poco, non abbastanza per armare migliaia di soldati. Anche se, a dire il vero, non c'è un effettivo bisogno di armature metalliche. I Romani hanno conquistato il mondo con armature di cuoio, non lo sai?» Sorrise. «Tre strati di cuoio ben indurito e rafforzato da borchie di metallo sono in grado di resistere alla maggior parte degli assalti. Inoltre tutte le nostre armi sono di ferro e sono le migliori della Britannia, forgiate nelle nostre fucine. Se poi guardi meglio, vedrai che i nostri ufficiali hanno armature di metallo. Loro ne hanno più bisogno, dal momento che sono maggiormente esposti agli attacchi del nemico. Adesso possiamo andare?» «Aspetta un momento!» Aveva già cominciato a spronare il cavallo, ma si fermò di nuovo. «Il ferro, dove lo prendiamo attualmente?» «Dove lo abbiamo sempre preso, ovunque riusciamo a trovarlo. Carol ha degli aiutanti che non fanno che perlustrare il paese, da un capo all'altro. I giacimenti di minerale grezzo sono soprattutto nel sud della Cambria, subito a nord di Glevum, e lungo la costa sudorientale. Ma attualmente sono pochi coloro che lo estraggono e, naturalmente, le coste sudorientali sono state invase dai Sassoni. Pertanto la maggior parte del ferro grezzo proviene dal paese di Pendragon...» Tacque, pensieroso, poi sospirò. «Nei suoi scritti Publio Varro sosteneva che un giorno il ferro sarebbe diventato più prezioso dell'oro. Come vorrei che si fosse sbagliato!» Anch'io lo avrei voluto, ma purtroppo l'accuratezza delle previsioni del mio prozio era ormai una realtà, e da molti anni per giunta. Carol era l'armaiolo più anziano di Camelot, uno dei tre figli, ormai di mezz'età, di Equo, amico di vecchia data di Publio Varro e suo socio in affari; sapevo bene come gran parte del suo tempo venisse dedicata alla ricerca sempre più infruttuosa di ferro di prima fusione e persino di minerale grezzo. «In fatto di metalli, Publio Varro si sbagliava raramente. Ma parlando di Carol mi è venuto in mente che tra i miei bagagli ho qualcosa per te. Non si tratta di un regalo, poiché è tanto tuo quanto mio, ma sono certo che ti farà piacere. Non appena avremo finito l'ispezione, se vieni via con me potrò dartelo. Per ora, le nostre truppe hanno un aspetto magnifico, esattamente come devono... Adesso però è proprio ora che le raggiungiamo, le abbiamo fatte aspettare anche troppo a lungo.» Scendemmo verso la pianura e a mano a mano che ci avvicinavamo alla massa compatta delle nostre truppe, arrivando finalmente abbastanza vicino da distinguere i diversi visi, seri e concentrati, sotto file e file di elmi da guerra perfettamente identici, mi venne da pensare che nei giorni e nei mesi seguenti avrei avuto ben poche occasioni di vedere morbidi visi femminili. Ci vollero più di due ore per ispezionare i vari reparti, ma fu un compito piacevole e gratificante nel tiepido sole primaverile. I nostri uomini erano risoluti e pronti per la guerra, e tra di loro serpeggiava un crescente senso di anticipazione, sebbene si mantenessero perfettamente immobili e silenziosi mentre procedevamo tra i ranghi, osservando con occhio critico armi e armature, animali e selle. I veterani della guerra di Lot, che si era combattuta anni addietro, si distinguevano senza ombra di dubbio grazie alle decorazioni che si erano conquistate sul campo di battaglia. Soltanto loro avevano il diritto di esibire sugli elmi da parata un cimiero rigido e biancastro, fatto di setole di cinghiale, in commemorazione della vittoria riportata su Gulrhys Lot, il cui emblema era stato per l'appunto il cinghiale di Cornovaglia. Tutti gli altri soldati a cavallo avevano cimieri scuri di crine di cavallo. Oltre ai cimieri, molti dei nostri veterani esibivano orgogliosamente anelli al merito: in questo mio nonno Caio si era ispirato a una tradizione militare romana per la quale i soldati che si erano distinti durante il combattimento venivano premiati con degli anelli di misure e metalli diversi - oro, argento, bronzo e ferro - che venivano poi fissati alle loro corazze. Alcuni di questi anelli erano decorati, altri erano lisci, ma ciascuno aveva un significato particolare. Il più grande, grande quanto il palmo di una mano, simboleggiava la corona che nei tempi antichi poteva essere portata da soldati che si erano distinti per imprese eroiche, per esempio per aver catturato un caposaldo nemico. Sulla sua corazza, Terzio Lucca, il nostro primus pilus, sfoggiava ben tre file di questi anelli, che in pratica gli coprivano l'intero petto. Dei vari anelli, due erano di oro liscio, e indicavano atti di ineguagliabile valore, mentre due erano di argento lavorato in modo da sembrare una corda, e stavano a indicare che aveva comandato due diverse compagnie nel corso di due campagne vittoriose; altri due erano invece di argento liscio e i tre fissati più in basso erano di bronzo: ciascuno di essi testimoniava che da solo aveva salvato la vita di un compagno durante la battaglia. Portava anche delle spalline di ferro lucido, che ricoprivano la giunzione tra la parte anteriore e posteriore della corazza, su cui erano fissati altri dodici anelli più piccoli, saldati a strati uno sopra all'altro. Sulla sommità dell'elmo, dotato di piastre che gli coprivano interamente il viso a eccezione degli occhi, sfoggiava un enorme e vistoso cimiero rigido, fatto di crine di cavallo, che ondeggiava da una spalla all'altra, come quello dei centurioni. Terzio Lucca, nel fiore degli anni, era veramente imponente nella sua armatura da parata, e a conclusione della nostra formale ispezione dei suoi uomini lo ringraziammo cerimoniosamente prima di rimettere nelle sue mani il controllo del reparto, dopo un ultimo saluto al podio dove erano allineati gli stendardi delle nostre formazioni. Mentre Ambrogio e io ci allontanavamo, fianco a fianco e seguiti, nella nostra qualità di comandanti, dai nostri ufficiali, udimmo la possente voce di Lucca, che si rivolgeva un'ultima volta alle truppe ordinando loro di prepararsi a rompere le righe in buon ordine. Una volta rientrati al forte, ringraziai gli altri ufficiali e li congedai prima di accompagnare Ambrogio nella stanza in cui erano accatastate tutte le casse e le ceste che non avevo ancora vuotato. Trovai subito quella che cercavo, e mi affrettai a sollevare il coperchio che proteggeva la custodia di Excalibur, accuratamente sistemata tra trucioli di legno e le due copie realizzate con quanto restava della Pietra del Cielo. Ne presi una e la lanciai ad Ambrogio. L'afferrò prontamente e la sollevò verso la luce, osservandola attentamente. «Ci ho ripensato la notte scorsa, quando mi hai fatto tornare in mente il giorno in cui, in territorio sassone, ci siamo mostrati identici per sbalordire i nemici. Ti ricordi come eri preoccupato perché i nostri archi erano diversi, come se coloro che stavamo attaccando potessero notare una cosa simile da un centinaio di passi di distanza?» Sorrise e portò l'elsa ancora più vicino agli occhi. «Bene, almeno d'ora in poi le nostre spade saranno identiche.» Tirai fuori anche l'altra, perché potesse rendersi conto di quanto fossero identiche in tutto e per tutto, dal pomo all'estremità del fodero. «Chi ha fatto i foderi?» Impugnai la mia spada ed estrassi la lama. «Li ha fatti Joseph, usando le stesse tecniche dello zio Varro. Sono di pelle di pecora, come puoi vedere, ripiegata e cucita, con il vello all'interno, ma rasato in modo da lasciargli soltanto una leggera lanugine che pulisce e lucida la lama ogni volta che la si ripone o la si sguaina. La parte alta è rinforzata con un rivestimento di metallo che li mantiene rigidi e compressi attorno all'estremità superiore della lama, e fa da supporto al gancio lungo e diritto fissato sul retro. C'era bisogno di qualcosa che ci permettesse di portare queste spade e il gancio è quello che Joseph ha escogitato. La lama è troppo lunga perché la si possa sguainare con il braccio teso, sia che penda dalla spalla o dal fianco, ed è troppo lunga anche perché si riesca a camminare portandola appesa alla cintura. L'unica alternativa sarebbe tenerla in mano per tutto il tempo, il che ovviamente è ridicolo. Pertanto, il lungo gancio sul retro del fodero si infila nell'anello fissato tra le spalle, in modo che il fodero penda lungo la schiena con l'elsa che spunta sopra le spalle. Fin qui nulla di nuovo. La novità arriva quando è il momento di brandire la spada. Vedi?» Mentre parlavo gli avevo dato una dimostrazione dei vari movimenti. «Afferri l'elsa, porti la mano libera dietro la schiena, in basso, e spingi verso l'alto il fodero finché il gancio si sfila dall'anello che hai sulle spalle, poi mandi avanti la lama, sopra la spalla, in modo da poterla afferrare di nuovo con la mano libera. Sguaini la spada, così, e fai scivolare il gancio del fodero nella cintura, per non perderlo. Il fodero rimane appeso, flessibile e innocuo, e tu hai in mano un'arma nuda e micidiale. Sei d'accordo?» «Hmm, sì. Molto ingegnoso. È stato Joseph a escogitarlo?» Ambrogio armeggiava dietro la propria schiena, cercando di inserire il lungo gancio del fodero nell'anello che aveva tra le spalle, dove normalmente stava appesa la spatha, in dotazione alla cavalleria, la cui lunga lama veniva fatta passare direttamente attraverso l'anello. «Proprio lui. Non preoccuparti, ti ci abituerai. Per i primi giorni anch'io ho avuto delle difficoltà, ma è solo questione di pratica, come in tutte le cose per altro, equilibrio e sensibilità. Ormai ho imparato a fissare il gancio senza neanche pensarci, e sono in grado di afferrare la spada e di averla nuda tra le mani prima che chiunque possa contare fino a tre.» Alla fine riuscì a sistemare il fodero e poi cercò di sguainare la spada, ma i suoi movimenti erano lenti e impacciati. Li ripetei io stesso, con scioltezza e disinvoltura, dando un colpo alla lama ancora inguauiata contro la mia spalla destra per facilitare l'operazione, poi girando il polso verso l'interno e portando infine la lama trasversalmente rispetto al mio petto dove con la sinistra potei afferrare il fodero proprio sotto l'elsa; tirando con entrambe le mani in direzione opposta sguainai la spada, pronto a colpire. Il fodero ormai vuoto pendeva dalla mano sinistra, e lo feci scivolare nel gancio della cintura. «Come ti ho detto, farai in fretta a imparare il trucco, e la cosa più bella è che a cavallo funziona ancora meglio che a piedi.» Ambrogio stava esaminando la lama della sua spada, tenendola accanto al viso e muovendola in modo che la luce si riflettesse su tutta la sua lunghezza. «Sì» disse infine, distrattamente. «Sono sicuro che sarà così. Quest'arma appare persino più bella - voglio dire, guardandola così da vicino - di qualsiasi altra spada mi sia mai capitato di vedere. Il ferro ha un motivo ondeggiante, molto più pronunciato di quello che si può notare sulle altre spade. So che deriva dal modo in cui il fabbro ha piegato e attorcigliato le barre con cui ha forgiato la spada, quando le ha riscaldate e poi martellate per appiattirle, tuttavia sembra diverso.» «Certo che è diverso. È il metallo a essere diverso: questo è metallo della Pietra del Cielo, non è semplice ferro.» Si voltò verso di me e raddrizzò le spalle prima di far scivolare con grande cura la lama della nuova spada nella sua custodia di cuoio. «Dov'è adesso Excalibur?» Feci un cenno verso la grande cassa ancora aperta. «È lì.» «Posso darle un'occhiata?» Presi la cassetta di legno lucido, soffiando via qualche truciolo che era rimasto attaccato alla sua superficie brillante, poi la aprii e tirai fuori Excalibur, afferrandola direttamente per la lama protetta dal drappo di seta e porgendo l'elsa a mio fratello. Ambrogio la contemplò in un silenzio pieno di meraviglia, senza fare alcun movimento per afferrarla, poi rapidamente sguainò di nuovo la spada che teneva ancora in mano, lasciando cadere sul tavolo il fodero vuoto e spostandone l'elsa nella mano sinistra prima di prendere Excalibur con la destra. Rimase poi a osservare le due spade, tenendole davanti a sé, una accanto all'altra. «È molto più... elaborata» mormorò. «Sì, certo. È un'arma da parata oltre che da difesa e offesa, un'arma da re. Al confronto l'altra è un semplice strumento da lavoro, la spada di un guerriero.» Alzò la testa per guardarmi in faccia, con un mezzo sorriso sulle labbra. «Vorresti dire che un re potrebbe non essere anche un guerriero?» «Lo sai benissimo, fratello. Ma spesso si da il caso che un grande guerriero non possa mai diventare re.» «No, e che non lo voglia neppure diventare.» Era tornato a osservare le due spade. «Guarda come luccica la lama! Non è mai esistito nulla di simile.» «No, ti sbagli, Ambrogio. Ce ne sono altre due, esattamente uguali, e tu ne hai una in mano. Le loro lame sembrano più opache, indubbiamente, ma è solo perché Excalibur è brunita. Sono repliche, perfettamente identiche, l'unica differenza è che queste due sono semplici e disadorne, mentre l'originale è più appariscente.» «Più appariscente... è una parola sgradevole, Cay. Fa pensare a qualcosa di falso. Questa è Excalibur! E non ha nulla di falso! Artù l'ha già vista?» «No, non ne conosce l'esistenza. È ancora troppo giovane. Presto sarà sua, ma prima devo essere assolutamente convinto che sia abbastanza grande da capire perché fino a ora gliel'ho tenuta nascosta.» Ambrogio mi guardò aggrottando le sopracciglia, poi dopo avermi indirizzato un sorrisetto sardonico, modificò il modo in cui fino a quel momento aveva tenuto la spada: la impugnò per la guardia a croce e porse l'elsa a me. «Direi proprio che la tua affermazione era contorta,» disse lentamente, «ma penso di aver capito che cosa intendessi dire.» «Ottimo. Allora sentiamo se sei in grado di ripeterlo.» «Il ragazzo è troppo giovane, e non sarà abbastanza grande per sapere finché non sarà grande abbastanza da sapere che è troppo giovane. Non è forse questo che intendevi?» Risi e chiusi il coperchio della lucida cassetta di legno, poi rimisi la gloriosa spada nel cassone in cui veniva custodita. «Esattamente. Fratello! È precisamente quello che ho detto.» PARTE SECONDA CAMBRIA VII. «Merlino, guarda Bedwyr.» Le parole di Donuil mi strapparono ai miei pensieri e mi fecero voltare la testa per guardare verso il punto che mi indicava. Immediatamente vidi il giovane Bedwyr che scendeva al gran galoppo lungo il leggero pendio della collina che si innalzava di fronte a noi, evitando con cura gli spuntoni di roccia che punteggiavano il terreno erboso e scegliendo la via più breve e agevole per raggiungere l'altura da cui lo stavamo osservando. «Cavalca come un centauro, non ti pare?» «Sì, proprio così» risposi. «Ma quello di cui abbiamo bisogno è di guerrieri che possano volare come aquile.» Sempre restando in sella mi voltai per controllare le mie truppe sparpagliate per oltre un miglio, lungo l'ampia striscia pianeggiante che si snodava lungo la costa. Dietro di loro, il sole del mattino si rifletteva con luminosità abbagliante sulle onde che increspavano la superficie del mare: era ancora agitato, nonostante il cielo completamente privo di nuvole, per i postumi del violento temporale estivo che la notte precedente si era abbattuto sulla zona. La pianura costiera, lungo il limite più occidentale della Cambria meridionale, era ampia, e non avevo alcun timore di restare intrappolato, nonostante il mio esercito se ne stesse sparpagliato intorno e i soldati si stessero riposando al sole dalle fatiche della marcia. Ben presto però udii la voce roca di Rufio che borbottava una risposta alla mia osservazione. «Non so a quanto servirebbero, Merlino. Siamo in Cambria, te Lo sei dimenticato? Anche un'aquila che voli alta nel cielo può essere abbattuta da una freccia di Pendragon se ben mirata.» Sorridendo mi voltai per guardarlo in faccia. Accanto a lui, in piedi con una mano appoggiata sul collo del cavallo di Rufio, il suo amico Huw Fortebraccio, il massiccio capo dei guerrieri di Pendragon che si erano alleati con noi, mi stava osservando scuotendo la testa con una certa bonomia di fronte al commento di Rufio. Il suo arco lungo gli pendeva da una spalla e dietro la testa spuntava una faretra piena di frecce. Ammiccai verso di lui e ribattei voltandomi verso Rufio. «Vero Rufio, ma tutti gli archi lunghi di Pendragon sono dalla nostra parte, dunque quello che hai detto vale poco.» «Hmm, puah!» proruppe pieno di disgusto. «La maggior parte, comandante, solo la maggior parte, non dimenticarlo. Per i miei gusti, con Ironhair ci sono troppi voltagabbana, troppi figli di puttana!» Si riferiva a Owain delle Grotte, lo sapevo bene. Annuii, poi mi rivolsi a Benedetto, il cui cavallo era talmente vicino al mio, sulla sinistra, che le nostre ginocchia si toccavano. «Bene, adesso sapremo che cosa ha scoperto Filippo nell'entroterra. A giudicare dalla velocità con cui galoppa Bedwyr dovrebbe essere qualcosa di importante.» Benedetto sorrise. «Sì, a meno che stia semplicemente cercando di far scoppiare il cavallo poiché ha visto che lo stiamo guardando.» Dietro di me, udii Derek ridere rumorosamente alla battuta di Benedetto. Il re di Ravenglass cavalcava un cavallo grande quanto il mio Germanico. Era cambiato molto da quando era arrivato a Camelot. La sua decisione di smettere di combattere aveva cominciato a venir meno a mano a mano che si era convinto della necessità di farla finita, subito e una volta per tutte, con Ironhair e il suo folle alleato Carthac. Infatti, essendo anch'egli un re, Derek di Ravenglass aveva un senso della giustizia che non poteva tollerare l'esistenza degli usurpatori. In quel momento indossava un'uniforme che al tempo della dominazione romana lo avrebbe qualificato come un tribuno, con tanto di mantello scarlatto, elmo piumato e una corazza di cuoio riccamente lavorata. Guardai prima Derek e poi Benedetto, scuotendo la testa con finto disappunto. «Cinici! Sono circondato da cinici e pessimisti. Stando così le cose, c'è poco da stupirsi che ce la caviamo tutt'altro che bene qui in Cambria!» Spronai leggermente il mio cavallo e mi spostai un po' più avanti, sia per vedere distintamente Bedwyr sia per far sì che potesse notare che lo stavo aspettando. Rimasi immobile mentre il ragazzo si avviava su per il pendio e dopo qualche minuto raggiungeva la sommità, ansando quasi quanto il suo cavallo. Nei mesi che avevamo trascorso insieme in Cambria era cresciuto molto e si era notevolmente irrobustito; osservandolo mi accorsi di pensare ad Artù e non potei fare a meno di chiedermi se anche lui avesse fatto progressi analoghi, ovunque si trovasse laggiù nel nordest. Bedwyr fece fermare il cavallo e saltò a terra. Poi mi si avvicinò, si mise sull'attenti in un rigido saluto, portando il pugno destro contro la spalla sinistra, e con occhi spalancati alzò lo sguardo verso di me che lo fissavo dall'alto del mio cavallo. «Comandante legato Merlino!» Annuii, reprimendo a fatica un sorriso di fronte alla sua accigliata compostezza. «Riposo, soldato, e procedi con il tuo rapporto.» Respirò profondamente e si tenne ancora più rigido, con i gomiti leggermente piegati e contratti per mantenere il corpo completamente immobile, mentre i pugni serrati poggiavano appena sui fianchi. Poi, con voce secca e con un tono formale molto diverso da quello consueto, snocciolò il suo messaggio. «Comandante legato Merlino, il legato Filippo desidera comunicarti di non essere riuscito a stabilire alcun contatto significativo con le forze nemiche. Negli ultimi sei giorni è penetrato nei territori che gli sono stati assegnati per questa ricognizione, come stabilito e secondo le istruzioni ricevute, e non ha incontrato alcuna resistenza. Desidera riferire che il territorio e le colline compresi tra la sua posizione presente, quindici miglia a nord di qui, e la tua presente posizione, inclusa tutta la regione costiera, sono privi di formazioni nemiche. Le sue coorti di fanti hanno esplorato le cime e i pendii più elevati senza incidenti, e le truppe a cavallo, agli ordini dei tribuni Falvo e Tessio, hanno completato il pattugliamento delle valli e della parte bassa delle alture, da entrambi i lati della catena di colline loro assegnate. Si sono ricongiunti due giorni fa, senza aver incontrato alcun impedimento nella loro marcia di avvicinamento verso il punto di incontro. Il legato ha raggiunto gli obiettivi che gli erano stati assegnati, e ora mantiene le proprie posizioni, secondo gli ordini ricevuti. Attende ulteriori istruzioni, ma rispettosamente ti informa che ieri nella zona più settentrionale le sue sentinelle hanno avvistato il passaggio di una flotta che, pur tenendosi in alto mare, si dirigeva velocemente in direzione sud, con la possibilità di un cambiamento di rotta verso la tua attuale posizione. La tempesta della notte scorsa, ipotizza il legato, potrebbe averla dispersa o affondata, tuttavia alle prime luci dell'alba mi ha inviato a tutta velocità a riferirti le notizie. La flotta è costituita da una grande bireme, accompagnata da un numero imprecisato di galee, che si tenevano troppo al largo per poter essere contate con sicurezza, ma il cui numero è stimato non inferiore a quindici imbarcazioni. Comandante legato!» La formula finale di congedo era accompagnata da un rigido saluto militare, a indicare che il rapporto era terminato. Respirai profondamente, poi mi rivolsi a lui. «Grazie, soldato. Un rapporto eccellente e succinto. Nessuna domanda. Riferisci ora a Terzio Lucca, se lo desideri, e fatti assegnare un posto in cui mangiare e dormire, dopo esserti preso cura del tuo cavallo. Quando ti sarai riposato, potrai tornare da me per ulteriori istruzioni.» Bedwyr mi salutò nuovamente, poi si voltò e se ne andò. Lo osservai mentre montava a cavallo e galoppava via, quindi mi rivolsi ai miei compagni. «Stessa storia, ma questa volta c'è anche una flotta. Probabilmente passeranno al largo, tuttavia è meglio tenersi pronti, nel caso in cui Ironhair avesse deciso di darci fastidio.» Guardai verso il cielo, ancora chiaro e senza nuvole. «Radunate i comandanti della cavalleria, se non vi dispiace. Ci incontreremo nella tenda del comando tra mezz'ora. Grazie.» Non appena ebbero cominciato a disperdersi, Donuil colse il mio sguardo e si indicò il petto, alzando un sopracciglio, come per chiedermi se desideravo che rimanesse. Scossi la testa, facendogli cenno che poteva andare. Pochi istanti dopo, ero solo. Mi guardai attorno per essere certo che nessuno mi prestasse attenzione, poi spronai Germanico e scesi lungo il fianco della collina, dalla parte opposta rispetto al mare, verso una stretta nicchia che si apriva nel versante sovrastante la valle che Bedwyr aveva attraversato poco tempo prima. Avevo scoperto, e utilizzato, quel rifugio il giorno precedente quando, come in quel momento, avevo avuto bisogno di solitudine. Una volta lì, sapevo di essere nascosto agli occhi di tutti. Scesi da cavallo e mi tolsi il pesante elmo, asciugandomi la fronte e l'interno della visiera con uno dei morbidi fazzoletti ricamati che Tress mi aveva confezionato proprio per quell'uso. Poi mi stirai con forza, sollevandomi sulla punta dei piedi, e sbadigliai, cercando di alleviare l'indolenzimento delle natiche. Frugai nella sacca da sella alla ricerca della pietra per affilare che portavo sempre con me, sganciai e sguainai la spada, poi mi sedetti comodamente su uno spuntone di roccia che costituiva una sorta di sedile naturale. A quel punto cominciai ad affilare la spada, mentre i miei pensieri andavano avanti e indietro seguendo il movimento ritmico della pietra che strisciava contro il bordo della lama. Bedwyr manteneva in perfetta efficienza le mie armi - faceva parte del suo addestramento - ma le abitudini di una vita sono difficili da cambiare e affilare personalmente le mie lame almeno una volta al giorno mi dava sicurezza. Poi, mentre la mia mente si lasciava cullare dalla monotonia e dalla meccanicità dei miei movimenti, anche i miei pensieri presero a fluire più agevolmente. Erano passati quattro mesi dall'ultima volta che avevo parlato con Ambrogio e più di tre da quando ero arrivato in Cambria alla testa delle due legioni di Camelot. Da quel momento in poi eravamo stati impegnati in una finta guerra, marciando avanti e indietro, in lungo e in largo, da un capo all'altro della Cambria, cercando di venire in contatto con un nemico sfuggente, effimero e inconsistente come le nuvole e le nebbie che di buon mattino avvolgevano le montagne. Eppure i nemici c'erano davvero, erano reali e per giunta numerosi. Li vedevamo di frequente, in lontananza, davanti a noi, ma per la maggior parte del tempo si tenevano alla larga, per poi sparire nel nulla non appena ci avvicinavamo. Nei primi giorni accadeva talvolta che un gruppo di temerari, frustrati quanto noi dalla forzata inattività, cercasse di coglierci di sorpresa, nascondendosi tra le felci mentre avanzavamo per poi sbucare improvvisamente dai loro nascondigli e saltarci addosso, prendendoci alle spalle. La nostra strategia mirava proprio a incoraggiare attacchi di questo tipo, e a rispondere a simili incursioni rapidamente e spietatamente, accerchiando gli attaccanti e massacrandoli. E ben presto nessuno osò più cercare lo scontro. In verità, all'inizio della campagna avevamo avuto anche troppo successo. Il fatto è che il nostro arrivo aveva suscitato grande preoccupazione ed era stato radunato in gran fretta un vasto esercito, forte di parecchie migliaia di uomini, pronto ad attaccarci e cacciarci fuori dalla Cambria. Ignaro dell'imminenza dello scontro, pochi giorni prima avevo diviso le mie forze, mandando verso sud e a ovest, lungo la pianura costiera, metà delle mie truppe - per la maggior parte fanteria, accompagnata da cinquecento esploratori e sotto il comando di Terzio Lucca - con il compito di catturare i porti di Cardiff e Caerwent, cacciarne gli invasori provenienti dalla Cornovaglia e impedirne l'accesso alle navi cariche di rifornimenti. Pertanto, le truppe che avevo ai miei ordini quando avvenne lo scontro con l'esercito di Ironhair erano costituite prevalentemente da soldati a cavallo. Dei miei tremila fanti, me ne restavano meno di mille, insieme a duemila cavalieri. Soltanto con leggero anticipo ero stato avvisato che, col favore delle tenebre, si sarebbe improvvisamente materializzato un esercito, in attesa a tre miglia di distanza in un'ampia vallata di cui aveva occupato la parte alta. Così ero stato costretto a prendere le contromisure in gran fretta e ad assumermi un rischio maggiore di quello che avrei voluto. Ciò non toglie che mi sentissi rincuorato dalla ferma convinzione che le probabilità fossero in nostro favore qualora si rivelasse corretta la mia ipotesi fondamentale: che agli occhi dei mercenari di Ironhair la nostra cavalleria pesante era un fattore sconosciuto. Senza concedermi il lusso di esitare, anche perché non ne avevo il tempo, suddivisi la fanteria in due coorti di cinquecento uomini ciascuna e le mandai avanti in formazione, marciando in file di dieci, in modo che ogni divisione formasse un blocco di cinquanta file, mentre gli alfieri che portavano gli stendardi della coorte marciavano tra i due blocchi. Davanti e dietro, come avanguardia e retroguardia, schierai due reparti di cavalleria pesante, ognuno formato da duecento cavalieri, che cavalcavano in venti file di dieci cavalieri ciascuno, mentre l'intera colonna era fiancheggiata su entrambi i lati da un'unità mobile di cinquanta soldati a cavallo, schierati come supporto e difesa. Il risultato era una lunghissima colonna, apparentemente vulnerabile, che speravo potesse invitare a un attacco improvviso da entrambi i lati. Suddivisi la restante cavalleria, millecinquecento unità in tutto, in tre gruppi eguali. Due vennero mandati ai lati della strada che sarebbe stata percorsa dal grosso delle truppe, con l'ordine di trovare il modo più rapido e veloce per aggirare il nemico e, subito dopo, di tenersi pronti ad attaccare su entrambi i fianchi non appena io stesso avessi dato il segnale. Il terzo gruppo lo tenni accanto a me: restammo molto indietro rispetto agli altri, avanzando lentamente in cinque lunghe linee parallele. Come ho già detto, il mio piano, per quanto improvvisato, funzionò anche troppo bene. L'esercito che ci trovammo di fronte era quasi senza capi, privo di generale e i vari contingenti non disponevano di uno stratega che impartisse loro gli ordini. Ironhair era molto lontano, lo scoprimmo in seguito, e Carthac era con lui. Ci battemmo dunque contro un esercito che era un'accozzaglia delle truppe che ancora restavano nella Cambria meridionale, messo insieme alla meno peggio e composto di diversi corpi di mercenari. Se mancava un generale in capo, al contrario c'era abbondanza di ufficiali di grado inferiore, anche troppi, ma nessuno aveva l'autorità di dare ordini a un reparto che non fosse il proprio, e nessuno aveva pensato di mandare avanti degli esploratori a verificare l'entità delle nostre forze. Per questo motivo, i due reparti di cavalieri a cui avevo ordinato di aggirare il nemico, riuscirono a occupare i punti più elevati in fondo alla valle senza che nessuno li vedesse e tantomeno li contrastasse. Inoltre il nemico stupidamente sprecò l'unico vantaggio di cui disponeva, abbandonando subito la posizione favorevole occupata fino a quel momento e precipitandosi giù dalla collina per caricare, con ululati di gioia, la colonna lunga e stretta che si snodava sul fondo della vallata. Non appena le orde urlanti diedero inizio all'attacco, il contingente di cavalleria che si trovava davanti, alla testa della nostra colonna, finse di ripiegare e fuggire, indietreggiando da entrambi i lati, galoppando via a tutta velocità e lasciando le lunghe file di fanti esposti all'attacco nemico. Era del tutto evidente che nessuno degli attaccanti aveva mai sperimentato la tattica romana. Infatti nessuno di loro notò che la cavalleria, apparentemente in fuga, si raggruppava immediatamente da entrambi i lati della falange della retroguardia, che all'inizio dell'attacco si era invece fermata ed era rimasta immobile. Nessuno vide - o se lo vide, era ormai troppo tardi - che la fanteria era pronta a disporsi per fronteggiare l'attacco, sistemandosi in modo da costituire due quadrati, ciascuno dei quali formava sui quattro lati una muraglia impenetrabile, dello spessore di tre uomini, prima che le schiere nemiche potessero arrivare a tiro. Non appena la prima ondata di attaccanti si fu precipitata inutilmente e con furia suicida contro ciascun quadrato, io stesso giunsi nella valle alla testa dei miei cinquecento uomini e li schierai alla destra della retroguardia. Nessuno cercò di bloccarci. Il combattimento era limitato ai quadrati della fanteria, che non avevano alcuna difficoltà a resistere al nemico. Guardai in fondo alla valle, dove gli altri mille cavalieri erano in attesa, a meno di un miglio di distanza, agli ordini di Tessio. A quel punto mi accorsi di dover impartire ancora un comando prima di dar loro il segnale di attacco. Chiamai dunque Bedwyr e lo mandai di gran carriera, scortato da sei cavalieri, a ordinare a Tessio di caricare verso ovest, scendendo lungo la linea dei quadrati alla mia sinistra. Doveva caricare immediatamente, subito dopo aver ricevuto il mio ordine; io mi sarei mosso nello stesso istante, guidando le mie truppe verso est, sulla destra dei quadrati. Da un lato e dall'altro avremmo schiacciato il nemico sotto gli zoccoli dei nostri cavalli, pur restando abbastanza lontani dai quadrati stessi per non rischiare di costituire un pericolo per la nostra fanteria. Osservai Bedwyr mentre galoppava via con la sua scorta e rimasi in attesa che attraversasse il campo di battaglia. Per un comandante niente è più difficile del restare in attesa, mentre davanti a lui i suoi uomini vengono uccisi. Tuttavia anche nel breve tempo che occorse a Bedwyr per attraversare il fondovalle, cominciò a essere evidente che stavamo per riportare una grande vittoria. I nemici erano fieri e assetati di sangue, feroci e indisciplinati, ma non erano stupidi. Avevano ormai compreso quanto fosse stato folle gettarsi contro quel muro impenetrabile di scudi e lance, e ora molti di loro cominciavano a fermarsi con le armi in mano, guardandosi attorno a est e a ovest, scrutando verso la nostra cavalleria, che restava immobile ma minacciosa. Vidi molti uomini correre qua e là, esortando altri, aggrappandosi ad armi e vesti, e poi cominciò a notarsi del movimento, dapprima appena percettibile, in un luogo lontano dalla battaglia, nel momento in cui gruppi di soldati iniziarono a disimpegnarsi e allontanarsi. Giunse poi il suono penetrante delle trombe di Tessio e la lunga fila dei suoi uomini si mise in movimento. Immediatamente suonarono anche le mie trombe e io sguainai la spada dando di sprone a Germanico, che partì al galoppo. Fu una carneficina: niente di meno. Attraversammo il campo di battaglia, da ovest a est, e a fronteggiarci non rimase neppure un essere vivente. Sembra che fossero molto più numerosi di noi, quasi un migliaio in più, ma le nostre perdite ammontarono a meno di una ventina di fanti e in cambio catturammo una cinquantina dei loro uomini. Gli altri, quasi quattromila, giacevano morti. Parecchie decine riuscirono a fuggire, ma non cercammo di inseguirli. Abbandonammo i morti a marcire dove erano caduti, dal momento che non avevamo né il tempo né i mezzi per seppellirli, e lasciammo che di quel luogo spaventoso ne parlassero i nostri nemici; a poco a poco gli uccelli, le belve e gli insetti, insieme all'azione purificatrice del tempo, avrebbero sgombrato il campo di battaglia. Da quel giorno in poi, il nemico non si fece più vedere e il rapporto inviatomi da Filippo tramite Bedwyr era ormai diventato quotidianità. In Cambria non c'era più nessuno che osasse combattere contro di noi, sebbene le terre di Pendragon fossero ancora invase dai mercenari di Ironhair e ogni giorno venisse combattuta una guerra di invasione. Il nemico era vicino, ma sempre fuori dalla nostra portata. Eppure avevamo fatto di tutto, ed eravamo arrivati vicino alla vittoria: due volte eravamo riusciti a snidare il nemico, spingendolo davanti a noi come si fa con le pernici e obbligandolo ad andare verso la costa, ma tutte e due le volte, grazie a qualche sistema di comunicazione o di segnalazione che qualcuno potrebbe essere stato tentato di definire magia, una flotta di galee era sempre stata in attesa poco lontano, pronta a portarli in salvo prima che avessimo potuto chiudere la partita. Bisognava trovare qualcosa di nuovo, ma per il momento non ero stato in grado di mettere a punto una strategia alternativa che potesse offrire qualche speranza di successo. D'altro lato, la nostra campagna lungo la costa meridionale, dove i nostri obiettivi erano città e porti ben precisi, aveva avuto un successo incoraggiante, e la nostra vittoria era stata completa. Attualmente in tutta la parte meridionale della Cambria non c'era luogo in cui Ironhair potesse far approdare le sue navi senza paura di essere attaccato e di perdere il carico. Ormai le sue flotte bordeggiavano a nord e a sud, mantenendosi a distanza di sicurezza dalla riva, e quelle poche truppe fresche che venivano trasportate dai suoi vascelli dovevano approdare molto a nord, e poi aprirsi la strada verso sud attraverso un terreno inospitale, infestato da nemici ostinati e pericolosi. I miei pensieri furono interrotti dal rumore di una pietra che rotolava, e poco dopo mi giunse la voce di Donuil che dall'alto mi chiamava per dirmi che i miei ufficiali mi attendevano riuniti in assemblea. Sospirai e mi alzai in piedi, poi riposi nella sacca la pietra per affilare e rimisi la spada nel fodero prima di riprendere l'elmo e di salire in groppa a Germanico, che si diresse verso il punto da cui proveniva la voce di Donuil senza neppure bisogno di essere spronato. Il gigantesco celta mi stava aspettando, e quando lo ebbi raggiunto diede di sprone al suo cavallo e cavalcò al mio fianco. «Guarda laggiù» mi disse. Mi voltai e guardai verso la costa alla mia destra, proteggendomi gli occhi dal riverbero accecante del sole sulla superficie dell'acqua. «Cosa c'è? Non riesco a vedere nulla.» Anche Donuil teneva gli occhi socchiusi. «Neanch'io, adesso» mormorò. «Ma la grande bireme è laggiù, anche se sembra solo un puntino contro l'orizzonte. Derek l'ha vista per primo e ha subito dato l'allarme.» Guardai con più attenzione, socchiudendo gli occhi e cercando di fissare la superficie del mare, ma non si vedeva nulla eccetto strisce scintillanti di una luminosità accecante. «E le galee che l'accompagnano? Quante sono?» Ormai stavamo scendendo lungo il versante della collina, verso la tenda del comando che era stata montata sullo spiazzo erboso che sovrastava la spiaggia. «Sono troppo lontane per vederle, non parliamo poi di contarle» disse Donuil. «Però dovresti riuscire a scorgere qualcosa di più, non appena saremo scesi. In basso l'angolatura è migliore e i riflessi sono meno forti.» Era proprio così. Infatti, non appena fummo arrivati a livello della spiaggia, il riverbero del sole sulle onde era decisamente più blando tanto che potei distinguere l'enorme sagoma della bireme, chiaramente accompagnata da una flottiglia di navi più piccole. Raggiunsi la tenda del comando dove trovai tutti rivolti verso il mare; stavano chiacchierando tra di loro, cosicché nessuno si accorse del mio arrivo. Scesi da cavallo e mi avviai verso la tavola sistemata su di una piattaforma fuori dalla tenda. «Bene» dissi. «Qualcuno di voi è in grado di avanzare qualche ipotesi sulle intenzioni di questa flotta? Pensate che verrà direttamente contro di noi? O sta semplicemente passando al largo per dirigersi verso qualche porto a est di qui?» Huw Fortebraccio si voltò per guardarmi in faccia e mi si avvicinò. «Non verranno verso di noi.» «Perché no, Huw?» «Innanzitutto non hanno altro posto in cui attraccare a eccezione di questa spiaggia, ma la pendenza è eccessiva per permettere loro di portarsi molto vicino a noi. Prima che siano sbarcati e siano arrivati qui, con l'acqua fino alla cintola, saranno tutti morti e noi avremo finito le frecce.» Annuii. «Giusto. Non verranno qui. Tuttavia ci hanno individuati, su questo non c'è alcun dubbio. Pensate che per noi possa essere uno svantaggio?» Intanto anche gli altri ufficiali, una quarantina, si erano avvicinati a noi e ascoltavano quello che stavamo dicendo. L'imponente capitano di Pendragon si strinse nelle spalle: evidentemente non aveva altro da aggiungere, e io cambiai discorso. «Quanto tempo ti ci vuole, Huw, per fare in modo che mi possa incontrare con Uderic?» Finsi di non udire l'improvviso brusio da cui fu accolto il nome dell'uomo che aveva preso il posto del defunto Dergyll ap Griffyd come capo dei Celti di Pendragon. Sollevai una mano per mettere tutti a tacere, mentre, nel frattempo, Huw meditava sulla mia sorprendente richiesta. «Uderic?» scosse la testa grigia. «Chi lo sa? Mi ci potrebbe volere un mese per scoprire dove si trova; lui non si fida di me e io non mi fido di lui. Comunque, una volta che l'avrò scovato, se riuscirò a trattenerlo abbastanza a lungo da fargli sentire quello che ho da dirgli, dovrebbe essere facile organizzare un incontro con te. Perché vuoi parlare con Uderic?» «Perché avrei dovuto parlargli già mesi fa. Allora rifiutò di incontrarmi per ragioni sue, ma nel frattempo noi abbiamo accumulato un bel po' di vittorie, e questo è andato a suo vantaggio. Lui e io abbiamo bisogno l'uno dell'altro, nonostante la sua riluttanza a condividere qualsiasi cosa con me. In fondo, attualmente è Uderic colui che ha più diritto a essere proclamato re e capo supremo di Pendragon. Sembra anche che sia l'unico uomo in Cambria in grado di agire rapidamente e incisivamente per contrastare le manovre di Ironhair e convincere altri a unirsi alle proprie truppe.» Vidi crescere la protesta negli occhi di Huw e ripresi rapidamente a parlare per prevenire la sua reazione. «Lo so che non è proprio così, e che ci sono altri che a ragione potrebbero vantare diritti anche più fondati a farsi proclamare re. So pure che molti di loro sono capi in gamba, certo. Ma non si può negare che tra di loro Uderic sia il più dinamico, o che abbia la lealtà dei suoi uomini e anche di parte di quelli che sono legati ad altri comandanti. Di fatto però, tra i capi di Pendragon è l'unico che non abbia ancora incontrato e mi sembra sia arrivato il momento di farlo. Vuoi andarmelo a cercare?» «Sì, ma prova avversione nei tuoi confronti, ancor più di quanto diffidi di me.» Nel dire queste cose, Huw appariva palesemente a disagio. «No, Huw, lui crede di provare avversione nei miei confronti, ma non mi ha mai incontrato. Può provare avversione per l'idea stessa della mia esistenza, e può anche darsi che diffidi di me: questo posso capirlo, dal momento che vede in me una minaccia alle sue ambizioni. Avendo conquistato il suo nuovo regno, essendosene impadronito con la forza, non si sente sicuro, e poi sa che io sono imparentato con Uther. Ma spero che sia abbastanza intelligente da vedere i vantaggi di avere me - di avere tutti noi - come suoi alleati. Uderic deve combattere una guerra e deve vincerla, ed è lo stesso anche per noi, per ragioni nostre. Agendo insieme potremmo vincerla in fretta, salvando migliaia di vite.» «La grande nave si sta dirigendo verso di noi!» Il grido proveniente dalla spiaggia fece voltare tutti verso il mare. Mi aprii la strada tra i miei ufficiali per vedere meglio che cosa stesse accadendo, con Derek e Donuil che mi stavano a fianco. Non c'era dubbio: l'imponente bireme si era avvicinata e ben presto sarebbe stata proprio davanti a noi, forse non più lontana di un miglio dalla costa. Le galee che la accompagnavano, a colpo d'occhio potei contarne una decina, si avvicinavano a riva, tenendoci d'occhio, ma sempre fuori dalla portata degli archi di Pendragon. «Non penso che si avvicineranno di più, ma si comportano in modo curioso.» Mi voltai verso Donuil. «Fai esporre i nostri stendardi, Donuil. E che i trombettieri suonino la nostra sfida. Sistema anche un buon numero di arcieri sulle rocce più alte, nella speranza che qualcuno si avvicini troppo.» Non appena si fu allontanato per far eseguire i miei ordini, mi voltai verso Huw, che era rimasto in piedi accanto a me. «Dunque, Huw, quanti uomini pensi di prendere con te e quanto ti ci vorrà per prepararti? Mi piacerebbe vederti partire oggi stesso.» «Allora sarà così. Prenderò i miei cinquanta uomini, con i miei arcieri di Pendragon mi sento sicuro contro quei maledetti stranieri, non importa quanti possano essere. Con l'aiuto degli dèi, troverò Uderic entro la fine della settimana, a meno che non sia morto e sepolto, e prima che siano passati tre giorni sarò di ritorno. Dove vuoi che avvenga l'incontro tra te e Uderic?» «Onestamente non ho idea» gli dissi. «Scegli tu il posto, possibilmente a metà strada tra dove siamo ora e dove troverai Uderic. Fai in modo però di avere il tempo sufficiente a tornare qui e ad accompagnarmi nel posto fissato per l'incontro prima del giorno stabilito.» Annuì con un sogghigno. «Devo andare ora? Sono pronto.» «Allora va', e accetta i miei ringraziamenti.» Si voltò e se ne andò, ma mentre lo osservavo allontanarsi udii un altro grido proveniente dalla spiaggia. «Dite al comandante Merlino che uno di loro sta venendo verso di noi!» Mi mossi immediatamente prima ancora che la notizia mi fosse trasmessa, ma non appena ebbi raggiunto la spiaggia vidi Donuil che galoppava verso di me lungo la striscia di sabbia al limite dell'acqua. «È Feargus, Merlino!» gridava. Non c'era alcun dubbio: riconobbi immediatamente la galea che veniva verso di noi grazie al rosso della sua vela. E non appena guardai di nuovo verso la maestosa bireme che solcava le acque davanti alla sua scorta, rimasi davvero di stucco. «Connor Mac Athol!» ruggii nell'improvviso silenzio. «Incosciente, sfrenato, pazzo uomo con una gamba sola!» La galea di Feargus si avvicinava rapidamente puntando dritta verso la spiaggia, mentre i suoi remi grondanti brillavano sotto i raggi del sole. Raggiunsi il limite dell'acqua, alzando le braccia in segno di benvenuto e solo con fatica riuscii a trattenermi dal correre. Donuil, lo sapevo, era smontato da cavallo ed era alle mie spalle, esattamente come gli altri. La galea veniva verso di me finché, all'ultimo momento, i rematori sollevarono i remi all'unisono e lo scafo, lungo e liscio, scivolò in avanti senza bisogno di spinta: la sua velocità diminuì rapidamente finché si fermò sul fondo basso e sabbioso, a meno di venti passi da dove ero io. Solo allora il piccolo uomo che comandava quell'agile imbarcazione si precipitò a prua per rivolgermi un saluto formale. «Merlino di Camelot! L'ammiraglio dei mari di re Brander ti manda i suoi saluti! Vorresti avere la cortesia di salire a bordo della sua bireme!?» «Ne sarei lieto» gridai. «Ma non so camminare sull'acqua e non posso nuotare con indosso l'armatura.» Mentre parlavo, tuttavia, vidi che la piccola imbarcazione veniva avanti per prendermi a bordo; mi volsi allora verso Donuil. «Tuo fratello non smette mai di stupirmi. L'ultima volta che ci siamo parlati mi ha detto che aveva intenzione di rubare una delle biremi di Ironhair. Me lo sarei dovuto aspettare! Vieni con me.» Mi voltai verso Derek, Benedetto e Rufio che ci guardavano sogghignando. «Staremo via poco. Le mie scuse agli altri per aver interrotto la riunione, ma questo imprevisto potrebbe aver cambiato ogni cosa. Chissà che Connor Mac Athol non abbia vinto la guerra per noi?» A bordo della sua nuova e magnifica nave Connor ci fece un'accoglienza regale e non appena furono conclusi i convenevoli e ci fummo scambiate le notizie personali, ci descrisse il modo in cui se l'era procurata, intrufolandosi senza farsi notare, e con più di un centinaio di uomini, nell'accampamento che costituiva il suo porto di riferimento sulla costa settentrionale della Cornovaglia. Il suo piano aveva funzionato senza intoppi. Lui stesso, i suoi uomini e le sue navi erano stati accolti bene dalla gente della Cornovaglia: nessuno aveva sospettato di nulla, dal momento che erano stati scambiati per mercenari non dissimili dalle centinaia di altri che andavano continuamente avanti e indietro. Per sei giorni Connor aveva aspettato l'occasione buona facendosi passare per uno di loro. Poi, il settimo giorno, era arrivata la bireme e il bottino catturato nel corso delle razzie messe a segno in Cambria nel mese precedente era stato scaricato e sistemato su carri per essere trasportato dove Ironhair era solito immagazzinare il frutto delle sue scorrerie. Connor aveva scoperto che il giorno seguente sarebbero state imbarcate nuove truppe per essere trasportate in Cambria e pertanto si era trovato di fronte a due possibilità: imbarcare i suoi uomini il giorno seguente, per poi catturare la nave una volta in alto mare, oppure prendere l'iniziativa immediatamente e impadronirsi della nave quella stessa notte. Aveva scelto la seconda, poiché le stive che i suoi uomini avrebbero dovuto occupare durante la navigazione erano profonde ed era possibile che non potessero lasciarle prima della fine del viaggio. Più volte aveva sentito raccontare di mercenari confinati nelle stive, sotto boccaporti bloccati, per tutta la durata del viaggio, soprattutto con il cattivo tempo. Per di più, una volta in alto mare la nave sarebbe stata difesa dagli armati che aveva a bordo. Connor aveva dato gli ordini, e i suoi uomini erano saliti a bordo della nave nel cuore della notte, dopo aver sopraffatto senza difficoltà le poche guardie che la custodivano. Una volta a bordo, il resto era stato facile, e la bireme era scivolata via dagli ormeggi, sotto un nuovo comando, e senza che nessuno si fosse accorto di nulla. Due cose tuttavia avevano sconvolto lui e i suoi uomini: il fetore terribile, che proveniva dai banchi in cui erano incatenati i rematori e che aleggiava per tutta la nave e la scoperta che i rematori erano schiavi. Connor non se l'era affatto aspettato. Quando se ne era reso conto, era stato sul punto di rinunciare a tutta l'operazione, sapendo che i rematori sarebbero stati incatenati ai loro remi e consapevoli di quanto stava accadendo. Tuttavia, le dimensioni della nave, la sua enorme massa e la superiorità che offriva lo avevano convinto dell'assurdità di rinunciare al suo progetto semplicemente per il timore delle reazioni di un equipaggio di schiavi. Certo, aveva pensato, avrebbero potuto ribellarsi e dare l'allarme non appena avessero scoperto il furto, nel qual caso Connor e i suoi si sarebbero trovati nei guai; oppure avrebbero potuto rifiutarsi di remare, il che non sarebbe stato granché meglio. Connor tuttavia aveva preferito pensare che avrebbero scelto la libertà, e dunque l'aveva offerta loro, superando le difficoltà di linguaggio con il semplice espediente di gettare in mare un gigantesco sorvegliante, insieme alla sua frusta, di togliere le catene ai rematori e di mettere alcuni dei suoi uomini a faticare insieme a loro mentre la nave veniva fatta uscire dal porto. Il suo messaggio di speranza si era diffuso rapidamente e con tutta probabilità gli schiavi avevano remato anche più velocemente di quanto avessero mai fatto, senza bisogno di essere incitati. All'alba la bireme navigava tranquillamente al largo, circondata dalle nostre galee, senza alcuna minaccia di inseguimento. A quel punto lo interruppi per chiedergli che cosa ne avesse poi fatto degli schiavi, e Connor mi rispose sorridendo. «Quasi la metà sono tuttora a bordo, quelli che erano abbastanza in forze da sentirsela di combattere.» «E gli altri?» «Sono nel nord, nelle varie isole. Alcuni sono morti, ma molto pochi. Gli altri sono... in via di guarigione.» «Quando è accaduto tutto questo?» Il suo sorriso si fece ancora più aperto. «Quando è stato, tre mesi fa? No, quattro. Dopo avervi lasciati, sono andato direttamente a sud, e la nave l'abbiamo presa poco tempo dopo... forse un paio di settimane. Il mio piano era corretto, come vedi. Non era il caso di respingerlo senza tanti complimenti.» «E poi siete tornati a casa, puntando direttamente a nord?» Rise. «Non è stato possibile fare diversamente, amico! Non potevamo restare dove eravamo. Sono sicuro che non hai mai sentito un fetore come quello che c'era a bordo. I rematori erano incatenati ai loro remi e non venivano mai liberati, per nessun motivo, e dunque erano costretti a vivere in mezzo ai loro escrementi. I miei uomini non facevano che vomitare per la puzza. Non era possibile mangiare e tenere il cibo nello stomaco! Siamo stati costretti a pulire tutta la nave, da cima a fondo. L'abbiamo tirata in secco, a nord di qui, non appena siamo stati certi di non essere inseguiti, e l'abbiamo lavata, ma il fetore era penetrato profondamente nel legname e non era facile eliminarlo.» Annuii. «Puzza ancora» dissi, ma Connor respinse sdegnosamente il mio commento. «Oh, adesso è niente, al confronto, e continua a diminuire. Come ti ho già detto, all'inizio era insopportabile. Quando siamo arrivati a casa, nelle nostre isole, non ce la siamo sentita di portarla dove vive la nostra gente, così l'abbiamo di nuovo tirata in secco e abbiamo passato due mesi a raschiare lo scafo e a sfregare i rivestimenti interni in legno con sapone e liscivia per cercare di togliere il fetore. Ma anche così, era duro da sopportare. Poi l'abbiamo rimessa in acqua e per due settimane abbiamo acceso dei piccoli fuochi di torba lungo i ponti, dentro dei bracieri, lasciando che il fumo impregnasse le pareti; questo ha migliorato un po' la situazione. Dopodiché, abbiamo riempito gli spazi tra un ponte e l'altro con fieno appena falciato. Presto accenderemo di nuovo fuochi di torba, e questo dovrebbe bastare. Puoi star certo che adesso nessuno piscia o caga tra i banchi, sotto pena di essere frustato. Ma che nave, Merlino! Che nave! Adesso ho a bordo quasi cinquecento uomini. Cinquecento uomini! Ci stanno stretti, non si può negarlo, ma cinquecento uomini su una sola nave!» Si fermò, poi scosse la testa. «Pensa, sono tanti se mai affondasse sotto di noi.» Si alzò e si mise a passeggiare per la sua cabina, ma sulla sua testa il soffitto era abbastanza alto da permettergli di farlo senza doversi chinare. Picchiettò contro la parete ricurva. «Non c'è pericolo che accada, comunque. Solida, ecco cos'è, e dura come il ferro, anche se non riesco a immaginare con quale legno sia stata fatta.» «Che ne è dell'altra?» «Dell'altra uguale a questa? Non ne ho idea, e non l'ho mai vista. Se naviga ancora tra queste acque, un giorno o l'altro la troverò.» «E poi? Che cosa farai?» «La brucerò o la catturerò.» «Pensi di ingaggiare un combattimento, nave contro nave?» Il suo sogghigno era feroce. «Perché no? Il vantaggio sarebbe tutto dalla mia parte. La loro nave ha un equipaggio di schiavi, la mia di uomini liberi. Saremo più forti di loro, ai remi, alle vele e in combattimento.» Diedi uno sguardo a Donuil, per vedere come la prendeva e vidi che anche lui sogghignava guardando suo fratello. «E così sia» dissi. «Dove siete diretti, e come mai siete capitati qui?» Connor scrollò le sue larghe spalle. «Sapevo che eravate in Cambria, ma non sapevo dove. Durante la tempesta della notte scorsa ci siamo messi in salvo in una piccola baia a due ore da qui, e ora stiamo navigando per ricongiungere le nostre forze con quelle di Logan. Andrò lungo la costa, fino a quando non avrò raggiunto la foce del fiume, poi svolterò verso sud e mi dirigerò di nuovo verso ovest lungo la costa settentrionale della Cornovaglia. Logan punterà a est, dall'estremità della Cornovaglia, per unirsi a me e andare a fare una visita al porto di Ironhair, quello in cui abbiamo trovato questa bellezza. È difeso da un forte, costruito sulla scogliera, ma come tutti i forti, è stato eretto in modo da guardare verso terra, e dunque per noi non è una gran minaccia. È per questo che l'altra volta siamo riusciti ad andarcene tanto facilmente. Questa volta però vi entreremo, ma naturalmente ora sanno che siamo nemici, prima ancora che attracchiamo. Riconosceranno immediatamente questa bellezza. È possibile che quando arriviamo anche sua sorella sia in porto, nel qual caso ce la prenderemo, se ci riusciamo, oppure la distruggeremo se non possiamo fare diversamente. In un caso e nell'altro, intendo rendere la vita difficile ai soldati che sono lungo la costa, fuori dal forte e nei pressi della città.» Si interruppe per un attimo. «Hai uno sguardo, Merlino Britannico, uno sguardo che conoscevo molto bene quando avevi la testa gialla, la prima volta, intendo. Che cos'hai in mente?» Scossi la testa. «In realtà, proprio niente. Come si chiama questo forte? Per caso è Tintagel?» Connor annuì. «Sì, il nome è proprio questo. Lo conosci?» «Certo che lo conosco. Il padre di Lot di Cornovaglia ne ha iniziato la costruzione, e poi Lot ha portato avanti i lavori. È fatto di pietra?» «Parzialmente, alcune parti sono effettivamente di pietra. Ci sono stati muratori che vi hanno lavorato per anni, ma è tutt'altro che completo. Per la maggior parte però è fatto di legno: palizzate di tronchi. Vuoi venire con me a dargli un'occhiata?» Toccò a me rispondere con un sogghigno. «Mi piacerebbe moltissimo, ma i miei cavalieri si sentirebbero abbandonati vedendomi partire così. Penso sia meglio che resti qui, nel caso in cui si cominciasse a combattere.» «Bene, allora lascia che ti mostri la mia nave, prima che debba ripartire. Nel sud Logan ha con sé meno di dieci galee, perciò non voglio proprio lasciarlo in attesa del mio arrivo. Vieni.» Rimasi colpito dalla spaziosità della sua nuova nave. Vista dall'esterno sembrava enorme, ma camminando tra i suoi ponti, fu possibile coglierne le reali dimensioni in tutta la loro spaventosa grandiosità. Come aveva detto Connor era lunga ottanta passi, da poppa a prua, mentre l'ampiezza del ponte principale era di venticinque passi. I boccaporti erano allineati in una lunga fila nel mezzo della nave e davano accesso alle stive vere e proprie tre ponti più in basso. Le doppie file di remi erano azionate da rematori che sedevano su un ponte a gradini al centro della nave, dove le due schiere lavoravano una sopra all'altra separate da un'altezza pari a metà della statura di un uomo. I segni della recente presenza di schiavi erano ancora evidenti: anelli di ferro fissati al pavimento e scanalature nel legno del ponte dove strisciavano le catene a cui erano stati legati i rematori. All'estremità posteriore del ponte dei rematori, direttamente ai piedi della scala di boccaporto che portava al ponte di comando, c'era un massiccio tamburo sistemato su di un tripode. Questo, spiegò Connor, era il posto del caporematore, colui che dava il ritmo ai grandi movimenti dei remi che mandavano avanti la nave. Dalla sua posizione, subito sotto il comandante, costui poteva udire facilmente i comandi che gli venivano trasmessi e i colpi cadenzati delle mazze sul tamburo stabilivano il ritmo che dovevano tenere i rematori. Sotto il ponte occupato dai rematori ce n'era un altro destinato al carico, mentre su un ponte superiore venivano sistemati i guerrieri. In origine le biremi romane erano state nient'altro che delle piattaforme galleggianti su cui truppe terrestri potevano combattere come se si fossero trovate su un campo di battaglia e questa caratteristica era cambiata poco nel corso dei secoli. Davanti e dietro, sul ponte principale si innalzavano grandi torri, che davano alla nave un aspetto sgraziato quando veniva vista di lato; queste torri erano molto utili come piattaforme per le catapulte e altre macchine da guerra, e inoltre costituivano gli alloggiamenti degli ufficiali e dei comandanti. A ciascuna delle due estremità del ponte c'erano due alti ponti levatoi. Mossi per mezzo di pulegge, quando la nave si trovava in porto venivano usati per collegarla alla terraferma, ma durante la battaglia erano utilizzati per agganciarsi al fianco delle navi, permettendo ai soldati di fare irruzione sul ponte delle imbarcazioni nemiche. Connor, lo sapevo, aveva buoni motivi per essere fiero della sua fortezza galleggiante, ma la sua più grande fonte di orgoglio era l'enorme ariete di solido legno, rivestito di rame e più largo delle mie braccia aperte nel punto in cui formava la prua della nave. Sporgeva di sei lunghi passi dalla prua della bireme ed era rastremato in modo da formare una punta aguzza sotto la linea d'acqua. "Il cielo aiuti l'imbarcazione che debba trovarselo di fronte" pensai quando me lo mostrò. Connor ci riportò a riva, promettendoci di tornare per la via più breve dopo aver saccheggiato il porto di Ironhair in Cornovaglia. Calcolava che gli servisse meno di una settimana per raggiungerlo, fare quello che doveva fare e tornare. Gli promisi che saremmo stati ancora là quando fosse tornato, purché la sua stima fosse precisa, dal momento che dovevo assolutamente attendere il ritorno di Huw Fortebraccio, il che avrebbe richiesto non meno di una settimana. Dopodiché, però, sarei partito non appena fosse necessario, per incontrarmi con Uderic Pendragon. Camminò con me e Donuil fino alla murata, poi si appoggiò con la sua gamba di legno contro il parapetto prima di sporgersi in avanti, afferrandosi a una corda, per osservarci con un sogghigno divertito mentre scendevamo nervosamente giù per una stretta scala di legno legata lungo il fianco della grande nave. Di colpo ci rendemmo conto di quanto fosse stato facile salire a bordo di quel mostro dalla piccola barca che ora ondeggiava spaventosamente, sballottata senza sosta dalle onde, leggermente oltre la nostra portata. Aggrappati alla scaletta, in bilico sulle onde che si infrangevano contro il fianco della nave, cercammo di calcolare il tempo e la distanza e saltammo dove mani volenterose furono pronte ad afferrarci e a impedirci di rovesciare la barca, che entrambi raggiungemmo sani e salvi, anche se con assai poca dignità. Il mio stomaco era ancora penosamente sottosopra quando il fondo della barca strisciò sulla sabbia e io saltai fuori, sguazzando nell'acqua che mi arrivava alle caviglie verso la rassicurante solidità della spiaggia asciutta, evitando con cura lo sguardo dei presenti. Per il resto di quella giornata la priorità fu una sola. Radunai nuovamente i miei ufficiali e mi scusai per l'interruzione della nostra riunione, dopodiché li incaricai di stendere turni di servizio che tenessero utilmente occupate le nostre truppe per tutto il tempo in cui avremmo dovuto attendere il ritorno di Huw. Fatto questo, passai il comando a Donuil, in qualità di aiutante in campo, e mi ritirai nella tenda per aggiornare il mio diario. Le parole delle prime due frasi scritte quel giorno mi sono rimaste impresse nella memoria, poiché si da il caso che siano state talmente inadeguate, talmente al di sotto della verità, che, nel rileggerle, risi di cuore di fronte alla capacità che talvolta abbiamo di sorprendere noi stessi con la nostra inettitudine. «Connor è tornato inaspettatamente,» avevo scritto, «ed è in possesso di una delle biremi di Irhonhair. Ora, dopo mesi di inattività, sembra che le cose possano cominciare a cambiare.» Bene, cambiarono davvero. Tutto cominciò il giorno seguente, subito prima di mezzogiorno, quando uno squadrone di cavalieri arrivò da Camelot. Non mi aspettavo di ricevere notizie da casa e mentre mi avviavo loro incontro sentii l'ansia attanagliarmi dal momento che, sospettavo, le notizie non potevano essere buone. La mia preoccupazione si trasformò poi in paura quando scoprii che l'ufficiale al comando era uno dei giovani tribuni che avevo visto partire con Ambrogio, diretto verso nord. «Dovresti essere con mio fratello» apostrofai bruscamente l'ufficiale non appena si fu messo sull'attenti davanti a me. «Perché sei qui, e dov'è Ambrogio?» «Il comandante legato Ambrogio sta bene e si trova in Northumbria insieme a re Vortigern, comandante Merlino. Mi ha mandato da te subito dopo il suo arrivo per rassicurarti sulla sua situazione, dal momento che ritiene possibile di doversi trattenere in Northumbria un po' più a lungo di quanto originariamente previsto. Sono venuto a tutta velocità, fermandomi solo brevemente a Camelot per procurarmi cavalli freschi. Devo consegnarti dei dispacci. Questo è da parte del comandante legato, mentre il più piccolo è del legato Dedalo, e proviene da Camelot.» Presi le due custodie che il giovane Sulla mi porgeva e lo ringraziai cortesemente, sentendomi un po' in colpa per la freddezza con cui lo avevo accolto inizialmente. Poi lo salutai, ed egli si allontanò insieme a Donuil e ai suoi uomini; quindi congedai anche gli altri e mi ritirai nella mia tenda. Una volta certo di non essere disturbato, mi ritrovai a posporre il momento in cui avrei aperto la sacca di cuoio che conteneva le lettere di Ambrogio. Mi versai una tazza di birra e mi sedetti comodamente sulla mia sedia pieghevole, inclinandola in modo da farla appoggiare solo sulle gambe posteriori e sistemando i piedi sul tavolo da campo, vecchio e rigato, che era stato di mio padre e prima ancora del padre di mio padre, e presi a strofinare il pollice sul robusto cuoio della borsa. Alla fine, però, dovetti ammettere con me stesso che stavo semplicemente rimandando l'inevitabile, e mi decisi a sciogliere i lacci che tenevano chiusa la sacca. Nell'interno c'erano due rotoli, uno molto più pesante dell'altro, e fin dal primo sguardo capii che non erano entrambi di mio fratello. Il messaggio di Ambrogio portava il suo sigillo, un emblema floreale i cui petali ricordavano una margherita, con al centro il suo stemma, una testa d'aquila. L'altro aveva un comune sigillo di cera, fermato semplicemente con la punta di un coltello. Sorrisi mentre rompevo il sigillo e srotolavo un unico foglio di papiro, coperto di caratteri fitti e minuti. Era di Artù - la prima lettera che mai avessi ricevuto da lui - e le numerose correzioni e cancellature mostravano chiaramente gli sforzi che ne aveva richiesto la stesura: «Al comandante legato Caio Merlino Britannico, saluti Cugino: ti scrivo questa lettera per ordine del comandante legato Ambrogio, che ha deciso che devo imparare a conoscere il potere delle parole scritte sul papiro. Tra i compiti che mi sono stati assegnati ogni giorno c'è la stesura di un rapporto che ogni mattina devo sottoporre al suo controllo e alla sua approvazione. Di per sé la stesura del rapporto non è una cosa difficile, ma scegliere le parole adatte, descrivere gli eventi senza essere troppo con precisione, senza sprecare tempo e spazio, porta via molto tempo. Siamo giunti sani e salvi a Lindum, dove re Vortigern tiene ora le sue truppe, dopo averle trasferite a sud dal precedente caposaldo di Eboracum, tre anni fa. Siamo acquartierati proprio nell'antico forte romano di Lindum, che di recente è stato rimesso a nuovo e rafforzato, con mura di pietra erette sulle antiche mura di fango. Lungo la strada non abbiamo avuto alcun problema, a eccezione di un incidente che purtroppo mi sono perso, quando una piccola pattuglia di esploratori è stata attaccata da una banda di briganti, il cui numero era decisamente superiore, con un rapporto di cinque a uno. I briganti non avevano mai combattuto contro uomini a cavallo, e se la cavarono molto male. Avrei voluto esserci anch'io. I nostri soldati a cavallo hanno suscitato l'ammirazione della gente di Lindum. Da queste parti non si era mai visto niente del genere. Re Vortigern sarebbe lieto che ci fermassimo qui, ma Ambrogio gli ha detto che dobbiamo tornare. Ambrogio, io credo, era tanto dispiaciuto di doverglielo dire quanto il re di ascoltarlo. Credo che in passato sia stato molto legato a Vortigern. Prima di partire faremo un rapido giro di ricognizione nei possedimenti principali del re, e lo faremo in sua compagnia. Ambrogio pensa di addentrarsi nelle grandi foreste a sud e a est, per dare una dimostrazione della nostra forza ai Danesi e ai Sassoni che vìvono da quelle parti. Vorrei proprio Purtroppo Ambrogio dice che non combatteremo, ma che dovremo mostrarci pronti a combattere. Re Vortigern non ha mai cavalcato su una sella con staffe, ma poiché sostiene di essere ormai troppo vecchio per imparare, continuerà a cavalcare come ha sempre fatto. Ambrogio dice che non appena avremo completato questa lunga ricognizione ci dirigeremo immediatamente verso casa, io però mi auguro che ci porti direttamente in Cambria e che arriviamo quando la guerra non è ancora finita. Spero di rivederti presto. Saluta Bedwyrper me. Mi chiedo se ha già insanguinato la sua spada. Artù Rilessi la lettera tre volte, e a ogni rilettura il mio sorriso si faceva più divertito nell'immaginare gli sforzi che la sua stesura doveva essere costata al ragazzo. Mi sentivo ancora più vicino a lui poiché ricordavo distintamente la fatica con cui, anche a un'età maggiore della sua, mettevo per iscritto i miei pensieri. Mi divertirono in particolar modo le parole cancellate e le poche macchie che comparivano sul foglio, poiché indicavano che Artù non si era ancora fatto abbastanza esperto da capire che una lettera poteva essere scritta in brutta, a fatica e disordinatamente, e poi ricopiata interamente con cura. "Bene," pensai, "presto imparerà tutto questo, così come imparerà anche a non desiderare la violenza e il sangue della guerra." Questo pensiero, con tutte le sue implicazioni, mi tolse la voglia di sorridere; presi dunque la lettera di Ambrogio. «Lindum Ambrogio Britannico a Caio Merlino Britannico; Salve, fratello! Mi chiedo quale di queste due lettere aprirai per prima. Il mio intuito mi dice che, nonostante il desiderio di conoscere da me quale sia la situazione qui, nel nord-est, avrai certamente deciso di leggere prima che cosa ha da dirti Artù. Devo ricordarmi di domandartelo la prima volta che ci vediamo. Vortigern sta bene e con mia grande soddisfazione risiede a Lindum, il che mi ha permesso di trascorrere un po' di tempo con i miei genitori adottivi, Jacob e Gwilla. Tu non hai mai incontrato Gwilla, la sorella di mia madre, tuttavia lei mi ha incaricato di trasmetterti i suoi saluti, e così pure Jacob che invece si ricorda bene di te dopo il vostro primo, e ultimo, incontro a Verulamium, quando accompagnò Vortigern al Grande Dibattito, quello in cui tu e io ci siamo incontrati, tanti anni fa. Il re è in buona salute e ambizioso come sempre, e scoprirlo è stata una piacevole sorpresa. A essere sinceri, mi ero aspettato che fosse già morto e che i suoi territori fossero dilaniati dalla guerra civile, invece non è affatto così. Ciò nondimeno ha dei grossi problemi, tutti causati dal figlio di Hengist, Horsa, anche se fino a questo momento non sono ancora arrivati allo scontro aperto. Sono comunque convinto che la situazione non rimarrà tale ancora per molto. Horsa, da quanto ho sentito, sono ormai parecchi anni che si sta preparando seriamente alla guerra e ha radunato un forte esercito - da cinque a diecimila guerrieri, a seconda di chi si ascolta — che per il momento tiene acquartierati molto a sud e a est di qui, tra i grandi acquitrini delle paludi costiere. Di lì, tradizionalmente non hanno mai fatto altro che compiere incursioni verso sud, contro i nuovi venuti sassoni che si sono stabiliti nella zona, e questo onora l'accordo stretto inizialmente con Vortigern - di tenere lontani dal suo regno gli invasori sassoni - e ha portato a quella pace, ostile e precaria, che ormai dura da anni. Come ho già detto, mi aspetto che le cose cambino molto presto. La mia analisi mi fa sospettare che, per quanto riguarda l'esercito di Horsa di cui tanto si parla, la stima di diecimila uomini potrebbe essere esatta, anzi, forse inferiore alla realtà. Mi sento di affermarlo sulla base della mia valutazione delle forze di cui ha bisogno, tenendo in considerazione la vastità del territorio che deve controllare: l'area che chiamiamo Costa Sassone, direttamente a sud della sua base. Notizie recenti e affidabili raccolte da Vortigern indicano che nel sud i Sassoni diventano più forti e più numerosi di anno in anno. Le flotte che arrivano con scadenza annuale sono sempre più grandi, e portano orde di stranieri affamati di terre a ingrossare la massa che già si trova qui, ma ci sono anche nuove flotte, provenienti da nuove direzioni, dal momento che tra le tribù dei territori germanici dominati tanto a lungo dai Romani si è sparsa la voce dell'esistenza di terre che si possono occupare. Ora che i Romani se ne sono andati, non c'è più nulla che li tenga a freno, e dunque ogni anno dilagano in Britannia a migliaia e migliaia, occupando terre, dissodandole ed espandendosi oltre i confini dell'anno precedente. Gran parte di questa espansione attualmente è diretta verso nord, per restare in vista della costa, dal momento che si tratta di tribù di navigatori; il che significa che per il momento Horsa è impegnato a respingere queste incursioni e non ha né il tempo né le risorse per occuparsi del regno di Vortigern. Ma i nemici si rinnovano e sono continuamente riforniti, perciò credo che presto Horsa dovrà ripiegare contro i territori di Vortigern, per stabilire una nuova linea che sia in grado di difendere dalle incursioni che provengono da sud. A questo punto, è possibile che nel nord iproblemi finiscano, ma l'espansione cercherà altri sbocchi, e nel frattempo l'esercito di Horsa si troverà faccia a faccia con quello di Vortigern. Temo proprio che nella nostra Colonia abbiamo finito con il sentirci troppo sicuri, cullandoci in una falsa sicurezza, semplicemente perché essendo tanto a ovest non vediamo né sentiamo quello che sta accadendo altrove. Migrazioni della portata di quelle che si stanno abbattendo sui territori orientali non saranno contenibili a lungo, poiché, per quanto a noi la Costa Sassone possa sembrare vasta, non potrà sostenere ancora per molto il massiccio affollamento che si sta verificando attualmente e arriverà presto il momento in cui questa crescita incontrollabile investirà altre regioni della Britannia. La logica conseguenza sarà che lo sconfinamento avverrà verso ovest, e cioè verso di noi. Mi chiedo come stia procedendo la campagna di Cambria. È sempre nei miei pensieri, poiché adesso temo che la guerra contro Ironhair e Carthac sia di gran lunga il minore dei nostri problemi: una scaramuccia locale in confronto al pericolo che si fa sempre più preoccupante qui, dall'altro lato della Britannia. Poiché ritengo che da queste parti la situazione sia molto grave, ho deciso di andare a vedere di persona, e questo vuol dire dover prolungare la mia permanenza qui almeno di un mese, il minimo indispensabile per un'ampia e veloce ricognizione dei territori meridionali. Durante tutta l'operazione non intendo attardarmi in nessun luogo e tanto meno cercare lo scontro. Il mio scopo è semplicemente mostrare la nostra presenza e le forze di cui disponiamo come alleati di Vortigem, e nel contempo farmi un'idea più precisa e di prima mano delle truppe che potrebbero essere schierate contro di noi in futuro. Nel frattempo, ti invio questo messaggio per mano di Paolo Sulla, così da tenerti informato. Come avevamo previsto, Vortigern vorrebbe che io mi trattenessi qui, nel nord, per molto tempo, ma gli ho già detto che devo assolutamente far ritorno a Camelot quanto prima. Gli ho comunque promesso di tornare il prossimo anno, con un contingente ancora maggiore. Sono convinto che questa sia la strategia migliore da adottare, e sono altrettanto convinto che anche tu sarai d'accordo non appena avrai compreso la gravità di quanto ho scoperto. Quanto al prossimo anno, è mia opinione che abbiamo di fronte due alternative: se in Cambria la guerra sarà finita, tu e io verremo qui insieme; se invece continuerà a trascinarsi, allora assumerò io il comando e tu verrai qui, nel nord, per farti tu stesso un'opinione di come vanno le cose da queste parti. Reputo tassativo che tu venga qui di persona per valutare la situazione. Da parte mia, ritengo che qui il pericolo sia enorme, che ci sia il rischio di un conflitto aspro e di grandi proporzioni, e questo mi ha anche costretto a riconsiderare gran parte delle tue posizioni che finora non condividevo, quando ti accusavo di immotivata xenofobia. Ironhair e Carthac e i loro simili potranno essere litigiosi e intrattabili, ma adesso mi rendo conto che sono celti come noi, in ultima analisi appartengono alla nostra stessa gente. Al contrario, il pericolo rappresentato dalle orde minacciose che stanno dilagando nei territori nordorientali potrebbe culminare nell'annientamento del nostro popolo e del nostro stesso stile di vita, qui in Britannia, se non prenderemo prontamente le misure necessarie per passare al contrattacco. Tornerò a Camelot non appena mi sarà possibile. Se tu sarai ancora in Cambria, ti raggiungerò lì. In un caso e nell'altro, disporrò di molte più informazioni di quante ne abbia ora. Arrivederci, e possano gli dèi della guerra essere favorevoli al tuo esercito. Ambrogio» Dopo la prima lettura di quella lettera lunga e sorprendente, rimasi a sedere immobile, lasciando che il tono e le notizie si sedimentassero nella mia mente e senza fare alcun tentativo di analizzare quanto Ambrogio aveva scritto. Sapevo che qualsiasi altro comportamento, qualsiasi reazione mi fossi permesso in quel momento sarebbero stati sbagliati. Desideravo rileggere più volte la lettera e poi riconsiderare dettagliatamente l'intera situazione prima di parlarne con chiunque altro, E dunque, sapendo come opera la mia mente, tornai alla missiva di Dedalo, certo che avrei lavorato sulle informazioni di Ambrogio mentre leggevo quelle di Dedalo. Aprii il cilindro e ruppi il semplice sigillo che chiudeva il documento. Come potevo aspettarmi, Dedalo non aveva perso tempo in saluti e preliminari, ma era giunto subito al punto. «Caio, oggi è arrivato il giovane Paolo Sulla, che è in viaggio per recarsi da te e consegnarti alcuni dispacci di Ambrogio, pertanto gli affido anche questa lettera. Si sta preparando per partire al più presto, così ho poco tempo. Non ho assolutamente idea di quello che Ambrogio può aver scritto nei suoi dispacci, ma da quel poco che sono riuscito a farmi dire dal giovane Sulla ho dedotto che non sarà di ritorno così presto come aveva previsto e che in Northumbria le cose si stiano muovendo più di quanto avessimo potuto sospettare. Se non altro, comunque, Vortigern è ancora vivo e Sulla non mi ha parlato di guerra. Per quanto invece riguarda il tuo piano per raccogliere nuovi alleati al di fuori di Camelot, posso comunicarti che la spedizione nelle terre di Nerone Niger e a Corinium è stata effettuata con un centinaio di uomini prima che fosse trascorsa una settimana dalla vostra partenza, esattamente come avevamo pianificato, e che ha avuto un grande successo. Oggi Corinium è tornata a vivere, ci sono persone che vivono dentro le sue mura e dispone di un primo nucleo di una guarnigione che si sta allenando insieme ai nostri uomini. I primi rapporti sembrano incoraggianti, sebbene io continui a nutrire dubbi sulla possibilità di trasformare contadini in soldati. Si tratta comunque di dubbi strettamente personali, e sono pronto a farmi convincere dell'errore. Da allora sono partite altre due spedizioni analoghe, una per la città più vicina a nord di Corinium. Non aveva nome, o comunque anche se lo aveva è stato da tempo dimenticato. Adesso la nostra gente la chiama Secunda. La terza spedizione è stata diretta a Tertia - come ben potevi immaginare - un altro accampamento fortificato, e senza nome, a sud di Camelot, una ventina di miglia a ovest di Lindinis. Questa non era prevista, ma grazie al successo della spedizione di Corinium un giorno è arrivata una delegazione. Accadde infatti che qualcuno dell'area di Tertia, che era stato da quelle parti e aveva parlato con Nerone Niger, fosse poi tornato a casa entusiasta. A quanto sembra Tertia dispone di fertile terreno agricolo ed è molto popolata. Ho esposto la cosa in Consiglio ed è stata approvata, pertanto la spedizione a Tertia ha avuto inizio e mi è stato riferito che in meno di due mesi hanno fatto progressi quanto la gente di Corinium in quattro. Attualmente sono in preparazione altre due spedizioni, entrambe dirette verso luoghi simili, che non hanno nome, ma in cui si trovano i resti di antiche mura romane e nelle cui vicinanze c'è abbondanza di fertili campi. In questa regione il tuo piano funziona bene, amico mio, non importa quante frustrazioni tu sia costretto ad affrontare dove ti trovi adesso. So che saperlo può farti piacere. Qui tutto va come dovrebbe, sebbene non mi piaccia affatto lavorare con il Consiglio: troppe discussioni, poche decisioni. La guarnigione va avanti bene, e occuparmene mi piace. Vedo spesso la tua Tressa di solito in compagnia della moglie di tuo fratello, Ludmilla. È chiaro che sono diventate buone amiche, dunque togliti dalla testa che senza di te sia triste e sconsolata. A dire la verità, qui a Camelot sembra così a suo agio che nessuno crederebbe che sia arrivata solo da poco. Avrei voluto chiederle se voleva che ti comunicassi qualcosa da parte sua, ma non mi è stato possibile poiché Sulla è ansioso dipartire al più presto ed è impaziente che finisca la mia lettera. Falla finita alla svelta con Ironhair e Carthac, ma fallo con la massima durezza. La decapitazione andrebbe bene. Dedalo» Decapitazione! Sorrisi tra me e me, scuotendo la testa mentre posavo la lettera di Ded e lasciavo che si arrotolasse nuovamente su se stessa. Le notizie riguardanti gli insediamenti esterni erano decisamente buone e mi sentii grato, e persino un po' sorpreso, per il fatto che avesse pensato di mandarmele. Le sue riserve sulla qualità delle guarnigioni che stavamo organizzando nei nuovi insediamenti non erano comunque una novità: Ded era un soldato di professione e semplicemente non poteva credere che persone che avevano occupazioni diverse potessero diventare buoni soldati. Le notizie migliori, tuttavia, erano quelle riguardanti Tress e Ludmilla. Mi era bastato veder nominare Tressa per sentirmi pieno di tenerezza e di nostalgia, e a quel punto mi concessi il lusso di pensare a lei a lungo, ricordando il suo profumo, la dolcezza e l'allegria dei suoi occhi, il suono della sua voce, confessando a me stesso che mi mancava terribilmente. Poi, rendendomi conto del rischio di esagerare, riposi la lettera di Ded nel suo cilindro e ripresi il lungo messaggio di Ambrogio. Avevo appena finito di leggerlo per la seconda volta che udii la voce di Donuil che mi chiamava. Passò qualche istante e Donuil sollevò un lembo della tenda ed entrò, seguito da Derek. Aveva un'espressione strana, e immediatamente mi colpì un vociare confuso proveniente dall'esterno. «Che cosa c'è che non va?» Donuil scosse la testa mostrando una certa perplessità. «Non riesco a capire; Connor è andato verso est: ti aspettavi che tornasse indietro da quella parte?» «Sì, oppure direttamente da sud. Di che cosa stai parlando?» «Bene, o sta tornando indietro da ovest oppure c'è un'altra grande bireme che viene a trovarci.» «Proveniente da ovest? Fammi vedere.» Mi costrinsi a non mostrare inquietudine o impazienza, arrotolando lentamente e accuratamente la lettera di mio fratello prima di farla scivolare di nuovo nel suo cilindro. Fatto questo mi diressi verso l'ingresso, tenendolo aperto finché Donuil non mi fu passato davanti. Non c'era alcun bisogno di spostarsi più in avanti; la grande sagoma scura della bireme in avvicinamento era inconfondibile. «Bene, quello non è Connor» dissi senza alzare la voce, dopo averle dato uno sguardo. «Dunque, chiunque possa essere, è stato mandato da Ironhair e non è qui per caso. Dubito che sia tanto folle da tentare un attacco di qualsiasi genere in questo posto, e per di più non ha altre imbarcazioni: pertanto devo supporre che abbiamo un visitatore che desidera parlare con noi.» Donuil era vicino a me e mentre parlavo mi stava osservando attentamente; sapevo comunque che i suoi non erano gli unici occhi puntati verso di me. «Vediamo di mostrarci disciplinati. Donuil, raduna la nostra gente sulla spiaggia e schierala in ordine di combattimento. Penso che ci vorrà ancora mezz'ora prima che ci raggiungano, a meno che non cambino rotta e se ne vadano altrove. Ordina ai comandanti di grado superiore di indossare l'armatura da parata, se non ti dispiace, e mandami immediatamente il mio attendente che mi aiuti a mettermi in pompa magna. Non c'è tempo da perdere.» VIII. Donuil tornò nella mia tenda proprio mentre mi stavo togliendo il pesante mantello militare: faceva troppo caldo e inoltre mi ero reso conto di essermelo messo sulle spalle troppo presto. Anche Donuil comunque si era cambiato: aveva indossato l'armatura da parata e sotto il braccio sinistro portava il suo elmo lavorato a sbalzo e ornato da un maestoso cimiero. Lo squadrai dalla testa ai piedi e non potei che approvare. «Sono arrivati, Merlino» disse calmo. «Sono a non più di cinquanta o sessanta passi dalla spiaggia, dove l'acqua è ancora profonda. Ma non hanno minimamente accennato ad alcun saluto. Come dobbiamo comportarci?» «Hanno lasciato capire quali sono le loro intenzioni?» «No, ma non sembrano ostili. Sono arrivati al punto in cui si trovano ora muovendosi lentamente e non riesco a vedere armi o spade sguainate, da nessuna parte.» «Non hanno messo in acqua una barca?» «No, nulla. Non hanno fatto proprio nulla. C'è un gruppetto di uomini che sembrerebbero ufficiali...» «Solo gli eserciti hanno ufficiali, Donuil, e una gerarchia ben precisa. È possibile che siano dei capi, ma non sono di certo degli ufficiali.» «D'accordo, c'è un gruppo di loro sulla prua della nave, proprio di fronte a noi, e sta guardando in questa direzione.» «E noi guardiamo verso di loro?» «Penso di sì» rispose con un certo stupore. «Sono proprio di fronte a noi, e non c'è nient'altro da guardare.» «Ti sbagli, Donuil. Là fuori ci sono centinaia di altre cose da guardare, e sono tutte più interessanti di quelle persone.» Aprii la porta della mia tenda e guardai fuori, dove parecchi dei miei ufficiali erano in attesa di ordini. «Signori, volete venire qui?» Non appena furono entrati, mi volsi verso Donuil. «Donuil mi dice che il nemico ci sta guardando - o meglio, osservando - e che è possibile che noi lo osserviamo a nostra volta. Esigo che non avvenga. Per favore, voi andrete nei vostri reparti, immediatamente, e ordinerete ai vostri soldati di ignorare queste persone. Devono fissare lo sguardo dritto verso l'orizzonte che sta loro di fronte. Possono guardare il mare, le onde, le nuvole in cielo o la nuca di chi hanno davanti, ma non devono assolutamente guardare la nave nemica o i membri dell'equipaggio, è chiaro?» Li fissai uno a uno, e tutti annuirono. «Bene. Grazie a tutti. Tra un attimo vi chiederò di raggiungere i vostri uomini, cominciando da quelli che sono più vicino alla nave nemica. Ma prima che andiate, voglio dirvi come ci comporteremo, e continueremo a comportarci, durante tutto l'incontro. La loro pretesa di essere nostri pari è offensiva, assolutamente inaccettabile, ed esigo che sia ben chiaro. Non tratterò con Ironhair, o qualcuno dei suoi scagnozzi, in alcun modo che possa lasciar intendere, sia pur minimamente, una condizione di parità. Non ho alcun desiderio di dare la falsa impressione che potrei avere il benché minimo interesse ad ascoltare quello che eventualmente avessero da dirmi.» Di nuovo li fissai negli occhi uno a uno, e di nuovo tutti annuirono con molta serietà. «Bene. Donuil sarà l'unico a trattare o anche semplicemente a parlare con loro. Ve lo chiedo ancora una volta: avete ben compreso che cosa vi ho detto?» Tutti annuirono, con un coro di «Sì, comandante» e a quel punto li congedai perché potessero far eseguire immediatamente i miei ordini. Non appena furono usciti, mi volsi verso Donuil: «Indubbiamente queste persone avranno la sfrontatezza di aspettarsi che io vada loro incontro. Ma non lo farò. Ironhair non è su quella nave. Non è tanto incosciente da affrontare un rischio simile. Pertanto, chiunque ci sia a capo di questa spedizione, si tratta di un suo delegato, e dunque conferirà con te che sei il mio delegato. Adesso non parlano né si muovono, ma prima o poi dovranno parlare, o gridare, e poi venire da noi. Nessuno dei nostri si recherà da loro, per alcun motivo. Se vogliono parlare con noi, devono venire a riva, e quando lo avranno fatto, dovranno parlare con te e soltanto con te. Quando li avrai ascoltati, se ritieni che anch'io debba sentire quello che hanno da dire, li condurrai da me, e poi aspetteranno che io abbia tempo per riceverli. Me ne porterai non più di tre o quattro, ancor meno se possibile, e sotto scorta, sotto scorta armata. Non dovrà esserci nulla che possa illuderli che intendiamo rendere loro onore: nessuna cerimonia, nessuna deferenza, nessuna cortesia, tranne lo stretto necessario per evitare la violenza. Dovranno essere trattati come una banda di briganti sotto la protezione di una tregua temporanea e indesiderata. Briganti, Donuil, non guerrieri, non uomini onesti». Donuil mi fissava con la massima attenzione, memorizzando ogni parola, poi annuì. «Mi accerterò personalmente che non possa essere messa in dubbio la considerazione in cui li teniamo.» «Bene, ma cerca di capire appieno quanto ho appena detto. Tu solo valuterai l'importanza delle loro parole e deciderai se è opportuno o meno che li ascolti anch'io. Se deciderai che non ne vale la pena, li accompagnerai fino a riva e attenderai che se ne siano andati.» A questo punto lo vidi aggrottare la fronte. «È proprio quello che intendevo dire, Donuil. È un confronto che spetta a te, e che condurrai come riterrai opportuno. Sei il mio aiutante, e hai la piena discrezionalità di decidere se questa faccenda merita che io le dedichi il mio tempo. Non metterò in discussione la tua decisione. Adesso va' fino al limite dell'acqua e aspetta che ti chiamino, ma non incoraggiarli. Non mostrarti incuriosito, e per nessun motivo non essere il primo a parlare o ad agire. Limitati a guardarli come se fossero qualche sorta di oggetto dannoso e sgradevole che galleggia. Quando avranno capito che non hai alcuna intenzione di muoverti, vedrai che si muoveranno loro.» Annuì, mi fece il saluto militare, si rimise l'elmo e se ne andò, lasciandomi solo e in attesa. Per un po' passeggiai avanti e indietro nella mia tenda, cercando di capire che cosa stesse accadendo all'esterno, ma il silenzio era stupefacente. Di tanto in tanto potevo sentire qualche frase mormorata a bassa voce, o l'ordine di qualche ufficiale, talvolta persino lo scricchiolio della sabbia mista a sassi quando il cavallo di qualcuno scivolava e faceva uno scarto, e poco più. Avrei voluto uscire fuori, o quanto meno sollevare un lembo della tenda per poter vedere qualcosa, ma non intendevo mostrare il benché minimo interesse. Alla fine, udii in lontananza qualcuno chiamare a voce alta, ma non potei udire che cosa avesse detto. Non ci fu alcuna risposta, e io cominciai a contare, lentamente. Quando ero arrivato a quindici, il grido fu ripetuto, ma era ancora troppo attutito dalla distanza perché potessi capirne il senso; questa volta però Donuil rispose. «Se avete qualcosa da dire, venite qui e ditelo da uomini, non muggendo come tori. Nessuno vi farà del male.» Seguì un lungo momento di silenzio, poi avvertii il suono di passi che si avvicinavano, e il giovane Bedwyr sollevò un lembo della tenda. «Comandante Merlino? Devo informarti che c'è una barca che si sta avvicinando, con cinque uomini a bordo, oltre a quattro rematori.» «Grazie, Bedwyr» risposi. «Ora resta dove sei e voltati. Puoi vedere che cosa sta accadendo?» «Sì, comandante. La barca si sta avvicinando alla riva.» «Bene. Adesso chiudi la tenda, e rimani all'esterno. Guarda verso la spiaggia e riferiscimi semplicemente tutto quello che vedi. Ti sento perfettamente senza che tu debba alzare la voce.» «Sì, signore.» Poi un lungo silenzio. «Adesso hanno smesso di remare, comandante. Ora i rematori sono in acqua e tirano la barca sulla spiaggia... Gli altri sono saltati fuori e si stanno avvicinando al tribuno Donuil. Non gradiscono gli arcieri.» «Quali arcieri?» «Il tribuno Donuil ha ordinato a due squadroni di arcieri di Pendragon di schierarsi alla sua destra e alla sua sinistra, con la freccia incoccata e rivolta verso il limite dell'acqua, in una formazione a imbuto. I nuovi venuti camminano in mezzo agli arcieri e si stanno avvicinando al tribuno.» «Bene, e che sta facendo Donuil?» «Nulla, signore. Attende, in piedi davanti a loro, con le mani dietro la schiena. Adesso stanno parlando, ma non riesco a sentirli... L'aiutante ora li sta accompagnando verso la tenda del furiere... Si siede al tavolo del furiere, davanti alla tenda, di fronte a loro, e sta dicendo qualcosa... Mi dispiace, signore, ma mi volta la schiena. Non mi riesce di sentire che cosa dice.» «Va bene così, Bedwyr. Che sta accadendo dell'accampamento? Che cosa fanno gli altri soldati?» nel resto «Nulla, signore. Nessuno si è mosso.» «Grazie. Rimani dove sei e avvisami quando qualcuno si muove.» Mi costrinsi a tornare al mio tavolo da lavoro e a sedermi, e poi a estrarre la lettera di Ambrogio dal suo contenitore e a leggerla di nuovo. Non saprei dire quante volte iniziai a leggere soltanto per rendermi conto di aver dimenticato quello che avevo appena letto ed essere costretto a tornare al punto di partenza, ricominciando dai saluti. Alla fine, dopo quella che mi era sembrata un'eternità, Bedwyr riprese a parlare. «Il tribuno Donuil si è alzato, signore. Ora sta venendo da questa parte.» «Bene. Vieni dentro.» «Signore!» entrò e rimase sull'attenti proprio all'ingresso. Il rumore dei passi di Donuil si avvicinava e la sua ombra cominciava a profilarsi. Quando entrò, io gli stavo di fronte. Diede uno sguardo a Bedwyr, poi si voltò verso di me. «Penso che dovresti incontrarli, Merlino.» «A che proposito? Qual è la loro proposta?» «Non lo so, ma ne hanno una. La potrai valutare tu stesso, molto meglio di me. Il loro capo si chiama Retorix, e comanda le truppe che Ironhair ha raccolto in Cornovaglia. È uno spaccone arrogante e dall'atteggiamento minaccioso, ma si esprime con più chiarezza degli altri. È a lui che Ironhair ha affidato l'incarico di parlare con te. Il che significa che non ha alcuna intenzione di dire a me quello che gli è stato ordinato di dire a te, tanto che sono stato tentato di rispedirlo a calci sulla sua nave, ma qualcosa mi dice che non convenga farlo. Penso proprio che dovresti incontrarlo.» «Molto bene, allora, portalo qui, ma lascia gli altri ad aspettarmi sulla spiaggia.» Donuil annuì e cominciò ad avviarsi, tuttavia sembrava esitante; era evidente che voleva aggiungere qualcosa. «Pensi che sia saggio lasciarli fuori tutti e quattro, Merlino? Voglio dire, se devi dirgli qualcosa, parole dure o altro, non pensi che sarebbe meglio che ci fossero dei testimoni? Se gli parli da solo, senza nessuno che senta, potrà riferire a Ironhair quello che gli pare, senza che nessuno possa smentirlo. Se sono presenti anche gli altri, a me sembra che sarà costretto a dire la verità o quanto meno qualcosa che non se ne discosti troppo.» «Hai ragione, amico mio. Portali tutti qui, ma falli fermare davanti alla mia tenda, dentro non li voglio.» Attesi di sentirli avvicinarsi, e poi rimasi ad ascoltare soddisfatto il tintinnio metallico delle armi e delle armature nel momento in cui le guardie che li circondavano rispondevano ai comandi del loro ufficiale. Qualche istante dopo, Donuil mi si avvicinò e mi comunicò che la delegazione della Cornovaglia mi attendeva. Rimasi seduto al mio tavolo e per l'ennesima volta mi costrinsi a rileggere interamente la lettera di Ambrogio. Poi mi alzai e mi gettai sulle spalle il mantello da cerimonia, drappeggiandolo con cura in modo che il prezioso ricamo che faceva bella mostra nella parte centrale — un grosso orso ricamato con filo d'argento - venisse a trovarsi esattamente al centro della mia schiena. Dopo aver ordinato a Bedwyr di seguirmi, presi l'elmo da parata e uscii accostandomi al luogo in cui i nuovi arrivati attendevano, in gruppo, sotto lo sguardo vigile di un intero squadrone di guardie che li circondavano da tre lati. Non fu affatto difficile individuare Retorix, il loro capo. Superava di mezza testa i suoi compagni, e i suoi abiti erano più ricchi e più elaborati. Di per sé era un uomo prestante, con spalle larghe, vita snella e gambe robuste, e poteva avere trentatré anni. Era rasato, senza barba né baffi, e il modo in cui era armato era vagamente romano: la corazza di bronzo gli riparava le spalle e il petto e portava un elmo con una protezione che gli copriva il collo, ma non arrivava a nascondere i folti riccioli della lunga chioma nera che gli scendeva oltre le spalle. Dalla vita in giù non portava armatura. Indossava una tunica imbottita che gli scendeva fino alle ginocchia e da cui spuntavano calzoni di tessuto pesante, fatto in casa, fermati da legature incrociate dalla caviglia al ginocchio. I suoi stivali erano di cuoio spesso, e sembravano duri e scomodi. Un pesante mantello grigio di lana dava un tocco di romanità al suo aspetto: lo portava drappeggiato sulla spalla destra, con un'estremità tirata su fin sotto il braccio sinistro, dove una grossa fibula d'argento, di foggia barbarica, lo teneva a posto. Ignorai deliberatamente gli altri quattro uomini e fissai lo sguardo soltanto su Retorix. «Chi sei?» «Gli altri mi chiamano Retorix.» «Aria fritta?» Vidi che spalancava gli occhi. «Questo è quello che significa "rhetoric" nella mia lingua: aria fritta e argomentazioni da sbruffoni. "Rhetorics" dovrebbe essere un plurale: dunque una gran quantità di aria fritta.» Potei vedere che le mie parole, se non il mio tono, lo avevano sbalordito, e mi rimproverai da solo per essere sceso a un tale livello. «Chi sono questi "altri" che ti chiamano Retorix?» «La mia gente.» «Questo lo sapevo già, dal momento che presumo che soltanto la tua gente si interessi a te. Qual è la tua gente? Questo è quello che ti sto chiedendo.» Si raddrizzò tutto, e il suo atteggiamento lasciava trasparire l'oltraggio ricevuto. «I Romani li chiamavano Belgae, e sono gli abitanti della Cornovaglia.» Lo fissai negli occhi. «I Romani se ne sono andati da un pezzo. Il loro tempo è finito. Noi siamo Britanni. Vuoi sapere come noi oggi chiamiamo la gente della Cornovaglia, la gente che ubbidisce agli ordini di un individuo come Peter Ironhair?» Distolsi lo sguardo dalla sua persona, senza fare alcuno sforzo per mascherare il disgusto, poi tornai a fissarlo. «Il mio aiutante mi ha detto che hai un messaggio per me, io però ho ben poco tempo per ascoltarti, dunque sputa in fretta quello che hai da dire e vattene alla svelta.» Potevo vedere che a ogni mia parola la sua collera non faceva che aumentare, tuttavia riuscì a controllarsi e dopo aver inspirato profondamente attraverso il naso più e più volte cominciò finalmente a parlare. «Tu sei Merlino di Camelot, non è così?» «E allora?» Vidi che i suoi occhi si spostavano rapidamente da me a Bedwyr, che stava alle mie spalle, e non appena notai la grande attenzione con cui lo fissava esaminandolo dalla testa ai piedi, compresi di colpo che pensava che Bedwyr in realtà fosse Artù. Da quando ero uscito, infatti, aveva guardato soltanto me. Ora tuttavia distolse nuovamente lo sguardo per tornare a fissarmi e, per quanto mi sforzassi, nei suoi occhi non potei notare alcun interesse per il ragazzo. «Porto i saluti del mio capo, Iron...» «Allora te li puoi anche tenere, perché non mi interessano affatto.» Si interruppe di nuovo, sforzandosi palesemente di controllare la propria ira. «Mi è stato assegnato un incarico, mastro Merlino! Vuoi permettermi di riferire il mio messaggio senza interrompermi a ogni parola?» Lo fissai, provando un'involontaria ammirazione per il suo autocontrollo. Donuil lo aveva definito un "arrogante spaccone", ma fino a quel momento non avevo visto nulla che lo facesse ritenere tale. «Molto bene, allora. Riferisci quello che devi riferirmi.» «Ironhair ti manda i suoi saluti, come un capo che si rivolge a un altro. Tu come comandante legato di Camelot, lui come comandante supremo degli eserciti della Cornovaglia. Non intende insultarti fingendo che tra di voi possa esistere amicizia, né pretenderà che possiate negoziare sulla base di una reciproca stima. Tuttavia ritiene che tu stesso ammetterai come entrambi, e coloro che sono alleati con voi, abbiate molto da guadagnare dalla fine di questa guerra.» Si interruppe, evidentemente si aspettava una risposta; io invece continuai a fissarlo, senza che il mio viso lasciasse intendere nulla. Alla fine non poté far altro che continuare. «La tua presenza in Cambria è un'intrusione - questa è la sua opinione - mentre le sue attività sono legittime. Egli rappresenta il tuo lontano parente, Carthac, il cui diritto a occupare il trono di Pendragon, attualmente vuoto, è E più forte, poiché deriva da una parentela diretta.» Non poté resistere alla tentazione di volgere nuovamente lo sguardo verso il giovane Bedwyr. Si trattò soltanto di un rapido sguardo, un lampo, ma confermava quanto avevo già notato. Sfortunatamente i suoi compagni non erano dotati del medesimo autocontrollo, dal momento che fissavano il ragazzo tanto insistentemente che persino l'interessato se ne accorse. Io invece, mi resi conto che a quel punto Bedwyr stava cominciando a parlare, così mi voltai di scatto per impedirglielo. «Perché state...?» «Sta' zitto, ragazzo!» Bedwyr spalancò gli occhi di fronte all'asprezza del mio tono. Rimasi immobile, volgendo la schiena agli altri, finché i suoi occhi si fissarono nei miei, e allora cercai di ammiccare verso di lui prima di continuare nello stesso tono aspro. «Sei diventato matto? Come osi far sentire la tua voce quando io ho garantito che non ci sarebbe stata alcuna interruzione? Va’ immediatamente nella mia tenda e restaci finché non ti faccio chiamare. Muoviti!» Il povero ragazzo fece un passo indietro: era evidente che la confusione e l'imbarazzo lo avevano portato sull'orlo delle lacrime; cercò di ricomporsi, raddrizzò le spalle, si voltò rapidamente ed entrò nella mia tenda. Mi voltai, rivolgendomi di nuovo a Retorix. «Puoi continuare e nessuno ti interromperà più. Stavi parlando di Carthac.» Posai lo sguardo sui miei uomini, senza cercare di nascondere la mia collera. In verità, a mandarmi su tutte le furie era l'intollerabile insolenza di quanto stavo ascoltando. Quando il mio sguardo tornò su di lui, notai che Retorix non aveva smesso di osservarmi, tenendo continuamente gli occhi fissi sul mio viso, e io mi chiesi se fossi davvero riuscito a non lasciar trasparire di essermi accorto del suo interesse per Bedwyr, Artù, come credeva lui. Infine annuì, si schiarì la gola e continuò a parlare. «Il padre di Carthac era Mor, il fratello minore di Uric Pendragon, padre di Uther. Carthac ha richiesto, e ottenuto, l'aiuto di Peter Ironhair per far valere il suo diritto a essere proclamato re, e per questo motivo Ironhair è venuto in Cambria. Al contrario, la vostra presenza qui non è stata richiesta da nessuno. Dergyll ap Griffyd, con cui un tempo avevate buoni rapporti, è morto, mentre il suo posto è stato preso dall'usurpatore Uderic, che non è vostro amico. Pertanto il vostro esercito è soltanto una forza di occupazione, cosa che è resa ancora più evidente e pienamente confermata dal semplice fatto che ben pochi degli uomini di Pendragon si sono uniti a voi. La realtà è che non cercano per nulla il vostro aiuto per sistemare le loro questioni. Anzi, sono del tutto convinti di essere perfettamente capaci di risolvere da soli le loro divergenze senza alcun bisogno della vostra interferenza.» Si interruppe di nuovo, raccogliendo le idee prima di continuare; nel frattempo mi sforzavo di rimuovere dalla mente il riferimento a Uderic come a un usurpatore. Naturalmente Ironhair la pensava così, ma Uderic si era conquistato il suo titolo in battaglia, mettendosi a capo della sua gente quando si era battuta contro il tentativo di usurpazione da parte di Carthac. Infine Retorix riprese a parlare. «La proposta del mio comandante, che successivamente potrà essere meglio definita con soddisfazione di entrambi, in sintesi è questa: è suo convincimento che tu consideri la sua presenza in Cambria una minaccia contro la tranquillità e la sicurezza della tua Colonia di Camelot. Al contrario, Ironhair ritiene che tale minaccia non esista affatto e che la sua presenza qui sia solo temporanea, poiché mira esclusivamente a concludere rapidamente e con successo la sua campagna a sostegno di Carthac Pendragon. Quando la guerra sarà terminata, Ironhair tornerà in Cornovaglia con tutte le sue truppe, lieto di avere un alleato forte in Cambria a nord e, presumibilmente, un alleato di comodo a Camelot, a nord-est, vale a dire, voi. D'altro lato, tu otterrai il notevole beneficio di non doverti immischiare nelle questioni della Cambria, il che ti permetterà di dedicare tutta la tua attenzione al pericolo che dai territori dei Sassoni si sta diffondendo a est e a nord rispetto a voi, e persino di rafforzare la tua alleanza con re Vortigern, in Northumbria, qualora ritenessi consigliabile proteggere i tuoi interessi in quel modo. Perché tu non debba temere attacchi dalla Cambria, Ironhair sostiene che per risolvere la questione esiste già un precedente: potrebbe essere istituita e mantenuta una forza di pattugliamento costituita da contingenti della tua cavalleria, molto simile a quella che un tempo era giunta in aiuto di Dergyll ap Griffyd, come interposizione tra la Cambria e Camelot. Questa forza sarebbe riconosciuta e potrebbe liberamente agire senza alcuna interferenza.» Mentre Retorix parlava, in diversi momenti avevo voltato la testa da un'altra parte, sforzandomi di farlo in modo casuale e fingendo di osservare il comportamento dei miei cavalieri, per altro assolutamente immobili, semplicemente per controllare meglio l'espressione del mio viso. La notizia che Ironhair sapeva dei nostri rapporti con Vortigern e della minaccia che proveniva dalla Costa Sassone mi giunse del tutto inattesa, sebbene mi fosse nota la capacità di Ironhair di giungere molto lontano nel tessere le sue trame. Le sue affermazioni a proposito di Uderic - che non poteva essere considerato tra i miei amici - erano meno sorprendenti, dal momento che Uderic non faceva mistero di nutrire sospetti sui motivi che mi avevano spinto a venire in Cambria. Era la sua difesa di Carthac quello che mi riusciva più difficile da accettare senza ribellarmi, sebbene cercassi di dire a me stesso che stavo ascoltando semplicemente delle parole, che miravano a mettermi a disagio e a impedirmi di seguire un'altra linea di condotta. Era questo che mi faceva arrabbiare, poiché era proprio la linea di condotta a non essermi chiara. L'ipotesi che Ironhair potesse vedere più chiaro di me, e che potesse agire contro di me per impedirmi di intraprendere una strada che io neppure intravedevo, mi faceva infuriare. C'era poi la faccenda di Artù. Ironhair sapeva di Artù, sapeva chi era suo padre, conosceva il suo lignaggio e pertanto non poteva ignorare che aveva diritto più di chiunque altro a sedere sul trono di Cambria. Non per nulla, il nostro trasferimento a Mediobogdum era stato reso necessario da un tentativo di assassinio ai danni del ragazzo, avvenuto per istigazione di Ironhair in persona. Ora, finalmente ricomparso dopo essere sparito per tanto tempo, era presumibile che avrei tenuto il ragazzo con me. Per altro, Retorix e i suoi compagni avevano certamente ricevuto ordine di osservare bene il ragazzo che eventualmente fosse in mia compagnia, e la loro reazione alla vista di Bedwyr indicava chiaramente che erano a conoscenza dell'età di Artù, ma che non avevano idea del suo aspetto. Perché allora, mi chiedevo, Ironhair mi aveva propinato quella panzana sui presunti diritti di Carthac? Doveva certamente sapere che non mi sarei mai sognato di prenderla per buona, e allora che cosa cercava di ottenere? In che modo avrei danneggiato la mia causa e avvantaggiato la sua, rifiutando le sue proposte sulla base della legittimità dei diritti di Artù? Era questo che mi lasciava fortemente perplesso, perché mi rendevo conto che Ironhair doveva conoscere la risposta. E improvvisamente compresi: la soluzione giunse tanto inaspettata che quasi mi tolse il respiro, perché di colpo eliminava quello che sembrava un vantaggio di Ironhair su di me. Per nascondere la mia reazione di fronte a quella scoperta improvvisa, feci qualche passo in avanti con studiata lentezza, tenendo gli occhi bassi e mostrando di avere l'intenzione di andare a sedermi sull'unica sedia che si trovava accanto al tavolo posto tra Retorix e me. Mi appoggiai allo schienale e sistemai il braccio sinistro di traverso sul petto, posando il gomito destro sul pugno sinistro, e pizzicando il labbro inferiore tra il pollice e l'indice della mano destra. Retorix mi osservava, socchiudendo gli occhi, pensando che io stessi valutando le sue parole. In effetti, quello che stavo considerando era il modo in cui avrei dovuto sfruttare quanto avevo appena compreso, tanto che il mio più grande desiderio sarebbe stato correre nella mia tenda per essere solo con i miei pensieri. Avrei avuto bisogno di analizzare immediatamente la mia intuizione per vedere quali potessero essere i punti deboli, ma sapevo che Bedwyr mi aspettava e mi avrebbe impedito di concentrarmi; al contrario, se fossi restato semplicemente dove mi trovavo, nessuno avrebbe osato interrompere il filo dei miei pensieri. Ironhair, ormai ne ero convinto, scommetteva sul fatto che non avrei tollerato né la sua insolenza nel tentare questo approccio né la spuria rispettabilità che cercava di attribuire a Carthac. Pienamente consapevole della legittimità delle pretese di Artù, in quanto erede di Uther, era certo che avrei reagito con sdegno alla sua offensiva proposta e avrei cacciato i suoi mercenari dalla mia presenza. Il suo ragionamento, e le sue speranze di successo, adesso erano ben chiare nella mia mente e lui stesso mi aveva dato la chiave per trovare la soluzione. Ma citando Uderic e la sua avversione nei miei confronti, Ironhair aveva esagerato. Quando avessi rifiutato il suo invito a ritirarmi alle sue condizioni, che partivano sostanzialmente dal modo in cui aveva definito la mia presenza in Cambria - e cioè una forza di occupazione - in questo conflitto mi sarei inevitabilmente presentato, proprio in base a quella definizione, come una terza forza, nemica di entrambi i contendenti. Forte della falsa legittimazione del suo appoggio a Carthac, che era pur sempre un Pendragon, Ironhair avrebbe potuto avvicinarsi a Uderic e fare causa comune con lui - sia pure temporaneamente - per cacciare dalla Cambria l'esercito invasore di Camelot. Su Uderic non mi facevo alcuna illusione. La sua ambizione era grande quanto quella di Ironhair, e i suoi occhi guardavano allo stesso premio: il cerchio d'oro che avrebbe cinto la fronte di chiunque fosse diventato re di Pendragon. Il fatto che molti, forse la maggioranza, dei suoi stessi uomini rifiutassero di credere che Camelot avesse delle mire sulla Cambria, influiva ben poco sui progetti di Uderic. Si sarebbe alleato con Ironhair per cacciarci dal territorio di Pendragon. Poi, una volta che ce ne fossimo andati, schiacciati dagli eserciti dei due alleati, si sarebbe sentito libero di occuparsi di Carthac e Ironhair, sistemandoli a dovere. Uderic era un abile capo militare e il successore naturale di Dergyll, ma gli mancava l'intelligenza e il sostegno popolare che il defunto re aveva saputo conquistarsi senza fatica. Quanto a me, avrei scommesso che Ironhair avrebbe vinto, dieci volte su dieci, il confronto con Uderic. Ciò non toglie che tutto questo non aveva nulla a che vedere con i miei problemi immediati: per il momento dovevo fare i conti con quello che Ironhair aveva in mente. Quando ero un ragazzino di dieci, o forse undici anni, Publio Varro mi aveva detto qualcosa che non avevo mai dimenticato. Un giorno aveva scoperto che gli avevo mentito a proposito di una scappatella da ragazzi, quando, cercando di evitare a Uther un non ben specificato castigo, avevo sostenuto di non sapere dove si trovasse mio cugino. A quel punto, lo zio Varro mi aveva costretto a riflettere a lungo sulla menzogna, facendomi notare, e sottolineandolo più e più volte, come il mentire avesse già in sé la propria punizione, che si accresce e si alimenta da sola fino al punto in cui il bugiardo perde ogni rispetto e credibilità. Era tornato sull'argomento per settimane, tanto che non ne potevo proprio più; poi però aveva concluso la lezione chiedendomi se sapessi quale fosse la tragedia del bugiardo. Insistette perché riflettessi sulla sua domanda e trovassi una risposta; dovetti dunque pensarci e ripensarci, finché credetti di aver finalmente trovato la risposta. «Allora?» mi chiese lo zio Varro. «Credo... che una volta che un uomo è diventato davvero un gran bugiardo... un bugiardo abituale... allora la sua tragedia deve essere che, qualunque cosa dica, nessuno riuscirà più a credergli.» Mio zio annuì. «È davvero spaventoso, non ti pare? Vorresti trovarti in una situazione simile?» «No.» «No, e neanch'io lo vorrei. Vivere per tutta la vita sapendo che nessuno potrà mai crederti in nulla deve essere davvero terribile. Tuttavia, Cay, non è questa la vera tragedia del bugiardo. La tragedia del bugiardo è molto, molto più terribile ancora.» Lo guardai spalancando gli occhi. «Come, zio? Che cosa potrebbe essere peggio di non essere creduto?» «Questo, Cay: la vera tragedia del bugiardo è che non potrà mai credere a nessuno.» La sua affermazione mi lasciò sconcertato poiché ero ancora troppo giovane per comprenderne tutte le implicazioni, ma non l'ho mai dimenticata, e non ho mai neppure smesso di pensarci; poi, una volta diventato adulto cominciai a rendermi conto dell'effettiva portata di una simile tragedia: se un uomo sa, nel profondo del proprio cuore, di essere un bugiardo, un impostore e un ipocrita, come potrà attribuire sincerità, onestà o integrità a chiunque altro? Ora, Ironhair mi stava giudicando in base ai suoi parametri e si sbagliava. Mi attribuiva le sue venali ambizioni, credendo che io cercassi davvero di regnare in Cambria e aspirassi a diventare re con lo stesso ardore con cui lo desiderava lui, dal momento che non credevo affatto che Carthac sarebbe sopravvissuto all'accordo con Ironhair quanto bastava perché potesse reclamare la corona. Ironhair non avrebbe mai potuto credere la verità: che il mio scopo era vendicare il tradimento che lui aveva portato a Camelot. Volevo la sua morte, e quella di Carthac, semplicemente perché pensavo che il mondo sarebbe stato un posto migliore se privato di entrambi. A quel punto avrei potuto tornarmene a Camelot e viverci in pace finché non fosse arrivato il momento in cui Artù poteva farsi avanti e reclamare ciò che gli era dovuto. Credevo di aver capito che cosa avesse in mente. Ma Ironhair non sapeva che avevo appena mandato Huw Fortebraccio a contattare Uderic. Quando Uderic e io ci saremmo incontrati faccia a faccia, gli avrei rivelato quello che Ironhair aveva in mente, e avremmo marciato insieme contro di lui, unendo i nostri eserciti. Uderic aveva molti difetti, e fino a quando non avessi avuto modo di accertarmi del contrario, ero pronto ad accettare che potesse anche essere inaffidabile: ma almeno era sano di mente, a differenza di Carthac. Con un sibilo, inspirai profondamente tenendo i denti stretti, poi mi alzai. Retorix e i suoi compagni erano ritti di fronte a me, attorniati dai miei cavalieri, e per un attimo provai una leggera esitazione, chiedendomi se non stessi per compiere un grave errore. In quel momento, Connor doveva essere in azione nelle acque di fronte a Tintagel: non avrebbe avuto di che ringraziarmi se, per colpa mia, mentre si stava dirigendo verso casa, gli uomini di Ironhair gli fossero arrivati alle spalle quando meno se lo aspettava. Parlai rivolgendomi direttamente a Retorix attentamente i suoi occhi. e osservando «Quanto ti ci vorrà per portare la mia risposta a Ironhair? Suppongo che se ne stia al sicuro a Tintagel!» Per un attimo spalancò gli occhi, ma la sua risposta arrivò immediatamente e con voce calma. «Aspetta il nostro ritorno, ma non a Tintagel.» «No, naturalmente no. Voi siete arrivati da ovest.» Poi, sapendo di aver ragione, inasprii il tono e snocciolai quello che avevo da dire, parlando con durezza e senza dargli la possibilità di interrompere o di cavillare. «Comunque, da qualsiasi parte siate arrivati, da sud o da ovest, siete venuti qui senza che nessuno vi avesse invitati e vi ho ascoltati con pazienza, sebbene controvoglia. Ora, avendo ascoltato quello che avevate da dirmi, questa è la mia decisione...» Passai dall'altra parte del tavolo, fermandomi a meno di due passi da loro, senza che nulla ci dividesse. «Lasciate che cominci dall'inizio. Io sono il comandante legato di Camelot, e pertanto vi siete rivolti a me correttamente. Al contrario, il vostro "comandante supremo", come voi lo chiamate, è un impostore, un uomo che è stato esiliato da Camelot. È un bugiardo e un assassino di donne, e sebbene cerchi di farlo da solo, non merita che gli venga attribuita alcuna nobiltà, poiché ne è assolutamente indegno. Il suo amico Carthac, che lui afferma essere un mio lontano parente, non ha alcun legame di parentela con me. È un demente degenerato e assolutamente indegno persino di essere considerato un essere umano. Quanto al suo cosiddetto diritto al trono di Cambria, è semplicemente ridicolo anche solo ipotizzare che la gente di Pendragon vorrà porsi spontaneamente sotto il suo tallone. Il motivo per cui sono giunto qui in Cambria, accompagnato dal mio esercito e senza essere stato invitato, è presto spiegato. Il mio scopo è uno solo: causare la morte e la distruzione di Ironhair e di tutto quello che rappresenta. Pertanto, tornate a bordo della vostra nave e riferite quanto vi ho detto all'impostore che vi ha mandato. E qualora foste tanto folli da tornare da queste parti, sappiate che sarete ricevuti come meritate, proprio come avremmo dovuto trattarvi oggi.» Mi voltai verso il comandante delle guardie: «Scorta costoro fino a riva e fai in modo che spariscano dalla mia vista». Mi voltai di scatto ed entrai nella mia tenda. Trovai Bedwyr che mi stava aspettando: i suoi occhi erano sereni, la sua espressione rassegnata, tutto il suo comportamento mostrava la decisione di accettare virilmente il castigo che avessi deciso di infliggergli. Lo guardai sorridendo. «Hai capito che cosa è accaduto là fuori e perché me la sono presa con te?» Qualsiasi cosa si fosse aspettato di udire, non era certo quella, e i suoi occhi erano velati di perplessità mentre si sforzava di capire che cosa intendessi dire. Infine scosse la testa. «No, non l'ho proprio capito.» «Pensavano che tu fossi Artù. È per questo che ti fissavano tutti. Non hanno fatto che parlare del diritto di Carthac di diventare re di Pendragon, ma sanno bene che Artù può vantare diritti ben più solidi, e sanno anche che Artù è affidato a me. Dunque, ritenevano che tu fossi Artù. E io volevo che continuassero a pensarlo, così quando hai cominciato a parlare, ti ho zittito immediatamente. Non ero arrabbiato con te, non lo sono stato neppure per un attimo, ma non volevo che dicessi qualcosa che potesse lasciar loro comprendere che tu non sei Artù. Ora, fa' il bravo ragazzo e vammi a cercare Donuil, giù sulla spiaggia. Digli di venire da me non appena si sarà liberato.» «È già qui, signore.» Il ragazzo indicò l'ingresso della tenda e non appena mi voltai vidi che Donuil si stava avvicinando insieme a Benedetto, Derek e Rufio. «Bene, in questo caso ho un altro compito da darti. Va' a vedere se riesci a trovare qualcosa da mangiare, perché sono ore che non ti vedo muovere le mascelle, e trovo che la cosa sia assolutamente insolita e persino preoccupante.» Arrossì, sorridendo, poiché erano mesi che veniva preso in giro per il suo incredibile appetito. Stava per salutarmi, ma lo fermai. «Dopodiché, quando avrai riacquistato le forze, voglio che ti procuri in fretta una scorta di sei uomini, scegliendoli tra gli esploratori; fatti consegnare le razioni dal furiere e poi torni immediatamente dal legato Filippo. Non c'è alcun bisogno che ammazzi il cavallo mentre corri da lui, ma non perdere neppure tempo. Comunica al legato che ho inviato Huw Fortebraccio a trattare con Uderic, e informalo anche di quanto è accaduto oggi. Digli che ho bisogno di averlo qui, alla massima velocità a cui possono muoversi le sue truppe. Quanto al ritorno, vale quel che ti ho detto per l'andata. Di' con chiarezza a Filippo che non c'è alcuna emergenza. Può tornare indietro a velocità di marcia di addestramento, ma non è necessario che sfinisca uomini e cavalli. Questo è tutto. Ma prima di andare, mangia. Bada bene che questo è un ordine. Adesso va'; spero di vederti entro un paio di giorni o poco più.» Bedwyr mi salutò e si allontanò rapidamente, arrossendo di nuovo, ma questa volta per la consapevolezza della propria responsabilità. Mentre usciva incrociò Donuil e gli altri che stavano entrando: li invitai a trovarsi un posto in cui mettersi a sedere. Donuil si lasciò cadere sulla mia sedia e si tolse immediatamente l'elmo, mentre Benedetto si sistemava sulla cassa di legno in cui erano custodite le mappe. Rufio portò dentro la sedia che era accanto al tavolo, all'esterno, e che io stesso avevo usato poco prima. Derek rimase in piedi vicino all'ingresso della tenda, con le mani strette attorno alla fibbia della cintura; la nuova corazza di cuoio di foggia romana lo faceva sembrare ancora più imponente. «Allora?» chiesi quando tutti si furono sistemati. «Ho preso la decisione giusta?» «Sono pronto a dare per certo che sia così.» Donuil pulì la visiera dell'elmo con un lembo del mantello, poi si asciugò il sudore che gli imperlava la fronte prima di sollevare la testa per lanciarmi un'occhiata incerta. «Ma nessuno di noi ha la minima idea di quale sia stata la tua decisione. Una cosa è sicura: per quel che riguarda i loro padroni non possono avere alcun dubbio circa la tua opinione.» «Bene, è esattamente quello che volevo. Da che parte si sono diretti quando se ne sono andati?» «A ovest, da dove erano arrivati, ma dopo aver dato una ventina di colpi di remo per allontanarsi dalla spiaggia hanno cominciato a muoversi molto velocemente. A quest'ora dovrebbero già volare sulle onde. E adesso che cosa facciamo?» Spostai lo sguardo su Benedetto e poi su Rufio. «Speriamo che Huw Fortebraccio torni presto e nel frattempo decidiamo che cosa intendiamo fare non appena sarà arrivato. Ho ordinato al giovane Bedwyr di partire subito per richiamare Filippo e i suoi dal pattugliamento in cui sono impegnati, dal momento che da quelle parti non c'è più niente da pattugliare.» Feci una pausa. «Ho capito qualcosa là fuori, mentre ascoltavo la diatriba di Retorix: Ironhair non è così abile come crede di essere, e ha uno svantaggio di cui non si rende conto.» Rufio si strinse nelle spalle. «Quale svantaggio?» Esposi loro brevemente che cosa mi era tornato alla mente a proposito della tragedia di chi è bugiardo. Poi, come mi aspettavo, Donuil e Benedetto rimasero a sedere in silenzio, meditando su quanto avevo detto, mentre Rufio scuoteva la testa. «Che c'è che non va, Rufio? Non ti piace la mia storia?» «La storia è bella, Cay, e di per sé non fa una piega, ma tratta i bugiardi come se fossero tutti uguali, invece Ironhair non è un bugiardo come gli altri. La tua teoria ti porta a ritenere che il semplice fatto di essere incapace di credere la verità, e cioè che non ti interessa diventare re della Cambria, lo indebolisca. E allora? Potresti aver ragione, ma odio rischiare la vita su quel "potresti".» «Pensi che le cose stiano diversamente?» «Sì, proprio così. Che Ironhair ti creda o non ti creda, non fa differenza: non cambierà quello che ha in mente di fare. Ironhair vede le cose in modo diverso da noi. Dove noi vediamo bianco, lui vede nero, e neppure se mille uomini giurassero che siamo noi ad avere ragione si convincerebbe di avere torto. Crede alle sue bugie perché nella sua mente contorta sono la verità, l'unica verità che mai abbia conosciuto o che mai conoscerà. Non gliene importa un bel niente di quello che è vero o di quello che è falso per gli altri. La sua verità è tutto quello che conta per lui. Cercherà di ingannarti a ogni pie’ sospinto - te e chiunque altro si metta sulla sua strada - e non perderà certo il sonno per questo, dal momento che in fondo alla sua anima è fermamente convinto di essere al centro dell'universo e che al mondo tutto sia stato creato a suo uso e consumo. Nella sua mente è lui il Signore del Creato e nessuno - né tu, né io, né nessun altro - potrà fargli cambiare idea.» Era forse il discorso più lungo che mai avessi udito da Rufio, e la mancanza di imprecazioni mi colpì e mi lasciò perplesso ancor più della sua insolita eloquenza. Inoltre, nei confronti di Ironhair, tradiva un rispetto di gran lunga maggiore, per ambiguo che fosse, di quello di cui lo avrei creduto capace. Non feci alcun tentativo di controbattere. «Come dici tu stesso, nessuno può influenzare le sue scelte, ma, nella fattispecie, le sue scelte sono tutt'altro che perfette. Per esempio, non sa che ci siamo già messi in contatto con Uderic, per chiedergli di incontrarlo. Ora, quando ci incontreremo, e sarà prima di quanto Ironhair possa immaginare, manderò all'aria tutti i suoi piani. Saremo noi ad allearci con Uderic, e insieme butteremo in mare Ironhair e Carthac.» «Sì, se ci si può fidare di Uderic.» «Perché ti viene in mente di dire una cosa del genere? Quello che intendiamo proporgli sarà nel suo interesse. È ovvio che si comporterà lealmente quando scoprirà che così otterrà quello che vuole e come vuole.» «Se ci crede e se si fida di te. Da quanto ho sentito dire sinora, non è affatto così.» Guardai gli altri, sperando in un appoggio da parte loro, ma tutti continuarono a restare in silenzio. Vedendo che per il momento non avevo altro da aggiungere, Rufio riprese a parlare. «Guarda, Caio, che non sto affatto cercando di dissuaderti. Mi sembra soltanto che in questo caso la tua logica non sia abbastanza rigorosa. Ho soltanto l'impressione che tu stia sottostimando la tortuosità dei suoi ragionamenti.» Le sue parole attirarono la mia attenzione. «Che intendi dire?» «Intendo dire che Ironhair è tutt'altro che stupido, e che in passato ha dato prova di aver commesso ben pochi errori. Supponi solo per un attimo, che ci abbia già pensato. Supponi che, avendo intuito quale sia la strada da percorrere, abbia avuto l'intelligenza di ipotizzare che potresti averla intuita anche tu. Un'alleanza con Uderic. Rifletti. Dunque, avendoci pensato, ed essendosi reso conto che potevi averci pensato anche tu, che cosa avrà deciso di fare? Avvicinarti facendoti un'offerta, come è effettivamente accaduto, pur sapendo che tu, considerandola per quello che era, e cioè un insulto, l'avresti respinta? E poi correre da Uderic alla ricerca di un'alleanza nel momento stesso in cui tu la rifiuti?» Rufio fece una pausa, guardandomi dritto negli occhi, per darmi il tempo di riflettere prima di continuare. «Oppure pensi che potrebbe prima mandare i suoi uomini da Uderic, solo per parlare, proprio come ha fatto con te oggi, facendo una proposta al nemico — una proposta che potrebbe suonare ragionevole e moderata - offrendogli cioè di mettere da parte le divergenze per il tempo necessario a distruggere il nemico comune, cioè noi, ma soprattutto tu, Merlino di Camelot. Uderic potrebbe prenderla in considerazione, non pensi? È da tempo che vede in te una minaccia.» Si interruppe di nuovo, continuando a fissarmi con insistenza. «Ora, se la proposta di Ironhair fosse stata studiata con cura, e prevedesse di parlare a Uderic della visita che avremmo ricevuto oggi, Uderic potrebbe pensare che l'offerta di Ironhair sia per lui doppiamente vantaggiosa: conterrebbe l'offerta di eliminare la minaccia costituita da te, convincendoti a ritirarti pacificamente, senza alcun rischio per lui. In caso contrario, gli offrirebbe il modo per liberarsi definitivamente di te, con il pretesto della tua ambizione e del tuo arrogante rifiuto di ritirarti da una contesa che non ti riguarda. Se ti ritiri adesso, Uderic non si sentirà più minacciato, senza aver perso nulla. Se invece resti, sarai dichiarato un nemico ed egli unirà le sue armate con quelle della Cornovaglia per schiacciarti, riservandosi di fare i conti con Ironhair in un secondo momento.» «Dannazione, Rufio, mi fai sentire stupido!» «Perché? Non ce n'è alcun motivo. Tu e Ironhair siete due persone completamente diverse. Io non sono così legato alle tue idee di onore e nobiltà, perciò posso sforzarmi di ragionare come Ironhair. Ma potrei anche sbagliarmi.» Lo fissai, cercando di leggergli nel pensiero. «Sì, potresti, ma probabilmente hai ragione.» «Forse.» Il suo viso non mostrava alcuna soddisfazione. «Non abbiamo alcuna possibilità di sapere come stiano effettivamente le cose...» «Ma dovremmo fare i nostri piani in base a questo...» Annuì. «Abbiamo bisogno di un piano che possa funzionare in entrambi i casi, e che sia flessibile quanto basta perché, all'occorrenza, possa essere cambiato anche a metà strada.» «Ma tu sei assolutamente convinto che non debba fidarmi di Uderic?» Rufio guardò prima Donuil e poi gli altri, scuotendo la testa; infine si voltò verso di me con uno sguardo ironico. «Non avevi certo bisogno che te lo dicessi io, amico mio. Non è forse così? Ti saresti fidato di lui se io non avessi parlato?» Scossi leggermente la testa. «No, Rufio, non mi sarei fidato, perché di lui non mi sono mai fidato. Non avevo scrutato così a fondo nelle pieghe dei suoi possibili comportamenti, come invece mi hai costretto a fare tu, ma non mi sarei precipitato alla cieca nelle grinfie di Uderic. Adesso però parliamo di quello che potrebbe accadere qui. Credo che, dal momento che Uderic ha sbandierato ai quattro venti quanto poco si fidi di me, insisterà affinché il nostro incontro avvenga in un luogo sicuro per lui, in modo da poter controllare agevolmente la situazione. È anche quasi certo che insisterà perché porti con me pochi uomini. Mi consentirà di avere una scorta, purché sia piccola. Lo so...» Alzai una mano per prevenire le sue proteste. «Questo apre la possibilità di un tradimento. Credo, ciò nondimeno, che le cose andranno così.» Benedetto si schiarì la gola. «Quella nave si è diretta verso ovest a grande velocità. Non mi intendo molto di queste cose, ma ho avuto l'impressione che i rematori non avrebbero potuto mantenere un ritmo del genere per molto tempo, dunque non dovevano essere diretti troppo lontano.» Rufio lo stava osservando, aggrottando la fronte. «Non ti seguo, Ben.» Benedetto fece un sogghigno assai poco divertito. «Sarebbe interessante vedere da quale direzione arriva Huw. Se fosse da ovest, nelle prossime settimane sarei propenso a tenere sempre la cotta di maglia sotto la corazza.» Infine parlò Donuil, per la prima volta da quando si era seduto. «C'è bisogno di formare due gruppi, Cay, uno a cavallo e uno a piedi, armati di archi di Pendragon. Bisogna che ciascun gruppo sia formato almeno da dieci uomini: il primo cavalcherà allo scoperto, il secondo seguirà senza farsi vedere.» Guardai Benedetto. Si strinse nelle spalle e chinò la testa, premendo i palmi delle mani l'uno contro l'altro. «Servono tutti gli uomini che possiamo portare, in entrambi i gruppi, ma non meno di dieci a cavallo. Io cavalcherò con te, e sono d'accordo con Rufio. Penso proprio che andremo incontro al tradimento e all'inganno. Sarà dunque meglio che ci teniamo pronti.» IX. Il fianco della collina che si innalzava di fronte a noi era una vasta distesa spoglia e grigiastra, interrotta qua e là da una leggera spruzzata di verde nei rari punti in cui muschi, licheni e qualche chiazza di erba nana riuscivano a fare debolmente presa sulla nuda roccia. Su questo sfondo monotono, un'unica e irregolare striscia di un verde cupo si stagliava come una cicatrice, quasi a mascherare un profondo burrone scavato dalle acque del torrente che, sgorgando dalla sommità, andava poi a congiungersi con lo stretto fiume che scorreva molto più in basso. Da una parte e dall'altra dell'ampio letto del torrente, profondamente scavato nella roccia nel corso dei millenni e protetto dai venti che spazzavano furiosamente i fianchi della collina, alberi indomabili avevano messo radici ed erano cresciuti fino a riempire completamente la gola, con i loro tronchi antichi e i loro rami contorti completamente rivestiti dello spesso strato di muschio che rendeva il loro aspetto così terribilmente spettrale. Poco oltre la metà del letto del fiume, i raggi luminosi del sole del mattino si riflettevano su una cascatella che sbucava dagli alberi per cadere lungo un breve strapiombo prima di sparire nuovamente nella folta vegetazione sottostante. Mentre osservavo la parete, improvvisamente vidi un uomo sbucare tra il verde, mantenersi in equilibrio per qualche istante sul bordo della cascata e calarsi con precauzione a forza di braccia prima di scomparire di nuovo in mezzo agli alberi. «Con questo fanno cinquanta, e ce ne sono altri in arrivo» borbottò Huw. Gli risposi senza neppure guardarlo: «Cinquantasette». Poi, mentre ne sbucava un altro, impegnato nella stessa, difficile manovra prima di scomparire tra la vegetazione: «E con questo fanno cinquantotto». Erano passati dieci giorni da quando erano giunti gli inviati di Ironhair. In quel momento ci trovavamo sulla sommità di una collina non lontana dalla costa occidentale della Cambria, ben nascosti da una folta distesa di cespugli, e osservavamo il realizzarsi delle profezie di Rufio - profezie che avevano preannunciato tradimento e inganno mentre un'interminabile fila di uomini si calava con estrema cautela lungo il fianco scosceso della collina, dal lato opposto della stretta valle che ci separava da loro. La notte precedente uno degli uomini di Huw Fortebraccio si era intrufolato proprio tra coloro che in quel momento si stavano calando lungo la gola e aveva avuto modo di scoprire molte cose. Erano quasi tutti mercenari di Ironhair, guidati da pochi abitanti della Cambria, e il loro piano prevedeva di risalire la collina dal lato che dava sulla costa per poi calarsi lungo la profonda gola e infine nascondersi sul fondo della valle. Lì avrebbero atteso che noi attraversassimo lo stretto ponte che permetteva di superare la corrente impetuosa del fiume; a quel punto ci avrebbero precluso ogni via di scampo. L'uomo di fiducia di Huw, che si chiamava Gwynn Occhio di Sangue, si era poi dileguato silenziosamente per comunicarci in tutta fretta quanto aveva scoperto, viaggiando per gran parte della notte e raggiungendo il nostro accampamento proprio all'alba. Cosicché quando il primo mercenario aveva cominciato a scalare la sommità della collina che stava di fronte a noi, nel fondovalle non c'era più alcun segno di vita e io me ne stavo ben nascosto con i miei uomini sul fianco della collina, proprio di fronte a loro. Sotto di noi, sul fondo della valle, c'era il fiume, con la stretta striscia di foresta che lo delimitava su entrambi i lati, e il ponte di pietra costruito quattrocento anni prima dalle legioni di Paulino, nel corso della campagna con cui erano stati spazzati via i Druidi di Cambria. Oltre il ponte, l'antica strada che un tempo veniva percorsa dai legionari si dirigeva nuovamente verso nord, seguendo il corso del fiume fino a sbucare in una piana formata dalla convergenza di tre vallate. Altri mercenari, più di trecento, si erano invece nascosti sulla piatta sommità della collina che divideva le due vallate più settentrionali. Avevamo scoperto la loro presenza proprio il giorno prima, anche questa volta grazie alle pattuglie di Huw che, con grande abilità, avevano esplorato le alture. Il piano era chiaro: saremmo dovuti arrivare nella piana seguendo l'antica strada romana che ci avrebbe condotti proprio sotto i pendii dove si nascondevano i nostri assalitori. Una volta che ci avessero attaccati, a noi non sarebbe rimasto che combattere o fuggire, e dovevano essersi messi in mente che avremmo fatto entrambe le cose, dal momento che il loro numero sarebbe stato decisamente superiore al nostro. Coloro che fossero rimasti a combattere, sarebbero morti sul posto, mentre chi avesse preferito fuggire avrebbe trovato la morte per mano del gruppo di rinforzo che era in agguato vicino al ponte. Il loro piano, però, aveva un punto debole: si aspettavano che a cadere nella loro imboscata fossimo in venti o poco più, mentre eravamo in cinquanta e alle nostre spalle erano pronti altri millecinquecento uomini. Devo ammettere che su di me i sospetti di Rufio avevano avuto un effetto salutare. Dal preciso momento in cui aveva espresso con tanta eloquenza i suoi timori e le sue preoccupazioni, tutti i nostri piani erano stati messi a punto in modo da circoscrivere, e possibilmente eliminare, i pericoli che ci aspettavamo di dover affrontare. Richiamato da Bedwyr, Filippo era tornato in fretta e si era dimostrato pienamente d'accordo con l’interpretazione degli eventi proposta da Rufio. Dopodiché, mano a mano che i nostri piani prendevano forma e noi stessi ci familiarizzavamo con la tattica che avevamo deciso di adottare, il nostro obiettivo si faceva più chiaro e anche il modo di affrontare gli eventi diventava via via più incisivo, più sicuro ed efficace. Dopo tre giorni anche Connor era tornato, baldanzoso per il successo della sua razzia ai danni della roccaforte di Ironhair, a Tintagel. In pratica li aveva colti completamente di sorpresa e non aveva incontrato alcuna resistenza, catturando agevolmente due delle sei galee ancorate sotto le fortificazioni di Ironhair e bruciandone altre quattro. Dopodiché, essendosi ormai assicurati il controllo degli accessi al mare, i suoi uomini si erano spinti profondamente nell'entroterra, dove si erano impossessati di grandi quantità di cibo, di bevande e di merci di vario genere, saccheggiando i rifornimenti accumulati nei magazzini della Cornovaglia e destinati alle armate di Ironhair. La sera del loro ritorno anche il nostro esercito, che da quattro mesi andava avanti a razioni da campo, fece gran baldoria, banchettando sulla spiaggia e abbuffandosi con il cibo, il vino, l'idromele e la birra che la flotta di Connor aveva razziato. Quella notte Connor aveva ascoltato il racconto dei nostri sospetti su Ironhair e Uderic, e si era dichiarato pienamente concorde con le nostre valutazioni e con i piani che avevamo elaborato. L'unico suo commento era stato un semplice invito ad agire con determinazione ancora maggiore. Era sua opinione che dovessimo mettere in campo tutte le forze a nostra disposizione. Sostenne che, se avessimo fatto ciò che era opportuno fare, e se lo avessimo fatto con decisione e prontezza, avremmo potuto volgere a nostro vantaggio la difficile situazione in cui ci eravamo venuti a trovare. Per illustrare meglio la sua posizione, impartì a tutti noi una lezione di strategia navale, tracciando un piano di battaglia sulla cenere, proprio accanto al fuoco, e mostrandoci come poteva schierare le sue galee, sistemandole in fila di poppa o di prua, in modo da concentrare il peso maggiore sul punto più debole della formazione nemica. Mentre parlava, osservavo il viso dei comandanti delle mie truppe: una ventina di loro si era infatti avvicinata al fuoco per ascoltare Connor. Tutti quanti, in piedi o seduti, si sporgevano in avanti, attenti e concentrati. Quando ebbe finito, Connor si voltò verso di me e a quel punto gli occhi di tutti si spostarono sulla mia persona, in attesa di quello che avrei risposto. «Dunque, se non vado errato, in vista del possibile scontro mi consigli di trasportare tutte le mie truppe sulle colline e ritieni auspicabile che ci riesca senza farmi vedere? Ho capito bene?» Guardò Derek, sollevando un sopracciglio, poi sogghignò, divertito, con un ampio sorriso che mise in mostra tutta la dentatura. «Perfettamente!» «Magnifico, Connor. Ora dimmi, hai qualche idea circa il modo in cui potrei fare una cosa del genere? So che tra i miei soldati si dice che in gioventù sarei stato una specie di mago, che avrei avuto poteri simili a quelli degli dèi. E so anche che Derek, tanto per citarne uno, è convinto che io abbia facoltà occulte e sovrumane. Purtroppo però, fino a questo momento almeno, non ho ancora trovato il modo di trasportare mille uomini e cinquecento cavalieri senza che nessuno se ne accorga. Tuttavia, a quanto sembra, è proprio questo quello che vorreste che facessi. Ma come? Se tu o Derek, con cui sembri condividere qualche idea molto divertente, poteste suggerirmi un qualsiasi sistema per riuscirci, ve ne sarei immensamente grato.» «Domani» disse, continuando a sorridere. «Domani. Perché proprio domani?» «Huw Fortebraccio potrebbe essere di ritorno.» «Sì, potrebbe, e allora? Il suo ritorno ha qualcosa a che vedere con tutto questo? Come potrebbe aiutarmi a portare il mio esercito attraverso monti e valli senza che nessuno lo veda?» «Potrebbe dipendere dal luogo in cui intendi recarti.» Connor si guardò attorno, ammiccando ancora una volta verso Derek. Tuttavia, quando si voltò di nuovo verso di me, sul suo viso non c'era più alcuna traccia di riso. «Ascolta, Merlino, tu sospetti che Ironhair e Uderic si siano messi d'accordo, non è così? Bene, per agire insieme è necessario che ti affrontino in qualche punto non lontano dal mare, dal momento che Ironhair non se la sentirà di allontanarsi troppo dalle sue navi e dalla sua via di fuga, questo te lo posso assicurare. Quando si hanno i nemici alle spalle, sulla terraferma, è terribilmente allettante sapere che in qualsiasi momento c'è la possibilità di mettersi in salvo su una nave pronta all'ancora! Mi vengono in mente due eventualità. È possibile che si mettano d'accordo per massacrarti, aspettandosi che ti rechi da Uderic nel modo che lui stesso ha indicato, e cioè con pochi uomini fidati. Oppure, può darsi che abbiano deciso di tenderti un'imboscata strada facendo; in questo caso Ironhair ti attaccherà prima che tu abbia raggiunto Uderic, che così potrà evitare di sporcarsi le mani. Comunque sia, non faranno nulla lontano dalla costa. Una volta spintisi in mezzo alle montagne, gole e colline potrebbero giocare tanto a loro favore che a loro sfavore. E dunque cercheranno di fare in modo che tu rimanga vicino alla costa, dove possono sfruttare il terreno a loro vantaggio. Non appena Huw sarà di ritorno sapremo dove e quando. A quel punto potrò caricare i tuoi mille fanti sulle mie navi e sbarcarli sani e salvi dove vorrai, e senza che nessuno se ne accorga, molto prima che tu raggiunga il luogo fissato per l'appuntamento. Era questa l'idea di Derek, e lui stesso verrà con noi, visto che si sente più a suo agio su una galea che su un cavallo. Tu invece ti sposterai via terra con l'intera pattuglia di esploratori, tutti i tuoi cinquecento cavalieri; ma, attenzione! Dovrai andare avanti con trenta o quaranta uomini, non di più, lasciando che gli altri ti seguano al riparo da occhi indiscreti. Gli arcieri di Huw, quanti di loro sono qui?» «Circa duecento, contandoli tutti. Con sé ne ha presi soltanto un centinaio, mentre gli altri sono qui con noi.» «Allora i duecento arcieri di Pendragon, che sono nati e cresciuti da queste parti, potranno stendere un ampio schermo davanti a voi, facendo piazza pulita di qualsiasi sguardo indiscreto. Con loro davanti, a sgombrarvi la strada per un paio di miglia sia di fronte sia sui fianchi, nessuno dovrebbe riuscire ad arrivare tanto vicino a voi da individuare l'armata che vi segue. Ricordati che si aspettano che tu non sospetti di nulla. Secondo loro, ti stai semplicemente recando a incontrare un potenziale alleato per convincerlo delle tue intenzioni amichevoli, e dunque cavalcherai allo scoperto, sicuro del salvacondotto che ti è stato offerto.» Aveva ragione, naturalmente, e decidemmo di seguire i suoi suggerimenti. Huw arrivò il giorno seguente, e fin dal primo istante in cui vidi il suo volto, compresi che non era affatto contento del risultato della sua missione. Lo presi immediatamente da parte e gli chiesi di non dire nulla fino a quando non avessi riunito Connor, Rufio, Benedetto, Derek e Donuil. La sua relazione fu breve e precisa: aveva trovato Uderic non lontano dalla nostra attuale posizione, a ovest, dopo averlo invece cercato a nord. Uderic lo aveva ricevuto con ostilità a mala pena mascherata e aveva ascoltato il mio messaggio con ostentato disprezzo, poi si era palesemente lasciato convincere che incontrarsi con me avrebbe potuto essergli utile. Infine aveva fissato il tempo e il luogo: esattamente dopo sette giorni, sul sito del forte romano di Moridunum, ormai abbandonato. Riconobbi il nome del forte per averlo letto nei diari di mio nonno. Sapevo che si trovava a circa due miglia dal mare, su di un fiume stretto, ma navigabile, e che nella Cambria meridionale era stata la fortificazione romana più occidentale, una delle poche ad aver conservato un'intera guarnigione fino a quando le legioni non erano state ritirate dalla Britannia. Dovevo incontrarmi con Uderic nei pressi dell'antico forte, con una scorta non superiore ai trenta uomini, e Uderic avrebbe provveduto a far sì che potessi attraversare senza pericolo i "suoi" territori. Di fatto, però, nell'accettare l'incontro, Uderic era sembrato a disagio, tradendo un'ambiguità che a Huw era sembrata tanto più preoccupante perché indecifrabile. Nulla di quanto aveva detto o fatto era palesemente falso, eppure Huw aveva avuto la netta impressione che nulla fosse come voleva sembrare. Non appena Fortebraccio ebbe finito il suo rapporto, gli dissi della visita di Retorix e di quanto era poi stato deciso. A quel punto la sua preoccupazione scomparve immediatamente, sostituita come per incanto dal sollievo con cui ascoltò quanto avevo da dirgli. Infine si unì a tutti gli altri nel mettere a punto quello che sarebbe stato il nostro comportamento nei giorni seguenti. Sì, disse a Connor, tra i suoi uomini più fidati ce n'era una ventina originaria della regione in cui sorgeva il vecchio forte di Moridunum; questi sarebbero andati con la flotta per far da guida ai nostri fanti; gli altri invece, un intero contingente di duecentoquaranta arcieri, avrebbero protetto la nostra cavalleria mentre si dirigeva verso ovest, attraverso la Cambria. Il giorno dopo il ritorno di Huw, cavalcai alla testa dei nostri cinquecento esploratori, accompagnato da Donuil e Filippo; sarebbero stati loro a comandare il grosso della nostra cavalleria che ci avrebbe seguito a un paio di miglia di distanza. Huw e i suoi duecentoquaranta arcieri erano invece partiti all'alba, tre ore prima di noi, per avere il tempo di sparpagliarsi e di formare un ampio ventaglio protettivo che si aprisse a semicerchio proprio davanti a noi. Benedetto e Rufio rimasero nell'accampamento insieme alla nostra fanteria: sarebbero partiti il mattino seguente a bordo della flotta di Connor e sarebbero stati sbarcati a poche miglia dalla nostra destinazione, almeno un giorno prima del nostro arrivo. L'ultimo mercenario si calò lungo il burrone proprio di fronte a noi. Quando fu scomparso dalla vista, rimasi in attesa contando fino a cento prima di voltarmi verso Huw, che se ne stava appoggiato al tronco di un albero. «Credo che non ce ne siano più. In tutto ne ho contati settantuno.» Huw borbottò. «Allora devo aver perso il conto, poiché ne ho visti soltanto sessantaquattro. Comunque sia, credo proprio che tu abbia ragione e che siano scesi tutti. A questo punto, il primo deve ormai aver raggiunto il fondo ed essersi nascosto tra gli alberi. Non li vedremo più fino a quando non ci attaccheranno.» «Bene, allora, diamogli qualcosa da attaccare. Quanto ti ci vuole per raggiungere i tuoi uomini là in fondo?» Circa la metà degli arcieri di Huw avevano infatti attraversato il fiume molto prima e ora erano ben nascosti nella foresta che si estendeva a nord. «Meno di mezz'ora per arrivare fin là senza farmi vedere. C'è un burrone anche da questo lato, proprio oltre la collina, sulla destra. Porta direttamente nel punto in cui ho detto ai miei uomini di aspettarmi. A quest'ora dovrebbero avermi già teso una corda attraverso il fiume.» Annuii. «Bene, allora, va' e buona fortuna. Quanto a me, avrò bisogno di mezz'ora per raggiungere i miei uomini e di un'altra mezz'ora per condurli lungo la strada che costeggia il fiume fino al ponte. Una volta che lo avremo attraversato, gli uomini di Uderic si faranno avanti per bloccare il ponte alle nostre spalle e sarà allora che i tuoi arcieri potranno colpirli. Noi andremo avanti finché non avremo raggiunto te e la tua avanguardia, poi attireremo il nemico dritto nella tua trappola.» Mi interruppi, vedendo il suo sguardo preoccupato. «Che cosa c'è che non va?» «E se invece fossero impazienti? Sono molto più numerosi di voi. Che cosa accadrà se vi attaccano, invece di limitarsi a lasciarvi passare per poi impedirvi qualsiasi ritirata?» «Hmm.» Mi strinsi nelle spalle. «Dubito che lo facciano. Sono mercenari. Alcuni hanno archi e frecce, ma la maggior parte è costretta a combattere contro di noi corpo a corpo, con la non piccola differenza che loro sono a piedi, e noi a cavallo e freschi di forze. Non credo proprio che ci sia questa probabilità. Comunque, se le cose andranno così, non ci resterà che sperare che i tuoi arcieri siano abili come sempre e vengano prontamente in nostro aiuto.» Alzai la mano per salutarlo, poi rimasi a osservarlo mentre annuiva prima di voltarsi e scendere lungo la cresta della collina puntando verso il burrone in cui si sarebbe calato. Quando fu scomparso, mi voltai anch'io e mi diressi verso il fianco posteriore della collina, là dove avevo lasciato Germanico, al sicuro oltre la linea dell'orizzonte. Lo scontro fu breve e violento. Attraversai il ponte alla testa dei miei cinquanta cavalieri e nessuno osò attaccarci. Attorno a noi la fitta foresta, appena interrotta dalla gola in cui scorrevano impetuose le acque del piccolo torrente, era silenziosa e apparentemente priva di vita, sebbene sapessi che nascondeva gli uomini di Ironhair e mi sforzassi di scoprirli. Nella fitta boscaglia che si estendeva oltre i cespugli e gli arbusti che crescevano ai margini della strada, nulla si muoveva, e non potei fare a meno di stupirmi per l'abilità con cui quegli uomini riuscivano a mimetizzarsi tra la vegetazione. La nostra cavalleria avanzava rumorosamente, rassegnata all'impossibilità di attutire o di mascherare il rumore metallico delle armi e i fruscii e i cigolii delle selle di cuoio. Al contrario, gli uomini di Ironhair e quelli di Huw si muovevano furtivamente, senza fare il minimo rumore. Sapevo che mentre avanzavamo eravamo spiati da decine di occhi, ma sapevo anche - ed era una consapevolezza molto rassicurante - che coloro che ci spiavano erano del tutto ignari della presenza di un centinaio di arcieri di Huw Fortebraccio, ben nascosti alle loro spalle. Una volta superato l'arco di pietra del ponte, muovendoci in colonne di quattro, continuammo ad avanzare, cavalcando senza forzare e seguendo la strada che piegava verso nord, alla nostra destra, cosicché ben presto non fummo più visibili dal ponte e proseguimmo la nostra cavalcata in mezzo agli alberi che crescevano fitti ai due lati della strada. Mancava meno di un miglio al punto in cui sarebbe avvenuta l'imboscata. Mentre ci avvicinavamo alla fine di quel tratto di strada, poco prima di raggiungere il limite del bosco che impediva la vista della valle che si estendeva davanti a noi, feci segno ai miei uomini di rallentare. Avevo scorto del movimento tra la vegetazione prima di fronte e poi sulla mia destra, e dopo qualche istante Huw Fortebraccio comparve sul ciglio della strada. Nella sinistra impugnava il suo arco lungo, e non appena mi fui fermato cominciò a parlare. «Nessun problema laggiù?» «No, assolutamente nulla. I tuoi uomini sono pronti?» «Sì, tutti ai loro posti. Saremo nelle vicinanze, nascosti soltanto dai cespugli che crescono ai margini della strada. Quando vi attaccheranno, fai indietreggiare i tuoi uomini, lungo la strada, così, non appena vi sarete allontanati, ci faremo avanti noi e i vostri assalitori riceveranno un benvenuto che non si aspettano di certo.» «Bene, Huw. Al momento dell'attacco daremo l'impressione di essere colti dal panico e tra le nostre file scoppierà una gran confusione. Ogni uomo conosce bene la sua parte. In un primo momento ci sparpaglieremo e sembreremo completamente disorganizzati. Alcuni non indietreggeranno lungo la strada, ma ci terremo tutti ben alla larga dalle vostre frecce. Avvisa, però, i tuoi uomini che, non appena sentiranno il mio trombettiere, dovranno fare molta attenzione, perché a quel punto torneremo tutti indietro per darvi man forte: anche i miei uomini hanno bisogno di sporcarsi di sangue. Poi, quando qui sarà tutto tranquillo, faremo dietrofront e torneremo al ponte. Nel frattempo gli altri tuoi uomini dovrebbero essersi sistemati alle spalle dei mercenari di Ironhair e aver fatto piazza pulita.» Osservai i miei cavalieri che, immobili sulle loro selle, in silenzio tenevano gli occhi fissi su di me. «Molto bene, allora, muoviamoci.» Sollevai la mano e ordinai di riprendere la marcia. Avanzammo in buon ordine, procedendo al piccolo galoppo mentre entravamo nella distesa erbosa in cui convergevano le valli, senza dare l'impressione a coloro che ci stavano spiando di stare all'erta o di aspettarci guai di sorta. Proprio di fronte a noi, come a bloccarci la strada, sorgeva la collina che ci era stata descritta da Huw: la sommità piatta e i pendii apparivano deserti e senza vita. Lentamente piegammo alla nostra destra, dirigendoci verso la valle che si apriva a est. Passai parola di cavalcare in ordine sparso, per dare ancor più l'impressione che non ci sentivamo minimamente in pericolo, e continuai ad avanzare. Ma mentre passavamo sotto la collina e il nostro fianco sinistro era pienamente esposto a qualsiasi attacco proveniente dalle alture, nel mio petto potevo sentire crescere la tensione. Improvvisamente sulle alture spuntarono i primi nemici. In realtà erano apparsi anzitempo; una comparsa prematura, dovuta semplicemente a mancanza di disciplina, ma che, qualora non ci fossimo aspettati l'imboscata e fossimo davvero caduti nella loro trappola, ci avrebbe consentito un preavviso sufficiente a metterci in salvo e a sfuggire all'attacco. In ogni caso, il loro entusiasmo mi causò qualche problema, dal momento che a quel punto dovetti fare di tutto per dare l'impressione di non cogliere l'opportunità di fuggire. Feci dunque voltare Germanico e vidi che i miei uomini, consapevoli quanto me dell'errore nemico, si erano messi a correre all'impazzata facendo impennare i cavalli nel tentativo di inscenare una convincente dimostrazione di panico e di indecisione. Intanto, sulla sommità della collina, chiunque fosse al comando ebbe modo di vedere che cosa stava accadendo e gli attaccanti spuntarono ben presto da ogni parte: correvano precipitosamente verso di noi, mentre gli ululati del loro grido di battaglia sconvolgevano la quiete di quel pomeriggio d'estate. Paolo Scorvo, uno dei comandanti più abili e pieni di iniziativa, si staccò dal fondo della colonna, così come era stato deciso, e trascinò dietro di sé un gruppetto di otto uomini, voltando il cavallo leggermente verso monte, davanti alla linea degli attaccanti, e tirandoseli dietro, in basso e a destra, nella direzione in cui stava scappando. Rufo Metello, un'altra delle giovani teste calde che Ambrogio aveva promosso comandante di squadrone, stava galoppando verso nord, guidando un branco disordinato di altri sedici soldati a cavallo lontano dalla zona dell'attacco, verso il lato destro della strada, a una velocità sufficiente a impedire qualsiasi inseguimento. Diedi di sprone a Germanico e lo feci tornare indietro lungo la strada da cui eravamo giunti, poi, gridando, mi precipitai in mezzo ai miei soldati che si affrettarono a raggrupparsi a casaccio alle mie spalle prima di lanciarsi in una fuga disordinata e precipitosa simulando il panico più completo. A quel punto, il grido di guerra che fino a quel momento aveva rimbombato sulle nostre teste si trasformò in un urlo di esultanza non appena i nostri inseguitori ci videro fuggire disordinatamente, mentre la maggior parte di noi si dirigeva verso l'altra trappola che ci era stata tesa poco oltre. Mi rizzai sulle staffe, tenendomi facilmente in equilibrio ora che Germanico aveva ritrovato la sua andatura, e mi volsi per guardarmi alle spalle, scrutando la sommità della collina. Tutti i nostri assalitori ci stavano inseguendo. Il grosso puntava direttamente verso di me, mentre sia da una parte sia dall'altra un piccolo gruppo si era staccato per inseguire i due contingenti minori guidati da Scorvo e Metello. Con la coda dell'occhio feci appena in tempo a intravedere uno sfarfallio che una freccia cadde in mezzo in noi; subito dopo scorsi anche l'arciere, fermo sul fianco della collina. Un rapido sguardo mi fu sufficiente per vedere che il suo arco era corto, il tipo di arco usato comunemente da tutti a eccezione degli arcieri di Pendragon. Poi udii uno schianto e un duplice grido alle mie spalle mentre un cavallo cadeva a terra. Feci voltare bruscamente Germanico a sinistra, tirando brutalmente le redini mentre cercavo di vedere che cosa fosse successo. Uno dei nostri cavalieri giaceva a terra, con la schiena arcuata per il dolore e gridava disperatamente: la sua bocca spalancata sembrava un grande buco oscuro. L'uomo il cui cavallo, con il collo trapassato da una freccia, era disteso poco lontano si sforzava disperatamente di rialzarsi. Spronai Germanico e mi sporsi dalla sella tendendogli una mano per aiutarlo a rimettersi in piedi, ma il malcapitato continuava a gridare: i suoi occhi fissi e spalancati mi guardavano senza vedermi. Dalle condizioni della sua schiena capii che per lui non potevo fare più nulla. Subito dopo avvertii un rapido avvicinarsi di passi. Allungai la mano dietro le spalle e sganciai la spada, poi la snudai rapidamente e appesi il fodero all'anello che pendeva dalla mia cintura. L'arma mi fece un'impressione strana, mi sembrò leggera come una piuma e quasi immateriale, ma sapevo che si trattava di una sensazione che derivava semplicemente dal fatto di averla mai impugnata per combattere contro un nemico vero. Poi udii un respiro affannoso e un'imprecazione. Mi voltai alla mia sinistra, giusto in tempo per scorgere un uomo gigantesco che si slanciava verso di me brandendo la sua corta spada, pronto a uccidere. Non avendo tempo per fare altro, alzai la spada e la lasciai cadere pesantemente su di lui, puntando il piede nella staffa per fare più forza. La lama mancò la testa dell'assalitore, ma raggiunse il suo braccio destro, sollevato per vibrarmi il colpo mortale, e lo tranciò di netto con tanta facilità che quasi non avvertii l'impatto, sebbene gli avessi trapassato l'osso. Gridò e cadde a terra, afferrandosi il moncone prima ancora che il sangue avesse cominciato a sgorgare; tirai le redini per far voltare Germanico fino quasi a farlo impennare, poi diedi immediatamente di sprone non appena i suoi zoccoli anteriori ebbero toccato terra di nuovo. C'era soltanto un altro nemico abbastanza vicino da essere pericoloso, ma Germanico lo travolse calpestandolo. Non appena cominciai a prendere velocità, spingendomi avanti lungo la leggera discesa, altri mercenari si slanciarono verso di me, ma nessuno fu tanto veloce da arrivare a un contatto. Poi un coltello da lancio colpì violentemente la visiera del mio elmo, facendomi piegare la testa all'indietro e intontendomi con il rumore assordante del colpo inatteso. Barcollai e per un attimo dovetti sforzarmi di ritrovare l'equilibrio, lottando contro le mie reazioni istintive. Poi, ripreso il controllo, superai l'ultimo cavaliere, e intravidi gli arcieri di Huw che uscivano allo scoperto, abbandonando la folta macchia in cui si erano nascosti, per schierarsi in ranghi compatti sull'erba bassa che ricopriva il terreno tra la strada e il limite della foresta. Rendendomi conto di aver superato anche l'ultimo arciere, mi fermai immediatamente e mi voltai per osservare la scena. I mercenari che dalla sommità della collina si erano precipitati all'attacco si erano fermati di colpo, mentre coloro che erano in testa si erano ritrovati a non più di dieci o venti passi dal formidabile ostacolo che improvvisamente era apparso davanti a loro: gli arcieri di Huw schierati su tre file, ciascuna formata da una trentina di uomini. Prima ancora di aver avuto modo di rendermi conto esattamente di quanto stava succedendo, la prima fila scagliò le proprie frecce e poi si fece da parte: ogni uomo si spostò alla propria destra. Quindi si fece avanti la seconda fila, con l'arco già teso, e lasciò partire le proprie frecce. Subito dopo anch'essi indietreggiarono per cedere il posto agli arcieri che stavano alle loro spalle e riempire i vuoti lasciati dai compagni della prima fila, che si erano già ritirati di un passo e ora incoccavano le frecce, pronti a farsi di nuovo avanti. Quasi più velocemente di quanto possa descriverlo, quattro nugoli di frecce erano andate a segno, compiendo una vera e propria strage tra gli attaccanti. Poi fu la volta di una quinta scarica che si alzò in volo prima ancora che gli sbalorditi mercenari riuscissero a riprendersi quanto bastava per cercare di mettersi in salvo. In realtà, non avevano alcun posto in cui fuggire e furono sbaragliati rapidamente. Ben presto il terreno fu ricoperto di feriti che si contorcevano negli spasimi dell'agonia e l'aria si riempì di urla e gemiti. Tutti gli uomini che avevano fatto parte del contingente principale erano ormai a terra e la battaglia era finita ovunque tranne che in due punti lontani, alla mia destra e alla mia sinistra. Qui, abbandonata da tempo la messinscena del panico, le tre squadre - formate da otto uomini ciascuna - comandate da Scorvo e Metello stavano impartendo una lezione pratica di arte militare ai malcapitati inseguitori che avevano deciso di mettersi alle loro calcagna. Il trombettiere stava alla mia sinistra, in attesa di un mio segnale, ma gli feci cenno di lasciar perdere: non c'era alcun bisogno dei miei uomini. Pochi istanti dopo scorsi Paolo Scorvo fare cenno ai suoi di dirigersi verso di me, e intanto, forse ancor prima di loro, anche Rufo Metello e i suoi sedici cavalieri avevano preso a galoppare nella mia direzione. A quel punto mi volsi verso Benedetto e gli ordinai di mandare due uomini a cercare - e possibilmente portare soccorso - al soldato che era caduto proprio dietro di me. Lo trovarono in fretta, con la gola tagliata da un orecchio all'altro. Nel frattempo gli uomini di Huw Fortebraccio si erano riuniti davanti a me, ma i loro volti erano stranamente inespressivi, come se la carneficina non avesse procurato loro alcun piacere. Quanto a me, mi accingevo a ricondurre il nostro squadrone al ponte, quando udii un certo trambusto alle mie spalle, mi voltai e vidi che altri tre arcieri di Huw stavano arrivando di corsa: anche nei pressi del ponte il combattimento era ormai finito, e le nostre perdite ammontavano soltanto a quattro uomini. Al contrario, nessuno dei mercenari che si erano calati nel burrone era sopravvissuto allo scontro con gli uomini di Fortebraccio. Non mi restava dunque che ricondurre l'intera compagnia nel punto in cui le due valli convergevano e attendere il grosso delle mie truppe. La prima ad arrivare fu la cavalleria, forte di quattrocentosessanta uomini, lungo la strada che anche noi avevamo appena percorso. Prima che fosse passata mezz'ora, il suono di una tromba annunciò che la nostra fanteria si stava avvicinando, e ben presto comparve anch'essa, marciando nel fondovalle in colonne di dieci, guidata dagli esploratori di Huw Fortebraccio. Secondo i piani prestabiliti, la fanteria proveniva dalla costa dove era giunta a bordo delle galee di Connor. Quando si furono riuniti tutti - cinquecento cavalieri, mille fanti e più di duecento arcieri di Pendragon - salii su un roccione che sporgeva dal fianco della collina e rivolsi loro un breve discorso, illustrando quello che ancora dovevamo fare. Poi, a tappe forzate, li condussi a nord e a est verso il luogo in cui avremmo dovuto incontrare Uderic Pendragon. Quando giungemmo a Moridunum, il "re" non c'era. Era ovvio che la notizia di quanto era accaduto doveva averci preceduto, e dunque trovammo il vecchio forte romano silenzioso e vuoto, sebbene i rifiuti sparsi un po' dovunque e il fumo di numerosi fuochi indicassero chiaramente che un gran numero di uomini era stato lì fino a non molto tempo prima. Senza scendere da cavallo, mandai subito Benedetto e i nostri cinquecento esploratori all'inseguimento di chiunque riuscissero a scovare, poi ordinai agli altri di accamparsi per la notte. Quanto a me, decisi di dare uno sguardo al forte. Era del tutto simile a Mediobogdum, dove avevamo abitato negli ultimi anni, tranne per il fatto che era situato in un fondovalle invece che su un'altura. Per il resto, però, si trattava essenzialmente dello stesso tipo di forte, costruito secondo il progetto classico degli edifici destinati alle coorti, ed era in grado di alloggiare comodamente seicento uomini. Persino le terme, situate oltre le mura, erano paragonabili, anche se non altrettanto confortevoli; le fornaci erano fredde e abbandonate da tempo, con i condotti ostruiti dalla fuliggine e dai detriti di decenni. Tuttavia, a differenza di Mediobogdum che, alto e inaccessibile in mezzo alle montagne, era rimasto pressoché inviolato per più di duecento anni, tutti gli edifici di Moridunum erano stati usati da intrusi e malamente danneggiati tanto che, dopo soli quarant'anni di abbandono, erano in rovina, senza tetto e con i muri cadenti. Terminai il giro accompagnato da Rufio e tornai all'ingresso principale del forte, dove Donuil mi chiamò, invitandomi a dare uno sguardo a qualcosa che aveva appena scoperto. Potei vedere il giovane Bedwyr inginocchiato per terra, con il corpo parzialmente nascosto dallo stipite di pietra, ma non appena mi alzai sulle staffe per saltare giù dalla sella, udii un fischio mortale, inquietante e rapido come il lampo, e con la coda dell'occhio scorsi qualcosa che si muoveva. Quindi, senza che avessi il tempo di reagire, un violento colpo in mezzo alle scapole mi fece volare sopra le orecchie del cavallo e poi cadere a terra privo di sensi. Rinvenni in uno degli edifici in rovina del forte, sotto quel che restava di un tetto incurvato, che partendo dalla facciata si estendeva per circa tre passi prima di lasciare spazio al cielo aperto. Non appena aprii gli occhi per qualche istante la mia visione rimase confusa e annebbiata, poi scorsi Donuil e Rufio, Derek di Ravenglass, Benedetto, Filippo, Paolo Scorvo, Rufo Metello e molti altri, tra cui Huw Fortebraccio. Stavano tutti guardando qualcuno che doveva trovarsi alla mia sinistra, ma in quei primi istanti i loro visi sembravano ondeggiare e dissolversi per poi riprendere forma soltanto di quando in quando. I miei occhi si sforzavano di abituarsi alla luce accecante che riempiva la stanza. Mentre continuavo a restarmene sdraiato, ancora stordito e con le orecchie che mi ronzavano, a poco a poco mi tornò in mente che cosa era accaduto: il violento colpo alla schiena, il rimbombo di qualcosa che batteva contro l'elmo e le orecchie del cavallo che improvvisamente mi apparivano davanti al viso per poi passare oltre. Nessuno mi aveva visto aprire gli occhi e ora udivo il suono delle loro voci, dapprima confuse e impercettibili, poi sempre chiare. Fu Donuil che per primo abbassò lo sguardo verso di me e vide che avevo aperto gli occhi; la sua reazione, il modo in cui pronunciò il mio nome, mise tutti a tacere e li fece avvicinare ancora di più. Lentamente, confusamente, sollevai il braccio per allontanarli, ed essi si scostarono, esitanti e preoccupati. Poi un nuovo volto si chinò su di me, quello di Muzio Quinto, il nostro medico più esperto - e già avanti negli anni — che dopo la morte di Lucano aveva preso il suo posto. Mi appoggiò la mano sulla fronte, costringendomi a restare sdraiato sul pagliericcio, e mi chiese se lo riconoscessi. Con stupore mi accorsi che quando cercai di rispondergli la mia lingua sembrava incapace di articolare qualsiasi parola, allora inghiottii, respirai profondamente più volte e ci riprovai. Questa volta riuscii a parlare. «Sto bene, Quinto» gracchiai, con una voce del tutto dissimile dalla mia. «Che cosa è accaduto? Qualcosa deve avermi colpito. Sono caduto?» Annuì, mentre la preoccupazione sembrava sparire dal suo viso: ormai era evidente che non mi trovavo più in punto di morte. «Sì» rispose. «Sei caduto da cavallo battendo la testa. Sei stato colpito da una freccia di Pendragon.» «Una freccia di Pendragon?» Riflettei per qualche istante. «Allora dovrei essere morto!» «Sì, dovresti proprio esserlo.» Questa era la voce di Derek e potei vedere la preoccupazione sulla sua rude faccia barbuta. «Dovresti essere morto e per due motivi, ma la freccia ha colpito la lama della spada che porti sulla schiena, che a quanto pare è ancora più dura della tua testa.» Scoprii che era stato Donuil a salvarmi la vita poiché, essendosi accorto che c'era del grasso su uno dei cardini delle cerniere che reggevano la grande porta e stupito che fosse ancora lì dopo più di quarant'anni, mi aveva chiamato perché anch'io dessi uno sguardo. Reggendomi sulle staffe per scendere da cavallo e andare da lui, avevo dunque spostato il collo e il bersaglio cui l'arciere stava mirando era stato sostituito dalla parte alta della spada che portavo sulle spalle. Soltanto quella lama, fatta con il metallo della Pietra del Cielo, avrebbe potuto reggere l'urto di una freccia di Pendragon. Una semplice corazza ne sarebbe stata trapassata e io sarei morto all'istante. Invece la freccia aveva colpito la lama esattamente nel centro e nell'impatto era finita in mille pezzi; il colpo tuttavia aveva fatto sì che l'impugnatura della spada andasse a sbattere contro il mio elmo facendomi volare sopra le orecchie del cavallo, cosicché ero caduto a testa avanti sulle pietre del selciato e per più di un'ora ero rimasto privo di conoscenza. Tuttavia, la lama della spada, quando più tardi ebbi modo di esaminarla, non mostrava neppure il più piccolo graffio: soltanto il sottile rivestimento di ferro del fodero appariva ammaccato e rovinato. Un dolore lancinante alla spalla destra mi fece gemere e quando cercai di mettermi a sedere ricaddi disteso, in preda alle vertigini. Quinto si chinò immediatamente su di me, con il viso preoccupato, allungando la mano per tastarmi la fronte, ma l'allontanai. «Non occorre, Quinto, va tutto bene, è solo un capogiro. Aiutami a tirarmi su.» Mi sostenne con il braccio destro e io mi appoggiai a lui. Inspirai profondamente e dopo un po' la stanza smise di girare e potei vedere con chiarezza. Cominciavo a sentirmi meglio e anche la nausea mi stava passando. Dopo un po', mi sentii abbastanza forte da mettermi a sedere reggendomi da solo, senza bisogno di appoggiarmi al braccio di Quinto. Inspirai ancora profondamente, poi guardai il piccolo gruppo che si era raccolto attorno a me e mi osservava con palese preoccupazione, una preoccupazione la cui intensità variava da uno all'altro ma che era evidente sul volto di tutti. «Non sono morto e non intendo morire, dunque qualcuno vuol essere tanto gentile da dirmi chi mi ha colpito?» Parecchie teste si voltarono verso Huw Fortebraccio, che fece un passo avanti, arrossendo leggermente, poi lanciò verso il mio letto un arco lungo di Pendragon che andò a finire proprio in mezzo alle mie gambe. «Owain» grugnì. «L'Uomo delle Grotte.» Owain delle Grotte, il traditore che ci aveva lasciati per unirsi a Ironhair, l'uomo che avevo sospettato di complicità nell'attentato alla vita di Artù. Fissai Huw negli occhi, conoscendo la risposta alla mia domanda prima ancora di averla formulata. «Dov'è adesso?» «È morto. Vorrei poter dire che l'ho ucciso io, ma la mia fu soltanto una delle sette frecce da cui fu colpita la sua carcassa, e Llewellyn gli aveva già tagliato la testa prima ancora che io mi fossi avvicinato.» Huw si interruppe e nessun altro pensò di approfittare della sua esitazione per prendere la parola. «Si era nascosto qui, in una delle torrette di guardia. Sperava di riuscire a colpirti e deve essersi convinto che, pur di farcela, valesse la pena di sacrificare la sua vita, dal momento che non poteva ignorare che una volta che si fosse mostrato non sarebbe più uscito vivo di qui. Ti ha colpito da non più di sessanta passi. Non so come possa averti mancato la prima volta, ma il secondo tiro era diretto esattamente contro il bersaglio. In ogni caso deve essere morto contento, pensando di averti ucciso.» Quell'uomo aveva sacrificato la sua vita solo per uccidere me. Perché? Poi mi tornò alla mente ciò che avevo visto subito prima di essere colpito, e allora compresi. «Dov'è Bedwyr?» Fu Filippo a rispondermi. «È fuori che cerca di riparare il rivestimento del fodero della tua spada. Perché, vuoi che lo faccia chiamare?» Mi lasciai ricadere sul letto, rendendomi conto soltanto in quel momento di quanto mi fossi irrigidito per protestare contro quello che la mia mente mi aveva suggerito. «No, non disturbarlo.» Tornai a fissare Huw. «Non dava la caccia soltanto a me, voleva anche il ragazzo. Era convinto che si trattasse di Artù.» Huw fu l'unico a non unirsi al brusio da cui furono accolte le mie parole. Strizzò gli occhi, poi annuì. «Sì» borbottò. «È ragionevole. Dunque, la prima volta non ti ha affatto mancato. Da quella distanza Owain delle Grotte non avrebbe mai sbagliato un bersaglio grande e facile come te. Il primo colpo era per il ragazzo; ma il ragazzo era inginocchiato per terra, mezzo nascosto dallo stipite, e intento a scrutare nella merda che riempiva il buco, e poi tra lui e Owain c'era della gente che andava avanti e indietro. Il primo colpo è dunque andato a vuoto e ha colpito lo stipite. Ma il secondo è stato per la tua persona, sapendo che, se ti avesse colpito, tutti sarebbero corsi da te e il ragazzo sarebbe diventato un bersaglio scoperto e facile da centrare. Tuttavia non aveva fatto i conti con Llewellyn che, neanche a farlo apposta, guardava nel posto giusto al momento giusto. Un figlio di puttana molto sospettoso, quel Llewellyn il Guercio, non si fida di nessuno e non gli piacciono i posti strani. Non abbassa mai la guardia e con un occhio solo vede molto di più di quanto riesca a vedere la maggior parte della gente che di occhi ne ha due. Ha scorto Owain armeggiare per scagliare la prima freccia, e quando la seconda si era appena alzata in aria, Llewellyn aveva già incoccato la sua, pronto a colpire. Brav'uomo, Llewellyn, per essere un sospettoso, brutto figlio di puttana con un occhio solo.» Sorrisi a Huw, sentendomi di colpo molto stanco. Cercai tuttavia di scrollarmi di dosso la spossatezza, provai a posare i piedi a terra e ad alzarmi in piedi, tenendomi alla sponda del letto. La stanza riprese a ondeggiare, ma poi il capogiro finì e mi sforzai di inspirare profondamente. «Più tardi mandalo da me, ti dispiace? Vorrei ringraziarlo personalmente per avermi salvato la vita.» Huw Fortebraccio fece un fischio di diniego. «Llewellyn? Scordatelo, Caio Merlino. Non ti sarà certo grato se lo ringrazi, e non ti ringrazierà di certo se lo farai sentire in debito nei tuoi confronti per avergli espresso la tua riconoscenza. In realtà, non vorrà doverti ringraziare affatto, e il ringraziamento migliore sarà stare lontano da lui e non dire un bel niente.» Il mio sorriso si allargò in una sorta di sogghigno e scossi la testa. «Questo non posso farlo, amico mio. Mandalo da me, troverò il modo di ringraziarlo, un modo che piaccia anche a lui.» Mi interruppi, chiedendomi come sarei poi riuscito a concretizzare la mia ultima affermazione. «Ti piace, questo Llewellyn e ho anche l'impressione che ti fidi parecchio di lui, o sbaglio?» Huw annuì. «Sì. Come ti ho già detto, l'aspetto non è un granché, è un orrendo, spaventoso figlio di puttana, su questo non c'è alcun dubbio, ma una delle mie sorelle lo ha sposato qualche anno fa, riuscendo a vedere l'uomo che si nasconde sotto il suo viso sfigurato, e ora pensa di essere stata prescelta dagli dèi e che il dio che l'ha scelta sia proprio lui. È molto buono con lei - in tutto e per tutto - e anche nei confronti di chiunque gli stia attorno. A parte la mostruosità del suo viso, non ha un solo difetto. Nessuno è come lui, credimi, è davvero il migliore.» Quando Huw si voltò per andarsene, dopo aver ripreso con sé l'arco di Owain, lo fermai con un gesto della mano. Si trattò di un impulso, poi, altrettanto capricciosamente, cambiai idea. Scossi la testa e lo congedai di nuovo, ma Huw esitava. «Che c'è? Volevi dirmi qualcosa?» «Sì, ma non ha importanza. Owain è morto. Volevo semplicemente dirti che avrei voluto guardarlo un'ultima volta negli occhi, prima che morisse.» Huw annuì ancora, poi sogghignò malignamente. «Beh, negli occhi puoi ancora guardarlo, ma non credo che otterrai una gran risposta. Più tardi ti manderò Llewellyn.» Lo osservai allontanarsi, chiedendomi che cosa avesse voluto dire, poi non ci pensai più e mi rivolsi agli altri. «Donuil, hai notizie di Connor?» «Sta pattugliando la costa con la sua flotta, sperando di intercettare Ironhair a bordo dell'altra grande bireme.» «Filippo?» Filippo interruppe la sua conversazione con Benedetto per voltarsi verso di me e mentre così faceva gli tesi una mano. Mi afferrò il polso e io mi alzai in piedi aggrappandomi a lui e usando la sua robusta corporatura per evitare di finire poco decorosamente sul letto. Non appena fui riuscito a ritrovare l'equilibrio, lasciai il suo braccio. Tuttavia ero costretto a tenere le gambe divaricate e faticavo a reggermi in piedi, anche se a ogni istante sentivo che le forze mi stavano tornando. Poi mi rivolsi a Benedetto, ricordando di avergli dato ordine di partire di buon mattino per cercare di trovare qualche traccia dell'esercito di Uderic. «Benedetto, hai trovato niente?» Borbottò una risposta negativa, e per rafforzarla scosse energicamente la testa. «Abbiamo cercato le loro tracce per circa un'ora, ma il terreno era troppo duro perché fosse possibile seguire una traccia di qualsiasi genere. Una volta arrivati in fondo alla valle, le strade che avrebbero potuto percorrere senza salire sulle colline erano addirittura tre. Pensai che potessero essersi divisi ed essere andati in tre diverse direzioni, ma non ho voluto suddividere le mie forze sulla base di semplici sospetti, così ho deciso di riportare indietro i miei uomini.» Annuii, trovando corretta la sua decisione, e mi rivolsi a Filippo. «Bene, che cosa hai da dirmi di Connor?» Filippo scosse leggermente la testa. «Nulla, in realtà. Non so nulla di più di quanto Donuil non ti abbia già detto. Ma Connor mi ha raccomandato di farti sapere che punterà dritto verso nord, facendo dietrofront di tanto in tanto per assicurarsi che alle sue spalle le acque siano, per usare le sue parole, completamente prive di rifiuti. Comunque si manterrà in prossimità della costa e da ogni galea terranno d'occhio la terraferma. Se tu desiderassi, o avessi bisogno, di incontrarti con lui, le sue vedette staranno all'erta per scoprire tre fuochi uguali che brucino uno accanto all'altro. Quello sarà il segnale per chiamare Connor. Quattro fuochi saranno invece il richiamo per l'intera flotta. In ogni caso, non appena vedranno uno dei due segnali, aspetteranno la prima alta marea e poi toccheranno terra. Connor pensava infatti che tu avessi intenzione di proseguire verso nord, mantenendoti lungo la costa occidentale.» «Bene, sia così.» A quel punto cominciai a tentare un primo, esitante passo, poi riuscii a fare il giro della branda senza aver bisogno di aiuto, mentre tutti mi stavano a guardare. Quando ebbi completato il giro, mi voltai e lo rifeci un'altra volta. «Sto bene» dissi infine. «Non ho nulla che un buon sonno non possa guarire. Volete lasciarmi adesso? Svegliatemi se accade qualcosa. Se arriva qualche messaggero, voglio sentire immediatamente quel che ha da dire. Grazie, signori.» Se ne andarono tutti, tranne Quinto che rimase a guardarmi preoccupato mentre mi sdraiavo sul letto da campo e chiudevo gli occhi. Sembrava che non avesse alcuna intenzione di lasciarmi solo. «Che c'è, Quinto? Che cosa vuoi?» Si schiarì la gola. «Voglio che tu dorma, Caio. Se ti preparassi una pozione, saresti disposto a berla?» Aprii di nuovo gli occhi e lo guardai di traverso, chiedendomi se potevo fidarmi che in lui il soldato prevalesse sul medico. «Sì,» borbottai, «purché tu sia in grado di garantirmi che la tua pozione non mi bloccherà a letto per giorni, e privo di sensi per giunta. Ho bisogno di essere lucido tanto quanto ho bisogno di dormire. Se i miei comandanti hanno necessità di svegliarmi, devo poter essere subito vigile e in grado di fare tutto quello che sia necessario. Puoi assicurarmelo?» «Sì, penso proprio di sì. Un semplice sedativo, che ti aiuti a dormire, è questo che voglio darti. Tre o quattro ore dovrebbero essere sufficienti per smaltirne l'effetto. Dopodiché, dovresti essere di nuovo perfettamente lucido.» «Come sarebbe a dire "dovrei"? Non mi assicuri che sarò?» Si strinse nelle spalle. «Dovresti essere lucido, di più non posso dire. Sono un medico, non un mago.» «Hmm, facciamo così allora e va' a prepararmi la tua disgustosa pozione.» Uscì immediatamente, ma quando fu di ritorno dormivo già profondamente e la pozione rimase inutilizzata sul tavolino pieghevole accanto alla mia branda. X. La pozione di Quinto fu la prima cosa che vidi quando, dopo parecchie ore di sonno profondo, mi svegliai da solo proprio prima del tramonto, sentendomi ormai completamente ristabilito. Qualcuno aveva sistemato una bacinella di cuoio su di un cavalletto proprio accanto alla mia branda, così, non appena mi fui alzato, potei sciacquarmi il viso con l'acqua fredda che versai da un secchio che stava appeso a un treppiedi. Dopodiché uscii per vedere che cosa stesse accadendo. Il forte, affollato al limite della capienza, era in piena attività: i soldati si affaccendavano qua e là, mentre nei prati circostanti erano state rizzate decine e decine di tende di cuoio. Forse a causa dell'incidente di cui ero stato vittima poco prima, il mio odorato sembrava essersi fatto particolarmente acuto e per qualche tempo rimasi con la testa rovesciata all'indietro per cercare di identificare i diversi aromi che riempivano l'aria di quel tardo pomeriggio: l'odore dei cavalli e del letame, che proveniva dall'enorme area sul retro del forte dove erano stati sistemati gli animali; il fumo di centinaia di fuochi di legna e poi il profumo delle carni arrostite e del pane cotto sotto la cenere. Non lontano da me qualcuno stava friggendo del prosciutto salato e affumicato, e da un'altra direzione giungeva di tanto in tanto un gradevole odore di cipolle selvatiche e di aglio. Non appena quella miscela di aromi inconfondibili mi fu entrata nelle narici, mi venne l'acquolina in bocca e di colpo mi accorsi di avere una fame tremenda. Cominciai dunque a guardarmi attorno, cercando la sagoma familiare della grande tenda dei cuochi che, durante le campagne, fungeva da dispensa e cucina. Nel far questo scorsi qualcosa che non avevo ancora notato e mi caddero le braccia per lo stupore non appena mi resi conto che ero passato a pochi passi da quel macabro trofeo senza accorgermi di nulla. Il cadavere di Owain delle Grotte era stato decapitato e la sua testa, conficcata su di una picca, era stata sistemata davanti all'edificio in cui ero stato portato privo di sensi. Era questo quello che aveva cercato di dirmi Huw nel suo modo enigmatico. Ora, però, nel vedere quel viso cereo, con i lunghi baffi e i lisci capelli scuri, la fame mi passò del tutto. Mi avvicinai all'orribile trofeo, lottando con i miei stessi sentimenti. Questa, lo sapevo, era la giustizia di Pendragon, un esempio e un monito per gli altri, eppure quella vista spaventosa provocò in me una forte indignazione. Avrei voluto strappare dalla picca una presenza tanto disgustosa per gettarla il più lontano possibile, ma sapevo anche che l'ultima cosa al mondo che avrei voluto fare era toccarla. Mi immaginavo mentre l'afferravo per i capelli e la facevo roteare sopra alla mia testa prima di scagliarla lontano, spargendo gocce di sangue rappreso. Mi pareva di sentire scivolare tra le dita le ciocche unte. Invece mi limitai a rabbrividire per l'orrore; mi costrinsi non solo a non allontanarmi, ma a osservarla, cercando di ricordare l'uomo cui quella testa era appartenuta. Era stato un guerriero fiero e valoroso, che aveva servito mio cugino Uther onorevolmente e validamente, e durante la guerra di Lot era stato uno dei suoi comandanti più fidati. Soltanto dopo la morte di Uther, per ragioni che sarebbero rimaste per sempre sconosciute, Owain aveva voltato le spalle alla sua carica, alla lealtà che doveva a Pendragon e a Camelot, vendendosi a Ironhair; da quel momento in poi aveva brigato per fare di quell'uomo venuto dal nulla il capo di Pendragon. Per ottenere un simile risultato era arrivato al punto di cospirare per uccidere il figlio di Uther e infine aveva volontariamente dato la propria vita nel tentativo di compiere quel gesto infame. Perché? Che genere di poteri aveva Ironhair se era stato in grado di soggiogare un uomo forte come Owain delle Grotte e indurlo a tradire le Persone cui era stato leale per tutta la vita? Già centinaia di volte mi ero posto quelle domande e non mi ero mai avvicinato alla risposta, proprio come mi accadeva in quel momento. Stranamente, mentre osservavo quella testa senza vita, chiedendomi inutilmente quali pensieri, quali sentimenti e quali desideri avesse ospitato, scoprii che l'orrore stava rapidamente svanendo. Infine, fissando lo sguardo in quegli occhi opachi e senza vita, feci un cenno di saluto mormorando: «Adesso riposa e regola i tuoi conti con Dio». Quando mi voltai per andarmene, un uomo che fino a quel momento era rimasto seduto accanto a uno dei fuochi improvvisati per cucinare, si alzò e cominciò a fissarmi. Il fumo denso mi impediva di vederlo distintamente, ma mi bastò un rapido sguardo perché il suo aspetto insolito mi colpisse. Chiunque fosse, pensai, il suo abbigliamento sembrava fatto apposta per farsi notare. Era di statura media, e aveva un fisico proporzionato e ben fatto, con la vita stretta e spalle ampie e squadrate. Indossava una cappa corta e incredibilmente bella di pelliccia di ermellino bianco, come si presenta durante l'inverno. Un'estremità era gettata all'indietro sulla spalla sinistra, in modo che le punte nere delle code che formavano il bordo esterno finivano per costituire una sorta di lucida striscia nera che andava da un capo all'altro del suo petto. I suoi colori erano il bianco e il nero, messi ancora più in evidenza da vari pendagli e gioielli d'argento. Mi stavo chiedendo chi potesse essere, ma non appena il fumo si diradò, potei vedere il suo viso dai lineamenti orribilmente sfigurati e capii che si trattava di Llewellyn il Guercio. Tagliai corto, guardando direttamente nella sua direzione e sforzandomi di nascondere qualsiasi reazione di fronte alle terribili condizioni del suo viso. Poi voltai leggermente la testa per indicare il macabro trofeo che campeggiava sulla picca, alzando la voce perché potesse sentirmi distintamente. «Questa è opera tua, Llewellyn?» Venne verso di me, camminando lentamente e tenendo in mano una gamba arrostita di non so quale uccello. Quando mi fu accanto, guardò la testa sulla picca e addentò un grosso boccone di carne prima di rispondermi. Vedendolo masticare, la fame tornò a farsi sentire, più forte che mai. Osservò attentamente la testa, come se non avesse mai visto nulla del genere. «Sì» disse infine, parlando con la bocca piena. «È opera mia. Ti dispiace?» Mi accorsi che cominciavo a sorridere. «Tutt'altro, è esattamente quello che si meritava e la tua freccia mi ha salvato la vita. Volevo ringraziarti.» Mi guardò storto, piegando curiosamente la testa per riuscire a fissarmi con l'unico occhio, il destro. «Stronzate» disse in tono sprezzante. «È la tua spada che ti ha salvato la vita, e comunque la freccia seguente sarebbe stata per il ragazzo. Quando ho scagliato la mia credevo che tu fossi già morto. Per di più, l'ho colpito per mia soddisfazione. Era un maledetto figlio di puttana quel traditore, una vergogna per il suo nome e la sua gente.» «Come, e per quale motivo? Forse perché combatteva per Ironhair?» Llewellyn si voltò in modo da guardarmi bene in faccia. «No, perché si era venduto agli stranieri. Era di Pendragon, nato e cresciuto nella terra di Pendragon, un figlio di queste montagne, e ha tradito la sua nascita e la sua gente. Per questo doveva essere ucciso. Non importa quale sia il nome dello straniero, quello che conta è che non si trattava di un uomo di Pendragon.» «Che cosa è capitato al tuo occhio?» Mentre Llewellyn parlava, avevo osservato con attenzione, l'orrore spaventoso del suo viso: la domanda mi era venuta alle labbra prima ancora che mi rendessi conto di essere sul punto di pronunciarla. Si irrigidì di colpo, poi inclinò di nuovo la testa da un lato, guardandomi con l'unico occhio buono e mettendo in evidenza il lato più sfigurato del suo viso mostruoso. «Un incidente» rispose con calma. «È successo quando ero un ragazzo e imparavo il mestiere di fabbro. Stavo fondendo del ferro e il metallo mi è schizzato addosso.» Il solo pensarci mi fece rabbrividire, ma lui continuò come se non si fosse accorto di nulla. «Mi raggiunse nell'occhio sinistro e poi colò sulla guancia e sul naso. Il fabbro mi infilò la testa in una tinozza piena d'acqua pensando che tanto sarei morto. Invece non morii. Così, quando le gocce di ferro si furono raffreddate, me le tolse dal viso... Beh, qualcuna la dovette tagliare via, mi è stato detto, poiché la carne vi si era attaccata, arrostendo... Ma io avevo perso i sensi e dunque non ricordo nulla. Se guardi bene da vicino puoi ancora vedere i punti in cui è schizzato il ferro fuso.» Improvvisamente mi si accostò, inclinando il viso perché potessi esaminare meglio le cicatrici: sapevo che si aspettava che mi ritraessi inorridito, invece guardai. Non c'era che dire, le cicatrici erano chiaramente visibili. Una grossa goccia, simile a una lacrima, era schizzata sullo zigomo sinistro e si era poi estesa anche dentro l'occhio, accecandolo. Il terribile calore, che aveva letteralmente bruciato il bulbo, aveva scavato anche un profondo incavo nella palpebra inferiore. Nel cicatrizzarsi, la tensione dei lembi della ferita aveva deformato la pelle e la carne tirandole verso il basso così da mettere a nudo l'orbita, creando sotto l'occhio un profondo solco che andava a congiungersi con la goccia più grande. Ma sul suo viso erano cadute anche altre tre gocce. La più piccola era finita nell'incavo del naso, proprio sopra la narice sinistra, un'altra aveva colpito la parte esterna del labbro superiore e la terza, grande quasi quanto lo schizzo principale, lo aveva colto tra lo zigomo e l'orecchio, dove aveva scavato un buco profondo prima di colare lungo la mandibola. In seguito, quando le ferite si erano rimarginate, la forma e la profondità delle mutilazioni avevano trasformato il viso dell'uomo in una maschera grottesca e spaventosa. L'intero lato sinistro del suo volto sembrava fatto apposta per spaventare i bambini: un'inquietante orbita vuota campeggiava sopra un intrico di cicatrici che non lasciavano la minima traccia di connotati umani. Al di sopra del contorno della bocca, come per sottolineare maggiormente la spaventosa deformità del suo viso, un buco circolare grande quanto un'unghia metteva allo scoperto il canino e la relativa gengiva. Llewellyn mi osservava attentamente, aspettando che dicessi qualcosa che tradisse la mia repulsione. Ma io non ne provavo affatto. «Sì, hai ragione. Le cicatrici sono ben visibili. Quattro gocce, due piccole, due grandi... una addirittura enorme. Ma almeno ti sono rimasti i denti.» Mi guardò ancora per qualche istante, poi il suo viso si contorse in un grande sogghigno. Finì di masticare il cibo che aveva in bocca, prima di passarsi la lingua su un dente, sul lato destro, e di pulirsi le labbra con il dorso della mano. «Huw mi ha detto che volevi parlarmi. Di che cosa si tratta?» «Te l'ho già detto, volevo farti i miei ringraziamenti, ma Huw mi ha messo in guardia sostenendo che non avresti accettato la mia gratitudine. Lavori ancora il ferro, oppure...» «...quello che mi è successo da ragazzo mi ha fatto cambiare mestiere?» rise, con un unico, fragoroso, scoppio di ilarità. «No, non è andata così e ora faccio il fabbro, tranne quando siamo in guerra. Sono un uomo di Pendragon, prima di tutto e soprattutto, per questo combatto.» «Un fabbro.» «Sì, si potrebbe dire che il ferro è parte di me» rise ancora. «Di certo ha consumato parte di me, ma ora sto più attento, di gran lunga più attento. Sai qualcosa del mestiere di fabbro?» «Più o meno. Quando ero ragazzo, avevo uno zio, lo zio prediletto, che era un maestro nell'arte del forgiare. Si chiamava Publio Varro, e mi ha insegnato qualcosa su come si forgia e si modella il ferro.» Llewellyn si raddrizzò leggermente. «Ne ho sentito parlare. Tu ora possiedi il suo grande arco, non è così?» «Sì, ma come fai a saperlo?» «Huw mi ha parlato di te, e ho visto la fibbia che porta sempre con sé, quella con i segni delle frecce.» Annuii, ricordando con piacere la volta in cui Huw e io avevamo fatto una gara tirando con l'arco. Entrambi avevamo scagliato le nostre frecce, una accanto all'altra, nel minuscolo cerchio all'interno della fibbia che sua moglie gli aveva regalato, centrandolo con tanta precisione che le punte delle frecce avevano lasciato due segni paralleli sul bordo superiore e inferiore dell'anello interno della fibbia d'argento. Huw la portava con lo stesso orgoglio con cui un centurione romano avrebbe esibito la corona sulla propria corazza. Poi un altro pensiero mi passò per la mente. «Dimmi, come facevi a sapere che la seconda freccia di Owain delle Grotte sarebbe stata per il ragazzo?» «Non lo sapevo, non ne avevo la minima idea fino a quando Huw non mi ha raccontato che cosa avevi detto tu stesso.» Allora mi misi a guardarlo fissamente, cercando di studiare l'uomo e di valutarne il carattere. «E ora hai qualche idea sul motivo per cui avrebbe cercato di eliminare il ragazzo, ancor prima di uccidere me?» «Sì, pensava che fosse qualcun altro: Artù Pendragon.» «Hmm, e tu che ne sai di Artù Pendragon?» Llewellyn torse la bocca in quello che avrebbe potuto essere un sorriso, se non avesse messo in mostra il dente che stava sotto il buco nella guancia. «È il figlio di Uther, almeno così dicono. È il figlio che ha avuto dalla moglie di Lot di Cornovaglia, di cui era diventato amante.» Addentò di nuovo la zampa arrostita che teneva ancora in mano e potei sentire distintamente la carne succosa staccarsi dall'osso. «Non è rimasto niente dove hai preso quella zampa?» «Sì, o almeno di carne ce n'era ancora quando mi sono allontanato. Vieni.» Mi accompagnò verso il fuoco, e quando ci accostammo i due uomini che vi sedevano accanto si alzarono. Con un cenno della mano Llewellyn fece le presentazioni. «Gwynn Occhio di Sangue e Daffyd, Merlino di Camelot. Daffyd è il nostro cuoco, migliore di tutti i cuochi che hai portato con te, ci potrei scommettere. Gwynn Occhio di Sangue è qui perché in questo posto è l'unico figlio di puttana ancora più brutto di me! Siediti.» Feci un cenno verso i due uomini, poi mi sedetti su di una pietra, guardando le carcasse ancora intere di due volatili che, infilzati su uno spiedo, continuavano a rosolarsi sul fuoco, mentre il loro grasso colava sui tizzoni, scoppiettando in una miriade di piccole scintille. Su un piatto sistemato accanto ai piedi di Daffyd c'era un grosso mucchio di ossa e una carcassa quasi del tutto spolpata pendeva da un altro spiedo. Non appena mi fui seduto, l'uomo chiamato Gwynn Occhio di Sangue, che in effetti aveva un occhio completamente rosso - una massa informe in cui non era possibile distinguere l'iride o la pupilla - si chinò e mi porse un piatto di legno simile a quello che stava accanto ai piedi di Daffyd. Lo ringraziai e me lo sistemai sulle ginocchia, mentre Llewellyn si accostava al fuoco, prendeva rapidamente uno degli spiedi e faceva scivolare la carcassa del volatile direttamente sul mio piatto. «Mangia» disse. «È anatra, rosolata in grasso di maiale. Ti piacerà. In quel vaso di terracotta c'è del sale.» Tornò ad addentare la sua zampa mentre io cominciavo a mangiare la mia, incurante del calore che mi scottava le dita. Addentai una coscia sgocciolante, bruciandomi le labbra con il grasso bollente, ma quasi non ci feci caso, intento com'ero a gustare il delizioso sapore della carne che mi riempiva la bocca. Per qualche tempo attorno al fuoco la conversazione cessò, almeno fino a quando non ebbi spolpato interamente la carcassa del volatile. Quando ebbi finito e non rimasero che le ossa, le gettai nel fuoco e Llewellyn mi tese uno straccio per pulirmi le mani. «Avevi proprio fame!» «Sì, erano due giorni che non mangiavo davvero. Non mi ero reso conto di quanto fossi affamato finché non sono uscito a dare uno sguardo in giro e ho incontrato te con quella coscia in mano.» «Tieni.» Si chinò e mi porse una brocca di terracotta piena di birra; bevvi abbondantemente. Aveva un sapore assai diverso da qualsiasi bevanda avessi mai avuto modo di assaggiare fino a quel momento. Quando mi fui tolta la sete, posai la brocca e guardai Llewellyn. «Credo proprio di non aver mai bevuto birra migliore in vita mia. In nome di Dio, dove sei riuscito a scovarla?» «Tu sei straniero da queste parti, Merlino di Camelot. Noi abitiamo qui, e quella birra è stata fatta a non più di cinque delle tue miglia romane da dove siamo ora.» Mentre Llewellyn parlava, Gwynn Occhio di Sangue e Daffyd si alzarono, mi fecero un cenno di saluto e si allontanarono in direzioni diverse. Rimaneva un ultimo uccello ancora infilzato sullo spiedo e Daffyd se lo portò via. Mi voltai verso il mio ospite con uno sguardo interrogativo. «Dove sono andati?» «Chi lo sa? Hanno delle cose da fare e sanno che noi abbiamo varie questioni di cui vogliamo discutere. Mi stavi parlando del ragazzo, di Artù, prima che la tua fame facesse passare tutto in secondo piano. Hai esaurito l'argomento?» «No.» Ammiccai verso di lui, sorpreso del modo diretto in cui mi aveva riportato alla conversazione precedente. «Avevi appena finito di indicarmi chi sono i suoi genitori, un particolare che io credevo fosse un segreto. Da dove ti giungono le informazioni?» «Ti riferisci a Uther e alla sua amante? Ma è una cosa che sanno tutti!» «È davvero così, in nome di Cristo? Non lo immaginavo proprio.» «Beh, diciamo che si tratta di voci. Pochi, o forse nessuno, sanno esattamente come siano andate le cose. Quando i nostri uomini sono tornati dalla Cornovaglia, dopo la morte di Uther, hanno raccontato delle sue imprese e del suo amore per quella donna. E hanno anche detto che lei aveva avuto un bambino, di questo erano certi, che poi il padre fosse Uther o fosse Lot, beh, questo era difficile da stabilire. E che fine avesse fatto, la maggior parte della gente lo ignorava del tutto. Poi, però, qualche anno fa, si è ricominciato a parlare del bambino. Qualcuno diceva che si trovava a Camelot, con te, altri sostenevano che eri fuggito da Camelot portando via il ragazzo e che eri andato a vivere in mezzo agli Scoti, dall'altra parte del mare. C'era anche chi affermava che il ragazzo era morto, ucciso nei primi anni di vita. A dire la verità, in quel periodo io non ne sapevo nulla e me ne importava ancor meno, perché ne avevo anche troppo dei guai miei perché mi restasse la voglia di occuparmi di quelli degli altri. Non avevo preso parte alle guerre di Uther poiché pensavo che le sue guerre non fossero affar mio. La mia guerra la dovevo combattere ogni giorno contro chi mi stava attorno, contro la mia stessa gente che aveva paura di me a causa della mia faccia. Poi però, otto o nove anni fa, ho incontrato mia moglie, Martha, e suo fratello Huw e siamo diventati buoni amici. Da allora ho cominciato a capire che le cose non erano proprio come avevo creduto e che per la maggior parte si era trattato di stronzate, frutto di autocommiserazione. Adesso guardo la vita con un occhio diverso, e Huw rispetta me e le mie opinioni. Così, quando mi ha parlato di te e del ragazzo di cui ti prendi cura, e mi ha rivelato la sua probabile identità, ho cercato di trarre le logiche conclusioni. Il ragazzo è il figlio di Uther, non ho forse ragione?» «E se ce l'avessi?» «Se davvero avessi ragione, allora cambierebbe tutto e questa dannata guerra avrebbe uno scopo e un campione. Se ho visto giusto, Artù Pendragon è il legittimo re, destinato a regnare sul trono di suo padre e tutte queste scemenze - tanto Carthac che quell'idiota di Uderic - non hanno nessun senso.» «Perché sarebbero prive di senso?» «Perché il vero re è con te, a Camelot. E gli altri sono semplici impostori! Quello di cui abbiamo bisogno è sbarazzarci di questi falsi pretendenti - di tutti quanti - e riconoscere come nostro re il figlio di Uther Pendragon. È questo, no, il motivo per cui sei venuto in Cambria? Per salvaguardare gli interessi del ragazzo!» Mi schiarii la voce. «Sì e no. Artù è ancora troppo giovane.» Avevo ormai deciso, e a dire la verità, lo avevo deciso in quel preciso momento, di fidarmi pienamente di Iiewellyn. «Ma c'è dell'altro. Come figlio di sua madre, può accampare diritti anche sulla Cornovaglia. È questo il motivo principale per cui Ironhair lo vuole morto. E non basta ancora. Dal momento che sua madre era la figlia di Athol Mac Iain, un tempo re degli Scoti dell'Eire, il giovane Artù può aspirare anche a quel regno. Contemporaneamente però è l'erede di Camelot, bada bene, l'erede, non il re, poiché Camelot non avrà mai un re. Ma comunque sia, il bisnonno di Artù era Publio Varro, quello dell'arco, e il prozio era Caio Britannico, il fondatore di Camelot.» Non appena ebbi finito di parlare, Llewellyn scosse lentamente la testa. «Troppe cose, Merlino di Camelot, e troppo pericolose. Perché hai raccontato tutto questo a me, uno straniero che fino a oggi non avevi mai incontrato?» «Perché Huw Fortebraccio si fida di te, e anch'io mi fido, ora che ti ho parlato e so come la pensi. Ho capito che sei fermamente convinto che il ragazzo abbia diritto al trono di Pendragon. Gli darai il tuo aiuto?» «Certamente. L'ho appena detto, non è forse così?» «Gli darai il tuo aiuto, ora?» Llewellyn aggrottò la fronte. «Ora? Come posso farlo? Lui non è qui, e poi tu stesso hai detto che è troppo giovane.» «Non ho detto che è troppo giovane, ho detto solo che non è ancora abbastanza grande. Ha sedici anni, o meglio il suo prossimo compleanno sarà il sedicesimo. Ma in questo momento quello che gli serve è un maestro, e credo che tu potresti insegnargli quanto ha bisogno di imparare. Vuoi diventare il suo maestro?» Si ritrasse, pieno di stupore. «Un maestro? Io? Al ragazzo basterà vedere la mia faccia per spaventarsi e scappare via. E poi, non so nulla che valga la pena di essere insegnato.» «Tu non conosci il ragazzo, Llewellyn. Vedendoti non farà una piega. E quanto al fatto che tu non conosca nulla che valga la pena di essere insegnato, mi permetto di avere dei dubbi. Artù è un Pendragon di Cambria, come te, ma non conosce nulla né del paese né della sua gente. Parla la lingua di Pendragon, ma non sa nulla di chi vi abita. Diventerà un guerriero valoroso, di questo non dubito, tuttavia si intende soltanto di cavalleria e di cavalli, di spade, lance e mazze. È un ragazzo forte e robusto, ma non è ancora un arciere, e ignora come si combatte tra le montagne. Vorrei che potesse imparare tutto questo. Qui nessuno conosce Artù, è questo il motivo per cui Owain delle Grotte ha cercato di uccidere Bedwyr. Ma se a portarlo da queste parti sono io, tutti sapranno esattamente chi è, per il semplice motivo che sta con me. Al contrario, vorrei che tu tornassi con me a Camelot, per incontrare il ragazzo e portarlo via con te, perché possa vivere un anno tra la gente del tuo clan e imparare a essere il Pendragon che deve diventare. Vuoi fare questo per me? Per lui?» «Per tutti noi.» Poi rimase in silenzio, a lungo, e quando ricominciò a parlare lo fece con enfasi. «Sì, lo farò. Sarà il mio apprendista. Imparerà a lavorare i metalli, ma farò anche in modo che la gente lo conosca. Gli insegnerò tutto quello che deve sapere: cacciare, tirare con l'arco e vivere delle risorse che il paese offre. Quando partiamo?» Risi. «Non prima di aver sistemato Ironhair, Carthac e persino Uderic. Non possiamo partire anzitempo.» Llewellyn borbottò. «Bah, per loro la fine è già cominciata, è bastato semplicemente che tu arrivassi in Cambria. E poi quella imboscata non resterà impunita. Non aveva nulla a che vedere né con l'onore né con il coraggio, ed è la prova più lampante che Uderic ha cominciato a mettersi d'accordo con gli invasori. Per altro, anche in passato aveva fatto ben poco per rendersi gradito alla gente di Pendragon, e negli ultimi quattro mesi la sua musica non è piaciuta affatto. Quest'ultimo tradimento lo ucciderà, o quanto meno ucciderà tutti i suoi progetti. Ascolta bene le mie parole, Merlino di Camelot: entro un mese, avrai al tuo comando tanti arcieri di Pendragon quanti sono ora i tuoi cavalieri, e questo eliminerà una volta per tutte Carthac e l'immondizia che lo segue. Ogni arrivo nel tuo accampamento di un nuovo arciere di Pendragon sarà un passo avanti nell'unificazione di Pendragon sotto un unico capo. Certo, quel capo non sarà di Pendragon - questo è vero - dal momento che anche tu sei nominalmente uno straniero, ma almeno seguiremo un capo a cui stanno a cuore gli interessi del nostro popolo.» «E Huw?» Ancora una volta assunse quella curiosa immobilità che già avevo notato in lui. Poi però mosse la testa per guardarmi con attenzione. «Che cosa c'entra Huw?» Non avevo una risposta, eppure sentivo che il mio ragionamento era giusto e dunque continuai. «Non so. Sto soltanto meditando ad alta voce. Come hai detto giustamente, sono uno straniero, per di più non ho alcun desiderio di diventare il capo di Pendragon. Eppure, perché possano unirsi, gli uomini di Pendragon devono avere un capo. In questo momento mi sta venendo in mente che Huw Fortebraccio potrebbe essere la guida di cui hanno bisogno. Non è forse una specie di capo tra la vostra gente? So che la sua famiglia era padrona di terre a sud di qui, lungo la costa. È stato lui che ha affittato dei terreni a Liam il Gobbo perché vi pascolasse i suoi animali, e ricordo che una volta mi disse che la sua famiglia era Padrona di queste terre già molto prima dell'arrivo dei Romani.» Llewellyn sbuffò, poi annuì chinando leggermente la testa. «Questo è vero. Huw è uno dei nostri capi più autorevoli, se ragioni in termini di diritto a esercitare il comando. Come hai detto tu stesso, i suoi antenati possono essere annoverati tra i nostri capi ragguardevoli e più abili, fin da quando i Romani non erano ancora comparsi. Ma Huw non aspira a diventare re. Tutto quello che gli sta a cuore è la pace e la possibilità di vivere serenamente con la sua famiglia.» «Ma sono anni ormai che è in guerra! Qual è l'ultima volta che ha trascorso un po' di tempo a casa?» «Molti anni fa...» Llewellyn contorse di nuovo il viso, in quello che avevo ormai imparato a riconoscere come un sorriso ironico. «Che cosa intendi dire, Merlino di Camelot? Sputalo in fretta.» «Intendo dire che per Huw Fortebraccio il modo più rapido per tornarsene a casa e viverci in pace potrebbe essere assumersi il fardello del comando, non sei d'accordo? Lui è un uomo d'onore...» «Stronzate! Non puoi continuare a far conto sull'onore. È un concetto romano, noi non ne abbiamo alcun bisogno. Tuttavia hai ragione quando dici che Huw Fortebraccio gode di molta stima tra la sua gente. Questo è certo, e non è una posizione facile da raggiungere.» «Bene, allora, dovremmo convincerlo che tocca a lui aiutarci a far finire al più presto questa guerra. Se lui dovesse farsi avanti, la gente lo seguirebbe?» «Sì, ne sono certo. Ma lui vorrà farlo? Questo è quello che non so...» si interruppe, riflettendo, poi continuò. «Facciamo un passo indietro, torniamo a quello che stavamo dicendo poco fa a proposito del giovane Pendragon, del tuo Artù.» «A proposito di che?» «Di suo padre, innanzitutto. Tra la nostra gente, Huw era il miglior amico di Uther, lo sapevi?» mi limitai ad annuire e Llewellyn riprese subito. «Bene, ma c'era anche qualcosa di più. Uther era il legittimo re di Huw. L'uno e l'altro lo avevano ben chiaro in mente. Huw era un uomo di Uther, fino alla morte, e lo era sempre stato. Questo è il motivo per cui non ha mai avuto il minimo desiderio di regnare su Pendragon: con la morte di Uther, è morta la regalità stessa e, quanto a se stesso, Huw non ha mai pensato in termini di regalità. Prima di tutto e soprattutto, lui sente di essere un uomo del re, non un re: questo è quello che lui si sente. Se Uther gli avesse affidato un compito, quel compito sarebbe diventato la vita stessa di Huw, finché non lo avesse portato a termine.» Tacque di nuovo, e io attesi. «Dunque, mi sembra che a questo punto Huw potrebbe farsi avanti e combattere per sostenere il ragazzo, il figlio del vero re. Che ne pensi?» «Penso che dovremmo chiederglielo subito, finché vediamo le cose con questa chiarezza. Dove potrebbe essere?» «Ovunque sia, non sarà di certo lontano da qui.» Llewellyn si alzò. «Andrò a cercarlo e lo porterò qui. Aspettami.» Non appena quell'uomo enigmatico se ne fu andato, rimasi solo, ripensando a tutto quello che era accaduto nell'ultima ora. Cominciava a far buio, tanto che riuscivo a stento a vedere oltre il fuoco; così gettai nuova legna sui tizzoni che ancora brillavano nell'improvvisato focolare che mi stava davanti. Ma quando Llewellyn fu di ritorno in compagnia di Huw Fortebraccio, quella legna si era già consumata per una buona metà. Dal viso di Huw, capii subito che Llewellyn non gli aveva detto il motivo per cui lo aveva portato da me. Mi ci volle più di un'ora per spiegarglielo, e in quel lasso di tempo molti dei miei uomini vennero a cercarmi e furono invariabilmente mandati via senza neppure essere ascoltati. Alla fine Huw aveva accettato la mia proposta, appoggiata con fermezza e convinzione da Llewellyn. Disse che sarebbe stato il punto di riferimento di quelli tra la sua gente che avessero voluto raccogliersi attorno a lui sebbene la sua modestia fosse tale da fargli nutrire seri dubbi su una simile eventualità - e avrebbe preparato la strada e la gente di Cambria all'avvento del nuovo re, l'unico figlio di Uther: Artù Pendragon. Nel sentire quelle parole dovetti mordermi con forza il labbro, perché improvvisamente mi tornò alla mente quanto mi aveva riferito Ambrogio circa l'esistenza di un altro figlio di Uther, il primogenito, nascosto non si sa dove ma pronto a farsi avanti al momento giusto. Tuttavia cacciai quel pensiero e giurai a Huw che, se fosse stato fedele a questa causa come lo era stato a Uther, da parte mia avrei appoggiato il suo sforzo di porre fine a questa guerra con tutte le truppe che Camelot poteva mettere in campo. Così fu fatto l'accordo. Alla metà del pomeriggio del giorno seguente, nel campo non restava un solo celta di Pendragon. Infatti, Llewellyn e Huw si erano immediatamente messi all'opera e per tutta la mattina gli uomini di Pendragon non avevano fatto che riunirsi in piccoli gruppi qua e là per il campo, per poi suddividersi, spargere la voce, e raggrupparsi di nuovo in assembramenti più cospicui. Per mezzogiorno erano quasi in trecento a essersi riuniti per manifestare rumorosamente il loro appoggio a Huw Fortebraccio. Huw aveva allora pronunciato un breve discorso, che era stato ascoltato anche da molti dei miei cavalieri, incuriositi e attratti da tutto quel febbrile andirivieni. Poco dopo il rumoroso e variopinto popolo celta aveva cominciato a dividersi, sparpagliandosi in mille direzioni perché ogni villaggio e ogni capanna dell'intero territorio di Pendragon sapessero della perfidia di Uderic e della chiamata alle armi di Huw Fortebraccio. Per quanto il loro numero fosse stato esiguo, la loro partenza lasciò un certo vuoto nel nostro accampamento che divenne improvvisamente assai più tranquillo e silenzioso. Per tenere occupati i miei uomini e sfruttare le energie messe in moto dagli avvenimenti del mattino, ordinai loro di riparare e rafforzare le antiche mura. Infatti, era ormai evidente che ci saremmo fermati in quel forte per due settimane o magari anche più a lungo, in attesa del ritorno di Huw e di Llewellyn, e c'era bisogno di molto lavoro per ovviare a quarant'anni di abbandono e far sì che la postazione tornasse a essere una roccaforte accettabile e difendibile. Ai lavori di ripristino decisi di prendere parte anch'io e mi misi all'opera indossando la sola tunica, lieto di quel rude esercizio fisico che mi costringeva a sudare in mezzo ai miei uomini: passavo pesanti blocchi di pietra dall'uomo che mi stava alle spalle a quello che si trovava davanti, in una lunga catena che terminava dove un gruppo di muratori era impegnato a riparare un tratto di mura. Quando Derek e Benedetto vennero a chiamarmi stavo faticando da più di un'ora e dunque non provai alcun rimorso ad abbandonare la catena per seguirli, asciugandomi il sudore dalle spalle, dal collo e dal viso con uno straccio ruvido. Erano arrivati dei messaggeri, mi disse Benedetto, inviati da Terzio Lucca, che era accampato presso i porti di Caerdyff e Caerwent sulla costa meridionale della Cambria, alle nostre spalle e verso est. Lucca mi informava che erano in arrivo cospicui rifornimenti da Camelot: sarebbero giunti direttamente a lui, a Caerdyff, da dove li avrebbe poi dirottati verso di noi. Nelle ultime sei settimane le sue truppe non erano state impegnate in nessuno scontro e Lucca era giunto alla conclusione che i comandanti di Ironhair si fossero rassegnati alla perdita dei porti sudorientali e non avessero più alcuna intenzione di cercare di riprenderli. Avevano imparato la lezione, affermava Lucca, solo dopo aver subito pesanti perdite in tutta una serie di furiosi attacchi in cui non erano mancati tentativi di sbarco, invariabilmente falliti, a est e a ovest delle nostre posizioni, nella vana speranza di circondare la nostra guarnigione. Per questo motivo, aveva finito con il pensare che parte dei suoi uomini sarebbero stati impiegati in modo più utile nel nostro campo, invece di restare lì ad annoiarsi, bloccati in una guarnigione che non si sentiva per nulla minacciata. Avrebbe potuto lasciare sul posto un contingente, magari un terzo dei tremila uomini di cui disponeva al momento, a occupare, pattugliare e difendere i porti della costa sudorientale. I restanti duemila avrebbero potuto trasferirsi da noi, viaggiando in compagnia del convoglio di rifornimenti. Se io fossi stato d'accordo, aggiungeva, i rinforzi sarebbero arrivati in pochi giorni. Ringraziai i messaggeri e li congedai, prima ancora di consultarmi con i miei comandanti. Tutti avevano delle riserve, e anch'io ne avevo. La verità era che, data la nostra attuale situazione in cui da mesi non avevamo avuto alcun contatto con il nemico, a eccezione dell'imboscata tesaci dal nostro presunto alleato Uderic, non c'era alcun bisogno di altri uomini. Fino a quando non fossimo stati pronti a rimetterci in marcia, eventuali rinforzi avrebbero semplicemente rappresentato altre bocche da nutrire. Benedetto, taciturno come sempre, fu l'unico a restarsene in silenzio per tutta la discussione tanto che dovetti chiedergli a bruciapelo che cosa avesse in mente. Mi rispose chiedendomi quali fossero i miei piani in vista del ritorno di Huw e Llewellyn e quanti uomini mi aspettassi che portassero con sé. Naturalmente aveva messo il dito direttamente nella piaga, costringendomi ad ammettere che non ero in grado di dare una risposta a nessuna delle sue domande, dal momento che la prima dipendeva dalla seconda. Da parte mia, feci notare che ero riluttante a impegnarmi e a mettere a punto un piano d'azione, per il semplice motivo che lo stesso Huw aveva forti dubbi sul fatto che la sua gente fosse disposta a seguirlo. Le sue parole scatenarono vivaci commenti, ma fu lo stesso Benedetto a metterli a tacere sollevando imperiosamente la mano. Un gesto tanto insolito in lui richiamò immediatamente l'attenzione. Benedetto si voltò allora verso di me, strizzando gli occhi per ripararsi dalla luce del sole, poi si guardò attorno fissando uno a uno tutti i presenti. «Neanche a parlarne» disse, alzando la voce. «Semplicemente assurdo.» Alzò bellicosamente la mascella, come se si aspettasse di essere sfidato. «Mi conoscete tutti, e sapete che non mi piacciono le congetture e non amo fare previsioni. Ma ne farò una adesso e se ci penserete bene, dovrete ammettere che ho ragione.» Si voltò di nuovo verso di me. «Prima della fine dell'anno, Huw Fortebraccio sarà a capo di tutta la Cambria, e senza alcuna opposizione. Per arrivare a questo, nessuno è più adatto di lui che, per altro, è perfettamente all'altezza della situazione. Se Ironhair è qui insieme a Carthac è perché fino a ora non c'è stata la volontà di cacciarli ed è mancata l'organizzazione. Noi abbiamo l'organizzazione, è vero, ma non possiamo raggiungere i suoi conterranei in cima alle colline e tanto meno possiamo combattere al loro posto. Per di più siamo stranieri né più e né meno di quei due, e dunque sospetti. A Pendragon ci sono troppi capi, piccoli o meno piccoli, ciascuno con la propria banda che si ritiene un esercito; ciascuno combatte per sé, per il suo interesse, per la sua piccola ambizione. Fortebraccio non è niente di tutto questo, e se si fosse fatto avanti prima, adesso sarebbe già a capo di tutto il territorio. Ma ora è arrivato il momento; adesso la gente di Pendragon lo seguirà ovunque decida di condurla, ed egli la condurrà alla vittoria prima di chiunque altro. Per questo sono certo che tornerà, e presto, e che porterà con sé migliaia di uomini. E dunque è meglio che ci prepariamo, in modo da essere pronti a partire non appena sarà arrivato, facendo da piattaforma alla sua catapulta. Questo è quanto avevo da dire.» Mentre rumoroso boato di Benedetto piacere. ancora stava parlando, Derek lo aveva interrotto con un grugnito di approvazione che si era trasformato in un acclamazioni non appena gli altri si unirono a lui. si guardò attorno quasi minacciosamente, arrossendo di Lo afferrai bonariamente per le spalle. «Hai assolutamente ragione, Benedetto. Dobbiamo tenerci pronti per il ritorno di Huw, in forma e pronti a metterci in marcia.» Mi voltai verso Filippo. «Non appena i messaggeri di Lucca si saranno riposati, ordina loro di ripartire immediatamente e di comunicare al loro comandante la mia piena approvazione del suo piano. Dovrà affidare il comando della guarnigione che presidierà i porti a un subordinato di sua fiducia e portare qui personalmente gli altri duemila uomini insieme al convoglio dei rifornimenti e a tutte le razioni extra e le vettovaglie che riuscirà a trovare.» Mi alzai e raddrizzai le spalle. «Bene allora, amici miei. Continueremo esattamente come ora, dal momento che non possiamo fare molto finché non saranno arrivati gli altri. Tuttavia, voglio che i nostri uomini siano in gran forma quando ce ne andremo di qui. Potrà passare una settimana o dovranno forse passarne ancora molte, ma nel frattempo desidero che le truppe riprendano ad allenarsi seriamente. Temo che i mesi di inattività ci abbiano impigriti tutti, ma da questo momento in poi voglio che sia ben chiaro che non c'è più posto per la pigrizia. Questo è tutto.» Li lasciai e andai in cerca di acqua calda, rimpiangendo una volta di più che le terme fossero irreparabili. Terzio Lucca arrivò prima della fine della settimana, a capo di un imponente convoglio di carri pieni fino a scoppiare di armi, fornimenti e provviste di vario genere. Il giorno del suo arrivo fu dedicato interamente alla sistemazione dei suoi duemila uomini e l’inventario di quanto aveva portato con sé. Poi, il mattino seguente, poco prima di mezzogiorno, dall'avamposto più settentrionale un messaggero arrivò di gran carriera per avvisarci che una forza non identificata, ma che superava i duemila uomini, stava puntando verso di noi da nord e da ovest. Pur sperando che Huw avesse avuto successo nel raccogliere la sua gente, mi sembrava troppo presto perché gli fosse stato possibile mettere insieme un esercito di quelle proporzioni, anche contando su tutta la sua determinazione. Feci dunque suonare l'allarme generale. Ma prima ancora che le trombe fossero tornate silenziose, giunse un secondo messaggero con la notizia che l'armata in arrivo era stata identificata e che proveniva da Pendragon. Stupito, ma lieto, approfittai dell'agitazione suscitata dall'allarme e cavalcai verso nord alla testa di cinquecento cavalieri per salutare Huw in quel suo trionfale ritorno. Trovai invece Llewellyn, che marciava alla testa dei suoi uomini nel suo nuovo ruolo di comandante, e pur rallegrandomi di vederlo mi chiesi che fosse accaduto a Huw. Llewellyn venne direttamente verso di me e prese le briglie del mio cavallo. Huw era ancora nel nord, mi disse, e in questo momento si stava dirigendo verso le roccaforti di Pendragon, nell'est e nel sud-est della Cambria, ingrossando di giorno in giorno le sue fila. Aveva deciso di inviarmi quei primi duemila uomini perché potessi cominciare a spostarmi verso nord, penetrando tra le montagne al centro del paese, dove Carthac stava seminando il panico con continue incursioni alla testa delle sue bande di mercenari. Sperava che sarei stato disposto a usare le mie truppe, schierandole come mura mobili sul fondo delle valli montane, in modo da distruggere quel che restava dei mercenari di Ironhair, obbligati a scendere dalle alture dagli arcieri di Pendragon. Sorrisi, lieto di udire come il messaggio di Huw prevedesse lo stesso stratagemma proposto da Benedetto una settimana prima. Inoltre avevo modo di apprezzare i cambiamenti che la nuova grande responsabilità aveva operato in Huw Fortebraccio: era partito come un subordinato e un alleato, ora invece, dopo meno di due settimane, si rivolgeva a me come a un suo pari, forse persino come a un subalterno, passandomi tramite un suo comandante ordini a malapena mascherati da richieste. Ma questo non mi dispiaceva affatto. Huw mi aveva mandato duemila uomini per dimostrarmi concretamente la sua buona fede e ne stava raccogliendo altri. Era il loro numero a sorprendermi e chiesi a Llewellyn quanti uomini potesse mettere in campo Pendragon. «In totale? Direi più di diecimila in età da combattere.» «Buon Dio! Non credevo che potessero essere così tanti. Pensavo che al massimo si potessero prevedere cinquemila uomini; mi sembra proprio che mio cugino Uther ne comandasse cinquemila, non di più.» «Quando? Durante la guerra di Lot? Ma era molto tempo fa! Siamo un popolo numeroso, Caio Merlino, e prima di tutto siamo contadini. È vero che le nostre fattorie sono piccole, e non sono né fertili né ricche quanto le vostre nel sud, ma richiedono cure maggiori, proprio perché non sono altrettanto fertili. Cinquemila uomini sono stati quelli messi in campo da tuo cugino negli ultimi anni della guerra di Cornovaglia, ma non dimenticare che ne lasciò sempre un numero cospicuo a coltivare i campi della Cambria. Abbiamo perduto troppi uomini allora. L'ultima battaglia ci è costata cara, ma ora ci siamo ripresi. E questa guerra si combatte qui, sulla nostra terra e sui nostri campi. Questa volta vinceremo in fretta, con Huw che ci guida e con il tuo aiuto, e ogni uomo di Cambria farà la sua parte. Huw ci porterà altri cinquemila arcieri, suppongo, e altri ancora verranno in seguito.» Ero ancora allibito e per qualche istante rimasi in silenzio, guardandomi attorno, prima di voltarmi di nuovo verso di lui. «Torniamo all'accampamento. Cavalcherai con me, se ti procuro un cavallo?» Llewellyn mi guardò sogghignando. «Sì, volentieri, ma farai scendere da cavallo uno dei tuoi uomini per far montare in sella me?» Mi voltai verso Bedwyr, che era rimasto in ascolto, e stava già smontando. Una volta a terra, offrì le sue redini a Llewellyn che le accettò con un cenno di ringraziamento prima di issarsi agevolmente in groppa al cavallo. Bedwyr si aggrappò al braccio sano di Rufio e salì in sella dietro di lui. Mi stupii dell'abilità con cui Llewellyn era montato in sella, una sorpresa che dovette leggere sul mio viso. Mi disse infatti: «Rufio mi ha insegnato a cavalcare. Imparo in fretta io». «Sembra proprio di sì.» Diedi di sprone a Germanico, mentre Llewellyn cavalcava alla mia sinistra, per tornare con me all'accampamento. E intanto ripresi la conversazione che avevamo interrotto. «Altri cinquemila? Mi chiedo proprio quale sarà la reazione di Uderic!» Llewellyn si voltò verso di me, ma senza guardarmi, continuando anzi a tenere la testa bassa, con l'unico occhio fisso sulle orecchie di Germanico, o almeno così mi sembrava. «Uderic? Oh, non reagirà affatto. È morto.» A quel punto mi guardò bene in faccia per godersi il mio stupore, senza abbandonare il suo consueto sogghigno ironico. «Uderic ha avuto delle grosse difficoltà non appena abbiamo sparso la voce del suo accordo con Ironhair. Non gli è affatto piaciuto sentirsi chiamare con il nome che meritava, e così ha sfidato Huw. Avrebbe dovuto essere più saggio e limitarsi ad andarsene, ma si sa che Uderic non è mai stato saggio. Si sono battuti, ed è stato un combattimento rapido.» «Allora adesso Huw è davvero re.» «Oh, credevo che tu e lui aveste chiarito la questione una volta per tutte! Huw Fortebraccio non ha alcun desiderio di diventare re. Non ne abbiamo già parlato? Huw è il capo dei guerrieri di Pendragon e non vuole essere nient'altro. Ritiene che il suo compito sia preparare il terreno per il nuovo re, il figlio di re Uther. Bada bene, hanno cercato di farlo re dopo che ebbe ucciso Uderic, ma lui li ha derisi dicendo che era stato proprio quello il guaio, fin da quando era morto Uther: troppi pretendenti, desiderosi di diventare re, e nessuno in grado di farlo. E con questo ha chiuso loro la bocca.» Cavalcammo in silenzio e quando ricominciai a parlare fu per rivolgergli la domanda che mi frullava in testa da parecchi giorni, fin da quando Benedetto aveva fatto la sua previsione. «Vorrei fare un regalo a Huw, in segno di rispetto e di stima per il compito che si è assunto. Che cosa pensi che sarebbe degno del capo dei guerrieri di Pendragon? Potrei donargli un'armatura o delle armi, ma credo che non abbia bisogno né dell'una né delle altre, certamente non di quelle che usiamo noi. Riesci a pensare a qualcosa che potrebbe fargli piacere?» «Sì, una di quelle.» Eravamo arrivati al nostro accampamento e io mi sporsi per vedere che cosa avesse individuato con tanta facilità, ma non notai nulla di particolare. Llewellyn scorse l'incomprensione sul mio viso e indicò dritto davanti a sé. «Una di quelle. Quella grossa tenda laggiù.» «Che cosa? Vuoi dire la tenda del comando?» «Proprio così; Huw non ce l'ha. In Cambria, non esiste niente di simile. Quale miglior regalo da offrire al capo dei guerrieri di Pendragon che un tale simbolo del suo potere? Una grande, spaziosa tenda di cuoio, alta e comoda, dove riunire e incontrare tutti i suoi comandanti, in tutte le stagioni, al caldo e all'asciutto anche quando infuria la bufera. Sarebbe un dono da re, se fosse in tuo potere farglielo. Hai un'altra tenda come quella?» Feci una grande risata e, divertito, gli diedi una pacca sulla schiena. «Llewellyn, sei proprio un uomo in gamba. Certo, si tratta del dono più adatto e Huw Fortebraccio lo avrà. Non solo ne ho un'altra, ma ce l'ho bella e nuova, mai usata, con i pannelli di cuoio che odorano ancora di fumo e di tintura, e con i pali e le corde perfettamente puliti e senza traccia di fuliggine o di polvere. Terzio Lucca me ne ha portata una proprio ieri, in uno dei suoi carri, un dono inatteso da parte del Consiglio di Camelot, perché la usassi io. Sarà invece di Huw, visto che, nonostante la lodevole sollecitudine del Consiglio, la mia tenda è ancora in condizioni perfette. Ottimo, Llewellyn, ottimo davvero. E ora dimmi: c'è qualcosa che tu desidereresti avere?» Mi rispose subito. «Sì, certo che c'è. Vorrei possedere un cavallo mio e una sella.» Adesso sorrideva proprio, e tutto il lato sinistro del suo viso era completamente contorto. «Ho scoperto che cavalcare mi piace. Non intendo servirmene quando sono con i miei uomini. Tuttavia quando vengo con te, vorrei poter cavalcare a mio agio.» «Sia così, amico mio. Va' nelle nostre scuderie e scegliti il cavallo che più ti piace, poi di' a Filippo di procurarti una sella. Lo sai, vero, che una volta diventato padrone di un cavallo dovrai averne cura personalmente?» «Certo, Merlino, lo so. Rufio è stato un buon maestro. È lui che dovresti prendere come maestro per il giovane Artù, non me.» Annuii sorridendo. «Potrei anche essere d'accordo con te, ma Artù ha da tempo imparato tutto quello che Rufio gli poteva insegnare. E ora è lui che insegna a Rufio! È per questo che c'è bisogno di te: nuove tecniche, nuovi trucchi, quelli della gente di Cambria, per non lasciare impigrire il ragazzo.» Il mattino seguente ci mettemmo in marcia. Avevo inviato messaggeri a Camelot, per avvisare di aver ricevuto i rifornimenti e nel contempo chiedere al Consiglio di far sapere ad Ambrogio, qualora fosse tornato dalle terre di Vortigern, di attendere mie notizie a Camelot, poiché non avevo idea di quanto tempo sarebbe durata la guerra e per il momento non mi servivano rinforzi. Mandai anche messaggeri a Huw Fortebraccio, per fargli avere il mio dono — il giorno precedente i messaggeri avevano impiegato ore e ore per imparare a montare e smontare la tenda di comando e tenerlo informato su quanto intendevamo fare una volta che fossimo penetrati tra le montagne al centro della regione. Avremmo marciato puntando a nord e a est, verso le antiche miniere di Dolocauthi, dove sembrava più probabile che si trovassero Ironhair e Carthac, alla ricerca di oro negli antichi cunicoli. Lo invitai dunque a inviarmi lì i suoi messaggi dal momento che, qualora non avessimo scovato la nostra preda a Dolocauthi, ci saremmo trovati di fronte a due possibili alternative. La prima, verso nord ed est, era una fortificazione romana di cui non conoscevo il nome originario, e che per Llewellyn era semplicemente la località romana di Colen, al centro della Cambria. Ancora più a nord, a un intero giorno di marcia piegando alquanto a ovest, c'era poi Mediomanum, l'ultimo forte romano della Cambria centrale. A sud-ovest di Dolocauthi, c'era invece il celebre forte di Cicutio, che per molto tempo era stato una roccaforte della Legio Vicesima Valeria Victrix. Se avessi potuto scegliere liberamente, avrei optato per questa possibilità, tuttavia la destinazione finale sarebbe stata decisa in base alle informazioni di Huw circa gli spostamenti del nemico. Quel mattino stesso, appena usciti da Moridunum, ci dirigemmo velocemente verso le antiche miniere d'oro, inoltrandoci nelle valli che si facevano sempre più profonde e scure mano a mano che le montagne si innalzavano più alte verso il cielo. Ma a partire da quel momento, non passò giorno senza che gruppi più o meno numerosi di uomini di Pendragon scendessero dalle alture per unirsi silenziosamente a noi, ingrossando le nostre file, fino a farci toccare il tetto di novemila combattenti. I nostri ranghi aumentavano tanto rapidamente e in modo tanto massiccio che gli addetti agli approvvigionamenti cominciarono a preoccuparsi per il numero eccessivo di bocche da sfamare. Per fortuna il cibo ci giungeva senza che dovessimo cercarlo, inviato spontaneamente dai villaggi e dai borghi, oltre che dalle fattorie solitarie che si trovavano nelle vicinanze della nostra strada. A dire la verità, vedemmo ben pochi centri abitati, poiché ci tenevamo lungo il fondovalle mentre la maggior parte dei villaggi sorgeva sui fianchi delle colline, ben nascosta nel folto degli alberi. Un mattino, mentre sedevo su uno spuntone di roccia e osservavo le truppe sfilare sotto di me, ai piedi della collina, notai un reparto che era divenuto di giorno in giorno più numeroso. Dedicai più attenzione ai Celti di Llewellyn che ai miei soldati a cavallo. Cupi e silenziosi, austeri e riservati, i nuovi arrivati erano diversi dai Celti di Pendragon che avevamo conosciuto fino a quel momento. Questi montanari, il vero popolo di Pendragon, nati e cresciuti tra la solitudine delle montagne, solo raramente erano entrati in contatto con degli stranieri; si tenevano dunque in disparte, con un orgoglio fiero, diffidente e consapevole. Pur senza aprire bocca, facevano capire chiaramente che marciavano con noi in risposta alla chiamata dei loro capi e della loro terra, ma non dovevano alcuna lealtà a noi, a Camelot o a qualche altra potenza straniera. Per lo più marciavano in completo silenzio ed esibivano armi di tutti i tipi e di tutte le dimensioni, sebbene prevalesse l'arco lungo di Pendragon. Sembrava che ogni uomo avesse un arco la cui lunghezza era pari alla sua statura e almeno una faretra piena di lunghe frecce fatte con giovani rami di frassino e impennate con piume d'oca. La grande quantità di archi mi stupì, poiché avendo letto i diari di Publio Varro e di mio nonno - per altro scritti solo alcuni decenni prima - sapevo che un tempo queste armi erano rare e preziose, e non superavano le poche centinaia. Ullic Pendragon, nonno di Uther, aveva persino decretato che gli archi lunghi dovessero appartenere alla comunità e che nessuno potesse possederne uno: ogni uomo aveva temporaneamente in custodia un arco, ed era responsabile della sua manutenzione; poi, dopo un anno, doveva consegnarlo a qualcun altro. Molti degli archi che stavo vedendo erano stati protetti da quella legge e ora avevano cinquanta o sessantanni, qualcuno persino di più. Sapevo anche che per decenni i Druidi avevano percorso quelle terre alla ricerca di alberi di tasso, piantandone e coltivandone nuovi boschetti ovunque trovassero un terreno adatto. E parallelamente all'aumentare delle piante cresceva il numero di persone addette alla fabbricazione di archi e di frecce, tanto che tra questi uomini fieri e risoluti l'arte di costruire quelle preziose armi era diventata la più apprezzata. Poi osservai attentamente la forma degli archi e mi stupii nuovamente. Tutti gli archi lunghi che avevo visto fino a quel momento avevano una sezione rotonda, ed erano stati ricavati con amorevole cura da un unico ramo di tasso, essiccato e trattato. Invece, alcuni di quelli che ora passavano davanti a me avevano una sezione rettangolare come l'enorme arco laminato che possedevo io stesso, e che ormai aveva più di cent'anni ed era stato reso lucido da decenni di cure e di attenta manutenzione. L'arco di Varro, come lo chiamavo io, era di struttura composita con una forma doppia: di fatto si trattava di due archi, uno sopra e uno sotto l'impugnatura scolpita al centro. Era fatto con lamine piatte di qualche esotico legno scuro, rinforzato da piastre d'osso e corde di tendini intrecciati, incollati ed essiccati fino a diventare duri come il ferro; il tutto era stato modellato, legato e ricotto con tecniche conosciute in terra d'Africa, a opera di un abile scita ormai morto da tempo: una tecnica difficile da copiare in Britannia. Quando mi passò accanto Liewellyn, gli chiesi di questi nuovi archi ed egli confermò quanto avevo sospettato. In effetti erano fatti di lamine, anche se seguivano la forma ad arco singolo di quello tradizionale di Pendragon. Per la maggior parte erano di frassino, disse, sebbene ne esistesse ancora qualcuno fatto con l'assai più raro legno di tasso. L'arco rotondo originario richiedeva un ramo che avesse dimensioni e caratteristiche ben precise, in particolare lo spessore e la forma diritta. Poiché non tutti gli alberelli crescono diritti, la logica conseguenza era che non tutti fossero adatti a diventare un arco. Tuttavia gli artigiani ricordavano che l'arco di Varro, da cui erano stati copiati tutti i loro nuovi archi, era laminato. Di conseguenza qualcuno aveva continuato a lavorare usando legno meno adatto che, pur non avendo l'elasticità del tasso, aveva comunque altre pregevoli qualità: densità, grana stretta e flessibilità. Altri avevano poi scoperto che un ramo diritto di frassino della lunghezza adeguata se segato, ben trattato e seccato al forno, poteva essere diviso lateralmente con molta cura, poi riassemblato e trattato con colla impermeabile; i pezzi andavano posizionati al contrario, di modo che la venatura dell'uno fosse in direzione opposta a quella dell'altro: in questo modo, l'insieme era più robusto. Fatto questo, il legno così ottenuto poteva essere piallato a mano, lisciato e rastremato per produrre un'arma formidabile, dotata di una potenza inferiore rispetto a quella dell'arco lungo di tasso, ma pur sempre efficace e mortale, in grado di trapassare un'armatura anche da grande distanza. Ringraziai gentilmente Llewellyn per la spiegazione e continuai da solo, riflettendo sui progressi compiuti in Britannia dall'arte militare. Lo stesso arco lungo era spuntato dal nulla in un centinaio di anni, ispirato dall'enorme arco che ora viaggiava con i miei bagagli. La cavalleria che in quel momento stava avanzando in formazione alla mia destra, esisteva soltanto perché io stesso mi ero imbattuto nel segreto delle staffe su cui ora poggiavano i piedi di ciascun cavaliere. La lunga spada dall'elsa a croce che pendeva da un anello fissato in mezzo alle mie spalle era anch'essa qualcosa di speciale: di spade così al mondo ne esistevano soltanto tre. La palla di ferro che era appesa alla mia sella, legata da una correggia al suo corto e robusto manico di legno, e che veniva fatta roteare per mezzo di una catena, era stata inventata da mio cugino Uther ed era ora ampiamente usata: un flagello mortale che in combattimento quintuplicava la forza di un uomo. E le lance, lunghe e sottili, leggere e quasi flessibili, eppure indistruttibilmente robuste, in dotazione alla maggior parte dei miei cavalieri, erano nate dalla necessità di avere un'arma che i nostri uomini potessero usare con efficacia anche mentre stavano cavalcando. Persino la nostra cavalleria, me ne rendevo conto ora, aveva raddoppiato le proprie prestazioni grazie alla creazione del reparto degli esploratori. Profondamente immerso nei miei pensieri, riflettevo su quanto fosse facile dare per scontato che tutti possedessero quelle armi e quelle innovazioni. Naturalmente non era affatto così. Poche persone, al di fuori di Camelot e della Cambria, avevano mai visto nulla di simile; nessuno era dotato di armi che potessero reggere il confronto, e nessuno aveva l'abilità, gli anni di addestramento e la tecnica per poterle copiare. In quel preciso istante mi venne in mente, con la forza di una rivelazione, che se avessimo sfruttato le nostre forze e i nostri vantaggi in modo adeguato saremmo stati invincibili. Quella sera convocai una riunione per condividere quanto avevo scoperto con i miei compagni, i miei subordinati e i miei alleati. Gli intervenuti, tra i quali c'erano anche Llewellyn e parecchi dei suoi comandanti, erano rimasti in silenzio a lungo, rimuginando su quanto avevo appena esposto. Sebbene conoscessero da tempo gran parte di quello che avevo detto loro, nessuno aveva ancora compreso appieno che cosa implicasse realmente. Tuttavia, l'importanza della mia scoperta si manifestò in tutta la sua evidenza il giorno seguente, nella fiducia e nel buon umore che si diffuse ovunque, grazie all'entusiasmo comunicato dai comandanti ai propri uomini spesso con il semplice atteggiamento. La nostra avanzata verso nord proseguì senza sforzo e con pieno successo, e le poche concentrazioni nemiche che incontrammo furono sterminate senza pietà dai montanari che perlustravano le alture sopra e di fronte a noi. Pochi poterono sfuggire alle loro frecce, e coloro che vi riuscirono persero la vita poco dopo, quando, costretti a scendere verso la vallata, finirono nella morsa dei miei uomini. Qualche giorno dopo la partenza da Moridunum, mi ero unito a coloro che combattevano sulle alture, lasciando la cavalleria pesante e la fanteria molto più in basso e conducendo con me gli esploratori. La nostra presenza limitò i movimenti dei nemici alla sommità di montagne e colline, dove gli arcieri di Llewellyn li trattavano come fanno i contadini con gli insetti, intrappolandoli e schiacciandoli. Ciò nondimeno, nonostante le lunghe cavalcate, quando raggiungemmo le miniere d'oro abbandonate di Dolocauthi, avevo insanguinato la spada una volta soltanto, in una rapida scaramuccia con alcuni uomini di Cornovaglia che stavano fuggendo. Sapevo che Huw Fortebraccio era arrivato prima di noi poiché, proprio il giorno precedente, me lo avevano comunicato le pattuglie di Llewellyn. I suoi arcieri si erano spinti in avanscoperta nelle vallate sottostanti ed erano venuti in contatto con gli uomini di Huw, i quali si erano invece sistemati tra le colline, a nord e a est della valle, vicino alle vecchie miniere d'oro. Gli arcieri di Llewellyn avevano occupato i pendii meridionali e occidentali, mantenendosi dietro le creste e facendo di tutto perché le truppe della Cornovaglia e i mercenari appostati nel fondovalle ignorassero la loro presenza fino a quando non fossero sopraggiunte fanteria e cavalleria pesante a bloccare tutte le vie di fuga. Confidando nell'abilità di Filippo di comandare il grosso delle nostre truppe, mi tenni nella parte alta delle valli, sperando di riuscire a portare i miei esploratori in un punto che ci permettesse di caricare il nemico dall'alto. Eravamo ormai in vista dell'ultima catena che ci separava dal luogo in cui prevedevamo di batterci, quando udii un gran frastuono e compresi che qualcuno non era stato capace di attendere il momento adatto. Non scoprii mai chi o che cosa avesse causato quell'attacco prematuro, ma la velocità con cui il rumore si faceva sempre più assordante indicava chiaramente che la battaglia stava sfuriando. Imprecando per la rabbia e la frustrazione, detti il segnale ai miei uomini e li guidai all'attacco il più rapidamente possibile. Sfortunatamente, il terreno su cui ci trovavamo rendeva impossibile muoversi in formazione e acquistare velocità; così la nostra avanzata non fu compatta, dato che uomini e cavalli furono costretti ad aprirsi la strada tra macigni e burroni che ci sbarravano il cammino. Mi fu dunque impartita una lezione pratica sul motivo per cui la cavalleria sia inutilizzabile in un terreno montuoso. Spinsi Germanico per un sentiero in salita che mi sembrò abbastanza ampio e pareva una pista molto battuta dal bestiame; ma sebbene la sua robusta mole ci guidasse su per la collina, gli uomini che mi stavano a fianco dovettero restare indietro quando il sentiero si restrinse bruscamente e infine terminò sull'orlo di un burrone. Tirai con forza le redini e feci voltare Germanico a sinistra per scendere lungo il fianco della collina, ma dovetti spostarmi indietro sulla sella, facendo forza sulle staffe, mentre il massiccio animale si apriva la strada seguendo l'orlo del burrone. Potevo sentire che qualcun altro stava scendendo dietro di me, ma non mi voltai per vedere chi fosse; ero troppo impegnato a osservare la confusione che regnava tra i miei esploratori, sparpagliati lungo i fianchi delle colline e il fondovalle. Alla fine trovai un punto dove attraversare il burrone, poi il terreno migliorò leggermente e riuscii ad avanzare un po' più velocemente verso la sommità della catena montuosa che mi impediva la vista del campo di battaglia. Proprio sotto la vetta, mi trovai di fronte un grande cumulo di pietre e Germanico fu nuovamente costretto a rallentare prima di trovare il modo di aggirarlo e raggiungere uno spiazzo che si affacciava su un altro burrone, questa volta però abbastanza stretto da poter essere superato con un salto. Fermai Germanico proprio sull'orlo, gli feci fare dietrofront e lo feci retrocedere il più possibile per consentirgli di muovere qualche passo prima di lanciarsi. Ma, mentre si slanciava in avanti e si preparava a saltare, vidi un uomo spuntare improvvisamente da una sporgenza al di sopra del punto in cui avremmo toccato terra. Teneva in mano una lancia ed era pronto a colpire; le dita della mano sinistra erano rivolte verso di me mentre prendeva la mira e poi lanciava l'arma. Si trattava di una lancia lunga e pesante, ma l'asta era storta cosicché mentre roteava seguiva una traiettoria circolare. Vidi distintamente la lunga punta affilata dirigersi verso di me, ma non c'era nulla che potessi fare: Germanico era già sollevato da terra e si gettava in avanti. Nell'attimo del salto, mentre eravamo sospesi in aria, la lancia mutò leggermente direzione e cadde davanti a me. Avevo appena cominciato a mormorare una preghiera di ringraziamento, quando mi resi conto che il mio cavallo era stato colpito. Si trattò di un rumore secco e lacerante: sentii il grande e forte animale sotto di me bloccarsi a mezz'aria, rovesciando la testa all'indietro e rantolando, in agonia. Poi, non appena le sue ginocchia ebbero toccato terra dall'altro lato del precipizio, si accasciò al suolo, facendomi volare sopra la sua testa. Percepivo quanto stava accadendo in modo nitido e angosciosamente dettagliato, come se il tempo avesse rallentato la sua corsa, consentendomi di mantenere tutte le mie facoltà e di reagire istantaneamente. Non so come, ma toccai terra in piedi; ero fortemente sbilanciato in avanti ma non caddi. Tenevo in mano la spada senza che mi fossi neppure reso conto di averla sganciata. La sguainai e mi lanciai su per il pendio, puntando direttamente verso il luogo in cui il mio assalitore si era ora accucciato, con l'ascia in mano, in attesa. Sapevo che Germanico, il fedele amico di tanti anni, era morto o stava morendo alle mie spalle, ma non mi voltai. Raccolsi invece tutte le forze per salire il ripido pendio che mi stava davanti. Non appena raggiunsi la cima, il mio assalitore si scagliò in avanti per farmi a pezzi come fossi un tronco. La lucidità quasi soprannaturale di poco prima non mi aveva abbandonato e riuscii facilmente a evitare il suo assalto mortale. Il fendente si abbatté e la lama dell'enorme ascia colpì il terreno proprio nel punto in cui mi ero trovato qualche istante prima, sprizzando scintille al contatto con le pietre. La violenza del colpo vibrato aveva fatto perdere l'equilibrio al mio assalitore; mentre barcollava la corta tunica di pelle di pecora - unico indumento che indossava dalla vita in su - si sollevò, mettendogli a nudo l'incavo della schiena. Balzai su di lui e lo colpii dall'alto calando con entrambe le mani un fendente che lo colse di taglio, penetrando profondamente attraverso la cintola; il colpo fu così netto e profondo che, nell'estrarre la lama, gli trapassai le viscere, tagliandolo in due. Forse era dovuto alla rabbia che infuriava dentro di me, ma non ho mai colpito nessuno tanto violentemente e selvaggiamente come quell'uomo. Il fendente vibrato con la lama lunga e affilata della Pietra del Cielo fu così rapido e distruttivo che l'uomo continuò a gridare anche quando la metà inferiore del suo corpo era ormai separata da lui. Feci un passo indietro ma non avvertivo né sorpresa né ripulsa. Solo allora udii il rumore di qualcuno che si avvicinava correndo. Mi voltai e scorsi tre dei suoi compagni che venivano verso di me, uno armato di lancia e due di corte spade di foggia romana. Con un gesto istintivo, colpii la lancia e facendo perno sul piede destro mi girai, roteando la spada in un cerchio completo per decapitare l'uomo che impugnava la lancia. Appena il corpo rotolò di lato, abbassai E ginocchio destro e ritrassi la mano che impugnava la spada fino a farla quasi strisciare sul terreno vicino alla mia caviglia. Uno dei due assalitori rimasti si fece avanti, ma si mosse troppo velocemente; si rese conto del suo errore, ma prima che potesse rallentare lo colpii con un fendente che lo raggiunse sotto lo sterno. Liberai la punta della spada, balzai di nuovo in piedi e mi lanciai sul terzo uomo. Curvò le spalle, e, sollevando il piccolo scudo rotondo che aveva con sé, venne verso di me. Non portava elmo e io gli fracassai il cranio prima ancora che la sua corta spada potesse avvicinarsi alla mia persona. A quel punto ero rimasto solo sulla collinetta, ma fui costretto a voltarmi di nuovo, colpito dal rumore di passi che smuovevano i sassi del pendio. Non appena mi fui precipitato verso il punto da cui proveniva il rumore, roteando la spada, scorsi la punta del cimiero che ornava gli elmi dei miei uomini: subito dopo apparve il viso di Donuil. Mi fermai e allungai la mano per aiutarlo a raggiungermi, poi entrambi restammo immobili e in silenzio a guardare la carneficina che stava avvenendo attorno a noi. Ovunque si vedevano piccoli gruppi di uomini intenti a combattere, ma i nemici si battevano con la forza della disperazione e morivano uno dopo l'altro, sempre più numerosi, per la maggior parte abbattuti dalle frecce mortali che venivano scagliate dalle rocce sovrastanti. Un uomo gigantesco e con il ventre prominente, che brandiva una lama lunga e piuttosto rozza, fu gettato in un burrone da una freccia che lo colpì proprio sopra l'orecchio, sollevandolo da terra e facendolo volare via come se fosse stato senza peso. A quel punto mi resi conto che Donuil mi stava gridando qualcosa. Il rumore era assordante ma fino a quel momento non me ne ero accorto. Scossi la testa e mi sforzai di ascoltare. Donuil mi stava chiedendo se fossi ferito o mi fossi fatto male; la domanda mi stupì e capii perché Donuil me l'avesse fatta solo abbassando lo sguardo: l'armatura, la tunica, le braccia, le mani e la spada che stavo ancora stringendo grondavano letteralmente sangue, e per un attimo fui preso dal panico pensando che potesse essere il mio. In realtà me l'ero cavata senza un graffio. Scossi ancora la testa e mi guardai di nuovo attorno, questa volta osservando con più attenzione quanto avevo davanti agli occhi. Il combattimento era cessato pressoché ovunque, a eccezioni di pochi, violenti scontri che ancora infuriavano qua e là. Quella che si stava compiendo era un'autentica carneficina: i nemici gettavano le armi cercando di arrendersi, ma venivano uccisi indiscriminatamente, soprattutto dalle frecce che piovevano dall'alto. Inspirai profondamente e ordinai a Donuil di trovare il nostro trombettiere e di far suonare l'adunata, ma mi accorsi che mi tremava la voce. Donuil mi lanciò uno sguardo interrogativo poi, senza pronunciare una sola parola, si voltò e scomparve. Con le gambe intorpidite mi incamminai verso il lato opposto della piccola altura. Non ricordo di essere andato alla ricerca del mio cavallo, ma mi ritrovai inginocchiato accanto alla sua testa, a osservare tra le lacrime il suo muso nobile e il velo lattiginoso che cominciava a formarsi sull'unico occhio che ero in grado di vedere. La lancia lo aveva trafitto, conficcandosi profondamente nel suo petto prima ancora che Germanico potesse appoggiare le zampe posteriori al suolo e l'intero peso del suo corpo possente si abbattesse su di essa, spingendo la punta nel suo grande cuore. Per una ventina di anni quel magnifico animale mi aveva portato in groppa fedelmente, offrendomi tutta la sua obbedienza e il suo affetto in cambio delle mie poche attenzioni. Lo spettacolo della sua nobile morte mi sconvolse profondamente; mi sedetti e piansi, appoggiando la schiena contro la sua spalla e allungando il braccio sinistro sul suo collo, forte e liscio come la seta. Tutto attorno a me, sparsi tra le rocce e i precipizi di quel luogo inospitale, i corpi dei morti e dei morenti giacevano come indumenti abbandonati, ma non mi ispiravano alcun sentimento di dolore. La loro morte era stata la conseguenza naturale di una vita di guerrieri e di mercenari. Al contrario, la morte di Germanico, il mio nobile e generoso amico, era un fatto esclusivamente personale che mi opprimeva con un insopportabile senso di abbandono e di privazione. Qualche tempo dopo, avvertii la mano di Donuil appoggiarsi delicatamente sulla mia spalla; allora mi alzai, con gli occhi ormai asciutti, e lo seguii dove mi attendeva un altro cavallo. Cavalcammo in silenzio per andare a incontrare Huw Fortebraccio. La vittoria, mi disse più tardi Huw, era stata molto più grande e completa di quanto avessi immaginato. Gli invasori si erano precipitati a Dolocauthi in numero decisamente superiore alle nostre aspettative, attirati dalle miniere d'oro. Colti di sorpresa contemporaneamente sia da nord sia da sud, erano stati sconfitti e costretti alla fuga, mentre le loro fik venivano decimate dagli arcieri di Pendragon appostati sulle colline sovrastanti. I sopravvissuti, a migliaia nonostante le forti perdite, erano ora in fuga verso ovest; tornavano di nuovo verso la costa, ma questa volta erano incalzati e bersagliati senza sosta dai temibili montanari in grado di uccidere un uomo scagliando le loro lunghe frecce da una distanza di quasi mezzo miglio. Huw era di ottimo umore, pieno di entusiasmo e di eccitazione, e sembrava ancora più imponente di quanto ricordassi, decisamente più regale. Mi ci volle qualche istante per rendermi conto del cambiamento, tanto che lo stesso Huw, accorgendosi dell'intensità con cui lo osservavo, interruppe a metà quello che stava dicendo per guardarmi sorpreso. «Che c'è?» chiese. «Che ti succede? Sembri... C'è qualcosa che non va, Merlino?» «Il tuo elmo» replicai, scuotendo la testa. «Lo riconosco, anche se non lo avevo mai visto prima d'ora. Apparteneva a Ullic Pendragon. Ho letto la sua descrizione nei libri di mio zio. Ma deve avere più di cent'anni, eppure sembra nuovo. Com'è possibile?» I suoi occhi brillarono per la sorpresa, poi con entrambe le mani si tolse l'elmo e me lo porse. La testa della grande aquila dorata appollaiata sulla sommità sembrava viva, tanto fieri erano i suoi occhi. Le ali enormi erano ripiegate a entrambi i lati e le penne della coda, aperte a ventaglio, scendevano fino a coprire le spalle. «Tieni» mi disse. «Guardalo bene. L'anno scorso questo uccello volava ancora. L'elmo di Ullic era simile, ma questo è mio, ed è stato appena fatto per me.» Osservai attentamente gli occhi, fatti di vetro o di pietra lucida, e il modo in cui le piume del collo erano state sistemate sulla visiera dell'elmo. «L'elmo con l'aquila è l'elmo cerimoniale del capo dei guerrieri di Pendragon, Merlino, e ogni nuovo capo ha il suo. Uric e Uther erano entrambi re, come lo era Dergyll ap Griffyd, ma solo Ullic era sia re sia capo dei guerrieri, per questo aveva l'elmo. Da quando è morto Ullic, io sono il primo a essere nuovamente capo dei guerrieri di tutta Pendragon.» Gli restituii l'elmo con tutta la deferenza che meritava. Poi Huw ci accompagnò dove era stata eretta la sua nuova tenda; qui si erano già riuniti comandanti e sottocapi, in attesa di ricevere nuovi ordini. Mentre lo udivo esporre in dettaglio i suoi piani e apprezzavo il modo in cui dava ascolto a ogni nuovo rapporto e prontamente vi si adeguava, sentii rinascere l'entusiasmo e la forza di accettare con rassegnato pragmatismo la dolorosa perdita di Germanico. Durante le tre settimane seguenti, prendemmo d'assalto i passi montuosi e le valli della Cambria occidentale, lasciando una scia di sangue al nostro passaggio. Raggiungemmo poi la costa occidentale dove trovammo quel che restava dei malridotti mercenari di Ironhair trincerati lungo la spiaggia, pronti a fronteggiarci al riparo di fortificazioni improvvisate e sommarie. I loro piani di evacuazione erano falliti miseramente, mentre la flotta, che avrebbe dovuto portarli in salvo, non si era ancora fatta vedere, e non c'era alcun segno di un suo imminente arrivo. Inoltre, rischiavano l'assedio, la fame e la sete, ammassati com'erano in uno spazio angusto, privo di vegetazione a eccezione delle alghe portate a riva dall'alta marea, e con il mare alle spalle. Eppure rifiutarono di arrendersi, temendo, senza dubbio, l'assoluta mancanza di pietà che gli uomini di Pendragon erano soliti dimostrare nei confronti dei propri nemici. Al termine della terza mattinata di assedio, erano ormai completamente circondati e alla mercé della schiacciante superiorità degli assedianti. Andai dunque a incontrare Huw Fortebraccio e gli chiesi di approvare la mia decisione di tornare a Camelot con la mia gente. Ai miei occhi e ai suoi, l'invasione di Ironhair era ormai finita. Per quanto ne sapevamo, i due responsabili principali, lo stesso Ironhair e Carthac Pendragon, erano sfuggiti incolumi, tuttavia il loro tentativo di impadronirsi della Cambria era miseramente fallito. Infine, esattamente come l'esercito di Ironhair si era aspettato di essere messo in salvo dalla sua flotta, anch'io avevo pensato di vedere qualche segno della presenza di Connor Mac Athol nelle acque al largo della costa. Dal momento però che nessuna delle due flotte si era fatta vedere, la mia ipotesi era che si fossero incontrate in mare aperto e dunque l'una o l'altra, a seconda del risultato della battaglia, sarebbe potuta spuntare all'orizzonte in qualsiasi momento. Tuttavia, comunque fossero andate le cose, le forze con cui Huw aveva stretto i nemici sulla spiaggia erano sufficienti a consentirgli di dominare facilmente la situazione. Non aveva alcun bisogno della nostra continua presenza o dell'aggravio di doverci nutrire, quando invece potevamo essere più utili a casa nostra, a Camelot. Huw riteneva probabile che Ironhair e Carthac sarebbero ricomparsi, ma certamente non si sarebbero fatti vivi prima di un anno. A quel punto però la Cambria sarebbe stata saldamente sotto il suo controllo, e dunque imprendibile. Tra gli uomini di Pendragon la coscienza di far parte di un unico popolo era sconosciuta da tempo - in pratica dalla morte di Uther - e il suo riemergere quasi miracoloso diede loro una forza e un vigore eccezionali. Comunque, se in futuro Ironhair avesse tentato nuovamente di invadere il paese, Huw avrebbe chiesto ancora una volta il nostro aiuto, in cambio del suo pieno appoggio alle rivendicazioni del giovane Artù e alla sua aspirazione di diventare re della Cambria in quanto erede di Uther Pendragon. Quando gli parlai del mio accordo con LleweUyn, che si era preso l'impegno di portare il ragazzo in Cambria l'anno seguente, Huw lo sollevò immediatamente dai compiti che gli aveva affidato, perché potesse venire a Camelot con noi. Poi ci abbracciammo come amici ed eguali, e poco dopo diedi ordine alle mie due mezze legioni di mettersi in marcia per tornare a Camelot. Eravamo stati lontani dalla nostra Colonia per un tempo che mi pareva infinito. XI. Quando, venendo da nord-est e procedendo senza incidenti da Dolocauthi sulle colline centrali, calammo dall'altopiano per avviarci a Camelot, l'autunno aveva già toccato gli alberi con il suo gelido soffio. Avanzammo lungo la costa meridionale della Cambria, quindi volgemmo a oriente, seguendo il litorale. Nel tragitto ci unimmo alle nostre truppe provenienti da Caerwent e Cardiff. Poiché eravamo sul finire dell'estate non fu un'impresa difficile attraversare durante la bassa marea la foce del fiume a occidente di Glevum. Ci addentrammo quindi verso sud-est, passammo accanto ad Aquae Sulis e infine ci immettemmo sulla grande strada che proseguiva a sud fino a Camelot. Eravamo contenti di rivedere la patria, eppure stranamente abbattuti; serpeggiava un'aria di scontentezza, alimentata dalla conclusione ineluttabile, cui accennavamo appena, che erano stati i Celti di Pendragon e non le forze di Camelot, a battere gli invasori. Sapevamo di essere l'incudine sulla quale si era abbattuto con forza il martello celtico debellando i nemici, intrappolati e schiacciati dal nostro massiccio e irriducibile impatto. Lo stesso Llewellyn aveva dato vita a questa immagine. Ma l'orgoglio alimentato in noi dalla consapevolezza di essere cittadini di Camelot non era incline ad accettare un ruolo di secondo piano. Ecco perché eravamo insoddisfatti e inappagati, convinti di non avere conseguito nulla di significativo. Inutile dire che l'umore del nostro esercito migliorò mano a mano che ci avvicinavamo a casa e alle gioie domestiche. Gli uomini non vedevano l'ora di togliersi l'armatura e riposarsi per un po'; il pensiero di fare l'amore con la moglie o la fidanzata era presente in tutti, me compreso. Il ritorno fu trionfale e nello stesso tempo caotico. Non era mai accaduto che un esercito ritornasse lamentando così pochi caduti: nella campagna durata tutta l'estate erano morti meno di cento uomini e non più di trecento erano stati feriti. Il caos derivava dal fatto che ci presentavamo come una moltitudine di bocche affamate. Sebbene la nostra venuta fosse attesa con animo impaziente e lieto, l'apparizione improvvisa di un'immane schiera di uomini provocò sgomento e costernazione tra i commissari militari della Colonia: come mi aveva detto pochi giorni prima Publio Tetra, il commissario anziano, una cosa è calcolare la presenza di seimila legionari, che tornano alla propria comunità, un'altra era tenere conto che al loro seguito, quale scorta, se ne muoveva un altro migliaio; non era cosa da poco vedere settemila uomini in carne e ossa che scendevano in massa sbirciando avidamente le provviste e i granai. Grazie alla lungimiranza di Tetra e dei suoi collaboratori, ci eravamo preoccupati di attenuare, almeno da questo punto di vista, l'impatto del nostro arrivo, e nei cinque giorni precedenti organizzai gruppi di cacciatori che setacciassero la zona. Ci presentammo quindi portando carri di carne fresca e di cereali, raccolti nei granai delle nuove postazioni che avevamo superato nel tragitto. Infatti, i contadini di tre comunità ci avevano dato di buon grado le scorte di grano che erano loro avanzate alla fine dell'estate. Era un segno di gratitudine per la presenza dei contingenti armati che vegliavano sulla loro sicurezza in quelle zone distanti; inoltre il nuovo raccolto prometteva di essere abbondante ed entro un mese sarebbe riaffluito nei loro magazzini. Un'altra imprevedibile causa del caos era rappresentata dal numero degli ospiti che, con diversi livelli di impazienza, ci aspettavano alla Colonia. Venni subito a sapere che a Camelot si trovava Connor Mac Athol, sbarcato da qualche giorno appena, e che vi aveva incontrato suo fratello Brander, anch'egli in attesa del mio arrivo. Mio fratello e Artù, calati il mese prima dalla Northumbria, erano sicuri di vedermi di ritorno dalla Cambria, e Ambrogio si era portato dietro parecchi consiglieri anziani di Vortigern. Erano venuti con il pretesto ufficiale di conferire con me circa la spedizione che l'anno successivo avrei condotto nelle terre nordorientali; in realtà l'intento di Ambrogio era di dimostrare a quegli uomini potenti e, tramite loro, al re stesso, che Camelot, dove non erano mai venuti in precedenza, era in realtà come avevamo detto noi: una colonia prospera e florida, un potenziale alleato più ricco dei cinquecento Scoti che Ambrogio aveva condotto. Nell'attesa del mio arrivo, Ambrogio aveva fatto da anfitrione agli ospiti, insieme a Brander, apparso con un seguito composto da sua moglie Salina, sua nipote Morag e una ventina di capitani scozzesi in veste di consiglieri. E quasi non bastasse, era arrivata un'intera delegazione di undici prelati guidata dall'anziano vescovo Enos, che aveva somministrato i sacramenti alla mia prozia Luceia. Anche loro erano venuti a cercarmi. Tutto questo lo venni a sapere da Dedalo, che a capo di una splendida guardia d'onore ci aspettava ai confini di Camelot sulla grande strada che parte da sud e raggiunge le terre settentrionali. Conclusa la cerimonia di benvenuto, io e Ded proseguimmo a cavallo, fianco a fianco, mentre lui mi avvertiva che molti avrebbero chiesto di conferire con me. Quando ebbe finito, mi venne da ridere pensando che avevo ardentemente sperato di potermi appartare con Tressa. Lo feci partecipe delle mie illusioni, e lui rise con me, un riso traboccante di comprensione. Dopo pochi minuti, superata l'ultima curva, si profilarono davanti ai nostri occhi le mura di Camelot sulla sommità della collina, e immediatamente fummo travolti da un turbine di saluti di benvenuto. Di tutto questo ho serbato solo una successione di immagini e ricordi frammentari. So di avere incontrato e salutato Brander, sua moglie Salina, il vescovo Enos, ma a fatica distinguo nella memoria i diversi gruppi che li accompagnavano. Tutti quei volti, a me sconosciuti, si sovrapponevano e si fondevano in una sconnessa serie di saluti. Ricordo di avere pensato che poiché gli Scoti dell'Ibernia erano riconoscibili per le loro vesti dai vivaci colori e gli uomini di chiesa per le loro lunghe tonache di tessuto grezzo, gli altri sconosciuti dovevano essere gli uomini della Northumbria, venuti con Ambrogio. Mio fratello fu il primo a venirmi vicino e, mentre lo abbracciavo, stringendolo a me, con lo sguardo cercavo Artù: ricordo di avere provato un senso di delusione non vedendolo in mezzo alla folla che si era levata ad accogliermi quando ero smontato da cavallo. Poi con aria timida avanzò Tressa, e il mio cuore ebbe un sussulto di gioia. Mi staccai da Ambrogio e a braccia aperte mi volsi a lei. Era bellissima. Indossava un abito verde, di una stoffa fine e morbida che l'avvolgeva disegnando le curve del suo corpo. Sentii in gola un groppo di amore e di desiderio. Si spense il brusio della folla, scomparvero quanti mi circondavano: esisteva solo la splendida donna che era venuta per condurmi a casa e accogliermi nel suo letto. Mi si avvicinò, le gote arrossate, gli occhi luminosi, poi all'improvviso si fermò e, tenendomi stretto, mi fissò con occhi velati di lacrime. Quando mi ero chinato per cingerla alla vita con un braccio, avevo avvertito la pienezza del suo corpo; la sollevai in alto, quasi fosse una piuma leggera, per avvicinare la sua bocca alla mia; intorno a me percepivo il suono stranamente distante delle risa e di qualche applauso. Riposandola a terra e stringendole la mano, la tenni al mio fianco mentre passavamo tra la folla osannante assiepata nel cortile. Le successive ore passarono veloci come un battito di ciglia, scandite dalle suppliche di chi mi aspettava per dirmi che la sua richiesta era più urgente di ogni altra. A tutti sorridevo e promettevo di dare udienza alla prima occasione, e dietro il sorriso mi chiedevo come e quando sarei riuscito a trovare il tempo, visto che sentivo prepotente il desiderio di rimanere con Tressa. Venne alla fine il momento in cui noi tre fummo finalmente soli, la prima volta da quando ero arrivato. Presi in disparte mio fratello trattenendolo per un gomito e con l'altra mano stringendo Tressa vicino a me, mentre chiedevo agli astanti di scusarci. Non appena fummo soli, lasciai andare il braccio di Ambrogio e scostandomi di un passo mi appoggiai alla parete, con Tressa al mio fianco. Ambrogio mi fissava con occhi ridenti. «Sono al tuo servizio» disse con un leggero inchino e uno sguardo divertito. «Dimmi che cosa vuoi.» «Voglio restare solo con Tressa. Ecco quello che mi sta a cuore sopra ogni altra cosa. Mi sorprenderebbe che non l'avessi già capito. Poi voglio sapere dove si trova Artù e perché non è qui. E anche perché tanta gente vuole parlarmi. Voglio mettere un po' d'ordine nelle richieste. Non posso accoglierli tutti insieme, ma sembra che ciascuno consideri le proprie esigenze improrogabili. Connor è latore di notizie che mi preme conoscere, e sarà il primo che incontrerò. Ma finché non so di che cosa vogliono discutere gli altri, non posso prendere una decisione. Che cosa sai?» Il suo sorriso non si spense. «In ordine di importanza? Molto bene. La tua prima cura sia per te stesso. Segui Tressa e non farti vedere fino a stasera. Mi premurerò di scusarti adducendo la tua... stanchezza. Il secondo pensiero sarà Artù. È innamorato. L'unica ragione che l'ha tenuto lontano quando sei arrivato. A sua difesa dirò che ignoravamo che sareste stati qui così presto. Girava voce che non vi avremmo visti prima di domani, forse più tardi. Il tuo messaggero ci ha raggiunti ieri avvertendoci che eravate in anticipo, ma nel frattempo Artù si era allontanato con Shelagh e la giovane Morag. Sono andati a caccia e rientreranno nel pomeriggio. Artù sarà deluso di non essere stato presente al momento del tuo arrivo. Ne parla da settimane. Vedrai com'è cambiato, non sei d'accordo, Tressa?» «Sì» sussurrò, annuendo con un sorriso. «Potrai incontrare Connor non appena sarai di ritorno dalla villa» proseguì Ambrogio. «Quanto agli altri, è Brander quello che aspetta da più tempo. Partirà subito dopo averti parlato, ma le cose che deve chiederti, preoccupanti per lui, non dovrebbero esserlo per te. In realtà non è con te che vorrebbe conferire, ma con Huw Fortebraccio. Vuole chiedergli il permesso di riportare nelle terre di Pendragon Liam il Gobbo e le sue mandrie. Sembra che il clima della loro isola non si presti all'allevamento. Gli ho promesso di inoltrare la sua richiesta e gli ho detto che a mio avviso non vedevo impedimento a che fosse accolta. Temendo che Fortebraccio sia rimasto amareggiato dopo le vicende belliche, preferisce parlarti personalmente. Ma il tuo arrivo si è fatto attendere e ora è di fretta, desideroso di andarsene, ritornare ai suoi doveri...» Tacque, riflettendo prima di proseguire. «I miei ospiti venuti dalla Northumbria possono aspettare. Non hanno particolare urgenza di rientrare in patria. Del vescovo Enos, invece, non so che dire. Non ho idea di quale sia la sua missione e se il tempo gli sia tiranno. Dovrai giudicare tu. Ecco tutto quello che posso dirti. Il consiglio che ti do è di vedere Connor per primo, poi Brander, che è re, quindi Enos, e infine gli uomini della Northumbria.» «E così sia. Procederò nell'ordine da te indicato. E ora riesci a farci uscire di qui senza che nessuno se ne avveda?» Prima che Ambrogio rispondesse, Tressa, girandosi tra le mie braccia e stringendosi a me, mi posò le dita sulle labbra, quasi invitandomi a tacere. Voleva dirmi che non dovevamo essere egoisti, nessuno dei due, né io né lei. Mi aveva aspettato per mezzo anno, disse, arrossendo per essere così schietta alla presenza di Ambrogio, un'altra mezza giornata sarebbe stata sopportabile. Tentai di interromperla più volte, ma a ogni tentativo la pressione delle dita sulle mie labbra mi tratteneva dal parlare e, ascoltandola, finii con l'ammettere, seppur con riluttanza, l'assennatezza del suo ragionamento. Ambrogio taceva, guardandoci intento. Alla fine acconsentii. Tressa lesse l'accettazione nei miei occhi e allontanò la mano dalle mie labbra. Mi chinai per baciarla, poi mi raddrizzai per rivolgermi a mio fratello al di sopra della sua testa. «Tanta abnegazione esige di essere rispettata. Dove possiamo parlare con Connor?» Incontrammo l'ammiraglio nel salone. Chiudemmo a chiave le porte alle nostre spalle per essere sicuri di non venire disturbati. Faceva quasi freddo, e si coglieva quel brivido annunciatore dell'inverno che nelle corte giornate d'autunno spesso si infiltra nei luoghi non toccati dal sole. Ambrogio si inginocchiò per accendere la legna già pronta nel caminetto, e nel frattempo io mi avvicinai allo stipo dove conservava l'idromele, facendo segno a Tress che si sedesse e mi concedesse di dedicarle qualche premura. Girandomi per porgere le coppe a Connor e Tress, mi accorsi che avevano già cominciato a parlare del nuovo insediamento di Scoti nelle isole nordoccidentali. Quando Ambrogio si allontanò dal caminetto, togliendosi dalle ginocchia la fuliggine che vi si era attaccata, gli porsi il bicchiere e insieme facemmo un brindisi. Dopo essermi seduto, volsi uno sguardo attento a Connor, che subito si accinse a farmi un resoconto, metà storia, metà relazione. Come sospettavo, aveva intercettato la flotta di Ironhair mentre evacuava i mercenari della Cornovaglia. Era stato il caso a farli incontrare subito dopo l'alba di una giornata senza vento, in un'ora in cui sulla superficie del mare indugiava una nebbiolina inquieta. Non appena si era dissolta la foschia, le due flotte si erano trovate l'una di fronte all'altra in piena vista. Quella di Ironhair era in una posizione di svantaggio, chiusa tra le navi di Connor e la costa rocciosa della baia. Quanto a forza, i due schieramenti erano quasi pari: Ironhair disponeva di venti galee, oltre alla sua bireme; Connor, di una bireme e diciotto galee. Ma Ironhair poteva far conto anche su innumerevoli imbarcazioni minori, per lo più pescherecci e chiatte di basso pescaggio, adatte a raggiungere la riva dove, secondo i suoi piani, avrebbe raccolto i soldati che affluivano lì dall'entroterra e da Dolocauthi. Ironhair aveva colto di sorpresa Connor attaccandolo senza indugio. Lo scafo della sua massiccia bireme, sotto lo sforzo dei rematori che vogavano con vigore, aveva solcato rapidamente il tratto di mare staccandosi dalla costa e puntando sull'ammiraglia nemica, e aveva raggiunto la massima velocità prima ancora che Connor si fosse reso conto del pericolo. Ma l'ammiraglio di re Brander, intuendone le intenzioni, aveva subito messo in atto una manovra evasiva, girando la bireme verso destra e subito dopo virando a sinistra, mentre l'avversario, abboccando alla finta, avanzava cambiando di volta in volta direzione. Subito dopo, aveva lanciato alla sua flotta il segnale di attacco, lasciando che le imbarcazioni si avventassero contro l'assembramento nemico in formazione sparsa lungo la costa, e riservando a sé il compito di affrontare la bireme di Ironhair. Per più di un'ora, raccontò, i due grandi vascelli si erano fronteggiati in una sorta di danza compassata ma mortale, mentre ciascun capitano cercava di aggirare l'avversario e di portarsi in posizione di vantaggio. Fin dall'inizio Connor aveva capito che Ironhair mirava a speronare la sua nave, sfondandone lo scafo sotto la linea di galleggiamento con l'enorme rostro che sporgeva dalla prua. Dal canto suo, Connor, che intendeva catturare la bireme nemica, l'aveva costretta, mostrando di volerla affiancare, ad adottare manovre difensive ed evasive. Aspettava che balzasse in avanti, quindi scartava all'improvviso dalla propria rotta e si metteva di lato per attraversare subito dopo la scia e posizionarsi alle spalle in attesa del successivo attacco. Una tattica che aveva dato del filo da torcere, ma l'intento di Connor era stato quello di catturare la nave nemica, non di distruggerla, il che lo aveva esposto a un grave rischio. Ogni volta che i due imponenti vascelli si erano trovati vicini, dal ponte posteriore della bireme di Ironhair le catapulte avevano lanciato contro le vele di quella di Connor recipienti di olio bollente. Sebbene molti proiettili fossero finiti in mare senza arrecare danno, gli uomini avevano dovuto adoperarsi al limite delle forze per spegnere le fiamme di ben tre di essi che, piombando sul ponte di combattimento, avevano mandato in frantumi il legno stagionato e impeciato, e sparso intorno l'olio bollente con il serio pericolo che il fuoco incendiasse il sartiame e bruciasse tutto. Un compito duro quello di molti combattenti che si erano visti esposti al duplice rischio delle fiamme - non esiste nulla di peggio in mare - e delle frecce. Da entrambe le parti gli arcieri scaricavano una pioggia di dardi non appena i due vascelli si trovavano a breve distanza. Connor mi disse che gli sarebbe piaciuto avere sulle sue navi un contingente di uomini armati con gli archi di Pendragon, perché si rendeva conto che nello scontro gli sarebbero state di grande vantaggio la maggiore velocità e robustezza di quelle armi. La strategia portante di Connor consisteva in una manovra alla quale il suo equipaggio si esercitava da qualche tempo, e fino ad allora tenuta in serbo in attesa del momento propizio. Dando a vedere, anche a costo di apparire ridicoli e codardi, di voler evitare il confronto diretto, Connor Mac Athol aveva giocato d'astuzia. Inizialmente i suoi scarti laterali non avevano avuto uno scopo preciso, salvo che, ogni volta che aveva evitato l'attacco nemico, si era rapidamente portato alle sue spalle attraversando la scia e ritirandosi a distanza di sicurezza. Ben presto, dopo numerose fughe, i suoi uomini avevano cominciato a essere bersaglio di insulti da parte degli avversari, non appena passavano loro vicino. Ma proprio questo era stato l'intento: avevano fatto di tutto per meritarsi quegli sberleffi così da mettere in atto la loro strategia, e a ogni manovra evasiva avevano cercato di avvicinarsi lentamente alla costa. Da ultimo un subitaneo attacco aveva portato la nave nemica entro i confini della baia e direttamente verso le secche costiere. Questa volta, non appena passata la bireme avversaria, Connor aveva dato il segnale e immediatamente era cambiato il ritmo dei tamburi che cadenzavano la manovra. I rematori sulla sinistra avevano levato i remi, mentre quelli sulla destra li avevano abbassati, ruotando così la pesante imbarcazione in modo che la prua fosse in linea con la poppa avversaria a una distanza pari alla metà della gittata di una freccia. I remi di sinistra erano quindi affondati nell'acqua, il rullo del tamburo si era intensificato, la nave di Connor si era messa all'inseguimento della bireme, che per la prima volta aveva dovuto navigare in acque piene di secche, nel ruolo di preda. A questo punto il capitano nemico si era trovato inerme. Convinto di essere più abile del suo avversario, aveva allentato la vigilanza e sottovalutato la minaccia. Un errore fatale. A ogni colpo di remi, sotto la chiglia della sua imbarcazione l'acqua era diventata sempre più bassa; d'altra parte il pericolo di venire speronato da Connor gli aveva impedito di spostarsi lateralmente. Mostrando grande coraggio e determinazione, aveva allora fermato la nave per tentare di sottrarsi all'inevitabile. Nel breve arco di tempo necessario ad affondare una sola volta i remi, i suoi uomini avevano cominciato a remare all'indietro così subitaneamente che lo stesso Connor era stato colto di sorpresa. Una manovra geniale, che lui stesso non aveva potuto fare a meno di ammirare, sebbene si fosse premurato di neutralizzarla, cambiando la rotta della propria bireme in modo da affiancare il nemico invece di speronarlo direttamente a poppa. Mentre i due vascelli si accostavano, i vogatori di Ironhair avevano cercato di ritirare i remi e ci sarebbero riusciti se la bireme di Connor non fosse stata troppo vicina e i suoi uomini non avessero reagito con immediatezza. Quelli che operavano sul fianco sinistro avevano levato i remi verticalmente prima che quelli di destra del vascello avversario tentassero di fare lo stesso. Scivolando lungo il fianco destro dell'imbarcazione di Ironhair, la bireme di Connor ne aveva spezzato i remi quasi fossero stati ghiaccioli, e facendo strage anche degli uomini che, incatenati, erano stati colpiti da una pioggia di schegge. I pochi che, seduti a prua, erano riusciti a ritirare i remi erano stati travolti dalla confusione che era scoppiata alle loro spalle. Mentre i rematori di sinistra si erano trovati in posizione sopraelevata sull'acqua, quelli della parte anteriore destra della nave di Connor avevano dato fondo alle loro forze per portare la bireme di fianco alla preda. Non appena erano stati sufficientemente vicini, le due passerelle, a prua e a poppa, si erano abbassate artigliando il ponte della nave nemica e creando un passaggio sul quale gli Scoti si erano avventati come una marea urlante. Ambrogio, Tress e io ascoltavamo a bocca aperta la descrizione dello scontro. Il successivo combattimento corpo a corpo era stato breve e decisivo; era stato un bene che nessuno dei suoi uomini fosse incatenato ai remi, e che di conseguenza tutti avessero potuto combattere. Connor si era impossessato della bireme e, salvo gli schiavi e gli uomini del comando, aveva gettato l'equipaggio in mare, lasciandolo libero di annegare o raggiungere la salvezza a nuoto. Soltanto in quel momento aveva prestato attenzione a quanto succedeva alle altre imbarcazioni della sua flotta. L'intera costa era ricoperta dei resti dei pescherecci e dei piccoli velieri che si erano accodati alle navi da combattimento. Aveva saputo successivamente che gli Scoti avevano ottenuto una vittoria strepitosa, infliggendo pesanti perdite al nemico, affondando nove delle venti galee e catturandone o danneggiandone gravemente altre cinque. Soltanto sei erano riuscite a fuggire. Il prezzo della vittoria era stato di tre galee affondate e due incendiate. Molti degli uomini di queste cinque navi erano stati tratti in salvo. Mi allietava la buona nuova della vittoria, ma ero impaziente di sentire che ne fosse stato di Ironhair e Carthac. Le informazioni di Connor al riguardo mi lasciarono penosamente sorpreso. Nessuno dei due uomini si era trovato a bordo della bireme. Il capitano, catturato, aveva riferito che Ironhair non era con la flotta e neppure in Cambria con gli eserciti. Non si trovava neppure in Cornovaglia, anzi da più di due mesi nessuno lo vedeva. Era lontano, insieme a Carthac, impegnato a rafforzare l'esercito. A quelle notizie Connor si era messo immediatamente sulle mie tracce, dapprima navigando verso nord dove i contingenti di Huw premevano sullo sfortunato nemico ormai ridotto a combattere su una stretta lingua di terra, poi muovendo rapidamente a sud e a est per intercettarmi a Cardiff. Essendovi giunto troppo tardi, si era di nuovo spinto verso meridione dove aveva trovato la flotta di suo fratello Brander ancorata nel punto della costa più vicino a Camelot. Si era quindi mosso nell'entroterra, arrivando alla colonia prima di noi. Le notizie di Connor su Ironhair non mi giungevano affatto gradite, perché avevo confidato che lo scontro si sarebbe concluso con la cattura o la morte di quel mio irriducibile nemico. Sapere che era ancora vivo, e quindi una minaccia, mi lasciò muto e sgomento. Sentivo le dita di Tressa che si stringevano intorno alle mie e la sua mano che premeva la mia, ma non sapevo se lo facesse per darmi coraggio o condividere la mia angoscia. Ambrogio e Connor sedevano in silenzio, con lo sguardo fisso su di me, in attesa che parlassi. Ambrogio aveva la fronte aggrottata, perplesso. «È ancora vivo» dissi alla fine. «Vivo e pericoloso. Non è quello che speravo e che mi occorreva! Che sia maledetto!» «Non sono buone nuove, fratello» intervenne Ambrogio ancora più corrucciato in viso. «Ma voglio chiederti una cosa, e sappi che la mia domanda deriva da ignoranza e curiosità. Perché quest'uomo crea tanta ansia in te? Mi sembra che te la prenda troppo. So che siete nemici, so anche che in passato lui ha cercato di corrompere qualche persona che ti era vicina. L'hai cacciato da Camelot, ma lui non ha mai tentato di tornare. Perché basta pronunciare il suo nome per provocare la tua furia? Peter Ironhair non ha mai costituito una minaccia diretta per Camelot. Non ci ha mai attaccato direttamente. Ha invaso la Cambria, certo, ma solo per venire in aiuto a Carthac Pendragon, che, per quanto appaia grottesco, potrebbe aspirare al trono per via dei suoi legami di sangue. Forse pretestuosamente Ironhair gli ha dato un appoggio. Ma per le sue gesta in Cambria non crucciarti troppo. Se mai muoverà contro Camelot, allora avrai tutte le ragioni per volerlo morto. Nel frattempo credo che le tue ansie siano eccessive e che tu faccia male a comportarti così.» Lo fissavo mentre parlava, senza neppure tentare di nascondere il mio stupore e, lo confesso, il mio disappunto. Per la prima volta avevo manifestato le mie convinzioni e motivazioni. Sentirlo esprimere il suo disaccordo in modo così netto, mi mandò il sangue alla testa, e a fatica cercai di frenare la lingua e non ribattere con asprezza. Mi sforzai di fare mie le parole di Ambrogio e, per quanto mi era possibile, di valutare in modo imparziale il mio atteggiamento e vedermi con i suoi occhi. Ma non ci riuscii: la rabbia esplose sopraffacendo ogni pensiero razionale. Ambrogio capiva di avere provocato quel mio sfogo. Ma aveva parlato con sincerità e senza paura. Il silenzio si protrasse. Seduto immobile, Connor pareva una statua; Tress, lo intuivo, teneva gli occhi bassi. Risposi quando finalmente fui sicuro di poter parlare con calma. «Vediamo se riesco a soddisfare la tua curiosità. Conosci il vecchio detto: "Il nemico del mio nemico è mio amico"?», e quando annuì, proseguii: «Immagino che accetti questo principio, non è così?». «Sì, credo di sì» assentì stringendosi nelle spalle. «Che cosa ne dici del corollario: "Il nemico del mio amico è mio nemico"? Sei d'accordo? Non rispondere ora, perché in questo momento non è importante. È importante invece che io ci creda. Tu e io non abbiamo ancora parlato delle ultime fasi della campagna in Cambria, ma la svolta c'è stata quando Huw Fortebraccio divenne il condottiero di tutta Pendragon. Huw non ha ambizioni per se stesso: se ne avesse, da tempo si sarebbe messo in lotta per il trono. Oggi è un signore della guerra. Ha giurato che si batterà per l'onore e la libertà di Pendragon in Cambria, al servizio dell'uomo che ritiene il vero re, l'erede del sovrano al quale fu fedele fino all'ultimo, Uther Pendragon. Huw oggi regna, o regnerà, in Cambria quale reggente di Artù, proprio come Flavio Stilicone governò a Roma quale reggente del giovane imperatore Onorio.» «Speriamo che faccia meglio di Stilicone» borbottò Ambrogio. Non coglievo nulla di divertente in quella risposta. «Lo ritieni improbabile?» «No, naturalmente.» Scuotendo la testa, Ambrogio cercò di Placarmi. «È stata una battuta infelice. Continua, per favore. Non sapevo nulla delle vicende di Huw Fortebraccio. Ritieni davvero che si schiererà a favore delle rivendicazioni di Artù?» «Indubbiamente. Ho portato con me Llewellyn, il più fidato dei capitani di Huw, fabbro e soldato. Condurrà Artù con sé in Cambria, in incognito, perché stia tra la sua gente per un anno e ne apprenda i costumi e i modi di vita. Il progetto mi rallegra perché sono convinto che gli gioverà adattarsi a nuove abitudini, sottratto alla tua e alla mia influenza. Ma ora che vengo a sapere che Ironhair è vivo e vegeto, che sta raccogliendo un esercito da qualche parte, ne sono preoccupato. Nel caso di una nuova invasione, il giovane Artù sarebbe isolato, senza il nostro aiuto.» «Qualora preparasse una nuova invasione, mentre Artù è in Cambria, Ironhair sarebbe, in tali circostanze, una minaccia alla pace e un pericolo per nostro nipote...» «Anche mio nipote!» interloquì Connor. «Sì, anche tuo nipote» proseguì Ambrogio. «In tal caso tutto cambierebbe. Non ero al corrente del tuo progetto.» Annuii, ammansito, e continuai. «Grazie per queste parole, ma ascolta ancora. Ho avuto modo di conoscere Peter Ironhair, e so che uomo è. Tu no. In diverse circostanze, di lui arriverei a dire che è simpatico. Ha molte qualità - acuta intelligenza, grande forza, notevole arguzia - e sa mostrarsi generoso con gli amici e con gli alleati. Molti lo seguono istintivamente, perché ha le doti del capo. Ma ha anche alcuni tratti detestabili. Qualcosa non va in quell'uomo, qualcosa dentro di lui, e non si tratta di ambizione. L'ambizione la tollererei. Si è dimostrato essenzialmente venale e traditore, un essere infido e spregiudicato, capace di tutto per conseguire i propri scopi. Esperto in intrighi, corrompe e seduce gli amici portandoli al delitto. Una serpe. Lo ucciderei senza alcuno scrupolo come si uccide una vipera, e poi ne sarei lieto, perché avrei eliminato un pericolo dal mondo. Lo odio, ma soprattutto lo temo e ne diffido, non l'uomo in sé, ma la sua malvagità. Mi sentirei meglio se sapessi che è morto.» «Comincio a capire» disse Ambrogio arricciando il naso. «No, Ambrogio, sono sicuro di no. Non hai mai conosciuto Julia, la moglie di Ettore e la madre di Bedwyr, una donna dolce e amabile, che non ha mai fatto male a nessuno. Morì per mano dei sicari che Ironhair mandò a Camelot con l'incarico di eliminare il piccolo Artù. Se non altro per punirlo di quel delitto ho giurato che un giorno lo avrei ucciso. Prima di allora, Camelot era un vero paradiso terrestre. Ironhair ha distrutto l'innocenza e ci ha costretti ad andarcene, impauriti e diffidenti.» Intervenne Connor cambiando argomento. «Hai detto che sta rafforzando il suo esercito. Come può farlo? So che usa truppe mercenarie, ma da dove prende l'oro per pagarle? I mercenari sono sanguisughe, avidi di denaro. Chi non li soddisfa lo fa a proprio rischio e pericolo.» «No, Connor, Ironhair non ha bisogno di soldi.» I miei compagni mi guardarono aspettando che spiegassi la mia affermazione. «Ne ho parlato più volte con Huw e Llewellyn. I mercenari di Ironhair non sono della Britannia, molti vengono dalla Borgogna, dalla Gallia, alcuni sono Franchi. I Borgognoni già davano fastidio ai Romani molto prima che le legioni si ritirassero dalla Gallia; si è combattuto aspramente nell'intera regione dall'altra parte del Mare Stretto. Sono terre assai più popolate della Britannia, e vi domina l'anarchia. Vi vivono migliaia di uomini diseredati, banditi e briganti. Sono le truppe di Ironhair. Promette loro il bottino di cui si impadroniranno in Britannia; promette loro abbondanza di cibo, di donne, di alcol; promette loro una casa. Accorrono in gran numero ad arruolarsi sotto le sue insegne perché combattono nel proprio interesse; sono nemici crudeli e implacabili. La sua unica difficoltà è tenerli sotto controllo, ma poiché li lascia scorazzare liberi di fare quello che vogliono purché servano al suo scopo, si tratta di una difficoltà irrilevante.» Seguì una pausa e in quel momento qualcuno bussò alla porta. Lanciai un'occhiata ad Ambrogio, che stringendosi irritato tra le spalle chiese urlando chi fosse. Riconobbi immediatamente la voce pacata di Artù, e lasciando la mano di Tressa, mi avviai a grandi passi verso la porta. L'aprii atteggiando il viso a un sorriso che mi si gelò sul viso non appena mi trovai davanti a un giovane alto come me, che mi guardava negli occhi senza dover alzare il volto. Non avrei mai immaginato che in quei pochi mesi fosse cresciuto tanto. Lo avevo lasciato ragazzo sulla soglia di diventare adulto e lo ritrovavo uomo fatto. Indietreggiai di un passo, fissandolo. Percepivo la presenza di una giovane donna alle sue spalle, ma la ignorai intento com'ero a scrutare Artù Pendragon e a notare i cambiamenti che scorgevo in lui. Esitava sulla soglia, sorridendo timidamente verso di me e annuendo incerto in direzione di Ambrogio, Connor e Tressa quasi a volersi scusare della sua intrusione. I suoi occhi tornarono a posarsi su di me. «Sii benvenuto, Merlino» disse con voce esitante. «Mi sarebbe piaciuto accoglierti al tuo arrivo. Non ti aspettavamo fino a domani. Ne sono dispiaciuto.» Mi avvicinai a lui, allargando le braccia e stringendolo al petto con vigore. Restituì l'abbraccio, quindi mi scostai per osservarlo meglio. «Sei cresciuto. Lo immaginavo, ma nessuno mi aveva avvertito che eri diventato un uomo.» Sorrise, ma prima che potesse rispondere, mi misi di lato per stringere la mano alla giovane Morag che se ne stava timidamente alle sue spalle. «Entra, Morag, sono lieto di rivederti. Com'è andata la caccia? Conosci già Ambrogio e Tress; conosci anche Connor, lo zio di Artù?» Annuì lanciandogli un sorriso, rivolse un lieve cenno del capo ad Ambrogio e Tressa, quindi tornò a mettersi al fianco di Artù. «Abbiamo ucciso un cervo» disse questi rispondendo per lei. «Un bell'animale. Ma sono stato io a colpirlo, perché all'ultimo momento Morag non se l'è sentita di farlo.» Si strinse nelle spalle sotto il mio sguardo indagatore. «Lo avrei lasciato andare, ma Shelagh lo aveva inseguito tutta la mattina. Non volevo sembrarle ingrato.» «Hai deciso per il meglio» lo rassicurai sorridendo. «Naturalmente stai bene...» «Sì... Perdonatemi per avervi interrotto... Volevo vederti, Merlino, e darti il benvenuto.» «Non crucciarti... sono contento che tu sia venuto. Sei appena tornato?» «Non te lo dice l'odore del sudore? Sono venuto qui di corsa senza neppure togliere la sella al cavallo.» «Vergogna! A cosa ti sono serviti i miei insegnamenti? Corri dal tuo cavallo. Quando sarai pronto, avremo finito anche noi, e allora staremo insieme.» Rimasi vicino alla porta, tenendola socchiusa mentre i due giovani si allontanavano. Artù era alto e forte, stretto in vita e largo di spalle, con gambe muscolose e lunghe. Indossava una tunica imbottita di color verde, stretta da una cintura, che metteva in risalto l'ampiezza delle spalle; i gambali erano infilati in un paio di stivali di un cuoio morbido ed elastico. I capelli scuri gli ricadevano sulle spalle. Quando furono a una decina di passi, Artù cingendo con il braccio la vita di Morag richiamò la mia attenzione sulla figura della giovane che, come notai, si era lasciata alle spalle le forme infantili. Sentivo la presenza di Ambrogio dietro di me. «Che ne dici? Non c'è ombra di dubbio che è della nostra stirpe, eh?» «No» gli detti ragione. «È uno di noi... per come è diventato alto e forte e per come guarda una bella ragazza. Sono... cioè...» «Vuoi sapere se fanno l'amore? No, a meno che non mettano in atto qualche magia. Quella giovane donna è guardata a vista, non meno di come fai tu con la tua spada. Re Brander osserva i suoi doveri con grande senso della responsabilità. I due ragazzi sono sempre insieme, ma non rimangono mai soli per il tempo che sarebbe necessario a combinare qualcosa. Se Shelagh non li accompagna, sono sotto gli occhi di Brander, o di Salina, o di Tress oppure sotto il mio sguardo. Non hanno il tempo di macchinare qualcosa. Non del genere amoroso per lo meno.» Connor, che nel frattempo se ne era stato in silenzio, prese a ridacchiare, quasi fosse stato a parte di un segreto. Colsi il suo sguardo. «Che hai da sogghignare, Connor?» «Niente, niente!» protestò con aria innocente. «Sono impressionato dall'efficienza delle misure di sicurezza in vigore a Camelot, perché una cosa so per certo: se fossi mio nipote e fossimo nelle nostre isole, niente, né in terra né in cielo, riuscirebbe a impedirmi di infilarmi tra le gambe della mia bella.» «Connor Mac Athol, sei un rubacuori» intervenne Tressa prima che riuscissi a rispondere. «Nessuna donna potrebbe resisterti. Non è quello che dici? Ma qui si tratta di una storia d'amore tra un giovanotto squisito e una dolcissima fanciulla vegliata continuamente. Sta' attento, perché un giorno voglio proprio sentire da tua moglie come te la cavi.» «Che linguaccia per essere così bella e giovane» ribatté Connor con un sospiro profondo. Tornai a guardare Ambrogio. «Non avrei mai creduto che potesse crescere così in fretta. È un gigante. Come si è comportato durante il viaggio? Ti ha dato seccature?» «È stato impeccabile, meglio di come avrei creduto. Mi aspettavo che gli ci volesse un po' di tempo per adattarsi a me dopo essere stato così a lungo sotto la tua protezione, ma non ci sono state difficoltà di sorta. Fin dal primo momento, quando ci siamo avviati sui nostri cavalli, si è dimostrato disponibile a imparare, pronto ad assorbire tutto quello che gli dicevo e adeguarsi prontamente ai miei desideri e alle mie abitudini. L'ho tenuto sotto pressione impegnandolo senza posa, ma ci sono state volte in cui ci siamo scambiati idee e opinioni che sono servite a farci conoscere meglio. È un giovane ammirevole; di lui hanno stima anche le mie truppe. Una volta, durante il viaggio, quando non c'era più nulla da temere da parte di Horsa, lo mandai in una missione di pattugliamento con un gruppo di Scoti, quale osservatore e sotto la costante sorveglianza dei miei comandanti. I rapporti che mi vennero inoltrati su come si era comportato furono così eccellenti che alla fine mi convinsi ad affidargli il comando di un'azione di ricognizione. Non trascurai tuttavia di mettergli al fianco uno dei miei decurioni anziani, tanto per essere sicuro che niente andasse storto. Se la cavò magnificamente dimostrando di non avere bisogno di tutela.» «Lo sapeva di essere sotto sorveglianza?» chiesi ricordando che mio padre e lo zio Varro avevano fatto lo stesso con me e Uther in occasione della nostra prima spedizione ricognitiva. «Non credo che abbia avuto sospetti» mormorò Ambrogio. «Se se n'è accorto, l'ha nascosto benissimo.» «Da quanto tempo è qui Morag?» domandai chiudendo la porta perché ormai la coppia si era allontanata ed era uscita dal nostro campo visivo. Ambrogio fece un segno della testa verso Tressa. «Tre settimane, Tressa?» «Quasi quattro. È arrivata la settimana dopo che tu e Artù siete tornati.» Mi si avvicinò e mi cinse alla vita con un braccio. Per qualche tempo discutemmo della situazione nella Cambria e alla fine decidemmo che per tutto l'imminente inverno avremmo mandato spie in Cornovaglia per cercare di capire quello che aveva in mente Ironhair. Connor partecipava appena al dibattito, e gli chiesi quanto contava di fermarsi. Alzatosi in piedi e stiracchiandosi, in precario equilibrio su un piede e sulla gamba di legno, annunciò che sarebbe partito la mattina dopo. «E tuo fratello?» «Brander? Che cosa vuoi sapere di lui?» «Ha chiesto di conferire con me e, stando ad Ambrogio, non gli ci vorrà molto tempo. Poi partirà. Ha varie faccende di cui occuparsi. Potreste raggiungere insieme la costa, se entro stasera riesco a finire con lui.» «D'accordo» acconsentì Connor. «Andrò a dormire per un po'. Sto invecchiando. Se non compaio a cena, manda qualcuno a svegliarmi.» Quella sera a cena sedetti vicino a Brander e a sua moglie. Fu subito chiaro che non c'erano molte cose da dibattere: a Brander stava a cuore assicurarsi che fossero rinnovati i contratti di affitto di Liam il Gobbo sulle terre meridionali di Huw Fortebraccio per un minimo di tre anni fino a un massimo di cinque. Si erano accorti che le nuove razze di bovini non si adattavano all'asprezza degli inverni nordici e avevano bisogno di pascoli in zone più miti. Non c'era motivo di dubitare che Huw avrebbe acconsentito al ritorno di Liam perché la convivenza era stata di reciproco vantaggio e Liam si era ingraziato i Pendragon che vivevano a sud, i quali sapevano essere assai poco cordiali, quando così a loro andava. Dissi a Brander che Huw era sopravvissuto alla guerra in Cambria e che non ci sarebbero state difficoltà a trovare un accordo. Il nuovo re assentì con aria benevola, convinto ormai di potersene tornare in patria con la certezza di un futuro di pace. I due fratelli concordarono di partire insieme il giorno successivo. Mentre li ascoltavo, cominciai a chiedermi quale sarebbe stata la reazione di Artù. Guardandomi intorno nel refettorio, lo scorsi con i suoi amici Bedwyr, Gwin, Ghilly, intenti tutti insieme ad ascoltare Dedalo. Ded era solito intrattenere i convitati con storie di guerra, di straordinari eventi o più di frequente con battute di umorismo nero. Non avevo ancora finito di formulare questo pensiero che l'intera tavolata scoppiò a ridere, i giovani con altrettanta allegria dei soldati anziani. Sporgendomi in avanti sulla destra, scorsi Morag seduta accanto a sua madre, con il viso rivolto alla vivace e rumorosa brigata. Che Artù si sarebbe dispiaciuto per la partenza della giovane era indubbio. La nuova avventura in Cambria sarebbe stata un efficace rimedio. Con l'energia e la curiosità dei giovani avrebbe saputo seppellire il dolore, distratto dalle difficoltà del nuovo compito che gli si prospettava. Decisi sui due piedi di allontanarlo in fretta. Il gomito destro di Tressa mi si affondò nelle costole mentre la sua mano sinistra si posava sulla mia. «Stai guardando un'altra donna, Caio Merlino. Dovrei ingelosirmi?» Mi volsi verso di lei e le accarezzai una guancia. «Perdonami, amor mio. Non credevo che te ne saresti accorta.» Poi le sorrisi scuotendo la testa. «Pensavo ad Artù. Che cosa farà quando Morag partirà?» «Sarà diverso stavolta» rispose lanciando uno sguardo ad Artù. «Allora si conobbero e subito si separarono. Questa volta sono stati insieme per settimane. Non si sono mai lasciati, ma sapevano che si sarebbero di nuovo divisi non appena tu fossi tornato. Avranno fatto qualche progetto per rivedersi. Vedrai, amor mio. Non ci sarà rabbia questa volta: dispiacere ma non rabbia.» Mi era vicinissima e io sentivo la fragranza dei suoi capelli puliti e il profumo delle erbe aromatiche che portava in un piccolo portaprofumi sul petto. Pieno d'amore per lei, le posai una mano sulla coscia, sotto il tavolo, ma la tolsi immediatamente dopo una breve stretta. Dovevo in ogni modo tenere la mente lontana dai piaceri che mi erano irresistibilmente vicino. Accorgendosi che avevo ritirato la mano, mi sorrise. «Sii paziente, amor mio. Quanto ancora dovrai fermarti a parlare dopo cena?» «Poco, spero» dissi con un profondo sospiro. «Forse dovrò intrattenermi con il vescovo Enos per qualche tempo, ma soltanto domani incontrerò i legati della Northumbria. Per prima cosa, quindi, il vescovo Enos; subito dopo mi sentirò costretto a sottoporre alla tua attenzione alcune questioni, questioni urgentissime, che, spero, vorrai aiutarmi a risolvere rapidamente e piacevolmente.» «Rapidamente?» disse sorridendo. «Sì, tanto per cominciare. Piacevolmente? Questo te lo prometto. Ma dovrai dedicarmi un bel po' di tempo, comandante Merlino. Intendo intrattenerti a piacer mio e tuo.» Mi afferrò la mano inerte e lentamente ne baciò il dorso per farmi sentire la pienezza delle sue labbra. Mi schiarii la gola e spinsi la sedia all'indietro, chinandomi per carezzarle l'orecchio con la mia bocca, e mi sentii pervadere dalla dolcezza del suo profumo. «Non resisto più» le sussurrai. «È più di quanto sia capace di sopportare. Se mi concedi licenza, vado subito dal vescovo sperando che quanto avrà da dirmi mi lascerà tornare immediatamente da te.» Chinò la testa sorridendo lievemente, e io mi accinsi a raggiungere Enos che sedeva insieme ai suoi prelati. Vedendomi, fece l'atto di levarsi, ma da lontano gli indicai di restare seduto. Mi avvicinai a lui e gli posai una mano sulla spalla, consapevole della curiosità di tutti gli altri vescovi che mi squadrarono e subito distolsero lo sguardo fingendo di volerci lasciare parlare in privato. Il vecchio si piegò di lato e prese a fissarmi, il viso tranquillo e un sorriso accattivante in attesa che cominciassi. «Perdonatemi, eminenza, se vi ho trascurato finora. Non era mia intenzione. So che avete qualche informazione da darmi...» «Sono io che dovrei chiedervi venia, Caio Merlino» mi interruppe levando la mano per arginare le mie parole mentre il sorriso gli si allargava in viso. «Le notizie che porto sono destinate a voi, ma non sono così urgenti da dover essere ascoltate subito. Mi dispiace di avervi dato questa impressione. Siete appena tornato e vi aspettano nuove responsabilità. Il tempo è prezioso per voi. Credetemi se vi dico che non c'è fretta. Ci sono re e uomini di alto rango che desiderano conferire con Caio Merlino: le loro esigenze vengono indubbiamente prima delle mie. Sono qui per porgervi gli auguri di un uomo che si è raccomandato che ve li esprimessi di persona.» Ero sul punto di rispondere, ma con un lieve e aggraziato movimento della mano mi invitò al silenzio. «Non vi dico che la semplice verità, Caio. Vi porto soltanto dei voti augurali... non sono latore di ambascerie che richiedono l'immediata attenzione, non porto notizie di catastrofi o dolori.» «Avete notizie di Germano?» «Sì, dalla Gallia. Veniamo da lì con un incarico da parte sua. Vi considera uno dei pochi amici stretti e fidati che abbia in Britannia. Sarete felice di sapere che sta bene, sebbene sia oppresso dal lavoro e abbia troppe preoccupazioni. Ho una sua lettera per voi.» «Vi ringrazio. Mi avete incuriosito. Quali doveri può il vescovo di Auxerre avere assegnato ai vescovi della Britannia? Certamente agisce al di fuori della sua giurisdizione.» «Sarebbe così se il nostro impegno fosse esclusivamente con il mondo degli uomini, ma quando si tratta dell'anima immortale e del rapporto con Dio, il concetto di giurisdizione terrena perde significato.» Quelle parole mi coglievano di sorpresa e, spinto dal desiderio di saperne di più, chiesi al vescovo di spostarsi sulla panca perché potessi sedermi vicino a lui. Ci furono sussurri intorno alla tavola mentre i convitati si stringevano per farmi posto. Borbottai un ringraziamento prima di tornare a dedicare tutta la mia attenzione al prelato. «Pelagio? Ancora? Pensavo che la controversia si fosse conclusa.» «Ne eravamo convinti anche noi l'ultima volta che l'abbiamo affrontata. Come ricorderete, il dibattito fu lungo. Non tutte le conclusioni cui arrivammo allora furono di piena soddisfazione per alcuni. Erano chiare e i precetti avevano efficacia assoluta: Pelagio fu dichiarato eretico e blasfemi i suoi insegnamenti. Non ci sarebbero state sanzioni e castighi per chi riconosceva l'errore e si adoperava per porvi rimedio. Furono istituite alcune scuole nelle quali la parola divina sarebbe stata insegnata con somma chiarezza secondo i principi dei Padri della Chiesa. I vescovi che, trasgredendo queste regole, continuavano per la strada additata da Pelagio erano automaticamente scomunicati, allontanati dal consorzio della Chiesa. Naturalmente non potevano né ricevere né amministrare i sacramenti.» Non tentai di nascondere la mia perplessità. «Lo ricordo; i vescovi convocati avevano accettato questa linea di condotta. Forse alcuni avrebbero dissentito, ma concordarono e si impegnarono ad attenersi ai principi dei Padri. Ero presente. Può darsi che non abbia capito tutti i punti, ma ricordo le conclusioni. Germano stesso me le spiegò. Rappresentavano un punto fermo. Come mai ora insorgono nuove difficoltà?» Enos abbassò gli occhi sul piatto di legno davanti a lui sulla tavola, e io seguii il suo sguardo. Il piatto era pulito e vuoto, salvo che per l'ossicino di qualche volatile e alcune briciole di pane. Aveva mangiato poco. Tese la mano e con un dito premette un paio di briciole, portandosele alla bocca. Fu un gesto lento, pensoso. Con un sospiro volse lo sguardo su di me. «Vi ricordate di Agricola? Il vescovo, non il soldato.» Corrugai la fronte cercando di rivangare nella memoria e di lasciare da parte il ricordo di Giulio Agricola dell'antichità. «Il vescovo Agricola? Sì, lo incontrai a Verulamium, credo, nell'accampamento di Vortigern, se la memoria non mi tradisce. Erano amici, anche se non stretti. Vi riferite a lui?» «Sì, era e rimane il più illustre tra i maestri del credo di Pelagio. Vortigern, che simpatizzava per quei principi sebbene non li abbia mai adottati apertamente e non ne sia mai diventato un seguace, accolse Agricola nelle sue terre e gli consentì di viverci. Aveva un confidente e amico, Fastidius. Lo avete conosciuto?» «No, credo di no. Perché?» «Agricola e Fastidius erano in gioventù seguaci di Pelagio. Oggi sono vecchi, ma ancora seguono le dottrine apprese nella giovinezza e le insegnano contravvenendo alle leggi.» «È terribile! Sono uomini di Dio e hanno accettato pubblicamente di attenersi ai principi stabiliti a Verulamium. Se recedessero dall'impegno assunto, si esporrebbero all'accusa di essere ipocriti e infidi. Sarebbero certamente colpiti da scomunica.» Sentivo che intorno a me gli altri vescovi ascoltavano apertamente quello che dicevamo; lanciando uno sguardo a uno di loro, seduto all'altro lato della tavola, Enos emise un sospiro e scosse la testa. In quel momento, dalla parte anteriore del salone, giunse un'esplosione di suoni: erano entrati alcuni dei musici di Connor e stavano accordando gli strumenti in preparazione dello spettacolo. Tendendo la mano, Enos mi afferrò il polso, mentre il volto gli si velava di un'espressione che mi parve di rassegnazione. Annuendo con la testa, indicò i musici. «Mi avete portato lontano con il mio discorso, Caio, e ora io vi accompagnerò per il resto della strada. Perché non usciamo? Tra qualche istante non potremo più parlare.» Mi alzai per seguirlo in cortile, lanciando nel passare uno sguardo di intesa e un sorriso a Tressa, e facendole con la mano segno che mi aspettasse. Usciti dal rumoroso salone e avvolti nel silenzio fresco del cortile vuoto, Enos mi condusse verso una panca lunga e bassa contro il muro nord. Si sedette e intorno alle spalle si strinse il mantello per ripararsi dall'aria autunnale già gelida. «Dove eravamo rimasti?» chiese sistemandosi. «Ah, sì. Discutevamo dell'atteggiamento assurdo di un uomo di Dio che sfida i precetti della fede e si espone alla minaccia di essere scomunicato.» «Sì, è ridicolo.» «Certamente.» Mi guardò pensoso, la testa china da un lato. «Spero che mi perdonerete, Caio Merlino, se vi sembrerà che sia l'ignoranza a dettarmi le parole. Non ci conosciamo bene, noi due. Sono stato il confessore di vostra zia Luceia e ho raccolto i suoi più riposti pensieri, ma voi e io non ci siamo frequentati. So che avete conosciuto Germano, mio santo fratello, sulla via che conduce a Verulamium, e che lo avete aiutato a ottenere una clamorosa vittoria contro le forze pagane avversarie, ma credo che conosciate poco Pelagio e i suoi insegnamenti. Ho ragione?» «Su Pelagio avete perfettamente ragione. Lo conosco poco. Ma ancora meno so della clamorosa vittoria cui avete accennato. A che cosa vi riferite? Conobbi Germano mentre con la sua gente era stato intrappolato dai banditi in una fattoria abbandonata. Li salvammo senza gravi perdite per noi. Ma era stata una scaramuccia, non una battaglia con i suoi vincitori e i suoi vinti. In seguito non ci furono altri combattimenti, tranne uno scontro irrilevante con aspiranti banditi a Verulamium. A quale vittoria vi riferite?» «La vittoria dell'Alleluia, come viene comunemente chiamata.» «Cosa?» «Lasciate che vi spieghi» disse Enos levando una mano. «Stando al vescovo Germano, che mi riferì tutta la storia per protestare contro la versione che ne era stata data, lui e i suoi uomini, ritenendo di trovarsi in una zona priva di pericoli, avevano trascurato la solita prudenza. Li accompagnavano, sì, alcuni soldati, ma altro non erano che una guardia d'onore, quello che rimaneva della guarnigione romana in Gallia, e avevano seguito Germano e gli altri ecclesiastici di loro iniziativa. Germano, che era stato soldato, procedeva armato di tutto punto per poter proteggere il corteo se mai si fosse profilata qualche minaccia. Si comportavano, com'è naturale, da chierici, non da militari. Passarono una notte in un casolare abbandonato e al mattino, al risveglio, si trovarono circondati da una schiera armata di Pitti e Sassoni. I prelati credevano che sarebbero morti tutti quand'ecco che da un'altura si scatenò una pioggia di frecce. I proiettili letali e precisi nella traiettoria seminarono il panico tra i nemici che si videro costretti ad abbandonare il bersaglio e fronteggiare i nuovi attaccanti. La ritirata consentì a Germano di condurre i suoi uomini fuori della trappola. E quando i prelati furono in salvo, si mise a capo dei pochi armati del suo seguito per inseguire gli aggressori. So che voi eravate uno degli arcieri appostati su quell'altura e che con altri due avete distratto gli assedianti dal loro obiettivo. Nel frattempo avete ordinato alla cavalleria di entrare nella valle da settentrione e di percorrerla in direzione sud per soccorrere gli assediati. Gli attaccanti, riconoscendosi vinti, si spaccarono in gruppetti che furono facilmente schiacciati.» Tacque e mi sorrise. «È una ricostruzione precisa di quanto accadde quel giorno?» «Precisa, salvo il fatto che io, dall'alto della collina, non avevo capito che cosa avesse scatenato lo scontro.» Mi fermai stringendomi nelle spalle. «Sì, si può parlare di vittoria, ma non fu clamorosa. Ci capitò di trovarci nel luogo giusto al momento giusto con il giusto contingente di uomini. I nemici erano una massa di sbandati. Il risultato era inevitabile.» Esitai. «Come mai fu chiamata la vittoria dell'Alleluia?» Enos ridacchiò, un mormorio sommesso ed esitante. «I vescovi sono uomini di Dio ma anche uomini come tutti gli altri. Per voi fu una schermaglia, una delle tante, un piccolo incidente, avete detto, che si concluse con perdite irrilevanti. Ma i vescovi, Caio Merlino, i vescovi! Ai loro occhi quell'avvenimento fu di ben diversa natura. Immaginatevi di vedere la scena con i loro occhi! Avevano viaggiato molto più a lungo e si erano spinti molto più lontano di quanto fossero mai stati soliti fare. Si erano accampati per la notte in una piacevole vallata, al riparo di un muro in rovina. Dopo avere pregato fino a tarda notte, si erano coricati per trovarsi, al risveglio, a dover fronteggiare una morte crudele per mano di selvaggi dal corpo dipinto e di Sassoni dagli elmi ornati di corna che urlavano di volerli sterminare. Germano, loro guida spirituale e loro condottiero, non era in grado di proteggerli. Non poteva contrattaccare, c'era un'unica via d'uscita, e questa era sorvegliata dai nemici. Gli uomini di Dio caddero in ginocchio e pregarono di avere salva la vita. E mentre pregavano una pioggia di frecce prese a cadere dal cielo uccidendo gli assedianti e mettendoli in fuga. Pochi istanti dopo, Germano li portò in salvo al di là della cinta del casolare nel quale si erano visti intrappolati. Li lasciò in luogo sicuro sotto la protezione di una scorta e con gli uomini armati si mise a inseguire il nemico. Prima di accingersi all'attacco gridò: "Alleluia, sia lode a Dio.". Non appena i vescovi in preda al terrore caddero in ginocchio per rendere grazie al Cielo, sentirono il rumore di un'altra schiera che si avvicinava e quando i nuovi salvatori, miracolosamente apparsi, passarono loro accanto, i vescovi tornarono a gridare: "Alleluia!" e l'invocazione fu ripetuta dai cavalieri al galoppo che si gettarono nella mischia con quel grido sulle labbra...» Tacque e per qualche tempo rimase a fissarmi prima di concludere. «Come vedete, figlio mio, siete stati testimoni, voi e loro, dello stesso avvenimento, ma lo avete vissuto in modi assai diversi. Per i confratelli chierici, rincantucciati vicino a quel casolare abbandonato, la salvezza fu opera miracolosa, un intervento divino che li soccorse nell'estremo pericolo. Ne sono convinti. Voi dite di esservi trovati per puro caso lì al momento giusto con il giusto contingente di uomini. Loro credono che foste mandati dal cielo in loro difesa nel momento del maggior bisogno. Se non fosse andata così, il vescovo Germano sarebbe morto e non si sarebbe mai svolto il concilio di Verulamium. Quale delle due versioni è la più attendibile? In quanto cristiano, potete mettere in dubbio la loro e negare che Dio sapesse che eravate nei pressi quel giorno?» «Ma... la portata dell'avvenimento, Enos! Si trattò di una scaramuccia!» «Ah!» Un'esclamazione sbrigativa e secca. «Le conseguenze furono di poco conto? Il concilio di Verulamium? Il vostro intervento quel mattino salvò la vita del vescovo e il Grande Dibattito sulla fede. Rafforzò le fondamenta stesse della Chiesa e significò il naufragio di un'eresia. Sono fattori, Caio Merlino, che ai miei occhi di vecchio, e agli occhi di molti altri, trasformano una scaramuccia in una grande vittoria. Che ne dite se lasciamo le cose come stanno? Se la modestia vi impedisce di riconoscere quello che avvenne in realtà, così sia! Immagino che sarete lieto di ascoltare quello che ne derivò.» Il sorriso si fece più ampio inducendo anche me a sorridere. «Che cosa ne derivò?» «Qualcosa che non ha niente a che fare con voi. In nessuna versione degli eventi viene fatto il vostro nome.» Il sorriso era quasi un'aperta risata. «La vittoria dell'Alleluia è di esclusiva pertinenza del vescovo Germano. Ecco perché ne è tanto tormentato. Ritiene che sia nobilmente offensivo nei vostri confronti e oltraggiosamente lusinghiero nei suoi. Devo dirgli che voi preferite che sia così?» «Ah!» gettando indietro la testa scoppiai a ridere, contento di allietare il vecchio vescovo. «Fatelo, eminenza! Mi rallegra sapere che una vittoria così clamorosa non ha nulla a che fare con me e con Camelot.» Rise anche lui. Poi chinandosi in avanti picchiettò le dita sulle mie ginocchia. «Siamo usciti dal seminato. Stavamo dicendo che altri vescovi sembrano incerti. Quanto alle dottrine di Pelagio, stavo per dire che a mio parere ne sapete poco. Ne avete convenuto, no?» Annuii guardandolo attentamente. «Sapete niente dei suoi insegnamenti?» continuò. «Sei erano le argomentazioni sulle quali poggiava la sua teologia... Le conoscete?» «No. Ne sentii parlare al Concilio, ma ne compresi ben poco. Simpatizzavo con quei principi, non perché li conoscessi ma perché li condivideva un vecchio amico di mio padre, il vescovo Alarico, un vero uomo di Dio.» «L'ho conosciuto da giovane, e sono del vostro stesso parere. Sei erano le tesi di Pelagio, e ve le illustrerò brevemente. Ciascuna si riferisce, separatamente o congiuntamente, a due principi fondamentali della fede cristiana: il peccato originale di Adamo e il dono divino della Grazia. Ricordate che stiamo parlando di eresia, quindi non lasciatevi incantare.» Cominciò a enumerare le tesi sulle dita della mano, cominciando dal mignolo della destra. «Uno: Pelagio sosteneva che la vita è inseparabile dalla morte. Insegnava che Adamo sarebbe morto, anche se non avesse peccato. Due, più sedizioso: affermava che il peccato di Adamo era personale. Puniva soltanto Adamo, non l'intera umanità. Tre, strettamente collegato al secondo: asseriva che il neonato è in stato di innocenza, come lo era stato Adamo prima del peccato. Quattro, forse la tesi più difficile da accettare: diceva che l'umanità non muore a seguito del peccato e della morte di Adamo, e neppure si risolleva grazie alla resurrezione di nostro signore Gesù Cristo. Cinque...» tacque prima di affrontare il successivo punto; io ascoltavo trattenendo il fiato. «Pelagio voleva farci credere che le antiche scritture, l'Antico Testamento contenente le leggi di Mosè, non sono da meno dei Vangeli per additare la via del Paradiso...» Aspettavo che continuasse, ma pareva smarrito nei suoi pensieri e intento a riflettere soprattutto su quest'ultimo punto, che dei cinque mi era sembrato il meno importante. Dopo un po', schiarendomi la gola, chiesi: «E il sesto?». «Cosa?» «Avete detto che le tesi di Pelagio erano sei. Me ne avete indicate cinque.» «Perdonatemi. Vediamo... La sesta: secondo Pelagio, c'erano uomini senza peccato anche prima dell'avvento di Cristo.» Respirai a fondo appoggiandomi con le spalle al freddo muro. Quell'ultima tesi mi aveva toccato in un punto dolente. Ne aveva accennato mio padre, seppure usando parole diverse. Il vescovo Alarico gli aveva insegnato che, anche prima di Cristo e della Redenzione, erano esistiti uomini pii e generosi, che avevano saputo distinguere tra il bene e il male, tra il giusto e l'ingiusto. Capivo che c'era una profonda differenza tra le due versioni di quel principio e per la prima volta dopo il viaggio a Verulamium, compiuto tanti anni prima, mi accorsi di non avere voglia di scrutare nell'abisso teologico che si spalancava davanti a me. Gli uomini, in particolare quelli di Chiesa, avevano un'infinita capacità di spaccare il capello in quattro. Enos, che non si era accorto della mia reazione, continuava a parlare. «Agricola e Fastidius erano i paladini di Pelagio a Verulamium, così come Germano e Lupo di Troyes, che lo accompagnava, erano i paladini della Chiesa. Entrambi accettarono di adeguarsi ai decreti stabiliti nel Concilio, ed entrambi così fecero, almeno ufficialmente, per parecchi anni. Di recente tuttavia, hanno abiurato e ripreso a praticare l'eresia. La vostra domanda sottintendeva l'incredulità che potessero essere così caparbiamente intransigenti e in coscienza devo dirvi che loro non credono di avere peccato abiurando. L'arroganza è riprovevole, ma non è peccato salvo che degeneri in orgoglio. Preferiscono non credere al peccato originale di Adamo e alla Grazia Divina intesa quale veicolo che dalla Chiesa conduce al paradiso e alla salvezza. Aderiscono, con arroganza diciamolo pure, all'antica concezione degli stoici greci, secondo la quale la forza morale dell'uomo, se rafforzata dall'ascetismo, è sufficiente alla salvezza. Da qui la semplificazione del loro credo: gli uomini hanno da sempre la capacità di scegliere tra il bene e il male; coloro che scelgono il bene - perché sconfiggono dentro se stessi i bassi istinti, o rifuggono il peccato o aspirano a Dio - possono salvarsi per i loro meriti. Un sentiero seducente e invitante per chi non è avveduto.» «Sì» ammisi parlando per la prima volta dopo un tempo che mi parve durasse da ore. «Soprattutto qui in Britannia dove gli uomini credono che la rettitudine morale e la probità personale siano virtù.» «Proprio così.» Enos mi lanciò un'occhiata penetrante mentre mi dava ragione. Mi chiesi se avesse percepito un tono ironico nelle mie ultime parole. «Questo però non ha niente a che fare con il fatto riconosciuto che i Padri della Chiesa hanno dedicato anni e anni a studiare il pensiero di Pelagio e hanno scritto molti libri sull'argomento per concludere, nella loro saggezza, che sul piano della dottrina quei principi erano inaccettabili. È stato proclamato eretico, e le sue opere sono state censurate. Agricola e Fastidius hanno operato una scelta e sono stati condannati, ma non si può ignorare il pericolo che rappresentano. Ecco perché Germano ritornerà in Britannia l'anno prossimo. Perdonatemi, forse vi ho guastato il piacere di leggere la lettera del vostro amico. Non volevo anticiparvi le notizie, ma Germano stesso mi ha chiesto di informarvi della sua intenzione. In tal modo non avrebbe dovuto impiegare lunghe ore per comunicarvelo per lettera.» Sbalordito com'ero, gli chiesi conferma di quello che mi aveva appena detto. «Germano allora ritorna? Dove è diretto?» «A Verulamium.» «È impossibile, Enos. Verulamium è nelle mani dei Danesi, dei Sassoni, degli Angli e di altri. Sono pagani e selvaggi, non hanno idea di che cosa siano l'amore, la tolleranza, gli insegnamenti di Cristo. Distruggeranno il vescovo cristiano che dimostra di essere così stolto da mettere piede nelle loro terre.» Lo vidi scuotere la testa e cercai di leggere l'espressione dei suoi occhi che mi parve di pietà. «Caio Merlino,» disse a voce bassa «che cosa noi, come vescovi, siamo tenuti a fare? Quali sono i nostri compiti? Lo sapete?» «Io...» la domanda mi aveva lasciato attonito. «Mostrate agli altri la via del Signore e insegnate i precetti della Chiesa.» «Così è. Ma chi sono questi "altri" cui vi riferite?» «Il gregge dei cristiani.» «Da dove viene questo gregge?» in quel momento provava davvero pietà per me. «Opero tra gli Angli delle coste orientali, la Costa Sassone, come la chiamate voi. E lo stesso fanno i miei confratelli, tutti e dieci. Noi siamo i pastori delle anime di quei poveracci che voi definite "invasori". Non tutti naturalmente, alcuni sono solo dei "nuovi venuti": è una parola più adatta e quella che preferisco usare quando mi rivolgo a loro. Molti di loro sono feroci e bellicosi, nessun dubbio su questo. Ma è una bellicosità che trae origine dalla paura perché, in quanto nuovi venuti, devono conquistare la terra sulla quale si insedieranno con le loro famiglie. Una volta che si saranno radicati, che si sentiranno sicuri e soddisfatti, l'ostilità si placherà e accetteranno gli insegnamenti del buon Gesù. Germano andrà a Verulamium con animo di pace e su di lui veglieranno gli abitanti di quelle terre, gli Angli. Non ho timori, neppure Germano ha timori. In quella regione il gregge dei fedeli si è stanziato da anni; alcune comunità vivono lì da generazioni. Non sono più pagani, non rappresentano un pericolo per i servi di Dio.» «Ma alcuni sono di certo minacciosi» non riuscii a trattenermi dal dire. «Alcuni, è vero. Ma cambieranno se e quando Dio vorrà. La volontà di Dio prevarrà sempre su quella degli uomini. Neppure gli imperatori di Roma, al vertice della loro potenza, riuscirono a soffocare la parola del Signore, a uccidere il Suo amore. Pensate che questi Sassoni incolti saranno più forti degli imperatori di Roma?» «Mi state dicendo che, andandovene da qui, vi dirigerete verso la Costa Sassone a predicare il Verbo alle popolazioni pagane?» «Sì, e mi premurerò anche di spargere la voce che l'anno venturo arriverà il vescovo Germano. I fedeli lo aspetteranno e la sua congregazione si riunirà.» «Che ne sarà dei due eretici, Agricola e Fastidius? Vi aspettate che lo riveriscano, dato che tutti li conoscono come apostati?» «Mi auguro che siano lì anche loro, ma non farà differenza. Le loro persone non sono in pericolo, dovrebbero preoccuparsi della loro anima e del fatto che impartiscono insegnamenti eretici a uomini semplici, pronti ad accettarli. A questo bisogna provvedere. L'ultimo Concilio di Verulamium è stato un dibattito. Il prossimo sarà molto diverso e comporterà l'esposizione di una dottrina, la stesura di una legge canonica, la condanna di questa eresia e di coloro che vi aderiscono.» «Non sarà pericoloso per Germano e i suoi seguaci?» «Pericoloso?» L'anziano vescovo sollevò le sopracciglia facendomi sentire sciocco, e la mia sensazione si accentuò quando mi sorrise. «Stiamo parlando di vescovi, Caio Merlino, non di soldati. Come potrebbe Germano essere in pericolo, e così gli altri?» «Proprio per quello che avete appena detto, vescovo. Il prossimo Concilio porterà a una dichiarazione su una serie di punti di dottrina e alla formulazione di una legge canonica. Significherà la condanna di Pelagio, della sua eresia e di quanti l'adottano. Ne consegue che sarà anche una condanna inequivocabile e ufficiale di Agricola e Fastidius e dei loro seguaci. Può anche darsi che i vescovi mantengano la calma, ma non è detto che gli "eretici" accettino docilmente la condanna. E questo sarebbe un pericolo per Germano e la sua gente, stranieri in una terra lontana.» Il vecchio vescovo levò la mano e mi benedisse con il segno della croce. «Non abbiate paura, Caio Merlino. Agricola e Fastidius sono uomini, oltre che vescovi, e non sarebbero contenti di essere biasimati alla presenza dei loro fedeli: non lasciatevi trarre in inganno, sanno che è esattamente quello che accadrà perché già sono stati ufficialmente censurati. Se andranno a Verulamium, porteranno soltanto pochi del loro gregge. Ci andranno con la speranza di ricevere clemenza, ma non mi fiderei di una loro rinnovata dichiarazione di conversione. Andranno e chiederanno clemenza con la segreta speranza di ritornare nelle terre di Vortigern a continuare nei loro insegnamenti sovversivi. Questo non possiamo permetterlo. Ma i loro seguaci saranno numericamente assai inferiori ai fedeli che troveranno a Verulamium. Germano non sarà mai in pericolo tra tanti cristiani.» Mi strinsi nelle spalle, addolcito ma non convinto da quelle ultime rassicurazioni, sebbene mi rendessi conto che Enos ci credeva veramente. Prima che potessi rispondere ci giunse il rumore delle porte del refettorio che si spalancavano e il suono delle risa dei convitati che si riversavano fuori nell'aria fredda della sera. «Vi ho trattenuto molto più a lungo di quanto intendessi, amico mio. Porgete le mie scuse a coloro che hanno dovuto pazientare. La cena è finita, e tutti rientrano a casa. Vi farò recapitare da uno dei vescovi la lettera di Germano.» Gli dissi che non era necessario: avrei mandato un soldato a prenderla entro un'ora. Poi gli feci strada verso la sala e lo lasciai con i suoi confratelli che si preparavano alla partenza. Non appena mi allontanai da Enos, raggiunsi Rufio, che quella notte era a capo della guardia, e gli chiesi di inviare una scorta che accompagnasse i vescovi ai loro alloggi e, ritirata la lettera, me la portasse. Mi avvicinai quindi a Tressa seduta tra Connor e Brander. Vicino a lei, chino per parlarle all'orecchio, stava Artù. Vedendomi, Tressa disse qualcosa al ragazzo che si raddrizzò nello scorgermi. Prima ancora di raggiungerli, sapevo che qualcosa non andava. Quando fui vicino, Brander si alzò e dandomi un colpo sulla spalla mi augurò la buona notte e promise di vedermi il mattino dopo, prima di partire con Connor. Mentre si accomiatava con sua moglie e i suoi uomini, mi volsi verso Artù che mi fissava a occhi spalancati. «Che cosa non va?» chiesi. «Devo andare in Cambria con Llewellyn il Guercio?» Lanciai a Tressa un'occhiata di stupore, ma lei si strinse nelle spalle con gesto eloquente, indicando che non era stata lei a dirglielo. «Chi te ne ha parlato?» «È vero?» «Sì, ne sei dispiaciuto?» «Mi hai promesso che sarei stato con te al tuo ritorno. E invece devo andare in Cambria con un uomo che non conosco. Un uomo che indossa una maschera.» Da quando era arrivato a Camelot, Llewellyn aveva sempre portato una maschera per risparmiare alle nostre donne la vista di una faccia orrendamente deturpata. Ma qualcosa nel tono di Artù, che indirettamente insultava un uomo che avevo finito per considerare un amico, mi mandò su tutte le furie. «Gli hai chiesto che cosa possa averlo persuaso a indossare una maschera?» Il ragazzo mi fissò sorpreso dall'improvvisa asprezza del mio tono. «Forse per impedire che persone a lui sconosciute possano dare sfogo alla loro crudeltà, sbeffeggiandolo? O forse ritiene che gli insulti a lui rivolti perché porta quella maschera siano più accettabili di quelli che dovrebbe sopportare se non ce l'avesse? Lo chiamano Llewellyn il Guercio per una buona ragione. Il suo non è un bel viso da guardare. Gli fu devastato da una colata di metallo fuso quando era un ragazzo più giovane di te, e al vederlo i bambini si spaventano. Tu non sei un bambino, vero?» Artù mi fissava costernato, e capii che non era stata sua intenzione essere crudele. Ne fui immediatamente contrito, ma non lo dimostrai. Addolcii invece il tono della mia voce. «Llewellyn il Guercio è un brav'uomo e io sono orgoglioso di poterlo chiamare amico, così come lo sarai tu, una volta che lo conoscerai meglio. Di questo parleremo più a lungo domani; nel frattempo ecco che cosa ti dico: sei il figlio di Uther Pendragon, il legittimo re della Cambria meridionale e delle terre basse di Pendragon, eppure tu ignori tutto del tuo popolo, e loro di te. A questo porrà rimedio Llewellyn. È un fabbro e un grande guerriero, un arciere rispettato da quelli del suo mestiere, che, come sai, sono i migliori in Britannia e forse anche altrove. Ho deciso che rimarrai con lui per un anno, per imparare come vive la gente di quella terra. In questa impresa non posso esserti di aiuto. Se ti vedessero con me, ti riconoscerebbero, e tale riconoscimento, prima che tu sia pronto a prendere il tuo posto, potrebbe esserti fatale. Llewellyn conosce la verità, e la conosce anche Huw Fortebraccio, e adesso Huw Fortebraccio è il signore della guerra di Pendragon, legato da giuramento a servire te e la tua casata. Insieme questi due uomini ti faranno conoscere alla loro gente, ti introdurranno ai loro costumi e tradizioni, al loro modo di vivere. Una riflessione su quanto vedrai e apprenderai non potrà che giovarti.» Intuivo che quelle nuove non lo rallegravano, così decisi di lasciarlo parlare. «Sarà solo per un anno, non di più. Te lo prometto. Che cosa hai da dire?» Distolse lo sguardo dal mio viso e lentamente lo fissò verso un punto lontano, dietro le mie spalle, mentre si succhiava una guancia. Emettendo un respiro breve e rapido, raddrizzò le spalle. «È tua convinzione che io sia in grado di farlo.» Era un'affermazione, non una domanda. «Sì, è questa la mia convinzione. Quanto al fatto che mi avresti seguito nella mia spedizione, non sospettavo che tu ci facessi affidamento. Se ti ho deluso, me ne rammarico. Possiamo porvi rimedio. Andrai in Cambria per un anno. So che alla tua età un anno sembra un'eternità, ma vola in un attimo, e a mano a mano che si cresce, gli anni si abbreviano. Dopo quest'anno ritornerai a Camelot, e poi saremo fianco a fianco in ogni impresa, se lo vorrai. Nel frattempo sarai maggiorenne, autonomo e indipendente. Ambrogio mi ha detto che fino a oggi hai superato ogni sua aspettativa, e naturalmente questo mi da un piacere immenso. Adesso desidero che ti comporti in modo tale che la stessa cosa di te possa dirla Llewellyn il Guercio tra un anno.» Scorsi Morag che dietro a lui si allontanava insieme a sua madre e alle dame del seguito: si attardava volgendo lo sguardo verso di noi con la speranza di intercettare quello di Artù. Tornai a rivolgermi a lui. «Domani ti presenterò a Llewellyn, e ti prometto che ti piacerà... l'uomo vero dietro la maschera. Credo che in questo momento una giovane donna cerchi di attirare la tua attenzione.» Si volse e un attimo dopo si era allontanato a gran passi verso la sua innamorata. Mi girai verso Tressa che mi sorrise. «Ho temuto all'inizio che lo trattassi con troppa severità. Ne era costernato, soprattutto all'idea di non poterti essere vicino.» «Sì, la mia prima reazione è stata affrettata e ingiusta, ma grazie a Dio ho capito il mio errore in tempo e ho evitato un danno più grave.» Lanciai un'occhiata a Connor, i cui occhi assonnati erano chiusi a metà. «Allora, ammiraglio, come ti senti?» Sorrise lentamente. «Non c'è male, ma volentieri baratterei un piatto del tuo manzo con una bella ciotola fumante di zuppa di cereali.» «Coltivi di nuovo avena in quelle tue isole paradisiache?» Il suo sorriso si allargò, ma gli occhi rimasero semichiusi. «Continueremo a coltivare avena in eterno. L'avena ci nutre e ci da forza.» «Perché non me l'hai detto? Anche noi la coltiviamo, ma la usiamo come foraggio per i cavalli. Forse per questo hanno un vigore enorme. I fienili delle nostre stalle traboccano di avena. Questo mi ricorda che devo procurarmi un altro cavallo. Lo sapevi che ho perduto Germanico?» Connor si raddrizzò con un sobbalzo. «Il tuo grande cavallo nero? No, non lo sapevo. Quando e dove è successo?» Glielo raccontai brevemente, quindi posai una mano sulla spalla di Tressa. «Connor, amico mio e compagno d'armi, posso invitarti a ritirarti? Ho qui altra compagnia, come avrai notato. Se ci permetti di lasciarti da solo, avrai la nostra gratitudine.» Sorridendo e stiracchiandosi, Connor sbadigliò, ignorando il gridolino di Tressa per la mia indiscrezione. Si rizzò in piedi e rimase lì barcollante. «Ho bevuto troppo» disse. «Spero che lo stesso non si possa dire di te, amico d'armi. Ti auguro la buona notte, dato che evidentemente non vuoi trattenermi. Dormi bene se avrai il tempo.» Si volse maestosamente, ruotando sulla gamba di legno e dirigendosi verso l'ampia porta a due battenti all'estremità del salone, affrontando con prudenza i gradini del palco sopraelevato. Mentre usciva a passo incerto, vidi che entrava un soldato per recapitarmi la lettera di Germano. Oltre a me e a Tressa, c'era ancora una decina di convitati, ma con nessuno di loro avevo questioni da discutere. Il soldato scattò sull'attenti e facendo il saluto di rito mi porse un involto cilindrico con la lettera. Lo ringraziai e infilai il messaggio nella mia tunica, poi tesi la mano a Tressa. «Sei tenuto a leggerlo subito? Hai finito i colloqui? Ti è rimasto un po' di tempo per me?» «Sì.» Le posi una mano sulla parte posteriore del collo e insieme ci incamminammo verso il vestibolo dove avevamo appeso i nostri mantelli. Ci aspettava alla porta il piccolo carro a due ruote che Rufio aveva avuto l'accortezza di prepararci. Il conducente, anche lui soldato, ci aiutò a salire, e ci coprì le ginocchia con una coperta calda e morbida. Tressa si accoccolò vicino a me, e io infilai la mano tra le sue cosce. Salutai con un cenno della testa le guardie ai cancelli che al nostro passaggio si misero sull'attenti. Mi volsi quindi a Tressa e poco dopo - mi parvero attimi brevissimi - entravamo nel portico della villa Britannico. Trovammo Platone, il maggiordomo, che ci aspettava per condurci nei nostri appartamenti al primo piano. La camera da letto era illuminata dal lume di numerose candele, e le loro fiammelle guizzavano nella lieve brezza che veniva dalla finestra socchiusa e che gonfiava leggermente i tendaggi. Ricordo di avere chiuso la porta alle spalle di Platone, e ricordo di essermi girato verso Tressa assaporando la sua bellezza che il tremulo bagliore esaltava. Ricordo di essermi avvicinato a lei e di averla presa tra le braccia, sentendo la pienezza del suo corpo e la dolcezza della sua bocca che si apriva per essere baciata dopo tanti mesi di separazione. Ricordo la violenza del desiderio che si impossessò di me, ma non ricordo il tempo che trascorse da quel momento a quando ci trovammo, entrambi nudi, l'uno accanto all'altra. Ricordo il suo peso tra le mie braccia mentre cadeva sotto di me e mi tirava verso di lei. Mi parve che fosse diversa, più decisa e dura, da come era stata, ma in quel momento non ci feci caso, tanto era prepotente il desiderio. Non ho ricordi precisi di quei nostri abbracci, ma qualcosa di profondo dentro di me ancora rammenta il piacere e la gioia di sentire il suo corpo muoversi, le gambe allargarsi per accogliermi e farmi affondare dentro di lei. Ho un ricordo accecante e fuggevole di qualcosa che mi sgorgava dalla bocca e dai lombi, mentre pareva che lei volesse succhiarmi la vita e portarmi all'estasi. Dopo di allora non ricordo nulla. XII. Il mattino dopo, al risveglio, ero solo nel letto e ad attestare la presenza di Tressa restavano soltanto le lenzuola spiegazzate. Mi tirai su immediatamente, la chiamai, ma non era nella camera. Allora mi lasciai ricadere tra le coperte, stiracchiandomi voluttuosamente nel loro tepore e percependo la lieve fragranza del suo corpo. Dovevo essermi riaddormentato perché quando riaprii gli occhi, lei era seduta sul letto e, china su di me, sussurrava il mio nome. Mi svegliai di botto, allungando le braccia per afferrarla e baciarla. Infilai una mano sotto le voluminose vesti che indossava, ma lei scivolò via in fretta e, spalancando le imposte, lasciò entrare a fiotti la luce del giorno. «Santo cielo, Tressa, che ore sono? Perché non mi hai svegliato prima? Sarà quasi mezzogiorno!» «No, è metà mattina, ma avevi bisogno di dormire. Ti ho lasciato tranquillo quando mi sono alzata.» Sorrise con malizia. «Ho pensato che ti sarebbe stato necessario.» «Come? Che vuoi dire?» «Che cosa voglio dire, secondo te? Semplicemente che, quando ti sarai riposato, avrai recuperato le forze per prendermi come piace a me, senza addormentarti.» «Senza che? È successo?» Naturalmente, lo sapevo bene che era andata così. Si avvicinò al letto e mi accarezzò una guancia. Avvertii la mia eccitazione e cercai di afferrarla per il polso, ma fu rapida nello sfuggirmi. «Torna a letto» mormorai con voce rauca. «Stanotte, ma non adesso, amor mio. Ambrogio, Artù, Dedalo e quello strano uomo con la maschera ti stanno aspettando: affrettati; anch'io devo sbrigarmi. Non voglio che pensino che stiamo facendo quello che ti piacerebbe fare in questo momento. Platone ti porterà l'acqua calda, lavati il viso in fretta e scendi. Ti ho preparato una nuova veste di cuoio e una tunica che io stessa ho confezionato. Fa' in fretta» disse mentre usciva dalla camera. Gemendo mi levai a sedere sul bordo del letto, guardando gli abiti cui aveva accennato. Strofinandomi gli occhi, li esaminai attentamente, ammirandone la squisita fattura. Sentii bussare alla porta, e apparve Platone augurandomi il buongiorno. Lo seguivano due soldati: uno reggeva un aggeggio pieghevole che comprendeva un catino, un recipiente di cuoio e una brocca; l'altro portava una caraffa di acqua calda. Mentre montavano il tutto sotto lo sguardo attento di Platone, mi volsi a osservare lo strano capo di abbigliamento che tenevo in mano. Era un pezzo unico, di lana cardata leggera e liscia. Identificai i buchi nei quali infilare le braccia e la testa, ma mi ci volle un po' per capire la funzione delle appendici inferiori, due aperture simili a maniche nelle quali infilare le gambe. Tra queste pendeva un lembo che avrei dovuto far correre tra le cosce e agganciare sul davanti. Contento di avere capito come indossare quel capo di vestiario, lo lasciai cadere e mi avvicinai alla tinozza piena di acqua fumante. Platone e i suoi assistenti si erano nel frattempo allontanati, e io mi sbrigai in fretta a ripulirmi e asciugarmi con una salvietta pulita. Nell’accingermi a indossare quel capo di biancheria mi dissi I che prima dovevo inserire le gambe nelle due aperture, che erano corte e non arrivavano al ginocchio, ma fasciavano bene la parte superiore delle cosce e lasciavano pendere comodamente i genitali, e successivamente sgusciare nella parte superiore, priva di maniche. Allacciai sul petto i lembi del profondo taglio a forma di "V" dapprima stringendolo ma poi allentandoli per essere più a mio agio; mi passai tra le gambe la fascia pendula e, feci passare nelle asole le due sottili stringhe attaccate agli angoli e le legai all'altezza della vita. Mi venne da sorridere pensando a com'era ingegnosa quella veste. Mi sarebbe stato facile, al richiamo delle esigenze della natura, slacciare i due nodi che trattenevano il lembo. Infilai le brache di cuoio e la nuova tunica, assaporandone la morbidezza del tessuto che la foderava. Da ultimo indossai una giacca di cuoio. Flettei le spalle e inarcai la schiena per accertarmi che l'indumento non mi stringesse le scapole, ma era comodo e soffice e mi si adattava alla perfezione. Era aperto sul davanti e a mezza altezza pendevano due cinture, anch'esse di cuoio, l'una tre volte più lunga dell'altra, e ciascuna fatta di fettucce intrecciate gialle e azzurre. Infilai quella di destra, più lunga, in un'asola verticale, finemente cucita lungo i bordi, praticata nella piega della parte sinistra, la tirai in modo che mi stringesse sul ventre e, passandomela dietro la schiena, la allacciai annodandola sulla destra con il lembo più corto e lasciando pendere sciolte le cime. Non avevo un'idea chiara dell'effetto finale, ma sentivo che quell'abbigliamento mi si adattava bene. La parte inferiore della giacca sotto il punto vita era frangiata; ciascuna frangia era decorata con un motivo celtico impresso in rilievo per mezzo di uno stampo e intorno correva un ricamo in filo azzurro. Le spalle della giacca erano a più strati, rigide come quelle di una corazza, e da lì pendevano piccole nappe che abbellivano la parte superiore delle maniche con nastri azzurri e dorati. Da ultimo indossai un paio di stivali foderati di morbido vello. Me li infilai in fretta rallegrandomi della solidità delle suole borchiate e sapendo che avrei dovuto camminare con attenzione sui pavimenti di legno levigato e lucidato delle camere del piano superiore. Tressa mi aspettava sulla scala che portava di sotto nel cuore della casa. Dal sorriso sul suo viso capii che era soddisfatta di come apparivo nelle vesti da lei confezionate. Mentre scendevamo insieme, Dedalo si lasciò scappare un fischio di apprezzamento poco garbato, ma sapevo che era diretto a me, non a Tressa. Decisi di ignorare i suoi modi rudi, ma non resistetti alla tentazione di fermarmi ai piedi della scala e pavoneggiarmi nella mia nuova tenuta. Ambrogio, Artù, Dedalo e persino Llewllyn riconobbero l'eleganza del mio abbigliamento e si complimentarono sinceramente con Tressa. Lei chinò il capo con grazia, lusingata, e ci lasciò soli. Ambrogio affrontò subito il nocciolo della questione. Gli uomini di Connor e il corteo di Brander avevano lasciato Camelot all'alba: nessuno dei due aveva voluto che fossi disturbato, dato che già ci eravamo accomiatati la sera precedente. Ambrogio mi chiedeva ora di accogliere i suoi ospiti dalla Northumbria. La lunga dormita e la sorpresa per il mio nuovo abbigliamento mi avevano fatto dimenticare che in quel giorno Connor e Brander sarebbero partiti; capii allora il motivo del malumore di Artù, che aveva un'aria abbattuta e melanconica. Morag se ne era andata, e io pensai che la cura migliore sarebbe stata il richiamare l'attenzione del ragazzo su quello che avrebbe fatto nell'immediato futuro. «Gli uomini della Northumbria sono tutti qui?» «No, aspettano di essere convocati.» «Bene. Non ho ancora mangiato e dobbiamo discutere un'altra questione prima di incontrarli. Vediamo se riusciamo a farci dare qualche avanzo da Platone.» Poco dopo sedevamo tutti e cinque intorno alla tavola in una delle dispense adiacenti l'enorme cucina della villa, attingendo dal cibo che ci era stato messo davanti. C'erano pane sfornato da poco e ancora tiepido, mele, prugne e pere raccolte nel frutteto, e una gran varietà di carne fredda e salsicce speziate. E abbondava il latte. Mi rivolsi a Llewellyn. «Ieri sera qualcuno ha avvertito Artù che verrà con te in Cambria. È stato colto di sorpresa perché non ti conosce e non sapeva niente del progetto. Neanche tu lo conosci, eppure sarà sotto la tua responsabilità finché sarai tu a prenderti cura di lui. Ecco perché voglio parlarti del giovanotto in sua presenza. È un discreto arciere, forse leggermente sotto la media. Confido che riuscirai a migliorare la sua tecnica. Stando ai suoi istruttori, Rufio e Dedalo, ha la stoffa del grande spadaccino, so che tra la tua gente avrà poche occasioni di esercitarsi nella scherma. Sa andare a cavallo, ma so che nelle vostre terre dovrà imparare a usare le gambe e aumentare il fiato e la resistenza... Ti piacerà sentire che sa leggere e scrivere in latino con assoluta padronanza della lingua e che conosce i libri di suo nonno.» Lanciai uno sguardo ad Artù e notai che ascoltava attentamente, socchiudendo gli occhi. «Credo di averti detto che il suo bisnonno, Publio Varro, era un maestro tra i fabbri e costruiva splendide armi. Quando ero ragazzo, mi insegnò qualcosa della sua arte, purtroppo molto poco. Eppure ricordo tutte le nozioni che appresi allora; mi insegnò ad avere rispetto per le spade e per il ferro di cui sono fatte.» Mi rivolsi direttamente ad Artù. «Anche Llewellyn è un fabbro, un artigiano maestro nel suo mestiere, e spero che accetti di insegnarti qualcosa della sua tecnica. Imparerai che la tua arma prediletta, la spada, è davvero uno strumento potente e soprattutto imparerai a rispettare le proprietà dei materiali - tutti i materiali e tutte le risorse, dai metalli agli uomini - con i quali lavorerai. Ieri sera hai trovato da ridire che questo mio amico indossasse una maschera. Ti ho risposto con asprezza... sbagliando, temo.» Tacqui e Artù parve mortificato. «Con gli anni capirai, come abbiamo capito tutti, che non c'è uomo che non indossi una maschera di un tipo o di un altro: alcune appaiono sorridenti e innocue, ma il sorriso a volte è ingannevole. In certi momenti cerchiamo di nascondere quello che sta dietro il viso. Alcuni lo fanno per timore che trapeli la loro doppiezza; altri, pochi, caritatevoli e sfortunati, lo fanno per risparmiare a chi sta loro vicino dolore, paura, imbarazzo.» Tornai a volgermi a Llewellyn. «Vuoi toglierti la maschera, amico mio?» Intuendo le mie intenzioni, si raddrizzò e senza indugio si slegò la fascia che teneva la maschera legata alla testa. Un profondo silenzio seguì alla vista del suo volto devastato; sorrise, o meglio, la parte intatta del suo viso si aprì nel sorriso, l'altra si contorse in una smorfia orribile, scoprendo il canino che si intravedeva attraverso un buco nella guancia. «Questa è la maschera vera» disse rivolgendosi direttamente ad Artù. Quindi sollevò il lembo di cuoio nel quale erano stati praticati i buchi in corrispondenza degli occhi. «È soltanto una cortina. Non sentirti in colpa per quello che provi: sono abituato a vedere reazioni come le tue. La mia faccia spaventa i bambini, lo so, ma non ci faccio più caso. Per anni ho provato odio per me stesso e per quanti mi circondavano. Quando sono nato non ero un mostro e mi ricordavo com'era stata la mia vita prima di essere sfigurato. Ma di recente ho appreso che alcuni, gli amici, riescono a prescindere dall'orrore e dalle cicatrici. Mia moglie mi ama e mi rispetta; i miei figli mi hanno conosciuto con questo viso e mi accettano per come sono. Ho imparato a convivere con la mia disgrazia.» Il viso di Artù assunse un'espressione di compassionevole pietà: non vi era più traccia dell'orrore che aveva mostrato non appena aveva visto il volto di Llewellyn. Chinandosi leggermente verso di lui, gli chiese: «Com'è successo?». «Fu un getto di metallo fuso e la disattenzione. Avrei potuto morire, ma ero giovane e forte e sono sopravvissuto. Lavoravo come apprendista presso un fabbro che era solito alzare il gomito. Un giorno bevve troppo, inciampò e il metallo incandescente schizzò intorno. Non molto, ma mi colpì.» Artù ebbe un tremito e notai che anche gli altri rabbrividivano. «Fate ancora il fabbro?» «Non lo ero allora, lo sono diventato dopo. Al tempo della disgrazia avevo soltanto dodici anni. Mi accorsi che avevo più cose in comune con il ferro che con il mio prossimo. Dunque è deciso: verrete con me nella Cambria a conoscere il popolo di vostro padre e la sua terra?» Artù mi guardò, gli occhi pieni di lacrime. Sebbene non sapessi quali pensieri gli attraversassero la mente, provai un enorme sollievo, e sentii in gola un groppo di commozione. «Sì,» sussurrò annuendo con forza quasi a voler convincere quella parte di sé che ancora dubitava «sì, verrò.» «Alla vostra salute, ragazzo! Piacerà a entrambi, ve lo prometto, e Huw Fortebraccio vi insegnerà ancora più cose di quante ve ne insegnerò io, una volta che capiteremo dalle sue parti. Partiremo il prima possibile, perché, in tutta confidenza, non mi trovo a mio agio dove non posso arrampicarmi. Le montagne sono più alte e più selvagge, ma uno lì può girare come gli pare e trovare sostentamento. Qui ci sono soltanto cucine piene di gente che ha più fame di te, e si deve vivere dei loro avanzi. Nessuna libertà, ragazzo mio: non ci sono pesci da prendere all'amo, conigli da catturare con le trappole, uccelli da abbattere con le frecce, non ci sono uova nell'erica e neppure cervi che brucano sul selciato dei cortili. Oggi e domani li dedicheremo ai preparativi, e il giorno dopo ce ne andremo liberi, con la pioggia e il vento. Vi piacerà la Cambria, ragazzo mio. Vi metterò sotto torchio e vi bistratterò, ma sarà una buona scuola. Per non parlare poi degli occhi splendenti e di altri attributi delle ragazze di lì. Che delizie vi aspettano! Non ce ne sono di più belle in tutto il mondo, vedrete. Cantate?» Artù mi guardò confuso; gli sorrisi e parlai per lui: «No, non molto, ma se la cava». «Se siete figlio di vostro padre, ve la caverete più che bene. Canterete tra le montagne, non riuscirete a trattenervi. Lì abitano gli dèi, e gli dèi cantano.» Mi levai sorridendo e, rivolgendomi ad Ambrogio che fino ad allora non aveva aperto bocca, dissi: «È ora di raggiungere gli ospiti, no?». L'incontro con i delegati di Vortigern fu schietto e pacato; soltanto una delle informazioni che mi diedero era di una certa importanza. Uno di loro, il più anziano del gruppo, disse che Vortigern sperava di sedare pacificamente l'irrequietezza che da tempo fermentava tra i suoi sudditi e i giovani guerrieri di Horsa, avidi di terre. A suo avviso, Vortigern, e lo stesso Horsa, avevano raggiunto una specie di accordo con una piccola comunità di Danesi stanziatisi all'estremità sudorientale di quella regione che si chiamava Weald, ma che i Danesi chiamavano Kent, o un altro nome esotico. In quell'angolo della Britannia, l'originaria Costa Sassone, avevano da poco cominciato a riversarsi in massa numerose tribù germaniche alla ricerca di un punto strategico. Sebbene gli abitanti, anch'essi lì insediatisi da poco, avessero vittoriosamente respinto gli attacchi, il numero dei predatori aveva continuato a ingrossarsi costantemente e in modo preoccupante, sicché la loro supremazia sembrava inevitabile. Tale situazione, ai miei occhi amaramente ironica, in cui gli invasori si trovavano a respingere un'invasione, aveva persuaso i condottieri danesi del sud-est a contattare Vortigern nel nord-est, sapendo che questi da lungo tempo proteggeva e difendeva le comunità danesi stanziate nei suoi domini, e a chiedergli aiuto per difendere le proprie terre. Erano di conseguenza diminuite le pressioni su Vortigern grazie alla prontezza con cui i guerrieri di Horsa avevano accolto quell'occasione, che sembrava offerta da un destino benevolo: una guerra da combattere, nuove terre da conquistare, donne sconosciute della loro stessa razza che, in amicizia e comunanza, avrebbero soddisfatto le loro esigenze. A quanto pareva, erano salpati verso meridione centinaia di guerrieri al comando di Horsa. Non si prevedeva che tornassero nella Northumbria, ma nessuno poteva dire con certezza quanto sarebbe rimasto nel sud. Il dibattito mi fece venire in mente che non avevo ancora letto la lettera di Germano. Mi costrinsi ad ascoltare con cortesia i miei interlocutori, impaziente di ritornare nel mio alloggio. Le notizie dalla Northumbria avevano indebolito le argomentazioni di Enos circa l'incolumità di Germano, qualora questi avesse tentato di attraversare le terre sudorientali della Britannia. Horsa non era un guerriero cristiano, il suo esercito era un'orda pagana, un'autentica minaccia al progetto del nuovo Concilio, qualora il vescovo avesse deciso di arrivare a Verulamium dalla Gallia passando per il Weald. Preso da questi pensieri, non mi accorsi che dopo avere parlato dei guerrieri di Horsa gli ospiti erano passati a celebrare le meraviglie che avevano visto a Camelot. Ritornai in me, riuscendo a non tradire gli attimi di disattenzione, soltanto quando uno di loro mi pose una domanda. Lodavano il fatto che la Colonia fosse pronta ad affrontare un conflitto e io sottolineai che eravamo in grado di reagire a un attacco da qualsiasi parte venisse e in qualsiasi momento fosse sferrato. Li rassicurai dicendo che entro l'anno successivo avrei comandato una nuova spedizione nelle terre di Vortigern, al fine di ribadire la nostra posizione di alleati fedeli. Subito dopo cercai di escogitare una buona ragione per tornare ai miei doveri, e fu lo stesso Ambrogio che mi diede una mano levandosi e ringraziandomi del tempo che avevo concesso a lui e ai suoi ospiti. Mi accomiatai esprimendo la mia gratitudine a tutti per essere venuti a Camelot, e chiesi loro di portare i miei saluti al re Vortigern con la promessa che sarei andato da lui personalmente l'estate successiva. Preso così congedo, tornai alla villa e qui Platone mi comunicò che Tressa si era recata al forte con Shelagh e sarebbe stata di ritorno nel tardo pomeriggio. Lo ringraziai e salii al primo piano dove, appoggiato sul tavolo vicino alla finestra della nostra camera da letto, trovai il cilindro di cuoio contenente la lettera di Germano. Lo presi, ridiscesi al pianterreno sfregando oziosamente il sigillo di cera, e mi misi comodamente seduto nell'atrio in un angolo soleggiato. «A Caio Merlino Britannico Da Germano Pontifex Auxerre, Gallia Carissimo amico, ti scrivo ben sapendo che passerà lungo tempo prima che tu possa leggere questa lettera, e che frattanto avrai avuto modo di parlare con il vescovo Enos, un vecchio amico. Enos è qui con me da circa tre mesi e tra poco ritornerà ai suoi doveri nella città che un tempo era chiamata Venta Belgarum, in quei territori della Britannia che ormai tu consideri perduti e saldamente nelle mani degli invasori. Enos ti avrà comunicato che, con il consenso dei miei superiori, intendo ritornare in Britannia e porre termine alle lacerazioni eretiche tra i vescovi della tua infelice terra. Così come stanno le cose, temo che la salvezza fisica e spirituale degli uomini sia già gravemente minacciata, senza che si aggiungano i pericoli disseminati tra loro da cattivi maestri. Arriverò quindi in Britannia verso la metà della primavera dell'anno prossimo. Attraverserò il Mare Stretto e sbarcherò nel vecchio porto romano di Dubris e da qui proseguirò verso nord, in direzione di Verulamium. Credimi, amico mio: riesco a figurarmi la preoccupazione con la quale leggerai questa mia intenzione. So che ai tuoi occhi commetto un'imprudenza a viaggiare in una regione di pagani senza Dio. Non è così: Enos e i suoi fratelli hanno fatto conoscere la luce di Cristo a centinaia di loro, soprattutto agli Angli del sud-est, e a questa brava gente affiderò la mia incolumità con la certezza di avere la benevolenza di Colui che servo. Come sai tuttavia, quella parte di me che un tempo era guerriera si rifiuta di darmi serenità durante i viaggi in strane terre e mi ammonisce dicendomi che non sarò sempre circondato da buoni cristiani. Oltre a questa innata prudenza, c'è il detto secondo il quale Dio aiuta chi si aiuta. Posso chiederti di aiutarmi a condurre a termine questa impresa cui mi accingo in nome del Signore? La tua presenza al mio seguito con un contingente quale portasti a Verulamium la volta in cui ci siamo conosciuti sarebbe una benedizione, sia durante il percorso sia durante il soggiorno. Temo che il Concilio sarà meno sereno del precedente. Ti rivolgo questa richiesta senza tenere conto dei tuoi progetti e impegni, pienamente consapevole dell'egoismo che in tal modo manifesto. Se non fossi in grado di accogliere la mia istanza, sarò deluso ma non offeso. Se invece decidessi di unirti a noi, sarò davvero felice di rinnovare l'amicizia con te e ringrazierò Dio della sua misericordia. Enos provvederà a inoltrarmi la tua risposta. Tu e i tuoi cari sarete sempre ricordati nelle mie preghiere. Il tuo amico e fratello in Cristo Germano Pontifex» Non avevo ancora finito di leggere questa lettera che avevo già preso ad andare avanti e indietro, mentre i pensieri si accavallavano tumultuosi. Da quando la sera prima avevo parlato con Enos, mi ero convinto che lui e i suoi vescovi fossero riusciti a convertire al cristianesimo, alcuni almeno, degli Angli delle regioni sudorientali, ma il pensiero che Germano andasse tra quelle genti mi atterriva perché, malgrado tutto l'ottimismo e la buona volontà, continuavo a pensare che fossero - e tali sarebbero rimasti - pagani selvaggi, stranieri venuti da un altro mondo, invasori che una sottile verniciatura di cristianesimo non avrebbe mai addomesticato né cambiato. Sapere che in quelle terre, quando vi sarebbe arrivato il mio amico, ci sarebbero state anche le orde di Horsa, non faceva che accentuare le mie paure e acuire la mia ansia circa la sua incolumità. La proposta di Germano di accompagnarlo nel suo viaggio non creava tutti quegli inconvenienti che lui temeva. Dal canto mio, da un punto di vista politico, intravedevo in quel progetto alcuni benefici. Lo spostamento a sud-est degli eserciti di Horsa avvantaggiava in modo immediato ed evidente Vortigern, che non sarebbe più stato stretto dalla necessità di trovare una soluzione alla questione della loro presenza nei propri territori. Quanto più ingente fosse stato il numero di Danesi che si riversavano a sud-est, tanto meno incalzanti sarebbero state le pressioni sui suoi sudditi di cedere altre terre a quei mercenari, e la necessità di cospicui aiuti da parte nostra alle comunità del nord-est si sarebbe attenuata proporzionalmente all'entità dell'esodo dei Danesi. Avevo buone ragioni per credere che sarebbe stato compiaciuto se, prima di raggiungerlo a nord come avevamo convenuto, avessimo dato dimostrazione della nostra presenza nel sud-est. Tale mossa, che assecondava il mio desiderio di esplorare quella parte del paese, era possibile soltanto grazie all'arrivo di Germano e l'acquiescenza degli Angli convertiti. Gli uomini che avrei scelto per scortare il vescovo e vegliare su di lui e il suo seguito, e che dalla costa li avrebbero guidati verso nord, avrebbero potuto muoversi molto più agevolmente di quanto sarebbe stato possibile in altre circostanze. Malgrado i suoi vantaggi strategici, l'operazione tuttavia era assai complicata e insidiata da molti rischi sul piano politico. Si agitava dentro di me un turbinio di pensieri contrastanti, ispirati dalle riserve, quali trapelavano dalle parole di Enos, sull'atteggiamento tutt'altro che ostile di Vortigern verso gli eretici. Forse il re non sarebbe stato contento di sapere che mi schieravo a favore di Germano e delle sue convinzioni ortodosse nei confronti dei principi di Pelagio, sebbene quel mio impegno fosse dettato da un sentimento di lealtà verso il mio amico, non da una sincera adesione a quelle tesi. In realtà, gli insegnamenti di Pelagio, così come li avevo intesi molto tempo prima, mi sembravano fondati e sensati. Accettavo la dottrina di base secondo la quale l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, e nasce avendo innata in sé quella scintilla divina che gli consente di scegliere tra il bene e il male. Non individuavo pertanto alcun difetto di ordine morale nella premessa che gli esseri umani fossero in grado di comunicare con Dio e arrivare in tal modo alla salvezza. I Padri della Chiesa avevano però sancito nella loro saggezza che tale credenza era sintomo di orgoglio, uno dei sette peccati capitali, e che gli uomini non avrebbero mai potuto conseguire alcunché senza la Grazia divina amministrata loro per il tramite dei rappresentanti di Dio in terra, i sacerdoti e i vescovi, insomma il clero. Le sottili questioni teologiche della controversia che richiamava in Britannia Germano erano al di là della mia capacità di comprensione e mi lasciavano sostanzialmente indifferente. Avevo appreso i precetti di Pelagio dall'esempio di vita dei miei più cari congiunti e amici, e non scorgevo nei loro modi alcuna colpa. Io stesso vivevo secondo quanto mi dettava la coscienza e non mi affannavo a convertire il prossimo. Avevo tuttavia motivo di credere che Vortigern si interessasse alla disputa per motivi essenzialmente politici. Si proclamava re cristiano, ma nello stesso tempo negava di essere un teologo e si dichiarava poco avvezzo alle sottili distinzioni teologiche. Non aveva mai preso posizione nel dibattito sul pelagianesimo svoltosi a Verulamium. Eppure i due portavoce più schietti ed espliciti di quell'eresia, Agricola e Fastidius, provenivano dal regno di Vortigern e fino ad allora non avevano incontrato ostacoli alla loro predicazione in tutta l'ampia regione che si estendeva a nord del Vallo di Adriano e a ovest fino alla Cambria settentrionale e a nord delle terre di Pendragon. Avevo quindi la certezza che Vortigern avrebbe guardato con disappunto il servizio che avrei reso a Germano, un disappunto attenuato dal vantaggio di avere la cavalleria di Camelot nei nuovi territori di Horsa. Quando, cessando il mio andirivieni, mi sedetti di nuovo per rileggere la lettera, avevo già preso un bel po' di decisioni. Riflettei ancora a lungo prima di impugnare la penna e compilare l'elenco delle misure da prendere, tanto per vedere come apparivano. Sorrisi tra me e me pensando che l'abitudine, ormai acquisita dopo anni di pratica, di scrivere ogni cosa, mi portava a diffidare istintivamente di ogni idea che non vedessi delineata nero su bianco almeno nella sua forma e nel suo profilo generale. Poi rilessi attentamente quanto avevo scritto, provando una certa soddisfazione. Come avevo promesso, avrei condotto, l'anno successivo, un manipolo di mille cavalieri nei territori di Vortigern, ma prima di allora avrei inviato al re alcuni messaggeri per comunicargli che avrei ritardato l'arrivo in quanto dovevo prima muovere in direzione sud per andare ad accogliere il vescovo Germano e condurlo sano e salvo a Verulamium. Se in tale occasione Vortigern fosse sceso in meridione, avrei poi condotto, insieme a lui, i miei uomini nella Northumbria. Nel frattempo avrei avuto qualche mese di tempo per capire se il Weald e la circostante regione costituissero un pericolo per Camelot, e per mettere bene in chiaro agli invasori lì stanziati che disponevamo di una cavalleria forte e potente e che eravamo intenzionati a combattere una guerra contro chiunque minacciasse la nostra pace. Sarei stato di ritorno a Camelot nell'autunno e allora sarebbe stato agli sgoccioli anche il soggiorno di Artù nella Cambria e, raggiunta la maggiore età, il giovane avrebbe potuto assumere il comando di tutte le forze di Camelot. Nel redigere l'elenco delle successive imprese, avevo cercato anche di definire quali ostacoli avrebbero potuto impedirne la buona riuscita. Non mi parve di cogliere nessun grave inconveniente. Ironhair aveva subito una clamorosa sconfitta in terra e in mare, e la Cambria era saldamente nelle mani di Huw Fortebraccio. La presenza di Huw e l'appoggio della flotta di Connor, potenziata dalla cattura delle due biremi, avrebbero scoraggiato non solo Ironhair ma anche Carthac, dissuadendoli dal ritentare la conquista di Pendragon. E analogamente la colonizzazione del Weald da parte di Horsa avrebbe allontanato la minaccia che la Northumbria e in generale le regioni settentrionali scatenassero una guerra. Soltanto nell'estremo sud-ovest, nella Cornovaglia di Ironhair, era possibile intuire la presenza di minacciose inquietudini, ma non potevo fare niente per parare quel pericolo, salvo inviare le mie spie in quelle terre e cercare di ottenere informazioni. Decisi che avrei agito in tal modo, non senza essermi consultato in anticipo con mio fratello e gli strateghi più esperti. Nel frattempo avrei scritto a Germano affidando la lettera a Enos perché la inoltrasse a destinazione, e anche a Vortigern. Avendo così deciso, andai a cercare mio fratello per farlo partecipe dei miei pensieri. XIII. Il secondo giorno dal mio arrivo a casa mi levai prima di quanto avessi fatto la mattina precedente, eppure il sole era già alto e di nuovo il posto di Tressa nel letto, accanto a me, era vuoto. Sceso al pianterreno, ancora assonnato, mi avviai verso i bagni, sperando di trovarla ma a giudicare dagli spruzzi d'acqua tutto intorno, lei li aveva usati e se ne era andata. Poco dopo, vestito e affamato, entrai nella cucina della villa e da Platone seppi che, come il giorno prima, Tressa aveva raggiunto Shelagh al forte. A quel punto ero curioso di sapere che cosa le due donne avessero da sbrigare così di buon'ora; così ordinai di sellarmi un cavallo e di portarlo all'ingresso principale. Finito che ebbi di mangiare, mi avviai verso il forte. Quella mattina mi aspettava un'altra missione. Dovevo recarmi alle stalle e consultarmi con il responsabile per sostituire degnamente il fedele Germanico. Le mie esigenze erano semplici: il cavallo doveva avere un dorso sufficientemente largo ed essere abbastanza forte da sostenere il mio peso. Mi sarebbe piaciuto che fosse nero, ma ero disposto ad accettare temporaneamente qualsiasi alternativa. La perdita di Germanico era ancora troppo recente per compiacermi al pensiero di rimpiazzarlo con un altro al quale affezionarmi. Il sole non era penetrato ancora nelle stalle, che quindi erano fresche e buie, illuminate dalla luce tremula delle torce; sotto di esse ampie bacinelle raccoglievano le scintille che si staccavano dall'anima delle fiaccole, prima che potessero appiccare fuoco alla Paglia sparsa sul pavimento. Non appena entrai nella stalla, fui subito avvolto da un inconfondibile odore acre e pungente. Respirando a fondo, mi guardai intorno prima di smontare dalla sella alla ricerca dello stalliere di servizio. Era infatti regola che le stalle non rimanessero mai abbandonate a se stesse. Eppure allora ero da solo nell'enorme edificio che conteneva una sessantina di animali. Legai le redini intorno a un palo, perché volevo ritornare a togliere i finimenti al cavallo e a strigliarlo, dopo aver dato un'occhiata all'estremità della stalla dove erano alloggiati gli esemplari più pregiati della nostra popolazione equina. Dai segni lasciati dalle ramazze sul pavimento si capiva che era stato pulito da poco, e una balla di paglia fresca era stata portata fin lì ma non ancora sparsa intorno. C'erano dodici comparti, ciascuno destinato a un solo cavallo, ma arrivato all'altezza del primo, non andai oltre: una testa alta e nobile si allungò verso di me. Ebbi l'impressione di un animale di notevole statura, di orecchie nere frementi puntate verso il basso, di una criniera fitta e irta. Poi scorsi gli occhi. Incredulo che una bestia simile potesse trovarsi nelle nostre stalle, avanzai e schiusi il cancello. Il cavallo indietreggiò con uno scatto nervoso, scuotendo la testa e sbuffando dalle froge. Quando gli fui di fronte, mi fermai, levai lo sguardo e tesi la mano. Ebbe qualche istante di esitazione, quindi delicatamente abbassò il muso e allungò il collo per annusarmi le dita. Rammaricandomi di non aver portato qualcosa da dargli da mangiare, mi limitai ad accarezzarlo e a guardarlo. Nel buio della stalla il suo mantello pareva nero come la pece. Non indietreggiò, e io infilai le dita intorno alla cavezza di semplice corda e lo condussi verso il corridoio centrale della stalla e da lì all'esterno, nella piena luce del giorno, dove lo osservai attentamente. Era un esemplare magnifico, più alto e più muscoloso di come era stato Germanico; mi sentii un groppo in gola vedendo il suo mantello lucente come una pozza di acqua nera. La criniera e la coda erano pulite e lunghe, le zampe erano protette da gambali che arrivavano al nodello e nascondevano quasi completamente gli zoccoli. Il dorso era diritto e ampio, sul petto i muscoli gli guizzarono quando si mosse per indietreggiare. Non il minimo difetto gli deturpava il mantello, era nero dalla punta delle orecchie fino agli zoccoli. «Si chiama Bucefalo.» Mi girai di scatto al suono inaspettato di quella voce vicino a me. Dalla soglia della stalla mi fissavano Shelagh e Tressa. Fui così sorpreso al vederle lì che non mi venne in mente di chiedere loro come ci fossero arrivate. Mi volsi invece di nuovo verso il cavallo. «Di chi è?» chiesi. «Tuo, naturalmente» mi rispose Tressa ridendo. Nei brevi istanti che mi ci vollero per voltarmi a guardarla, dal suo viso e dalla voce era sparita ogni traccia di riso. «Non ci aspettavamo che Germanico morisse, e neppure tu del resto. Ambrogio teneva da parte per te questo puledro da prima che compisse l'anno, e per quattro anni lo ha allevato in gran segreto. Germanico cominciava a invecchiare, e in previsione del giorno in cui non avrebbe avuto la forza di portarti, tuo fratello...» Intervenne Shelagh a completare la frase lasciata incompiuta da Tressa. «Donuil mi raccontò di Germanico subito dopo essere arrivato qui, e noi ieri abbiamo fatto arrivare Bucefalo dalla fattoria in cui è cresciuto.» Sorrisi a Shelagh, volgendole un muto ringraziamento, quindi mi girai verso il cavallo. «Vedo che è stato addestrato. Non ha paura, non è bizzoso. Chi lo ha domato?» «Io.» La breve risposta di Shelagh e il suo tono indifferente, mi fecero restare a bocca aperta. Ignorò il mio stupore. «È vivace e selvaggio, ma di buona indole con chi si conquista la sua fiducia.» Mi sorrise con una lieve espressione di malizia nello sguardo. «Tu gli sei piaciuto.» Ero ancora attonito. «Lo hai domato da sola?» «No, non da sola, con un esperto. Ma sono stata io a cavalcarlo per prima. Mi ha insegnato i suoi trucchi, e io gli ho insegnato i miei.» Intuivo dal colore delle sue gote che era fiera del risultato e aveva ragione di esserlo. Lanciai un'occhiata a Tressa. «E gli hai anche dato il nome?» «Non io. È un nome straniero che viene da terre straniere. Non c'entro affatto.» «Ti credo, Shelagh. Lo sai chi era Bucefalo, intendo il primo Bucefalo?» «Il cavallo di un re di luoghi lontani.» «Imperatore, Shelagh, non soltanto re. Fu il più grande guerriero del mondo antico, prima dell'epoca romana. Alessandro di Macedonia. Lo chiamarono Alessandro il Grande. Il suo cavallo era Bucefalo.» «Ne ho sentito parlare. Il cavallo lo fece cadere da una rupe e lo uccise. Brutto auspicio per il re che condurrà questo cavallo. È stato tuo fratello Ambrogio a scegliere il nome.» «Ancora Ambrogio. Lo ringrazierò perché mi ha fatto un meraviglioso regalo. Il nome però non va bene, e lo cambieremo. Bucefalo era bianco, da quanto ricordo. Questo lo chiameremo Germanico. Il nono Germanico che serve un Britannico.» Tressa mi si era avvicinata e io, posandole un braccio sulla spalla, per la prima volta mi resi conto che indossava una strana veste. Mi ero abituato nel corso degli anni a vedere Shelagh in abiti maschili quando andava a cavallo, ma ora mi accorgevo che sotto il suo ampio mantello Tressa portava una specie di pettorale. La tirai davanti a me e, aprendole le falde del mantello, osservai incredulo la corazza di cuoio che portava sopra un breve gonnellino militare a frange rinforzate di metallo. Le lunghe gambe erano infilate in un paio di pantaloni, come i soldati, ma di un cuoio assai più fine e riccamente lavorato. Nel breve intervallo che mi ci volle per portare lo sguardo dalle sue gambe al suo viso, lei era arrossita. Guardai dall'una all'altra. Leggendo la confusione nel mio sguardo, cominciarono a raccontarmi come avevano passato il tempo mentre io ero lontano, in guerra. Shelagh aveva insegnato a Tressa ad andare a cavallo, e glielo aveva insegnato bene, con severità più che con gentilezza dei modi. Per mesi Tressa si era levata all'alba e si era recata alle stalle con Shelagh per familiarizzare con i cavalli e aver cura dei finimenti e dell'attrezzatura, prima di cominciare a badare a uno tutto suo. Poi, una volta abituatasi a stare in sella, aveva imparato a cavalcare al modo degli uomini, e a volte si era esercitata per l'intera giornata, allenando i muscoli alla disciplina dell'equitazione e del controllo dell'animale, e sopportando le vesciche, i crampi, i dolori alle gambe, alle cosce e alla schiena. Sentendo l'entusiasmo nella voce di Tressa mentre mi raccontava questa sua avventura e ammirando il colorito del suo viso e lo sguardo animato dei suoi occhi, mi spiegai la fuggevole sensazione che avevo percepito la prima notte dopo il mio rientro a casa. Si era davvero indurita, aveva muscoli più sodi, pieni, più visibili; le forme del suo corpo erano meno voluttuosamente rotonde, sebbene non avessero perso nulla della loro bellezza e sensualità femminile. Tressa non aveva imparato soltanto a cavalcare, ma anche a usare una spada corta, la leggera lancia da cavalleria in uso a Camelot, e l'arco. Quest'ultimo, con una faretra piena di frecce, era agganciato alla sua sella e dal fianco destro le pendeva la spada. Non era in grado di combattere, ma certamente, come mi confermò Shelagh, era capace di difendersi in qualsiasi situazione. Ogni giorno trascorrevano insieme il tempo libero, cavalcando da un capo all'altro della Colonia. Ascoltai in silenzio il loro resoconto e quando finirono tesi le mani a Tressa. Fino a quel momento mi aveva lanciato occhiate nervose, chiedendosi come avrei reagito a quelle notizie, ma placai ogni suo dubbio domandandole di darmi una dimostrazione della sua bravura. Le due donne entrarono immediatamente nelle stalle e io, seguendole, vidi che andavano a prendere le loro cavalcature già sellate. Da anni Shelagh aveva la sua bestia prediletta: un solido cavallo castrato, di colore grigio, non bello, ma di grande resistenza e buona volontà. Quello di Tressa era bruno, di notevole stazza. Con piglio sicuro lo condusse fuori della stalla, tenendolo per la briglia, e poi, afferrandosi alla sella, infilò il piede nella staffa e si tirò su con un movimento sciolto e disinvolto. Infilato il piede destro nell'altra staffa, per qualche attimo rimase ritta sulle gambe, il tempo di sistemare il mantello dietro a sé. Risi felice, e portai il braccio di traverso sul petto in segno di rispettoso omaggio verso tanta destrezza; poi, per curiosità, chiesi loro dove fossero dirette quella mattina. Non ne avevano idea, disse Shelagh. Avrebbero imboccato la strada che portava alla vecchia villa Varo, la residenza più vicina a dove abitavamo noi, poi forse si sarebbero avviate verso l'allevamento equino nella parte orientale della Colonia, non lontano dalle colline Mendip, dove Publio Varro aveva trovato la Pietra del Cielo. La mia prima reazione fu di ansia al pensiero di due donne che se ne andavano in giro da sole. Tuttavia era evidente che non erano donne come le altre: Shelagh era una guerriera, e quanto aveva detto sulle capacità di Tressa era per me una garanzia sufficiente. Mi rassicurava sapere che sarebbe stata in grado di cavarsi d'impaccio in caso di bisogno. Volevo raccomandare loro di fare attenzione, ma rimasi in silenzio perché non mi rinfacciassero di essere troppo ansioso, se mi fossi azzardato a esprimere una preoccupazione. «Girate armate?» chiesi. «Certamente» rispose Shelagh in tono leggermente spazientito. «Che cosa credevi? Lo stabilisce la legge. Abbiamo anche un elmetto attaccato alla sella. Sono sicura che altrimenti non ci lasceresti andare a zonzo.» Dissi loro che dovevo vedere Ambrogio di lì a poco, ma poi, se lui e Donuil ne avessero avuto voglia, avremmo potuto seguire le loro tracce, per puro divertimento e, nel mio caso, anche per familiarizzarmi con la nuova cavalcatura. Rimanemmo d'accordo così, e si allontanarono lasciandomi con Bucefalo e una voglia matta di andare loro dietro. Ma prevalse il senso del dovere. Condussi nella stalla il cavallo nero, quindi tolsi i finimenti a quello con cui ero venuto fin lì. Quella mattina segnò l'inizio di un periodo breve e idilliaco durante il quale arrivai a vedere Tressa con nuovi occhi. L'amore che ci univa divenne più profondo e maturò al calore dei legami di autentica amicizia che si consolidavano tra noi mentre insieme, ogni giorno, uscivamo a cavallo. Ero sorpreso dalla sua perizia in sella, pari quasi a quella di Shelagh, la cui bravura era leggendaria tra i soldati; Tressa maneggiava la lancia lunga e leggera con straordinaria disinvoltura, quasi fosse un'estensione del suo braccio. Si lanciava al galoppo e con la punta dell'arma riusciva a raccogliere da terra un oggetto convenuto, con gran dispetto di molti soldati che non uguagliavano la sua destrezza. Ancora più brava era nell'uso dell'arco e quasi sempre cinque su sei delle sue frecce si conficcavano entro l'anello interno del bersaglio. Soltanto a una distanza superiore ai cento passi la sua mira mostrava qualche pecca, ma forse il difetto era imputabile alla leggerezza dell'arco più che a una carenza di precisione nel tiro. Perfino stando in sella, girata verso il bersaglio, riusciva a centrarlo almeno quattro volte su sei. Ero sbalordito. Nell'uso della corta spada tradiva una debolezza tipicamente femminile. I muscoli delle braccia non avevano la forza necessaria a impugnare e maneggiare uno strumento così pesante e micidiale. Al posto del vecchio gladium le diedi una daga, più corta e a doppio filo, maneggevole e pericolosa nei combattimenti ravvicinati, se mai ci fosse stato bisogno di ricorrere a quegli estremi rimedi. Artù lasciò Camelot insieme a Llewellyn dopo una settimana circa dal mio arrivo, ma prima di andarsene fece da testimone al mio matrimonio con Tressa. A officiarlo fu il vescovo Enos poco prima della partenza. La cerimonia fu raccolta e ristretta, ma lieta, e gli amici vi parteciparono mostrando affetto e ammirazione. La festa di nozze durò una giornata soltanto, e partiti i nostri ospiti, ebbe inizio la vita coniugale, piena di promesse di una felicità serena e tranquilla, scevra di affanni e disgrazie. Liberi dalla pressione di necessità urgenti, io, Tressa, Donuil e Shelagh prendemmo l'abitudine, piacevole e benefica per tutti noi, di partire a cavallo e visitare le piccole guarnigioni che sorgevano al di fuori dei confini di Camelot, lungo le grandi strade in direzione nord, sud ed est. L'idea di una rinascita si era propagata in fretta. Le comunità che visitavamo erano pervase da ottimismo. La gente lavorava ogni giorno con fervore per costruire nuovi avamposti in grado di accogliere quanti dal circondario confluivano lì a stabilirsi. Le bande di briganti che, di tanto in tanto, attaccavano i nuovi insediamenti venivano respinte con determinazione implacabile da un nuovo soggetto sociale: una comunità di gente semplice ma consapevole di riuscire a difendersi, certa di essere nel giusto, fiduciosa di poter contare sul soccorso di forze esterne. Davanti a tanta unità e compattezza si disperdeva la plebaglia dei fuorilegge; chi cercava di invadere i nuovi insediamenti veniva ucciso impiccato - e il corpo lasciato a penzolare fuori degli accampamenti o al margine dello stanziamento. I campi che da tempo non conoscevano l'aratro venivano dissodati; si disboscavano le terre; gli alberi abbattuti fornivano il materiale da costruzione e, una volta sradicati i tronchi dal suolo, i contadini potevano disporre di più ampie superfici di terreni coltivabili. Furono edificate molte case di legno grezzo e vedevamo innumerevoli artigiani - vasai, tessitori, conciatori, ciabattini, fabbri, bottai - impegnati nei loro mestieri. Temporaneamente le attrezzature trovavano riparo sotto qualche tettoia, talvolta esposte all'inclemenza del clima perché non c'era stato il tempo di innalzare i muri perimetrali. Ovunque andassimo, percepivamo nell'aria l'odore del legno tagliato e dell'impalpabile segatura. In ogni comunità fervevano da mattina a sera le esercitazioni militari, mentre i nuovi arrivati che avevano raggiunto l'età per combattere si addestravano sotto lo sguardo severo dei veterani provenienti da Camelot e lì temporaneamente dislocati. Dopo decenni di paura e anarchia, finalmente la gente si raccoglieva, decisa a proteggersi contro i saccheggiatori che avevano imperversato dopo che se ne erano andate le legioni. Dappertutto si coglievano la speranza e la voglia di risorgere. Non era possibile ignorare questo spirito di rinascita mentre i tiepidi giorni dell'autunno trasformavano l'intera regione in un arazzo d'oro e rosso, e le messi promettevano di essere copiose. Per la prima volta dopo lunghissimo tempo comparvero i musici, gli attori, i saltimbanchi, e i lunghi pomeriggi dorati erano spesso rallegrati dal suono di qualche melodia che si diffondeva a grande distanza nell'aria chiara e tranquilla. Quando circolava voce che ci sarebbe stato uno spettacolo, il pubblico era sempre più numeroso del previsto, le donne e i bambini nei loro abiti di festa, gli uomini allegri e vociferanti con i boccali in mano, desiderosi di chiacchierare e sempre più espansivi a mano a mano che si abituavano a vivere nella sicurezza e nell'agio. Seppure, come mi fece notare Ambrogio, dovunque girassero soldati, ci consolava sapere che erano del tipo migliore: padri di famiglia il cui atteggiamento militaresco era dettato dalla ferrea determinazione di proteggere i loro cari. Raramente si mostravano indisciplinati o riottosi. Erano pronti a battersi per le persone e le cose che amavano, e altrettanto pronti a godere dei benefici della loro disciplinata presenza e assidua vigilanza. L'inverno si annunciò con una spruzzatina di neve sul finire di dicembre, poi parve ritirarsi e allentare i suoi rigori, come aveva fatto l'anno precedente, sicché dal cielo grigio scendeva soltanto una pioggia intermittente. Non ci furono né tempeste né bufere né venti ululanti. I rami degli alberi restavano immobili, l'erba rimaneva verde sotto i nostri piedi, e noi potemmo continuare le nostre visite agli amici al di là dei confini della Colonia senza interruzioni. I commerci prosperavano pacificamente lungo la grande strada romana che da Camelot portava a nord, verso Appia, la nuova colonia di Appio Niger, vicino a Corinium, e a sud conduceva alle nuove guarnigioni di Ilchester e ai piccoli avamposti in direzione di Isca. Questa strada era chiamata Via Appia dal nome di quella in Italia che, come tutte le altre, arrivava a Roma. Grazie alla fiducia maturata in passato tra i pacifici Appii e i rappresentanti dei contadini intorno a Corinium, gli abitanti di quella regione avevano cominciato a riparare le mura originarie dell'antico accampamento, con qualche esitazione all'inizio e poi con crescente fiducia, a mano a mano che l'opera procedeva. Con l'aiuto efficiente degli Appii subito si stanziò in quelle terre risanate un abbozzo di guarnigione. Una volta insediatasi, e con l'aiuto di un consiglio di anziani scelti per vegliare sull'osservanza delle leggi, nell'arco di pochissimo tempo la sua popolazione aumentò, e Corinium divenne una delle mete fisse delle nostre ricognizioni. Una mattina Tressa mi si avvicinò mentre stavo seduto in un angolo inondato dalla luce del sole, e sul tavolo, accanto al mio gomito, appoggiò un vaso pieno di fiorellini bianchi, blu e gialli. Era arrivata la primavera e quei boccioli ne erano il primo luminoso annuncio. Mi venne da sospirare al vederli, perché segnavano la fine di quei giorni idilliaci. La primavera mi avrebbe di nuovo portato lontano da Camelot, questa volta verso est, incontro a Germano. Non avevo voglia di andare. Tressa mi chiese che cosa mi crucciasse, temendo di avermi in qualche modo offeso. Le raccontai i pensieri che mi erano venuti in mente. Quando capì che era stata mia intenzione lasciarla a casa, ne fu così stupita che non si accorse della mia sorpresa all'idea che lei potesse avere voglia di accompagnarmi. Le nostre diverse reazioni crearono uno di quei momenti pericolosi in cui da una circostanza banale e insignificante possono esplodere conflitti dalle conseguenze incalcolabili; per fortuna fui abbastanza avveduto da accorgermene ed evitare ogni diverbio. Invece di respingere nettamente la sua proposta di seguirmi, tacqui, la lasciai parlare e mi costrinsi ad ascoltare le sue ragioni. Senza rendersi conto dell'enormità del suo progetto, mi disse che lei e Shelagh avevano deciso che il loro posto era con noi: ci avrebbero seguito ovunque, a parte il campo di battaglia. Era convinta che la guerra fosse per i guerrieri, e che le donne non avessero né l'addestramento né la forza per affrontare un nemico corpo a corpo. Ma il mio viaggio non poteva essere considerato una campagna militare. Ammetteva che i preparativi parevano quelli della mobilitazione di un esercito, ma le circostanze erano tali da non escludere né lei né Shelagh. Si vestivano con abiti di foggia maschile e andavano a cavallo alla maniera maschile; sapevano usare le armi e accudire alle loro cavalcature; non si aspettavano di essere aiutate dagli uomini. Avrebbero prestato assistenza alla spedizione in molti modi: sarebbero andate a caccia, avrebbero vegliato nei turni di guardia, cercato il foraggio e, se fosse stato necessario, curato piccole ferite. Mentre continuava nel suo chiacchiericcio snocciolando una serie infinita di argomenti a favore della loro partecipazione alla spedizione e contro la loro esclusione, mi fu difficile sopprimere un sorriso di ammirazione. Tutte le mie obiezioni si scioglievano come neve al sole tiepido della primavera, sicché ancora prima che avesse finito di parlare e prima che fossi riuscito a inserire una sola parola in quel discorso, già avevo preso una fondamentale decisione. Tressa e Shelagh ci avrebbero accompagnati. Sapevo che Donuil non vi avrebbe visto niente di male, e che gli altri non avrebbero avuto nulla in contrario. Shelagh e Tressa erano le uniche due donne amazzoni in tutta la Colonia eh' i soldati avrebbero accettato, perché non andavano a cavallo come le altre e non avevano la civetteria di pensare sempre e soltanto al loro aspetto. Come Tressa tacque e rimase a guardarmi, in piedi vicino a me, a occhi sgranati e chiaramente incerta di quale sarebbe stata la mia reazione, accennai di sì con la testa e dopo avere soffocato un singulto in gola l'avvertii di preparare i bagagli entro la settimana successiva. Mi fissò incredula, poi con un rantolo di gioia mi baciò in fretta e si precipitò ad annunciare la novità a Shelagh. Guardandola avviarsi, mi chiesi come avrebbe reagito se avesse saputo la vera ragione per cui avevo accolto la sua proposta. Quando, circa diciotto anni prima, in occasione del precedente Concilio, mi ero recato a Verulamium e vi avevo conosciuto Germano di Auxerre, avevo lasciato a casa mia moglie e al ritorno l'avevo trovata brutalmente assassinata. Questa volta la mia donna mi sarebbe stata vicino giorno e notte, e chiunque avesse avuto l'intenzione di minacciarla o farle del male, avrebbe dovuto vedersela con me. Germano arrivò al luogo fissato per l'incontro in una bellissima giornata di tarda primavera. Le tre imbarcazioni che portavano lui e il suo seguito procedevano su una rotta verso occidente, lungo la costa. Le sentinelle cercavano di captare il segnale convenuto per il luogo di approdo. Dietro a me, mille uomini stavano a guardare disposti in ranghi concentrici e disciplinati sui pendii di basse colline ad anfiteatro. Il nostro gruppo comprendeva in realtà più di milleduecento persone, perché un manipolo di soldati ha bisogno di innumerevoli servizi, come il ricambio dei cavalli, i carri con le vettovaglie e un equipaggiamento medico. Con un'ultima occhiata all'assembramento e poi con un cenno di assenso verso Dedalo gli comunicai di prendere il comando, quindi mi avviai verso la riva dove già si era raccolta una folla per dare il benvenuto al vescovo e al suo corteo. Mi seguivano Donuil, Filippo, Falvo, Benedetto, una dozzina di capitani delle truppe e naturalmente Tressa e Shelagh. Procedevo in testa al gruppo, tenendo con la destra le redini del mio cavallo e con la sinistra quelle di un castrato bianco. Ignoravo se Germano montasse ancora in sella, ma con la speranza che lo facesse, avevo scelto appositamente per lui una cavalcatura tranquilla. Enos doveva aver preparato con cura l'incontro perché, come avemmo occasione di notare, per tutta la strada che da Camelot portava a Sorviodunum e da lì a Venta Belgarum, la gente del posto aspettava il nostro arrivo. La stessa accoglienza ci fu riservata lungo le sessanta miglia che da Venta portavano alla costa in direzione sudest. Ci accompagnava una scorta di chierici dalle tonache scure, che reggevano croci e bordoni, ansiosi di farci capire che, malgrado avessimo una diversa impressione, ci muovevamo in realtà tra un gregge di cristiani pacifici e animati da buone intenzioni. E, a conferma di ciò, con gran sorpresa generale, non ci trovammo nelle terre da noi attraversate davanti a scene di panico o a reazioni di paura prodotte dal nostro ingente numero o dalla nostra presenza, sebbene molti di quelli che incontravamo fossero di ceppo straniero. Viaggiavamo in una terra sassone, e sassoni erano i suoi abitanti. Ci capitò, naturalmente, di dover fronteggiare qualche episodio di ostilità nella nostra marcia verso sud. Uno in particolare produsse su di me una durevole impressione, e fu Dedalo a darmene notizia. Era avanzato in ricognizione, mi disse, a capo di un manipolo di suoi uomini, quando si era accorto che una fattoria isolata veniva in quel momento saccheggiata. Avevano in breve tempo disperso gli aggressori senza che ci fossero state perdite tra i nostri. Ded, venuto subito a comunicarmelo, mi aveva trovato in testa al nostro contingente intento a parlare con Benedetto. Brusco come sempre, ci interruppe. «Guarda qui» disse tendendomi una specie di arma. «Che ne dici?» La esaminai frettolosamente. «Mi sembra il parente povero del mio mazzafrusto» dissi, soppesando l'aggeggio con la mano sinistra e con la destra sganciando dalla mia sella il minaccioso strumento di ferro costruito da Uther Pendragon. L'arma di Uther, e ora mia, consisteva di una palla di ferro attaccata a una catena corta e pesante, a sua volta agganciata a una spessa impugnatura di legno. Lo strumento che in quel momento tenevo nella sinistra era simile ma di differente fattura. Invece di una palla di ferro, aveva una grossa pietra quasi sferica, avvolta in una rete di canapa i cui fili avevano lo spessore di un mignolo. I fili longitudinali, in numero di quattro, erano annodati in prossimità della testa dell'aggeggio, e avvolgevano tutta l'impugnatura. La rete, frutto di un lavoro paziente e accurato, si riavvolgeva su se stessa sicché le estremità dei fili erano nascoste e non si vedeva traccia di nodi. L'intera arma era stata quindi immersa in una sorta di cera o liquido vischioso che aveva indurito le fibre della rete, proteggendole: un maneggevole strumento di morte, spaventosamente efficace. «Non è affatto il parente povero» replicò Ded con sdegno. «È un'opera d'arte.» Esaminai di nuovo l'arma e non potei non dargli ragione. «Sì, ma è di corda e pietra. La mia è di ferro massiccio.» «Esattamente. Per questo te l'ho mostrata. Ti ricordi la nostra discussione su come sono cambiate le cose da quando i Romani se ne sono andati? Ti lamentavi che era difficile trovare una spada perché le legioni, partendo, si erano portate dietro i loro armieri.» «Sì, lo ricordo.» «Ed ecco la prova. Guarda l'attento lavoro che è stato fatto soltanto per agganciare una pietra. Quest'arma, Merlino, è stata costruita da qualcuno che aveva visto l'originale in ferro, ma non aveva gli strumenti per riprodurlo. Ma, quanto a efficacia, non è da meno. Guarda.» Si chinò per tirare fuori dalla bisaccia attaccata alla sella un'altra arma, assai più rozza. Era, o era stata, una lancia di fattura primitiva, consistente in una daga legata con una correggia di pelle a un'asta di legno. Dopo avermela mostrata, Ded la buttò sprezzantemente tra l'erba. «Così erano le armi che avevano quei figli di puttana.» Vedendomi inarcare le sopracciglia, proseguì in fretta. «Abbiamo visto una banda di selvaggi che assalivano una fattoria a circa tre miglia da qui. Forse erano Sassoni, ma ne dubito. Probabilmente banditi, puri e semplici. Ladri e assassini. Hanno ammazzato quattro di quelli che abitavano nel casolare, e catturato gli altri, una decina di persone. Nessuno di loro aveva una spada decente: disponevano soltanto di coltelli e mazze di legno. Quella pietra era l'arma migliore su cui potessero contare.» «Che cosa ne deduci?» «Che probabilmente siamo gli unici nei dintorni a possedere armi vere.» Gli sorrisi, e lo stesso fece Benedetto. «Forse hai ragione, Ded» dissi. «Ma non butteremo via le nostre spade per paura che tu possa esserti sbagliato.» Quella conversazione mi tornò in mente mentre osservavo l'assembramento di oltre cento uomini in attesa sulla riva. Erano quasi tutti Sassoni, e qui e lì si scorgevano le vesti brune di qualche chierico, ma nessuna arma. Erano per lo più cristiani, e convertiti da poco, ma sarebbe stato iniquo privarli, per tale motivo, della possibilità di difendersi mentre erano lontani dalle loro case. Ci avevano lanciato occhiate in tralice il pomeriggio precedente, ma con mitezza, più curiosi che ostili. Osservandoli ora con maggiore attenzione, mi sentivo di confermare la prima impressione: non erano armati. Fermai il mio cavallo sulla striscia erbosa sovrastante la distesa di ciottoli che arrivava fino a riva, sorridendo meravigliato che tutta quella gente allungasse il collo con la speranza di scorgere le tre piccole navi, quando sarebbe stato sufficiente venire là dove ci eravamo appostati noi per vedere ogni cosa con facilità. In quell'assembramento nessuno era di ceppo celtico; me ne accorsi per via delle vesti che apparivano bigie e incolori ai miei occhi avvezzi da anni alle tinte sgargianti dei miei compatrioti. Quanti erano lì convenuti indossavano abiti rozzi, tessuti in casa, monocromi, marrone opaco o grigio spento. Da nessuna parte si coglieva un tocco di colore, neanche di nero o di bianco; neppure il tessuto era lavorato con qualche motivo decorativo. Vedendo avvicinarsi la piccola imbarcazione di Germano, fui contento di avere insistito per cambiare la località dell'approdo. Aveva previsto di sbarcare in prossimità del forte di Dubris, a circa cinquanta miglia sulla costa, nel punto in cui le scogliere bianche della Britannia sono più vicine alla Gallia, dall'altra parte del Mare Stretto. Avevo obiettato sostenendo che era troppo pericoloso per lui e per me. Sarebbe infatti sbarcato su suolo straniero, affidandosi a comunità la cui conversione al cristianesimo non era certa; per accoglierlo avrei dovuto attraversare una terra che non conoscevo, affidando la sicurezza dei miei uomini a gruppi che a loro volta si limitavano a fare semplice dichiarazione di buona volontà. Dubris sorgeva al margine meridionale del Weald; per arrivarci, e quindi ripartire, avremmo dovuto marciare nei territori di Horsa. Avevamo perciò concordato che, all'altezza di Dubris, la sua nave avrebbe virato a ovest e proseguito parallelamente alla costa fino alle rovine di Anderita, il forte più a occidente tra quelli della Costa Sassone. Avrebbe poi doppiato il promontorio che, subito dopo Anderita, si protende a sud, e continuato a costeggiare in direzione nord-ovest, fino al punto in cui la sponda di nuovo volge a ovest. Avremmo aspettato il suo arrivo direttamente a sud di Londinium e di Verulamium, situate a circa ottanta miglia nell'entroterra. Per indicargli un approdo sicuro gli avremmo lanciato segnali di fumo da tre grandi falò, due a ovest del luogo di sbarco e il terzo a est. La piccola flotta si avvicinò il più possibile al litorale che, con la bassa marea, sembrava allungarsi fin quasi a coprire la metà della distanza che ci separava dalla Gallia. Guardandola, mi felicitai che le acque fossero calme, perché, in condizione di mare agitato, sarebbe stato impossibile effettuare l'operazione di sbarco che invece si concluse in mezz'ora. Vedevo le prime tre barche cariche avvicinarsi alla riva e la gente affollarsi intorno ai nuovi venuti per accoglierli. Levai la mano per avvertire i miei compagni di aspettare lì dov'erano. Infatti, se ci fossimo mossi allora, il nostro arrivo avrebbe inevitabilmente e ingiustamente attirato l'attenzione generale, e privato quanti erano venuti a piedi dell'occasione di salutare l'uomo che intendevano accogliere con tanto entusiasmo. Scorsi subito Germano, ma sentii un nodo alla gola vedendo il cambiamento che si era operato in lui da quando ci eravamo incontrati l'ultima volta. Un tempo, davanti a me avevo visto l'ex delegato delle forze armate di Roma, un uomo di cinquantanni, vigoroso, sbarbato, forte e agile, robusto nelle braccia e solido sulle gambe, con cosce muscolose in grado di stringersi senza sforzo intorno al dorso di un cavallo: il generale Germano di Auxerre che aveva deciso di diventare un uomo di Dio. L'uomo che, seppure a una certa distanza, ora vedevo non aveva nulla in comune con un soldato. Era vecchio, con una fluente barba bianca. Scorgendomi, levò una mano per salutarmi. Lo salutai anch'io ma non mi mossi per andargli incontro, preferendo che lui finisse di ricevere l'omaggio degli amici e dei seguaci, che si genuflettevano e gli baciavano la mano. Alcuni, dopo questo atto di reverenza, lo abbracciarono, ma per lo più si tirarono indietro per fare spazio ad altri. Dietro a me un cavallo nitrì e picchiò rumorosamente gli zoccoli sul terreno, forse punto da qualche insetto; ma l'irrequietezza si diffuse e molti cavalieri furono costretti a tirare con forza le redini per mantenere l'ordine tra le loro bestie. Avevo gli occhi fissi su Germano, mentre i ricordi si affollavano nella mia mente. Non ci vedevamo dall'estate del 429, l'anno in cui era stata uccisa Cassandra. Nel 431 era nato Artù, che oggi aveva sedici anni. Germano doveva essere sui settant'anni; io, allora, non ancora trentenne, oggi ne avevo quarantasei. «Scenderai a riva per andargli incontro?» mi chiese Tressa che mi aveva raggiunto e stava alla mia destra. «Tra poco. Sa dove siamo. Ci farà sapere quando sarà pronto a incontrarci.» Mentre parlavo, l'andirivieni intorno al vescovo si era attenuato, ma altri sopraggiungevano a salutarlo. Per qualche momento rimase solo. Quando gli si avvicinarono alcuni chierici, Germano li tenne a distanza agitando la mano e levando lo sguardo verso di noi, fermi sul crinale della collina. Un sorriso gli illuminò il viso mentre ci faceva cenno di avvicinarci. Germanico imboccò il pendio e raggiunse la spiaggia, ma, accorgendomi che il suo passo era incerto sul terreno ciottoloso, scesi di sella e mi avviai a piedi verso il mio amico. Mi lasciai cadere in ginocchio, tendendo la mano per prendere e baciare la sua, nel gesto simbolico di offrire la pace di Cristo. Mi permise di genuflettermi, ma subito dopo mi tirò su e mi abbracciò con lo slancio di un caro amico che non ti vede da tempo: mi sorprese la forza che mostrava di avere. Lo presentai al mio seguito e agli altri ufficiali, cominciando da quelli di più alto rango. Germano li salutò con cordialità, usando per ciascuno parole diverse e ringraziando tutti per il disturbo che ci eravamo presi per andargli incontro. Lungo la riva si erano in gran parte concluse le cerimonie di saluto, e la folla, disposta in cerchio, se ne stava in silenzio, attenta a capire quello che succedeva tra noi e il vescovo. Germano si volse al suo corteo levando le braccia e la voce per richiamare l'attenzione, prima di accorgersi che già tutti erano in attesa delle sue parole. Abbassò immediatamente le braccia. «Cari amici, mi è di consolazione sapere che con questi segni e portenti Dio mi comunica che siamo nel giusto nel perseguire la santa causa che ci ha portati in Britannia. Durante la traversata ci ha elargito un mare calmo e un cielo sereno che ci hanno consentito di arrivare nel giorno fissato e di trovarvi in attesa del nostro approdo. E soprattutto Egli ha ritenuto opportuno che rivedessi il mio amico Caio Britannico che ci salvò la vita quando per la prima volta sbarcammo in Britannia quasi due decenni fa, e ci scortò fino a Verulamium. Oggi è qui di nuovo per scortarci ancora una volta, ma adesso è presente su nostra richiesta e con forze molto più ingenti. Nei prossimi giorni avrete modo di conoscere lui e i suoi uomini. La strada per Verulamium è lunga e forse insidiosa, ma gli amici venuti da Camelot veglieranno sull'incolumità di tutti noi. In questo momento una scorta, armata di tutto punto, è sulla collina e sotto il sole aspetta il nostro passaggio. Non sarebbe caritatevole prolungare il disagio di quegli uomini più del tempo strettamente necessario. Avviamoci, dunque.» Tacque e, lanciandomi un'occhiata, chiese: «Quanto è distante l'accampamento nel quale trascorreremo la notte?». «È vicino. Meno di un miglio da qui. Mi è sembrato opportuno che riposassi almeno una giornata prima di intraprendere il viaggio. Abbiamo disposto di partire domani; un sostanzioso pasto ci attende all'arrivo all'accampamento. Consideralo un gesto di ringraziamento per essere arrivato con tanta tempestività. Così almeno lo interpretano i miei uomini, che non sono abituati a un pranzo succulento a metà giornata se non nelle occasioni speciali.» «Magnifico!» Trasmise l'annuncio al suo seguito e con le braccia fece segno a tutti di avanzare. Notai che la sua lunga veste, tagliata verticalmente sul davanti dalla vita in giù, mostrava aprendosi un paio di brache e stivali di cuoio assai pratici e comodi. Quando tornò a voltarsi verso di me, lo presi per il gomito e insieme avanzammo. «Sono contento di vederti abbigliato per montare a cavallo, vescovo. Mi hai scritto una volta che da anni non salivi più in sella.» «Lo so, ma subito mi sono reso conto che commettevo peccato di orgoglio e mostravo ingratitudine verso Dio, lasciandomi prendere dalle Sue cure al punto di non avere il tempo per i piaceri che ci elargiva. Per porvi rimedio ho ripreso l'abitudine dell'equitazione prima ancora che la lettera ti arrivasse. Da allora non ho smesso di esercitarmi. Hai un cavallo per me?» «Certamente. È equipaggiato anche con le staffe. Sai usarle?» Si fermò e scoppiò a ridere, leggermente ansimante per la fatica di camminare sul terreno sassoso della spiaggia. «Che domanda mi fai? Ricordati che le prime staffe sono arrivate in Britannia dalla Gallia. Voi le avete adattate e ne avete elaborato una nuova versione che, una volta dimostratasi più efficiente, è stata prontamente copiata dai cavalieri della Gallia. Prima che partissimo da Verulamium uno dei miei fratelli ha fatto un disegno delle selle in uso qui, e sulla base di questo documento ci è stato facile costruirle. Sicché oggi cavalco esattamente come te.» «Alleluia!» esclamai. Germano mi lanciò un'occhiata penetrante. «Ne hai sentito parlare? Ti da fastidio?» «La vittoria dell'Alleluia? Perché dovrebbe darmi fastidio? Mi trovavo lì, non ricordi?» Vedendomi sorridere, il viso gli si illuminò. Con un cenno del capo indicai il cavallo che gli avevo destinato. «Ti va bene?» Inarcò le sopracciglia osservando lo splendido animale. «Come potrebbe non andarmi bene? Ma io sono vescovo, Merlino, e questo è un cavallo da re. Non si può trovare una bestia meno sontuosa?» «Sì, ma non vorrai peccare ancora di orgoglio. Questo cavallo mi è venuto incontro proprio quando ne cercavo uno per te.» Esitai per un attimo, quindi aggiunsi: «Anche i colori sono intonati: la tua barba è bianca come la sua criniera. Permettimi di aiutarti a salire in sella». Germano rise di nuovo, poi appoggiandosi alla mia spalla, mise il piede nelle mie mani unite a coppa. Mi levai sulle ginocchia e lo alzai all'altezza della staffa e a questo punto lui portò la gamba destra oltre il dorso dell'animale. «Si chiama Pegaso» dissi. «Non ha le ali, ma il colore è quello descritto nel mito. È veloce e docile.» Raggiunsi il mio Germanico e, salito in sella, notai che Tressa, davanti a noi, si avvicinava al punto in cui si trovavano le truppe. Quando mi volsi verso Germano, lo vidi che, eretto su Pegaso, osservava ammirato le schiere dei soldati. «Magnifico, Merlino, magnifico. Roma non ha mai visto l’uguale.» Tacque, ma dal suo atteggiamento si capiva che di lui si era nuovamente impossessato lo spirito guerriero. «Posso ispezionarle?» «Sarà un onore, vescovo, un onore per i soldati e per me.» «Andiamo allora. Accompagnami.» Nella mezz'ora che seguì le truppe di Camelot rimasero sull'attenti mentre il legato di Roma le passava in rassegna. Quando ebbe finito, e alle truppe fu permesso di ritornare all'accampamento, io, cavalcando di fianco al vescovo, gli spiegai che avevamo provveduto a portare con noi comodi carri forniti di panche imbottite in modo che, sia lui sia gli uomini del suo seguito, potessero raggiungere Verulamium viaggiando con agio invece che recarvisi a piedi come nella precedente occasione. Parlammo di molte cose in quel breve tragitto, ma eravamo circondati da un folto gruppo di persone, e sapevo che avrei dovuto aspettare prima di avere la possibilità di discutere i temi che più mi assillavano. Fu quindi con grande sollievo che lo ascoltai esprimere il desiderio di rimanere da solo con me, lontano dai doveri inerenti alla sua attuale missione e ai suoi impegni vescovili. Mi avrebbe dedicato un po' del suo tempo il giorno dopo, a conclusione della prima tappa del viaggio verso settentrione. Il nostro accampamento era disposto come un tradizionale accampamento romano, ma questa volta, in vista di dover accogliere circa millecinquecento persone, avevo ordinato che le cucine e la zona mensa fossero situate oltre il campo vero e proprio. La brezza ci portava i profumi invitanti della cacciagione che veniva cotta allo spiedo. Gli feci strada fino a dove alloggiavamo io e gli ufficiali. Avevo fatto innalzare, a uso di Germano, tre ulteriori tende accanto alla mia; due di queste erano abbastanza comode per accogliere gli uomini del suo seguito che avesse voluto tenere vicino a sé. Lo condussi al suo alloggio e, smontati da cavallo, porsi le redini a due palafrenieri in attesa. A questo punto piegando di lato la testa mi guardò. «I tuoi ufficiali... quelli che mi hai presentato... non ricordo i loro nomi, ma avevano il grado di tribuno, centurione e decurione. Non è strano?» «Strano? Perché?» «Erano ranghi romani.» «E allora? Non conta. Erano tìtoli militari, vescovo.» «Chiamami Germano, quando siamo soli. Perché romani? Voi non siete romani, vero?» «No, siamo britannici, ma le nostre radici sono romane.» «Come chiami i tuoi ufficiali?» «Perdonami, ma che cosa intendi dire? Sono i miei ufficiali... li chiamo per nome.» Germano scosse la testa sorridendo. «Scusami per non essere stato più chiaro. Lo storico in me sa che i tribuni romani non erano ufficiali di cavalleria né per nascita né per formazione. Lo stesso vale per i centurioni, che erano della fanteria. Cavalieri erano i decurioni, ma qui tutti i tuoi ufficiali sono di cavalleria.» «E allora? Non capisco» dissi confuso. Si strinse nelle spalle. «Quello che voglio dire è che, se si intendono adottare i costumi romani, allora è bene aderirvi con scrupolo. A Roma i padri fondatori appartenevano ai patrizi, gli altri erano i plebei. Successivamente, tra le due classi, ne emerse una terza, cui lo stato forniva cavalli e stipendio con il denaro pubblico. Erano gli uomini dell'ordine equestre, corrispondente a quello dei cavalieri di oggi. I tuoi uomini appartengono quindi all'ordine equestre. Dovresti, amico mio, chiamarli cavalieri e distinguerli in qualche modo dagli altri soldati.» «Cavalieri? Dovrei fondare un ordine nobiliare? A Camelot?» «Perché no? Forse non un vero e proprio ordine nobiliare, dato che nobiltà è una parola astratta e troppo spesso ambigua, ma certamente un nuovo ordine militare che raccolga gli spiriti migliori. Da come si presentano le tue truppe direi che Camelot è una comunità abbastanza matura per meritare qualche simbolo a testimonianza della propria eccellenza. Una semplice idea, ma vale la pena prenderla in considerazione. Potrebbe essere un incentivo per chi tra i tuoi uomini aspira alla vita militare.» «Ma quale segno distintivo dare a tale onore? Tutti abbiamo cavalli nella Colonia.» «Escogita qualcosa» disse Germano stringendosi nelle spalle. «È comunque soltanto un'idea. Pensaci su, amico mio. Dio ti guiderà, di questo sono sicuro. Ecco che arriva Ludovico, il mio segretario e la croce che mi porto in questa vita. Perdonami, e devo parlare con lui prima di ritrovarci per il pranzo.» Lo affidai alle attenzioni del corpulento chierico che veniva a reclamarlo; dal canto mio, mi misi alla ricerca di Tressa. Avevo la mente in subbuglio per i suggerimenti datimi da Germano. Dovevo farne partecipe qualcuno, ed era Tressa la persona che più mi stava a cuore. Ne discutemmo a pranzo, e lei si entusiasmò al progetto quanto me, percependo per la prima volta le possibilità che poteva offrire la costituzione di tale ordine, qualora avessimo compiuto i passi giusti. Prima della fine di quel pomeriggio, mentre Germano era occupato con i suoi vescovi in una riunione che si sarebbe protratta fino a tarda notte, io parlai dell'iniziativa a tutti i miei più prossimi collaboratori. Nessuno di loro - con mia grande tristezza - parve intuire le possibilità che Tressa e io avevamo scorto. Perfino Shelagh si limitò a pochi commenti laconici. Cercai di nascondere la delusione e di smorzare l'entusiasmo per paura di metterli in imbarazzo, ma l'idea non aveva perduto la sua attrattiva. Quella notte mi svegliai molto prima dell'alba con una visione in mente, una visione che avrebbe potuto essere un sogno: vedevo Artù, assai più avanti negli anni, che reggeva Excalibur davanti a sé, in mezzo a una cerchia di giovani coraggiosi con elmo e armatura e nello sguardo un'espressione di profonda ammirazione. Mi misi seduto sul letto nell'oscurità, e mi concentrai su quanto avevo visto, assaporando la luce e la bellezza di quel gruppo, finché l'immagine non si dissolse lentamente. Poi mi distesi di nuovo sul giaciglio, ma invano aspettai di riaddormentarmi. XIV. Il giorno seguente mi alzai prima dell'alba, ma quando uscii dalla mia tenda, nell'accampamento già fervevano mille attività. A strapparmi dalla branda erano stati gli scalpitii dei cavalli legati alle staccionate e il fracasso intorno ai carri che venivano caricati. Dopo essermi lavato in fretta con l'acqua fredda nei bagni comuni e aver consumato la colazione nelle cucine, trascorsi le ore successive a controllare i preparativi per la partenza. Da occidente, subito dopo il levar dell'alba, cominciò a soffiare una brezza robusta e tiepida, che si scaldava a mano a mano che in cielo si alzava il sole. I piccoli stendardi attaccati alle lance dei capitani del nostro squadrone garrivano nel vento e i portatori avevano difficoltà a reggere i grandi vessilli che proclamavano la nostra identità: il mio mostrava un grande orso d'argento su sfondo nero, e il leone rampante di Camelot, bianco su campo rosso. L'esodo parve all'inizio caotico, perché gran parte della folla che era venuta ad accogliere Germano rimase in attesa finché non fummo pronti ad avviarci, e subito dopo si disperse per ritornare a casa. Dopo mezzo miglio già si erano allontanati tutti, chi in una direzione, chi nell'altra, e noi ci ritrovammo soli: una colonna compatta e diritta che puntava verso nord, adeguando il passo di marcia al più lento dei carri coperti, il pesante veicolo dalle ruote larghe, trainato da muli, sul quale viaggiava il vescovo. In quella zona rurale di dolci colline, lontana dalle strade, quei carri erano nello stesso tempo un punto di forza, perché trasportavano le vettovaglie del gruppo, e un punto di debolezza, perché avevano difficoltà a superare ogni piccola salita e declivio. Il terreno, tuttavia, era solido, e i massi che ostruivano il percorso erano rari, sicché avanzavamo lentamente, ma senza difficoltà, mentre le larghe ruote lasciavano solchi profondi nel suolo. Portavamo nella bisaccia attaccata alla sella le razioni di cibo per la giornata e a mezzogiorno mangiammo senza scendere da cavallo per riposare, perché il ritmo della nostra andatura non rappresentava una minaccia al vigore delle bestie. Qualche tempo dopo, forse un'ora più tardi, mi giunse un odore di fumo. Portato dalla stessa folata, lo percepì anche Filippo, che procedeva di fianco a me, e sentenziò che si trattava di erba bruciata. A mano a mano che proseguivamo, il vago odore si faceva sempre più persistente e penetrante finché, a un certo punto, davanti a noi si parò una nube scura e densa. Vidi che Dedalo e Benedetto, alla testa del corteo, ritornavano indietro. Ci informarono che le colline antistanti, a nord e a ovest, erano avvolte dalle fiamme, alimentate dal costante vento che soffiava da occidente. Si erano avvicinati fino al fronte dell'incendio, confidando che la cortina di fuoco fosse sottile e facilmente superabile, ma il terreno stesso bruciava e sotto il primo strato gessoso se ne stendeva un altro di torba, che ardeva in profondità, togliendo ogni speranza di poter superare in fretta il tratto in fiamme. Impossibile, ci disse Dedalo in tono lugubre, aggirare l'ostacolo da settentrione. Eravamo quindi costretti a puntare a destra, verso oriente, e accerchiare il fuoco. A che sarebbe servito lamentarsi o arrabbiarsi? Bastava dare un'occhiata a Dedalo - coperto di fuliggine, con chiazze di bruciaticcio e gli occhi arrossati - per rendersi conto che il suo resoconto era veritiero. Ordinai a Filippo di cambiare la direzione della nostra marcia, e a Dedalo e Benedetto dissi di richiamare gli uomini che procedevano in perlustrazione davanti a noi e di indirizzarli nell'altra direzione. Il corteo girò a est, il che non mi tranquillizzava affatto, ma tenni per me la preoccupazione. Davanti a noi, infatti, si stendeva il Weald, dove da poco si erano insediati orde di Danesi, e non avevo voglia di suscitare un vespaio. Il seguito di Germano reagì immediatamente, e poco dopo lo stesso vescovo mi raggiunse a cavallo in testa alla fila. Il progetto del viaggio prevedeva che viaggiassimo puntando a settentrione, mi disse con ansia, ed erano stati presi accordi perché attraversassimo, senza essere molestati, quelle terre, ma nessuna misura era stata presa per garantire l'incolumità nell'altra direzione. Fino a che punto intendevo deviare dall'itinerario stabilito? Dissi che saremmo avanzati verso est finché non fosse calato il vento e si fossero spente le fiamme a nord. Avremmo seguito un percorso lungo i margini dell'incendio fino a quando non avessimo potuto girare di nuovo a ovest e riprendere l'itinerario originario. Fece un cenno di assenso con la testa, ma il suo disappunto era pari al mio. Se anche l'incendio si fosse estinto immediatamente, non avremmo potuto puntare a nord, perché sul terreno bruciato le bestie non avrebbero trovato di che nutrirsi. Il nostro destino era nelle mani di Dio, e in Lui dovevamo confidare. Per i successivi quattro giorni proseguimmo verso est, cercando di deviare a nord non appena fosse possibile. Gli esploratori mandati in avanscoperta setacciavano le terre che ci accingevamo ad attraversare e gli uomini del corteo stavano all'erta. Il vento tacque durante la notte del secondo giorno; Ded e Benedetto ci tenevano costantemente informati sulle condizioni a nord e a ovest di dove ci trovavamo. La mattina del quarto giorno avevamo lasciato la zona collinosa e di nuovo ci dirigevamo verso nord-ovest, attraversando un territorio ricoperto da arbusti e cespugli. Superammo prospere fattorie che erano fiorite dove un tempo c'erano stati i terreni incolti di una zona a vegetazione bassa, lungo il margine esterno di un tratto boscoso che si sviluppava verso est rispetto a noi. Non c'erano strade in questa regione, dove i Romani non si erano mai stanziati, ma dappertutto si vedevano i segni di abitazioni umane e di sentieri tortuosi, che conducevano da un casolare all'altro attraverso il folto della foresta. La popolazione di quel circondario, mi disse Germano, era costituita da Angli, lì insediatisi decenni o anche generazioni prima, e ora, pacificamente radicatisi, lavoravano la terra e provvedevano alla numerosa progenie. Fiutavo l'aria, per così dire, perché implicitamente diffidavo di tutti coloro che non erano di ceppo celtico o romano. Non colsi tracce di ostilità tra quella gente, e mi parve che dimostrassero un genuino affetto per il vescovo. Mi fu di sollievo capire che i numerosi Angli che lì abitavano erano di per sé una forma di garanzia. I Danesi di Horsa non avrebbero trovato punti di appoggio, perché non c'erano terreni liberi. Nel pomeriggio del quarto giorno ci ricongiungemmo finalmente con la strada che avevamo dovuto abbandonare e puntammo direttamente verso nord. Sul far del crepuscolo, mentre le ombre si allungavano al tramonto del sole, vedemmo un gruppo di gente che, evidentemente, aspettava il nostro arrivo. Quando ci avvicinammo, un uomo e una donna andarono incontro a Germano. Erano inequivocabilmente angli, e mi piacquero la dignità del loro atteggiamento e l'autorevolezza dei loro gesti. L'uomo, mi disse Germano, si chiamava Cuthric. Capii subito da come si comportava che era un capo tra la sua gente. Alto, diritto, si muoveva come se fosse sempre in vista, sotto gli occhi di una moltitudine, mostrando un garbo innato e un naturale decoro che lo distinguevano tra tutti. Le vesti che indossava erano ricche, di un pesante tessuto verde scuro, lussuoso al confronto degli abiti dimessi e di umile fattura dei suoi connazionali. La barba era fluente e la chioma, simile a una criniera dorata, gli scendeva fino sulle spalle larghe. Dava l'impressione che avrebbe saputo affrontare chiunque lo avesse sfidato. La donna che gli stava al fianco, indubbiamente sua moglie, era alta quasi quanto lui. Aveva gli stessi capelli biondi, fitti e lucenti; l'abito era un unico drappo bianco bordato di verde scuro. Si muoveva con una regalità spontanea. Insieme erano il ritratto della compostezza e di una sicura probità. Il viso di Germano si allargò in un ampio sorriso. Si rivolse ai nuovi venuti nella loro lingua, che parlava con la stessa padronanza del latino. Rimasi sbalordito perché non l'avevo mai sentito esprimersi in quell'idioma e ignoravo che lo conoscesse. Finalmente, volgendosi a me, mi pose la mano sul braccio. «Si chiamano Cuthric e Cayena» esordì. Il grazioso nome della donna mi rimase subito in mente. Feci con la testa un cenno verso i due e sorrisi, mormorando qualche parola cortese che Germano si affrettò a tradurre. Doveva essersi espresso con eloquenza perché entrambi, l'uomo e la donna, chinarono il capo con un gesto che mi parve di gratitudine e deferenza. «Cuthric è molto potente tra gli Angli» spiegò Germano. «Non è propriamente un re, perché la sua gente non ha il senso della regalità in quanto tale, ma è indubbiamente il loro principale rappresentante, riverito per la sua saggezza e la sua capacità di amministrare la giustizia con equità. È uno jarl, ma forse sarebbe meglio dire che è un capo e anche...» si interruppe alla ricerca della parola migliore. «Stavo per dire un uomo di religione, ma non è l'espressione adeguata nel suo contesto. Meglio definirlo un cristiano devoto ed esemplare. Il termine latino magus è forse quello esatto.» Sbattei le palpebre, guardando Cuthric e Germano. «Un mago? Vuoi dire uno stregone?» «No, naturalmente. Non ti ho detto che è un devoto cristiano? È un saggio, uno studioso, che conosce le antiche tradizioni della sua gente, e per questo è tenuto in grande stima. Ci accompagnerà verso nord, e la sua presenza, più ancora di quella dei tuoi mille uomini, ci proteggerà da ogni molestia.» Se mai poteva esserci un che di offensivo in quella sua ultima osservazione, il sorriso con cui accompagnò le parole servì a dissiparlo. «Ne sono contento. Ci serve ogni aiuto finché non saremo fuori portata delle minacciose orde di Horsa. Ti lascio, vescovo, ai tuoi ospiti: mi dedicherò ai miei doveri finché non saremo di nuovo pronti a partire.» Mi accomiatai da Cuthric e dalla nobile Cayena portandomi una mano stretta a pugno sulla parte sinistra del petto all'altezza del cuore, quindi, girato il cavallo, mi avviai verso le mie truppe che in formazione sciolta si erano disposte intorno alla fattoria. Rimasi per una mezz'ora con Tressa, Shelagh e Donuil, scambiando con loro complimenti e battute mentre Germano era intento alle sue faccende. Quando riapparve seguito dai due angli, li accomodammo su uno dei carri riservati ai passeggeri, e subito dopo riprendemmo la marcia. Nei giorni successivi mi trovai spesso in compagnia di Cuthric che, sempre vicino a Germano, parlava con lui nella sua lingua. A onor del vero, ogni volta che mi avvicinavo, Germano prendeva a usare il latino con me e si affrettava a tradurre a Cuthric. Nella settimana che seguì all'arrivo di Cuthric, ebbi due tra le più importanti conversazioni della mia vita: la prima fu profondamente meditata e accuratamente predisposta, la seconda sgorgò spontanea. Sono passati molti anni da allora e ancora mi rammarico che quest'ultima sia avvenuta soltanto sul finire del viaggio. Se d'altra parte fosse stata anticipata, la prima conversazione, indubbiamente la più importante, non avrebbe mai avuto luogo. Avevo sperato di poter trascorrere un po' di tempo da solo con Germano subito dopo il nostro incontro, nel corso dei primi giorni, ma così non era stato. C'era un viavai di chierici che quasi per magia incontravamo lungo la strada anche quando cambiavamo direzione di marcia. Questi messaggeri, ciascuno latore di notizie di maggiore o minore urgenza da sottoporre al vescovo, gli assorbivano tutto il tempo disponibile con incontri e riunioni che a volte si protraevano fino a notte fonda. Germano mi disse che, invecchiando, sentiva sempre meno il bisogno di dormire, e quando i soldati mi confermarono che spesso passavano il tempo con lui durante le ore di guardia antecedenti l'alba, mi convinsi che così era effettivamente. Eppure non appariva mai stanco o distratto; era anzi vigile e allegro e, dopo mangiato, saliva in sella con l'energia di un giovane. Alcuni giorni dopo avere ripreso la strada che conduceva a settentrione, a sera inoltrata, quando già le fiamme dei falò si levavano con minor vigore, mi chiamò mentre, diretto alla mia tenda, passavo accanto alla sua. Misi la testa dentro e lo trovai seduto al tavolo pieghevole, intento a parlare con due dei suoi vescovi. Levò lo sguardo sorridendo. «Credi di riuscire a trovare una borraccia di idromele, amico mio? Abbiamo quasi finito qui, e mi accorgo di essere stato ben poco tempo in tua compagnia da quando, chiedendoti di venirmi incontro, ti ho trascinato fin qui. Abbiamo molte cose da discutere.» Feci un cenno di saluto ai due vescovi, quindi gli sorrisi. «Credo di potermi procurare una o due borracce, ma non vogliamo mangiare niente? Hai cenato? Farò portare un po' di pane e di carne, e mangeremo qui. A che ora devo tornare?» Germano guardò gli altri due, ed entrambi stringendosi nelle spalle si dichiararono soddisfatti delle conclusioni raggiunte nel colloquio. «Quanto tempo ti ci vuole per procurarti le provviste?» «Rimani qui, sarò subito di ritorno.» Poco dopo rientravo nella tenda portando due borracce dell'idromele di Shelagh, contenuto nell'enorme botte che lei aveva insistito a portarsi dietro nella spedizione. Avvicinatomi al tavolo, vi poggiai sopra le due borracce, tirai fuori due boccali di corno e mi slacciai il fodero con la lunga spada. Non mi ero neppure accorto di averlo ancora addosso. L'appoggiai in un angolo della tenda. «Tra poco porteranno da mangiare» dissi. Riempii i due boccali e ne porsi uno a lui. Li avevamo appena accostati alle labbra quando tre soldati si affacciarono all'apertura della tenda, il primo reggendo un tavolo pieghevole, e gli altri due, un enorme piatto da portata di legno con una grande quantità di carne affettata di cinghiale selvatico, una brocca di vino rosso, due pagnotte di pane fresco e croccante, un piatto di verdura cotta, olio di oliva e olive marinate. Notando il mio stupore e indicando quelle leccornie, Germano sorrise. «Sei mio ospite. È tutto per te. Mi ero accorto a Verulamium che ti piacevano le olive e ricordo che dicesti di non averne mai mangiate di così buone.» «E di altrettanto squisite non ne ho più assaggiate» precisai con un tono di autentica gratitudine. Il suo sorriso si fece più ampio. «Il vino è quello dei nostri vigneti in Gallia. Ho chiesto ai miei fratelli di consegnare queste cose al tuo furiere, sapendo che le avrebbe tenute in serbo per te. Ha evidentemente deciso di utilizzare le provviste per stasera. Speriamo che abbia agito con discrezione perché ne ho portate in misura limitata, soltanto per la tua tavola.» Mangiammo come re quella sera, assaporando la tranquillità dell'ora che non ci costringeva ad affrettarci e rinnovando l'amicizia che ci legava. Toccammo infiniti temi durante quel lungo banchetto a due; non erano argomenti gravi, sebbene discutessimo anche della campagna in Cambria contro Ironhair e Carthac, e indugiassimo a parlare delle comunità che nascevano intorno a Camelot e delle nuove speranze che vi fiorivano. Ormai il pasto volgeva al termine: le olive marinate erano finite, le ultime gocce di olio erano andate a inzuppare il buon pane, ben poco rimaneva del cinghiale e ancora meno del vino rosso. Germano si lasciò cadere sulla sedia e, coprendosi la bocca con una mano, lasciò andare un piccolo rutto. «Quanto è piacevole per una volta mangiare fino a essere sazi, amico mio. Mi capita di rado di avere il tempo di concedermi un pasto completo, e ancora più di rado mi capita di mangiare così bene. Vuoi mostrarmi la tua spada?» Andai a prenderla nell'angolo dove l'avevo posata e, prima di porgergliela dalla parte dell'elsa, la tolsi lentamente dal fodero. La impugnò tendendo il braccio orizzontalmente davanti a sé con vigore assai maggiore di quanto avrei ritenuto possibile alla sua età. Osservò la lama socchiudendo gli occhi, poi ne saggiò il bordo affilato con il polpastrello del pollice sul quale comparve un sottile filo di sangue. «L'ho appena sfiorata» mormorò. «È molto tagliente.» «Sì, una cosa miracolosa, si potrebbe dire.» Continuando a studiare l'arma, toccò l'impugnatura con le dita della mano sinistra. «Non ne ho mai vista una così bella. Come l'hai avuta?» «L'ha forgiata il nostro fabbro a Camelot.» «Da dove viene il ferro? Sembra... un materiale diverso.» «Lo è. È il metallo ricavato dalla Pietra del Cielo.» Dall'espressione del suo viso mi accorsi che non aveva idea di che cosa intendessi dire. Forse fu il vino a incitarmi a parlare, fatto sta che mi trovai all'improvviso a raccontargli la storia di Publio Varro e della Pietra del Cielo. Cercai di essere conciso, e non accennai a Excalibur, ma la storia non si prestava alla brevità e, prima che avessi finito, nella tenda era sceso il buio. Germano taceva, gli occhi gli brillavano mentre rifletteva su quanto gli avevo detto. Guardandomi intorno, notai il guizzo di una candela votiva in un angolo. «La luce della cultura» mormorai. «Che cosa?» «È buio qui, l'oscurità è calata quasi all'improvviso. Ricordo che di notte eri solito accendere numerose candele.» «Lo faccio ancora, sebbene Accendiamone qualcuna.» non con tanta abbondanza. Si levò dalla sedia e mi restituì la spada, poi raggiunse una tenda divisoria e la tirò mostrando un tavolo lungo e basso sul quale posavano numerosi candelabri. Dal lume votivo prese uno stoppino e si accinse ad accendere le grosse candele, quasi una ventina. La tenda si trasformò allora in un fantastico baluginio di luci. Lo guardavo ben consapevole che, mentre raccontavo la storia della spada, si erano dileguati gli effetti del vino e che non avevamo quasi toccato le borracce di idromele. Mi alzai per andare a prendere i boccali e gliene porsi uno. «Allora,» riprese immediatamente «per anni, prima che ti venisse in mente di ricavarne una spada, nessuno toccò la statua trovata da tuo zio. Che cosa ti suggerì di utilizzarla per farne un'arma? Come ti è venuto in mente che la statua della Signora del Lago potesse servire per costruire una spada?» Un angolo della sua bocca fremeva nel sorriso che la barba curata mascherava ma non nascondeva del tutto. «Non dimenticare che sono un vescovo, consacrato alla verità divina.» «Perdonami, vescovo... non ti capisco.» «Oh, sì, mi capisci. Sai quello che voglio dire. Esiste un'altra spada, vero? Varro ne ricavò una dalla statua. Solo così si spiega la differenza di peso - ne hai accennato prima - e si giustifica la forma di questa spada, unica e singolare, che hai detto di avere disegnato. Ma tu, Caio Merlino, non sei un armiere. Ci sono lacune nel tuo racconto, sebbene tu abbia cercato di sorvolare. Credo che tu custodisca un segreto, e se è davvero un segreto, dimmelo e non ti chiederò altro.» Levai cupamente la coppa di corno nel gesto di un brindisi. «Alla tua perspicacia» dissi. «Poche cose ti sfuggono, vescovo. Alla tua salute. Adesso capisco perché hanno mandato te a discutere di sottili questioni teologiche. Hai indovinato. Esiste un'altra spada, Excalibur. Sei la prima persona che abbia intuito la sua esistenza.» Si sporse in avanti, lo sguardo acceso di curiosità. «Ce n'è un'altra? Sapevo della sua esistenza, ma credevo che fosse stata rubata o fosse andata perduta.» «Da anni è nascosta e io la veglio. È la spada del re.» «Quale re?» «Il grande re di tutta la Britannia. Il riothamus... Artù Pendragon.» «Artù? Il ragazzo di cui sei il tutore? Raccontami, Merlino.» Qualcosa mi dice che è una storia interessante. Che cosa ha di tanto straordinario questa spada? Come l'hai chiamata?» «Excalibur. L'elsa è stata forgiata da un blocco di metallo, come quella della spada che ti ho mostrato. Un blocco di metallo massiccio.» Leggendo l'incomprensione sul suo volto, saltai in piedi con un'idea in testa. «Voglio mostrarti una cosa che ho nella mia tenda. Vado a prenderla.» Ritornato da lui, gli mostrai il piccolo cubo di argilla bianca che usavo come fermacarte per i tanti documenti che ogni giorno si accumulavano sul mio tavolo da lavoro. «Prendilo e tira. È fatto di due pezzi.» Aprendosi il cubo lasciò cadere un pomo di ottone. «È di metallo massiccio. La plasmò mio zio Varro, anni fa. Fin da quando morì, la porto con me a dimostrazione della sua bravura. I due stampi di argilla che la racchiudono sono ciascuno una copia perfetta di metà della mela, come puoi vedere. Riempì lo stampo di cera, poi unì le due metà legandole con un robusto filo di ferro, perché non vi entrasse l'aria, quindi vi versò il metallo fuso, lentamente, attraverso un minuscolo foro sulla sommità. Il metallo sciolse la cera che colò fuori attraverso alcuni sottili forellini praticati nello stampo: un'operazione lenta per essere sicuri che il metallo si distribuisse uniformemente all'interno, senza bolle d'aria, dato che di aria non ce n'era quando fu versata la fusione. Il risultato è una mela di ottone perfetta e massiccia. Le else di queste due spade sono state costruite nello stesso modo; lo stampo fu costruito intorno al codolo della lama e alle barre laterali portanti della guardia. Una volta colato, il metallo fuso si saldò perfettamente con il codolo e la guardia; l'elsa è un pezzo unico, perfetto. Ecco l'origine del nome Excalibur, che significa "ricavata da un unico stampo".» Germano rimase in silenzio per qualche minuto, sfregando con il pollice la superficie della mela. Poi tese la mano per prendere la spada e studiò a lungo l'elsa, accarezzandola. Levò lo sguardo su di me. «Non ho mai visto un'arma più bella, Merlino, e neppure più lunga e più forte. Excalibur, che così gelosamente custodisci, è ancora più bella?» Mi strinsi nelle spalle facendo una smorfia. «Al confronto con Excalibur questa spada è insignificante, opaca, banale. La lama di di Excalibur sembra fatta con l'argento brunito: è accecante, se la si fissa a lungo; nel suo spessore si intrecciano diversi strati di metallo, disegnando un motivo che rifulge cangiante quando la si espone alla luce. Taglia un capello tanto è affilata, ed è così resistente che riesce a spezzare ogni altra spada. Anche la mia può farlo, ma non offre lo spettacolo che Excalibur elargisce a ogni stoccata. La guardia, che in questa è semplice, in Excalibur è riccamente decorata con motivi celtici; l'impugnatura è avvolta nella pelle grezza presa dal ventre di un enorme pescecane, lavorata con fili d'oro e d'argento, sicché non può sfuggire di mano. Il pomo è costituito da una conchiglia d'oro, perfetta in ogni particolare, e ha le dimensioni e la forma di una conchiglia che fu effettivamente trovata dallo stesso Publio. L'artigiano che la forgiò, un prete di nome Andros, era un artista. A differenza della mia spada che è disadorna, Excalibur ha una decorazione perfetta.» «Che cosa ne pensa il giovane Artù di questa spada che un giorno dovrà impugnare?» «Ne ignora l'esistenza. Non gliel'ho mai mostrata.» Sapevo di averlo sorpreso, ma nascose lo stupore. Prese la coppa e sorseggiò qualche goccia di idromele trattenendolo nella bocca mentre rifletteva intensamente. «Parlami del ragazzo» mi chiese alla fine. «Che cosa vuoi sapere?» «Tutto, ma in primo luogo sul suo diritto di essere re. Hai detto che Excalibur è la spada del re. Non di un re. Spiegamelo. Credimi: la mia non è una domanda futile.» Gli spiegai nei dettagli l'ascendenza di Artù, collegandoli con il grande sogno di mio nonno, l'ambiziosa speranza che aveva condiviso con Publio Varro e gli altri fondatori della Colonia. Germano ascoltò attentamente, senza interrompermi. Quando tacqui, si sporse in avanti. «Sicché le sue pretese, da parte di madre e di padre, investono la Cambria, l'Eire, la Cornovaglia e Camelot, cioè tutta la Britannia romana, tranne le regioni ora occupate dagli invasori. Si tratta di un territorio immenso, e la sua responsabilità sarà enorme. Dalle lettere che mi ha scritto - e dalla corrispondenza intercorsa tra noi due — so che è un ragazzo serio e impegnato, dedito ai compiti a lui assegnati, ma è ancora troppo giovane. Così giovane, anzi, che mi sento tenuto a chiederti, in confidenza, se è in grado di addossarsi un fardello di tale natura. Lo ritieni degno della fiducia che gli accordi?» «Sì» dissi annuendo. «Credo che sia capace e sia degno. Ha straordinarie qualità. La vita che conduce, il suo modo di pensare, il suo comportamento dimostrano che crede in ciò che fa. È stato molto influenzato da Ambrogio. E, come sai, Ambrogio è parco di lodi e non ostenta mai una pietosa indulgenza. Avrebbe ben potuto essere un uomo di Chiesa, un vescovo, se il destino non lo avesse portato a Camelot e a me. Enos lo giudica così.» Germano annuì. «Lo so, me l'ha detto lui stesso. Il ragazzo ha molta considerazione per Ambrogio?» «Moltissima. Ha grande rispetto anche per me, e Dio sa che io non sono né devoto né pio. I principi morali di Artù, il suo senso cristiano e il suo modo di vivere che si ispira a tali principi, si conformano più all'esempio dato da Ambrogio che ai miei insegnamenti.» Gli illustrai allora l'istruzione impartita ad Artù e la sua formazione, e da ultimo il ruolo che a Camelot aveva avuto ciascuno di noi nell'educarlo. Germano ascoltava con attenzione, sebbene fosse al corrente di quasi tutto quello che gli dicevo. Poi cominciai a parlargli della filosofia di quel ragazzo, ammesso che si possa affermare che un adolescente abbia una sua filosofia. Gli spiegai quello che Artù intendeva per giustizia e dignità umana, e gli narrai come si fosse infuriato sulla tomba di Lucano, quando lo aveva colto il dubbio che negli anni a venire avrebbe potuto essere profanata da sconosciuti e che nessuno sarebbe stato lì a parlare in difesa del nostro bravo medico o a proteggere il luogo del suo riposo. Questa volta, non appena finii di parlare, Germano si alzò in piedi. «Vieni con me» disse. «Abbiamo ancora molto da dire su questo, ed è tardi. L'aria fresca della notte ci schiarirà la mente.» Facemmo tutto il giro dell'accampamento, e nel tragitto fu lui a parlare. Era molto preoccupato dalle incursioni sempre più frequenti e massicce dei Sassoni invasori. Gli Angli si convertivano al cristianesimo in numero cospicuo ed erano per lo più uomini di buona volontà, attenti alle necessità delle loro famiglie. I Sassoni, invece, di tutt'altra pasta, avevano dichiarato guerra alla Chiesa di Dio e ai suoi missionari. Gli arrivavano, tramite i suoi vescovi, resoconti sempre più frequenti di atrocità spaventose compiute contro i chierici cristiani: decapitazioni, mutilazioni, torture crudeli che prolungavano l'agonia prima che sopraggiungesse la morte. I vescovi e i preti venivano fustigati, la pelle cadeva a brandelli fino a mostrare la carne viva. Alcuni venivano poi lasciati in quel modo, appesi per i polsi a morire tra tormenti orribili, altri venivano uccisi sulla graticola a fuoco lento. Uomini che agivano in quel modo non potevano essere figli di Dio, diceva, ma creature in preda al demonio, uscite dall'inferno, mandate da Lucifero per affliggere l'umanità. Perfino il vescovo apostata Agricola, l'uomo che lui era venuto a denunciare, lo aveva messo in guardia contro i pericoli di viaggiare sulla costa orientale della Britannia. Mentre camminavamo lungo il confine dell'accampamento, salutando le guardie nel passare, aumentavano in me la preoccupazione e l'angoscia per i tanti mali sui quali il mio amico mi aveva ragguagliato. Sapevo che la Britannia era soggetta a saccheggi, ma non avevo sospettato che fossero state così numerose le stragi compiute. Cominciavo a chiedermi se l'isolamento di Camelot dalle regioni occidentali fosse una benedizione o una maledizione. Percorremmo l'ultimo tratto del percorso in silenzio. Entrati nella sua tenda, Germano si tolse il mantello, e io mi sedetti. «Un quadro nero quello che mi hai descritto, amico mio» dissi. Strinse le labbra, fissandomi negli occhi, quindi annuì con un gesto brusco. «Sì, la situazione non promette niente di buono, ma comincio a pensare che non sia del tutto disperata. Questo giovane, Artù Pendragon, potrebbe davvero essere la salvezza di noi tutti.» Credetti in un primo momento che intendesse essere tragicamente faceto, ma poi mi resi conto che parlava sul serio. «Secondo te Artù potrebbe essere la nostra salvezza oggi? È assurdo. Non ci si può neanche prospettare una cosa del genere. È soltanto un ragazzo, ha sedici anni.» «È un re, hai detto, il re. Hai detto che potrebbe essere riothamus.» «Un giorno, forse, tra molti anni.» «No, il prossimo anno invece. Il prossimo anno avrà diciassette anni. Flavio Stilicone aveva diciassette anni quando Teodosio lo mandò come ambasciatore presso i re stranieri. A ventun anni era a capo degli eserciti dell'impero. Fu imperatore mio e di tuo padre.» «Stilicone fu il più grande genio militare dopo Alessandro... più grande di Caio Mario, più grande perfino di Giulio Cesare! E vivendo accanto al trono poteva contare su tutti gli appoggi possibili. Artù Pendragon è un ragazzo che nessuno conosce. L'anno prossimo diventerà maggiorenne, certo, e a Camelot otterrà i suoi incarichi ed eserciterà il relativo potere; assumerà le sue responsabilità, ma deve imparare a esercitarlo, il potere. Fino ad allora, nessun guerriero di valore si metterà al seguito di un adolescente. L'idea stessa è assurda.» «Davvero? Sarebbe assurda anche se io lo incoronassi e riconoscessi formalmente in lui l'uomo che veglia su Santa Madre Chiesa? Ti assicuro, amico mio, che una simile investitura avrebbe maggior peso di quella concessa da un imperatore, oggi che i grandi di Roma sono ormai sul punto di sparire dal mondo.» Mi sedetti guardandolo a bocca aperta, senza parole. Mi sorrise. «Parlo sul serio, Merlino, non a vanvera.» «Ma come... come è possibile?» «Agiremo in nome di Dio. Dio ha bisogno di un eroe, Merlino, per difendere il Suo popolo qui in Britannia, e tu, questa notte, hai identificato questo eroe in Artù Pendragon. Sarà alla testa di Camelot, come tu stesso hai prospettato, e ciò potrebbe avvenire in tempi più brevi di quanto avevi previsto. Non sollevare le obiezioni che ti vengono alla mente! Prima di respingere la mia proposta rifletti su quanto ti ho detto stanotte. La Britannia è sul punto di sprofondare nelle tenebre, pericolosamente esposta al pericolo di cadere preda di diavoli scatenati, pronti a uccidere i vescovi che diffondono la parola di Dio. Il gregge dei fedeli è al sicuro nel nord-est, dove al potere è Vortigern, nel sud-est dove governano uomini come Cuthric e nell'ovest, a Camelot. Vortigern ha qualche difficoltà con i suoi amici Danesi, ma insieme riescono a tenere a bada i Sassoni nelle terre meridionali. Mi hai detto che di recente i Danesi si sono stanziati nel Weald. Se Dio così vorrà, potranno allearsi con Cuthric per arginare le orde scatenate. A occidente, dove governa Camelot, la nostra gente e la nostra fede non sono in pericolo. E Camelot - gli eserciti di Camelot - sono invincibili. Non esiste in Britannia una forza militare pari alla loro. Chi è a capo di questi eserciti è tenuto a regnare sulla Britannia, purché sia un uomo di fede, di dignità e innata nobiltà. Artù Pendragon sarà quell'uomo. Noi lo innalzeremo, lo porremo su un trono così alto che tutta la terra di Britannia potrà vederlo; sotto la sua guida le genti si uniranno per cacciare i Sassoni e poter tornare a pregare senza paura.» Continuavo a scuotere la testa, incapace di parlare e di mettere ordine nei miei pensieri. Si allontanò da me per raggiungere l'angolo dove avevo messo la spada. Mi tornò vicino tenendola per il fodero. «Ricordi che ti ho accennato a un ordine nuovo?» «Sì, i cavalieri, un ordine di cavalleria. Ci ho riflettuto.» «Che cosa hai deciso?» «Niente.» Scossi la testa, perplesso dal fatto che avesse cambiato argomento. «Non so quali criteri fissare per accedere a tale rango. Non basta il requisito di possedere un cavallo; tutti i nostri soldati ne hanno uno.» Germano sfilò la spada dal fodero con un suono sibilante, poi ne conficcò con forza la punta nel terreno, lasciandola oscillare leggermente avanti e indietro. «Ecco l'altro requisito!» «Che cosa vuoi dire?» «Guarda! Guarda l'ombra che disegna sulla parete.» Afferrò un candelabro e lo tenne levato in modo che l'ombra della spada si stagliasse sulla tenda. «È una Croce, il simbolo della nostra fede.» «I grandi movimenti necessitano tutti di un simbolo riconoscibile per smuovere gli uomini.» «Sì. E anche gli ordini religiosi o di altra natura. Quale simbolo più adatto della Croce per una comunità cristiana? Decreteremo che i migliori uomini intorno ad Artù entreranno nel nuovo ordine dei cavalieri dopo che si saranno conquistati i meriti per averne il diritto. Vi saranno ammessi grazie all'impegno, consacrato dal giuramento, di salvaguardare Madre Chiesa e il suo gregge. I cavalieri diventeranno i difensori della fede cristiana; avranno la benedizione della Chiesa e il diritto di indossare il simbolo della Croce sull'armatura. Riesci a figurartelo?» «Sì» sussurrai, mentre il cuore mi martellava nel petto e mi tornava alla mente il sogno fatto alcune notti prima. «La Croce in rosso sul loro petto.» «In rosso? Perché no? Il simbolo del Redentore e il colore del sangue da Lui versato. Su campo bianco a indicare la purezza dell'anima e l'umiltà dello spirito.» Sembrava che parlando Germano fosse cresciuto in statura, e i suoi occhi brillavano di eccitazione ed entusiasmo. «Pensi che al nostro re piacerà questa idea?» Annuii mentre il viso mi si allargava in un sorriso. «Sì, gli piacerà. Ci crederà... Devo bere qualcosa.» Mi levai e andai a riempirmi una coppa, pronto a porgerne una anche a Germano, ma era troppo immerso nei suoi pensieri. Non appena mi fui di nuovo seduto, proseguì sussurrando quasi tra sé e sé. «Un'incoronazione, dobbiamo celebrare la cerimonia dell'incoronazione.» Tacque di nuovo, ma pochi istanti dopo, prese a misurare a grandi passi la tenda avanti e indietro al chiarore guizzante delle candele. «Sarebbe perfetto, Merlino, pensaci. Un'incoronazione come nei giorni dell'antica Roma, quando ai più grandi eroi veniva posta sul capo una corona che li distingueva da tutti gli altri guerrieri. Artù sarà il nostro eroe, il difensore della Chiesa e della fede cristiana. I suoi uomini - i cavalieri - saranno combattenti di Dio, chiamati a proteggere il Suo popolo. La cerimonia dovrà essere celebrata davanti a tutti e solennemente annunciata, officiata in qualche luogo di grande significato... a Verulamium, nel grande teatro che lì sorge. Settemila posti a sedere. Immagina la scena, Merlino. Vi converranno tutti i vescovi della Britannia per celebrare insieme una grande messa trionfale. Artù entrerà scortato dai suoi cavalieri; in città l'esercito garantirà che la cerimonia si svolga pacificamente. Dopo la consacrazione, prima che la comunità si disperda, io stesso, o qualche altro vescovo, porrà sulla testa di Artù una corona d'oro e lo proclamerà re in nome della Chiesa. Pensa alla suggestione della scena! Nessuno metterà in dubbio il suo diritto al trono.» «Potrebbe farlo Vortigern, tanto per citarne uno» borbottai. Germano mi scoccò un'occhiata di sdegno. «Vortigern non possiede un corpo di cavalieri, e neppure spade lunghe come questa. Non si può inoltre dire che abbia peccato di eccessivo zelo nei nostri confronti. Da lui protetti, Agricola e i suoi seguaci proliferano. Sono sicuro che Vortigern si piegherà al volere del papa, se ha a cuore la salvezza della sua anima immortale.» «Il volere del papa?» dissi, sentendomi invadere da un'ondata di sollievo. «Lo sai, amico mio? Avresti dovuto fare l'impresario teatrale. Avresti senz'altro dato un grande contributo al mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.» Non reagì alla mia battuta; parlò invece in tono grave. «Scherzi, ma non dovresti farlo. Le apparenze, il fasto e la pompa contano molto in certe circostanze. Per creare la suggestione di un momento speciale - mi propongo di suscitare forti emozioni e impressioni — bisogna renderlo memorabile. Le cerimonie spettacolari scuotono gli animi e li inducono alla venerazione e al rispetto, danno origine alla memoria storica. Ricorreremo ai colori, alla musica, alla spettacolarità, a un cerimoniale solenne. Non dimenticare Roma e le persecuzioni contro i cristiani. A migliaia morirono nelle circostanze più varie, ma si ricordano soprattutto quelli che furono uccisi nell'arena, sbranati dai leoni e dalle tigri, schiacciati dagli elefanti infuriati, mentre la plebe esultava. Noi faremo dell'incoronazione del nostro re uno spettacolo grandioso. Tutti ne parleranno e lo rammenteranno per sempre. Tieni conto delle mie parole.» Prese lo stampo di argilla che racchiudeva la mela d'oro, rimasto sul tavolo. «Posso tenerlo per un attimo? Te lo restituirò subito.» Annuii. «Quando mostrerai Excalibur ad Artù?» «Non lo so» risposi stringendomi nelle spalle e scuotendo la testa. «Quando sarà pronto, immagino.» «E come farai a capire che è pronto?» Aggrottai la fronte. «Non lo so, ma sono sicuro che tu lo sai. Ho ragione?» «Forse.» Aprì lo stampo, tolse la mela e subito la ripose di nuovo. «C'è solo un modo per rimettere questa mela nel suo involucro di argilla...» Rimasi in silenzio ad ascoltarlo. «...Ho un'idea, ancora allo stato larvale e incompleta, ma buona, credo. Per attuarla è necessario che il ragazzo continui a ignorare l'esistenza di Excalibur fino alla sua incoronazione. È possibile?» «Certamente, ma perché dobbiamo tenerlo all'oscuro?» «Perché lui, come tutti gli altri, deve rimanere abbagliato alla sua vista, quando verrà mostrata al mondo. Nel momento in cui presenteremo un'arma che sembra il frutto di un miracolo, è bene che tutti - dico tutti — la vedano come un miracolo e la vivano in tale modo.» Scossi la testa, sentendomi all'improvviso stanco. «Non ti seguo. Un miracolo, dici? So che sei un uomo di Dio, vescovo, e che hai una grande mente, ma come intendi organizzare un miracolo?» Me lo spiegò, e per quella notte mi fu impossibile prendere sonno. XV. Mi è quasi impossibile descrivere il periodo che seguì quella discussione. Ho accennato al fatto che ebbi due conversazioni importanti nel corso di un'unica settimana, e a profusione ho scritto della prima, riportando con precisione e chiarezza ogni parola di Germano, ogni sua inflessione di voce. Ma sono ossessionato dalla memoria, crudele e amara, dei giorni che seguirono; sono immagini frammentarie, grevi di terrore e sofferenza, di disperazione e incredulità, immagini che non si allontanano mai e sfidano ogni capacità di descrizione. Il mio vecchio amico Dedalo, che aveva buone conoscenze di ingegneria, mi rivelò una volta una verità fondamentale, nota a suo avviso a ogni tecnico par suo. L'occasione fu, mi pare, una discussione su come i genieri dell'esercito avevano prosciugato il lago nel quale Publio Varro sperava di trovare la Pietra del Cielo. Il lago, che si trovava all'estremità di una valletta, si era formato a causa di una specie di diga di rocce cadute dalla montagna per un cataclisma; i genieri avevano esaminato il tratto di parete rocciosa che emergeva sopra il livello dell'acqua, quindi scavando alla base, l'avevano frantumata quasi fosse stata una ciotola di coccio. Partendo dal paragone con la chiave di volta dell'arcata dei ponti, Ded mi aveva spiegato che in ogni costruzione - fosse opera della natura o dell'uomo - esiste un punto fondamentale e centrale dal quale si irradiano, e sul quale convergono, tutte le linee di forza. Distruggendo quel punto - trave, roccia, tronco - o spostandolo, l'intera struttura crolla rovinosamente. La costruzione che era per me ragione di vita si schiantò dopo la seconda conversazione, sfasciandosi sul terreno duro della realtà, e la forza distruttiva che la travolse fu una voce umana che parlava una lingua sconosciuta. Per dirla in breve, il giorno successivo alla conversazione con Germano, ci capitò di imbatterci in un cospicuo contingente di stranieri. Fu Benedetto a portarci la nuova del loro arrivo. Era andato con un esiguo numero di uomini in perlustrazione sul fianco destro della nostra formazione, e uno dei suoi esploratori, oltrepassando i confini a lui assegnati, aveva visto il nemico che si avvicinava. Se avesse obbedito agli ordini impartitigli e si fosse rigorosamente mantenuto entro i limiti fissati dal suo dovere, non li avrebbe avvistati. Ma in questo caso si affrettò a fare rapporto a Benedetto. Da un avamposto nascosto, a due miglia da noi, Benedetto vide e contò più di mille uomini, a piedi, che avanzavano ripartiti in cinque divisioni, ciascuna composta di forse duecento uomini. Erano emersi dalla foresta a est e, attraversato il fondovalle, puntavano diritti verso il nostro accampamento, muovendosi con marcia costante e in formazione disciplinata. Benedetto non attese di vedere altro, convinto che conoscessero la nostra postazione e si dirigessero alla nostra volta. Si ritirò con i suoi uomini e a tutta velocità venne a comunicarci quanto aveva visto. Tra il nemico e noi si stendevano due ampie valli. Le pendici di quella più lontana erano coperte da fitti boschi; i fianchi della seconda, sul crinale della quale eravamo accampati noi, erano erbosi e non vi crescevano alberi. Impartii rapidamente le disposizioni del caso, con mente lucida e logica. Per disporre di un contingente di mille uomini ovviamente il nemico si era organizzato da tempo; probabilmente aveva avuto l'intenzione di intercettare il passaggio di Germano e del suo seguito, e forse non ignorava la nostra presenza. Nella mia mente si delineò con precisione un piano, ispirato al ricordo dei commenti espressi da mio nonno sulla tattica di Alessandro il Macedone. Ordinai subito a cento dei miei uomini di lasciare i cavalli e mostrarsi come un corpo di fanteria, e agli altri di portarsi sull'altro lato della collina in modo da essere fuori vista. Diedi quindi rapidi ragguagli a Germano su come procedere. Il piano era che lui scendesse a valle alla testa di un piccolo gruppo di cavalieri e, seguito da tre carri con altri venti miei uomini in abiti clericali, si avviasse incontro al nemico. Quando si fossero trovati faccia a faccia, i miei cento si sarebbero schierati in formazione difensiva e avrebbero aspettato le mosse degli avversari. I carri e i loro occupanti si sarebbero dati alla fuga, i miei "chierici" sarebbero saltati giù dai lenti veicoli, abbandonandoli e allontanandosi dai fanti, nel tentativo di fornire un'esca al nemico e di incitarne l'attacco. Poi, al primo segno di un'avanzata, i miei cento, fingendo la ritirata, sarebbero saliti sul pendio della collina mantenendo lo schieramento, riservandosi di sparpagliarsi e fuggire solo quando gli attaccanti si fossero impegnati a caricare sul fondo della valle e sul pendio dell'antistante collina. A quel punto, con il nemico impegnato a combattere in salita, avrei dato via libera alla cavalleria di scorazzare sui due fianchi. Germano ascoltò questo piano strategico e poi con un sorriso mi chiese se i suoi uomini dovessero gridare: «Alleluia!». Gli restituii il sorriso e con i miei cavalieri mi ritirai oltre il cucuzzolo della collina, e qui diedi le ultime disposizioni sullo schieramento e assegnai una scorta a Tressa e Shelagh. Non volevo che assistessero all'imminente scontro e con mia gradita sorpresa acconsentirono senza protestare. La scaramuccia fu di breve durata, e non varrebbe neppure la pena di accennarne se non avesse provocato una carneficina. Il nemico combatté con coraggio e mostrò maggiore disciplina di quella che avevo notato nei reparti avversari in Cambria; i soldati mantennero ciascuno la propria posizione e arrivarono perfino a costruire con gli scudi un muro difensivo per parare l'attacco. Ma l'impatto e il numero dei nostri cavalli travolsero ogni resistenza, e il muro di scudi cedette e si disintegrò. Da quel momento in poi la sconfitta era segnata, e pochi furono i sopravvissuti. Aggirandomi tra le pile dei morti e dei feriti, notai che, come aveva detto giustamente Dedalo, erano male armati. Pochi disponevano di una spada; l'arma più diffusa era l'ascia; alcuni avevano pesanti lance; un buon numero poteva fare affidamento soltanto su pesanti bastoni e pugnali, avevano rozze stanghe di legno appena sagomate. Molti sarebbero forse sopravvissuti se fossero stati soccorsi, ma non stava a me provvedervi. Non avevo né il tempo né la voglia di prendermi cura di sconosciuti. Germano tuttavia si rifiutò di abbandonarli alla morte e incaricò i suoi vescovi di andare tra i feriti a porgere aiuto. Anche alcuni miei soldati, in particolare i medici, cominciarono a offrire assistenza. Passammo quindi il resto di quella giornata infruttuosa a occuparci dei nemici e a improvvisare un accampamento sulla collina. Due giorni dopo, vicino a Londinium, che secondo Enos era ormai abbandonata da circa dieci anni, e a meno di due giorni di viaggio dalla nostra destinazione di Verulamium, intorno ai fuochi si parlava ancora della carica di cavalleria e di come avevamo battuto il nemico, che qualcuno aveva identificato come gli luti. Ero di cattivo umore e irritato, perché avevo dormito male le due notti precedenti, disturbato da sogni terrificanti che interrompevano il sonno e mi lasciavano madido di sudore e rantolante di orrore. L'incapacità di ricordare quello che mi aveva svegliato lasciandomi in preda a una profonda paura mi mandava su tutte le furie e mi spaventava. Da tutta la vita temevo i sogni che non riuscivo a ricordare da sveglio, ma avevo sperato che fosse una fase superata della mia esistenza. La frustrazione provocata dai miei terrori notturni suscitò in me un'irritazione così acuta che, al sentire quei discorsi di vittoria, sbottai dicendo che per nostra fortuna i nemici erano stati i rozzi luti, non i temibili Danesi di Horsa. Avevamo finito di mangiare ed eravamo raccolti intorno al fuoco. Sedevo tra Germano e Tressa sulla sinistra; Cuthric, a destra del vescovo, aveva vicino a sé sull'altro lato Cayena. Venivano poi Dedalo e Benedetto, e altri ancora che non ricordo, perché le fiamme ruggivano vigorose e nascondevano chi stava di fronte. Notai che alle mie parole Cuthric sollevava le sopracciglia e poi si chinava verso Germano per dirgli qualcosa. Questi gli rispose, rimase di nuovo ad ascoltare, si strinse nelle spalle e si rivolse a me. «Cuthric ti ha sentito parlare di Horsa e dei suoi Danesi. Si chiedeva come sei venuto a sapere della loro esistenza.» «So poco di lui e dei suoi uomini. So che esistono, e questo mi basta. Ho cominciato a respirare liberamente soltanto quando sono stato certo che ci eravamo lasciati quelle orde alle spalle. Nei primi giorni, soprattutto mentre ci dirigevamo a est, ho temuto di sconfinare nei loro territori e di incontrarli da un momento all'altro. Ci sono donne al nostro seguito e l'idea di uno scontro non mi andava a genio.» Germano tradusse queste parole a Cuthric che, sorpreso, borbottò qualcosa guardandomi negli occhi. Attesi che Germano mi traducesse le sue osservazioni. «È sorpreso che tu sappia della presenza dei Danesi nel Weald, perché non sono più lì e le tue preoccupazioni erano infondate. Vi sono rimasti per qualche tempo, insediandosi in diversi forti romani lungo la costa, mentre esploravano l'entroterra alla ricerca di ricchezze di cui impossessarsi. Ma poi se ne sono andati tutti circa un mese fa, imbarcandosi su molte navi, una flotta intera.» «Cosa? Sono tornati verso nord?» chiesi incredulo. Germano rivolse qualche domanda a Cuthric, ma questa volta notai che alla risposta, il suo viso sbiancava e la persona gli si irrigidiva. «Santo Dio!» esclamò rivolgendosi a me con voce spenta dallo sgomento. «Vengo a sapere che Vortigern è morto.» Si girò verso Cuthric. La conversazione tra loro era tesa e rapida. Fremevo dall'impazienza di sapere che cosa si dicessero, e alla fine il vescovo mi confermò scoraggiato. «È vero. Vortigern è morto, ucciso in battaglia dallo stesso Horsa. Lo riferì a Cuthric uno dei suoi consiglieri anziani, la cui figlia si era innamorata di un danese che si vantò con lei di avere tranciato la mano di Vortigern che aveva osato minacciare il suo re. Cuthric non sa chi sia, o sia stato, Vortigern; per lui è un re senza volto che governava le lontane terre settentrionali. Che la sua anima riposi in pace.» «Amen» sussurrai. «Quando ero ancora un ragazzo, mio padre diceva che si sarebbe arrivati a questo. Sapeva che niente, se non il danno, sarebbe derivato dal lasciare entrare stranieri sulla nostra terra.» Emisi un sospiro. «Vortigern è morto e Horsa è ritornato a nord. Sarà diventato il re della Northumbria, immagino.» «Un re danese in Britannia? Spero di no.» «Com'è che Cuthric è così bene informato su Horsa?» Il vescovo si strinse nelle spalle. «Ha con te un interesse in comune, credo. Horsa e i suoi Danesi rappresentano una minaccia per gli Angli insediati nella regione vicina a quella da loro oggi occupata.» Esitò. «Non so però fino a che punto sia al corrente di come stanno le cose. Dice che gli stendardi portati dai guerrieri danesi erano così numerosi da oscurare il cielo.» «Sei preoccupato?» chiesi aggrottando la fronte. «C'è qualcosa che non mi convince e che mi suona falso. I Sassoni non usano stendardi, neppure gli Angli e gli luti. Nessuna di queste popolazioni.» «Horsa è danese, non sassone, e da tutta la vita tiene d'occhio Vortigern. E lui di stendardi ne usava in gran quantità. Il suo vessillo era la testa di un lupo. Mi sembra incredibile che sia morto. Vortigern, comunque, amava esibire per scopi spettacolari le sue insegne. È quindi possibile che Horsa abbia tratto esempio da lui. Domanda a Cuthric di descriverci il vessillo di Horsa.» «Dice che è un orso» mi comunicò il vescovo dopo qualche istante. «Non del tutto dissimile dal tuo, salvo nel colore; il suo è nero, il tuo è argenteo. Tutte le sue navi hanno come vessillo un orso nero, ma variano l'uno dall'altro nei dettagli.» Si girò di nuovo per parlare a Cuthric mentre io guardavo le espressioni sulle facce di quanti, seduti intorno al fuoco, avevano saputo della morte di Vortigern. Ero intento a parlare con Tressa quando sentii sul mio braccio la mano del vescovo. Era ancora immerso nella conversazione con Cuthric, ma sapevo che intendeva chiedermi qualcosa. Si volse verso di me con occhi turbati. «Horsa è ritornato nel Weald circa un mese fa, come ci ha appena detto Cuthric, ha radunato i suoi soldati - ci ha messo una settimana a raccoglierli tutti - poi ha ripreso il mare. Ma soltanto un terzo dei suoi uomini si è imbarcato sulle navi dirette a nord; la maggior parte è salita su quelle dirette a sud, sotto la guida di un ufficiale anziano.» Fui percorso da un brivido premonitore. «A sud? Non c'è niente a sud tranne il Mare Stretto. Credi possibile che abbiano puntato verso la Gallia, senza Horsa?» «Ne dubito.» Di nuovo si volse a Cuthric, e mi chinai verso di loro per ascoltare il loro mormorio straniero che suonava gutturale e aspro alle mie orecchie. Mi parve che questa volta confabulassero per ore intere, ma in quel sussurro indistinto in una lingua sconosciuta colsi all'improvviso una parola tristemente distinguibile: Ironhair. Quando Germano tornò a prestarmi attenzione, già mi ero levato in piedi, con il sangue che mi ruggiva nelle orecchie e il corpo che si contraeva per il terribile sospetto che mi aveva invaso. Ironhair! Nome maledetto! Ironhair, l'uomo che radunava pirati, alleati, mercenari. Non lo avevamo trovato in Cambria quando eravamo andati sulle sue tracce. Nessuno allora sapeva dove fosse, e nel frattempo le sue truppe si erano messe a setacciare Dolocauthi e le sue miniere d'oro! Mi maledissi perché in quel momento capii che avrei dovuto saperlo da tempo, dal momento in cui lo stesso Ironhair me l'aveva comunicato tramite il suo ambasciatore, Retorix. Questi infatti mi aveva consigliato di concludere la pace per aiutare il mio alleato Vortigern ad affrontare i Sassoni nel lontano nord-est. Conosceva i Danesi di Horsa, me l'aveva detto lui stesso. Quanto ero stato stolto! Avrei dovuto immediatamente intuire come funzionava la mente contorta di Ironhair! Se, a un grido di Tressa, Donuil non fosse balzato in piedi e mi avesse afferrato stringendomi contro il suo petto, sarei caduto in mezzo alle fiamme. Scorsi alle sue spalle Filippo e Benedetto, attoniti, ancora all'oscuro delle nuove che mi erano state comunicate. Neppure io sapevo ogni cosa, ma mi era bastato sentire il nome di Ironhair. Tirando un profondo respiro, cercai di riprendere il controllo di me stesso. Donuil, sul cui viso leggevo l'ansia e la preoccupazione, mi sorresse per il braccio finché non fui seduto. Benedetto e Filippo si erano avvicinati, Dedalo mi stava sulla sinistra, il pugno stretto intorno al manico del pugnale. Mi volsi di nuovo verso Germano, che pareva visibilmente invecchiato in quel breve intervallo, con profonde rughe che gli solcavano il viso. «Che cosa ha detto?» chiesi. Prima di poter rispondere dovette umettarsi le labbra e inghiottire un paio di volte. «Temo di avere rovinato la tua opera chiedendoti di raggiungermi qui, amico mio...» «Sei un vescovo, non un veggente» borbottai interrompendo le sue scuse in modo brusco. «Quello che è accaduto non è per colpa tua. Riferiscimi quanto ti ha detto Cuthric.» Si erano nel frattempo messi ad ascoltare tutti; giungeva soltanto il ruggito delle fiamme del braciere. Schiarendosi la gola, Germano proseguì. «La prima ondata di Danesi si riversò nel Weald l'autunno scorso e trascorse l'inverno nelle fortezze che sorgono lungo la costa. Poi, meno di un mese fa, Horsa ritornò al comando di una flotta più ingente e li incitò a seguirlo. Aveva stretto alleanza, spiegò, con un re dell'estremità occidentale della Britannia, un uomo di nome Ironhair, che chiedeva aiuto per pacificare i suoi domini. In cambio, era disposto a concedere vaste terre del suo regno, a nord e a ovest, che avrebbero consentito ai Danesi di accedere alle miniere d'oro di Dolocauthi in Cambria, oltre che di impossessarsi delle ricchezze che avrebbero tolto al nemico col saccheggio. Ironhair, che era presente sulla nave di Horsa, confermò la promessa. I Danesi partirono nel giro di una settimana.» «Era ingente la flotta di Horsa?» Germano tradusse la mia domanda a Cuthric, che ascoltò attentamente e rispose annuendo. Germano accennò di sì con la testa. «Non lo sa con certezza, ma gli hanno riferito che le navi erano più di duecento.» «Duecento! Dio lo mandi all'inferno! Ha l'ambizione di diventare re. Le terre a nord-ovest della Cornovaglia sono nostre. Intende depredare Camelot e la Cambria. Voglio tornare, stanotte stessa.» Mi dissuasero in fretta dal commettere quella sciocchezza. Secondo Germano, i nostri uomini avrebbero dovuto mettersi in marcia alle prime luci dell'alba, ma io respinsi quel progetto. Il grosso del nostro contingente si sarebbe mosso con troppa lentezza, legati come erano a procedere a fianco dei carri. Sarei invece rientrato alla testa di un esiguo manipolo, in grado di muoversi con la massima rapidità e abbastanza cospicuo da scoraggiare ogni aggressione. Il corpo principale della spedizione ci avrebbe seguiti. Ci fu qualche discussione su chi dovesse accompagnarmi e chi dovesse rimanere, ma in quel momento di estremo pericolo tagliai la testa al toro scegliendo io stesso gli uomini. Donuil, Tressa e Shelagh sarebbero venuti con me; lo stesso avrebbero fatto Ded, Benedetto e Bedwyr, con una ventina di soldati, tra i migliori, scelti da Dedalo. Filippo, Falvo e Rufio sarebbero rimasti al comando del resto del corpo di spedizione con la consegna di riportare circa mille persone a Camelot il più rapidamente possibile. Germano e il suo seguito, ormai abbastanza vicini a Verulamium, ci sarebbero arrivati per proprio conto, potendo ormai contare su un tragitto scevro da pericoli. Soltanto venti miglia li separava dalla loro destinazione, e avevano a loro vantaggio un nutrito numero di Angli bene armati che da tutte le parti erano convenuti ad accoglierli. Non avevamo avuto sentore di irrequietudini locali - le truppe incontrate quella mattina erano composte da soldati venuti da lontano - e condividevo con Germano la fiducia che tutto si sarebbe svolto senza inconvenienti. Mi accomiatai a quel punto e andai a letto, deciso se non proprio a dormire, almeno a cercare un po' di riposo per le ossa doloranti e tacitare le paure. Malgrado i presentimenti infausti e l'animo in subbuglio, il mio fu un sonno pesante, e mi svegliai con un grido quando Dedalo, entrato nella mia tenda nelle tenebre antecedenti l'alba, mi riscosse scuotendomi per la spalla. Aveva passato la notte preparando le razioni di cibo da portare nella marcia - in numero sufficiente da durare per dieci giorni almeno, nel caso non fossimo riusciti a procurarci da mangiare in altro modo - e scegliendo i cavalli che sarebbero stati sellati. Ciascuno di noi poteva contare su una cavalcatura di riserva. I venti soldati che sarebbero venuti con noi aspettavano il segnale della partenza nell'oscurità, di tanto in tanto illuminati dalle fiamme dei fuochi. Ero armato di tutto punto e dalla mia sella pendeva il lungo arco di Varro. Germano, venuto ad accomiatarsi, mi abbracciò in silenzio e, stringendomi le spalle, mi guardò negli occhi. «Va' con Dio, amico mio» disse. «Spero che nel tuo cuore non nutrirai rancore verso di me per averti fatto allontanare da Camelot in un momento difficile. Pregherò Dio con tutta la forza della mia anima perché il ritorno sia tempestivo e sicuro. Che i suoi angeli veglino su di voi durante il viaggio. Non appena sarai rientrato e avrai sventato la minaccia che ora insidia la tua patria, ricordati di quello che abbiamo discusso. Enos, che rimarrà in costante contatto con te, ci terrà reciprocamente informati per non perdere tempo inutilmente. Prego che ci si possa incontrare l'anno prossimo in occasione della Pasqua per celebrare i nostri re, quello celeste e quello terreno. Addio, e che il viaggio sia tranquillo.» Sospirai e, prima di accomiatarmi, gli strinsi le braccia sopra il gomito. «Prega intensamente, amico mio, perché temo che abbiamo bisogno di preghiere. Artù è in Cambria, da solo con Llewellyn, nessuno conosce la sua identità... forse è al sicuro. Se usciremo vivi da questa situazione, lo vedremo incoronato così come auspichi tu; la Britannia cristiana avrà un re cristiano.» Si volse, baciò Tressa e Shelagh sulle guance, poi, impartita la benedizione, si ritrasse. Quando fui in sella al mio cavallo mi guardai intorno: una folla dei nostri uomini si erano raccolti per vederci partire. Stavano in silenzio, ancora avvolti dall'oscurità, neri nelle tenebre della notte. Vidi Filippo e accanto a lui Falvo e Rufio, e li salutai portando la mano all'elmo. Si misero tutti e tre sull'attenti, e mentre la folla circostante faceva lo stesso, mi giunse il clangore delle corazze. Feci un cenno con la testa, girai il cavallo e mi allontanai verso la strada che conduceva a Camelot. Malgrado le preghiere del vescovo perché ci fosse concesso un viaggio facile, fu subito chiaro che Dio e i Suoi angeli celesti avevano altro cui pensare. Fin dall'inizio la nostra marcia fu un incubo. Un territorio sconosciuto, che si estendeva per oltre cento miglia, ci divideva dalla meta, e i pericoli ci insidiavano a ogni passo. Le esigenze contraddittorie imposte dalle circostanze erano motivo di rabbia e frustrazione. L'imperativo prioritario era di procedere con la massima velocità possibile, ma paradossalmente proprio tale necessità ci imponeva di rallentare il passo. «Festina lente», «affrettati lentamente», era l'antico monito dei Romani, e fummo costretti a riconoscere la verità di quel principio. Non era possibile affondare gli speroni nei fianchi dei cavalli e lanciarli in una corsa ventre a terra; dovevamo preoccuparci che non esaurissero le forze e mantenessero il fiato, se non volevamo correre il rischio di ucciderli per strada e rimanere appiedati. Così, pur insofferenti della disciplina imposta dalla marcia, ci adeguammo, cambiando andatura ogni quarto d'ora, dal passo al trotto al piccolo galoppo, e viceversa. Raramente ci riposavamo durante il giorno, e al crepuscolo, quando sostavamo presso un torrente per toglierci in fretta di dosso la polvere del viaggio, l'abbraccio gelido dell'acqua ci riportava alla realtà. Ben presto la sporcizia fu tale che puzzavamo di sudore, umano ed equino; ma ancora più di noi soffrivano le due donne, entrambe in quei giorni nel loro periodo mestruale, e certamente il disagio era per Tressa e Shelagh ai limiti della sopportazione. Viaggiavamo fino a tarda notte: nei primi tre giorni la fortuna ci assistette regalandoci cieli sereni e la luna piena. Soltanto quando la luna tramontava e l'oscurità si infittiva ostacolando la marcia, scendevamo di sella e ci coricavamo per qualche ora sul nudo terreno, avvolti nelle coperte. Per due volte, nei primi due giorni, ci imbattemmo in gruppi di banditi; per fortuna riuscimmo a scorgerli prima che loro si accorgessero di noi. Ma la consapevolezza che tali masnade si aggiravano nei dintorni fu motivo di grave inquietudine, e alla fine del quarto giorno, in un paesaggio di dolci colline a perdita d'occhio, a tre giorni buoni da Camelot, eravamo esausti. Mi resi conto che proseguire a quel ritmo era una follia. "Festina lente", mi dissi. Trovato un fitto boschetto di alberi bassi, decidemmo di accamparci per quella notte, piantando le tende e organizzando turni di guardia di due ore, e sebbene non osassimo accendere un fuoco, almeno riuscimmo a dormire profondamente per la prima volta da quando eravamo partiti. A un certo punto, nel cuore di quella notte, mi svegliai al picchiettio della pioggia sulla tenda; ben presto lo scroscio si trasformò in un acquazzone che pareva intenzionato a durare a lungo. Quando smontammo l'accampamento, ci sembrò che l'intero mondo fosse stato inondato e mentre arrotolavamo le tende non facevamo che maledire il terreno viscido e scivoloso. Proseguimmo il viaggio con l'animo oppresso, mangiammo le nostre razioni di cereali arrostiti e noci stando in sella, tutti desiderosi di avere mantelli più pesanti, più caldi e più impermeabili. Nel primo pomeriggio uno dei cavalli scivolò nel fango e si ruppe una delle zampe anteriori. Il cavaliere per fortuna non riportò danni, ma per la paura che qualcuno sentisse i lamenti strazianti dell'animale fummo costretti ad abbatterlo immediatamente. Il soldato montò sul cavallo di riserva e distribuì tra gli altri parte del carico che portava. Davanti a noi si stendeva una zona di fitti boschi e basse colline; di tanto in tanto una parete di roccia nuda spuntava sopra le cime degli alberi. Avevo il viso gelato dalla pioggia che scendeva a rivoli dall'elmo, e per contrasto mi venne in mente il precedente viaggio, quando eravamo partiti da Camelot. Allora ci eravamo mossi lentamente e intorno a noi l'aria era piena dei cigolii dei carri e delle ruote, di voci liete e risa, degli schiocchi delle bardature dei cavalli, dei sordi tonfi dei loro zoccoli. Adesso invece procedevamo con cupi presentimenti nell'animo, in silenzio, ciascuno facendosi forza per non lasciarsi sopraffare dalla paura, e il mondo intorno rimbombava del fragore della corsa e del sibilo costante della pioggia. All'inizio alcuni, Tress e altri, cercarono di parlarmi sperando di darmi una qualche consolazione e alleggerire il fardello dei pensieri tormentosi che mi assillavano, ma poi abbandonarono ogni tentativo di distrarmi e proseguimmo in un silenzio cupo e triste. Verso la metà del pomeriggio la pioggia cessò, le nuvole si aprirono, e il sole fece capolino con fasci di luce che per un po' ci rallegrarono. Soltanto per un po', tuttavia, perché ben presto il cielo tornò a coprirsi di nubi temporalesche che lo solcavano rapide, cambiando forma, sotto la spinta dei forti venti. La luce assunse una minacciosa sfumatura giallastra, e in lontananza il tuono rombò con cattivo auspicio. Fu poco dopo che scorsi numerosi cavalieri sui crinali delle colline alla nostra destra. Una visione repentina e fuggevole, perché, immerso com'ero nei miei pensieri, avevo prestato poca attenzione a quanto mi circondava e avevo osservato invece i nembi che rapidi correvano in cielo. In un primo momento mi illusi che fosse qualcuno dei nostri, perché non ci eravamo imbattuti in altri uomini a cavallo da quando eravamo partiti da Camelot, ma mi bastò dare una rapida occhiata intorno per verificare che nessuno del gruppo si era allontanato. Spinto dalla sensazione di un pericolo imminente, chiamai Dedalo, ma nel punto da me indicato ormai non si vedeva anima viva, e mi parve che Dedalo fosse scettico. Arrabbiato perché si dubitava di me, e lo stesso dubitando di avere davvero visto quegli uomini, spronai il cavallo e mi diressi verso le colline dove mi era parso di scorgerli. Uno scalpitio di zoccoli dietro a me mi disse che Dedalo mi aveva seguito. Non c'era dubbio: sul terreno si vedevano le tracce lasciate dalle bestie. Dedalo imprecò, e insieme tornammo al nostro gruppo. Ci proponemmo di rafforzare la vigilanza e proseguimmo in una formazione a cuneo, serrata e compatta, utile sia per l'attacco sia per la difesa. Non avevamo idea di chi potessero essere quegli uomini, ma ci preoccupava che fossero a cavallo. Procedevo con Dedalo sulla mia sinistra e Tressa sulla destra; mi tolsi il pesante mantello e, dopo averlo arrotolato, lo fissai sulla sella insieme alle coperte nelle quali mi avvolgevo per dormire, sguainai la spada e, per averla a portata di mano, la sistemai infilandone la punta nella staffa destra. Procedevamo sul fondo di un avvallamento poco profondo dirigendoci verso la cresta a circa mezzo miglio di distanza, ma quando arrivammo a cento passi da quel punto, l'improvviso urlo di un soldato ci portò a guardare il pendio boscoso sulla destra e lì vedemmo uno sciame di uomini che si avventavano contro di noi. Un secondo urlo di avvertimento proveniente da sinistra lanciava lo stesso messaggio: eravamo attaccati su due fronti. Mi levai sulle staffe, roteando la spada sulla testa, e condussi la carica puntando verso la cresta dell'avvallamento, l'unica via d'uscita. Eravamo intrappolati in un imbuto. Imprecai contro me stesso per non essermi cautelato mandando alcuni uomini in perlustrazione. Il terreno cambiava bruscamente subito oltre il crinale. Arrivati in cima, scoprimmo che l'altro versante scendeva scosceso e ripido tra alte sponde di sempreverdi. Lo stretto sentiero che avevamo seguito era bloccato, poco sotto, da uno spuntone di roccia intorno al quale si erano assiepati diversi uomini che, armati di rami appuntiti, si apprestavano ad attaccarci. Colsi con una sola occhiata la trappola nella quale ci eravamo cacciati, e dello stesso trabocchetto si avvide Dedalo, che già si girava verso di me, facendomi con la mano cenno di buttarmi sulla sua destra, mentre, spronando il cavallo, si lanciava a sinistra. Ci separammo. Vidi che Tressa aveva capito la manovra e virava verso l'esterno, sulla mia destra. Dietro a noi gli altri seguivano al galoppo, volgendo le cavalcature a destra o a sinistra, a seconda della loro posizione nella formazione a cuneo prestabilita, ed evitando comunque di andare diritti incontro a una morte certa. Non appena mi trovai tra gli alti alberi che crescevano fitti, concentrai ogni sforzo per tenermi in sella cercando di non andare a sbattere contro un ostacolo, uccidendo me e il cavallo. Nell'arco di pochi minuti fummo ridotti quasi all'immobilità, visto che era impossibile muoverci speditamente in quella densa boscaglia. Il terreno era scosceso e ricoperto di alberi morti e sterpaglia. Erano ostacoli di piccole dimensioni, ma in grado di trafiggere il ventre delle nostre bestie. Sentivo dietro a me le imprecazioni degli uomini quando inciampavano in qualche intoppo, e di tanto in tanto il fragore del ferro, ma non avevo né il tempo né l'occasione di guardarmi indietro. Tressa, davanti a me, era sana e salva. Non appena gli alberi si diradarono, accelerai l'andatura e a buona velocità ci trovammo fuori del bosco su quella specie di corridoio senza alberi che avevamo seguito fino al crinale. Voltai il cavallo e vidi che il sentiero sovrastante era pieno di uomini che di gran carriera muovevano nella mia direzione. Dal bosco cominciò a emergere anche il mio gruppo, ma il nemico si avvicinava in fretta. Non mi parve opportuno imboccare il ripido sentiero per raggiungere il mio seguito, e decisi di affrontare il nemico dal punto in cui mi trovavo. La lunga spada mi sembrava leggera e la usai con grande efficacia uccidendo i primi tre che si trovarono a portata della lama prima che avessero la possibilità di attaccarmi con le loro armi. Il quarto mi si gettò contro con una lancia lunga e pesante, ma la tagliai di netto quasi fosse stata un ramoscello cavo e con il successivo fendente, vibrato di rovescio, lo colsi sulla fronte. Una freccia venne a frantumarsi contro la mia corazza facendomi perdere l'equilibrio, e in quell'attimo qualcuno mi tirò la gamba per buttarmi a terra. Con la sinistra afferrai il pomolo della sella e menai la spada, ma l'assalitore aveva già abbandonato la presa e, barcollando all'indietro, cercava disperatamente di afferrare tra le scapole la lancia con cui Tressa lo aveva trafitto. Gli cadde vicino un altro, anche lui trafitto da una lancia, un terzo gli piombò addosso mentre il sangue gli sgorgava dalla bocca. Sentii una mano che tirava le mie redini e la voce di Ded che mi urlava di indietreggiare. Girai il cavallo, e pochi istanti più tardi, eravamo di nuovo sul sentiero che scendeva, cercando di non scivolare sul terreno vischioso. Eravamo quasi in prossimità del fondo, e ben presto il terreno divenne pianeggiante. Mi girai per contare quanti erano gli uomini del nostro gruppo, e fui sorpreso di constatare che quasi tutti erano sopravvissuti all'agguato. Shelagh cavalcava vicino a me, Donuil le stava al fianco; Benedetto perdeva sangue da un taglio superficiale al naso, ma per il resto sembrava in forze. Gli aggressori erano rimasti indietro, distanziati dal passo veloce dei nostri cavalli. Persi il conto dei nostri uomini, una ventina circa, ma mi sentivo il cuore leggero. Avevamo rischiato di perderne una buona metà. Sentii qualcuno che chiedeva quanti erano stati gli attaccanti, e un altro rispondere che di certo erano stati più di cento, dato che ne aveva contati una quarantina sulla destra prima che l'attacco venisse sferrato sulla sinistra. Ci giunse il grido di Dedalo e vedemmo davanti a noi, in lontananza, un gruppo di cavalieri, intenti a osservarci. Non parevano intenzionati a impegnarci in uno scontro, si limitavano ad aspettare che arrivassimo in loro prossimità. Calcolai che circa duecento passi ci separavano. «Otto» urlò Donuil e Ded rispose: «Otto sono quelli che vediamo... Solo il buon Dio sa quanti stanno nascosti. Ma non abbiamo alternative. Non potendo tornare indietro dobbiamo andare avanti. A me!». Si levò sulle staffe brandendo la spada, quindi si risedette in sella e spronò il cavallo. Non avendo né il tempo né lo spazio sufficiente per disporci in una formazione a cuneo, fummo costretti ad affidarci alla velocità delle nostre bestie e allo slancio dell'attacco. Ma la sfortuna ci aspettava all'angolo. Dedalo era in testa a tutti, seguito a breve distanza da tre soldati che gli stavano quasi alle calcagna e da altri quattro sparpagliati. Seguivano Tressa, Shelagh e Donuil, in fila, poco davanti a me. Lanciando un'occhiata all'indietro e vedendo che tutti i nostri uomini erano lì, mi accinsi ad accelerare per raggiungere la testa del gruppo, appiattendomi sul dorso di Germanico e incitandolo con la lama di piatto. In quel momento vidi Dedalo spinto all'indietro e disarcionato, quasi fosse andato a cozzare contro un muro. I piedi in alto, ben al di sopra della testa, compì una capriola e piombò a terra a faccia in giù. Nello stesso modo furono spinti all'indietro i tre uomini che seguivano e che di colpo si abbatterono al suolo. Erano stati colpiti con tanta violenza che per un attimo pensai che il nemico avesse usato i lunghi archi di Pendragon, ma mentre osservavo i caduti per scorgere le frecce, altri due uomini furono disarcionati. In quel momento scorsi la corda che li aveva uccisi, legata tra due alberi, a un'altezza che corrispondeva alle spalle di un uomo in sella. Un altro dei nostri cercò invano all'ultimo istante di scartare su un fianco per evitare l'impatto mortale, ma rimase impigliata la cresta del suo elmo e mi giunse, sopra lo scalpitio degli zoccoli dei cavalli, il suono secco dell'osso del collo che gli si spezzava. Donuil, Shelagh e Tressa stavano per fare la stessa fine, vicini com'erano alla fune tesa, del tutto inconsapevoli del pericolo. Lanciai un urlo e conficcai gli sproni nei fianchi di Germanico che con un alto nitrito si buttò in avanti, cercando di superare nella corsa i miei compagni, mentre io, levato sulle staffe, roteavo la spada sopra la testa. In preda al timore di avere calcolato male la distanza e di mancare il bersaglio, e nello stesso tempo consapevole che forse il mio intervento non sarebbe stato abbastanza tempestivo da salvare la vita dei miei amici, mi chinai in avanti per tranciare la corda, calando la lama che emise un sibilo secco. Mi giunse lo schiocco della fune che si spezzava di botto, e subito dopo colsi un altro suono: l'urlo di Tressa nel momento in cui il suo cavallo, colpito sul muso dalla fune tagliata all'improvviso, si era impennato e levatosi sulle zampe posteriori agitava all'impazzata quelle anteriori. Vidi Tressa che, liberati i piedi dalle staffe, si gettava lontano dall'animale. Ribollivo dalla rabbia mentre gli otto cavalieri, che avevano attuato quell'agguato mortale, si disperdevano. Le loro cavalcature erano lente, e io li raggiunsi prima che si fossero riavuti dalla sorpresa del mio provvidenziale intervento. Due li uccisi subito, uno sulla mia sinistra e uno sulla destra, poi sterzando per rinnovare l'attacco, mi lanciai sulla sinistra e, avventandomi contro uno da dietro, gli tranciai di netto il braccio destro. Un altro, più coraggioso dei suoi compagni, mi venne incontro, un braccio teso all'indietro per lanciarmi una corta lancia. La gettò, ma con la spada intercettai quel pesante proiettile e lo tagliai in aria. Ma l'impatto mi sbilanciò sulla sinistra; sentii che il piede destro perdeva la staffa e caddi. Non persi conoscenza nel momento in cui piombai a terra, ma rimasi senza fiato. Per qualche attimo fui paralizzato, con il petto e la gola doloranti. C'era rumore intorno a me, quando all'improvviso due mani mi tirarono, mi sollevarono e io riuscii finalmente a respirare. Donuil mi rimise in piedi, conficcandomi le dita sotto le ascelle, scorsi i suoi occhi che mi fissavano ansiosi. Mi chiese a gran voce se potevo muovermi, e io, annuendo, cercai di allontanarlo, ma lui mi rimase vicino e quasi mi trascinò fin dove stava il mio cavallo soffiando e roteando gli occhi, trattenuto da uno dei nostri soldati. Donuil mi aiutò a rimontare. Vidi Tressa e Shelagh, entrambe di nuovo in sella, che mi fissavano in attesa di riprendere la marcia. «Dov'è Ded?» chiesi con una voce che pensai sarebbe stata un urlo e fu invece un bisbiglio sommesso. «È morto, Cay» mi rispose Donuil. «Sono morti tutti quelli che si sono schiantati contro la fune. Muoviamoci!» Si portò al mio fianco sulla destra, mentre Benedetto cavalcava sulla sinistra. Riprendemmo la marcia e dopo un po' già andavamo a rapido galoppo. A poco a poco ripresi a respirare normalmente, e ben presto feci segno alle mie due scorte che ormai ero in grado di controllare la cavalcatura. Con un cenno di assenso si allontanarono da me, e dopo qualche tempo ripresi a guardarmi intorno. Il nostro gruppo era stato più che dimezzato. Donuil sapeva quello che mi passava per la testa. Chinandosi verso di me, con una voce affievolita dal fragore del vento che si infilava sotto i paraorecchi del mio elmo, urlava: «...Non so chi siano quegli uomini... non possiamo impegnarli in combattimento... sono troppi... sarà una fortuna se riusciremo ad attraversare il loro schieramento. Molti sono a piedi... ma hanno alcuni cavalli... non ne conosco il numero... non saranno lontano da noi alle nostre spalle... conviene avanzare... fuggire al loro inseguimento». Poco dopo il terreno si fece più erto e i cavalli cominciarono a dare segni di stanchezza. Germanico aveva la bava alla bocca, e io capii che era prossimo a cadere. Seguì un tratto pianeggiante e spinto dall'impulso tirai le redini indicando agli altri di fermarsi, poi mi volsi a guardare la strada che avevamo percorso. Ci trovavamo in un punto difendibile, perché il crinale era una sorta di passaggio diritto e sotto si stendeva una frangia di cespugli bassi e fitti. Chiunque si fosse avvicinato si sarebbe esposto alla vista, ma noi avremmo potuto rimanere nascosti. Saltai immediatamente a terra e slegai i lacci che trattenevano ben stretto alla sella il grande arco di Publio Varro, chiedendo a uno dei soldati di porgermi la faretra, a sua volta legata all'altra parte della sella. Presi una corda e preparai l'arma, dicendo nel frattempo a Donuil di sellare i cavalli di riserva e lasciare riposare quelli che avevamo utilizzato fino ad allora. Dallo scontro erano uscite incolumi quasi tutte le bestie. Mentre gli uomini si affaccendavano, io rimanevo all'erta, pronto a tirare al primo segno di movimento sul pendio sottostante. Rimasi lì di guardia per una buona mezz'ora, in attesa che i soldati e le cavalcature tirassero il fiato e riprendessero le forze. In cielo si muovevano e si accavallavano le une sulle altre nubi pesanti e cupe, dagli strani colori. Sentii qualcuno dietro a me lanciare un'imprecazione, e quando mi volsi a chiedere che cosa succedesse, il soldato si limitò a levare le mani a palme in su per mostrarmi che aveva cominciato a piovere. Mi giunsero dal sottostante pendio un suono stridulo e una bestemmia soffocata. Alzai di scatto il braccio, dando l'allerta agli altri, quindi scrutai il folto degli alberi sotto di me. In quel momento emersero quattro uomini; uno di loro, zoppicante, correva buttandosi di lato e cercando di grattarsi via dal ginocchio il fango che si era incrostato. Guardavano in alto verso il punto nel quale mi trovavo, ma non sembrava che mi avessero scorto. Mi nascondevano il ciglio del crinale e i bassi cespugli sottostanti. Da come correvano, caparbi e silenziosi, ma incauti, era chiaro che non si aspettavano di trovarci lì. Seguivano altri cinque, e dal folto degli alberi giungevano le voci di altri ancora. Avevo ventitré frecce nella faretra, più una che era già sull'arco, pronta a partire. Tirai quasi senza prendere la mira, e l'uomo in testa cadde all'indietro. Lanciai immediatamente la seconda freccia, poi la terza, e due nemici si abbatterono al suolo. Ci fu uno scoppio di voci, alle quali subentrò il silenzio rotto soltanto dai gemiti dell'ultimo caduto. Lo ignorai, resistendo alla tentazione di finirlo sprecando una freccia, e scrutai la vegetazione sottostante. Il quarto uomo si era gettato dietro un poggio ricoperto d'erba, e di lui sporgeva soltanto una gamba. Aveva ripreso a piovere, e il rumore della pioggia tamburellante sulle foglie sovrastava ogni altro suono. Dietro a me sentivo quelli del mio gruppo che si preparavano a salire in sella e a riprendere la marcia. Stavo prendendo la mira per colpire la gamba che sbucava dal poggio erboso, quando sopraggiunse Donuil. Mi girai appena per guardarlo quando l'intero mondo esplose in un'abbagliante luce bianca e azzurra, e noi fummo lanciati all'indietro, lontano dal crinale. La luce sparì repentina così come era comparsa; quasi accecato, sbattevo le palpebre in preda al panico mentre alle narici mi arrivava un odore che non avevo mai percepito prima. Avvolto nelle tenebre dell'improvvisa cecità, sentivo intorno a me gli uomini che urlavano e i cavalli che nitrivano. Poi a poco a poco recuperai la vista, imperfettamente dapprima, compromessa da macchie abbaglianti che mi impedivano di cogliere immagini coerenti. Brancolando in preda alla nausea, raggiunsi di corsa il bordo del sentiero e, sbattendo freneticamente le palpebre, scorsi qualcosa che si muoveva sul sottostante pendio. Non vedevo chiaramente, ma intuivo la presenza di uomini che correvano. Il cervello mi diceva che un fulmine ci era caduto vicino, e che i nemici, rimasti indenni, ora sciamavano su per la collina. Inserii nell'arco una freccia, scelsi un bersaglio sulla mia sinistra, e tirai verso la figura che avanzava correndo. Persi però di vista sia il bersaglio sia la freccia, senza capire se lo avevo centrato o no. Con lo stomaco stretto in uno spasimo di paura, ripetei la manovra, mirando questa volta sulla destra e lanciando la freccia verso una forma appena intravista: l'uomo roteò su se stesso e cadde nell'erba alta. Ero semiaccecato, ma gli attaccanti, che non lo sapevano, si gettarono a terra. Vidi, a una certa distanza sulla mia destra, la vegetazione che si agitava come quando in mezzo vi cammina qualcuno, ma era troppo distante per fornirmi un bersaglio. Sapevo però che cosa significava quel fremito nell'erba e tra i cespugli: c'erano uomini che salivano il colle per circondarci. Lanciai altre due frecce davanti a me. Nel frattempo l'area visiva si era quasi normalizzata. Fu allora che scorsi qualcosa di sorprendente. Le cime degli alberi che toccandosi, avvinghiandosi, unendosi sembravano formare una cupola compatta parvero flettersi e appiattirsi, come se una mano possente e invisibile le avesse schiacciate. Davanti a me tutto scomparve all'istante e divenne di un grigiore impenetrabile, avvolto in un fragore che sembrava un ruggito. La grandine cadde con tanta violenza che finii a terra. Il rumore dei chicchi sul mio elmo di metallo era assordante, e la violenza dello scroscio mi paralizzava, rendendomi incapace di alzarmi. Mi lasciai andare a faccia in giù, abbandonando le armi che portavo. Le parti scoperte del mio corpo erano doloranti per delle fitte acute e penetranti. Forse sarei morto lì, ucciso dalle antiche divinità dei boschi. Ma a poco a poco la furia della tempesta si placò, e io riaprii gli occhi. Donuil si avvicinò e, chinatosi su di me dalla sella, protese le braccia per aiutarmi a rimettermi in piedi. Raddrizzatomi, afferrai l'arco con la sinistra mentre nella destra tenevo un chicco di grandine grosso quanto un pugno. Lo lasciai cadere, e mi strinsi al braccio di Donuil, che mi sollevò e mi mise di traverso in groppa al suo cavallo. Era una manovra che avevamo praticato centinaia di volte. Raggiunti gli altri, montai su Germanico. Ci muovemmo insieme alla ricerca di un riparo, ben difficile da trovare in quella situazione. La grandine aveva strappato le foglie del fitto baldacchino verde che ci aveva nascosti alla vista dei nemici, e ora all'improvviso così come era cominciata, cessò, lasciandosi dietro un profondo silenzio. Nessuno si muoveva in quella quiete, neppure i cavalli, quasi avessimo paura che gli dèi delle tempeste, disturbati, potessero di nuovo scatenare la loro furia. Ma il silenzio si prolungava, si intensificava tanto che cominciammo a credere che fosse finita. Mi girai sulla sella per guardarmi intorno, contento di avere riacquistato completamente la vista. Intorno a noi il terreno era coperto di chicchi di grandine. Mi ricomposi e spronai il cavallo, pur sentendo fitte di dolore nel punto in cui ero stato colpito; gli altri si mossero con me, raccogliendosi in gruppo e puntando verso il sentiero. Eravamo rimasti in dodici: Benedetto, il giovane Bedwyr, che pareva esausto e mostrava molto più dei suoi anni, Shelagh, Tressa, Donuil e sei soldati. Germanico, il mio cavallo nero, era sano e salvo, anche se aveva perduto le sacche agganciate alla sella, e dietro a lui scorgevo una decina di cavalcature di riserva. Una freccia mi sfiorò il viso e rimbalzò senza fare danni sulla corazza dell'uomo che mi precedeva: ci colse tutti di sorpresa e ci ricordò che i nemici ci stavano alle calcagna. Levai l'arco e feci per prendere una freccia dalla faretra, ma con sgomento mi accorsi che l'avevo perduta, probabilmente nel punto in cui Donuil mi aveva tirato sul suo cavallo. Con un cenno del braccio indicai di proseguire. Spronammo le nostre cavalcature, imprecando di tanto in tanto mentre ci arrampicavamo sull'erto sentiero e gli zoccoli dei cavalli scivolavano sulla coltre di chicchi di grandine. Alcuni attimi dopo, la pioggia riprese, offuscò la luce del tardo pomeriggio e ridusse la visibilità tanto che a stento riuscivamo a scorgere chi ci precedeva. Le imprecazioni si intensificarono, ma ci era di conforto sapere che il nemico era a piedi e doveva trovarsi in difficoltà maggiori delle nostre. Il sentiero si restringeva e si faceva sempre più scosceso, scivoloso e insidioso sotto gli zoccoli delle bestie. Dopo una curva a sinistra ci trovammo su un pendio esposto, con uno spuntone roccioso sopra di noi e sulla destra un burrone. In lontananza, sopra la valle avvolta in un sudario di nebbia, di tanto in tanto un lampo squarciava il cielo e subito dopo, quasi in risposta, ne brillava un altro più vicino. Shelagh procedeva davanti a me; tre soldati conducevano i cavalli di riserva; il gruppo di testa comprendeva Donuil, Benedetto, di cui intravedevo la cresta dell'elmo, Tressa e accanto a lei un soldato. Una freccia mi cadde vicino, ma quando mi girai per vedere da dove era stata lanciata, non scorsi nulla. Ero sicuro che fosse stato l'ultimo tentativo, l'ultima freccia che in tono di sfida indicava la rinuncia del nemico a seguirci. Avevamo vinto. In quel momento il mio cavallo indietreggiò in preda al panico. Vidi che poco oltre un cavallo cadeva nel vuoto scalciando disperatamente. Davanti a me si svolgeva una scena di terrore e di folle paura, di armi mulinanti; una massa di animali che rinculavano, s'imbizzarrivano, precipitavano. Un altro cavallo cadde con il cavaliere che si afferrava al suo dorso, e un'altra forma umana si stagliò, brancolante nell'aria. Il cavallo di Shelagh, che mi precedeva di poco, scivolò all'indietro e mi finì addosso. Mi gettai sulla sinistra, e scorsi Shelagh che piombava a terra sulla schiena. Sentii un macabro schiocco, come di un osso che si spezza, mentre mi abbattevo al suolo e, intontito, aspettavo che insorgesse l'acuto dolore che sempre accompagna una frattura. Percepii invece soltanto il terreno duro coperto di grandine. Mi accorsi in quel momento che lo schiocco era stato quello dell'arco, il possente e antico arco lungo di Varro, che ora giaceva rotto e inutile al mio fianco. In un istante di strana inconsapevolezza ricordai che quell'arma aveva più di cento anni, che per generazioni era stata tenuta da conto e che adesso la sua parabola era finita. Mi ripresi all'istante. Erano caduti in molti. Shelagh giaceva immobile, le braccia e le gambe larghe. Vidi qualcun altro, all'estremità del sentiero: un elmo e un paio di spalle, le mani che cercavano di afferrarsi al bordo gelato del sentiero, occhi enormi che mi fissavano terrorizzati. Mi gettai in avanti, cercando di agguantare quelle braccia, ma mi sfuggirono. Ero finito a faccia in giù e scivolavo sulla corazza di metallo oltre l'orlo dell'abisso. Roteai su me stesso con forza cercando di aggrapparmi a qualcosa e alla fine mi trovai a penzolare sul burrone a testa in giù. Non so per quanto tempo rimasi lì, ma ricordo i pensieri che mi attraversarono la mente. Sapevo che a fermare la mia caduta era stata una delle gambiere. Si era evidentemente agganciata a una protuberanza del terreno, una radice o un alberello. Soltanto due strisce di cuoio tenevano legata la gambiera. Se una si fosse spezzata, anche l'altra si sarebbe rotta, e sarei precipitato a testa in giù. Sentivo sulla schiena la spada, rimasta attaccata al mio corpo, e ora l'elsa si era incastrata sotto il lembo dell'elmo a protezione della nuca. Ne percepivo il peso che tirava la striscia di cuoio sotto il mento e premendo contro la mascella rischiava di soffocarmi. Qualcuno sul fondo del burrone gemeva, i lampi guizzavano nel cielo all'imbrunire, il rombo del tuono arrivava in assordanti ondate. La pioggia continuava a cadere. Fu Benedetto a scorgermi. Lo sentii che mi chiamava e mi raccomandava di non muovermi. Tentai di rispondergli, ma la cinghia dell'elmo sotto il mento mi impedì di aprire la bocca. Passò un po' di tempo, poi mi giunsero dei rumori: due uomini, Benedetto e un soldato di nome Marco, stavano calandosi lungo una corda. Non appena si fu ancorato saldamente alla parete del burrone, Marco, che reggeva un altro tratto di corda, ne passò un'estremità a Benedetto che, dall'altra parte rispetto a me, me lo infilò sotto le spalle. Capii che mi legavano strettamente con la fune e legavano anche la spada che portavo contro la schiena, poi Benedetto mi sostenne mentre Marco tagliava i lembi della gambiera. Caddi tra le braccia di Benedetto, e mi trovai a penzolare di fronte alla parete rocciosa, solidamente legato. I due risalirono sul sentiero e da lì lentamente, a poco a poco, mi tirarono su. Non fui sorpreso nel constatare, arrivato in cima, che era stato Donuil, a sollevarmi sotto lo sguardo ansioso degli altri due. Facevo fatica a reggermi sulle gambe, mentre Benedetto slegava la corda che mi circondava il petto. Donuil era tornato vicino a Shelagh, seduta contro la parete rocciosa. Aveva gli occhi aperti, ma lo sguardo era assente. Chiesi a Donuil se stava bene, e lui rispose con un cenno affermativo della testa. Mi guardai allora intorno. Benedetto e Marco erano vicino a me e poco distante altri due uomini erano occupati con i cavalli. «Dov'è Tressa?» Intuii la risposta prima ancora che Benedetto, a capo chino, mi dicesse: «Se n'è andata, Cay. Il suo cavallo è precipitato». Mi parve di essere sopraffatto da un'onda di stanchezza infinita. «Come è accaduto, Ben?» «Colpa di un gatto selvatico» disse dopo avere tratto un respiro profondo. «Cosa?» «Un gatto selvatico o un altro animale. Probabilmente in preda al panico per il temporale. L'ho visto spiccare un balzo da uno spuntone di roccia sopra di noi, piombare sul collo del cavallo, e a quel punto mi è parso che il mondo impazzisse. Ho visto tutto ma non ho potuto evitare il disastro. Era il caos. Il cavallo di Tressa è indietreggiato imbizzarrito e si è levato sulle zampe posteriori, lei in piedi sulle staffe cercava di controllarlo, ma uno degli zoccoli della bestia è scivolato oltre il bordo del sentiero, e sono rovinati nel burrone l'uno sull'altro. Anche il mio cavallo è caduto, ma verso l'altro lato del sentiero, inchiodandomi contro la parete rocciosa, e lì è rimasto finché non si è rimesso in piedi. Donuil è stato disarcionato ma è riuscito a non farsi schiacciare dagli zoccoli della sua bestia. Sono stati disarcionati anche Marco e Rufio, ma se la sono cavata. Shelagh si riprenderà, sebbene abbia preso un brutto colpo. Ti ho visto piombare oltre l'orlo del sentiero, e per un momento ho pensato che fossi morto come gli altri. Per fortuna siamo venuti a vedere.» Mi vennero in mente i gemiti che avevo sentito provenire dal fondo del burrone. «Qualcuno è ancora vivo laggiù.» «Sì, lo sappiamo, ma non riusciamo a localizzarlo.» «Potrebbe essere... Tressa.» Fece una smorfia. «Ne dubito. Tressa è caduta molto più su, lungo il sentiero. I gemiti che abbiamo sentito erano di un uomo.» Cercai con uno sforzo di mettermi in piedi, ma ricaddi all'indietro. «Dobbiamo accertarcene. Abbiamo le corde. Scenderemo nel burrone.» «Non possiamo, Merlino. È buio ormai, troppo pericoloso. Siamo rimasti soltanto in sette, siamo stanchi, semicongelati. Rischiamo di morire se ci impegniamo in un salvataggio del genere. Dovremo aspettare fino a domattina.» «Prima di allora possono essere morti tutti.» «Lo so, ma non c'è alternativa.» Feci di nuovo il tentativo di rimettermi in piedi e questa volta ci riuscii, ma come tentai di spostarmi di un passo, la gamba destra, quella con la quale ero rimasto appeso nel vuoto, si piegò sotto di me, e Benedetto arrivò appena in tempo a sostenermi prima che cadessi lungo disteso. Con il viso andai a sbattere contro la sua corazza, e il mondo divenne tutto nero. XVI. La follia può assumere diverse forme. La mia aveva le fattezze di Peter Ironhair. Ecco perché trascorse un anno prima che dal profondo del cuore piangessi la perdita di Tressa. Quando era morta Cassandra, il grande amore della mia vita, mi ci erano voluti due anni prima che il dolore si facesse sentire, ma allora ero ammalato, incapace di capire quanto era accaduto, di ricordare il passato, di raccogliere i miei pensieri. Tressa, l'unica altra donna che aveva potuto vantare dei diritti sulla mia anima, dopo avere soggiogato il mio cuore, dovette attendere un anno intero mentre io, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, sentivo dentro di me soltanto un'inestinguibile sete di vendetta. Ero consapevole della perdita, consapevole del dolore che, non trovando sfogo, si era accumulato e incancrenito, consapevole del vuoto che avevo intorno, consapevole che la gioia si era ormai allontanata per sempre: eppure mi rifiutavo di riflettere sui mali che mi affliggevano. Mi ero assegnato un compito da portare a termine prima di morire: annientare un nemico e strappargli il cuore. Nei miei sogni a occhi aperti, e in quelli che mi tormentavano di notte, era sempre presente il viso di Ironhair. Non appena finivo di discutere qualche piano strategico con i miei ufficiali, me ne andavo per isolarmi: non avevo amici in quel periodo e comunicavo con il prossimo esclusivamente sulla base delle esigenze del momento. Nella solitudine subito mi assaliva il pensiero di Ironhair. Immaginavo il suo riso di scherno e lo vedevo come era stato a Camelot prima che ne fosse cacciato: un uomo sorridente, gioviale, apparentemente schietto e animato da buone intenzioni, capace di essere sollecito e solidale. Il suo viso, che ricordavo in ogni dettaglio, mi era più familiare del mio stesso volto. Mi era vicino perfino nel sonno. Notte dopo notte, nel mio letto solitario, mi accadeva di svegliarmi di soprassalto con la sensazione di averlo visto alle spalle di altre persone: Tressa, Ded, perfino Artù. Lucano compariva spesso nei miei sogni e anche lui a un tratto assumeva le fattezze beffarde di Ironhair. Ho detto che in quei giorni non avevo amici, e questo è nello stesso tempo vero e falso. Gli amici mi stavano accanto - Donuil e Shelagh, Benedetto e Falvo, Filippo e il fedele Rufio - ma io li evitavo, li tenevo a distanza con freddezza e indifferenza quando cercavano la mia compagnia, li trattavo come subordinati quando amministravo gli affari del governo o della guerra. Sopportavano con pazienza, conoscendo il motivo di quell'atteggiamento, ma oggi, ripensando a quei momenti, capisco quanto dovevano sentirsi sgomenti nell'animo. Con il tempo passò il terribile dolore, ma non fui più capace di ricostituire l'intimità sicura che avevo conosciuto in loro compagnia; non ero più Merlino, il fidato compagno, il fratello d'armi, il cordiale amico: ero diventato Merlino il predatore, il vendicatore, lo stregone, il mago. Un anno perduto salvo che per pochi ricordi effimeri; due anni trascorsi sotto l'identità di un altro uomo, un'intera vita che ero disposto a sacrificare per appagare un sogno di vendetta. Ebbe inizio sull'erto sentiero sopra l'abisso che aveva inghiottito Tressa. Il sole mattutino, che si levò in un cielo senza nubi scevro da ogni traccia della micidiale tempesta, ci trovò ancora immersi nel sonno, sette corpi infreddoliti, percorsi da brividi, avvolti in vesti fradice, stretti l'uno all'altro alla ricerca di un po' di tepore. Qualcuno, credo sia stato Benedetto, aveva coperto quel groviglio di corpi addormentati con le coperte che ci eravamo portati dietro e con i mantelli, poi aveva impilato sopra, strato su strato, le tende di cuoio. Shelagh, accoccolata contro la mia schiena, mi stringeva a sé con le braccia, io a mia volta ero accucciato contro Rufio. Quando si svegliò il primo di noi, si destarono anche gli altri e ricordo che, uscendo da quel letto improvvisato, tremavo nel freddo del mattino. Mangiammo in fretta e in silenzio, senza darci la pena di contare le razioni che restavano nelle bisacce attaccate alle selle; poi cominciammo a cercare gli amici. Il burrone che ci era sembrato così profondo e tenebroso la notte precedente non era dopo tutto un abisso spaventoso. Il fondo era a una ventina di passi dal sentiero, ma era coperto di massi, da tempo staccatisi dalla parete rocciosa e ora nascosti da una bassa vegetazione. L'arboscello al quale ero rimasto appeso, e al quale il mio gambale era ancora attaccato, mi aveva retto a un'altezza sul vuoto non superiore alla mia statura, sufficiente a uccidermi se fossi caduto a testa in giù, ma certamente non pari a quella che mi ero immaginato. Sotto un albero sulla sinistra, in una leggera cavità del terreno, trovammo Bedwyr, privo di conoscenza ma vivo, con la gamba sinistra rotta e l'osso spezzato che sporgeva dalla coscia. Rufio e Marco, il medico che ci seguiva, gli raddrizzarono e fasciarono la gamba mentre era ancora svenuto, e lo issarono. Alcuni andarono alla ricerca degli altri. Tressa era morta schiacciata dal peso di un cavallo: non del suo che giaceva a diversi passi di distanza, ma del mio, lo splendido esemplare nero che lei chiamava Bucefalo. Distesa supina, sembrava immersa nel sonno; il viso aveva un'espressione tranquilla, anche se ormai aveva assunto una colorazione bluastra. Calzava ancora l'elmo che le nascondeva i bellissimi capelli, tanto che sembrava un ragazzo più che una donna. La parte inferiore del corpo, dalla vita in giù, era finita sotto la massa insanguinata della bestia, che aveva il ventre squarciato. Aveva avuto ragione a chiamarlo Bucefalo; ricordai che una sera, a letto - la sera stessa del giorno in cui gli avevo cambiato il nome la mia Tress mi aveva preso in giro. Bucefalo le piaceva più di Germanico, aveva dignitas, diceva, evocava un destriero storico. Per tutta risposta, l'avevo stretta tra le braccia e le avevo detto che Bucefalo aveva ucciso l'uomo più grande dei suoi tempi gettandolo da una rupe, e mentre giacevo su di lei l'avevo sfidata a disarcionarmi con altrettanta facilità. Ma quella notte Tress non aveva avuto alcuna intenzione di disarcionarmi! E ora Bucefalo aveva ucciso la donna che in quegli anni più avevo amata. Ci volle mezza giornata per condurre i cavalli sul fondo del burrone, spostare l'inerte massa nera dal corpo di Tressa e quindi seppellirla. Scelsi per lei un angolo tranquillo e riparato, tra due spuntoni di roccia poco sotto il punto in cui era morta. Io stesso scavai la buca nella quale l'avrei deposta, usando la spada per incidere il suolo e il gambale che mi restava per togliere la terra. Posi delicatamente il corpo nella fossa e lo ricoprii tutto, tranne il viso. Presi quindi due lastre di pietra e le collocai obliquamente l'una contro l'altra, a formare una specie di tetto sulla sua testa. Poi raccolsi altre pietre e ricoprii la tomba per impedire ai lupi e agli orsi di raggiungere il corpo. Per ore lavorai, prendendo le pietre intorno e impilandole fino a elevare un tumulo a piramide che mi arrivava all'altezza del petto. Soltanto allora smisi, sentendo che il dolore minacciava di sopraffarmi. Gli altri non erano rimasti in ozio e avevano dato sepoltura ai tre soldati - Gunnar, Casso, Secondo - che erano morti precipitando da quell'insidioso sentiero. Li conoscevo appena. Mentre risalivo, mi venne incontro Donuil e mi tese la mano per aiutarmi a superare gli ultimi passi. Ma nell'istante in cui gliel'afferrai, mi parve che il suo volto trasmutasse e diventasse quello di Ironhair. Indietreggiai e lo tirai con l'intenzione di buttarlo nel fondo del burrone. Grazie a Dio, si era attaccato a un albero, eppure fui sul punto di sbilanciarlo, tanto brusco fu il mio strattone e intensa la sua sorpresa. Brontolò, aggrottò la fronte ed emise un profondo respiro; poi mi tirò su e si allontanò da me. Sapevo di essere fuori di senno e in seguito lui me lo confermò, dicendo di aver scorto nei miei occhi uno sguardo folle. Quel momento passò e io rimasi lì a scuotere la testa mentre lui mi chiedeva che cosa mi fosse preso. Arrivammo a Camelot qualche giorno più tardi; trasportavamo Bedwyr su una specie di barella fatta con il cuoio delle tende legato a due rami e attaccata a due cavalli. Del viaggio e del nostro arrivo non ricordo nulla. La prima volta che fui davvero consapevole di essere di nuovo in patria fu nel sudarium. Ero seduto intento a parlare con Benedetto, che mi stava di fronte, quando fui all'improvviso assalito da una specie di vertigine e una folla di immagini mi si assiepò nella mente, simili a quelle che avevo visto anni prima, nel periodo in cui avevo perduto memoria di me stesso. Benedetto si tese verso di me, il viso segnato dall'ansia, chiedendomi se mi sentivo bene. Accennai di sì con la testa, e decisi in quell'istante di non fare parola dell'episodio. Continuò a lanciarmi occhiate preoccupate, ma non fece commenti. Nel rivestirmi mi accorsi che gli abiti erano puliti e diversi da quelli che avevo indossato durante il viaggio; dedussi perciò che ero arrivato da abbastanza tempo, per lo meno quel tanto che mi era servito per cambiarmi. Mi avviai per cercare Dedalo, ma all'improvviso ricordai di averlo visto cadere da cavallo e sfracellarsi al suolo. Dedalo era morto. Il senso di vertigine si impossessò ancora una volta di me. Mi appoggiai a una parete, cercando di placare un conato di vomito. Vomitai, ma non provai sollievo, e all'improvviso caddi sulle ginocchia e svenni. Quando ripresi coscienza, vidi chine su di me Shelagh e Ludmilla. Accorgendosi che avevo aperto gli occhi, Ludmilla mi posò sulla fronte la sua morbida mano. «Hai la febbre, Caio. Siamo in ansia per te da qualche giorno. Riposa finché chiamo Mucio. Shelagh ti rimarrà accanto.» Quando Ludmilla se ne fu andata, cercai di volgermi verso Shelagh, ma non riuscendo a girare la testa, fui preso dal panico. I ricordi mi portavano all'altra volta che ero stato ferito, quando Lucano aveva dovuto perforarmi il cranio per aumentare la pressione. Per farlo mi aveva legato la testa a un congegno che mi avrebbe impedito di muoverla. Shelagh, che era stata a osservarmi, mi infilò le braccia sotto il collo e mi aiutò a sollevarmi. Questo placò le mie paure. Era la debolezza a inchiodarmi al letto. Cercai di parlarle, ma le labbra parevano sigillate. In fretta lei inumidì un panno e mi bagnò la bocca. Mi venne in mente che la zia Luceia aveva compiuto molti anni prima lo stesso gesto, e mi aveva arrecato grande sollievo. Mi leccai le labbra e parlai, ma la voce era poco più che un sussurro. «Che cosa succede Shelagh? Dov'è Ambrogio?» Lei corrugò la fronte. «Come... dov'è Ambrogio?» Si spalancò la porta davanti al letto, ed entrò di gran furia Mucio Quinto, portandosi subito al mio capezzale e posandomi la mano sulla fronte. Non guardava me, tuttavia, ma fissava Shelagh. «Come sta andando?» le chiese. «Non ricorda niente» rispose scuotendo la testa, la fronte sempre aggrottata. Quinto mi osservò e sollevò la mano che mi aveva posato sulla fronte. «Sta meglio» brontolò. «Stavolta non devo temere di arrostirmi la mano.» Sorrise. «Raramente mi è capitato di dover curare una febbre alta come quella che ti ha colpito, amico mio. Per quasi una settimana sei stato in fiamme. Bruciavi. Quanto ricordi?» «Di che cosa?» chiesi in un sussurro sbattendo le palpebre. «Di qualsiasi cosa. Qual è l'ultima cosa che ricordi?» L'immagine della tomba di Tressa, di quell'alto tumulo di pietre, mi attraversò la mente come un lampo. Mi sentii soffocare. Cercai di richiamare altre immagini del passato e vidi Donuil che mi tendeva la mano. «Ironhair» dissi. «Hmm» mormorò Quinto senza mostrare sorpresa. «Ti ricordi di essere tornato a Camelot?» Scossi la testa in segno di diniego. «Donuil aveva ragione allora.» Si voltò e per qualche attimo rimase fuori del mio campo visivo; subito dopo si avvicinò, reggendo in mano una coppa di corno. «Bevi» disse, sollevandomi la testa con una mano. «Donuil aveva ragione?» borbottai. «E Shelagh?» «Anche lei ha ragione. Su, bevi.» Tenni le labbra strette rifiutando la pozione. «Sto perdendo la ragione, Quinto?» «Perdendo? Ti riferisci alla memoria?» Rise gettando all’indietro la testa, e mi sentii sollevato. «No, naturalmente no. Ci riconosci, no? Quelli che siamo qui? E sai chi sei; la memoria va bene. Sei stato malato, Caio, ecco tutto. Una febbre da cavallo e la tosse asinina. Polmonite, e non c'è da sorprendersi. Anche Benedetto l'ha avuta, sebbene in forma meno virulenta della tua; inoltre non è stato toccato dal lieve disturbo cutaneo di cui soffri tu. La memoria è a posto, te lo garantisco. Forse non ricordi alcuni particolari recenti, ma è imputabile alla febbre, non all'incapacità della mente. Bevi e dormi.» «Come mai non riesco a muovermi?» «Perché sei debole come un bambino, denutrito e disidratato. Ringrazia il cielo di essere vivo. Ritornerai in forze. Su, bevi!» La pozione aveva un sapore amaro, ma la sorbii tutta, e quando l'ebbi finita, Quinto mi aiutò a rimettere la testa sul cuscino. China su di me, Shelagh mi pulì gli angoli della bocca e mi posò un bacio lieve sulla fronte. Percepii il contatto delle sue labbra morbide e delicate, e sentii che si allontanava. «Quale disturbo della pelle?» chiesi ma nessuno mi rispose. Sapevo che era un sogno fin dall'istante in cui aprii gli occhi. La camera era buia ma riuscivo a vedere perfettamente. Ironhair se ne stava seduto vicino al mio letto, su una poltrona imbottita, tenendo il mento appoggiato sulla mano sinistra, e mi fissava attraverso gli occhi socchiusi. Indossava una toga praetexta, la toga dal bordo purpureo usata dai senatori romani. Accorgendosi che mi ero destato, si raddrizzò e sorrise. «Caio Merlino Britannico,» disse in tono strascicato «mi riferiscono che mi hai cercato. In che modo posso esserti utile?» «Restando vivo finché non verrò a cercarti» risposi. Rise con un tono che dimostrava un genuino spasso. «Certamente! Sta' pur sicuro che non ho nessuna intenzione di morire. Ma perché vuoi venire a cercarmi?» Lo guardai senza muovermi dalla posizione supina, il viso ingannevolmente piacevole, apparentemente privo di malizia. «Perché?» ripetei. «Perché ti sei prefisso di distruggere la mia vita.» «Distruggere?» Rise di nuovo, ma il solco tra le sopracciglia indicava che era perplesso. «Perché, secondo te, dovrei sprecare il mio tempo a distruggerti? La tua arroganza e la tua presunzione arrivano a questo punto?» La voce era fredda, rabbiosa. «Sei soltanto un uomo, Britannico, e sebbene le mie parole possano offenderti, ti dirò che ho altre cose, ben più importanti di te, che mi tengono occupato. Ho una missione da compiere: conquistare un regno per un cliente... Carthac Pendragon, che mi ha assoldato, e finché non avrò concluso questa impresa, disporrò di ben poco tempo da sprecare sulle rivendicazioni passate.» Tacque e io gli chiesi: «Cliente? Sei per caso un senatore per permetterti un cliente?». Ignorando la mia interruzione, proseguì come se non avessi aperto bocca. «È vero che una volta noi due avevamo opinioni divergenti, e che hai usato il tuo potere per ostacolarmi. Ma da allora sono passati molti lunghi anni, e la vita è andata avanti: nuove imprese da compiere, nuove terre da conquistare, nuovi traguardi da raggiungere! Ho di rado pensato a te in tutto questo tempo, tranne che in un paio di occasioni, quando si è fatto il tuo nome. Merlino di Camelot, così ti fai chiamare oggi. Assai diverso dal Caio Merlino Britannico, comandante legato delle forze armate di Camelot, come una volta ti sei presentato a me.» «Ti è rimasto impresso, eh?» «Rimasto impresso? Suvvia, Merlino! Siamo cresciuti entrambi da allora. Quel titolo pretenzioso era il segno della presunzione di un piccolo uomo che si credeva grande e temeva che il suo potere fasullo potesse essere messo in discussione. Ammettilo.» «No, sbagli. Era un titolo autorevole, sufficiente a porti sotto di me e vanificare i tuoi piani per usurpare questa Colonia.» «Soltanto temporaneamente» disse con voce soffocata, quasi impercettibile. «Che cosa hai detto?» Sorrise, un sorriso lento e protratto. «Ho detto che ho rimandato i miei piani soltanto temporaneamente. Camelot sarà mia, e tu lo sai, una volta che Carthac avrà rivendicato i suoi diritti sulla Cambria.» «Non accadrà mai finché sarò vivo, riuscirò a fermarti» mormorai. «Tu? Merlino, sei già mezzo morto. Sei lucido mentalmente, ma fisicamente?» Scosse la testa. «La lebbra segnerà la tua fine a Camelot.» «Forse» dissi senza sgomentarmi al sentirlo dare un nome al mio terrore più profondo. «Ma non prima che ti abbia strappato il cuore dal petto!» «Ah!» Si levò in fretta e si portò dietro la poltrona, quindi, prima di girarsi e appoggiare le mani sullo schienale e chinarsi verso di me, si attardò a sistemare le pieghe della candida toga. «Merlino,» riprese con una voce che tradiva un guizzo di impazienza «non sei uno stupido, lo so. Irritante, ma non stupido. Non sentirai altre parole da me dopo quelle che sto per dirti. Ascoltale con attenzione: morirò, come è destino di tutti gli uomini, ma non per mano tua. Di questo stai pur certo. Non ostacolarmi. Continua a vivere la tua stupida, miserabile vita come meglio ti pare, ma per favore - se devo implorarti, lo farò - non illuderti che mi abbasserò a occuparmi di quello che fai. E adesso me ne vado, la mia presenza è necessaria altrove.» «Carthac?» «Che vuoi sapere di lui?» «Perché ti sei schierato al suo fianco?» «Carthac è lo strumento che mi serve per conseguire i miei fini. È un pazzo, una creatura bestiale, indegno di essere definito uomo, ma necessario, almeno per il momento. È immune al dolore e non conosce la paura. È invulnerabile. Sanguina come tutti, ma dubito che possa essere ucciso al pari degli altri. Una volta ho osservato un chirurgo che gli toglieva dalla coscia una lunga freccia. Carthac sopportò quello strazio senza un lamento, senza il guizzo di un turbamento. Va detto, però, che subito dopo uccise il chirurgo a sangue freddo, d'impulso, senza alcuna premeditazione. È pazzo, te l'ho detto.» «E quando ti dilanierà, Ironhair, che cosa dirai allora?» «Non lo farà mai. Mi vuole bene a suo modo, il modo di un folle. Sono l'unico amico che abbia mai avuto, si fida ciecamente di me. Ora devo andare. Dammi congedo.» «Te lo concedo, ma hai molte cose di cui rispondere. L'aggressione ai nostri bambini, tanti anni fa, l'assassinio della moglie di Hector, Julia, donna di grandi virtù. La morte recente di mia moglie, Tressa. La morte del mio caro amico Dedalo e molte, molte altre colpe.» «Sono accuse insensate, Britannico» m'interruppe con voce impaziente. «Non ne so niente di questa Julia, anche se ti prendo in parola e ti credo quando dici che è stata uccisa. Un incidente, un evento fortuito rispetto allo scopo principale, che era di eliminare quel moccioso di Artù Pendragon. Ti ho fatto del male una volta, non di più. Ce l'avevo con te. Bada bene: se allora avessi saputo ciò che so ora, mi sarei impegnato con maggior accanimento. Ma tutto ciò avveniva prima che Carthac entrasse nella mia vita. Quanto a tua moglie e ai tuoi amici, che colpa ne ho io? Sei tu che hai deciso di rientrare in patria trascurando di prendere le misure più ovvie per salvare loro la vita. Sei stato tu a decidere di attraversare una terra sconosciuta senza farvi precedere da un manipolo che esplorasse la zona. Perché? Non ho lanciato minacce contro Camelot, e non lo farò finché non avrò concluso quello che ho avviato in Cambria. Devi ammettere che non ho alcuna colpa.» «E Horsa?» «Che vuoi sapere di lui? Avevo bisogno di soldati mercenari e lui me li ha procurati.» «È un danese, uno straniero.» «È un soldato di ventura, un mercenario, Merlino. È pagato per combattere.» «E anche per saccheggiare, per accaparrarsi le terre, per rubare. Ha ucciso Vortigern, che con lui era stato generoso e magnanimo. Lascerai i suoi seguaci liberi di scorrazzare tra i tuoi uomini?» Le labbra ebbero una smorfia di scherno. «Cos'è questa storia dei "miei uomini"? Gli unici uomini che ho sono quelli che ho comprato. Risparmiami queste frasi a effetto. Addio!» Accolsi il suo commiato con un cenno della testa. «Vai pure, ma sii pronto a incontrarmi di nuovo, Ironhair.» Sorrise e lentamente la sua immagine si dissolse davanti ai miei occhi, mentre si attenuava la luce che me lo mostrava. «Te l'ho detto, Merlino, non mi troverai. Bada a te stesso e al ragazzo a te affidato, Artù Pendragon. Per lui dovresti crucciarti e angustiarti... Una maledizione grava sulla sua testa... e anche sulla tua...» Quando la camera fu di nuovo immersa nell'oscurità, tentai di tirarmi su nel letto, ma non riuscii a muovermi. Chiamai e mi rispose una voce femminile che proveniva da dietro la porta. Poi la porta si spalancò ed entrò una giovane donna, reggendo una lampada. «Comandante Merlino, cosa posso fare per voi?» «Niente» risposi, compiaciuto nel constatare che la mia voce era forte come lo era sempre stata. «Come vi chiamate?» Non ricordo il suo nome, ma mi disse che mi aveva sentito parlare nel sonno. Sorrisi e le spiegai che avevo fatto un sogno. Se ne andò, lasciandomi solo. Rimasi disteso a fissare il soffitto buio, passandomi le dita sul petto e percependo al contatto la pelle secca, quasi fosse coperta di scaglie. La lampada gettava una luce forte, intensificata dal riflettore di ottone lucidato. Era strano che non mi avesse abbagliato dopo che per tante ore ero rimasto nell'oscurità. Ma i miei occhi si erano abituati alla luce intensa prima ancora che lei entrasse nella camera. Non sono mai riuscito a spiegare questo fenomeno, ma credo che quella notte Ironhair sia stato davvero nella mia stanza, e spesso mi sono chiesto se lui lo sapesse. Una settimana dopo, ero di nuovo in piedi, guarito dalla strana malattia che mi aveva colpito; soltanto la pelle era ancora arrossata e scabra. Mi controllai attentamente il petto, ma non riscontrai nulla che sembrasse una lesione; la notte della tempesta aveva lasciato come unico segno un'epidermide arida e squamosa. La ferita profonda era dentro di me. Esaminai tutti gli avvenimenti accaduti prima del nostro arrivo, e quando Filippo, Rufio e Falvo arrivarono alla testa dei loro mille uomini, ero di nuovo in pieno possesso della situazione. Connor aveva visto la flotta danese doppiare il promontorio della penisola di Cornovaglia. Aveva osservato che veleggiava sottovento e si era precipitato a precedere le navi straniere con le sue due biremi e quindici galee. Davanti a un nemico assai più potente e numeroso - calcolò che l'avversario avesse duecento navi non aveva tentato di attaccare, ma cambiando rotta aveva puntato verso nord, intenzionato a ricompattare la propria flotta. Si era preoccupato tuttavia di inviare alcuni messaggeri a noi e a Huw Fortebraccio, accampato a Cardiff. Sarebbe tornato quando fosse stato in grado di battersi con una flotta così numerosa. Quando la notizia era giunta a Camelot, Ambrogio non aveva avuto altra scelta se non di correre in aiuto a Huw. Una flotta così imponente portava almeno quattromila uomini, venti per nave, ma si sapeva che i Danesi usavano equipaggi di trenta uomini su ogni unità, tutti guerrieri pronti a combattere e avidi di bottino. Aveva calcolato che il nemico poteva contare su almeno seimila uomini, forse addirittura ottomila o diecimila. Ambrogio sapeva bene che dopo la vittoria conseguita sulla costa nei pressi di Dolocauthi l'esercito di Huw si era disciolto. Nessuno si era aspettato che Ironhair ritornasse all'attacco prima dell'anno successivo, e nessuno aveva previsto di dover affrontare un altro nemico, ben diverso. Ambrogio era partito prima di sapere che i Danesi erano i nuovi alleati di Ironhair. Ci sarebbe voluto un mese intero per ricostituire le truppe di Huw, visto che gli uomini avevano ripreso il lavoro dei campi e in quella stagione erano occupati ad arare in vista della semina. Un esercito di migliaia di soldati, che sbarcasse inaspettatamente, sarebbe dilagato come le fiamme di un incendio, acquistando forza prima di attaccare o essere attaccato. Soltanto la cavalleria di Camelot aveva qualche probabilità di fermarli perché, seppure temibili sulle loro navi, sulla terra erano soltanto fanti, vulnerabilissimi davanti ai nostri cavalieri organizzati. Prima della fine della settimana, Ambrogio, che aveva preso con sé due legioni complete - duemila soldati a cavallo armati pesantemente, mille esploratori, tremila fanti - era entrato in Cambria puntando direttamente verso la costa meridionale, alla volta di Cardiff, dove sperava di trovare Huw Fortebraccio. A lui si era unito Derek di Ravenglass. A Camelot erano rimasti, con pieni poteri, Terzio Lucca con un contingente di duemila uomini, i tre quarti della nostra fanteria. Mi aveva lasciato detto che, se fossi tornato prima di lui, avrei dovuto restare sul posto a occuparmi della difesa anche delle terre circostanti - dalla Colonia Appia nel nord fino a sud a Hchester e oltre - e, qualora non ci fossero state minacce in patria, di mandare mille cavalieri, sotto la guida di Terzio Lucca, a rinforzo dei suoi. Nessuna notizia era arrivata da Artù, che in quel periodo si trovava in Cambria. Al nostro ritorno, Ambrogio era partito da circa un mese. Un giorno, dopo il rientro di Filippo e degli altri, arrivarono nel mio alloggio due soldati portando una grande cassa di legno. Veniva da Platone, il responsabile dell'amministrazione di villa Britannico; sul coperchio era attaccato un foglio. Esprimeva le condoglianze per la morte di mia moglie, e mi diceva che la cassa veniva da Derek il quale l'aveva lasciata alla villa il giorno prima di partire con Ambrogio. Rimasi a fissarla, indovinandone il contenuto, prima ancora che, preso il coltello e tagliati i legacci che la chiudevano, sollevassi il coperchio e guardassi dentro. Sotto l'ampio mantello rosso accuratamente piegato di mio cugino Uther era riposta la sua armatura. Mostrava i segni di alcuni profondi fori, ma era in ottime condizioni. L'elmo con una maestosa cresta di crini di cavallo di un rosso acceso era ancora più bello di come lo ricordassi; la visiera era ornata con il fiero drago che era il vessillo di Uther, smaltato in rosso. La stessa decorazione - un drago ad ali spiegate, eretto sulle zampe posteriori e con fiamme che gli uscivano dalla bocca - ma di dimensioni più grandi, era incisa sulla corazza; lo smalto rosso risaltava nitido sul colore opaco del pettorale. Rividi mio cugino, con indosso quell'armatura, che rideva di me mostrando i denti bianchi e regolari. Mi aveva detto una volta che ero troppo portato a giudicare e questa sua opinione mi aveva ferito profondamente prima di rendermi conto che era esatta. All'improvviso sentii la mancanza di Uther. Presi il pesante mantello e lo distesi sul pavimento, allargandolo in tutta la sua ampiezza. Sulla schiena compariva lo stesso drago, ricamato ad arte nella stoffa con fili di oro puro. Artù avrebbe fatto una splendida figura indossando quel manto, mi dicevo, e così facendo mi volsi verso il punto in cui mi ero immaginato che Uther mi guardasse. Lo vidi con la testa gettata all'indietro e sentii le sue parole. «Una maledizione grava su quel ragazzo...» disse con la voce di Ironhair. Distolsi gli occhi da quella visione, e chiusi il coperchio della cassa, sbattendolo con forza. Rimasi seduto a fissarla mentre il ricordo andava ad altri due forzieri in mano mia, contenenti gli arnesi di morte dei due stregoni egizi, Caspar e Memnon. Creature malvagie al servizio di un signore altrettanto malvagio, Lot di Cornovaglia, erano venuti a Camelot portando distruzione e rovina, e con la magia nera avevano ucciso mio padre. Dopo la loro morte, su indicazione di Donuil, mi ero impadronito dei due forzieri che contenevano gli strumenti della loro infausta e maledetta arte. Lì avevo trovato, accuratamente disposti strato su strato e avvolti ciascuno in una confezione protettiva, una serie di preparati mortali e potenti: polveri e pozioni, unguenti e pomate, liquidi e cristalli, foglie, bacche, erbe disseccate e successivamente tritate o lasciate intere, e infinite altre sostanze conservate in scatole, fiale, involucri di seta, brocche di ceramica. Maneggiandole con somma cautela, poiché sapevo a chi erano appartenute, avevo scoperto che una sola era la funzione di quell'armamentario: infliggere la morte in forme diverse e virulente. Per mesi le avevo studiate non appena mi si presentava l'occasione, cercando di penetrarne i segreti, e ci ero in gran parte riuscito, sebbene di un terzo degli ingredienti ignorassi ancora i segreti. Tra i due terzi di sostanze identificate, tuttavia, avevo individuato innumerevoli strumenti di morte. Cominciò allora a delinearsi nella mia mente il profilo di un piano. Raddrizzai le spalle, traendo un profondo sospiro. «Ironhair,» sussurrai «ho un regalo per te.» Il giorno seguente partecipai a una riunione del Consiglio di Camelot e me ne andai prima che il dibattito si fosse concluso. Dopo un'assenza durata tanti anni, conoscevo pochi consiglieri e mi accorgevo di non avere la pazienza di discutere delle minuzie relative all'amministrazione della Colonia. Nell'accomiatarmi dall'assemblea, feci cenno a Terzio Lucca di seguirmi, e superando insieme il cancello del forte in cui si tenevano le riunioni, gli dissi che era mia intenzione ignorare la richiesta di mio fratello che lo voleva al più presto alla testa di mille cavalieri. Il suo posto, dissi, era a Camelot; per temperamento e per formazione, era il più adatto a tenere sotto controllo le guarnigioni degli avamposti e a lavorare con il Consiglio. Avrei mandato Filippo con i rinforzi, gli comunicai; a lui, Terzio Lucca, avrei dato pieni poteri fino al ritorno di Ambrogio. Ascoltò a occhi bassi e quando ebbi finito, annuì, accettando senza discutere i miei ordini, mettendosi sull'attenti. Lo lasciai sotto le mura e mi diressi verso le terme, mentre il petto mi si gonfiava al truce proposito che mi prefiggevo. Poco dopo rientrai nei miei alloggi, nudo fino alla cintola, per rifare quello che una volta avevo visto fare da Lucano. Presi un lungo ago da cucito di Tressa e me lo conficcai lentamente e con circospezione nel petto, spostandolo da un punto all'altro e prendendo nota delle reazioni. Quasi dappertutto sentii la puntura; ma a tratti, in circa una decina di punti, l'ago penetrò nella pelle senza che lo percepissi. Mi misi seduto, una volta compiuta quell'ispezione, lo sguardo smarrito, svuotato e indifferente alla scoperta. Avevo individuato poco prima, durante il bagno alle terme, una serie di macchie di forma quasi circolare, scolorite dove l'epidermide era arida e squamosa; in quelle zone i peli erano grigi. Nessuna lesione ancora, ma si erano moltiplicate le aree insensibili. Il "lieve disturbo cutaneo" individuato da Mucio Quinto era lebbra. Dopo qualche tempo mi levai e mi rivestii, indossando le mie migliori vesti di cuoio, quindi mandai a chiamare Filippo, Falvo e Rufio, e non appena arrivarono, dissi loro di prepararsi a partire per la Cambria entro due giorni. Trascorsi le ore che seguirono a passare in rassegna il contenuto dei due forzieri. Quella notte andai a cercare Donuil e Shelagh per avvertirli che sarei stato lontano da Camelot per qualche tempo e che non dovevano crucciarsi per me. Assegnai a Donuil il compito di occuparsi di tutto durante la mia assenza e a Shelagh chiesi di badare a Donuil. Quando questi fece il gesto di abbracciarmi, lo scansai rudemente attirandomi una sua occhiata attonita. Shelagh si posò un bacio sul palmo della mano, poi mi sfiorò delicatamente una guancia. Emisi un sospiro profondo, cercai di inghiottire il groppo che mi sentivo in gola e mi allontanai. Alcune ore più tardi, quando soltanto le guardie del turno di notte erano sveglie, visitai le stalle, dove trovai un carro leggero a due ruote e un cavallo grosso e solido per tirarlo. Misi i finimenti all'animale e lo condussi davanti al mio alloggio, quindi caricai quattro casse sul carro. Una di queste conteneva l'armatura di Uther; due erano i forzieri appartenuti agli stregoni egizi; l'ultima racchiudeva una gran quantità di oggetti, che avrebbero potuto essermi utili nel viaggio: vestiario, cordicelle, una piccola ascia, filo di ferro di diverso spessore, coltelli di varia misura, lenze e ami per pescare, un insieme costituito da una spada corta e da una daga costruite da Publio Varro, uno specchio che era appartenuto a mia zia Luceia, la spada lunga ed Excalibur nella sua custodia di legno. Caricai anche alcune provviste raccolte alla meglio nelle cucine: pane, fette di carne salata e affumicata, un sacco di farina, un cespo di cipolle, alcune teste d'aglio, quello che restava dell'olio di oliva, delle stupende olive e del vino offertimi in dono da Germano. Una volta caricato tutto il bagaglio, indossai una veste di fattura austera, che mi arrivava alle caviglie, fornita di larghe maniche e di un ampio cappuccio che mi nascondeva il viso. Avevo trovato quell'indumento poco prima, nel pomeriggio, attaccato a un piolo nel refettorio, lasciato lì da qualcuno che era andato a procurarsi da mangiare. Al suo posto avevo lasciato il mio pesante mantello di lana, senza maniche ma di qualità assai bella, troppo bella per quello che avevo intenzione di fare. Mi sistemai a cassetta, tirai le redini, e il cavallo si avviò. Come mi ero aspettato, quando superai la porta nelle mura di Camelot, poco prima dell'alba, nessuna delle guardie mi prestò attenzione. Raggiunsi la piccola valle nascosta di Avalon mentre, sul suo fondo, intorno al laghetto, gli alberi gettavano lunghe ombre alla luce del sole ormai abbastanza alto in cielo. Sette anni erano passati da quando ci ero venuto per l'ultima volta, e la mia Tressa era vissuta e morta senza esserci mai stata e ignorandone perfino l'esistenza. La tomba di Cassandra si vedeva appena: il tumulo era affondato nel terreno, la porta della casetta di pietra era saldamente chiusa. Era il mio santuario e il mio rifugio; il mondo non aveva nessun potere su di me. Le corde del vecchio letto erano ancora abbastanza forti da sostenere il mio peso e ben presto mi addormentai. Mi svegliai neanche un'ora dopo, riposato e pervaso da un profondo senso di calma, mentre ascoltavo il cinguettio degli uccelli nei boschi intorno alle rive del laghetto. Trascorsi qualche tempo a raccogliere la legna per farmi un fuoco nella buca scavata nel pavimento dietro la porta. Mangiai un po' di carne fredda affumicata e di pane che mi ero portato dal forte, quindi, sedutomi accanto al fuoco, aprii i due forzieri e mi misi a leggere le numerose note che io stesso avevo stilato. Trascorsi così, senza avvedermene, molte ore perché quando mi guardai intorno il sole era tramontato e il fuoco era quasi spento, sebbene nel corso della giornata lo avessi alimentato più volte. Lo attizzai per rivitalizzare le fiamme, accorgendomi solo allora che avevo consumato quasi tutto il combustibile ammassato quella mattina e rimasi lì immerso nei miei pensieri mentre intorno a me calava l'oscurità. Carthac non conosceva la paura, me l'aveva detto in sogno Ironhair. E lo stesso aveva affermato Huw Fortebraccio che lo aveva definito invincibile, invulnerabile, impavido. E impavidi, stando a quanto dicevano tutte le fonti, erano anche i Danesi di Horsa. Uomini selvaggi, di inaudita ferocia, implacabili nell'odio contro chi li ostacolava o cercava di contrastare; nella loro sfrenata arroganza non temevano né gli uomini né le belve. Anche i miei uomini erano coraggiosi in guerra; invincibili nella radicata fiducia di poter abbattere qualsiasi avversario. Eppure sapevo che a Camelot molti avevano avuto paura di me quando ero stato giovane: non della mia forza fisica, ma dei poteri straordinari che, secondo loro, io, Merlino, possedevo. Paure infondate perché le azioni che suscitavano il loro terrore erano state compiute con l'inganno ed erano frutto di suggestione. Il più notorio di questi trucchi era stata la scomparsa di Cassandra nel cuore della notte da una stanza sorvegliata dalle guardie, e non si era trattato soltanto di un inganno. Avevo temuto per la sua incolumità e l'avevo allontanata prima che le guardie si mettessero a sorvegliare una stanza vuota. Il mistero sopraggiunse successivamente, quando dichiarai di essere stato svegliato da un sogno che mi diceva che se ne era andata. La ricerca subito intrapresa aveva confermato le mie parole. Per anni, dopo questo evento, i soldati avevano continuato a temermi e a guardarmi di sottecchi, aspettandosi nuovi prodigi. Quegli uomini impavidi, che nulla temevano, avevano avuto paura di me e delle tenebre che avrei potuto evocare, nelle quali sarebbero state inservibili le loro spade. Nella luce tremula gettata dal fuoco avevo disposto davanti a me un intero arsenale di strumenti forieri di morte, che avrebbero potuto provocare terrificanti effetti, raccolti da due uomini, due antichi stregoni egizi, i cui scopi erano stati malvagi e che nient'altro avevano desiderato se non seminare il terrore causando la morte con mezzi innaturali e orribili. Toccai alcune spine piccole, nere, avvelenate, che avrebbero ucciso tra gli spasimi chiunque si fosse punto toccandole; possedevo un impasto che avrebbe annientato chi si fosse procurato anche una leggera abrasione, consumandolo come un fuoco interno, tra mille tormenti. Avevo una moltitudine di unguenti, oli, polveri, sali, cristalli, bacche seccate, semi e noccioli, pozioni di ogni tipo; erbe, ramoscelli, misteriose sostanze fibrose che intorpidivano con il loro fumo, e tutte, in una forma o nell'altra, provocavano la morte. A Carthac, a Ironhair, a tutti i loro seguaci avrei insegnato la paura. Avrebbero conosciuto un terrore quale mai si sarebbero figurati di poter sperimentare: la paura di una morte vivente e di un incantesimo; la paura delle tenebre, la paura delle creature maleodoranti e mostruose che strisciavano nell'oscurità; la paura di essere nudi in mezzo a belve feroci di cui non potevano neppure immaginare la forma, esseri raccapriccianti, mai visti prima e mai evocati dai più remoti recessi della mente. Io, Merlino, avrei insegnato loro il terrore. Ma prima di poter realizzare anche in parte il mio piano, dovevo risolvere alcune questioni pratiche. Quanta di quella roba avrei potuto portarmi dietro e come l'avrei portata? Avrei viaggiato da solo, e pertanto sarebbe stato sciocco caricarmi di cose che valesse la pena di rubare. E avrei viaggiato a piedi, una volta raggiunta la Cambria, perché un cavallo rischiava di attrarre un'attenzione inopportuna. Sarei stato inerme e avrei tenuto nascoste sotto il mantello la daga e la spada corta. Speravo di poter viaggiare di notte e mi avrebbero aiutato l'oscurità e la lunga veste scura. Quanta di quella cupa massa di strumenti di morte sarei riuscito a portarmi addosso? Mi venne in mente Lucano e sorrisi. Lucano, che raccoglieva tutto quanto poteva essere usato per ottenere un farmaco - foglie, erbe, radici, bacche, baccelli - aveva escogitato un sistema che gli permetteva di avere le mani libere. Si era fatto confezionare diversi mantelli secondo un suo modello ben preciso: vesti lunghe, di un doppio tessuto rozzo e casalingo, nere, senza maniche, strette in vita da una cintura, aperte sul davanti dal collo alle caviglie, piene di tasche e sacche applicate e sovrapposte le une alle altre. Ricordo con quanto divertimento e orgoglio mi aveva mostrato un esemplare del suo guardaroba. Avevo fatto qualche divertito commento su quell'indumento, ma aveva ignorato le mie osservazioni, invitandomi a pensare non all'apparenza ma alla funzionalità e alla possibilità di portare diverse specie di piante, bacche e foglie, senza timore di perderle o di mescolarle. Lucano era morto da tempo, ma nel mio alloggio di Camelot ancora pendeva uno dei suoi abiti, lì dimenticato da anni, da prima ancora che partissimo per Ravenglass. L'avevo notato soltanto pochi giorni prima, ma non ci avevo badato. Adesso sapevo che era quello ciò che mi occorreva; sarei tornato a Camelot per prenderlo. Contento di aver delineato un itinerario da percorrere, mi dedicai a scegliere gli strumenti micidiali che mi sarei portato dietro nella mia missione. Misi da parte una scatola di ceramica sigillata da un coperchio a perfetta tenuta, contenente il composto verde velenoso. Era l'elemento essenziale: la morte che avevo deciso di infliggere a Ironhair e a Carthac. Sarebbero spirati, consumati da un fuoco interno, crudele e tormentoso, come era avvenuto per lo stregone Caspar. Presi anche i nastri arrotolati che trattenevano gli aculei avvelenati, posti l'uno accanto all'altro con grande cura. A mano a mano la scelta si faceva più difficile. C'erano fiale piene di un veleno così potente da uccidere un intero esercito se il loro contenuto fosse stato versato nell'acqua; scatole di polverine che, mescolate al cibo, producevano nell'arco di pochi istanti convulsioni e bava alla bocca. C'erano fibre che gettate nel fuoco emettevano un fumo in grado di indurre negli astanti uno stato di torpore. Una sola sostanza non mi creava dubbi o imbarazzo: una polvere di zolfo contenuta in una grande scatola. Un mortaio, poi, conteneva una varietà di cristalli rossastri tritati, un composto che, ingerito, paralizzava le membra. L'unico mio rammarico era di averne una quantità limitata. Anni prima ne avevo dissolta una piccolissima dose nell'acqua e poi l'avevo data da bere a un coniglio che si era irrigidito ed era morto in tempo brevissimo. Ma qualche ora dopo, intenzionato a bruciare il povero animale, mi ero accorto che il coniglio "morto", era risuscitato e si era messo a saltellare nel vedermi muovere. Sorpreso da quell'esito, avevo ripetuto l'esperimento con un'altra bestiola e il risultato era stato lo stesso: la paralisi era totale, ma reversibile nell'arco di un'ora. Al secondo esperimento osservai che gli occhi dell'animale non si velavano, come sarebbe accaduto se fosse subentrata la morte, ma restavano vigili, seppure immobili. E quando avevo accostato uno stoppino acceso, avevo notato che le pupille si contraevano e reagivano alla luce. Pur non essendone certo, avevo dedotto che il coniglio non aveva perduto la coscienza ma soltanto la mobilità. Forse la sostanza avrebbe avuto lo stesso effetto sugli uomini. Misi da parte i cristalli rossastri, accertandomi che il coperchio sigillasse in modo impermeabile la scatola che li conteneva. Da ultimo rimossi con cura dal suo imballaggio una maschera umana con la sua corona di capelli, che mi si adattava perfettamente al viso. Rimisi nei due forzieri quello che non avrei portato con me, li chiusi e li trascinai al riparo di un boschetto di alberi e qui, dopo averli coperti con un drappo di cuoio, li nascosi sotto uno strato di rami. Era nel frattempo calata l'oscurità; rientrato nella casupola, accatastai in un angolo quanto ritenevo indispensabile portarmi in viaggio. Il giorno successivo, tornai a Camelot, evitando tutti e soffermandomi nel mio alloggio soltanto il tempo necessario per prendere la veste di Lucano. Fui di nuovo nella mia valle assai prima di notte e nel corso della serata preparai l'occorrente per la partenza. Notai con soddisfazione che la veste di Lucano era molto più capiente di quanto avessi pensato. Era pesante una volta indossata, ma si adattava bene al corpo, e quando riposi i vari oggetti nelle diverse tasche, attento a distribuirli in modo che non facessero rumore tintinnando, osservai che riuscivo a muovermi silenziosamente. Trascorsi l'intera giornata successiva a esercitarmi nel memorizzare in quale tasca e saccoccia avevo infilato ogni singolo oggetto per poterlo prendere senza esitazione. PARTE TERZA VERULAMIUM XVII. La sentinella si irrigidì quando le balzai addosso, ma prima che avesse il tempo di urlare o muoversi, le avevo tappato la bocca con la mano, l'avevo stretta a me e, premendo la punta della daga contro il collo nudo, le avevo sibilato nell'orecchio: «Rischi di morire, amico. Non voglio farti del male. Sono Merlino Britannico. Accenna di sì con la testa se mi credi e se intendi stare zitto». Mosse la testa, e lasciandolo andare, feci un passo indietro. Volse piano il viso verso di me, gli occhi spalancati dalla paura. Non lo conoscevo, ma mi parve che a poco a poco lui mi riconoscesse. «Comand...» cominciò, ma con un gesto della mano gli imposi di fare silenzio. «Chi è il responsabile della guardia stanotte? Rispondi a bassa voce.» «Il comandante Falvo, signore.» «Portami da lui.» Trovai Falvo nella tenda insieme a Benedetto. Rimasero entrambi a bocca aperta nel vedermi entrare e balzarono in piedi con un'esclamazione di gioia, ma scorgendo la mia veste rimasero attoniti. Sapevo di avere un aspetto strano, ma non avevo tempo da perdere in spiegazioni e convenevoli. Era un grande accampamento, pieno di uomini e di cavalli, e vi ero penetrato senza difficoltà, ricorrendo al semplice stratagemma di muovermi nell'ombra e indossare un abito nero. «Benedetto, Falvo» li salutai rivolgendo a ciascuno dei due un cenno della testa. «Le misure di sicurezza che avete adottato sono deboli e insufficienti. Le guardie sono inutili; nessuna mi ha visto entrare. Nessuno si è accorto di me, e sì che non ho fatto alcun tentativo di nascondermi. Ambrogio è qui?» Benedetto mi rispose. «No, Ambrogio è partito questo pomeriggio con Derek e un centinaio di uomini in avanscoperta. Abbiamo combattuto oggi.» «E le guardie si sono guadagnate il diritto di dormire durante il loro turno? Lo so che c'è stato uno scontro. L'ho visto dalla cima della montagna che sorge a nord. Un combattimento inconcludente. Il muro di scudi ha vanificato il vostro sforzo. I nemici vi hanno tratti in inganno inducendovi a seguirli sul terreno a loro più favorevole e vi hanno battuto usando le tattiche dei Romani. Non avete ottenuto niente. Datemi una coppa di vino.» Ci fu un silenzio imbarazzato mentre ascoltavano le mie parole di rimprovero, poi Falvo disse: «Abbiamo soltanto dell'idromele. Ti va bene?». Annuii. Aveva l'aria abbattuta, ma senza aggiungere altro, si levò per riempirmi un boccale. Sapevo di essere stato duro; forse si aspettava maggiore cordialità da parte mia dopo una separazione di mesi, ma quello che avevo detto era la pura verità. Quel giorno i Danesi avevano avuto la meglio; per tenerci a bada erano ricorsi alla formazione a testuggine delle antiche legioni, disponendosi in file serrate e proteggendosi con i grandi scudi rotondi, in modo da formare un fronte compatto contro i nostri cavalieri, che si erano trovati quindi costretti a caricare su un pendio in salita. La battaglia si era conclusa dopo ore senza una netta vittoria di nessuna delle due parti. Essendomi capitato per puro caso di osservare il combattimento da lontano, mi ero infuriato per la confusione cui avevo assistito e per il fatto che non avevo modo di intervenire. Falvo mi porse il boccale di idromele; lo presi e ne bevvi la metà. «Grazie, Falvo. Quando tornerà Ambrogio? Oppure lo chiamate Merlino? A quanto pare lo fanno tutti.» Sapevo di dire cose antipatiche, ma mi era difficile controllare le mie parole. Falvo mi fissò, aprì la bocca come se stesse per rispondermi, quindi si volse a Benedetto che se ne stava seduto a guardarmi con una strana espressione sul viso e che girò la testa verso di lui per cogliere il suo sguardo, poi si strinse nelle spalle. «Che avete? Perché mi guardi in quel modo, Falvo?» Benedetto brontolò. «Pensavamo che fossi morto. Ne eravamo tutti convinti.» «Non è così, come potete constatare. Perché lo credevate?» «Dal meridione ci è giunta voce che era stato trovato il tuo cadavere bruciato e mutilato» disse Falvo. «Forse qualcuno lo desidera» dissi scuotendo la testa. «Chi ha messo in giro questa diceria rimarrà deluso.» Benedetto non trovò divertente la mia reazione. «Lo si diceva mesi fa e da allora nessuno ha avuto tue notizie o ti ha visto. Ti abbiamo pianto.» «E Ambrogio ha assunto il mio nome. Perché? Dappertutto si dice che Merlino di Camelot è a capo del suo esercito.» Si scambiarono di nuovo qualche occhiata e questa volta fu Falvo a stringersi nelle spalle. «È stato suo desiderio e sua decisione. È convinto che il nome di Merlino susciti paura. Merlino è conosciuto, Merlino ha il rispetto dei guerrieri della Cambria. Ecco perché fin dall'inizio Ambrogio ha combattuto ed è sceso in campo come Merlino. Nessuno si è accorto della differenza. Poi quando si è sparsa la voce che eri morto, giurò che, finché fosse stato in vita lui, tu non saresti mai morto.» Tacque. «Tuo fratello ti stima moltissimo» disse con un tono di voce che sottintendeva che non tutti condividevano quel giudizio. Mi sedetti con un sospiro su una delle sedie davanti al suo scrittoio. «Mi sono tenuto nascosto alla vista degli uomini, ma non alla vita. Sono stato impegnato non meno di voi. Avete sentito parlare della "vendetta di Merlino"?» Benedetto sollevò di scatto la testa. «Sì, tutti ne hanno sentito parlare, senza tuttavia capire di che si trattava. Correvano voci di morti improvvise e stregonerie, di uccisioni e terrori notturni. Sembra che i Danesi e i loro alleati vivano nell'incubo del calar della notte e delle strane creature che strisciano nelle tenebre.» «È vero, ed è quello che volevo. Vivono nel terrore della notte. Mi sono adoperato perché fosse così.» «Tu?» Gli occhi di Falvo ebbero un guizzo di curiosità. «Sei tu l'autore di questi atti di stregoneria?» «Sì, e della paura che ne deriva. Da quasi tre mesi mi aggiro di notte, seminando il terrore.» «Perché sei vestito così?» disse con una lieve esitazione, indicando la mia veste con un cenno del capo. «Serve a nascondermi quando mi aggiro nell'oscurità. In pieno giorno indosso abiti normali.» «Che ci racconti della faccenda della stella? È opera tua?» «Sì. La chiamano "la stella della vendetta di Merlino". Lavoro in mezzo a loro, mi credono un idiota e mi assegnano lavori umili. Porto l'acqua ai cuochi e sbrigo quei lavori che i guerrieri non si degnerebbero di svolgere, ma che sono necessari. E così facendo avveleno l'acqua, avveleno il cibo, a volte anniento un intero accampamento. Quando compio uno di questi massacri, e ho sufficiente tempo, compongo il mio messaggio: otto cadaveri disposti intorno a un falò, con la testa tra le fiamme e i piedi all'esterno, a raggiera, in modo da formare una stella a otto punte. Altre volte uccido le guardie o gli ubriachi che incontro nei boschi di notte. Con questi uso aculei avvelenati e lascio i cadaveri dove si trovano in attesa che qualcuno, prima o poi, vi inciampi. Lo scopo è stato, e tuttora è, di seminare il terrore. Talvolta per accentuare la suggestione mi sono mostrato avvolto da una nuvola di fumo, terrorizzando gli ubriachi che già erano spaventati a forza di sentir narrare le mie gesta. Dico loro che sono la morte, la morte latrice della "vendetta di Merlino".» Benedetto scoppiò a ridere, ma si percepivano la tensione e il nervosismo. «Santo cielo, Merlino, per poco non ci ho creduto...» «Aspetta.» Mi levai e mi diressi verso un angolo buio, superando un fuocherello che ardeva in un cesto di ferro sulla nuda terra. Lì, voltando loro la schiena, tirai fuori dalla veste la maschera dello stregone, la applicai al viso, sistemai le ciocche scomposte e abbassai il cappuccio. Estrassi quindi da un'altra tasca un po' di zolfo, mi voltai e mi avvicinai al fuoco, tenendo la testa china. Gettai tra le fiamme la polvere sulfurea e quando la fiammata e le scintille si spensero e tutto intorno si levarono spire di fumo, avanzai verso di loro. Sembravano paralizzati tanto erano rigidi, pietrificati dalla paura, intenti a fissarmi con orrore, capaci soltanto di vedere le mostruose fattezze della mia maschera. Rimasi in silenzio, quindi con voce sepolcrale intonai: «Sono la morte, latrice della "vendetta di Merlino"!». Poi mi tirai indietro il cappuccio, mi tolsi la maschera e aprii i lembi della tenda per far uscire il fumo acre e pungente. Nessuno dei due si mosse e continuarono a guardarmi attoniti e sgomenti. «Naturalmente,» dissi «voi non cadreste nell'inganno. Ma i Danesi sono pagani e si lasciano terrorizzare dalle cose e dalle creature che pensano di non poter abbattere con un'arma. Credono nei demoni e nei mostri che dimorano nelle tenebre. Io alimento le loro paure e mino la fiducia che hanno nella propria invincibilità. È una pagliacciata, ma efficace.» Benedetto parve tranquillizzarsi, ma quando parlò, la sua voce era tesa. «Sì,» mormorò «una pagliacciata, forse, ma puzza di stregoneria e assassinio. Che cos'era tutto quel fumo... e quella fiammata?» «Basta gettare una certa polvere sul fuoco: ecco tutto.» Falvo emise un sospiro a lungo trattenuto che gli uscì dalla bocca come un sibilo. «Be', ci hai convinti con la tua dimostrazione... Hai detto che da tre mesi vai di accampamento in accampamento a spaventare i Danesi in questo modo.» Sbuffò con l'aria di mostrarsi divertito. «O sono più coraggiosi o sono più stupidi di quel che credevo. Dal canto mio, credo che me la sarei data a gambe se avessi pensato di avere un simile diavolo alle calcagna. Sei venuto qui a ragguagliarci sulle tue imprese?» «No, sono venuto perché da tre mesi non ho notizie di quanto succede a Camelot? Va tutto bene lì?» «Sì, nessuna novità» disse Benedetto con voce più ferma. «Tutto tranquillo laggiù stando ai rapporti ricevuti due giorni fa; la vita procede regolarmente.» «Quali notizie avete del vescovo Germano e del dibattito di Verulamium? Ne sapete niente?» «Non ci è giunta nessuna voce» intervenne Falvo scuotendo la testa. «Il Concilio sarà da tempo concluso; probabilmente Germano è ritornato in Gallia.» «Il vescovo Enos? È passato di qui? Vi ha inoltrato qualche notizia?» Vidi che i due scuotevano la testa in segno di diniego. «E Artù? Che cosa si sa di lui?» Dovetti sforzarmi per mantenere un'espressione imperscrutabile, perché temevo la risposta che avrei potuto ricevere. «Artù è qui» disse Benedetto e subito precisò: «Lo era fino a oggi. È partito con Ambrogio». Il cuore ebbe un balzo di contentezza. «Come sta il ragazzo? Sta bene?» «Benissimo» rispose Falvo ridendo. «Non è più un ragazzo. È un comandante di cavalleria. Grande e forte non meno di te; è cresciuto come una pianta rigogliosa. È molto amato e rispettato dai suoi uomini. Sarai orgoglioso di lui.» «Grazie» dissi abbandonandomi sulla sedia tanto era intenso il sollievo che mi avevano dato quelle parole. «Sono le notizie migliori che avrei potuto ricevere. Avevo il terrore che gli fosse accaduto qualcosa. Era con Llewellyn quando sbarcarono i Danesi di Horsa?» Benedetto annuì. «Ma ci hanno raggiunto non appena siamo arrivati qui. E da allora Artù è rimasto sempre con noi. È un grande guerriero, audace e generoso.» «E di Llewellyn che notizie si hanno? Non è venuto insieme ad Artù?» «Sì, ma è ripartito per stare al fianco di Huw Fortebraccio. Vuoi ancora un po' di idromele?» «No, è ora che vada» dissi scuotendo la testa e alzandomi. «Voglio essere a una buona distanza da qui prima che sorga l'alba. Il mio compito è di compiere la "vendetta di Merlino". Ma prima di andarmene vi chiedo un'altra informazione. Sapete dove si è acquartierato Ironhair? E dove si trova Carthac? Sembra che tra i loro eserciti non ci siano scambi, tranne che ai massimi livelli. Nessuno di quegli stolti in cui mi imbatto sa dove si trovino i loro comandanti.» Alzatosi e avvicinatosi all'apertura della tenda, Falvo ne sollevò i lembi e fissò l'oscurità che avvolgeva l'accampamento. «Ironhair è dovunque, stando ai rapporti. Non sappiamo dove si trova perché non si ferma mai a lungo in una stessa località. Rufio lo chiama l'"uomo del vento" perché passa rapido e improvviso come una folata, e là dove è passato rimangono tracce assai sgradevoli...» Lasciò ricadere i lembi della tenda, poi rivoltosi nuovamente verso di me, si mosse per tornare a sedersi al tavolo. «Carthac invece è vicino. Ha un accampamento permanente in una valle tra le montagne a otto miglia verso occidente da dove siamo noi in questo momento. Una fortezza naturale imprendibile... non ce la faremmo a conquistarla neppure con la cavalleria. Ci sono sette od otto vie d'accesso, ma tutte convergono in tre stretti passaggi, su cui veglia costantemente un nutrito corpo di guardia. I suoi uomini lo credono immortale. È per loro una specie di semidio, seppure di natura malvagia e crudele. Non c'è atrocità che non abbia compiuto, non c'è eccesso cui non si sia spinto; i suoi guerrieri lo rispettano per la sua cupidigia e avidità. A centinaia lo ossequiano, fanatici nell'adulare quell'imbecille. Impossibile avvicinarlo...» Tacque, per un attimo inseguendo altri pensieri, quindi riprese: «Se anche ci riuscissimo, dubito che potremmo ucciderlo. È una forza della natura, una presenza terrificante e travolgente». «Assurdità, Falvo. È un uomo come tutti e deve morire. Intendo ucciderlo... una morte lenta e dolorosa. Per questo sono qui. Ma per ucciderlo devo trovarlo, e dopo averlo trovato, dovrò avvicinarlo. Una volta morto, il vostro compito sarà assai più facile.» Muovendomi per uscire dalla tenda, mi calai il cappuccio fino a nascondere buona parte del viso. «Portate i miei saluti a mio fratello... Merlino... e ragguagliatelo su tutto. Ditegli che la morte di Carthac è il mio primo obiettivo.» Con un lieve sorriso proseguii: «Ditegli che non prenderò nessuna iniziativa per smentire la sua identità. Ditegli che è sempre nei miei pensieri, e lo stesso è per Artù; riferite che spero di rivederli entrambi tra poco, quando tutto questo sarà finito. Addio». Le tenebre mi inghiottirono e nessuno mi vide allontanarmi dall'accampamento. Passarono sei giorni; in una bella mattina luminosa, alle prime luci dell'alba, sedevo appoggiato a uno spuntone roccioso, intento a osservare un accampamento nella valle sottostante. Assaporavo il canto di una allodola mentre tendevo l'orecchio ad alcuni suoni che mi dicevano che un uomo stava salendo dietro a me sul lato opposto del crinale, verso la stessa fenditura nella roccia che aveva attratto la mia attenzione il giorno prima. Pensando di essere solo, il nuovo venuto non si premurava di muoversi con passo leggero. Da un bel po' lo sentivo avanzare scivolando e inciampando nei sassi del letto ripido e secco di un torrente. Ero arrivato sulla cima del crinale la sera precedente e, quando avevo finito di osservare l'accampamento, era troppo tardi per avventurarmi a scendere nell'oscurità che ormai stava calando. Dietro a me il nuovo venuto raggiunse la sommità e si fermò; sentivo il suo respiro affannoso. Era un omone, tarchiato, con la barba grigia. Rimasi in attesa, nascosto alla sua vista, osservando il volo dell'allodola. Sotto di me un nutrito gruppo di uomini entrò nella valle dall'estremità settentrionale, avviandosi verso l'accampamento. Mi giunsero il suono di uno scatto metallico e il borbottio dell'uomo che dietro a me si levava con cautela per portarsi con la testa nella fenditura della roccia e osservare, senza essere visto, l'accampamento. Da dove sedevo avrei potuto sfiorarlo, se avessi allungato la mano. «Ho fatto un sogno la notte scorsa» dissi sottovoce. Seguì il brontolio di chi, colto di sorpresa, ha un sussulto di paura, poi un istante di tensione in cui trattenne il respiro immobilizzandosi, quindi un'esclamazione soffocata di sollievo e il suono di un corpo che si afflosciava a terra. «Merlino, figlio di puttana. Sei ammattito. Vuoi farmi secco. Che razza di stregoneria è questa?» Mi piegai di lato e, tendendo una mano a Derek di Ravenglass, lo aiutai a issarsi attraverso la fenditura. «Attento!» lo ammonii. «Il terreno è scosceso quassù, ma nessuno può vederci. Siamo sotto la cresta.» Si sedette respirando pesantemente, si tolse l'elmo, lo ripulì con la manica dell'abito e si deterse il sudore dalla fronte. Soltanto dopo che si fu rimesso l'elmo ed ebbe ripreso a respirare regolarmente, si volse verso di me, emettendo un breve fischio. «Falvo e Ben mi hanno detto che eri passato da loro, ma in nome del cielo, che cosa ci fai qui?» «Ci ho passato la notte.» Con un cenno della testa indicai il sottostante accampamento. «Carthac è laggiù e ho intenzione di fargli una visita per porre fine alla sua ignobile vita. Non te l'hanno riferito? Per questo sono venuto in Cambria. Che cosa ci fai tu qui? Anche tu devi avere passato la notte nei dintorni.» «Sì, ai piedi dell'ultimo tratto del pendio che porta su questa cima.» Guardò la valle ai suoi piedi da un capo all'altro. «Sono venuto per vedere che cosa succede laggiù. Quali parolone useresti per descrivere questa mia intenzione? Pattugliamento di ricognizione?» Non risposi e Derek rimase in silenzio per qualche attimo. «Davvero mi hai visto in sogno la notte scorsa?» mi chiese alla fine. Sorrisi e scossi la testa e lui parve rasserenarsi. «Grazie al cielo, allora! Mi viene il panico al pensiero che tu possa sognarmi. Che cosa ti sei fatto alla mano?» «Che cosa?» Senza accorgermene mi ero massaggiato la mano sinistra con il pollice destro, e ora osservando il lembo di pelle tra il pollice e l'indice notai che era squamoso e grigio. Dominai l'impulso di nascondere la mano e mi sforzai invece di fletterla più volte, «Me la sono scottata una settimana fa. Sta guarendo, ma ogni tanto duole.» Derek distolse lo sguardo. «Non è granché come accampamento, ti pare?» «No, ma ai loro fini è sufficiente. È protetto e sicuro. Quasi imprendibile, direi.» «Che cos'è quella costruzione?» chiese brontolando. Era un edificio lungo e basso, eretto con le pietre staccatesi dalle pareti rocciose e disseminate sul terreno circostante. «Sembra un ovile o una stalla, un riparo per il bestiame, insomma. Che altro ci potrebbe essere? Ci sono pascoli laggiù, ma non un terreno adatto per costruirvi una casa. Deve essere una vaccheria.» «Adesso però la usano come casa. Quanti sono lì dentro? Ne hai idea?» Guardai di nuovo con attenzione prima di rispondergli. Oltre all'edificio principale, si vedevano i ruderi di alcune capanne, poco più che cumuli di pietre impilate a casaccio. Contro la base della parete rocciosa, dall'altra parte della valle, davanti a noi, correva una linea di chiazze verdi, marrone, multicolori. Dopo averle a lungo osservate la notte precedente, avevo concluso che dovevano essere una fila di rozzi rifugi, fatti con rami e arbusti ammassati contro il fianco roccioso della collina e riparati alla meglio con qualche coperta. «La notte passata ho fatto il calcolo che ce ne sono una sessantina all'interno dell'accampamento. Non so quanti altri possano essere dislocati nelle vicinanze, a difesa delle strade di accesso. Probabilmente altrettanti.» Derek sospirò con impazienza. «Ci deve essere un modo per arrivarci.» «Esiste, ma non per uomini a cavallo... è comunque un'impresa ardua. Chi intende compierla deve mettere in conto di combattere. Ci sono tre accessi, forse due percorribili dai cavalieri, ma non prima che le alture sovrastanti siano state ripulite dei nemici. Sarà duro farlo.» Avevo trascorso i cinque giorni precedenti a esaminare per quale strada arrivare all'accampamento. La valle era tra montagne alte e impervie, chiusa da erte pareti rocciose. Tre erano i punti di accesso, stretti passaggi tra pendici scoscese. Lo sapevo perché mi ero arrampicato su quelle rocce cercando di valutare le alture che sui due lati sovrastavano i transiti, standomene per ore disteso sulla pancia a cercare di capire quale fosse la strategia difensiva. Muovendomi da solo, sarei stato in grado, prestando grande attenzione, di penetrare nell'accampamento, ma l'impresa sarebbe risultata impossibile per un qualsiasi manipolo. I montanari forse avrebbero avuto qualche possibilità di farcela, ma gli uomini di Camelot, abituati a muoversi in pianura non avevano alcuna possibilità. Derek ascoltava con aria cupa, succhiandosi a tratti le labbra. Piegai la testa. «Che cosa non va, Derek? Perché sei venuto quassù? Non si addice alla tua età saltabeccare tra queste montagne; neanche alla mia. Ma io ho un buon motivo per trovarmi qui. Mi sono proposto un compito che devo portare a termine da solo.» «Anch'io.» Con la mano indicò un'altra collina verso sud. «Ambrogio è laggiù con Artù. In certi momenti i resoconti di seconda mano non bastano. Sono venuto quassù per accertarmi di persona. Ma non c'è granché da vedere, no?» «Dipende da quello che cerchi, amico mio. A che distanza siamo da loro?» «Duecento passi?» disse dopo un breve calcolo. «Non molto di più, immagino.» «In realtà sono quasi quattrocento, ma sono in discesa, il che vuol dire che il nemico è alla portata degli archi di Pendragon.» Si voltò di scatto a guardarmi, mentre io proseguivo: «Il pendio è ripido, ma non è impossibile percorrerlo. Noi due ce l'abbiamo fatta, ciascuno per conto suo. Su questo terreno dove siamo passati in due, possono passare in duecento, e con duecento arcieri collocati qui, quell'accampamento diventa una trappola mortale. Più avanti nella giornata scenderò in modo da arrivarci al calar della notte, quando sarà difficile che mi vedano. Mi tratterrò fino alle prime luci dell'alba per capire come funziona l'organizzazione, e domani - domani sera — cercherò di avvicinarmi a Carthac. E allora sarà un uomo morto». «Come puoi esserne così sicuro, Merlino? Quello non è un essere umano, è una creatura disumana. Dicono che lo protegge un incantesimo, che gli dèi stessi vegliano su di lui, che nessuna arma inventata dagli uomini potrà ucciderlo.» Lo fissai, le sopracciglia levate. «Superstizioni, sciocchezze. Sono sicuro che non ci credi.» Derek si strinse nelle spalle e abbassò la testa, imbarazzato. «Non lo so, Merlino. Ma combatte come nessun altro. Non sarà facile annientarlo.» «Non voglio che la sua morte sia facile, ma morirà comunque, se avrò la possibilità di avvicinarmi a lui. Quando incontrerai Ambrogio?» «Oggi, verso la metà del pomeriggio, ai piedi della montagna.» «Digli dove mi trovo e illustragli il mio piano. Poi conduci qui Huw Fortebraccio e i suoi arcieri. Sono a grande distanza?» «Huw non è lontano, ma circa un migliaio sono andati con Llewellyn.» «Conducili da questa parte, e avvertili di portare frecce in grande quantità: devono bastare per un assedio di parecchi giorni. Di' ad Ambrogio di disporre i suoi soldati in prossimità dei tre accessi all'accampamento. Morto Carthac, i suoi uomini saranno carne da macello. La morte del "capo immortale", distruggerà in loro ogni volontà di combattere e resistere. Avverti Llewellyn che i suoi arcieri, non appena saranno stati annientati gli uomini dell'accampamento, dovranno ripulire dei nemici anche le alture prospicienti gli accessi. Non incontreranno grande resistenza. Hai portato del cibo?» Annuì. «Allora mangiamo» dissi prendendo le vettovaglie dal pesante sacco ai miei piedi che, oltre alle provviste, conteneva anche il lungo mantello, le sostanze e gli strumenti magici. Derek guardò il grosso involto. «Intendi portarti laggiù quel peso?» «Certamente» risposi sorridendo. Sul suo viso era comparsa un'espressione severa. «Che cosa contiene?» «Varie cose, soprattutto vestiti di riserva» spiegai stringendomi nelle spalle. «Stronzate! Troppo pesante per contenere soltanto abiti. Probabilmente vi hai racchiuso cose pericolose. Se qualcuno se ne accorge, sarai ucciso.» «Non accadrà, non è mai accaduto in questi tre mesi.» «Ma eri solo. È un sacco troppo voluminoso, un invito ai ladri. Oppure te lo vuoi portare dietro mentre compi la tua missione di morte?» Aveva ragione. Era stata mia intenzione nasconderlo, una volta arrivato ai piedi dell'altura, ma la valle era piccola, e il viavai dei soldati, intenso. Vedendo la mia esitazione, Derek riprese a parlare. «Sei deciso a raggiungere l'accampamento, lo so. Se non ucciderai Carthac, morirai, e sarà la tua fine. Anche se ci riuscirai, probabilmente morirai, perché i suoi fedeli non ti lasceranno andare via illeso. Quindi con tante probabilità avverse, perché vuoi rendere l'impresa più rischiosa di quello che è, trascinandoti questo peso? Assurdo che tu muoia per il bagaglio che ti porti appresso...» Tacque e io non risposi. «Lo prendo io, Merlino, lo riporto nel nostro accampamento. Lo metterò al sicuro: non lo aprirò e non permetterò a nessuno di aprirlo. Se il tuo dio cristiano sarà così misericordioso come sostengono i suoi fedeli, e da lì uscirai vivo, lo ritroverai intatto.» Strappai un pezzo di pane dalla pagnotta che mi ero portato e per un po' rimasi in silenzio, pensoso, prima di accennare di sì con la testa. «Così sia» dissi. «Prendilo. Ma non azzardarti ad aprirlo, Derek, e veglia su questo involto con la cura con cui veglieresti su tua moglie o tuo figlio. Ricorda la "vendetta di Merlino". Ti giuro che in quel sacco c'è veleno sufficiente a sterminare tutta la popolazione di Camelot!» Non avrei dovuto mangiare quella mattina, perché rimasi intossicato da qualcosa, forse dalla carne affumicata. Strano che non avessi annusato l'odore di guasto. Come avevo potuto essere così sventato? Solo in seguito mi venne in mente che forse sulle mie dita erano rimasti attaccati alcuni residui dei veleni che avevo maneggiato mentre li inserivo nelle fiale che mi portavo ovunque. I primi crampi, ancora lievi, mi colsero parecchie ore più tardi, prima che mi incamminassi lungo l'erta discesa e quando ancora Derek era con me. Stoltamente non ci feci caso, sicuro che si sarebbero attenuati fino a scomparire. Si acuirono invece, sia per intensità sia per frequenza, sicché, arrivato a circa metà strada, stavo malissimo. Faticavo a camminare e per poco non feci una brutta fine quando, chino per vomitare, mi scivolò il piede. Caddi in avanti e privo di forze non riuscii a frenare la caduta. Mi bloccò uno spuntone di roccia a breve distanza dal ciglio di un burrone che si spalancava sotto di me. Rimasi lì aggrappato a lungo prima di avere la forza di levare la testa e guardarmi intorno. Le immagini erano confuse davanti ai miei occhi e le cose si dissolvevano se cercavo di metterle a fuoco. Mi trascinai fino a una lieve conca tra due piccoli poggi erbosi e lì rimasi ansimando, finché non ripresi a vedere distintamente. Non c'erano ripari in quel tratto di terreno; il pendio non offriva nascondigli. Se anche fossi stato in perfette condizioni fisiche, avrei dovuto muovermi con grande circospezione, strisciando al suolo come un serpente. Ma in quello stato, dilaniato da atroci dolori allo stomaco, la vista annebbiata, tormentato da continui conati di vomito, procedere era impensabile. Non avevo altra scelta che restarmene in quella conca, relativamente al sicuro dagli sguardi nemici. Non lontano, poco sotto, una macchia di cespugli mi avrebbe fornito un riparo migliore, ma per raggiungerla dovevo superare lo spuntone di roccia dal quale non ero per poco precipitato, e non sarei stato in grado di farlo prima di aver ripreso il controllo dei muscoli doloranti. Poco dopo cominciai a sudare così copiosamente che in breve i miei abiti furono fradici. Mi rendevo conto che a tratti perdevo conoscenza. Nei rari intervalli di lucidità riuscivo persino a cogliere il ridicolo di quella situazione: io, il grande avvelenatore, mi ero avvelenato da solo. Ed eccomi lì, sul pendio di una collina con ai piedi una schiera di uomini che, se avessero saputo chi ero, mi avrebbero spellato vivo. Sapevo che, in quel mio stato di prostrazione e sofferenza, non ero in grado di pensare con coerenza, e, nonostante questo, la parte sana di me riusciva persino a sorriderne. Fui sopraffatto da un conato di vomito che mi lasciò esausto e ansimante, e dopo qualche minuto svenni. Quando mi ripresi, sentii la pioggia che mi batteva sul viso. Mi rinfrancò al punto che presi a scendere lungo il fianco della collina. Ero debolissimo e mi pareva di avere la testa vuota, ma capivo che, muovendomi a tentoni e inciampando, facevo troppo rumore. Dicono che gli antichi dèi proteggano gli stolti, i bambini e gli ubriachi; e quel pomeriggio qualcuno protesse in me sia lo stolto, tale mi giudicavo per la mia imprudenza, sia il bambino, ne avevo la debolezza, sia l'ubriaco perché procedevo barcollando quasi fossi in preda all'ebbrezza. La pioggia si fece più forte: cadeva con violenza da nubi gonfie e basse che sembravano aderire alle pendici delle montagne e delle colline; era un punto a mio favore perché mi nascondeva e, senza intoppi, raggiunsi la base dell'altura. Ma, quando vi arrivai, ebbi un nuovo collasso; il mio corpo era percorso da spasmi dolorosi e conati di vomito che lasciavano nella mia bocca l'amaro sapore della bile. Sudavo copiosamente e sapevo di avere la febbre alta. Quando ripresi conoscenza, era buio, aveva smesso di piovere, e mi giungeva il suono di voci non lontane. Non sapevo dove mi trovavo rispetto al punto che mi ero proposto come meta; mi parve che la lingua fosse celtica, ma nei momenti di lucidità mi rendevo conto che forse avevo solo sognato di comprenderli. Mi comparivano davanti agli occhi immagini di Danesi alti, massicci, biondi, armati di asce, con gli elmi ornati di corna di toro, intenti a parlare fluentemente con me nella mia lingua. Sapevo che era un delirio, sapevo anche che faceva freddo, e sebbene mi sentissi staccato dal corpo, mi figurai di emergere dai cespugli che mi nascondevano come uno schermo, di strisciare fino alle fiamme dei fuochi che certamente erano stati accesi, di chiedere in latino - una lingua che, usata in quelle circostanze, sarebbe stata di per sé una condanna a morte - il permesso di riscaldarmi e riposare. Mi accoccolai invece su me stesso, rabbrividendo; alla fine dovevo essermi addormentato. Mi risvegliai perché qualcuno mi scosse bruscamente con il piede. Spalancando gli occhi alla luce del sole, mi trovai su un mucchio di erba, ben consapevole di essere stato scoperto. Imprecando cercai di alzarmi, ma una mano rude mi afferrò per i capelli e mi piegò la testa all'indietro. Un ginocchio mi premeva su un fianco; qualcuno mi spinse e caddi battendo la schiena su una pietra appuntita. Scorsi confusamente una sagoma piegata su di me; in mano impugnava una daga pronta a colpire. Chiusi gli occhi sapendo di essere perduto. Poi qualcuno, in un tono di voce che manifestava stupore e incredulità, pronunciò il mio nome. Alcuni attimi dopo, mi sentii afferrare sotto le ascelle e trascinare. Quando il movimento si interruppe, le stesse mani mi misero in posizione seduta, la schiena appoggiata a un albero o a un masso. Percepivo la presenza di qualcuno accucciato al mio fianco. Aprendo gli occhi riconobbi Turoc, l'aratore, un celta cristiano originario della Cornovaglia, venuto a Camelot l'anno in cui vi ero arrivato con Cassandra. Era una delle otto spie che avevo personalmente spedito, otto mesi prima, in Cornovaglia per accertare le mosse di Ironhair. Ora, inginocchiato davanti a me, mi scrutava ansiosamente. Riuscii a chiamarlo per nome e il viso gli si rasserenò per il sollievo. «Merlino, in nome di Dio, che cosa ci fate qui? Per poco non vi ho ucciso. Stavo per colpirvi con la daga quando vi ho riconosciuto. Che cosa avete? Non state bene. Che cosa ci fate qui? Siete un uomo morto se qualcuno vi vede.» «Malato» sussurrai. «Avvelenato. Ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male, ieri.» «Riuscite a camminare?» «Non lo so, Turoc» risposi scuotendo la testa. «Non credo; ho la febbre alta.» Si mise seduto guardandosi attorno. «Per fortuna, non c'è nessuno nelle vicinanze.» Mi lanciò un'occhiata. «Siete congelato e i vostri abiti sono fradici di pioggia. Andrò a cercare qualche panno asciutto e qualcosa di caldo da mangiare. Chissà che per miracolo non sia rimasto dello stufato o almeno una tazza di brodo. Aspettatemi qui e non muovetevi. Nessuno vi vedrà se starete qui. Forse mi ci vorrà un po'. Nel frattempo liberatevi di quelle vesti e indossate queste.» Si slacciò l'ampio mantello e me lo avvolse intorno dopo avermi tolto con gesti rapidi i panni bagnati. «Per lo meno è asciutto» brontolò. «Questi li metterò ad asciugare vicino al fuoco» disse facendone un fagotto. «Sono qui da un mese e questo mi da il diritto di avere un cantuccio per me. Aspettate qui e rimanete immobile. Tornerò il prima possibile.» Lo guardai che si allontanava, camminando tranquillamente nella luce del mattino e portando sotto il braccio il fagotto dei miei abiti. Chiusi gli occhi e mi abbandonai al piacere di essere avvolto in un indumento caldo e asciutto. Turoc mi aveva spogliato di tutti i miei abiti e non aveva fatto commenti al vedere che la mia pelle era segnata e lacerata in più punti. Probabilmente aveva pensato che le aree di epidermide morta e bianca fossero l'effetto del gelo che mi aveva prostrato. Ritornò prima di quanto mi aspettassi; mi porse un boccale di argilla pieno fino all'orlo di un brodo di carne salata nel quale galleggiavano alcune verdure. Lo sorseggiai piano, timoroso che lo stomaco si ribellasse al cibo, ma non fu così. Al primo sorso, con il buon sapore sulla lingua e contro il palato, si risvegliò in me la fame. Turoc dovette strapparmi il boccale di mano per impedirmi di berne il contenuto troppo in fretta con il rischio di vomitare e peggiorare il mio stato. Imponendomi un po' di decoro, sorseggiai il brodo lentamente assaporandone ogni goccia, mentre sentivo che mi tornavano le forze. Mi pareva di riprendere a vivere. Turoc, che fino a quel momento era rimasto a guardarmi attentamente, mi indicò ora il fagotto degli abiti che aveva riportato indietro. «Asciutti» brontolò. «Non puliti, ma asciutti. Metteteveli subito. Ancora non mi avete detto perché siete qui e come ci siete arrivato.» Puntai un dito verso il pendio dal quale ero sceso. «Sono venuto da lì; voglio trovare Carthac. Dov'è?» Sollevò le sopracciglia, ma mi rispose senza reticenza e con un grugnito di sorpresa. «Non si trova nell'accampamento. È partito ieri prima di mezzogiorno con un gruppo di uomini; sono diretti a saccheggiare qualche località. Non è ancora tornato.» Una notizia infausta, ma dovetti inghiottire la rabbia e la delusione. «Dov'è andato? Quanti uomini ha portato con sé?» Turoc chinò la testa di lato facendo una smorfia. «È partito con un centinaio di uomini, ma non so qual era la loro meta. Non mi trovavo all'accampamento; stavo sulle rocce che sovrastano l'accesso settentrionale, Che cosa volete da Carthac? Vi ucciderà non appena vi vedrà. È un pazzo scatenato, l'uomo più temibile che abbia mai conosciuto. Nessuno è al sicuro con lui, nessuno. Perfino i suoi capitani lo temono.» «Lo so, Turoc.» Raddrizzandomi sulla schiena, emisi un gemito mentre fitte di dolore mi correvano su e giù per le costole. «Sono qui per ucciderlo, non per essere ucciso. Voglio raggiungerlo.» Si accucciò sui calcagni e mi fissò, scuotendo la testa e scrutandomi da cima a fondo. «Non potete neppure stare in piedi. Come farete a uccidere un uomo che non può essere ucciso? L'ho visto circondato da venti nemici, tutti desiderosi di annientarlo, e ne è uscito con qualche graffio appena.» «Però qualche graffio l'aveva!» «Sì, certamente» rispose guardandomi con aria interrogativa quasi dubitasse della mia sanità mentale. «Ma niente di serio. La ferita più grave era stata causata da una lunga freccia che gli era rimasta conficcata nella coscia destra.» «Uccise il medico che gliela tolse, no?» «Come lo sapete?» chiese sgranando gli occhi. «Non importa come» dissi. «A me basta poterlo graffiare, ecco tutto. E poi morirà, puoi esserne certo.» Scuotendo la testa, Turoc distolse lo sguardo per nascondere la confusione e la preoccupazione. Non c'era logica, a suo avviso, nelle mie parole. Lo capivo. Tesi la mano e riuscii ad afferrargli il braccio, ma mi accorsi che mi era difficile muovermi e coordinare i gesti. «Turoc,» dissi sforzandomi di suonare convincente «abbi fiducia in me. So quello che faccio e so di poterlo uccidere. Una volta morto, i suoi guerrieri si disperderanno come nebbia al sole. Si alimentano della leggenda della sua invulnerabilità e immortalità. Ma non appena lo vedranno cadere, proveranno disgusto per la sua memoria. Ricorderanno il cannibale, non il semidio; il torturatore, non il guerriero. Trovami un posto dove possa vederlo e toccarlo; al resto penserò io.» Scosse di nuovo la testa, con più forza questa volta. «Vi riconosceranno subito e vi uccideranno. Che senso ha?» «Sbagli, amico. Guardami: ti sembro Merlino di Camelot? Osserva la mia barba, i miei abiti. Per poco non mi hai ucciso perché neppure tu mi avevi riconosciuto, anche se mi conosci da quasi vent'anni. Nessuno di quegli uomini mi ha mai visto, e al sentir parlare di Merlino di Camelot pensano a mio fratello Ambrogio, che oggi è l'uomo che fui io un tempo. Portami dentro l'accampamento, Turoc. Non ti chiedo altro. Portami dentro e poi lasciami lì.» «Ma non vi riconosceranno come uno di loro. Sono rozzi e violenti, Merlino, ma non così stupidi da non accorgersi di una faccia nuova tra le loro tende.» «Dirò che sono un messaggero. Dove si trova Ironhair?» «Ironhair? Dio solo lo sa. Dicono che sia con i Danesi, impegnato a combattere nelle terre a settentrione. Non lo vediamo da mesi.» «Manda messaggeri a Carthac?» «Di tanto in tanto, raramente.» «Allora dirò che sono un messaggero, un messaggero ammalato, avvelenato, rimasto vittima della "vendetta di Merlino", mentre mi dirigevo verso questo accampamento. Dirò che mi chiamo...» tacqui cercando di trovare un nome non insolito, che fosse facile da tenere a mente per entrambi. «Mod» dissi ricordando il giovane druido che Carthac aveva assassinato. «Mod va benissimo. Dirai che ti sei imbattuto in me quando sono entrato nell'accampamento venendo da sud e che mi hai visto tremante e delirante per la febbre. Mi conosci da molto tempo e appena mi hai visto ti sei ricordato di me. Sono un pescatore ma anche un guerriero. Nessuna spiegazione su come sia sfuggito alla sorveglianza delle guardie che vegliano su quell'accesso. Viaggio da solo affidandomi alla misericordia di Dio. Sono latore di un messaggio per Carthac da parte di Ironhair. In attesa del suo ritorno, ho bisogno di scaldarmi vicino a un fuoco per recuperare le forze e riprendermi dall'avvelenamento. Una malattia interna, ricorda, non contagiosa. Puoi spargere questa voce?» Annuì con il viso ancora turbato. «Sì, posso farlo, ma non mi piace. Non siete armato. Come pensate di poter uccidere Carthac senza un'arma? Non mi piace, Merlino, non mi piace affatto.» «Non occorre che ti vada a genio, Turoc. Basta che mi porti nell'accampamento. E poi un'arma ce l'ho. Il pugnale che tengo nella bisaccia.» «Questo?» disse con voce sprezzante, prendendo la daga di Varro infilata nella sua guaina. «Sarebbe questa la vostra arma?» Temendo che potesse estrarre la lama sulla quale avevo spalmato uno spesso strato di veleno, lo bloccai bruscamente, allungando la mano per afferrare la daga. «Non mi serve altro. Legami la bisaccia intorno alla vita. Se ti spaventa il pensiero di quello che mi propongo di fare, non dimenticarti chi sono e le cose che certamente hai sentito raccontare su di me. Chiediti anche come mai si fa un gran parlare della "vendetta di Merlino" a proposito dei Danesi e dei mercenari di Carthac morti in Cambria. Come mai, tu che sembri credere all'immortalità di Carthac, dubiti invece che Merlino sia uno stregone?» Si raddrizzò a quelle parole e vidi che segretamente si portava una mano dietro la schiena per compiere un gesto di scongiuro della mala sorte. Attesi finché non riprese a respirare normalmente, poi aggiunsi: «Siamo d'accordo? Se acconsenti, muoviamoci subito. Mi stanno tornando le vertigini». Brontolando si mise in piedi e mi tese la mano per alzarmi. Con il suo aiuto mi levai faticosamente. Vacillavo, ma Turoc mi mise un braccio intorno alla vita e posò la mia mano sinistra sulla sua spalla, afferrandomi saldamente per il polso. «Non temete di appoggiarvi anche con tutto il peso. Ma cercate di camminare, se ce la fate. Non distiamo neppure cento passi dalla casa lunga. Se incontriamo qualcuno, evitate di parlare. Lasciate fare a me.» Ci avviammo; sentivo le gambe molli, quasi fossero prive di muscoli. La testa mi girava e la vista mi giocava strani scherzi. Scorsi diversi uomini che, avvicinandosi a noi, ci lanciavano occhiate stupite e proseguivano per la loro strada. Una sola volta qualcuno chiese a Turoc che cosa avessi, e Turoc recitò la storiella che avevo preparato e che fu accolta con un brontolio e il consiglio di tenere alla larga quel figlio di puttana. Poco dopo entrammo attraverso la porta aperta del lungo edificio. Ricordo che, levando lo sguardo, mi accorsi che il soffitto era a un'altezza maggiore di quanto non sembrasse da fuori e che due alte porte di legno pendevano da cardini arrugginiti e quasi divelti. Ci addentrammo e notai che nel soffitto di paglia erano state praticate rozzamente alcune aperture da cui filtrava la luce del giorno. Mi giunse alle narici l'odore acre del fumo di legna; poi fui deposto per terra e mi sentii avvolto da ondate di calore. Aprendo gli occhi mi accorsi di essere vicino a un fuoco acceso sotto una delle aperture nel tetto. Turoc rimboccò intorno a me le falde del suo ampio mantello. Risuonavano numerose voci intorno a me, e tra queste predominava quella di Turoc che ripeteva la storia delle mie peripezie. Mi conosceva da anni, assicurava; era inciampato sul mio corpo quella mattina per caso e per fortuna. Se non mi avesse trovato, probabilmente sarei morto, ma portavo da Ironhair un messaggio per Carthac. Ero sopravvissuto alla "vendetta di Merlino" che si era abbattuta su un accampamento giù, in pianura, disse a quanti lo ascoltavano. Per strada mi ero quasi disintossicato dal veleno. Ora avevo bisogno di riprendere le forze, e poiché Carthac non era ancora rientrato, la cosa migliore era che dormissi fino al suo ritorno. Ci fu un coro di borbottii, e meraviglie delle meraviglie, mi addormentai e dormii cullato dal crepitio e dal calore delle fiamme. «Carthac! Carthac! Carthac! Carthac!» Dapprima parve un sogno, ma mentre le voci diventavano sempre più forti fino a somigliare a un boato, aprii gli occhi e mi vidi circondato da una foresta di gambe. Il semidio era tornato presso i suoi fedeli che lo adoravano. Lentamente, con cautela, mi levai in piedi, stringendomi intorno il mantello e abbassandomi il cappuccio fino a coprire quasi completamente il viso. Quel pandemonio rischiava di travolgermi, ma lucidamente mi rendevo conto che forse mi si presentava l'occasione propizia per avvicinarmi alla mia preda: muovendomi in mezzo a quel turbinio di uomini selvaggi ed esultanti, avevo buone probabilità di accostarmi al bersaglio quanto bastava per poterlo colpire. Sapevo che subito dopo sarei stato ucciso, ma ero venuto a patti con quell'eventualità prossima alla certezza. Sapendo di aver contratto la lebbra, non desideravo vivere, e mi sembrava che avrei impiegato bene la mia vita, pur sacrificandola, se avessi liberato il mondo da quel mostro di Carthac. Sebbene non l'avessi ancora visto, il gran strepito mi diceva che era entrato in quella specie di caserma nella quale mi aveva trascinato Turoc. Guardandomi intorno, incerto sulle gambe, mi accorsi che tra me e il fuoco stavano alcuni uomini. Ecco la risposta all'interrogativo su come avvicinarmi senza suscitare sospetti. Non appena lo avessi localizzato, avrei gettato tra le fiamme un po' di zolfo creando un diversivo e forse anche seminando il panico. E mentre tutti erano disorientati dal fumo e dallo scoppio, avrei colpito. Mi portai lentamente sulla destra, e allora lo vidi: una figura grottesca, orribile e gigantesca, una specie di ciclope ghignante; calvo su un lato del cranio dove una mostruosa cicatrice lo sfigurava e sembrava proclamare che quell'essere non apparteneva al genere umano. Aveva perso l'occhio sinistro e al suo posto si vedeva una massa ripugnante di carne rugosa. La testa era sformata, appiattita e distorta fin dalla nascita; aveva un rigonfiamento sul lato destro, dove da ragazzo era stato colpito dal calcio di un cavallo che aveva peggiorato la sua innata bruttezza. L'unico occhio era grande e azzurro, quasi a mostrare come avrebbe potuto essere se la natura non si fosse presa tragicamente beffa delle sue fattezze. Quel luminoso occhio azzurro fu la prima cosa che scorsi di lui, prima di notare la mostruosità degli altri suoi tratti. Poi mi accorsi delle sue dimensioni. Torreggiava su tutti, le spalle possenti e il petto glabro, privo di armatura. Indossava una veste senza maniche fatta con il vello di un animale; le brache erano dello stesso materiale. Un pesante paio di stivali gli copriva i piedi e arrivava fino ai polpacci; alla vita portava una larga cintura ornata con borchie d'oro. Le braccia, grosse e forti, luccicavano quasi fossero state spalmate d'olio; i bicipiti erano stretti in bracciali di rame. Muovevo le mani sotto il mantello per aprire la bisaccia di cuoio nella quale avevo riposto quanto mi rimaneva della polvere di zolfo: circa due manciate. Ne presi un po' con la destra, poi scorsi la spada che impugnava. Con una risata sonora e selvaggia la roteò sulla testa e gli uomini intorno si scansavano in gran fretta. Uno di loro rimase ferito al petto e il sangue prese a sgorgare. Tre volte roteò l'arma, poi si erse solitario nel mezzo della sua cerchia di fedeli, scoppiando in un ghigno raggelante quasi a sfidare chiunque intendesse affrontarlo. Mi parve che il fracasso intorno cessasse all'improvviso e calasse un tetro silenzio mentre in me subentrava la certezza che in qualche modo, impensabilmente, si era impossessato della mia spada. Sapevo che era impossibile perché l'avevo lasciata nel capanno nella mia piccola valle, dato che per l'impresa che mi accingevo a compiere usarla sarebbe stata un'inutile ostentazione. Eppure eccola lì, impugnata dal gigantesco Carthac. Ero intento a fissarla incredulo, quando la sua risata si trasformò in un urlo di sfida trionfante. Sollevando il braccio sinistro, prese ad agitare qualcosa sopra la testa. Guardai, e la mia mente si rifiutò di accettare quella vista. Lanciò un altro urlo, questa volta pronunciando il mio nome: «Merliiiino!». Era la testa di mio fratello; la testa di Ambrogio. La scagliò lontano e mi parve, vedendola roteare nell'aria, che il tempo si fosse fermato. I begli occhi azzurri erano spalancati e spenti; le ciocche bionde erano macchiate di sangue. Mi accorsi che si era lasciato crescere la barba durante la campagna militare, una barba grigia come la mia. Poi la testa cadde tra le fiamme, rimbalzando pesantemente tra i tizzoni. Spinto dal cieco istinto di salvare mio fratello dal fuoco, mi lanciai in avanti, mentre un urlo strozzato mi saliva nella gola. Inciampando nell'orlo del mantello, nell'impeto della corsa, andai a sbattere con la spalla contro l'uomo che stava davanti a me. Nel momento di cadere, la bisaccia che tenevo in mano, contenente la polvere solforica, finì sul falò. Esplose una fiammata gigantesca con un boato assordante, si sprigionò una terrificante pioggia di scintille e tizzoni, si levò una nuvola di fumo. Avevo serrato gli occhi, ma l'accecante vampata penetrò attraverso le palpebre abbassate. Gettato lontano il mantello, in preda al furore, mi tastai alla vita per impugnare la daga e la strinsi con tanta violenza che la mano mi si indolenzì. Dimentico della confusione caotica intorno a me, mi levai in piedi e attraversando la nuvola di fumo mi lanciai contro Carthac. Lo trovai fermo nel punto in cui lo avevo visto, che mi fissava a bocca spalancata mentre mi avventavo su di lui; non cercò di evitarmi e prima che potesse compiere alcun gesto avevo affondato la lama nel suo petto. Emise uno strano suono simile a un miagolio; come unico movimento di difesa mi scansò con le mani, una delle quali ancora stringeva la spada che ora sapevo essere quella di Ambrogio. Accecato dal dolore, dall'incredulità, dall'odio, gli strappai dal petto il pugnale che vi avevo conficcato e cercai di affondarlo nell'unico suo occhio, ma lui girò la testa prima che io avessi potuto penetrargli fin dentro il cervello. Lo accecai però, colpendolo nell'orbita. Mi sollevò con una mano sola e mi gettò tra le fiamme. Bruciavo - la mano sinistra che era finita tra i tizzoni, le braccia, i piedi, le gambe - e barcollando, urlando di dolore, mi allontanai dal fuoco. Raggiunsi il muro dell'edificio e lì mi accovacciai, togliendomi di dosso i carboni ardenti che si erano attaccati alla carne e liberandomi dei brandelli infuocati della tunica che era il mio unico indumento. Rimasi lì, tremante di dolore, incapace di formulare un pensiero coerente. Dopo qualche tempo, al di sopra dei miei gemiti, mi giunse l'urlo di Carthac, un ululato disumano di dolore, che crebbe fino a diventare un ruggito. Ignorando le acute sofferenze che mi affliggevano, spinto dal desiderio di vederlo, mi sforzai di levarmi premendo la schiena contro il muro e lanciai uno sguardo verso il punto dal quale provenivano quei lamenti. Il fumo cominciava a diradarsi, e lo scorsi barcollare all'estremità opposta dello stanzone in prossimità delle porte aperte, le mani strette intorno alla testa; si muoveva vacillando e inciampando contro tutto ciò che gli si parava davanti. Cadde e riuscì ad alzarsi di nuovo, continuando a urlare. Eravamo rimasti soli lì dentro e nessuno veniva a vedere che cosa stesse accadendo. Dolorante, ma riacquistando forza a ogni passo, avanzai lentamente senza perderlo di vista per un attimo. Ricadde sulle ginocchia; scorsi vicino a lui la spada di Ambrogio, fatta con il metallo della Pietra del Cielo. Sentii ravvivarsi in me la forza e, incurante delle scottature sul mio corpo, inconsapevole della debolezza, mi avvicinai fino ad afferrarla. La impugnai con la destra e, stringendo il polso con la sinistra ferita dalle fiamme, levai la lama e l'abbattei sulla testa deforme con un unico colpo che assorbì tutto il vigore che ancora mi rimaneva. Caddi sul suo cadavere. Trovai poi la testa di mio fratello. Era rotolata in un angolo dello stanzone e il fuoco l'aveva soltanto lambita. La raccolsi tra i singhiozzi, ricordando tutto ciò che avevo amato in lui. Mi parve che il cuore mi si spezzasse nel petto per il dolore, un'angoscia profonda e tormentosa, che superava ogni altra sofferenza. Piansi e piansi. Piangevo per Ambrogio, piangevo per Tressa e Dedalo, piangevo per tutti gli amici e le persone care che avevo perduto. E mentre mi abbandonavo alle lacrime nell'oscurità di quel luogo in rovina, una pioggia di frecce scagliate dalle colline con gli archi di Pendragon uccise ogni cosa vivente si muovesse nella valle. Non tutti quelli che si erano trovati nello stanzone erano morti. Molti erano fuggiti prima che iniziasse l'attacco degli arcieri, in preda al terrore di Merlino lo Stregone, la cui fama di mago, malvagio e demoniaco, esperto negli incantesimi, si era diffusa in tutta la Britannia. Non era certamente servito a sedare il terrore il fatto che Carthac, tornato all'accampamento portando come cimelio la testa di Merlino, l'avesse gettata nel fuoco: infatti dalle fiamme, che si erano levate alte con un boato di tuono, scatenando un turbine di scintille ed emettendo un fumo irrespirabile, era emerso Merlino. Merlino era ritornato in vita e aveva ucciso l'invincibile. Il giorno dopo, l'esercito di Camelot era entrato nella valle fortificata di Carthac e aveva fatto prigionieri i soldati rimasti: furono costoro, una volta che la paura si fu un po' placata, a dire di aver visto con i loro occhi rinascere dalle fiamme Merlino lo Stregone. XVIII. «Merlino? Sei tu?» Sorrisi e, voltandomi, vidi una forma alta che si stagliava contro la luce guizzante delle torce infilate negli anelli tutto intorno all'enorme teatro. La figura lontana retrocesse di poco, poi riprese ad avvicinarsi, reggendo in mano una delle torce. Rimasi immobile, mentre il tonfo dei suoi passi risvegliava echi profondi in quell'ambiente vuoto. Poi la voce chiamò di nuovo. «Sei tu, vero? Lo so perché nessuno avrebbe il coraggio di venire qui nel cuore della notte, alla mercé delle mie guardie sempre vigili. E quando vedo un'ombra scura che si muove nell'oscurità so che non può trattarsi che di mio cugino Caio.» Artù Pendragon era splendido mentre avanzava sul pavimento di marmo. L'alto pennacchio dell'elmo lo faceva apparire ancora più imponente e maestoso di quanto non fosse per natura. Dietro a lui ondeggiava l'ampio mantello. Era bello come il giorno in cui, circa due anni prima, alla testa delle sue truppe era penetrato nella valle dove si trovava allora l'accampamento di Carthac e mi aveva trovato, accoccolato nello stanzone. Lo avevo lasciato, prima di allora, che era un ragazzo: alto, forte, muscoloso, con un volto luminoso di coraggio e lealtà che attirava lo sguardo degli uomini e delle donne, ma pur sempre un ragazzo. Quella mattina, in cui di nuovo era entrato nella mia vita, la metamorfosi si era già compiuta: avevo visto davanti a me un uomo, un veterano esperto nell'uso delle armi, un guerriero che conosceva il suo mestiere. Non sapeva ancora di essere diventato, dopo la morte di Ambrogio, il comandante legato delle forze di Camelot. E questa notte si mostrava con la sicurezza e la disinvoltura del condottiero vittorioso. Mi commosse vedergli addosso l'armatura di cuoio nero a più strati, lucido e sagomato, che un tempo era stata mia e prima ancora di mio padre. Eravamo tutti uomini di alta statura e dalle spalle larghe. L'armatura, fatta appositamente per mio padre nel momento della sua massima potenza, aveva una decorazione di rosette d'argento battuto; era stata la tenuta cerimoniale di un comandante di cavalleria romano vissuto all'epoca di Flavio Stilicone che, in quanto reggente dell'impero romano d'Occidente, aveva ripreso la strategia di Alessandro. Era perfetta indosso ad Artù. Nell’avvicinarsi il mio giovane cugino levò una mano per togliersi l'elmo di cuoio rafforzato e verniciato, ornato in cima da un pennacchio di crini di cavallo e ciuffi di piume bianche e nere, trattenuto da un anello d'argento lavorato. Il volto gli splendeva e il sorriso mostrava una fila di denti bianchi mentre mi stringeva a sé con il braccio che reggeva l'elmo, attento a tenere lontano l'altra mano che impugnava la torcia. Restituii la stretta, con il cuore gonfio di orgoglio, poi lo allontanai. Chinò la testa di lato e negli occhi del color dell'oro brillò una luce divertita. «Che succede?» chiese con voce scherzosa. «Hai l'aria di essere stato colto a combinare qualche marachella che forse non incontrerebbe l'approvazione del vescovo Enos.» Si guardò intorno, tenendo il braccio che reggeva la torcia e guardando a tratti l'altare vicino a lui. «Che cosa ci fai nel santuario? Pensavo che, compiuta la consacrazione, soltanto i servi di Dio potessero entrare qui.» Scossi la testa e assunsi un'espressione afflitta e rammaricata. «Intendi alludere che non sono un servo di Dio, Artù?» «Mio cugino Caio lo è, questo è sicuro. Ma lo è anche Merlino il Mago? Qualcuno potrebbe dubitarne» disse impassibile. Sorrisi e, così facendo, percepii la pelle tesa della cicatrice sull'angolo sinistro della bocca, sicché parve che invece di sorridere facessi una smorfia. «Sbaglierebbe a dubitare. Sono qui su incarico del vescovo Enos per portare a termine quello che farebbe lui stesso se non fosse impegnato con i suoi pii confratelli. Piuttosto, che ci fai tu qui?» «Ho ispezionato il corpo di guardia; voglio che gli uomini siano all'erta. Sono contenti se il loro capitano da l'impressione di non andare mai a dormire, e lo rispettano: un insegnamento che mi hai impartito tu, se ben ricordi. Hai finito qui? Andiamo a fare quattro passi; la notte è splendida.» Percorremmo la strada dalla quale era venuto. Si rimise in testa l'elmo e ripose la torcia nell'anello dal quale l'aveva levata poco prima; con un cenno del capo salutò la sentinella che se ne stava impettita e immobile come un pilastro. Era quello il primo dei tre giorni della Pasqua, quello che i cristiani chiamavano venerdì santo. Avevamo presenziato alle cerimonie che commemoravano la Crocifissione di Cristo. Tra due giorni ci sarebbe stata la festività per la Resurrezione della Carne. Mentre emergevamo dai vasti portali facendoci strada tra i capannelli di soldati e altri militari, Artù indicò in lontananza una cittadina. Le luci dei fuochi e delle torce illuminavano un luogo che altrimenti sarebbe stato una distesa vuota e tenebrosa. «Chi l'avrebbe detto che Verulamium avrebbe ripreso a vivere in tempi come questi? Quanti anni sono passati da quando ci sei venuto la prima volta e hai conosciuto Germano? Diciotto?» «Quasi venti» risposi. «L'anno della tua nascita. Mi rammarico soltanto che Germano non sarà con noi a Pasqua.» Il mio amico era morto nella sua diocesi in Gallia l'anno precedente, nell'estate successiva al ritorno da Verulamium, avvenuto nel 447. Non gli avevo più parlato e neppure scritto da quella notte in cui bruscamente avevo preso congedo da lui. Avevo saputo che la sua missione a Verulamium aveva dato buoni frutti; i rapporti, seppur vaghi e non confermati, dicevano che i due vescovi Agricola e Fastidius erano stati pubblicamente censurati, dichiarati apostati e scomunicati, e che si erano prese adeguate misure per ovviare ai danni che avevano disseminato tra le anime fiduciose a loro affidate. Da allora, tuttavia, dopo la morte di Hengist e Vortigern, tutto era cambiato nel nord-est. Da mesi non avevamo notizie di quanto accadeva nella Northumbria e, se anche ci fossero giunte, sarei rimasto sorpreso che fossero di natura religiosa, riguardanti l'eresia di Pelagio o l'ortodossia cattolica. Per quanto ne sapevo, il cristianesimo avrebbe potuto essere stato spazzato via in quella regione. Fino alla morte, Germano si era adoperato per realizzare il progetto che avevamo delineato per il destino di Artù e per la sopravvivenza e la diffusione del cristianesimo in Britannia. La responsabilità di condurli a buon fine era passata a Enos, vescovo di Venta Belgarum nella parte sudorientale, ormai nota come Anglia. «Ci credo» mormorò Artù. «Peccato che non l'abbia conosciuto di persona. Doveva essere un uomo interessante. Guerriero e vescovo: uno strano connubio.» «Sì, ed è stato eccezionale in entrambi i ruoli. Ne avresti tratto vantaggio dal conoscerlo. Gli saresti piaciuto.» «Ti fanno male i piedi e le gambe oggi?» Camminavamo lentamente e Artù adeguava il suo passo alla mia andatura, rallentata dal mio zoppicare. «Funzionano, malgrado tutto» risposi stringendomi nelle spalle. «A volte mi fanno soffrire, ma sempre più di rado.» Quando con forza bestiale mi aveva allontanato da sé, mandandomi a finire tra le fiamme del falò, Carthac, poco prima di morire, mi aveva ferito. Le bruciature, estese e profonde, avevano danneggiato i tendini del ginocchio e del calcagno sinistro, e ne risentivo ancora, sebbene fossi guarito dalle ustioni. Anche la mano sinistra era stata compromessa e ora era contratta e inutilizzabile; erano sparite dalla mia pelle le macchie della lebbra e in quei punti l'epidermide era una cicatrice callosa. Le bruciature al viso mi avevano sfigurato, tanto che il mio amico Llewellyn si divertiva a dirmi che in mia compagnia lui faceva la figura del più bello. Artù continuava a fissarmi, tanto che mi fermai. «Che cos'hai? Conosco quel tuo sguardo. Hai intenzione di chiedermi o di dirmi qualcosa. Quale delle due?» Mentre così dicevo, mi giunse all'orecchio il rumore degli zoccoli di un cavallo che si avvicinava, e subito dopo un cavaliere, fermatosi vicino a noi, scese dalla sella per mettersi subito rigidamente sull'attenti davanti al comandante e porgergli un rotolo contenente un dispaccio. Scossi la testa in silenziosa ammirazione nel vedere come una ferrea disciplina poteva portare al controllo totale del corpo e dei muscoli. Avevo passato metà della mia vita in sella, ma non ero mai stato chiamato a compiere le prodezze che i giovani cavalieri di Artù eseguivano con naturalezza e non ero mai stato addestrato a farlo. Artù si allontanò per leggere il dispaccio alla luce di una torcia, quindi fece un cenno d'assenso al messaggero, borbottando qualcosa che non feci lo sforzo di ascoltare. Era chiaro dal suo atteggiamento che non si trattava di una comunicazione urgente. Il cavaliere che l'aveva recapitata venne congedato. «Artù, come riescono a saltare giù di sella in posizione rigida, sull'attenti? Non ho mai visto niente di simile in vita mia e lo vedo soltanto da quando sei tornato dalla Cambria. È necessario?» Sorrise. «No, Merlino, non è necessario, e ti assicuro che mi sembra perfino una dimostrazione di zelo eccessivo, l'espressione del desiderio di distinguersi ed eccellere che sembra pervadere tutti i miei uomini. Lo fanno per orgoglio, per spirito di corpo. Tutto ha avuto inizio nella fase finale della campagna di Cornovaglia, mentre ripulivamo la regione degli ultimi coscritti di Ironhair. Uno dei miei ufficiali, saltando di gran premura giù da cavallo in quel modo per conferire con me, atterrò in posizione eretta e rigida. In quel caso fu soltanto un colpo di fortuna e nient'affatto intenzionale, di questo sono sicuro, ma lui successivamente se ne vantò e disse di averlo fatto di proposito. Gli ufficiali che lo avevano visto ne rimasero assai impressionati. Entro un mese era una cosa che facevano tutti, e oggi è la regola. Le truppe scelte impongono a se stesse, spontaneamente, una disciplina che le distingue da tutte le altre.» «Capisco quello che vuoi dire» risposi senza tentare di nascondere l'ironia. «Anche i pretoriani erano soliti fare lo stesso. Ai loro tempi arrivarono perfino a eleggere e abbattere gli imperatori...» Vedendo che non reagiva alla mia battuta, mi chiesi se per la testa non gli passassero pensieri più cupi di quanto desse a vedere. «Dalla noncuranza con cui hai accolto il dispaccio ne ho arguito che non riguardava un affare urgente. Sbaglio?» Sbatté le palpebre, poi appuntò lo sguardo su di me. «È urgente, ma non inaspettato. E riguarda una situazione per la quale non posso fare niente. Viene da Bedwyr. I suoi esploratori avvertono che i Danesi di Horsa si stanno di nuovo raccogliendo, nel nord-est intorno a Lindum. Bedwyr prevede che si dirigeranno a sud verso i confini di Camelot. Lo prevedevamo anche noi. Horsa ha bisogno di espandersi. Lo abbiamo cacciato dalla Cambria e gli abbiamo impedito di costituire una sua base in Cornovaglia. Non c'è spazio per i suoi uomini lungo la Costa dei Sassoni, perciò deve conquistare i territori a ridosso dei nostri confini. Il che vuol dire che dovremo vedercela con questi nuovi invasori, ma Horsa non sa ancora a chi pesterà i piedi. Prima che lo capisca, spero che le nostre forze saranno in grado di sconfiggerlo duramente. Si troverà lontano dal mare questa volta, non ci sarà una flotta al largo a infondere sicurezza e coraggio a lui e ai suoi Danesi. Ma, come vedi, sarà una difficoltà che dovremo affrontare nel futuro; non riguarda la situazione attuale.» «Ne sei sicuro? Diffido delle analisi sulla situazione attuale quando si frappongono grandi distanze.» «Anch'io. Ma che fare? Non posso essere dappertutto simultaneamente. Aspetterò e nel frattempo mi terrò pronto a intervenire tempestivamente.» «Bene» dissi non potendo controbattere a quella logica. «Torniamo a quello che volevi chiedermi o dirmi.» Mi posò una mano sulla spalla. «Su, ti accompagno al tuo alloggio e strada facendo ti chiederò qualcosa.» Mentre ci avviavamo verso le distanti luci della cittadina, scorsi le ombre silenziose e discrete della squadra di arcieri che accompagnavano dappertutto Artù. Si allontanarono e si disposero in cerchio intorno a noi. Accorgendosi che li guardavo, sorrise. «Le mie guardie del corpo! Volevo congedarle, ma sono agli ordini di Huw, e per loro sarebbe un dilemma tormentoso obbedire a me e, così facendo, dispiacere a lui. Io sono il loro re, ma Huw Fortebraccio è il loro dio.» Non feci commenti. Artù l'anno precedente era diventato re dei clan di Pendragon, sotto gli auspici e la vigile tutela di Huw Fortebraccio, che oggi prestava ad Artù la stessa lealtà incondizionata che aveva giurato a Uther. «Mi preoccupa la faccenda della spada, Cay» continuò Artù. Ogni altro pensiero che avessi in mente passò in seconda linea a queste parole. Di rado si rivolgeva a me chiamandomi Cay e lo faceva solo perché qualcosa lo assillava. Gli lanciai un'occhiata cercando di rimanere impassibile e di non tradire l'ansia. «Perché dovresti essere preoccupato? È stato concordato tutto.» «Lo so, ma il cruccio rimane. Non capisco il senso, non capisco quale vantaggio possa derivare da una messinscena così plateale.» «Non è una messinscena, è un simbolo, un simbolo che ha un profondo significato. Rappresenterà la tua causa, la causa della Britannia. Gli uomini hanno bisogno di simboli per rendere visibile ciò in cui credono. Ne abbiamo discusso molte volte.» «Sì... ma non penso che l'idea possa reggere. Senti...» e con un sospiro proseguì: «Non è il significato simbolico che mi preoccupa... o almeno la necessità di averne uno. Questo lo capisco... È l'oggetto in sé, la spada come cosa fisica. Devo trarre la spada dalla roccia. È la mia spada, Merlino, la spada di Ambrogio. La uso da due anni ormai, da quando tu me l'hai data quel giorno in Cambria. Tutti l'hanno vista, la conoscono. Sanno che la porto con me ogni giorno, attaccata alla schiena, tra le scapole. Perché secondo te dovrebbero restare tutti suggestionati nel vedermi mentre la traggo fuori dalla roccia? Per mio conto è più facile che scoppino a ridere. Io lo farei davanti a una stupidaggine del genere». Avevo alzato la mano per chiedergli di tacere, ma soltanto in quel momento mi guardò e subito tacque. «Ho una domanda da rivolgerti, Artù» esordii sorridendo. «Una domanda che fino a ora non ti avevo mai posto: hai fiducia in me?» «Che sciocchezza è questa? Di chi altri in tutto il mondo potrei fidarmi? Perché me lo chiedi?» «Te lo chiedo perché voglio che tu mi presti tutta la tua fiducia. Se nutri anche il minimo sospetto che possa danneggiarti o sminuirti o compromettere la tua causa, che io credo ti sia affidata da Dio, allora dimmelo adesso. Accetterò la tua decisione e non accennerò più alla spada.» Si strinse nelle spalle e rimase in silenzio. «Bene, ancora due cose ti voglio dire: ti giuro che nessuno tra quanti saranno testimoni di quell'evento riderà e proverà altro sentimento che non sia di riverenza e stupore. Te lo giuro. Nessuno - né uomo né donna - avrà meno rispetto per te e nessuno riconoscerà la spada. Forse dentro di te avrai qualche dubbio, ma hai il mio giuramento.» «Hmm.» Era tornato a sorridere con una punta di malizia. «Questa è una delle due cose che mi hai promesso di dirmi. Qual è l'altra?» «L'altra è... diversa nel significato e nella struttura.» Aveva colto la mia esitazione, ma trattenne la curiosità per darmi il tempo di scegliere le parole più opportune. Alla fine annuendo cominciai: «Consideralo un mio auspicio nei tuoi confronti. Quando avrai estratto la spada dalla roccia, e saprai che quanto abbiamo fatto è giusto, appropriato, adeguato sotto ogni aspetto a quelle che sono le nostre intenzioni, allora vorrei che tu facessi un'altra cosa, soltanto per me. Ti sembrerà strano, ma non ti costerà niente». «Dimmela e sarà fatta.» Trassi un profondo sospiro. «Quando avrai impugnato la spada davanti alla folla, e sarai convinto che è tuo diritto farlo, vorrei che tu colpissi la roccia con la lama - mettendoci tutta la forza — e poi capovolgessi la spada in modo da poggiare l'estremità del pomo sulla pietra. Come sai, io non sarò lì sotto agli sguardi di tutti, ma ti vedrò mentre compi quel gesto e lo accetterò come il segno che la tua fiducia in me era giustificata. Lo farai?» «Sì, naturalmente.» Aveva un'espressione turbata. Sapevo che gli era difficile assecondarmi nel mio desiderio di non espormi agli sguardi curiosi e oziosi della gente, ma ne avevamo discusso a lungo, e alla fine aveva aderito alla mia richiesta, seppure con riluttanza. «Grazie, grazie per non chiedermi spiegazioni. Adesso vado a letto e così fa' anche tu.» Provavo sollievo, ma anche una punta di rimorso, perché gli avevo strappato quella promessa sapendo bene che dietro c'era un piccolo inganno. Artù era convinto che la spada che avrebbe estratto dalla roccia il giorno di Pasqua fosse la sua. Era sua in realtà, ma si trattava di Excalibur. Ed ero certo che se avesse continuato a ignorarne l'esistenza, sarebbe stato folgorato dallo splendore dell'originale, così come lo sarebbero stati tutti gli astanti. Ecco perché, in qualità di depositario della spada, avevo continuato a serbarne il segreto molto più a lungo di quanto avessi pensato. Camminammo in silenzio finché non fummo vicino alle mura cadenti della città. Mentre superavamo la porta e il primo degli edifici in rovina, notai alcune guardie che indossavano uniformi dai colori insoliti. «Chi sono?» «Gli uomini di Cheric, credo. È il re di una regione del lontano settentrione, a oriente delle terre di Derek. Forse però sbaglio. I re stanno confluendo da ogni parte, e non tutti mi hanno comunicato la propria presenza. Una ventina sono qui da ieri, ciascuno con il suo seguito, e forse altri ne giungeranno. Neppure tutti i vescovi sono ancora arrivati, e molti di loro viaggiano con il re del luogo in cui si trova la loro diocesi.» «Sono tanti i re che regnano in Britannia» brontolai. «All'epoca di mio padre non ne avremmo trovato neanche uno e comunque non avrebbe portato il titolo di re, tranne Uric Pendragon. Brander è già qui?» «Sì, è acquartierato con Connor, Donuil, Shelagh e suo padre, Liam il Gobbo.» Gli lanciai un'occhiata in tralice. «È venuto con Morag?» «No, non questa volta. È venuto dalle sue isole su ordine di Connor.» Sorrise. «Quanto a Brander, almeno posso essere tranquillo che si tratta di un re che sicuramente non è invidioso.» «Non viene dalla Britannia ed è tuo zio. Ti dispiace avere tanti re vicino a te?» «Vicino?» disse ridendo. «No, mi sta bene che siano vicino. Così so quello che fanno. Sono uomini e hanno le debolezze degli uomini. Ma alcuni mi sono più simpatici di altri. Abbiamo anche qualche rappresentante degli Angli cristiani. Lo sai che Cuthric è venuto, vero?» E quando annuii, proseguì: «Forse ti farà sorridere la presenza di un altro sovrano: Retorix, il nuovo re della Cornovaglia». Sorpreso, mi fermai. Retorix, mi aveva detto Artù, si era stufato degli eccessi di Ironhair, dei suoi atteggiamenti e della sua sostanziale codardia, e aveva abbandonato lui e i suoi progetti. Da allora si era segnalato per essere uno dei condottieri più coraggiosi e capaci di tutta la regione sudoccidentale, e aveva assunto il comando dei clan di quella martoriata terra. Scossi la testa a quella notizia con un brontolio di incredulità. «Bene» disse Artù dopo alcuni passi. «Eccoci arrivati. Non è un palazzo sontuoso, vero?» Guardai il decrepito edificio nel quale ero alloggiato insieme a Enos e ad alcuni suoi vescovi. «Non è villa Britannico, ma almeno metà del tetto è intatto, le pareti proteggono dal vento, ed è riscaldata dal fiato dei vescovi che discutono e dibattono senza posa.» Tornai a guardarlo. «Che cosa hai intenzione di fare, non appena mi avrai lasciato qui?» Lanciò un'occhiata alla scorta che lo seguiva discretamente. «Andrò a dormire, credo. Non c'è molto altro da fare.» Sorrisi ricordando i chiassosi incontri di vent'anni prima in una taverna costruita alla meglio che chiamavamo "Carpe diem". «Be', è quaresima, la stagione della penitenza» mormorai. «I vescovi non vedrebbero di buon occhio che le taverne rimanessero aperte la vigilia che commemora la morte di Cristo sulla croce per i nostri peccati. Dormi bene, ragazzo. Domani dovrai vegliare vicino all'altare per tutta la notte, e il giorno dopo, sarai incoronato re. Perciò approfitta di questo poco tempo che ti rimane. Dormi e riposati.» Si avvicinò a me e nel suo abbraccio, malgrado la corazza, sentii il calore e l'amore che mi portava. Rimasi sulla porta finché non scomparve alla vista, seguito dalle guardie di Pendragon. Non c'era nessuno nello stanzone quando entrai, ma nel braciere ardeva allegro il fuoco, e la luce di almeno venti candele di cera una prerogativa del clero - illuminava l'ambiente. In un angolo era collocato il giaciglio del vescovo Enos. Lo vidi intatto, il che indicava che il suo occupante non era ancora rientrato. L'intero edificio era immerso nel silenzio. Mi avvicinai al braciere per riscaldarmi le mani. Sentivo un pizzicore nella sinistra, residuo dell'ustione. Mi guardai intorno. L'arredamento, di semplicità spartana, si componeva di suppellettili e mobili portatili. La casa infatti, abbandonata per decenni, era stata il regno dei roditori e degli insetti. C'erano in giro alcuni tavoli e sedie pieghevoli, trasportati a Verulamium a dorso di mulo, e una serie di ceppi che fungevano da sedili quando Enos teneva consiglio. Per il resto la stanza era vuota e spoglia. Il lucernario dal quale un tempo scendeva la luce era stato chiuso con assi di legno; le pareti, ora illuminate dalle candele, avevano il colore della terra arida e in alcuni punti c'erano macchie irregolari di umidità. Probabilmente un tempo erano state molto belle. Il pavimento, spazzato regolarmente da quando eravamo arrivati, e forse perfino lavato, mostrava le tracce di una decorazione a mosaico, deturpata tuttavia dalla polvere depositatasi nel corso degli anni. Su un tavolo, non lontano dal caminetto, erano poggiate una brocca d'acqua - Enos non beveva altro - e una di idromele. Lì vicino erano stati lasciati un coltello dalla lama affilata, un grosso pezzo di formaggio ricoperto da una pezza di tessuto grezzo e una pagnotta di pane sfornata quella mattina, nascosta sotto il lembo di una tovaglia da chiesa. Accostai al fuoco una delle sedie e il tavolo, mi sedetti buttando all'indietro il cappuccio, scuotendo i capelli e li ravviai: era una delle poche cose che le dita della mano sinistra, rattrappite com'erano, riuscivano ancora a fare. Ero stanco e fui felice di potermi sedere e stiracchiare le gambe. Quella giornata, lunga e intensa, era servita a mettere a punto i particolari di un progetto al quale lavoravamo pazientemente da anni. Qualche attimo dopo, sentendo i morsi della fame, mi tagliai una fetta di pane e una di formaggio, e mi riempii un boccale di idromele. Contemplando con piacere il silenzioso guizzo delle fiammelle, nella quiete e nella pace della stanza, rimasi a fissare il fuoco, ma la mia mente vagava nel passato. Dal giorno in cui era morto mio fratello non avevo più impugnato una spada e non ero montato in sella. Me lo impedivano le ustioni e i tendini danneggiati. Artù aveva organizzato il mio trasporto a Camelot su un carro appositamente attrezzato con una cuccetta sospesa, costruita dai falegnami sul modello di quella che in navigazione usava Connor Mac Athol, il capitano dalla gamba di legno. Mi ero ripreso sotto le amorevoli cure di Ludmilla che, dopo la perdita del marito, una volta superata la prima ondata di dolore e lutto, aveva riversato su di me parte dell'affetto che aveva nutrito per lui. Con tutte le forze si era adoperata perché io sopravvivessi alle ferite e riprendessi la solita vita, come a loro tempo avevano fatto Connor e Publio Varro. Mi aveva esortato a esercitare fino allo sfinimento gli arti danneggiati, mi aveva persuaso a sforzarmi, mi aveva stirato i muscoli compromessi e ustionati finché non avevano ripreso la loro elasticità, mi aveva costretto a camminare diritto. In certi momenti zoppicavo più che in altri, il braccio e la mano sinistra erano inutilizzabili, ma per il resto ero forte e in forma. Fu Ludmilla che alla fine diagnosticò la lebbra. Ma era stata educata all'arte medica da Lucano che non aveva temuto la malattia e aveva nutrito grande ammirazione per l'amico Mordechai Emancipato il quale, dopo aver operato per decenni tra i lebbrosi, alla fine aveva contratto la malattia. Lucano le aveva insegnato che di per sé la lebbra non è molto contagiosa e non è mortale; i lebbrosi morivano perché, evitati, allontanati e temuti dagli altri, non riuscivano più a procurarsi il cibo. Vedendo le lesioni sulla mia pelle, le aveva riconosciute per quello che erano. Parlammo a lungo delle conseguenze che avrei dovuto affrontare, una volta che si fosse saputo della malattia che mi affliggeva. Fu Ludmilla che mi dimostrò come la gente comune, credendomi uno stregone, mi evitasse. Mi diede da indossare il lungo mantello nero con il cappuccio e la lunga veste che avevo usato per nascondermi nelle mie imprese notturne contro i nemici in Cambria e che Derek aveva portato a Camelot per me. Mi convinse che sarebbero stati altrettanto utili di giorno, per celare agli occhi dei curiosi il viso sfigurato e le lesioni della pelle. L'ampio cappuccio che mi ricadeva sul viso lo celava completamente con la sua ombra, e le maniche, ampie e lunghe, ricadevano oltre le dita delle mani. Sfruttavo la paura che tutti avevano delle arti magiche per eludere quella, ancora più intensa, della lebbra. Vedendomi vestito da mago, fuggivano in preda al terrore, e quel terrore mi proteggeva dalla loro curiosità. Nel periodo in cui mi riprendevo dalle ferite, Artù combatteva in Cambria. Dopo la morte di Ambrogio e il mio ritiro dalla guerra attiva, era ormai lui il comandante in capo e, con l'appoggio incondizionato di Huw Fortebraccio, aveva superato l'opposizione di chi riteneva prematuro che gli fosse conferita quella carica. Capo militare supremo, Huw aveva immediatamente proclamato l'ancora inesperto giovane re legittimo e incontestabile, in quanto figlio di Uther Pendragon, e immediatamente gli altri comandanti avevano giurato al nostro cugino e pupillo quella stessa fedeltà e lealtà che un tempo avevano giurato ad Ambrogio e a me. E Artù aveva avuto l'occasione di dare prova delle geniali capacità che si nascondevano sotto il suo giovane aspetto. L'uccisione di Carthac aveva disperso la feccia che gli si era raccolta intorno, e aveva distrutto le illusioni legittimistiche di Peter Ironhair, che aveva così visto sfumare ogni speranza di insediarsi in Cambria. La sua presenza su quelle terre era ormai considerata mera e brutale aggressione, senza parvenza di legittimazione. I suoi soldati mercenarii lo avevano abbandonato, cercando riparo in ogni direzione dalla furia della fanteria di Artù. Alcuni di loro avevano tentato di unirsi ai Danesi di Horsa, ma erano stati respinti. Agendo autonomamente nell'elaborazione della strategia militare e delegandone l'esecuzione a coloro che erano stati comandanti sotto Ambrogio, Artù aveva messo a punto un piano brillante per sconfiggere definitivamente quanto rimaneva dell'esercito di Carthac. Suddividendo le forze in manipoli e coorti alla maniera dei Romani, e usando la tattica impiegata da Caio Mario quattrocento anni prima - tattica che io stesso gli avevo illustrato quando era ancora un ragazzino - aveva organizzato le unità combattenti perché operassero in stretto coordinamento, dividendo in settori i territori del loro intervento e utilizzando i corpi di pattuglia in funzione di collegamento tra le diverse unità. Non appena decisi i punti principali della spedizione, aveva perseguito spietatamente la sua strategia, incalzando il nemico che si era precluso ogni possibilità di ottenere clemenza dopo le atrocità commesse contro la popolazione inerme delle terre saccheggiate. Una volta conclusa quell'impresa, aveva lanciato la cavalleria contro i Danesi, che al momento costituivano la minaccia più grave. I fieri guerrieri di Horsa avevano dato prova di essere più pericolosi della marmaglia di Carthac, che era stata sbaragliata dalla fanteria, e Horsa stesso si era dimostrato condottiero di grandi capacità quando si era confrontato con la potenza della cavalleria di Camelot. La battaglia senza né vincitori né vinti, combattuta il giorno in cui mi ero infiltrato nell'accampamento di Ambrogio, aveva insegnato molte cose a Horsa: aveva imparato che, trovandosi su un'altura e utilizzando la tecnica del muro di scudi, poteva proteggersi dalla nostra cavalleria come se fosse stato al riparo di una fortezza. Da quel giorno combatteva tenendo d'occhio i terreni elevati e curando la compattezza della propria difesa. Gli erano servite anche le mie solitarie imprese durante le quali ero riuscito a seminare la paura uccidendo e avvelenando. Dopo tre mesi di terrori notturni, i Danesi avevano abbandonato l'abitudine di combattere in piccole unità indipendenti. La "vendetta di Merlino" li aveva compattati e ora costituivano un corpo coeso, un vero esercito di tremilacinquecento soldati forti e coraggiosi, che si muovevano come un'unica, possente entità. La cavalleria di Artù era micidiale per i Danesi quando venivano colti all'aperto e di sorpresa, ma erano occasioni ormai rare che non si presentarono più dopo la prima fase del conflitto. Horsa aveva capito che un attacco poteva essere sferrato in ogni momento, e quindi teneva sempre raccolti i suoi uomini, pronti a levare il muro protettivo di scudi per tenere a debita distanza la cavalleria. Quel punto di forza aveva però anche un lato debole: i suoi valorosi soldati non potevano usare le bipenni, di cui erano armati, mentre tenevano gli scudi levati e quasi agganciati gli uni agli altri. Inoltre era una tattica difensiva che aveva la meglio sulla cavalleria soltanto se applicata su un terreno in pendenza, con i cavalieri in basso, perché su un campo piatto l'impatto dei cavalli riusciva ad abbattere lo schieramento. Quando invece il nemico attaccava cercando di risalire il fianco di una collina costituiva un ottimo bersaglio per i lunghi archi degli arcieri. Il conflitto era diventato quindi uno scontro tra due tattiche, la postazione a testuggine e quella a istrice, senza che nessuna delle due riuscisse a prevalere e conseguire una vittoria decisiva, ma le forze danesi si dissanguavano nello stillicidio di una guerra di attrito. La cavalleria di Artù impediva loro di accedere alla pianura e, sparsi tra le colline, non ottenevano risultati degni di nota. A merito di Horsa va detto che, resosi ben presto conto della situazione, aveva cominciato ad arretrare, conducendo il suo esercito verso la costa, combattendo duramente metro per metro e perdendo sulle colline molti uomini che furono abbattuti dalle frecce dei micidiali archi di Pendragon. Artù aveva continuato a incalzarli, lanciando di tanto in tanto la cavalleria contro il muro di scudi. Li aveva inseguiti fino alla costa, dove la flotta aspettava Horsa e i suoi uomini per riportarli nelle loro terre. In prossimità del mare Artù aveva fermato la sua avanzata e disposto la cavalleria in modo da formare una barriera invalicabile intorno alla spiaggia. Avrebbe potuto sterminare i Danesi ma non l'aveva fatto. Mi spiegò in seguito le ragioni della sua clemenza: Horsa, guerriero coraggioso e capace, aveva capito che era impossibile conquistare la Cambria. Non sarebbe ritornato. Artù Pendragon rimase a guardare la flotta nemica che levava l'ancora e veleggiava verso la salvezza. In seguito, Artù venne a sapere che Connor Mac Athol aveva incalzato quella flotta fin dal suo arrivo, arrecandole numerosi danni. Come lupi affamati, le biremi e le galee di Connor si erano appostate intorno al tratto di mare in cui era all'ancora, evitando lo scontro aperto con i vascelli che cercavano di contrattaccare e facendo invece continue incursioni, bruciando e affondando le navi di giorno e di notte. Di conseguenza, la flotta che era salpata dalla Cambria era molto inferiore a quella che era approdata sulle sue sponde, e ogni imbarcazione aveva dovuto portare un carico di uomini molto più numeroso di quanto non si fossero aspettati i capitani. Nel frattempo mi era stato negato di coronare uno dei miei sogni più ardenti. Peter Ironhair era morto e la notizia era stata per me come cenere amara in bocca. Molte volte Ambrogio mi aveva detto che passavo troppo tempo a rimuginare su Ironhair e su come mi sarei vendicato il giorno in cui ci fossimo trovati faccia a faccia. Ora che erano svanite le mie speranze di vendetta, mi sentivo curiosamente sollevato, non più oppresso dal fardello dell'odio che per tanto tempo aveva gravato sul mio animo. Le cose erano andate così. In qualche modo si era inimicato Horsa, il suo alleato, e ne aveva pagato le conseguenze con la vita; nessuno di noi avrebbe mai saputo come e perché era accaduto. Mi turbava tuttavia che, così come Ironhair mi aveva detto in sogno, si fosse avverata la sua promessa. Non lo rividi più, e non lo rivide nessun altro a Camelot, tranne Filippo che, nel corso di una perlustrazione, si imbatté nel suo cadavere appeso a un albero nell'accampamento dei Danesi. Non mi sfuggì l'ironia del fatto che il suo predecessore in Cornovaglia, Gulrhys Lot, aveva subito lo stesso destino: impiccato a un albero da mani ignote. Tutto questo era avvenuto prima della fine dell'estate, pochi mesi dopo la mia partenza dalla Cambria. Avendo tempo a propria disposizione, non pressato da altri affari più urgenti, Artù si era adoperato per consolidare le vittorie. Aveva inviato in tre successive spedizioni, delegando il comando a Filippo e affidando il trasporto alle massicce triremi di Connor, un forte contingente di cavalieri e fanti in Cornovaglia, al fine di snidare Ironhair e i suoi infidi e malvagi seguaci. Lui stesso poi aveva condotto, con azione fulminea, il resto del suo esercito a nord, lungo le pendici occidentali della catena montuosa che divide in due la Britannia. E aveva lanciato il suo messaggio: era tempo che i popoli della Britannia si unissero per respingere gli stranieri. Camelot era la roccaforte contro gli invasori e avrebbe accolto chiunque avesse deciso di battersi per cacciarli lontano dalle sue sponde. Non era mancata l'opposizione al suo progetto, ma era stata debole. La vista delle migliaia di cavalieri pesantemente armati che lo seguivano aveva avuto un effetto rassicurante e pacificatore perfino per quei re che avrebbero potuto sentirsi minacciati dal suo arrivo. Prima che avesse raggiunto il Vallo di Adriano e da lì, seguendone la direzione, avesse puntato a oriente verso il mare che separava la Britannia dai suoi possibili invasori, già la fama lo aveva preceduto. Aveva proseguito a sud, fino al punto in cui la strada superava un largo fiume in prossimità del vecchio forte romano di Longovicum. Qui la guarnigione locale era assediata da un numeroso esercito di Sassoni che dalla costa avevano risalito il fiume per circa venti miglia. Approfittando del fattore sorpresa, Artù aveva diviso il suo esercito in due parti e attaccato immediatamente, incendiando con frecce infuocate le lunghe imbarcazioni nemiche e distruggendo gli assedianti. Il re di quella regione era Vitico, ora presente a Verulamium per assistere alla cerimonia dell'incoronazione. Prima che fosse passato un anno da quando aveva preso il comando, Artù Pendragon aveva percorso in lungo e in largo la Britannia, raccogliendo le diverse genti e i loro re e persuadendoli a unirsi in un fronte comune contro gli invasori. Si era reso conto nel frattempo che Camelot non era l'unico insediamento romano di quel tipo, ma nessun altro era così solido e forte e nessun altro disponeva di una cavalleria. Al suo ritorno gli avevo dato in dono sia l'armatura che era stata mia, dicendogli che ormai non mi serviva più, sia quella, ancora più bella, che era stata di suo padre. Ne era rimasto profondamente commosso e gli occhi gli si erano velati di lacrime, ma aveva preso a indossare la mia affermando che era quella di Camelot. L'altra, appartenuta a suo padre, dichiarò, l'avrebbe usata nelle cerimonie ufficiali in segno di omaggio a Uther. «Merlino? Perdonatemi, amico mio, non era mia intenzione spaventarvi arrivando all'improvviso.» Non avendo sentito la porta aprirsi alle mie spalle, ero saltato in piedi e avevo rovesciato un po' di idromele. Mi ripresi rapidamente e tranquillizzai Enos. Sorrise e, togliendosi dalle spalle il pesante mantello, si avvicinò al mio giaciglio. Gli riempii la coppa di acqua e tagliai una fetta di formaggio. Accettò il pasto frugale con parole di gratitudine. «Non avete incontrato difficoltà?» mi chiese. «No, ma per poco Artù non mi ha colto in flagrante.» Ridacchiò piano mentre gli raccontavo l'accaduto; poi descrisse come si sarebbero svolte le cose il giorno successivo. Mentre parlava, mi sorpresi a confrontare la voce quieta di quel momento con la voce che era solito usare quando impartiva ordini. Non più giovane, era scarno e curvo sotto il fardello della sua missione pastorale, che lo costringeva a continui viaggi nel freddo e nel gelo per portare la Parola al suo gregge anche negli angoli più remoti. Eppure in ogni cosa che intraprendeva dimostrava energia, sapeva infondere sicurezza ed era stato infaticabile nel convincerci che tutto si sarebbe svolto secondo i piani e che la cerimonia sarebbe stata uno spettacolo quale non si era mai visto in Britannia. Che molte fasi dovessero essere preparate in gran segretezza era un fattore che stimolava il suo entusiasmo, ed era riuscito a gestire i complessi rapporti con la congregazione dei vescovi, sparsi su un vasto territorio, con l'accortezza che un bravo capitano mostra nel condurre le sue legioni. Negli incontri avuti quel pomeriggio aveva spiegato con passione ai convenuti la storia del grande teatro costruito dai Romani e illustrato la cerimonia che vi avrebbe avuto luogo. Al pari di tutti gli altri, ero rimasto ad ascoltarlo affascinato. Aveva poi dato le istruzioni necessarie per trasformare il teatro in un'ecclesia e dare al luogo del passatempo la maestà del luogo di devozione. E nell'impartire la benedizione che sanciva quella diversa destinazione dell'edificio, una lunga processione aveva cominciato a sfilare sotto lo sguardo incantato della folla. Più di cento vescovi, preceduti dai turiferi che diffondevano intorno nubi di incenso, erano avanzati, cantando all'unisono la solenne preghiera della fede cristiana, quale era stata definita nel Concilio di Nicea svoltosi più di un secolo prima. Dietro ai vescovi, raccolti in semicerchio sulla piattaforma alle spalle di Enos, si erano posti i prelati di rango minore, reggendo una semplice tavola di legno, una tovaglia candida ripiegata, un masso di pietra verde molata, meravigliosamente sagomato da un capace artigiano. E mentre Enos aveva descritto ogni passo di quella procedura, la pietra, collocata sul drappo bianco che ricopriva la tavola, era stata benedetta con acqua santa. Era arrivata, spiegò Enos, quel giorno da Camelot, ma era stata originariamente raccolta a Verulamium, su richiesta e sotto la supervisione del vescovo Alarico. Era bello che la pietra dell'altare venisse da Camelot e che fosse il vescovo di Verulamium a consacrarla. Conteneva la reliquia di un santo che, al tempo dei Romani, aveva immolato la sua vita per la fede; quella presenza trasformava il teatro in luogo di culto. Così dicendo, Enos aveva tolto dalla fusciacca una grande croce d'oro di semplice fattura e l'aveva infilata nell'incavo della pietra, completando la cerimonia della consacrazione. A quel punto aveva preso a narrare la storia dell'Ultima Cena di Nostro Signore, della consacrazione del pane e del vino, e tutti i presenti, uomini e donne, si erano fatti avanti per ricevere l'eucaristia dai vescovi che prendevano le ostie da grandi cesti, le benedivano e le consacravano. Concluso il sacramento, Enos aveva descritto la Passione e la Crocifissione di nostro Signore alla terza ora dopo il mezzogiorno, e la sua preghiera si era conclusa proprio allo scoccare di quell'ora. Poi, accompagnato dalle voci di tutta la congregazione, aveva intonato di nuovo il Credo di Nicea, cui era seguito un lungo momento di silenzio. Il mondo, aveva pronunciato con voce possente, era immerso nella tenebra spirituale e vi sarebbe rimasto fino all'alba del terzo giorno quando, con la Resurrezione della carne, avrebbe esultato e l'umanità avrebbe conosciuto la salvezza e il rifiorire della speranza. Mentre così parlava, un gruppo di vescovi aveva ricoperto con drappi viola e nascosto alla vista tutti i simboli della Chiesa - i candelabri, gli emblemi sacri, le croci, gli ostensori - quindi i presenti erano stati benedetti e congedati. Non ero mai stato soggiogato dai riti della religione, ma la cerimonia semplice e al tempo stesso complessa officiata da Enos mi toccò in fondo all'anima e ancora una volta provai rammarico che Tressa non potesse essere lì a condividere quell'emozione. All'improvviso, mi resi conto che Enos aveva smesso di parlare e che non sapevo quale argomento aveva trattato. Mi sentii in colpa e arrossii. «Enos,» dissi «ora tocca a me chiedervi scusa. Ero con la mente lontanissimo da qui, intento a pensare alla magnifica cerimonia cui ho assistito oggi. Ma non c'è perdono per le cattive maniere. Da quando sono entrato, non ho fatto che sognare. Sono stanco e dovrei essere a letto. Posso ritirarmi?» «Certamente» rispose con sguardo benevolo. «Anch'io dovrei andare a dormire. Dio vi benedica, Caio Merlino, dormite bene.» Il giorno successivo fu tranquillo. Invece di espormi agli sguardi curiosi, non volendo suscitare paura nella folla che ora riempiva la città oltre la sua capienza, passai la giornata nel mio alloggio, osservando da una finestra del primo piano quanto accadeva fuori. Dappertutto si aggiravano soldati, e non tutti venivano da Camelot, ma non c'erano disordine e confusione. Molti dei sovrani avevano portato il loro seguito: consiglieri, guardie del corpo, mogli e figli, domestici; i colori dei loro abiti, delle loro uniformi, delle loro armi riempivano le strade e davano gaiezza e allegria a quell'occasione di incontro, sebbene fosse di natura religiosa. Alla festosità diffusa contribuivano in gran misura i venditori ambulanti, scaturiti dal nulla come spesso fanno, per approfittare di quel gran concorso di gente e vendere non solo cibo e bevande ma anche ninnoli, ornamenti e qualsiasi cosa potesse attirare un acquirente. C'era, tuttavia, in quell'allegrezza diffusa un tocco di pacato raccoglimento: sarebbe stato infatti un giorno di assorta riflessione sui mali di un mondo che era arrivato a condannare e crocifiggere il Figlio di Dio, un giorno di preghiera tra le tenebre dell'anima e la luce della Resurrezione che avrebbe rischiarato il giorno successivo. Verso sera fui convocato urgentemente da Artù che mi chiedeva di raggiungerlo il prima possibile nel suo alloggio. Senza difficoltà attraversai le strade affollate diretto al suo accampamento, mentre al mio passaggio la gente si faceva in disparte come le onde del mar Rosso davanti a Mosè. Pensai cupamente che doveva esserci qualcosa di repellente nel mio modo di camminare e vestire. Ma il disagio scomparve immediatamente non appena vidi Artù. Aveva il viso segnato dalla preoccupazione e, quando arrivai, stava impartendo una serie di ordini chiari, assennati e precisi al centinaio di capitani raccolti intorno a lui. Vedendomi entrare mi fece segno che mi avrebbe raggiunto subito. Mi ritirai in un angolo e aspettai, leggendo rispetto, paura, talvolta ostilità negli sguardi che mi fissavano furtivamente e si distoglievano non appena cercavo di intercettarli. Artù alla fine congedò tutti e mi si avvicinò. Era vestito come la notte precedente, salvo che non portava né il mantello né l'elmo. «Qualcosa non va, Artù?» «Tutto, Merlino. Nelle ultime tre ore mi sono pervenute brutte notizie, l'una dietro l'altra, fitte e compatte come grandine. Sono preoccupato.» «Raccontami.» Strinse le labbra e respirò a fondo. «La notte scorsa ti ho detto che i Danesi di Horsa si raccoglievano fuori Lindum. Ora si stanno muovendo. Mi ha informato Bedwyr poco dopo mezzogiorno. Ma non basta. Meno di due ore dopo mi sono arrivate altre notizie da Gwyn. Lui e Ghilly sono nelle terre degli Angli, a sud di dove si trova Bedwyr, nel regno di Cuthric. Anche lì c'è fermento. Dai loro insediamenti, i Sassoni continuano con le loro incursioni massicce e pesanti, e si muovono verso occidente, da quanto ci informa Gwyn. Si scontreranno con i Danesi di Horsa che avanzano verso meridione.» «Se si scontreranno, sarà un bene per te: si ammazzeranno l'un con l'altro.» «Stanno avanzando verso occidente anche i Danesi del Weald. Gli uomini di Benedetto si attengono agli ordini rigorosi che ho dato: stare a guardare ma non impegnarsi in uno scontro. L'ho saputo meno di un'ora fa. Ben mi chiede l'autorizzazione ad attaccare. Non gli piace il modo in cui si spostano: troppo numerosi, secondo lui, troppo disciplinati e ben organizzati perché si apprestino a compiere una semplice incursione.» «E gli altri, Bedwyr e le sue truppe di ricognizione? Anche loro retrocedono?» «Sì, tutti. Sono questi gli ordini che ho impartito: osservare, ritirarsi davanti alla minaccia senza attaccare e tenermi informato costantemente. Ho ricevuto notizie da quasi tutti, e qualcosa dentro di me mi dice che la situazione laggiù è più grave di come appare. Per questo ho ritenuto opportuno prendere queste misure.» «Quali misure? Non capisco quello che dici.» «Se i Danesi e i Sassoni avessero concordato un punto di incontro e non si muovessero alla cieca l'uno contro l'altro? Se avessero stretto alleanza? È un'ipotesi temibile, che acquista consistenza dai rapporti che mi ha inoltrato Ben. L'istinto mi dice che non abbiamo tempo da perdere. Ho ordinato all'esercito di raccogliersi all'alba, tutti, nel campo antistante il teatro. Sarò incoronato a mezzogiorno. Entro la metà del pomeriggio voglio che i soldati siano schierati oltre i confini della città, a distanza di sicurezza per la comunità, sulle alture, pronti a muoversi in una qualsiasi direzione. Penso proprio che intendano venire qui, a Verulamium.» Non credevo che le conclusioni da lui tratte avessero un fondamento reale e logico, ma io stesso gli avevo insegnato a dare credito alle proprie convinzioni in momenti simili. «Se è così, quanto tempo ci metteranno ad arrivare?» «Da Lindum a qui,» disse stringendosi nelle spalle «ci sono più di cento miglia, quasi centotrenta. Il che vuol dire che impiegheranno sette giorni. Sono partiti quattro giorni fa. Il messaggero di Bedwyr ha stroncato il suo cavallo a forza di sproni per venire a informarci il prima possibile. Ma, nel frattempo, i due eserciti si sono già uniti, se quanto sospetto è vero. Potrebbero essere qui domani, se avanzano a marce forzate, ma più probabilmente compariranno dopodomani e, se Dio ci aiuta, anche più tardi. Ma questa stessa velocità di marcia la terranno gli uomini che vengono dal Weald, e questi sono molto più vicini. Ho dato ordine di levare l'accampamento e radunarsi domani all'alba. Non possiamo correre il rischio di farci cogliere impreparati.» «Lo so, Artù, ma le mie preoccupazioni sono più immediate. Se si sparge la voce, potrebbe diffondersi il panico in città e rovinare tutto ciò che abbiamo preparato.» «Non lo faremo sapere. Ho preso le precauzioni necessarie. Soltanto i miei uomini sono al corrente. I soldati saranno richiamati nelle caserme e lì resteranno confinati per tutto il giorno.» Annuii. «Per quanto possa valere a questo punto il mio parere, ti dico che hai agito nel modo migliore. Credo però che sarebbe un bene se le truppe potessero assistere alla cerimonia dell'incoronazione. In tal modo, anche se si sparge qualche voce inquietante - quando mai una voce non si è sparsa? - la gente, vedendo l'esercito che disciplinatamente presenzia alla manifestazione, si tranquillizzerà.» Mi fissò a lungo. «Non è possibile, se non altro perché non c'è abbastanza spazio per tutti i soldati.» «Sì, ce n'è. Il teatro accoglie settemila persone sedute. Ieri i chierici di Enos hanno calcolato che i presenti saranno meno di cinquemila, ma bisogna considerare che alcuni sono arrivati in ritardo e quindi domani potrebbero esserci davvero cinquemila persone. Ma rimangono duemila posti a sedere vuoti e ampio spazio per altri mille in piedi intorno alle pareti.» «I miei uomini sono più di seimila.» «Tiriamo a sorte. Convincili che presenziarvi sia un privilegio. Sono sicuro che faranno a gara tra loro per accertarsi che le cose siano fatte per bene. I tuoi capitani dovrebbero partecipare tutti, ma ciò non è possibile. Tiriamo a sorte anche tra di loro. Un ufficiale su quattro resterà in servizio; per i sottufficiali la regola sarà che due su quattro saranno in servizio. In questo modo riempiamo tremila posti, ma sono sicuro che troveremo lo spazio per accoglierne quattromila. A parte la funzione di tranquillizzare gli animi, mi piacerebbe vedere i soldati presenti, e tu, Artù, avresti solo da guadagnare da questo. Ti vedranno incoronato dai vescovi con la benedizione della Chiesa. Sapranno che il loro comandante è un re, unto dal Signore.» «Ci penserò» disse sospirando. «Quanto al resto... approvi gli ordini che ho impartito? Non ho solidi argomenti, ho obbedito all'istinto.» Sorrisi leggendo il fervore della sua espressione. «Che importa quello che penso io? È stata una tua decisione, giusta o sbagliata. Personalmente credo in tutta sincerità che tu abbia fatto bene.» Per la prima volta da quando ero arrivato mi restituì il sorriso. XIX. Su suggerimento di Enos - un suggerimento sorprendente e assennato - mi avviai verso il teatro il mattino di Pasqua vestito come uno dei suoi vescovi: non indossavo più la mia lunga veste nera, ma un paramento bianco altrettanto lungo e fornito anch'esso di cappuccio. Faceva molto freddo, il cielo era nero di nubi, e mentre il vento pungeva attraverso l'abito talare da cerimonia, rimpiangevo il mio pesante mantello di lana. Ma la sostituzione mi era stata utilissima perché lungo il mezzo miglio che avevo percorso, nessuno della folla mi aveva riconosciuto né prestato attenzione, salvo che per lanciare qualche occhiata curiosa al piccolo scrigno che portavo e forse chiedersi che cosa contenesse. Nella solenne processione sfilavano centoventi prelati, e io ero l'unico mago nelle quattro file del corteo. Non appena eravamo passati, la folla si chiudeva dietro a noi e ci seguiva verso il maestoso edificio che sorgeva oltre le mura cittadine, su una distesa priva di alberi. Mi giunsero dei mormorii - anche dai vescovi - quando fu chiaro che si era raccolto l'intero esercito di Artù, con le schiere allineate dietro i vessilli, i soldati rigidamente seduti con l'aria di essere pronti a scattare. Nei pressi del teatro il corteo si snodava attraverso le formazioni militari. Non appena l'accolito, reggendo una lunga asta sormontata da una croce avvolta in un drappo viola, aprì la processione, i capitani militari emanarono con voce possente un ordine e tutti i reggimenti si misero sull'attenti in segno di rispetto verso i vescovi. Strinsi più forte tra le mani lo scrigno di legno. Custodiva, appoggiata su uno splendido cuscino che anni prima Tressa aveva ricamato per farmene dono, la corona d'oro forgiata appositamente per adattarsi alla testa di Artù. Era un semplice cerchio, non più alto di un pollice, una fascia d'oro sobria e liscia, priva di ogni decorazione salvo una croce sulla parte anteriore, e nella parte posteriore un elegante nastro annodato i cui lembi finivano con una ghianda. Non avevo idea di come fossero state le antiche corone militari romane, ma avendo visto e ammirato la semplicità di quella di Athol Mac Iain, ne avevo copiato il modello chiedendo ai migliori artigiani della Colonia di eseguire il lavoro sulla base della mia descrizione. Nel momento in cui stavamo per entrare nel teatro, vidi Artù. Il mio sguardo fu attratto dallo splendore del manto porpora e oro che indossava, lo stesso mantello, unico e perfettamente distinguibile, che una volta avevo inseguito lungo le coste della Cornovaglia. Lo scorsi di spalle. Stava con i gomiti aperti e le gambe allargate, sicché sulle sue spalle era maestosamente visibile il drago dorato, ad ali spiegate, del vessillo di suo padre. Scorgendolo a testa scoperta, ne dedussi che teneva l'elmo sul fianco, sotto il manto purpureo. In quel momento mi accorsi che stava parlando a Benedetto e ad altri ufficiali, che apparivano stanchi del viaggio e tuttavia intenti ad ascoltare il loro condottiero. Capii dall'atteggiamento di Artù che qualcosa di grave era nell'aria. Affidando lo scrigno al chierico che mi stava a fianco, gli dissi di consegnarlo a Enos e immediatamente mi staccai dal corteo. Scorgendo con l'angolo dell'occhio la mia veste bianca, Artù aggrottò la fronte, impaziente, comunicando con l'espressione del viso che non aveva né il tempo né la voglia di conferire con un prelato in un momento come quello. Mi avvicinai a lui: stava per volgersi con ira quando sentì sul braccio la mia mano. «Sono io, Artù. Ho solo cambiato il colore della veste.» «Merlino!» Si girò di scatto, ignorando il tono leggero, quasi frivolo, delle mie parole. «Grazie al cielo, sei qui! Dobbiamo rimandare... rimandare la cerimonia.» Con un cenno della mano indicò la processione che affluiva verso l'arena. «Dovremo annullare la celebrazione, rinviarla a un momento più propizio. Devo partire. Stavo per dare l'ordine di metterci in marcia.» Mi scrutò dalla testa ai piedi, osservando l'insolita veste che indossavo, ma non lessi sul suo viso alcun lampo di curiosità o interesse. Scorsi dietro a lui numerosi uomini, compresi alcuni capitani, che ci guardavano con aria interrogativa. Sapevo che alcuni di loro, soprattutto quelli che un tempo erano stati soldati, non avrebbero esitato ad avvicinarci. La rabbia che palesemente gli ribolliva dentro avrebbe potuto esplodere a quella innocente provocazione, e non avevo voglia di assistere a un incidente spiacevole proprio quel giorno. Lanciai un'occhiata a Benedetto, che mi rispose con un grave cenno d'intesa, quindi uno a uno fissai gli altri. «Venite» dissi. «Qui ci sono orecchi avidi di cogliere ogni parola.» Li condussi a qualche passo di distanza, dove nessuno avrebbe potuto sentirci e avvicinarci senza che avessimo il tempo di avvertirlo di tenersi discosto. «Artù, che cosa succede?» «Un'invasione, Merlino. Un'invasione immensa, massiccia, quale non si è mai vista in Britannia, neppure quando sbarcarono i Romani. Migliaia di galee... gli uomini di Ben non sono riusciti a contarle.» «Santo cielo! Ben, eri nel Weald?» «Sì, ci sono stato. Ma, obbedendo agli ordini, ci siamo ritirati, tenendoci a buona distanza dal nemico per non essere visti. Si sono diretti dapprima verso nord, poi verso nord-est, alla volta di Londinium. Lì per poco non abbiamo perduto tutto, compresa la vita. Tenevamo d'occhio il nemico che procedeva dietro a noi, un intero esercito. Ma erano soltanto una pattuglia rispetto a quello che abbiamo trovato in loro attesa alle nostre spalle. Non è soltanto una flotta di invasori. Ne abbiamo già viste. Questa è una flotta che comprende varie flotte. Il Tamigi brulica di navi, da Londinium al mare, per oltre quaranta miglia. Su entrambe le rive quasi non c'è più uno spazio libero per attraccare una barca.» «Come fai a sapere tante cose? Sei andato in ricognizione sulle rive del fiume?» «No» rispose. «Abbiamo incontrato alcuni Angli che scappavano da quelle terre e ci hanno raccontato ciò che accadeva. È stata la loro fuga a metterci in allarme, appena in tempo per non finire tra i Sassoni. Londinium è invasa e funge da punto di raccolta di questi uomini, chiunque essi siano. Stando agli Angli, sono di ceppo sassone, non danese. Altro non so. Come ha detto Artù, ci siamo accostati abbastanza per vederli, ma abbiamo perduto il conto delle loro navi. Dio solo sa quanti sono gli invasori! È stato un miracolo se siamo riusciti ad arrivare qui, nascondendoci e scivolando via senza farci accorgere. Ci abbiamo messo molto tempo. Ti giuro, Merlino, nessuno di noi ha mai visto niente di simile. Queste terre pullulano di Sassoni. Presto saranno qui a Verulamium.» Mi mordevo il labbro, sconvolto dalle cose che Benedetto diceva e dalla loro immensa portata. Non ero sorpreso che Artù si apprestasse ad annullare la cerimonia fissata per quel giorno. Sarebbe stato un suicidio non farlo. Ma cercai di ragionare con lucidità. «A che distanza sono i nemici, Ben? La loro avanguardia, voglio dire.» Si concentrò prima di rispondere. «Parecchie ore. Ci siamo mossi in fretta, non appena abbiamo capito che non ci avrebbero visti. Potrebbero essere qui stanotte.» «Ci sono probabilità che trovino qualcuno che si oppone alla loro avanzata?» «Non a Londinium. La città è perduta. Forse, se quello che dice Artù è vero, si sono fermati lì, in attesa di Horsa. Ma non ci scommetterei. C'è tra noi e loro un piccolo schieramento di nostre truppe, ma saranno un ben fragile baluardo se quei bastardi avanzeranno in massa.» Fissai Artù e prima di rivolgermi a lui rimasi a riflettere per qualche tempo. «Devi prendere una decisione, comandante, ma se hai mai dato credito ai miei consigli, lascia che ti dica quello che penso prima di impegnare te stesso e i tuoi soldati in un'impresa di guerra.» Era chiaro che non gradiva la mia interferenza, ma strinse i denti per resistere alla tentazione di dirmi chiaro e tondo che la responsabilità del comando era sua, soltanto sua. Volse la testa dall'altra parte per guardare le schiere immobili dei soldati. Era teso, lo si vedeva, e cercava di mantenere la calma. Alla fine, placò l'ondata di impazienza, le spalle gli ricaddero e si girò dalla mia parte, annuendo. «Molto bene» disse con voce tranquilla. «Dimmi che cosa hai in mente. Non mi hai dato cattivi consigli in passato, e adesso più che mai ho bisogno di un saggio avvertimento.» «Le mie parole sono soltanto per le tue orecchie, Artù» lo ammonii. «Le ascolterà anche Benedetto, il primo ufficiale dopo di me. Ne saranno informati anche Terzio Lucca, Rufio, Falvo e Filippo.» Si volse verso coloro che non aveva nominato. «Posso chiedervi, signori, di trovare questi quattro ufficiali e di mandarli direttamente da me?» Gli uomini stavano per accomiatarsi, ma lui li trattenne. «Ancora una cosa. So che non è necessario che ve lo dica, ma siete al corrente di notizie... pericolose. Vi chiedo quindi di non parlarne, neppure tra voi. Una loro prematura diffusione potrebbe essere disastrosa.» Gli uomini si misero sull'attenti e subito dopo si allontanarono in fretta. Non appena se ne furono andati, Artù mi guardò. «Che cosa progetti di fare, Cay?» Pareva nello stesso tempo giovanissimo e precocemente invecchiato. «Non intendi aspettare gli altri?» «No, ci vorrebbe troppo. Comunicheremo arriveranno, quello che è opportuno sappiano.» loro, quando «Molto bene.» Trassi un lungo sospiro. «La tua prima reazione istintiva è stata di rimandare la cerimonia di oggi. Ti capisco; l'ho pensato anch'io al sentire le notizie che ci ha portato Ben. Ma poi è intervenuto il buon senso. Hai sentito Ben. Malgrado tutte le nostre paure e le peggiori aspettative, è previsione assennata ritenere che il nemico non sarà qui prima di stasera, il che vuol dire non prima di domattina, perché nessuno che abbia un po' di cervello ingaggerebbe battaglia di notte. Pensaci, Artù: sarebbe una follia sospendere la cerimonia ora che ogni cosa è stata organizzata. Il rito fissato per oggi è molto di più di una cerimonia, è una consacrazione. Non possiamo sospenderlo e rimandarlo a data da destinarsi. È il punto culminante di un progetto maturato per anni...» «Sì, ma premono circostanze urgenti!» «No, Artù, non c'è niente di più importante. Credevo che volessi ascoltarmi fino in fondo.» Annuì, con l'aria di chi vuole chiedere scusa. «Perdonami. Continua, ti prego.» «Non esiste evento più urgente né causa più nobile di quella che oggi si compirà qui. Sono convenuti a Verulamium tutti i vescovi per celebrare la Pasqua e la Resurrezione del Signore, il nostro Salvatore. Anche tu sei un salvatore ai loro occhi, Artù! Il salvatore della Britannia e della fede cristiana. Per questo ci troviamo a Verulamium e non a Camelot. Non esiste a Camelot un luogo abbastanza degno e grande per accogliere un raduno di questo significato. La cerimonia deve svolgersi qui, nell'antico cuore della Britannia, dove stanno convenendo migliaia di persone. Davanti a loro tu sarai dichiarato e proclamato dai rappresentanti di Cristo stesso re della Britannia. La Chiesa ti ha convocato qui oggi, la Chiesa ha convocato qui tutti i sovrani dei regni minori della Britannia perché vedano che i vescovi ti incoronano e, benedicendoti, ti danno il loro appoggio. Tu, il capitano della cavalleria di Camelot, sei l'unica speranza realistica che la Britannia abbia di respingere gli invasori e vegliare che gli uomini possano vivere come hanno scelto.» Tacqui in attesa di una sua risposta, poi gli chiesi: «Hai sentito quello che ti ho detto, Artù?». Si umettò le labbra; il viso era pallido. «Sì.» La risposta era un sussurro. «Bene, e adesso l'aspetto pratico. Se vado subito da Enos e gli spiego come stanno le cose, accetterà, ne sono sicuro, di abbreviare il rito e procedere senza indugi alla benedizione dell'Eucaristia. Fatto questo, può dare immediatamente inizio all'incoronazione ponendo sulla tua testa la corona di difensore della fede in Britannia e chiedendoti di impegnare tutte le tue forze e risorse a protezione della religione di Cristo contro i nemici di Dio. Si può concludere in due ore, e ti rimarrà mezza giornata, prima che scenda la notte, da dedicare ai preparativi per affrontare l'invasore. Sarà un utile impiego del tempo. Noi sappiamo che cosa ci aspetti. Pensa a quello che te ne verrà: avrai la benedizione di Dio stesso, sarai il difensore della Chiesa, consacrato da una cerimonia alla quale hanno solennemente partecipato i re e i popoli della Britannia, e il tuo stesso esercito. Quale maggiore incitamento per i tuoi soldati a scendere in guerra con fiducia e speranza?» Artù mi ascoltava con gravità, e la sua espressione lo faceva sembrare più vecchio dei suoi anni. Annuì. «E così sia. Mi hai convinto. Procediamo in fretta.» «Sì. Mentre io conferisco con Enos, tu fa' sfilare le tue truppe nel teatro, come avevamo previsto. Spero che avrai già effettuato i sorteggi.» «È tutto pronto.» E rivolto a Benedetto disse: «Ben, trasmetti gli ordini. Terzio Lucca aspetta». E volgendosi di nuovo a me: «Caio Merlino, sono nelle tue mani per la prossima ora. Cercherò di prestare attenzione a quello che succede. Sei ancora dell'idea che debba colpire la roccia con la spada, una volta che la cerimonia dell'incoronazione sarà conclusa?». Gli sorrisi. «Sì, Artù. Fallo per me.» Assistetti allo svolgimento della cerimonia nascosto dietro un arco del colonnato che coronava la sommità dell'enorme edificio. Il teatro traboccava di gente; i soldati di Artù erano schierati contro il muro in triplice fila. Il corridoio mediano, che dall'entrata scendeva gradualmente fino ai piedi dei gradini dell'altare, era l'unico spazio libero; i passaggi che si irradiavano da quel punto centrale erano affollati. Una volta completata la consacrazione del pane e del vino, sarebbe stato impossibile distribuire l'ostia eucaristica a tutti i presenti. L'avrebbero fatto i vescovi successivamente, nei prati circostanti l'edificio. In prima fila, nei posti d'onore riservati agli ospiti più illustri, sedevano le autorità civili di Camelot. C'erano Shelagh, Ludmilla, Turga, che era stata la nutrice di Artù e ora aveva il volto segnato dall'età; ai due lati di queste tre donne sedevano Luceia e Ottavia, le figlie maggiori di Ambrogio e Ludmilla, la generazione più giovane della famiglia dei Britannico, e più in là numerosi consiglieri anziani di Camelot. Intorno e dietro a questo gruppo si erano raccolti i re della Britannia in rappresentanza delle varie regioni che non avevano ceduto alla forza degli invasori e non avevano accettato il loro dominio. Erano una trentina; ne conoscevo qualcuno. Vidi Derek di Ravenglass, Brander Mac Athol con i fratelli Connor e Donuil, questi ultimi tuttavia un po' in disparte in quanto ospiti e alleati venuti da oltre i confini naturali della Britannia. Dal mio posto di osservazione riuscivo a percepire la tensione e la diffidenza dei re locali, che si tenevano rigidamente in disparte, sebbene fossero tra loro vicinissimi, divisi da sottili barriere di spazi vuoti, che si premuravano di non superare. Lentamente, quasi impercettibilmente, il silenzio si riempì dei mormorii di quanti si sporgevano per commentare le fasi della cerimonia. Enos ci volgeva le spalle, intento a conferire con i suoi vescovi, mentre gli altri prelati se ne stavano nel semicerchio intorno all'altare consacrato. Il brusio della folla si era accentuato non appena erano sfilati i soldati di Artù, ma Enos aveva subito tacitato ogni timore, dicendo che gli uomini in armi erano venuti per presenziare ai riti della Pasqua e prendere l'ostia consacrata. Ma adesso di nuovo il vocio dilagava e a ogni istante cresceva di intensità. Enos si fece avanti levando le braccia, e i sacerdoti con i quali era rimasto a conferire fino a quel momento scesero dal podio consacrato e con dignità, a due a due, sfilarono fuori del teatro. Il silenzio si ristabilì prima che raggiungessero il portale esterno. Una lieve folata di vento mi indusse ad alzare gli occhi al cielo, mentre cercavo di reprimere un brivido, non so se dovuto al freddo o al nervosismo. Se in quel momento fosse cominciato a piovere, sarebbe stato un disastro. Osservando Enos, mi resi conto di avere commesso una sciocchezza ad appollaiarmi in quella postazione in alto, sulla cima dell'edificio. Da lì non riuscivo a vederlo in viso, ma scorgevo soltanto la sommità della sua testa. Enos prese a parlare con una voce assai più sommessa di quella che aveva usato fino ad allora e faticavo a distinguerne le parole. Raggiunsi la scala e mi accinsi a scendere i gradini, alti e pericolosi, per i quali ero salito. Con disappunto mi accorsi che dovevo muovermi con cautela, aggrappandomi alla ringhiera come un vecchio curvo. Era una questione di equilibrio: a ogni passo trascinavo la gamba sinistra, rigida, che rischiava di mancare il bordo del gradino e di farmi cadere. Dovevo quindi avanzare con il piede sinistro e, prestando grande attenzione, poggiarvi il peso del corpo. L'altezza vertiginosa della scala mi era sembrata una inezia nell'andata, quando vi ero salito facendo forza sulla gamba destra sana e trascinando la sinistra, debole e rigida. Ora, nel tragitto inverso, mi sembrava che la fila di gradini si beffasse di me. Mi chiesi che cosa avrei fatto una volta arrivato in fondo. Dove mi sarei diretto? Poi, dimenticando che indossavo i paramenti vescovili, decisi che mi sarei mescolato alla folla. Di tanto in tanto, scendendo, mi fermavo ad ascoltare quello che diceva Enos. Aveva cominciato parlando del Dio di Israele e dicendo che aveva sempre protetto i suoi servi fedeli e vegliato su di loro. Passò poi a raccontare dei Maccabei, i guerrieri fieri e ribelli che avevano combattuto contro i Romani con coraggio e tenacia e avevano lietamente affrontato la morte per difendere la propria fede religiosa. Mentre continuavo lungo il corridoio fino alla successiva rampa di scale, mi chiesi che cosa avessero a che fare i Maccabei con la Britannia. Quando, al sottostante piano, ripresi ad ascoltare, Enos era già passato ai Romani e alla regina Boadicea che aveva lottato contro gli invasori. Cominciava a delinearsi nella mia mente il quadro del suo discorso e a dipanarsi il filo del suo ragionamento, sicché non fui sorpreso di sentirlo parlare di Camelot e delle orde sassoni che minacciavano la Britannia. Vedevo che i soldati avevano sul viso un'espressione compiaciuta e ammiccavano l'uno all'altro soddisfatti. Avevo imboccato la terza rampa quando mi fermai bruscamente. Mi giunse il suono sorprendente e inaspettato di un unico corno di bronzo e lo riconobbi alle prime note: era il richiamo ufficiale di Camelot, che veniva suonato nelle occasioni speciali. Per la prima volta lo sentivo risuonare lontano dalla Colonia. Dai lunghi corni circolari, un tempo usati dai legionari e legati intorno al corpo dei trombettieri, scaturirono delle note profonde. Al primo richiamo, si aggiunse quello del secondo corno dei quattro che avrebbero completato l'appello. Guardai la folla sottostante, affascinato dall'effetto che i suoni producevano su tutti. Mentre la musica saliva in un crescendo e si arricchiva del suono degli altri corni, i presenti furono percorsi da un fremito di stupore e meraviglia. Nel momento in cui le note raggiunsero il massimo dell'intensità, dal portale maggiore entrò Artù Pendragon, scortato da sei vescovi. Percorse lentamente il corridoio fino ai gradini dell'altare. Dal punto in cui mi trovavo non riuscivo a scorgere Enos; vedevo soltanto la sua mano tesa per accogliere il giovane che avanzava a capo scoperto, eretto, il mantello rosso con il grande drago dorato in suggestivo contrasto con i paramenti bianchi del seguito. Non appena ebbe percorso i gradini della piattaforma su cui sorgeva l'altare, i trombettieri tacquero e calò un improvviso silenzio. Imprecando per essere stato così stupido da ficcarmi in quell'angolo poco privilegiato, mi affrettai verso il piano sottostante e, uscito dal teatro, mi trovai oltre le mura esterne. Dovetti quindi percorrere un lungo tratto della cinta perimetrale dell'edificio sulla mia destra. Correvo con tutta la velocità consentita dalla mia infermità, costeggiando il muro e portando avanti a ogni passo la debole gamba sinistra per procedere più speditamente. Sapevo che dall'altra parte della cinta si svolgeva una cerimonia a cui avevo dedicato la mia vita. Ignorai le schiere serrate dei soldati, i fanti, i cavalieri. Nella mente mi si affollavano immagini caotiche e contrastanti. Tra queste c'era lo zio Varro e le pergamene sulle quali aveva scritto i ricordi del nonno Caio e parlato del suo sogno di grandezza, libertà e unità di questa terra; un sogno che avrebbe visto le genti della Britannia sopravvivere alla disastrosa caduta del corrotto impero di Roma per emergere infine vittoriose e forti. All'improvviso, inaspettatamente, mi trovai davanti all'ingresso del teatro, e stranamente fui assalito dal timore di entrarvi. Mentre me ne stavo lì esitante, una goccia di pioggia mi bagnò il viso. Guardai il cielo, ma non scorsi nubi temporalesche; in lontananza, una solitaria chiazza di azzurro pareva promettere una schiarita. Mi addentrai, fermandomi di tanto in tanto ad ascoltare: ero sorpreso dal silenzio di quelle migliaia di persone. Poi, all'interno del santuario, i vescovi intonarono il Credo e pronunciarono le parole solenni e maestose: «Credo in unum Deum...». A circa dieci passi da me, nel mezzo della navata, un solitario accolito, nascondendomi la vista, reggeva una lunga asta sormontata dalla croce avvolta in un drappo viola, proclamando Simbolicamente la presenza di Cristo. Nel vederlo, mi ricordai che quel giorno indossavo le vesti vescovili e con intuizione fulminea seppi che cosa fare. Mi abbassai il cappuccio sulla testa, mi avvicinai all'accolito e, dandogli un lieve colpetto sulla spalla, gli tolsi piano dalle mani la croce. Riconobbe in me un vescovo e, senza obiezioni, si fece in disparte e mi lasciò il posto. Reggendo l'asta come avevo visto fare nelle processioni, percorsi con passo grave la lunga navata verso l'altare, mentre le solenni voci si facevano sempre più possenti a mano a mano che procedevo. Mi fermai quando fui a meno di trenta passi. Fino ad allora nessuno aveva prestato attenzione a me; si erano limitati a prendermi per quello che apparivo. Dietro l'altare, con il viso rivolto alla folla assiepata, sedeva Artù. L'ampio mantello gli ricopriva le spalle e i lembi posati sulle ginocchia scendevano fino ai calzari. Davanti, il mantello aprendosi lasciava intravedere il bagliore cupo della corazza. Sembrava a proprio agio. Vedevo sulla fronte il segno chiaro, lasciato dall'olio santo del crisma e dalle ceneri di palma bruciata. La cerimonia era quindi prossima a concludersi. Mentre le voci del Credo si spegnevano, Enos si girò ancora una volta verso la folla e avanzò di qualche passo, lanciandomi nel frattempo qualche occhiata. «Ai primordi di Roma,» cominciò con voce autorevole «ai tempi della Repubblica e molto tempo prima degli eccessi dell'impero, era costume assegnare ai più audaci tra gli audaci una corona militare. Di queste corone esistevano cinque tipi: ogni corona doveva premiare un particolare atto di valore, ma tutte venivano conferite soltanto a chi avesse dato prova di coraggio e di eroismo. Coloro che le ricevevano erano eroi e campioni di ardimento. Nessuno lo metteva in dubbio; tutti lo riconoscevano pubblicamente.» Tacque e per qualche attimo volse lo sguardo sull'immensa folla. Poi riprese. Nessuno si mosse e il vescovo proseguì abbassando la voce. «Nessuna di quelle corone fu mai assegnata per un'impresa di cavalleria, perché inizialmente i Romani non possedevano un corpo di cavalieri. E, prima che l'umanità venisse redenta dal Cristo, nessuno mai l'ottenne per avere vegliato sulla fede.» Tacque di nuovo. «Oggi la romanità è scomparsa; siamo Britanni. Eppure ci sembra buona cosa che un campione e difensore della fede debba portare un segno di onore. Dell'antica Roma adottiamo questo costume e reintroduciamo la corona.» Mentre così parlava, avanzarono Silvano, vescovo di Lindum, accompagnato da Giunio, vescovo di Arboricum, e da Declan, vescovo di Isca. Silvano reggeva il cuscino ricamato da Tressa su cui era appoggiata la corona d'oro; gli altri due, al suo fianco, facevano oscillare i turiboli dai quali si levavano nuvole di incenso. Si misero dietro al sedile di Artù, ed Enos avvicinatosi a loro prese la corona e la tenne in alto sopra la testa del giovane in modo che tutti potessero vederla. «Ecco la corona della Chiesa di Dio in Britannia. Notate la santa croce sopra il bordo superiore: "In hoc signo vinces”. Con questo segno vincerai.» Abbassò gli occhi e riprese con voce possente: «Artù Pendragon, di stirpe reale, discendente di capitani e di uomini nobili e valorosi, accetti di portare questa corona con tutte le responsabilità a essa collegate, con l'umiltà che si conviene all'unto dal Signore?». «Sì, mio signore e pastore di anime» rispose raddrizzandosi e parlando con voce sonora e vibrante. Enos abbassò la corona fino a sfiorargli quasi la testa. «Ti impegni a servire Dio per tutta la tua vita, obbedendo alla Sua volontà, proteggendo la Sua Chiesa e i fedeli del Suo Divino Figlio, Gesù il Cristo?» «Sì.» Enos posò la corona sulla testa e allontanò le mani. «In hoc signo vinces» disse di nuovo. «In nome di Dio Onnipotente ed Eterno, del Suo Unico Figlio, Gesù il Cristo e dello Spirito Santo, ti proclamiamo riothamus, sommo duce e re spirituale della Britannia, difensore della Fede, rex Britannorum, re di tutti i Britanni. Alzati.» Mentre Artù si levava, il silenzio era quasi palpabile. Tutti stavano con il fiato sospeso. Sentii in gola un groppo di orgoglio e di amore e mi salirono le lacrime agli occhi. Tra la folla non mancavano coloro che avrebbero voluto contestare la cerimonia, ma non osarono farlo in quel momento e in quel luogo. Anche senza guardarmi intorno, percepivo che alcuni dei re lì presenti non apprezzavano affatto quell'incoronazione. Ritraendosi di un passo, Enos fece un cenno di assenso a due vescovi che aspettavano il suo segnale. Questi avanzarono e si misero ai lati del nuovo riothamus, poi, preso ciascuno un braccio di Artù, lo condussero dietro l'altare, con la faccia rivolta alla congregazione. Lì lo lasciarono, allontanandosi, e di nuovo avanzò Enos, avvolto da nubi di incenso, fino a trovarsi a fianco di Artù. Lo prese delicatamente per il gomito, poi gli fece allungare il braccio finché la mano non si posò sulla croce coperta dal drappo viola. Enos quindi si allontanò di un passo e ancora una volta prese la parola. «È cosa fatta. Sulla sacra pietra dell'altare di Dio, sotto gli occhi di Dio e davanti a voi testimoni, quest'uomo, Artù Pendragon, rex Britannorum, si è assunto l'impegno, nel giorno più glorioso dell'anno cristiano, di dare un nuovo inizio alla nostra vita in modo che possiamo tutti operare in fratellanza, senza timori di persecuzioni e invasioni. Il suo è un compito enorme...» All'improvviso, tra la sorpresa generale, Artù lo interruppe: «Posso parlare, vescovo?». Enos annuì con gentilezza e il nuovo re, rivolgendosi alla folla, aggrottando leggermente la fronte e traendo un profondo sospiro, con voce che all'inizio parve esitante e commossa ma che rapidamente si fece più forte e sicura, proseguì. Le sue dita si strinsero intorno alla croce, e mi parve che vi si appoggiasse, quasi ad attingerne forza. «Il vescovo Enos ha detto che davanti a me ho un compito gigantesco, e credo sia così. Ma credo anche che si tratti di un compito possibile da condurre a termine, dato che ho il sostegno e la buona volontà di tutti voi che siete qui presenti oggi e di tutti coloro che abitano le nostre terre.» Tacque e il silenzio si fece ancora più tangibile. «So che alcuni di voi mi ritengono troppo giovane per assumermi questa responsabilità, spirituale e temporale. So che alcuni di voi provano risentimento e paura per la mia incoronazione. Spero che tutto ciò cambierà con il passar del tempo e che riuscirò a convincervi: nessun re, nessun sovrano, nessun guerriero dovrà temere per la salvaguardia dei suoi territori finché io governerò. Avete sentito che il vescovo mi ha dato l'appellativo di riothamus: re spirituale, il combattente di Dio, il difensore della fede. È quanto spero di essere e così intendo regnare. Dai miei maestri, e molti di loro sono qui presenti oggi, ho imparato a essere vigile sul piano morale e tale continuerò a essere. Ma sull'altare di Dio io formulo un ulteriore giuramento. Giuro solennemente che, finché vivrò e regnerò, nessuno - uomo, donna, bambino, indipendentemente dalla sua ricchezza, dal suo rango, dalla sua posizione nella società soffrirà torti per colpa altrui senza che io intervenga a porvi rimedio. Il mio sarà un regno all'insegna della legge, con l'aiuto di Dio e con la vostra collaborazione.» Mi sorpresi con gli occhi umidi, intento a ricacciare indietro le lacrime; sentivo in gola un groppo di orgoglio e amore per quel meraviglioso giovane, leale e coraggioso, che pronunciava quelle parole con sincerità, spontaneità e profonda convinzione. Enos avanzò di nuovo. «Così sia! Alleluia! È compiuto, e sia lode a Dio. Gesù è risorto e il mondo è pieno di gaudio. Preghiamo che il cielo ci dia un segnale, un simbolo della luce di Dio e della sua benedizione.» Mentre così parlava, le nubi si ruppero e un fascio di luce gloriosa e dorata perforò la buia atmosfera e si posò sull'altare. La folla trattenne il respiro con religiosa riverenza; sentii che dietro a me una donna prorompeva in singhiozzi. Nel frattempo Artù si guardava intorno, apparentemente inconsapevole di quella manifestazione che sembrava miracolosa. Mi ci volle qualche tempo per capire quello che stava facendo. Il segnale gli era venuto da Enos con le parole conclusive "simbolo della luce di Dio e della sua benedizione". Cercava con lo sguardo la pietra contenente la spada. Enos si chinò verso di lui, mormorandogli qualcosa all'orecchio e Artù lo fissò sorpreso e chiaramente confuso. Il vescovo annuì e Artù toccò la croce sulla quale aveva prestato giuramento. Prossimo ad afferrarla, ebbe un attimo di esitazione prima di chiudervi intorno il pugno e, levando gli occhi sul vescovo, vide che questi annuiva con la testa. Poi, come le sue dita si strinsero sull'impugnatura coperta dal drappo purpureo, si rilassò e lentamente cominciò a sfilare la spada. I presenti stavano immobili in silenzio, con gli occhi puntati su di lui. Mesi prima, avevo personalmente allargato il foro in cui era piantata la croce, finché non era stato abbastanza largo da accogliere la lama di Excalibur. Quando Artù mi aveva sorpreso quel Venerdì Santo accanto all'altare, avevo appena finito di sostituire con la spada la croce che Enos aveva piazzato la mattina, davanti a tutti, prima di coprirla con il drappo purpureo. Avevo usato il mio pugnale per far saltare il tappo di legno che era stato incollato a fianco del tavolo, perfettamente allineato da Enos direttamente sotto la fessura nell'altare, poi avevo nascosto la croce nell'ampia tasca del mantello e infilato la spada al suo posto, giù attraverso la pietra e il legno sottostante, fino a toccare il pavimento, nascosta alla vista dal lungo telo bianco che ricopriva l'altare. Quando fu fissata al suo posto, avevo rimesso il drappo di porpora esattamente come giaceva prima, in modo che nessuno si potesse accorgere di alcunché. Ero ancora in ginocchio, alla ricerca del tappo di legno che avrebbe potuto tradire l'intera messinscena. Ora Artù stava estraendo la spada, sempre più in alto, fino a tenere diritto il braccio davanti agli occhi. Soltanto allora abbassò lo sguardo sulla lama. Non appena vide l'argentea lama lucente di Excalibur, mentre si era aspettato di vedere la sua semplice lama di bronzo, sul suo viso si diffuse la meraviglia mentre il raggio di sole che illuminava il suo volto parve trasfigurarlo. Tornò a infilare la spada nel suo pertugio e la mano ne abbandonò l'impugnatura. Il drappo ricadde sull'elsa cruciforme. Enos tese un braccio e gli posò una mano tra le spalle, spingendolo innanzi, e di nuovo il giovane re appena incoronato afferrò l'impugnatura. Con movimento lento e deciso trasse la luccicante lama e la levò sopra la testa. L'impeccabile bellezza di Excalibur sfavillò alla luce del sole. Qualcuno sul fondo emise un'esclamazione di esultanza e all'improvviso parve scoppiare il pandemonio. Con gesto rapido Artù allora levò il drappo che aveva nascosto l'elsa e tenne la spada davanti a sé brandendola. Un sorriso di gioia trionfante gli illuminava il viso, mentre tutti esprimevano con voci gioiose il loro entusiasmo. Lo fissavo mentre le lacrime mi scendevano dagli occhi e mi rigavano le gote. Alcuni istanti dopo il suo sguardo si posò su di me e con un sorriso calò la spada verso il basso, percuotendo l'altare con la lama. Il canto della spada si sprigionò come una cosa viva, che in un attimo raggiunse una nota purissima, vertiginosamente alta. Tutti si ritrassero. Sorpreso ancora una volta, Artù abbassò rapidamente Excalibur e non appena la lama ebbe toccato i paramenti dell'altare, il suono si arrestò. Seppur breve, quel canto del metallo si era diffuso fino a raggiungere gli angoli più remoti del teatro. Artù si raddrizzò, gli occhi sgranati sulla spada che teneva in mano. Mi avvicinai a lui, senza darmi pensiero di essere riconosciuto. «Rifallo, Artù, e stavolta tienila in alto e lasciala cantare.» Lentamente sollevò di nuovo la lama e, mentre gli occhi di tutti gli astanti erano fissi su di lui, la calò di piatto sulla pietra dell'altare. La limpida nota si levò pura e netta. Artù tenne levata la spada finché l'ultimo trillo si spense, e in quel momento, con gli occhi levati e le braccia allargate, la tese in modo che tutti potessero vederla. Poi con un gesto solenne, che neppure Germano avrebbe immaginato, ripose Excalibur nella pietra dell'altare e la lasciò lì, con la splendida elsa magnificamente ornata, nera, oro e argento, e la lama infilata nella pietra. Per un lungo attimo il giovane rimase a osservarla, poi tornò a guardare la folla e invitò tutti a sedersi. Non appena si fu ristabilito il silenzio, Artù comunicò, senza artificio e senza recriminazioni, quello che aveva appreso quella mattina: un'invasione era iniziata, probabilmente con forze massicce, e quel giorno stesso egli si sarebbe messo in viaggio per affrontarla. Raccomandò a tutti di rimanere ai loro posti mentre i suoi soldati sarebbero sfilati fuori, e, rivolgendosi ai re, chiese loro di incontrarsi con lui entro un'ora. Allora avrebbe comunicato loro i suoi piani e risposto alle loro domande. Fece un segno di assenso verso Terzio Lucca che diede il segnale alle truppe di Camelot. Ma gli uomini del nuovo re non vollero saperne di andarsene prima di aver dato il loro contributo alla cerimonia di quella giornata. Qualcuno sul fondo pronunciò il nome di Artù e, come un fuoco d'estate, il saluto si propagò finché parve che i muri stessi tremassero sotto l'impeto delle voci. Artù allora estrasse di nuovo Excalibur dalla pietra e per tre volte roteò la lucente lama sopra la testa, mentre le voci raggiungevano l'intensità del rombo del tuono. Poi si volse e si allontanò, portando la spada. Ci volle qualche tempo perché tutti sfilassero fuori dal teatro. Lo trovai poco dopo, quando ormai la folla si era dispersa, intento a fissare la spada. «Si chiama Excalibur» dissi. «L'ha forgiata il tuo bisnonno, sessantanni fa, e da allora, custodita con segretezza in un luogo sicuro, ha atteso che tu raggiungessi la maggiore età per impugnarla. Ora è tua e non ne esiste una uguale. Ecco il fodero. L'ho confezionato io stesso, di recente.» Gli tesi la guaina di cuoio che avevo preparato e lui annuì, ma non fece il gesto di riporre la spada. «Il nome ha un suo significato» proseguii sorridendo davanti all'ammirazione con cui osservava la magnificenza dell'arma. «E non mancano storie e leggende sulla sua fattura. Te le racconterò non appena avremo l'occasione di parlare da soli.» «Excalibur...» ripeté. «Il suo nome è un canto sulle labbra che lo pronunciano... Che cosa vuol dire?» «Vuol dire innanzi tutto che la Britannia ha un re quale mai ha avuto prima. E vuol dire che il re di Britannia possiede una spada che tutti riconosceranno e desidereranno poiché è stata solennemente estratta dall'altare di Dio davanti agli occhi di una moltitudine. Ma non basta: è il dono del tuo bisnonno, che come tuo nonno sognava di te, pur senza averti mai visto né conosciuto...» «Excalibur.» Infilò la lama nella guaina. «Tu sapevi che è una spada che canta, vero?» «Sì, lo sapevo» risposi, sorridendo a quella domanda. «Perché me lo chiedi? Mi sospetti forse di avere praticato qualche arte magica davanti all'altare del Signore?» Mi restituì il sorriso e di nuovo accarezzò con lo sguardo l'elsa ornata. «Hai parlato con le tue zie?» chiesi, schiarendomi la gola. «Non ancora, mi è mancato il tempo, ma le ho intraviste tra la folla. Andrò da loro adesso.» «Sei un vero re, ora... riothamus, rex Britannorum. Re di tutti i Britanni.» «Non ancora, Merlino» disse scuotendo la testa. «Ho il titolo, la responsabilità, i doveri di un re, ma devo ancora conquistarmi la fiducia e l'appoggio di coloro di cui mi dichiaro re. Tra poco, tra un'ora, incontrerò gli altri sovrani. Non sarà facile e sarò costretto a dire ai miei uomini che ci aspetta una guerra da combattere e vincere. Peccato che tu non possa essere al mio fianco nella battaglia. Mi serviranno i tuoi consigli.» «Ti starò sempre vicino con i miei consigli, ragazzo mio. Non ho perduto la capacità di pensare. Tu combatterai, io ragionerò; tu prenderai le decisioni, io provvederò che tutto si svolga secondo la tua volontà. Insieme cambieremo questo paese e tu regnerai nel modo migliore. Sei d'accordo?» «Sì, in nome dell'amore di Dio, lo faremo!» Sorrise e allargò le braccia per stringermi a sé. Restammo così per qualche istante, poi mi sussurrò all'orecchio: «Usciamo insieme a salutare i soldati. Sono ancora i tuoi uomini. Non tutti ti temono o diffidano di te». Allontanandomi un poco e tenendomi davanti a lui, lo fissai negli occhi. «Sarò lieto di stare al tuo fianco, ma non per ricevere acclamazioni e atti di omaggio. La vita che conduco è quella che meglio mi si confà. È stata una mia scelta. Questo è il tuo momento, le acclamazioni spettano soltanto a te.» «Va bene» disse. «Ma aspettami finché non saremo pronti a partire. Ti vedrò prima di partire?» Sorrisi e, postagli una mano sulla spalla, lo avviai verso la porta. "Sì," pensai tra me "mi vedrai, e ne sarò felicissimo, ragazzo mio." Camminando dietro a lui nelle mie vesti vescovili, dissi tra me e me: "Ti vedrò sul cammino della gloria". Qualche ora più tardi, nella spianata all'esterno del grande teatro, in compagnia di Shelagh, Ludmilla, Turga, di parenti e amici, guardai Artù Pendragon, re di Britannia, saltare in groppa al suo cavallo e, avvolto nel manto porpora e oro, levandosi sulle staffe, estrarre Excalibur. La grande lama d'argento scintillò quando lui la roteò sopra la testa. Dovetti chiudere gli occhi e respirare a fondo mentre intorno a me si levava il rombo delle voci degli uomini in armi che acclamavano il suo nome.
Scarica