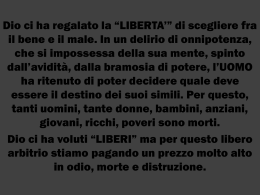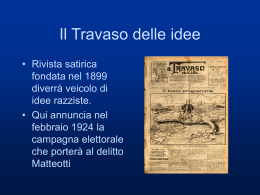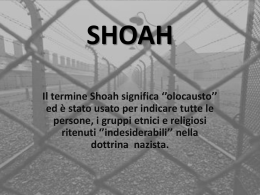LADOMENICA DOMENICA 4 MARZO2012 NUMERO 366 DIREPUBBLICA CULT Nel giorno del suo compleanno All’interno La copertina La nuova vita della poesia tra boom di vendite e social network intervista esclusiva a una leggenda del rock MAGRELLI E SIMIC “Sono fortunato, mi reggo ancora sulle mie gambe” La recensione Il racconto di Nesi: speranza e umiltà della letteratura al tempo della crisi FILIPPO CECCARELLI LOU REED Anni Settanta Il reportage Qui si parla yiddish, viaggio a caccia della lingua perduta MAREK HALTER La storia Zen, scienza e Lsd, la fisica quantistica salvata dagli hippy FEDERICO RAMPINI ANGELO AQUARO I NEW YORK l divo del rock che camminava sul lato selvaggio della vita a settant’anni ha ancora gli incubi di un debuttante qualsiasi. «Mi trovo nel deserto: e ho dimenticato le scarpe. Faccio per prendere l’autobus: e non riesco più a trovare il biglietto. Sono sull’autobus: e ho dimenticato la chitarra. Finalmente arrivo al concerto: ed è già tutto finito. Ecco, questo è il più ricorrente». Ecco, questo è Lou Reed. L’ex ragazzo che a quattordici anni visse l’orrore dell’electroshock, per superare quelle che allora chiamavano “turbe omosessuali”, il 2 marzo ha compiuto settant’anni, ma la moglie Laurie Anderson («L’artista più geniale che conosca: ma forse sono un po’ di parte») ha dovuto organizzargli una festa a sorpresa per superare la ritrosia a festeggiare il Big Birthday. Una carriera lunga e provocatoria come il vero rock: dai Velvet Underground fondati da Andy Warhol ai Metallica snobbati dai critici, che lui solo poteva portare a reinterpretare insieme Lulu, il capolavoro espressionista di Frank Wedekind. «E i loro fan ora mi odiano» dice nell’ufficio-studio nel cuore del West Village, muri a vista e parquet («Niente scarpe, please»), le chitarre in un angolo e il mega-iMac da 22 pollici nell’altro. «Pazzesco: mi odiano — devono avere il quoziente intellettuale di una sedia». Lou Reed ha settant’anni: e come si sente? «Fortunato. Non mi muovo con la sedia a rotelle e posso alzarmi da solo sulle mie gambe». Woody Allen dice che quando si guarda allo specchio rivede lo stesso ventenne. «Abbastanza vero: anche per me. Del resto l’Oscar per la sceneggiatura l’ha preso lui: lasciamogli la battuta». Segue il cinema? La sua prima e ultima volta in un film è stato Blue in the Face di Paul Auster: diciotto anni fa. «Veramente io volevo fare l’attore». E perché ha cambiato idea? «Perché ho sempre avuto una cattiva memoria. E non pensavo di essere bravo abbastanza. Così ho cominciato a scrivermi i miei monologhi in musica: piccole commedie con me come protagonista». (segue nelle pagine successive) FOTO TIMOTHY GREENFIELD SANDERS L’intervista Sem-Sandberg “Quei dimenticati del ghetto di Lodz fuori dalla storia” SUSANNA NIRENSTEIN Teatro Non c’è Brando nel Tennessee Williams di Antonio Latella RODOLFO DI GIAMMARCO Il libro Una certa idea di mondo: “Goldman e la fiaba della principessa” ALESSANDRO BARICCO Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 LA DOMENICA ■ 30 La copertina Anni Settanta Il peso della celebrità: “Andatelo a dire ai minatori”. Il peso dell’età: “Non sto su una sedia a rotelle”. Obama: “Già, dove è finito?”. Israele: “Trasferiamolo nello Utah”. New York: “Troppo cara” Soddisfatto? “Mai”. Intervista alla rockstar che amava passeggiare sul lato selvaggio della vita ANGELO AQUARO Velvet Underground sembrano il frutto del matrimonio segreto tra Bob Dylan e il marchese de Sade”. «Chi l’ha detto?». Richard Goldstein, lo storico reporter dei diritti gay, New York Magazine, 1967. Ma senta quest’altra: “Tre mesi prima di Sgt. Pepper’s, i Velvet Underground hanno chiuso il gap tra il rock e l’avanguardia”. E questo è Alex Ross, 2010, l’acclamatissimo critico del New Yorker. Quale definizione sceglie. «Non ci penso proprio. Paragoni e confronti non mi piacciono. Solo i giornalisti lo fanno. Ti danno i voti: come a scuola». Questa fama di non sopportare i giornalisti: ma non ha studiato giornalismo? Lo scrivono tutte le biografie... «Ho studiato scrittura. Regia». Niente giornalismo. «Appena un semestre: e ne ho avuto abbastanza. Ti insegnavano come esporre tutte le informazioni all’inizio dell’articolo. Dicevano: le opinioni tenetele per voi. Mollato subito. Ma non credo che la categoria abbia sentito la mia mancanza». Però lei col giornalismo, una volta famoso, ci ha comunque provato: è vero che una celebre rivista le rifiutò un articolo? «Come no: Rolling Stone. Volevano fare qualche correzione. E io: voi volete fare qualche correzione a me?». Magari qualche suggerimento. «Qualche suggerimento, certo: ma io non voglio suggerimenti. Dicono che ti correggono la grammatica e tutt’a un tratto suoni come chiunque altro. Quando Andy Warhol fondò Interview le interviste erano tutte piene di “Oh!”, “Uh!”, “Ah!”. Lui voleva che si scrivesse come la gente parla davvero». ‘‘I Andy Warhol è il suo eroe. «Io non ho eroi. Detto questo: un uomo incredibilmente grande. E che fortuna averlo incontrato. Terribile non avere intorno, oggi, uno del suo genio». Oggi abbiamo il digitale, internet, YouTube: tutto un altro mondo. «Mi devo ricordare di ripulire il mio profilo su Google: in questi giorni scattano le nuove regole della privacy. Ma non è incredibile? Voglio dire: io sono il primo a passare lì sopra tutto il tempo — ma che diritto hanno di conservare i miei dati? Oppure YouTube: ormai tutto è su YouTube. Interviste di cinquant’anni fa, che avresti voluto bruciare, dove sei al peggio di te: Dio mio!». Le fa paura? «Guardate Amy Winehouse: così gio- RITRATTI Per i suoi 70 anni Lou Reed ha posato per Repubblica davanti all’obiettivo di Timothy GreenfieldSanders (a sinistra), il grande fotografo e premio Grammy per il documentario Lou Reed: Rock and Roll Hearth vane e perseguitata fino alla morte dalla stampa. Senza scampo». Accusa i media della sua morte. «Oh yes. Voglio dire: non aveva scampo. Tutta quella attenzione su di sé. Sei lì che vomiti, e c’è subito una bella foto in rete di te che vomiti. Buona fortuna». Ma non è piuttosto il frutto dell’ideologia del rock maledetto? “Forse sono destinato a morire giovane: in fondo tutti i grandi cantanti di blues sono morti giovani”. Lo scriveva Lou Reed: nel 1970. «L’ho scritto io? Ah sì, dopo la morte di Brian Jones dei Rolling Stones. Ma che dicevo? Non lo ricordo più». Che viene un momento nella vita di ogni rocker in cui la pressione del pubblico ti costringe a rispondere alle aspettative create dalla maschera. «Nessuno dovrebbe rispondere alle aspettative di nessuno. E poi: ma quali pressioni? E allora chi lavora in miniera? Respiri tutta quella merda, paga orribile. Altro che aspettative: riempito di botte a morte — come un cane. Mentre i signori di Wall Street vengono salvati dal governo e ti fottono tutto quello che possono. A proposito: dov’è finito il nostro uomo? Barack Obama...». Deluso? «Mi piace pensare che si tenga le ali ben strette per ottenere un secondo mandato. Ma avete visto l’opposizione? Rick Santooooorum? Oh my God: that’s fantastic. Se fossi uno di quei paranoici direi che Obama ha organizzato il tutto per farsi rieleggere. Però finora dov’è stato? Un giorno dà un discorso davanti alla statua di Martin Luther King: ma Martin Luther King quel giorno sarebbe stato con i ragazzi di Occupy Wall Street. È per quello che l’abbiamo eletto. E invece no: Obama missing in action. Disperso in battaglia». Quando gli chiedono della rivoluzione anni ’60, Ralph Metzer, il professore che con Timothy Leary diede il là alla cultura psichedelica, oggi dice: “Ma quale rivoluzione. Gli anni ’60 sono stati solo un pallido assaggio di quello a cui stiamo assistendo adesso”. «Per forza. Oggi è l’intero mondo a bruciare. Guardate in Siria. In Egitto è ancora tutto all’aria. E che succederà con l’Iran? Ha diritto ad avere l’atomica? Ok, saranno dei pazzi fottuti — e probabilmente davvero pensano che sia una bellezza mandare all’aria il mondo intero. Io non lo so: spetta a menti più eccelse della mia. E la Siria? Perché questo tizio non prende e se ne va? Ecco, questi sono tutti i soldi che vuoi, ma prendi la tua bella moglie-trofeo e sparisci. Ma spetta poi a noi continuare a fare i poliziotti del mondo? Lasceremo fare agli israeliani?». Lei che ne pensa? «Dice un mio amico che dovremmo prendere Israele e trasferirlo nello Lou Reed “Ero uno che dormiva sui treni ora faccio rock dentro un ufficio” Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 ■ 31 COPERTINE The Velvet Underground & Nico (1967);White Light/White Heat (1967); The Velvet Underground (1968); Loaded (1970); Live at Max’s Kansas City (1972); Lou Reed (1972); Transformer (1972); Berlin (1973); Live 1969 Vol. 1 e Vol. 2 (1974); Rock’n’Roll Animal (1974); Sally Can’t Dance (1974); Lou Reed Live (1975); Metal Machine Music (1975); Coney Island Baby (1976); Rock’n’Roll Heart (1976); Take No Prisoners (1978); Street Hassle (1978); The Bells (1979); Growing Up In Public (1980); The Blue Mask (1982); Legendary Hearts (1983); New Sensations (1984); Live In Italy (1985); Mistrial (1986); New York (1989); Songs for Drella (1990); Magic and Loss (1992); Live MCMXCIII (1993); Set The Twilight Reeling (1996); Perfect Night In London (1998); Ecstasy (2000); American Poet (2001); The Raven (2003); Animal Serenade (2004); Le Bataclan ’72 (2004); Hudson River Wind Meditation (2007); Metal Machine Music Live (2007); The Creation Of The Universe (2009); Lulu (2011) FOTO TIMOTHY GREENFIELD SANDERS Utah: adesso basta, ragazzi, fuori da qui. Insomma: è terribile quello che succede con i palestinesi». Sta dicendo cose molto discutibili e politicamente scorrette: Israele è un paese sotto minaccia. E poi, scusi, lei non è ebreo? «Ebreo di origine russo-polacca. Mi considero democratico senza confini». Ha detto: “Vorrei realizzare nella mia musica il Grande Romanzo Americano”. «Ogni disco è un capitolo». Molti ambientati a New York. «Non sono mica Gore Vidal, seduto nella sua bella villa italiana a scrivere dell’Italia». E com’è cambiata la sua New York dai tempi in cui cominciò? «Dovremmo andare avanti a parlarne per cinque giorni... Molto gentrificata, tutti giovani professionisti. Gli artisti non possono viverci più. Molto molto molto molto molto molto molto molto più cara. La gente si sposta a Brooklyn e anche Brooklyn è ormai cara». Lei è nato a Brooklyn: le manca? «Mi mancano così tante cose». “Penso che la vita sia troppo breve per concentrarsi sul passato. Io guardo piuttosto al futuro”: Lou Reed, 1988. Che cosa vede nel futuro ? «È vero: non mi interessa rivangare il passato. Preferisco il presente». Sì, ma il futuro? «Vivo nel presente: o almeno cerco di. E poi: quale futuro? Per carità: adesso non voglio fare filosofia spiccia. Sono solo un musicista di rock’n’roll». Forse qualcosa in più. «Diciamo che ho mandato avanti anche un altro paio di cosette». Soddisfatto? «Mai saputo cosa voglia dire». “Sarebbe divertente avere un bambino da portare in giro”: così cantava in New York, 1989. Le manca un figlio? «Sarebbe davvero divertente: ma ‘‘ non ne ho. Lì mi divertivo a immaginarlo. La parola chiave è: sarebbe». Solo fantasie. «Ma chi l’avrebbe detto, per esempio, che uno come me avrebbe dovuto avere un ufficio? Ho fatto di tutto nella mia vita per non finire in un ufficio: poi alla fine hai bisogno di un posto dove portare avanti tutte le tue cose ed eccomi qua. In un ufficio. Naturalmente è in un palazzone di artisti: e non mi ci trovo poi così male». Una rockstar in ufficio. «Ma io dormivo sui treni, nelle lobby degli hotel, c’erano le sale dei cinema che restavano aperte tutta la notte: tanti non avevano dove andare a dormire». “La celebrità esige ogni tipo di eccesso”. È l’inizio di Great Jones Street, il romanzo del rock di Don DeLillo. Ed è il 1973: un anno dopo la sua Walk on the Wild Side, la canzone-simbolo di una vita tutta sesso, droga e rock’n’roll. «La celebrità non richiede un bel niente. E ciò che fai della tua vita e del tuo corpo dipende solo da te. Nessuno ti ha chiesto nulla. E non c’è nessuna clausola da rispettare nel contratto». Mai sentito schiacciato dalla celebrità? «Ripeto: la vera pressione la senti in miniera. Avere a che fare con queste stronzate della celebrità non è pressione: è un gioco». Rimpianti? «Nessuno». Niente da recriminare? «C’è questo bellissimo rotolo giapponese di quattro secoli fa. Mostra uno scheletro seduto nella posizione del fior di loto che cerca di ottenere un buon karma: dopo una vita vissuta pericolosamente. L’ho mostrato a Laurie che me ne ha fatto una copia: bellissima. Ma avete presente? Uno scheletro che cerca la posizione per avere un buon karma: forse un po’ troppo tardi, no?». © RIPRODUZIONE RISERVATA Vivere pericolosamente Su un antico rotolo giapponese c’è uno scheletro seduto nella posizione del fior di loto, cerca di ottenere un buon karma dopo una vita vissuta pericolosamente Forse un po’ troppo tardi, no? Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 LA DOMENICA ■ 32 Il reportage Train de vie Fondata da Stalin ottant’anni fa, celebrata come “l’Israele siberiana” e poi dimenticata, la prima repubblica ebraica ancora oggi è uno sperduto baluardo della cultura e della lingua yiddish A riscoprirla ci ha pensato uno scrittore che qui racconta il suo viaggio felice ai confini della memoria A Birobidzhan!A Birobidzhan! MAREK HALTER C hi conosce il Birobidzhan, la repubblica autonoma ebraica creata nel 1932 da Stalin, in Siberia, sul fiume Amur, di fronte alla Cina? Nella mia cerchia di conoscenze, nessuno. Io stesso, che pure ne avevo sentito parlare, la credevo scomparsa da tempo. E invece una sera, a Mosca, con mio grande stupore, vedo un telegiornale che racconta della visita ufficiale del presidente della Federazione russa Dmitrij Medvedev a… Birobidzhan. Non credo ai miei occhi: c’è una delegazione, di cui fanno parte anche due rabbini, ad accoglierlo. Insieme visitano la sinagoga e assistono a un matrimonio ebraico. In questo inizio di XXI secolo, il Birobidzhan esiste ancora e la sua lingua ufficiale è lo yiddish, la mia lingua madre! Sono nato in un mondo che pensavo ormai risucchiato dalle acque, come Atlantide. Ho sempre sognato di mostrare quel mondo al mondo e di apostrofare i miei contemporanei: «Guardate! Guardate quelle persone, ascoltatele. La lingua che sentite, lo yiddish, oggi non la parla quasi più nessuno. Quando ero bambino era parlata da più di undici milioni di persone». Ed ecco che vengo a sapere che esiste un posto dove lo yiddish è ancora parlato, dove è addirittura insegnato. Come avrei potuto non precipitarmi laggiù? Ci sono andato in treno, novemila chilometri da Mosca, come gli ebrei degli Anni ’30. Novemila chilometri sono tanti, ma a differenza di quelli che li percorsero a bordo di vagoni merci appena riadattati, equipaggiati con grandi stufe centrali che bisognava alimentare con ciocchi di legno ammassati nelle stazioni, io viaggio sul Transiberiano, con quattro cuccette per scompartimento coperte da vecchi materassi a righe. «Dove va?» mi domanda con curiosità il controllore capo vedendo che sono accompagnato da un fotografo e da un’équipe televisiva. «A Birobidzhan». «Ah, gli ebrei!», fa lui. E aggiunge, non molto fiero: «Da noi perfino gli ebrei hanno la loro repubblica». Due minuti più tardi ritorna con una divisa nuova di zecca sperando di farsi fotografare. La stazione di Birobidzhan è un casermone in mattoni rossi, con un’insegna, bene in vista, in russo e in yiddish. Speravo di incontrare qualche ebreo sul binario. Ne intravedo tre nell’atrio, con la kippahsulla testa. Mi avvicino. Mi presento e chiedo di cosa stanno parlando. Stanno discutendo del nuovo rabbino, troppo giovane secondo loro. Scoppio in una risata tinta di infinita nostalgia, tanto quanto questi ebrei di Birobidzhan assomigliano agli attori del teatro yiddish della mia infanzia. Quanti ebrei sono rimasti a Birobidzhan, in questa città di settantasettemila abitanti? Non lo sa nessuno. Ufficialmente ottomila, ma un abitante su due ha una bisnonna o un prozio ebrei, compresi i numerosi coreani e cinesi. Allo scoppio della rivoluzione bolscevica, gli ebrei nell’impero dello zar erano quasi cinque milioni. Cinque milioni confinati in zone di residenza, banditi dall’amministrazione pubblica e dalle scuole. Eppure si organizzarono, crearono le loro scuole e i loro sindacati, ma restavano i più poveri dei poveri, i più sfruttati degli sfruttati. Il giorno in cui i commissari bolscevichi li chiamarono «compagni», in yiddish, si sentirono finalmente riconosciuti e aderirono in massa alla Rivoluzione. A partire dagli Anni ’20 e ’30 li si ritrovava in tutte le istituzioni della nuova Russia: la politica, i giornali, la letteratura e il cinema, il teatro e le arti plastiche. I più grandi si chiamano Sergej Ejzenstein, Isaac Babel, Boris Pasternak, Marc Chagall, El Lissitzky, Ossip Mandel’stam, Vasilij Grossman, Mark Donskoj, David Ojstrach, Emil Gilels, Alexis Granowsky, Solomon Michoels…Perfino la sorella maggiore di Lenin, Anna Uljanova, raccontava a chi voleva saperlo che il loro nonno materno, figlio di Moise Blank, di Zhitomir, era ebreo. Stalin si affrettò a far scomparire questa informazione. Cominciava a trovare i suoi amici ebrei troppo vistosi. E troppo irrequieti. Il presidente del Soviet supremo, il vecchio Michail Kalinin, ebbe un’idea. Perché non regalare agli ebrei una repubblica, una regione autonoma come tutti gli altri popoli dell’Unione Sovietica? In questo modo i loro diritti sarebbero stati garantiti e le autorità, senza essere tacciate di antisemitismo, avrebbero avuto la possibilità di rimuoverli dai numerosi posti di responsabilità che occupavano nelle varie repubbliche. Gli ebrei si rallegrarono del progetto. Speravano nel Caucaso e invece ricevettero un pezzo di Siberia, una regione alla frontiera con la Cina, sul fiume Amur, che si chiamava Birobidzhan. Le autorità ci spedirono migliaia di famiglie ebree: Stalin prevedeva centomila persone. Molti partirono volontariamente. Uno Stato ebraico, e per di più socialista! Mancavano ancora quindici anni alla proclamazione dello Stato di Israele. Per opporsi all’ebraico raccomandato dai sionisti, che i comunisti all’epoca consideravano la lingua della sinagoga, il governo dichiarò lo yiddish, la lingua del proletariato ebraico, idioma ufficiale del Birobidzhan. La guerra e le persecuzioni degli ebrei in Europa e nella parte di Russia occupata dai nazisti spingono migliaia di ebrei verso il Birobidzhan, l’Israele siberiana, come alcuni la chiamano all’epoca. La vita culturale si sviluppa. L’agricoltura anche. Il kolchoz Waldheim (“La casa della foresta”) diventa uno dei più esemplari di tutta l’Unione Sovietica. Nasce addirittura, negli Stati Uniti, un’associazione per aiutare gli ebrei del Birobidzhan. La diaspora acquista con entusiasmo macchine agricole e medicinali che spedisce ai suoi fratelli in Siberia. Centinaia di ebrei americani, francesi, argentini, in maggioranza comunisti, raggiunsero il Birobidzhan per partecipare a questa prima avventura nazionale ebraica. Ben presto le purghe staliniane frenarono questo slancio generoso. Diciassette anni dopo, nel 1953, la morte del padrone del Cremlino aprì le porte del Birobidzhan. Gli ebrei sovietici partono in massa verso Israele, svuotando progressivamente la regione autonoma della sua sostanza ebraica. La lenta agonia del Birobidzhan, sommata alla scomparsa delle comunità ebraiche dell’Europa centrale, segnò la fine della cultura e della lingua yiddish. Mi sembrava di essere il testimone della sparizione definitiva di quel mondo di cui anch’io, con la mia memoria, la mia tradizione e il mio accento, faccio parte. Appena usciti dalla stazione, capiamo subito dove ci troviamo: c’è un monumento che domina la piazza, una menorah, il candelabro a sette braccia che è anche l’emblema della regione, appollaiata in cima a una sorta di torre. Qualche metro più in là, un’imponente scultura in bronzo che rappresenta l’eroe popolare ebraico inventato da Sholem Aleichem: Tewje il lattivendolo. In città ci sono due sinagoghe. La prima, quella grande, è affiancata da un altro edificio che ospita un centro culturale e un’associazione di beneficenza. Nella biblioteca trovo, con emozione, i libri di poesie di mia madre. Al primo piano una dozzina di donne si riuniscono tre volte la settimana per cantare delle melodie tradizionali yiddish. La seconda sinagoga è un’isba (tipica casa di campagna russa, ndr) degli anni ’40. Ce n’era anche una terza, più antica, ma è stata distrutta da un incendio. «Era all’epoca di Krusciov», mi dice il rabbino Andrej Lukatski. «Non è da escludere che si sia trattato di un incendio doloso». Il rabbino mi racconta che suo padre riuscì a salvare dalle fiamme i rotoli della Torah, rotoli che lui è riuscito a far restaurare grazie all’aiuto della vicinissima comunità ebraica giapponese. «Li vuole vedere?». Siamo nella sua sinagoga, la sua isba, ornata di un’enorme stella di David intagliata nel legno. All’interno, su una panca, addossata al muro, la moglie del rabbino e tre vecchie signore che in inverno vengono qui a riscaldarsi. Il rabbino prende un mazzo di chiavi e apre non l’armadio che tradizionalmente ospita i rotoli della Torah, ma una cassaforte. Commosso, lo aiuto a togliere la mantellina di velluto elegantemente ricamata che protegge i rotoli. Il rabbino ha due figli adulti in Israele. Gli chiedo: «E lei, perché non ci va?». Il rabbino si meraviglia della domanda: «E chi custodirà la sinagoga?». «E quando lei sarà morto?». Andrej Lukatski mi racconta che ha un terzo figlio di sei anni, e che l’ha concepito, insieme a sua moglie, perché si faccia carico della tradizione quando lui non ci sarà più. «Il ricambio è assicurato», dice soddisfatto. L’ex attrice Polina Moissenevna Kleinerman ci tiene a cantare per me Mein yiddische Mame, “La mia mamma ebrea”. Non ha più voce, ma le restano i gesti e la mimica. La ascolto e pian- L’AUTORE Scrittore, ma anche pittore e fondatore con Bernard-Henri Lévy del movimento SOS Racisme, Marek Halter nasce nel 1936 in Polonia, la madre poetessa in lingua yiddish, il padre tipografo A cinque anni fugge con i genitori dal ghetto di Varsavia. La famiglia si rifugia in Russia e poi in Francia dove Halter ancora vive Collabora con numerose testate tra cui Libération, Paris Match, El Pais e Repubblica. Il suo ultimo libro uscito in Italia è Il cabalista di Praga (Newton Compton) go. È in compagnia di questa piccola comitiva che visito il vecchio cimitero di Birobidzhan. Polina Kleinerman non ha dimenticato di portarsi dietro una busta riempita di sassolini, in modo che ognuno di noi, secondo la tradizione ebraica, possa lasciarne uno sulle tombe a testimonianza del suo passaggio. Birobidzhan non è soltanto una città. È una vasta regione, grande il doppio del Belgio, annunciata al suo ingresso da un edificio monumentale con un’iscrizione in caratteri cirillici ed ebraici. I kolchoz ormai sono chiusi, come in tutta l’Unione Sovietica, ma alcuni ebrei hanno acquistato dei pezzetti di terra che continuano a coltivare. Ziama Michailovic Geffen ha novantadue anni. Sta appoggiato a un bastone mentre ci mostra il suo cortile e le sue capre. «Capiscono lo yiddish!», dice ridendo. Il suo occhio azzurro si anima quando rievoca il suo arrivo nella regione. Era proprio all’inizio, negli Anni ’30. Aveva undici anni. «Non c’era niente qui, nient’altro che la taiga. Abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo dissodato i campi, costruito la città, la stazione, le scuole. Abbiamo perfino lanciato un giornale…». Il Birobidzhaner Stern, “La stella di Birobidzhan”, esiste ancora. Originariamente era un quotidiano, pubblicato integralmente in yiddish. Oggi è un settimanale in russo, con soltanto quattro pagine in yiddish. La direttrice non è ebrea. Elena Ivanovna Sarashevskaja, che ha appena trent’anni, ha sposato un ebreo e ha imparato lo yiddish all’università. Quanti lettori ha il giornale? Non sa rispondere. La tiratura è di cinquemila esemplari venduti nelle edicole. Ne compro due copie come ricordo. Dopo aver scelto due riviste in russo un uomo, piuttosto giovane e biondo, ne prende una copia anche lui. Gli chiedo se è ebreo. «No. Lo pensa perché ho comprato il Birobidzhaner Stern? Lo compro tutte le settimane. Mi piace sapere che succede tra gli ebrei. Con loro c’è sempre da imparare…». La sua risposta mi ricorda quell’altro abitante del Birobidzhan che cercava della vodka kasher al mercato. Quando gli ho chiesto il motivo, mi ha risposto: «Se è una vodka ebraica, sicuramente dev’essere più buona». È forse questo il motivo del successo della trasmissione Yiddishkeit (“Ebraicità”), che va in onda sulla televisione locale e che offre un’introduzione alla cultura e alle tradizioni ebraiche? «Prima», mi dice Tatjana Kandinskaja, la presentatrice, «facevamo la trasmissione in yiddish. Oggi non ci sono più molti che lo capiscono. Ma da quando siamo passati al russo, questa trasmissione è diventata una delle più popolari della nostra rete e viene mandata anche alla radio». Nella macchina coreana che ci porta in giro per la città, cerco di sintonizzarmi sulla sua trasmissione. A Birobidzhan tutti girano a bordo di macchine coreane, con il volante a destra. Qui la Corea è vicinissima e l’Europa, distante diecimila chilometri, è qualcosa di vago e indistinto. Finalmente sento la voce di Tatjana Kandinskaja. Annuncia una puntata sul significato dello shabbat e le tradizioni culinarie che accompagnano questo giorno di riposo. Tra qualche minuto tutti sapranno come si prepara il Gefilte fish, la carpa farcita. Nell’attesa si sente la voce profonda di un uomo che canta: «Ho traversato oceani e continenti e non ho trovato nessun paese bello come il mio Birobidzhan». Arriviamo davanti al Teatro nazionale ebraico, inaugurato nel 1936 dal numero due del regime di Stalin, Lazar Kaganovic in persona. Quando entro nella sala, gli attori stanno provando una commedia musicale, I cercatori di felicità, da un film di propaganda realizzato nel 1936. Rimango turbato a vedere questi giovani che ballano e cantano sul ritmo della musica di Isaac Dunajevskij: «Addio America, addio Europa, buongiorno patria nostra, nostro Birobidzhan». Eppure siamo nel XXI secolo e lo Stato di Israele esiste da quasi sessantacinque anni. Ma qui, contrariamente a Israele, si studia lo yiddish. In una classe che visito, una giovane maestra insegna l’alfabeto ai bambini. Sconvolto dal fatto di ritrovarmi a casa, sì, a casa, a più di undicimila chilometri da Parigi, incrocio uscendo una cinese, madre di uno degli alunni, e le domando: «Perché fa imparare lo yiddish a suo figlio?». Lei mi risponde: «Può servire…». Scoppio a ridere. I cinesi sono un miliardo e duecento milioni e gli ebrei appena quattordici milioni. E tra di loro, solo una manciata ormai parla ancora lo yiddish! Ho sempre pensato che Hitler avesse perso le sue due scommesse: cancellare gli ebrei dalla faccia della Terra e trasformarli in qualcosa di diverso dagli esseri umani. Credevo però che su un punto avesse avuto successo: distruggere una civiltà ebraica, la civiltà dello yiddish. Credevo che il nazismo avesse annientato completamente quel mondo. E ora quaggiù, nel Birobidzhan, quel mondo è ancora vivo e pulsante, come l’eco lontana di una civiltà ferita. Seppellire la memoria, e in particolare la memoria di una lingua, è più difficile che seppellire i corpi. (Traduzione di Fabio Galimberti) © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 FOTO THIERRY ESCH ■ 33 LA STAZIONE. Tre amici con la kippah davanti alla stazione di Birobidzhan, un casermone in mattoni rossi, con l’insegna bene in vista in russo e in yiddish: vivono qui da quando erano piccoli LA SINAGOGA. La più vecchia delle due sinagoghe della città è ospitata in una isba degli anni Quaranta IL CIMITERO. I fedeli rendono omaggio a un amico scomparso A TAVOLA. La colazione dentro la sinagoga: la donna seduta LA SCUOLA. Una giovane maestra insegna l’alfabeto yiddish al centro è una ex attrice, Polina Kleinerman ai bambini: la maggior parte di loro non sono ebrei nel vecchio cimitero ebraico di Birobidzhan IL GIORNALE. Halter davanti alla sede del Birobidzhaner Stern: nato in yiddish, ora è un settimanale scritto in russo IL PASTORE. Ziama Michailovic Geffon è il più vecchio lavoratore dell’antico kolchoz: parla in yiddish alle sue capre Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 LA DOMENICA ■ 34 La storia Illuminazioni Ritiri zen sulle spiagge della California, esperimenti di telepatia, lezioni di yoga e di buddismo, spinelli e l’Lsd. Ma anche rigore e preparazione. Ecco il libro che racconta l’avventura di un gruppo di studiosi “scontenti, squattrinati e sottoccupati” che rivoluzionò la teoria quantistica Fisica Hippy FEDERICO RAMPINI n un prossimo futuro i nostri dati personali più preziosi, dal conto bancario alla carta di credito, forse saranno finalmente al sicuro dai furti degli hacker informatici. Se questo accadrà, sarà una delle applicazioni della crittografia quantistica. La stessa tecnologia, secondo l’astronomo John Gribbin della University of Sussex, consentirà il tele-trasporto di particelle che sarà alla base di una nuova generazione di “quantum computer”: la loro potenza sarà tale che «i nostri pc attuali ci sembreranno dei pallottolieri». La teoria quantistica è un ramo della fisica delle particelle e oggi attira migliaia di ricercatori nel mondo intero. Riceve finanziamenti per miliardi di dollari dalle grandi università e fondazioni scientifiche in America e non solo. Ma appena quarant’anni fa gli studi di fisica erano in uno stato di profonda crisi: la guerra del Vietnam concentrava i fondi nel Pentagono; lo stesso conflitto del sudest asiatico aveva spinto Washington a inviare al fronte anche molti giovani dottorandi (abrogando il privilegio del rinvio del servizio militare per gli universitari); i campus delle facoltà americane erano paralizzati dalla contestazione pacifista; una grave crisi economica provocata da shock petrolifero e stagflazione inaridiva le spese per la ricerca pura. Quelli che continuavano a occuparsi di fisica erano per lo più degli “integrati” al servizio del complesso militar-industriale. A rilanciare gli studi di fisica quantistica ci pensarono gli hippy californiani. Per la precisione, un gruppo di giovani studiosi «scontenti, squattrinati, sotto occupati e sempre curiosi», si riunì all’università di Berkeley, sulla baia di San Francisco, per «liberarsi dal conformismo accademico e avventurarsi nell’esplorazione del lato selvaggio della scienza». Fondarono un club esoterico, il Fundamental Fysiks Group, i cui metodi di ricerca erano a dir poco eterodossi. Si riunivano come congiurati in luoghi di ritiro zen sulle spiagge californiane. Passavano ore immersi in vasche di idromassaggio. Fumavano marijuana e qualcuno sperimentava l’Lsd. Si appassionavano di religioni orientali e trasmissione del pensiero. La loro storia viene ricostruita da un altro scienziato, David Kaiser del Massachusetts Institute of Technology (Mit), autorevole esponente della stessa disciplina: è stato eletto Fellow dell’American Physical Society. Come gli hippy salvarono la fisicaè la sua opera. Sottotitolo: Scienza, contro-cultura e il revival dei quantum. Questo libro è anche un gesto di gratitudine. Kaiser, che era un liceale quando «gli hippy salvarono la fisica», confessa di avere subìto «un’attrazione e un fascino per le opere di quel gruppo di giovani scienziati»: per lui fu la nascita di una vocazione. PER GENTILE CONCESSIONE FRED ALAN WOLF I SAN FRANCISCO Scienza, droga e rock’n’roll ANTICONFORMISTI Il Fundamental Fysiks Group nel 1975: da sinistra, Jack Sarfatti, Saul-Paul Sirag, Nick Herbert, Fred Alan Wolf Nella foto grande al centro, terapia di gruppo durante un incontro all’Esalen Institute, a Big Sur, in California, nel 1968 I personaggi al centro di quell’epopea sono pittoreschi. Fred Alan Wolf, socio fondatore del Fundamental Fysiks Group, è descritto come un «attore di vaudeville della New Age», seguace del guru delle droghe psichedeliche Timothy Leary, convinto di poter raggiungere poteri paranormali di comunicazione extrasensoriale. L’italo-americano Jack Sarfatti, un altro membro dello stesso club, riceveva i finanziatori a cui chiedeva fondi per le ricerche in una saletta privata al Caffè Trieste, mitico ritrovo nel quartiere italiano North Beach di San Francisco. Fritjof Capra divenne il più celebre nel 1975 grazie a un best-seller rimasto un classico di quell’èra: Il Tao della fisica. Quasi altrettanto successo ebbe Gary Zukav con il libro I maestri danzanti Wu Li. Una volta all’anno, la riunione del gruppo avveniva sulla costa di Big Sur, presso l’Esalen Institute, fra sessioni di yoga, lezioni di buddismo, e happening collettivi di autocoscienza. Erano a tutti gli ef- fetti “figli dei fiori”, tipici rappresentanti di un’epoca in cui la California era attraversata dalla corrente della New Age, quando i giovani si riunivano a vivere in campagna nelle comuni egualitarie e ambientaliste, contestavano al grido di «fate l’amore non la guerra», ascoltavano Jimi Hendrix e Janis Joplin, i Grateful Dead e Jefferson Airplane. Il fenomeno degli scienziati hippy non passò inosservato neppure in quegli anni. Tra i più acuti nell’avvistarlo ci fu un certo Francis Ford Coppola, la cui carriera di regista spiccava il volo proprio allora. Con i soldi guadagnati grazie a Il Padrino e alla produzione di American Graffiti, l’italo-californiano Coppola si comprò il magazine City of San Francisco. Uno dei primi numeri della rivista sotto la sua direzione fu dedicato ai «nuovi fisici che lavorano con la telepatia e s’immergono nel subconscio per sperimentare la mobilità psichica». Dalla lettura del pensiero alla reincarnazione, dalla comunicazione con gli extraterrestri al misticismo induista, la confusione dei generi era totale. Eppure, come spiega Kaiser, «quel gruppo di outsider, di emarginati e di reietti riuscì a ravvivare la fiamma della scienza». Perché dietro le apparenze hippy c’erano «veri scienziati, con solide basi di preparazione, metodi anticonformisti eppure rigorosi». Del resto c’era una sottile continuità tra loro e il gruppo di pionieri della meccanica quantistica, cioè Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Erwin Schroedinger: anche loro erano tutt’altro che “aridi” scienziati, adoravano discutere di filosofia, politica, massimi sistemi. Le implicazioni delle loro scoperte li portavano a spaziare in campi molto diversi dello scibile umano. Anche i “padri”, come dimostra il pacifismo di Einstein, avevano perseguito strade anticonformiste e contestatrici. Che i fisici hippy non fossero degli sprovveduti, lo dimostra il fatto che uno dei loro saggi, Quantum Reality di Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 PER GENTILE CONCESSIONE DI FRED ALAN WOLF PER GENTILE CONCESSIONE DI ROMAN JACKIW ■ 35 IL LIBRO Nick Herbert, è tuttora usato come manuale nelle facoltà di fisica americane. Scavando sotto la superficie tutta “sesso droga e rock’n’roll”, Kaiser individua in due contributi decisivi l’eredità rivoluzionaria del gruppo riunito a Berkeley negli anni Settanta. I ragazzi del Fundamental Fysiks Group si misero in testa di poter trasmettere dei segnali a una velocità superiore a quella della luce. Un obiettivo impossibile, in base alla teoria della relatività di Einstein. La ricerca sui “segnali superluminali” fu contestata da altri fisici, i quali però furono costretti a dimostrare l’errore, approfondendo le conoscenze sui quantum. Due dei fisici hippy, Herbert e John Clauser, fecero esperimenti sul cosiddetto teorema di Bell, secondo cui due particelle subatomiche una volta entrate in contatto resteranno allacciate anche dopo essere state allontanate: un principio da cui altri arrivarono alla possibilità di criptare i messaggi per renderne impossibile l’intercettazione. È in questo processo di “refutazione” che alla fine si arrivò allo sviluppo della crittografia quantica, le cui potenziali applicazioni cominciano solo ora a essere comprese. Kaiser traccia un parallelo con quel che era accaduto nell’Otto- FOTO ROGER RESSMEYER, PER GENTILE CONCESSIONE CORBIS PER GENTILE CONCESSIONE DI ROBERT L. JONES E JACK SARFATTI Come gli hippie hanno salvato la fisica di David Kaiser (Castelvecchi, 380 pagine, 22 euro) è ora in libreria. A destra, la bozza di un articolo del 1973 di Jack Sarfatti e Fred Alan Wolf. Sopra, i partecipanti a una conferenza di fisica teorica della fondazione est nel ’78: al centro Stephen Hawking ECCENTRICO MISTICO L’italo-americano Jack Sarfatti nel 1979: riceveva i suoi finanziatori al Caffè Trieste di North Beach, a San Francisco Fritjof Capra presenta Il Tao della fisica nel 1977: teorizza l’avvento di un nuovo paradigma ispirato al misticismo orientale cento quando alcuni scienziati si erano messi in testa di mettere a punto le macchine del moto perpetuo: lo sforzo dei loro colleghiavversari di dimostrarne l’impossibilità fece compiere dei progressi decisivi nella comprensione delle leggi termodinamiche. L’altro lascito dei fisici hippy fu perfino più importante nel lungo periodo. Grazie al successo di libri come Spazio-Tempo e oltre di Sarfatti, oltre al Tao della fisicadi Capra, una generazione di giovani cominciò a sentirsi attratta dagli studi di fisica nucleare. Improvvisamente quell’orientamento di studi non fu più associato con l’asservimento alle strategie militari della Guerra fredda. Nei campus delle accademie scientifiche si moltiplicarono i corsi con titoli come “The Zen of Physics”. Fu l’inizio di un lungo boom nelle iscrizioni a quelle facoltà. Se Bill Gates e Steve Jobs resero sexy l’informatica negli anni Ottanta, nel decennio precedente i giovani scienziati cultori dell’Lsd e della New Age erano riusciti a rendere cool una delle scienze più complesse e raffinate. E questo fu uno dei fiori sbocciati davvero, nel clima caotico e trasgressivo dei movimenti che ribollivano nella baia di San Francisco quarant’anni fa. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 LA DOMENICA ■ 36 Spettacoli Jeanne Moreau col fiatone portata in braccio da Jules e Jim dopo aver girato la sequenza simbolo della Nouvelle Vague Rivoluzioni È uno degli scatti di Raymond Cauchetier, fotografo di scena Ora, novantenne, viene celebrato a Parigi e Los Angeles “E pensare che ci pagavano come manovali” ANAIS GINORI L PARIGI a scena dura trenta secondi. Jeanne Moreau corre a perdifiato sopra un cavalcaferrovia con i suoi spasimanti, Henri Serre e Oscar Werner, che la inseguono. Sembrano spiccare il volo. Di quello slancio di libertà è rimasta un’immagine, l’icona del film, Jules e Jim, ma anche di un movimento che ha segnato per sempre il cinema. Raymond Cauchetier era accanto a François Truffaut con la sua Rolleiflex, macchina fotografica solitamente usata nei reportage di guerra e che lui aveva preso in Indocina, arruolato nell’aviazione militare. Nello scatto successivo si vede Moreau, esausta, portata in braccio dai due uomini dopo le riprese. In un altro momento inedito l’attrice gioca a fare la maglia. L’uomo che inventò il Backstage “Prima e dopo c’era un altro film” IMMAGINI In alto, in senso orario: Jeanne Moreau fa la maglia con Sabine Haudepin sul set di Jules e Jim (1961) di François Truffaut; Anouk Aimée in Lola (1960) di Jacques Demy; Jean-Luc Godard e Raoul Coutard (dietro la telecamera) mentre girano La donna è donna (1961) Nella pagina accanto, Jeanne Moreau corre sul cavalcaferrovia inseguita da Oscar Werner e Henri Serre in Jules e Jim Cauchetier è l’occhio nascosto. Dietro la telecamera, e dietro i registi. Per dieci anni spettatore di alcuni dei più grandi set della Nouvelle Vague, ha catturato tutto ciò che ruota intorno a quella strana umanità di celluloide. Mentre Truffaut, Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Claude Chabrol e tanti altri reinventavano il modo di girare, lui trasformava lo sguardo del backstage. «Quando ho capito cosa stava accadendo, mi sono detto che dovevo comportarmi come un giornalista davanti a una rivoluzione» racconta lui, novantaduenne, celebrato in questi giorni da due mostre, alla galleria Polka di Parigi e all’Academy of Motion Pictures Arts and Science di Los Angeles. All’inizio degli anni Sessanta, il fotografo di scena era ancora considerato dalla troupe come un fastidioso intruso. Poteva scattare solo un attimo dopo che il regista urlava «Coupez!». Gli attori restavano in posa, lui doveva limitarsi a ricalcare la stessa inquadratura, fornire un prodotto immediato per la promozione. «Prima di me non veniva riconosciuto un valore artistico al nostro mestiere. Eravamo pagati come i manovali. Alcuni registi ci consideravano delle spie del produttore che spesso scrutava le nostre immagini per sorvegliare le riprese, vigilare sull’opera in divenire». Tutto parte da un’intuizione, racconta Cauchetier: «Ogni set racchiude una storia che integra e completa il vero film». Quell’avanguardia un po’ folle diventa così un album da sfogliare. Nel 1959 Godard sta parlando in un café con Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo prima delle riprese di A bout de souffle. Lo guardano perplessi. Gli attori iniziano la giornata senza copione. Il regista scarabocchia qualche foglio, spiega frettolosamente. Sul tavolo, una tazza di caffé, il mensile Positif. Ciak, si gira. E Cauchetier è il primo testimone di quest’improvvisazione permanente. Mostra la telecamera nascosta in un carrello della posta che segue Seberg e Belmondo sugli Champs-Elysées. Riprende la stanza 12 dell’Hotel de Suéde, rive gauche, dove in pochi metri quadrati si gira la scena d’amore. Senza luce artificiale, né fonico. Il regista sussurra le battute agli attori mentre stanno recitando. Seberg, che ha già lavorato con il dispotico Otto Preminger, minaccia di andarsene. «Godard aveva un disprezzo totale delle regole cinematografiche, non face- SUL SET Godard spinge l’operatore seduto in carrozzella durante le riprese di A bout de souffle (1960) A destra, i protagonisti Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 ■ 37 Così il pubblico scoprì che a fare il cinema sono i registi EMILIANO MORREALE ai tempi dello studio system, le fotografie di scena hanno avuto sempre una funzione fondamentale per propagandare il mito del cinema, e in particolare il cuore di questo mito: i divi, con la loro prossimità e abissale lontananza. Ma negli anni della Nouvelle Vague, in tutto il mondo cambia qualcosa. Intanto, in questi film girati con apparecchiature più leggere, con troupe ridotte, da giovani, si ha un rapporto meno rigido, meno ufficiale, con la macchina-cinema. Fare un film è un’avventura, una scoperta, o come aveva scritto Truffaut «un atto d’amore». E il fotografo di scena coglie momenti che non sono più quelli, sempre un po’ artificiali, del cinema fatto negli studios. Ma c’è anche un altro dato. In quegli anni è sempre più il regista stesso a diventare nome, divo quasi. E la foto di scena, oltre che ritratto di volti famosi, diventa anche ritratto d’artista, di uomini che fanno il cinema. Nel cinema italiano, se Rossellini era soprattutto soggetto da rotocalchi per le sue turbinose storie d’amore, il primo vero regista-divo è Federico Fellini. La dolce vitaè un crocevia anche in questo, e porta oltretutto allo scoperto il connubio con un altro genere di foto “di cinema”, meno nobili: quelle dei paparazzi, che proprio esso battezzava. I film francesi immortalati da Cauchetier hanno in più un tono di gio- D ventù all’arrembaggio, di scampagnata tra coetanei, ma anche di sfida assai seria. Ma negli anni successivi, anche i cosiddetti movie brats (la generazione di Spielberg, Coppola, Scorsese) vanno all’assalto di Hollywood, e anche lì restano famose foto di questi trentenni, talvolta barbuti, alle prese con macchine produttive a volte colossali. Le immagini più toccanti, però, rimangono forse quelle di un outsider come John Cassavetes, attorniato da un gruppo di attoriamici, impegnati a concepire i film come un happening o uno scavo crudele. Mentre nel frattempo le foto dei divi in scena e fuori si fanno assai meno glamour, con le facce umanissime di De Niro o Dustin Hoffman. Oggi, in Italia, le foto di scena sono un ambito che ha visto emergere talenti notevoli (basti citare tra i tanti, Angelo Turetta o Philippe Antonello), anzi forse è uno dei generi che consentono una creatività particolare, tra realtà e finzione. Specie quando lo sguardo sui film è anche sguardo sui luoghi che le troupe attraversano, sugli angoli di una penisola che i registi riscoprono (talvolta) di saper guardare. E nell’incrocio tra set, fotografo e regista va ricordato anche un exploit paradossale: il viaggio di Ferdinando Scianna sul set di Baarìa, in Tunisia, ma a film finito, a visitare i fantasmi del cinema e della memoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA va neanche i raccordi per il montaggio». Cauchetier si adatta, riscrive anche lui i canoni della sua professione, inventa una narrazione propria. Incomincia a muoversi intorno al set, rubando momenti di ansia, discussioni, esplosioni di felicità. Oggi è anche grazie al suo archivio che si può capire come lavoravano quei giovani artisti con pochi mezzi e tanta fantasia. Godard che spinge l’operatore seduto in carrozzella, come una macchina bionica. Claude Chabrol che fa il pagliaccio. «Amava fare le smorfie, sapeva che non avrei resistito alla tentazione di scattare». Truffaut a bordo di una Citroen 2Cv riadattata per le riprese di Adieu Philippine. «Era un talento puro, un inquieto, aveva bisogno di essere costantemente rassicurato». Nella sua casa parigina, Cauchetier conserva migliaia di scatti, la memoria di un’epoca, ha fatto la cronaca della genesi di tanti capolavori. Per molto tempo, non ha avuto neppure il copyright delle sue immagini. Solo nel 1992, grazie a una legge sul diritto d’autore, si è rimpossessato dei suoi archivi, conquistandosi la stima di molti cultori di quel cinema. Mezzo secolo dopo, gli resta un po’ di nostalgia. È convinto che il suo sia un mestiere finito. Molte produzioni tagliano i costi del fotografo di scena. Con le riprese in digitale è possibile avere un’instantanea direttamente dal girato. Il dietro le quinte si è spettacolarizzato con video, interviste, director’s cut. Lo chiamano “bonus”. Forse non è più tempo di bizzarre utopie. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 LA DOMENICA ■ 38 Next Passaparola MOCKINGJAY di Suzanne Collins CATCHING FIRE di Suzanne Collins Si compra un testo elettronico su Amazon, lo si scorre e lo si sottolinea su Kindle. Le note finiscono in un sito insieme a quelle degli altri lettori “Perché a volte le cose accadono alle persone e queste non sono in grado di affrontarle” Così si condividono frasi, passaggi, pensieri. Così nasce il meta-libro e così cambierà il nostro modo di leggere frase sottolineata 13.983 volte “Ci vuole dieci volte più tempo per rimettere insieme che per fare a pezzi” frase sottolineata 8.482 volte ORGOGLIO E PREGIUDIZIO di Jane Austen “È verità universalmente riconosciuta che uno scapolo con un solido patrimonio debba essere in cerca di una moglie” ‘‘ frase sottolineata 8.340 volte Questo è probabilmente il mio ultimo libro cartaceo perché l’attenzione ormai è altrove La gente trascorre sempre più tempo su cose che succedono sugli schermi Non è mancanza di amore per i libri, è che il centro della cultura si è spostato Kevin Kelly fondatore di Wired 20mila I titoli di ebook in Italia nel 2011: nel 2009 erano 1.600 35mila I titoli elettronici in Gran Bretagna nel 2011: hanno sorpassato le nuove uscite in brossura (28mila) RICCARDO STAGLIANÒ rimaviene la Bibbia. Seconda la biografia del profeta Steve Jobs. Al sesto posto le tavole delle legge di Timothy Ferris, il guru di 4 ore alla settimana per il tuo corpo («Regola numero 1: evitate i carboidrati “bianchi”»). Sono tra i libri più sottolineati di Amazon, riduzione digitale della biblioteca di Babele. La classifica è affidabilissima perché siamo noi a compilarla quando, leggendo un ebook, evidenziamo con un dito un passaggio che ci piace. A quel punto l’algoritmo calcola quante altre persone hanno segnato lo stesso titolo o apprezzato la stessa frase e compila la graduatoria sul sito. Così la lettura diventa statistica. I libri degli altri diventano i nostri. Non necessariamente dall’inizio alla fine, magari solo alcune righe rimarche- P WIKI Il romanzo a più mani scritto coi nostri touch voli. Tra qualche anno, alla domanda «l’hai letto?», si potrà rispondere senza mentire «sì, ma solo le dieci frasi più annotate». Probabilmente Borges non sarebbe contento. Bauman, invece, potrebbe intenderlo come l’ennesimo inveramento della «modernità liquida», con tutta la frammentarietà che l’accompagna. Filosofie a parte, il salto è davvero forte. E di recente sempre più persone si sono convinte a far- lo. L’inglese Penguin ha appena annunciato che i suoi introiti da ebook sono raddoppiati in un anno e costituiscono il 12 per cento del fatturato. Sempre in Gran Bretagna è avvenuto il sorpasso dei titoli elettronici rispetto alle nuove uscite in brossura, 35mila contro 28mila nel 2011. Accelerazione fortissima anche in Italia: 1.600 titoli nel 2009, 7.000 un anno dopo e quasi 20mila all’ultimo Natale. Il problema, da noi, è che tanta offerta partorisce per ora lo 0,1 per cento del fatturato. Ma a giudicare dall’attivismo editoriale sembra chiaro a tutti che il conto economico cambierà in fretta. Chi supera l’ostacolo culturale difficilmente torna indietro. L’argomento dei tradizionalisti è quello cui Luciano De Crescenzo aveva appiccicato un’etichetta fortunata: «libridine», ovvero il godimento di avere tra le mani l’oggetto di carta. L’esperienza tattile si perde, e non è perdita da poco, ma quella cognitiva viene aumentata in così tanti modi che nel complesso la compensa con gli interessi. Riassumendo, una volta comprato un titolo, con un risparmio minimo di un terzo rispetto al prezzo cartaceo, si può leggere su Kindle, il lettore della casa, o sulle app gratuite per visualizzarlo su smartphone, tablet o computer. A quel punto si possono sottolineare delle parti e anche aggiungere commenti propri. Gli uni e gli altri Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 ■ 39 Ebook Epub Kindle Il libro elettronico è un file di testo che può essere visualizzato su un apposito lettore digitale Abbreviazione di electronic publication, in Italia è uno dei formati di ebook più diffusi In America di gran lunga prevalente è il formato .mobi, ovvero quello leggibile su Kindle Daily Review Flash card La funzione che Amazon offre ai suoi utenti per archiviare i libri online e “ripassare” le annotazioni Si vedono le frasi sottolineate in schede singole, versione digitale delle flash card cartacee usate dagli studenti LA BIBBIA “Credi in Dio con tutto il tuo cuore, e non peccare di presunzione Cerca in tutti modi di conoscerlo, e Lui ti indicherà la strada” frase sottolineata 1.100 volte STEVE JOBS di Walter Isaacson “Fingi di avere tutto completamente sotto controllo e le persone penseranno che ce l’hai” frase sottolineata 3.748 volte Piccole chiose sui margini dell’amore STEFANO BARTEZZAGHI rai motivi per preferire il libro all’ebook, gli appunti a margine arrivano normalmente per secondi, subito dopo l’odore della rilegatura. In realtà ora annotare libri elettronici si può anche ma siamo molto lontani da quello che Roland Barthes chiamava «il piacere di costellare (étoiler) il testo». La procedura è tuttora troppo farraginosa e tocca agire con tastiere progettate da qualcuno che odia la scrittura più di quanto ne diffidasse il dio Thamus di Platone. Il grado zero della chiosa è la sottolineatura semplice, a mano libera o con righello, quest’ultimo tratto distintivo di tipi assai precisi o così parsimoniosi da prevedere la rivendita del volume sotto la specie merceologica: «in buono stato». Attorno: esclamativi, frecce, note, lampadine, interrogativi, irrisioni, insulti. Si proclama così il testo come geniale, confutabile, stupido o anche trascurabile, quando nulla lo costella o addirittura sui suoi margini vi appaiano appunti relativi ad altro o scarabocchi insensati. Altre scelte che compongono l’identikit del chiosatore: matita, penna, pennarello o evidenziatore? Sottolineare quasi tutto (gente ansiosa, portata a imparare a memoria anziché assimilare) o quasi nulla (per lettori che si sentono superiori al libro)? Si è anche visto usare, in funzione di «controevidenziatore» un raccapricciante pennarello nero, con cui cancellare le parti del testo non utili per l’esame (secondo l’uso dell’artista Emilio Isgrò). A parte l’ultimo caso, chiosare i libri non implica mancanza di rispetto. C’è differenza (e ce lo insegna proprio l’ebook) tra amare il libro e amare il testo. Ma anche l’amore per il libro se esclude il desiderio di compenetrare il testo diventa devozione sterile. Per chi rispetta così tanto la carta dei libri da non volerci scrivere sopra c’è una soluzione riguardosissima: l’ebook. F EBOOK © RIPRODUZIONE RISERVATA verranno “salvati” sui server di Amazon e lì resteranno per consultazione. Ed è qui che il valore aggiunto si manifesta. Di ogni volume appare la lista delle sottolineature. Potete vederle una di seguito all’altra e, in colore diverso, anche quelle altrui. Per una banale considerazione di “intelligenza collettiva”, se centinaia di persone hanno sottolineato un passaggio che a voi è sfuggito, può valere la pena dargli un’occhiata. Per favorire il ripasso Amazon si è inventata la funzione “Daily Review”. Cliccandoci sopra vedrete le sottolineature una scheda per volta, come le flashcard mnemoniche che usano gli studenti americani di ogni ordine e grado. Ed è provato scientificamente che ripercorrere i propri appunti aumenta in maniera significativa la ritenzione delle informazioni. Ideale per la saggistica, ma anche per la narrativa non dispiace. La prospettiva più entusiasmante si apprezza nel lungo periodo. Perché se cominciate a leggere tutto in formato elettronico vi costruite un archivio personale cercabile per parole chiave. Sorprendentemente per il momento non si può fare dal sito, ma è solo questione di tempo (e comunque esistono vari stratagemmi per esportare le note in formato testo e ricercarle liberamente). Mentre è già possibile all’interno del lettore o dalle app. Vi ricordate solo un pezzo di quella bella citazione che inizia con «solum certum» in quello strepitoso libro sulla vita di Montaigne? Basta digitare anche solo un termine e la trovate tutta («l’unica cosa certa è che niente è certo»), compresa la rivelazione della paternità di Plinio il Vecchio. Provate a farlo sfogliando quel malloppo da 450 pagine e ne riparliamo. La somma delle vostre letture diventa conoscenza attivabile on demand, anche quando i neuroni fanno le bizze e le sinapsi si incantano. Lo stesso Borges, che ha scritto della memoria totale di Funes, stavolta apprezzerebbe. Ma non è che l’inizio delle cose in più che l’ebook di Amazon consente rispetto alla concorrenza digitale e a quella analogica. Una volta registrato al sito, per dire, Kindle vi assegna un indirizzo di posta elettronica dedicato. Basterà spedirgli un qualsiasi file pdf personale, un articolo lungo da leggere con calma, un rapporto, tutto ciò che non volete stampare, perché il sistema lo renda leggibile e ben impaginato. Niente cavi. Niente complicate sincronizzazioni. Giusto un’email. Questi ebook possono anche essere prestati a chi volete: basterà autorizzare un nominativo e, nel tempo che l’avrà lui, non potrete leggerlo voi. Per non dire del dizionario incorporato che traduce e spiega ogni parola evidenziata. Fosse ancora vivo Roland Barthes, forse ri- spolvererebbe per l’occasione la sua dicotomia tra «testi leggibili» e «testi scrivibili». I primi, semplificando molto, sono quelli che non chiedono un grande sforzo al lettore, offrendogli immagini pronte al consumo. I secondi pretendono un’interazione più forte, che completa il lavoro dello scrittore. In qualche modo è ciò che succede qui, con le glosse della comunità dei lettori che si moltiplicano e si stratificano, aggiungendo livelli di senso. Ma non è per questo che l’altra sera ho annullato l’ordine della versione tascabile di The Big Shortdi Michael Lewis — il miglior libro in circolazione sulla crisi — per sostituirlo con quella Kindle. Per quanto sia scritto benissimo, la materia — tra derivati, credit default swaps e altre tecnicalità finanziarie — è ermetica. Il ripasso elettronico sarà indipensabile. E tanto, tanto più comodo. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 LA DOMENICA ■ 40 I sapori Verde & bianco Vengono prodotti con l’arrivo della bella stagione, il loro nome varia da regione a regione, si adeguano ai paesi e ai dialetti. Ma il concetto non cambia Perché, dalle malghe valdostane al Lazio e alla Gallura, il latte sano si sposa con le essenze finissime dell’erba nuova Primo sale Raviggiolo La più immediata espressione del latte fresco, per il formaggio salato una volta sola — da cui il nome — che si gusta pochi giorni dopo la produzione Dolce, cremoso fino a squagliarsi (come il fratellino squacquerone, appena più acidulo), si prepara con latte crudo e dura pochissimi giorni LICIA GRANELLO giardini di marzo si vestono di nuovi colori», cantava Lucio Battisti. E insieme ai giardini, gli orti, i prati, la campagna intera, pronta a scrollarsi di dosso il gelo dell’inverno. Dal verde che fa capolino tra le zolle bruciate dal freddo alle primule con cui rallegrare il terrazzino di casa, la voglia di primavera ci assale, anche a tavola. Marzolini, li chiamano. Sono i formaggi figli della nuova stagione. Da regione a regione, il nome viene scomposto e ricomposto, perde il vezzeggiativo, si adegua ai dialetti, stiracchiando accenti e consonanti come si tira una pasta filata. Ma il concetto non cambia, idealmente rappresentato dall’immagine bucolica degli animali al pascolo, felici di brucare l’erba te- «I re la qualità del latte in arrivo da produttori diversi. Una pratica che dilaga grazie al potere delle lobby legate alle industrie alimentari. Una volta pastorizzato il latte, basta aggiungere dei fermenti esterni per realizzare le diverse tipologie. Ma nel frattempo si è del tutto smarrito l’unicum che caratterizza i latticini prodotti in queste settimane, con i loro finissimi odori di erba nuova e l’energia intatta di un latte sano, vigoroso, artigiano, lo stesso che le femmine danno ai loro piccoli (nelle cascine, questo è il tempo dei parti e degli allattamenti). Se l’erba e buona e gli animali sono trattati bene, al latte riesce davvero un piccolo miracolo di bontà. Lo sanno bene due grandi scienziati del formaggio come Roberto Rubino e Giuseppe Licitra, che da anni portano Se un formaggio fa primavera nera. Se pensiamo ai latticini primaverili, il collegamento a pecore e capre, bufale e mucche suona necessario, perché grazie alle ultime briciole del nostro Dna contadino sappiamo quanto il sapore del latte passi nei suoi derivati, a maggior ragione quando si parla dei formaggi freschi, freschissimi, finalmente svincolati dall’alimentazione invernale. Purtroppo non funziona sempre così. Al contrario, le produzioni industriali che tutto standardizzano, hanno azzerato il piacere delle differenze. Principale imputata, la pastorizzazione, che in nome della “sanificazione” del formaggio, uccide insieme ai batteri cattivi quelli responsabili dei sapori originali. La bollitura a temperature più o meno elevate è la strada più facile per evitare i guai connessi alle stalle non in ordine (con animali affetti da brucellosi, per esempio) e per livella- avanti la battaglia culturale ed economica per diffondere le produzioni a latte crudo con animali tenuti al pascolo, l’uno con l’Anfosc (associazione di valorizzazione dei formaggi “sotto il cielo”), l’altro con il Corfilac, il consorzio siciliano di filiera casearia che ha appena lanciato il progetto del “Latte vero a Km0”, connesso alla Cacioteca regionale, il primo centro dedicato allo studio e alla riproduzione dei sistemi storici di stagionatura dei formaggi. Assistiti dalle temperature miti, organizzate una gita nei luoghi dei formaggi a latte crudo, dalle malghe aostane alla Gallura. Annusate per inebriarvi dei profumi timidi e suadenti del latte di primavera. Assaggiate un tomino così, nudo e crudo come casaro l’ha fatto, e beatevi di tanta odorosa tenerezza. Per l’estate c’è tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA Marzolini Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 DOVE DORMIRE DOVE MANGIARE DOVE COMPRARE LA TERRAZZA DEL CHIOSTRO Corso Rossellino 26 Pienza (Siena) Tel. 0578-748183 Camera doppia da 100 euro, colazione inclusa OSTERIA LA PORTA Via del Piano 1 Monticchiello di Pienza (Siena) Tel. 0578-755163 Chiuso mercoledì, menù 30 euro FATTORIA BUCA NUOVA Via Primo Maggio 4 Pienza (Siena) Tel. 0578-748350 PODERE POGGIO ANTICO Via Tresanti 2 Montespertoli (Firenze) Tel. 0571-659063 LA TENDA ROSSA Piazza del Monumento 9 Loc. Cerbaia, Montespertoli (Firenze) Tel. 055-826132 Chiuso lunedì a pranzo e domenica, menù 60 euro PODERE DELL’ANSELMO Via Anselmo 12 Montespertoli (Firenze) Tel. 0571-671951 Camera doppia da 70 euro, colazione inclusa L’OASI DEL GRILLO Località Colonna del Grillo Castelnuovo Berardenga (Siena) Tel. 0577-355762 Monolocale da 60 euro CASEIFICIO LA FONTE Località Asciano Castelnuovo Berardenga (Siena) Tel. 0577-700031 LA BOTTEGA DEL 30 Via S. Caterina 2 Località Villa a Sesta, Castelnuovo Berardenga (Siena) Tel. 0577-359226 Chiuso martedì e mercoledì, menù 55 euro IL CACIO DI VOLTERRA Località Pallesse 68 Volterra (Pisa) Tel. 0588-81516 Marzolino Marzotica Marzirolo Case ’e marzo Latte di pecora al cento per cento per il cacio millenario nato nelle campagne del Chianti e soggetto a diversi gradi di stagionatura, da dolce a piccante Evoluzione della ricotta tipica della campagna leccese: sgrondata del siero, viene salata a secco e, una volta asciugata, rotolata nei cereali selvatici Dalla tradizione contadina valtellinese, il nome che battezza il primo gorgonzola dell’anno: latte di doppia mungitura e spore di Penicillium Roqueforti La marzellina casertana si prepara con latte di pecora e capra, cagliato grazie alle foglie di cardo. Dopo la salatura, si cosparge di timo selvatico Sulla strada Odor di Pienza, da città dell’arte a città del cacio STEFANO MALATESTA ienza, che si gloria dell’altisonante titolo di Città d’Arte, negli ultimi tempi è diventata Città del Cacio Pecorino. Basta salire su per le rampe che portano alla nobile piazza per venire avvolti da un acre odore di formaggio che esce da un numero inverosimile di spacci. Questi cambiamenti nelle percezioni olfattive non sono una esclusiva di Pienza e della Val D’Orcia. A pochi chilometri di distanza, nella Val di Chiana, celebre per le carni dei suoi manzi, un profumo di tagliata al rosmarino sale dalla valle su per le meravigliose colline dietro Trequanda, così forte che sembra connaturato a quei luoghi come l’odore del sandalo è connaturato allo Yemen o quello del cumino a Marrakesh. Quello che attrae oggi i visitatori della toscana è una attività essenzialmente manducatoria e gastronomica. Appena sbarcati nei paesi, le truppe cammellate dei turisti di massa, dopo rapide incursioni nelle chiese e nei musei, compiute per evitare sensi di colpa, peraltro altamente improbabili, si precipitano alla frenetica compera non sola di cacetti, ma di marmellatine, di prosciuttini, di finocchione. L’intento del guadagno pronto e subito sembra non avere più limiti, con conseguenze dannose per lo stesso prodotto primario, il cacio. La Val d’Orcia, per quanto vasta, può contenere un numero limitato di pecore, con una produzione di latte molto inferiore a quella che consumano da soli le due o tre grandi industrie casearie del posto. Così una parte cospicua delle caciotte è lavorata con latte importato e senza quella passione e cura che facevano del pecorino locale un vertice tra i formaggi della regione. Naturalmente rimangono delle eccezioni e ne vorrei citare almeno un paio di piccole aziende a conduzione familiare che resistono al degrado. La prima, l’azienda agricola Bagnolo, si trova sulla strada per Sant’Anna in Camprena ed è gestita da un abile sperimentatore caseario, Ernello, che ha creato qualcosa di simile al Reblochon francese chiamato Centomuffe. La seconda appartiene alla famiglia Cugusi, si trova alle porte di Montepulciano e produce l’intera gamma del pecorino pientino: dieci qualità tra cui il pecorino trattato con le foglie di noce e anche una sorta di gorgonzola più delicato. In Val d’Orcia è una assoluta novità. E anche una meraviglia. ILLUSTRAZIONE DI CARLO STANGA P Ricotta Il non-formaggio (da siero) è protagonista delle ricette di primavera, dalle insalate ai dolci Nota di merito per quella di pecora, più grassa e saporita LA RICETTA Insalata di puntarelle con alici e ricotta Tedesco di nascita e mediterraneo per scelta, Oliver Glowig gestisce il ristorante che porta il suo nome all’interno dell’hotel Aldrovandi di Roma A firmare la sua cucina, ricette morbide e rigore zen, come nel piatto creato per i lettori di Repubblica Ingredienti per 4 persone 200 gr. di alici fresche 2 cucchiai di colatura di alici 200 gr. di ricotta vaccina 3 mazzi di puntarelle olio extra vergine, aceto di Barolo, sale e pepe Pulire e spinare le alici Lasciarle in acqua e ghiaccio per dieci minuti per togliere il sangue Asciugarle con carta assorbente e condirle con colatura e olio extravergine. Pulire le puntarelle e tagliarle in quarti, immergerle per dieci minuti in acqua e ghiaccio per renderle croccanti e condirle con olio extravergine, aceto di Barolo, sale e pepe Setacciare la ricotta e stenderla sul piatto con un sac à poche. Sopra, appoggiare le puntarelle e le alici. Infine decorare con fiori commestibili ✃ GLI INDIRIZZI ■ 41 © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 4 MARZO 2012 LA DOMENICA ■ 42 L’incontro Rinati In principio fu l’alieno Mork, un successo planetario. Poi vennero l’alcol e la cocaina, la morte di Belushi, i matrimonifalliti e un infarto. E poi ancora grandissimi film e, ora, una nuova moglie: “Mi hanno salvato i figli, grazie a loro ho imparato a vivere alla giornata Robin Williams Mi resta un sogno: interpretare Einstein, seduto su una spiaggia con le ciabatte da donna ai piedi” a sua biografia parla chiaro: Robin Williams è un uomo che ha vissuto tre volte. La prima esistenza — a base di genio, sregolatezza, dipendenze da alcol e droga — lo ha portato, negli anni Ottanta, sull’orlo del baratro. La seconda, decisamente più sobria, è stata spezzata dal terribile attacco cardiaco che gli ha fatto rischiare la morte, nel marzo 2009. Così la terza, quella attuale, è segnata dalla consapevolezza di essere, in qualche modo, un miracolato. Caduto e risorto, in almeno due occasioni. Da qui la sua filosofia un po’ new age: «Considero ciò che ho un grande regalo», spiega, «i miei figli, la mia terza e spero ultima moglie, il mio lavoro. Un mestiere che mi permette di fare la cosa più bella del mondo, e cioè calarmi in ruoli completamente diversi da me. Persone buone e cattive, animali (grazie ai doppiaggi nei cartoon), perfino geni della lampada come quando ho prestato la voce nel disneyano Aladdin. Cosa si può volere di più?». L’incontro con l’attore sessantenne, in una stanza al secondo piano dell’hotel Ritz di Londra, è il trionfo dell’imprevedibilità. Un one-man-show Tra scherzi, imitazioni (da Silvio Berlusconi a Mike Tyson) e facce strane. «Il primo essere umano che ho imitato», ricorda, «è stata mia nonna: viveva lontana da noi, non l’avevo mai vista. La conoscevo solo per telefono. Così, per ‘‘ sieme a Kevin Kline e Christopher Reeve, Williams vede la sua carriera cambiare quando appare, nei panni del buffo alieno Mork, in una puntata del cult televisivo degli anni Settanta, Happy Days: «Tutto nacque perché il figlio dell’autore e regista Garry Marshall, influenzato da Star Wars, chiese al papà di mettere un extraterrestre accanto alla famiglia Cunningham. Quando me lo dissero, mi sembrò una follia: cosa c’entra una specie di marziano in una storia all-american anni Cinquanta? Ma alla fine ebbero ragione loro: non era Shakespeare, ma era divertente». Infatti il successo è clamoroso, da lì (siamo nel 1978) nasce la sitcom Mork e Mindy. Da allora un boom inarrestabile: partecipazioni tv, show dal vivo. E film. Alcuni non banalmente commerciali: Popeye di Robert Altman, Il mondo secondo Garp, Good Morning Vietnam. Intanto però nella sua vita ci sono al- Ho avuto così tanti giorni bui che nemmeno li ricordo So solo che quando mi svegliavo non sapevo dov’ero FOTO AP L LONDRA passare il tempo nelle ore di noia casalinghe, ho cominciato a rifare le sue frasi tipiche: “Allora che fai, stai guardando il wrestling? Stai mangiando la pizza?”. E cose simili. Sono stato molto solo nella mia infanzia: sono nato a Chicago, ma poi abbiamo girato tanto negli States. Mi facevano compagnia i soldatini, ne collezionavo migliaia. Da lì ho sviluppato l’immaginazione. E così, dopo mia nonna, nel mio mirino da imitatore sono finiti tutti quelli che conoscevo: amici, parenti, compagni di scuola. Il mio cavallo di battaglia, però, è e resta Stephen Hawking». Segue dimostrazione pratica. Terminata questa ennesima performance, Williams — pantaloni e polo blu, occhi chiari che spesso si restringono fino a diventare una indecifrabile fessura — torna se stesso. Ma sempre all’insegna dell’ironia. Come quando commenta la nuova ondata di popolarità che lo ha investito qualche mese fa, quando le sue nozze con la graphic designer quarantasettenne Susan Schneider hanno imperversato su cronache rosa e siti di gossip: «Che imbarazzo, tutti quegli articoli e quelle foto con me perfetto sposo. Sembrava che i tabloid non dovessero occuparsi altro che della mia luna di miele. L’amore lo consiglio, è una pillola della felicità più economica del Prozac. Quanto a mia moglie, che posso dire? La sua caratteristica più notevole è che è una donna davvero alta... Sono grato di questa nuova opportunità. Certo, lei è più giovane di me: ma la mia non è la classica crisi di mezza età, quella l’ho avuta almeno due decenni fa. Adesso invece sono sicuro che non ripeterò più i soliti errori. Donne comprese». Il riferimento è ai suoi due precedenti matrimoni — il primo con Valerie Velardi, il secondo con Martha Garces — finiti con divorzi dolorosi e onerosi (accordi per oltre 20 milioni di dollari). Che però gli hanno lasciato un bene prezioso: tre figli, che ora hanno 28, 22 e 19 anni. Sono stati loro a spingerlo, dopo ogni ricaduta, a uscire dalla dipendenza: «I bambini non è che li puoi lasciare lì e andarti a ubriacare, dicendo ripasso più tardi. Ti fanno riflettere, inevitabilmente, sulla vita che stai conducendo». Il problema, a sentire lui, ha origine nella repentinità dell’exploit planetario che lo vede protagonista, quando ha meno di trent’anni. Già studente di teatro alla celebre Juilliard School, in- col e droga: «La cocaina è lo strumento che Dio ti manda per farti capire che stai guadagnando troppo», ha ripetuto spesso, riferendosi a quel periodo. Uno stile di vita che lo coinvolge anche in episodi di cui lui, tuttora, rifiuta di parlare. Come quel maledetto 5 marzo 1982 all’hotel Chateau-Marmont, sull’hollywoodiano Sunset Boulevard in cui, nel corso di una festa ad alto tasso di stupefacenti, John Belushi muore di overdose. Secondo le tante ricostruzioni giornalistiche lì c’era anche Williams, almeno nelle prime ore. «Ho avuto tanti giorni bui, molti così bui che nemmeno li ricordo», si limita a commentare, «ricordo solo la sensazione di svegliarsi senza sapere dove si è. Ora però sono molto più saggio: del resto, si arriva a sessant’anni anche per questo. Ho conosciuto grandi personaggi, nella mia vita. Alcuni di loro se ne sono andati. Ma bisogna comunque tenere duro». La sbornia degli anni Settanta-Ottanta, per fortuna, finisce. Anche per Williams, che ci offre, nel decennio successivo, interpretazioni memorabili: Risvegli, La leggenda del Re Pescatore, Hook, Mrs Doubtfire, Will Hunting - Genio ribelle(che gli fa vincere un Oscar), Patch Adams. Altrettanto interessanti sono i ruoli dark che recita all’inizio del nuovo millennio, in pellicole come Insomnia o One-hour photo. Quelle in cui emerge il suo lato oscuro: «Ho amato tanto recitare questi personaggi così inquietanti, così pieni di disturbi. Antieroi di storie cupe, strane, borderline. Spero che mi offrano ancora ruoli del genere». Sul fronte opposto, quasi a compensare il suo versante buio, si collocano le partecipazioni a film per famiglie e a cartoon. Da Aladdin fino ai due recenti Happy Feet, in cui ha doppiato dei pinguini: «Mi piace il lavoro sull’animazione, perché lì l’improvvisazione è bene accetta. Sono bravo a improvvisare, posso fare quaranta variazioni sul tema su un unico personaggio. Poi adoro avere a che fare con gli animali: non solo sul set, anche nella vita privata. Il mio animale preferito è il gorilla. Una volta ne ho anche incontrato uno: era una femmina e si è subito innamorata, voleva appartarsi con me nel retro della stanza. Ho partecipato a diverse iniziative benefiche per la salvaguardia di questa specie. Hanno un’aria così incredibilmente umana, sono commoventi. Pure le scimmie sono forti: per risolvere i loro conflitti usano il sesso, il che è meravi- glioso». E a proposito di animali, tra i suoi prossimi impegni c’è il doppiaggio di un cane parlante nel film Absolutely Anything, che segna il ritorno del gruppo comico dei Monty Python. Prima, però, lo rivedremo sullo schermo vestito da prete in The Big Wedding, accanto a Robert De Niro e Diane Keaton: «È la storia di una notte di mezza estate che si svolge in Connecticut, un posto pieno di signore tutte rifatte col botox». E fra tanti impegni, un unico rimpianto: «Non ho ancora realizzato il mio sogno di interpretare Albert Einstein. Sono ossessionato da una sua foto in cui è sulla spiaggia, con pantofole da donna ai piedi. Straordinario. Forse un giorno riuscirò a entrare nei suoi panni». Dunque un nuovo matrimonio, nuovi film, nuove sfide. Forse per reagire a quel terribile marzo 2009, quando ha avuto una brutta crisi cardiaca, con intervento chirurgico per rimpiazzare la valvola aortica: «La nuova proviene da una mucca, quando mangio carne bovina devo alzarmi in piedi per rispetto». Poi conclude, quasi serio: «Fisicamente mi sento bene, il matrimonio è fantastico, i miei figli pure. L’unica cosa che odio davvero è ballare la discomusic: come fobia non è così grave. La realtà è che ho accettato l’idea di prendere tutto con un po’ più di leggerezza. Di apprezzare le piccole cose — perfino il mio respiro. Insomma, da tutta questa vicenda ho imparato qualcosa di importante: saper vivere alla giornata». Cogliere L’attimo fuggente, come recita il titolo del suo film più famoso. © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ CLAUDIA MORGOGLIONE Repubblica Nazionale
Scaricare