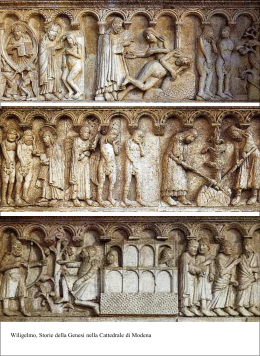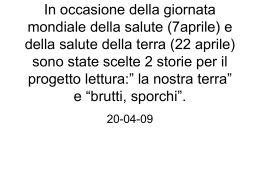massimo rizzante essere nessuno dialogo con sebastiano vassalli archivio di saggi 23 essere nessuno © 2014 Massimo Rizzante massimo rizzante, essere nessuno Tra un suo saggio intitolato Il mestiere di Omero, raccontare storie (2003) e un romanzo come Un infinito numero (2001) ho scoperto delle relazioni interessanti. In quest’ultimo lei esplorava, oltre che vicende legate alla redazione dell’Eneide di Virgilio, anche la storia degli Etruschi, un grande popolo che a differenza dei Greci non ci ha lasciato nulla di scritto. Nel suo testo sembra che lei rimpianga non solo il tempo di Omero – quando le storie si raccontavano oralmente e la scrittura non aveva altra funzione che quella di trasmettere l’opera ai posteri – ma anche il “sorriso” etrusco che illustra ambiguamente come forse il mestiere di raccontare storie non dovesse necessariamente contemplare la scrittura. Trovo ad un certo punto: “Per noi, oggi, raccontare storie significa scrivere storie. Da duemila anni, gli Etruschi non sorridono più; e la felicità di raccontare, così come la conosceva Omero, si è persa quasi del tutto”. Vor- 3 massimo rizzante, essere nessuno rei comprendere meglio questa sua riflessione polemica sulla nozione di “scrittura”, che lei paragona in un altro passo alla dantesca “selva selvaggia”. Questo significa forse che oggi, ancor più che ai tempi della Commedia, lo scrittore deve superare l’inferno della “scrittura” per conquistare il paradiso del racconto? La mia non è una polemica. Un infinito numero ruota attorno al tema della scrittura. E non è un caso se ho dovuto fare un passo indietro di duemila anni per trattarlo. Nell’età augustea, per la prima e forse unica volta nella storia umana, la scrittura diventa un mito. Orazio scrive: “Ho costruito un monumento più duraturo del bronzo”, ed è un monumento di parole. Nasce il senso, la certezza dell’immortalità che viene dalla scrittura. La scrittura è un ponte tra il finito della vita umana e l’infinito del tempo. Si potrebbe affermare che è una consapevolezza, un’illusione che riguarda soltanto i poeti, gli scrittori, gli intellettuali. Ma non è del tutto vero. Anche un uomo come Ottaviano, l’erede di Cesare, colui che si farà chiamare Augusto e che proveniva dall’ambiente militare (un uomo che non era propriamente un intellettuale, anche se pare che in giovinezza avesse scritto qualcosa) ha maturato questa certezza. Ottaviano, subito dopo la vittoria di Azio, che gli consegna l’impero e pone fine a sessant’anni di guerre civili, va in Egitto e, mentre prende possesso di quell’antico regno, si fa aprire la tomba di Alessandro. Gli storici riferiscono un aneddoto: qualcuno del suo seguito, 4 massimo rizzante, essere nessuno pensando che sia un appassionato di tombe, gli propone di visitare anche quelle dei Tolomei, i successori di Alessandro. Ottaviano risponde: “Io volevo vedere un re, non dei morti”. L’aneddoto, raccontato da Svetonio, la dice lunga su qualcosa che Ottaviano ha in mente prima di diventare imperatore. La costruzione politica di Giulio Cesare e la sua – un immenso impero sotto cui convivono popoli e culture diversi – è destinata a dissolversi, ad avere vita breve, come l’aveva avuta la costruzione di Alessandro Magno, se a tenere assieme il tutto, oltre alle armi e alle leggi di Roma, non ci sarà anche il mito di Roma. Ottaviano ha bene in testa questo pericolo quando pensa di fare di Virgilio il primo e il più importante dei suoi funzionari. C’è uno strano rapporto fra il principe e il poeta; un rapporto che si crea forse per la prima volta. I poeti, infatti, avevano avuto per lo più quella funzione un po’ marginale che ci è stata tramandata dai poemi omerici, dove il poeta è colui che intrattiene i convitati durante i banchetti. Nel tempo qualcosa si era aggiunto: ad esempio, la precisa descrizione di alcune vicende storiche, o la rassegna genealogica degli dei dell’Olimpo. Poco altro. Il poeta non aveva mai avuto un ruolo istituzionale. Virgilio è il primo a conquistarlo: e che ruolo! Virgilio, all’inizio, è entusiasta di partecipare alla costruzione del mito di Roma. Poi, per diverse ragioni, le cose cambiano. Le cronache dell’epoca sono piuttosto documentate su questi fatti (fatti su cui tornerò nel mio prossimo libro). Visitando la tomba di Alessandro Magno, Otta- 5 massimo rizzante, essere nessuno viano annuncia le sue intenzioni politiche. Ora, i politici si esprimono in due modi: uno è quello della comunicazione diretta, dei proclami ai sudditi (o agli elettori); l’altro, più indiretto e più efficace, è quello simbolico. Non è importante che Ottaviano sia stato o no sulla tomba di Alessandro: è importante che si sappia che lui c’è stato. Al suo ritorno, Ottaviano sbarca a Napoli e si mette in cammino verso Roma. Ma dopo un giorno di viaggio si ferma nella piccola città di Atella, ufficialmente per curarsi un mal di gola, in realtà per attendere sua moglie Livia Drusilla e il suo consigliere politico Mecenate che giungono da Roma. Ad Atella lo raggiunge anche Virgilio. E lì, nel teatro olimpico di Atella, per tre o quattro giorni consecutivi, vengono lette in pubblico alla presenza di Ottaviano le Georgiche, il poema che Virgilio ha appena terminato di scrivere. Il poema è fortemente voluto da Mecenate (all’inizio del terzo libro Virgilio ricorda gli inviti che Mecenate gli ha rivolto). Si tratta di un poema importante dal punto di vista politico: il poeta si rivolge a un’Italia dove, in sessant’anni di guerre civili, tutto è andato in malora. I campi si erano rimboschiti. Non c’era certezza di nulla. I contadini erano stati espropriati dei loro terreni dai veterani dei vari eserciti, che, fra l’altro, non li sapevano far fruttare. Le strade erano insicure. Le Georgiche non dovevano essere soltanto un poema sulla bellezza del coltivare i campi, ma l’opera che insegnava a ritrovare un rapporto con la natura. Per questo Ottaviano assiste di persona alla lettura. Ma proprio in quei giorni, in pri- 6 massimo rizzante, essere nessuno vato, è probabile che il terzetto composto da Ottaviano, Virgilio e Mecenate (che poi cadrà in disgrazia, ma che è ancora l’uomo più potente dell’impero dopo Ottaviano) lavori al progetto di un nuovo poema; tanto è vero che poco dopo Virgilio comincia la stesura dell’Eneide. È probabile che si parli del mito di Roma, anzi è probabile che l’idea dell’Eneide nasca ad Atella, e che al progetto del poema partecipino Ottaviano, Mecenate e forse Livia Drusilla, che nell’ombra tira molte fila del mondo augusteo. Da quanto lei dice, l’idea di comporre il poema dell’Eneide è nata non tanto dall’ispirazione di un ambizioso poeta innamorato della vita di campagna quanto dalla decisione di un ristretto politburo di potenti, i quali si rendevano conto che nessuna pianificazione imperiale era possibile senza un adeguato culto delle origini: un culto che per la prima volta si affidava al libro. Una storia che da allora si è ripetuta molte volte. Ma vorrei che lei ci illustrasse come, nel romanzo, all’esplorazione del mito (latino) della scrittura si sia sovrapposto quello (etrusco) dell’assenza di racconti mitici… Nei giorni in cui la scrittura diventava un mito capace di rendere l’uomo immortale, si concludeva anche la parabola storica di un’antica civiltà, quella etrusca, che per almeno trecento anni era stata per ricchezza e progresso tecnico alla stregua dei popoli più evoluti del 7 massimo rizzante, essere nessuno Mediterraneo. Si pensi che sono stati trovati più vasi attici in Toscana e dintorni che nella stessa Attica! Fra le divinità degli Etruschi c’era la dea del Tempo. Durante il capodanno, che cadeva in primavera, gli Etruschi piantavano nel tempio della dea un chiodo. Le distanze fra un chiodo e l’altro erano state calcolate da epoche immemorabili. Ogni anno il sacerdote piantava un chiodo sul muro. Si credeva che quando il muro fosse stato riempito di chiodi, il tempo sarebbe finito. E il tempo degli Etruschi stava finendo. Non solo perché gli Etruschi erano un popolo in rovina, al quale Roma da due secoli imponeva tutto (compresa la lingua), ma anche perché sul muro del tempo non era rimasto più spazio. Neppure per un chiodo! Questo è quanto riportano gli storici romani (di storici etruschi non c’è traccia). Mentre a Roma nasce il mito della scrittura, un popolo che non ha mai scritto giunge al termine del suo cammino. Caso unico forse nella storia, perché gli esseri umani sono sempre stati degli incredibili grafomani. Si è scritto in tutte le civiltà. Pompei ci ha restituito molte cose, comprese le scritte oscene nei gabinetti che si possono vedere ancora oggi. Gli uomini hanno sempre scritto. Per qualche strana ragione, l’uomo ha scritto anche prima della scrittura. Abbiamo una forma rudimentale di letteratura (le “pittografie”) anche presso gli indiani d’America. Le incisioni rupestri della Val Camonica sono una forma di racconto. Gli uomini raccontavano le loro scene di caccia. Quello che ha spinto l’uomo alla scrittura è il desiderio di raccontare; un altro motivo è la riflessione; poi ancora, la forma aurorale 8 massimo rizzante, essere nessuno di ogni letteratura: la poesia. Gli Etruschi possedevano una scrittura alfabetica, ma non hanno lasciato scritto nulla di letterario. I loro libri sacri erano repertori di cose da ricordare: il modo di costruire i ponti; come fondare le città; i segni per divinare il volo degli uccelli. Tutto ciò veniva registrato perché altrimenti, di generazione in generazione, se ne sarebbe persa la memoria. Erano scritture di servizio. Scrivevano i nomi delle persone nelle tombe, dopo che le persone erano morte. C’era qualcosa di molto forte che probabilmente li spingeva a non scrivere; penso fosse legato a qualcosa che aveva a che vedere proprio con la vita e la morte. Non credo che, da vivo, un etrusco avrebbe scritto il suo nome: e questo silenzio è durato settecento anni! Gli Etruschi non ci hanno lasciato un racconto, neppure su un insignificante fatto di cronaca; non ci hanno lasciato una riflessione, un pensiero; non ci hanno lasciato un verso. Quando si sparge la notizia di un nuovo ritrovamento di iscrizioni etrusche, i casi sono due: o si tratta di una scrittura di servizio, oppure è qualcosa che è stato scritto dagli Etruschi in età tarda, ed è perciò scritto in latino. Il grande mistero di questo popolo – il fatto che non scrivessero – doveva essere legato ad un tabù. D’altra parte (ce lo dicono gli storici, ma anche Seneca ne fa cenno) sappiamo che gli Etruschi erano superstiziosissimi. Forse, la scrittura per loro era talmente connaturata alla vita da diventarne quasi l’ombra, un suo pericoloso doppio. Un’immagine di morte. Studiando quell’epoca, volevo che la mia riflessio- 9 massimo rizzante, essere nessuno ne sulla scrittura nascesse dal confronto di due modi (quello assolutamente positivo e quello assolutamente negativo) di concepire il rapporto con la scrittura. Non volevo trarne delle conclusioni. Volevo solo che queste due concezioni si guardassero allo specchio. Lei ci ha parlato “del mestiere di Omero”, ovvero del mestiere del facitore di storie. Ora, il facitore di storie contemporaneo, secondo la sua concezione, si trova di fronte a un mondo le cui pareti sono talmente tappezzate di scrittura che per arrivare a conquistare il territorio della storia che semplicemente si lascia raccontare, deve inevitabilmente scorticarsi le unghie per ritrovare l’antico muro. Questo conquista è un po’ una chiave per comprendere il suo stesso percorso letterario. Il facitore di storie Vassalli, per ritrovare il filo del racconto, si interroga sul suo mestiere, e poiché vive in una civiltà profondamente radicata nella scrittura si interroga su coloro che non hanno scritto, che non hanno desiderato monumenti imperituri alla propria memoria. Lo specchio degli Etruschi lancia riflessi opachi. È esistito un popolo che ha conosciuto la felicità e non ha desiderato raccontarla. Ma soprattutto: è esistito un popolo che ha conosciuto l’infelicità e non ha desiderato renderla immortale attraverso un libro. La funzione antropologica della letteratura rafforza in ogni caso il suo peso specifico: se è esistito un popolo che ha potuto fare a meno del racconto, il mito della scrittura può essere definitivamente depotenziato. Il facitore di sto- 10 massimo rizzante, essere nessuno rie, il narratore è qualcuno che racconta qualcosa, non qualcuno che si compiace del suo strumento. Grazie al sorriso degli Etruschi, il facitore di storie Vassalli può finalmente sorridere della teoria letteraria, dell’avanguardia – con cui per molto tempo ha dovuto convivere – e dell’“Arkadia” di tutti gli impoeti… Che cosa ne dice? È una storia che si potrebbe raccontare? Ho riflettuto molto sulla questione delle avanguardie. Le avanguardie si riducono, in fondo, a ricerche di tipo formale. Io mi sono affacciato all’orizzonte della letteratura negli anni ’60, quando avevo vent’anni. All’epoca si riproponeva per l’ennesima volta nella letteratura italiana (e non solo italiana) la plurisecolare querelle fra Antichi e Moderni. Se fossi stato un genio, me ne sarei andato immediatamente con gli Antichi; ma purtroppo non lo ero – lo dico con la serenità di una constatazione ormai acquisita – e perciò ho seguito per un tratto la mia parabola con i Moderni. Poi, quando mi sono reso conto di aver perso del tempo, la cosa mi ha anche un po’ seccato e ho scritto agli inizi degli anni ’80 un pamphlet – Arkadia – che lei ha prima citato, una piccola cosa. Riflettendoci ancora meglio, dall’inizio degli anni ’80 sono passati molti anni, sono arrivato a capire che l’aver perso tempo con un’avanguardia non era una questione soltanto mia, ma che nella letteratura italiana molti avevano dovuto fare i conti con quell’esperienza; che la questione fra Antichi e Moderni si era riproposta almeno un paio di volte per secolo. In fondo, vi era 11 massimo rizzante, essere nessuno passato persino il padre Dante, che era nato in un’avanguardia che si chiamava Stil novo – guarda caso – e che se ne era allontanato poi più velocemente di me… Fin qui arriva la constatazione storica. Ma io sono convinto che fra tutte le ragioni che hanno spinto Dante a scrivere la Divina Commedia, una di queste è l’avversione per lo Stil Novo, che lui, in un certo momento della sua vita, identifica con Guido Cavalcanti. Quando ho provato a dire queste cose è successo il finimondo. In Italia si può parlare di tutto o di tutti, ma non si può fare un’ipotesi su Dante. In quel canto dell’Inferno in cui si parla di Guido Cavalcanti – uno dei momenti più drammatici della Commedia – emerge un nervo scoperto, non solo artistico, ma anche esistenziale di Dante. C’è un’altra cosa che vorrei affidare alla vostra riflessione. Quando Dante si sceglie come guida Virgilio, non conosce granché della sua opera. Dante vive fra il 1265 ed il 1321, se non sbaglio. Nei primi anni del Trecento, le opere di Virgilio non sono ancora disponibili. Se ne sa qualcosa da altri autori, ma l’Umanesimo è di là da venire. Dante non ha letto Virgilio, o comunque lo conosce poco. Si rifà poi alla leggenda sull’Egloga IV, quella del celebre “Verrà un bambino che porterà un nuovo ordine di secoli”. Un bambino poi è venuto davvero; cosa che, nel Medioevo, varrà a Virgilio la fama di profeta. Perché Dante sceglie Virgilio come sua guida? L’idea che mi sono fatto io è che questo autore, che era il più noto della latinità, ma la cui fama non era tanto legata alle opere quanto a fatti extratestuali, viene scelto da Dante perché gli offre la certezza di rappresentare l’An- 12 massimo rizzante, essere nessuno tico, in contrapposizione all’odiato Nuovo. Lo Stil novo è stato una volta per tutte rinnegato: Virgilio gli offre la certezza di guidarlo verso lo Stile antico. Abbiamo parlato di Dante, ma si potrebbero fare molti altri esempi. Quasi tutto ciò che c’è di buono nella letteratura italiana è stato fatto contro il Nuovo, contro ciò che aveva rappresentato, o rappresentava ancora, una moda. Pensate all’Ariosto, e al cardinale Ippolito d’Este che gli rimprovera di scrivere “corbellerie” invece di scrivere (come facevano tutti – e questo è il non detto del rimprovero) sonetti sul modello del Petrarca. Pensate a Manzoni, che nasce da un’avanguardia (anche se meno strombazzata), da quello Stil novo che è lo stile neoclassico. L’autore dei Promessi sposi ad un certo punto se ne vergogna: promette a se stesso di scrivere cose più brutte, ma non come quelle che ha già scritto.Tornando alla mia vicenda personale, alla fine mi sono detto: se ci sono passati tutti, posso esserci passato anch’io. Ho toccato due temi, quello della scrittura e quello del rapporto con le avanguardie. Ci sono paesi che si sono affacciati alla letteratura non più di cento, duecento anni fa. Queste culture non hanno problemi con le avanguardie: lì le avanguardie non esistono. Esistono invece in culture come la nostra, che nascono già antiche. La nostra letteratura ha già “consumato” due lingue (prima c’era il latino). Penso che le avanguardie siano una malattia senile dell’arte, anche se si propongono sempre come slancio vitalistico: in realtà nascono dal vecchio e sono manifestazioni di culture decrepite. 13 massimo rizzante, essere nessuno I continenti che si sono affacciati alla letteratura a fine Ottocento, o nel primo Novecento, non hanno di questi problemi. Il rapporto con la scrittura è un’altra cosa. Penso all’immagine che Dante mette all’inizio della Commedia – e che lei ha citato in una delle sue domande: alla “selva selvaggia, aspra e forte” che deve attraversare per arrivare al termine del poema. Penso che la selva di Dante sia innanzi tutto un’immagine della scrittura. Io guardo ad Omero (sarà un personaggio del mio prossimo libro) con molta invidia, perché lui raccontava delle bellissime storie e, beato lui, non le scriveva. Il mestiere dello scrittore – anche se si chiama così e parlarne in questi termini può sembrare una tautologia – non nasce dalla scrittura, ma dalle storie, dai personaggi e dalle loro storie. Sono tornato ad Omero per capire come nasce l’arte del racconto. E non sono tornato all’Iliade, ma all’Odissea. Tutta l’arte del racconto viene da lì (parlo naturalmente della tradizione orale che sta prima di Omero, dei cantori). Forse la parola Omero ci serve proprio per riassumere quella tradizione. L’Odissea nasce da un mondo che non è ancora raccontabile, perché è soggetto alle forze oscure che dominano la vita. La violenza, gli istinti, le false illusioni, la morte: queste e altre sono le cose che i cantori ciechi elaborano sotto forma di miti. Ecco allora la forza bruta diventare il mito di Polifemo; la lussuria trasformarsi nella maga Circe; le Sirene, le false illusioni che attirano gli uomini in trappole mortali. A poco a poco la letteratura trasforma le forze oscure 14 massimo rizzante, essere nessuno in miti. Il mondo diventa raccontabile. La scrittura viene dopo. All’inizio sembra una faccenda semplice (tutte le tecniche all’inizio sembrano neutre): la scrittura sembra una tecnica di fissazione della materia orale, un modo per fermare qualcosa che altrimenti volerebbe via. In realtà la scrittura, che nasce come serva, ben presto diventa padrona. Le storie sono sempre belle, prima di incominciare a scriverle. Poi subentra la scrittura, che le modifica, le altera. Le storie scritte sono un’altra cosa rispetto alle storie non scritte. Se le potessimo raccontare e basta, sarebbero diverse. Almeno questo è quello che gli anni delle ricerche formali dell’avanguardia mi hanno insegnato: non si può sottovalutare il rapporto con la scrittura. O comunque: bisogna acquisire sufficiente mestiere, una sufficiente padronanza di questo mezzo per impedirgli di andare dove vuole e farlo andare dove vogliamo noi. I formalismi degli anni ’60 me l’hanno insegnato. Ed è l’unica cosa che non ho rinnegato. C’è dunque una selva chiamata “scrittura” e, al di là di questa, la Storia – o meglio, le storie: ciò che resta di concreto quando finisce l’illusione che una Storia esista e possa essere studiata. Non esistono che le storie. Nel mondo, lei dice, in concreto non c’è altro. Ma vorrei tornare sul suo “mestiere”, di cui parlava alla fine del suo intervento precedente. Nei suoi libri, a partire dalla Notte della cometa (1984) e dallo sprofondamento nella biografia del “babbo matto”, come 15 massimo rizzante, essere nessuno lei chiama Dino Campana – che è un po’ il suo Virgilio – c’è un cambiamento di rotta. Dal punto di vista dei procedimenti, della ricerca documentaria, della concezione estetica, quali ferri del mestiere ha dovuto trovare per arrivare a quel modo di raccontare la Storia senza scrivere romanzi storici, modo che, credo, non ha più abbandonato? Se avessi ben chiare le tecniche per fare lo scrittore, forse ne trarrei giovamento. Si tratta di una ricerca continua. Non ci sono regole fisse. Facendo questo mestiere, negli anni, ho acquisito ben poche certezze, che potrei esporvi. La prima è che in letteratura tutto è possibile. È possibile assolutamente tutto, purché funzioni. Ed è lì il nodo. Si può mandare Astolfo sulla luna, si può incontrare una storia di cento anni fa e credere – a me è capitato con Il cigno (1993) – di aver trovato la chiave per raccontare il presente. Era un periodo quello – tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 – in cui tutto era fermo. C’erano ancora i vecchi partiti, non era ancora scoppiata Tangentopoli. Era talmente vero che avevo trovato quella chiave che poi, mentre scrivevo, tutto è accaduto. Sono dovuto andare due volte a Palermo, per vedere i giornali locali dell’epoca e per fare dei sopralluoghi, per esempio sulla linea ferroviaria Palermo-Bagheria, che è ad un solo binario ed è rimasta la stessa dai tempi del delitto e del defunto Notarbartolo. Dovevo vedere molte cose. La prima volta che ci sono andato, ho visto sull’autostrada il cratere della bomba 16 massimo rizzante, essere nessuno che qualche giorno prima aveva ucciso il giudice Falcone. La seconda bomba, quella che uccise Borsellino, l’ho anche sentita. Ero dalla parte opposta di Palermo, all’hotel Jolly, a dieci, dodici chilometri in linea d’aria. Si è sentito il botto e poi si è visto il fumo. Poi abbiamo saputo dalla televisione quello che era successo. Contemporaneamente succedeva quel gran trambusto che ha portato all’estinzione dei vecchi partiti. La storia che stavo scrivendo era accaduta cento anni prima: c’era una mafia già assolutamente moderna, c’era lo scandalo di fine Ottocento, delle banche che finanziavano la politica. Quando uscì, il libro fu scavalcato dalla cronaca. Angelo Guglielmi sull’“Espresso” scrisse: “Sembra la fotocopia del presente”. Ciò, naturalmente, fece sì che il romanzo non avesse un grande successo. Era un romanzo che anticipava troppo, che raccontava troppo: un altro libro sul carattere nazionale degli italiani. Il figlio della vittima di cui si parla nel libro (l’ex-sindaco di Palermo e direttore del Banco di Sicilia Emanuele Notarbartolo, che venne ucciso in treno con ventisette coltellate), ufficiale di marina, dopo che gli assassini materiali e i mandanti vennero prosciolti nel processo in terza istanza, non mise mai più piede in Sicilia. Infatti, dei Notarbartolo, questa antica famiglia, il ceppo maggiore ora è a Napoli. Leopoldo Notarbartolo scrisse nei primi anni del Novecento un memoriale – pubblicato pochi anni fa da una piccola casa editrice, l’editore Novecento di Palermo – le cui prime cento pagine contengono una radiografia del sistema mafioso 17 massimo rizzante, essere nessuno e dei rapporti tra politica e mafia che vale anche oggi. Leggendo quelle pagine viene la pelle d’oca. Per questo io non parlerei di romanzo storico. L’etichetta “romanzo storico” nel mio caso è impropria per molti motivi. Le storie che io racconto, per ciò che hanno di storico, sono già state scritte e pubblicate, ma non interessano a nessuno. Questo è il problema: ci sono tanti casi, storie strepitose dimenticate in riviste e in pubblicazioni specialistiche che nessuno mai leggerà. Io sono reverentissimo nei confronti di un grande scrittore come Manzoni, ma con il senno di poi ci siamo accorti che le cose stavano in modo esattamente opposto a come pensava lui. Ci siamo resi conto che i romanzi, che lui chiamava “componimenti misti di storia e di invenzione” non sono stati spazzati via, non hanno ceduto il passo a quella che lui chiamava la verità storica e alla storia come scienza, che avrebbe illuminato ogni angolo del passato. È avvenuto esattamente il contrario. La verità storica non esiste. La storia è un racconto e può essere raccontata in molti modi, indipendentemente dalla sua verità. Questo da qualche anno preoccupa anche gli storici, perché si trovano a fare i conti con un fenomeno come il revisionismo. I racconti sono per loro natura aperti e riapribili. Sono proprio i rapporti di forza che si sono rovesciati. Manzoni pensava che da una parte ci fosse la forza della scienza e della conoscenza, e dall’altra la leggerezza dell’invenzione che avrebbe dovuto soccombere. In realtà è accaduto il contrario: l’invenzione è l’elemento forte dei due termini, la capacità di scrivere in modo creativo (o ri-creativo) è un punto 18 massimo rizzante, essere nessuno di forza non solo dello scrittore, ma anche dello storico, che in definitiva non ne ha molti altri. Sarebbe sbagliato parlare oggi di romanzo storico: è un’etichetta che poteva andare bene per chi, come Manzoni, credeva nella Storia. Per chi, come me, non crede nella verità storica, non serve. Io credo nelle storie, nelle infinite storie. Non tutte meritano di essere raccontate: ma questo è un altro discorso. Noi vediamo i singoli fili del tessuto, ma il disegno complessivo non lo vedremo mai. Anche per questo la Storia non esiste. Non riusciremo mai a vedere cosa disegnano, nel loro insieme, le nostre storie. Esiste, ed io la rispetto, la storiografia. Ciò che chiamiamo Storia è una segnaletica del passato. È opportuno sapere che Napoleone è venuto dopo Giulio Cesare, ma questo è tutto. Una poetessa russa, Marina Cvetaeva, rivolgendosi in una sua opera al lettore, scriveva: “Vedi, tu non sei ancora nessuno, io sono già nessuno”. Nel suo breve testo su Omero, che ricordavo già all’inizio della nostra conversazione, lei cita l’episodio di Ulisse che, braccato nella grotta di Polifemo, dice di chiamarsi nessuno per non essere ucciso. Ulisse, lei scrive, “È il primo vero personaggio della letteratura occidentale, forse, della letteratura universale. Ulisse è l’uomo che rende raccontabile un mondo che prima di lui non era raccontabile”. Ulisse non è solo il primo personaggio, ma colui che, grazie alle sue avventure, rende possibile la creazione degli al- 19 massimo rizzante, essere nessuno tri personaggi. Il passaggio è decisivo e porta con sé un corollario che lei in parte espone e in parte fa intuire: chi rende raccontabile il mondo, chi scrive storie è nessuno e deve essere nessuno per far vivere gli altri. Mi fa venire in mente Kafka, il quale diceva che per scrivere bisogna “essere morti”. È così? Sulla necessità di essere nessuno mi interrogo nel mio prossimo libro. La letteratura nasce grazie ai cantori ciechi. Nella stessa Odissea ci sono due cantori, uno dei quali, Demodoco, è cieco (l’altro, mi sembra, è Femio). Il fatto che alle sue origini la letteratura, l’arte del racconto, venga legata ad una menomazione fisica forse è vicino a quanto lei dice a commento del mio testo. La menomazione fisica – la cecità – fa sì che questi uomini – gli aedi – possano avere più vita interiore degli altri, ma soprattutto fa sì che non possano avere storie proprie. Il narratore, perciò, è nessuno perché non può essere Achille né Ettore. Così presta la sua vita ai suoi personaggi e li fa vivere. Ora – a parte il caso di Kafka (da lei riportato), che è un grande scrittore – anche nel caso di un piccolo scrittore, se davvero è tale, la prima consapevolezza che acquisisce è proprio questa: per dar vita a dei personaggi vivi e credibili, l’autore può prestare loro l’unica vita di cui dispone, cioè la sua. Questo non significa che debba vivere appartato, ritirato. È un po’ lo stesso percorso che porta l’attore ad interpretare ogni giorno, in certi orari, un ruolo definito. Un attore, per due ore al giorno e per sei mesi della sua vita 20 massimo rizzante, essere nessuno può essere Amleto; il resto della giornata può tornare ad essere chi vuole. Chi fa questo mestiere sa di vivere ai limiti della schizofrenia. Grazie al cielo uno scrittore non entra ed esce da una scena, ma deve stare attento al rapporto con i suoi personaggi, che è meno intenso di quello dell’attore, ma è più duraturo e ha comunque una sua forza. Un grande personaggio modifica sempre il suo autore. Chi ha creato un grande personaggio non ne esce indenne. In ogni caso, il rapporto con i propri personaggi per un narratore esiste, ed è una cosa seria. Comprendo Kafka. Se volessi drammatizzare questa relazione pericolosa, anch’io come lui potrei senz’altro affermare che per narrare bisogna “essere morti”. In fondo, è quel che pensavano gli Etruschi, i quali, superstiziosi com’erano, non potevano raccontare le storie dei vivi. La superstizione era la loro religione. E forse anche la loro letteratura. Nulla accadeva per caso. Tutti gli eventi erano fra loro collegati. Tutte le storie erano governate da una logica nota soltanto agli dei, e nessun uomo poteva conoscere il disegno complessivo che le teneva insieme. In fondo, avevano capito già tutto. 21 www.massimorizzante.com
Scaricare