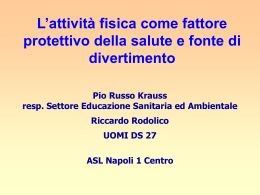ATTIVITA’ EMG A RIPOSO Attività da inserzione Attività di placca (rumore - potenziali) Fibrillazione, onde lente positive Fascicolazioni Miochimie Scariche complesse ad alta/bassa frequenza Miotonia Neuromiotonia Crampi ATTIVITA’ INSERZIONE attività elettrica provocata dal movimento dell’ago nel muscolo burst breve di onde irregolari - e + aumentato --> normale, denervazione diminuito--> grasso, fibrosi, ipoK assente---> idem, necrosi muscolare ATTIVITA’ DA INSERZIONE Dumitru 1996 L’inserzione brusca dell’ago in una fibra muscolare SANA, Out End-Plate Region injury potentials, attività fugace (dislocazione e danno locale della fibra muscolare) Attività di inserzione L’inserzione di un ago-elettrodo in un muscolo evoca normalmente una breve raffica di attività elettrica che si ripresenta ad ogni riposizionamento. L’attività inserzionale ha una durata di 100-300 ms (PATOLOGICA > 500 ms). Si presenta come un gruppo di spikes positivi o negativi ad alta frequenza accompagnati da un rumore simile ad un crepitio. Tali scariche originano dalle fibre muscolari meccanicamente stimolate dalla penetrazione dell’ago. danneggiate o La registrazione dell’attività di inserzione segnala l’ingresso della punta dell’ago nel muscolo. Detta attività può mancare se la punta dell’ago è erroneamente posizionata nel tessuto adiposo. Attività da inserzione Radiculopatia L5: m.EPA NORMALE AUMENTATA ATTIVITA’ DI PLACCA rumore di placca: fruscio sea-shell, 10-50 uV, <4ms, spike negativi, alta frequenza (pot.miniatura) potenziali di placca: 100-200 uV, >4ms, bifasici (inizio neg), irregolari alta frequenza, suono “crackling”, associato a rumore placca+dolore, (singola fibra muscolare) non correlato clinico Attività di placca Potenziale di placca: morfologia sede Bifasico inizio negativo: placca --> 0.2 mm Trifasico inizio positivo: 0.2 dalla placca --> 0.5 mm dalla giunzione muscolo-tend. Bifasico inizio positivo :dagli ultimi 0.4 mm della fibra (d.differenziale --> Fibrillazione) DUMITRU: Arch Phys Med Rehabil 1998 ATTIVITA’ DI PLACCA origine Jones 1965: fibre nervose intramuscolari Buchtal-Rosenfalck 1966: potenziali placca miniatura Wiederholt 1970: < curaro, > anticolinesterasici J.R.Daube, Dumitru, ...…..: potenziale extracellulare di singola fibra muscolare Attività elettriche della placca neuromuscolare In condizioni di riposo con l’ago fermo non si registra alcuna attività elettrica tranne che nella regione delle placche neuromuscolari. Registrando dalla regione delle placche neuromuscolari, l’irritazione dei sottili terminali dei nervi intramuscolari da parte della punta dell’elettrodo causa due tipi di attività elettriche: • il rumore di placca, ondulato, di bassa ampiezza, • i potenziali di placca di ampiezza più elevata. Attività spontanea Potenziali di fibrillazione attivazione di singole fibre Onde aguzze positive Scariche ripetitive complesse scariche rapide generate da molte fibre che in sequenza si attivano efapticamente Potenziali di fascicolazione scariche isolate di una unità motoria Miochimie scariche ripetitive di una unità motoria FIBRILLAZIONE Scarica spontanea di singola fibra muscolare osservata in un tessuto muscolare denervato o che in alternativa ha acquisito un potenziale di membrana a riposo instabile (- 90 -6070 mV) FIBRILLAZIONE onda bifasica inizio + (monof./trifas.), breve durata 1-5 ms, bassa ampiezza 20-400 uV, con freq. scarica lenta (0.5-20 Hz) regolare denervazione muscolo (anche funzionale: tox, paresi centrale), miopatie-neuropatie 0, + (2 zone, 1-2 s), ++ (3 o + zone), +++ (più zone, persistente), ++++ estremamente numerosa non correlato clinico. FIBRILLAZIONE Fibrillation potentials, positive sharp waves and fasciculation in the intrinsic muscles of the foot in healthy subjects FALCK 1983 53 soggetti sani, 18-70 anni Solo 19% silenzio elettrico a riposo 72% almeno un potenziale a riposo frequente piccola neuropatia dei nervi del piede NON SIGNIFICATO PATOLOGICO FIBRILLAZIONE Lesione traumatica >>> SLA, polineurop. (danno sincrono delle fibre>>> danno cronico che consente la rigenerazione parziale) compaiono dopo 15-20 giorni dalla lesione possono persistere per anni (diagnosi sindrome post-polio) FIBRILLAZIONE Fibre denervate: aumenta la distribuzione dei recettori per Ach anche nella membrana non giunzionale diminuisce la permeabilità per K, aumenta per Na potenziale di membrana < ed è più facilmente instabile ed eccitabile può essere avviata dal movimento ago considerata come il “richiamo” per l’assone o attività che mantiene la fibra muscolare attiva Fibrillazione “Firing” Aumentato da: > temperatura corporea, > catecolamine Diminuito da: < temperatura corporea, arresto circolatorio, < attività metabolica, ipossia ARREST OF CIRCULATION RESTORATION BLOOD FLOW PERFUSION SALINE SOLUTION ONDE LENTE POSITIVE (PSW) Onda positiva con lenta fase di ritorno negativa ONDE LENTE POSITIVE (PSW) ARE FIBRILLATION POTENTIALS AND POSITIVE SHARP WAVES THE SAME? NO Kraft 95-96 Più precoce della fibrillazione (ratto dopo 36-48h vs. 72h; uomo 7-8 gg vs 15 gg) EMG disease: PSW isolate non fibrillazione, autosomico dominante, solo quadro neurofisiologico (Wiechers 1979) Isolate in ipo-K, miotonie, polimiosite, trauma muscolare, neuropatie demielinizzanti (alta frequenza, regolari) ARE FIBRILLATION POTENTIALS AND POSITIVE SHARP WAVES THE SAME? YES Dumitru 95-96 La frequente osservazione dell’evoluzione da un’onda bi o trifasica (fibrillazione) in un’onda lenta positiva fa presupporre una chiara relazione fra i 2 segnali Single Muscle Fiber Discharge Transformations: FP. and PSW Dumitru 96-98 L’ago inserito nel muscolo può provocare un blocco completo (cut-end) o parziale (crush-end) del potenziale elettrico EXTRACELLULARE EXTRA + INTRA INTRACELLULARE DENERVAZIONE La registrazione può essere extracellulare, extra+intra o intracellulare Deformazione muscolare Dumitru 1998 Deformazione muscolare Dumitru 1998 FASCICOLAZIONE Singolo potenziale di UM che scarica spontaneamente e sporadicamente (Roth) frequenza di scarica irregolare 0.1-10 Hz Ampio morfologia, amp, durata variabili in genere visibili clinicamente (Sonography) Diversa dalla contrazione fascicolante di alcuni neuropatici, attivata dalla volontà (scariche sincrone di diverse UM, ritmiche) benigne e/o maligne fascicolazioni Fascicolazione: quantificazione linee guida AAN 0, + ++ 2 zone, + aree, +++ ++++ Sparse moderate prominenti 2-10/min., 10-15/min., 50-100/min., >100/min. linee guida AAEE Fascicolazione e Patologie SLA Neuropatie (diabetica, alcoolica, carenziale, paraneoplastica, amiloidosi, porfiria, connettivite, crioglobuline, tossiche…) radiculopatie, plessopatie siringomielia benigne, s. crampi-fascicolazioni neuropatie FP correlano con n° di polifasici (Raudino ‘91) Fibrillation potentials, positive sharp waves and fasciculation in the intrinsic muscles of the foot in healthy subjects (Falck ‘83) 53 soggetti sani, 18-70 anni Solo 19% silenzio elettrico a riposo 72% almeno un potenziale a riposo frequente piccola neuropatia dei nervi del piede Fasciculation potentials in healthy people (Mitsikostas ‘97) 122 soggetti sani, 17-67 anni FHB>EDB> FDI FPs/min = 8 maschi>femmine correla peso, altezza, ansia sindrome Fascicolazioni benigne 1.6% FASCICOLAZIONE ipotesi genesi Distale Non influenzabile dalla volontà Origine distale in 1 giunzione poi spreading antidromico alla arborizzazione della stessa UM FASCICOLAZIONE ipotesi genesi Distale Scompare con curaro Non scompare con blocco anestestico prossimale del nervo Aumentano con gli anticolinesterasici QUINDI : ORIGINE DISTALE Corrispondono alle UM low-threshold del normale Genesi Fascicolazioni SLA Ipotesi genesi Prossimale (Eisen, Praga ‘99) Fascicolazioni SLA: genesi rostrale motoneuroni spinale diffuse, larga escursione segmenti potenziali complessi, più ampi del singolo PUM (30% SLA) più “instabili” del singolo PUM, componenti “come and go” mean fiber density fascicolazione > PUM mean jitter fascicolazioni 472.6 +- 174 < con progredire di malattia per < glutamato Fascicolazione: jitter aumentato De Carvalho 1998 FP=instabili se DS amp e durata varia >10% (5 FP consecutivi) FP=stabili contrazione volontaria PUM = FP (var. amp e durata <20%) stimolo elettrico transcutaneo valutazione stabilità FP Fascicolazione: jitter normale De Carvalho 1998 Fascicolazioni BENIGNE ipotesi genesi Distale (EISEN, Praga ‘99) Fascicolazioni intermittenti caffeina, fatica, tabacco, postesercizio piccole escursioni segmenti interessati potenziali molto semplici, stabili, forma costante generatore terminale assonale Miochimie Doppiette, triplette o multiplette, bassa frequenza 0.5-10/ sec, ISI >, possibili blocchi Freq. UM variabile 5-62 Hz--> 20-200 Hz Iperventilazione CaCl ev (genesi periferica/centrale) visibili clinicamente Miochimie facciali HPN CaCl Scariche complesse ad alta frequenza AMPIEZZA STABILE SCARICHE COMPLESSE Scariche bizzarre alta (5-150 Hz) / bassa (0.3-10 Hz) frequenza, pseudomiotoniche, CRD Complesso base polifasico, durata 20-170 msec, ampiezza e forma stabili, spike piccoli inizio e fine bruschi neuropatie croniche, miopatie, sfintere uretra persiste dopo anestetico e curaro genesi muscolare spontanee, percussione, ago, dopo PUM polifasico SCARICHE RIPETITIVE COMPLESSE SCARICHE RIPETITIVE COMPLESSE Complesso base durata 20-170 msec contiene 2-50spike ciclo complesso base 0.5-100 Hz IDI = intervallo fra 2 complessi base IDI jitter 2-5 us IPI fra 2 spike SCARICHE COMPLESSE: schema CRD (Trontelj ‘83 SFEMG) La registrazione con microelettrodo mostra che le scariche ripetitive complesse sono costituite da numerosi potenziali di singola fibra muscolare in rapida sequenza. Una fibra funge da pacemaker ed attiva efapticamente fibre contigue, l’ultima delle quali genera un potenziale sufficiente a rieccitare la fibra pacemaker, dando così origine a nuovi cicli di attivazione che si ripetono identici fra loro fino a che la fibra pacemaker non si esaurisce. Scariche ripetitive complesse Le scariche ripetitive complesse hanno un’ampiezza compresa tra 50 mV e 1 mV ed una durata fino a 50-100 ms. Sono espressione dell’attivazione di un gruppo di fibre muscolari che scaricano secondo una determinata sequenza. L’intera sequenza si ripete ad una frequenza compresa tra 5 e 100 Hz. La morfologia polifasica e complessa rimane costante per ogni serie di scariche e termina bruscamente. Il suono ricorda quello di una mitragliatrice. La ripetibilità della forma delle singole scariche ripetitive complesse le distingue dalle scariche miotoniche, dalle scariche neuromiotoniche e dai crampi. Scariche ripetitive complesse Le scariche ripetitive complesse si osservano in numerose patologie che comportano sofferenza muscolare neurogena o miogena cronica: Polimiosite Malattie del motoneurone Radicolopatie Polineuropatia cronica Mixedema Sindrome di Schwarz-Jampel Distrofia muscolare di Duchenne Atrofia muscolare spinale Malattia di Charcot-Marie-Tooth MIOTONIA Scarica complessa alta frequenza Rumore di va e vieni Termina con modulazione della scarica, progressivam. Alterazione membrana muscolare canali Cl Patofisiologia delle scariche miotoniche Le scariche miotoniche sono dovute ad alterazioni dei canali del Na e del Cl. In condizioni normali, la conduttanza degli ioni Cl stabilizza la membrana tamponando l’effetto di correnti depolarizzanti. Una riduzione della conduttanza del Cl aumentando la resistenza della membrana, per effetto della legge di Ohm, aumenta l’eccitabilità. Durante la ripolarizzazione la ritardata inattivazione della conduttanza del K determina una iperpolarizzazione della membrana. Il lento ritorno della conduttanza del K ai valori normali determina, per l’accumulo di ioni K nei tubuli trasversi, una lieve depolarizzazione della membrana muscolare, che in condizioni patologiche, quali la ridotta conduttanza degli ioni Cl, può essere sufficiente ad indurre un nuovo eccitamento della membrana, iniziando così una attività ciclica che si automantiene. Nella paramiotonia e nella paralisi periodica iperkalemica sono implicate mutazioni del gene per il canale del Na nel muscolo scheletrico (cromosoma 17q 23-25). Nella distrofia miotonica sono presenti anomalie della conduttanza del Na e del Cl. Attività muscolare continua L’attività muscolare continua consiste in una diffusa attivazione spontanea di UM osservabile in varie malattie del SNC e SNP. Sinonimi di attività muscolare continua di origine periferica sono: Neuromiotonia Sindrome di Isaacs Miochimia generalizzata Pseudomiotonia Tetania normocalcemica Clinicamente si osservano dei movimenti ondulatori della cute sovrastante il muscolo ed un ritardo nel rilassamento dopo contrazione muscolare. L’attivtà muscolare continua ha origine da eccitazioni ectopiche che possono essere distribuite dai segmenti prossimali ai rami nervosi terminali della fibra nervosa. L’elettromiografia mostra scariche di UM ad alta frequenza fino a 300 Hz. L’ampiezza dei potenziali dell’UM diminuisce con l’aumentare del numero di fibre muscolari che non riescono a seguire l’alta frequenza della scarica. I farmaci stabilizzatori di membrana quali la carbamazepina e la fenitoina riducono l’attivazione muscolare involontaria. Scarica Neuromiotonica Isaac, neuropatie ereditarie, tossiche, neoplastiche, raggi complesso = 2 o più UM segue attivazione volontaria > ischemia non modificate da sonno, anestesia generale/spinale ampiezza < SFEMG Scarica Neuromiotonica Frequenza 0.3-5 Hz; “wings” 100 Hz IPI = 10-40 msec shape = PUM, costante (differente da CRD singola fibra muscolare) Scarica Neuromiotonica abolita da curaro persiste con anestetico regionale sparisce con anestetico periferico genesi: assone terminale intramuscolare (Oda ‘89), tutto nervo coinvolto (Wallis ‘70) Ac contro K channels, nodi Ranvier, dà rapido “firing” nelle fibre mieliniche, trasmissione ephaptica “assonale” Scarica Neuromiotonica NEUROMIOTONIA S. di Isaac-Mertens Scariche complesse alta frequenza Miochimie fascicolazioni crampi Anticorpi anti-canale K sensibile a CBZ CRAMPI Potenziali di UM che scaricano in alta frequenza durante accorciamento muscolare Scatenati da stimoli elettrici alta frequenza si interrompono all’allungamento muscolare CRAMPI I crampi sono contrazioni involontarie sostenute di un muscolo o parte di esso, spesso dolorose, che durano secondi o minuti e che coinvolgono più frequentemente i muscoli del polpaccio e del piede. Iniziano con potenziali singoli o doppi e diffondono alle regioni muscolari adiacenti coinvolgendo la quasi totalità del muscolo. La registrazione EMG mostra potenziali di UM che scaricano irregolarmente con frequenze comprese tra 40 e 60 Hz raggiungendo talora valori oltre 200 Hz. Le unità motorie tendono a scaricare sincronicamente a differenza di quanto accade durante l’attivazione volontaria.. Fattori scatenanti possono essere l’iponatriemia, l’ipocalcemia, il deficit vitaminico, la disidratazione e la riduzione dello spazio extracellulare. I crampi possono comparire in numerose malattie sia ereditarie che sporadiche nonché come sintomo associato a malattie del motoneurone, sciatalgie e neuropatie periferiche. CONTRATTURA Per contrattura si intende un accorciamento sostenuto del muscolo in assenza di attività elettrica. Sono indotte dall’esaurimento dell’ATP, che, come è noto, fornisce l’energia necessaria per rompere i ponti tra l’actina e la miosina e per riaccumulare lo ione Ca nel reticolo sarcoplasmatico. Possono essere indotte dunque dall’esaurimento energetico del muscolo per l’eccessivo affaticamento, o più frequentemente, in pazienti con deficit fosfofruttochinasi. della miofosforilasi o della
Scarica