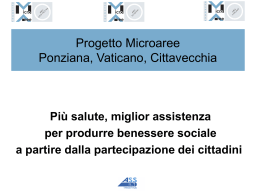ne, ” a Trieste: l’arte della cura nella medicina di comunità a trieste: ella cura nella medicina di comunità a trieste: storie e racconti di malattia storie e racconti di malattia e di raccontare, e delle Microaree, a sviluppare bitat sociali. per sperimentare are, descrivere, storie dall emerg to territoriale. [1.] [13.] onfronti [1.] Servizio 118 à delle pratiche, nziano Maria Grazia Cogliati Dezza era. storie dall emergenza “Laboratorio di comunicazi dall emergenza nestorie dei testi, LAVORO TERRITORIALE E MEDICINA DI COMUNITà: materiali e testi raccolti da Giova Servizio 118 iversi attori: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI Servizio 118 (l’intensità ratore e utente); “Laboratorio di comunicazione”: me punti di forza “Laboratorio di comunicazione”: materiali e testi raccolti da Giovanna Gallio negoziazione; ateriali e testi raccolti da Giovanna Gallio d’intervento capacità contesti, di salute). ade e i quartieri, a malattia grave, o in modi diversi della cura). ’ ’ ’ Progetto “Fare salute” - EnAIP d “Fare- EnAIP salute”di Trieste Progetto Progetto “Fare salute” Progetto “Fare salute” - EnAIP Trieste Ideatodida Maria Grazia Cogliati Dezza, Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 Triestina Comitato di progetto: Maria Grazia Cogliati Dezza, Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 Triestina; Giuditta Bambara, EnAIP FVG; Gianpaolo Quaia, EnAIP FVG; Carolina Moreira, EnAIP FVG; Giovanni Manisi, EnAIP FVG; Giovanna Gallio, ricercatrice LAVORO TERRITORIALE E MEDICINA DI COMUNITÀ: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI MARIA GRAZIA COGLIATI DEZZA 1 Lavoro territoriale e medicina di comunità: la cassetta degli attrezzi 1. Libertà - 2. “Fare salute”: un laboratorio aperto - 3. Sofferenza urbana e sviluppo di comunità: il progetto Habitat - 4. Il salto nelle microaree - 5. Cosa significa “deistituzionalizzare” in medicina - 6. Microaree e lavoro distrettuale - 7. Le macrozone – 8. Coesione sociale. [1. Libertà] Giovanna Gallio La prima volta che mi hai parlato del progetto “Fare salute”, nell’estate del 2009, ero un po’ disorientata all’idea di ricostruire casi clinici basandomi unicamente sull’oralità, senza attingere ad altre fonti o documenti scritti. In seguito sono stata sorpresa dalla ricchezza di queste narrazioni… Maria Grazia Cogliati Dezza Quando ho pensato al progetto, e te l’ho proposto, speravo di trovare la ricchezza di cui parli, ma non ero certa che le storie avrebbero rispecchiato la complessità delle pratiche. Un responsabile di distretto, per quanto condivida un flusso intenso di scambi con gli operatori e i servizi che coordina, svolge il suo ruolo a una certa distanza dai luoghi. Perciò sono stata felicemente sorpresa di trovare in questi racconti le peripezie e i rischi, le emozioni e soprattutto i “gesti”, le sequenze della presa in carico, con i dilemmi che si aprono ogni volta che si cerca di fare salute nei contesti di vita delle persone. In qualche modo era questo che volevo ottenere: mettere in scena il lavoro che noi facciamo nei suoi significati più profondi, coglierlo per così dire in atto, convinta come sono che si tratti di un lavoro per lo 1 MARIA GRAZIA COGLIATI DEZZA è responsabile del Distretto 2, e coordinatrice sociosanitaria della Ass n.1 “Triestina”. Il colloquio si è svolto il 28 dicembre 2012. 3 più ignorato dalla popolazione, e non sempre compreso anche all’interno dei servizi e delle strutture sanitarie. La concezione delle attività di cura può essere disomogenea tra le diverse sedi operative e amministrative dell’azienda, e a maggior ragione lo è tra i medici di medicina generale, gli specialisti e gli operatori dell’ospedale. Questi ultimi quando parlano del nostro lavoro lo raffigurano come un’attività assistenziale, non medica, come se il nostro ruolo fosse sovrapponibile a quello del servizio sociale del Comune, con cui a volte ci confondono. G. Gallio A colpire in queste storie è soprattutto il tema della libertà. Persone emarginate, silenti o passive, destinate all’abbandono o all’istituzionalizzazione, sono messe in condizione di scegliere e a volte realizzano, nel corso della malattia e perfino nella morte, desideri e progetti. A emergere non è solo la questione dei diritti alla cura, come riconoscerli e soddisfarli; prima ancora è una certa concezione della malattia che si afferma. Da un lato le dimensioni più private e intime del soffrire, il riconoscimento dell’unicità di ciascun caso e storia; dall’altro le dimensioni etiche e politiche di un’attività di cura che include nel proprio orizzonte di senso i luoghi abitati, le microcomunità di appartenenza dei soggetti. Nell’intervento sanitario queste dimensioni sono per lo più ignorate, o ridotte a categorie standard – mediche, sociologiche, psicologiche… M. G. Cogliati Dezza Sono molti i significati e le parole-chiave che possiamo ricavare da questi racconti, ma anch’io sono stata colpita dal tema della libertà: sia dal modo in cui gli operatori si battono per ottenerla e renderla possibile, sia dagli interrogativi che suscita, i cambiamenti che produce nelle vite dei singoli mediante la restituzione del potere di “dire”, di affermare i significati della sofferenza. Quando ci si ammala il dolore non è mai solo fisico: accanto a sentimenti di paura o vergogna, c’è il fatto di sentirsi umiliati e succubi, dipendenti da chi ti assiste. Nella cesura tra il prima e il dopo 4 l’insorgenza di una malattia vengono messi in discussione sistemi di valore, credenze e stili di vita; soprattutto si svela la fragilità dei legami, l’inconsistenza delle reti di supporto ogni volta che la persona è anziana, povera e socialmente isolata. Il lavoro di cura non può ignorare questa complessità; per questo si deve continuamente sottoporre a critica il riduzionismo medicospecialistico, che nella definizione di una patologia o di un disagio rende illeggibile la storia e l’esperienza dei soggetti. Questa concezione della malattia è stata da noi teorizzata fin dagli anni 70, nel lavoro con Basaglia; è il cuore stesso del nostro modo di procedere, anche se non siamo sempre in grado di esibire le prove che effettivamente si realizzi. Quel che più mi interessa nel tema della libertà, in cui si esprime il diritto di ciascuno di scegliere un proprio modo di vivere e di morire, è il rapporto fra l’istituzione e la persona: intanto il fatto che una relazione effettivamente si instauri, e in secondo luogo che questa relazione sia in grado di mediare l’intreccio tra la vita del malato e il mondo che lo circonda. Se li cogliamo in questa prospettiva, i racconti mettono in evidenza una grande prossimità dell’istituzione alla vita dei singoli: un’istituzione elastica, che si piega ed entra in maniera molto difforme a seconda dei bisogni, tenendo collegati i soggetti ai luoghi in cui avviene l’incontro. Le prove di questa elasticità abbondano in tutte le storie, ma diventano più visibili nei casi in cui le persone sarebbero altrimenti abbandonate al loro destino, nella terra di nessuno. Penso a Diego, l’uomo senza fissa dimora, o al giovane Amadou, rifugiato politico. Penso soprattutto ai numerosi casi di donne – Edda, Gabriella, Sarah, Corinna – dove il lavoro consiste nello sciogliere una serie di resistenze ad avviare il percorso di cura, affrontando ostacoli che sembrano insormontabili. In questi e altri racconti ho apprezzato la capacità degli operatori di “girare intorno”, quasi corteggiare il malato nel rispetto dei suoi ritmi e tempi, mediante una presenza estenuante ma dialettica. Ad ogni passo ci si interroga su che cosa è meglio fare e come farlo; si resta in ascolto di ciò che la persona vuole e non vuole, anche quando tace e 5 non parla, mentre parallelamente si convocano attorno al caso le più diverse competenze professionali e di aiuto. Da anni a Trieste l’integrazione tra i servizi è un fatto consolidato, una cultura portante in tutti i distretti, ma nelle microaree si realizza qualcosa di più e di diverso, quello che io chiamo “servizio diffuso”. L’asse in un certo senso si rovescia: non c’è un servizio che definisce il suo target di popolazione-utenza sulla base di una lista di prestazioni, ma interventi che si strutturano cammin facendo, attirando competenze e abilità che di volta in volta inventano la soluzione a un problema. In questo modo di procedere si esalta la capacità degli operatori di saper usare tutto quello che trovano: il pulmino di non so chi, il montascale prestato da un’associazione di volontari, lo spazio della parrocchia o della scuola per organizzare una festa, la professoressa in pensione che si fa aiutare da giovani un po’ sbandati, il vicino di casa che di notte ascolta i rumori e le voci dell’appartamento accanto e diventa parte attiva del percorso di cura. È una capacità guadagnata nel lavoro sul campo, basata sullo sviluppo di conoscenze e legami che vengono suscitati nei luoghi dove la persona abita. Si valorizzano rapporti di vicinanza per creare una socialità fatta di tanti pezzettini, un mosaico che si allarga giorno per giorno nel dialogo tra i più diversi personaggi: operatori “naturali” e di ruolo, studenti volontari, familiari e condomini, soci di cooperative e membri di associazioni, gruppi di cittadini che si costituiscono in itinere per realizzare piccoli progetti. Guai se non fosse così; se ciascun operatore del distretto dovesse seguire centinaia di malati con l’intensità di accompagnamento che emerge in queste storie, l’azienda sanitaria chiuderebbe per fallimento. Con le risorse a disposizione non ce la faremmo a reggere un impegno così accurato, una cura così personalizzata. Riuscire a utilizzare risorse per così dire infinite, mediante una capacità d’intrapresa proiettata all’infinito, credo sia un punto di forza che emerge da queste storie. Certo, non tutte le pratiche sono uguali, vi sono differenze significative da un contesto all’altro, da una microarea all’altra. Anche nei servizi più proiettati al territorio ci sono ancora operatori che agiscono al riparo del loro ruolo professionale, e 6 in parte lo si può capire: per chi esercita una pratica sanitaria fuori dai recinti ospedalieri, dagli ambulatori o dalle strutture protette, i rischi e i dilemmi sono all’ordine del giorno. Anche su questo punto, che investe la deontologia professionale, emergono dalle storie indicazioni importanti di cui tener conto. [2. Il progetto “Fare salute”: un laboratorio aperto] G. Gallio Il vero tema della nostra conversazione è cercare di ricostruire la cornice generale, le finalità e le motivazioni che hanno ispirato il progetto “Fare salute”. Questo ci permetterà di discutere la differenza esistente tra il lavoro distrettuale e di microarea, evocando anche i problemi e gli ostacoli che hanno caratterizzato la storia più recente del sistema sanitario triestino. Se ben ricordo, la tua intenzione iniziale era quella di applicare la ricerca alle pratiche territoriali in senso esteso, utilizzando come laboratorio soprattutto il Distretto 2. Solo in seguito, quando Enaip ha fatto proprio il progetto, hai deciso di estenderlo agli altri distretti e di concentrarlo sempre più sulle microaree. Come spieghi questo cambiamento di rotta? M. G. Cogliati Dezza Il progetto ha avuto una lunga incubazione prima di essere approvato; le sue finalità sono difficili da comprendere se non si mette a fuoco la particolare fase di transizione politico-amministrativa in cui è stato formulato. Il 2009 è stato l’anno in cui si è avuta la chiara percezione di un cambiamento che investiva non solo i vertici dell’azienda sanitaria, ma anche la concezione di servizio pubblico per come l’avevamo sempre praticata. È stata questa forte preoccupazione a spingermi a superare una serie di resistenze, dubbi ed esitazioni che avevo avuto fino a quel momento nell’interpretare il mio ruolo di coordinatrice sociosanitaria. L’incarico mi era stato conferito l’anno prima, allo scopo di promuovere e facilitare i rapporti di 7 collaborazione e partnership con i vari enti, pubblici e privati, che concorrono alla realizzazione di servizi sanitari. Per quanto fosse implicito nel mio ruolo il coordinamento delle microaree, era difficile realizzarlo per diverse ragioni. Da un lato si erano evidenziati fin dal principio modi differenti di implementare gli obiettivi del progetto nei diversi quartieri della città; dall’altro l’idea stessa di un ruolo di coordinamento sovra-distrettuale suscitava resistenze. Ciascuno, a partire dai capi-distretto, difendeva la propria autonomia: un po’ perché si riteneva che la varietà delle esperienze di microarea fosse di per sé un bene da salvaguardare, un po’ perché il carattere sperimentale del progetto lo sottraeva a criteri di valutazione univoci. Anche se c’era una lista di obiettivi a cui tutti eravamo vincolati, molti aspetti del lavoro di microarea non erano riducibili a variabili di computo statistico; non a caso negli anni precedenti erano naufragati i tentativi di creare una scheda di valutazione condivisa. Quando Win-Microarea è stato avviato, nel 2005, era stata istituita una forma di coordinamento affidata a Chiara Strutti, e a un piccolo team che lavorava alle dirette dipendenze di Franco Rotelli2. Per più di due anni si è molto puntato sulla valorizzazione dei singoli operatori, quasi tutte donne e infermiere che mettevano le loro capacità e la loro esperienza al servizio del progetto. In qualche modo si proteggeva la loro libertà di esplorare le aree territoriali e di costruire delle mappe, immaginando l’instaurarsi di un rapporto dialettico, produttivo di nuove conoscenze e stili di lavoro il più possibile aderenti alle realtà locali incluse nell’esperimento. Per questo veniva anche scoraggiata qualsiasi volontà egemonica: nessuno era autorizzato a mettere il proprio cappello sui significati che solo la pratica avrebbe potuto liberare, nel senso di “realizzare”. G. Gallio Si temeva che qualunque teoria, calata dall’alto o dall’esterno, avrebbe potuto ostacolare il riconoscimento delle diversità – 2 F. Rotelli era all’epoca direttore generale della Ass n.1 “Triestina”. 8 antropologiche, culturali, organizzative – dei contesti territoriali, omologandole in un linguaggio di tipo normativo o prescrittivo... Maria Grazia Sì, l’esperimento doveva essere tenuto aperto a diversi sviluppi, al di fuori di concezioni o teorie preformate. Questo spiega come mai io abbia a lungo esitato a prendere iniziative; il mio ruolo di coordinamento sovra-distrettuale non era chiaro, i compiti che mi venivano affidati erano rimasti impliciti. Tuttavia, nel 2009 mi sono fatta coraggio, e ho deciso di avviare il progetto “Fare salute”. Perché l’ho fatto, con quali finalità? Per rispondere a questa domanda devo risalire ancora più indietro nel tempo, a tutto ciò che collega l’esperienza delle microaree a un precedente progetto che ha inaugurato lo sviluppo di pratiche comunitarie nell’azienda sanitaria triestina. Sto parlando di Habitat, un progetto nato nel 1998, fortemente voluto da Rotelli, da me e da altri dirigenti e operatori dell’azienda. Anche se all’epoca non era ancora stata emanata la legge 328/00 di riforma dell’assistenza, avevamo la percezione che fosse urgente intervenire in alcuni rioni della città, caratterizzati dalla presenza di grandi insediamenti di case Ater, dove nel corso del tempo era stata concentrata una popolazione per lo più anziana, per lo più povera ed emarginata, trascurata nei secoli… G. Gallio … nei secoli dici? M. G. Cogliati Dezza Sì, nei secoli. È la stessa storia che si ripete, il problema della disuguaglianza sociale con cui ci siamo confrontanti già a partire dagli anni 70, iniziando il lavoro di smantellamento del manicomio. Certo ricorderai il libro “Classi sociali e malattie mentali”,3 scritto da Hollingshead e Redlich, su cui tutti ci siamo formati. I due autori, 3 A. B. Hollingshead, F. C. Redlich, Classi sociali e malattie mentali, Einaudi, Torino 1965. 9 un sociologo e uno psichiatra, per raccogliere dati sull’incidenza e la prevalenza dei disturbi mentali nella città di New Haven, nel Connecticut, avevano disegnato una mappa a cerchi concentrici, evidenziando che il maggior numero di ricoveri in ospedale psichiatrico proveniva dai cerchi esterni: le periferie, gli slums, i quartieri degradati dove viveva la popolazione più povera. Da allora molte ricerche hanno confermato che tutto ciò che sta intorno alla malattia, quelli che oggi chiamiamo i “determinanti non sanitari di salute” (età, sesso, condizioni economiche e abitative, reti familiari e di supporto sociale) sono molto più importanti dei fattori biologici nel motivare l’insorgenza e il decorso di una malattia, o nel prevedere gli esiti di un trattamento. Anche di recente, nel corso di un convegno alla Stazione marittima un epidemiologo dell’Università di Torino ha riprodotto una mappa della città suddivisa in settori, dimostrando che le persone che si ammalano di infarto provengono in maggioranza dalle periferie, dove è più elevata la soglia di accesso alle strutture cardiologiche e alla medicina d’urgenza.4 [3. Sofferenza urbana: il progetto Habitat] G. Gallio Che cosa si proponeva il progetto Habitat, quali erano i suoi obiettivi? M. G. Cogliati Dezza Un primo obiettivo era mettere al centro della discussione e delle pratiche distrettuali gli spazi fisici della povertà, i contesti della sofferenza urbana, quelle che in seguito sono state definite le “vulnerabilità collettive”, rendendo esplicito lo statuto interindividuale della malattia. Un secondo obiettivo era colmare la distanza che separa le fasce più deboli e svantaggiate della 4 Si parla del convegno organizzato dalla “Rete nazionale di promozione della salute”; l’epidemiologo a cui si fa riferimento è il prof. Geppino Costa. 10 popolazione dai servizi sanitari, mediante azioni e interventi che coinvolgevano non solo i responsabili delle politiche assistenziali e abitative, ma anche le parrocchie, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali. In quegli anni si stavano diffondendo un po’ ovunque in Italia progetti di risanamento dei territori dal punto di vista soprattutto urbanistico, mentre i criteri di finanziamento delle politiche sanitarie e sociali erano sempre più vincolati allo sviluppo locale o “welfare municipale”. Dunque si può dire che con Habitat si affaccia per la prima volta il problema dell’equità degli interventi e dei trattamenti attorno all’idea di costruire progetti orientati alle comunità locali, mediante strategie d’integrazione tra una pluralità di attori istituzionali, privati e pubblici. Nei progetti Habitat – realizzati nei quartieri di Ponziana, Vaticano, Gretta, Rozzol Melara, Valmaura, Borgo San Sergio – le dimensioni della salute vengono intrecciate alla qualità del vivere e dell’abitare. Si afferma il diritto delle persone più fragili e svantaggiate ad avere una casa decente, in un luogo dove passa regolarmente l’autobus, dove i marciapiedi non siano pieni di buchi, e vi sia un giardino o una panchina per sedersi. Ma la cura dell’habitat è collegata a obiettivi di abilitazione e inclusione sociale. G. Gallio I risultati ottenuti dal progetto Habitat sono stati molto lusinghieri: in breve tempo sono nati collettivi e gruppi che prima non c’erano, nuove organizzazioni… M. G. Cogliati Dezza Più che altro si sono attivati dei “comitati territoriali”, ed è stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra i diversi enti che partecipavano ai progetti. Nel protocollo, firmato anche dal Comune di Trieste, si prevedeva tra l’altro di rinnovare i portierati delle case Ater, appaltandoli a cooperative sociali che da tempo svolgevano progetti educativi o d’inserimento al lavoro nei diversi territori. Questo ha consentito ad alcune imprese sociali di investire sul progetto, 11 valorizzando i portierati come punto di ascolto dei bisogni della popolazione residente, avviando esperienze interessanti. Anche le associazioni di volontariato hanno ricevuto in quel periodo un forte impulso: alcune sono state riconosciute grazie a modesti contributi economici, che l’azienda sanitaria attribuiva loro sulla base di obiettivi che venivano definiti volta per volta. In tal modo si è creata una cornice di riferimento, un background culturale che ha reso possibile ante litteram quell’integrazione operativa poi auspicata dalla legge di riforma dell’assistenza, recepita dalla regione Friuli Venezia Giulia con un certo ritardo, nel 2004. Soprattutto abbiamo ottenuto le prove che, lavorando insieme in una prospettiva di integrazione comunitaria, si poteva garantire ai cittadini una diversa qualità dei servizi. Tuttavia, dai rapidi progressi che Habitat aveva consentito emergevano questioni irrisolte, problemi che investivano la dimensione propriamente sanitaria degli interventi. È su questo terreno che va colta l’originalità del progetto WinMicroaree, il cui scopo era responsabilizzare in prima persona gli operatori e i referenti delle strutture aziendali su una serie di obiettivi incentrati sulla gestione della salute. Non starò a ripeterli, ma se si legge la lista ci si accorge che i primi obiettivi riguardano la riduzione dei ricoveri impropri, la diminuzione del consumo di farmaci e degli esami specialistici, elevando l’appropriatezza diagnostica e delle prestazioni terapeutiche. Solo nella seconda parte subentrano obiettivi di equità e di partecipazione dei soggetti alla cura. Nell’insieme viene scoraggiata ogni forma di istituzionalizzazione delle persone con malattie di lunga durata, mettendo al centro del dispositivo sanitario il problema della coesione sociale. 5 5 Sugli obiettivi del progetto Win-Microaree, che a partire dal 2005 ha recepito i precedenti progetti Habitat trasformandone la concezione in senso esplicitamente sanitario, cfr. il testo in appendice a questo volumetto. Sono numerosi i siti internet, collegati all’Ass 1 “Triestina”, dedicati a presentare il progetto delle microaree. 12 [4. Il salto nelle microaree] G. Gallio Win-Microarea configurava un nuovo passaggio, un vero e proprio salto. Eri d’accordo con gli obiettivi del progetto? Maria Grazia Non solo ero d’accordo, ma ho collaborato a tutta la fase iniziale di riflessione su quelle che avrebbero dovuto essere le ricadute del lavoro di microarea sui distretti, prendendo molto sul serio il significato dell’esperimento. Tuttavia quasi subito ho registrato una certa difficoltà da parte degli operatori a fare propri gli obiettivi del progetto, come se la risposta integrata al bisogno dei pazienti costituisse il massimo oltre il quale era difficile andare. G. Gallio Cosa intendi dire? M. G. Cogliati Dezza Quando si parla di lavoro integrato, fra discipline o competenze professionali diverse, si configura un percorso comunque asimmetrico: da una parte c’è l’istituzione, rappresentata da un singolo operatore o da un gruppo di operatori, che formula una diagnosi e una prognosi, mettendo in atto una risposta il più possibile efficace; dall’altra c’è il cittadino/utente che in maniera passiva recepisce la bontà e la qualità dell’intervento che riceve. In questo modo di concepire l’intervento sanitario manca l’idea che il soggetto debba essere attivato nel suo contesto, diventando in qualche modo responsabile del proprio progetto di salute. Era questo principio – o criterio di attivazione – uno dei punti centrali di Win-Microaree, ma quando il progetto è stato formulato mancava, a una certa parte di operatori e dirigenti aziendali, la cultura e l’esperienza della deistituzionalizzazione di cui parlavo agli inizi. Non era cioè diffusa la consapevolezza che tra diagnosi e prognosi, tra prescrizione di un trattamento e pratica della cura, esiste una distanza 13 abissale, un vuoto che non è riempito da nessuno se non sei tu a problematizzarlo. Di questa distanza alcuni operatori fanno fatica ancora oggi a prendere atto. In anni di lavoro ho potuto constatare in che modo certi medici si trincerano dietro gli stereotipi della malattia, attenendosi ai pochi punti da repere che stanno nella loro valigetta. Pensano che, una volta fatta la diagnosi e scritta la ricetta, sia automaticamente assicurata la capacità del paziente di curarsi. Si presuppone che il malato di una malattia cronica sia in grado, con le sue forze, di realizzare un cambiamento che investe lo stile di vita, il sistema di alimentazione e via dicendo. La realtà ci dimostra che le cose non vanno quasi mai così, e quanto più la persona è isolata, povera dal punto di vista del reddito, o povera dal punto di vista culturale e relazionale, tanto più le prescrizioni mediche cadono nel vuoto. G. Gallio Delle cose che dici ciascuno, in misura maggiore o minore, fa esperienza nella propria vita, anche senza essere povero. Credo infatti che tu ti riferisca ad atteggiamenti e culture ovunque dominanti nel mondo sanitario, dove a tuttora prevale o il modello clinico – ospedaliero, che per definizione ignora le condizioni di vita del paziente. È di questo che stai parlando? M. G. Cogliati Dezza Sì, mi sto riferendo a una cultura che, anche nelle sue versioni più avanzate, prevede che per ogni malattia esistano delle procedure e linee guida a cui attenersi, dando per scontato che il malato si adegui. Negli ultimi anni il linguaggio dei professionisti si è in parte adattato alla cultura dei pazienti, e c’è chi dedica molto tempo a spiegare come fronteggiare una malattia, ma il cambiamento dello stile di vita viene prescritto sulla carta e tutto finisce lì. Nessuno si chiede fino a che punto la persona sarà in grado di assumere in proprio la gestione della malattia, o fino a che punto il recupero di uno stato di salute comporti il miglioramento della qualità di vita. 14 Tutto questo processo di comprensione della realtà, il farsi carico delle dimensioni sociali o esistenziali della malattia, in passato non accadeva mai, e anche ora è frequente che i problemi non siano esplicitati da parte dei medici, in modo da mettere in rete le conoscenze e le competenze. Per cui ancora oggi andiamo nelle case e troviamo armadietti stracolmi di farmaci; ci viene mostrata la prescrizione, ma quello che la persona fa è completamente altro. Anche al di là dei medici, io ho avuto la netta sensazione in quegli anni, quando il progetto delle microaree è stato avviato, che il mettere in discussione la concezione degli interventi fosse una richiesta eccessiva, in qualche modo inaspettata e difficile da mettere a fuoco. Non rientrava negli schemi e nei modi di pensare di molti operatori, che già ritenevano di sviluppare una pratica avanzata. Era come se le numerose attività sviluppate dai progetti Habitat fossero di per sé sufficienti, anche se coesistevano con un modo abbastanza tradizionale di concepire l’intervento medico. E questa mi sembrava una contraddizione. G. Gallio Anch’io ho avuto la sensazione che i progetti Habitat siano stati per lo più interpretati come un’attività di animazione dei quartieri, una sorta di complemento necessario del lavoro territoriale, ma non tali da revocare in dubbio gli stili di lavoro. In certi casi questa idea di animazione è stata trasferita, in maniera un po’ meccanica, nel progetto delle microaree, come se fosse il semplice prolungamento di qualcosa che era già stato sperimentato. M. G. Cogliati Dezza Habitat ha smosso molte cose, ma non aveva tra i suoi obiettivi quello di trasformare la cultura medica dei servizi territoriali, e forse il successo del progetto ha contribuito a confondere ancora di più l’immagine pubblica del nostro lavoro. Me ne sono accorta un giorno quando, parlando con alcuni medici che lavorano in ospedale, trapelava involontariamente dai loro discorsi l’idea che noi eravamo dei professionisti molto bravi perché facevamo al meglio una forma di 15 assistenza sociale. Io certamente non disdegno le politiche sociali, mi sono anzi carissime, ma la nostra mission è quella di fare sanità e salute, non assistenza. Quindi, per tornare alla domanda che mi ponevi agli inizi, nel 2009 ho cominciato a pensare che tutto il portato della nostra azione, la cultura della deistituzionalizzazione sviluppata a Trieste da Basaglia in poi, con l’andata via di Rotelli rischiava di morire per sempre, non essendosi abbastanza consolidata nel lavoro distrettuale. C’erano, sì, degli spunti interessanti, tante buone pratiche che venivano messe in atto, ma tutto questo non bastava a trasmettere agli operatori più giovani una cultura critica della medicina. Perciò ho deciso di avviare un percorso di formazione e ricerca che avesse, tra i suoi principali obiettivi, la messa in discussione di questo tema prima di ogni altro. G. Gallio Intendevi aprire la questione, mostrare che c’è… M. G. Cogliati Dezza Aprirla, perché mi sembrava che la pratica fosse in certi casi più avanti della teoria, e che di molte pratiche avanzate non ci fosse visibilità o consapevolezza tra gli operatori. Perciò, sentendomi debole e poco riconosciuta nel ruolo di coordinatrice sociosanitaria, ho deciso che il percorso di ricerca dovesse cominciare dal mio distretto, sperando che dalle prime storie da te raccolte potessero nascere nuove idee, spunti o riflessioni che in seguito avrebbero potuto essere estesi, contagiando le altre realtà distrettuali. Il mio intento era portare allo scoperto le contraddizioni che attraversano le pratiche, mettendo a fuoco le affinità esistenti tra le microaree, senza tuttavia esercitare alcuna imposizione. Da qui il carattere processuale della ricerca, e un metodo di lavoro che, oltre a raccogliere storie e materiali di analisi, aveva lo scopo di aiutare le referenti di microarea a discutere fra di loro e a riconoscersi come gruppo. Questo in effetti è avvenuto con risultati molto soddisfacenti, grazie al lavoro che hai svolto anche sul piano formativo, nel corso di 16 numerosi seminari e giornate di studio che abbiamo organizzato cammin facendo. [5. Cosa significa “deistituzionalizzare” in medicina] G. Gallio In generale con il termine “deistituzionalizzazione”, coniato verso la fine degli anni 60 in coincidenza con il superamento degli ospedali psichiatrici, si fa riferimento a un metodo di lavoro che scompone l’assetto organizzativo e simbolico di istituzioni segreganti (“totali”, diceva Goffman), sottoponendo a critica il paradigma medicoscientifico che giustifica l’isolamento del malato come precondizione della cura. Nell’atto stesso di distruggere un’istituzione che sequestra il corpo da curare, sospendendo la persona dai suoi diritti e ruoli sociali, si crea un nuovo sistema decentrato di servizi, andando come a ritroso, in un atto di restituzione dei poteri della cura ai soggetti e alle comunità locali. Come dobbiamo intendere la deistituzionalizzazione applicata alla medicina di territorio, se già questa dislocazione è avvenuta e in apparenza non ci sono più istituzioni totali da abbattere? M. G. Cogliati Dezza Forse io semplifico un po’, ma credo che deistituzionalizzare significhi in primo luogo non far coincidere il malato con la malattia, mettendo tra parentesi la categoria diagnostica che lo classifica. Certo, dobbiamo sapere che cos’è il diabete e come curarlo, ma ancora di più dobbiamo avere riguardo, conoscenza e relazione con la persona che ha un diabete. E siccome le persone sono tutte diverse le une dalle altre, il progetto di cura deve incontrare la diversità di quel malato senza omologarla. In particolare, come dicevamo agli inizi, bisogna attribuire ai soggetti il potere di scegliere e decidere, facendo in modo che se quel potere non c’è o è incostante, venga in qualche modo supportato perché emerga e si affermi. È evidente che nel fare questo gli operatori sono tenuti a esercitare una riflessione critica sul loro ruolo, ben sapendo che il modo di procedere delle istituzioni è definito da regole selettive, create apposta 17 per occultare le contraddizioni che la malattia apre nell’esistenza dei soggetti. È questa pratica, che suscita domande o risveglia bisogni più di quanti non ne possa soddisfare, a rendere possibile l’ingresso di altri attori e soggetti, che vengono coinvolti a partecipare non perché un protocollo lo ordina e lo prescrive, ma perché la loro competenza è indispensabile al percorso di cura. Prendiamo ad esempio la storia di Walt. Quando gli infermieri e il medico del distretto entrano nella casa trovano i segni dell’inerzia e dell’abbandono; ogni tentativo di insegnargli come curare il diabete cade nel vuoto, per mesi non succede niente, non si modifica nulla. Si instaura una relazione monotona, ripetitiva, costellata da crisi in cui l’uomo rischia ogni volta di morire, finché il medico del distretto, mettendo in discussione il suo ruolo, comincia a smontare tutto l’ingranaggio. Agli inizi è una politica dei piccoli passi, che cerca di dare risposte ai problemi più urgenti e immediati, ma in breve tempo la situazione cambia, si trasforma. Con l’aiuto di una psicologa volontaria Walt inizia un percorso di recupero: torna a parlare, a camminare, finché comincia a chiedere, a desiderare, a scegliere. Quando allora, discutendo con gli operatori di questa e altre storie, mi tornavano indietro dilemmi e contraddizioni insanabili, in cui si rimarcava la distanza tra la scienza medica e la possibilità di migliorare in concreto lo stato di salute delle persone, è stato chiaro per me che il vuoto esistente tra le persone e le istituzioni sanitarie doveva essere colmato da noi prima di chiunque altro. Non potevamo più continuare a criticare i medici di medicina generale per la loro assenza o incapacità di farsi carico dei pazienti; dovevamo innanzitutto guardare a quello che facevamo noi. Devo dire che le cose sono cambiate negli ultimi anni anche per l’arrivo nel distretto di giovani medici particolarmente acuti e capaci, e di infermiere brave e coraggiose. Con loro, discutendo e ragionando attorno ai problemi che mi venivano riportati, ci interrogavamo per riuscire a declinare in maniera diversa la questione del fare salute rispettando la soggettività, sostenendo la crescita di autonomia della persona, e quindi mettendosi “al servizio di”. 18 Ovviamente non è un mettersi al servizio in maniera acritica; la libertà di scelta non ha nulla a che vedere con le ideologie neoliberali o liberiste, attualmente dominanti, che trasformano il malato in utenteconsumatore. La possibilità di una persona di scegliere non può essere attribuita a priori, ma deve affermarsi sulla base di alternative che può concretamente afferrare e cogliere, mentre è in corso una specie di lotta tra i diversi significati che le scelte assumono su un piano di realtà. G. Gallio In questo senso il termine “deistituzionalizzazione” è importante anche nell’indicare una serie di limiti: sia del soggetto che scegliendo impara ad aver cura di se stesso, sia di un servizio che non è più autorizzato a presentarsi come onnipotente nelle promesse che fa. Il limite è un orizzonte molto concreto che si delinea nel percorso stesso della cura, quando il soggetto si costituisce come capace di decidere nel senso che “vede”, mette alla prova la sua libertà. Quella che nel frattempo cambia è la falsa idea di un’istituzione che garantisce tutto, dal principio alla fine. Basaglia diceva che l’istituzione mente, sapendo di mentire, ogni volta che promette il miglioramento delle condizioni di salute senza definire il piano di realtà in cui avviene l’incontro con il paziente. M. G. Cogliati Dezza Oggi non c’è nessuno che possa proporsi come garante esclusivo della salute o della bontà di un intervento sanitario; perciò è necessario rispettare le differenze esistenti tra gli individui. Non solo i cosiddetti poveri, anche le persone di ceto medio-alto, provviste di mezzi per ricorrere al privato, possono non adattarsi al percorso di cura. Perché accade? Non si sa, ciascuno ha i suoi perché. La domanda che dobbiamo porci è un’altra: il soggetto che decide di non adeguarsi alla cura possiede gli strumenti per comprendere e scegliere? Qui sta la differenza tra un lavoro ben fatto e uno mal fatto. Solo quando l’operatore mette in atto una pratica di riconoscimento del soggetto, oltrepassando la relazione duale che crea dipendenza, 19 solo allora può aspettarsi che il malato sia in condizioni di comprendere, nel senso che tocca con mano le alternative tra cui scegliere. Possibilità nuove, che non ha mai nemmeno vagheggiato o supposto. Walt è un esempio di quello che sto dicendo. Da anni viveva chiuso in casa, senza chiedere niente: non aveva idea di poter ricevere aiuti dalle istituzioni, non sapeva nemmeno quali fossero i suoi diritti. Soprattutto non sapeva che anche la sconfitta, il fallimento e l’inerzia possono essere trasformati in relazione, ripresa di senso e quindi miglioramento delle condizioni di salute. Se faccio in modo che il soggetto acquisisca strumenti per comprendere, metto cioè alla prova la mia capacità di coinvolgerlo in un progetto di cambiamento, solo allora posso parlare di libera scelta. A quel punto posso accettare anche il suo diniego alla cura, il rifiuto del ricovero o del farmaco. Posso cioè accettare che la persona si rifiuti di cambiare. [6. Microaree e lavoro distrettuale] G. Gallio Dalle cose che hai detto risulta chiaro che, avviando il progetto “Fare salute”, non avevi l’intenzione di appiattire o di omologare le esperienze di microarea.. M. G. Cogliati Dezza Al contrario, volevo far emergere ancora di più le soggettività e le peculiarità delle pratiche, cercando di comprendere fino a che punto la raccolta di materiali discorsivi e narrativi potesse far risaltare i temi e i problemi che, in maniera forse un po’ sommaria, inscrivo nella parola “deistituzionalizzazione”. Come dicevo agli inizi, non sapevo cosa aspettarmi dalla ricerca, non avevo idea di quale fosse il punto di arrivo degli operatori nemmeno nel mio distretto. Perciò quando ho letto le prime storie ho avuto una specie di sobbalzo constatando che era già all’opera, nei fatti, la capacità degli operatori di sottoporre a critica il modello medico. Da questo punto di vista non c’è quasi differenza tra le storie, e a maggior ragione si conferma che era 20 fondata la mia richiesta di portare allo scoperto non solo il racconto dei casi, ma anche il modo degli operatori di argomentare o di concettualizzare le pratiche. G. Gallio Tutti gli operatori che ho intervistato esprimono un livello alto di cultura e consapevolezza critica, non solo degli strumenti che usano, ma anche del campo che osservano e in cui intervengono. Questo mi ha dato molta forza, tanto che a un certo punto ho desiderato estendere all’infinito i racconti fino a comporre un paesaggio di storie parallele, per mostrare la ricchezza dei percorsi e la pluralità delle visioni che coesistono all’interno di schemi di azione molto simili. Questa è la prova che a Trieste sono state create condizioni di esercizio della medicina territoriale che agiscono di per sé; il sistema è poggiato su basi così solide da costituire una sorta di rotaia su cui le pratiche scorrono, potendo sopportare le contraddizioni, le inevitabili confusioni e i conflitti… M. G. Cogliati Dezza Sì, ma a questo proposito vorrei aggiungere ulteriori riflessioni su come cambiano gli stili di lavoro se li osserviamo in una realtà piuttosto che in un’altra. Se ho voluto che tu iniziassi la ricerca applicandola alle Unità operative distrettuali, è perché in qualche modo pensavo che non ci fossero grandi differenze rispetto al lavoro sviluppato nelle microaree. In generale ero scettica, mi dicevo: “abbiamo arato in lungo e in largo, ma ancora non siamo in grado di raccogliere quel che abbiamo seminato”. Mi tenevo bassa nelle mie aspettative, per poi accorgermi che da un lato le pratiche erano molto più avanti di quanto non sospettassi, e dall’altro che anche nel mio distretto, dove mi sono sempre impegnata per integrare il lavoro delle microaree con gli interventi distrettuali, anche lì c’erano notevoli differenze tra i due ambiti. Quindi è vero quello che tu dici: è il sistema operativo a immetterti in uno scenario nel quale devi ricollocarti e prendere posizione, ma lo scenario della microarea si differenzia profondamente da quello del 21 distretto perché sei tu l’artefice di tutto quello che accade, e dei risultati che consegui. Entrando nella casa di una persona non sei l’infermiere che fa la flebo, o medica la lesione da decubito; a volte fai anche questo, ma in genere la referente di microarea ha un compito di regia nella conduzione del caso. Deve cioè fare una diagnosi sistemica per mettere in atto una cura sistemica, coinvolgendo via via gli infermieri del Sid, il fisioterapista, l’assistente sociale del Comune, il volontario, i familiari e via dicendo. Sappiamo che le referenti di microarea sono operatrici scelte, ma se hanno potuto fare un salto conoscitivo è perché è stato attribuito loro il compito di mettere a fuoco la scena della malattia, tenendo conto di tutte le variabili. Il risultato che devono ottenere è subordinato al fatto di rafforzare la soggettività del malato, mettendo in moto un processo in cui viene a lenta maturazione l’autonomia della persona. Non a caso in tutte le storie risuona un passo delicato: le operatrici bussano alla porta ed entrano con discrezione, vanno e vengono, aspettano che le persone si convincano, che cresca la fiducia… G. Gallio È una danza… M. G. Cogliati Dezza È una danza, un’attesa che la medicina assolutamente non contempla, essendo molto rigida nei tempi che impone ai soggetti. G. Gallio Quindi è vero che la microarea è messa lì per vedere, come in una lente di ingrandimento, tutto ciò che il distretto ignora o non vede. In questo senso è un bene che le riflessioni che ho raccolto contengano elementi di analisi critica della situazione. Come ha detto una volta Franco Rotelli, la microarea è stata pensata come un avamposto che serve a segnalare le potenzialità ma anche le carenze, i difetti e i limiti del lavoro distrettuale... 22 M. G. Cogliati Dezza Questo è il punto: come mai questa funzione della microarea non si è ancora pienamente realizzata? Secondo me è per le ragioni che ho detto prima: la messa in discussione del modello medico non è abbastanza penetrata nello staff di governo dei distretti e delle strutture sanitarie territoriali. Probabilmente una trasformazione culturale di questa portata non poteva avvenire nel giro di pochi anni, tanto più che i cambiamenti di indirizzo politico-amministrativo hanno finito con l’oscurare tutto il processo riformatore, mettendo a rischio anche l’esistente. Non solo a Trieste, ma nell’intera regione, non si sono più avuti negli ultimi anni stimoli di sviluppo o di innovazione dei servizi, e ciascuno è sempre più obbligato a difendere i risultati del proprio lavoro secondo codici di valorizzazione economica, di risparmio delle risorse. A sostegno del progetto delle microaree era stata coinvolta, in passato, anche la componente amministrativa: si raccoglievano dati, venivano stilati dei report periodici sul numero di ricoveri, l’uso dei farmaci e la quota di persone ad alto carico sanitario distribuite nelle microaree. Tutti questi strumenti erano importanti per decidere come incanalare gli interventi, e ora non ci sono quasi più. L’unico dato che ci viene fornito è quello relativo alla frequenza dei ricoveri, e sembra incoraggiante: nelle microaree dove il tasso di ospedalizzazione è sempre stato elevato per le caratteristiche della popolazione (anziana, con patologie croniche, ecc.), il numero dei ricoveri si è abbassato di parecchi punti, fino a rientrare nei tassi medi di ospedalizzazione della città. Tuttavia, anche su questo punto l’analisi andrebbe approfondita: le operatrici si chiedono se si continuano a praticare ricoveri impropri, o se la degenza ospedaliera venga oggi utilizzata in maniera ottimale, scongiurando forme precedenti di trascuratezza e di abbandono dei pazienti. Dunque si può dire che il processo nel suo insieme si è abbastanza fermato sotto il profilo della valutazione, riducendo la nostra capacità di definire obiettivi mirati sulla base di evidenze statistiche. Questo ha indubbiamente abbassato la capacità delle microaree di riportare alla casa madre, e cioè ai distretti, i risultati del lavoro che viene svolto, 23 con la conseguenza di indebolire quel potere di influenzamento e di contagio che era stato auspicato, e che era implicito nel carattere sperimentale del progetto. [7. Le macrozone] G. Gallio Resta il fatto che le microaree hanno avuto un grande successo nel rapporto con la popolazione: il loro nome si è imposto come una specie di marchio, la cifra di riconoscimento di un certo stile di lavoro… M. G. Cogliati Dezza Quel che sicuramente abbiamo dimostrato, in alcuni rioni più che in altri, è la capacità delle istituzioni di dare a tutti le risposte dovute, a cominciare dagli ultimi. Molti risultati sono stati acquisiti nel promuovere un’idea di comunità intesa come attivazione di legami tra gli abitanti di un rione mediante l’organizzazione di feste, l’aiutarsi reciprocamente, il condividere progetti di miglioramento dell’habitat sociale. In questo senso si può dire che il risultato più importante delle microaree è aver spostato l’attenzione non solo dai servizi alla persona, ma anche dalla singola persona ai modi in cui gli individui si incontrano e si aggregano fra di loro in quanto abitanti di un territorio. Attualmente i servizi sanitari, anche quelli più avanzati, tendono a definire come oggetto del loro lavoro il singolo caso, la singola situazione individuale o familiare, ma non hanno occhio per il contesto urbano, o per la trama di relazioni da cui i soggetti ricavano appartenenza e identità. E quindi fanno fatica a vedere (o sono programmati per non vedere) le possibilità di attivare le risorse che circondano i soggetti in quanto abitanti di un luogo. La microarea è partita dal singolo, ma non ha potuto fare a meno di incontrarsi con i gruppi, prima di tutto quello dei condomini, cominciando dal problema degli ascensori che non ci sono per i vecchi del quinto piano, o dei piccioni che sporcano, i giardini incolti e abbandonati, le cassette della posta che mancano, le porte sbrecciate e 24 i muri scrostati. La microarea aveva nel suo mandato il compito di accorgersi di tutti questi ostacoli, ma non era certo che sarebbe riuscita a tematizzarli come parte integrante del progetto di salute. Dunque è l’intera città che dovrebbe essere suddivisa in tante microaree, zone di piccole dimensioni dove la persona e il suo contesto diventano al tempo stesso l’oggetto e il soggetto del lavoro. I tentativi fatti finora, di coinvolgere una serie di enti privati e pubblici per aprire nuove microaree (Enaip, Televita, Cacciaburlo, Villacarsia, gli stessi Centri di salute mentale), non sono andati sempre a buon fine, mentre vedo che sta cominciando a diventare produttivo, se pure con lentezza, il progetto delle macrozone che ho avviato nel mio distretto. G. Gallio In cosa consiste, vuoi parlarne? M. G. Cogliati Dezza Nell’ultimo anno, in collaborazione con altri operatori del distretto, ho cercato di applicare il modello della microarea al Servizio infermieristico domiciliare (Sid), suddividendo il territorio in cinque sottozone, ciascuna delle quali comprendente dieci o dodicimila mila abitanti. A ogni macrozona è stato assegnato un gruppo di quattro o cinque infermieri, suddivisi per strade o caseggiati, in modo da garantire il massimo di continuità nella cura delle persone di cui si fanno carico. Il lavoro dei gruppi è coordinato da un “facilitatore”, un ruolo che abbiamo cercato di rafforzare con i mezzi un po’ arcaici che il Sistema sanitario mette a disposizione: piccoli incentivi e riconoscimenti, anche finanziari, con cui si premia il raggiungimento di determinati obiettivi. Ai coordinatori è stato chiesto di mettere a punto una mappa delle aree territoriali di cui si occupano, in modo da rilevare i bisogni sanitari e le risorse esistenti – abitative, culturali, associative e di aiuto reciproco. Inoltre abbiamo organizzato un corso di formazione in cui erano soprattutto le referenti di microarea a trasmettere conoscenze sugli strumenti che utilizzano nel loro lavoro, la “cassetta degli attrezzi”. 25 A distanza di un anno dall’avvio del progetto abbiamo constatato dei cambiamenti significativi. Realizzando un intervento a tutto campo, gli infermieri hanno trasformato la loro visione del territorio: non solo perché sono più motivati e coinvolti di un tempo nell’affrontare i singoli casi, ma anche perché riescono a cogliere le dinamiche esistenti nei gruppi abitativi, e i diversi modi in cui la particolare fisionomia di un rione o di un caseggiato può migliorare o peggiorare i percorsi di salute. Su questo punto le verifiche sembrano a volte paradossali: quanto più un edificio è vecchio, abitato da una popolazione non benestante, tanto più migliora la qualità di vita. Se questo accade è perché le abitazioni hanno un ballatoio interno: le persone si conoscono e si parlano da un ballatoio all’altro, e anche per questo più facilmente si aiutano. Bisogna infatti considerare che nel Distretto 2, che comprende in prevalenza la parte centrale e ricca della città, le aree più povere – che pure esistono – non hanno una precisa identità sociale o architettonica. Nei rioni labirintici del Borgo teresiano c’è anomia: ogni caseggiato ha una storia a sé, una configurazione staccata e autonoma, nel bene come nel male. G. Gallio Quindi tu credi che la cultura degli infermieri del Sid sia cambiata… M. G. Cogliati Dezza È cambiata nel senso che oggi c’è una valorizzazione, sia personale che di gruppo, che viene ricercata e coltivata con continuità. Gli operatori hanno acquisito più autonomia e potere rispetto alle gerarchie aziendali: da una parte vengono investiti di responsabilità dirette, dall’altra si misurano con risultati non più valutati secondo una logica prestazionale, interna al servizio, ma guardando alle risorse complessive della persona e del territorio in cui intervengono. 26 [8. Coesione sociale] G. Gallio In conclusione vorrei sottoporti una questione che non abbiamo mai discusso, e che pure rappresenta una parola-chiave nel glossario delle pratiche territoriali. Parlo della “medicalizzazione”, e di tutto ciò che questo nome ricopre nella letteratura critica – sociologica, filosofica, antropologica. Sollevo il problema perché ci può essere un sospetto di abuso nella medicina territoriale e di comunità, già a partire dalla pretesa di egemonizzare le culture e i saperi della malattia e della salute. Anch’io, quando ho iniziato la ricerca, temevo di trovare le tracce di una sorta di invasione della medicina nella sfera privata dei soggetti. Il budget di salute, l’individualizzazione dei trattamenti: mi chiedevo in che modo queste procedure si potessero conciliare con una medicina di comunità. Soprattutto mi domandavo fino a che punto è lecito entrare nei caseggiati e bussare porta a porta, vincolando gli abitanti a una sorta di responsabilità nella cura anche degli altri. Se con il vicino di casa ho ragioni di ostilità o di conflitto, e se riesco a regolare il rapporto solo conservando una certa distanza, non vorrei essere forzata a stabilire un rapporto ravvicinato. Ciascuno a casa propria ha dei diritti inalienabili; d’altra parte sappiamo che i gruppi sociali più deboli si fanno più facilmente penetrare e colonizzare... M. G. Cogliati Dezza Io leggo la questione in un altro modo, nei termini del potere individuale di cui prima ho parlato. Dobbiamo partire dall’analisi che in certe fasce di popolazione non c’è potere nei confronti della propria vita, né nei confronti della collettività o della cosa pubblica, o nel dare indicazioni precise, mature e consapevoli, a una rappresentanza politica che sostanzialmente ti ignora, mentre dovrebbe difendere i tuoi bisogni e i tuoi interessi. Viviamo in un’epoca di grande distanza degli amministratori e dei politici dalla vita quotidiana delle persone; se dunque immaginiamo di dover rafforzare il potere non solo di 27 singoli individui, ma di gruppi di cittadini che diventano capaci di interloquire in maniera diretta con le istituzioni, avrei molto meno la preoccupazione che tu esprimi. Un punto su cui non abbiamo ancora lavorato abbastanza è la coesione sociale, la promozione e la difesa dei legami sociali. Nell’ottica della coesione sociale, tutte le attività comunitarie che abbiamo svolto, dal progetto Habitat in poi, non rappresentano il fine della nostra azione ma il mezzo, lo strumento per far sì che i singoli individui – che di volta in volta abbiamo attivato, accompagnato, supportato e riconosciuto – si confrontino gli uni con gli altri, assumendo l’identità di soggetti collettivi. Non sto parlando del comitato di quartiere fatto da cinque o sei persone, sempre le stesse, che si aggregano per rivendicare qualcosa, istituzionalizzandosi in una parodia di schemi politici obsoleti. Io parlo del bisogno di esserci, di individuarsi come abitanti o come cittadini in un campo dato, riuscendo a interloquire con l’amministrazione pubblica nel governo dei beni comuni. Parlo del fatto che la cultura del vivere e dell’abitare, e quindi anche del combattere la malattia e preservare la salute, non può consistere solo nel fatto che un cittadino usufruisce di prestazioni e servizi. In futuro sarà sempre più importante assumersi responsabilità dirette nel curare i legami sociali, o nell’accrescere le proprie competenze nel contesto in cui si vive. Su questo punto ritengo che il nostro lavoro non abbia ancora ottenuto tutti gli effetti sperati, i risultati per i quali da anni ci stiamo impegnando. G. Gallio Gli effetti del lavoro di microarea non si possono valutare sul breve periodo; tutto ciò che implica un cambiamento di cultura non è immediatamente visibile. Mi sembra piuttosto che tu lamenti un deficit culturale da parte di chi ha il potere di dirigere le politiche sanitarie. Sono gli amministratori locali a non porsi abbastanza il problema del legame sociale, o a interrogarsi troppo poco su come può cambiare in meglio il tessuto sociale se la malattia non viene trattata secondo schemi tradizionali… 28 M. G. Cogliati Dezza Proprio così, e allora rivendico la necessità di problematizzare e discutere questo tema. Nelle microaree dove si è cominciato a curare i legami fra le persone sono nati gli embrioni di una nuova socialità. Per fare un esempio, nella microarea di Ponziana si è svolto di recente un incontro tra l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Trieste, e un gruppo di abitanti che chiedeva di ottenere in affidamento un pezzo di giardino dove coltivare erbe aromatiche. L’obiettivo era quello di aprire uno spazio di attività e di incontro, soprattutto tra i vecchi e i bambini. Il fatto che questo progetto sia sulla buona strada per essere approvato, mostra che esistono delle possibilità per piegare le regole dell’amministrazione, in modo che gli spazi non vengano concessi solo ai comitati di quartiere, o ad associazioni ufficialmente riconosciute e regolate da uno statuto, ma anche a gruppi di cittadini che si aggregano fra di loro nel riconoscimento di un bene comune. I politici, quando parlano del bisogno di preservare i legami sociali, il che accade spesso, tendono a ripetere la stessa frase: “sviluppo uguale coesione sociale”. Questa equazione, di per sé ovvia, è molto opinabile una volta tradotta su un piano di realtà. Abbiamo infatti più volte verificato che lo sviluppo è una prerogativa di determinati gruppi sociali e non di altri, e che coloro che godono i benefici dello sviluppo spesso non producono coesione sociale nemmeno tra di loro. Il fatto di arricchire – e non impoverire – il capitale sociale degli individui e delle comunità locali, è un parametro essenziale di valutazione delle politiche stabilito in sede europea. Ma sono anche gli amministratori in carne ed ossa a doversi mettere a disposizione degli abitanti delle comunità, stabilendo un rapporto di vicinanza, di ascolto e confronto. G. Gallio In tutto questo qual è il rapporto della medicina con la politica? La medicina deve uscire da se stessa, ma deve poi continuamente 29 rientrare in se stessa, in un movimento che non è di appropriazione del territorio… M. G. Cogliati Dezza Certo. Noi parliamo di territori dove, svolgendo ogni giorno il nostro lavoro, discutiamo di come cambiare le politiche sanitarie e sociali, mentre cerchiamo di trasformare nella pratica le relazioni dei cittadini fra di loro nel governo della salute. Se prendiamo il concetto di salute nel senso più ampio è evidente che non può essere disgiunto dal bisogno di connettere le persone tra di loro, o di realizzare servizi accessibili, una buona rete fognaria, una rete di trasporti, scuole non cadenti, centri aggregativi per i giovani. Del resto, come dicevo, su questa strada del “fare comunità” e rafforzare i legami sociali resta ancora molto lavoro da fare nei prossimi anni. 30 Appendice: I dieci obiettivi-chiave del progetto Win-Microarea 1. Realizzare il massimo di conoscenza sui problemi di salute delle persone residenti nelle microaree (con azioni proattive, capillari, di grande prossimità, svolte “porta a porta” e individuando nelle banche dati sanitarie le persone fragili); 2. Ottimizzare gli interventi per la permanenza delle persone nel proprio domicilio, dove ottenere l’assistenza necessaria (iniziative volte a contrastare ulteriori incrementi del numero di posti in residenze assistite, tenendo conto che a Trieste esistono 100 case di riposo con oltre 3.200 ospiti anziani); 3. Elevare l’appropriatezza nell’uso di farmaci (ridurre i fenomeni di consumismo); 4. Elevare l’appropriatezza per prestazioni diagnostiche (ridurre l’accanimento/ dispersione diagnostica); 5. Elevare l’appropriatezza per prestazioni terapeutiche (evitare/ridurre le prestazioni che non servono, che generano spreco o false attese); 6. Promuovere iniziative di auto-aiuto ed etero-aiuto da parte di non professionali (costruire comunità, elevare il capitale sociale); 7. Promuovere la collaborazione di enti, associazioni e organismi profit e no profit per elevare il ben-essere della popolazione di riferimento (gestire i problemi in co-responsabilità); 8. Realizzare un coordinamento ottimale fra servizi diversi che agiscono sullo stesso individuo singolo o sulla famiglia (pre-occuparsi più delle ottimizzazioni che delle espansioni o delle razionalizzazioni); 9. Promuovere equità nell’accesso alle prestazioni, dando più qualità ai cittadini più vulnerabili (ridurre le disuguaglianze, per dare in modo disuguale ai diseguali); 10. Elevare il livello di qualità della vita quotidiana di persone a più alta fragilità (consentire di più e meglio una vita attiva e indipendente, soprattutto a chi parte svantaggiato). 31 FARE SALUTE – Laboratorio di formazion ricerca e comunicazione sulla “medicina di comunità” l’arte de storie e racconti di malattia FARE SALUTE - Laboratorio di formazione, Il progetto, realizzatodi nel biennio 2010-2011, si propone ricerca e comunicazione sulla “medicina comunità” a Trieste: con storie la voce dei protagonisti, e racconti di malattia la pratica medica dei Distretti e FARE SALUTE – Laboratorio di formazione, nella sfida che da anni, a Trieste, impegna gli operatori FARE SALUTE ricerca – Laboratorio di formazione, e comunicazione sulla “medicina comunità” progetto, avviatodinel 2010, si èaproposto di di raccontare conalaTrieste: voce unae medicina radicata nei luoghi, nelledeicase, negli hab comunicazioneIIsulla “medicina comunità” Trieste: storie racconti di malattia protagonisti la pratica medica dei Distretti e delle Microaree nella sfidaun chelaboratorio p L’idea-base del progetto è quella di aprire storie e racconti di malattia da anni, a Trieste, impegna gli operatori a sviluppare una medicina radicata nuovi metodi di racconto della malattia, al fine di informa Il progetto, realizzato nel biennio 2010-2011, si propone di raccontare, nei luoghi, nelle case,sinegli habitat L’idea-base del progetto è quella realizzato nel 2010-2011, propone disociali. raccontare, rappresentare i contenuti e le metodologie dell’intervent conbiennio la voce dei protagonisti, la pratica medica dei Distretti e delle Microaree, aprire medica un laboratorio per sperimentare nuovi metodi di racconto della protagonisti, ladi pratica deianni, Distretti e delle Microaree, Ricostruendo la storia di singoli casi, nella sfida che da a Trieste, impegna gli operatori a sviluppare malattia, al fine digliinformare, descrivere, rappresentare i contenuti e le stabilendo co che da anni, a Trieste, impegna operatori a sviluppare una medicina radicata luoghi, nelle case, neglilahabitat sociali. tra ilnei linguaggio delle procedure sanitarie e la complessità metodologie dell’intervento territoriale. Ricostruendo storia di singoli cina radicataL’idea-base nei luoghi, del nelle case, negli habitat sociali. progetto è quella di aprire un laboratorio per sperimentare evidenziati aspetti specifici casi, stabilendo confronti tra il vengono linguaggio delle procedure sanitarie e la che differen el progetto è quella di aprirediun laboratorio per sperimentare nuovi metodi racconto dellavengono malattia, al fine didi informare, descrivere, complessità delle pratiche, evidenziati aspetti specifici chequella ospedalie ladescrivere, “medicina comunità” da i di racconto della malattia, al fine di informare, rappresentare i contenuti e le metodologie dell’intervento territoriale. differenziano la “medicina di comunità” da quella ospedaliera. La raccolta di materiali orali, così come l’elaborazion re i contenuti e le metodologie dell’intervento territoriale. Ricostruendo la storia di singoli stabilendodei confronti La raccolta di materiali orali, così comecasi, l’elaborazione testi, serve a serve a documentare il grado di coinvolgimento dei di truendo la storia singoli casi, stabilendo confronti tra documentare ildilinguaggio sanitarie dei e ladiversi complessità delle ildelle gradoprocedure di coinvolgimento attori: da un pratiche, lato la da un lato la dimensione affettiva del lavoro di cura ( gio delle procedure sanitarie e la complessità delle pratiche, vengono aspetti specifici che dimensione affettivaevidenziati del lavoro di cura (l’intensità e ladifferenziano frequenza dei contatti, e la frequenza dei contatti, le relazioni ravvicinate fra oper gono evidenziati aspetti specifici che differenziano la “medicina di comunità” da quella ospedaliera. le relazioni ravvicinate fra operatore e utente); dall’altro i dubbi e le scoperte, a “medicina di comunità” da quella ospedaliera. dall’altro i dubbi e le scoperte, le incertezze e i conflitti com raccoltaedi materiali orali, cosìdicome testi,sul le La incertezze i conflitti come punti forza l’elaborazione di un interventodei basato lta di materiali orali, così come l’elaborazione dei testi, di un intervento basato sul continuo confronto e sulla n serve a documentare il grado di coinvolgimento dei diversi attori: continuo confronto e sulla negoziazione; dall’altro ancora gli aspetti ma ocumentare il grado dei affettiva diversiancora attori: gli nel aspetti di un sistema d da di uncoinvolgimento lato del lavoro ditempo, curaco-evolutivi (l’intensità co-evolutivi di la undimensione sistemadall’altro d’intervento protratto e l’importanza o la dimensione affettiva lavoro di (l’intensità e lache frequenza contatti, lepotere relazioni e utente); assumedel ladei capacità e ilcura degliravvicinate operatori difra esplorare i differenti protratto nel tempo, e operatore l’importanza che assume la c a dei contatti, le relazioni ravvicinate fra operatore evariabili utente); dall’altro i dubbi e le conto scoperte, e i conflitti come di forza contesti, tenendo di numerose (determinanti salute). ele ilincertezze potere degli operatori didipunti esplorare i differenti c bi e le scoperte,diAl leunincertezze e basato i iconflitti come punticonfronto forza erendono intervento sultenendo continuo sulla negoziazione; tempo stesso, racconti e le storie didimalattia conto della(determinanti d conto di numerose variabili vento basato sul continuo ancora confronto easpetti sullaorganizzativa, negoziazione; dall’altro gli co-evolutivi di un sistema complessità della dimensione affettiva ed etica del lavoro di case, le stra Soprattutto il racconto mostra glid’intervento interni delle ancora gli aspetticura co-evolutivi di un sistema d’intervento protratto tempo, e l’importanza assume la capacità al di fuorinel dello spazio ospedaliero o che ambulatoriale, offrendo una gli spaccati di vita delle persone che, ammalandosi di una tto nel tempo,straordinaria e l’importanza che assume la capacità ricchezza dioperatori indicazioni e riferimenti che vanno ulteriormente e il potere degli di esplorare i differenti contesti, possono assumere ruolo attivodiodegli passivo, interpretando otere degli operatori di esplorare differenti fruttatitenendo nel promuovere lenumerose capacitàcontesti, valutative e(determinanti auto-formative operatori. contoi di variabiliun salute). il cambiamento loro richiesto (stili di vita o conto di numerose variabili (determinanti di salute). Il progetto ilharacconto individuato nellegli storie parole-chiave: sorta di Soprattutto mostra interni delle case,una le strade e iglossario quartieri,e traiettorie racconto mostra gli interni delle case, le strade e i quartieri, sui tratti distintivi della “medicina territoriale edidiuna comunità”. gli spaccati di vita delle persone che, ammalandosi malattia grave, i vita delle persone che, ammalandosi diattivo una non malattia grave, L’elaborazione delruolo glossario, definito in astratto o a tavolino possono assumere un o passivo, interpretando in modima diversi mere un ruolo attivo o passivo, in(stili modididiversi mediante processiinterpretando discorsivi e nel lavoro di gruppo, accresce il controllo il cambiamento loro richiesto vita e traiettorie della cura). mento loro richiesto (stilidei di significati vita e traiettorie della cura).cognitiva fra gli operatori che personale e apre all’empatia diventano in tal modo capaci di immedesimarsi nel linguaggio in quanto patrimonio simbolico condiviso.
Scaricare