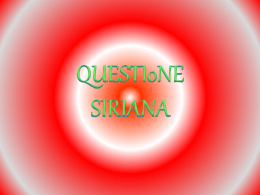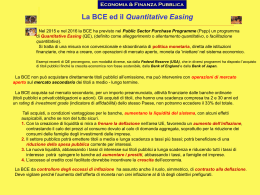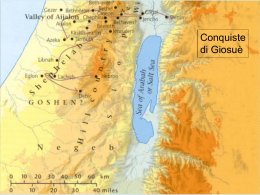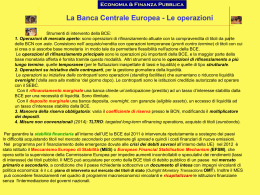ANNO XVII NUMERO 215 - PAG 3 MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2012 EDITORIALI L’aiuto di Draghi e il piano inclinato della perdita di sovranità Il Guatemala ringrazia QUELLA DELLA BCE È UNA SVOLTA, MA NON AVER POTUTO IMITARE IN TUTTO E PER TUTTO LA FED HA LE SUE CONSEGUENZE L’ incontro di oggi a Francoforte tra il primo ministro greco, Antonis Samaras, e il presidente della Banca cen- L’Anm, bontà sua, si accorge che Ingroia fa politica (e pure male) L ì dove s’era soltanto affacciato il Csm – di cui pure Giorgio Napolitano è formalmente il capo – irrompe infine l’Anm, associazione corporativa dei togati con una censura da urlo: “Tutti i magistrati, e soprattutto quelli che svolgono indagini delicatissime, devono astenersi da comportamenti che possono offuscare la loro immagine di imparzialità, cioè da comportamenti politici. Con il suo invito a cambiare la classe dirigente del paese, Ingroia si è spinto a fare un’affermazione che ha oggettivamente un contenuto politico”; con l’effetto di “appannare” la sua immagine di “imparzialità”. Non male come censura, per il magistrato palermitano prestato al ruolo di gran moralizzatore da ogni palco raggiungibile, non ultimo quello congressuale dei Comunisti italiani; non male, come sberla, per il capofila d’un gruppo di pressione che intorno alla mitologia della trattativa stato-mafia ha procurato uno scontro istituzionale senza precedenti con il Quirinale. Ad Antonio Ingroia e al suo collega Nino Di Matteo, il presidente dell’Anm Rodolfo Sabelli contesta un’oggettiva intelligenza (silenzio assenso) con gli assatanati del Fatto nel corso d’una “manifestazione plateale di dissenso nei confronti del capo dello stato”. Meglio tardi che mai. E adesso Travaglio e i suoi vadano pure in cerca di fantasmatiche telefonate tra Napolitano e Sabelli, se hanno altro tempo da gettar via. Manhattan, Gerusalemme, Nairobi Cosa c’entra la guerra in Somalia con il mondo post 11 settembre E’ l’undicesimo anniversario dell’attacco dell’11 settembre sul suolo americano e in Somalia sta succedendo una rivoluzione politico-militare che c’entra molto (no, non è la notizia di apertura per i telegiornali, ma è importante lo stesso). Ieri a Mogadiscio il Parlamento ha votato per un nuovo presidente, come primo passo verso un governo vero. Il Parlamento è stato aperto a fine agosto dentro il perimetro fortificato dell’aeroporto della capitale, dove un giorno apriranno anche le sedi diplomatiche occidentali, perché è la zona più sicura della città dagli attacchi di Shabaab, il gruppo africano che ha giurato fedeltà a Osama bin Laden e ai suoi successori. Si tratta comunque di un passo da gigante rispetto a prima: l’assemblea precedente si riuniva in un silos per il grano vicino al confine – con sedie portate da Amisom – in modo che i deputati potessero scappare in fretta in caso di minacce. Questo cambiamento è reso possibile dalla vittoria dei soldati dell’Unione africana contro Shabaab dopo uno stallo che è sembrato durare un’eternità. Shabaab è stato cacciato da Mogadiscio e si è rintanato nel sud, dove finisce sempre per rifugiarsi – aveva fatto così anche nel 2007, quando era inseguito dalle truppe dell’Etiopia. Si è trincerato a Kismayo, un porto in posizione invidiabile sull’Oceano indiano che garantisce ai fanatici armati un milione di dollari di ricavi ogni mese. In questi giorni è in corso una furiosa battaglia. L’esercito del Kenya è avanzato da sud e tenta di sloggiare Shabaab anche dalla sua roccaforte numero due. Le navi keniane bombardano dal mare. I capi del movimento, secondo notizie d’intelligence, si sono incontrati poco lontano con emissari di al Qaida – venuti da fuori – per decidere cosa fare nell’ora della disperazione. Il Kenya in guerra riconosce di essere aiutato da Israele, che interviene con consiglieri militari ed equipaggiamento contro quelli che Netanyahu nel 2011 definì “gli stessi nemici, sia per Israele sia per il Kenya”. Al tempo il premier israeliano promise di formare con i paesi dell’Africa orientale una coalizione regionale contro il fondamentalismo, che sta funzionando. La minaccia è globale, da Manhattan a Mogadiscio, e richiede una risposta altrettanto globale, poca timidezza e buona inventiva nelle alleanze. Troppa retorica sulla corruzione Dubbi sulle cause di un’economia ferma al di là della mazzetta P aola Severino, ministro della Giustizia, ha promesso lotta dura alla corruzione. Non è solo una missione etica, perché – ha detto a Cernobbio raccogliendo il plauso della platea di manager, imprenditori e ministri – il malaffare toglie tra il 2 e il 4 per cento del reddito e rappresenta una tassa del 20 per cento sugli investimenti esteri. L’Italia è tra i paesi più litigiosi, ai primi posti per il peso del pubblico marciume, il peggiore in assoluto per la lentezza della giustizia civile. Tutti lacci e lacciuoli terribili che impediscono lo sviluppo e ritardano la modernizzazione. I giornali ieri erano pieni di grafici e tabelle impressionanti, anche se non nuovi. E’ bene che la “questione morale” venga vista anche come “questione civile” e non solo in termini moralistici. Tuttavia il circo mediatico ha ancora una volta saltato il fosso alla ricerca del grande colpevole per il grande male che affligge il paese. Così, giù a scrivere che i capitali stranieri non vengono in Italia perché non vogliono pagare le tangenti che invece versano volentieri in Cina, India, Arabia Saudita e Brasile. O che non si aprono fabbriche per paura di essere denunciati (e allora dove la class action è pratica comune come negli Stati Uniti?). E’ vero che la memoria storica non è patrimonio universale, tuttavia bisognerebbe farsi qualche semplice domanda. La giustizia era più rapida negli anni 60? C’era più sicurezza negli anni 70 quando nelle linee di Mirafiori regnava la P38? Il paese era più stabile quando rapivano Aldo Moro? Negli anni 80 i capitali arrivavano a frotte, la valuta si rafforzava e Bettino Craxi voleva introdurre la lira pesante: allora c’era meno corruzione? Può darsi che Mani pulite fosse un complotto della Cia, ma se il buon senso c’è, sta nascosto per paura del senso comune. L’Italia si è fermata vent’anni fa, possiamo dire che non si è più ripresa dalla caduta della lira nel 1992 né dalla traumatica fine della cosiddetta Prima Repubblica. Con qualche breve eccezione, l’economia ristagna da allora e certo non per le politiche di austerità, visto che il debito pubblico era al 117 per cento del pil e oggi supera quota 120. Con l’euro le cose non sono migliorate. Infine è arrivato il collasso del 2008. Tra i tanti dati diffusi a Cernobbio ce n’è uno davvero impressionante: dal 1998, anno in cui è stato fissato il cambio tra lira ed euro, il costo del lavoro è aumentato del 40 per cento, quattro volte più della media europea, mentre in Germania è diminuito. Se i capitali non arrivano è perché investire in Italia non rende nulla. Le società quotate a Milano, dal crac Lehman, hanno perso due terzi del loro valore, nelle altre Borse oggi valgono più di prima. Forse è qui, in questo divario, la causa di fondo della stagnazione. Chiaro, senza trascurare i giudici troppo lenti e le tangenti troppo esose. L’afasia dei liberal sulla bomba iraniana Keller e gli altri si rifugiano nella noncuranza e aspettano l’inevitabile D IL FOGLIO QUOTIDIANO alle colonne del New York Times, che ha diretto per molti anni, Bill Keller ieri ha vergato un editoriale per sostenere che è meglio un Iran nuclearizzato a una guerra preventiva contro Teheran e che in ogni caso Teheran con la bomba all’uranio non sarà la fine del mondo. Dieci anni fa Keller si arruolò in quella nobile pattuglia di liberal che avrebbe sostenuto l’invasione dell’Iraq (assieme a Paul Berman, Christopher Hitchens, George Packer, Kenneth Pollack, Thomas Friedman, Kanan Makiya e altri). Oggi però, sulla bomba atomica iraniana, la stessa intellighenzia vive in una pericolosa afasia. Si fa portavoce di una sorta di fatalismo in cui abbiamo tutto da perdere, quello secondo il quale l’Iran diventerà in ogni caso nucleare e che comunque si deve tenere ferma la mano dello stato ebraico, che potrebbe trascinarci tutti nell’abisso in nome dell’Olocausto. Oppure i liberal si fanno portavoci di bizzarre teorie. Una in particolare campeggiava nel numero di agosto di Foreign Affairs, titolo: “Perché l’Iran dovrebbe avere l’atomica”. L’autore è Kenneth Waltz, fondatore della scuola neorealista nella teoria delle relazioni internazionali. Waltz sostiene che il problema in medio oriente è l’arsenale nucleare di Israele, che deve essere bilanciato da un altro potere, in questo caso l’Iran. In secondo luogo, Waltz ritiene che tale equilibrio atomico possa intrinsecamente stabilizzare la situazione, in tal modo riducendo, non aumentando, il rischio di conflitti. Siamo al delirio. Circola questa strana sensazione, che è come un rumore di fondo, per cui l’occidente non se la senta di imbarcarsi in una nuova spedizione preventiva in medio oriente e che prima o poi Teheran si doterà della bomba nucleare. Se Saddam Hussein era una minaccia per Israele e per gli Stati Uniti, immaginiamoci cosa possa diventare una teocrazia famelica di egemonia e dotata di armi di distruzione di massa. Dan Margalit, giornalista moderato fra i più noti d’Israele, ha scritto ieri che i liberal, “fra la scelta se attaccare o accettare un Iran nucleare, preferiscono sedersi e non fare niente”. Un po’ troppo poco come deterrenza contro il messianismo degli ayatollah. PENNSYLVANIA AVENUE DOMENICO LOMBARDI DI trale europea, Mario Draghi, testimonia il ruolo sempre più centrale dell’Eurotower. Dopo l’incontro di ieri con i rappresentanti della Troika – durante il quale i rappresentanti di Ue, Bce e Fondo monetario internazionale avrebbero espresso dubbi su alcune misure, del valore di 2,2 miliardi di euro, relative al settore pubblico, della sanità e della difesa, contenute nel pacchetto approntato dal governo di Atene – facendo leva sull’importante decisione della scorsa settimana, con la quale l’Eurotower ha rinunciato alla condizione di creditore privilegiato nell’ambito delle operazioni Omt (Outright Monetary Transactions), Samaras chiederà a Draghi una rinuncia simmetrica a valere anche sui titoli greci che la Bce ha in portafoglio. Proprio un atteggiamento più conciliante della Bce nei confronti di Atene spianerebbe la strada a una nuova ristrutturazione del debito greco. Tale ristrutturazione rappresenta una delle condizioni necessarie per il rilancio dell’economia e, nell’immediato, favorirebbe un nuovo pieno coinvolgimento del Fmi nella partita ellenica. Se il vertice di oggi non sarà risolutivo sulla questione, a qualche giorno dalla decisione di Draghi di introdurre l’Omt, è invece possibile un’analisi più accurata delle implicazioni di una richiesta di assistenza da parte italiana. La piattaforma tecnico-istituzionale che è stata approntata da Francoforte è del tutto inedita, ma la sua apparente complessità rischia di celare alcuni aspetti problematici che pure presenta. Procediamo con ordine. L’acquisto di soli titoli a breve rischia di creare qualche problema alla gestione del nostro debito pubblico. Infatti una delle ragioni per cui l’Italia è stata in grado di resistere a pressioni speculative senza precedenti nella storia recente sta proprio nella durata media del nostro debito che si aggira sui 7 anni. E’ evidente che un programma Omt sull’Italia, presubilmente protratto nel tempo, tenderà a far ridurre la sca- denza media del debito poiché le nuove emissioni si concentreranno sui titoli acquistabili dalla Bce che quoteranno rendimenti inferiori. Per converso, per quelli a più lunga scadenza, il Tesoro dovrà pagare un premio che ne renderà più costosa l’emissione. La scelta della Bce, inoltre, è andata in direzione opposta a quella della Federal Reserve americana che, anzi, ha addirittura privilegiato l’acquisto di titoli a lunga scadenza con la recente operazione “twist”. In realtà, per un paese ad alto debito, includere negli acquisti anche titoli a lungo termine non altererebbe l’incentivo a mantenere gli impegni. Se l’Italia rinnegasse tali impegni e la Bce terminasse i suoi acquisti, gli spread salirebbero istantaneamente portando i rendimenti dei titoli a livelli considerevolmente più elevati. Data la mole di debito da rifinanziare, l’incentivo a “rigar dritto” risulterebbe comunque significativo. Per converso nella versione attuale, poiché il programma di assistenza, se attivato, non sarà di breve durata, la scadenza media del debito verrà compressa, creando paradossalmente una condizione di maggiore vulnerabilità nel caso di futuri attacchi speculativi. Ciò rischia di rendere l’Italia sempre più dipendente da forme di assistenza sovranazionale e da quei paesi, leggi Germania, che tali istituzioni influenzano pesantemente. Per quanto riguarda il ruolo del Fondo salva stati (oggi è Efsf, domani sarà sostituito dall’Esm) in questo schema di intervento, esso potrebbe acquistare, sulla base delle sue attuali linee guida, sino alla metà delle emissioni di titoli sul mercato primario. Nel caso dell’Italia, tuttavia, tale limite è teorico. Il Fondo infatti dispone, al netto degli impegni già in essere, di 150 miliardi di euro che coprirebbero a malapena la metà delle emissioni primarie nette che il Tesoro, mediamente, effettua in un anno. Questo, solo nell’ipotesi inverosimile che nessun altro paese dell’Eurozona richieda il suo intervento. Il ruolo del Fondo salva stati è, piuttosto, quello di introdurre l’obbligo per il paese beneficiario di impegnarsi a un programma di condizioni ben definite. Attraverso questo escamotage, la Bce evita il serio imbarazzo di imporre una piattaforma formale di condizionalità ai suoi paesi membri. Eppure, l’Efsf/Esm non ha delle competenze autonome nel disegno di programmi di stabilizzazione. Proprio per questo, la piattaforma dell’Omt prevede l’intervento del Fmi che offrirebbe la propria opera nel disegnare le condizioni del programma e verificarne l’applicazione da parte del paese beneficiario. La supplenza futura del Fmi La domanda è che tipo di condizionalità verrà introdotta dal Fmi. Sulla scorta dei programmi già in essere nell’Eurozona, è probabile che copra le politiche strutturali e di competitività. Nel caso dell’Italia, infatti, è difficile immaginare una condizionalità fiscale che vada oltre gli impegni presi dal governo Monti e dalle forze politiche che lo appoggiano in Parlamento. Inoltre, la politica fiscale è già blindata dal Fiscal compact e dal quadro regolamentare europeo. In realtà, la presenza del Fmi aiuterebbe in maniera duplice. Da un lato, consentirebbe di alleviare il problema delle scarse risorse finanziarie del Fondo salva stati una volta che queste si esaurissero, offrendo una modalità meno umiliante e stigmatizzante per ricorrere a un finanziamento del Fmi nell’ambito di un programma formalmente tripartitico e a maggioranza europea. Dall’altro offrirebbe una exit strategy alla Bce, per cui, terminati in modo consensuale i suoi interventi, il paese in parola passerebbe una fase di convalescenza monitorato dal Fmi, per esempio, attraverso un programma di tipo precauzionale, con l’impegno ex ante a non effettuare alcun tiraggio. Vi è, infine, un ultimo aspetto da considerare. Con l’estensione dell’autorità multinazionale anche alle politiche economiche strutturali e di “competitività”, l’Italia avrà completato il processo di devoluzione della propria sovranità in materia di politica economica nella gestione dell’attuale crisi. Può essere che questo agevolerà l’impeto riformista del prossimo governo. E’, comunque, un aspetto di cui essere consapevoli. Glencore pensa prima di tutto a salvare se stessa e non l’Alcoa Milano. Una scena così non l’avrebbe immaginata nemmeno lo scrittore Ken Follett. Aeroporto di Luton, periferia londinese, giovedì 6 settembre, 15,53 (ora italiana), ovvero sette minuti prima delle 3 di pomeriggio dalle parti di Greenwich. In palio una fusione da 90 miliardi di dollari, quella tra Glencore e Xstrata: la più importante operazione corporate dell’anno da cui potrebbe nascere la quarta potenza nel mondo di tutte le materie prime, comprese quelle alimentari. E forse ne beneficerà anche l’alluminio di Portovesme di cui, per certo, non hanno parlato i giocatori della roulette più ricca dell’anno. Perché la società svizzera Glencore sta pensando innanzitutto a salvare se stessa. Così da una parte c’è Ivan Glasenberg, sudafricano che ha gareggiato in atletica anche sotto le insegne di Israele, numero uno di Glencore, il colosso delle materie prime minerarie e alimentari, balzato agli onori delle cronache italiane per l’interesse manifestato per lo stabilimento sardo di Alcoa. Dall’altra, lo sceicco Al Thani, numero uno del potente fondo sovrano del Qatar, grande azionista di Xstrata, gigante del carbone, vanadio e altre preziose materie prime, che fino all’ultimo si è opposto alle nozze. In mezzo, a far da arbitro, l’ex primo ministro inglese Tony Blair, passato dalla diplomazia al più lucroso mestiere di mediatore d’affari. Per niente facile: per mesi Glasenberg ha ripetuto che non avrebbe alzato il prezzo, così come chiedeva lo sceicco. Per mesi, Al Thani ha risposto picche. Glasenberg ha sparato la carta dell’ultimatum: l’offerta di Glencore valeva fino alle tre del pomeriggio, ora di Londra. Poi Ivan il terribile, miliardario dopo la quotazione alla City nel 2011 del colosso fondato da Marc Rich, sarebbe volato in Cina per l’assemblea dei soci. Al Thani non ha fatto una piega: il Qatar può permettersi di perdere una manciata di miliardi. Glasenberg no. E così, sette minuti prima dell’ora X, il ceo sudafricano ha alzato l’offerta e rinviato l’assemblea. Ieri, secondo Bloomberg, avrebbe fatto sapere che non intende migliorare i termini finanziari dell’offerta di fusione, attualmente pari a 36 miliardi di dollari. Ora la parola passa a soci e manager di Xstrata che decideranno il giorno 24. Prima di allora, poco ma sicuro, ci saranno altri colpi di scena. Perché tutti, da Mick Davis, numero uno di Xstrata, ai trader che in tutto il mondo trattano affari per conto dei due gruppi, praticano con coerenza la legge del denaro, senza alcuna preferenza politica, a ogni latitudine del globo. Glencore e Xstrata, entrambe domiciliate nel cuore della Svizzera, nel cantone di Zug, operano quasi ovunque. Glencore è leader nel business del rame, zinco, commercio di gas e petrolio ma anche dei cereali. Mentre Xstrata è prima nel carbone. Glencore è di casa in Africa così come in Sudamerica, mentre la base privilegiata di Xstrata è l’Australia. Le ragioni della fusione sono evidenti. Dopo anni di vacche grasse il trading di materie prime arranca, al punto che i pro- fitti di Glencore nel primo semestre sono calati del 44 per cento pur toccando la cifra di 1,8 miliardi di dollari, cosa che aveva fatto dire a Glasenberg che “la fusione per noi non è una necessità”. Forse. Ma il fatto che al momento decisivo lo zar di Glencore abbia chinato per la prima volta il capo dimostra che i problemi non mancano. I “cugini” svizzeri, entrambi nati per volontà di Rich, il finanziere cui Bill Clinton concesse la grazia il giorno prima dell’uscita dalla Casa Bianca, sono abituate a navigare tra le polemiche. Rich, che all’inizio degli anni 70 inventò il mercato spot del petrolio, è al centro di intrighi di ogni tipo, compresi i traffici con l’Iran. Una volta ottenuto il perdono di Clinton, si è ritirato in Svizzera cedendo il bastone del comando ai suoi luogotenenti, spesso dalla vita (quasi) altrettanto avventurosa. A proposito, in caso di fusione, il presidente di Glencore-Xstrata sarà John (alias James) Bond. E chissà se Mr. Bond sbarcherà in Sardegna. Non sente, il presidente siriano Assad, il fuoco amico alle spalle? E’ dopo il recente endorsement del presidente egiziano Mohammed Morsi, a favore dei ribelli siriani, che sarebbe iniziato il conto alla rovescia per il regime di DI PIO POMPA Bashar el Assad. Un endorsement preceduto, di qualche ora, da quello di Hamas e seguito, a distanza di pochi giorni, dal nuovo discorso (pubblicato in esclusiva mercoledì scorso sul sito del Foglio) del leader egiziano di al Qaida, Ayman al Zawahiri, che rivolgendosi al popolo turco lo incita a unirsi alla guerra santa contro il regime siriano definito “un pericolo per tutto l’islam e i musulmani”. Secondo quanto rivelato al Foglio da una fonte d’intelligence araba, “una simile concatenazione di eventi, sicuramente non casuale, è suonata a Damasco come un ultimatum cui, è stato accertato, non sarebbero estranei Teheran, nella persona del presidente D a una vita, si può dire, da quando era giovanissimo collaboratore di Mondo e missione al fianco di padre Piero Gheddo, Rodolfo Casadei segue le vicende dei cristiani sparsi per il mondo. Le segue per davvero, viaggiando spesso a incontrarli specie lì dove le loro condizioni sono più dure; i suoi libri perciò sono sempre reportage in presa diretta, che raccontano quel che ha visto con i suoi occhi e ascoltato con le sue orecchie. Quattro anni fa aveva dato alle stampe “Il sangue dell’agnello”, dedicato alle violenze di cui erano oggetto i cristiani dell’Iraq e della Turchia. Ora è la volta di questo “Tribolati, ma non schiacciati” che racconta ancora le sofferenze di perseguitati cristiani iracheni (ma anche libanesi, iraniani, sud-sudanesi e ugandesi), “però soprattutto vuole far conoscere la loro fede, il coraggio, la capacità di costruire, l’amore per Cristo e per il prossimo che hanno mostrato proprio nelle circostanze della persecuzione”. Casadei è stato l’ultimo giornalista occidentale a intervistare Paulos Faraj Rahho, l’arcivescovo caldeo di Mosul – la città martire in cui la presenza cristiana è stata ridotta al lumicino – che fu rapito e fatto morire di stenti nel 2008, e il primo a incontrare il suo successore, Amel Nona, che per raggiungere i fedeli della città vecchia – un tempo sede della maggioranza dei cristiani, ora roccaforte degli estremisti islamici è costretto a camuffarsi. Gli ha chiesto perché ha Mahmoud Ahmadinejad, e Hezbollah. Tant’è che sia Ahmadinejad sia Hassan Nasrallah (capo del Partito di Dio), avrebbero segretamente fornito il loro assenso alla clamorosa sortita contro Assad, di Morsi e del vicepresidente dell’ufficio politico di Hamas, Mousa Abu Marzuk, compiuta dichiarando il loro pieno appoggio alla causa del popolo siriano”. Due sarebbero gli obiettivi di una siffatta scelta strategica. Da un lato, impedire a ogni costo che Stati Uniti, Arabia Saudita e Turchia possano favorire l’affermazione, in Siria, di un regime sunnita che, oltre ad affievolire, partendo dal Libano, le prerogative dell’Iran e di Hezbollah sull’intera regione, finirebbe fatalmente col porsi al fianco di Riad. Dall’altro mantenere integro lo schieramento dei nemici d’Israele acuendone l’isolamento e lo stato di tensione, cosa che sta accadendo in questi giorni, attraverso la minaccia di un nuova LIBRI Rodolfo Casadei TRIBOLATI, MA NON SCHIACCIATI Lindau, 140 pp., 15 euro accettato una nomina tanto rischiosa. “Non potevo rifiutare di servire un popolo di cui conosco le sofferenze. La mia missione pastorale consiste nel mostrare che non bisogna avere paura della morte”. Monsignor Nona non è l’unico che, nel nord dell’Iraq, ha scelto di resistere. Hasim Harboli è novizio al monastero di Nostra Signora delle Messi, estremità settentrionale della piana di Ninive. La sua vocazione è maturata in Grecia, dove la famiglia si era rifugiata; ma dopo la morte di monsignor Rahho ha deciso, nonostante l’opposizione dei familiari, di tornare a vivere qui. Yessef Dured ha vissuto diciassette anni in Olanda, è tornato con la moglie e le tre figlie per prendersi cura del padre. Osserva: “I cristiani iracheni sono migliori di quelli olandesi. In Olanda i musulmani chiedono e ottengono tutto in nome dei diritti umani, e gli olandesi non capiscono che ai musulmani non interessa la realizzazione dei diritti offensiva, al confine israeliano, da parte di Hezbollah con lo scopo, non dichiarato, di rendere più difficile un eventuale strike di Gerusalemme contro i siti nucleari iraniani. “Sennonché – confida al Foglio la fonte d’intelligence – il successo di tale strategia è basata su uno snodo cruciale. Eliminare Bashar el Assad, esiliandolo o uccidendolo, in modo tale da togliere l’iniziativa ai ribelli e a coloro i quali, con in testa Stati Uniti e Arabia Saudita, possono favorire la vittoria sunnita costringendoli a scendere a trattative sui futuri assetti politici di quel paese. In questo momento, Assad e il suo entourage, sono praticamente tenuti in ostaggio e costantemente controllati da un centinaio di Guardie rivoluzionarie della Brigata al Quds e da altrettanti agenti di Hezbollah. Quel che il rais siriano, e suoi più stretti collaboratori, non sanno, ma forse sospettano, è di poter essere assassinati da fuoco amico. Tanto, come umani, ma vogliono far trionfare la loro religione”. Non c’è, peraltro, solo contrapposizione. Poco più in là, a Kirkuk, Louis Sako, arcivescovo caldeo, si è conquistato la stima di molte autorità islamiche: “Osama bin Laden non rappresenta noi musulmani, così come le vignette danesi su Maometto non rappresentano voi cristiani”, commenta lo sceicco Ali Kh-Samed, che tiene appesa a una parete dello studio una foto di Benedetto XVI. “Ma di questo abbiamo certezza solo quando ci conosciamo personalmente”. Un’ultima storia – tra le molte altre che Casadei racconta e che lasciamo al lettore – arriva dall’Africa nera. Margaret Arach Orech viaggiava su uno sgangherato bus lungo una strada dell’Uganda del nord. Una granata dei guerriglieri che attaccano il veicolo le trancia di netto una gamba. Si finge morta, anche mentre le strappano di dosso i vestiti, e così riesce a salvarsi; ma viene abbandonata da tutti, perché in Africa un mutilato, come un handicappato, è motivo di vergogna. Allora ha fatto appello alla sua fede: “Se Dio mi aveva salvato, doveva esserci un motivo. La risposta arrivò subito, leggendo la Bibbia, Isaia 43: ‘Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?’”. Ora gira il mondo come ambasciatrice della Campagna per la messa al bando delle mine antiuomo. da copione, è facile poi addossarne la responsabilità ad al Qaida o, ancora meglio, al Mossad”. Tutto questo avviene mentre velleitariamente si pensa, da parte americana e turca, di bombardare le postazioni del nocciolo duro dell’esercito lealista siriano attardandosi, in analisi e controanalisi, sulla possibilità che Assad possa ricorrere all’uso di armi chimiche. In realtà nessuno dei paesi presenti vuole un coinvolgimento diretto nella crisi siriana. Questo Ahmadinejad lo sa bene, e ora cercherà di giocare d’anticipo nonostante le resistenze della Guida suprema, Ali Khamenei. Per il presidente iraniano tutto è possibile quando si tratta di contrastare i disegni del miglior alleato d’Israele concordando, in ciò, con al Zawahiri: “Ricordatevi che la liberazione di Gerusalemme, da parte di Salahuddin, è iniziata con la liberazione di Damasco”. IL FOGLIO quotidiano Direttore Responsabile: Giuliano Ferrara Vicedirettore Esecutivo: Maurizio Crippa Vicedirettore: Alessandro Giuli Coordinamento: Claudio Cerasa Redazione: Michele Arnese, Annalena Benini, Stefano Di Michele, Mattia Ferraresi, Giulio Meotti, Salvatore Merlo, Paola Peduzzi, Daniele Raineri, Marianna Rizzini, Paolo Rodari, Nicoletta Tiliacos, Piero Vietti, Vincino. Giuseppe Sottile (responsabile dell’inserto del sabato) Editore: Il Foglio Quotidiano società cooperativa Via Carroccio 12 - 20123 Milano Tel. 02/771295.1 La testata beneficia di contributi diretti di cui alla legge n. 250/90 Presidente: Giuseppe Spinelli Direttore Generale: Michele Buracchio Redazione Roma: Lungotevere Raffaello Sanzio 8/c 00153 Roma - Tel. 06.589090.1 - Fax 06.58335499 Registrazione Tribunale di Milano n. 611 del 7/12/1995 Telestampa Centro Italia srl - Loc. Colle Marcangeli - Oricola (Aq) Poligrafico Europa srl - Via Enrico Mattei, 2 - Villasanta (Mb) Distribuzione: PRESS-DI S.r.l. Via Cassanese 224 - 20090 Segrate (Mi) Pubblicità: Mondadori Pubblicità S.p.A. Via Mondadori 1 - 20090 Segrate (Mi) Tel. 02.75421 - Fax 02.75422574 Pubblicità legale: Il Sole 24 Ore Spa System Via Monterosa 91 - 20149 Milano, Tel. 02.30223594 e-mail: [email protected] Abbonamenti e Arretrati: STAFF srl 02.45702415 Copia Euro 1,50 Arretrati Euro 3,00+ Sped. Post. ISSN 1128 - 6164 www.ilfoglio.it e-mail: [email protected]
Scaricare