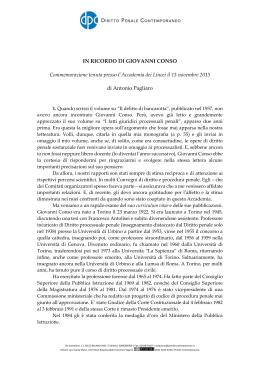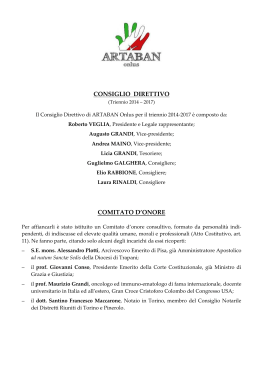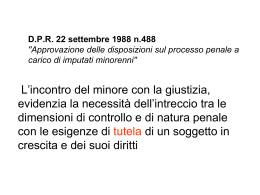CONSO E IL CORAGGIO DELLA SOLITUDINE Ora tutti ricordano e compiangono il grande giurista, il suo “spirito di indipendenza”, la sua “passione civica”, il suo “rigore personale”, il suo “intenso impegno al servizio dello Stato”, la sua “lucida ed appassionata dedizione alla scienza del diritto”, riconoscendo in Giovanni Conso “uno dei migliori studiosi del diritto e della procedura penale, punto di riferimento per più di una generazione di giuristi”. Noi lo ricordiamo come un esempio, anche per il coraggio con il quale, nel 2009 a Torino, a un importante Congresso dell’UCPI, con la sua logica rigorosa, dimostrò l’inevitabilità della separazione delle carriere, per la realizzazione del giusto processo, affermando più volte, contro il monocorde coro dei luoghi comuni, la necessità della separazione delle carriere come vera e propria precondizione che è costituita dalla terzietà del giudice. Piacerebbe anche a un cattolico che della sua laicità aveva fatto un vessillo, vedere evocato questo pensiero insieme al suo ricordo, in un momento in cui molti dimenticano l’arroganza con la quale, fino a pochi mesi prima della sua morte, Giovanni Conso veniva messo alla gogna. Vi è difatti un’idea arrogante e illiberale di modernità, vincitrice ma non vincente, che in questi anni si è impossessata del Paese, sostituendosi al dialogo, alla democrazia, all’equilibrio delle forze e delle istituzioni, un’idea di giustizia e dunque di giurisdizione, implicitamente violenta, che fa del processo un rimedio al male, uno strumento di vendetta sociale. Un’idea di giustizia e di processo che Giovanni Conso certo non amava e che con la sua vita e con il suo insegnamento, con il suo impegno per i diritti civili in campo nazionale e internazionale (non a caso era stato nominato Presidente della Commissione ONU per la redazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale permanente), aveva sempre combattuto, pensando a un processo penale nel quale – come ricorda oggi il Presidente Napolitano – “l’efficienza non fosse disgiunta dalle garanzie”. E’ capitato a un grande giurista del livello di Giovanni Conso, che non casualmente ha ricoperto il ruolo di Presidente della Corte Costituzionale e di Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, di essere anche chiamato a ricoprire la carica di Guardasigilli in un momento storico di grandi cambiamenti epocali e di grave crisi per la nostra storia democratica, lo stragismo mafioso, Tangentopoli, il crollo del sistema partitico della prima Repubblica (ed in quel medesimo contesto, il varo e la crisi del nuovo codice di procedura penale). Quella presunta idea di modernità, manichea ed inquisitoria, si rifiuta di leggere la storia con gli strumenti della ragione e della laicità e la costruisce a sua immagine e somiglianza, come uno scontro impari fra marchingegni criminali e idea platonica della giustizia, ignorando il tessuto reale di cui sono fatti l’impegno civile, ignorando quanto sia difficile realizzare in concreto, ed in concreto interpretare, il senso dello Stato e delle Istituzioni. E non dovette essere facile esercitarlo in quell’annus horribilis che durò dal febbraio del 1992 al maggio del 1994. E’ difficile credere che a Giovanni Conso, in quanto cattolico, e perché laico e, soprattutto, perché giurista di grande levatura, l’ignominia del carcere duro, la frode inumana, la tortura legalizzata del 41 bis, potessero sembrare un legittimo istituto giuridico, un sano strumento di riaffermazione della legalità. Qualcuno ha creduto – come ricorda Giovanni Bianconi – che si trattasse di “un segnale della disponibilità dello Stato ad arretrare di fronte al ricatto mafioso”. La mancata proroga degli oltre trecento 41 bis, che significava e significò di fatto la cancellazione di altrettante ignominiose ingiustizie, era e resta un gesto coraggioso ed alto di civiltà, di umanità e di giustizia, attuato in una “solitudine” fatta soprattutto di responsabilità, e comunque intriso al tempo stesso di sensibilità laica, di umanesimo cattolico e di autentico senso dello Stato. Noi sappiamo bene, per averlo sperimentato nelle nostre battaglie per la libertà, la legalità e la giustizia, cosa significhi essere accusati o sospettati di “contiguità mafiosa”, solo per aver osato difendere i più ovvi principi dell’umanità e del diritto contro la “tortura di Stato”, o essere accusati di collusione con il partito dei corrotti, per aver denunziato le dilaganti prassi distorsive di “mani pulite”. Quello sulla cosiddetta “trattativa” non è – come qualcuno ha scritto – un processo “lunare”, ma la terrena e mondanissima attuazione di una strategia in virtù della quale i processi diventano meri strumenti di potere. Noi continuiamo a credere che la Storia non la debbano scrivere i processi e che il nobile compito della magistratura sia altro. Ed è per questo che interpretiamo l’idea di legalità come difesa dei diritti degli “ultimi”, ed il processo penale come indeclinabile garanzia, contro il coro monocorde di ogni pensiero unico imperante, di quel pensiero che, forse, avrebbe voluto mandare Giovanni Conso al 41 bis. Roma, 5 agosto 2015 La Giunta
Scaricare